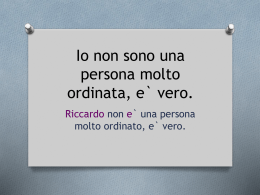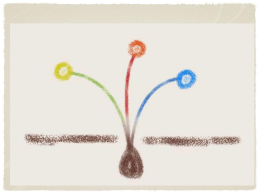«Una delizia.» - Zadie Smith UN ESTRATTO IN ANTEPRIMA GARY SHTEYNGART MI CHIAMAVANO PICCOLO FALLIMENTO Traduzione di Katia Bagnoli ESTRATTO SCELTO PER VOI DALLA REDAZIONE UGO GUANDA EDITORE IN PARMA Titolo originale: Little Failure. A Memoir Un ringraziamento a Moldy Fig Music per il permesso di riprodurre quattro versi della canzone «And She Was» di David Byrne. Su gentile concessione di Moldy Fig Music La fotografia è dell’archivio personale dell’autore. In copertina: fotografia dell’autore. Su gentile concessione Grafica di Guido Scarabottolo Per essere informato sulle novità del Gruppo editoriale Mauri Spagnol visita: www.illibraio.it ISBN 978-88-235-0885-9 Copyright © 2014 by Gary Shteyngart All rights reserved This translation published by arrangement with Random House, an imprint and division of Random House LLC © Ugo Guanda Editore S.r.l., Via Gherardini 10, Milano Gruppo editoriale Mauri Spagnol www.guanda.it 2 Ecco a voi il moccioso All’autore viene comunicato che in realtà la linea non funziona. CERTIFICATO DI NASCITA IGOR SHTEYNGART 5 luglio 1972 Cari genitori! Ci congratuliamo sentitamente con voi e partecipiamo alla vostra gioia per la nascita di un nuovo essere umano, un cittadino dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e membro della futura Società Comunista. Auguriamo alla vostra famiglia salute, molto amore, amicizia e armonia. 27 Siamo sicuri che alleverete vostro figlio perché diventi un lavoratore indefesso e coscienzioso e un patriota leale alla nostra grande patria! Firmato Comitato Esecutivo del Consiglio dei Delegati dei Lavoratori di Leningrado Sono nato. Mia madre incinta attraversa una strada di Leningrado e un camionista le suona il clacson, perché spaventare le donne incinte è la cosa giusta da fare. Lei si stringe la pancia. Si rompono le acque. Corre alla Casa della Nascita Otto sull’Isola Vasil’evskij, un’importante appendice galleggiante sulla mappa di Leningrado, la stessa casa della nascita dove sono venute al mondo lei e le sue due sorelle. (I bambini russi non nascono in ospedali con tutti i crismi come in Occidente.) Prematuro di parecchie settimane, abbandono mia madre uscendo con le gambe e il sedere. Sono lungo e tutto pelle e ossa e assomiglio a un bassotto tedesco umanoide, solo che ho una testa incredibilmente grande. « Ottimo lavoro! » dicono le infermiere. « Hai dato alla luce un bel mužik. » Un mužik, il maschio russo robusto e muscoloso, è l’ultima cosa che sarei diventato, ma quello che a mia madre brucia è che le inservienti le si rivolgano in modo informale, con il ty anziché con il vy. Mia madre è sensibile a queste distinzioni. Viene da una buona famiglia e non è semplicemente un’ebrea qualunque (evreika) che puoi insultare senza pensarci su. La Casa della Nascita Otto. Per un « membro della futura Società Comunista », questo palazzo pseudo-liberty è uno dei più bei posti della città, forse del paese, dove nascere. Sotto i piedi di mia madre, un raffinato pavimento in piastrelle con motivo di onde e farfalle, e sopra di lei lampadari cromati; all’esterno, gli enormi edifici in stile barocco petrino dei Dodici 28 Istituti dell’università statale di Leningrado e una tranquillizzante esplosione di sempreverdi russi inseriti in un paesaggio subartico. E fra le sue braccia, io. Sono nato affamato. Famelico. Voglio mangiare il mondo, e niente riesce a saziarmi. Latte materno, latte condensato, qualunque cosa ci sia, io la succhio, la addento, la inghiotto. Anni dopo, sotto la tutela della mia adorata nonna Polja, diventerò un ciccione, ma per adesso sono smilzo e affamato. Mia madre ha ventisei anni, una primipara attempata, per gli standard dell’epoca. Mio padre ne ha trentatré e in base all’aspettativa di vita dei maschi locali è già nel mezzo del cammino della sua vita. Mia madre insegna pianoforte in una scuola materna; mio padre è un ingegnere meccanico. Possiedono un appartamento di circa quarantacinque metri quadri dotato di balcone nel centro di Leningrado, il che li rende dei privilegiati; in termini relativi, molto più privilegiati di quanto riusciremo mai a essere negli Stati Uniti, persino quando alla fine degli anni Ottanta alle nostre sostanze si aggiungerà una casetta in stile coloniale a Little Neck, nel Queens. Altrettanto vero, anche se mi ci vorrà una vita per capirlo, è che i miei genitori sono troppo diversi perché il loro sia un matrimonio riuscito. L’Unione Sovietica dovrebbe essere una società senza classi, ma mio padre è un ragazzo di campagna, di un ceppo problematico, e mia madre appartiene all’ambiente culturale di Pietroburgo, una classe che ha i suoi problemi ma le cui sofferenze al confronto sono ridicolmente trascurabili. Per mia madre, i parenti di mio padre sono incivili e provinciali. Per mio padre, quelli di lei sono falsi e presuntuosi. Nessuno dei due si sbaglia del tutto. Mia madre sembra mezza ebrea, e dato il luogo e l’epoca significa che è ebrea per una metà di troppo, ma è bella in un suo modo compatto e sbrigativo; a coronare una faccia preoccupata sopra una maglia a collo alto ha un modesto alveare di capelli, e il sorriso è sempre pronto agli angoli della bocca, un sorriso riservato per lo più alla famiglia. Leningrado è la sua città, come fra poco lo sarà anche New York. Sa dove comprare una 29 volta ogni tanto le cotolette di pollo e i pasticcini che scoppiano di panna. Si tiene stretto ogni copeco, e quando a New York i copechi diventeranno centesimi, li terrà ancora più stretti. Mio padre non è alto, ma è bello, di una certa bellezza cupa e levantina, e si prende cura del suo fisico... in effetti, per lui, il mondo fisico è l’unica via di salvezza da una mente che frulla costantemente. Al mio matrimonio, molti anni dopo, più di una persona commenterà scherzosamente com’è strano che una coppia così avvenente abbia generato me. Penso che ci sia del vero. Il sangue dei miei genitori non si è mescolato bene. Ai padri non è permesso entrare nella Casa della Nascita Otto, ma per i dieci giorni in cui ci tengono separati mio padre è colpito dalla sensazione acuta (se non terribilmente unica) di non essere più solo al mondo e di dovermi stare vicino. Nei miei primi anni sulla terra esprimerà questo sentimento, chiamiamolo amore, con grande abilità e risolutezza. Gli altri aspetti della sua vita, una carriera generalmente poco entusiasmante passata a costruire grandi telescopi nella famosa fabbrica di strumenti ottici LOMO, il fugace sogno di diventare un cantante lirico, svaniranno mentre cerca di aggiustare il bambino rotto che tiene fra le braccia. Dovrà sbrigarsi! Alla Casa della Nascita Otto si pratica ancora allegramente la fasciatura dei neonati, e le fasce che avvolgono il mio corpo a forma di bassotto tedesco sono fissate con un enorme fiocco azzurro (bant) intorno al collo. Quando il taxi arriva al nostro appartamento nei miei polmoni non c’è quasi più aria e la mia grande testa buffa è azzurra quasi come il fiocco che mi sta strangolando. Vengo rianimato, ma il giorno dopo comincio a starnutire. La mia ansiosa madre (proviamo a contare il numero di volte in cui le parole « ansiosa » e « madre » compaiono vicine in questo libro) chiama il policlinico locale e chiede che le mandino un’infermiera. L’economia sovietica è un quarto di quella ame30 ricana, però medici e infermieri fanno ancora visite a domicilio. Alla nostra porta compare una donna corpulenta. « Mio figlio starnutisce, che cosa faccio? » chiede iperventilando la mia mamma. « Gli dici: ‘Salute’ » la istruisce l’infermiera. Nei tredici anni successivi – fino a quando indosserò un vestito abbondante per il mio Bar Mitzvah alla Congregazione Ezrath Israel ai piedi delle Catskill Mountains – soffrirò d’asma. I miei genitori si spaventeranno da matti, e spesso anch’io. Ma sarò anche circondato dalla strana, invadente meraviglia di essere un bambino malato, dal conforto che ne deriva, dal senso di sicurezza che ti dà sprofondare in un fortino di cuscini e piumoni e trapunte, oh, quelle trapunte sovietiche assurdamente spesse che lasciano sempre uscire l’imbottitura di cotone uzbeko. Dai termosifoni si sprigiona un caldo esagerato, ma anche il mio calore stantio di bambino mi ricorda che sono qualcosa di più di un contenitore per il catarro che mi ristagna nei polmoni. È questo il mio primo ricordo? I primissimi anni, i più importanti, sono i più difficili. Emergere dal nulla richiede tempo. Ecco che cosa mi sembra di ricordare. Mio padre, o mia madre, tutta la notte svegli, che mi tengono la bocca aperta con un cucchiaio, in modo che l’aria mi entri nei polmoni e l’asma non mi soffochi. Madre, delicata, preoccupata. Padre, delicato, preoccupato, ma triste. Spaventato. Un paesano, un mužik piccolo ma robusto, che lotta con una creatura difettosa. Tra le soluzioni di mio padre alla maggior parte dei problemi c’è il tuffo in un lago gelato, ma qui non ci sono laghi. La sua mano calda mi sostiene la nuca accarezzandomi compassionevole i capelli fini, ma riesce a stento a trattenere la frustrazione quando mi dice: « Ach, ty, Sopljak ». Ah, tu, Moccioso. Negli anni seguenti, mentre ci rendiamo conto che l’asma non se ne andrà, la rabbia e la delusione in quelle parole 31 saranno più pronunciate e io vedrò le sue grosse labbra incresparsi mentre spezza la frase nei suoi elementi costitutivi: Ah. Sospiro. Tu. Scrollata di capo. Moccioso. Tuttavia non sono ancora morto! La fame dentro di me è forte. Ed è fame di carne. Il « kolbasa del dottore », un morbido equivalente russo della mortadella; poi, a mano a mano che i denti aumentano in complessità, la vetcina, o prosciutto russo, e la buženina, carne di maiale cotta al forno, mangiata fredda e pericolosamente gommosa, il cui gusto permane sulla lingua per ore. Non sono alimenti facili da trovare: persino la prospettiva di un po’ di pesce puzzolente vecchio di una settimana attira centinaia di persone in una coda che si estende dietro l’angolo sotto l’uniforme cielo rosa del mattino. L’ottimismo del disgelo promosso dal leader post Stalin Nikita Krusciov è finito da tempo e sotto la guida sempre più sclerotica del comicamente tremebondo Leonid Brežnev l’Unione Sovietica sta cominciando la sua lenta discesa nell’inesistenza. Ma come bramo la mia carne, insieme ad alcuni cucchiaini di sgušcënka, il latte condensato, nelle iconiche lattine azzurre. « Latte, intero, condensato, con zucchero » sono forse le prime cinque parole che ho cercato di leggere in russo. Dopo i pesanti nitriti del kolbasa, ho la fortuna di ricevere un pizzico di questo dolce dispensato da mia madre. E ogni cerchio d’amore mi lega sempre più a lei, a loro, e ancora di più mi uniranno tutti i successivi tradimenti e le valutazioni sbagliate. Questo è il modello della famiglia ebreo-russa stucchevolmente unita, ma non è un’esclusiva della nostra etnia. Qui nell’URSS, con le limitazioni della libertà e le scarse forniture di kolbasa del dottore e di latte condensato, viene semplicemente amplificata. Sono un bambino curioso, e niente mi incuriosisce più della 32 presa di corrente. Per me il massimo dell’esperienza è ficcare le dita in quei due miseri buchi (freudiani, accomodatevi pure!) e sentire la scossa di qualcosa di più vivo di me. I miei genitori mi dicono che dentro la presa vive il Djadja Tok, o Zio Corrente, un uomo cattivo che vuole farmi del male. Djadja Tok, insieme al mio vocabolario carnivoro (vetcina, buženina, kolbasa) e a Sopljak (Moccioso), è una delle prime parole che imparo della vasta lingua russa. C’è anche il mio grido selvaggio « Ëbtiki mat’! », una storpiatura infantile di ëb tvoju mat’, o « in culo a tua madre », che, presumo, dà una simpatica visione d’insieme dei rapporti fra i miei genitori e le rispettive famiglie. Fame e curiosità vanno di pari passo con l’ansia. Ci vorranno altri cinque anni prima che io riesca a formulare il concetto di morte come fine della vita, comunque la mia incapacità di respirare me ne concede una buona anteprima. La mancanza d’aria mi rende nervoso. È elementare, no? Inspiri, espiri. Non ci vuole un genio. E io ci provo. Però non succede niente. Il meccanismo dentro di me cigola, senza risultato. Non conosco altri bambini, non ho termini di paragone, ma come bambino sono tutto sbagliato, lo so. E fino a quando le due creature che mi tengono la bocca aperta con un cucchiaio continueranno a farlo? Intuisco che li fa soffrire terribilmente. C’è una fotografia di me a un anno e dieci mesi scattata in uno studio fotografico. Indosso un paio di brache felpate con un coniglietto su una delle tasche anteriori, tengo in mano un telefono (lo studio fotografico è orgoglioso di esibire questa tecnologia sovietica d’avanguardia), e sto per scoppiare a piangere. Ho l’espressione di una madre che nel 1943 ha appena ricevuto un telegramma fatale dal fronte. Ho paura dello studio fotografico. Paura del telefono. Paura di qualsiasi cosa si trovi al di fuori del nostro appartamento. Paura delle persone con i loro grandi colbacchi. Paura della neve. Paura del freddo. Paura del caldo. Paura del ventilatore a soffitto, verso il quale punto un tragico dito prima di cominciare a piangere. Paura di qualsiasi cosa più alta del mio letto. Paura dello Zio Corrente. 33 « Perché avevo tanta paura di tutto? » chiedo a mia madre quasi quarant’anni dopo. « Perché sei nato ebreo » dice lei. Può darsi. Il sangue che mi scorre nelle vene è per lo più Jasnickij (mia madre) e Shteyngart (mio padre), ma le infermiere della Casa della Nascita Otto hanno anche aggiunto 10, 20, 30, 40 cc del sangue di Stalin e Berija, di Hitler e Göring. C’è un’altra parola: tigr. La mia infanzia non è abbellita dai giocattoli, o da quelli che oggi si chiamano strumenti educativi, però ho una tigre tutta mia. Nella Russia del 1972 il regalo collettivo che di solito si fa a una giovane madre è una scorta di pannolini di cotone. Quando i colleghi di mia madre scoprono che vive nei nuovi palazzi eleganti vicino al fiume Neva – oggi sembra una zona degradata di Mumbai, con balconi di legno di vari colori messi a casaccio – si rendono conto che i pannolini non vanno bene. E così raccolgono i diciotto rubli necessari per comprare un regalo lussuoso, una tigre di pezza. La tigre è quattro volte più grande di me ed è della giusta tonalità di arancione, e i baffi sono grossi come le mie dita e la sua espressione dice: Voglio essere tua amica, Mocciosetto. Riesco a montarci sopra, per quanto me lo consentano le mie capacità acrobatiche di bambino malato, così come salirò sul petto di mio padre per molti anni a venire e, come faccio con lui, le tiro le orecchie rotonde e le strizzo il naso grassoccio. Ci sono altri ricordi che mi piacerebbe catturare e mostrarvi, se solo fossi più rapido con la mia rete. Affidato alle cure della nonna paterna Polja, cado da una carrozzina e atterro a testa in giù sull’asfalto. Forse questo produce alcune difficoltà di apprendimento e coordinazione che persistono tutt’oggi (se mi vedete guidare sulla Route 9G state attenti, per favore). Imparo a camminare, non con particolare sicurezza. Nella vicina Lettonia, durante una vacanza estiva in una fattoria, dentro un pollaio inciampo, cado in ginocchio con le braccia tese e abbraccio un pollo. La tigre è sempre stata gentile con me: possibile che questo animaletto colorato si comporti peggio? Il pollo lettone scuote il bargiglio e mi rifila una beccata. Per ragioni politiche, 34 forse. Dolore e senso di tradimento e urla e lacrime. Prima, per lo Zio Corrente; adesso per il pollo baltico. Il mondo è cattivo e irrispettoso e si può contare solo sulla propria famiglia. E poi i ricordi cominciano ad affluire in quantità. E io divento quello che ero destinato a essere. Vale a dire, una persona innamorata. Ho cinque anni e sono perdutamente innamorato. Lui si chiama Vladimir. Ma per questo dovrete aspettare. CONTINUA IN LIBRERIA 35 NELLA TOP TEN DEL NEW YORK TIMES INCLUSO NELLA LISTA DEI 20 MIGLIORI GIOVANI SCRITTORI DAL NEW YORKER, INSIEME A JONATHAN SAFRAN FOER “Straordinaria capacità di miscelare autoironia e introspezione.” Michiko Kakutani, critico letterario del New York Times
Scaricare