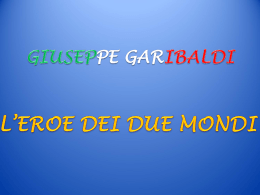1 2 Antonio Ghirelli L’eccidio di Fantina Sellerio editore Palermo 3 1986 © Sellerio editore via Siracusa 50 Palermo Seconda edizione 4 L’eccidio di Fantina 5 Introduzione «È con grande commozione che ho visitato i luoghi dell’eccidio di Fantina, uno degli episodi più dolorosi dell’epopea garibaldina; una pagina tragica della storia del nostro Risorgimento, un episodio che la storiografia ufficiale ha voluto dimenticare e seppellire nell’oblio, tanto che a quasi trent’anni dal suo svolgersi non fu ancora possibile, per gli ostacoli frapposti dalle autorità del tempo, erigere un monumento ai sette volontari garibaldini che ne furono le vittime». Si apriva con queste parole il discorso che il Presidente del Consiglio Bettino Craxi pronunciò il 24 novembre 1984, nello stesso paese in cui era avvenuto, sei giorni dopo l’infausto episodio dell’Aspromonte, l’eccidio delle sette camicie rosse per mano di ufficiali e militari dell’esercito regolare italiano. Dinanzi alla chiesa di Santa Maria Santissima della Provvidenza, su cui era stata murata la lapide commemorativa dettata dal patriota Raffaele Villari, in mezzo a una piccola folla di abitanti del luogo, alla presenza del sindaco Giuseppe Munafò e del parroco, Craxi rendeva omaggio «ai martiri dimenticati» di Fantina per sottolineare «la ricongiunzione permanente di tutti gli spiriti liberi con coloro che più di cento anni or sono si sono sacrificati per ideali che oggi sono comuni a tutti gli italiani». Il sindaco Munafò gli rispondeva ringraziandolo vivamente per la visita e sospirando che forse il paese non avrebbe avuto più l’onore di ospitare un altro Presidente 6 del Consiglio: «Qui non si vive», concludeva Munafò: «Si lavora aspettando la vita». Anche se non è molto evidente, esiste senza dubbio un nesso tra l’episodio rievocato da Craxi e l’amaro accenno del sindaco di Fantina ai problemi del sottosviluppo meridionale; il nesso sta nella maniera in cui la classe dirigente sabauda realizzò l’unificazione del Paese, disprezzando i grandi valori di libertà, di democrazia e di emancipazione popolare rappresentati da Garibaldi, da Mazzini e dai loro generosi compagni di lotta, e disconoscendo ad un tempo le grandi tradizioni culturali, i grandi bisogni spirituali ed economici delle popolazioni del Sud. Fantina può essere assunto perciò come un simbolo altamente emblematico dell’uno e dell’altro errore, talché approfondire la storia dell’eccidio del settembre 1862 può forse aiutare a capire anche il grido di dolore lanciato dal sindaco Munafò nel novembre 1984. La cerimonia a cui Craxi assité il 24 novembre 1984 e il discorso che pronunciò dinanzi alla lapide della chiesa di Fantina, alla presenza del sindaco e di una piccola folla, ristabilirono la verità almeno per quanto riguarda il barbaro episodio delle sette camicie rosse giustiziate dai loro connazionale dell’esercito. Dopo aver ricordato che Carlo Trasselli era «un reduce delle rivolte contro i Borboni», il primo Presidente del Consiglio socialista della storia d’Italia aggiungeva: «Quando i rapporti del colonnello Trasselli rendono noto l’episodio, i giornali repubblicani e garibaldini protestano con veemenza e sotto le pressioni della Camera il Governo è costretto ad 7 avviare un’inchiesta giudiziaria. Tutte le pressioni sono esercitate per mettere a tacere la stampa; e quando il magistrato di Messina mostra di voler andare a fondo nell’accertamento dei fatti, egli viene rimosso e sostituito con un altro magistrato che chiude l’inchiesta. Esercito e Governo, cioè, fecero blocco e si assunsero tutta la responsabilità di un atto efferato prodotto da una mentalità militarista ottusa e reazionaria. «La storiografia ufficiale ha rimosso Fantina dalla propria memoria che tuttora resta viva solo per i documenti dell’epoca; e per la denuncia coraggiosa che tornò a farne, ai primi del secolo, Napoleone Colajanni, sulla sua “Rivista Popolare”. Fu un comportamento grave, poiché le vittime di Fantina non erano soldati codardi che avevano fuggito il campo di battaglia, ma soldati coraggiosi infiammati dall’ideale della patria unita, che avevano lasciato l’esercito per tornare con i garibaldini in prima linea, a battersi e a sfidare la morte per la libertà di Roma e l’unità d’Italia. «L’epopea garibaldina è colma della parola “libertà”. Essa spiega la popolarità e il successo dell’azione garibaldina. La patria unita, perché gli uomini siano liberi. La storia ufficiale dell’Italia è stata invece per molti colma di ragioni di Stato». Alle ragioni di Stato il Presidente socialista sostituiva la ragione della verità, facendo luce sul passato per trasformare l’arrogante successo di una frazione nella vittoria tormentata di tutti gli italiani. A.G. 8 Parte prima Roma o morte 9 1 Il 27 marzo 1861, tredici giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia alla cui unificazione Garibaldi aveva offerto un contributo determinante con la travolgente conquista delle due Sicilie, la Camera dei Deputati approvava per acclamazione un ordine del giorno Oudinot-Boncompagni che auspicava la liberazione di Roma per farne la capitale d’Italia. Il Partito d’Azione non si lasciò tuttavia trarre in inganno da questa astratta petizione di principio, dietro cui indovinava la preoccupazione del conte di Cavour di realizzare il grande obiettivo senza suscitare reazioni apprezzabili nel Papa e soprattutto in Napoleone iii. Anzi nei primi mesi dell’anno, secondo informazioni che garibaldini e mazziniani ritenevano affidabili, il Conte sarebbe entrato in trattative con il Segretario di Stato, Cardinale Antonelli e avrebbe addirittura tentato di corromperlo con promesse di denaro per lui e di favori per i suoi familiari. Quali ne fossero esattamente le premesse, le trattative in questione erano comunque fallite e Cavour si stava accingendo probabilmente a battere un’altra pista, in direzione di Venezia (a questo proposito gli si accreditava una spedizione clandestina di armi nei Balcani, per creare difficoltà all’Austria) allorché, il 6 10 giugno 1861, usciva prematuramente di scena. La morte del grande statista rappresentò un colpo irreparabile per la costruzione del nuovo organismo statale e, in modo abbastanza paradossale, si rivelò funesta alla distanza anche per l’uomo che aveva sempre considerato Cavour un suo nemico giurato. In quel tempo Garibaldi attraversava uno dei suoi periodi di affollata solitudine a Caprera, dove era appena scampato ad un ulteriore attentato allorché ricevette una singolare proposta dagli Stati Uniti, lacerati dalla guerra di secessione. Latore delle proposta era l’ambasciatore americano a Bruxelles Sandford che, a nome del presidente Lincoln, veniva ad offrire al Generale un comando di primo piano nell’esercito dell’Unione. Pur se commosso e lusingato per un così solenne riconoscimento, che in fondo premiava anche la sua efficienza professionale, Garibaldi avanzò dapprima condizioni impossibili, come l’abolizione immediata della schiavitù per parte di un governo che non poteva non muovere da posizioni assai più prudenti, e quindi finì per declinare un invito che lo avrebbe portato troppo lontano dall’Italia. In quel momento non sarebbe tornato volentieri neppure nell’America del Sud. Il suo sogno era di completare l’unità del suo Paese con la liberazione di Venezia e Roma, magari attraverso lo stesso abile dosaggio tra iniziativa ribellistica e tacita intesa col Governo, che aveva propiziato il successo dell’impresa dei Mille. Naturalmente si trattava di un’ipotesi irrealizzabile perché molte circostanze erano cambiate sul piano inter11 nazionale e su quello interno e soprattutto era venuto meno il solo statista italiano capace di coniugare il più spietato e talora cinico realismo con l’utopia più generosa. I successori di Cavour restarono purtroppo assai al di sotto dell’inimitabile modello: il barone Ricasoli, gran galantuomo e grande patriota, era troppo inviso a Vittorio Emanuele e all’imperatore dei francesi per reggere a lungo alla concorrenza di Urbano Rattazzi che per suo conto, assunta la direzione del governo nella primavera del 1862, avrebbe dato via libera agli intrighi del Re, illudendosi di potersi barcamenare tra la Corona, il Partito d’Azione ed il concerto delle nazioni europee, come era riuscito al Conte. 12 2 Garibaldi, in ogni modo, non era uomo da sofisticate analisi politiche. Via via che i mesi passavano cresceva la sua impazienza, alimentata dalle ricorrenti offerte di alleanza che gli faceva pervenire Mazzini e dai contatti con altri gruppi come quello rappresentato da Ferdinando Lassalle, il quale sbarcò a Caprera nel settembre ’61 per prospettare al Generale l’immaginaria ipotesi di un’ondata rivoluzionaria da Mantova a Galatz, intesa a far tremare dalle fondamenta l’impero austriaco. Entusiasmato dalle fantasia del bollente ospite, Garibaldi se ne congedò con una frase enigmatica: «In primavera saprò mostrarmi degno del mio passato». Poche settimane dopo, in effetti, il meccanismo si rimetteva in movimento. In dicembre, nel corso di una rapida visita a Torino, il Generale era ricevuto in udienza privata dal Re; nel febbraio successivo, tornato nell’isola, riceveva a sua volta la visita di un emissario del barone Ricasoli. Con il pretesto di partecipare ad una partita di caccia, il senatore Plezza veniva a rassicurarlo che «il Governo non aveva rallentato, né rallenterebbe un istante dagli apparecchi dell’impresa nazionale» ma, in attesa che maturassero le 13 condizioni, pregava il Generale «a non voler con moti intempestivi guastare l’opera ben avviata». Ricasoli mandava a dire, comunque, che egli sarebbe stato avvertito tra i primi ed era invitato a considerare come pegno delle buone intenzioni del Governo la imminente inaugurazione della Società Nazionale di Tiro a Segno, un’associazione paramilitare alla cui sorte Garibaldi avrebbe dovuto interessarsi più da vicino. Il 2 marzo, in compagni della stesso Plezza, «l’irrequieto capitano» sbarcava a Genova per piombare a Torino proprio alla vigilia della caduta di Ricasoli. In apparenza lo scenario non era cambiato: il nuovo Presidente del Consiglio lo confermava nell’incarico di vice presidente, e animatore, della Società di Tiro a Segno, affidandogli un giro di propaganda in molte città del nord. Poco dopo, anzi, Rattazzi gli consentiva di costruire, sotto il comando del figlio Menotti, due battaglioni di «carabinieri genovesi» che, formalmente, avrebbero dovuto essere dislocati nel Mezzogiorno per combattere il brigantaggio: una destinazione che pareva comunque rievocare il magico ricordo della spedizione di due anni prima. Secondo Crispi ed altri esponenti del Partito d’Azione, sarebbe stato promesso anche il finanziamento di un milione di lire ma per un’impresa del tutto diversa, un’incursione delle camicie rosse in Grecia, dove era scoppiata una rivolta contro Re Ottone, sempre nell’intento di creare un focolaio antiaustriaco nei Balcani. Per un verso o per l’altro, Garibaldi tornava alla ribalta. «Ospite del senatore Plezza», a Torino, «la sua casa 14 pareva un ministero: una processione perpetua di garibaldini, di patrioti, di ministri, di deputati d’ogni colore, di ammiratori e sollecitatori d’ogni fatta passava e ripassava a visitarlo, ad onorarlo, a consultarlo; i principi reali di Savoia lo convitavano alla loro mensa». Lo stesso successo, assai più in grande, riscosse nel giro propagandistico in Lombardia e in Emilia dove ricevette l’omaggio delle autorità, vescovi compresi, ed un frenetico tributo di entusiasmo di «turbe immense di popolo» che lo evocavano al balcone al grido di «Venezia, Venezia», cui egli rispondeva invariabilmente: «Andiamo»; o scandivano il motto fatale «Roma o morte», suscitando naturalmente nell’eroe del ’49 un’emozione profonda. A questo punto il cerchio era chiuso: al sostegno, non esplicito ma concreto, del Governo e del Re corrispondeva il voto popolare. Il disegno che si andava delineando nella mente di Garibaldi poteva essere ancora vago ma appariva certamente legittimo, almeno quanto l’impresa dei Mille. 15 3 Nondimeno, al contrario dell’impresa dei Mille, questa volta il disegno fallì, in due tempi. Il primo obiettivo mancato fu Venezia. A fine aprile, dopo aver incontrato nella sua tournée propagandistica anche Alessandro Manzoni, Garibaldi si trovò a Trescore, una località climatica poco lontana dal confine trentino con l’Austria, col pretesto di curarsi i reumatismi. Naturalmente non fu creduto da nessuno, tanto meno dagli agenti di Vienna e di Parigi. Sul posto cominciarono ad affluire giovani e men giovani borghesi che avevano tutta l’aria di garibaldini travestiti, mentre il Generale riceveva la visita di un aiutante di Vittorio Emanuele ed apriva febbrili consultazioni (iniziativa per lui inconsueta) con i suoi collaboratori, ai quali espose un tortuoso progetto che prevedeva uno sbarco in Dalmazia per prendere Venezia dal mare. Non bastò l’accenno al sicuro appoggio del Governo a placare i dubbi di molti degli interlocutori, che vi scorgevano anzi la conferma ai loro peggiori sospetti circa l’intenzione del perfido Rattazzi di spingere Garibaldi fuori del paese, d’accordo con Napoleone, per emarginarlo dal gioco. Ma l’impresa era destinata ad andare in fumo per un caso del tutto fortuito e non privo di risvolti misteriosi, 16 una sorta di piccolo «giallo». Poche settimane prima del convegno patriottico-termale di Sarnico, una banda di rapinatori aveva assaltato a Genova il Banco Parodi e si era data quindi alla fuga attraverso i carrugi, trovando scampo su una tartana ormeggiata nel porto. La polizia, tuttavia, era piombata fulmineamente sulle tracce dei malfattori e li aveva catturati in mare tutti. Senonché nel corso dell’operazione si venne a scoprire che la stessa tartana era stata noleggiata, qualche tempo prima, dal colonnello garibaldino Cattabeni, per tenerla a disposizione del Generale in vista della famosa spedizione in Grecia. Quando fu rinvenuto a bordo il suo contratto di affitto, si mise in moto la macchina della giustizia. Il colonnello venne raggiunto a Sarnico e, nonostante le proteste dei suoi compagni, tradotto nel carcere di Alessandria, mentre una perquisizione ordinata dalla magistratura nel suo domicilio permise di scoprire, al posto delle prove della presunta complicità con i rapinatori, «gli apparati, gli ordini, i piani» dell’invasione del Tirolo vagheggiata da Garibaldi. A questo punto, avvertito dagli inquirenti, il Presidente del Consiglio si spaventò, tanto più che la concentrazione dei volontari nei dintorni del lago d’Iseo si andava facendo sempre più nutrita e vistosa. Da Torino partirono ordini perentori alle autorità locali: il colonnello Nullo e una cinquantina di garibaldini furono catturati a Palazzolo, altrettanti nei pressi di Sarnico. Ma quando una parte degli arrestati venne avviata nel carcere di Brescia, la folla tentò di dare l’assalto alla prigione, fu respinta 17 brutalmente dal picchetto di guardia e lasciò sul terreno tre morti, fra cui un ragazzo di 14 anni, e quattro feriti. Lo sdegno e la commozione di Garibaldi si riversarono in un messaggio al Paese in cui affermò di non voler credere che «soldati italiani» potessero «aver ammazzato e ferito fanciulli e donne inermi»; che gli uccisori non potevano essere che «sgherri mascherati da soldati» e chi aveva comandato la strage «un boia». Alle proteste dei farisei, che si stracciavano le vesti per il presunto oltraggio arrecato all’onore dell’esercito, il Generale replicò che non aveva né, da «soldato italiano», poteva aver avuto l’intenzione di «lanciare contumelie» all’esercito nazionale ma che si era limitato a sottolineare che «il dovere dei soldati italiani è di combattere i nemici della patria e del re, e non già di uccidere e ferire cittadini inermi». Nei fatti, comunque, il progetto tirolese era fallito. Rattazzi cercò alquanto goffamente di dissociare le proprie responsabilità da quelle di Garibaldi, fino ad emanare il 24 maggio una dichiarazione ufficiale che escludeva ogni connivenza del Governo con il tentativo di Sarnico. La reazione di Garibaldi questa volta fu incerta. Dopo una prima generica protesta, un abboccamento con il Re e con Rattazzi lo indusse a più miti consigli, al punto che il 3 giugno il Generale rinunciò a intervenire al dibattito parlamentare, limitandosi a mandare al Presidente della Camera una diplomatica dichiarazione che minimizzava il tentativo di Sarnico alla stregua di una normale esercitazione, anche se si chiudeva con un avvertimento piuttosto brusco: «Chi vuole opporsi di fronte al generoso 18 movimento, assume tutta la responsabilità delle disgrazie che si possono minacciare». 19 4 Il secondo obiettivo fallito fu Roma, e implicò un costo assai più alto. Garibaldi, che pure aveva vissuto l’avventura di Sarnico con scarsa convinzione, passò al contrattacco dopo pochi giorni. L’occasione gli fu offerta da una mozione indirizzata dal Parlamento a Re Vittorio per protestare contro l’arroganza di taluni alti prelati ma, ad orientarlo verso la nuova impresa, furono soprattutto i rapporti che gli fecero tenere Crispi e i suoi amici sulla situazione del Mezzogiorno, dove cresceva di giorno in giorno la delusione per l’ottusità burocratica del nuovo governo. Incoraggiato dalle notizie di Sicilia e sedotto dai gloriosi fantasmi del ’60, il Generale concepì pertanto il piano di marciare su Roma dal sud della penisola, nella lusinga di poter contare sulla complicità di Torino e sulla sorpresa di Parigi. Il primo passo fu di chiedere al Re, attraverso il senatore Plezza, una delega, una specie di luogotenenza per il Mezzogiorno ma Vittorio Emanuele ii trovò curiosamente la richiesta «troppo mistica», affermando di considerare Garibaldi «buon amico e buonissimo soldato, ma non buon amministratore né buon conoscitore di uomini». Il Re suggeriva piuttosto di dirigersi verso la Grecia, sul 20 cui trono sperava di insediare il figlio Amedeo al posto del pericolante Ottone di Baviera, anche perché escludeva l’eventualità di una rivolta borbonica nel Mezzogiorno. Senonché Plezza concluse imprudentemente la lettera in cui riferiva le opinioni del sovrano, con un’invocazione ambigua: «Per carità, Generale, alzate la voce contro chiunque volesse condurci alla guerra civile. Voi solo potete salvare la patria». Il destinatario della missiva la prese come un invito ad agire e, a fine giugno, lasciò improvvisamente Caprera, imbarcandosi sul «Tortoli» con un gruppo di uomini alla volta di Palermo, dove sapeva di essere atteso con enorme simpatia non solo dalla popolazione, ma anche dal rappresentante del Governo, Pallvicino-Trivulzio, già suo pro-dittatore ed amico personale. A giudicare dalle confidenze cui si abbandonò durante la traversata, non aveva in mente un piano preciso ma contava piuttosto di affidarsi alle circostanze, sapendo perfettamente in ogni caso che avrebbe incontrato l’ostilità dell’armata. Sperava, tuttavia, nella saggezza di Rattazzi: «Dovranno pensarci prima di lanciarla contro di noi!» E qui si sbagliava. Il 28 giugno, il «Tortoli» gettò le ancore nel porto di Palermo proiettando il Generale verso l’avventura più amara della sua vita. L’avvio, per la verità, fu poco meno che trionfale. Il prefetto Pallavicino-Trivulzio mise a sua disposizione lo stesso appartamento del Palazzo Reale che Garibaldi aveva occupato nel 1860 e anche questa volta fu teatro di un continuo pellegrinaggio di visita21 tori, ammiratori, seguaci, autorità di ogni ordine e grado. Non meno entusiastica fu l’accoglienza dei giornali, della popolazione e soprattutto dei giovani, con i quali l’illustre ospite andò intrecciando una serie di dialoghi sempre più accesi sui temi che gli stavano più a cuore: Napoleone, il Papato, le terre irredente, e che di solito culminavano nel grido: «Sì, a Roma, a Roma; a Roma presto a dispetto di chi non vuole!». Il 30 giugno, parlando dal balcone del Municipio, annunciò che Roma sarebbe stata presto italiana; due giorni dopo, in un teatro che portava il suo nome, all’ovazione del pubblico per Roma e Venezia, replicò ricordando che nei plebisciti monarchici si era votato per «l’Italia unita»; e più tardi, passando in rassegna la Guardia Nazionale, avrebbe intimato addirittura: «Napoleone sgomberi Roma». All’amico Plezza rispondeva ironicamente di essere a disposizione di Re Vittorio per una eventuale spedizione in Grecia, anche se en passant sperava di prendere «gli ultimi suoi ordini a Roma». Era il pensiero fisso, la stella polare. Da Palermo, il Generale si spostò in periferia, ricevendo accoglienze ancor più frenetiche da Alcamo, Partinico, Calatafimi, Corleone, Sciacca, Marsala, le tappe iniziali più gloriose dei Mille. In un crescendo di entusiasmo, parlando a Marsala dal balcone di casa Grignani, raccolse un grido partito spontaneamente dalla folla, il grido famoso: «Roma o morte», e perse ogni remora: «Noi non vogliamo l’altrui, vogliamo quello che è nostro. Napoleone è un ladro, un rapace, un usurpatore! Ha lavorato per ingrandire la sua famiglia, ha pronto un principino per Roma, 22 un signorino per Napoli, e così via… Infame! Traditore!| Napoleone, fuori fuori!». Il 20 luglio, nella cattedrale di Palermo, gremita da una folla immensa, il celebrante, che era fra Pantaleo, tenne un sermone sulle città irredente e alla fine chiamò il Generale perché giurasse, il braccio levato verso l’altare: «O Roma, o morte». Non tutti i compagni di avventura condividevano la sua determinazione. I più moderati, come Guerzoni, Enrico Guastalla, Giovanni Chiassi, temevano l’intervento dell’esercito sabaudo e si permisero di consigliargli prudenza, se non la rinuncia all’impresa almeno una sua accelerazione via mare, che avrebbe evitato la traversata di tutta l’isola, ma sopraggiunsero Corrao, Bentivegna ed altri garibaldini siciliani, al colmo dell’eccitazione, raccontando che nel bosco della Ficuzza si erano raccolti in armi migliaia di picciotti e garantendo che tutta la Sicilia era pronta ad insorgere. Non ci voleva altro per strappare il Generale alle ultime perplessità ed indurlo a partire immediatamente per il luogo dove si erano concentrati i volontari. Nel frattempo, le notizie dei preparativi e delle dichiarazioni di Garibaldi raggiunsero Torino, gettando nel panico il Governo. Rattazzi decise di destituire immediatamente Pallavicino-Trivulzio, sostituendolo con il prefetto De Ferrari cui fu ordinato di affiggere in tutta Palermo proclami contro i garibaldini. La popolazione, convinta in larga parte che, come nel 1860, esistesse un accordo segreto fra autorità e volontari, li strappò uno per uno dai muri. Ma stavolta il Presidente del Consiglio faceva sul serio. 23 5 A Mezzojuso, dove giunse il 2 agosto, il Generale fu informato delle drammatiche novità in arrivo da Torino. Il Governo Rattazzi, dimenticando le intese segrete e le concrete promesse, lo dichiarava fuorilegge proclamando lo stato d’assedio in tutta l’isola e designando il generale Cugia come commissario a Palermo con pieni poteri civili e militari. Il «prode esercito» col quale aveva sperato che i suoi garibaldini potessero offrire «un ultimo saggio del valore italiano», diventava un nemico dichiarato e nell’odioso ruolo di una forza di polizia. Per giunta, la massa dei volontari accorsi al richiamo era certamente più numerosa che nel 1860, ma la qualità morale e militare della truppa era ben diversa: salvo un nucleo di palermitani, battezzato come «il battaglione della cittadinanza», e un pugno di veterani del continente, il grosso era giudicato dagli stessi superstiti dei Mille «un’accozzaglia di vagabondi e di ragazzacci razzolata a caso». Niente affatto scosso da questo particolare non del tutto trascurabile e dalle allarmanti iniziativa del Governo, Garibaldi aveva dato inizio alla campagna, suddividendo i tremila volontari raccolti nel bosco della Ficuzza in tre colonne ed assumendo personalmente il comando della 24 più folta, mentre la seconda colonna era affidata al bollente Bentivegna e il colonnello Trasselli si metteva a capo della terza, destinata ad operare in retroguardia. Sarebbe maturato nel suo ambito il dramma di Fantina. Prima di lasciare Mezzojuso, Garibaldi era stato invitato ad assistere in chiesa ad un Te Deum che era culminato nella benedizione delle camicie rosse da parte di «preti cattolici», incuranti del fatto che l’obiettivo finale della spedizione fosse la liquidazione del potere temporale. Il 3 agosto arrivarono due vecchi amici del Generale, il duca della Verdura e il dottor Gaetano La Loggia che portavano gravi notizie, confermate da una lettera di Medici del Vascello: un proclama di Re Vittorio al popolo italiano sottolineava ufficialmente il ripudio di ogni sostegno alla nuova impresa delle camicie rosse, definendo «appello alla ribellione e alla guerra civile» ogni iniziativa che non partisse dalla Corona e ammonendo i volontari a guardarsi «dalle colpevoli impazienze e dalle improvvide agitazioni». Se una frase del proclama sembrava annunciare una prospettiva più incoraggiante per il futuro, là dove il sovrano assicurava i patrioti che, «giunta l’ora della grande opera», la voce del loro Re si sarebbe fatta udire, il documento si chiudeva tuttavia con la minaccia di applicare il rigore della legge a quanti disobbedivano alle direttive sovrane. La lettera di Medici era scritta nello stesso spirito del proclama: «Mettiti una mano sul cuore, pensa all’Italia, pensa a tutto quello che miracolosamente si è fatto. Non ostinarti nella via che percorri, essa conduce inevitabilmente alla guerra civile». 25 Ma né il proclama, né le argomentazioni dei due amici siciliani e neppure la lettera del vecchio difensore della Repubblica Romana valsero a distogliere il Generale da una decisione ormai irrevocabile. Anche perché egli attribuiva l’iniziativa del Re alle pressioni di Napoleone, basandosi soprattutto sull’accenno del proclama ai doveri di gratitudine verso «i nostri migliori alleati», nonché agli intrighi di un Governo che a suo avviso non interpretava affatto i sentimenti del paese. Tutt’al più, il voltafaccia di Vittorio Emanuele gli suggeriva di rinunciare definitivamente all’appoggio dell’esercito sabaudo, con cui adesso conveniva evitare per quanto possibile il contatto. Per il resto, il dado era tratto. Né molto diversa fu la reazione dei suoi ufficiali, ispirati da una fiducia senza limiti nell’uomo che li guidava e, almeno in parte, convinti che il proclama fosse dettato esclusivamente da preoccupazioni diplomatiche. Continuò così attraverso la Sicilia la marcia trionfale che stava comunicando a Garibaldi la sensazione illusoria di una reiterazione dell’impresa del ’60, mentre le voci di scontri fra l’esercito e le camicie rosse rimbalzarono sempre più frequentemente a Torino, costringendo Rattazzi ad imbarazzanti smentite in Parlamento: «Non abbiamo ricevuto alcuna notizia allarmante dalla Sicilia. Il generale Garibaldi non ha sinora ceduto alla voce autorevole del Re; speriamo vorrà cedere presto». E alle insistenti richieste di precisazioni, specialmente da parte di Minghetti, il Presidente del Consiglio ribadiva: «Non vi fu scontro tra truppa e volontari; non vi furono diserzioni 26 nell’esercito». Diserzioni, in realtà, cominciarono ad esserci mentre scontri effettivamente non ve ne furono né a Caltanissetta né a Castrogiovanni (come si chiamava allora Enna); vi furono invece festose manifestazioni popolari e – nonostante i proclami regi – il cerimonioso ossequio di autorità locali ma anche governative. Da Roma arrivò un certo numero di volontari che furono ripartiti in due gruppi, affidati al comando di Menotti Garibaldi e di Giovanni Corrao, l’ardente patriota siciliano che avrebbe conosciuto la morte, pochi anni dopo, per mano di un oscuro sicario. Nondimeno, i compagni più esperti del Generale avvertivano un clima assai diverso da quello dei giorni esaltanti del ’60: due anni di «dissolvente lavoro» del Governo sabaudo, con il La Farina alla testa, avevano logorato l’entusiasmo di molti giovani, suscitando profondo malcontento tra i contadini, diffuso scetticismo e indifferenza nella popolazione isolana, un quadro grigio sul quale l’operazione di Garibaldi gettava un fascio di luce abbagliante ma fuggevole. Probabilmente i vecchi compagni del Generale risentivano anche delle perplessità e delle riserve che andavano crescendo in Alta Italia contemporaneamente all’avanzata delle colonne garibaldine verso Catania. la pressione era forte. A Regalbuto piombò una delegazione di parlamentari della Sinistra che venivano da Torino a rappresentare, a nome di tutto il gruppo, il timore che un intervento francese o austriaco sbarrasse ai garibaldini la strada di Roma o addirittura 27 che l’ostilità dell’esercito sabaudo provocasse la guerra civile. Non senza qualche sollievo, i deputati scoprirono che molti ufficiali della Stato Maggiore condividevano le loro preoccupazioni, ma quando Mordini ne accennò cautamente al Generale, fu investito dalla sua ruggente collera: «Vadano, vadano subito; io non ho mai avuto bisogno di nessuno, basto da solo!». Poco prima era arrivata una lettera dell’ammiraglio Albini, che si dichiarava «lusingato» di mettere a disposizione di Garibaldi e del suo Stato Maggiore una pirofregata ancorata al largo di Acireale per accompagnarli «in qualsiasi punto dei Regi Stati»: documento che costituiva probabilmente un tentativo di dirottare la spedizione verso lidi più tranquilli ma si trasformò paradossalmente in una specie di salvacondotto regio. 28 6 Anche a prescindere dalle difficoltà politiche, la situazione dei volontari stava diventando pesante. Mancavano le armi, le scarpe e anche le vettovaglie, visto che le autorità civili e militari avevano ricevuto addirittura l’ordine di proibire ai mugnai la vendita della farina alla camicie rosse, evidentemente per affamarle, mentre le truppe del Governo avanzavano da tre direzioni sulla piana catanese per bloccare la marcia. Garibaldi decise allora di abbandonare la rotabile inerpicandosi per Centorbi, un villaggio che domina la valle, in attesa di essere raggiunto a tappe forzate dalla colonna di Corrao. A Paternò, tuttavia, non riuscì ad evitare il contatto con il battaglione regio, il cui comandante, maggiore Gallois, pur accordando i rifornimenti pretendeva in un primo momento di sbarrargli il passo, ma poi si lasciò convincere dalla lettera dell’ammiraglio Albini, che gli fu mostrata, appunto, come un salvacondotto. La discussione avrebbe potuto tuttavia provocare reazioni inconsulte tra i volontari se una gran folla di popolani non fosse intervenuta a trascinare trionfalmente in paese le camicie rosse. Più tardi fu a sua volta il Generale ad impedire che le truppe sabaude entrassero in collisione con la colonna di Corrao, che in poco più di 29 24 ore aveva compiuto una marcia di 44 miglia. La sera dello stesso giorno 18 Garibaldi entrava a Catania, accompagnato da un immenso festante corteo di popolo, «una grande striscia di luce che somigliava ad una corrente di lava e, all’avvicinarsi, prendeva l’apparenza di una di quelle processioni religiose che si fanno la notte» nei paesi del Sud. La luce era quella delle torce «con le quali i catanesi erano andati ad incontrare il Generale ad alcune miglia di distanza». In città l’illuminazione era ancora più festosa, le bandiere innumerevoli, l’entusiasmo dilagante, soprattutto quando Garibaldi si affacciò al balcone del palazzo dove aveva sede la Società degli Operai e rilanciò lo slogan fatale, «Roma o morte», asserendo che era venuto il tempo di abbattere «il potere del vampiro sacerdotale». L’atmosfera si arroventò quando si sparse la voce che i reparti governativi si avvicinavano alla città con intenzioni poco amichevoli: il popolo corse alle barricate, i volontari furono spediti a sorvegliare le vie di accesso, le campane suonarono a stormo come se arrivasse Federico Barbarossa. Il risultato fu che le truppe regie si ritirarono prudentemente a Misterbianco, quattro miglia da Catania, mentre il prefetto, barone di Tholosano, si rifugiava a bordo di una nave da guerra alla fonda nel porto e il generale Mella assicurava a una deputazione municipale che la città non sarebbe stata attaccata. In realtà il morale dell’esercito sabaudo era piuttosto depresso: alle dimissioni di 34 ufficiali del terzo e del quarto reggimento, si aggiungeva di ora in ora la diserzione di sottufficiali e soldati, che veni30 vano accolti, sia pure a malincuore, nelle file garibaldine. Era stato lo stesso Mella a peggiorare le cose allorché, durante un rapporto tenuto agli ufficiali ad Adernò, si era lasciato sfuggire una frase più che infelice: «Voi avete a fronte il nemico, eccovi un’occasione di acquistarvi della gloria e voi la coglierete». Quando la frase si era risaputa, i garibaldini se ne erano sentiti malamente offesi, a riprova di una tensione degli animi che, una volta partito Garibaldi, avrebbe provocato gravi torbidi in città. Gli esponenti più reazionari della nobiltà e i generali di Farini erano furiosi con i democratici catanesi che avevano offerto alle camicie rosse non solo luminarie ed applausi, ma anche denaro, vestiario, 5.000 fucili e 600 volontari, cui si erano aggiunti altri patrioti provenienti dai paesi vicini e una sessantina di disertori dell’esercito regio, accolti questi, come si è detto, con un certo disagio, ma con spirito fraterno. Nascerà proprio nell’ambito di questo gruppo il momento più lacerante del dramma di Fantina. 31 Parte seconda La ferita di Aspromonte 32 1 A Catania, apparsa ai volontari come «un vulcano di patriottismo», si era conclusa la fase preliminare della campagna. La lunga permanenza nella città, i sei giorni di discorsi, di festeggiamenti e di preparativi, erano stati imposti anche dalla difficoltà di risolvere il principale problema logistico della spedizione, lo sbarco sul continente. Ma la mattina del 24 agosto, occhieggiando sul mare dalla torre del Convento dei Benedettini, dove aveva stabilito il suo quartier generale, Garibaldi scoprì nella rada «con lo sguardo appassionato di un amante» due piroscafi che potevano fare al suo caso. Una delle navi era italiana; l’altra francese, ma il Generale decise di non lasciarsi paralizzare da eccessivi scrupoli: «Bonaparte non ci aveva rubato Roma e non se la teneva da tredici anni? e perché non potrò io disporre di un suo piccolo legno per una notte?». In ogni caso, scrupoli a parte, l’impresa non era facile. Un serio ostacolo era rappresentato dalla natura della costa, che intorno al porto di Catania è ira di scogli e di lava; un altro e ancor più arduo, dalla presenza di due fregate della Marina italiana che incrociavano al largo, evidentemente con il compito di sorvegliare i volontari. 33 Ma il pericolo maggiore veniva dall’esercito che andava stringendo la sua morsa intorno alla città. Bisognava, perciò, decidersi a partire, e Garibaldi non indugiò oltre: lasciato il convento, si precipitò al porto e prese a dirigere personalmente le operazioni di imbarco sui due piroscafi: il «Dispaccio» e il «Général Abbatucci». In teoria, non avrebbero potuto ospitare più di mille garibaldini in tutto, ma si riuscì a farne entrare più del doppio, stivandoli oltre ogni limite di prudenza, anche se, con sommo rammarico del Generale, ne restarono a terra molte centinaia e, tra essi, i ragazzi che sarebbero stati trucidati a Fantina. La piccola flotta uscì verso le dieci di sera, bordeggiando a poco distanza dalla costa per non essere intercettata dalle fregate regie, giacché Garibaldi non era soltanto un insuperabile guerrigliero, ma anche un provetto marinaio. A bordo regnava una confusione indescrivibile, ma la maggior parte dei volontari e tutti gli ufficiali si rendevano conto della preoccupazione che aveva ispirato al loro comandante l’apparente fuga da Catania, il timore cioè che lo scontro con le truppe governative si rendesse inevitabile. Al tempo stesso, avvertivano di andare incontro ad oscuri pericoli, ad imprevedibili insidie. La prima trappola si aprì appena toccata la sponda calabrese, a Lazzaro, una frazione di Reggio. Alcuni esponenti moderati del Partito d’Azione si fecero ricevere da Garibaldi per consigliargli prudenza: la popolazione della città, secondo loro, era favorevole ai volontari ma il giorno prima la guarnigione regia era stata rinforzata con reparti spediti da Messina e il generale Cialdini, giunto a 34 Reggio da poche ore, aveva impartito ordini severissimi. I tiepidi patrioti consigliarono, perciò, di aggirare la città a scanso di gravi complicazioni. In un primo tempo, Garibaldi parve deciso ad ignorare i loro suggerimenti, ricordando che aveva traversato tutta la Sicilia senza incontrare ostacoli e che l’insegna dei suoi uomini – «Italia e Vittorio Emanuele» – li metteva al riparo da un’impossibile aggressione delle truppe di Cialdini. In ogni caso, la spedizione puntava a Reggio soltanto per rifornirsi di viveri. A questa affermazione i galantuomini calabresi colsero la palla al balzo e garantirono che avrebbero provveduto in prima persona a far trovare sull’Aspromonte tutti i viveri di cui i volontari potevano avere bisogno. Il Generale era abbastanza ingenuo da non mettere in dubbio questa affermazione irresponsabile dei suoi interlocutori ma, se si decise effettivamente a prendere la strada che essi gli avevano additato, lo fece soprattutto perché la cannoniera «Terribile» ancorata a poche miglia dalla costa minacciava sul fianco sinistro i suoi uomini. Garibaldi si era appena affacciato a una curva prospiciente al mare che venne fatto oggetto di schioppettate partite dai fianchi della nave: col suo inimitabile candore, rispose al fuoco agitando la sciabola in segno di saluto, come se gli ignoti fucilieri gli avessero reso omaggio, ma rendendosi perfettamente conto che era preferibile cambiare rotta. Di fatto, giunto in vista di Pellaro, a breve distanza dagli avamposti regi, deviò la direttrice di marcia nella fiumara di San Gregorio, sul lato destro della strada che conduceva a Reggio. Era, paradossalmente, una sorta di 35 fuga ed insieme di salto in avanti a cui le camicie rosse si vedevano costrette dal timore di incrociare il fuoco con reparti dell’esercito italiano: forse entrando a Reggio si sarebbe forzata la resistenza delle truppe di Cialdini e magari ne sarebbe stata ingrossata la colonna dei volontari, ma il Generale era dominato dal terrore dello scontro fratricida e avrebbe continuata ad esserlo fino alla fine della malinconica avventura in terra di Calabria. 36 2 Dall’altra parte, invece, si nutriva la speranza opposta: Cialdini si proponeva di incalzare dappresso Garibaldi, di metterlo con le spalle al muro, di schiacciarlo. Munito dal Governo di poteri straordinari, si era imbarcato a Genova con l’idea fissa di impartirgli una lezione di modestia e di disciplina. E non si trattava soltanto della vecchia ruggine maturata due anni prima, quando il generale modenese aveva guidato l’armata del Re alle facili vittorie di Castelfidardo e di Ancona, consentendo a Vittorio Emanuele di piombare dal nord sul Volturno giusto in tempo per avvelenare il trionfo dei garibaldini ed umiliare il loro comandante. Il reciproco odio, o disprezzo, nasceva da un’antitesi ben più profonda tra i due uomini, irrimediabilmente diversi, emblematici di due modi diametralmente opposti di essere italiani. Il duca di Gaeta, prode soldato, eccellente tecnico, colonnello in Spagna contro i carlisti, poi generale sardo in Crimea a soli 40 anni, comandante di divisione a Palestro, simbolo incarnato di devozione al Re, alle istituzioni e al regolamento, non poteva capire né amare un uomo come Garibaldi, generoso campione dell’unità nazionale e devoto quanto lui al sovrano ma anticonformista, ribelle, libero da ogni angustia mentale. 37 Fin da quando era rimasto in vita a mediare tra questa due Italie il conte di Cavour, era stato possibile conseguire una sintesi felice dell’interesse del Paese attraverso una sapiente alternanza di iniziative, di freni, di complicità non confessate; ma ormai non c’erano diaframmi tra un uomo d’ordine come Cialdini e il suo gretto sogno di rivincita sulla grandezza e sulla popolarità di Garibaldi. La rivalità tra i due generali aveva già avuto modo di manifestarsi in forma clamorosa l’anno prima, quando Garibaldi aveva pronunciato un discorso ai delegati della Società Operaia e lanciato un progetto per l’istituzione della Guardia Nazionale, molto polemici l’uno e l’altro, il primo contro i consiglieri del Re, il secondo contro le prerogative dell’esercito regio. Queste prese di posizioni, confermate da un duro attacco in Parlamento al Governo Cavour, avevano indignato Cialdini, che il 22 aprile 1861 pubblicava sulla «Perseveranza» una lettera aperta colma di soldatesco furore: «Voi non siete l’uomo che io credevo, voi non siete il Garibaldi che amai. Con lo sparire dell’incanto è scomparso l’affetto che a voi mi legava. Non sono più vostro amico, e francamente passo nelle file dei politici avversari vostri». Gli rimproverava di essersi messo «al livello» del Re, di collocarsi al di sopra degli usi, presentandosi alla Camera «in un costume stranissimo», e al di sopra del Governo e del Parlamento, chiamando traditori i ministri che non gli erano devoti e colmando di «vituperii» i deputati che non pensavano come lui, nonché al di sopra del Paese, volendolo spingere dove e come meglio gli aggradava. Cialdini arrivava 38 a contestare almeno parzialmente l’impresa dei Mille, ricordando che le camicie rosse erano «in pessime condizioni» quando l’armata regia sopraggiunse sul Volturno, «distruggendo più della metà dell’esercito napoletano» e prendendo Capua, Gaeta, Messina e Civitella. La lettera aperta del generale modenese aveva suscitato collera e indignazione fra i garibaldini, ma il suo destinatario non l’aveva presa troppo sul serio, limitandosi a replicare che non si sarebbe certamente abbassato a giustificarsi e che, come deputato, si era limitato ad esporre alla Camera «soltanto» una piccolissima parte dei torti ricevuti dall’esercito meridionale ad opera del Ministero. Quanto al ricordo del Volturno, i volontari erano «al vespro della più splendida vittoria» allorché erano giunte, virtualmente a cose fatte, le truppe regie. E infine se «qualcuno» si fosse ritenuto offeso dal suo «modo di procedere», era «tranquillamente» pronto a dargli soddisfazione. Era una risposta formalmente serena, sostanzialmente severa che Cialdini si vedeva costretto a incassare ma non poteva dimenticare. Fu il Re che, morto Cavour e senza curarsi di un così grave precedente, ebbe il cattivo gusto di affidare proprio a lui il comando dei reparti cui si assegnava cinicamente il compito di «distruggere» Garibaldi e i garibaldini. Cialdini, «il pigmeo insultatore del gigante» era andato a guerra «come a festa». Partito da Genova, aveva fatto scalo a Napoli per concertare un disegno tattico con La Marmora, cui aveva assegnato il controllo della Basilicata e della Calabria settentrionale, riservando a se stesso l’intervento nel Reggino, dove 39 aveva raccolto 8 battaglioni di linea e 2 di bersaglieri, con 4 pezzi di artiglieria da montagna. Per giunta, pescando nelle riserve dell’esercito destinato alla repressione del brigantaggio, aveva messo 8 battaglioni agli ordini del colonnello Pallavicini con una consegna di incredibile asprezza: raggiungere Garibaldi, inseguirlo senza dargli tregua, attaccarlo e distruggerlo se avesse accettato il combattimento. Era un’impostazione irresponsabile e delirante, considerando la grandezza, le benemerenze e la popolarità dell’uomo che si intendeva braccare come un pericoloso bandito; ma dietro la protervia arrogante del generale sabaudo, v’era sicuramente il consenso di Vittorio Emanuele. In privato il Re aveva ammesso che inizialmente i garibaldini avevano eseguito ordini suoi, ma si era lamentato che successivamente si fossero spinti troppo lontano. 40 3 Dal momento in cui Garibaldi aveva rinunciato ad attaccare Reggio, era cominciato il calvario delle sue truppe, costrette a battere strade isolate senza la possibilità di rifornirsi di viveri o da difendersi dal crescente rigore del clima e vedendosi per giunta esposte nelle retrovie e ai fianchi ad attacchi di disturbo dell’esercito sabaudo. Marciando per quattro giorni «attraverso boschi e dirupi, lottando col sonno, con la fame, senza capanne, senza tende, col caldo di giorno e il freddo della notte», le camicie rosse si avventurarono alla disperata sulle balze dell’Aspromonte. Il grosso della colonna aveva perduto il contatto con l’avanguardia del Generale, che era già arrivata sopra Santo Stefano e ai Forestali, e questo isolamento accentuava la demoralizzazione degli uomini che, come si è già osservato, non potevano essere lontanamente paragonati ai Mille Né per l’efficienza, né per la saldezza morale. Fu perciò soltanto un pugno di valorosi che raggiunse sull’imbrunire, attraverso impervi sentieri, l’altopiano sul quale Garibaldi si era accampato alla meglio, installando il suo comando in una casetta di legno al limite di una bellissima foresta di pini mentre i volontari giacevano sdraiati a gruppi per la campagna, 41 sfiniti, affamati e tormentati da una pioggia sottile che accresceva la loro frustrazione. C’era aria di sconfitta anche se il Generale tentò di rianimare gli spiriti depressi accendendo un fuoco di fortuna con una bracciata di rami secchi e invitando i soldati a improvvisare rifugi di fortuna contro il freddo della notte. I più fortunati si inoltravano tra gli alberi, trovando rifugio sotto il fitto fogliame che non lasciava passare una goccia d’acqua; gas ribaldi discuteva animatamente con Corrao, che era appena arrivato, e con altri ufficiali superiori della situazione generale e dei piani da predisporre per l’indomani. L’indomani mattina, 29 agosto 1862, passò in rassegna gli uomini che avevano trascorso la notte sull’altopiano e i drappelli di picciotti in arrivo da Santo Stefano. La traversata della Stretto e le vicissitudini successive avevano ridotto a poco meno di 1.200 i 3.000 uomini partiti dalla Sicilia: il Generale li contemplò, probabilmente con una certa malinconia, dall’alto di una mula, mentre un pastore calabrese appena sceso dalla montagna intonava con la zampogna l’Inno di Garibaldi, una scena bucolicomarziale che colpì la fantasia di qualcuno dei presenti. «Il sole» scrisse poeticamente Edoardo Pantano «versava raggi luminosi sugli alberi del bosco, rifrangendosi in mille svariati colori sulle foglie gocciolanti, scintillando sulle baionette che come parafulmini si ergevano fuori dal tetto delle improvvisate tende. L’aere era pregno di fragranze boscherecce, il cielo splendeva di un mite azzurro e la natura ci sorrideva tutt’intorno. In seno a quel panorama dolce e sereno, quella musica agreste, meglio che 42 l’inno di guerra, sembrava la melodia della speranza». Il Generale parlò brevemente, esaltando la faticosa marcia dei volontari come un’impresa che valeva Calatafimi. «A compagni come voi» disse «non debbono perciò rivolgersi né parole di coraggio, né promesse di vittorie; ma soltanto una parola d’amore: amore ed abnegazione fra voi. I militi pensino all’inevitabile necessità della disciplina; gli ufficiali ricordino che il comando impone loro, più che diritti di superiori, obblighi di fratello a fratello. Siamo uniti: ancora uno sforzo e avremo superato i maggiori ostacoli; Noi raggiungeremo, ad onta di tutto, la nostra meta: O Roma o morte!». Poche parole tutt’altro che convenzionali, anzi assolutamente insolite sulla bocca di un guerrigliero, ma tipicamente del nobile idealismo di Garibaldi. Distribuiti i pochi viveri disponibili, il comandante diede l’ordine di partenza, dopo aver appreso che una colonna di truppe regie era giunta a pochi chilometri dai Forestali e minacciava di attaccare le camicie rosse. L’idea era di dividere gli uomini in due colonne per avviarli in parallelo verso Bagnara sulla via di Cosenza, e verso Monteleone sulle via di Catanzaro, dove erano state spedite in avanscoperta durante la notte pattuglie comandate da Missori, da Nicotera e da un altro paio di ufficiali. Ma dopo un’ora di marcia fu evidente che non era possibile evitare l’impatto con l’esercito: rischiava di realizzarsi insomma quell’ipotesi drammatica che Garibaldi aveva cercato di scongiurare in ogni modo sin dal primo giorno della spedizione, non solo perché ripugnava profondamente al suo 43 patriottismo ma perché poteva compromettere il successo dell’impresa. Ora non si poteva far altro che fronteggiare la spiacevole congiuntura cercando di limitarne i danni e perciò bisognava fermarsi ed attendere gli uomini di Cialdini, accampandosi nella miglior posizione, ossia sulle alture di Aspromonte. La postazione si presentava come una specie di semicerchio allungato, al cui centro una vallata spoglia e arida digradava dolcemente verso la piana dei Forestali, mentre una stupenda foresta di pini ne delimitava i bordi. Fu appunto ai margini del bosco che si accamparono i volontari, prima che il comando distribuisse i pochi viveri ancora disponibili, nonché i posti di combattimento. 44 4 L’impostazione tattica della giornata prevedeva il classico schieramento imperniato su un centro che era affidato agli uomini di Bedeschini e di Menotti Garibaldi e affiancato alle ali della colonna Badia sulla sinistra e da reparti di Corrao sull’altro lato. La posizione era salda, tale da intimidire anche un nemico più forte e numeroso, a condizione beninteso che si intendesse affrontarlo in campo aperto. Garibaldi era paralizzato dall’incubo della guerra civile, per quanto si illudesse ancora che l’esercito non avrebbe osato attaccare i suoi volontari. Cominciò a dubitarne allorché scorse, nelle prime ore del pomeriggio, una marea di soldati, all’incirca 14 battaglioni, spiegarsi in fondo alla sottostante pianura, inquadrati in ordine di marcia, le baionette scintillanti al sole ancora vivo. Una breve sosta, poi guide a cavallo si lanciarono al galoppo in tutte le direzioni per portare le istruzioni ai comandi di battaglioni. le ipotesi ottimistiche crollarono. Poco dopo infatti la colonna sabauda si mise in movimento, muovendo sui fianchi dello schieramento garibaldino reparti di bersaglieri il cui atteggiamento bellicoso non ammetteva equivoci. Ma neppure questa volta, persuaso che l’assalto regio era inevitabile, il Generale 45 perse il controllo. I suoi ufficiali lo videro emanare ordini secchi, assurdi e sacrosanti: «Nessuno faccia fuoco», una dolorosa rinuncia a combattere; «Siano tolte le capsule ai fucili, abbassare le baionette», la sola tecnica possibile per non lasciarsi compromettere nello scontro a fuoco; e, finalmente: «Se attaccati, non rispondere, lasciarsi fucilare al grido di: Viva l’Italia!», il sacrificio spinto fino al limite sublime dell’eroismo. Solo Garibaldi poteva impartire ordini del genere e aspettarsi di essere obbedito. Nello stesso momento il 6° bersaglieri, comandato dal colonnello Pallavicini apriva il fuoco contro i volontari garibaldini, lanciandosi a passo di carica su per l’erta montagna. Paralizzati insieme dalle direttive e dalla collera, i garibaldini vedevano cadersi intorno, feriti o esanimi, i compagni e sentivano fischiare sulla testa le pallottole sabaude senza poter reagire, senza poter far uso delle armi. Era un supplizio di Tantalo al quale non tutti seppero resistere: fu la colonna di Corrao a rispondere per prima al fuoco di un reparto comandato, per colmo d’ironia, da un ex-garibaldino, lo svizzero Eberhardt, al quale la voce comune rimproverava di aver abbandonato in fuga una postazione preziosa, due anni prima, ai Ponti della Valle mettendo nei guai Bixio. Momentaneamente bloccato dalla reazione di Corrao, il reparto di Eberhardt fece per irrompere di nuovo all’assalto quando Menotti non ci vide più e, sebbene fosse già leggermente ferito ad una gamba, comandò ai suoi picciotti di sferrare il contrattacco alla baionetta, subito imitato dal volontari dell’altra colonna. La confusione salì al massimo: in una 46 zona dell’Aspromonte si combatteva, nell’altra si assisteva sconsolatamente al combattimento, qualcuno urlava di abbandonare le armi, altri sparavano inneggiando a Garibaldi. E la confusione si sarebbe trasformata in una massacro se di colpo, mentre le trombe dei volontari lanciavano disperati segnali di cessare il fuoco, non fosse dilagata per tutto il campo – echeggiata come da un misterioso tam tam – la voce che Garibaldi era stato ferito. «Quella voce poté più di ogni ordine, più di ogni appello: tutte le armi caddero come per incanto dalle mani dei volontari». Del grave episodio e di tutti gli avvenimenti che lo precedettero, ci forniscono una versione piuttosto precisa le memorie dello stesso Generale. In primo luogo egli riconobbe di aver commesso un errore, che «per deferenza non è citato da nessuno di quanti scrissero sul doloro fatto di Aspromonte», l’errore di aspettare l’assalto delle truppe regie anziché precederle verso Santa Eufemia. Ammise altresì di essere stato condizionato da una «irresoluzione», una incertezza di fondo, di fronte alla incredibile prospettiva di una battaglia fratricida ma escluse, in ogni caso, che in quel momento fosse possibile battere in ritirata: «ciò sarebbe stato una fuga – e poca voglia vi era di fuggire». L’esitazione fu fatale. I soldati di Cialdini si erano distesi in linea, al di là del torrente, e avevano aperto un fuoco d’inferno, mentre il Generale continuava a raccomandare ai suoi trombettieri di far cessare il fuoco sul fianco destro, dove Menotti tambureggiava le posizioni sabaude, provocando in una decina di minuti 5 morti 47 e 24 feriti. In condizioni diverse, Garibaldi non avrebbe esitato ad applicare un piano molto lucido che corrispondeva a un suo schema molto semplice e preciso, che, in casi analoghi, aveva sempre funzionato. Secondo questo schema, si sarebbero appostati i fucilieri garibaldini sotto i primi alberi del bosco, in attesa che i reparti nemici traversassero il torrente tagliandosi automaticamente la via della ritirata, e quindi si sarebbe aperto a bruciapelo un fuoco di fucileria caricandoli sul fianco, con il vantaggio dell’altura, prima che i bersaglieri sabaudi del marchese Pallavicini di Proia potessero sopraggiungere, passando attraverso la foresta. Ovviamente, dal momento che mancava la possibilità, o la volontà di usare le armi, il piano risultava inapplicabile e, per giunta, nell’atto stesso in cui si rinunciava a contrastare l’attacco regio, si registrò l’episodio del ferimento di Garibaldi, di cui avrebbero parlato, discusso o favoleggiato, tra la furente indignazione e il livido compiacimento, molte generazioni di italiani. 48 5 I realtà le ferite furono due. Lo stesso Garibaldi annotò molto sobriamente sulle memorie: «Io fui ferito al principio della fucilata ed accompagnato all’orlo del bosco, ove fui obbligato a sedermi, rimanendo quasi nell’impossibilità di più poter distinguere ciò che succedeva sulla linea. Ebbi la prima medicatura al piede destro. Alla coscia sinistra un’altra palla mi aveva contuso, ma fu poca cosa». La voce popolare narrò che il Generale era caduto ferito mentre comandava ai ragazzi di Menotti la cessazione del fuoco, salutando con il cappello «i fratricidi» al grido di «Viva l’Italia!». Sostenne pure che, nell’istante in cui avvertì la fitta del proiettile, fu colto da un incontenibile impeto d’ira e tracciò nell’aria, cadendo, «terribile in volto», un cenno di minaccia. Enrico Cairoli che gli era vicino, raccontò di averlo visto fermarsi di colpo e portare istintivamente la mano alle gambe, pur tentando di restare in piedi per rassicurare il compagni: «Non è nulla!». Ma naturalmente dopo pochi passi non ce la fece più a reggersi e cadde tra le braccia di Cairoli che, aiutato da Nullo e da Guastalla, lo trasportò amorevolmente verso l’albero più vicino contro il quale venne adagiato, mentre continuava a sventolare il 49 berretto e gridare: «Non fate fuoco! lasciateli appressare! Viva l’Italia!». In effetti sul campo della mancata battaglia non si sparava più. Intorno al Generale, i medici garibaldini – il capo-ambulanza Ripari, Albanese e Basile – disputavano sulla opportunità di un intervento immediato. Dopo aver tolto lo stivaletto e aver scoperto una ferita «a bordi sottili e netti», quasi fosse stata aperta da un «coltello anatomico», Albanese avrebbe voluto operare subito, Ripari vi si oppose invocando l’autorità del grado. Durava ancora il non facile consulto quando altre camicie rosse trasportarono, sotto l’albero, accanto a Garibaldi, suo figlio Menotti, anche lui ferito ad un polpaccio da una pallottola di rimbalzo. I suoi picciotti e quelli di Corrao avevano ormai rinunciato a rispondere al fuoco dei bersaglieri e si mescolavano agli altri volontari che imprecavano, ai feriti che si lamentavano e ai soldati regi che andavano sopravvenendo e con i quali le camicie rosse presero a scambiare saluti, domande, spiegazioni, rimproveri. Imperturbabile nella confusione generale Garibaldi stava accendendo un sigaro, quando accadde qualcosa che gli fece perdere la calma. Il comando regio ebbe la cattiva idea di spedire un tenentino dei bersaglieri ad intimare, sciabola sguainata, la resa incondizionata all’eroe dei due mondi. Era troppo. Furente per l’oltraggio, il Generale ordinò che il giovanotto fosse disarmato e alle sue proteste replicò duramente: «Faccio la guerra da trent’anni e ne conosco meglio di voi le leggi. Non è così che si presentano i parlamentari». La stessa sorte toccò a 50 un altro malcapitato, il maggiore Giolitti, latore di analoga intimazione, anche se poco dopo le spade furono restituite ad entrambi gli ufficiali, il più giovane dei quali fu spedito al comando per chiamare Pallavicini. Garibaldi continuava intanto a fumare il suo sigaro e a discutere flemmaticamente con i medici, ai quali chiese se ritenevano necessario amputargli la gamba, dichiarandosi pronto ad ogni evenienza. Dopo venti minuti di attesa giunse alfine il colonnello Pallavicini, che era teso ed imbarazzato, pieno di rispetto per il suo illustre prigioniero, affianco al quale si inginocchiò, a capo scoperto, per pregarlo di arrendersi a discrezione «non avendo patti da offrire, ma soltanto ordini di combattimento». Aveva confessato poco prima agli ufficiali dello Stato Maggiore garibaldino, molti dei quali erano suoi vecchi conoscenti, che si trattava di istruzioni inequivocabili: attaccare e battere Garibaldi, farlo prigioniero. Aveva anche anticipato la loro richiesta di resa, ricevendo una risposta polemica, e cioè che non si poteva parlare di resa dal momento che non c’era stato combattimento. Garibaldi, invece, tranquillo e sereno come se ricevesse un invitato nell’orto di Caprera, si dichiarò a disposizione del Governo, manifestando preoccupazioni soltanto per la sorte dei volontari. Personalmente, spiegò, avrebbe preferito potersi imbarcare su un legno inglese ed andare esule lontano dalla patria. Il Colonnello, che stava sulle spine, fornì qualche vaga assicurazione senza compromettersi troppo, osservando di non aver nulla da obiettare sulla sua destinazione ma di essere obbligato a chiedere 51 istruzioni a Torino. Quanto ai prigionieri, pensava che sarebbero stati trasferiti a Messina e messi in libertà dopo qualche ora, al massimo dopo un giorno. Appena Pallavicini si fu allontanato, il Generale fece chiamare Corrao per raccomandargli di raccogliere quanti più disertori potesse e trarli in salvo aprendosi, con le buone o con le cattive, un varco attraverso le linee governative. Misurata la grettezza e la crudeltà dei suoi avversari, non nutriva più alcuna illusione sul loro conto e, quasi presagisse l’eccidio di Fantina, era angosciato per la sorte dei ragazzi che in Sicilia, esaltati dal richiamo della camicia rossa, avevano abbandonato i reparti regolari. Corrao riuscì a raccoglierne parecchi insieme con qualche centinaio di volontari, e se li trascinò dietro «per monti e dirupi» fino alla costa reggina, dove tuttavia giunsero in pochi perché i più compromessi avevano trovato rifugio, con l’aiuto dei «comitati patriottici», presso compiacenti famiglie calabresi. Al pomeriggio dell’indomani, mentre i superstiti della colonna Corrao travestiti da marinai si imbarcavano su una lancia alla volta di Messina, a poche miglia di distanza Garibaldi veniva trasferito a bordo del «Duca di Genova». Era stato trasportato in barella «per un cammino faticoso e pieno di accidenti», con una sosta notturna nel cascinale «La Marchesina», proprietà di un pastore calabrese, Vincenzo, che era una vecchia conoscenza dei primi Mille sbarcati nell’agosto di due anni prima in Calabria. Alle 14 del giorno dopo il melanconico corteo, scortato dai bersaglieri del maggiore Pinelli, giungeva a Scilla dove il 52 colonnello Pallavicini aspettava Garibaldi per riferirgli, non senza visibile imbarazzo, le drastiche disposizioni ricevute dal Ministero: non si permetteva al Generale di imbarcarsi su legno inglese, non gli si lasciavano scegliere gli ufficiali da cui aveva chiesto di essere accompagnato e gli si ingiungeva di imbarcarsi con Menotti a bordo della pirofregata «Duca di Genova». Preferì farlo subito. Allorché il convoglio passò dinanzi al vapore «Stella d’Italia», i prigionieri scorsero il Generale Cialdini che troneggiava in uniforme dal ponte, insieme con il contrammiraglio Albini e diversi altri ufficiali superiori. Nessuno di loro salutò Garibaldi, anzi Cialdini gli voltò le spalle. La sera prima aveva telegrafato a Torino la sua delirante versione dei fatti: «Dopo accanito combattimento in Aspromonte, Garibaldi, ferito, è caduto nelle nostre mani e quasi tutti i suoi sono nostri prigionieri. La colonna delle regie truppe era comandata dal colonnello Pallavicini». In un successivo rapporto al Ministro della Guerra, avrebbe definito lo scontro dell’Aspromonte addirittura come «un fatto d’armi, che per le conseguenze assume l’importanza di una battaglia», proponendo la promozione del Pallavicini e il conferimento della medaglia di bronzo a tutti i battaglioni partecipanti all’azione «per avere dato speciali prove di valore e sagacia militare». Una volta giunta all’altezza della pirofregata, la barca che portava il grande prigioniero fu posta su un paranco e issata con una macchinosa manovra che il Generale, seduto sulla barella, a testa alta, reggendosi con le mani 53 ad una corda, regolava egli stesso tra l’attonita ammirazione dei marinai. Sul «Duca di Genova» dove fu trasbordato in compagnia di Menotti, dei suoi medici e di altri amici, si congedò salutando con la mano i compagni che tornavano a Scilla e che si levavano commossi sulla barca, gridando «Viva Garibaldi! A Roma, a Roma!». 54 Parte terza Un massacro insensato 55 1 Per accelerare la marcia dei suoi picciotti nella ritirata dall’Aspromonte a Scilla, Corrao li aveva incitati più di una volta: «Avanti, avanti! Salviamo i disertori: questo è il comando di Garibaldi». E per suo conto, utilizzando i «comitati patriottici» era riuscito a metterne molti al riparo della collera sabauda. Ancora al momento di congedarsi dal marchese Pallavicini, Garibaldi aveva insistito con lui perché raccomandasse al Governo la causa dei disertori dell’Armata e se ne era sentito rispondere che lo avrebbe fatto ma se ne aspettava «poco buon esito» perché conosceva «le severe istruzioni in proposito». Due giorni dopo, nello stilare il suo gelido rapporto al Ministero della Guerra, il generale Cialdini aveva precisato che non tutti i «seguaci» di Garibaldi avevano potuto imbarcarsi con lui alla volta della Calabria, 700 e più erano stati catturati a Catania dalle truppe del generale Ricotti e di essi qualche centinaio era stato «improvvidamente» rinviato a casa con foglio di via. «Oltre a ciò, un certo maggiore Trasselli vagava alla testa di una banda la cui forza, da quanto ripetutamente dicevasi, sembrava di 800 o 900 uomini». Il rapporto del Comandante in capo proseguiva con lo stesso stile: «Fu dunque mestiere di 56 concertare la persecuzione di questa banda facendola eseguire da truppe di Catania e dalle poche di Messina, non permettendo lo stato degli animi di questa città un soverchio allontanamento di forze». Naturalmente il corsivo non sta nel testo originale del rapporto. Un decreto dello stesso Cialdini, in data 31 agosto, aveva invitato le truppe regie a considerare e a trattare «come briganti» i garibaldini che non si fossero costituiti all’autorità militare entro cinque giorni. Di fucilazione avrebbe parlato più tardi il già citato colonnello Eberhardt a proposito di chi fosse «colto indebitamente portatore o semplicemente detentore di armi». Il linguaggio dei capi era dunque quello di chi, occupando un paese straniero in rivolta, applica la più spietata legge di guerra. Del resto, già prima ancora della vergogna di Aspromonte l’ostilità contro i garibaldini si era manifestata in un episodio odioso che aveva coinvolto i colonnelli comandanti i due reggimenti della brigata Piemonte. Costoro dubitavano della lealtà dei numerosi ufficiali che avevano militato con Garibaldi durante la campagna del 1859 e del 1860 e ricorsero perciò a un espediente miserabile per accertare i loro effettivi sentimenti: durante la sosta a Paternò e Adernò li chiamarono a rapporto, invitandoli a presentare le dimissioni se non se la sentivano di «agire rigorosamente» contro il loro vecchio Generale e i suoi seguaci. Naturalmente il sottinteso era che la richiesta sarebbe stata accolta senza alcuna conseguenza disciplinare, diversamente gli ufficiali in questione non avrebbero di sicuro accettato l’invito. Erano 32, tra capi57 tani, tenenti o sottotenenti, più il maggiore Botta cospiratore contro i Borboni e più tardi molte volte deputato a Cefalù, tutti decorati al valore, coraggiosi e generosi. La maggior parte di loro lasciò l’esercito per arruolarsi nuovamente con Garibaldi, ma qualcuno come il sottotenente napoletano Armanni lo fece nella onesta convinzione che il Governo «eccitando una parte degli ufficiali del suo esercito a negarsi di combattere Garibaldi» avesse inteso dimostrare a Napoleone III che non poteva opporsi alla volontà della nazione di ritrovare la sua capitale. Ma quali che ne fossero i motivi ispiratori, gli ufficiali dimissionati ebbero presto modo di pentirsi della loro ingenuità. Appena accettato l’invito dei rispettivi colonnelli, si videro privati della sciabola e si sentirono avvertire che avrebbero dovuto consegnarsi agli arresti di rigore nella fortezza di Alessandria. Il terrore del diverso, dell’irregolare, del ribelle era più forte, in quei valentuomini, perfino del senso dell’onore e della lealtà. 58 2 L’ottuso terrore degli ufficiali di Cialdini preparava di peggio che quello spregevole inganno. Fu il 4 settembre, sei giorni dopo il ferimento di Garibaldi sull’Aspromonte, che i primi reparti della colonna Trasselli arrivarono, in preda allo smarrimento, alla fame e alla sete, in vista delle prime case di Fantina. «Piccolo e modesto villaggio», avrebbe scritto più tardi il garibaldino Edoardo Pantano, «sta Fantina sul dorso di uno di quei monti che circoscrivono le fertili pianure di Barcellona e di Milazzo», dunque in provincia di Messina, «e si ergono in alto quasi a specchiarsi sul mare e a contemplarvi l’incantato panorama delle isole Eolie. La sua storia è la storia di tutti i gruppi agricoli che hanno attraversato i secoli, martiri dell’aratro e vittime della solitudine campagnola, santificanti col lavoro la legge del riscatto sociale. Sfortunatamente, la sua celebrità non è dovuta a questi modesti ricordi, ma ad un grande misfatto». La prosa appassionata del vecchio patriota rende vigorosamente la melanconica realtà del piccolo villaggio anche se, per completare la descrizione, occorre aggiungere che il villaggio è lambito da un torrente che nasce dai Peloritani, all’altezza di Novara di Sicilia, e sfocia in mare pro59 prio di fronte alle Eolie. La colonna Trasselli era diretta appunto a Novara, dove il comandante e i suoi ufficiali si proponevano di consegnare le armi al sindaco Bertolani e alle altre autorità municipali, per evitare la umiliazione di capitolare di fronte ai loro colleghi sabaudi, e magari anche per ottenere qualche soldo da distribuire ai volontari smobilitati. Gli uomini, però, erano stanchi e l’ora tarda: Trasselli ordinò l’alt ai reparti e spedì a Novara una pattuglia in avanscoperta con la consegna di acquistare del pane con i tre scudi che gli restavano e di accertare la consistenza degli effettivi regi nella zona. La conferma non si fece attendere. A Tripi, otto miglia dalla località in cui si erano accampati i volontari, era stato avvistato un battaglione di soldati governativi. Dopo essersi inerpicato su un picco per avere una visione panoramica della situazione, Trasselli collocò agli avamposti i bersaglieri disertori ordinando che tutti i volontari, mano a mano che avessero consumato la magra cena, li raggiungessero sulla stessa posizione, che era inaccessibile da ogni lato. Spedì poi qualche ufficiale alla fiumara per rastrellare i dispersi e avviarli in quota, ma fu impossibile scovare una cinquantina di volontari che si erano sparpagliati fra i sabbioni del torrente e le poche casupole dei contadini, in preda ai morsi della fame e ad un avvilimento senza limiti. A prescindere dalla loro misera condizione personale, la ferita e l’arresto di Garibaldi sull’Aspromonte avevano distrutto un mito a cui si era consacrata tutta la vita di quei giovani combattenti, il mito dell’invincibilità e dell’invulnerabilità dell’eroe, 60 una sorta di sacralità laica. Una volta infranto quel totem, al primo impulso di collera subentrava in ciascuno dei volontari l’amara riflessione sul proprio destino individuale, sui rischi e sui pericoli dell’immediato futuro. Tornava in continuazione nei loro discorsi quel maledetto bando di Cialdini, di cui tutti parlavano come di una minaccia incombente; e il sonno arrivava piuttosto come una folla di incubi che come una liberazione. 61 3 Il dramma dei volontari rimasti a valle si consumò poco dopo la mezzanotte, mentre le lunghe file dei volontari di Trasselli, che al lume notturno potevano essere scambiati per «ombre fantastiche», si arrampicavano faticosamente sul dorsale del monte. Vinti dalla stanchezza i garibaldini si erano addormentati, chi sulle sabbie dei torrenti, chi nelle case più ospitali di Fantina o nella chiesetta, che era rimasta aperta, in un silenzio carico di attese e di sgomento. D’un tratto quel silenzio fu rotto, in lontananza, dal passo cadenzato di un grosso reparto militare che si avvicinava: era il 47° battaglione di fanteria, composto in grande maggioranza di effettivi meridionali già in forza nell’esercito borbonico e che ora militavano in quello regio sotto gli ordini di un inflessibile ufficiale piemontese, il maggiore Giuseppe C. De Villata. Costui condusse tutta l’operazione come se si trovasse in territorio nemico e dovesse fronteggiare non un pugno di sbandati senza armi e senza speranza, ma una banda di pericolosi guerriglieri. Cominciò con lo spedire i suoi uomini all’assalto di Fantina, mettendo a sacco le case dei poveri contadini e catturando i garibaldini che vi si erano rifugiati, per 62 avviarli lungo il greto del torrente dove già i soldati di un’altra compagnia del 47°, sorpresi i volontari nel sonno, li avevano svegliati brutalmente, puntandogli la baionetta al collo ed urlando con tutto il borbonico rancore di cui erano capaci: «Al Sessanta tu ed al Sessantadue noi!». Frastornati, stupiti, indignati per un così brusco risveglio, i volontari avevano appena accennato ad alzarsi e a scuotersi gli indumenti dalla polvere quando un ufficiale avanzò dal reparto per comunicare ai prigionieri gli ordini del comando: «Volontari!» disse «se in mezzo a voi si celano dei disertori, si facciano innanzi. Il Re li perdona e li lascierà immediatamante raggiungere i loro corpi». Tutte le testimonianze concordano sull’esattezza di questa citazione, di cui siamo debitori a Ernesto Pantano. A nome del comandante in capo, anzi addirittura del Re, l’ufficiale garantì ai disertori il perdono e il recupero nell’esercito governativo, un provvedimento generoso ma che non avrebbe avuto nulla di sorprendente visto che quei giovani avevano seguito Garibaldi per un’impresa patriottica e che, per giunta, non erano stati catturati in combattimento. Meno concordi, comunque, sono le testimonianze su quanto accadde dopo qeull’annuncio che, per le circostanze e il momento in cui veniva fatto, aveva assunto un tono solenne alle orecchie di chi l’aveva raccolto. La grande maggioranza delle fonti parla di sette uomini che, alle parole dell’ufficiale (rimasto anonimo), mossero fiduciosamente un passo avanti. Secondo Aurelio Saffi, che si occupò dell’episodio nel Proemio all’ottavo volume 63 degli scritti editi ed inediti di Mazzini, pubblicato 22 anni dopo, oltre ai sette dispersi se ne sarebbe fatto avanti un ottavo, un reduce dell’impresa dei Mille, Pietro Castagna, che avrebbe poi narrato la sua disavventura (a lieto fine) nel «Fascio della Democrazia», giornale bresciano. In ogni caso, sembra certo che due dei sette volontari sollecitati a presentarsi dal miraggio di una totale riabilitazione, non erano affatto disertori ma avevano risposto all’appello dell’ufficiale di De Villata, forse con la speranza di proseguire nelle file sabaude la marcia verso Roma, forse semplicemente con l’obiettivo di restare in servizio nell’esercito o addirittura per un banalissimo equivoco. Sette o otto che fossero, gli infelici vennero immediatamente circondati da un drappello del battaglione in assetto di guerra e condotti dinanzi ad un altro ufficiale, incaricato di interrogarli. Dovettero fornire le loro generalità, spiegare da che parte d’Italia venivano e a quale reparto avevano appartenuto prima di disertare: a parte Castagna, di cui si è già detto, i sette rispondevano ai nomi di Giovanni Botteri e Ulisse Grazioli di Parma, Ernesto o Giovanni Pensieri di Pavia, Costante Bianchi, Barnaba della Momma e Giovanni Balestra di Roma e Luigi o Cornelio Cerretti di Rovigo, di cui si sa che apparteneva al 29° battaglione bersaglieri, mentre della Momma era anche lui bersagliere ma del 25°, un reparto che aveva combattuto all’Aspromonte. Tre romani dunque e quattro settentrionali, cone del resto erano stati in gran parte i Mille. 64 Il breve interrogatorio non era neppure concluso che da Tripi, dove aveva stabilito il proprio quartier generale, arrivava il maggiore De Villata. «Nei suoi occhi» scrisse un patriota garibaldino «brillava un raggio di quella luce sinistra che illuminava i figli della dea Boania». Così dovettero vederlo, comunque, i sette (o otto) volontari che avevano abboccato ingenuamente all’invito del suo ufficiale e che ora sempre più furenti e spaventati scoprivano l’inganno. Il Maggiore cancellò la promessa del suo portavoce senza neppure menzionarla: «Soldati» disse freddamente «voi siete spergiuri verso la patria ed il Re. In nome della legge militare vigente, voi siete condannati alla pena di morte da eseguirsi all’istante». E concluse con lo stesso tono, come se stesse leggendo una pagina del regolamento dell’esercito: «Disertori ribelli, vi concedo dieci minuti da dedicare alla preghiera». Parole dure, tremende, che facevano passare fulmineamente i sette (o otto) volontari da una vaga preoccupazione alla certezza della morte, e di una morte tanto imminente quanto imprevista e inaccettabile. Le udirono con stupore muto, il volto solcato dalle lagrime e stravolto da un’ingiustizia che appariva troppo grande per suscitare anche soltanto una protesta. Quattro garibaldini caddero in ginocchio, chiedendo al Signore la forza di morire con dignità, mentre uno dei loro compagni restava fermo, immobile, rifiutandosi sdegnosamente alla preghiera, e i due giovani volontari realizzavano di colpo inorriditi, l’assurdità del loro destino. Gli infelici che si erano spacciati per disertori senza esserlo, presero improvvisamente e pietosamente 65 a protestare disperati dinanzi a Dio e agli uomini la loro innocenza piangendo gli affetti più cari, la città perduta, il maledetto calcolo che li aveva indotti in errore. Uno dei due, Costante Bianchi, un esule romando di 18 anni, quasi ancora un ragazzo «mesto e bello», non aveva al mondo che la madre, e lo disse urlando e scongiurando i vincitori di strapparlo alla morte, di non costringerlo a lasciarla sola, di non commettere l’estrema infamia. Il maggiore De Villata, che non aveva mosso un muscolo dinanzi alla preghiera degli altri condannati a morte, non si commosse neppure per le strazianti invocazioni dei due volontari, a cui del resto non prestava alcuna fede. Disse solo «Niente, briganti! non meritate che piombo nello stomaco» e fece cenno all’ufficiale che comandava il plotone di esecuzione di sbrigarsi. Caricate le armi, i soldati del plotone si schierarono su un’unica lunga fila. Nel buio sepolcrale della notte cadde un rullo di tamburo come un cupo, lento preannuncio di morte. Piangevano perfino gli ufficiali dell’esercito regio allorché dal gruppo dei condannati si staccò il giovane garibaldino romano alzando le mani per scongiurare i giustizieri: «In questo supremo momento lasciatemi il conforto», disse «di scrivere almeno una parola a mia madre». L’ufficiale che comandava il plotone, commosso, fece segno con la sciabola ai suoi uomini di abbassare i fucili e si avvicinò al maggiore De Villata, appostato poco lontano, prettamente alla distanza di appena una decina di metri dal luogo dove poi fu eretta una cappella. Non fu possibile udire ciò che egli diceva al Coman66 dante ma costui dovette sicuramente confermare la sua indiscriminata e aberrante sentenza visto che l’ufficiale tornò lentamente verso il piccolo gruppo di camicie rosse e allargando le braccia, costernato, mormorò: «Impossibile», senza avere neppure il coraggio di fissare negli occhi il ragazzo, che accolse la sua risposta trincerandosi dietro uno sprezzante silenzio. Un secondo rullo squarciò quella tragica notte siciliana. I condannati si guardarono in viso per l’ultima volta, qualcuno col volto inondato di pianto, qualcuno sorridendo malinconicamente per un così triste epilogo dell’avventura. Quando si udì il terzo e ultimo rullo di tamburi, dal piccolo gruppo dei morituri si levò il grido fatale «Roma o morte!» prima che una nube di fuoco li avvolgesse nel crepitio degli spari. Dilatata la nebbia, furono visti sette corpi inerti, sette giovani che pareva dormissero, co il «sangue che spicciava dai loro petti e si confondeva con il rosso delle loro camicie». Pochi istanti e l’ufficiale del plotone mandò alcuni dei suoi soldati a seppellire i morti. Uno dei volontari, il Castagna, a dare credito al racconto di Saffi, era rimasto illeso e riuscì più tardi, con l’appoggio del medico di battaglione ed il conforto dei documenti che aveva con sé, a convincere De Villata di non essere un disertore. Ma sul momento i soldati scoprirono con raccapriccio che un altro dei garibaldini, il Bianchi, era ancora in vita. Rianimato per un istane dal soffio della brezza notturna, aveva sollevato il capo e scorgendo i suoi giustizieri li aveva richiamati con un debole cenno ed un filo di voce: 67 «Fratelli, il voto dei morenti è sacro». Gli eroi del Risorgimento non dimenticavano nemmeno in punto di morte le regole della buona oratoria. «Se avete una madre che amate anche voi» riuscì ad aggiungere il giovane romano «lasciate che io scriva una parola alla mia». Uno dei soldati dell’esercito governativo che erano accorsi al richiamo del moribondo gli si inginocchiò a fianco e gli resse amorevolmente la testa, mentre il suo compagno passava un fazzoletto sulle sue labbra spumeggianti di sangue. Altri soldati fecero cerchio intorno a Bianchi, commentando impietositi la sua richiesta e suggerendo di appagarla, allorché qualcuno venne a portare l’ordine formale del maggiore De Villata: niente lettera e colpo di grazia. Una scarica di moschetto troncò così la vita di un ragazzo che aveva avuto il solo torto di sognare la sua Roma italiana. Compiuto il misfatto, il battaglione del maggiore e Villata si allontanò frettolosamente nella notte verso Novara di Sicilia, abbandonando sulla fiumara le spoglie dei martiri. Per fortuna, i contadini di Fantina dimostrarono maggior rispetto per i morti dei civilissimi piemontesi. All’alba del giorno 5 raccolsero i poveri resti dei sette garibaldini fucilati, li trasportarono nella vicina chiesa e li inumarono in una fossa già aperta nel pavimento. Anzi, secondo una testimonianza raccolta quando i protagonisti dell’episodio erano ancora in vita, la fossa dovette essere allargata per accogliere la salma di Costante Bianchi, «un giovane dalle forme atletiche», che ovviamente eccedeva le normali misure: sulle sponde del torrente dove i volon68 tari erano stati massacrati insensatamente sorsero, per iniziativa del sacerdote Giovanni D’Aveni e delle signore Búcalo, proprietarie del terreno, due edicole affrescate alla buona da un pittore della domenica, un altro prete, certo don Mariano Fontana. Una delle cappellette fu scoperta molti anni dopo, su un muro roccioso, seminascosto da una folta siepe, dal fotografo Affannato, che stava visitando la zona in cerca di ricordi dell’epoca. 69 4 Non fu facile per Trasselli placare gli animi esacerbati dei suoi uomini quando ebbero appreso la notizia dell’eccidio di Fantina. Dimenticando le delusioni e le sofferenze degli ultimi giorni, e trascurando perfino il messaggio pacificatore di Garibaldi, i volontari avrebbero voluto impugnare finalmente le armi contro gli uomini del 47° fanteria per vendicare la memoria dei loro compagni così vilmente trucidati. Il colonnello comandante riuscì per miracolo a trascinarli verso Novara e ad indurli a tenere le armi a disposizione del sindaco Bertolani, al quale fece sapere che non volendo essere «complice degli assassinî» commessi «da soldati italiani contro fratelli italiani», non aveva tirato un sol colpo, sebbene ne avesse avuto l’occasione in più di una tappa della sua lunga marcia, per esempio a Mandanici, dove «poteva bruciare tutti i soldati che ivi salivano». Veniquattr’ore dopo, giunto a Catania, Trasselli spediva al maggiore De Villata una lettera che, per il suo tono sferzante e provocatorio, equivaleva a una sfida. La lettera cominciava con un sarcastico complimento al Maggiore per il modo con cui aveva diretto «il valoroso attacco» contro i garibaldini, ma subito dopo cambiava 70 bruscamente tono: «Miserabile che siete, credevate con tutta la bonomia possibile che con i vostri, croati come voi, potevate vincere, disperdere, arrestare e fucilare, mentre la mia forza era composta da 800 individui tutti risoluti, e col magnetismo trasfuso in essi dal loro capo, con una posizione presa e nel cuore della notte?». Il capo, naturalmente era Garibaldi e croati sta per austriaci, tedeschi, insomma gli stranieri del Giusti, quelli che Vienna «schiavi [li] manda per tenerci schiavi». Ma ciò che, fuor di invettiva, al colonnello Trasselli premeva di sottolineare era che la presunta disfatta della sua colonna nasceva esclusivamente da una ragione ideale: «Se io non era italiano e non avessi avuto ad orrore lo spargere sangue italiano, credetelo, signore, sul mio onore voi non esistereste più con l’ultimo soldato che comandavate». Esclusivamente le istruzioni «del primo cittadino italiano» Garibaldi, che soltanto i soldati regi «da non italiani» avevano osato «maltrattare», indussero Trasselli ad evitare lo scontro, a non abusare mai della sua forza, a rispettare sempre i carabinieri che incontrava e che avrebbe potuto «per lo meno disarmare». Così diceva la lettera al maggiore piemontese, dopo aver elencato una per una le istruzioni di Garibaldi che cominciavano con lo slogan più famoso e glorioso del Risorgimento: «Il nostro programma è sempre lo stesso: Italia e Vittorio Emanuele». La sola idea di poter uccidere un fratello faceva orrore al colonnello Trasselli, mentre De Villata non si era fatto scrupolo di fucilarne sette, innocenti. «Voi abusaste contro gli inermi» proseguiva la lettera 71 con un’altra impennata di generoso furore, «voi ordinaste il sacco ai vostri soldati nel villaggio di Fantina, ed essi hanno tutto depredato di quanto si avevano nelle loro case quei villici, servendosi della vile menzogna che l’oro e gli oggetti dai vostri infamemente posseduti li avevano comperati dai garibaldini». Questo è un passo particolarmente interessante della lettera, perché accenna ad episodi di cui, diversamente, non si avrebbe notizia. Vi si indovina anche una certa angustia morale dei vincitori e non solo una generica prepotenza soldatesca. Il documento di Trasselli si conclude così vigorosamente, come se il Colonnello schiaffeggiasse il suo antagonista dinanzi ai reparti schierati: «Signore, con tutta la lealtà dell’animo mio, dopo il vostro operato io vi dichiaro vile e non italiano; e sappiate che la prima volta che avrò il bene di incontrarvi, avrò il coraggio di lacerarvi quella divisa che voi avete infamata e che sola è degna di portarsi da soldato italiano». Era un guanto di sfida, una precisa provocazione al duello, ma il maggiore De Villata ritenne più prudente fingere un disguido e opporre alla sferzante lettera dell’ufficiale garibaldino una fin de non recevoir, tanto più che la poco eroica impresa di Fantina stava per procurargli la promozione a tenente colonnello e il trasferimento a Genova in una col suo reggimento. Più ardimentoso si sarebbe dimostrato qualche anno più tardi, nel luglio del 1865, quando ebbe minacciato fuoco e fiamme contro gli autori rimasti anonimi di una scritto sui fatti di Sicilia, che era comparso su un giornale repubblicano, «Il Genova», e che in realtà ripeteva il racconto 72 di Ernesto Pantano e gli elementi essenziali della lettera di Trasselli. Ma neppure questa volta fu necessario scomodare il codice Gelli: il Maggiore si accontentò della pubblicazione di una lettera di solidarietà che evidentemente gli ufficiali del suo reggimento non ebbero modo di ricusargli. Fu invece, più tardi, un capitano del 20° reggimento a battersi, in nome di De Villata, contro lo scrittore garibaldino Giulio Barrili, un letterato di buona fama, ed a ferirlo leggermente ad una mano. Abbastanza comicamente, poi, il trionfatore di Fantina ottenne dal Governo una soddisfazione di carattere non cavalleresco, ma burocratico: un comunicato sulla «Gazzetta Ufficiale» in cui si dichiarava che il De Villata «era un galantuomo» ed aveva agito «in conformità dei suoi doveri e delle istruzioni ricevute». Una specie di attestato di buona condotta rilasciato dalli superiori. 73 5 I garibaldini e più in generale i democratici vicini al Partito d’Azione non dimenticarono i ragazzi fucilati sulla fiumara. Sette anni dopo l’eccidio, un gruppo di studenti di Novara di Sicilia incoraggiati da alcuni fogli locali di sinistra propose di dedicare un monumento ai martiri di Fantina, costituendo un comitato che presto trovò corrispondenza in un altro comitato sorto a Messina, da cui lanciata anche una sottoscrizione popolare. Ma nel 1869 il clima politico nazionale era poco propizio a un’iniziativa del genere. Aspromonte e Mentana erano ancora considerati atti di ribellione, le camucie rosse ancora escluse dal novero dei reduci delle patrie battaglie, le celebrazioni delle loro imprese fortunate o sfortunate appena tollerate o addirittura proibite come manifestazioni di spirito sovversivo. Le censura sabauda non scherzava davvero e fu inevitabile rimandare a tempi migliori il progetto del monumento. Ma i comitati di Messina e di Novara di Sicilia non si arresero e, in mancanza del monumento ripiegarono su una lapide da apporre sulla facciata della chiesa di Fantina. S’incaricò di preparare il testo Raffaele Villari, un vecchio garibaldino che faceva parte del Comitato di 74 Novara e che, in un primo momento, dettò un’iscrizione assai vibrante, nello stile magniloquente ma solenne dell’epoca: su quest’albo di marmo stanno incisi i nomi dei sette eroi assassinati vilmente sulla contesa marcia su roma ma dalla istoriata pietra si sprigiona un grido di vendetta all’italia e a dio contro il carnefice impunito I documenti non dicono perché mai il testo del Villari sia stato modificato, probabilmente nel timore che accenni alla vendetta, a Dio e soprattutto al «carnefice impunito», il quale era in definitiva un ufficiale del Regio esercito, potessero scandalizzare le autorità costituite e i benpensanti. Sul prospetto della chiesa di Fantina, in ogni caso, figura una iscrizione radicalmente diversa, nella seconda parte, da quella originaria: su quest’albo di marmo stanno incisi i nomi di eroi trucidati sulla contesa marcia su roma nel settembre 1862 ma dalla istoriata pietra un torrente di luce si sprigiona che ricorda i morti 75 che mantengono viva e sempiterna l’italia 76 Le preoccupazioni censorie, come sempre succede, avevano peggiorato sensibilmente lo stile e il contenuto del messaggio che, da preciso atto di accusa si trasformava in una sorta di enfatica esaltazione delle vittime, senza indicazione alcuna dei responsabili dell’eccidio: in meno di trent’anni, il cammino della libertà nel nostro Paese si era ristretto anziché dilatarsi. Comunque, la lapide fu inaugurata l’8 settembre 1890, a cura del Comitato presieduto dall’ingegner Felice Siracusano e con un alato discorso dello stesso Raffaele Vllari. Nessuna obiezione aveva mosso alla muratura della lapide sulla facciata della chiesa di Santa Maria Serenissima della Provvidenza, l’arciprete don Luigi Stancanelli, un parente del quale, l’avvocato Salvatore, figurava tra i promotori dell’iniziativa; ma pochi mesi dopo, probabilmente su pressioni del Prefetto, l’arcivescovo di Messina monsignor Giuseppe Guarino ne ordinò la rimozione. Si accese allora tra preti, savoiardi e partito repubblicano una feroce polemica, che gli studenti democratici di Novara di Sicilia troncarono allegramente una bella notte restituendo la lapide del Villari alla facciata della chiesa di don Luigi, donde nessuno osò più smontarla. Sarebbero trascorsi, tuttavia, quasi altri cento anni prima che la grande maggioranza degli italiani fosse messa al corrente – e nel modo più autorevole – dell’incredibile misfatto compiuto dal maggiore De Villata. L’episodio di Fantina rimase del tutto sconosciuto alle cronache ufficiali del Risorgimento italiano e delle guerre di indipen- denza perfino nell’ambito delle rievocazioni popolari del ferimento di Garibaldi sull’Aspromonte, mentre avrebbe dovuto suggerire severe riflessioni sulla ferocia con cui i vincitori imposero la loro legge nel Mezzogiorno, tanto nei confronti del «brigantaggio» più o meno filo-borbonico, quanto e forse ancor più rigorosamente rispetto agli esponenti del Partito d‘Azione, ai volontari garibaldini e agli affiliati della «Giovane Italia». Nella versione edulcorata che del complesso processo risorgimentale la propaganda monarchica e poi fascista diede invece fino alle soglie della seconda guerra mondiale, contrasti e repressioni scomparvero d’incanto, per dar luogo ad una ricostruzione apologetica nella quale la dinastia e il conte di Cavour svolgevano un ruolo provvidenziale con l’occasionale, e non sempre avveduta, collaborazione di Garibaldi e Mazzini. 77 Indice 78 L’eccidio di Fantina Introduzione 6 Parte prima Roma o morte 9 Parte seconda La ferita di Aspromonte 32 Parte terza Un massacro insensato 55 79
Scaricare