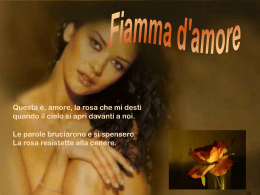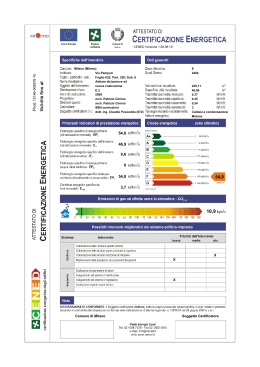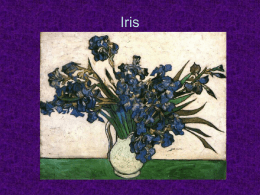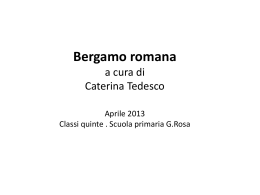Dal Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di 1Interesse Biologico Consiglio Nazionale delle Ricerche S T O R I C MI B A O S CH3 S C30H61 O NH2 N N HOCH2 O H HO H HO H N N H I 30 anni di attività dell’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico 2 Ringraziamenti Per la stesura di questa pubblicazione si ringraziano i seguenti colleghi: Oxynoe olivacea un comune sacoglosso meditarreno sull’alga Caulerpa prolifera Prof. Alessandro Ballio Prof. Colin Crane-Robinson Prof. Mario De Rosa Prof. Ernesto Fattorusso Prof. W.D. Grant Prof. Virigina Lanzotti Prof. Gino Lucente Dr. Antonio Malorni Prof. Lorenzo Mangoni Prof. Rodolfo Alessandro Nicolaus Prof. Raffaele Riccio Prof. Mosè Rossi Prof. Aldo Spinella Prof. Pierandrea Temussi I colleghi dell’ICMIB I colleghi dell’amministrazione Rosaria Vaccaro e Barbara Ognibene per il recupero delle informazioni in archivio, il Dr. Guido Villani per le foto, il Sig. Raffaele Turco per il supporto alla grafica, il Sig. Ciro Di Micco per le vignette che illustrano nella nostra memoria la storia dell’Istituto. Recapito Sulfobus solfataricus già Caldariella Spettrometro NMR 400 MHz Istituto di Chimica Biomolecolecare Consiglio Nazionale delle Ricerche Via Campi Flegrei Comprensorio ex-Olivetti Padiglione 70 Tel. 081-8675026 Fax 081-8041770 e-mail: [email protected] www.icmib.na.cnr.it Coordinatore della pubblicazione Dr. Antonio Trincone In copertina -Eunicella cavolini (gorgonia gialla) che è fonte naturale dell’ara-A (nell’inserto), l’unico farmaco di origine marina, tuttora utilizzato come anti-leucemico (al centro) -Soffione della Solfatara di Pozzuoli con l’insert della formula del caldariellaquinone isolato da Sulfolobus solfataricus nel 1977 (sopra) 3 La scienza è il capitano, e la pratica sono i soldati. Leonardo da Vinci I 30 anni dell’Istituto per la Chimica di Molecole di In- Soltanto chi parla di quello che ha sperimentato è fiducioso. Hermann Hesse Consiglio Nazionale delle Ricerche 4 Dal Indice Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico 5 Prefazione 6 Dediche Prof. Luigi Minale Prof. Guido Sodano all’Istituto di Chimica Biomolecolare 7 Introduzione ICMIB in cifre La fondazione 10 Le Direzioni La Direzione di R.A. Nicolaus La Direzione di Luigi Minale La Direzione di Mario De Rosa 12 I consigli scientifici 15 I reparti, attività fino al 1994 Sostanze naturali Batteri termofili Risonanza magnetica nucleare Spettrometria di massa La linea di ricerca Cristallografia 70 Uno sguardo dall’esterno 72 Le linee di ricerca attuali dell’Istituto L’attività del personale ex-ICMIB ICMIB nel mondo 92 93 Il coordinamento dell’Istituto nazionale Istituto di Chimica Biomolecolare 95 I 30 anni di attività dell’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico La nuova sede Appendici Articoli scientifici pubblicati Tesi di laurea svolte all’Istituto Elenco del personale attuale Pensionati e trasferiti 5 Prefazione Non è facile scrivere la storia perché essa risiede nelle persone; è invece relativamente più facile rintracciare i documenti relativi alla Storia. Questa pubblicazione si prefigge lo scopo di raggiungere entrambi gli obiettivi per quanto riguarda l’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico nel momento in cui tale nome verrà abbandonato per essere sostituito dal nuovo nome: Istituto di Chimica Biomolecolare nell’ambito della riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il secondo cambio di nome avviene in concomitanza con l’accorpamento con altri Organi di ricerca e del trasferimento delle attività dell’Istituto nella nuova sede del Comprensorio exOlivetti di Arco Felice. E’ molto probabile che vi siano lacune evidenti, non tanto nello scrivere la Storia -presente nei documenti, raccolta nella descrizione delle attività scientifiche dei reparti, registrata nei verbali dei vari Consigli Scientifici- quanto nel rintracciare la storia che risiede nelle persone. Tale sforzo è stato compiuto per immagini inserendo le foto dell’epoca e cercando di rintracciare quanto di registrato rimane nella memoria di quei momenti, sperando di allargare quanto più possibile la partecipazione attiva al racconto. Questo libro è dedicato alla memoria dei professori Luigi Minale e Guido Sodano il cui lavoro ha improntato di sé le tematiche scientifiche e la vita di tutti i giorni dell’Istituto. Il professore Minale è stato uno degli iniziatori dello studio delle sostanze naturali da organismi marini; il professore Guido Sodano ha continuato questo tipo di studi dedicandosi nell’ultima parte della sua carriera -svolta all’Università degli Studi di Salerno- anche a tematiche di sintesi chimica relative alle molecole di interesse biologico individuate. Il professore Guido Sodano ha sempre collaborato con l’Istituto anche quando era attivamente impegnato nelle attività di ricerca e di insegnamento universitarie. Soleva dirmi che “ad Arco Felice c’è sempre il sole”. Questo libro è dedicato inoltre a Silvia Niola figlioletta indimenticata di Valeria Calandrelli, tecnico afferente al Reparto Batteri Termofili. Antonio Trincone 6 Dediche E’ volontà di tutti dedicare questo libro a tre persone: a Luigi Minale, a Guido Sodano e a Giuseppe Ferracane. I primi due non hanno bisogno di presentazioni; il terzo è meno noto a chi, nei primi periodi di organizzazione del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico, non era presente. Riportiamo qui di seguito una brevissima traccia del percorso scientifico del prof. Luigi Minale da parte di Raffaele Riccio, e del prof. Guido Sodano a firma di Aldo Spinella. Nella restante parte di questa pubblicazione il loro nome compare più volte a caratterizzare la vita Il prof. Minale nacque a Tripoli (Libia) nel 1936. Dopo la Laurea in Chimica (indirizzo OrganicoBiologico) all’Università di Napoli, ottenne la Libera Docenza in Chimica delle Sostanze Naturali il 15 giugno del 1968 che fu confermata nel gennaio del 1974. Il prof. Minale fu ricercatore C.N.R. presso la III sezione del Centro Nazionale di Chimica delle Sostanze Organiche Naturali con sede presso l’Istituto di Chimica Organica dell’Università di Napoli. Il 1 luglio del 1969 divenne Ricercatore C.N.R. presso il Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico del C.N.R. di Arco Felice qualifica che conservò fino al 30 giugno del 1972 diventando poi Direttore di Ricerca presso lo stesso laboratorio fino all’ottobre del 1975. Dal settembre del 1973 al 30 giugno del 1981 fu Direttore del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico del C.N.R. di Arco Felice. Nato a Caserta il 29 Marzo 1942, il prof. Guido Sodano dopo la Laurea in Chimica presso l'Università di Napoli nel 1968 per poco tempo lavorò nell'industria "Cutolo Metallorganica". Nel 1969, dopo un breve periodo in cui fu titolare di un contratto di ricerca presso il Centro Nazionale di Chimica delle Sostanze Organiche Naturali, con sede presso l'Istituto di Chimica Organica della Facoltà di Scienze dell'Università di Napoli, a seguito di concorso pubblico, diventò ricercatore del CNR in servizio presso l'Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico con sede in Arco Felice (NA), posizione che tenne fino al 1986. In seguito, risultato vincitore di concorso nazionale per posti di professore universitario di I fascia, fu chiamato a coprire la cattedra di Chimica delle Sostanze Organiche Naturali dalla Facoltà di Scienze dell'Università della Basilicata e successivamente la cattedra di Chimica Organica dalla Facoltà di Scienze dell'Università di Salerno. Presso l'Università di Salerno, ha ricoperto importanti cariche istituzionali quali Consigliere di Amministrazione dell'Università (1993-94), Direttore del Dipartimento di Chimica (1994-95) e Preside della Facoltà di Scienze (1995-2000). E' stato inoltre Presidente della Sezione Basilicata della Società Chimica Italiana (1988-89), membro del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana (1997-98), membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Sintesi Organica "A. Corbella" della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico del Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno. L'attività di ricerca del prof. Sodano è tutta nell'ambito della chimica delle sostanze organiche naturali, con particolare riguardo a quelle di origine marina, ed è testimoniata da 140 pubblicazioni, comprendenti articoli di ricerca originali, capitoli in libri multiautore e reviews, e di un centinaio di comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali, alcu- 7 ne delle quali tenute su invito. E' stato responsabile di Unità Operative del P.F. Oceanografia e Fondi Marini (197781), del P.F. Chimica Fine e Secondaria (1981-85) e, nel triennio 1996 - 1998, di una unità di ricerca nell'ambito del progetto MAST III dell'Unione Europea. Durante il periodo di attività presso l'Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico si è occupato dello studio dei meccanismi di difesa chimica di molluschi privi di conchiglia. Ciò ha portato alla delucidazione della struttura di circa un centinaio di nuove sostanze naturali di origine marina. Il lavoro sulla biogenesi delle sostanze naturali marine costituisce un altro importante aspetto degli interessi scientifici del prof. Sodano. Tale studio ha portato al chiarimento della biosintesi di alcune di queste sostanze, con risultati particolarmente significativi per quanto attiene a steroli marini "non convenzionali" (tali ricerche sono state talvolta condotte in collaborazione col Prof. Djerassi della Stanford University). Altri risultati hanno riguardato il chiarimento della struttura, biosintesi e sintesi di glicolipidi che proteggono l'enzima nitrogenasi in eterocisti di cianobatteri azoto-fissatori e una proposta del meccanismo di interazione di composti dialdeidici dal gusto piccante con il recettore del gusto. Più recentemente, all'Università di Salerno, l'attività di ricerca del prof. Sodano si è spostata sulla sintesi di sostanze naturali complesse biologicamente attive, prevalentemente di origine marina, fra queste ricordiamo il sesterterpene antiinfiammatorio manoalide, la tossina tripeptidica janolusimide e numerosi steroidi polifunzionalizzati ed "altamente degradati". Il prestigio del Prof. Sodano nella Comunità Scientifica è testimoniato dal ruolo svolto in molte attività. Referee di numerose riviste scientifiche, fra le quali Journal of Organic Chemistry ed European Journal of Organic Chemistry. E' stato inoltre membro del comitato scientifico od organizzatore di numerosi congressi nazionali ed internazionali; in questo contesto va ricordato il suo ruolo determinante nella nascita dei convegni nazionali sulle sostanze naturali (NAT) giunti attualmente alla quinta edizione. A tutto ciò va aggiunto che i suoi interessi scientifici non si sono limitati solo agli aspetti specialistici ma la sua innata curiosità lo portava ad interessarsi di vari argomenti scientifici anche quelli riguardanti aspetti storici e metodologici. A seguito di una grave malattia il prof. Sodano è scomparso nel mese di giugno del 2001. Quello che ha lasciato dal punto di vista scientifico, come dal punto di vista umano va ben oltre il resoconto scientifico riportato qui sopra e nel resto di questa pubblicazione. La sua figura umana e scientifica è impressa indelebilmente nella memoria di tutti gli studenti e i colleghi che hanno avuto occasione di incontrarlo e ancor di più in quelli che hanno avuto modo di lavorare con lui in stretta collaborazione. Tutte le persone che lo hanno conosciuto conserveranno sempre il ricordo della sua costante attenzione e disponibilità, del suo estremo equilibrio e della sua grande umanità. Aldo Spinella Giuseppe Ferracane è stato il primo responsabile amministrativo del LCFMIB. Il suo aiuto prezioso è stato ricordato dal prof. Nicolaus e dal Dr. Guido Cimino. 8 9 Introduzione Verso la metà degli anni ’60 la chimica italiana vedeva a Napoli una straordinaria concentrazione di cervelli. Le più prestigiose cattedre erano occupate da personalità, tutte molto giovani, che avrebbero, negli anni successivi, inciso profondamente sullo sviluppo di tutte le discipline chimiche in Italia. Mi rallegra ricordare, in rigoroso ordine alfabetico, Giovanni Astarita per la Chimica Industriale, Alessandro Ballio per la Chimica Biologica, Paolo Corradini per la Chimica Generale ed Inorganica, Vincenzo Liberti per la Chimica Analitica, Alfonso Maria Liquori per la Chimica Fisica, Leopoldo Massimilla per la Chimica delle Combustioni, Lorenzo Mangoni per la Chimica Organica ed, infine, Rodolfo Alessandro Nicolaus per la Chimica delle Sostanze Naturali. Il progetto “Napoli Capitale della Chimica” era stato ideato e favorito dal decano del gruppo, il Prof. Nicolaus che, agli inizi degli anni ’60 dopo la scomparsa di Francesco Giordani, appena quarantenne era diventato, a Napoli, l’unica voce autorevole per le discipline chimiche. Questa vivacità culturale fu premiata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche che, nel programmare una serie di propri organi, assegnò alla Chimica un ruolo trainante. Nel 1968, cinque nuovi Laboratori del CNR iniziarono ad operare in Campania e, tra questi, ben tre appartenevano all’area chimica. Probabilmente, queste scelte furono favorite dal premio Nobel per la Chimica assegnato, nel 1963, a Giulio Natta ed, anche, dall’essere allora il CNR presieduto da un chimico, Vincenzo Caglioti. Così, nel 1968, nacque in Arco Felice il Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico. La sede non fu un problema. Infatti, essendo provvisoria avrebbe dovuto ospitare le attività del CNR per solo due, tre anni. Alcune villette destinate a residenze estive vennero locate e, con poche modifiche strutturali, trasformate in laboratori di ricerca. I saloni divennero laboratori, le cucine studi e gli scantinati sedi per le grandi apparecchiature. Al Prof. Nicolaus fu assegnata la responsabilità di costruire questa nuova realtà scientifica. Con lungimiranza, tre furono le priorità assolute: 1) professionalità del personale; 2) innovazione nella progettazione scientifica; 3) internazionalizzazione della ricerca. E’ straordinario ma, a distanza di 32 anni, ancor oggi questa sembra la miglior ricetta per produrre ricerca di frontiera. 1. La selezione del personale favorì il gruppo di ricerca che si era formato attorno al Prof. Nicolaus, quattro dei neo-ricercatori (Cimino, De Stefano, Sodano e Trivellone) avevano svolto il lavoro di tesi presso il Dipartimento diretto da Nicolaus ma il gruppo fu affidato all’esperienza di Luigi Minale, ricercatore CNR anziano pur avendo solo 32 anni. Inoltre, per favorire un avvio fulminante, Nicolaus chiese il coinvolgimento di alcuni suoi allievi già inseriti nel mondo accademico. Così Ernesto Fattorusso e Silvana Magno per più di due anni operarono costantemente presso il nuovo Laboratorio. La selezione del personale incluse anche alcuni brillanti neo-laureati (De Rosa M., Gambacorta, Tancredi e Malorni) anche se in altre discipline chimiche. Per cercare di capire meglio quest’epoca “romantica” non si può non ricordare un personaggio centrale per il futuro del Laboratorio: il fedelissimo Giuseppe (zio Pippo) Ferracane, che curava l’amministrazione del nuovo organo ma anche la selezione del personale tecnico che veniva valutato esclusivamente su basi di serietà, fedeltà ed affidabilità. Così titoli per essere assunti potevano essere la capacità di fare un eccellente caffè o quella di saper far ridere senza ricorrere a volgarità. Questo personale così “raccattato” raramente deluderà. 10 2. Le tematiche dovevano essere innovative, di frontiera e strettamente collegate al territorio. Ed essendo il territorio vulcanico e vicino al mare, due progetti venivano proposti, ed imposti, per tentare di conoscere la vita in condizioni estreme (Batteri Termofili) e quella presente nei fondali marini (Sostanze Naturali da Organismi Marini). Entrambe le tematiche rapidamente conquisteranno grande credibilità internazionale ed influenzeranno le scelte scientifiche di numerosi nuovi gruppi sia in Italia che all’estero. Dopo 32 anni, l’ICMIB è ancora su queste linee di ricerca un costante punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale. Altra sorprendente intuizione fu la fiducia per le grandi apparecchiature in un periodo in cui il ricercatore conosceva solo la chimica della provetta. Nel Laboratorio si vorrà installare subito il primo, in Italia, spettrometro NMR operante a 100 MHz e, dopo poco, uno spettrometro di massa a doppio fascio. Inoltre, l’Istituto volle anche competenze in cristallografia che furono assicurate da Raffaella Puliti. 3. I confini delle ricerche nel nuovo istituto non dovevano avere delimitazioni geografiche. Per meglio monitorare questa internazionalizzazione della ricerca era opportuno inserire nel Consiglio Scientifico personalità di grande autorevolezza internazionale. Edgar Lederer e John Bu’Lock diedero subito prestigio e credibilità internazionale al nuovo laboratorio. Inoltre, la loro azione influenzerà direttamente l’attività scientifica dei due principali gruppi di ricerca suggerendo temi di ricerca innovativi ed impegnandosi, personalmente o con i propri collaboratori, per la loro soluzione Alle “intuizioni” di Nicolaus seguirono le ”azioni” di Minale. Luigi Minale immediatamente divenne il braccio operativo nel nuovo laboratorio. Il suo rigore porterà il laboratorio a posizioni di assoluto prestigio internazionale che non furono limitate alle tematiche nelle quali era direttamente impegnato. Dal 1973 al 1981, con Minale Direttore dell’ICMIB, e dal 1981 al 1985, con la Direzione De Rosa, molti ricercatori dell’ICMIB conquistarono prestigiosi riconoscimenti personali. Minale, De Rosa e Sodano raggiunsero ambite posizioni accademiche ed i loro trasferimenti avrebbero potuto provocare una crisi nell’ICMIB. Infatti, più del 90% dei lavori pubblicati tra il 1968 ed il 1985 avevano, come autore di riferimento, uno di questi tre ricercatori. Ma, sorprendentemente, inizia dal 1986 una costante crescita scientifica che porterà l’ICMIB ad essere, negli anni ’90, uno dei più produttivi tra gli organi CNR afferenti al Comitato per le Scienze Chimiche. In realtà, dal 1984 al 1988 numerosi nuovi ricercatori (Gavagnin, Motta, Trincone, Lama, Spinella, Lanzotti e Di Marzo) vengono assunti, aggiungendosi ai pochi incrementi degli anni precedenti: Riccio (1973), De Rosa S. (1969), Nicolaus (1982). Comunque, ulteriori trasferimenti si avranno verso la fine degli anni ’80 ed agli inizi degli anni ’90 (Lanzotti, Riccio e Spinella), mentre le assunzioni rimarranno bloccate fino al 1999. Nonostante le precarietà strutturali, il blocco delle assunzioni ed il sempre maggior contenimento dei finanziamenti ordinari, l’ICMIB riuscirà, negli anni ’90, ad esprimere le proprie potenzialità nel modo migliore. E’ doveroso ricordare il prezioso lavoro svolto dal Consiglio Scientifico dell’ICMIB che, in particolare sotto la guida del Prof. Lorenzo Mangoni, è stato sempre attento nel favorire i cambiamenti evitando imposizioni traumatiche. La conservazione ed il potenziamento della produttività scientifica furono tutelati migliorando l’equilibrio tra l’esperienza dei ricercatori più anziani e l’entusiasmo di quelli più giovani. Dopo una lunga fase di preparazione, nel 1993, il Consiglio Scientifico dell’Istituto sollecitava una revisione della 11 rete scientifica interna chiedendo un maggior coinvolgimento di tutte le componenti. Tutti i ricercatori dell’ICMIB venivano direttamente responsabilizzati sulle proprie linee di ricerca mentre quelli più esperti assumevano su se stessi gran parte degli oneri organizzativi. Tutto ciò veniva realizzato continuando ad operare nella sede provvisoria del 1968! Rapidamente, la nuova organizzazione ha con i fatti respinto le giustificate preoccupazioni di eccessiva parcellizzazione. La produzione scientifica s’impennava e contemporaneamente numerosi contratti attivi nazionali ed internazionali venivano assegnati a ricercatori dell’ICMIB. L’Istituto sempre più assumeva un ruolo di riferimento per la comunità scientifica internazionale. Numerosi ricercatori stranieri (almeno 30) hanno voluto perfezionare la loro formazione sotto la guida dei ricercatori dell’ICMIB dando prestigio all’Istituto ma anche evidenziando le carenze storiche per: 1) sede; 2) personale; 3) finanziamenti. Finalmente! Alla fine degli anni ’90, il trasferimento nella nuova sede sembra realizzato ed, inoltre, viene cancellato il blocco delle assunzioni. Sette nuovi (anche se precari da molti anni) ricercatori/tecnologi verranno assunti tra il 1999 (Amodeo, Ciavatta, Fontana) ed il 2001 (De Giulio, Mollo, Strazzullo, Villani). Contemporaneamente, altre assegnazioni permettono di sanare quasi completamente le situazioni di precariato, sottoinquadramento ed avanzamenti di carriera esistenti in Istituto. Ci sarà spazio anche per il potenziamento, prevedendo l’assunzione di nuovi ricercatori, amministrativi e tecnici. Nel giugno 2001 il trasferimento nella nuova sede è realizzato. La precarietà di Arco Felice s’interrompe dopo 32 anni. La “storia dell’ICMIB” in Arco Felice è stata voluta non per ricordare ma per costruire. Sono convinto che le “intuizioni” di Nicolaus e le “azioni” di Minale sappiano ancor oggi suggerire uno stile per condurre ricerche di frontiera. Guido Cimino 12 I.C.M.I.B in cifre Personale dell’Istituto al 2001 Dirigenti 4 Primi Ricercatori 7 Ricercatori 9 Tecnici 20 Amministrativi 5 Ospiti (retribuiti e non) ca. 20 I lavori pubblicati a tutto il 2001 sono circa 1200 per una media di 35 lavori annui; prodotti, come si racconterà in questo libro, in una sede che è stata riconosciuta disagiata fin dall’inizio della storia di questo Istituto. Il personale dell’Istituto per lunghi periodi non è stato mai numeroso e il grosso del contributo per la produzione scientifica che ha caratterizzato quegli anni, è dovuto proprio all’entusiasmo che appare, oltre che nelle dichiarazioni, anche nei visi dei colleghi. Dagli inizi degli anni ’80 in poi, con l’avvento delle nuove assunzioni si è ogni anno superata la media dei lavori, in alcuni anni addirittura raddoppiandone il valore. Da questi dati possono facilmente essere individuate due fasce corrispondenti probabilmente a due periodi per l’Istituto: il periodo “della creazione” delle tematiche di base della ricerca, dell’acquisto apparecchiature etc. (1968-1984) e il periodo “della produzione scientifica” (1985 – tutt’oggi). La media dei lavori del primo periodo è di circa 20/anno, quella del secondo periodo è 53/ anno. Dal 1969 al 2001 Ospiti stranieri ca. 120 Ospiti italiani c.a. 100 Incarichi di insegnamento ca. 40 Tesi di Laurea 150 Pubblicazioni scientifiche Comunicazioni a congresso 63 2000 63 62 1998 60 44 1996 53 1200 1994 ca. 2000 1992 48 41 46 65 45 1990 55 47 1988 43 Dotazioni finanziarie 1969-2001 Finanziamenti ordinari 51 1986 37 1984 1969 28 266.000.000 26 30 1982 21 1974 90.000.000 23 1980 14 1980 203.000.000 18 1978 17 15 1976 1985 465.000.000 24 20 1974 1990 895.000.000 17 23 1972 17 1995 398.950.000 7 1970 14 3 1968 1999 412.000.000 0 10 20 30 40 50 60 70 13 La fondazione Nell’ambito della Storia del C.N.R. esiste un Istituto Nazionale di Chimica (INC) la cui costituzione risale al 10 luglio del 1936 ad opera di Marconi con direzione affidata a Parravano e la cui dissoluzione risale al 1° marzo del 1945. E’ importante risalire così indietro negli anni per parlare della fondazione del Laboratorio di Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico? La risposta a questa domanda è certamente affermativa se si pensa che una ricostituzione di un secondo INC fu impostata con decreto del Presidente del C.N.R. il 30 marzo del 1963 ed è in questo secondo INC che si intravedono i germogli di quello che fu poi il Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico. A guardar bene in realtà questi germogli erano già preesistenti nel Centro Nazionale di Chimica delle Macromolecole istituito nel 1961 e diviso in otto sezioni di cui due a Napoli. La prima diretta da Paolo Corradini e una seconda da Alfonso M. Liquori. E’ in questo contesto che l’11 febbraio del 1963, un giorno importante per la chimica nel C.N.R., fu firmato, tra gli altri, il decreto di costituzione di un “Centro Nazionale di Chimica delle sostanze naturali”. Per questo Centro si istituirono tre sezioni dirette da A. Quilico (Milano), L. Panizzi (Roma) e R. Nicolaus (Napoli). Tutto il decennio del 1960 in effetti è giudicato di grande importanza per le discipline chimiche nell’ambito del C.N.R.; è durante questo decennio però che la politica del Comitato Scienze Chimiche, che si sviluppa fra Università e C.N.R. non senza qualche ambiguità, porta alla dissoluzione il neo-nato INC nel 1968 e allo sviluppo di una rete di ricerca extra universitaria. Da: Per una Storia del Consiglio Nazionale delle Ricerche a cura di R. Simili e G. Paoloni Editori Laterza 2001 In questo capitolo sulla fondazione del Laboratorio di Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico abbiamo inteso raccogliere alcune testimonianze. La prima di esse, la più importante, ci viene dal prof. R. Nicolaus che in prima persona tratteggia il substrato scientifico sul quale l’idea di un Laboratorio di quel tipo nasce e si sviluppa con intensi rapporti internazionali anche in situazioni disagevoli di collocazione infrastrutturale. Al fine di caratterizzare meglio il periodo in cui il Laboratorio nasceva, nel quadro della politica italiana di allora, ci siamo avvalsi di un articolo di Franco Vegliani, famoso scrittore e giornalista che nel 1970 visitò l’Area di Ricerca di Arco Felice. Nell’ambito delle testimonianze del Laboratorio invece abbiamo riportato un colloquio con il prof. Fattorusso insieme ad alcune notizie ricavate dai primi rapporti di attività scientifica del Laboratorio stesso. Dal tutto si ricava l’idea di una realtà nascente 14 15 Se dovessi raccontarla questa storia potrebbe cominciare col classico: “C’erano un inglese, un austriaco ed un napoletano………..” ma questa non è una barzelletta sulle mosse furbe di un napoletano; cosa è invece siamo andati a chiederlo al napoletano stesso. Un colloquio con il Prof. Rodolfo Nicolaus Professore, quale fu l’origine di un Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico e perché fu decentrato rispetto alla sede universitaria? Un laboratorio multidisciplinare internazionale a struttura collegiale, inteso in senso di college, cioè un vero e proprio campus, per lo studio chimico e fisico delle molecole biologiche non esisteva negli anni ’60 in Italia. Questo tipo di aree di ricerca erano per la verità rare anche all’estero anche se tutte le scoperte biologiche erano venute da laboratori che avevano utilizzato tecniche fisiche e chimiche (IR, UV, NMR, MS, raggi X etc.) per la risoluzione di problemi di tipo biologico. Basti per esempio pensare alla doppia elica di Crick e Watson. L’idea prese corpo quando Adriano Buzzati Traverso e Alfonso Liquori suggerirono di istituire un’area di ricerca biologica avanzata a Napoli. Il 26 Gennnaio del 1967 il CNR decise di istituire una serie di nuovi organi di ricerca; la parte per la Fisica fu affidata al Prof. Eduardo Caianiello e la parte per la Chimica a me. Nel 1968 fui nominato Direttore del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico mentre le strutture edilizie non erano ancora terminate. Nel 1969 il Laboratorio era funzionante. Quante persone facevano parte del suo Laboratorio? I miei studenti appena laureati all’Università o gli studenti migliori di altri colleghi furono contattati e furono felici di prendere parte a questa iniziativa che per loro poteva valere come sistemazione anche dal punto di vista lavorativo oltre che occasione per lo sviluppo dei loro studi. Fra questi anche Luigi Minale che seguiva tutti gli studenti e i tecnici che lavoravano nel laboratorio. Secondo il decreto istitutivo dopo cinque anni l’organico doveva essere composto da un totale di 52 persone di cui almeno 20 ricercatori e 20 collaboratori tra Tecnici e Aiutanti. Il C.N.R. aveva previsto la presenza di un bibliotecario, di un amministrativo e 4 dattilografi. Il Laboratorio si poteva poi avvalere anche di personale esterno nella misura del 20%. Come decideste di organizzare il Laboratorio dal punto di vista della ricerca? Fu creato un ufficio di Direzione di 5 metri quadrati per avere più ampi ed attrezzati laboratori chimici. Furono creati ed attrezzati diversi laboratori chimici. Furono creati i reparti di risonanza magnetica nucleare, spettrometria di massa, analisi e il laboratorio di raggi X quest’ultimo facente capo al Prof. Liquori. Inoltre fu creata la Biblioteca; furono creati i servizi di ospitalità di ricercatori stranieri e la mensa. Molte persone hanno dormito in una stanza appositamente creata che faceva parte del nostro Laboratorio presente in una delle due palazzine. Tra le persone ospitate anche il Prof. Lederer che, ricordo, una mattina ci impressionò per il fatto che all’arrivo dei primi ricercatori non pareva essere presente nella stanza e non si trovava. Dopo un poco giunse dalla vicina campagna prospiciente il Monte Nuovo avvolto in una coperta. Ci disse che non era riuscito a dormire per il rumore dei camion sulla Domiziana, ed aveva cercato ricovero nella vicina campagna che gli appariva promettere maggiore silenzio. Lederer insieme con Bu’ Lock furono le due personalità scientifiche che presero parte al primo Consiglio Scientifico del Laboratorio, chi fece la scelta e su cosa fu basata? Il Consiglio Scientifico fu in pratica nominato da me. Oltre ai due stranieri vi erano anche italiani come il Prof. Mammi inizialmente e poco dopo anche il Prof. Jommi. Per quanto il laboratorio dovesse funzionare come servizio biologico fu scelta anche una propria ricerca. Con Lederer e Bu’ Lock si privilegiò una ricerca rivolta a molecole di interesse biologico facilmente accessibili e tipiche del territorio napoletano. Il Prof. Lederer era all’epoca il Direttore della chimica delle sostanze naturali a Gif sur Yvette ed era una personalità 16 scientifica molto in vista sia nel suo paese che nel resto del mondo. Anche gli interessi del Prof. Bu’ Lock erano molto affini ai miei dell’epoca. John si era interessato di melanine, dei metaboliti da funghi e curava di recente aspetti chimici della microbiologia. I suggeritori delle tematiche di ricerca furono loro. Ricordo che John e Edgar erano persone molto interessanti anche dal punto di vista umano. Ciò che mi ha sempre sorpreso è che Edgar Lederer non abbia ricevuto il premio Nobel. Nacquero in questo modo la chimica e fisica dei batteri termofili e degli organismi marini. Ci furono problemi inattesi della nuova sede di Arco Felice? Se si ne vuole parlare? Si certo, gli insediamenti dovevano essere provvisori. Tutta la zona era molto decentrata e disagevoli erano i contatti con l’Università. Guardi, le mostro un articolo pubblicato su di una rivista dell’epoca “Successo”; è il numero dell’Agosto del 1970. Troverà in esso molte informazioni al riguardo. DOVE ERAVAMO dal rapporto del Direttore (R. Nicolaus) del 1969 ...il laboratorio occupa due palazzine di una area dove si trovano anche il Laboratorio dei Polimeri diretto dal Prof. Ciferri , il Laboratorio di Cibernetica, diretto dal Prof. Caianello (in allestimento), il Laboratorio di Embriologia diretto dal Prof. Monroj. Le palazzine sono denominate D ed E. Parte della palazzina E è occupata dal Prof. Ciferri in attesa che gli venga assegnato un proprio laboratorio. Palazzina D (colonne in verticale); Palazzina E (riga orizzontale). Al primo piano si trovano: A) Ufficio di Direzione B) Segreteria C) Una biblioteca per 3000 volumi e con una capacità massima di 5000 volumi. Il locale è anche attrezzato per le riunioni del Consiglio Scientifico per seminari con una capacità di 80 persone. Viene normalmente utilizzato anche dal personale di altri laboratori D) Piccola aula per seminari capacità 25 persone. E) Ufficio per la documentazione, biblioteca, relazioni con l’estero F) Ufficio per la documentazione fotografica e per il disegno tecnico G) Ufficio per i ricercatori e tecnici del reparto di risonanza magnetica nucleare H) Stanzetta per gli ospiti e i ricercatori Al piano ammezzato si trovano: A) Ingresso con bacheche per gli avvisi, la pianta del laboratorio, un telefono B) Laboratorio di Chimica completamente attrezzato capace di ospitare 5 ricercatori C) Ufficio per 3 ricercatori D) Ufficio per 2 ricercatori E) Laboratorio di Chimica completamente attrezzato capace di ospitare 3 ricercatori F) Stanza per l’idrogenazione G) Stanza per la spettrofotometria UV ed IR e bilance di precisone Al piano ammezzato si trovano (da completare): A) Laboratorio per lo studio dei batteri termofili capace di ospitare 3 ricercatori B) Ufficio per 2 ricercatori C) Locale con pavimento rinforzato per autoclavi Locale per apparecchi elettronici Al piano terra si trovano: A) Locale per lo spettrometro R.M.N. completamente condizionato, dotato di una saletta capace di sostenere 10 tonnellate per metro quadrato. Vi si trova il primo apparecchio europeo pr lo studio oltre che del protone anche di altri nuclei. B) Camera frigorifera C) Piccola officina D) Piccolo deposito di vetreria e prodotti E) Box per la cromatografia in fase vapore F) Box per l’analisi automatica del C, H, N, e O. G) Box per il liofilizzatore H) Box per l’elettrofiresi ad alto voltaggio Centrifughe, apparecchio per l’acqua distillata, apparecchio per la produzione del ghiaccio 17 Nel primo rapporto di attività del Direttore, Prof. R. Nicolaus, del 1969 c’è una descrizione degli edifici in cui erano ospitati i laboratori, la palazzina D e la palazzina E, di fianco riportata. I vani descritti hanno subito nel tempo adattamenti ad usi diversi più confacenti alle attività che mano a mano si sono svolte. “Il Laboratorio nel 1969 si è principalmente occupato dello studio della struttura, della biogenesi e della distribuzione delle feomelanine; dell’isolamento, struttura e attività biologica dei metaboliti delle Porifere per quel che riguarda il reparto di Sostanze Naturali. I ricercatori del reparto NMR invece si sono occupati di isomerizzazioni conformazionali in cicli medi, di interazioni fra legami ammidici e agenti denaturanti, di fase di valenza secondaria in Da sinistra: Trabucco, Crispino, Esposito, Scognamiglio, Cantilena, S. Sodacomposti modello di polipeptidi, della determinazione dei chemi- no, S. De Rosa, G. Sodano, Gambacorta e Janine Aimì (ospite), nel 1969 nei cal shifts e dei segni delle costanti di accoppiamento in molecole pressi della pal. D. contenenti 15N e dello studio conformazionale di omopolipeptidi in soluzioni organiche. L’attività del reparto Batteri Termofili dal 29 Settembre del 1969 è stata invece centrata sulla ricerca di batteri termofili da fonti naturali (acque termali, fanghi) e sulla purificazione dei ceppi batterici isolati; sulla ricerca delle condizioni ottimali di fermentazione dei microorganismi e sull’indagine circa la composizione lipidica della “parete batterica”. Il rapporto del 1969 si conclude con una serie di relazioni sull’attività di ricerca svolta da diversi ricercatori e professori univeristari nell’ambito di vari progetti presso il Laboratorio di Arco Felice: A. Ballio, G. Marino, V. Buonocore, G. Prota, G. Scherillo, L. Mangoni, M. Adinolfi, R. Caputo, V. Dovinola, R. Scarpati, C. Santacroce, D. Sica, P. Temussi. Dall’Ottobre del 1968 all’Ottobre del 1969 sono stati tenuti 13 seminari, il primo dei quali dal Prof. E. FattoIl Prof. Nicolaus è nato a Napoli nel 1920. E’ stato studente di M. Bakunin, di T. Reichstein e di L. Panizzi. Professore di Chimica Organica dal 1952 al 1982 a Napoli, Roma e Lausanne. Ha fondato il Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico nel 1968. Il Prof. Nicolaus è ancora oggi attivamente all’opera nel campo di studio delle melanine. I risultati ultimi, basati su tecniche chimiche e fisiche molto moderne e sull’uso del computer, sono qui di seguito brevemente riassunti da lui stesso. La melanina, il pigmento nero della pelle e del cervello umano, è presente ovunque, negli ammassi neri degli spazi interstellari, nel terreno, nelle penne dei corvi e nei batteri svolgendo un ruolo che si stenta ancora a comprendere. Tuttavia evidenze teoriche e sperimentali ci permettono ormai di definire la melanina come un conduttore organico. Lo scheletro fondamentale, costituito da un poliene coniugato, alloggia sia elettroni disaccoppiati che buche cariche positivamente bilanciate da contranioni, in un equilibrio dinamico tipico dei semiconduttori, è definito con il termine di radical-polarone. In molte melanine (DHImelanina, adrenalin-melanina, catecol-melanina) è presente cioè il sistema radical-polaronico del nero di acetilene. Gli spettri IR ed EPR rivelano la natura di radicale libero della melanina e permettono di stabilire l’entità degli elettroni disaccoppiati. I controanioni invece permettono di valutare il numero di cariche positive. Calcoli quantomeccanici e studi di modeling moleco- lare ci hanno permesso di comporre il contrasto tra i dati analitici sulla composizione percentuale della sepiomelanina e la sua struttura; contrasto che ha costituito un blocco per l’avanzamento delle ricerche nel campo. Nel lavoro fatto noi proponiamo che la struttura della DHI-melanina sia fondamentalmente costituita da catene formate da unità ripetitive, 5 gem-diolo-indol-6 -one, legate nelle posizioni 4 e 7. Queste catene possono avere due conformazioni a bassa energia, un’elica ed una sheet. La posizione 2 del1’indolo può dar luogo a legami tra i filamenti formando piani e gabbie. Le gabbie spiegano il comportamento tipico delle melanine capaci di legare, ioni, acqua, gas. La struttura proposta per il pigmento cellulare, con il suo sistema radical polaronico del nero di acetilene, ben si accorda con le proprietà mostrate dalle melanine di condurre la corrente elettrica in condizioni biomimetiche. I calcoli quantomeccanici effettuati su una sola spira sono in accordo con l’ipotesi che la melanina sia un semiconduttore con un gap di 1,4 eV molto simile a quello trovato sperimentalmente. Il valore del gap tra la banda di valenza e quella di conduzione corrisponde al colore nero del modello a bande del semiconduttore. Lo studio effettuato concorre a spiegare non solo i comportamenti già noti delle melanine in generale, ma suggerisce nuovi possibili ruoli svolti dal pigmento cellulare. Un conduttore elettrico ad elica in un’area cruciale del cervello potrebbe generare un campo ma- 18 Il Prof. Nicolaus ci ha gentilmente messo a disposizione dal suo archivio personale una rivista del 1970 in cui è presente un articolo di Franco Vegliani che non è possibile riportare per intero; proponiamo la rilettura della parte che riguarda i laboratori di Arco Felice: a distanza di più di 30 anni l’articolo rappresenta la più fedele “foto” dell’epoca che abbiamo avuto tra le mani per la realizzazione di questo libro che ci sorprende per la attualità delle problematiche che vi si agitano. Un gruppo di assistenti attorno al professor Minale, nel Laboratorio per la Chimica e Fisica delle Molecole di interesse biologico, reparto chimica delle sostanze naturali nel Centro di Arco Felice (l’immagine e la didascalia sono quelle originali dell’articolo di Franco Vegliani sotto riportato in parte). Da sinistra: Raffaele Riccio, Luigi Forte, Gennaro Scognamiglio, Salvatore De Rosa, Guido Sodano, Salvatore Forenza, Mario De Rosa, Luigi Minale, Ernesto Mancusi, Antonio Crispino. Da SUCCESSO Milano, Anno XII Agosto 1970 di Franco Vegliani un articolo che descrive nuovi insediamenti scientifici nel meridione d’Italia nel 1970. Siamo ad Arco Felice: alle soglie di Pozzuoli, venendo da Capua per Castel Volturno. Cerchiamo il Centro di ricerca del CNR, il gruppo di laboratori localizzato appunto ad Arco Felice. C’è soltanto un contadino, né giovane né vecchio, che lavora attorno ai tralci della sua vigna, a cui chiedere la strada. La chiediamo con qualche imbarazzo. L’uomo alza la testa, ci guarda senza troppa curiosità e domanda: «Cercate la cibernetica? Ci siete. Basta tornare sulla Domiziana, fare qualche centinaio di metri verso nord. Troverete un cantiere per i lavori della Tangenziale; a quel punto girate a destra e sarete arrivati: la cibernetica è là ». Può sembrare, ed anche essere, un modo troppo disinvolto e troppo episodico per introdurre un discorso che è serio e che non manca di risvolti drammatici sui problemi della politica scientifica, o anche semplicemente della politica scolastica, nelle regioni meridionali. Eppure non dovrebbe essere del tutto insignificante considerare gli effetti indotti nella loro globalità, anche quando si presentano con manifestazioni microscopiche come quella che abbiamo citato. Voglio dire che il ”vivere vicino” a qualche cosa è sempre carico di conseguenze. Anche quando i rapporti sono minimi, addirittura nulli o limitati all’acquisto delle verdure per la mensa, non sarà mai la stessa cosa per un uomo essere cresciuto nella sfera d’influenza di una caserma, di un monastero o anche di uno stabilimento industriale, invece che in quello di un nucleo di attività intellettuali, sia o no un centro di ricerca. In realtà, i laboratori di cibernetica, di embriologia molecolare, dei polimeri, di chimica delle sostanze naturali, che costituiscono il Centro del CNR ad Arco Felice di Pozzuoli, non sono nel loro giusto luogo. Dovevano essere inseriti in un’ ”area napoletana della ricerca”, che non è nata perché le è stato negato lo spazio di cui aveva bisogno. Che c’era, che c’è anzi, e possiamo dire anche dove: nei molti e inutilizzati ettari sui quali avrebbe dovuto sorgere la Mostra d’Oltremare, che non pare abbia un avvenire apprezzabile per le vicende del Meridione: terreni amministrati da un Ente Fiera le cui resistenze né le autorità locali né quelle centrali hanno avuto la forza di vincere. L’insediamento ad Arco Felice, in un gruppo di villette progettate come quartiere residenziale e neppure tutte ultimate, rappresenta dunque un insediamento di ripiego e si definisce come provvisorio. « Anche se – dirà Sandro Aurisicchio, direttore di ricerca nel laboratorio appunto di cibernetica e che, al momento della nostra visita, sostituiva Eduardo Caianello, direttore del laboratorio e promotore del Centro, in viaggio negli Stati Uniti, – anche se si tratta di un provvisorio che corre molti rischi di diventare definitivo. Di trasformarsi in uno di quegli esempi di ”provvisorio-definitivo” che piacciono tanto nel nostro Paese ». Così si entra direttamente e forse 19 anche brutalmente nell’argomento. Perché il Centro di Pozzuoli, per la validità della sua attrezzatura, per la qualità del lavoro che vi si svolge, per la statura scientifica degli uomini che vi fanno parte, può costituire un esempio quasi al limite di quella che potrebbe essere, e non è, per un complesso di ragioni non tutte irrimediabili, la destinazione del Mezzogiorno italiano nel campo degli studi e della ricerca. Gli uomini del Centro con i quali ci siamo incontrati, Alberto Monroj, direttore del laboratorio di embriologia molecolare; Rodolfo Nicolaus, direttore del laboratorio per la chimica e la fisica di molecole di interesse biologico, e Sandro Aurisicchio che abbiamo già citato, parlano infatti all’indicativo quando si tratta del loro lavoro e passano al condizionale quando si tratta di un suo inserimento in un contesto più generale. « Napoli potrebbe diventare uno dei grandi centri della biologia in Europa – afferma Alberto Monroj. – C’è tutto perché questo accada. La splendida tradizione scientifica che risale alla Stazione Zoologica, fondata da un tedesco ma fondata qui, che opera qui dal 1870, che opera da un secolo come polo di attrazione per studiosi di tutto il mondo; il laboratorio di genetica e biofisica che si è acquistato rapidamente una grande reputazione a livello internazionale; il gruppo di biologi dell’Università, che si distingue per la vivacità dei suoi interessi e per la qualità degli studiosi che lo compongono; l’attività dei nostri laboratori che agiscono in sostanza nel campo dell’alta biologia e che hanno precisato la loro vocazione europea stabilendo un accordo con l’Università scozzese di Edimburgo per un corso triennale di biologia dello sviluppo, frequentato alternativamente ad Edimburgo e a Pozzuoli e che conferisce una laurea britannica di ricerca, in attesa che questa laurea venga istituita anche in Italia ». Potrebbe dunque, ma non può. Perché? Il confortante elenco degli elementi positivi fa presto a mostrare le sue crepe. « Manca la coordinazione », dice il professor Monroj. Ma non è solo questo: la Stazione Zoologica è attualmente in crisi, e in crisi, dopo le note vicende che hanno portato Adriano Buzzati Traverso a lasciare Napoli per l’Unesco, è anche il laboratorio di genetica e biofisica; la crisi dell’Università o almeno la rigidità delle sue strutture e la mancanza di fondi sono fatti costituzionali che non risparmiano certo l’ateneo napoletano. Un’impresa pionieristica Ma Napoli stessa è in crisi. Dal punto di vista urbanistico, prima di ogni altra cosa. Perché tra tutte le città italiane, quella in cui l’incontro tra il traffico e le strutture urbanistiche che la metropoli è capace di offrire per il suo scorrimento ha raggiunto un livello drammatico molto prossimo alla intollerabilità, è proprio Napoli. « E alla fine – è la conclusione concorde di tutti e tre i ricercatori, dal momento che è in crisi il Consiglio nazionale delle ricerche, siamo in crisi anche noi ». Equivale a dire, a parte la provvisorietà, l’atmosfera arrangiata dell’insediamento, che la larghezza istituzionale di fondi con cui il Centro è nato perché i suoi laboratori fossero attrezzati in modo perfetto e non mancassero davvero di nulla, vale sempre sulla carta, corrisponde sempre a un diritto, ma in pratica ha perso una grande parte della sua fluidità. E insomma il decollo scientifico, nel luogo del Meridione che appariva, e appare ancora, come il più idoneo a fare da piattaforma di lancio, da pista, nella realtà non è avvenuto o non è ancora avvenuto. L’organizzazione più nuova e più perfetta, quella che possiede gli strumenti più preziosi, stenta a collegarsi con le altre, anche con le più disposte a un lavoro complementare o integrato come l’Università, persino sul piano più banale delle comunicazioni stradali, del materiale andare e venire in automobile o con un mezzo pubblico. E agisce in un ambiente che rivela ad ogni passo i segni di un’impresa pionieristica. Entusiasmante forse per chi guardi alla ricerca e ai suoi protagonisti da un punto di vista romantico. Deprimente, invece, per chiunque abbia la consapevolezza che in questa materia l’avventura esiste, ma è altrove. E’ sulle frontiere dell’ignoto, sulle barriere del mistero che si cerca di penetrare, e non su quelle di una vita quotidiana avventizia e di una battaglia di ogni ora anche per la semplice sopravvivenza. Nel senso di unità scientifica, intendo. « Madame Curie e suo marito hanno scoperto il radium in un garage. Anche noi siamo nel nostro garage. Io non ho false modestie, io affermo che il nostro lavoro ha un contenuto qualitativo altrettanto valido. Ma affermo anche che ci sono le condizioni perché dal garage si possa uscire, perché si possa lavorare più a nostro agio. E che se questo non accade, non è certo per colpa nostra ». Così dice Rodolfo Nicolaus. Ma è forse ancora più patetico l’unico impiegato amministrativo di cui il Centro dispone, prestato al CNR da un’altra amministrazione, quando mi accompagna in giro per il villaggio della ricerca, sul brecciame con cui sono pavimentate le strade tra una villetta e l’altra, e mi porta a vedere l’intreccio di filo allo scoperto di un centralino telefonico improvvisato, i tombini ancora scoperchiati, i lavori in muratura finiti e non finiti, le opere di abbellimento che hanno ancora tutta l’aria di un tentativo. « Guardi qui – dice –, questo filare d’alberi ». Sono giovani pini italici piantati lungo la rete di recinzione, che dovranno dare ombra alle case e 20 cominciare a fornire un gradevole aspetto di giardino allo squallore della spianata che le ruspe avevano preparato per la costruzione delle villette. « Li abbiamo fatti piantare noi. Ce li ha forniti un vivaio qui vicino. Ma a credito. Quando arriveranno i soldi, li pagheremo ». E aggiunge che la fiducia della gente, là attorno, è piena e confortante, che il credito è generoso, che il centro è ”creduto”. « Non sanno esattamente quello che facciamo, ma vedono che lavoriamo e ci guardano con simpatia ». Il discorso Franco Vegliani http://www.editions-verdier.fr/italie/auteurs/vegliani.htm Né à Trieste en 1915, Franco Vegliani est mort à Milan en 1982. Sa mère était triestine et son père originaire de Fiume (aujourd’hui Rijeka, en Slovénie). Son nom réel, Sincovich, fut transformé en Vegliani dès le milieu des années trente en hommage à la petite île de Veglia, où il passa une partie de son enfance avant d’entreprendre des études à Fiume et de les achever à l’université de Bologne, où il rencontra Giorgio Bassani. Mais ces études de droit ne l’empêchent nullement de se consacrer à d’intenses lectures : les classiques grecs, Conrad et Italo Svevo. Journaliste à Milan, il sera envoyé spécial, puis rédacteur, du Tempo, et travaillera pour divers journaux et magazines. Son drame personnel sera de ne pouvoir imposer son œuvre de son vivant, malgré le jugement très positif émis par Claudio Magris sur son roman La frontière (La frontiera), publié une première fois en 1964 et réédité en 1988 : « Franco Vegliani est l’auteur d’un roman riche de mélancolie et de poésie quintessenciée, La Frontière, un des plus beaux livres de la littérature triestine de l’après-guerre, mais il ne fut pas une figure de cette dernière. » En 1972, il avait fait paraître La carta coperta (Le Papier caché), tandis que demeure inédit son récit historique Catilina et que ses juvéniles Lettere in morte di Cristiano Bess (Lettres pour la mort de Cristiano Bess) ont été publiées par sa veuve de façon posthume dans une édition hors-commerce. Enfin, de brèves Storie di animali (Histoires d’animaux) sont parues, totalement inédites, en 1991. La storia in pillole 26 Gennaio 1967 Art. 1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degi organi di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con D.P.C.M. 26 Gennaio 1967, il Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico. Il Laboratorio ha sede in Napoli. 21 Settembre 1973 Provvedimento del Presidente del C.N.R. n. 3664 relativo alla cessazione di incarico di Direttore del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico del Prof. Rodolfo A. Nicolaus a far data dal 31 Agosto 1973 ed alla nomina del Prof. Luigi Minale a Direttore del Laboratorio per la Chimica Fisica di Molecole di Interesse Biologico stesso a far data dal 1 Settembre 1973. 16 Maggio 1974 Provvedimento del Presidente C.N.R. n. 3938. La denominazione del Laboratorio per la Chimica e Fisica di molecole di Interesse Biologico - Arco Felice è così modificata: LABORATORIO PER LA CHIMICA DI MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO. 19 Dicembre 1979 Decreto del Presidente n. 6300: I laboratori di cui all’allegato al presente provvedimento assumono la denominazione di Istituti. Allegato: Laboratorio per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico - Napoli PASSA A Istituto di Chimica di Molecole di Interesse Biologico - Napoli 15 Gennaio 1980 Direzione Mario De Rosa: dal 15 Gennaio 1980 al 25 Giugno 1980 (direttore pro-tempore); dal 1 Luglio 1981 al 26 Novembre 1985 26 Novembre 1985 Direzione Guido Cimino. Dal Novembre 1985 al 1 Luglio 1986; dal 1 Luglio 1986 al 30 Giugno 1990 (primo mandato); dal 1 Luglio 1990 al 30 Giugno 1992 (secondo mandato) dal 1 Luglio 1992 al 30 Giugno 1996 (terzo mandato); dal 1 Agosto 1996 al 31 Luglio 2000 (quarto mandato); dal 1 Agosto 2000 a tutt’oggi. 22 Gennaio 2001 Provvedimento Ordinamentale n. 15773 “...Considerato che il Consiglio direttivo, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Comitato di consulenza scientifica su richiesta dello stesso Consiglio direttivo, ha deliberato, in data 25 maggio 2000 (deliberazione n.165), in data 21 giugno 2000 (deliberazione n. 192), nonché in data 20 dicembre 2000, la costituzione dell’Istituto di chimica biomolecolare, risultante dall’accorpamento dei seguenti organi di ricerca: Istituto di chimica di molecole di interesse biologico - Napoli; Istituto per l’applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici Sassari; Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico – Valverde (CT); Centro di studio sui biopolimeri – Padova; Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali Roma - Visto lo schema tipo di decreto presidenziale di costituzione dei nuovi Istituti, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo del 21 giugno 2000 (deliberazione n. 190); DECRETA Art. 1 Denominazione e sede 1. E’ costituito l’Istituto di chimica biomolecolare……2. L’istituto ha sede a Napoli…...” 21 Un colloquio con il Prof. Fattorusso Professor Fattorusso ci racconta qualcosa delle sue prime esperienze al Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico? Nel 1968 per prima volta sentii parlare del MIB, quando Nicolaus mi informò di una iniziativa del CNR per la creazione a Napoli di un grosso centro di ricerca in cui era prevista una sezione per lo studio avanzato della Chimica delle Sostanze di interesse biologico. Al progetto erano interessati alcuni influenti docenti di discipline chimiche, fisiche e biologiche dell’Ateneo napoletano, che in quegli anni viveva una stagione particolarmente agitata con frequenti contestazioni, occupazioni e scioperi. Un centro di ricerca lontano dalle tensioni del mondo universitario appariva allora una occasione unica per chi nella ricerca credeva ancora. Forse fu per questo motivo che il progetto andò avanti affrontando in primo luogo il grosso problema della localizzazione della sede. Tra le varie ipotesi prospettate si realizzò l’insediamento ad Arco Felice utilizzando un complesso di piccoli edifici che erano stati costruiti come villette di tipo turistico. Ricordo che, quando agli inizi del 1969 Nicolaus condusse Gigi Minale e me a visitare questo piccolo complesso turistico, in cui si stava già insediando il laboratorio di Cibernetica di Edoardo Caianiello, la sistemazione ci apparve non entusiasmante. Si disse, però, che questo doveva essere considerato un insediamento temporaneo, per poi realizzare, entro breve tempo, la costruzione della sede definitiva in un’altra zona dell’area flegrea. A parte la sede definitiva, in quella sede provvisoria le attività iniziarono? L’attività ad Arco Felice iniziò nella seconda metà del ‘69, dopo che nella prima delle due villette assegnate al MIB furono sistemati i banchi di lavoro e la strumentazione indispensabile per avviare la ricerca. Il gruppo di lavoro era costituito da un nucleo preesistente, che si spostava dall’Istituto di Chimica Organica dell’Università, formato, oltre che ovviamente da Rodolfo Nicolaus, direttore del MIB, che aveva avuto il merito di proporre e di realizzare la sua costituzione, da Gigi Minale, Silvana Magno, Guido Cimino, Salvatore De Stefano e da me. Gigi, Guido e Salvatore, ricercatori del centro CNR esistente presso il nostro Istituto, entrarono a far parte dell’organico del MIB, Silvana ed io eravamo dipendenti dell’Università, distaccati con un incarico di collaborazione gratuito. Utilizzando i ruoli assegnati al MIB furono assunti alcuni giovani laureati e cioè Guido Sodano, Enrico Trivellone, Agata Gambacorta e Mario De Rosa. Contemporaneamente furono coperti in breve tempo i ruoli del personale tecnico ed amministrativo. Tra i tecnici ricordo Antonio Crispino, Gennaro Scognamiglio, Alfonso Cantilena, Antonio Trabucco ed Enrico Esposito e, successivamente, Vincenzo Calandrelli; tra gli amministrativi la signora Vaccaro e Turco. L’attività scientifica partì immediatamente su un tema di ricerca, le feomelanine, su cui si lavorava da tempo nel laboratori dell’Istituto di Chimica Organica dell’Università, nell’ambito delle ricerche sulle melanine, su cui Nicolaus ed il suo gruppo avevano ottenuto, nel corso di alcuni decenni, risultati di assoluto rilievo internazionale. Quindi la sede cominciò tuttavia a funzionare. Ma gli argomenti di ricerca si limitarono a quelli che precedentemente sviluppavate all’Università? Oltre che all’attività di ricerca tutti ci impegnammo, nei limiti delle nostre competenze, ad attivare le strutture di base del laboratorio, quali la biblioteca (di cui mi interessai), i laboratori di spettroscopia analitica, l’officina ecc. Mettemmo su anche una miniforesteria costituta da un’unica stanza da offrire ad ospiti del laboratorio. La ricerca sulle feomelanine rappresentò solo un avvio della attività scientifica del MIB, che, invece, secondo un opinione praticamente condivisa da tutti, doveva in breve tempo avviare ricerche nuove, che caratterizzassero e qualificassero il nascente laboratorio. Di tale opinione era soprattutto il Consiglio Scientifico del MIB; questo organismo rappresentò allora, come penso sia avvenuto anche in seguito, un punto di forza del MIB. Il merito dell’ottimo funzionamento del Consiglio Scientifico, come guida e controllo dell’attività di ricerca del laboratorio, fu sicuramente di Nicolaus, che, da Direttore, si adoperò affinché ne facessero parte personalità prestigiose. Non si costituì, cioè, come purtroppo avveniva per altri Laboratori, un organismo composto da amici del Direttore, ma si realizzò uno strumento autonomo ed autorevole, preziosissimo per il futuro sviluppo del MIB. Del Consiglio scientifico facevano parte eminenti studiosi come Edgar Lederer, direttore del famoso Istituto CNRS di Gif sur Yvette e John Bu’Lock dell’Università di Manchester. 22 Questi componenti stranieri del Consiglio Scientifico diedero un grosso contributo all’avvio di attività scientifiche innovative. Lei rammenta questi aspetti? Se ricordo bene, fu proprio John Bu’Lock a suggerire di intraprendere ricerche legate al territorio: la chimica degli organismi marini, dove si poteva utilizzare un collegamento con la Stazione Zoologica e la chimica dei Batteri termofili presenti nella Solfatara di Pozzuoli. Gigi ed io fummo attratti dall’idea di studiare gli organismi marini, anche se ignoravamo la letteratura esistente sull’argomento. Decidemmo allora di documentarci; passammo circa due mesi (solo di mattina) nella biblioteca della Stazione Zoologica a studiare. Alla fine realizzammo che sul metabolismo secondario degli organismi marini era riportato pochissimo in letteratura. Questo poteva significare due cose: i) i metaboliti secondari erano poco diffusi tra gli organismi marini; ii) i ricercatori avevano trascurato i metaboliti secondari marini e si erano concentrati solo su quelli terrestri. Nel primo caso affrontare una ricerca di questo tipo avrebbe avuto poche prospettive di successo, nel secondo caso invece avrebbe potuto aprire un ottimo filone di ricerche. Decidemmo di provare. Fu abbastanza coraggioso da parte vostra impegnare la vostra attività scientifica in un filone “al buio” pieno di possibili prospettive ma anche ricco di rischi. Decideste di provare; quali furono le scelte iniziali? Sorse allora il problema su quale materiale biologico iniziare il lavoro. Ci parve conveniente partire dallo studio di qualche pigmento marino, in quanto entrambi avevamo una ottima esperienza nel campo della chimica dei pigmenti naturali (tutti e due eravamo allievi di Nicolaus, un’autorità nel campo). Dopo attento studio della letteratura la scelta cadde su due pigmenti a struttura incognita di cui era stata segnalata l’esistenza; entrambi potevano essere estratti da organismi reperibili nel golfo di Napoli: la calliactina dell’antozoo Calliactis parasitica ed un pigmento giallo della spugna Aplysina aerophoba. Ricordo che di quest’ultimo composto si parlava in un capitolo (brevissimo) dedicato alla chimica dei Poriferi in un volume delle serie “Chemical Zoology”. Aplysina aerophoba Da un tecnico della Stazione Zoologica addetto al reperimento di organismi marini nel Golfo di Napoli riuscimmo ad ottenere una quantità notevole (alcuni chili) di Aplysina aerophoba. Alla nostra iniziativa si aggregò Guido Sodano (Guido Cimino, che all’epoca faceva il servizio militare, si unirà al nostro gruppo al rientro) e così partimmo all’isolamento del pigmento giallo, dopo averlo estratto con l’aiuto prezioso di Crispino. Fu un disastro. Perché? Il pigmento scompariva inesorabilmente durante il processo di purificazione su colonne di silice e di allumina. Guido, però, che era un osservatore attento ed intelligente, notò che da alcune frazioni cromatografiche si formava, durante il processo di evaporazione del solvente, un precipitato bianco che appariva abbondante e cristallino. Sul prodotto furono fatti gli spettri IR ed NMR. Noi allora non avevamo molta esperienza in spettroscopia interpretativa: lo studio delle melanine, materiale insolubile e non omogeneo su cui avevamo lavorato negli ultimi anni, non poteva utilizzare l’analisi spettroscopica. Avevamo però a disposizione un ottimo apparecchio (per allora), l’NMR Varian HAQ-100, che Nicolaus aveva deciso di acquistare prioritariamente; questa fu un’altra delle scelte felici di Nicolaus che influì molto positivamente sullo sviluppo del MIB. Cosa venne fuori? Con l’aiuto di Enrico Trivellone facemmo i primi spettri NMR; successivamente avemmo lo spettro di massa eseguito sullo spettrometro AEI MS9 che si trovava presso il Centro di Spettrometria di massa dell’Università. Nonostante la nostra inesperienza, capimmo che si trattava di una sostanza nuova contenente bromo, a cui successivamente avremmo dato il nome di aerothionina. Quasi contemporaneamente isolammo dalla stessa spugna un altro nuovo prodotto, battezzato in seguito aeroplysinina. Iniziò allora la nostra prima indagine di determinazione strutturale su metaboliti marini. La ricerca sulla aerothionina la portammo a termine in collaborazione con il gruppo di Thomson dell’Università di Aberdeen (Scozia). 23 Si, in questo libro si racconta di numerosi contatti internazionali fin dall’inizio dell’attività scientifica. Vorrei raccontare qualcosa su questa collaborazione, perché mi permette parlare del Prof. Thomson dell’Università di Aberdeen, un ottimo ricercatore, un uomo correttissimo ed amabile, che ci aiutò parecchio nella nostra nuova attività di ricerca. Egli da tempo si interessava delle melanine ed aveva scritto un’ottima monografia sull’argomento; per tale ragione era da alcuni anni in contatto con Nicolaus ed era venuto come ospite a Napoli presso l’Istituto di Chimica Organica dell’Università. Quando il MIB decise di invitare una serie eminenti ricercatori stranieri con l’obiettivo di inserire il laboratorio nel circuito dei buoni laboratori internazionali di ricerca sulle Sostanze Naturali, Ron Thomson fu tra i primi ad essere invitato e venne ad Arco Felice quando la ricerca sull’aerothionina era partita da qualche mese. Può apparire incredibile, ma nel nostro incontro ci accorgemmo che, indipendentemente, ad Arco Felice e ad Aberdeen era venuto in mente di lavorare sulla aerothionina. Nel corso di una riunione di lavoro che durò una mattinata confrontammo i risultati ottenuti fino ad allora dai nostri gruppi: noi avevamo accumulato una serie di dati NMR e MS; altri dati spettrali, integrati da studi degradativi erano stati ottenuti ad Aberdeen. Al termine della discussione noi, utilizzando anche i risultati ottenuti dal gruppo di Ron, proponemmo una ipotesi di struttura che, successivamente, si rivelò esatta. Decidemmo allora di riunire le forze e di comple- Pausa pranzo ai Damiani …anni dopo. Da sinistra: Trabucco, G. Sodano, Gambacorta, tare il lavoro in collaborazione. Pubblicammo la nota preliminare sull’aerothionina Esposito su Chemical Communication del 1970 (il lavoro definitivo fu pubblicato su J. Chem. Soc. del 1972). Sullo stesso fascicolo di Chemical Communication fu pubblicata una nota, cui non partecipò Thomson, sull’altro metabolita della spugna, l’aeroplysinina. L’aeroplysinina e l’aerothionina furono i primi due prodotti marini isolati da noi e di cui determinammo la struttura. Il successo ottenuto ci spinse a proseguire sulla chimica delle spugne, anche perché avevamo stabilito un contatto con il Prof. Sarà di Genova, zoologo esperto dei Poriferi di prestigio internazionale; con il suo aiuto ci avvicinammo alla biologia delle spugne e ci avvalemmo di lui per la identificazione delle specie sotto indagine. Io andai a Genova per contattarlo e qualche settimana dopo Egli tenne un seminario ad Arco Felice. Ricordo che Gigi ed io eravamo così sprovveduti in biologia da chiedergli perché le spugne erano da considerarsi degli animali; egli ci rispose: provate a lasciare per qualche giorno una spugna all’aria e avvertirete il classico cattivo odore di un animale che va in putrefazione. Pietro De Luca e Raffaele Turco di fronte con altri studenti nel 1970 Bene. Il filone era aperto e appariva anche promettente. Ci furono altri risultati che vuole ricordare? Ben presto nuovi composti di natura furanoterpenica furono isolati da alcune spugne appartenenti all’ordine delle Dictyoceratidae del genere Spongia ed Ircinia. Eravamo entusiasti dei risultati ottenuti. Cominciammo a darne comunicazione in Congressi e Seminari. Gigi parlò a Salice Terme nel Maggio del 71 al V Convegno Nazionale di Chimica Organica della Società Chimica Italiana. Io tenni nell’Ottobre del 71 due Seminari in Università della Gran Bretagna, uno ad Aberdeen e l’altro a Manchester. Dai nostri contatti nazionali ed internazionali e dai consensi ed incoraggiamenti ottenuti derivò la sensazione che il nostro lavoro fosse apprezzato dalla comunità scientifica dei chimici delle sostanze naturali. Questo ci gratificò molto e contribuì a creare un ambiente di lavoro gradevolissimo. I rapporti umani tra noi ricercatori, i numerosi studenti che lavorano alla tesi ad Arco Felice, tra i quali vi erano Lello Riccio, Pietro De Luca, Giordano Martone, Salvatore Forenza e Franco Cafieri, i tecnici e tutto il personale Manifesto della Stazione Zoologica di Napoli 24 Le Direzioni dell’Istituto Le Direzioni che si sono avvicendate, prima al Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico e poi all’Istituto sono dettagliate nella “Storia in pillole” nel capitolo “La Fondazione” dove sono anche ricordati vari momenti salienti della storia dell’Istituto tra cui i decreti per il cambio di nome e l’istituzione dell’Istituto di Chimica Biomolecolare. Tutti i direttori hanno da sempre messo in evidenza alcune carenze della sede e altri problemi connessi allo svolgimento dell’attività di ricerca. Nel colloquio con il Prof. Nicolaus egli ha tenuto ad evidenziare le promesse di ampliamento della pianta organica del Laboratorio non mantenute dal C.N.R. Per quanto riguarda le ultime due direzioni, quella del Prof. Mario De Rosa e quella del Dr. Guido Cimino, appare interessante a questo riguardo proporre la rilettura di quanto scrivevano rispettivamente nel Rapporto di attività del 1981 ed in quello del 1986 che rappresentano i momenti iniziali delle due rispettive Direzioni. Di seguito sono riportati alcuni momenti delle direzioni Minale e di De Rosa Rapporto di attività - Mario De Rosa 1981 PREMESSA In qualità di Direttore dell’istituto di Chimica M.I.B., mi corre l’obbligo, nella presentazione del consuntivo scientifico per l’anno 1981, di mettere in evidenza gravi problemi che provocano difficoltà al corretto sviluppo dell’attività di ricerca, la quale fino ad oggi non è stata compromessa solo grazie all’impegno del personale dell’Istituto. A) Carenze delle strutture dell’Istituto L’Istituto M.I.B. ha come sede provvisoria, da ormai 13 anni, due palazzine site nell’Area di Ricerca di Arco Felice. Questi edifici furono concepiti per civili abitazioni ed il loro uso, come laboratori di ricerca, ha comportato non pochi compromessi. Oggi questa situazione è aggravata da una generalizzata fatiscenza delle strutture, su cui per molteplici ragioni non si sono mai effettuati nel passato interventi di risanamento. Questa grave situazione ha portato negli ultimi mesi del 1981 all’intervento delle autorità competenti….[che riscontrando gravi irregolarità]...hanno elevato contravvenzioni alle direzioni imponendo (120 giorni) con rapidità una serie di interventi atti a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. B) Assunzioni Nonostante la nuova pianta organica dell’Istituto preveda l’acquisizione di 18 unità lavorative, ad oggi solo uno dei concorsi è stato bandito. Va sottolineato che questa situazione è tanto più grave, se si considera che praticamente dalla sua costituzione l’organico dell’Istituto non ha subito significative integrazioni. Questo ha causato un aumento dell’età media del personale inaccettabile in una struttura di ricerca in evoluzione….. [per la gestione amministrativa]...per 13 anni essa è stata affidata a solo due archivisti dattilografi… C) Grandi apparecchiature All’istituto M.I.B. negli scorsi anni sono state assegnate due grandi apparecchiature: uno spettrometro di massa ed un apparecchio NMR da 500 MHz. Queste nuove e Rapporto di attività - Guido Cimino 1986 Nel presentare la relazione sull’attività ordinaria svolta all’I.C.M.I.B. nel 1986 volutamente tralascio qualsiasi commento sull’attività scientifica lasciando all’analisi dei dati oggettivi ogni valutazione. ...ma perdurando le condizioni di disagio, si corre il pericolo di danneggiare irreversibilmente quanto di positivo è stato finora realizzato. Pertanto è indispensabile che, in tempi brevi, alle più che leggittime attese siano date risposte adeguate. Dopo questa necessaria premessa, ritengo opportuno fare alcune considerazioni in merito: 1) 2) all’attività all’interno dell’I.C.M.I.B. alla sua collocazione all’interno dell’Area di Ricerca di Napoli Attività all’interno dell’I.C.M.I.B. Il 1986 ha visto profondi cambiamenti, il Prof. Mario De Rosa che dal 1981 ha guidato con competenza e sicurezza l’Istituto, a causa di subentrati impegni universitari, ha lasciato nei primi mesi dell’anno la direzione dell’Istituto. Contemporaneamente anche il Prof. Guido Sodano, da sempre una delle personalità scientifiche di maggior rilievo dell’Istituto, ha preso servizio quale professore straordinario presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Potenza. …. Posizione dell’I.C.M.I.B. l’interno dell’Area di Ricerca di Napoli Dal 1978 l’ex Merrel è ritenuta l’unica sede che, in tempi brevi, avrebbe potuto offrire un’adeguata soluzione logistica all’I.C.M.I.B. A questa soluzione tutto il personale ha finora lavorato con rigoroso impegno, rispondendo a tutte le richieste e suggerendo più volte razionali occupazioni degli spazi…..ciononostante fino ad ora poco è stato realizzato e i tempi per l’attuazione del trasferimento rimangono fissati in due-tre anni. Spero fermamente che almeno a me non debba toccare, come già successo per i Direttori che mi hanno precedu- 25 Per quel che riguarda il periodo della Direzione del prof. Nicolaus gran parte delle cose sono state dette da lui stesso nel colloquio che abbiamo avuto mentre altre, a conferma di quanto egli diceva, sono rintracciabili nella testimonianza del Prof. Fattorusso nell’articolo di Franco Vegliani e in gran parte dei ricordi delle persone che ancora vivono in Istituto. Il prof. Nicolaus è stato il Direttore del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico dalla sua creazione, il 26 Gennaio del 1967, fino al Settembre del 1973; quello che rappresenta, se si guarda al grafico delle pubblicazioni scientifiche per anno, l’inizio del periodo della “creazione”. Superato lo stupore iniziale di dover fare ricerca chimica in villette di tipo turistico poi la si è fatta davvero: si è dato spazio alla creazione di efficienti laboratori chimici con attrezzature d’avanguardia che hanno permesso ai giovani di allora di acquisire familiarità con le tecniche più moderne dell’indagine strutturale usandole in modo efficiente per le loro ricerche. Come testimoniato dai rapporti di attività e dai ricordi di tutti, il periodo della direzione del prof. Nicolaus è stato inoltre caratterizzato da intensi rapporti internazionali. Questi sono significativamente espressi nella scelta dei due componenti stranieri del Consiglio Scientifico ma sono stati anche primariamente costituiti dalla quotidianeità dei numerosi seminari tenuti in Istituto e dalle collaborazioni scientifiche internazionali che grazie ad essi vi si instauravano e che portavano, a mano a mano, i ricercatori ad essere proiettati sulla scena internazionale data anche l’innovatività del contributo scientifico che tali studiosi stavano apportando. E’ difficile dire se la volontà di “creazione” sia stata solo provocata da un escaping dall’Università, che stava attraversando gli anni della contestazione studentesca, o se ciò fosse dovuto ad un disegno politico più ampio contenuto dapprima nella riforma del C.N.R. fortemente voluta dal presidente Giovanni Polvani (1960-1965) e continuato poi sotto la presidenza di Vincenzo Caglioti (19651972). “Di fatto, nel 1968, sotto la presidenza di Vincenzo Caglioti vennero istituiti un rilevante numero di nuovi organi di ricerca. Questa politica di espansione del CNR rappresentò un fattore positivo per lo sviluppo di una rete di ricerca extra-universitaria in Italia. Tuttavia la mancanza di una seria programmazione e l’assenza di interventi infrastrutturali adeguati non ne permisero il consolidamento.” (da M.R. Valensise “I settanta anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche 1923-1993, CNR, Roma e da E. Martuscelli La ricerca sui polimeri in Italia IRTEMP-CNR ). All’epoca la prima percezione di questa mancanza fu di Nicolaus come egli stesso evidenzia oggi nelle conclusioni del colloquio che abbiamo avuto con lui. Il 12 Febbraio del 1973 nella riunione del C. S. il prof. Minale, rispondendo al prof. Crescenzi -il quale aveva chiesto informazioni circa la direzione del laboratorio- riassume la situazione “…. ricordando che il prof. Nicolaus ha inoltrato al presidente del C.N.R. (e per conoscenza al prof. Monroy, presidente del Comitato di Coordinamento dell’Area di Ricerca di Arco Felice), una lettera in cui dichiara la propria indisponibilità ad una eventuale riconferma nella direzione del laboratorio.” Nello stesso anno, il 18 aprile, nella riunione del successivo C.S. il prof. Lederer propose di scrivere al C.N.R. per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore e del rinnovo del Consiglio Scientifico stesso “...il C.S. di questo laboratorio,...preso atto della lettera...del prof. Nicolaus del 17 aprile del 1973 indirizzata al presidente del C.S., nella quale ribadisce la sua indisponibilità a mantenere l’incarico della direzione del laboratorio, confermando così le dimissioni espresse nella 26 La Direzione del prof. Luigi Minale durò fino al luglio del 1981 quando egli fu sostituito dal prof. Mario De Rosa, sebbene in precedenza lo stesso Mario De Rosa avesse svolto la funzione di direttore pro-tempore a causa degli impegni universitari e degli incarichi di insegnamento a Mogadiscio del prof. Minale. Uno dei momenti significativi del passaggio della Direzione Minale-De Rosa si rintraccia agevolmente nel verbale del consiglio scientifico del 3 luglio del 1980. In esso si legge: “...Alcune indicazioni sulle persone che possono espletare il compito di dirigere l’Istituto sono già venute nella scorsa seduta del C.S. [il prof. Minale]..aggiunge che nel periodo della sua assenza il dr. Mario De Rosa ha ben espletato il compito di sostituirlo e che questo è stato fatto con la collaborazione di tutto il personale. La sua indisponibilità è irrevocabile a partire dalla scadenza del suo mandato (agosto 1981); non sarebbe tuttavia alieno da interrompere prima qualora se ne ravvisasse la necessità. Nell’esprimere la sua disponibilità ad un futuro rapporto di collaborazione con l’Istituto e nel dichiararsi d’accordo con il principio della rotazione discusso nella precedente seduta del C.S. invita il C.S. stesso a dare un’indicazione sulla persona che dovrebbe cominciare la rotazione.” Dopo una “approfondita discussione nella quale prendono la parola il prof. Bu’Lock, il dr. Trivellone, il prof. Mangoni, il prof. Mammi e il prof. Jommi” il C.S. individua nelle persone di Mario De Rosa e di Guido Sodano due ricercatori dell’Istituto che “attualmente offrono tutte le garanzie per assolvere ai compiti di Direttore, in accordo anche con le segnalazioni dell’attuale Direttore e tenendo conto che il personale è a conoscenza di tali candidature ed ha mostrato il suo gradimento.”. Dopo aver ricordato brevemente i profili curricolari dei due ricercatori e dopo aver registrato la loro disponibilità ed averli segnalati entrambi all’attenzione del Comitato Scienze Chimiche, il verbale si conclude in questo modo: “segnala peraltro che il Dr. De Rosa ha già tenuto protempore la direzione dell’Istituto dal 15 gennaio del 1980 fino al 25 giugno del 1980 con pieno merito e soddisfazione secondo quanto riconosciuto dal personale, dal C.S. e dallo stesso attuale La Direzione Mario De Rosa La crescita scientifica dell’Istituto negli anni 80 e la scelta consapevole di volere un direttore a “tempo pieno” portano ad esprimere, dal personale in staff all’Istituto, il successore a Luigi Minale, chiamato a coprire un ruolo di professore ordinario prima presso l’Università di Catania e successivamente di Napoli. Il testimone tocca ad un giovane ricercatore, Mario De Rosa, responsabile del reparto “Batteri termofili”, una unità di ricerca dovuta alla lungimiranza del compianto prof. J. D. Bu’ Lock, autorevole membro del Consiglio Scientifico. Entrato appena laureato in chimica nell’Istituto da poco fondato, Mario De Rosa e la giovane ricercatrice Agata Gambacorta si dedicano con spirito pionieristico ed entusiasmo allo studio delle forme di vita presenti negli ambienti ad alta temperatura, una tematica, nata come una curiosità scientifica legata alla natura vulcanica dei luoghi. Ma in pochi anni questa ricerca si sviluppa, diventando uno dei punti di forza dell’Istituto, e si rivela ricca di risultati di grande rilevanza scientifica, che trovano nella medaglia Ciamician concessa a Mario De Rosa dalla Chimica Organica italiana il giusto riconoscimento. Già da responsabile del Reparto Batteri Termofili si evidenziano le doti di organizzatore ed il dinamismo di Mario De Rosa, infatti all’attività del piccolo gruppo di ricerca da lui diretto si deve la scoperta del primo organismo appartenente alla terza linea evolutiva della vita sul nostro pianeta, l’archeobatterio Caldariella acidofila, un nome che riecheggia la sua paternità napoletana. Successivamente la scoperta in questi microrganismi di nuove tipologie di lipidi isoprenoidici e di un modello organizzativo di membrana cellulare sostanzialmente differente da quello presente in tutti gli organismi viventi fino ad allora noti porta l’attività del gruppo e dell’Istituto all’attenzione internazionale. Una politica aperta di collaborazione estesa a livello nazionale ed internazionale rende l’Istituto un importante punto di nucleazione che porta l’avvincente tematica degli organismi estremofili all’attenzione di prestigiosi laboratori nazionali ed internazionali interessati allo studio dei mec- canismi molecolari alla base della vita a temperature superiori al punto di ebollizione dell’acqua. Un seme importante se si considera che oggi più di un centinaio di gruppi di ricerca in Europa si interessano a questa tematica. Quelli della direzione di Mario De Rosa sono anni difficili per l’inconciliabilità del processo di crescita dell’Istituto con i limiti delle strutture di Arco Felice nate con logiche abitative. Si incomincia un lungo e difficile processo di ricerca di nuovi spazi più adatti alle esigenze di laboratori di ricerca ed inizia la tormentata acquisizione da parte del CNR della struttura della ex-Merrel in Napoli. La crescita dell’Istituto e la stringente necessità di collocare in spazi adatti le attrezzature specialistiche della Risonanza Magnetica e della Massa spingono Mario De Rosa ad attivare accordi di collaborazione con l’Università Federico II, che mette a disposizione spazi e strutture presso le strutture del Policlinico di via Pansini. La grande vitalità dell’Istituto emerge a pieno durante il difficile e lungo periodo del bradisismo, costellato da numerosi momenti di reale pericolo per uo- 27 Il 23 gennaio 1986 ci fu un consiglio scientifico abbastanza importante per le decisioni che si dovevano prendere. In esso il prof. Mario De Rosa comunicò che aveva presentato le sue dimissioni da collaboratore tecnico-professionale del CNR a seguito della chiamata a ricoprire un posto di professore associato alla I Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli e che aveva “in tal senso informato il Presidente del Comitato per le Scienze Chimiche al fine di avviare la procedura per la sua sostituzione.” Il consiglio scientifico in quella riunione dopo aver preso atto di alcuni verbali assembleari del personale dell’Istituto e ribadendo che allo stato “esiste nell’Istituto più di un ricercatore in grado di ricoprire validamente l’incarico di direzione, pur con diverso grado di maturazione…” stabilì quattro criteri sui quali valutare le candidature. Tra l’altro si disse che “tenuto conto del momento particolare della vita dell’Istituto, il C.S ritiene opportuno formulare al Comitato una indicazione nominativa unica al fine di giungere ad una rapida decisione.” Fra i quattro criteri c’era uno che riteneva “auspicabile [un] avvicendamento di competenze nelle tematiche di ricerca proprie dell’Istituto. Pertanto, tenendo presente anche il [suddetto] criterio dei quattro sovraesposti nel valutare i possibili candidati, il C.S. ritiene di poter suggerire il nome del dr. Guido Cimino quale direttore dell’Istituto per il prossimo mandato.” La direzione del dr. Guido Cimino si è strutturata su più mandati: dal 1 Luglio 1986 al 30 Giugno 1990 (primo mandato); dal 1 Luglio 1990 al 30 Giugno 1992 (secondo mandato); dal 1 Luglio 1992 al 30 Giugno 1996 (terzo mandato); dal 1 Agosto 1996 al 31 Luglio 2000 (quarto mandato); dal 1 Agosto 2000 a tutt’oggi. Nel consiglio scientifico del 17 novembre del 1989 in occasione della discussione del punto all’ordine del giorno intitolato “Proposte da inserire in un eventuale piano di ristrutturazione degli Organi del CNR” il direttore presentò una relazione nella quale erano contenute alcune considerazioni su circa venti anni di storia dell’Istituto. In particolare, dopo aver tracciato un quadro delle tematiche operative all’interno dell’Istituto e del personale ad esse afferente egli concludeva “Il merito di aver costruito questa struttura, unica in Italia, dove l’ottima integrazione delle diverse competenze ha consentito a tutte le tematiche di esprimersi su livelli di eccellenza, va riconosciuto prevalentemente all’opera di quanti mi hanno preceduto nel dirigere l’ICMIB ed alla politica di sviluppo suggerita da tutti i membri dei diversi Consigli Scientifici. Ovviamente tutto ciò sarebbe stato vano senza la presenza nell’ICMIB di uno straordinario gruppo di ricercatori perfettamente coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo. La validità dell’attività scientifica prodotta nell’ICMIB è testimoniata anche dal successo riportato da diversi ricercatori in concorsi universitari: 1975 (prof. Minale), 1985 (prof.ri De Rosa e Sodano), 1986 (prof R. Riccio), 1987 (dr. VirigiPubblicazioni ICMIB su riviste internazionali (a) e nazionali (b) nel periodo 19701988 Linee 1970-1979 1980-1984 1985-1987 1988 (ultimo anno) a b a b a b a b SN 83 1 46 - 47 1 9 1 BT 39 7 36 - 34 - 11 - NMR 37 1 15 1 17 - 8 - MS 8 8 1 4 2 1 10 1 RX 7 - 6 - 4 - 3 - 28 29 I consigli scientifici Membri del Consiglio Scientifico dell’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico (dal 1969 al 2001) Prof. A. Ballio 1993-1997 Prof. J.D. Bu’ Lock 1969-1992 Prof. G. Carrea 1997-2001 Prof. V. Crescenzi 1969-1973 Prof. J. Degani 1993-1997 Prof. G. Jommi 1973-1992 Prof. E. Lederer 1969-1982 Prof. M. Mammi 1969-1992 Prof. L. Mangoni 1976-2001 Prof. L. Panizzi 1969-1970 Prof. E. Peggion 1997-2001 Prof. P. Potier 1993-1997 Prof. J. Ros 1997-2001 Prof. Vitagliano 1970-1973 Dr. G. Cimino 1986-2001 Sig. A. Crispino 1997-2001 Prof. M. De Rosa 1973-1986 Dr. S. De Rosa 1973-1992 Dr. S. De Stefano 1969-1973 Sig. E. Esposito 1997-2001 Dr. A. Gambacorta 1982-1993 Dr. M. Gavagnin 1993-2001 Dr. A. Malorni 1982-1993 Prof. L. Minale 1969-1981 Dr. A. Motta 1997-2001 Prof. R.A. Nicolaus 1969-1976 Dr. B. Nicolaus 1993-1997 Dr. R. Puliti 1993-1997 Prof. G. Sodano 1969-1970; 1977-1986 Dr. T. Tancredi 1986-1997 Dr. E. Trivellone 1970-1986 In base alla normativa vigente prima della recente riforma, agli Organi del CNR era preposto un Consiglio Scientifico composto oltre che da membri interni anche da esperti sia italiani che stranieri, cui erano demandate importanti funzioni quali quelle di fissare le linee generali di attività dell’Organo e di esprimere annualmente un parere sull’attività svolta. Al di là dell’aspetto formale, i Consigli Scientifici che si sono succeduti nel Laboratorio per la Chimica e la Fisica di Molecole di Interesse Biologico prima e nell’Istituto di Chimica di Molecole di Interesse Biologico poi hanno sempre operato in un clima di totale consonanza con i Direttori protempore e con il personale scientifico, tecnico e amministrativo. Tale sinergia ha certamente contribuito al conseguimento dei risultati che hanno collocato il Laboratorio (e poi l’Istituto) in una posizione di tutto rilievo in campo sia nazionale che internazionale. All’atto della sua fondazione (nel 1969) la presidenza del Consiglio Scientifico del Laboratorio venne affidata al prof. Edgar Lederer, all’epoca direttore dell’ Istituto di Chimica delle Sostanze naturali del CNRS di Gif sur Yvette, presidenza tenuta fino al 1982. Scienziato di fama mondiale, Edgar Lederer ha portato contributi rilevanti in numerosi campi della chimica organica, tra i quali non possono essere taciuti la introduzione e lo sviluppo dei metodi cromatografici nello studio delle sostanze naturali. Chi scrive, entrato a far parte del Consiglio Scientifico a partire dal 1976, lo ricorda presiedere il Consiglio con grande autorevolezza passando con estrema disinvoltura dal francese all’inglese non senza qualche escursione in italiano. Nel 1983 a succedere al prof. Lederer venne chiamato il prof. John Bu’Lock, eminente studioso del Dipartimento di Chimica dell’Università di Manchester, noto soprattutto per i suoi studi sui metaboliti di microrganismi, il quale faceva parte del Consiglio già dal 1969. Non è peraltro priva di significato la circostanza che, all’inizio della sua carriera, Bu’Lock si era anche dedicato allo studio della biosintesi delle melanine, sostanze che proprio a Napoli sono state e sono oggetto di indagini approfondite. John Bu’Lock rimase alla presidenza del Consiglio Scientifico fino al 1992, anno in cui lasciò anche il Consiglio. Nel 1993 la presidenza fu assunta, non senza qualche giustificato timore nell’essere chiamato a portare avanti l’opera dei due illustri predecessori, da chi scrive, che la ha poi conservata fino alla confluenza dell’Organo nel nuovo Istituto di Chimica Biomolecolare. Fortunatamente, anche in questo periodo il Consiglio ha potuto avvalersi della preziosa collaborazione di due prestigiose personalità straniere: il francese Pierre Potier, direttore dell’Istituto di Gif sur Yvette al cui vertice era già stato Lederer (dal 1993 al 1997) e lo spagnolo Joandomenec Ros eminente studioso di Ecologia marina (dal 1997 al 2001). Dei vari Consigli Scientifici che si sono succeduti hanno naturalmente fatto anche parte, oltre ai membri interni, molti valenti colleghi italiani. Tra tutti, voglio citare soltanto il compianto prof. Giancarlo Jommi dell’Università di Milano ed il prof. Mario Mammi dell’Università di Padova, i quali mi sono stati più a lungo accanto nel Consiglio Scientifico. Del primo mi piace ricordare la profonda umanità ed il raro equilibrio con il quale contribuiva a risolvere i problemi all’esame del Consiglio; del secondo la eccezionale conoscenza di tutte le normative CNR e la cura con cui annotava in un apposito quaderno personale il resoconto di tutte le adunanze. 30 Le personalità scientifiche straniere Il Consiglio Scientifico dell’Istituto ha da sempre goduto della presenza di diverse personalità scientifiche straniere che hanno brillantemente indirizzato i giovani ricercatori presenti all’inizio su tematiche che si sono poi rivelate di enorme profitto scientifico. Si ricordano qui i primi, il Prof. Edgar Lederer e il Prof. John Desmond Bu’ Lock. Entrambi seppero cogliere d’istinto gli aspetti territoriali che lasciavano intravedere la possibilità di proficue indagini scientifiche; accanto alla brillantezza professionale non bisogna dimenticare la loro passione per gli interessi più variegati e l’impegno politico. All’inizio della sua appartenenza al consiglio scientifico dell’Istituto il Prof. Lederer era schierato contro la guerra del Vietnam. Più recentemente hanno fatto parte del Consiglio scientifico il Prof. Pierre Potier, che come il Prof. Lederer è stato direttore dell’Istituto di Chimica delle sostanze naturali del CNRS a Gif sur Yvette, e il Prof. Joandomenec Ros del Dipartimento di Ecologia dell’Università di Barcellona. Di seguito sono riportati due ricordi per il Prof. John Desmond Bu’ Lock, citando un articolo su Biotechnology Techniques da lui diretto, e per il Prof. Lederer citando un sito Internet dove sono riportati cenni della sua biografia. Sono inoltre riportati un planning di Bu’ Lock del 1969 e due John Desmond Bu’ Lock 1928 - 1996 ...“Almost everyone who met John was immediately struck by his sheer intellectual brilliance. He dazzled us with his breadth of knowledge, and not just biotechnology and chemistry which were his professional loves, but also in matters antiquarian, in medieval archaeology as well as being a devotee of Japanese gardens all of which received his immeasurable enthusiasm…” “….Although John’s work and interests on fungal metabolites continued until his retirement, he could not resist challenges: in 1970 scientists at the CNR Institute in Pozzuoli, Italy, asked John to help them unravel the complexities of the lipids being recovered from bacteria isolated from volcanic fumeroles. These were the thermophilic, acidophilic archaebacteria. John visited Italy many times to carry out the collaborative proramme - set up long before European Union grants were available. From this work came the first structures of the isopranoid ether lipids though other researcher elsewhere were also working hard to claim priority in his newly emerging areas….” Biotechnology Techniques Volume 10 No. 6 (June Edgar Lederer 1908 - 1988 Né à Vienne en 1908, Edgar Lederer a connu bien des vicissitudes avant de devenir directeur à l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif. Son origine juive l'obligea à quitter l'Autriche, en 1930, pour l'Allemagne qu'il dut fuir à son tour en 1933 à l'arrivée d'Hitler. Sans vrai contrat en France, il part pour l'URSS et devient directeur de l'Institut des Vitamines à Léningrad. Les purges staliniennes le font revenir en France en 1937. Intégré au CNRS il en est exclu par les lois anti-juives de 1941. Réintégré en 1944 il travaille à partir de 1947 à l'Institut de biologie physico -chimique à Paris. En 1958 il succède au Pr Fromageot, à la Sorbonne. C'est à cette époque que le projet de l'ICSN se développe, Edgar Lederer en sera l'un des deux directeurs jusqu'à sa retraite en 1978. Précurseur dans de nombreux domaines, il avait noué des contacts avec l'industrie dès 1939. Ses contrats lui valent de sévères critiques... avant d'être officialisés en 1950 et repris par l'ANVAR en 1966. Son nom reste attaché à la chromatographie qu'il a largement contribué à introduire et développer. Il savait détecter "d'instinct" les sujets de recherche prometteurs et son champ d'action était très ouvert . En 1986 il faisait remarquer que ses dernières publications étaient parues dans "Infection and Immunity" et "Pharmacology". Ceux qui l'ont connu à Gif se souviennent de son engagement contre la guerre du Vietnam. 31 Il 17 giugno del 1969 in preparazione della seduta del Consiglio Scientifico di luglio il prof. Bu’ Lock scriveva a tutti i membri del consiglio scientifico e al direttore dell’Istituto la lettera riportata nel riquadro a fianco corredata da una analisi riportata per intero qui di seguito. Proporre la rilettura di questo documento ci pare abbastanza interessante. Esso testimonia l’impegno che le personalità scientifiche straniere del Consiglio Scientifico profusero nel17th June, 1969. lo sviluppo del Laboratorio e ripropone alcune linee organizTo the Director and to all members of the zative standard che dovrebbero essere tenute presenti, non Scientific Council senza qualche aggiornamento dovuto ai tempi, nello sviluppo del nuovo Istituto di Chimica Biomolecolare. The following comments upon planning our future activities are being circulated to you at my request. They summarise my own opinions on several topics and represent only my own personal thoughts. I have asked for them to be circulated in advance of our July meeting so that they can be considered without the disadvantages which would follow if I were to express them personally at the meeting, with all the linguistic problems this would entail. I respect highly your judgement upon my opinions and submit them with great respect. Planning the Arco Felice Institute 1. The Institute cannot be justified if it provides merely an alternative locale for existing programmes of research. It must itself add to the range of existing programmes by developing innovation in research lines. It should also promote both new and existing research interests by the introduction of new techniques and facilities. In all these aspects the question of personnel is of central importance. 2. Given that the Institute should exíst, why should it be in the Naples area? It must exploit fully any relevant advantages which can be gained from its location. The first of these is that the attractive situation should assist certain aspects of recruitment which are discussed below. The second is that research lines should so far as possible exploit favourable Yours sincerely, local circumstances. One such circumstance is the nearby availability, partly but not exclusively through the Stazione Zoologica, of expert knowledge and research material in the area of marine biology. Non-zoological aspects of marine life, and in particular algology and the virtually unknown area of marine mycology, are also important in this respect. Another regional advantage is the availabílity of a unique flora of thermophílic, halophilic, and acidophi'lic bacteria in the thermal area of Pozzuoli. Such considerations help to define research areas for which the situation of the Institute provides unique attractions. 3. The question of the general character of research to be studied wíthin the broad terms “Chemistry and Physics” requires attention, particularly in relation to laboratory equipment. My view is that two areas can usefully be defined, in terms of two kinds of “molecules of biological interest", namely “Small Molecules" and “Large imolecules". Under the heading “Small Molecules", the existing interest in animal pigments should be pursued, but new problems, preferably in a marine animal context, should be developed to take the place of the phaeomelanin problem which now has a limited future. Work on phytochrome problems should be developed in connection specifically with phytochrome effects in algae, which offer specific experimental advantages. Work in chemical microbiology should develop out of programs on marine mycology and on the bacterial fauna of the thermal areas. The field of “Large Molecules" offers special scope for new developments, partícularly in relation to dynamic aspects of the conformational studies of biologically active macromolecules. The application of physical methods to the investigation of chemical mechanisms and small-scale structures in bio-macromolecules, should be a major part of the Institute’s particular program. 4. Major items of equipment for the Institute should follow above considerations. The N.M.R. group will provide a general service facility but it should also develop a research interest within the above framework and preferably within the “Large Molecules" area.If in this area the group develops sufficient research potential to justify the installation of a 220 MCS machine, at a minimum cost of $ 200,000, Scientific Council should be prepared to plan for such an installation in about five years time. The “Large Molecules" area should also develop the use of ORD/CD methods and acquire the necessary instrumentation in the immediate future. The question of high-quality instrumentation is related to some aspects of recruitment: first, permanent personnel will need to acquire high-quality technical competence; second, temporary personnel of high quality will be attracted to a specially well equipped Institute. A completely new technique has obvious advantages on both counts. Such a technique, which promises to be of very great potential in chemical study of biological materials, is that of Induced (Auger) 32 Electron Emíssion spectrometry. My information on this technique leads me to the proposition that the requisite instrumentation [e. g. Varian V- IEE- 15, $ 70,000; AEI - ES - 100, price not known] should be purchased as soon as possible and that suitable personnel should be assigned for training. 5.On the general question of personnel the following points merit consideration. a) The maximum use should be made of the Institute’s powers to second staff to suitable centres, in Italy and abroad, for the specific purpose of training in new experimental techniques. b) New permanent staff should be recruited by the normal process of press advertisement, placing notices in newspapers in Italy and in intemational scientific joumals such as " Nature" , " Science" , " Eur. J. Biochem.“ , etc., followed by the submission of a written curriculum vitae and by interview by the Director of the Laboratory and representatives of the Scientific Council. c) The maximum use should be made of the Institute’s powers to recruit temporary staff from elsewhere, both in Italy and outside. The aim of such appointments should be to secure something more than the mere presence of a visiting research worker, and to recruit temporary staff of the highest possible calibre who would have the task of establishing new research lines in the Institute. A suitable mechanism for securing this would be to recruit someone for, say, a total of 12 months distributed as convenient over a period of three years, during which time the visitor would establish a new research line, to be carried out with Institute staff, in the hope that at the end of three years, research in this area would have become an integral part of the Institute’s work and could be continued independently by the permanent staff who had been involved. I have no doubt that such appointments could be made sufficiently attractive to scientists of real distinctíon; this would overcome many of the difficulties in staffing the Institute, by providing very skilled direction for new research lines and new techniques. A scheme of this kind, for "visiting directors" , would still leave scope for “visiting fellowships" of the normal kind, which can have a valuable ínfluence in less direct ways. 6. With regard to the balance between the Council’s two duties, of supervising the development of the Arco Felice Institute and of giving financial support to research programmes elsewhere I believe that in the immediate future, the needs of the Arco Felice laboratory, as outlined above, should be our first concern, so far as this does not jeopardise valuable research elsewhere. The criteria for research support in other laboratories should in general be similar to those outlined above for Arco Felice itself, with particular emphasis upon innovation, training, the acquisition of new techniques, and the maximum spread of benefits, within the appropriate areas of scientific interest. To enable the Council to make a proper judgement on applications for the support of research in other laboratories, such applications should be made in a standard manner and should provide the Council with clear statements along the Il 26 Novembre del 1981 ci fu una cerimonia per la consegna di una targa ricordo al prof. Lederer che lasciava il C.S. stesso: gli fu consegnata la targa e durante la cerimonia alcuni ricercatori dell’Istituto tennero delle comunicazioni circa la loro attività scientifica. Qui sotto è ricordato il Programma di quella manifestazione. Programma Ore 10.15 Consegna targa ricordo al Prof. Lederer Ore 10.30 Chimica e comportamento di difesa di alcuni nudibranchi mediterranei G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano Ore 11.00 Recenti risultati su saponine e steroidi poliossidrilati da stelle di mare L. Minale, C. Pizza, R. Riccio, e F. Zollo Ore 11.30 Caffè Ore 12.00 Lipidi degl arcaebatteri, una nuova storia evolutiva in termini molecolari M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus e J.D Bu’ Lock Ore 12.30 Nuovi processi nel settore biotecnologico basati sull’impiego di arcaebatteri M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, V. Buonocore e E. Drioli 33 Pierre Potier Bom 22nd August 1934, Bois-Colombes (near Paris) Pharmacist (Paris, 1957) Ph.D. (physical and chemical sciences) (Paris, 1960) Laureate: Faculty of Pharmacy, Paris (1954, 1955, 1957) Laureate: National Academy of Medicine (1960,1990) Laureate: French Chemical Society (Le Bel and Raymond-Berr awards) Laureate: Royal Society of Chemistry, London, 1990 Hanus Medal, Pragues 1990, etc. Member of the french Academy of Sciences, of the National Academy of Pharmacy, of the "Comit Acadmique des Applications de la Science" Director of the "Institut de Chimie des Substances Naturelles" of the National Center for Scientific Re- Member of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (E. 0. R. T. C.) Member of the board of editors of various international scientific journals etc. Joandomenèc Ros Born 1946 in Barcelona (Spain), married, three children. Biology Studies in the University of Barcelona (UB), where he graduated (1968) and did his Ph.D. thesis (on Ecology of Opisthobranch Molluscs, 1973). Assistant professar (1970-81) in the UB and professor in the Universities of Murcia (UMU,1981-86), La Laguna (1983) and UB (from 1986 onwards), where he teaches undergraduate and postgraduate courses on General Ecology, Marine Ecology, Opisthobranch Biology and Environment Science. Former head of the Department of Ecology (UMU, 1981-1986), which he boosted, and of the UB (1986-93), where he succeeded Prof. Ramon Margalef, his Ph.D. thesis director. Main research fields: (1) ecology of Opisthobranchs (25 scientific papers); (2) ecology and bionomy of littoral bottoms and their benthic communities (34 Chromodoris elegans, Mar Rosso search at Gif-sur-Yvette Professor of Chemistry at the National Museum of Natural History in Paris Visiting-Professor at the University of Strathclyde (Glasgow, U.K.) (1984-1990) President of one of the sections of the National Committee for Scentific Research (1988-1991) Member of the Scientific Board of the National Center for Scientific Research Founder (with Y. BAN) of the French Japanese Society for fine and medicinal chemistry Founder (with E.J. COREY) of the FrenchAmerican Chemical Society Consulting member of the UN'F-SCO La copertina di uno dei libri del Prof. Ros papers and 3 books); (3) ecology of marine benthic groups (22 papers). Other papers, 3 books and a score of technical reports on environmental impact studies and conservation. He has directed and/or participated in many research programs on these topics, and has formed several specialist and research teams on marine benthos ecology in several Spanish universities, with 34 which he currently collaborates. He has a long relationship of collaboration with the Istituto per la Chimica delle Molecole di Interesse Biologico (ltaly), and with other European and American research centres. Author or coauthor of more than one hundred technical and scientific papers. Editor or author of several books, among them: Pràcticas de Ecologa (1979), Els sistemes naturals de les illes Medes (1984), Topics in Marine Biology 1989), Homage to Ramon Margalef, or Why there is such pleasure in studying nature (1992), La nostra ecologia de cada dia (1995) Topics in Marine Benthos Ecology (1995), La extinciòn ce especies animales y vegetales (1995), Ecology of Marine Molluscs (1997) and Trossos do natura inacabats (1997). He has attended several national and international scientific meetings, some of which he has organized, to which communications and/or invited lectures were presented. He is or has been editor or director of three scientific journals and is member of the Editorial Committee of several others. Fellow of several scientific societies and of the Institut d'Estudis Catalans and other academies, and member of some consultative bodies of the European, Spanish Portu- Da sinistra: Giacomo Carrea, Joandomenec Ross ed Enrico Esposito alla riunione del Consiglio Scientifico del Luglio 2001 nella nuova sede. Tra i presenti, dalla sinistra: Rosaria Vaccaro, Enrico Trivellone, Salvatore De Rosa, Agata Gambacorta (nascosta) e Antonio Trincone. Il pranzo dopo il Consiglio Scientifico del Luglio 2001. A partire dal basso a sinistra: Aniello Lopez, Antonio Crispino, Giacomo Carrea, Guido Cimino, Lorenzo Mangoni, Agata Gambacorta, Andrea Motta, Margherita Gavagnin (nascosta), Enrico Trivellone, Joandomenec Ross e Guido Villani. 35 I reparti Attività scientifica dalla fondazione al 1994 Sia il Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico inizialmente, sia l’Istituto successivamente, si sono dati da sempre un’organizzazione per Reparti. La parola reparto compare già nel primo rapporto del prof. Nicolaus del 1969. Si formarono differenziati nel tempo il Reparto Sostanze Naturali, il Reparto di Risonanza Magnetica Nucleare, il Reparto Batteri Termofili, il Reparto Spettrometria di Massa e la Linea di Ricerca Cristallografia. Luigi Minale fu il primo caporeparto del Reparto Sostanze Naturali in seguito sostituito da Guido Cimino, da Salvatore De Stefano e poi da Salvatore De Rosa. Il reparto di Risonanza Magnetica Nucleare fu affidato all’inizio al Prof. Temussi e successivamente a Enrico Trivellone, ed in seguito a Teodorico Tancredi. Il reparto Batteri Termofili è stato prima diretto da Mario De Rosa e poi da Agata Gambacorta. Il reparto di Spettrometria di Massa è stato seguito sempre da Antonio Malorni. La Linea di ricerca Cristallografia è stata da sempre affidata a Raffaella Puliti. In un consiglio scientifico del 1993 si discusse circa la riorganizzazione dell’Istituto e il coordinamento scientifico delle varie linee fu affidato ai singoli ricercatori. I reparti non venivano cancellati ma mantenuti nell’organizzazione dell’Istituto nella speranza di conservarne la funzione coesiva, per quanto riguarda la funzionalità generale, il coordinamento economico, la responsabilità delle apparecchiature etc. Nelle pagine che seguono è dettagliata l’attività dei vari reparti dall’inizio al 1994. Ai capireparto attuali è stato affidato il compito, non facile, di ricordare e riportare quello che il loro reparto ha dato alla vita dell’Istituto in termini non soltanto scientifici ma anche di organizzazione delle risorse umane e di storia personale. A Salvatore De Rosa (Sostanze Naturali), Agata Gambacorta (Batteri Termofili), Antonio Malorni (Spettrometria di Massa), Raffaella Puliti (Linea di Ricerca Cristallografia) e a Teodorico Tancredi (Risonanza Magnetica Nucleare), va un grosso ringraziamento. Il coordinamento scientifico delle varie attività dopo il 1994 è stato affidato ai singoli ricercatori cui è stato chiesto di contribuire con un inquadramento, nella storia dell’Istituto, della loro attività; tali contributi sono riportati in seguito nel capitolo “Le linee di ricerca attuali dell’Istituto”. 36 Reparto Sostanze Naturali da bromocomposti di origine tirosinica, a vari tipi di Salvatore De Rosa terpeni, tra cui gli insoliti C-21 furanoterpeni, a steroli inusuali, come gli A-nor e 19-nor, a metaboliti di origi- Il Reparto di Sostanze Naturali, fin dalla nascita ne mista, mevalonica benzenoide, non dimenticando un dell’Istituto, tranne un brevissimo periodo iniziale teso gran numero di altri metaboliti che non trovano al completamento degli studi sulle feomelanine, già un’unica etichettatura. argomento di ricerca del Centro CNR progenitore del La prima spugna ad essere studiata, fu la Aplysina ae- Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Inte- rophoba, da cui fu isolato un bromo composto, denomi- resse Biologico, ha operato nel campo dei metaboliti da nato aeroplisinina-1, di cui è ben chiara la sua origine organismi marini. Su suggerimento del lungimirante tirosinica. L’aeroplisinina-1 data l’elevata attività cito- Prof. E. Lederer, presidente del Consiglio Scientifico, statica, contro diverse linee cellulari, fa parte di un ri- nel Laboratorio si diede inizio lo studio dei metaboliti stretto numero di molecole naturali tuttora sottoposto a secondari da organismi marini, quest’idea sembrò un studio come potenziale farmaco anticancro. Dalle spu- azzardo, perché all’epoca della fondazione del Labora- gne del genere Ircinia, successivamente, furono isolati torio (fine degli anni ’60), in letteratura si potevano quattro sesterterpeni aciclici con il raro gruppo furani- contare solo pochissimi lavori su tale argomento, ma co, mentre dal genere Cacopongia fu isolato un impor- visto i risultati ottenuti in pochissimo tempo, tale scelta tante gruppo di sesterterpeni tetraciclici, con uno sche- fu vincente. letro carbonioso nuovo, denominato scalaranico. Il Nel Reparto, all’inizio, operavano i dr.i Guido Cimino, H Salvatore De Stefano e Guido Sodano, ed i sigg. Antonio Crispino e Gennaro Scognamiglio, coordinati dal O Prof. Luigi Minale, nonché numerosi studenti, del corso di laurea in Chimica dell’Università di Napoli, per svol- HO O O gere la loro tesi sperimentale. A questi si aggiunse poco dopo il dr Raffaele Riccio, già frequentatore del laboratorio in qualità di studente. O Cacospongionolide B Nel corso di pochi anni ci si rese composto più rappresentativo di questo gruppo è lo conto che gli organismi marini scalaradiale, tuttora oggetto di studi, per le sue proprie- erano una fonte inesauribile di tà biologiche. Esso è un ottimo inibitore della fosfolipa- nuove molecole con caratteristiche si A2, ed ha delle potenziali applicazioni in campo far- strutturali mai riscontrate in natu- maceutico. L’importanza del ritrovamento di tutti que- aeroplisinina-1 ra, infatti, furono isolati e caratte- sti sesterterpeni, a parte le loro caratteristiche strutturali Br Br HO CN rizzati numerosi composti. Il pri- e biologiche del tutto insolite, risiede nel fatto che pri- mo periodo fu, quindi, dedicato allo studio sistematico ma di questi ritrovamenti (1972) in letteratura erano dei metaboliti secondari da poriferi del golfo di Napoli, riportati solo 13 sesterterpeni naturali. Ulteriori studi, analizzando circa trenta specie, appartenenti a quattro sempre su spugne della famiglia Spongiidae, portarono ordini: Dictioceratida, Poecilosclearida, Halicondrida all’isolamento dei cacospongionolidi, un nuovo gruppo ed Axinellida, che permise l’isolamento di circa 100 di sesterterpeni, con potente attività antibiotica ed anti- nuovi prodotti di varia complessità strutturale andando infiammatoria, con l’inibizione specifica della fosfoli- 37 pasi A2. Il più studiato, il cacospongionolide B, quando con l’inibizione è somministrato ai ratti, esplica un’azione anti- degli enzimi ciclo-ossigenasi e HO lipo-ossigenasi, ed una moderata O O attività O ircinina O crobica. Per queOH O O antimi- Cl O ste ultime proprietà, si sta moPomata a base di avarolo strando un ottimo composto contro alcune dermatite, con un potenziale infiammatoria superiore ai comuni farmaci anti- uso topico. Attualmente, in Germania, è in vendita una infiammatori non steroidei, e non mostra i ben noti ef- pomata a base d’avarolo, usata contro dermatiti aspeci- fetti collaterali (rossore e/o perforazione della mucosa fiche. gastrica) dei farmaci in commercio. dell’avarolo (1974) ad oggi, nel Chemical Abstract si Il genere Spongia si rivelò una ricca fonte di furano- possono contare non meno terpeni con 21 atomi di carbonio. La contemporanea di 80 lavori sulle sue attivi- HO da sottolineare presenza, in alcune spugne tà del genere Spongia, di fu- sull’isolamento di composti OH rano-sesterterpeni e degli insoliti C-21 furano-terpeni H E’ biologiche che dall’isolamento o strettamente correlati. Altri gruppi di ricerca, spar- fece supporre che questi si in varie parti del mondo, ultimi fossero derivati dai quasi contemporaneamente, primi per la perdita di iniziarono lo studio chimico quattro atomi di carbonio. Ipotesi ulteriormente avvalo- degli organismi marini, ed rata dall’isolamento dalla spugna Ircinia oros delle note in breve tempo ci fu un fiorire di pubblicazioni scienti- ircinine e di un norsesterterpene con la funzione cheto- fiche con la descrizione di nuovi composti isolati da cloro-idrina, chiaramente derivante dalla decarbossila- organismi marini, per lo più da invertebrati. Nel 1974, zione, dopo alogenazione ed idrolisi dell’acido tetroni- alcuni ricercatori coinvolti nel campo delle sostanze co. naturali di origine marina, chiesero alla IUPAC di orga- avarolo nizzare un congresso separato dal classico congresso sui prodotti naturali, perché non avrebbero avuto spazio Una citazione particolare la merita l’avarolo, un sesqui- sufficiente per presentare le nuove ricerche nel campo terpene-idrochinone, con una biogenesi mista terpene/ degli organismi marini. Visto l’elevato numero di pub- benzenoidica, isolato dalla spugna Dysidea avara, che blicazioni e considerato la continua espansione nel set- mostra una larga varietà d’attività farmacologiche, tra tore della ricerca dei prodotti naturali da organismi ma- cui una moderata attività contro il virus HIV-I, agente rini, il consiglio direttivo della IUPAC accettò la richie- patogeno dell'AIDS, una notevole attività anti- sta e nel 1975 sponsorizzò il primo “International Sym- leucemica (in vitro ed in vivo), ed antiinfiammatoria, posium on Marine Natural Products” (MaNaPro) 38 (Aberdeen, Scozia). Gli ottimi risultati ottenuti, dal riferi del golfo di Napoli, si sentì la necessità di una gruppo di ricerca del Laboratorio, non tardarono a pro- diversificazione dei soggetti da indagare, in parte dovu- curare riconoscimenti da parte della comunità scientifi- to alla rarefazione della materia prima, sia per qualità ca affidarono sia per quantità, ed in parte dovuto alla convinzione che l’organizzazione del secondo MaNaPro (Sorrento, 1978 il mare era, ed è tuttora, uno scrigno in cui si poteva, e foto) e successivamente anche del settimo (Capri si può, prendere a piene mani potendo ottenere risultati, 1992). Tuttora questo convegno si svolge, ad intervalli sicuramente, soddisfacenti ed interessanti. Questa fase quasi regolari, nelle Nazioni in cui operano gruppi di coincide, anche, con il trasferimento del dr. Salvatore internazionale, che, infatti, gli De Rosa dal reparto “Batteri Termo- OH fili”. O O Ac2O OH ponendo, in un primo momento, at- OAc tenzione sulle quattro gorgonie Py O Questa nuova fiducia fu premiata (Eunicella cavolini; E. stricta; Lep- O ricerca sull’argomento. Ai ricercatori del Reparto, inol- togorgia sarmentosa; Paramuricea chamaleon) del tre, furono commissionate una serie di monografie, golfo di Napoli, che procurarono una notevole mole di inserite in diversi volumi pubblicati su argomenti speci- lavoro e di risultati. Furono isolati e caratterizzati alcu- fici su prodotti marini. ni steroli con delle inconsuete funzionalizzazioni ed alcune basi puriniche e pirimidiniche con riconosciute NH2 N N HOCH2 O H HO H HO H H ara-A N Con la nomina del Prof. N Minale a direttore del attività antivirali. Tra gli steroli è da segnalare il deriva- Laboratorio, nel 1976, fu diosfenolica localizzata nell’anello D, che in condizioni designato caporeparto il molto blande perde facilmente la catena laterale dando dr. Cimino. origine a composti del tipo androgeni, mentre tra le basi Dopo il primo decennio di puriniche è da sottolineare l’isolamento dalla gorgonia ricerca sistematica su po- E. cavolini della ben nota ara-A,(arabinofuranosil- to del colesterolo nella figura sopra, con la funzione adenina), già in uso come farmaco antileucemico, e del s u o 3 ' - acetilderivato. L’ara-A è, tuttora, l’unico composto d’origine marina utilizzato come farmaco, non perché sia il più attivo Da sinistra: Salvatore De Rosa, Enrico Trivellone, Slobodan Macura e Aldo Spinella ed interessante tra tutti i composti iso- 39 lati da organismi marini, ma per il suo facile ottenimento per via sintetica. Contemporaneamente, il Prof. Minale, in stretta collaborazione con il dr. Riccio, attivava una nuova linea di ricerca rivolta alla determinazione strutturale di saponine da oloturie e stelle di mare sia del Mediterraneo sia da altri mari. Con la chiamata, del Prof. Minale alla cattedra di Chimica Organica, prima all’Università di Catania (1980) e poi con il suo trasfe- primo in Italia, fu introdotta, con il valido aiuto dell’esperto dr. Slobodan Macura (Università di Belgrado), la CN tecnica per l’acquisizione di spettri 2D-NMR, che diede un nuovo impulso nella determina- axisonitrile-1 zione strutturale dei composti isolati. rimento alla Facoltà di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli (1982), questa linea di ricerca seguì il suo ideatore e si rivelò un argomento molto prolifero, consentendo la pubblicazione di numerosi lavori. Per continuare le sue ricerche su quest’argomento, il dr. Riccio quale com- O ponente O dell’unità operativa, coordinata dal longifolina Prof. Minale, nell’ambito del Progetto Finalizzato (P.F.) “Oceanografia e fondi marini”, chiese ed ottenne il distacco presso la Facoltà di Farmacia, con successivo trasferimento come professore associato (1988). La diversificazione più importante, che contribuì ad una modifica della visione della ricerca nel campo delle sostanze naturali e a darle un significato più profondo intuitivo e leggibile, fu lo studio comportamentale dei molluschi senza conchiglia, in pratica senza difese visibili, del tipo opistobranco-nudibranco. La spinta allo studio fu l’osservazione che questi animali, lenti, indifesi, non sono minacciati, in pratica, da predatori e, come corollario non indifferente, non vi erano indicazioni sicure (tranne una generica indicazione che fossero carnivori) di quali fossero le loro prede. Ovviamente, l’analisi chimica ha offerto contributi determinanti all’accertamento di relazioni preda-predatore sulla base della presenza di “marker” chimici. Questa nuova proposizione, trovò migliore realizzazione per la collabora- Successivamente, l’attenzione si estese a vermi, briozoi, ascidiacee, molluschi ed alghe senza un reale mutamento di filosofia, se non quel- CHO CHO lo di scoprire nuovi composti che arricchissero le conoscenze della chimica organica delle sostanze naturali. Quello che Poligodiale mi preme sottolineare, è che tutto ciò comportò l’acquisizione, sicuramente più qualificata, delle tecniche cromatografiche per l’isolamento dei prodotti e, ciò che ancor più conta, l’apprendimento dell’uso delle tecniche spettroscopiche più all’avanguardia ed utili per il chiarimento strutturale. Nel corso del 1983, infatti, con l’acquisto dello spettrometro NMR a 500 MHz, il zione di valenti biologi marini (giusto per ricordare qualcuno, il Prof. J. Ros dell’Università di Barcellona), portò ad interessanti conclusioni come per esempio, mediante uno studio anatomico-chimico, la localizzazione delle sostanze di difesa in zone definite del mantello dei molluschi. In breve questi animali, oltre a difese meccaniche o mimetiche, ne utilizzano anche di chimiche tratte dalla loro dieta o sintetizzate de novo. Numerosi feromoni d’allarme o allomoni di difesa furono caratterizzati, come ad esempio il poligodiale che, per uno straordinario disegno della natura, può essere considerato come un antifeedant, ottimo su organismi viventi molto diversi, come pesci, insetti ed uomo. Questo esempio ci mostra come la natura, pur nella sua diversità, è molto 40 più omogenea ed unitaria di quanto l’uomo possa im- composti sul mangime commerciale ed osservare maginare. Gli studi, dei molluschi nudibranchi, sono l’effetto sui pesci. Utilizzando il ben noto poligodiale, risultati più ricchi di un significato intrinseco ed hanno composto molto piccante, si osservò che i pesci abboc- permesso dei trasferimenti d’informazioni sulle mole- cavano il mangime trattato ma immediatamente lo ri- cole isolate precedentemente dalle spugne. E’ doveroso gettavano. Successivamente, fu dimostrato il meccani- segnalare, come esempi di relazione preda-predatore: smo d’azione biologica del poligodiale e di altre 1,4dialdeidi terpenoidiche. In genere composti 1,4- i) il nudibranco Peltodoris atramaculata e la spugna dialdeidici, con una ben definita stereochimica, reagi- Petrosia ficiformis, fu dimostrato, usando una vasca a scono facilmente con i gruppi amminici liberi delle Y tipo lisine, presenti nel recettore del gusto, dando luogo ad d’esperimento, che consisteva nel porre alcuni esempla- un anello pirrolico. Sottoponendo altri metaboliti estrat- ri di P. atramaculata in un ramo della vasca e la spu- ti da nudibranchi (prevalentemente dal mantello) a sag- gna, alternativamente, in uno dei rimanenti rami facen- gi di attività antifeedant si poté stabilire, per molti di do scorrere un leggero flusso di acqua dai due rami essi, il loro ruolo difensivo nei nudibranchi, che sicura- verso i nudibranchi. In questo modo gli animali poteva- mente devono avere un ruolo di protezione anche per le no scegliere una delle due vie, tutti i nudibranchi si spugne. appositamente costruita per questo dirigevano sempre verso la P. ficiformis. Cambiando la spugna, con altra specie, i nudibranchi si dirigevano in Esperienze di biosintesi sul nudibranco Dendrodoris modo random nei due rami della vasca. Così fu possibi- limbata, portarono a risultati le stabilire che la spugna P. ficiformis è l’unica preda di particolare interesse. Fu del nudibranco P. atramaculata. La conferma si ebbe evidenziata, infatti, per la dalla stretta correlazione dei metaboliti isolati dal nudi- prima volta in un mollusco, la HN branco e quelli della spugna (miscela di composti aceti- capacità di metabolizzare, de lenici ad alto peso molecolare e del petrosterolo, un novo, la propria difesa chimi- insolito sterolo presente nella spugna); ca, tra cui il poligodiale. OH N N HN OH Calliactina ii) la Phyllidia pulitzeri che fu raccolta mentre mangia- Il 1977 segnò una profonda svolta nell’assegnazione va la spugna Axinella cannabina, e da cui fu isolato la dei fondi ai laboratori ed istituti del CNR. Prima di miscela di sesquiterpeni isonitrili ed isotiocianati, tra questa data, l’erogazione di tutti i fondi erano assegnati, cui il più abbondante axisonitrile-1, noti metaboliti del- agli organi del CNR, tramite i Comitati di Consulenza. la spugna; Con l’approvazione da parte del CIPE, (1977) del primo P.F. “Oceanografia e fondi marini”, fu introdotta la iii) l’isolamento dai nudibranchi Glossodoris valencien- novità che, il progetto era pluriennale, vedeva il coin- nesi e G. gracilis della longifolina metabolita della spu- volgimento delle industrie e per accedere ai fondi biso- gna Pleraplysilla spinifera. Gli studi sui molluschi nu- gnava presentare un progetto di ricerca articolato, con dibranchi hanno, inoltre, il merito di aver promosso la successiva valutazione da parte di un Comitato Scienti- messa a punto di alcuni test di attività, come quello per fico. A questo progetto ne seguirono altri, sia Finalizza- evidenziare l’attività antifeedant. Questo esperimento ti (in genere quinquennali) sia Strategici (P.S., di più consiste nel fare assorbire, a varie concentrazioni, i breve durata). Il reparto S.N. ha sempre presentato pro- 41 grammi di ricerca nell’ambito dei vari progetti con no- in considerazione lo studio di tale prodotto, ma per tevole successo, ed in alcuni casi furono, anche, finan- molti anni non si riuscì a capire la struttura, sia per la ziate due Unità Operative. non perfetta purezza del pigmento sia per la poco solubilità nei solventi organici. Finalmente, nel 1986, grazie La partecipazione delle industrie ai P.F., in particolare ad un nuovo metodo di purificazione, ed all'utilizzo di della Farmitalia-Carlo Erba e della Farmoplant grosse apparecchiature, come NMR a 500 MHz, fu (Montedison), fece sviluppare gli aspetti più applicativi possibile proporre la sua probabile struttura. della ricerca sui metaboliti secondari da organismi marini, con una valutazione farmacologica e/o insetticida Dopo un lungo periodo, in cui non ci furono nuove sulle sostanze isolate. assunzioni, il 1983 segnò una svolta, infatti al Reparto E' difficile non ricordare l’interesse per gli studi con- furono assegnati alcuni assistenti (Angelo Capezio, dotti su alcuni pigmenti da organismi marini, perché il Carmine Iodice, Desiderata Ricciardi e Clementina vistoso colore di alcuni animali marini, ha da sempre Faruolo), per trasferimento da altre sedi o per la parte- attirato l'attenzione di molti ricercatori. La spugna A- cipazione ai corsi di formazione professionale previsti plysina aerophoba è, infatti, colorata in giallo-arancio, dalla legge 285/77 (alcuni di loro, dopo la formazione ma che a contatto con l'aria diventa immediatamente furono assunti dal CNR e sono tuttora in servizio scura. L'isolamento del pigmento giallo, che rapida- nell’Istituto, solo Iodice è rimasto nel Reparto), ed un mente diventa nero, fu effettuato nel lontano 1882 da nuovo ricercatore, il dr. Aldo Spinella, che diede un Krukenberg, in seguito, altri ricercatori si interessarono notevole contributo allo studio degli allomoni di difesa al problema, senza ottenere apprezzabili risultati, per e feromoni di allarme nei molluschi (nel 1991, si trasfe- l’elevata instabilità del pigmento. La struttura fu stabili- rì all’Università di Salerno come professore associato). ta, come 3,5,8-triidrossi-4-chinolone, e denominato In seguito, al Reparto furono assegnati altri giovani uranidina. L’uranidina è molto instabile in ambiente ricercatori (dr. Margherita Gavagnin, 1985; dr. Vincen- basico ed alla presenza di ossigeno, mentre è stabile se zo Di Marzo, 1988) ed assistenti (dr. Alfonso De Giu- conservato in soluzioni neutre o leggermente acide, lio, 1986; dr. Giuseppe Strazzullo, 1986; entrambi in- questa osservazione ci permise di ottenere dei dati di quadrati nel ruolo ricercatore nel 2000). Questo non NMR e quindi stabilire la sua struttura. Le spugne Axi- comportò un incremento di personale, perché nello nella verrucosa e Acanthella aurantiaca, sono, stesso tempo alcuni validi ricercatori, vincitori di con- anch’esse, fortemente colorate in giallo-arancio. Da corso a cattedra, si trasferivano in varie Università, queste, due spugne, fu isolato lo stesso pigmento, con come i dr. Riccio e Spinella già ricordati ed il dr. Soda- uno scheletro carbonioso del tutto insolito. Fu possibile no (Prof. Ordinario all’Università di Potenza, 1986). stabilire la struttura grazie ai dati spettroscopici e dall’analisi ai raggi X. L’anno 1986 vide nell’Istituto (nel frattempo il Laboratorio aveva assunto la denominazione di Istituto) pro- Un altro pigmento, denominato calliactina, estratto nel fondi cambiamenti, oltre alle citate assunzioni e parten- 1940 dal prof. Lederer, dall'anemone Calliactis parasi- ze, anche il prof. Mario De Rosa, già direttore tica, per molti anni appassionò molti studiosi, senza dell’Istituto, si trasferì, con l’incarico di Prof. Ordina- riuscire a stabilirne la struttura. Considerato i rapporti rio, alla Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli, tra i ricercatori del Reparto ed il Prof. Lederer, fu preso il dr. Cimino fu nominato direttore, mentre la guida del 42 Reparto era affidata al dr. De Stefano. Ci fu una riorga- con la soluzione del composto, in ambiente sterile, a nizzazione del personale in servizio, per una migliore temperatura controllata ed al buio. Successivamente, fu razionalizzazione esistenti introdotto il test antifeedant sui pesci, già precedente- nell’Istituto, ed un impegno da parte del nuovo direttore mente accennato. Nel 1986, considerata la disponibilità a trovare le condizioni per permettere ai neolaureati la e l’impegno assunto dal direttore a fare frequentare possibilità di frequentare laboratori stranieri per acqui- laboratori stranieri ai neo laureati, il dr. De Giulio sog- sire esperienze su tematiche per lo sviluppo di nuovi giornò per alcuni mesi negli Stati Uniti, presso il Labo- programmi. ratorio diretto dal prof. Mc Laughlin, per acquisire le Queste furono le conoscenze nella messa a punto di esperimenti biologi- premesse per ci diretti ad evidenziare attività antitumorale (dischi di l’individuazione patate infestate dall’Agrobacterium tumefasciens) e di varie temati- citotossica (Artemia salina). Questi due saggi di attività che di ricerca, erano e sono riconosciuti dal National Cancer Institute nell’ambito del (NCI, USA) come test preliminari, ed infatti, i composti Reparto, che con inviati al NCI, con questi dati, superano direttamente la il loro sviluppo prima fase nello screening per la valutazione citotossica portarono, successivamente, alla definizione delle at- ed antitumorale. Questa esperienza fu ulteriormente tuali linee di ricerche. Il germe delle linee di ricerche incrementata, nell’ambito dell’unità operativa “Studio lanciato dal Reparto fu recepito dagli altri ricercatori guidato da saggi di attività biologica” del P.S. dell’Istituto ed infatti il 1992 fu l’anno di nascita delle “Chimica dei processi biologici”, sviluppando saggi linee di ricerca. anti-microbici e di ittiotossicità. Lo sviluppo di questa L’esperienza - acquisita nella partecipazione ai P.F., in serie di saggi di attività biologica fu la premessa per cui era previsto l’invio dei prodotti isolati alle industrie l’individuazione, successivamente, di una delle temati- per essere sottoposti a saggi di attività biologica, il cui che di ricerca (isolamento dei metaboliti secondari gui- responso arrivava con notevole ritardo e riprendere il dato da saggi di attività biologica) sviluppate nel Re- lavoro comportava enormi disagi, - radicò l’idea di parto. N O delle potenzialità H H Saraina 1 N introdurre nel Reparto una serie di semplici esperimenti biologici per avere dei dati immediati anche se prelimi- Come accennavo prima, nel lontano 1987 furono indi- nari, in modo da sottoporre le molecole a screening viduate tre tematiche, che nel corso degli anni furono mirati in laboratori di ricerca specialistici sia pubblici ulteriormente sviluppate o modificate: sia privati. Come si fa a dimenticare il dr. De Stefano, aiutato dalla Sig.ra Pasqualina Salzano, mentre misuravano le radici ed i germogli dei semi di orzo (Hordeum vulgaris), per valutare l’attività fitoregolatrice di alcuni composti isolati? Questo fu, infatti, il primo approccio nell’introdurre saggi di attività biologica. Il test di fitoattività consiste nel paragonare il diverso sviluppo radi- 1. Studio della struttura e stereochimica di nuove sostanze naturali di origine marina; 2. Studio su basi chimiche dell’ecologia dei molluschi opistobranchi; 3. Isolamento dei metaboliti secondari guidato da saggi di attività biologica. cale e/o dei germogli dei semi di orzo trattati e non, dopo tre settimane dalla loro a dimora a contatto diretto Il 1987 fu, anche, l’anno che vide la definizione struttu- 43 rale delle saraine, una nuova classe di alcaloidi isolati vati di acidi grassi polinsaturi, quali gli eicosanoidi, e di dalla spugna Reniera sarai. Per lungo tempo, questi altre molecole lipidiche, nella segnalazione inter- ed composti avevano resistito ad ogni attacco teso alla loro intra-cellulari di invertebrati ed agli studi sulla biosinte- delucidazione strutturale. Solo grazie all’introduzione si dell’anandamide (N-arachidonil-etanolammina), che della cromatografia preparativa liquida ad alta pressio- è un ligando fisiologico del recettore dei cannabinoidi ne ed all’utilizzo di tecniche 2D-NMR con spettrometro nel cervello dei mammiferi. operante a 500 MHz, fu possibile proporre la struttura L’accordo firmato, nel 1988, tra il CNR ed il Ministero di queste insolite molecole, che fu confermata per lo Sviluppo del Mezzogiorno (MISM), che preve- dall’indagine ai raggi X, su cristalli ottenuti dal diacetil deva la formazione professionale, di giovani laureati, -derivato di una di esse. per l’inserimento nel mondo della ricerca sia pubblica sia privata, fece sperare in un ampliamento dell’organico, fortemente deficitario a tutti i livelli professionali. All’Istituto, nel 1989, furono assegnati 15 borsisti, di cui 4 (L. Ciavatta, G. Di Vincenzo, A. Fontana, R.R. Vardaro) al Reparto S.N., che furono inseriti nelle varie tematiche. Come previsto dall’accordo, si diede, anche, inizio allo studio di colture cellulari di piante largamente diffuse nel Meridione, a tale scopo si scelse il LycoLa Tethys fimbria è un mollusco relativamente grande persicon esculentum (pomodoro), che è una delle prin- che per sfuggire ai predatori ricorre ad una strategia cipali fonte economiche della Campania. Le aspettative simile a quella delle lucertole, infatti quando molestato dell’accordo CNR-MISM furono completamente delu- cede per automia delle appendici, dette cerata, che, se, perché alla fine del corso di formazione nessuno fu continuando a contrarsi, distraggono il predatore e con- assunto dal CNR, ma solo alcuni poterono usufruire, sentono la salvezza dell’animale. L’isolamento di pro- con forte ritardo, di borse di studio, specificamente staglandine-1,15-lattoni dalla T. fimbria fece pensare ad bandite allo scopo. Dei 15 borsisti iniziali solo tre (P. un loro coinvolgimento nel processo di automia eserci- Amodeo, L. Ciavatta e A. Fontana), dopo vari rinvii tato da questo mollusco. Studi successivi dimostrarono (nel 1998), sono stati assunti ed inquadrati come ricer- che la T. fimbria è in grado di biosintetizzare ed accu- catori nell’organico dell’Istituto. mulare questi lattoni. Questo ritrovamento rappresenta il primo esempio, mai riportato in natura, di un proces- Nel 1992, ci fu un avvicendamento tra il dr. De Stefano so metabolico mediante il quale le prostaglandine sono ed il dr. De Rosa, nel coordinamento del Reparto, e immagazzinate per poi essere rilasciate al momento come accennato precedentemente, questo fu l’anno in opportuno ed esercitare la loro azione biologica. Questi cui si delinearono tre linee di ricerca: studi furono alla base della linea di ricerca “Lipidi come segnali chimici inter- ed intra-cellulari in invertebrati”, che nel corso degli anni si è sviluppata rivolgendosi, essenzialmente, allo studio dell’intervento di deri- 1. Studio su basi chimiche dell’ecologia dei molluschi opistobranchi; 2. Metaboliti biologicamente attivi e loro modifica 44 strutturale per migliorare l’indice terapeutico. – Chimica e biochimica di colture cellulari; 3. Lipidi come segnali chimici inter- ed intracellulari in invertebrati; 4. Studi chimici degli antozoi che ancora oggi, ulteriormente integrate, sono la base delle ricerche che si effettuano nel Reparto. Il Reparto, come del resto tutto l’Istituto, è stato sempre sensibile alle collaborazioni sia con ricercatori italiani sia stranieri, ed alla visita di personalità scientifiche di riconosciuto valore, tra i quali, solo per fare qualche nome, R.H. Thomson (Università di Aberdeen), C. Djerassi (Stanford University), K. Nakanishi (Columbia University, N.Y.), P. Scheuer (Università delle Hawaii), e tanti altri che sarebbe utile menzionare, ma renderebbe arida questa presentazione. In un primo momento, le visite di personalità di alto valore scientifico gravavano sul bilancio dell’Istituto, che con il passare del tempo divennero sempre più onerose, ma nel 1984, con gli accordi bilaterali tra CNR ed enti di ricerca di vari Paesi, si aprirono nuove possibilità di scambio a costo zero per l’Istituto. Dopo il primo accordo tra CNR e la Yugoslavia, a cui ricercatori del reparto furono coinvolti, ne seguirono molti altri, tra cui uno dei più proficui fu quello tra CNR e CSIC (Spagna). Attualmente, ogni volta che si presenta l’opportunità, ricercatori del Reparto presentano domanda per essere inseriti in questi accordi bilaterali. Infine, è doveroso segnalare la presenza attiva di ricercatori del Reparto in vari progetti finanziati dalla Comunità Europea, un ulteriore segno dell’alto valore scientifico raggiunto da tutti i ricercatori, chiaramente non va dimenticato l’apporto del personale tecnico che senza il loro valido aiuto, non si sarebbe raggiunto il livello scientifico attuale. 45 Attività scientifica della Linea di Ricerca ripiegate. Inoltre, l’approccio cristallografico e termodinamico (microcalorimetrico) su derivati di oligopeptidi Cristallografica ha mostrato una stringente correlazione tra informazio- Raffaella Puliti ni strutturali nello stato cristallino e dati termofisici relativi a passaggi di stato. Gli studi cristallografici su La Linea di Ricerca Cristallografica è presente dal 1971 ciclodestrine sono serviti a chiarire i fenomeni di inclu- nei programmi scientifici dell’Istituto C.M.I.B. Essa sione, in primo luogo le interazioni non covalenti tra rientra nella tematica generale di isolamento, caratteriz- CD e molecole ospiti, e il ruolo svolto dall’acqua sulla zazione e studio delle relazioni struttura-attività di com- stabilità di questi complessi di notevole importanza in posti di interesse biologico che da sempre ha costituito molti campi, primo fra tutti quello farmacologico. Infi- uno dei principali interessi scientifici di questo Istituto. ne, analisi cristallografiche e spettrofotometriche su L’attività si è svolta prevalentemente nel campo della coloranti cationici del gruppo acridinico tendenti strutturistica chimica ed è finalizzata alla caratterizza- all’autoaggregazione sia allo stato solido sia in soluzio- zione della struttura molecolare di sostanze naturali, ne, hanno lo scopo di fornire dati sui differenti schemi isolate in preferenza da organismi marini, e allo studio di autoassociazione di queste sostanze. Tali autoasso- chimico-fisico di molecole o complessi intesi come ciazioni rappresentano utili modelli anche per lo studio modelli per macromolecole biologiche. Nel corso delle dei processi di intercalazione di queste molecole planari ricerche, i metodi tradizionali e avanzati della strutturi- in materiale genetico. stica diffrattometrica sono stati di volta in volta affian- In particolare, tra le molte problematiche affrontate nel cati da altre metodologie chimico-fisiche, in particolare corso degli anni e riguardanti le sostanze naturali, pos- spettrofotometriche, microcalorimetriche e da calcoli di sono essere ricordati i seguenti contributi dati dinamica e meccanica molecolare. Il confronto dei ri- dall’indagine cristallografica alla caratterizzazione chi- sultati ottenuti si è dimostrato utile per chiarire e corre- mica e biologica di nuove molecole. lare il comportamento sia allo stato solido che in solu- Studi cristallografici su saraine: questi alcaloidi polici- zione di sostanze di interesse in campo biologico. In clici con caratteristiche strutturali senza precedenti tra i particolare: metaboliti la cono- spongianici scenza delle caratteristiche strutturali e di stereochimi- sono formati ca, ottenute mediante studio diffrattometrico su cristallo da una strut- singolo, ha facilitato la correlazione tra aspetti struttu- tura centrale rali e attività biologica di sostanze spesso di possibile a utilizzo in campo farmacologico, come anche la formu- protonata, lazione di corrette ipotesi sulla biogenesi delle moleco- da cui parto- Nell’ambito delle MOLECOLE NATURALI, le. Nel campo delle no MOLECOLE MODELLO, la caratte- studi cristallografici, conformazionali e termodinamici due differenti cate- OH ne O O H ha fornito dati sia sulle preferenze conformazionali di specifiche sequenze di residui di amminoacidi, sia sulla stabilità in catene polipeptidiche di particolari strutture a l - OAc rizzazione strutturale di derivati peptidici mediante gabbia, OAc Struttura molecolare della raspacionina. L’immagine sopra rappresenta il modello X-ray che indica la la stereochimica relativa dei centri chirali. 46 chiliche cicliche (sature e insature) di varia lunghezza. ziale interesse in campo farmaceutico. La complessità e peculiarità di queste affascinanti mo- Infine, un ampio programma di studi cristallografici è lecole ha reso particolarmente valido l’approccio cri- stato condotto su una serie di metaboliti spongianici del stallografico per la loro completa definizione struttura- tipo avarolo/avarone, molecole caratterizzate da sche- le. letri sesquiterpenoidici con sostituzione idrochinonica (chinonica) e che possiedono una vasta gamma di attidato vità biologiche utilizzabili in campo biomedico, data la dall’indagine cristallografica per la univoca definizione bassa tossicità delle sostanze. Questi studi sono stati della struttura delle raspacionine: metaboliti spongia- affiancati da calcoli di meccanica molecolare fornendo nici a scheletro triterpenoidico strutturalmente derivati dati, in perfetto accordo tra loro, che hanno chiarito le dello squalene isolati da Raspaciona aculeata che pone preferenze conformazionali di questa classe di moleco- ancora intriganti problematiche connesse alla classifica- le, favorendo una migliore correlazione tra aspetti strut- zione tassonomica. La studio diffrattometrico su cristal- turali e bioattività. L’accessibilità conformazionale è lo singolo di alcune di queste sostanze ha validamente infatti direttamente collegabile alle potenzialità biololo- contribuito a definirne le caratteristiche strutturali e di giche di queste molecole in quanto, una maggiore fles- stereochimica. sibilità conformazionale significa anche maggiore capa- Un sostanziale contributo è stato anche cità di adattamento per stabilire specifiche interazioni stabilizzanti con i recettori. Le collaborazioni più significative, nel corso degli anni, si sono avute con ricercatori dei seguenti Enti di Ricerca ed Università: Università “Federico II“ di Napoli Il ritrovamento di composti alogenati tra metaboliti da Università “La Sapienza” di Roma spugne e molluschi è sempre più frequente e sempre University of Sheffield più stimolanti sono le problematiche connesse alla bio- Università di Torino genesi di tali sostanze che spesso partecipano, con ruoli Università di Salerno specifici, ai meccanismi chimici di difesa della specie. Università di Bari Lo studio cristallografico condotto su vari bromoderi- Centro Studi Biocristallografia-CNR, Napoli vati (steroli, imidazoli, terpenoidi, bromoalleni) ha per- Istituto Ricerca Sviluppo Metodologie Cristallografiche messo di stabilirne univocamente la stereochimica as- -CNR, Bari soluta, mediate l’utilizzo del contributo anomalo alla Centro Termodinamica Chimica Alte Temperature- diffrazione dell’atomo pesante presente in queste mole- CNR , Roma cole. Krebs Institute Biomolecular Research, UK. Analisi cristallografiche su diverse dialdeidi insature a scheletro terpenoidico tipo poligodiale hanno fornito dati dettagliati sulla stereochimica, in particolare dei gruppi aldeidici. Tale stereochimica risulta direttamente collegata all’attività biologica di queste molecole coinvolte in specifiche strategie di difesa e quindi di poten- 47 Dai “Batteri Termofili” agli “Estremofili” tività tutti gli avvenimenti, che sono stati stemperati dal colore rosa della nostalgia e grigio dei ricordi. Il a ...? Agata Gambacorta programma di ricerca di cui dovevamo interessarci Era il 29 Settembre 1969 e mentre Lucio Battisti riprendeva nel suo primo album la celebre canzone dell’ Equipe 84: Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me Poi d’ improvviso lei sorrise E ancora prima di capire Mi trovai sottobraccio a lei…. veniva ufficialmente istituito il Reparto Batteri Ter- Sulfolobus solfataricus già Caldariella acidophila mofili del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Mo- riguardava genericamente i batteri termofili, cioè quel- lecole di Interesse Biologico (LCFMIB), chiamato li che richiedono temperature di crescite superiori ai brevemente “la chimica”, dai colleghi degli altri Isti- 50°C. Tale tema di ricerca era di grande innovazione tuti con sede in Arco Felice. Al neonato Reparto veni- negli anni 60-70 soprattutto in Italia ove solo due vano assegnati due neo “aspiranti ricercatori”: Mario gruppi si interessavano a tale ricerca. Il primo era a De Rosa ed Agata Gambacorta assunti il 1 Padova facente capo al Prof. Scoffone con due giovani Maggio1969 e 16 Giugno 1969, rispettivamente. ricercatori, Fontana e Veronesi, che si interessavano La canzone di Mogol e Battisti si presta bene ad esse- di proteine stabili e termoresistenti ed un altro guidato re parafrasata al caso del neonato Reparto Batteri Ter- dal Prof. Tecce a Roma. mofili. Infatti la scrivente conobbe il proprio futuro Perché i Termofili al LCFMIB? I neonati laboratori compagno di lavoro proprio in una riunione informale erano insediati nella terra del fuoco, i Campi Flegrei, dei neo-ricercatori del LCFMIB presso il Complesso ricchi di sorgenti calde terrestri e marine, e quindi il Turistico Damiani per discutere sul presente e sul fu- territorio dava lo spunto per una ricerca attuale e di turo del Laboratorio. Infatti seduta in quel caffè io non interesse applicativo. All’epoca non si conosceva an- avrei mai potuto prevedere i risvolti scientifici, umani cora l’esistenza degli archeobatteri e ancora non era e quant’altro ha caratterizzato poi la vita del Reparto. stata utilizzata la Taq-polimerasi per la PCR. Erano gli anni della post-contestazione sessantottina L’intuizione brillante del Prof J.D. Bu’Lock, propo- che tutti noi ricercatori avevamo conosciuto con mino- nente di tale ricerca, sull’ ampio respiro che la ricerca re o maggiore partecipazione ed il mondo girava velo- avrebbe potuto avere nel tempo, è stata ampiamente cemente. Poi all’improvviso dopo pochi giorni mi confermata dai risultati conseguiti in termini di buona trovai sottobraccio a lui, Mario De Rosa, per percor- ricerca, di collaborazioni nazionali ed internazionali e rere l’ avventura del neonato reparto per oltre quindici di diffusione di una tematica sicuramente innovativa. anni, fino al 1986, anno della sua chiamata a cattedra presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli. E’ difficile ricordare con lucidità, chiarezza ed obiet- 48 Gli inizi: come dei pionieri I primi studi potevano essere considerati pionieristici sia per i mezzi a disposizione sia per l’ inesperienza dei due giovani ricercatori. Nonostante ciò riuscimmo in breve tempo a coagulare molti interessi intorno ai termofili, tali che la tematica si diffuse rapidamente in Italia. Numerose furono le collaborazioni sia nell’ ambiente scientifico napoletano che in varie parti di Italia. In genere ai primi congressi cui partecipavamo riscontravamo sempre un grande interesse e curiosità per questi esseri viventi che sfidavano tutte le regole biologiche fino ad allora conosciute. I due giovani ricercatori all’inizio furono non poco spaesati e ciò non deve sorprendere se si tiene presente che Mario De Rosa aveva svolto la tesi sperimentale in un laboratorio di tipo biochimico-enzimologico occupandosi delle interazioni tra aspartato- e glutammato- amino trasferasi, mentre io venivo da un laboratorio di microbiologia clinica in cui i batteri erano tutti patogeni e la tesi riguardò l’ azione dell’ acido nalidixico sulla flora intestinale dei ratti. Certamente la preparazione alle spalle di ambedue era abbastanza lontana dall’ argomento proposto. Batteri termofili: chi erano costoro? Eravamo aspiranti ricercatori con contratto a termine e pertanto dovevamo impegnarci con molta grinta per diventare ricercatori aggiunti e per percorrere la strada lunghissima per diventare Direttore di ricerca, ultimo livello della vecchia normativa contrattuale CNR. Iniziammo con lo studiare e prendere contatti con gli altri due gruppi che all’ epoca in Italia si occupavano di termofili. Purtroppo tali contatti ci furono utili solo per collezionare la letteratura, poiché le proteine “padovane” erano già un prodotto avanzato della ricerca sui termofili ed il gruppo di Roma faceva essenzialmente tassonomia. LCFMIB era un laboratorio giovane formato essenzialmente da giovani con poca esperienza e sebbene fosse dotato di alcune apparecchiature di avanguardia come lo spettrometro NMR, certamente non aveva un microscopio e meno che mai un incubatore e un’ autoclave. In realtà quest’ ultima a cosa ci serviva se dovevamo fare i “termofilari”? “Termofilari o “batteristi”, erano i nomi con cui confidenzialmente ci chiamavano sia i colleghi dell’Istituto che molti collaboratori. Per sterilizzare usavamo il vecchio metodo della bollitura fino all’ arrivo di una mastodontica autoclave. Quante difficoltà dovevamo affrontare dibattendoci tra la volontà di non arrenderci ed i sorrisetti ironici dei colleghi che poco credevano a quello che facevamo. Guardavamo in un microscopio giocattolo prestatoci dal collega De Stefano, crescevamo degli “animaletti” come qualcuno li chiamava nei bidoni della Delchimica con una resistenza ad immersione che si staccava alla temperatura raggiunta grazie ai due interruttori umani: Mario che gridava stacca ed Agata che correva a staccare la spina. Le nostre frustrazioni erano grandi a fronte del lavoro svolto e dei risultati scarsissimi, mentre i colleghi già pubblicavano. Le pubblicazioni, tormento di ogni generazione di ricercatori, oggi tale tormento è dato oltre che dal numero anche dai ”fattori di impatto”. Passa tutto il 1969 e nel 1970 fui Alicyclobacillus acidocaldarius spedita in Inghilterra dal Professore Rose che si occupava di microbiologia dei termofili, sempre nel 1970 Mario venne nominato Caporeparto e venne assegnato al reparto un tecnico ausiliare: Enrico Esposito la cui esperienza lavorativa, fino ad allora, era stata essenzialmente idraulica ed elettrica. Comunque questa originaria esperienza lavorativa di Enrico anche a distanza di 30 anni è sempre stata preziosa per tutte le manutenzioni, le installazioni ed uso delle apparecchiature dalle più semplici alle più sofisticate e moderne che sono oggi in dotazione del Reparto. Ma ritorniamo alla nostra storia. Nel 1970, andando in 49 giro a campionare, dopo gli insuccessi della solfatara ove prelevavamo campioni dalle pozze calde lanciando un pentolino legato ad una canna da pesca, scoprimmo il nostro paradiso terrestre “Pisciarelli”. Le fonti naturali e, finalmente, la prima pubblicazione! A parte la bellezza del posto che sembra uscito dalla descrizione dell’ inferno dantesco con fumi che soprattutto nei giorni umidi si alzano altissimi e queste piccole pozze che bollono e tutto intorno aghi di zolfo ed un “dolce delicato profumo di idrogeno solforato”, Pisciarelli è stato la base della nostra vita scientifica. Per prima cosa rilevammo le caratteristiche chimicofisiche: temperatura tra gli 80 e i 98 °C, pH tra 0.5 e 2.5. Infatti ritornammo al Laboratorio con i pantaloni e le calze bucati, ma felici e certi, chissà perché, di avere trovato il nostro filone di ricerca dentro quelle pozze infernali. Ed è stato vero. Così, mentre venivano allestiti i nuovi laboratori nella palazzina E al piano ammezzato, isolammo il nostro primo microrganismo con temperatura ottimale 65°C a pH 3.5-4.0 che classificammo Bacillus acidocaldarius (ora Alicyclobacillus acidocaldarius) e dal quale prese vita la storia sintesi degli acidi cicloesilici. Si è anche valutato il livello di specificità del sistema enzimatico responsabile dell’attivazione del precursore cicloesanoico e del suo trasporto ai sistemi di sintesi in cui ha luogo l’elongazione per unità C2 della catena alifatica degli acidi grassi. Questo studio ha permesso di accertare che il sito attivo della transacilasi è criticamente controllato dalla geometria del precursore e che, degli elementi di riconoscimento tra enzima e substrato, il più importante è costituito dalla distanza che intercorre tra la testa polare e apolare del precursore. Dando per via fermentativa precursori esogeni non naturali con cicli da C4 a C7 si ottiene la biosintesi di una nuova serie di acidi ciclici di tipo sintetico. La presenza di questi acidi grassi ωcicloesilici sembra essere correlata al controllo della fluidità della membrana. L’inserimento di un ciclo in posizione terminale sugli acidi grassi, condizionando i gradi di libertà delle catene carboniose, mantiene, al crescere della temperatura, lo strato lipidico della membrana cellulare su valori sempre ottimali di fluidità. L’ analisi della componente lipidica delle specie di Alicyclobacillus ha portato all’ isolamento e caratterizzazione di metaboliti di tipo isoprenoidico che sono anch’ essi marker chemiotassonomici del genere in oggetto. Oltre ai normali componenti di batteri come il menachinone e gli α-cis-prenoli, si trovano anche composti inusuali come i prenoli tutti trans. scientifica del lipidi di Con Pisciarelli e con i lipidi del Bacillus acidocalda- membrana. il rius arrivò anche la prima sospirata pubblicazione su nostro primo interesse Chem. Comm., 619, (1971) “Bacterial triterpenes”, il sulle molecole di inte- cui reprint mi venne consegnato da Mario all’ uscita resse biologico sui ter- della Chiesa dopo il mio matrimonio. Infatti a parte la mofili fu rivolto allo studio della componente lipidica. ricerca, la nostra vita privata andava avanti. Sempre Hopene-b Infatti nel 1971 veniva assegnato al reparto un altro tecnico, I lipidi di membrana di questo batterio contengono acidi grassi saturi, lineari e ramificati e due nuovi acidi identificati come ωcicloesilundecanoico e acido ω cicloesiltridecanoico. Di questi acidi è stata studiata l’origine biogenetica con esperienze di incorporazione di precursori marcati. Si è messo così in evidenza che la porzione cicloesilica è originata da acido scichimico che, attraverso una nuova via biogenetica, dà origine ad un precursore C7 di tipo cicloesancarbossilico che funziona da precursore per la Salvatore Sodano e nasceva il primo figlio di Mario De Rosa. Il secondo amore non si scorda mai Ma la nostra vera fortuna scientifica fu l’isolamento, sempre dal nostro Eden, del secondo microrganismo classificato in un primo momento come Caldariella acidophila e poi, con la scoperta degli archeobatteri, riclassificato Sulfolobus solfataricus. L’ isolamento di 50 che vorrei qui ricordare. Intorno alla metà degli anni ’70 arriva anche il primo fermentatore in vetro da 90 litri, un prototipo della Ditta Terzano. I primi studi eseguiti sul Sulfolobus furono sui lipidi di membrana ai quali apportarono i loro contributi Salvatore De Rosa, ricercatore del Reparto dal 1974 al 1978 e Barbara Nicolaus, borsista dal 1978, che è poi stabilmente rimasta nel Reparto fino ai nostri giorni. I risultati ottenuti sulla struttura dei lipidi di membrana del Sulfolobus hanno aperto un nuovo capitolo della chimica, biochimica e chimica-fisica dei lipidi. Con il passare degli anni la nostra esperienza sui lipidi eterei questo nuovo microrganismo coincise con la nascita fu sempre più ricca in funzione del sempre più nume- del mio unico figlio. Correva il fortunato anno 1972. roso ritrovamento di archeobatteri. Tale esperienza ha permesso di stabilire numerosissime collaborazioni L’ archeobatterio Sulfolobus solfataricus (Caldariella acidophila) è stato isolato da piccole pozze calde, 90°C pH 1.0, del crinale SE della solfatara di Pozzuoli ed è stato sicuramente uno dei primi archeobatteri termoacidofili scoperti e studiati con molto approfondimento. Esso pur crescendo in condizioni estreme, 87°C pH 3.5, è tra tanti archeobatteri uno dei più versatili per l’ottenimento di biomasse e per la manipolazione stessa del microrganismo. Il Sulfolobus è stato studiato sia per la fisiologia di crescita che per la comprensione di metabolismi che di molecole di interesse applicativo, come gli enzimi. Da ultimo, ma certamente non meno importanti sono stati gli studi sulla struttura, biogenesi e fisiologia dei lipidi di membrana e loro assemblaggio in seno alla membrana. Dall’isolamento del Sulfolobus ci fu un fiorire di collaborazioni in tutta Italia su argomenti di più svariato approfondimento che hanno dato un contributo notevole per la comprensione della termofilia e dell’evoluzione e fisiologia degli archeobatteri. Si apre un decennio ricchissimo di riconoscimenti con inviti a tenere letture in Congressi Nazionali ed Internazionali in consessi scientifici di differente estrazione culturale, dalla chimica, alla microbiologia, alla biochimica. Numerose furono le novità scientifiche e le collaborazioni, alcune delle quali ancora in essere. Molti collaboratori sono poi diventati dei cari amici soprattutto con i tassonomisti che si avvalgono dell’ analisi dei lipidi per orientare le prove fisiologiche per la caratterizzazione dei nuovi isolati. Gli archeobatteri sono microorganismi appartenenti al Dominio Archaea che è il terzo dominio degli essere viventi. Esso comprende tutti procarioti estremofili che vanno dall’estrema termofilia all’estrema alofilia, alcalofilia, stretta anaerobiosi. Essi sono raggruppati in due regni: Euryarchaeota e Crenarcheota. I lipidi sono basati su alcooli isoprenoidici, in genere saturi, di differente lunghezza che formano legami eterei con la glicerina con configurazione sn-2,3 e non si trovano acidi grassi. Il componente ubiquitario è l’archeolo, 2,3-di-O-fitanil-sn-glicerolo, che ha catene isoprenoidiche a 20 atomi di carbonio e abbastanza diffuso è anche il suo dimero, difitanilgliceroltetraetere, chiamato caldarcheolo. Varianti di questi tipi base sono state riscontrate. Archeoli insaturi, catene con 25 atomi di carbonio combinate con un’altra catena C25 o C20, 3-idrossifitanil derivati, ciclopentani nelle catene C40 (3R,7R,11R,15S,18S,22R,26R,30R3 , 7 , 1 1 , 1 5 , 1 8 , 2 2 , 2 6 , 3 0 octametildotriacontani) di vario numero e posizione, sono gli altri “core lipids” riscontrati negli archeobatteri. Un altro tipo strutturale, calditolcaldarcheolo, è formato da una glicerina con due catene C40 e un poliolo con un ciclopentanotetraolo. L’ unicità delle strutture lipidiche degli archeobatteri si riflette 51 Modello di membrana in Sulfolobus solfataricus, un termofilo estremo anche a livello della loro architettura in seno alla membrana citoplasmatica e delle loro proprietà chimico-fisiche che si sono rivelate interessanti per applicazioni biotecnologiche come la preparazione di liposomi per impieghi farmacologici e cosmetici. I lipidi polari degli archeobatteri sono basati sugli archeoli, caldarcheoli e calditolcardarcheoli legati a teste polari che vanno dagli zuccheri, a gruppi fosfati e ad inositoli. Nonostante la loro struttura sia difficile da determinare, tuttavia, essi sono molto utili anche ai fini tassonomici, in quanto la loro struttura è spesso genere-specifica. I lipidi polari basati sull’archeolo e le sue varianti sono simili alle corrispondenti strutture da batteri ed eucarioti, invece quelli basati sui macrocicli sono caratteristici dei lipidi degli archeobatteri. Gli aminolipidi mancano nel fenotipo degli alofili e degli ipertermofili, ma si ritrovano nel fenotipo dei metanogeni. I lipidi polari degli alofili sono fenotipo-specifico e sono caratterizzati da glicolipidi solforati e da fosfolipidi relazionati al fosfoglicerolo e al fosfoglicerolfosfato, è presente anche un fosfosolfoglicerolo. Caratteristica è la seconda glicerina di questi lipidi che ha configurazione sn-1,2. I lipidi polari basati sui macrocicli, possono presentare una sola testa polare legata ai macrocicli o due teste polari, ma di differente natura, legate ai due lati opposti dei macrocicli; infatti, una caratteristica dei lipidi degli archeobatteri è la loro asimmetria. In molti casi guardando tutte le strutture dei lipidi polari di uno stesso microorganismo sembra che i lipidi basati sui tetraeteri siano i dimeri di due lipidi polari basati sugli archeoli. Questa osservazione porta all’ ipotesi biogenetica che i lipidi polari si biosintetizzino a partire da precursori insaturi che dopo funzionalizzazione, vanno soggetti a dimerizzazione ed eliminazione delle insaturazioni. In molti casi questa ipotesi è stata confermata da esperimenti con opportuni precursori marcati e non. Numerosi studi sono stati eseguiti per verificare il rapporto tra la struttura dei lipidi e le condizioni di crescita. G l i a r c h e o b a t t e r i v e r o s i m i l me n t e rappresentano il relitto arcaico delle più primitive forme di vita comparse sul nostro pianeta. Sono in accordo con una tale ipotesi una interessante serie di studi geochimici che, traendo spunto dai dati chimicospettroscopici ottenuti sui lipidi di Sulfolobus, hanno portato ad identificare in sedimenti terrestri e marini e in depositi petroliferi di antichissima datazione, idrocarburi isoprenoidici C40 anche variamente ciclizzati. Alla luce di queste evidenze i lipidi degli archeobatteri rappresentano uno dei più antichi esempi di biogenesi isoprenica. Studi di incorporazione di acetato e mevalonato opportunamente marcati confermano l’origine isoprenica delle catene C40 dei lipidi di Sulfolobus. Studi recenti, che hanno tenuto conto della diffusa presenza della “non mevalonato pathway” non hanno smentito che i lipidi degli archeobatteri seguono la via mevalonica. La complessità della struttura dei lipidi degli archeobatteri non ha ancora permesso di chiarire tutta la via biogenetica che porta alla formazione del lipide finito. La struttura e le dimensioni dei macrocicli tetraeterei, l’assenza di un piano di rottura preferenziale dei microorganismi con lipidi tetraeterei, l’estrema rigidità degli aggregati dei lipidi termofili archeobatterici, esperimenti di marcatura con agenti non penetranti sulle cellule intatte e le proprietà delle membrane nere ottenute con i lipidi tatraeterei supportono l’ipotesi che i macrocicli tetraeterei sono strutturati nelle membrana biologica come doppio strato covalentemente legato. Si passa a tale modello da una membrana formata da C20C20 che forma un “classico” doppio strato, ma con interazioni certamente più forti che non quello basato su lipidi lineari o comunque poco ramificati, alla membrana con effetto “cerniera lampo” di alcuni aloalcalofili in cui ambedue o una delle catene è C25, 52 causando una penetrazione profonda nello strato opposto a quella dei metanogeni ed alcuni termofili in cui si alternano in proporzioni variabili catene C20 e catene C40, nei quali si alternano pertanto doppi strati a doppi strati covalentemente legati. Il modello di membrana dei termofili estremi con legami covalenti nel centro della membrana assieme ai ciclopentani controlla l’omoviscosità della membrana alle alte temperature di crescita. Una volta definita la struttura dei lipidi del Sulfolobus si iniziarono in collaborazione con Sandra Gliozzi, dell’ Università di Genova studi chimico-fisici. Lo studio della disposizione dei lipidi all’ interfaccia aria-acqua è stata molto studiata anche in vista delle applicazioni biotecnologiche dei lipidi. Tali studi hanno dimostrato che mentre gli archeoli hanno un comportamento simile ai lipidi esterei, differente è quello dei lipidi basati sui tetraeteri. Infatti a priori si può ipotizzare che questi possono assumere sia una forma ad U che una forma distesa. I lipidi basati sul caldarcheolo assumano una forma ad U, mentre quelli basati sul calditolcardarcheolo cambiano configurazione in funzione della pressione che viene applicata. Studi di microscopia elettronica hanno dimostrato che è possibile passare dalla forma metastabile distesa a quella stabile passando da alte pressioni a pressioni più basse. Le isoterme pressione-aria mostrano una regione di “plateau” che indicano la presenza di un primo ordine di transizione. Il “core lipids” calditolcaldarcheolo, può dare luogo a membrane artificiali secondo le tecniche classiche se si opera però a temperature superiori ai 40°C. Studi del comportamento di queste membrane in un intervallo di temperatura da 6 a 80°C dimostrano che essi formano un monostrato in cui le molecole sono distese nell’ intero spessore della membrana stessa. Non tutte le frazioni lipidiche dei lipidi tetraeterei formano monostrati come ad esempio il caldarcheolo. Membrane asimmetriche si sono ottenute con una nuova tecnica ed usando il calditocaldarcheolo come frazione lipidica. Studi di conduttanza e capacitanza hanno dimostrato che le membrane artificiali a monostrato ottenute dai lipidi archeobatterici si comportano da buoni isolanti e che le molecole ionofore inducono piccoli incrementi nelle conduttanza di queste mem- brane rispetto a quelle delle corrispondenti membrane artificiali ottenute con il lipidi monopolari. Vi è oggi una grande richiesta di liposomi con caratteristiche meccaniche, termiche e di stabilità, in generale, per le più svariate applicazioni, come trasporto di farmaci e preparazione di membrane per processi di separazione. I lipidi bipolari da archeobatteri offrono interessanti proprietà, dovute allo loro organizzazione in monostrato, alta resistenza chimica (completamente saturi e basati su legami eterei). Questi lipidi sono pertanto resistenti alle ossidazioni, alle esterasi e pertanto sono stabili in larghi intervalli di pH e di temperatura. Inoltre contaminanti batterici e virali possono essere agevolmente eliminati per autoclavaggio, che non è possibile con i liposomi preparati con lipidi esterei. Dopo la classificazione del Sulfolobus iniziammo alcune collaborazioni sull’enzimolgia di tale microrganismo. Il primo lavoro di enzimologia sul Sulfolobus fu in collaborazione con Marcello Cacace sulla RNApolimerasi-DNA dipendente. Con tale lavoro partecipammo, nel 1975, al primo congresso mondiale sui termofili a Zurigo, al quale parteciparono da tutto il mondo circa sessanta ricercatori. Con l’amico Buonocore, con il quale avevamo già una collaborazione sull’ α-amilasi da Bacillus acidocaldarius, iniziammo poi a lavorare sul metabolismo del glucosio in Sulfolobus e gli enzimi ad esso relazionati. Questo microorganismo è capace di crescere su terreni minimi a base di carboidrati semplici e complessi a base di glucosio. I nostri studi hanno dimostrato che il microorganismo metabolizza il glucosio attraverso due vie biogenetiche. La prima comporta una fosforilazione ossidativa ATP-dipendente, che porta a glucosio-6-fosfato, rapidamente isomerizzato a fruttosio-6-fosfato. Nella seconda il glucosio, ad opera di una deidrogenasi NAD-dipendente è ossidato a gluconato; questo successivamente subisce una disidratazione a 2-cheto-3-deossi-gluconato, da cui per azione di un’ aldolasi si ottengono piruvato e gliceraldeide. La conversione del glucosio a piruvato rappresenta un nuovo tipo di via biogenetica, che si differenzia dal ciclo di Entner-Doudoroff per l’ assenza di processi di fosforilazione a livello di metaboliti intermedi. 53 Sempre a metà degli anni ’70 nacque una lunga e proficua collaborazione nonché una lunga amicizia con Piero Cammarano dell’ Università La Sapienza di Roma sullo studio del complesso ribosomale e la sintesi proteica. In una serie di lavori si individuano gli elementi responsabili della termostabilità del complesso ribosomale dell’archeobatterio Sulfolobus solfataricus, analizzando comparativamente le proprietà del sistema ribosomale di Bacillus (Alicyclobacillus) acidocaldarius e di Escherichia coli, due batteri di cui il primo termofilo ed il secondo mesofilo. In alcuni studi si è anche esaminato il fegato di ratto, al fine di evidenziare gli elementi di similitudine esistente tra la linea evolutiva degli archeobatteri e quella degli eucarioti. Gli studi sono stati eseguiti analizzando 1) stabilità termica, 2) composizione in basi dei tratti a singola elica, 3) lunghezza dei tratti a doppia elica che fondono indipendentemente, 4) contenuto dei tratti elicizzati del rRNA. I “melting” degli rRNA di Sulfolobus solfataricus sono superiori a quelli dei due batteri di confronto così come i tratti elicizzati sono più ricchi in coppie CG, la lunghezza dei tratti elicizzati che fondono indipendentemente risulta maggiore in paragone ai due modelli batterici. L’insieme di tali fattori rende il sitema ribosomale dell’ archeobatterio più stabile dei modelli di paragone. In ogni caso per spiegare l’elevata temperatura di “melting” dei ribosomi del Sulfolobus bisogna tenere conto che un ruolo non secondario, deve essere svolto dalle proteine ribosomali e dalla natura delle interazioni proteinerRNA. Studi eseguiti in tal senso hanno dimostrato che tali interazioni sono molto più forti nel modello archeobatterico che non in quelli batterici di paragone. Sono stati eseguiti studi tesi a valutare la massa delle subunità ribosomali di Sulfolobus. I risultati ottenuti hanno dimostrato che la subunità 30S di Sulfolobus ha una massa maggiore dei modelli di confronto mentre la subunità 50S dell’archeobatterio, pur avendo una massa maggiore dei modelli di paragone è tuttavia più simile ad essi. Tale aumento è imputabile al contenuto proteico, che è risultato essere in numero maggiore con una massa complessiva di circa due volte superiori ai modelli batterici con una quantità di cariche positive nettamente inferiore ai modelli di confronto. Pyrodictium occultum i cui lipidi di membrana sono stati studiati in collaborazione con il Prof. K.O. Stetter Le caratteristiche della subunità 30S ricordano quelle della subunità 40S degli eucarioti. Questa osservazione suggerisce una più stretta relazione degli archeobatteri con gli eucarioti. Tale ipotesi, confermata anche da altri studi genetici ed enzimatici non ha ancora oggi una valida conferma e fiumi di letteratura sono stati scritti in proposito. Molti lavori mostrano come a livello molecolare la cellula eucariota possa essere considerata una chimera filogenetica in cui si ritrovano caratteristiche batteriche ed archeobatteriche. Il sistema di sintesi proteica dei cloroplasti e dei mitocondri è di tipo batterico, alcune proteine ribosomali e il fattore EF-2 hanno similitudini strutturali con quelle di origine archeobatteriche. Il fattore di elongazione in Sulfolobus è funzionalmente analogo al fattore EF-Tu batterico ma non mostra la stessa sensibilità agli antibiotici di quello batterico e non mostra determinanti antigenici comuni con EFTu (fattore di elongazione batterico). La pulvomicina e la kirromicina bloccano specificamente l’ attività di EF-Tu ma non quello da eucarioti (EF-1). Il fattore da Sulfolobus è insensibile ai due antibiotici. Tale comportamento non è dovuto alla temperatura poiché in Thermus thermus, un batterio più termofilo del Sulfolobus non si riscontra, mentre la stessa risposta agli antibiotici si evidenzia in un modello alofilo archeobatterico. Resta comunque da capire la relazione filogenetica con il fattore EF-1 eucariotico. Sempre nella metà degli anni ’70 nasceva una collaborazione che sicuramente ha influito poi sul destino accademico di Mario De Rosa e alla nascita di un lun- 54 dalla presenza di una forza ionica citoplasmatica eccezionalmente elevata. La simultanea presenza di queste due poliammine negli archeobatteri alofili e termofili potrebbe suggerire l’ esistenza di specifici ruoli di questi policationi nella stabilizzazione delle strutture cellulari esposte a stress ambientali come temperatura e forza ionica. Questa particolare condizione microambientale è non secondaria rispetto al ruolo chiave giocato delle poliammine in “vivo”, legato al crearsi di interazioni elettrostatiche più o meno specifiche con importanti classi di componenti cellulari. I risultati mostrano una generalizzata presenza della caldina e della termina nel pool delle poliammine degli archeobatteri alofili. La simultanea presenza di queste due poliammine negli archeobatteri alofili e termofili potrebbe suggerire l’ esistenza di specifici ruoli di questi policationi nella stabilizzazione delle strutture cellulari esposte a stress ambientali come temperatura e forza ionica. Collegati alla via delle poliammide sono gli studi di purificazione e caratterizzazione degli enzimi propilammino transferasi, S-adenosilsintetasi, Sadenosildecarbossilasi e metiltioadenosina fosforilasi nell'archeobatterio termofilo Sulfolobus solfataricus. go sodalizio scientifico ed umano, che dura con immutato affetto ancora oggi. Sto parlando del gruppo del Professore Zappia con il quale abbiamo studiato la caratterizzazione e la biosintesi delle poliammine nel Sulfolobus e gli enzimi ad essa relazionati. Tra i collaboratori, non posso fare a meno di ricordare le Prof. Cartenì-Farina, Giovanna Cacciapuoti e Marina Porcelli, con le quali ho avuto una stretta collaborazione durata molti anni e con le quali si è stabilito un rapporto di affetto e stima reciproca. E’ stata esaminata la composizione in poliammine del Sulfolobus solfataricus (Caldariella acidophila). Si è visto che accanto alla spermidina, si trovano due nuove poliammine, denominate caldina (sim-nor-spermidina) e termina (sim-nor-spermina). L’ identità strutturale dei due nuovi policationi è stata ottenuta mediante tecniche di spettroscopia NMR e MS. La biosintesi è stata studiata somministrando opportuni precursori marcati alle culture di Sulfolobus solfataricus. I risultati ottenuti hanno suggerito che 1,3 diammino propano, proveniente dalla degradazione della spermidina, addiziona il gruppo propilamminico della S-adenosil(5’)3-metilpropilammina, dando luogo a caldina e metiltioadenosina. La triammina reagisce con una seconda molecola di composto di solfonio formando sim-nor-spermina e metiltioadenosina. Al fine di accertare il valore chemiotassonomico delle due nuove poliammine nella linea evolutiva degli archeobatteri si è condotta un’ indagine sistematica sulla composizione in poliammine di un altro gruppo di archeobatteri, quello degli estremi alofili, caratterizzati Vi sono state anche collaborazioni occasionali limitate ad un solo argomento come con il Prof. Marino e con il Prof. Bocchini, ambedue della Federico II (aspartato ammino trasferasi e fattori di elongazione da Sulfolobus solfataricus), Prof. Scandurra, dell’ Università La Sapienza, sulla glutammico deidrogenasi. Gli anni 80: persone nuove e collaborazioni nuove Gli anni ’70 finivano con un bel riconoscimento ai nostri sforzi: il conferimento della Medaglia Ciamician a Mario De Rosa per le ricerche sui lipidi degli archeobatteri. Il 1980 è l’inizio di un nuovo decennio che vede Mario de Rosa prima Direttore pro-tempore dell’Istituto per la Chimica di molecole di interesse biologico (ICMIB) e poi Direttore fino al 9 Gennaio 1986. Subentro, pertanto, come responsabile del Reparto. Alcuni dipendenti con le borsiste MISM in un momento sportivo. In piedi da sinistra: Lopez, Di Maso, Lama, Manca; seduti da sinistra: Marsiglia, Improta, Palmieri e Esposito. Gli anni ’80 portano al consolidamento dell’attività scientifica dei primi dieci anni. Tale consolidamento è avvenuto grazie al discreto numero di nuovi assunti 55 assegnati al Reparto stesso. Barbara Nicolaus entra parto. Cominciamo ad occuparci di alofili e non solo definitivamente in ruolo, arrivano Virginia Lanzotti, di termofili. La collaborazione con il Prof. Grant per- ricercatore, Valeria Calandrelli ed Eduardo Pagnotta, mette a persone del Reparto di recarsi come ospiti prima come personale in formazione e poi come tecni- presso i laboratori dell’Università di Leicester. Altre co di ruolo, Ida Romano, come personale tecnico, preziose collaborazioni nascono con il gruppo del Antonio Trincone, prima come tecnico e poi come Prof. Zillig e del Prof. Stetter con i quali si ha uno ricercatore, Licia Lama, prima come borsista e poi scambio molto importante di ceppi, di visite e di in- come ricercatore. Nascono nuove collaborazioni formazioni con importanti contributi sia sulla tematica all’interno dell’ Istituto con Guido Sodano, con Istituti dei lipidi degli estremofili che sulla tassonomia degli vicini, con il Prof. archeobatteri. Rossi dell’IBPE, La nuova linfa immessa dai giovani assunti ci spinge con il Dipartimen- verso tematiche nuove e si comincia a lavorare in to di Chimica di un’area più biotecnologia che vede l’utilizzo di cellule Ingegneria con il intere, più raramente di enzimi, per l’ ottenimento di Prof. Drioli e si reattori enzimatici per reazioni di biocatalisi. A titolo consolidano di esempio riporterò alcuni studi su un’attività amiloti- le collaborazioni ca da Sulfolobus. intraprese nel decennio precedente. Con il Prof. Drioli della Federico II Enrico Esposito in Antartide ci siamo interessati della preparazione di bioreattori utilizzando sia la β -galattosidasi purificata da Sulfolobus sia cellule intere o parziali purificati. Si sono preparate membrane piane e capillari con la tecnica dell’ inversione di fase, di cellulosa e polisolfone. La preparazione di tali membrane per l’ allestimento di reattori enzimatici, è stata resa possibile dalle caratteristiche di stabilità delle cellule di Sulfolobus e del suo patrimonio enzimatico. Infatti il metodo utilizzato è denaturante per tutti gli enzimi da fonti convenzionali. Lasciano il Reparto Mario De Rosa, in quanto chiamato a ricoprire una cattedra universitaria, Virginia Lanzotti, vincitrice di un posto di ricercatore all’ Università del Molise e Salvatore Sodano. Si stabilisce una stretta collaborazione con dell’Università di Leicester, il Prof. Grant per due volte visiting professor presso il nostro Istituto. Tale collaborazione porta alla nascita di un nuovo filone di ricerca nel Re- Un’ attività amilolitica capace di produrre trealosio è stata parzialmente purificata e caratterizzata per la prima volta da Sulfolobus solfataricus. Tale attività è funzionante in un ampio intervallo di pH con un pH ottimale spostato verso valori acidi. A differenza da altre attività isolate da S. solfataricus questa attività non è molto termofila, avendo una temperatura ottimale di 70°C, ben 17°C inferiore alla temperatura ottimale di crescita. Viceversa la termostabilità è molto elevata. Molto interessante sono i prodotti di idrolisi di tale attività in funzione dei substrati saggiati. Usando glicogeno si ottiene solo glucosio alla fine della reazione, mentre usando amido, amilopectina e amilosio si ottengono con rapporti variabili, glucosio e lo zucchero non riducente, trealosio identificato mediante spettroscopia NMR. Usando oligosaccaridi da due unità fino a sette unità glucosidiche si vede che maltosio non è substrato, maltotriosio origina glucosio e maltosio e dagli altri si ottiene glucosio, maltosio e trealosio. Incubazioni a tempi brevi da questi substrati dà come prodotto maggiore il trealosio, a partire da substrati a 5 unità saccaridiche. Dai risultati ottenuti si possono fare due ipotesi per la formazione del trealosio: il disaccaride è biosintetizzato solo quando nel mezzo si raggiungono livelli elevati di glucosio; il trealosio si forma per un meccanismo concertato di 56 enzimi intramolecolare. Per distinguere tra queste due ipotesi si sono eseguiti esperimenti con precursori marcati e analizzati i prodotti mediante spettroscopia NMR. I risultati hanno confermato una formazione intramolecolare del trealosio. Il disaccaride non riducente riveste un grande interesse biotecnologico, pertanto si è studiata la capacità di produzione del trealosio usando cellule intere immobilizzate in sodio alginato. strutturali della/e proteina/e sulfolobale/i con le corrispondenti da mesofili. Immunoblots con gli anticorpi anti-enzimi eucariotici indicano una specifica cross-reattivita' con una componente di massa 50kDa, corrispondente a meno della meta' delle dimensioni dell'enzima poli-ADPribosilante nucleare (116kDa). La proteina di 50kDa e’ stata purificata all’ omogeneita’ e ne sono state determinate le principali caratteristiche cinetiche e biochi- La collaborazione con il gruppo del Prof. Rossi, sulla caratterizzazione di una serie di enzimi e loro applicazioni da Sulfolobus: DNApolimerasi, enzima malico, β-galattosidasi, alcool deidrogenasi diventa in questi anni molto attiva. Alcune di queste attività enzimatiche purificate vengono utilizzate per reazioni di biotrasformazioni. Contemporaneamente si stabilisce un’ intensa collaborazione con le Prof. Farina e Faraone Mennella della Federico II su un tema molto innovativo, mai affrontato nei termofili e negli archeobatteri: studio sul sistema di ADP-ribosilazione. Tale collabo- Cyanospira rippkae e il triolo α-glucoside isolato dagli eterocisti miche. razione continua con profitto e con grande affiatamento ancora oggi. Si e' voluto indagare sull'eventuale presenza di un sistema ADPribosilante in Sulfolobus solfataricus e sulle proprieta' che caratterizzano tale reazione, tenendo presente che questo microrganismo vive in condizioni estreme di temperatura (87°C) e di pH (3.5). E' stata messa in evidenza una definita attivita' ADPribosilante, i cui livelli sembrano essere in relazione con le fasi di crescita dell' archeobatterio, raggiungendo i valori piu’ elevati nella tarda fase logaritmica. Il sistema e' attivo ad una temperatura di 80°C e non sembra sensibile a variazioni di pH comprese tra 5.0 e 8.0; non si osservano variazioni notevoli di attivita' dopo prolungata esposizione (24 ore) alle elevate temperature (60- 80 °C) . Risultati preliminari sull'identificazione dei prodotti della reazione enzimatica depongono per la presenza, in S. solfataricus, di un sistema di poli-ADPribosilazione Studi immunochimici condotti utilizzando anticorpi policlonali diretti contro gli enzimi eucariotici, sia mono(ADPR)transferasi che poli(ADPR)polimerasi, hanno messo in evidenza che la preparazione enzimatica da S. solfataricus e' in grado di reagire con entrambi gli anticorpi, suggerendo analogie Alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 per due anni il Reparto ospita quattro borsiste dell’ accordo MISM-CNR. Alla fine degli anni ’80 gli interessi scientifici del Reparto Batteri Termofili sono rivolti non solo ai termofili, ma agli estremofili in generale, soprattutto alofili ed alcalofili. Grazie a tale esperienza il gruppo di ricerca del Reparto partecipa al Progetto Nazionale Ricerche in Antartide che ha permesso al Sig. Esposito di recarsi per due volte in Antartide. Tale partecipazione alla campagna antartica è stata di grande profitto. A parte l’esperienza personale di Enrico che ha potuto visitare un Continente così lontano, le campagne da lui effettuate sono state molto proficue perché ci hanno permesso di isolare nuovi termofili ed alofili dai suoli vulcanici e salini della terra del freddo. L’avventura antartica dura ancora nel nuovo millennio e ci auguriamo di potere partecipare al PNRA anche nel prossimo biennio in fase di approvazione. Quasi a volere stabilire un filo conduttore con Arco Felice, 57 58 Uno sguardo dall’esterno Diversi dipendenti dell’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico nel corso della loro carriera hanno rivolto il loro sguardo all’esterno: dal Prof. Luigi Minale proseguendo con diversi altri. L’ultimo esempio riguarda il Dr. Antonio Malorni; in questa sezione viene descritta brevemente l’attività del personale ex-ICMIB che sta continuando la carriera scientifica non più al servizio dell’Istituto. Molti, se non tutti, hanno sempre continuato a collaborare con Mario De Rosa - dimissioni 1986 Il Prof. Mario De Rosa è autore di oltre 231 lavori su riviste scientifiche internazionali e di 18 brevetti Laureato con lode in Chimica nell’Università di Napoli nel novembre 1968 1969 Ricercatore CNR 1970 Responsabile del reparto Batteri Termofili dell’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico ( ICMB ) del CNR 1973 Membro del Consiglio Scientifico del ICMB 1975 Ricercatore capo del CNR 1978 Incaricato supplente di Chimica e Propedeutica Biochimica all’Università di Napoli, I° Facoltà di Medicina 1978-85 Professore incaricato di Chimica e Propedeutica Biochimica all’Università di Napoli, I° Facoltà di Medicina 1981 Vincitore della Medaglia Ciamcian della Società Chimica Italiana 1981-86 Direttore dell’ICMB del CNR di Napoli 1981-91 Membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto per lo Studio delle Sostanze Naturali di Interesse Alimentare e Chimico Farmaceutico del CNR di Catania 1983-91 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Biochimiche gestito da un consorzio tra le Università di Napoli e Bari 1985 Professore associato di Chimica e Propedeutica Biochimica all’Università di Napoli, I° Facoltà di Medicina 1986 Dall’11 luglio professore straordinario di Chimica e Propedeutica Biochimica all’Università di Napoli, I° Facoltà di Medicina 1989 Dal 30 maggio opta sulla cattedra di Chimica Medica all’Università di Napoli, I° Facoltà di Medicina 1989 Membro del Consiglio Scientifico di Finbiotec. 1990 Dall’11 luglio professore ordinario di Chimica e Propedutica Biochimica all’Università di Napoli, I° Facoltà di Medicina 1992 Membro del Consiglio Scientifico di Technobiochip 1994-1998 Responsabile nazionale del gruppo Biotecnologie Biochimiche della Società Biochimica Italiana 1996 Membro del C.D.A. della Seconda Università di Napoli 1998 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “ Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche” 1999 Delegato del Rettore per il Polo Medico della Seconda Università di Napoli. Virginia Lanzotti - dimissioni 1985 La Prof. Virginia Lanzotti è titolare di Chimica Organica Presso il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università del Molise Campobasso 1982 Laurea in Chimica (110 e lode) 1982 Borsa di studio presso il Dipartimento di Chimica delle Sostanze naturali Università di Napoli diretti dal Prof. Fattorusso 1985 Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Arco Felice (Napoli) 1985 Vincitrice di una Borsa di studio del CNR presso l’Università di Bonn, Germania, nei laboratori diretti dal Prof. Eberhard Breitmaier. 1988 Ricercatore di Chimica Organica alla Facoltà di Agraria, Università del Molise 1989 Vincitrice di una borsa di studio EMBO (European Molecular Biology Organization) all’Università di Leiden (Olanda) nei laboratori diretti dal Prof. Cornelis Altona 1992 Presa di servizio come Professore Associato di Chimica Organica presso la Facoltà di Agraria, Università del Molise 1993 Commisario di concorso per un posto di ricercatore all’Istituto Zooprofilattico di Teramo 1994 Contratto come “Visiting Scientist” all’Università di Leiden (Olanda) nei laboratori diretti dal Prof. Cornelis Altona. Antonio Malorni - dimissioni 2001 Il Dr. Antonio Malorni è Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR (Avellino) 1968 Laurea in Chimica indirizzo Organico-Biologico 1969 Addestramento post-laurea in spettrometria di massa sotto la guida del Prof. John M. Wilson Department of Chemistry University of Manchester 1972 Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Arco Felice (Napoli) 1981 Direttore responsabile del SESMA prima e del CISESMA successivamente, nochè membro del relativo comitato tecnico-scientifico 1985 Primo ricercatore CNR 1991 Dirigente di ricerca CNR 2000 Trasferimento all’Istituto di Scienza dell’alimentazione del CNR 2001 Direttore dell’Istituto di scienza dell’alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche Nel periodo Maggio 1988-Maggio 1994 è stato membro del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Chimiche del CNR. Nel periodo Giugno 1988-Maggio 1994 è stato membro del Comitato Nazionale di Consulenza per le Biotecnologie e Biologia Molecolare del CNR e di questo comitato è stato membro del Consiglio Direttivo. Con decreto del Presidente del CNR dal 4 Luglio 1992 svolge la funzione di esperto nel consiglio scientifico dell'Istituto per la Chimica e la Tecnologia dei Materiali Polimerici di Catania. Dal Maggio 1997 e fino al 2001 è il rappresentante del CNR nel Consiglio di Amministrazione della Seconda Università degli Studi di Napoli. 59 Raffaele Riccio - dimissioni 1992 Il Prof. Raffaele Riccio è Ordinario di Chimica Organica e Preside della Facoltà di Farmacia dell’Università di Salerno Laurea in Chimica (indirizzo Organico-biologico) conseguita presso l'Università di Napoli il 21.07.1972 con voti 110/110 e Lode. 01.04.1973 - 19.11.1987 Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico, Arco Felice NA. 15.10.1976 - 15.11.1977 Junior researcher, Department of Chemistry University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii (USA). 01.11.1987 - 31.10.1994 Professore Associato di Chimica Organica, Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dall’01.11.1994 Professore Ordinario di Chimica Organica, Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno maggio 1998 – novembre 2000 Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Salerno dal 01.11.2000 Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Salerno Aldo Spinella - dimissioni 1992 Il Prof. Aldo Spinella è Professore Associato di Chimica Organica Università di Salerno 1977 Laurea con lode in Chimica Ha fatto parte del Settore Sviluppo Chimico della Divisione Fermentazioni della Ciba-Geigy SpA 1983 Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Arco Felice (Napoli) 1988-89 Ha svolto attività di ricerca presso il Monell Chemical Senses di Filadelfia e presso la Scripps Institution of Oceanography di S. Diego (California) 1992 Professore Associato di Chimica Organica Università di Salerno Aldo Spinella in una vignetta dell’Istituto. Alfonso Cantilena che saluta Mario De Rosa. Tra gli altri dalla sinistra: Rosaria Vaccaro, Aniello Lopez, Antonio Malorni e in ultimo Ciro Di Micco. Raffaele Riccio, seduto con Raffaele Turco e uno studente in piedi, nel 1970. Aldo Spinella, Ida Romano e Antonio Trincone i neo-assunti del 1983. 60 L’ICMIB nel mondo L’attività dell’Istituto, sin dalla sua fondazione, è stata sempre caratterizzata da intensi rapporti scientifici internazionali. Si è già detto quanto questo aspetto fu presente durante gli anni della direzione del prof. Nicolaus. Da questo punto di vista non mancano all’appello le altre direzioni e numerosi ricercatori con contatti scientifici internazionali di alto livello. E’ certamente privo di speranza ogni tentativo di collezionare con completezza il numero di seminari tenuti da ospiti italiani e stranieri in Istituto o quello di elencare i rapporti internazionali nel corso di questi anni. Pertanto per caratterizzare questo aspetto abbiamo voluto raccogliere rappresentativamente alcuni contributi dei visiting professor più ricordati ed importanti. Quello che segue è una raccolta delle loro memorie del periodo che hanno trascorso qui con noi sotto l’aspetto sia scientifico che umano. Il prof. William Duncan Grant della University of Leicester è stato ospite dell’Istituto in due occasioni; egli ha avuto una intensa collaborazione scientifica con il reparto “Batteri termofili” che data REFLECTIONS ON ARCO FELICE – BILL GRANT My association with the CNR goes right back to the late 1970s. At that time we were working on a group of microbes originally isolated from the very salty and also very alkaline (pH 12!) Lake Magadi in Kenya. These odd bright red bugs were rather different from other red bugs known to inhabit neutral salty environments. In the course of trying to characterise these bugs, we had developed a quick screening procedure for the core lipids of these and other organisms based on lipid mobility on thin layer chromatographic plates. This showed very clearly that the bugs were members of the archaea (then known as archaebacteria), the major evolutionary group then recently described by Carl Woese. However, the chromatographic mobility of the lipids seemed to be slightly different from those of their relatives from the neutral salt lakes. Around that time John Bu’Lock, who was then one of the governing council of the CNR came to give a seminar at Leicester, and on hearing about our lipids, immediately said we should talk to the experts, namely Mario de Rosa and Agata Gambacorta at Arco Felice and that he could arrange for someone in the lab to go to CNR for a short visit. Hamish Ross, who was my graduate student in 1980, took some precious material to CNR for analysis, and it became clear that our bugs had not only the novel C20C20 archaeal lipid with two carbon hydrocarbon chains linked to glycerol, they had also asymmetric lipids with one twenty carbon hydrocarbon and a new twenty five carbon hydrocarbon. I recall that Mario was somewhat disappointed, because he was hoping that our bugs were present-day sources of an odd sixteen carbon hydrocarbon with presumed ancient microbial origins that had just been found in the ancient Messel oil shales! Hamish’s sojourn in Naples was dramatically curtailed by the major earthquake in 1980 and he had to come home early. So started the collaboration that was to extend well into the 1990s – shortly afterwards, the collaboration showed that there were also C25C25 core lipids in our bugs, and the emphasis then switched to structural determinations of the complex lipids, notably the glycolipids. This work prospered wonderfully well, and indeed was essential in defining the taxonomy of this whole group of red bugs right up until the end of the 1980s, when gene sequence comparisons became more common. Even today, a quick chromatographic analysis of complex and core lipids of these bugs is extremely useful in establishing what particular type they might be. I had two short sabbaticals in Arco Felice, the first in 1987 with my family for part of the time, and a second in 1988 where I was awarded a CNR Senior Research Fellowship for Distinguished Foreign Workers (very grand). Both visits were great fun – by then Mario De Rosa had moved to the University and Agata Gambacorta was the group leader. The lab component included Agata, Barbara Nicolaus, Virgina Lanzotti, Enrico Esposito, Valeria Calandrelli, Licia Lama, Edoardo Pagnotta, Tonino Trincone and some students; the atmosphere was extremely convivial, with frequent stops for espresso (either brewed in the lab – this was before the days of the health and safety zealots! - or across the road at Damiani Country Club). I much enjoyed the interaction with the group, despite not speaking Italian. Everyone was incredibly friendly, with some great social occasions, back at Italian colleagues houses. My accommodation in Naples was a small, somewhat down-market hotel near the football stadium (Agata warned me to be very careful of Napoli football supporters at home games!) and every morning I got picked up, usually by Valeria, occasionally by Aniello Lopez the Institute general factotum who impressed me as a man who could arrange most things, including very nice trips to see the fantastic 61 Il prof. Colin Crane-Robinson è stato uno dei primi visiting professor a frequentare l’Istituto proprio agli inizi della storia del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico sotto la direzione del prof. Nicolaus; fu ospite del reparto di Risonanza Magnetica Nucleare che all’epoca era affidato al prof. Pierandrea Temussi. Ospitiamo con piacere il contributo del prof. THE PORTSMOUTH CONNECTION It all started in 1970 on a beach not too far from Cagliari in Sardinia. We were all there for some scientific purpose (conferencing I suppose) but the beach and the sea are what remain in the mind (oh, and the stories of Sardinian bandits who roam the mountains). Between plunging in and out of the waves, it transpired that Messrs. Temussi and Paolillo had scientific interests that overlapped with those of Messrs. Crane-Robinson and Bradbury. It centred on studying the helix-coil transition of synthetic polypeptides by means of NMR and we were all interested in both the problem and the te- Il Prof. Colyn Crane-Robinson (Il secondo da destra, con la chnique for studying it. It should be recalled that in those days almost no- toga, all’inaugurazione dello spettrometro NMR a 600 MHz body used NMR to study macromolecules since it was assumed that line- all’Università di Portsmouth, primavera 2001) widths would be far too high to permit any interesting measurements to be made. Although initially the axis was Portsmouth Biophysics/Istituto Chimica, it was not long before it was broadened to include the lab. in Arco Felice (L.C.F.M.I.B., C.N.R. – editorial space restrictions do not allow me to spell this name out in full). This broadened the team to include Enrico (Trivellone) and Teodorico Tancredi, whom I christened Teodorakis in recognition of his love of songs and his left-wing leanings. Before long, L.C.F.M.I.B. acquired a 100 MHz NMR spectrometer (yes, that very high frequency was the ultimate technology in those days), providing the opportunity for extended working visits from Portsmouth to Arco Felice. Of course, the practical arrangements were excellent, the peripheral touristic attractions numerous and should the experiments falter, the Cumean Sibyl could always be consulted for advise on how to proceed. I recall the Stanza Ospiti, a room set aside to accommodate visitors and to us it seemed the heights of good organisation that on-site accommodation should be provided. One practical consequence of this was that I was the first person to discover the The Flood: not the earlier one that induced immediate high quality boat-building but the one that covered the NMR in water to a height of nearly a meter. During the night there had been one of those cataclysmic storms of a ferocity that might induce one to seek refuge in the underworld (entrance immediately at hand, costing less than the Tangenziale). On waking in the Stanza Ospiti, I decided to descend to the basement where I was storing my supply of Williams (yes, pears) in the cold-room. If I had had the usual rubber boots, they would have been useless, the water being so deep. One must recall that the NMR had an electromagnet of enormous dimensions and to have it half immersed in water was truly a disaster. It certainly took some while not only for the flood waters to subside but for repairs to be carried out. As the breadth of our collaborations grew, so did the lengths of our visits to L.C.F.M.I.B. and here Damiani’s played a vital role. I always thought ‘bungalow’ was a quintessentially English word but it seems it’s a respectable Italian word as well – and that’s where we lived when I arrived with all the family. It was all very conDa sinistra: Salvatore Sodano e Teodorico Tancredi, nel 1973. venient and the combination of the two S’s (science and sightseeing) proved very enjoyable and profitable. Oh yes, and we did some really quite good science. We did not try to use NMR to explain the liquefaction of blood (an important local question, it turned out), the aim was to demonstrate how conformational changes in polypeptide chains could be followed using NMR, in both aqueous and non-aqueous solvents. We had alpha-helices that were right-handed one moment and with a small change of solvent could be flipped to being left-handed, DL copolymers that performed various conformational dances, all of which could be monitored in the NMR spectrum. I won’t bore you with a blow-by-blow account of all the dozen or so papers we published over about 7 years in journals from JACS, Biopolymers, Macromolecules to the European Journal of Biochemistry (the last concerning histones) but one set of observations was important and prescient enough that it required re-discovery at a much later date. In 1972 we 62 published a note in Chem. Comm. of The Chemical Society (Paolillo, Tancredi, Temussi, Trivellone, Bradbury and Crane-Robinson) that covered no more than a page and a half but pointed out that the 13C chemical shift differences between the helical and random coil conformations of a polypeptide chain is very substantial and reliably quantifiable. We pointed out that 13C spectroscopy is substantially better than proton spectroscopy for following conformational changes. This of course was done with natural abundance 13C: it was not the current situation in which almost 100% labelling can be achieved. Nowadays, when the determination of the secondary and tertiary structure of proteins by NMR has become an almost routine matter with high level labelling, (the structural proteomics era is with us now) the best way of defining where helices are located is to monitor the chemical shift of the α-carbon atom. When this is done, the reference is to a paper published by Wishart, Sykes and Richards in 1992 but those truly ‘in the know’ appreciate the true origins of this understanding. We all worked very hard to get lots of good spectra out of the 100 MHz instrument and as you all know, if it all gets too intense there is immediate relief at hand in the shape of a strong coffee across the road in Damiani’s bar (is it still there, I wonder)? This vital ritual never ceased to be a source of surprise: the coffee was most excellent and its stimulatory qualities undoubted but I always wanted to savour its taste and so took a moderate length of time to drink it (moderately short I would have called it, I could have taken much longer). Not so the men and women of L.C.F.M.I.B. who put it straight down in a single gulp, like the medicine they clearly regarded it. And if the heat in the NMR basement became at all oppressive, there was always that superb Neapolitan delicacy Granite di Limone to restore ones humanity and tranquillity. The moral of this tale is plain and simple: if people of like interests and enthusiasms get together to carry out a task and there is good rapport at the personal and social level, as well as at the scientific, things go well, there is success and everyone is pleased that they have done a good job. That was the case for all of us, I feel sure. Colin Crane-Robinson 63 64 Le linee di ricerca attuali dell’Istituto Il 3 di Giugno del 1994 nella seduta del Consiglio Scientifico uno dei punti all’ordine del giorno era la riorganizzazione ICMIB; per quanto riguarda questo punto il verbale riporta: ….Passando al punto 4 all’o.d.g. il Direttore illustra la riorganizzazione dell’ICMIB (allegati a1-a3) che vede, nel permanere della struttura di reparto come momento organizzativo, l’individuazione al suo interno di linee di ricerca specifiche (allegato a3) con responsabili determinati per ciascuna di esse. Nel dibattito che ne consegue si concorda che questo tipo di organizzazione per linee di ricerca presenta aspetti favorevoli di dinamicità, con possibili aumentati stimoli a favorire interazione tra tematiche diverse, appartenenti a più reparti o realtà scientifiche; in questo quadro si auspica che possano aumentare le interazioni tra competenze chimiche e biochimiche. Viene in ogni caso raccomandata attenzione ad evitare il pericolo di frammentazione…. allegato a3 SOSTANZE NATURALI (De Rosa Salvatore) RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (Trivellone Enrico) 1. Studio su basi chimiche dell’ecologia degli invertebrati marini. Cimino G., Gavagni, M., Castelluccio, F., Scognamiglio G., Villani G. 9. Determinazione della struttura di molecole di interesse biologico mediante la NMR. Trivellone E., Cimino G., Gavagnin M., Trincone A. 2. Metaboliti biologicamente attivi e loro modifica strutturale per migliorare l’indice terapeutico. Chimica e biochimica di colture cellulari di vegetali. De Rosa S., De Giulio, A., Iodice C., Crispino A. 10. Determinazione della struttura di proteine in soluzione e calcoli conformazionali. Motta A. 11. Studio delle relazioni struttura attività di 3. Studi chimici degli antozoi. De Stefano S. Crispino A., De Giulio A., De Rosa S., Scognamiglio G. CRISTALLOGRAFIA (Puliti Raffaella) BATTERI TERMOFILI (Gambacorta Agata) 12. Analisi mediante raggi X di metaboliti e studi chimico-fisici su molecole modello Puliti 5. Metaboliti da estremofili ed alghe. Studi chimici e chimico-fisici dei lipidi di membrana. Gambacorta A., Lama L., Nicolaus B., Trincone A., Calandrelli V., Esposito E., Pagnotta E., Romano I. 6. Studi di attività enzimatiche di potenziale interesse applicativo. Lama L., Nicolaus B., Gambacorta A., Calandrelli V., Esposito E., Pagnotta E., Romano I. 7. Microbiologia degli estremofili e dei cianobatteri. Studi sui loro metaboliti. Nicolaus B., Gambacorta A., Lama L., Calandrelli V., Espo- SPETTROMETRIA DI MASSA (Malorni Antonio) 13. Spettrometria di massa di molecole di interesse biologico a medio peso molecolare. Ma- Nelle pagine che seguono è dettagliata l’attività di ricerca non solo dei titolari delle linee di ricerca dell’allegato a3 del 1993 ma anche quella di altri ricercatori assunti dopo tale data. Tale quadro rappresenta l’attualità scientifica dell’ICMIB e sarà di certo parte dell’attività del futuro Istituto di Chimica Biomolecolare. 65 Linee di ricerca Predizione e determinazione strutturale di molecole di interesse biologico con tecniche di modellazione molecolare e sviluppo dei relativi metodi di calcolo Studi chimici su microorganismi marini Pietro Amodeo Letizia Ciavatta Studio di metaboliti secondari biologicamente attivi e loro modifiche strutturali Alfonso De Giulio Metaboliti biologicamente attivi e loro modifica strutturale per migliorare l'indice terapeutico. -Chimica e biochimica di colture cellulari Salvatore De Rosa Struttura, biosintesi, ruolo biologico e attivita’ farmacologica di mediatori lipidici inter- ed intra-cellulari Vincenzo Di Marzo, Tiziana Bisogno Chimica Bio-Organica di Prodotti Naturali Marini (CHIBIO) Isolamento, caratterizzazione e biosintesi di metaboliti a basso peso molecolare Angelo Fontana Agata Gambacorta Studi chimici dell’ecologia degli invertebrati marini Margherita Gavagnin Studi su attività enzimatiche di interesse applicativo Licia Lama Esplorazione di nuove risorse naturali marine Ernesto Mollo Determinazione della struttura di proteine in soluzione e calcoli conformazionali Andrea Motta Microbiologia degli estremofili e dei cianobatteri e studi sui loro metaboliti Ricordi: Il mio incontro con il Laborabotorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico Barbara Nicolaus Raffaella Puliti Isolamento, caratterizzazione e impiego di sostanze naturali per applicazioni biotecnologiche Giuseppe Strazzullo Studio delle relazioni struttura-attività di peptidi biologicamente attivi e proteine mediante spettroscopia NMR e calcoli energetici Teodorico Tancredi Studi chimici e biochimici sulla biocatalisi Antonio Trincone Determinazione strutturale di molecole di interesse biologico mediante risonanza magnetica nucleare Enrico Trivellone 66 Linea di ricerca n. Pietro Amodeo Predizione e determinazione strutturale di molecole di interesse biologico con tecniche di modellazione molecolare e sviluppo dei relativi metodi di calcolo Storicamente, la linea si origina dall’attività svolta presso l’ICMIB dal Dr. Amodeo in qualità di borsista MISM, e poi proseguita sotto forma di collaborazione a vario titolo con i ricercatori del reparto NMR. Questa attività è stata orientata allo sviluppo e all’ottimizzazione di procedure per determinare la struttura in soluzione di peptidi e altre macromolecole biologiche, mediante uso integrato di dati NMR e tecniche di calcolo, con applicazioni principalmente incentrate sui peptidi oppioidi e sull’ormone calcitonina. Lo sviluppo dei metodi e delle apparecchiature per il calcolo di strutture e proprietà molecolari ha reso disponibile uno strumento potente e flessibile, integrabile con la maggior parte delle tecniche sperimentali, che consente la determinazione di strutture a livello atomico e l’individuazione di relazioni struttura-attività. Il suo uso è stato esteso dal livello “interpolativo” dei dati sperimentali, utilizzato nella determinazione strutturale, a quello “estrapolativo”, per la predizione strutturale e la modellazione per omologia. La presente linea di ricerca si prefigge sia uno sviluppo metodologico, volto a migliorare gli aspetti quantitativi del calcolo e ad estenderne il campo di applicabilità, sia l’applicazione delle tecniche disponibili alla determinazione e predizione strutturale di varie classi di biomolecole, a partire da semplici composti organici, fino a macromolecole biologiche e loro complessi (aggregati multimerici, complessi enzimasubstrato, complessi proteina-acido nucleico o polisaccaride). Pur collocandosi in modo integrato nell’ambito del reparto NMR, la linea di ricerca può sinergicamente interagire con la maggior parte delle linee di ricerca presenti nell’istituto, migliorando la comprensione dei sistemi studiati, e permettendo l’estrazione di un numero maggiore di Figura 1 informazioni da ciascuno di essi. I principali risultati finora conseguiti sono rappresentati dallo sviluppo di metodi e protocolli per lo studio di biomolecole volti a massimizzare l’estrazione delle informazioni contenute nei dati sperimentali, e dalla predizione e determinazione strutturale di molecole e loro complessi di dimensioni e proprietà variabili in un ampio intervallo. Ad esempio, è stata possibile la simultanea determi- nazione della stereochimica di un centro chirale e della struttura 3D del Flabellatene A, una molecola ad attività antiproliferativa estratta da una spugna antartica (Fig 1). Passando a sistemi di complessità maggiore, lo sviluppo di protocolli di calcolo e/o integrazione dei dati sperimentali ha consentito la caratterizzazione strutturale di peptidi in soluzione per i quali equilibri conformazionali e/o limitazioni nei dati disponibili rendevano inefFigura 2 ficaci i protocolli standard. A titolo di esempio si ricordano gli studi sull’ormone peptidico calcitonina, di cui è stata caratterizzata la forma presente nel salmone, quella umana, e sono in corso di raffinamento alcuni analoghi sintetici disegnati per migliorare le proprietà farmacologiche e il peptide ad attività analgesica orfanina FQ2 (Fig. 2). Nello studio di proteine e aggregati proteici e peptidici, i protocolli sviluppati hanno consentito l’ottenimento di strutture di complessi utilizzando un insieme ridotto di dati sperimentali, come nel caso del trimero formato in metanolo dal peptide corrispondente alla regione citosolica della proteina “Invariant chain”, in cui sovrapposizioni nello spettro e l’uso di peptidi non marcati, insieme alla forma relativamente poco compatta del trimero, rendevano disponibili un numero limitato di effetti NOE intermolecolari. Particolare attenzione, derivante dalle elevate potenzialità nel campo della proteomica, è attualmente dedicata ai metodi per ottenere modelli di complessi proteinapeptide con limitato supporto sperimentale e uso di inforFigura 3 mazioni strutturali indirette e non canoniche. Questo filone ha già portato a due applicazioni in cui sono state univocamente identificate le regioni di interazione tra la proteina calmodulina e due peptidi, la mellitina, estratta dal veleno delle api, e il peptide corrispondente alla regione autoinibitoria del modulo chinasico della proteina muscolare titina. Per quest’ultimo sistema, il lavoro effettuato si è e- 67 Linea di ricerca n. Letizia Ciavatta Studi chimici su microorganismi marini P ur afferendo alla linea di ricerca “Studi chimici dell’ecologia degli invertebrati marini” come ricercatrice soltanto da tre anni, il lavoro da me svolto all’ICMIB è cominciato nel 1991 come borsista. Appena giunta ad Arco Felice mi sono interessata di composti derivati dall’autoossidazione del colesterolo alimentare, composti ritenuti i veri responsabili della formazione delle placche aterosclerotiche e di conseguenza di quelle malattie cardiovascolari che sono tra le cause di mortalità più comuni nel mondo occidentale. Il lavoro, svolto in collaborazione col dott. A. Fontana, mirava soprattutto alla messa a punto di una metodica di estrazione, separazione e riconoscimento di questi ossidi di colesterolo che fosse quanto più semplice e che soprattutto evitasse la formazione di artefatti durante il work-up. L’innovazione proposta fu quella di dosare ed identificare questi ossidi, peraltro presenti in quantità molto piccole, mediante la Risonanza Magnetica Nucleare (NMR). Durante questo lavoro si sono utilizzati sia campioni alimentari come biscotti o polvere d’uovo disidratata, sia miscele di colesterolo e altri grassi preparate in laboratorio. Inoltre vennero valutati alcuni fattori fisici come l’esposizione alla luce o a fonti di calore che portavano ad un incremento della quantità di questi ossidi. I risultati, che furono molto buoni, misero in evidenza che la formazione di questi ossidi aumentava con l’esposizione alla luce e a fonti di calore e che il mantenimento a livelli bassi di questi composti dipendeva in parte da queste fattori, ma era regolato anche dal tempo di invecchiamento della polvere o dei biscotti. Successivamente il lavoro, anche se come borsista, si è intrecciato con la linea di ricerca sopracitata, ed ha avuto come obiettivo lo studio di quegli organismi marini che essendo privi di difesa meccanica come la conchiglia avevano sviluppato uno o più meccanismi di difesa attraverso l’uso di sostanze chimiche. Queste ultime o vengono biosintetizzate “de novo” o vengono immagazzinate e/o modificate dagli organismi che rappresentano la fonte dietarica dei molluschi. Così da alcuni Notaspidea furono rinvenute, solo sul mantello, sostanze probabilmente usate per difesa, al contrario di quanto supposto per questa famiglia di molluschi opistobranchi dove la difesa era da imputare quasi esclusivamente alla secrezione acida presente su tutto il mantello. Ovviamente il lavoro si è articolato anche su altri tipi di molluschi (nudibranchi e anaspidea) e su spugne, alghe, madreporari provenienti da ogni parte del mondo: infatti da sempre una caratteristica del nostro gruppo di ricerca, è la collaborazione con biologi e chimici di altri paesi, che, attraverso i progetti bilaterali, mettono a disposizione il materiale biologico, le loro conoscenze e le loro esperienze per una più approfondita comprensione dei meccanismi che regolano l’ecologia di questi organismi marini. Lo studio di questi invertebrati ha portato all’isolamento di sostanze con scheletri noti ma mai rinvenuti nel mondo marino o di composti nuovi che sono stati completamente caratterizzati dal punto di vista chimico: questi ultimi composti rappresentano anche probabili molecole capostipite per attività farmacologiche e quindi HO O O H H OH con forti potenzialità applicative. Spesso tuttavia il rinvenimento di alcuni metaboliti, con determinate caratteristiche strutturali (come il cladocorano sotto riportato), ha fatto ipotizzare la presenza sulla superficie o nel tessuto stesso dell’organismo di altri organismi non identificabili ad occhio nudo: infatti per le molecole ritrovate in un organismo marino tipiche di altri phila, è ipotizzabile la presenza di altri organismi che vivono associati o in simbiosi. Da qualche anno infatti l’interesse della comunità scientifica internazionale nei riguardi degli invertebrati marini si è rivolto soprattutto ai microrganismi che possono vivere associati con essi, in particolare a funghi e batteri. I funghi e i batteri di origine terrestre hanno fornito un gamma molto ampia di metaboliti con potenti attività farmacologiche: inoltre il loro adattamento alle condizioni climatiche più avverse è ben conosciuto, quindi il loro ritrovamento nel mare non è sorprendente. Una letteratura piuttosto ampia si è sviluppata in questi ultimi anni dimostrando che, come i loro congeneri terrestri, essi sono in grado di produrre metaboliti dotati di forti potenzialità farmacologiche. 68 Linea di ricerca n. Alfonso De Giulio Studio di metaboliti secondari biologicamente attivi e loro modifiche strutturali I l lavoro di ricerca che ho sviluppato come collaboratore dell’Istituto ICMIB sin dal 1986 può essere sintetizzato in “Studio di metaboliti secondari biologicamente attivi e loro modifica strutturale per migliorarne l'indice terapeutico e di aspetti chimici e biochimici di colture cellulari”. Allo scopo di poter sviluppare adeguatamente il tema relativo alle attività biologiche sono stato ospite presso la Purdue University in Indiana (U.S), del gruppo diretto dal Prof. J.L. MaLaughlin ed ho appreso le tecniche rivolte all'isolamento di nuovi metaboliti guidato da saggi che consentono di individuare sia attività citotossiche (Artemia salina) che antitumorali (con dischi di patate infettati da Agrobacterium tumefaciens). Successivamente, un soggiorno di studio trascorso presso il Dipartimento di Chimica Organica dell'Università di Pavia, mi ha consentito anche di appropriarmi delle tecniche rivolte alla valutazione le attività antibatteriche ed antifungine dei prodotti naturali. Dagli studi condotti sugli estratti di alcune spugne, l’uso delle tecniche di isolamento guidato da saggi di attività ha permesso di ritrovare tutta una serie di nuove molecole con interessanti attività biologiche, come ad esempio il composto 12-deacetossiscalarina (un sesterterpene scalaranico senza sostituenti al C12) dalla spugna Cacospongia mollior che mostra una notevole attività citotossica. L'isolamento di nuovi metaboliti guidato da saggi di attività ottenne risultati ragguardevoli dalle spugne Petrosia ficiformis e Dysidea avara. Inoltre dalle spugne Spongia officinalis, ed Ircinia oros, dai tuberi di Asphodelus ramosus , da bulbi di Pancratium maritimum furono isolati una serie di composti con attività veramente interessanti. Gli studi delle interessanti attività del metabolita avarolo (in particolare inibizione specifica della cicloossigenasi e della lipo-ossigenasi), isolato circa trenta anni or sono dalla spugna Dysidea avara, hanno stimolato la ricerca del miglioramento del suo indice terapeutico attraverso la sintesi di derivati. A tale scopo sono stati sintetizzati una serie di amminoderivati ed è stata studiata la loro attività sia seguendo dei protocolli in uso nei nostri laboratori, sia attraverso gli effetti prodotti sull’attività degli enzimi microsomiali preposti al metabolismo di sostanze xenofobe. Dalla spugna Fasciospongia cavernosa, raccolta nell'Alto Adriatico (inizialmente classificata come Cacospongia mollior ) è stato isolato, il composto cacospongionolide un sesterterpene, che mostrava interessanti attività citotossiche ed antitumorali. La spugna. che da una approfondita classificazione risultò essere la, ha permesso di isolare insieme al cacospongionolide, alcuni nuovi metaboliti strettamente correlati tra di loro. In particolare il più abbondante è il cacospongionolide B, che mostra interessanti attività citotossiche, antimicrobiche, con concentrazione inibente paragonabile a quella della gentamicina e moderatamente ittiotossico. L'attività antiinfiammatoria del cacospongionolide B, infine, è stata coperta da brevetto (Spain Pat. 96 00884). Un altro aspetto importante del lavoro svolto all’ICMIB è stato lo studio dei metaboliti prodotti da cellule di Lycopersycon esculentum in coltura, durante il quale sono stati isolati, oltre al lupeolo, un triterpene che è risultato essere cicloartenolo ed una serie di glicosidi, l'isopentenilgetiobioside, l'androsina e tre glicosidi dell'alcol benzilico. Ancora più recentemente sono stati isolati l'isofucosterolo ed il nuovo glucosilderivato dell'isofucosterolo e tutta una serie di acilglucosidi dell'isofucosterolo, composti che isolati precedentemente sia da animali che vegetali erano stati descritti per avere attività di protezione contro gli effetti mutageni della mitomicina C. L’analisi da noi fatta non ha confermato tale attività per i nostri composti. Infine un ultimo ma non meno importante sviluppo della ricerca condotta nell’Istituto prende il suo naturale avvio dal fatto che negli ultimi trenta anni la chimica delle sostanze naturali, con l'isolamento e la caratterizzazione di numerosi metaboliti con interessanti proprietà biologiche, ha portato ad un notevole sviluppo nella ricerca di base ed in particolare nell’isolamento da organismi marini. D'altro canto, però, non si è registrato un pari trasferimento al mondo produttivo degli enormi risultati ottenuti. In questo ambito i poriferi e le alghe sono certamente le più ricche fonti di metaboliti con interessanti attività biologiche e molti di questi potrebbero essere utilizzati nei più svariati settori industriali (alimentare, farmacologico, cosmetologico) ma la difficoltà di reperimento, in particolare per alcune specie più rare, nonché la complessità delle molecole, con la relativa difficoltà di sintesi, sono i maggiori ostacoli al loro impiego su vasta scala. La crescita controllata in am- 69 Linea di ricerca n. Salvatore De Rosa Metaboliti biologicamente attivi e loro modifica strutturale per migliorare l'indice terapeutico. -Chimica e biochimica di colture cellulari L a linea di ricerca “Metaboliti biologicamente attivi e loro modifica strutturale per migliorare l'indice terapeutico. -Chimica e biochimica di colture cellulari” è la naturale evoluzione degli studi che io intrapresi, prima con la partecipazione ai vari Progetti Finalizzati (P.F.) e Strategici (P.S.), che avevano, sempre, come tema l’isolamento di composti biologicamente attivi da organismi marini. Nei primi due P.F., “Oceanografia e fondi marini” e “Chimica fine e secondaria”, l’attività biologica (farmacologica ed insetticida) era sviluppata dalla Farmitalia-Carlo Erba e Farmoplant (Montedison). Successivamente, nel 1986, come responsabile dell’unità operativa "Studio guidato da saggi d’attività biologica, di sostanze naturali marine", del P.S. “Chimica dei processi biologici”, e subito dopo (1989-1994) dell’unità operativa "Sostanze naturali biologicamente attive da organismi marini" del P.F. "Chimica Fine II", veniva introdotti e messi a punto due saggi, ed era modificato il saggio di ittiotossicità, avendo così a disposizione i seguenti saggi: a) attività antifeedant; b) attività fitoregolatrice, diverso sviluppo delle radici e/o dei germogli d’orzo (Hordeum vulgaris); c) attività citotossica, con Artemia salina; d) attività antitumorale, con dischi di patate infestati da Agrobacterium tumefaciens; e) attività tossiO ca, su pesci O (Gambusia affiO HO nis), con calcolo della dose letale Cacospongionolide B al 50% (LD50). I risultati, ottenuti, sono in perfetto accordo con la tossicità su ratti. Avendo a disposizione queste potenzialità, per molti anni ho utilizzato, prevalentemente, tali saggi nell’isolamento dei metaboliti con attività biologica. Chiaramente, questo era solo il primo approccio nell’evidenziare le attività biologiche dei prodotti isolati, infatti, in stretta collaborazione con il Prof. Miguel Paya dell’Università di Valencia, abbiamo potuto evidenziare l’attività anti-infiammatoria di numerosi composti d’origine marina. E' difficile non ricordare l’attività mostrata dall’avarolo, con l’inibizione specifica della ciclo-ossigenasi e della lipo-ossigenasi. Per queste ed altre caratteristiche, l’avarolo è utilizzato, in Germania sotto forma di crema, nella cura di dermatite. Grosse soddisfazioni sono derivate dallo studio dell’attività antiinfiammatoria del cacospongionolide B, che portò al deposito di un brevetto, sull’utilizzo di questo composto come potente e selettivo inibitore della fosfolipasi A2. Per approfondire gli studi sull’attività di questo composto, avevo bisogno di una sua maggiore quantità, quindi incominciai ad estrarre la spugna, produttrice, raccolta in varie parti del Mediterraneo, e con sorpresa, isolai tutta una serie di composti strettamente correlati al cacospongionolide, tutti con notevole attività, sia anti-infiammatoria sia antibiotica. Particolare attenzione è stata dedicata alla modifica strutturale dell’avarolo ed alla valutazione della loro attività biologica. A questa parte della mia attività scientifica sono particolarmente affezionato, perché l’isolamento e la determinazione strutturale dell’avarolo sono stati oggetto della mia tesi di laurea. Questi studi fanno parte del mio lavoro attuale, e considerato i risultati finora ottenuti spero, nei prossimi anni, di produrre qualche derivato di particolare interesse applicativo. E’ ben noto che i poriferi sono considerati, non singoli animali, ma come un microcosmo. Con i poriferi vivono, infatti, numerosi altre specie, sia macro organismi (vermi, ecc.), sia microrganismi (batteri, funghi e micro alghe). Recenti studi hanno mostrato che alcuni metaboliti isolati da spugne, in effetti, sono prodotti da microrganismi a loro associati. Lo studio dei microrganismi associati agli invertebrati marini è, quindi, di estremo interesse, perché è possibile produrre in quantità illimitata quei metaboliti di interesse industriale, isolati da spugne e che non trovano applicazione per la difficoltà del loro reperimento. Facendo queste osservazioni, recentemente, ho iniziato lo studio dei metaboliti da microrganismi, associati o simbionti con organismi marini, in particolare con spugne. Da alcuni batteri, associati a spugne marine, abbiamo isolato e caratterizzato alcuni interessanti peptidi. La loro struttura fa pensare che essi possono esplicare interessanti attività biologiche, che tuttora stiamo studiando. Negli ultimi trenta anni, dalle spugne sono stati isolati numerosi prodotti con potenziale uso industriale, purtroppo, nessuno di essi ha trovato applicazione per la difficoltà ad ottenere quantità sufficienti dei composti desiderati dalla fonte naturale, sia per l’impatto ecologico, per una massiccia raccolta della spugna produttrice, sia perché la spugna è rara e la sua crescita è lenta. Recentemente, si è ipotizzato che mettendo in coltura le cellule di spugna, si potrebbe ottenere, in condizioni controllate, una biomassa sufficiente all’isolamento dei prodotti d’interesse industriale. Partendo da queste premesse e 70 Linea di ricerca n. Vincezo Di Marzo, Tiziana Bisogno Struttura, biosintesi, ruolo biologico e attivita’ farmacologica di mediatori lipidici inter- ed intra-cellulari L a membrana citoplasmatica contiene molte delle molecole necessarie alla comunicazione e al riconoscimento cellulare. Alcune di esse derivano dai fosfolipidi. L’importanza non solo strutturale di questa classe di molecole è stata pienamente riconosciuta a partire dagli anni ‘70 con la scoperta di una pletora di derivati dell’acido arachidonico, gli eicosanoidi (prostaglandine, leucotrieni, ecc.). Successivamente sono stati individuati altri segnali lipidici derivati dal metabolismo dei fosfolipidi, ad es. i diacilgliceroli, il fattore di attivazione delle piastrine, le ceramidi, l’acido lisofosfatidico, gli endocannabinoidi e le ammidi bioattive di acidi grassi a lunga catena. Questa linea di ricerca si è originata dalla necessità di intraprendere studi sui mediatori lipidici sfruttando l’esperienza in biochimica e farmacologia molecolare del dott. V. Di Marzo. Prima del 1994, il dott. Di Marzo aveva già coordinato studi su acidi idrossieicosatetraenoici, prostaglandine lattoni, e diacilgliceroli in organismi invertebrati acquatici. L’importanza di tali modelli per lo studio del metabolismo e della funzione biologica di mediatori lipidici è sottolineata in una rassegna pubblicata nel 1994 (Articolo 21, 1994). Nel 1993 il dott. Di Marzo, con l’Unità 109 dell’INSERM di Parigi intraprendeva uno studio sulla biosintesi dell’allora appena scoperta anandamide (arachidonoiletanolammide, Fig. 1), un agonista endogeno dei recettori dei cannabinoidi. Lo studio si concluse con la scoperta delle vie metaboliche e di disattivazione dell’anandamide in neuroni di ratto (Articolo 14, 1994), e segnò l’inizio di un periodo di grande produttività per questa linea di ricerca, anche grazie all’arrivo all’ICMIB della dott.ssa Tiziana Bisogno, e ad un prestigioso finanziamento da parte del Human Frontiers in Science Program. Nel 1995 nasceva l’Endocannabinoid Research Group (ERG), un gruppo di ricerca trasversale che, oltre al gruppo del dott. Di Marzo (coordinatore), include anche il dr. L. De Petrocellis, dell’Istituto di Cibernetica del CNR e occasionalmente anche il dott. P. Orlando, dell’IBPE.-CNR, ed il Prof. M. Bifulco, del CEOS-CNR. La marijuana, il ben noto preparato medicinale e psicotropo ottenuto dalla Cannabis sativa, deve le sue tipiche proprietà sul sistema nervoso centrale (SNC) ad un costituente lipidico, il (-)- ∆ 9 tetraidrocannabinolo (THC), nonché alla presenza nel cervello dei mammiferi di un recettore selettivo per il THC, il recettore dei cannabinoidi CB1. La scoperta del CB1 ha suggerito l’esistenza di una o più molecole in grado di stimolare l’attività di tale recettore (una sorta di marijuana endogena). Due di tali molecole, denominate endocannabinoidi (Articolo 18, 1998), sono state scoperte: l’anandamide (dalla parola Sanscrita “ananda” per “stato di grazia”), e il 2-arachidonilglicerolo (2-AG). Il lavoro svolto dall’ERG negli anni 1995-2001 ha consentito non solo di individuare le vie metaboliche responsabili della formazione ed inattivazione degli endocannabinoidi, ma anche di comprenderne in parte la regolazione in alcune situazioni fisiologiche e patologiche. Inoltre, l’ERG ha contribuito alla progettazione e “screening” dell’attività farmacologica di inibitori selettivi della disattivazione (ricattura cellulare seguita da idrolisi enzimatica) degli endocannabinoidi (Articolo 20,1999). Nel complesso, i risultati scientifici più importanti conseguiti dall’ERG possono essere così riassunti: Scoperta dell’attività antiproliferativa degli endocannabinoidi su cellule tumorali della mammella e della prostata umana e su tumori tiroidei (Articolo 15, 1998; Bifulco et al., FASEB J., in stampa); Scoperta della partecipazione degli endocannabinoidi all’inibizione del movimento in un modello animale del morbo di Parkinson (Articolo 7, 2000); Scoperta del ruolo protettivo degli endocannabinoidi contro la spasticità in un modello animale di sclerosi multipla (Baker et al.; FASEB J., 15, 300-302, 2001); Scoperta del ruolo del sistema endocannabinoide nella regolazione dell’appetito e dell’assunzione di cibo in condizioni fisiologiche e patologiche (Di Marzo et al. Nature, 410, 822825, 2001); Scoperta dell’influenza della dieta sui livelli di anandamide nel cervello (Berger et al., Proc. Natl. Acad. Sci.USA, 98, 64026406, 2001); Ritrovamento degli endocannabinoidi nel latte ed individuazione del loro possibile ruolo nello sviluppo del neonato (Articolo 25, 1998). Recentemente, l’ERG ha intrapreso una serie di studi chimico-farmacologici O suggeriti dalla somiO OH OH R NH R N glianza strutturale tra H OCH l’anandamide e la Arvanil Anandamide capsaicina, il princiO H C OH pio piccante del pepeR= R O CH ronicino rosso. Tali H C OH studi hanno portato a 2-arachidonilglicerolo (2-AG) scoprire che l’anandamide è un ligando fisiologico del recettore della capsaicina (recettore dei vanilloidi VR1) (Articolo 26, 1999), e alla sintesi di agonisti “ibridi” dei recettori CB1 e VR1 (Di Marzo et al., Biochem. Biophys. Res. Commun., 281, 444-451, 2001), come ad esempio l’arvanil (Fig. 1), che presentano promettenti attività farmacologiche (protette da un brevetto internazionale) quali potenti agenti anti-tumorali, anti -spastici e analgesici. Infine, l’ERG si è dedicato allo studio di altre ammi3 2 2 71 Linea di ricerca n. Angelo Fontana Chimica Bio-Organica di Prodotti Naturali Marini (CHIBIO) G Gavagnin e Guido Cimino alla pianificazione e sviluppo della ricerca di CHIBIO. Biosintesi di Metaboliti Secondari Il programma di ricerca si sviluppa intorno alla questione di come i metaboliti secondari sono prodotti in organismi marini. Il tema sottende anche la funzione che specie microbiche, ad esempio simbionti, possono avere nell’elaborazione di molecole complesse isolate da organismi bentonici come spugne, molluschi o tunicati. Per ragioni storiche, i principali target biologici di queste ricerche sono costituite dagli opistobranchi marini, che, a partire dagli studi pionieristici del Prof. Scheuer, hanno dimostrato la capacità di elaborare de novo le molecole difensive. Tuttavia, in collaborazione con il Dott. Guido Villani che si occupa del reperimento degli organismi e della loro stabulazione, la ricerca comprende la biogenesi di metaboliti secondari in spugne, tunicati e, soprattutto, in microalghe e batteri marini. Un tema principale della ricerca è costituita, inoltre, dagli studi della via NonMevalonica o via del metileritritolo fosfato (MEP). Questa via metabolica, per il fatto di essere completamente assente nelle cellule eucariotiche, si presta, potenzialmente, ad essere target per lo sviluppo di nuovi agenti antibiotici. Pertanto, oltre ad uno studio metabolico della formazione di composti terpenoidici in organismi marini, parte della ricerca mira ad individuare composti naturali di origine marina, che attraverso l’inibizione della biosintesi non-mevalonica, possano funzionare come potenziali antibatterici, antiprotozoarici e fitofarmaci. Semi-sintesi organica. Il principale scopo di questa parte della ricerca è quella di preparare, per via principalmente chimica, molecole marcate con isotopi stabili o radioattivi per gli studi di biosintesi. L’attività riguarda sia la modificazione strutturale di substrati naturali sia la preparazione ex novo del precursore metabolico, attraverso un approccio sintetico che consenta la semplicità delle manipolazioni chimiche ed l’utilizzo di materiali facilmente accessibili. Nell’ambito di questo programma vi è anche la sintesi di inibitori ed intermedi della via non-mevalonica. Un esempio è la preparazione di metileritritolo marcato per la determinazione degli intermedi non ancora noti della via non-mevalonica. Isolamento, caratterizzazione strutturaIncorporazione di [1-13C] glucosio negli isoprenoidi del batterio marino Streptomyces sp. le e meccanismo di azione di metaboliti via non-mevalonato (J. Org. Chem., 2001, 66 (18), 6202) secondari marini. La principale finalità *CHO della ricerca è stabilire una correlazio*CH 3 H OH O ne su basi molecolari tra metabolita * HO H CO2H HO H OPP H OH secondario e attività biologica, intesa H OH O li studi di “Chimica Bio-Organica di Prodotti Naturali Marini (CHIBIO)” sono focalizzati nell’area della chimica di prodotti naturali biologicamente attivi, con un’enfasi sul metabolismo secondario lipidico. L’attività è strettamente connessa alla chimica e biochimica di prodotti naturali di origine marina con proprietà biologiche che riguardano sia aspetti naturali che applicativi. Gli interessi della ricerca spaziano dall’origine biosintetica di queste molecole, al ruolo eco-fisiologico, alle proprietà farmacologiche. Il lavoro coinvolge integrazione di studi strutturali e stereochimici, esperimenti biosintetici in vivo e su lisati cellulari, trasformazione in condizioni biomimetiche e semi-sintesi organica. La filosofia generale di CHIBIO è quella di fornire un programma scientifico di frontiera tra Chimica dei Prodotti Naturali, Biochimica ed Eco-Fisiologia perlo studio dei meccanismi molecolari attraverso i quali i metaboliti secondari, principalmente lipidici, vengono formati, svolgono il loro ruolo naturale o esprimono le loro proprietà biologiche. Un’importante parte della ricerca è ovviamente la chimica strutturale che fa perno su tecniche spettroscopiche avanzate (Risonanza Magnetica Nucleare e Spettrometria di Massa), assistite, dove necessario, da metodologie chimiche e biochimiche. L’attività del gruppo, inoltre, poggia su una serie di collaborazioni esterne tra cui quelle che coinvolgono gli studi eco-fisiologici su microalghe e dinoflagellati (Stazione Zoologica “A. Dohrn”), origine biosintetica di metaboliti secondari in molluschi e batteri marini (Department of Oceanography and Chemistry della University of British Columbia), antigeni non tradizionali ed attività immunoregolatrici di prodotti naturali marini (Facoltà di Medicina dell’Università di Studi di Napoli “Federico II”). Sebbene CHIBIO sia nato solo da poco tempo, la filosofia di ricerca si avvantaggia dell’esperienza di altre tematiche esistenti in Istituto. In particolare, il legame è molto forte con gli studi coordinati dalla Dott.ssa Gavagnin sull’ Ecologia Chimica di Opistobranchi Marini. La piu’ chiara dimostrazione dell’osmosi tra i due programmi scientifici è proprio costituita dall’attiva partecipazione di Margherita H OH CH2OH * CH2OP 72 Linea di ricerca n. Agata Gambacorta Isolamento, caratterizzazione e biosintesi di metaboliti a basso peso molecolare T ale linea di ricerca si rifà agli studi condotti nel reparto Batteri Termofili sin dalla sua istituzione. Infatti tale ricerca si è proposta di studiare la componente lipidica da nuovi isolati sia appartenenti agli estremofili che ai cianobatteri. Lo studio dei lipidi di membrana dei microrganismi è uno strumento di notevole ausilio per la classificazione di nuovi isolati e per l’ottenimento di molecole con caratteristiche utili per la preparazione di liposomi con proprietà nuove per possibili applicazioni biotecnologiche. Lo studio accurato della struttura dei lipidi degli archeobatteri ha anche evidenziato delle regole biogenetiche che sono state poi suffragate da esperimenti con isotopi a da studi di alcune attività enzimatiche Presso il Reparto batteri Termofili esiste una ricca collezione di “standards” di lipidi complessi e di “core lipids” (ottenuti dopo metanolisi dei lipidi polari) che sono di aiuto per un primo “screening” della composizione lipidica presente in una miscela di microrganismi non ancora purificati. L’ analisi del “pattern” lipidico permette di orientare i successivi studi di purificazione e di fisiologia dei microrganismi in funzione del Dominio di appartenenza. Lo studio dettagliato dei lipidi di membrana di un microrganismo purificato permette di indirizzare la tassonomia fino al genere di appartenenza. Numerosissimi sono stati i microrganismi studiati appartenenti sia al Dominio Archaea che Bacteria. Molti sono stati isolati nel Reparto Batteri Termofili molti sono stati inviati da gruppi di ricerca di tutto il mondo per la nota esperienza nel campo del gruppo di ricerca del Reparto Batteri Termofili. Nell’ ambito del Progetto OH O O HO 4 OH OH 6 5 1 O 2 OH OH OH HO 3 calditol 1 Europeo MAST sono stati esaminati i lipidi polari e i “core lipids” di oltre cento ceppi di termofili marini. Molti studi sono stati eseguiti per capire alcuni dei meccanismi che sono alla base della funzionalità della membrana sottoposta a “stress” ambientali. Tali studi sono stati condotti mediante l’ ottenimento di membrane artificiali ottenute con i lipidi eterei da Sulfolobus solfataricus, che grazie alla loro natura bipolare hanno permesso di mettere a punto una nuova tecnica per ottenere tali membrane artificiali. Si è visto che le membrane ottenute dal glicerolcalditolte- traetere sono tra le più sottili fino ad ora ottenute che hanno permesso di chiarire quali tipi di trasporto possono essere operanti. Interessanti sono anche gli studi sulle proprietà dei liposomi ottenuti con i lipidi del Sulfolobus, come le proprietà di fusione e la stabilità a differenti parametri chimico-fisici. Sono state studiati anche i possibili modi di organizzazione dei lipidi sia nella nativa membrana citoplasmatica che nella loro organizzazione in vitro all’ interfaccia ariaacqua. Di molti microrganismi, archeobatteri e batteri, sia termofili che alofili o aloalcalofili si sono studiati gli effetti di uno o più stress ambientali sulla modulazione dei lipidi di membrana. I risultati hanno dimostrato che i microrganismi, da noi presi in considerazione, cambiano la loro componente lipidica rapidamente in funzione delle ingiurie esterne per mantenere in ogni condizione la fluidità e quindi la funzionalità della membrana citoplasmatica. Nell’ ambito degli studi sulla comprensione dei meccanismi di risposta dei microorgansimi ad uno o più stress ambientali si sono iniziate, in tempi più recenti, ricerche tese a caratterizzare molecole di basso peso molecolare: gli osmoliti. Tale sostanze, isolate per la prima volta, in organismi alofili e definite come molecole capaci di compensare il turgore cellulare delle cellule sottoposte a pressione osmotica, oggi hanno invece un ruolo molto più ampio di protettori. Innanzi tutto non esistono solo negli alotolleranti, ma sono biosintetizzati in quasi tutti i microorganismi quando sono sottoposti a “stress” ambientali e si è visto che essi hanno un ruolo più generale di “stress protettori” dell’ integrità cellulare non solo alla salinità, ma alla temperature sia alte che di congelamento. Infatti essi hanno una grande importanza in campo biotecnologico come stabilizzatori di biomolecole, enzimi, DNA, membrane, dell’ intera cellula microbica, come antagonisti del sale, etc. Esse sono sostanze a basso peso molecolare molto solubili in acqua e possono essere zuccheri, polioli, ammino acidi e derivati di essi. Possono essere assunti dal terreno di cultura o biosintetizzati de novo. Gli studi sono stati condotti su un microrganismo modello molto versatile da noi isolato da sabbie dure del Lago di Venere, lago costiero dell’ isola di Pantelleria ed estesi a un gran numero di microrganismi della nostra banca batterica. I cianobatteri, i più antichi organismi fotosintetici, sono classificati in cinque sottogruppi e rappresentano un grosso gruppo eterogeneo di procarioti. Essi hanno la capacità di fare la fotosintesi che li accomuna alle alghe e alle piante superiori. Essi sono molto importanti dal punto di vista ecologico, in quanto contribuiscono all’ equilibrio dell’ atmosfera terrestre fornendo ossi- 73 Linea di ricerca n. Margherita Gavagnin Studi chimici dell’ecologia degli invertebrati marini A lla linea di ricerca “Studi chimici dell’ecologia degli invertebrati marini”, di cui sono responsabile dal 1995, partecipano altri quattro ricercatori del Reparto Sostanze Naturali, M. L. Ciavatta, G. Cimino, A. Fontana ed E. Mollo. Originatasi dalla tematica storica dell’ICMIB “Chimica delle Sostanze Naturali Marine” con cui il Reparto iniziò la sua attività trenta anni fa, questa linea si è differenziata sempre di più dalla ricerca classica di nuove sostanze naturali nel corso degli anni '80, ponendosi come obiettivo la caratterizzazione delle molecole specificamente coinvolte nei meccanismi di comunicazione inter- ed intra -specifici (difesa chimica, relazioni trofiche, ecc.) di invertebrati bentonici. Noi abbiamo ritenuto che l’identificazione dei composti coinvolti in tali meccanismi e la comprensione della loro naturale funzione in vivo e del loro meccanismo di azione può essere considerato il punto di partenza per studi ulteriori che abbiano come fine la ricerca di nuove molecole con potenzialità applicative. In particolare, gli studi da noi condotti sono stati prevalentemente focalizzati sugli opistobranchi, molluschi privi di conchiglia, in grado di difendersi dai predatori mediante strategie difensive alternative che includono l’uso di composti chimici tossici o repellenti. Queste ricerche non soltanto hanno portato all'iOAc CHO solamento e alla definiAcO zione strutturale di una serie di nuovi composti, OAc OAc spesso con strutture comhalimedatetracetate plesse e promettenti attività biologiche, mai rinO H venuti in nessuna altra fonte naturale, ma hanno anche contribuito al chiaMeO O rimento di alcuni fondatridachiahydropyrone mentali meccanismi di comunicazione chimica CHO operanti in questi molluschi e hanno fornito inCHO formazioni preziose nello studio della loro evoluoxytoxin -2 zione. Molti esempi potrebbero essere ovviamente riportati qui, ma la necessità di contenere questo report in termini accettabili impone una scelta. Vorrei ricordare due argomenti a cui sono affettivamente legata: a) gli studi sugli aspetti chimici dell'ecologia evolutiva di molluschi appartenenti all'ordine Sacoglossa e b) le ricerche condotte sui diacilgliceroli terpenoidici. a) Lo studio chimico dei metaboliti secondari di saco- glossi elysioidei e oxynoidei, comprendenti sia specie con conchiglia che specie senza conchiglia e raccolti in due distinte aree geografiche, Mediterraneo e Caraibi, ha mostrato la presenza in questi organismi di differenti gruppi di molecole, sesquiterpeni o diterpeni di origine dietarica, accumulati tal quale (ad es. halimedatetracetate) o modificati (ad es. oxytoxin-2) oppure polipropionati biosintetizzati de novo (ad es. tridachiahydropyrone). L’affermazione nei sacoglossi di differenti strategie per ottenere i propri metaboliti di difesa (bioaccumulazione, biotrasformazione, biosintesi) rende questo gruppo di opistobranchi estremamente interessante dal punto di vista ecologico. I nostri studi hanno dimostrato che il trend evolutivo che si osserva in questo gruppo dalle specie con un residuo di conchiglia a quelle senza conchiglia sembra essere straordinariamente in accordo con quello che può ipotizzare su basi chimiche dalle specie che accumulano metaboliti bioattivi dalla dieta a quelle che biosintetizzano de novo tali molecole. b) I diacilgliceroli terpenoidici, composti bioattivi estremamente interessanti, possono essere considerati il marker chimico di un gruppo di nudibranchi doridi appartenenti ai generi Anisodoris, Archidoris, Austrodoris, Doris e Sclerodoris. Dal punto di vista strutturale, queste molecole sono dei gliceridi, in cui il glicerolo è esterificato in posizione 1’ da un acido terpenoidico e in posizione 2’ o 3’ da un’unità di acido acetico. Le ricerche da noi condotte su diverse specie di nudibranchi doridi proveOAc nienti da differenti aree geoO OH grafiche hanno portato O all’isolamento dal mantello di questi molluschi di numerosi nuovi gliceril esteri, in verrucosin-B cui la struttura dell’acido terpenoidico legato al glicerolo presenta uno scheletro che può essere sia lineare che ciclico più o meno riarrangiato (ad es. verrucosin-B). I nostri studi hanno anche portato alla determinazione della stereochimica assoluta del carbonio carbinolico 2’ della glicerina che è risultata essere S per tutti gli 1,3diacilgliceroli esaminati, tranne per quelli rinvenuti in nudibranchi dell’Antartide che presentano la configurazione opposta. Ulteriori studi da noi sviluppati e rivolti alla valutazione delle attività biologiche hanno mostrato che questi composti sono potenti attivatori della proteina chinasi C in vitro e inducono significativi effetti morfogenetici sulla rigenerazione in vivo dei tentacoli dell’idrozoo Hydra vulgaris. Le interessanti proprietà 74 Linea di ricerca n. Licia Lama Studi su attività enzimatiche di interesse applicativo L a mia storia al CNR inizia nel 1980. Un avviso di tesi sperimentale all’Università attirò la mia attenzione: “Enzimi da microrganismi termofili come possibili biocatalizzatori e tecniche di immobilizzazione di intere cellule microbiche” da svolgersi presso il Reparto “Batteri Termofili”. Rimasi subito affascinata dall’argomento. E fu così che prima come studentessa poi come borsista e infine come ricercatore mi sono trovata coinvolta a partecipare all’attività del reparto interessandomi sempre più specificamente di tematiche di tipo biotecnologico. In particolare l’interesse si è focalizzato sull'isolamento e caratterizzazione ed immobilizzazione di una serie di attività enzimatiche di alcuni microrganismi estremofili. L'eccezionale stabilità degli enzimi di questi microorganismi con le loro notevoli potenzialità biotecnologiche, come resistere a temperature elevate ma anche ad agenti denaturanti, ha creato un interesse scientifico, negli ultimi anni, di grande attualità. I processi biotecnologici, che utilizzano biocatalizzatori, siano essi enzimi o intere cellule o parti di esse, sono infatti favoriti rispetto a quelli chimici tradizionalmente usati nelle industrie. Tali processi permettono di preparare prodotti per l’industria nei più disparati settori applicativi in maniera alternativa alle metodologie proprie della chimica convenzionale. Una delle caratteristiche più interessanti di questi “estremozimi” è stata quella di poter utilizzare nuove tecniche di immobilizzazione o di enzimi purificati o di intere cellule con materiali polimerici naturali o sintetici, che per le condizioni largamente denaturanti non erano state sviluppate in precedenza con enzimi o cellule non termofile. In particolare voglio ricordare l’immobilizzazione con albume d’uovo e gluteraldeide dell’intera cellula di Sulfolobus solfataricus che h a Cellule di Sulfolobus solfataricus immobilizzate in schiume poliuretaniche permesso di ottenere un biocatalizzatore in forma granulare in grado di operare in reattori a colonna o in fase dispersa. Un’ altra tecnica di immobilizzazione è stata quella in schiume poliuretaniche. Il microrganismo viene sospeso nella soluzione organica del prepolimero e per aggiunta di acqua si ottiene una vasta gamma di schiume elastiche, e grazie alle enormi superfici di contatto enzima substrato le reazioni enzimatiche decorrono in maniera efficiente La linea di ricerca “Studi di attività enzimatiche di potenziale interesse applicativo” si interessa anche dell’isolamento e caratterizzazione di una serie di attività enzimatiche di archeobatteri ed eubatteri termofili. che degradano polisaccaridi. Uno degli scopi principali delle industrie è l'utilizzo di materiali disponibili in grandi quantità, tra questi certamente i residui dell'agricoltura sono quelli più importanti in quanto rappresentano una fonte energetica rinnovabile e di basso costo (amido, cellulosa emicellulosa). In quest'ottica è stato interessante lo studio di attività enzimatiche che degradano tali polimeri quali amilasi, pullulunasi, xilanasi, cellulasi, e le cui applicazioni sono molteplici. Di particolare interesse scientifico e biotecnologico è stata l’identificazione, nell’archeobatterio Sulfolobus solfataricus, di un nuovo sistema enzimatico in grado di idrolizzare l’amido. Infatti, per la prima volta, è stato messo in evidenza un sistema enzimatico che forma, come prodotti principali di idrolisi, glucosio e trealosio dall’amido e solo glucosio dal glicogeno. Il sistema enzimatico è costituito da due enzimi, uno catalizza l’idrolisi dell’amido da cui si ottiene glucosio e uno catalizza la sintesi di trealosio con un meccanismo intramolecolare. Da menzionare anche lo studio effettuato su un nuovo microorganismo termofilo, Bacillus thermoantarcticus, proveniente dal Monte Melbourne in Antartide. Questo microorganismo è in grado di utilizzare xilano come unica fonte di carbonio e produce un’attività xilanolitica extracellulare che é costituita da una xilanasi, che attacca i legami all'interno della catena del polimero formando xilo-oligosaccaridi e da una β-xilosidasi che rilascia residui di xilosio dall'estremità finale dei xilo-oligosaccaridi. Queste due attività sono state ampiamente caratterizzate, come anche una D-xilosio isomerasi citoplasmatica. Questo enzima è in grado di convertire sia xilosio che glucosio e non vi sono significative differenze di comportamento dei due substrati rispetto ai vari parametri chimico- fisici. Avere a disposizione un sistema enzimatico che degrada lo xilano a xilosio e una xilosio isomerasi che isomerizza lo xilosio formatosi a xilulosio è molto interessante in quanto lo xilulosio è il substrato di partenza che molti lieviti utilizzano per 75 Linea di ricerca n. Ernesto Mollo Esplorazione di nuove risorse naturali marine L a continua esigenza di nuove fonti marine di prodotti naturali ha spinto alcuni ricercatori dell’ICMIB ad estendere le loro attività di studio oltre i confini del Mediterraneo. Campagne di prelievo di materiale biologico sono state condotte lungo i litorali costieri di diverse aree geografiche del mondo. In generale, per i prelievi sono state preferite le aree tropicali ad elevate diversità di specie e biochimica. I programmi di raccolta sono stati attuati attivando diverse iniziative: - biologi ed ecologi marini sono stati coinvolti nei progetti di ricerca con la costruzione di una vasta rete multidisciplinare di collaborazioni scientifiche; - nell’ambito di accordi di cooperazione scientifica internazionali tra il CNR ed enti stranieri di ricerca, i biologi dell’ICMIB hanno condotto spedizioni di ricerca in Spagna, Messico, Brasile, Egitto ed India; - in collaborazione con il prof. Jesus Ortea della Università di Oviedo, il personale dell’ICMIB ha preso parte ad ulteriori campagne in Messico, Venezuela, Costa Rica e Cuba; la partecipazione al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide ha offerto ai ricercatori dell’ICMIB la straordinaria opportunità di studiare il metabolismo di specie che vivono in condizioni ambientali estreme. Per ridurre al minimo gli effetti dannosi dei campionamenti sull’ambiente marino: - i chimici dell’ICMIB si sono impegnati ad operare su modeste quantità di materiale; durante il lavoro in mare i biologi marini hanno selezionato gli organismi da raccogliere individuando fenomeni sinecologici che risultano spesso regolati da mediatori chimici; - l’attenzione dei raccoglitori è stata concentrata su quei raggruppamenti sistematici di invertebrati bentonici, come spugne, cnidari, tunicati e molluschi opistobranchi (nella foto Hexabranchus sanguineus dal Mar Rosso), che sono consi- ICMIB Accordi di ricerca CNR – CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (Brasile) CNR – ACADEMY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY (Egitto) CNR – CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (Spagna) CNR – CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Messico) CNR – COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (India) ICMIB – UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Spagna) PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE Campagne di prelievi BRASILE 1993 EGITTO 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 SPAGNA 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 MESSICO 1996, 1997 INDIA 1998, 1999, 2000 VENEZUELA 1993 MESSICO 1994, 1995 COSTA RICA 1996 CUBA 1996 ANTARTIDE 1990-1991, 1993-1994, 19981999, 1999-2000 76 Linea di ricerca n. Andrea Motta Determinazione della struttura di proteine in soluzione e calcoli conformazionali D urante la preparazione della tesi di laurea mi piaceva molto l’idea che l’NMR fosse una delle poche tecniche, se non l’unica, che consente di studiare il comportamento delle proteine in soluzione. L’idea, certamente non originale, era comunque non perseguibile a Napoli perché uno spettrometro operante a 270 MHz (quello usato per la tesi) non consentiva di apprezzare le potenzialità della tecnica. Nel 1982 mi era stato offerto un posto di “postdoctoral research associate” per studiare la struttura dei domini del plasminogeno umano nel laboratorio del Prof. M. Llinás alla Carnegie-Mellon University (Pittsburgh, Pennsylvania, USA) dove esisteva l’unico spettrometro al mondo operante a 600 MHz. Ancora proteine, ma stavolta lo spettrometro era adeguato. All’ICMIB, nel cui reparto NMR avevo cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1985, esisteva un 500 MHz, certamente appropriato per lo studio delle proteine; ma quando nel 1987 diventai responsabile scientifico di un progetto per lo studio delle proteine mi accorsi che mancavano le … proteine e che all’ICMIB non c’era nessuno che potesse aiutarmi. Per allenarmi mi concentrai sulla calcitonina (CT), un ormone polipeptidico di 32 amminoacidi che inibisce l’attività degli osteoclasti e favorisce l’assorbimento di Ca2+ da parte delle ossa. Per questo motivo è diffusamente utilizzata come farmaco per la un’occasione che non persi. Infatti, nel maggio 1992 ottenni, insieme a ricercatori di prestigiosi centri di ricerca europei, un importante riconoscimento internazionale per un progetto in cui era coinvolta la CaM. La prestigiosa “Human Frontier Science Program Organization” di Strasburgo ci finanziò il progetto “Control of muscle filament assembly by titin and nebulin: a multidisciplinary approach”. La titina appartiene alla famiglia delle proteine modulari specifiche d e i Figura 2. Struttura del complesso TK-CaM muscoli striati dei vertebrati e degli invertebrati. Nella parte C-terminale essa presenta una regione chinasica ad elevata omologia con la chinasi della catena leggera della miosina. Questa omologia suggerisce che la sequenza amminoacidica che segue la chinasi della titina (TK) possa essere il substrato autoinibitore dell’enzima nonché il sito di interazione con la CaM. Dimostrammo che questo era vero e proponemmo una struttura del complesso TK-CaM (Figura 2). Figura 1. Rappresentazione stereo delle strutture della CT ottenute mediante calcoli di “distance geometry” e dinamica molecolare da dati NMR. cura e la prevenzione dell’osteoporosi. Imparai così ad utilizzare tutte le nuove tecniche NMR bidimensionali e mi resi conto dell’importanza del “calcolo” per ottenere strutture da dati NMR. La struttura terziaria della CT in soluzione è riportata in Figura 1. Nonostante la CT non sia rigorosamente una proteina, il progetto CT mi ha appassionato. Attualmente stiamo lavorando a calcitonine umane modificate nella regione C-terminale, che presentano un’elevata attività biologica e un’antigenicità molto bassa, al contrario di quelle usate che per lunghi trattamenti diventano inefficaci. Stiamo anche valutando la possibilità di clonare il recettore della CT per studiarne direttamente l’interazione. Contemporaneamente mi imbattei nella calmodulina (CaM), una proteina citoplasmatica di 148 amminoacidi che lega ed attiva molti enzimi in risposta ad un aumento della concentrazione cellulare di Ca2+. Fu E’ attualmente in corso uno studio del complesso CaM-Al3+ che si ritiene essere coinvolto nei meccanismi molecolari di molte neuropatologie come ad esempio l’Alzheimer. Questa volta però siamo in grado di fare tutto in casa, dalla produzione della proteina agli spettri NMR eteronucleari multidimensionali al calcolo della struttura. Nel febbraio 1996 ottenni, in collaborazione con eminenti immunologi e biologi cellulari europei, un finanziamento dall’Unione Europea (settembre 1996-marzo 2002) per il progetto “Intracellular mechanisms of antigen processing and presentation by the MHC class I and class II molecules”, occupandomi della struttura della proteina Invariant chain (Ii). Le molecole MHC di classe II sono coinvolte nella presentazione di peptidi derivati da antigeni esogeni alle cellule “T helper”. Le molecole di classe II si associano nel reticolo endoplasmatico con la Ii e sono poi trasportate nel compartimento endocitico. Qui la Ii è sottoposta a proteolisi e dissociata dalle molecole di classe II. La Ii è formata da 77 Linea di ricerca n. Barbara Nicolaus Microbiologia degli estremofili e dei cianobatteri e studi sui loro metaboliti L a vita si origina dalla vita. Uno dei punti fermi del pensiero biologico sintetizzò, quale accattivante metafora, il mio percorso professionale nell’Istituto ICMIB. Nel 1968 nasceva l’Istituto. Un po’ a casa mia, raccontano ora, ricercatori, tecnici e libri di storia. Arrivai all’Istituto vincendo una borsa di studio, macinando chilometri in laboratorio e collezionando miriadi di provette. Era il 1978 ma di quel filone di ricerca sapevo tutto o quasi! La sfida, allora quasi impossibile, sulle origini della vita, la ricerca, cioè, affidata ai batteri termofili, aveva inconsapevolmente segnato la mia vita. Quella sfida che vide, nel 68, con il Prof. Rodolfo Nicolaus, mio padre, e altri illustri scienziati, creare l’Istituto del CNR e lo stesso polo di ricerca a Napoli, sarà la mia sfida. Prologo, permettetemelo strettamente personale, di un filone di ricerca che grazie, al contributo di tanti oggi, è ancora all’avanguardia in campo scientifico. Ma a cosa si richiama questo filone targato Napoli? La linea di ricerca “Microbiologia degli estremofili e dei cianobatteri e studi sui loro metaboliti” riguarda l’isolamento e la caratterizzazione di nuovi microrganismi estremofili e delle loro biomolecole. L’idea era quella di ampliare le nostre conoscenze nel mondo dell’estremofilia con la scoperta di nuovi microrganismi e la formazione di una banca di batteri estremofili da noi caratterizzati. L’ipotesi è che questi organismi rappresentino i relitti arcaici delle forme di vita che per prime hanno popolato la terra quando, miliardi di anni fa, l’atmosfera del pianeta era povera di ossigeno ed i suoi mari ribollivano originando, per l’imponenza dei processi di evaporazione, vasti ambienti ad elevata salinità. Insomma, le origini. La materia prima, per il nostro studio, proveniva innanzitutto dal patrimonio ambientale della Campania ricco di zone termali. In quegli anni gli ambienti geotermali, e in generale gli ambienti estremi, non erano stati esaurientemente studiati e non si conosceva la biodiversità delle zone che presentavano parametri chimico-fisici di tipo estremo. Gli studi, negli anni, si sono ampliati con la caratterizzazione di nuovi isolati campionati in varie parti d’Italia, del Mediterraneo, e del Continente Antartico. I batteri termofili presentano una temperatura media ottimale di crescita superiore a 60°C. L’esistenza di vita a temperature così elevate ha posto importanti interrogativi sui meccanismi molecolari. Com’è possibile, ad esempio, una loro crescita a temperature anche superiori al punto di ebollizione dell’acqua? La strategia di stabilizzazione del patrimonio molecolare allo stress termico è multifattoriale e con logiche differenti investe tutte le componenti cellulari come DNA, RNA, proteine, ribosomi, membrane cellulari, polisaccaridi. I risultati di questi studi hanno permesso di identificare e di caratterizzare le biomolecole di numerosi nuovi microrganismi, termofili, alofili, e cianobatteri, Di particolare interesse è stato l'isolamento e l'identificazione di estremofili del Continente Antartico, in quanto i microorganismi provengono da un continente incontaminato e segregato dal resto del mondo. Grosse soddisfazioni, in particolare, sono risultate dalla caratterizzazione di un isolato termofilo proveniente dal cratere del Monte Melbourne in Antartide. Infatti si e' potuto stabilire l'esatta collocazione tassonomica di questo nuovo isolato, da noi denominato “Bacillus thermoantarcticus” che rappresenta un nuovo ramo del gruppo 5 del genere Bacilli del dominio Bacteria. E tanti altri ancora. Basti ricordare il nuovo archeobatterio alofilo appartenente al genere Haloarcula isolato in Tunisia; il nuovo organismo aloalcalofilo denominato Halomonas pantelleriense proveniente da Pantelleria; e più recentemente dal Monte Rittmann, per la prima volta visitato dall’uomo durante la spedizione italiana in Antartide, l’Alyciclobacillus rittmannii. E sul Monte Rittmann c’era un napoletano Enrico Esposito dell’ICMIB. In questi ultimi anni una attenzione sempre maggiore è stata riposta nell' uso dei microrganismi per la produzione di biopolimeri. Le ricerche più recenti in campo biomolecolare dimostrano il ruolo di tali molecole come portatrici di informazione al pari degli acidi nucleici e delle proteine. Ci è sembrato quindi interessante, dopo aver costituito nel reparto una grande “banca” di batteri, studiare i polisaccaridi di origine naturale. Lo scopo di questa ricerca è stato ed è quello di isolare e migliorare la produzione di polisaccaridi microbici, studiare la loro struttura primaria e le loro proprietà chimico-fisiche e biomolecolari per eventuali applicazioni industriali. In questo ambito il lavoro è stato indirizzato verso lo screening preliminare di microrganismi estremofili come il S. solfataricus, l’ Haloferax mediterranei, il B. thermoantarcticus ed alcuni cianobatteri come l’A. cylindrica. Successivamente sono stati effettuati studi atti a migliorare le rese di produzione di questi biopolimeri, analizzando le loro caratteristiche chimico fisiche ed infine, per alcuni si è potuto passare alla definizione strutturale completa o parziale della macromolecola. Queste ricerche del tutto innovative rispetto alla nostra precedente esperienza incentrata tutta sul metabolismo del Sulfolobus solfataricus sono state rese possibili grazie all’entusiasmo di tutti i colleghi del reparto, dei giovani studenti e dei borsisti che hanno 78 Linea di ricerca n. Raffaella Puliti R ICORDI : I l m io in con tro con il Labo rato r io pe r la Chim ica e F is ic a d i Mo le co le d i In t eresse Bio log ico nel lontano 1970, ragioni connesse alla Q uando mia vita privata mi spinsero a ricercare una collocazione scientifica nella zona di Napoli (dove peraltro si era svolto il mio primo quinquennio di attività post-laurea), valutai la possibilità di un mio trasferimento, dalla III sezione del Centro Nazionale di Chimica delle Macromolecole di Roma al Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico, diretto dal prof. R.A. Nicolaus. Si trattava di un Laboratorio di recente istituzione (1968) e quindi in via di sviluppo. Fortemente voluto dal suo primo direttore prof. Nicolaus che alcuni anni prima assieme ad un gruppo di validissimi e motivati studiosi dell’area napoletana, tra cui i proff. Ballio, Califano e Liquori (poi trasferitisi in altre sedi), si erano intelligentemente mossi, con grande impegno personale, presso l’allora presidente del CNR prof. Vincenzo Caglioti, gettando le basi per la costituzione di una ‘Istituzione interdisciplinare’ che facesse scuola nel campo delle ricerche su sostanze naturali, peptidi e altre molecole di interesse biologico e su microrganismi. Il “Laboratorio” era formato nel ‘70 da pochi giovani ricercatori, per lo più provenienti dall’area organica, impegnati su tematiche per quell’epoca del tutto innovative centrate sulla caratterizzazione chimica e biologica, con tecniche di avanguardia, di nuove sostanze naturali isolate da organismi marini e di batteri termofili provenienti dalla zona napoletana della Solfatara. Appoggiata dai proff. Ripamonti e Mazzarella, coi quali avevo in precedenza collaborato e che allora operavano nell’area strutturistica dell’Istituto Chimico dell’Università di Napoli e che ben vedevano l’inserimento delle tecniche diffrattometriche tra le competenze di questa nuova unità di ricerca CNR, avviai i primi contatti. Devo onestamente dire che la prima impressione mi lasciò alquanto perplessa a causa della realtà logistica della collocazione e struttura del “Laboratorio”. Le mie precedenti esperienze di lavoro avevano infatti trovato fino ad allora collocazione (pur essendo io da sempre strutturata come CNR) nei complessi di due prestigiose Università, di Napoli e Roma, in locali antichi ma ricchi di storia e all’epoca abbastanza funzionali, vivacizzati da un notevole flusso di studenti e da stimolanti scambi culturali con personalità scientifiche internazionali di chiara fama. La sede del Laboratorio ad Arco-Felice era in una zona turistica, molto decentrata rispetto alle altre sedi di ricerca e universitarie, in palazzine che non avevano certo una struttu- ra adatta a laboratori di ricerche chimiche: tutto ciò non era precisamente invitante. Comunque, le stimolanti chiacchierate con la coinvolgente personalità del prof. Nicolaus, le spinte degli strutturisti dell’area Chimico-fisica e soprattutto l’entusiasmo e lo spirito pionieristico di un motivato manipolo di giovani ricercatori, tra i quali voglio ricordare in particolare Luigi Minale, seriamente proiettati su ricerche d’avanguardia e con tecniche non tradizionali, unitamente alla presenza di tecnici e amministrativi impegnati a rendere funzionali le strutture del Laboratorio, mi fecero decidere, dopo una breve riflessione, a chiedere al CNR il mio trasferimento da Roma al Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di Interesse Biologico di Arco Felice-Napoli. Da allora (15 giugno 1970) sono passati più di 30 anni: una vita! In tutti questi anni la storia del Laboratorio si è evoluta. Nuove forze si sono aggiunte così come nuove linee di ricerca si sono sviluppate seguendo la naturale evoluzione degli interessi scientifici d’attualità e le competenze di nuove giovani forze. Varie Direzioni e Consigli Scientifici si sono succeduti, lasciando ciascuno la propria impronta e dando un sostanziale contributo di idee e consigli verso lo sviluppo attuale. Molti ricercatori si sono trasferiti presso altri Organismi di ricerca o Università dando vita a nuovi gruppi di ricerca autonomi. Due, Luigi Minale e Guido Sodano, che hanno profondamente segnato la storia di questo Istituto, ci hanno purtroppo prematuramente lasciato. Recentemente, in contemporanea con l’iter di trasformazione nell’Istituto di Chimica Biomolecolare e al concretizzarsi, dopo molti anni, del trasferimento nella nuova più idonea sede, vi è stata una crescita esponenziale del numero di dipendenti che sicuramente favorirà lo sviluppo di ulteriori tematiche interdisciplinari e collaborazioni, sia interne che esterne (nazionali e internazionali) proiettando l’Istituto verso ricerche sempre più d'avanguardia. Come ho detto la mia partecipazione alla vita scientifica di questo Istituto supera il trentennio e corrisponde a gran parte della mia attività scientifica. Non sta a me valutare il contributo che ha dato la Linea di ricerca cristallografica, di cui sono responsabile, allo studio di nuove sostanze naturali. Indubbiamente le continue interazioni con le altre Linee di ricerca mi hanno notevolmente arricchito, consentendomi di entrare nei campi di competenza degli altri ricercatori e abituandomi a colloquiare con linguaggi diversi su tematiche comuni. Penso per altro di avere sicuramente contribuito a rafforzare le interazioni tra il 79 Linea di ricerca n. Giuseppe Strazzullo Isolamento, caratterizzazione e impiego di sostanze naturali per applicazioni biotecnologiche H o iniziato la mia attività di ricerca nei campi applicativi della Chimica delle Sostanze Naturali nel 1984 e mi sono occupato, fin dall’inizio, di isolamento e caratterizzazione dei metaboliti secondari da estratti ottenuti da organismi marini, un tema generale di ricerca che caratterizza l’attività scientifica dell’Istituto ICMIB. Le prime ricerche svolte con la supervisione del Dr. Cimino e del Prof. Sodano sugli allomoni di difesa da molluschi opistobranchi hanno condotto all’isolamento dal mantello del mollusco del genere Bursatella della molecola chiamata bursatellina e alla definizione della sua corretta struttura attraverso la sintesi ottenuta a partire dal cloramfenicolo D-base. Gli altri studi sui metaboliti secondari delle spugne del genere Dysidea hanno consentito, in seguito, di isolare e caratterizzare dei nuovi terpenoidi contenenti lo scheletro scalaradianico insieme all’avarolo (un sesquiterpenoide idrochinone con scheletro drimanico riarrangiato); il chinone ad esso correlato ed alcuni suoi derivati. Le indagini sulle potenziali attività antivirali dell’avarolo confortate dai dati riportati in letteratura circa la sua efficacia contro il virus HIV-I hanno indirizzato successivamente il lavoro di ricerca alla sintesi e alla modificazione strutturale di metaboliti biologicamente attivi, potenziali inibitori della transcriptasi inversa dei retrovirus. Sono stati, per questo, sintetizzati e saggiati dei derivati della molecola allo scopo di ampliarne la gamma delle sue attività biologiche. In seguito sono state anche studiate altre sostanze di origine naturale dotate di attività anti -blastica ed antivirale come le Kelletinine (molecole isolate dal gasteropode marino B. corneum). Questo ultimo lavoro è stato condotto in collaborazione con l' Istituto di Embriologia ed Enzimologia del CNR di Napoli attraverso l'impiego come "target" della DNA polimerasi a e della trascrittasi inversa. Le successive ricerche svolte principalmente nell’ambito del progetto scientifico “Studio guidato da saggi d’attività biologica, di sostanze naturali marine” hanno consentito la messa a punto di tecniche di frazionamento di estratti anche di origine vegetale guidato da saggi di attività citotossica (Artemia salina) ed antitumorale (con dischi di patata infestati da Agrobacterium tumefaciens). Infine ho collaborato alla determinazione della struttura e calcoli conformazionali di peptidi e molecole bioorganiche in soluzione attraverso l'impiego di dati NMR multidimensionale omo ed eteronucleare presso la sezione di Risonanza Magnetica Nucleare di questo Istituto. Attualmente sono impegnato nella progettazione e sviluppo degli aspetti biotecnologici connessi alla realizzazione ed all’utilizzo di films biodegradabili ottenuti utilizzando ficocolloidi, in particolare alginati, estratti da alghe brune. Questo progetto di ricerca ha per obbiettivo l’ottenimento di polisaccaridi complessi da fonti biologiche abbondanti e rinnovabili, isolati attraverso tecniche di estrazione e lavorazione idonee ecocompatibili e di minore impatto ambientale. L’impiego dei ficocolloidi come alternativa all’uso di polimeri di sintesi nella realizzazione di materiali plastici trae origine da esperimenti effettuati inizialmente utilizzando films contenenti amido termoplastico per prove in campo che hanno consentito di ottenere dei buoni risultati in termini di efficacia pacciamante (resistenza meccanica ed effetto serra) e tempi di biodegradazione. E’ ben noto che i prodotti d’origine algale sono già utilizzati come fertilizzanti, integratori o correttori delle caratteristiche chimiche del terreno. Il loro uso favorisce l’aumento del periodo di fruttificazione delle piante, una migliore crescita degli ortaggi con maggiore pezzatura e minor contenuto d'acqua oltre all’aumento della capacità di difesa di piante e semi verso l’aggressione di specie patogene. Gli effetti sono attribuiti alla presenza, nelle alghe, di auxine, giberelline e citochinine; all'induzione, da parte dei polisaccaridi d’origine algale, dell'espressione di enzimi deputati all’autodifesa ed ai metaboliti secondari quali terpeni, composti solforati e bromurati con spiccate attività antiOH batteriche. La liOH nea di ricerca ha come obbiettivo la NC NHCHO O realizzazione di films biodegradaBursatellina bili ottenuti per termoplasticizzazione o per spray-drying da materiale algale e polisaccaridi di origine algale che abbiano gran parte dei componenti auxotrofi e fertilizzanti delle alghe in forma disponibile e che essi, oltre a svolgere la loro funzione specifica, si trasformino per naturale degradazione in fertilizzanti. Tra i ficocolloidi, estratti prevalentemente da alghe Rodofite e Cromofite, quelli che risultano più interessanti merceologicamente perché capaci di gelificare sono l'agar, le carragenine e l'acido alginico (una miscela complessa di acido polimannuronico MM, poliguluronico GG e polimeri misti MG). In particolare, la capacità addensante e le proprietà gelificanti 80 Linea di ricerca n. Teodorico Tancredi Studio delle relazioni struttura-attività di peptidi biologicamente attivi e proteine mediante spettroscopia NMR e calcoli energetici E ra il 1966 e, studente del quarto anno del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico chimico fisico (così allora si chiamava), era tempo di scegliere il laboratorio dove svolgere la tesi di laurea. La Cattedra di Chimica Generale dell’Istituto Chimico aveva deciso di costituire un gruppo di Risonanza Magnetica Nucleare ed era stato ordinato uno spettrometro Varian-A60-A. Al dr. Enrico Menna, che insieme al neolaureato Livio Paolillo costituiva il gruppo di ricerca, era stato dato l’incarico di elaborare un programma di ricerca di NMR. Era un campo completamente nuovo, che offriva pochi o nessun elemento (niente tradizione, nessun risultato) di valutazione ad uno studente che volesse orientarsi su dove fosse più opportuno chiedere un progetto di tesi. Fu proprio l’elemento di novità, la possibilità di fare uno studio assolutamente originale, almeno per uno studente dell’Università di Napoli, che mi spinse a chiedere di entrare a far parte come studente “interno” del gruppo di NMR. Fui accettato. Mi ritrovai quasi subito, per mancanza di apparecchiature e di programmi NMR, a “farmi le ossa” nel laboratorio di un giovane ricercatore del CNR (il mio primo contatto con questo ente), il dr. Rosario Palumbo, a sintetizzare e purificare fosfine variamente sostituite, di cui si volevano studiare le capacità clatranti. Esse risultarono assolutamente trascurabili, ma in compenso riuscivo ad ottenere dei bei fuochi fatui, dato che molto spesso si incendiavano all'interno dei refrigeranti durante le fasi di purificazione. Nel frattempo lo spettrometro era stato installato, il Dr. Menna si era dimesso e l’inizio del mio apprendistato all’interno del gruppo NMR coincise con il ritorno dagli Stati Uniti del Prof. Pierandrea Temussi, di cui ignoravo allora l’esistenza, e che scoprii essere andato all’estero appunto per lavorare con l’NMR. Fu lui ad “ereditarmi” e ad assegnarmi un progetto di tesi in cui l’NMR veniva impiegata per risolvere un problema di isomeria conformazionale. La metodica impiegata venne poi estesa allo studio dell’influenza dei sali sulle transizioni conformazionali di poli-aamminoacidi, studiati in qualità di modelli di proteine. L’attuale linea di ricerca del dr. Tancredi nell’ambito dell’ICMIBCNR può considerarsi la naturale evoluzione di questi primi studi condotti presso l’Istituto Chimico dell’Università di Napoli. Si è naturalmente approfittato dello sviluppo delle tecniche e delle strumentazioni NMR, che permettono oggi di effettuare in tempi ragionevoli studi che era impossibile immaginare agli inizi degli anni 1970, cercando di delucidare le relazioni intercorrenti tra struttura ed attività di molecole di interesse biologico. I principali sistemi presi in considerazione comprendono peptidi e proteine attivi in vari meccanismi biologici quali la percezione del sapore, l’attività oppioide, la percezione del dolore e la citoprotezione. Tra gli studi più recenti, vorrei citare nel campo dei peptidi oppioidi quello riguardante la βENDORFINA. Questo peptide è il più lungo peptide oppioide naturale conosciuto (YGGFMTSEKS10ZQTPLVTLFKN20AIIKNAYKK G30E). La conoscenza della sua conformazione bioattiva può essere molto importante per la mappatura indiretta del sito attivo dei recettori oppioidi. Il peptide è stato studiato in acqua, dimetilsolfossido, ed in miscele acquose di metanolo, glicole etilenico, dimetilsolfossido, trifluoroetanolo o esafluoroacetone. Le conclusioni di questo studio rivelano che la bendorfina umana ha una tendenza molto bassa ad assumere strutture ordinate in acqua, mentre in soluzioni acquose di alcoli ed in particolare di esafluoroacetone il peptide assume una conformazione elicoidale che si estende per la maggior parte del suo "address domain", da P13 a Y27; in tutti i sistemi solvente usati il dodecapeptide N-terminale rimane disordinato. La struttura trovata suggerisce un possibile meccanismo di interazione con i recettori oppioidi: un attacco a due punti, con la parte elicoidale dell' "address domain" che va ad interagire con una delle eliche transmembraniche del recettore, mentre il "message domain" N-terminale interagisce con il sottosito recettoriale comune a tutti i recettori oppioidi. Nell’ambito dello studio delle sostanze che impartiscono il sapore dolce, lo studio più recente riguarda la determinazione della struttura in soluzione della MNEI, u n a monellina a singol a catena, arricchita i n 1 5 N , ottenuta attraverso metodi di ingegneria proteica. L a 81 Linea di ricerca n. Antonio Trincone Studi chimici e biochimici sulla biocatalisi L a linea di ricerca “Studi chimici e biochimici sulla biocatalisi non è stata una linea di ricerca di innovazione nell’ambito dell’Istituto. Essa infatti si rifà agli studi, condotti nel reparto Batteri termofili fin quasi dalla sua istituzione, sulle attività catalitiche presenti negli organismi estremofili. Quegli studi, almeno inizialmente, ponevano l’accento sull’identificazione delle attività catalitiche, sulla caratterizzazione da un punto di vista enzimologico e sulle possibilità espressive nell’ambito del microorganismo producente. Questa linea di ricerca invece ha sempre tentato di porre maggiore attenzione alla catalisi, alla stereochimica che la governa e alla possibilità di utilizzare le attività catalitiche nel campo della sintesi organica. In realtà idee preliminari, al passo con i tempi di allora, erano già presenti nell’ambito del reparto dove questa linea ha preso inizio: ricordo con piacere infatti le chiacchierate con il Prof. Sodano circa una vecchia collaborazione (tra i reparti Sostanze naturali e Batteri termofili) riguardante la possibilità di trasformazione di anelli steroidici con attività catalitiche presenti nel microorganismo che fu di interesse peculiare in laboratorio in quegli anni: il Sulfolobus solfataricus. Sull’onda di queste discussioni -e di altri lavori in collaborazione con il vicino Istituto di Biochimica delle Proteine ed Enzimologia- riguardanti l’individuazione di una alcool deidrogenasi nell’archeobatterio, nel 1986 iniziò un’indagine per individuare la stereochimica della riduzione del gruppo chetonico ad opera di quella attività. Questo aspetto fu investigato molto approfonditamente sia dal punto di vista della configurazione del gruppo carbinolico prodotto sia da quello dell’idruro del NADH che veniva utilizzato per effettuare la reazione di riduzione. Ma l’interesse principe di questa linea di ricerca è stato lo studio di un’altra attività presente in Sulfolobus solfataricus. Una β-galattosidasi ritrovata nell’omogenato di cui si fa menzione già nei primi rapporti scientifici dell’Istituto. Tale attività, accanto alla caratterizzazione enzimologica era stata utilizzata sotto l’aspetto esclusivamente idrolitico e portò, tra l’altro, alla pubblicazione di un brevetto per la produzione di latte delattosato. Una più ampia caratterizzazione biochimica fu poi portata avanti in stretta collaborazione con l’Istituto di Biochimica mentre nel nostro reparto poco dopo fu messa in risalto la capacità di sintesi del legame glicosidico ad opera dell’enzima. Grosse soddisfazioni sono risultate dallo studio di questo aspetto della glicosil idrolasi. In principio la specificità di substrato per individuare acceptor semplici e/o complessi dove l’unità zucche- rina veniva trasferita, poi la stereochimica della formazione di questo legame per quel che riguarda la regioselettività di funzionalizzazione di più gruppi ossidrilici presenti sullo stesso acceptor ed infine, più recentemente, la messa a punto di sistemi per la sintesi enzimatica di oligosaccaridi sia con l’enzima HO HO HO OH O H O OH H3 C Isomero naturale dell’aleppotriolos ide sintetizzato enzimaticamente. OH CH3 nativo che con lo stesso enzima geneticamente modificato. Intanto sotto questo specifico aspetto anche altri enzimi presenti nello stesso archeobatterio sono stati studiati: è materia recente la caratterizzazione della prima α-xilosidasi archeobatterica ed il suo utilizzo nella sintesi e nella idrolisi di derivati dello xiloglucano, un polisaccaride con attività biologica. Particolarmente affascinante è stato lo studio della regioselettività di formazione del legame glicosidico per la glicosil idrolasi presente nel Sulfolobus. I risultati di questo studio permisero di ideare una via sintetica semplice per un glucoside naturale trovato in Adonis aleppica la cui stereochimica, per le esigue quantità isolate, non era stata determinata. Furono così sintetizzati i quattro diastereoisomeri possibili dell’aleppotrioloside utilizzando una via di sintesi che prevedeva l’uso di una lipasi commerciale e, infine, della glicosidasi del Sulfolobus solfataricus. Quest’ultima mostrò la capacità, in presenza di tre gruppi ossidrilici, di attaccare il glucosio al gruppo ossidrilico primario in modo del tutto esclusivo con una purezza anomerica del 100%. Numerosi altri Derivato cromogenico di uno dei trisaccaridi sintetizzati enzimaticamente. β-Glc-[1,6] β-Glc-[1,3]-β-Glc-O-oNP glicosidi naturali sono stati sintetizzati in questo modo sia semplicemente adottando la capacità di sintesi della sola glicosidasi, sia in tandem con altre attività enzimatiche commerciali o da funghi per la sintesi degli agliconi. Ma il prodotto di sintesi dell’enzima da noi studiato è sempre substrato per l’enzima stesso e ciò comporta l’obbligo di adottare opportune tecniche per favorire la sintesi anziché l’idrolisi (eccessi di acceptor, uso di cosolventi etc.). Un’ingegnosa opportunità per ovviare a questo inconveniente presente in tutte le glicosidasi è invece stata data recentemente dalle modifiche del sito attivo dell’enzima mediante ingegneria genetica. Questi studi hanno permesso di 82 Linea di ricerca n. Enrico Trivellone Determinazione strutturale di molecole di interesse biologico mediante risonanza magnetica nucleare variazioni conformazionali di catene polipeptidiche. Dalla fine degli anni settanta, agli inizi degli anni Ripercorrendo con la memoria (e qualche appunto) gli anni trascorsi, mi sembra più opportuno parlare di attività complessiva che non solo di linea di ricerca. Ciò scaturisce dalla naturale interconnessione fra le funzioni di responsabile del Servizio di NMR e di Ricercatore. Dopo un breve periodo di "addestramento alla ricerca" con una borsa del CNR presso l'Istituto di Chimica Generale dell'Università di Napoli Federico II, dal '67 al '69 ho appreso i primi rudimenti della tecnica NMR effettuando le misure dei campioni dei ricercatori dell'Istituto di Chimica Organica diretto dal Prof. Rodolfo Alessandro Nicolaus ed ho conosciuto e stretto collaborazioni, con i dr. Livio Paolillo e Pierandrea Temussi, già esperti di questa tecnica. Questa attività si è consolidata con la fondazione dell'Istituto per la Chimica e la Fisica di Molecole di Interesse Biologico del CNR (ICFMIB) comprendente un Reparto di NMR di cui diventavo il responsabile nel 1970. In tutti questi anni la mia attività si è divisa equamente fra la gestione di un Servizio di NMR e lo sviluppo di una linea di ricerca. L'attività di ricerca, essendo strettamente legata alla tecnica (NMR), ha sentito necessariamente l'influenza delle collaborazioni che si sono succedute o sovrapposte negli anni, presentando a volte aspetti molto diversi fra loro. Si possono individuare, le seguenti tematiche: H3C R2 C CH 2R1 CH NH CH CO NH CH 5 H2C OC H HO R5 4 CO HN CH 3 2 CH X N OC CH NH CO H2C CO NH 6 HC CH R4 CH 2 1 CO CH 3 C 2H5 7 CH NH CO 8 CH NH COR 3 R6 Fig. 2 Struttura generale delle Amatossine novanta, la linea di ricerca è stata prevalente caratterizzata dalla collaborazione con il Dr. L. Paolillo sullo studio della relazione attività struttura di polipeptidi. In particolare voglio ricordare gli studi strutturali sulle Amatossine e sulla Bombesina e loro analoghi. Le Amatossine costituiscono i componenti più tossici prodotti dal fungo Amanita phalloides. Sono inibitori dell'RNA polimerasi B, interrompendo la sintesi proteica specialmente nel fegato e nella milza. Esse sono octapeptidi biciclici con un unusuale ponte fra i residui Triptofano e Cisteina (Fig2) Anche gli studi della Bombesina (BBS) e dei suoi analoghi sono stati dettati dalle loro molteplici attività biologiche. Durante questo ventennio, pur se in maniera saltuaria, si è sempre realizzata una collaborazione con i colleghi del Reparto di Sostanze Naturali. Questa linea di ricerca, é ancora oggi attiva ed è basata (i) Studi conformazionali su composti modello, (ii) Studi conformazionali su macromolecole naturali, (iii) Relazione attività struttura di peptidi, (iv) Struttura di metaboliti da organismi marini. Il primo approccio all'applicazione della NMR a problemi conformazionali, è stato effettuato, in collaH borazione con il Prof. Giorgio Montaudo (Università di Catania), Fig. 1 con lo studio di composti del tipo Ar-X-Ar, dove X= O, S, SO2 mediante la NMR protonica su numerosi composti della serie variamente sostituiti sugli anelli aromatici. Le conformazioni preferite, del tipo illustrato in Fig.1, sono responsabili dello schermo diamagnetico delle correnti di anello che il protone in orto sente, in modo diverso, secondo la conformazione adottata. Quasi contemporaneamente si è avviata una collaborazione, durata sette anni, dei Ricercatori del Reparto NMR (il sottoscritto ed il dr. Teodorico Tancredi) con i dr. L.Paolillo e P.A.Temussi e con il dr. Colin Crane Robinson ed il prof. Morton Bradbury dell’Istituto di Biofisica di Portsmouth. Tali studi hanno prodotto numerose pubblicazioni su riviste internazionali, che hanno messo in evidenza la capacità della tecnica NMR ed in particolare del 13C, di fornire informazioni qualitative e quantitative sulle H X 9 .. N O − δ 16' 15' + 18' 17' N 6 14' 2' 13' 12 1' 15 13 14 N 4' 5' 16 6' Saraina 1 H 2 Oδ 5 11 N H 3 4 10 H 7 8 3' 7' 12' 8' OH OH 10' 9' 11' Saraina - A sull'applicazione delle più avanzate tecniche di NMR mono e bidimensionali per risolvere la struttura dei metaboliti da organismi marini. Di particolare interesse sono stati gli studi per determinare la struttura delle Saraine, metaboliti della spugna Reniera sarai. Le Saraine, si erano rivelate particolarmente interessanti per le loro proprietà chimiche e biologiche, ma le difficoltà di ottenere prodotti puri e la scarsa riproducibilità e interpretabilità degli spettri di NMR (100 MHz), ci avevano indotto ad abbandonarne lo studio. L'affinamento delle tecniche cromatografiche e le 83 Il coordinamento dell’Istituto Nazionale Istituto di Chimica Biomolecolare Il mese di Giugno del 1995 e il mese di Febbraio del 1997 sono due date significative per la nascita dell’Istituto di Chimica Biomolecolare di cui oggi facciamo parte. A Giugno del 1995, nella sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma fu organizzata una Giornata di Coordinamento per la presentazione dell’Istituto Nazionale della Chimica dei Sistemi Biologici. Il successo della manifestazione non riuscì a rimuovere completamente il timore, presente in molti partecipanti di stare lavorando a qualcosa che difficilmente si sarebbe realizzata. Dopo quella data però molte cose cambiarono e gli Istituti Nazionali di Coordinamento divennero una realtà indiscussa cui era associato un ruolo trainante nell’ambito della riforma dell’ente. Il 9-10 Gennaio del 1997 a Roma, nell’ambito del Convegno “La ricerca chimica verso il 2000: attività ed iniziative del Comitato Scienze Chimiche”, fu riservata un’attenzione significativa all’attività e alle prospettive dei costituendi Istituti Nazionali. Subito dopo, il 24-25 Febbraio dello stesso anno, fu organizzato un Convegno dell’Istituto Nazionale di Coordinamento della Chimica dei Sistemi Biologici in cui furono presentate le iniziative del Consiglio Direttivo dell’INC-CSB miranti a valorizzare la visibilità dell’Istituto, a costruire solidi rapporti col mondo produttivo, a realizzare un efficiente coordinamento scientifico. Le giornate furono organizzate con una formula innovativa da una commissione costituita dal Dr. Paolo Bovicelli, dal Dr. Antonio Trincone e presieduta dal Dr. Mauro Marchetti con la volontà di favorire il dialogo tra tutte le componenti operanti negli organi afferenti all’INC-CSB. Negli atti di quelle due giornate fu dato spazio ad ogni Direttore per un’ampia relazione delle attività dell’organo e ogni ricercatore poté relazionare oralmente in una breve comunicazione tesa ad illustrare la sua attività. Tutti gli interventi ebbero spazio negli atti di quel convegno. Molti dei rapporti che nacquero in quella occasione si sono rinsaldati nel tempo ed hanno certamente costituito la base per la realizzazione dell’Istituto di Chimica Biomolecolare. E’ con vivo piacere che ospitiamo in questa pubblicazione l’intervento del prof. Romano Cipollini sull’esperienza degli Istituti Nazionali di Coordinamento. Nelle pagine seguenti è riportato un intevento del prof. Gino Lucente direttore del Centro di Studio per la Chimica del Farmaco uno degli Organi CNR confluiti nell’Istituto di Chimica Biomolecolare che aiuta a tracciare il percorso di coordinamento che i vari Organi hanno seguito, insieme all’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico, fino alla costituzione 84 E’, in questi giorni, attivo nel paese un vivace dibattito sul passato, e sul presente e sulla futura vocazione del CNR. Avendo per più di dieci anni presieduto il Comitato Nazionale delle Scienze Chimiche del CNR, ritengo opportuno ricordare alcune iniziative che hanno favorito, a partire dalla fine degli anni ’60, l’alta competitività degli organi del CNR in settori d’avanguardia delle discipline chimiche. In particolare, in quegli anni, il Prof. Vincenzo Caglioti creò una rete scientifica basata su intuizioni forti e, spesso, avveniristiche. Nel settore chimico, vennero costituiti laboratori ed istituti impegnati su tematiche che, dopo oltre 20 anni, sono ancora d’attualità. Polimeri, tecnopolimeri e compositi, certificazione e qualità, ingegneria genetica, sostanze naturali biologicamente attive, ecologia e protezione ambientale, microelettronica sono alcune delle tematiche introdotte nei costituenti laboratori alla fine degli anni ’60 e che, per la chimica, saranno parole chiave fino agli inizi degli anni ’90 ed, in alcuni settori, lo sono tuttora. Il Comitato Scienze Chimiche, in quest'ultimo periodo, ritenne doveroso rianalizzare criticamente quanto realizzato nell’area di sua competenza. Il bilancio, anche se oltremodo positivo, imponeva alcuni cambiamenti. Infatti i circa 60 Istituti e Centri afferenti al Comitato per le Scienze Chimiche erano, nella gran maggioranza, altamente competitivi nei propri settori di ricerca, ma era opportuno creare migliori condizioni per favorire una crescente competitività internazionale su tematiche fondate sulle conoscenze di base ma orientate anche verso lo sviluppo degli interessi del mondo socio-economico. Così, all’inizio degli anni ’90, nacquero, in modo informale, gli Istituti Nazionali di Coordinamento. Agli organi afferenti al Comitato per le Scienze Chimiche venne richiesto di coordinarsi in modo spontaneo per creare una massa critica su grandi tematiche d’interesse internazionale e con positive eventuali ricadute per le attività industriali. Dopo una lunga fase di preparazione, che vide attivamente coinvolti direttori e personale di tutti gli organi CNR dell’area chimica, quattro Istituti Nazionali di Coordinamento (INC) vennero, su proposta del Comitato di competenza, costituiti dagli Organi Direttivi del CNR nel giugno 1996: INC per la Chimica dei Sistemi Biologici (Presidente: Guido Cimino); INC per le Metodologie e le Tecnologie Chimiche Innovative (Presidente: Rinaldo Psaro); INC per la Chimica e Tecnologia dei Sistemi Macromolecolari Sintetici e Naturali (Presidente: Ezio Martuscelli); INC per i Materiali Innovativi e le Tecnologie Relative (Presidente: Sesto Viticoli). Attraverso quest’operazione le attività di 58 organi del Comitato Chimica venivano concentrate in solo 4 macrostrutture. Il primo di questi istituti (INC-CSB) coordinava 5 Istituti e 10 Centri e la presidenza fu assegnata al Direttore dell’organo, per dimensioni, più rappresentativo, l’Istituto per la Chimica di Interesse Biologico (ICMIB). Il Consiglio Direttivo dell’INC-CSB dettò una politica centrata sulla realizzazione di tre obiettivi: 1) valorizzare la visibilità dell’INC, 2) costruire solidi rapporti col mondo produttivo; 3) realizzare un efficiente coordinamento scientifico. Per alcuni di questi obiettivi (1 e 3) gli esiti furono oggettivamente positivi. Visibilità e coordinamento scientifico furono favoriti da alcune iniziative congressuali, tutte realizzate in Roma presso la sede centrale del CNR. Alla fine di Giugno del 1995, fu organizzata una Giornata di Coordinamento per la presentazione dell’INC-CSB; nel Gennaio 1997, il Comitato per le Scienze Chimiche ritenne opportuno, nell’ambito del Convegno “La ricerca chimica verso il 2000: attività ed iniziative del Comitato per le Scienze Chimiche”, ritagliare uno spazio consistente per sostenere le iniziative promosse dai Direttivi dei 4 Istituti Nazionali; nel Febbraio 1997 l’INC-CSB organizzò due giornate per dibattere su “Attività. Coordinamento e Prospettive dell’INC-CSB”. Queste iniziative favorirono la formazione di una “consapevolezza del gruppo”. E’ per me motivo di soddisfazione l’aver potuto constatare, in numerosi appuntamenti, quanto sia stato caratterizzante, per molti ricercatori, l’orgoglio d’appartenere all’Istituto Nazionale per la Chimica dei Sistemi Biologici. Contemporaneamente, non posso trascurare di ricordare che poco si è realizzato nei rapporti col mondo produttivo, nonostante la ricerca costante da parte del Direttivo dell’INC-CSB di dialogare col mondo industriale ed, in particolare, con la Federchimica e la Federfarma; le numerose tavole rotonde, giornate di lavoro, riunioni informali hanno creato interessanti prospettive ma pochi reali avanzamenti. Probabilmente, in alcuni settori della chimica la ricerca corre troppo velocemente e, per il mondo produttivo, non è immediato comprendere come utilizzarla. Al termine del triennio di coordinamento (1996-1999), la ristrutturazione voluta dagli organi direttivi del CNR trovava gli organi afferenti all’INC-CSB pronti per una aggregazione istituzionale. Così ben 11 dei 12 organi, che avevano afferito all’INC-CSB con la totalità del proprio personale e delle proprie strutture, proponevano di riaggregarsi in due Istituti: l’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) con sede in Napoli e quattro sezioni a Catania, Roma, Sassari e Padova; 85 Quando nel 1995, dietro invito del Comitato per le Scienze Chimiche, fu proposta la costituzione dell’Istituto Nazionale per la Chimica dei Sistemi Biologici, presieduto dal dr. Guido Cimino direttore dell’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico (ICMIB), i ricercatori operanti presso il Centro di Studio per la Chimica del Farmaco di Roma (CCF/RM) parteciparono con grande interesse e fiducia all’iniziativa. Appariva già da allora chiara la possibilità di ricadute positive, specialmente nei confronti dei piccoli organi, che non potevano possedere, proprio per le loro ridotte dimensioni strutturali, le capacità di gestire programmi di ricerca di vasto respiro né di operare una adeguata attività di raccordo con altri enti pubblici e privati. E’ iniziato, con questa prima fase, un periodo di ininterrotta ed onerosa attività dell’INC-CSB volto a curare tutti gli aspetti organizzativi ed in particolare a coordinare i programmi di ricerca ed a promuovere il dialogo tra le varie componenti. I ricercatori del CCF/RM hanno partecipato attivamente a questa fase di coordinamento dell’attività scientifica ed in occasione delle Giornate di Consuntivo Scientifico annuale “Attività, Coordinamento e Prospettive” dell’INC-CSB del Febbraio 1997 hanno presentato contributi che si collocano nell’area delle basi chimiche dei processi biologici che è una tematica caratterizzante la aggregazione in atto; possono essere ricordate a questo proposito le ricerche riguardanti le modificazione strutturali di prodotti naturali di natura peptidica, ciclopeptidica e carboidratica, finalizzate allo sviluppo di nuovi agenti terapeutici ed alla comprensione dei meccanismi d’azione biologica coinvolti. Il dialogo ed il costruttivo confronto tra le varie componenti è poi proseguito sino alla definizione di un organo più ristretto e più omogeneo rispetto all’INC-CSB, alla predisposizione congiunta del piano trennale 2001-2003 ed infine alla costituzione della nuova struttura che costituisce l’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) avente sede a Napoli. Di questo Istituto il CCF/RM costituisce appunto, insieme all’altro Centro di Roma (Centro di Studio per la Chimica delle Sostanze Organiche Naturali CSCSON/RM), la sezione romana. In questi circa sei anni di attività che hanno consentito di accordare le linee di ricerca con le tematiche che caratterizzano l’ICB, il CCF ha operato sempre con la convinzione che la propria lunga esperienza e le specifiche competenze nel settore della chimica del farmaco potessero utilmente inserirsi ed integrarsi con le componenti culturali e scientifiche presenti negli organi costituenti la nuova aggregazione. E’ opportuno ricordare che tra le tematiche di ricerca tradizionalmente sviluppate all’interno del CCF/RM si collocano quelle nel settore della progettazione, sintesi e studio delle proprietà strutturali e conformazionali dei peptidi. Questa tematica costituisce, anche in ambito internazionale, uno dei settori di indagine più perseguiti e promettenti; in esso sono infatti insite enormi potenzialità sia per l’acquisizione di informazioni sul meccanismo d’azione di sistemi biologici chiave, quali i sistemi recettoriali ed enzimatici, sia per lo sviluppo di farmaci che siano meno estranei, dal punto di vista struttuale, agli organismi viventi e presentino quindi una minore aggressività rispetto a molti prodotti attualmente in uso. Anche in altri settori di ricerca avanzata, riguardanti prodotti naturali non peptidici, attivi sul sistema nervoso centrale, sono state evidenziate concrete possibilità di vantaggiose collaborazioni che mettono a frutto capacità e competenze che si sono rivelate altamente complementari. Proprio nello specifico settore dei prodotti attivi sul SNC, uno dei gruppi di ricerca del CCF/RM ha in corso di attuazione un progetto di ricerca con un gruppo dell’ICMB che costituirà la sezione di Napoli del nuovo ICB. E’ quindi con la fiducia che nasce dalla consapevolezza dell’impegno e delle provate capacità 86 La nuova sede Nei primi mesi del 2001 è stato finalmente effettuato il trasloco delle attività sperimentali dell’Istituto alla nuova sede ubicata nel Fabbricato 1970 dell’ex Comprensorio Olivetti in Pozzuoli. Il trasloco, coordinato nella fase logistica dal Sig. Antonio Trabucco, si è concluso nel più breve tempo possibile (nel mese di giugno) rendendo immediato il ripristino delle attività. Il problema della sede è sempre stato sentito all’interno dell’Istituto sia dai Direttori che si sono avvicendati alla sua guida che da tutto il personale. Già nei primi rapporti scientifici del Prof. Rodolfo Nicolaus si leggono osservazioni circa la funzionalità delle fogne; ai tempi della direzione del Prof. Mario De Rosa si arrivò vicino al Relazione 2000 Attività di Ricerca Relazione del Direttore Guido Cimino Finalmente! Dopo 32 anni di assoluta precarietà logistica, all’Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico è stata consegnata la nuova sede. La solennità del momento richiede rigorosi bilanci….. Una vignetta di Ciro Di Micco dedicata al problema della sede e, a destra, l’entrata della palazzina D dell’Istituto nella vecchia sede di Arco Felice. completamento dell’operazione di trasferimento dell’Istituto alla sede dell’ex Merrel. Finalmente nel 2001, dopo trentadue anni di attività nell’originaria sede “provvisoria”, si è realizzato quello che per molti è rimasto un sogno: una sede più idonea sia negli spazi che dal punto di vista delle attività sperimentali e di ricerca. “Finalmente” è stata la parola usata per aprire il commento del direttore Guido Cimino ne rapporto di attività scientifica per l’anno 2000. Affianco è raffigurato quello che per trentadue anni è stato l’ingresso della palazzina D della vecchia sede in Arco Felice, la stessa immagine usata per la copertina del rapporto del 2000. La descrizione della vecchia sede è stata riportata nel capitolo sulla fondazione, dal rapporto del 1969. La sede dell’Istituto in Arco Felice è stata per molti anni composta dalle palazzine D ed E. Negli anni più recenti, il reparto NMR, precedentemente spostato in locali dell’Università, presso il II Policlinico, è ritornato nella sede di Arco Felice, in concomitanza con l’acquisto dello spettrometro Bruker AMX 500 MHz, ed è stato ubicato nella nuova palazzina M. 87 Qui di fianco è presentata la piantina del livello degli studi nella nuova sede del Comprensorio ex-Olivetti. Tredici vani studi si individuano nella fila in basso, mentre altri cinque sono ubicati in alto a destra nella piantina. Il corpo centrale racchiuso tra gli studi comprende la Biblioteca dell’Istituto, gli archivi e gli spazi biblioteca in comune con altri Istituti. In alto sulla sinistra sono individuabili due piccole aule, un disimpegno antistante ad esse e confinante con l’accesso agli ascensori. Il piano laboratori, è quello qui sotto fotografato: si intravede lo spazio su cui danno le uscite di sicurezza dei laboratori. Piantina Livello degli studi della nuova sede del comprensorio ex-Olivetti Piantina Livello Laboratori della nuova sede del comprensorio ex-Olivetti La piantina del piano laboratori invece è riportata qui di fianco. In essa si individuano nella fila in basso a partire da destra i laboratori assegnati al reparto Batteri Termofili (primi 3 spazi) e al reparto Sostanze Naturali (ultimi 5 spazi a partire da sinistra); lo spazio confinante è uno spazio comune. Molti spazi centrali sono servizi condivisi. Al reparto Sostanze Naturali sono assegnati in più taluni spazi-laboratorio nelNella piantina degli spazi NMR qui di fianco riportata è invece visibile sulla estrema sinistra il vano (nella foto) dove sono ospitati gli spettrometri, gli studi dei ricercatori e tecnici NMR nella parte inferiore ed alcune stanze per apparecchiature infomatiche di fronte ad essi. Piantina spazi NMR della nuova sede del comprensorio ex-Olivetti Spazi dedicati agli spettrometri NMR nella nuova sede del comprensorio ex-Olivetti 88 Articoli scientifici ELENCO Anno 1968 1. E. Fattorusso, G. Cimino. Ulteriori ricerche sulla sepiomelanina. Rend. Acc. Sci. Fis. Mat. Napoli, 35, 617, 1968. 2. E. Fattorusso, L. Minale, S. De Stefano, G. Cimino e R. A. Nicolaus. Struttura e biogenesi delle feomelanine. NotaV. Sulla struttura della gallofeomelanina-1 Gazz. Chim. It., 98, 1443, 1968. 3. P.A. Temussi and T. Tancredi. The Mechanism of Isomerization of Methyl Nitrite. J. Phys. Chem. 72, 3581, 1968. ELENCO Anno 1969 1. E. Fattorusso, L. Minale, G. Cimino, S. De Stefano e R. A. Nicolaus. Struttura e biogenesi delle feomelanine. Nota VI. Sulla struttura della gallofeomelanina-1. Gazz. Chim. It., 99, 29, 1969. tricosiderine. Gazz. Chim. It., 99, 1193, 1969. 12. L. Mangoni e V. Dovinola. The stereochemestry of Woodward cis-hydroxylation of same steroidal olefins. Tetrahedron Letters, 5235, 1969. 13. R. Caputo, V. Dovinola e L. Mangoni. Diterpeni dalla Araucaria Cunninghami. La Chimica e l’Industria, 51, 1382, 1969. 14. R. Scarpati, M. L. Graziano e R. A. Nicolaus. Reazioni dei cheteni.Nota XIV. Prove della Formazione intermedia di ∆² -1,2,3-triazoline nella reazione fra cheteni dialchilacetali ed azidi. Gazz. Chim. It., 99, 1969. ELENCO Anno 1970 1. G. Nota, G. Marino, V. Buonocore e A. Ballio. Liquid-solid chromatografy with open glass capillary columns: separation of 1-imethylaminophthalene-5-sulphonyl amino acids. J. Chromatogr., 46, 103, 1970. 2. L. Minale, E. Fattorusso, G. Cimino, S. De Stefano e R. A. Nicolaus. Struttura e biogenesi delle feomelanine. Nota VIII. Sulla struttura della gallofeomelanina-1. Gazz. Chim. It., 99, 431, 1969. 2. L. Minale, E. Fattorusso, S. De Stefano, S. Magno, G. Cimino e R. A. Nicolaus. Struttura e biogenesi delle feomelanine. Nota XII. Modelli sintetici in relazione alla struttura delle feomelanine. Gazz. Chim. It., 100, 870, 1970. 3. E. Fattorusso, L. Minale, S. De Stefano, G. Cimino e R. A. Nicolaus. Struttura e biogenesi delle feomelanine. Nota IX. Feomelanine biosintetiche. Gazz. Chim. It., 99, 969, 1969. 3. L. Minale, E. Fattorusso, S. De Stefano e R. A. Nicolaus. Struttura e Biogenesi delle feomelanine. Nota XI. Ulteriori ricerche sulla Biogenesi delle feomelanine. Gazz. Chim. It., 100, 461, 1970. 4. P. Ganis, A. Musco e P. A. Temussi. Bond Shift in Cyclooctatetraene and in Tetramethylcyclooctatetraene. J. Phys. Chem.,73, 3201, 1969. 5. P. Temussi, T. Tancredi e F. Quadrifoglio. Conformational Rigidity of the Amide Bond. A VariableTemperature Nuclear Magnetic Resonance Study of the System Ag+ -N, N-Dimethylacetamide. J. Phys. Chem.,73, 4227, 1969. 6. J. A. Ferretti, L. Paolillo. Nuclear Magnetic Resonance Investigation of the Helix to Random Coil Transfomation in Poly-α-amino acidis. I. Poly-L-alanine. Biopolymers, 7, 155, 1969. 7. G. Marino, M. De Rosa, V. Buonocore e V. Scardi. Characterization by isoelectric Focusing of pig hearth aspartate aminotransferase. FEBS Lett., 5, 347, 1969. 4. E. Fattorusso, L. Minale e G. Sodano. Feomelanine e eumelanine da nuove fonti naturali. Gazz. Chim. It., 100, 452, 1970. 5. E. Fattorusso, L. Minale, S. De Stefano e R. A. Nicolaus. Struttura e Biogenesi delle feomelanine. Nota XIII. Sulla struttura della gallofeomelanina-1. Gazz. Chim. It., 100, 880, 1970. 6. E. Fattorusso, L. Minale e G. Sodano. Aeroplysin-I, a New Bromo-compound from Aplysina aerophoba. J.C.S. Chem. Comm., 751, 1970. 7. E. Fattorusso, L. Minale, G. Sodano, K.Moody e R.H.Thomson. Aerothionin, a Tetrabromo-compound from Aplysina aerophoba and Verongia thiona. J.C.S. Chem. Comm., 752, 1970. ELENCO Anno 1971 8. A. Ballio. Meccanismo d’azione di antibiotici di interesse terapeutico. La Chimica e l’industria, 51, 826, 1969. 1. E. Fattorusso, G. Cimino. Sul processo di polimerizzazione dei 5,6-diossindoli. Rend. Acc. Sci. Fis. Mat. Napoli, 38, 173, 1971. 9. R. A. Nicolaus, G. Prota, C. Santacroce, G. Scherillo e D. Sica. Struttura e biogenesi delle feomelanine. Nota VII. Sulla struttura delle tricosiderine. Gazz. Chim. It., 99, 323, 1969. 2. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e E. Fattorusso. Furospongin-1; a new C-21 furanoterpene from the sponges Spongia officinalis and Hippospongia communis. Tetrahedron, 27, 4673, 1971. 10. G. Misuraca, R. A. Nicolaus, G. Prota e G. Ghiara. A Cytochemical study of phaeomelanin formation in feather papillae of New Hampshire chick embryos. Experientia, 25, 920, 1969. 3. E. Fattorusso, S. Forenza, L. Minale e G. Sodano. Isolation of 3,4-dihydroxyquinolin-2-carboxylic acid fom the Sponge Aplysina Aeophoba. Gazz. Chim. It., 101, 104, 1971. 11. G. Prota, G. Scherillo, O. Petrillo e R. A. Nicolaus. Struttura e biogenesi delle feomelanine. Nota X. Sulla struttura delle 4. E. Fattorusso, L. Minale, K. Moody, G. Sodano e R. H. Thomson. 89 Homo-aerothionin, a second tetrabromo compound from Aplysina aerophoba and Verongia thiona. Gazz. Chim. It., 101, 61, 1971. ELENCO Anno 1972 5. E. Fattorusso, L. Minale, G. Sodano e E. Trivellone. Isolation and structure of nitenin and dihydronitenin, new furanoterpenes from Spongia nitens. Tetrahedron, 27, 3909, 1971. 1. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e E. Fattorusso. Minor C-21 furanoterpenes from the sponges Spongia officinalis and Hippospongia communis. Tetrahedron, 28, 267, 1972. 6. S. Forenza, L. Minale e R. Riccio e E. Fattorusso. New Bromo-pyrrole Derivatives from the Sponge Agelas oroides. Chem. Comm., 1129, 1971. 2. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e E. Fattorusso. Ircinin-1 and -2, linear sesterterpenes from the marine sponge Ircinia oros. Tetrahedron, 28, 333, 1972. 7. E. M. Bradbury, P. Cary, C. Crane-Robinson, L. Paolillo, T. Tancredi and P. A. Temussi. Experimental Evidence fo the Assignment of α-CH peaks in the NMR Spectra of Polypeptides. J. Am. Chem. Soc., 93, 5916, 1971. 8. G. Montaudo, P. Finocchiaro, E. Trivellone, F. Bottino and P. Maravigna. Conformational Preferences of ortho-substituted Diphenyl-Ethers and Diphenyl-Thioethers. Tetrahedron, 27, 2125, 1971. 9. M. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale and J.D. Bu’Lock. Bacterial Triterpenes. J. Chem. Soc. D Chem. Comm., 619, 1971. 10. M. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale and J.D.Bu’Lock. Cyclohexane fatty Acidis from a Thermophilic Bacterium. J. Chem. Soc. D (Chem. Comm.), 1334, 1971. 11. G. Prota, S. Suarato e R. A. Nicolaus. The isolation and Structure of Trichosiderin B. Experientia, 27, 1381, 1971. 12. G. Prota, G. Nota e A. Previero. Resolution of pivalyl aminoacid methylester by g.l.c. and its application to the analytical determination of N-terminal residue in peptide chains. Recent Development in the Chemical Study of Protein Structure. Inserm, 45, 1971. 13. M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. An isolate of Bacillus acidocaldarius an acidophilic thermophile with unusual lipids. Giornale di microbiologia, 19, 145, 1971. 14. R. Scarpati e M.L. Graziano. Further Investigations on the Reaction Between Phenylketene Dimethylacetal and Ethyl Azidoformate. Tetrahedron Lett., 4771, 1971. 15. R. Scarpati e M.L. Graziano. Synthesis and Some Properties of 1-phenyl-2,2-dimethoxy-2(Nalkoxycarbonylamino)-diazoethanes. Tetrahedron Lett., 2085, 1971. 16. M.L. Graziano e R. Scarpati. Sintesi di N- carbalcossi-2-alcossiimmidoesteri e N-carbalcossi-2alcossiammidi. Gazz. Chim. It., 101, 316, 1971. 17. L.Paolillo, P.A.Temussi, E.Trivellone, E.M.Bradbury and C.Crane Robinson. Nuclear Magnetic Resonance and Optical Spectroscopic Studies of Block Copolymers of Polypeptides. I. Block Copoly (Benzyl-LGlutamate)n:(Benzyl-L-Aspartate)m. Biopolimers, 10, 2555, 1971. 3. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Polyprenyl derivatives from the sponge Ircinia spinosula: 2polyprenylbenzoquinones,2-polyprenylbenzoquinois, prenylated furans and C-31 difuranoterpene. Tetrahedron, 28, 1315, 1972. 4. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e E. Trivellone. New sesquiterpenes from the marine sponge Pleraplysilla spinifera. Tetrahedron, 28, 4761, 1972. 5. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Further linear furanoterpenes from marine sponges. Tetrahedron, 28, 5893, 1972. 6. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Prenylated Quinones in Marine Sponges: Ircinia sp. Experientia, 28, 1401, 1972. 7. E. Fattorusso, L. Minale, e G. Sodano. Aeroplysinin-1 an Antibacterial Bromo-compound from the Sponge Verongia aerophoba. J. C. S. Perkin I, 16, 1972. 8. K. Moody, R.H.Thomson, E. Fattorusso, L. Minale e G. Sodano. Aerothionin and Homoaerothionin: Two Tetrabomo Spiracyclohexadienylisoxazoles from Verongia Sponges. J. C. S. Perkin I, 18, 1972. 9. F. Cafieri, E. Fattorusso, C. Santacroce e L. Minale. Fasciculatin, a Novel Sesterterpene from the Sponge Ircinia fasciculata. Tetrahedron, 28, 1579, 1972. 10. L. Minale, e G. Sodano e W.R. Chan e A.M. Chen. Aeroplysinin-2, a Dibromolactone from Marine Sponges Aplysina (=Verongia) aeophoba and Ianthella sp. J.C.S. Chem. Comm., 674, 1972. 11. P. De Luca, M. De Rosa, L. Minale e G. Sodano. Marine Sterols with A New Pattern of Side-Chain Alkylation from the Sponge Aplysina (=Verongia) aeophoba. J. C. S. Perkin I, 2132, 1972. 12. L. Paolillo, T. Tancredi, P.A. Temussi, E. Trivellone, E. M. Bradbury and C.C. Robinson. The Hexil-Coil Transition of Poly-(γ-Benzyl-L-Glutamate) using ¹³C Resonance Spectroscopy. J. C. S. Chem. Comm., 335, 1972. 13. L. Paolillo, P.A. Temussi, E. Trivellone. Donor-Acceptor forces in Polypeptide Model Compound. A PMR Study. Gazz. Chim. It., 102, 300, 1972. 14. G. Montaudo, F. Bottino, E. Trivellone. Conjugative and Steric Factors affecting the Conformational Prefer- 90 ence of Some Aromatic Sulphides. J. Org. Chem., 37, 504, 1972. 15. M. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale and J.D. Bu’Lock. The formation of ω-Ciclohexyl fatty acidis from shikimate in an acidophilic thermophilic Bacillus. A new Biosynthetic Patway. Biochem. J., 128, 751, 1972. 5. P. De Luca, M. De Rosa, L. Minale, R. Puliti and G. Sodano and F. Giordano and L. Mazzarella. Synthesis of 24,28-Didehydroaplysterol and X-Ray Crystal Structure of Aplysterol. Unusual Marine Sterols. J. C. S. Chem. Comm., 825, 1973. 16. L. Mazzarella, R. Puliti. Crystal structure and absolute configuation of Aeroplysinin-1. Gazz. Chim. It., 102, 391, 1972. 6. M. De Rosa, L. Minale and G. Sodano. Metabolism in Porifera-I. Some studies on the Biosynthesis of Fatty Acidis, Sterols and Bromo-Compound by the Sponge Verongia aerophoba. Comp. Biochem. Physiol., 45B, 883, 1973. 17. L. Paolillo, P.A. Temussi, E.M. Bradbury and C.Crane Robinson. NMR and Optical Spectroscopic Studies of Copolymers of Polypeptides.II. Random. Copoly-(Benzil-L-Glutamate; Benzyl-L-Aspartate) and (Benzyl-D-Glutamate; Benzyl-L-Aspartate). Biopolymers, 11, 2043, 1972. 7. M. De Rosa, L. Minale and G. Sodano. Metabolism in Porifera-II. Distribution of Sterols. Comp. Biochem. Physiol., 46B, 823, 1973. 18. G. Prota, M. D’Agostino e G. Misuraca. The Structure of hallachrome: 7-hydoxy-8-methoxy-6-methyl-1,2anthraquinone. J.C.S. Perkin I, 1614, 1972. 19. L.Cariello e G. Prota. Occurrence of 3-hydroxy-L-kynurenine in gorgonians. Comp. Biochem. Physiol., 41B, 195, 1972. 20. G. Prota, E. Ponsiglione. A reinvestigation of the reaction of p-benzoquinone with cysteine ethylester: Revision of a structural assignement. Tetrahedron Lett., 1327, 1972. 21. G. Prota, E. Ponsiglione. Un riesame della reazione della ninidrina con la cisteina. La Chimica e l’Industria, 54, 1025, 1972. 22. G. Prota. Structure and Biogenesis of Phaeomelanins. Pigmentation; its genesis and biological control, ed. Yernon Riley, Appleton-Century-Croft. New York, 615, 1972. 23. G. Marino, M. Paternò and M. De Rosa. Multiple forms of aspartate aminotransferase. The formation of AAT. FEBS Lett., 21, 53, 1972. ELENCO Anno 1973 1. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Deoxoscalarin, a further sesterterpene with the unusual tetracyclic carbon skeleton of scalarin, from Spongia officinalis. Experientia, 29, 934, 1973. 2. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Paniceins, unusual aromatic sesquiterpenoids linked to a quinol or quinone system, from the marine sponge Halicondria panicea. Tetrahedron, 29, 2565, 1973. 3. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Methyl trans-monocyclofarnesate from the sponge Halicondria panicea. Experientia, 29, 1063, 1973. 4. G. Montaudo, F. Bottino, P. Finocchiaro, P. Maravigna and E. Trivellone. Conformational preferences of ortho-substituted DiphenylSulphones. J. of Mol. Struct., 16, 299, 1973. 8. M. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale e J.D.Bu’Lock. Isoprenoids of Bacillus acidocaldarius. Phytochemistry, 12, 1117, 1973. 9. L. Paolillo, P.A. Temussi, E. M. Bradbury and C.Crane Robinson. NMR Studies of the Helix-Coil Transition of polypeptides in nonprotonating solvent mixtures. Polymer, 14, 303, 1973. 10. L. Paolillo, P.A. Temussi, E. M. Bradbury and C.Crane Robinson. NMR Studies of Polypeptide in a non-protonating solvent system. J. Amer. Chem. Soc., 95, 1683, 1973. 11. L. Paolillo, P.A. Temussi, E. Trivellone, E. M. Bradbury and C.Crane Robinson. Conformational Studies of random DL Copolypeptides in solution using high resolution nuclear magnetic resonance. Macromolecules, 6, 831, 1973. 12. L. Ferrara, P.A. Temussi. Solvent dependence of helix-coil transition of poly-γ-benzil-Lglutamate. A PMR Study. Biopolymers, 12, 1451,1973. 13. V. M. Coiro, E. Giglio, A. Lucano e R. Puliti. Determination of the molecular packing in the crystal of 5α-androstan -3, 17-dione by means of potential-energy calculations. Acta Cryst., B29, 1404, 1973. 14. L. Mazzarella, C. Pedone, R. Puliti. Crystal packing of amides: X-ray structure analysis of optically active dilactylamide. Acta Cryst., B29, 2699, 1973. 15. F. Addeo e A. Malorni. Le ammine volatili della birra. Identificazione a mezzo tlc-ms e gcms dei dansil-derivati. Annali della Facoltà di Agraria, VII, 3,1973. 16. F. Addeo, A. Malorni e M. Ameno. Studio a mezzo di gc-ms dei silil derivati delle ammine biogene. Annali della Facoltà di Agraria, VII, 1973. 17. S. Andini, E. Benedetti, L. Ferrara, L. Paolillo, P.A. Temussi. NMR Studies of prebiotic polypeptides. 4th ICOL, session III b, paper n° 86, Barcelona, June 1973. ELENCO Anno 1974 1. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Occurrence of hydroxyhydroquinone and 2-aminoimidazole in 91 sponges. Comp. Biochem. Physiol., 47B, 895, 1974. 2. G.Cimino, D. De Rosa, S. De Stefano e L. Minale. Isoagatholactone, a diterpene of a new structural type from the sponge Spongia officinalis. Tetrahedron, 30, 645, 1974. 3. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Oxidized furanoterpenes from the sponge Spongia officinalis. Experientia, 30, 18, 1974. 4. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Pleraplysillin-2, a further furanosesquiterpenoid from the sponge Pleraplysilla spinifera. Experientia, 30, 846, 1974. 5. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Scalaradial, a third sesterterpene with the tetracarbocyclic skeleton of scalarin, from the sponge Cacospongia mollior. Experientia, 30, 846, 1974. 6. L. Minale, R. Riccio e G. Sodano. Acanthellin-1, an unique isonitrile sesquiterpene from the sponge Acanthella acuta. Tetrahedron, 30, 1341, 1974. 7. L. Minale, G. Sodano. Marine sterols: 19-nor-stanols from the sponge Axinella polypoides. J.C.S. Perkin I, 1888, 1974. 8. M. De Rosa, A. Gambacorta, G. Millonig and J.D. Bu'Lock. Convergent characters of extremely thermophilic acidophilic bacteria. Experientia, 30, 866, 1974. 9. M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. Effects of pH and temperature on the fatty acid composition of Bacillus acidocaldarius. J. Bacteriol., 117, 212, 1974. J. C. S. Perkin I, 2380, 1974. 16. L. Paolillo, P.A. Temussi, E. M. Bradbury, P.D.Cary, C. Crane Robinson and P.G. Hartman. Proton Magnetic Resonance spectroscopy of synthetic Poly (α amino acidis). In: Peptides, Polypeptides and Proteins, edited by E.R. Blout, F.A.Bovey, M. Goodman and N. Lotan,177, 1974. 17. A. Panuzzi, L. Paolillo, P.A. Temussi. Chair inversion and nitrogen inversion in heterocyclohexanes. A variable temperature P.M.R. investigation of Hexahydro-1,3,5Trimethoxy-1,3,5-Triazine. Gazz. Chim. It., 104, 1173, 1974. 18. G. C. Casinovi, B. Santurbano, G. Conti, A. Malorni, G. Randazzo. The structure and spectroscopic properties of an isomer of fusicoccin deacetylaglycone and some derivatives. Gazz. Chim. It., 104, 679, 1974. 19. F. Addeo, A. Malorni, G. Marino, G. Randazzo. A Method of analysis of dansylamides in mixtures by mass spectrometry. Biomed. Mass. Spectrom., 1, 363, 1974. 20. F. Addeo, A. Malorni. Sulla presenza di ammine biologiche nei mosti e nelle bevande fermentate: uno studio analitico. S&TA, 241, 1974. ELENCO Anno 1975 1. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e G. Sodano. Metabolism in Porifera. III. Chemical pattern and classification of the Desmospongiae. Comp. Biochem. Physiol., 50B, 279, 1975. 10. M. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale and J.D. Bu'Lock. Cyclic diether lipids from very thermophilic acidophilic bacteria. J.C.S. Chem. Comm., 543, 1974. 2. G. Cimino, P. De Luca, S. De Stefano e L. Minale. Disidein, a pentacyclic sesterterpene condensed with an hydroxyhydroquinone moiety, from the sponge Disidea pallescens. Tetrahedron, 31, 271, 1975. 11. M.De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock Origin and utilization of cyclohexanecarboxylic acid in Bacillus acidocaldarius. Phytochemistry, 13, 1793, 1974. 3. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. ent-chromazonarol, a chroman-sesquiterpenoid from the sponge Disidea pallescens. Experientia, 31, 1117, 1975. 12. M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. Specificity effects in the biosynthesis of fatty acids in Bacillus acidocaldarius. Phytochemistry, 13, 905, 1974. 4. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Occurrence of 4-hydroxyphenylpyruvic acid oxime in the marine sponge Hymeniacidon sanguinea. Experientia, 31, 756, 1975. 13. E. M. Bradbury, C. Crane-Robinson, L. Paolillo, T. Tancredi, P.A. Temussi and E. Trivellone. Conformational Transition of (Benzyl-Aspartate)(Benzyl-Glutamate) Copolymers Using 13C Resonance Spectroscopy. In: Peptides, Polypeptides and Proteins, E. R. Blout, M. Goodman and N. Lotan Eds., J. Wiley & Sons, New York, N.Y., USA, 190, 1974. 5. G. Cimino, S. De Stefano, A. Guerriero e L. Minale. Furanosesquiterpenoids in sponges I: pallescensin-1, -2, -3 from Disidea pallescens. Tetrahedron Lett., 1417, 1975. 14. L. Minale, R. Riccio e G. Sodano. Avarol, a novel sesquiterpenoid hydroquinone with a rearranged drimane skeleton from the sponge Disidea avara. Tetrahedron Lett., 3401, 1974. 15. L. Minale e G. Sodano. Marine Sterols: Unique 3β-Hydroxymethyl-A-nor-5α-steranes from the sponge Axinella verrucosa. 6. G. Cimino, S. De Stefano, A. Guerriero e L. Minale. Furanosesquiterpenoids in sponges II. Pallescensins E-G from Disidea pallescens: a new skeletal type. Tetrahedron Lett., 1421, 1975. 7. G. Cimino, S. De Stefano, A. Guerriero e L. Minale. Furanosesquiterpenoids in sponges III. Pallescensins A-D from Disidea pallescens: new skeleton types. Tetrahedron Lett., 1425, 1975. 8. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e E. Trivellone. 92 Furanosesquiterpenoids in sponges V. Spiniferins from Pleraplysilla spinifera. Tetrahedron Lett., 3727, 1975. 9. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Furanosesquiterpenoids in sponges IV. Microcionins from Microciona toxystila. Tetrahedron Lett., 3723, 1975. 10. G. Cimino, S. De Stefano, W. Fenical, L. Minale e J. Sims. Zonaroic acid from the brown seawed Dictyopteris undulata (= zonaroides). Experientia, 31, 1250, 1975. 11. G. Cimino, S. De Stefano e L. Minale. Long alkyl chains 3-substituted pyrrole-2-aldehyde (-2-carboxylic acid and methyl esters) from the marine sponge Oscarella lobularis. Experientia, 31, 1387, 1975. 12. M. De Rosa and A. Gambacorta. Qual'è la temperatura massima per la vita sul nostro pianeta? Le Scienze, 80, 74, 1975. 13. M. De Rosa, A. Gambacorta and L. Minale. Terpenoid 4,7-thianaphtenequinone from an extremely thermophilic and acidophilic microorganism J.C.S. Chem. Comm., 392, 1975. 14. M. De Rosa, L. Minale and G. Sodano. Metabolism in Porifera IV. Biosynthesis of 3ß-hydroxymethyl-A-nor -5-O-steranes from cholesterol by Axinella verrucosa. Experientia, 31, 408, 1975. 15. M. De Rosa and A. Gambacorta. Identification of natural and semisynthetic ω-cycloalkyl fatty acids. Phytochemistry, 14, 209, 1975. 16. M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. Extremely thermophilic acidophilic bacteria convergent with Sulfolobus acidocaldarius. J. Gen. Microbiol., 86, 156, 1975. 17. G. Millonig, M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'lock. Ultrastructure of an extremely thermophilic acidophilic microorganism. J. Gen. Microbiol., 86, 165, 1975. 18. M. De Rosa, L. Minale and G. Sodano. Metabolism in Porifera V. Biosynthesis of 19-nor-stanols Conversion of cholesterol into 19-nor-cholestanols by the sponge Axinella polypoides. Experientia, 31, 758, 1975. 19. S. Andini, E. Benedetti, L. Ferrara, L. Paolillo, P.A. Temussi. NMR Studies of Prebiotic Polypeptides. Origins of Life, 6, 147, 1975. 20. P.A. Temussi. Studi di macromolecole biologiche mediante la spettroscopia di risonanza magnetica di ¹³C.-¹³C-FT-NMR. E. Tiezzi, edito dall’Università degli Studi di Siena,1, 1975. 23. G. Belvedere, A. Frigerio, A. Malorni, D.Nardi. Mass spectra of some 4-substituted phenyl-1,3-dihydro-2H-1,5Benzodiazepine-2-Thiones. Boll. Chim. Farm., 114, 151, 1975. 24. G. Marino, A. Malorni. Peptide fragmentation mechanisms. 3rd Intern. Symposium on Mass spectrometry in Biochemistry and Medicine, 34, 1975. ELENCO Anno 1976 1. L. Minale, G. Cimino, S. De Stefano e G. Sodano. Natural Products from Porifera. Fortschritte der Chemie Organischer Naturstoffe, 33, 1, 1976. 2. M. G. Cacace, M. De Rosa and A. Gambacorta. DNA-dependent RNA polymerase from the thermophilic bacterium Caldariella acidophila. Purification and basic properties of the enzyme. Biochemistry, 15, 1692, 1976. 3. M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. The Caldariella group of extreme thermoacidophile bacteria: direct comparison of lipids in Sulfolobus, Thermoplasma and the MT strains. Phytochemistry, 15, 143, 1976. 4. M. De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock Isoprenoid triether lipids from Caldariella. Phytochemistry, 15, 1995, 1976. 5. M . De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta, M. Cartenì-Farina and V. Zappia. Occurrence and characterization of new polyamines in the extreme thermophile Caldariella acidophila. Biochem. Biophys. Res. Comm., 69, 253, 1976. 6. M. G. Cacace, M. De Rosa and A. Gambacorta. Thermophilicity and thermostability of RNA polymerases from two strains of Caldariella acidophila, an extremely thermoacidophilic bacterium. Experientia Suppl., 26, 363, 1976. 7. V. Buonocore, C. Caporale, M. De Rosa and A. Gambacorta. Stable, inducible thermoacidophilic α-amylase from Bacillus acidocaldarius. J. Bacteriol., 128, 515, 1976. 8. M. De Rosa, L. Minale and G. Sodano. Metabolism in Porifera VI. Role of the 5,6 double bond and the fate of the C-4 cholesterol during the conversion into ß-hydroxymethyl-A -nor-5-O-steranes in the sponge Axinella verrucosa. Experientia, 32, 1112, 1976. 9. T. Tancredi, P.A. Temussi, L. Paolillo, E. Trivellone, E. M. Bradbury and C. Crane-Robinson. A Study of Calf Thymus Histone H2B Using 13C Magnetic Resonance. Eur. J. Biochem. 70, 403, 1976. 21. S. Capasso, C. Mattia, R.Puliti, A. Zagari. The Crystal Structure of S-Benzyl-L-cysteinyl-S-Benzyl-L-Cysteine. Acta Cryst., B31, 2466, 1975. 10. F. Lelj, T. Tancredi, P.A. Temussi and C. Toniolo. Stereochemistry and Taste: the Sweetness of Aspartame. In: Peptides 1976, A. Loffet Ed., Presse Université de Bruxelles, Bruxelles, Belgio, 585, 1976. 22. F. Addeo, A. Malorni, G. Marino. Analysis of dansylamides in mixtures by mass spectrometry using metastable defocusing. Anal. Biochem., 64, 98, 1975. 11. F. Lelj, T. Tancredi, P.A. Temussi and C. Toniolo. Interaction of α-L-Aspartyl-L-Phenylalanine Methyl Ester with the Receptor Site of the Sweet Taste Bud. J. Amer. Chem. Soc. 98, 6669, 1976. 93 12. S. De Rosa, L. Minale, R. Riccio e G. Sodano. The absolute cnfiguration of Avarol, a rearranged sesquiterpenoid hydroquinone from a marine sponge. J.C.S. Perkin I, 1408, 1976. 13. L. Minale. Natural Products Chemistry of the marine sponges. Pure and Appl. Chem., 48, 7, 1976. 14. L. Minale e R. Riccio. Constituent of the digestive gland of the Molluscs of the genus Aplysia. I. Novel diterpenes from Aplysia depilans. Tetrahedron Lett., 2711, 1976. 15. M. De Rosa, L. Minale e G. Sodano. Metabolism in Porifera VI. Role of the 5, 6 double bond andthe fate of the C-4 of cholesterol during the conversion into 3-βhidroxymethil-A-nor-5α-steranes in the sponge Axinella verrucosa. Experientia, 32, 1112, 1976. ELENCO Anno 1977 1. G. Cimino. A survey of sesquiterpenoids from marine sponges. In: Marine Natural Products Chemistry. D.J.Faulkner and W.Fenical eds., Plenum Press, New York, 61, 1977. La biochimica dei microrganismi termofili. Annuario della EST, Enciclopedia della scienza e della tecnica Mondadori, 18, 330, 1977. 10. L.Minale e G. Sodano. Non-conventional sterols from marine origins. In: Marine Natural Products Chemistry. D.J. Faulkner and W. Fenical eds.,Plenum Press, New York 87, 1977. 11. B. Danise, L. Minale, R. Riccio, V. Amico, G. Oriente, M. Piatelli, C. Tringoli, E. Fattorusso, S. Magno e L. Mayol. Further perhydroazulene diterpenes from marine organisms. Experientia, 33, 413, 1977. 12. F.Imperato, L. Minale e R. Riccio. Constituents of the digestive gland of the Mollusks of the Genus Aplysia. II. Halogenated monoterpenes from Aplysia limacina. Experientia, 33, 1273, 1977. 13. L. Minale, R. Riccio, O. Scalona, G. Sodano, E. Fattorusso, S. Magno, L.Mayol e C. Santacroce. Metabolism in Porifera VII. Conversion of 7, 7-³H2-fucosterol into calysterol by the sponge Calyx nicaensis. Experientia, 33, 1550, 1977. 14. F. Chioccara, E. Novellino, G. Prota e G. Sodano. Trimeric aldolization product of 1, 4-benzothiazine. J.C.S. Chem. Comm., 50, 1977. 2. G. Cimino, S. De Stefano, L, Mina1e and E. Trivellone. 12-epi-scalarin and 12-epi-deoxoscalarin, sesterterpenes from the sponge Spongia nitens. J.C.S. Perkin I, 1587, 1977. 15. S. Capasso, C. Mattia, L. Mazzarella, R. Puliti. Structure of a cis-Peptide Unit: Molecular Conformation of the Cyclic Disulphide L-Cysteinyl-L-cysteine. Acta Cryst., B33, 2080,1977. 3. G. Cimino and S. De Stefano. New acetylenic compounds from the sponge Reniera fulva. Tetrahedron Lett., 1325, 1977. 16. G. Randazzo, C. Sepe e A. Malorni. Esempi di determinazione di struttura di alcune sostanze ad attività biologica. Boll. Chim. Farm., 116, 191, 1977. 4. M. De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale and J.D. Bu'Lock. Chemical structure of the ether lipids of thermophilic acidophilic bacteria of the Caldariella group Phytochemistry, 16, 1909, 1977. 5. M. De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. Lipid structures in the Caldariella group of extreme thermoacidophile bacteria. J.C.S. Chem. Comm., 514, 1977. 6. M. De Rosa, S. De Rosa and A. Gambacorta. C-NMR assignment and biosynthetic data for the ether lipids of Caldariella. Phytochemistry, 16, 1961, 1977. 13 7. M. De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta, L. Minale, R. Thomson and R. Worthington. Caldariellaquinone, a unique benzo-b-thiophen-4,7-quinone from Caldariella acidophila, an extremely thermophilic and acidophilic bacterium. J.C.S. Perkin I, 653, 1977. 8. P. Cammarano, F. Mazzei, P. Londei, M. De Rosa, S. De Rosa and A. Gambacorta. Stability of the large ribosomal subunit of the extremely thermophilic acidophilic bacterium Caldariella acidophila. In: Translation of natural and synthetic polynucleotides. A.B. Legoekii ed. Elsevier, Neederland, 367, 1977. 9. M. De Rosa, A. Gambacorta and L. Minale. 17. M.R. Faraone Menella, B. Nicolaus, B. Farina and V. Leone. Research on inhibitors of uricase. Acc. Soc. Naz. Scienze Serie IV, XLIV, 1977. ELENCO Anno 1978 1. G. Cimino, F. Cafieri, L. De Napoli e E. Fattorusso. 13 C-NMR spectrum and absolute stereochemistry of furoscalarol. Tetrahedron Lett., 2041, 1978. 2. G. Cimino e S. De Stefano. Chemistry of Mediterranean gorgonians: simple indole derivatives from Paramuricea chamaeleon. Comp. Biochem. Physiol. 61C, 361, 1978. 3. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale e E. Trivellone. Furanosesquiterpenoids in sponges VI. Further structural studies for spiniferins, sesquiterpenes from Pleraplysilla spinifera. Experientia, 34, 1425, 1978. 4. M. De Rosa and A. Gambacorta. Adattamenti biochimici alla temperatura. Le Scienze, 120, 78, 1978. 5. M. De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta, M. Cartenì-Farina and V. Zappia. The biosynthetic pathway of new polyamines in Caldariella acidophila. Biochem. J., 176, 1, 1978. 94 6. A.Oliva, M. Cartenì-Farina, G. Napolitano, G. Romano, V. Zappia, M. De Rosa and A. Gambacorta. 5'-metiltioadenosina fosforilasi da Caldariella acidophila. I Purificazione e parziale caratterizzazione. Bollettino Sibs, 54, 2355, 1978. 7. M. Cartenì-Farina, A. Oliva, G. Romano, G. Napolitano, V. Zappia, M. De Rosa and A. Gambacorta. 5'-metiltioadenosina fosforilasi da C. acidophila. II Identificazione e caratterizzazione dei prodotti di reazione. Bollettino Sibs, 54, 2362, 1978. 8. V. Zappia, R. Porta, M. Cartenì-Farina, M. De Rosa and A. Gambacorta. Polyamine distribution in eukaryotes: occurrence of sym-norspermidine and sym-nor-spermine in arthropods. FEBS Lett., 94, 161, 1978. 9. P.A. Temussi, F. Lelj and T. Tancredi. Three-Dimensional Mapping of the Sweet Taste Receptor Site. J. Medicinal Chem., 21, 1154, 1978. 10. T. Tancredi, P.A. Temussi and G. Di Pascale. 13C Study of the Self-Aggregation of Calf Thymus Histones. In: Proceedings of European Conference on NMR of Macromolecules, F. Conti Ed., Lerici, 443, 1978. 11. L. Bibolino, L. Minale e G. Sodano. Investigations on the ring contraction step in the biosynthesis of Anor-stanols by the sponge Axinella verrucosa. J. C. S. Chem. Comm., 524, 1978. 12. A. Malorni, L. Minale e R. Riccio. Steroids from sponges: occurrence of steroidal ∆4’17 dichetones in the marine sponge Raphidostila incisa. Nouveau Journal de Chimie, 2, 351, 1978. 13. L. Minale. Terpenoids from marine. In: Marine Natural Products. New Perspectives, ed.P.J.Scheuer, Pergamon Press, I, 175, 1978. 14. L.Minale, R. Riccio, F. De Simone, A. Dini, C. Pizza e E. Ramundo. Starfish saponis I. 3β-hydroxy-5-cholesta-8, 14-dien-23-one, the major genin from the starfish Echinaster sepositus. Tetrahedron Lett., 2609, 1978. 15. E. Fattorusso, S. Magno, L. Mayol, C. Santacroce, L. Minale, R. Riccio, O. Scalona e G. Sodano. Opening of the cyclopropene ring of the sponge-derived calysterol by acetylation in the hot. Gazz. Chim. It., 108, 571, 1978. 16. L. Ferrara, L. Paolillo, C. Toniolo e E. Trivellone. ¹³C-NMR of protamines (clupeines). Proc. European Conference on NMR of Macromolecules, F. Conti Ed., Lerici, 415, 1978. 17. Mattia, Mazzarella, R. Puliti, Sica e Zollo. X-Ray crystal structure determination of petrosterol-pbromobenzoate. A Revision. Tetrahedron Lett., 41, 3953, 1978. 18. H. Suzuki, M. Rocca, M. Valpreda, B. Nicolaus and R. De Prisco. Comportamento nel tempo delle attivita' di alcuni enzimi nucleolitici nel plasma seminale bovino. Acc. Soc. Naz. Scienze, Serie IV , XLV, 1978. ELENCO Anno 1979 1. G. Alfano, G. Cimino e S. De Stefano. Palinurin, a new linear sesterterpene from a marine sponge. Experientia, 35, 1136, 1979. 2. G. Cimino, S. De Stefano e A. Di Luccia. Further sesterterpenes from the sponge Spongia nitens: 12-episcalaradial and 12,18-diepi-scalaradial. Experientia, 35, 1277, 1979. 3. G. Cimino, B. Desiderio, S. De Stefano e G. Sodano. Chemistry of Mediterranean gorgonians. Pregna-4,20-dien-11α-ol-3one acetate, a novel steroid from the gorgonian Eunicella cavolini. Experientia, 35, 298, 1979. 4. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale, R. Riccio, K. Hirtosm e J. Clardy. Two novel sesterterpene hydroxyquinols from the sponge Microciona toxistyla. Tetrahedron Lett., 3619, 1979. 5. D. Castiello, G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, G. Izzo e G. Sodano. Studies on the relationship between the opisthobranch Peltodoris atromaculata and the sponge Petrosia ficiformis. Colloque CNRS n. 291 - Biologie des Spongiaires. E. C. Levi et N. Boury-Esnault, CNRS, Paris, 413, 1979. 6. G. Cimino, S. De Stefano, L. Minale, R. Riccio, G. Sodano. Costituenti chimici di alcuni organismi marini e loro interesse biologico e farmacologico. Convegno Scientifico Nazionale Progetto Finalizzato Oceanografia e Fondi Marini.CNR, Roma, 483, 1979. 7. M. De Rosa, C. Di Pinto, A. Gambacorta and B. Nicolaus. C-NMR spectroscopy of cycloalkyl fatty acids. Phytochemistry, 18, 1735, 1979. 13 8. A. Gambacorta, M. De Rosa, R. Porta, M. Cartenì-Farina and V. Zappia. Occurrence of novel polyamines in eukaryotes. Italian J. Biochem., 28, 373, 1979. 9. M. Cartenì-Farina, A. Oliva, G. Romeo, G. Napolitano, M. De Rosa, A. Gambacorta and V. Zappia. 5'-methylthioadenosine phosphorylase from Caldariella acidophila. Purification and properties. Eur. J. Biochem., 101, 317, 1979. 10. A. Oliva, M. Cartenì-Farina, G. Romeo, M. De Rosa and A. Gambacorta. Studies on 5'-methylthioadenosine phosphorylase from Caldariella acidophila. Italian J. Biochem., 28, 380, 1979. 11. T. Tancredi and P.A. Temussi. Secondary Structure of Calf Thymus Histone H1 by Means of 13CNMR Spectroscopy. Biopolymers, 18, 1, 1979. 12. S. Capasso, L. Mazzarella and T. Tancredi. Conformational Analysis of the Cyclic Disulfide L-Cysteinyl-LCysteine. Biopolymers, 18, 1555, 1979. 13. S. Andini, L. Ferrara, P.A. Temussi, F. Lelj and T. Tancredi. Collision Complex. 2. An 1H Nuclear Magnetic Resonance Study of the Complex Caffeine-Benzene. 95 J. Phys. Chem., 83, 1766, 1979. 14. T. Tancredi, F. Lelj, L. Ferrara, S. Andini and P.A. Temussi. Collision Complexes. 3. An 1H Nuclear Magnetic Resonance Study of the Complexes Caffeine-Mesitylene and CaffeineDiphenylmethane. J. Phys. Chem. 83, 2902, 1979. ELENCO Anno 1980 1. D. Castiello, G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. High molecular weight polyacetylenes from the nudibranch Peltodoris atromaculata and the sponge Petrosia ficiformis. Tetrahedron Lett., 5047, 1980. 2. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. Cholest-4-en-4,16β-18,22R-tetrol-3-one-16,18-diacetate a novel polyhydroxylated steroid from the hydroid Eudendrium sp. Tetrahedron Lett., 21 3303,1980. 3. G. Cimino, S. De Stefano, S. De Rosa, G. Sodano e G. Villani. Novel metabolites from some predator-prey pairs. Bull. Soc. Chim. Bel., 89, 1069, 1980. 4. M. De Rosa, A. Gambacorta, M. Cartenì-Farina and V. Zappia. Novel bacterial polyamines. In: Polyamines in biomedical research. J.M. Gaugas ed.: published by J. Wiley & Sons, New York, 255, 1980. 5. M. De Rosa, S. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'lock. Structure of Calditol, a new branched-chain nonitol, and of the Caldariella group. Phytochemistry, 19, 249, 1980. 6. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, V. Buonocore and E. Poerio. Immobilized bacterial cells containing a thermostable βgalactosidase. Biotechnology Lett., 2, 29, 1980. 7. M. De Rosa, A. Gambacorta, E. Esposito, E. Drioli and S. Gaeta. Thermophylic microbial cells immobilized in cellulose acetate membranes. Biochimie, 62, 517, 1980. 8. M. De Rosa, E. Esposito, A. Gambacorta, B. Nicolaus and J.D. Bu'Lock. Effects of temperature on ether lipid composition of Caldariella acidophila. Phytochemistry, 19, 827, 1980. 9. M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. Regularity of isoprenoid biosynthesis in the ether lipids of archaebacteria. Phytochemistry, 19, 791, 1980. 10. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, S. Sodano and J.D. Bu'Lock. Structural regularities in tetraether lipids of Caldariella and their biosynthetic and phyletic implications. Phytochemistry, 19, 833, 1980. 11. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus and J.D. Bu'Lock. Complex lipids of Caldariella acidophila, a thermoacidophile archaebacterium. Phytochemistry, 19, 821, 1980. 12. E. Drioli, S. Gaeta, C. Carfagna, M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. Thermophilic enzymatic semipermeable membranes. J. Memb. Sci., 6, 345, 1980. 13. V. Buonocore, O. Sgambati, M. De Rosa, E. Esposito and A. Gambacorta. A constitutive β-galactosidase from the extreme thermoacidophile archaebacterium Caldariella acidophila: properties of the enzyme in the free state and in immobilized whole cells. J. Appl. Biochem., 2, 390, 1980. 14. E. Drioli, G. Iorio, M. Rossi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Kinetic behaviour of immobilized enzymes in polymeric porous membranes. In: Recent developments in filter media and their applications. Proceedings of the International Symposium held in Bruges, 551, September 1980. 15. M. Beato, A. Saavedra, P. Puigdomènech, T. Tancredi and P.A. Temussi. Progesterone Binding to Uteroglobin. In Steroid Induced Uterine Proteins, M. Beato Ed., Elsevier/North Holland, Amsterdam, Olanda, 105, 1980. 16. F. Lelj, T. Tancredi, P.A. Temussi and C. Toniolo. Interaction of α-L-Aspartyl-D-Phenylalanine Methyl Ester with the Receptor Site of the Bitter Taste. Farmaco Ed. Sci. 35, 988, 1980. 17. P.A. Temussi, T. Tancredi, P. Puigdomènech, A. Saavedra and M. Beato. Interaction of S-Carboxymethylated Uteroglobin with Progesterone. Biochemistry, 19, 3287, 1980. 18. F. De Simone, A. Dini, L. Minale, R. Riccio, F. Zollo. The sterols of the asteroid Echinaster sepositus. Comp. Biochem. Physiol., 66B, 351, 1980. 19. A. De Stefano e G. Sodano. Metabolism in Porifera XII. Further information on the biosynthesis of 3β-hydroxymethyl-A-nor-steranes on the sponge Axinella verrucosa. Experientia, 36, 630, 1980. 20. A. De Stefano e G. Sodano. Ring opening of a steroidal cyclopropanol catalyzed by silica gel. Gazz. Chim. It., 110, 643, 1980. 21. V. Zappia, M. Cartenì-Farina, G. Cacciapuoti, A. Oliva e A. Gambacorta. Recent studies on the metabolism of 5’ methylthioadenosine. In: Natural sulfur compounds: novel biochemical and structural aspects (B. Cavallini, G.E. Garell and V. Zappia, eds).Plenum Press publishing Co. 133, 1980. 22. A. Acampora, G. Boffa, L. Chianese, A. Malorni, N. Sannolo, G. Sodano e W. Taccone. Un nuovo metodo di analisi quantitativa degli acidi bicarbossilici mediante gas-cromatografia. Boll. Soc. It. Biol. Sperim., 56, 512, 1980. 23. S. Capasso, C.A. Mattia, L. Mazzarella and R. Puliti. A study of the aerial oxidation of L-cysteinyl-L-cysteine: purification of the product and equilibrium relationship involving the monomeric and dimeric cyclic derivatives. J. C. S. Perkin II, 1297, 1980. 96 ELENCO Anno 1981 233, 1981. 1. G. Cimino, S. De Rosa e S. De Stefano. Scalarolbutenolide, a new sesterterpenoid from the marine sponge Spongia nitens. Experientia. 37, 214, 1981. 14. F. De Simone, A. Dini, E. Finamore, L. Minale, C. Pizza, R. Riccio e F. Zollo. Starfish saponis V. Structure of Sepositoside A, a novel steroidal cyclic glicoside from the starfish Echinaster sepositus. J.C.S. Perkin Trans. I, 1855, 1981. 2. G.Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. Novel sesquiterpenoid esters from the nudibranch Dendrodoris limbata. Tetrahedron Lett., 22, 1271, 1981. 15. L. Minale, R. Riccio, F. De Simone, A. Dini, C. Pizza e F. Zollo. Steroidal Glycosides from Asteroids. In: Natural Products as Medicinal Agents, ed. by J.L. Beal and E. Reinhard, Hippokates Verlag Stuttgart, 319, 1981. 3. G. Cimino, A. Crispino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. Polyacetylenes from the sponge Petrosia ficiformis found in dark caves. Experientia, 37, 924, 1981. 16. R. Riccio, F. De Simone, A. Dini, L. Minale, C. Pizza, F. Senatore e F. Zollo. Starfish saponis. VI. Unique 22, 23-epoxysteroidale cyclic glycoside, minor constituents from Echinaster sepositus. Tetrahedron Lett., 22, 1557, 1981. 4. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, G. Scognamiglio e G. Sodano. Cholest-4,14-dien-15,20-diol-3,16-dione, a novel poly-oxygenated marine steroid which easely loses the side-chain. Tetrahedron Lett., 22, 3013, 1981. 5. M. De Rosa, A. Gambacorta, G. Sodano and A. Trabucco. Transformation of progesterone by Caldariella acidophila, an extreme thermophilic bacterium. Experientia, 37, 541, 1981. 6. P. Galletti, M. De Rosa, A. Gambacorta, C. Manna, R. Festinese and V. Zappia. Protein methylation in Caldariella acidophila, an extreme thermoacidophilic archaebacterium. FEBS Lett., 124, 62, 1981. 7. E. Drioli, G. Iorio, R. Molinari, M. De Rosa, A. Gambacorta and E. Esposito. High-temperature membrane-entrapped cells. Biotechnology and Bioengineering, 23, 221, 1981. 8. M. De Rosa, A. Gambacorta, L. Lama, B. Nicolaus and V. Buonocore. Immobilization of thermophilic microbial cells in crude egg white. Biotechnology Lett., 3, 183, 1981. 9. G. Romeo, G. Cocchiara, M. De Rosa, F. Giordano and V. Zappia. Trasporto della citidindifosfocolina in differenti modelli biologici. I) Sintesi e caratterizzazione della [53H, Met14C] citidindifosfocolina. Bollettino Sibs, 57, 1175, 1981. 10. P. Galletti, M. De Rosa, A. Gambacorta, C. Manna, F. Della Ragione and F. Giordano. Metilazione delle proteine in Caldariella acidophila, parziale caratterizzazione dell'enzima proteina metilasi II. Bollettino Sibs, 57, 1075, 1981. 11. G. Romeo, G. Cocchiara, M. De Rosa, A. Andreana, G. Ruggiero and V. Zappia. Trasporto della citidindifosfocolina in differenti modelli biologici. II) Trasporto della [53H, Met14C] citidindifosfocolina nel fegato di ratto isolato e perfuso. Bollettino Sibs, 57, 1182, 1981. 12. M. R. Ciajolo, F. Lelj, T. Tancredi and P.A. Temussi. Anti-Anisaldehyde Oxime. Acta Cryst., B37, 1130, 1981. 13. P. Cristinziano, F. Lelj, T. Tancredi and P.A. Temussi. Structure Determination of Collision Complexes by NMR Methods. In Intermolecular Forces, B. Pullman Ed., D. Reidel Publishing Co., 17. E. Drioli, G. Iorio, R. Santoro, M. De Rosa, A. Gambacorta e B. Nicolaus. Whole cell immobilization in polyurethane structured foam. J. Mol. Catalysis, 14, 247 1981. 18. F. Addeo, S.Kuzdzal, L. Chianese, A. Malorni e C. Sepe. Les composès liposolubles mineures du lait de bufflonne. Le lait, 61, 187, 1981. 19. A. Malorni, G. Marino e A. Parente. Sequence determination of biological macromolecules by mass spectrometry. Annali di Chimica, 71, 59, 1981. 20. A. Malorni. Impiego della spettrometria di massa nello studio di sequenze di macromolecole biologiche. In Introduzione alla Spettrometria di Massa Organica (N. Uccella, ed.), Stab. Tip. De Rose, Cosenza, 205, 1981. 21. N.Sannolo, P.Vajro, A. Acampora e A. Malorni. Estrazione dei lipidi fecali e determinazione dell’acido idrossistearico mediante gas cromatografia-spettrometria di massa (GC/MS). Boll. Soc. Ital. Biol. Sper., 57, 118, 1981. ELENCO Anno 1982 1. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, L. Cariello e L. Zanetti. Structure of two biologically active sesquiterpenoid amino-quinones from the marine sponge Disidea avara. Experientia, 38, 896, 1982. 2. G. Cimino, R. Morrone e G. Sodano. New diterpenes from Spongia officinalis. Tetrahedron Lett., 23, 4139, 1982. 3. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, L. Mazzarella, R. Puliti e G. Sodano. Isolation and X Ray crystal structure of a novel bromo-compound from two marine sponges. Tetrahedron Lett., 23, 767, 1982. 4. G. Cimino, S. De Rosa , S. De Stefano e G. Sodano. The chemical defense of four Mediterranean nudibranchs. Comp. Biochem. Physiol., 73B, 471, 1982. 5. G. Cimino, S. De Rosa e S. De Stefano. Guggulsterol-like steroids from the Mediterranean gorgonian Leptogorgia sarmentosa. Experientia, 38, 1443, 1982. 97 6. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, G. Sodano. Recenti risultati nello studio dei costituenti chimici di organismi marini dotati di attività biologica e farmacologica. Atti del Convegno Unità Operative sottoprogetti Risorse Biologiche e Inquinamento Marino. CNR, Roma, 255, 1982. 7. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus and S. Sodano. Incorporation of labelled glycerols into ether lipids in Caldariella acidophila. Phytochemistry, 21, 595, 1982. 8. A. Gliozzi, R. Rolandi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Artificial black membranes from bipolar lipids of thermophilic archaebacteria. Biophysical J., 37, 563, 1982. 9. E. Drioli, G. Iorio, R. Santoro, M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. Whole cell immobilization in polyurethane structural foam. J. Mol. Catalysis, 14, 247, 1982. 10. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, H.N.M. Ross, W. D. Grant and J.D. Bu'Lock. An asymmetric archaebacterial diether lipid from alkaliphilic halophiles. J. Gen. Microbiol., 128, 343, 1982. 11. G. Cocchiara, G. Romeo, M. De Rosa and V. Zappia. Trasporto della citidindifosfocolina in differenti modelli biologici. III) Trasporto della [53H, Met14C] citidindifosfocolina in eritrociti umani intatti. Bollettino Sibs, 58, 218, 1982. 12. P. Cammarano, P. Londei, R. Biagini, M. De Rosa and A. Gambacorta. Characterization of the secondary structure features of Escherichia coli, Caldariella acidophila and mammalian ribosomal RNA species by chemical modification of sterically exposed bases. Eur. J. Biochem., 128, 297, 1982. 13. P. Cammarano, F. Mazzei, P. Londei, M. De Rosa and A. Gambacorta. Secondary structure features of ribosomal RNA species of extremely thermoacidophilic archaebacteria (Caldariella acidophila), moderate thermoacidophilic and mesophilic eubacteria. Spectrofotometric studies. Biochim. Biophys. Acta, 669, 1, 1982. 14. G. Sodano, A. Trabucco, M. De Rosa and A. Gambacorta. Microbiological reduction of steroidal ketones using the thermophilic bacterium Caldariella acidophila. Experientia, 38(11), 1311, 1982. 15. A. Gliozzi, R. Rolandi, M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. Membrane models of archaebacteria. In: Transport in Biomembranes: Model systems and reconstitution. R. Antolini, A. Gliozzi and A. Iorio eds. Raven Press., New York, 39, 1982. 16. A. Gliozzi, G. Paoli, R. Rolandi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Structure and transport properties of artificial bipolar lipid membranes. Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 9, 591, 1982. 17. E. Drioli, G. Iorio, M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. High temperature cell trapped ultrafiltration membranes. In: Enzyme Engineering. I. Chibata, S. Fukui and Jr.L.B. Wingard eds. Plenum Press, N.Y., 6, 209, 1982. 18. E. Drioli, G. Iorio, M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. High temperature immobilized-cell ultrafiltration reactors. J. Membr. Science, 11, 365, 1982. 19. P. Cammarano, A. Teichner, G. Chinali, P. Londei, M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus Archaebacterial elongation factor Tu insensitive to pulvomycin and kirromycin. FEBS Lett., 148, 255, 1982. 20. T. Tancredi, P.A. Temussi and M. Beato. Interaction of Oxidized and Reduced Uteroglobin with Progesterone. Eur. J. Biochem., 122, 101, 1982. 21. M. R. Ciajolo, F. Lelj, T. Tancredi, P.A. Temussi and A. Tuzi. Structure Analysis of Two Conformationally Flexible Sapidants, oand p-Tolyl Urea. Acta Cryst., B38, 2928, 1982. 22. M. R. Ciajolo, F. Lelj, T. Tancredi, P.A. Temussi and A. Tuzi. Crystal Structure Analysis of Meta-Tolyl Urea, a Flexible Bitter Compound. Gazz. Chim. It., 112, 429, 1982. 23. A. Dini, L. Minale, C. Pizza, R. Riccio e F. Zollo. The sterols of the sponge of Axinella damicornis. Comp. Biochem. Physiol., 71B, 285, 1982. 24. M. D’Ischia, G.Prota e G. Sodano. Reaction of polygodial with primary amines: an alternative exploration to the antifeedant activity. Tetrahedron Lett., 3295, 1982. 25. L. Minale, C. Pizza, F. Zollo e R. Riccio. 5α-cholestane-3β,6β,15α,16β,26-pentol; a polydroxylated sterol from the starfish Hacelia attenuata. Tetrahedron Lett., 1481, 1982. 26. L. Minale, C. Pizza, F. Zollo e R. Riccio. Steroidal glycosides from starfishes. Pure Appl. Chem., 54, 1935, 1982. 27. L. Minale, C. Pizza, F. Zollo e R. Riccio, A. Dini e T. Sevenet. Starfish saponis VII. Structure of luzonicoside, a further steroidal cyclic glycoside from the pacific starfish Echinaster luzonicus. Experientia, 38, 68, 1982. 28. L. Minale, C. Pizza, F. Zollo, R. Riccio e J. Pausset. Starfish saponis Part. 8. Structure of nodososide, a novel type of steroidal glycoside from the starfish Protoreaster nodosus. Tetrahedron Lett., 2899, 1982. 29. L. Bohlin, U. Sjöstrand, G. Sodano e C. Djerassi. Sterols in marine invertebrate.33. The structure of six new 3βhydroxymethyl-A-nor-steranes:indirect evidence for transformation of dietary precursors in sponges. J. Org. Chem., 47, 5309, 1982. 30. C.A.Mattia, L. Mazzarella, R. Puliti. 4-(2-amino-4-oxo-2-imidazolin-5-ylidene)-2-bromo-4,5,6,7tetrahydropyrrolo-[2,3,c]azepin-8-one methanol solvate. Acta Cryst., B38, 2513, 1982. ELENCO Anno 1983 1. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, G. Sodano e G. Villani. Dorid nudibranch elaborates its own chemical defense. Science, 219, 1237, 1983. 98 2. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, R. Self e G. Sodano. The bromo-compounds of the true sponge Verongia aerophoba. Tetrahedron Lett., 24, 3029, 1983. 3. V. Zappia, M. Cartenì-Farina, G. Romeo, M. De Rosa and A. Gambacorta. Purification and properties of 5'-methylthioadenosine phosphorylase from Caldariella acidophila. In: Methods in Enzymology, Polyamines, H.Tabor and C.Tabor eds. Published by Academic Press, N.Y., 94, 355, 1983. 4. P. Londei, A. Teichner, P. Cammarano, M. De Rosa and A. Gambacorta. Particle weights and protein composition of the ribosomal subunits of the extremely thermoacidophilic archaebacterium Caldariella acidophila. Biochem. J., 209, 461, 1983. 5. A. Gliozzi, R. Rolandi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Monolayer black membranes from bipolar lipids of archaebacteria and their temperature induced structural changes. J. Membr. Biol., 75, 45, 1983. 6. M. De Rosa, A. Gambacorta and J.D. Bu'Lock. Isoprenoid Biosynthesis in Archaebacteria. In: Biosynthesis of isoprenoid compounds. J.N. Porter and S.L. Spurgeon eds.: published by J. Wiley & Sons Itd., New York, 159, 1983. 14. F. Galdiero, M.A. Tufano, M. De Rosa, A. Gambacorta, P. Catalanotti and L. Sommese. Modulazione della risposta immune negli archeobatteri. Atti del XX congresso della Società Italiana di Microbiologia Gardone, Riviera, 389, 1983. 15. V. Busico, L. Mevo, G. Palumbo, A. Zambelli and T. Tancredi. Preliminary Results on Ethylene/propene Copolymerization in the Presence of Cp2Ti(CH3)2/Al(CH3)3/H2O. Macromol. Chem., 184, 2193, 1983. 16. M. R. Ciajolo, F. Lelj, T. Tancredi, P.A. Temussi and A. Tuzi. Interaction of Conformationally Flexible Agonists with the Active Site of Sweet Taste. A Study of Arylureas. J. Med. Chem., 26, 1060, 1983. 17. S. Salvadori, R. Tomatis, W. A. Gibbons, A. Pastore, T. Tancredi and P.A. Temussi. NMR Studies of Natural Dermorphin and its Synthetic Analogues. In: Peptides. Structure and Function. V. J. Hruby and D. H. Rich, Eds., Pierce Chemical Co., Rockford, Ill., USA, 785, 1983. 18. S. De Rosa e S. De Stefano. Chrysin 7-gentiobioside from the flowers of Spartium junceum. Phytochemistry, 22, 2323, 1983. 19. L. Minale, C. Pizza, R. Riccio and F. Zollo. Starfish saponin. Part. X. Further 24-O-glycosidated steroids from the starfish Hacelia attenuata. Experientia, 39, 569, 1983. 7. P. Cammarano, F. Mazzei, P. Londei, A. Teichner, M. De Rosa and A. Gambacorta. Secondary structure features of ribosomal RNA species within intact ribosomal subunits and efficiency of RNA-protein interactions in thermoacidophilic (Caldariella acidophila, Bacillus acidocaldarius) and mesophilic (Escherichia coli) bacteria. Biochim. Biophys. Acta, 740, 300, 1983. 20. L. Minale, C. Pizza, R. Riccio and F. Zollo. Starfish saponis. Part.IX. A novel 24-O-glycosidated steroid from the starfish Hacelia attenuata. Experientia, 39, 567, 1983. 8. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus and W.D. Grant. A C25-C25 diether core lipid from archaebacteria haloalkalophiles. J. Gen. Microbiol., 129, 2333, 1983. 21. L. Minale, C. Pizza, R. Riccio and F. Zollo. Trace polyhydroxylated steroids from starfish Hacelia attenuata. J. Nat. Prod., 46 , 736, 1983. 9. P.I. Lelkes, D. Goldenberg, A. Gliozzi, M. De Rosa, A. Gambacorta and I.R. Miller. Vescicles from mixtures of bipolar archaebacterial lipids with egg phosphatidilcholine. Biochim. Biophys. Acta, 732, 714, 1983. 22. L. Minale and R. Riccio. Steroidal glycosides of marine origin. Rad. Jugoslav. Akad. znan i umjet, Kem.2, 143, 1983. 10. M. De Rosa, A. Gambacorta and B. Nicolaus. A new type of cell membrane, in thermophilic archaebacteria, based on bipolar ether lipids. J. Membr. Science, 16, 287, 1983. 11. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, B. Chappe and P. Albrecht. Isoprenoid ethers, backbone of complex lipids of the archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Biochim. Biophys. Acta, 753, 249, 1983. 12. A. Gliozzi, G. Paoli, M. De Rosa and A. Gambacorta. Effect of isoprenoid cyclization on the transition temperature of lipids in thermophilic archaebacteria. Biochim. Biophys. Acta, 735, 234, 1983. 13. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, P. Catalanotti and M.A. Tufano. I lipidi degli archeobatteri, "marker" tassonomico di una nuova linea evolutiva. Atti del XX congresso della Società Italiana di Microbiologia Gardone, Riviera 315, 1983. 23. S. Capasso, C.A.Mattia, R.Puliti e A. Zagari. [Ni(C12 H13 N3 O5 )]. 3H2 O: Crystal structure. Acta Cryst., C39, 1517, 1983. 24. C.A.Mattia, R.Puliti, L. Mazzarella, V.Vitagliano. Stacking interactions in the acridine days. J. Cryst. Spect. Res., 14, 1983. 25. S.Andini, G.D'Alessio, A.Di Donato, L.Paolillo, R.Piccoli and E.Trivellone. Comparative Proton NMR Studies of Bovine Semen and Pancreas Ribonucleases. B.B.A., 742, 530, 1983. 26. G. Esposito, A. Motta and P. A. Temussi. Influence of the Ionic Environment on the Conformation of Aspartic Acid and Possible Relevance to its Neurotransmitter Action. J. Neurochem., 40, 903, 1983. 99 ELENCO Anno 1984 Simulation of the Active Site of the Receptor of Sweet Molecules. Int. J. Quant. Chem., XXVI, 889, 1984. 1. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. C-18 hydroxy steroids from the Mediterranean gorgonian Leptogorgia sarmentosa. Experientia, 40, 246, 1984. 14. A. Pastore, P.A. Temussi, T. Tancredi, S. Salvadori and R. Tomatis. Proton Magnetic Resonance Studies on Dermorphin and its Peptide Fragments. Biopolymers, 23, 2349, 1984. 2. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, A. Spinella e G. Sodano. The zoochrome of the sponge Verongia aerophoba (Uranidine). Tetrahedron Lett., 25, 2925, 1984. 3. G. Cimino, S. De Rosa e S. De Stefano. Antivira1 agents from a gorgonian, Eunicella cavolini. Experientia, 40, 339, 1984. 4. G. Cimino, A. Spinella e G. Sodano. Identification of an intermediate in the reaction between polygodia1 and methylamine in biomimetic conditions. Tetrahedron Lett., 25, 4151, 1984. 5. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. A new furanosesquiterpene from the Mediterranean a1cyonacean: Alcyonum palmatum. J. Nat. Prod., 47(5), 877, 1984. 6. G. Cimino, G. Sodano, R. Self e G.R. Fenwick. Fast atom bombardment mass spectra of complex halogenated metabolites from Veronqia sp. sponges. Gazz. Chim. It., 115, 533, 1984. 7. V. Zappia, M. De Rosa, G. Pontoni, C. Manna, A. Salluzzo, L. Del Piano and P. Galletti. Mechanism of choline-phosphate transfer:kinetics and substrate specificity of 1,2-diacylglycerol:CDP-cholinephosphotransferase. In: Novel biochemical, pharmacological and clinical aspects of cytidinediphoshocholine. V. Zappia, E.P. Kennedy, B. Nilsson, P. Galletti, eds. - Elsevier, New York, 41, 1984. 8. M. De Rosa, P. Galletti, G. Romeo, A. Nappi, G. Pontoni, E. Arrigoni and V. Zappia. Pharmacokinetics and metabolism of double-labelled CDP-choline. In: Novel biochemical, pharmacological and clinical aspects of cytidinediphosphocholine.V. Zappia, E.P. Kennedy, B. Nilsson, P. Galletti, eds - Elsevier, New York, 139, 1984. 9. M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, P. Giardina, E. Poerio and V. Buonocore. Glucose metabolism in the extreme thermoacidophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Biochem. J., 224, 407, 1984. 10. M. Rossi, M. De Rosa, A. Gambacorta, V. Buonocore, E. Drioli, R. Rella and S. Bartolucci. Potential applications of enzymes and cells of thermophilic archaebacteria. In: Biotechnology Proceedings of Commission of the European Communities Braunschweig, 58, 1984. 11. M. Carballo, P. Puigdomènech, T. Tancredi and J. Palan. Interaction Between Domains in Chromosomal Protein HMG-1. Embo Journal, 3, 1255, 1984. 15. A. Pastore, S. Salvadori, T. Tancredi, P.A. Temussi and R. Tomatis. NMR Studies of Opioid Peptides in a Simulated Receptor Environment. In: Peptides 1984, U. Ragnarsson Ed., Almquist & Wiksell International, Stockholm, Svezia, 333, 1984. 16. V. Di Marzo, G. Marino, A. Palmisano, G. Sannia, S. Tomlin, L. Rees, A. Etienne and H.R. Morris. Methionine-enkephalin precursor in Neuroblastoma x Glioma hybrid cells: in vivo and in vitro evidence. Biochem. Int., 9, 361, 1984. 17. S. De Rosa, S. De Stefano, S. Macura, E. Trivellone and N. Zavodnik. Chemical studies of North Adriatic Seaweeds I. New dolabellane diterpenes from the brown alga Dilophus fasciola. Tetrahedron, 40, 4991, 1984. 18. L. Minale, C. Pizza, R. Riccio, F. Zollo, J. Pusset and P. Laboute. Starfish saponins XIII. Occurrence of nodososide in the starfishes Acanthaster planci and Linckia laevigata. J. Nat. Prod., 47, 558, 1984. 19. L. Minale, C. Pizza, R. Riccio, F. Zollo, J. Pusset, C. Sorrentino and G. Bargibant. Minor polyhydroxylated sterols from the starfish Protoreaster nodosus. J. Nat. Prod., 47, 790, 1984. 20. L. Minale, C. Pizza, R. Riccio, F. Zollo, J. Pusset, Squillace Greco and J.L.Menou. New Polyhydroxylated sterols from the starfish Luidia maculata. J. Nat. Prod., 47, 784, 1984. 21. M.V.D’Auria, E. Finamore, L. Minale, C. Pizza, R. Riccio, F. Zollo, M. Pusset and P. Tirard. Steroid from the starfish Euretaster insignis: a novel group of sulphated 3β,21-dihydroxysteroids. J.C.S. Perkin Trans.I, 2277, 1984. 22. I. Bruno, L. Minale, C. Pizza, R. Riccio, F. Zollo and F.A.Mellone. Starfish saponins. Part.XIV. Structures of the steroidal glycoside sulphantes from the starfish Marthasterias glacialis. J.C.S. Perkin Trans. I, 1875, 1984. 23. L. Minale, C. Pizza, A. Plomitallo, R. Riccio, F. Zollo and F.A.Mellone. Starfish saponins XII. Sulphated steroid glycosides from the starfish Hacelia attenuata. Gazz. Chim. It., 114, 143, 1984. 12. S. Capasso, L. Mazzarella, T. Tancredi and A. Zagari. Synthesis and Properties of L-Cysteinyl-L-Cysteine Disulfides. Biopolymers, 23, 1085, 1984. 24. M.V.D’Auria, L. Minale, C. Pizza, R. Riccio and F. Zollo. Starfish saponins XV. Stereochemistry at C-24 od nodososide (24-Oglycositadated steroid) and at C-25 of 26-hydroxysteroids. Gazz. Chim. It., 114, 469, 1984. 13. P.A. Temussi, F. Lelj, T. Tancredi, M. A. Castiglione Morelli and A. Pastore. Soft Agonist Receptor Interactions: Theoretical and Experimental 25. C. A. Mattia, L. Mazzarella, V. Vitagliano and R. Puliti. Stacking interactions in the acridine dyes: spectrophotometric data and crystal structure of acridine orange hydroiodide and acridine 100 orange hydrochloride monohydrate. J. Cryst. Spec. Res., 14, 71, 1984. 26. R. Puliti, C.A. Mattia, and G. Barone. Crystal structure of 2-deoxy-β-d-lyxo-hexose galactose). Carbohydr. Res., 135, 47, 1984. Biochem. Pharmacol., 34, 4121, 1985. (2-deoxy-β-d- 27. P. A. Temussi, M. Parrilli, A. Pastore, M. A. Castiglione Morelli, C. Beretta, and A. Motta. Experimental Simulation of Receptor Site Environment. 1H Spectra of Amino Acids in Apolar Solvents. Gazz. Chim. It., 114, 257, 1984. 28. C. A. Beretta, M. Parrilli, A. Pastore, T. Tancredi and P.A. Temussi. Experimental Simulation of the Environment of the δ Opioid Receptor. A 500 MHz Study of Enkephalins in CDCl3. Biochem. Biophys. Res. Comm., 121, 456, 1984. ELENCO Anno 1985 1. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, R. Morrone e G. Sodano. The chemical defense of nudibranch mollusc: structure, biosynthetic origin and defensive properties of terpenoids from the dorid nudibranch Dendrodoris grandiflora. Tetrahedron Symposia-in Print, 41, 1093, 1985. 10. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, M. Cartenì-Farina, M. De Rosa and A. Gambacorta. Studies on polyamine content in halophilic archaebacteria. Italian J. Biochem., 34, 171A, 1985. 11. G. Pontoni, C. Manna, A. Salluzzo, L. Del Piano, P. Galletti, M. De Rosa and V. Zappia. Studies on enzyme substrate interactions of cholinephosphotransferase from rat liver. Biochim. Biophys. Acta, 836, 222, 1985. 12. S. Bruno, S. Cannistraro, A. Gliozzi, M. De Rosa and A. Gambacorta. A spin label ESR and saturation transfer-ESR study of archaebacteria bipolar lipids. Eur. Biophys. J., 13, 67, 1985. 13. W.D. Grant, G. Pinch, J.E. Harris, M. De Rosa and A. Gambacorta. Polar lipids in methanogen taxonomy. J. Gen. Microb., 131, 3277, 1985. 14. E. Drioli, M. Filosa, G. Catapano, G. Iorio, M. De Rosa, A. Gambacorta and L. Lama. Membrane enzimatiche capillari termostabili. La chimica e l’industria, 67, 617, 1985. 2. G. Cimino, A. De Giulio, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. Further high molecular weight polyacetylenes from the sponge Petrosia ficiformis. J. Nat. Prod., 48, 22, 1985. 15. A. Gulik, V. Luzzati, M. De Rosa and A. Gambacorta. Structure and polymorphism of bipolar isopranyl ether lipids from archaebacteria. J. Mol. Biol., 182, 131, 1985. 3. G. Cimino, G.Sodano, A.Spinella e E.Trivellone. Aglajne-1, a polypropionate metabolite from the opisthobranch mollusk Aglaja depicta. Determination of carbon-carbon connectivity via long-range 1H-13C couplings. Tetrahedron Lett., 26, 3389, 1985. 16. W.L.C. Vaz, D. Hallmann, R.M. Clegg, A. Gambacorta and M. De Rosa. A composition of the translational diffusion of a normal and membrane-spanning lipid in Lα phase, 1-palmitoyl-2oleoylphosphatydilcholine bilayers. Europ. Bioph. J., 12, 19, 1985. 4. G.Cimino, S.De Rosa, S.De Stefano e G.Sodano. Observations on the toxicity and metabolic relationships of polygodial, the chemical defense of the nudibranch Dendrodoris limbata. Experientia, 41, 1335, 1985. 5. G.Cimino, S.De Rosa, S.De Stefano e G.Sodano. 1,2,7-Trihydroxy-8-methoxy-6-methylanthracene,the putative precursor of the marine pigment hallachrome. J. Nat. Prod., 48, 828, 1985. 6. G.Cimino, A.De Giulio, S.De Rosa, S.De Stefano, C.A.Mattia, L.Mazzarella e R.Puliti. Isolation and X-ray crystal structure of a novel 8-oxopurinecompound from a marine sponge. J. Nat. Prod., 48, 523, 1985. 7. I.R. Miller, D. Bach, M. De Rosa and A. Gambacorta. Thermotropic properties of bipolar lipids of Sulfolobus solfataricus and of their mixture with dipalmitoylphosphatidylcholine. Biophys. Chem., 22, 27, 1985. 17. A. Pastore, T. Tancredi, P.A. Temussi, S. Salvadori and R. Tomatis. Interpretation of the mu Activity of Several Dermorphin Fragments in Terms of a New Receptor Model. In: Peptides. Structure and Function, C. M. Deber, V. J. Hruby and K. D. Kopple Eds., Pierce Chemical Co., Rockford, Ill., USA, 529, 1985. 18. M. Goodman, J. Bland, J. Tsang, J. Coddington, P.A. Temussi, T. Tancredi, F. Lelj, W. D. Fuller and M. S. Verlander. Molecular Correlations of Taste Including a New Class of Amino Acid Based Sweeteners. In: Peptides. Structure and Function, C. M. Deber, V. J. Hruby and K. D. Kopple Eds., Pierce Chemical Co., Rockford, Ill., USA, 725, 1985. 19. V. Di Marzo, A. Etienne, G. Marino, H.R. Morris and A. Palmisano. β-endorphin in Neuroblastoma x Glioma hybrid cells. Neuropeptides, 6, 53, 1985. 8. M. Cartenì-Farina, M. Porcelli, G. Cacciapuoti, M. De Rosa, A. Gambacorta, W.D. Grant and H.M.N. Ross. Polyamines in halophilic archaebacteria. FEMS Microbiol. Lett., 28, 323, 1985. 20. G. Marino, A. Palmisano, V. Di Marzo, D. Melck and A. Miralto. Native opioid-like peptide(s) in Squilla mantis ganglia. Peptides, 6, 403, 1985. 9. P. Galletti, M. De Rosa, M.A. Nappi, G. Pontoni, L. Del Piano, A. Salluzzo and V. Zappia. Transport and metabolism of double-labelled CDPcholine in mammalian tissue. 21. P. Cammarano, A. Teichner, P. Londei, M. Acca, B. Nicolaus, J.L. Sans and R. Amils. Insensitivity of archaebacterial ribosomes to protein synthesis inhibitors. Evolutionary implications. Embo J., 4(3), 811, 1985. 101 22. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, G. Pontoni, M. Cartenì-Farina, A. Gambacorta and V. Zappia. Propylamine transfer reactions in Sulfolobus solfataricus. Italian J. Biochem., 34, 183A, 1985. 23. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, M. cartenì-Farina, A. Gambacorta and V. Zappia. Purification and propylamine transferase from Sulfolobus solfataricus. Italian J. Biochem., 67, 617, 1985. 24. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, A. Gambacorta, M. Cartenì-Farina, and V. Zappia. Studies on S-adenosylmethionine synthetase from Sulfolobus solfataricus. Italian J. Biochem., 34, 439, 1985. 25. R. Riccio, C. Pizza, O. Squillace Greco and L. Minale. Starfish saponins. Part. XVII. Steroidal glycoside sulphates from the starfish Ophidiaster ophidianus (Lamark) and Hacelia attenuata (Gray). J.C.S. Perkin Trans. I, 655, 1985. Studies of Swedish Marine Organisms. Part. 6; A novel bioactive steroidal glycoside from the starfish Crossaster papposus. J. Chem. Res., 366, 1985. 35. A. De Marco, A. Motta, M. Llnàs and R.A. Laursen. Macro- and micro-stabilities of the kringle-4 domain from Plasminogen. The effect of ligand binding. Biophys. J., 48, 411, 1985. 36. M. Llnàs, A. Motta, A. De Marco and R.A. Laursen. Kringle 4 from human plasminogen: ¹H-NMR study of the interactions between ω-amino acid ligands and aromatic residues at the lysine binding site. Proc. Int. Symp. Biomol. Struct. Interactions, Supplement J. Biosci., 8 (1), 121, 1985. 37. G. Barone, G. Castronuovo, V. Elia, C.A. Mattia, R. Puliti e R. Rizzo. Thermodinamic and spectroscopic properties of 2-deoxy-sugar in water: comparison with the crystal structures. Thermochim. Acta, 85, 447,1985. ELENCO Anno 1986 26. R. Riccio, O. Squillace Greco, L. Minale,J. Pusset and J.L.Menou. Starfish saponins. Part. XVIII. Steroidal glycoside sulphates from the starfish Linckia laevigata. J. Nat. Prod., 48, 97,1985. 1. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano e G. Sodano. Marine Natural Products: New Results from Mediterranean Invertebrates. Pure Appl. Chem., 58, 375, 1986. 27. R. Riccio, F. Zollo, E. Finamore, L. Minale, D. Laurent, G. Bargibant and J. Pusset. Starfish saponins. Part. XIX. A novel steroidal glycoside sulphates from the starfish Protoreaster nodosus and Pentaceraster alveolatus. J. Nat.Prod., 48, 266, 1985. 2. G. Cimino, S. De Stefano, G. Scognamiglio, G. Sodano e E. Trivellone. Sarains: a new class of alkaloids from the marine sponge Reniera sarai. Bull. Soc. Chim. Belg., 95, 783, 1986. 28. M.V. D’Auria, R. Riccio and L. Minale. Ophioxantin, a new marine carotenoid sulphate from the ophiuroid Ophioderma longicaudum. Tetrahedron Lett.,1871, 1985. 3. G. Cimino, A. Crispino, S. De Stefano, M. Gavagnin e G. Sodano. A naturally occurring analog of methylthioadenosine (MTA) from the nudibranch mollusc Doris verrucosa. Experientia, 42, 1301, 1986. 29. R. Riccio, M.V. D’Auria and L. Minale. Unusual sufated marine steroids from the ophiuroid Ophioderma longicaudum. Tetrahedron, 41(24), 6041, 1985. 4. M. De Rosa, A. Gambacorta, V. Lanzotti, A. Trincone and W. D. Grant. A range of ether core lipids from the methanogenic archaebacterium Methanosarcina barkeri. Biochim. Biophys. Acta, 875, 487, 1986. 30. R. Riccio, M.V. D’Auria, M. Iorizzi, L. Minale, D. Laurent and D. Duhet. Starfish saponins XXV. Steroidal glycosides from the starfish Gomophia watsoni. Gazz. Chim. It., 115, 405, 1985. 5. M. De Rosa, A. Gambacorta and A. Gliozzi. Structure biosynthesis and physicochemical properties of archaebacterial lipids. Microbiol. Rev., 50, 70, 1986. 31. R. Segura De Correa, R. Riccio, L. Minale and C. Duque. Starfish saponins. Part. XXI. Steroidal glycosides from the starfish Oreaster reticulatus. J. Nat. Prod., 48, 751, 1985. 32. R. Riccio, M. Iorizzi, O. Squillace Greco, L. Minale, D. Laurent and V. Barbin. Starfish saponins XXVI. Steroidal glycosides fromthe starfish Poraster superbus. Gazz. Chim. It., 115, 505, 1985. 33. R. Riccio, M. Iorizzi, O. Squillace Greco, L. Minale, M. Debray and J.L.Menou. Starfish saponins. Part. XXII. Asterosaponins from the starfish Halityle regularis: a novel 22,23-epoxysteroidal glycoside sulphates. J. Nat. Prod., 48, 756, 1985. 34. L. Andersen, S. Bano, L. Bohlin, R. Riccio e L. Minale. 6. M. De Rosa and A. Gambacorta. Lipid biogenesis in archaebacteria. Syst. Appl. Microbiol., 7, 278, 1986. 7. S. Bruno, S. Cannistraro, A. Gliozzi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Linear and non-linear electron spin resonance study of lipids from Sulfolobus solfataricus. In: Archaebacteria 85, O. Kandler, ed., published by Gustav Fischer Verlag, New York, 416, 1986. 8. L. Del Piano, A. Salluzzo, M. De Rosa, M. A. Nappi, G. L. Russo and V. Zappia. Farmacodinamica della (5-3H; Met-14C)CDP-colina, somministrata per via orale nel ratto In: Cinetica distributiva della radioattività da 3H e 14C. Rendiconti ed Atti dell'Accademia di Scienze Mediche e Chirugiche, CXL, 11, 1986. 102 9. A. Salluzzo, L. Del Piano, M. De Rosa, P. Galletti, M. A. Nappi, G. L. Russo and V. Zappia. Farmacocinetica della (5-3H; Met-14C)CDP-colina, somministrata per via orale nel ratto. In: Identificazione e determinazione dei livelli delle specie molecolari marcate. Rendiconti ed Atti dell'Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche, CXL, 25, 1986. 10. M. Rossi, R. Rella, M. Pensa, S. Bartolucci, M. De Rosa, A. Gambacorta, C. Raia and N. Dell'Aversano Orabona. Structure and properties of a thermophilic and thermostable DNA polymerase isolated from Sulfolobus solfataricus. Syst. Appl. Microbiol., 7, 337, 1986. 11. A. Gulik, V. Luzzati, M. De Rosa and A. Gambacorta. Structure and polymorphism of bipolar isopranyl ether lipids from Sulfolobus solfataricus. Syst. Appl. Microbiol 7, 258, 1986. 12. A. Trincone, A. Gambacorta, V. Lanzotti and M. De Rosa. A new benzo [1,2-b; 4,5-b’] dithiophene -4,8-quinone from the archaebacterium Sulfolobus solfataricus. J. Chem. Soc. Chem. Comm., 733, 1986. 13. A. Gliozzi, G. Paoli, D. Pisani, F. Gliozzi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Phase transitions of bipolar lipids of thermophilic archaebacteria. Biochim. Biophys. Acta, 861, 420, 1986. 14. C. Scolastico, A. Sidymov, D. Potenza, M. De Rosa, A. Gambacorta and A. Trincone. Cyclopentane ring formation in isoprenoid ether lipids of archaebacteria. In: Archaebacteria 85.0. Kandler ed. Verlag N. Y., 417, 1986. 15. A. Gliozzi, S. Bruno, T. K. Basak, M. De Rosa and A. Gambacorta. Organization and dynamics of bipolar lipids from Sulfolobus solfataricus in bulk phases and in monolayer membranes. Syst. Appl. Microb., 7, 266, 1986. 16. P. Giardina, M. G. De Biasi, M. De Rosa, A. Gambacorta and V. Buonocore. Glucose dehydrogenase from the thermoacidophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Biochem. J., 239, 517, 1986. 17. V. Lanzotti, A. Trincone, A. Gambacorta, M. De Rosa and E. Breitmaier. H and 13C NMR assignment of benzothiophenquinones from the sulfur-oxidizing archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Eur. J. Biochem., 160, 37, 1986. 1 18. R. Rolandi, H. Schindler, M. De Rosa and A. Gambacorta. Monolayers of ether lipids from archaebacteria. Eur. Biophys. J., 14, 19, 1986. 19. P. Ammendola, A. Zambelli, L. Oliva and T. Tancredi. Polymerization of α-olefin in the Presence of δ-TiCl3-Al(CH3)3. Macromol. Chem., 187, 1175, 1986. 20. A. Guarino, W. Taccone, G. Boffa, N. Sannolo, A. Malorni e G. Sodano. La gas cromatografia-spettrometria di mass nello studio delle organico acidurie. G. I. Pat. Clinica, 1, 45,1986. 21. G. Monfregola, D. Martellotta, S. De Stefano, G. Brono, P. Santoianni. Studio comparativo dei livelli plasmatici di 8-metossipsoralene. G. I. Derm. Vener., 121, 1986. 22. A. Malorni, G. Marino e A. Milone. Effect of matrix modification by strong mineral acidis on the positive fast atom bombardment mass spectra of peptides. Biomed. Environ Mass Spectrom., 13, 477, 1986. 23. P. Ammendola, T. Tancredi and A. Zambelli. Isotactic Polymerization of Styrene and Vinylcyclohexene in the Presence of a 13C Enriched Ziegler-Natta Catalyst: Regioselectivity and Enantioselectivity of the Insertion into Metal-Methyl Bond. Macromolecules, 19, 307, 1986. 24. A. Motta, T. Tancredi, E. Trivellone, E. Ceccarini, P. Lorenzoni, D. Lamba and A. Segre. 1H and 13C Resonance Identification of an Octaglycopeptide from Ovalbumin. Proceedings of the 23th Congress Ampère on Magnetic Resonance, B. Maraviglia, F. De Luca and R. Campanella, Eds., ISS, Roma, 414, 1986. 25. T. Tancredi, A. Motta, P.A. Temussi, M. Goodman and P. Lucietto. Conformational Analysis by 500 MHz 1H NMR of a Retro-inverso Cyclic Somatostatin Analogue. Bull. Magn. Res., 8, 214, 1986. 26. G. Marino, A. Palmisano, V. Di Marzo, H.R. Morris, A. Howlett and S. Tomlin. RIA/chromatographic evidence for novel opioid peptide(s) in Squilla mantis ganglia. Neuropeptides, 7, 281, 1986. 27. J.R. Tippins, V. Di Marzo, M. Panico, H.R. Morris and I. McIntyre. An investigation on the structure/activity relationship of human calcitonin gene related peptide (CGRP). Biochem. Biophys. Res. Comm., 134, 1306, 1986. 28. V. Di Marzo, J.R. Tippins and H.R. Morris. The effect of vasoactive intestinal peptide and calcitonin gene-related peptide on peptido-leukotriene release from platelet activating factorstimulated rat lung and ionophore-stimulated guinea pig lung. Biochem. Int., 13, 933, 1986. 29. B. Nicolaus, A. de Simone, L. del Piano, P. Giardina and L. Lama. Production of 2-Keto-3-Deoxygluconate by immobilized cells of Sulfolobus solfataricus. Biotechnology Lett., 8, 497, 1986. 30. G.Zanotti, G.D'auria, L.Paolillo and E.Trivellone. Synthetic Amatoxin Analogue. A Two Dimensional Proton NMR Study of S-Deoxo-(Ile3)-(D-Ala 7)-amaninamide. B.B.A., 870, 854, 1986. 31. M. D'Agostino, S. Crescenzi, G. Prota, S. De Rosa and G. Sodano. Acid-catalyzed isomerization of Hallachrome, the red pigment of the marine worm Halla parthenopeia. J. Nat. Prod., 49, 145, 1986. 32. S. De Rosa, S. De Stefano and N. Zavodnik. Hydroazulenoid diterpenes from the brown alga Dictyota dichotoma var. implexa. Phytochemistry, 25, 2179, 1986. 33. G. Sodano e A. Spinella. Janolusimide, a lipophilic tripeptide toxin from the nudibranch mollusc Janolus cristatus. 103 Tetrahedron Lett., 27, 2505, 1986. 34. S. B. Seidel, J.R. Proudfoot, C. Djerassi, D. Sica e G. Sodano. Minor and trace sterols from marine invertebrates. Novel coprostanols from the marine sponge Petrosia ficiformis. Steroids, 47, 49, 1986. 35. J. R. Proudfoot, C.A.N. Catalan, C. Djerassi, D. Sica e G. Sodano. Biosynthetic studies of marine lipids. 6. Evidence for an unprecedented biomethylation pathway in the biosynthesis of the cyclopropyl -containing marine sterol, petrosterol. Tetrahedron Lett., 27, 423, 1986. 36. M. Iorizzi, L. Minale, R. Riccio, M. Debray e J.L. Menou. Starfish saponins part.XXIII. Steroidal glycosides from the starfish Halityle regularis. J. Nat. Prod., 49, 67, 1986. 37. R. Riccio, O. Squillace Greco, L. Minale e D. Duhet. Highly hydroxylated marine steroids from the starfish Arcaster typicus. J.C.S. Perkin Trans. I, 665, 1986. 38. R. Riccio, M. V. D’Auria e L. Minale. Two new steroidal glycoside sulfates, longicaudoside A and B, from the mediterranean ophiuroid Ophioderma longicaudum. J. Org. Chem., 51, 533, 1986. 39. L. Minale, R. Riccio, C. Pizza e F. Zollo. Steroidal oligoglycosides of marine origin, in natural products and biological activities. A Naito Foundation Symposium. Ed. by H. Imura, T. Goto, I. Murachi, T. Nakajima. University of Tokio Press, 59, 1986. 40. R. Riccio, M. Iorizzi e L. Minale. Starfish saponins XXX. Isolation of sixteen steroidal glycosides and three polyhydroxysteroids from the mediterranean starfish Coscinasterias tenuispina. Bull. Soc. Chim. Belg., 95, 869, 1986. 41. M. Anastasia, P. Allevi, P. Giuffreda e R. Riccio. Configuration assignment of 24R- and 25S-isomers of 29 – oxygenated steroids by 1H and 13C NMR spectroscopy. Tetrahedron, 42, 4843, 1986. 42. F. Zollo, E. Finamore, D. Gargiulo, R. Riccio and L. Minale. Marine sterols. Coprostanols and 4α-methyl sterols from mediterranean tunicates. Comp. Biochem. Physiol., 858, 559, 1986. 43. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, M. Cartenì Farina, G. Dardo, A. Gambacorta e V. Zappia. Inhibition of Sulfolobus solfataricus propylamine transferase by substrate and product analogs. In: Biomedical Studies of Natural Polyamines. C. M. Caldarera, C. Clò and C. Guarnieri, eds. CLUEB, Bologna, Italia, 83, 1986. 44. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, M. Cartenì Farina, G. Dardo, A. Gambacorta e V. Zappia. Occurrence of S-adenosylmethionine synthetase in Sulfolobus solfataricus, an extreme thermophilic archaebacterium. In: Biomedical Studies of Natural Polyamines. C. M. Caldarera, C. Clò and C. Guarnieri, eds. CLUEB, Bologna, Italia, 91, 1986. 45. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, M. Cartenì Farina, G. Dardo, A. Gambacorta e V. Zappia. Purification and characterization of propylamine transferase from Sulfolobus solfataricus, an extreme thermophilic archaebacterium. Eur. J. Biochem., 161, 263, 1986. 46. A. Motta, R. A. Laursen e M. Llinàs. Characterization of the low-field proton magnetic resonance spectrum of plasminogen ksingle 4 via selective Overhausen experiments in ‘H2O. Biochemistry, 25, 7924, 1986. 47. A. Motta, R. A. Laursen, M. Llinàs e N. Rajaw. Proton magnetic resonance study of Ksingle 1 from human plasminogen. J. Bio. Chem., 261, 13684, 1986. 48. G. Bovermann, L. Moroder, E. Wunsch, T. Tancredi, A. Motta, P.A. Temussi, D. Mierke, P. Lucietto e M. Goodman. Conformational studies on three cyclic hexapeptides related to the sequence 7-11 of Somatostatin. Peptides 1986. 49. M. A. Castiglione Morelli, T. Tancredi, E. Trivellone, S. Salvatori, R. Tomatis e P. A. Temussi. Conformation activity relationship of a series of peptides related to dermorphin. A 500 MHz study. Peptides, 1986. 50. L. Mazzarella,C. Pellecchia, C. A. Mattia, V. De Felice, R. Puliti. Secondary enamines as ligands. Synthesis and characterization of complex of group VIII metals with 2-(2-pyridinylmethyl) amino-3-(2 - pyridinylmethylene) amino-2-butenedinitrile (PPH).Crystal structure of the iron (II) complex Fe| (PP)2H|.PF6.2H2O. J. Coord. Chem., 14, 191, 1986. 51. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, M. Cartenì-Farina, G. Dardo, A. Gambacorta and V. Zappia Occurrence of S-adenosylmethionine synthetase in Sulfolobus solfataricus, an extreme thermophilic archaebacterium. In: Biomedical Studies of natural polyamines. C.M. Caldarera, C. Clò and C. Guarneri eds. CLUEB, Bologna, Italia, 91, 1986 ELENCO Anno 1987 1. V. Caprioli, G. Cimino, R. Colle, M. Gavagnin, G. Sodano e A. Spinella. Insect antifeedant activity and hot taste for human of selected natural and synthetic 1,4-Dialdehydes. J. Nat. Prod. , 50, 146, 1987. 2. G. Cimino, M. Gavagnin, G. Sodano, A. Spinella, G. Strazzullo, F. J. Schmitz e G. Yalamanchili. Revised structure of Bursatellin. J. Org. Chem., 52, 2301, 1987. 3. G. Cimino, G. Sodano e A. Spinella. New Propionate derived metabolites from Aglaja depicta and from its prey Bulla striata (Opisthobranch Molluscs). J. Org. Chem., 52, 5236, 1987. 4. G. Cimino, S. De Stefano e G. Strazzullo. Homolog of kelletinin I from the Mediterranean Prosobranch Buccinulum corneum. J. Nat. Prod., 50, 1171, 1987. 5. G. Cimino, S. De Rosa, S. De Stefano, R. Puliti, G. Strazzullo e C. A. Mattia e L. Mazzarella. Absolute stereochemistry of disidein and of two new related halogenated sesterterpenoids. Two dimensional NMR studies and X-ray crystal structure. Tetrahedron, 43, 4777, 1987. 6. G. Cimino, A. Crispino, S. De Rosa, S. De Stefano, M. Gavagnin e 104 G. Sodano. Studies on the structure of calliactine, the zoochrome of the sea anemone Calliactis parasitica. Tetrahedron, 43, 4023, 1987. 7. G. Cimino, G. Sodano e A. Spinella. Correlation of the reactivity of 1,4-dialdehydes with methylamine in biomimetic conditions to their hot taste: covalent binding to primary amines as a molecular mechanism in hot taste receptors. Tetrahedron, 43, 5401, 1987. 8. V. Luzzati, A. Gulik, M. De Rosa and A. Gambacorta. Lipids from Sulfolobus solfataricus, life at high temperature and the structure of membranes. Notal Symposium "Membrane proteins": Structure, Function, Assembly, Karistoga Chemica Scripta, 27B, 211, 1987. 9. M. De Rosa, A. Gambacorta, A. Trincone, A. Basso, W. Zillig and I. Holz. Lipids of Thermococcus celer a sulfur-reducing archaebacterium: Structure and biosynthesis. Syst. Appl. Microbiol., 9, 1, 1987. to Dermorphin. A 500 MHz Study. In: Peptides 1986, D. Theodoropoulos Ed., W. de Gruyter & Co., Berlin, FRG, 443, 1987. 18. G. Boverman, L. Moroder, E. Wünsch, T. Tancredi, A. Motta, P.A. Temussi, D. Mierke, P. Lucietto and M. Goodman. Conformational Studies on Three Cyclic Hexapeptides. Related to the Sequence 7-11 of Somatostatin. In: Peptides 1986, D. Theodoropoulos Ed., W. de Gruyter & Co., Berlin, FRG, 311, 1987. 19 A. Motta, T. Tancredi and P.A. Temussi. Nuclear Overhauser Effects in Linear Peptides. A Low Temperature 500 MHz Study of Met-Enkephalin. FEBS Lett., 215, 215, 1987. 20. G. Lembo, M. Scalvenzi, S. De Stefano, M. Montesano. Minoxidil topico nell‘alopecia aerata. Ann. It. Derm. Clin. Sper., 41, 75, 1987. 21. A. Gliozzi, G. Paoli, D. Pisani, Gliozzi F., M. De Rosa and A. Gambacorta. Phase transition of bipolar lipids of thermophilic archaebacteria. Biochim. Biophys. Acta, 861, 420, 1987. 10. R. Rella, C. A. Raia, M. Pensa, M. S. Pisani, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Rossi. A novel archaebacterial NAD+-dependent alcohol dehydrogenase. Purification and properties. Eur. J. Biochem., 167, 475, 1987. 22. A. Motta, D. Picone, T. Tancredi and P.A. Temussi. NOE Measurements on Linear Peptides in Cryoprotective Aqueous Mixtures. J. Magn. Reson., 75, 364, 1987. 11. W. L. C. Vaz, J. Stumpel, D. Hallmann, A. Gambacorta and M. De Rosa. Bounding fluid viscosity and translational diffusion in a fluid lipid bilayer. Eur. Biophys. J., 15, 111, 1987. 23. M.A. Castiglione-Morelli, F. Lelj, A. Pastore, S. Salvadori, T. Tancredi, R. Tomatis, E. Trivellone and P.A. Temussi. A 500 MHz Proton Nuclear Magnetic Resonance Study of µOpioid Peptides in a Simulated Receptor Environment. J. Med. Chem., 30, 2067, 1987. 12. R. Rella, C. A. Raia, A. Trincone, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Rossi. Properties and specificity of an alcohol dehydrogenase from thermophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Biocatalysis in Organic Media. Edited by C. Laane, J. Tramper, M.D. Lylli Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 273, 1987. 24. P.A. Temussi, T. Tancredi, A. Pastore and M.A. CastiglioneMorelli. Experimental Attempt to Simulate Receptor Site Environment. A 500 MHz 1H Nuclear Magnetic Resonance Study of Enkephalin Amides. Biochemistry, 26, 7856, 1987. 13. R. Rella, C.A. Raia, F.M. Pisani, A. Trincone, C. Vaccaro, R. Nucci, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Rossi. Specificity and stability in organic solvents of a novel archaebacterial. Proc. 4th European Congress on Biotechnology. Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 2, 336, 1987. 14. S. Bartolucci, R. Rella, A. Guagliardi, C. A. Raia, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Rossi. Malic enzyme from archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Purification, structure and kinetic properties. J. Biol. Chem., 262, 7725, 1987. 15. V. Luzzati, A. Gambacorta, M. De Rosa and A. Gulik. Polar lipids of thermophilic prokaryotic organism: chemical and physical structure. Ann. Rev. Biophys. Chem., 16, 25, 1987. 16. V. Lanzotti, M. De Rosa, A. Trincone, A. L. Basso, A. Gambacorta and W. Zillig. Complex lipids from Desulfurococcus mobilis, a sulfur-reducing archaebacterium. Biochim. Biophys. Acta, 922, 95, 1987. 17. M.A. Castiglione-Morelli, T. Tancredi, E. Trivellone, S. Salvadori, R. Tomatis and P.A. Temussi. Conformation Activity Relationship of a Series of Peptides. Related 25. V. Di Marzo, J.R.Tippins and H.R. Morris. Neuropeptides and leukotriene release: effect of peptide histidine isoleucine and secretin on platelet activating factor-stimulated rat lungs. Neuropeptides, 9, 51, 1987. 26. V. Di Marzo, J.R. Tippins, H.R. Morris and A.C. Turnbull. Leukotriene release by non-pregnant human endometrium and myometrium M.C.P. Rees. Adv. Prostaglandin Thromboxane Leukotriene Res., 17, 1125, 1987. 27. J.R. Tippins, V. Di Marzo and H.R. Morris. The effect of vasoactive intestinal peptide and calcitonin gene-related peptide on leukotriene release from guinea pig and rat lung. Adv. Prostaglandin Thromboxane Leukotriene Res., 17, 1024, 1987. 28. V. Di Marzo, J.R. Tippins, H.R. Morris and A.C. Turnbull. Leukotriene release by endometrium and myometrium throughout the menstrual cycle in dysmenorrea and menorrhagia. M.C.P. Rees. J. Endocrinol., 113, 291, 1987. 29. Y. Yiangou, V. Di Marzo, R.A. Spokes, M. Panico, H.R. Morris and S.R. Bloom. Isolation, characterization and pharmacological actions of peptide histidine valine 42, a novel prepro-vasoactive intestinal peptidederived peptide. J. Biol. Chem., 262, 14010, 1987. 105 30. H. Erdjument, D.A. Lane, H. Ireland, M. Panico, V. Di Marzo, I. Blench and H.R. Morris. Formation of a covalent disulphide linked antithrombin-albumin complex by an antithrombin variant, antithrombin 'Northwick Park'. J. Biol. Chem., 262, 13381, 1987. 31. V. Di Marzo, J. R. Tippins and H.R. Morris. Platelet-activating factor-mediated leukotriene biosynthesis in rat lungs: effect of prostaglandins E1 and F1α. Biochem. Biophys. Res. Comm., 147, 1213, 1987. 32. V. Di Marzo, J.R. Tippins and H.R. Morris. Dual role of the neuropeptidergic system in the pathology of asthma? Trends Pharmacol. Sci., 8, 168, 1987. 33. S. De Rosa and S. De Stefano. Guaiane sesquiterpene from Lactarius sanguifluus. Phytochemistry, 26, 2007, 1987. 34. S. De Rosa, S. De Stefano, R. Puliti, C.A. Mattia and L. Mazzarella. Isolation and X-Ray crystal structure of a derivative of 2,6diaminopurine from a sea anemone. J. Nat. Prod., 50, 876, 1987. 35. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, M. Cartenì-Farina, G. Dardo, A. Gambacorta and V. Zappia. Partial purification and characterization of multiple enzymatic form of S-adenosylmethionine from Sulfolobus solfataricus. Ital. J. Biochem., 36, 24, 1987. 36. C. Margot, C.A.N. Catalan, J.A. Proudfoot, G. Sodano, D. Sica and C. Djerassi. Biosynthesis of three cyclopropene-containing sterols in the sponge Calix niceaensis. J. C. S. Chem. Comm., 1441, 1987. 37. R. Riccio, M. Iorizzi and L. Minale. Recent advances in the chemistry of echinoderms. In: Biologically Active Natural Products. Ann. Proc. Phytoc Soc. Europe , ed. by K. Hostettmann and P. J. Lea, Clarendon Press, Oxford, 27, 153, 1987. 38. A. Motta, R. A. Laursen, M. Llinàs, A. Tulinsky and C. H. Park. Complete assignment of the aromatic proton magnetic resonance spectrum of the kringle 1 domain from human plasminogen structure of the ligand-binding site. Biochemistry, 26, 3827, 1987. 39. F. Giordano, R. Puliti. Structure of the 2,5-dimethyl ether of avarole, a sesquiterpenoid hydroquinone from the marine sponge Dysidea avara. Acta Cryst., 43C, 985, 1987. 40. M. V. D‘Auria, R. Riccio, L. Minale, S. La Barre and J. Pusset. Novel marine steroid sulfates from pacific ophiuroids. J. Org. Chem., 52, 3947, 1987. 41. R. Riccio, L. Minale, S. Bano and V.U. Ahmad. Starfish saponins XXXIII. Two novel steroidal xylofuranosides from the starfish Astropecten indicus. Gazz. Chim. It., 117, 755, 1987. 42. L. Anderson, L. Bohlin, R. Riccio and L. Minale. Studies of Swedish Marine Organisms.Part.8. Three novel minor polyhydroxylated steroidal glycosides from the starfish Crossaster papposus L. J. Chem. Res. (S), 246, 1987 (M) 2085, 1987. 43. L. Minale and R. Riccio. Recent results in the chemistry of echinoderms: steroidal glycosides and polyhydroxysteroids. Rev. Latinoamer. Quim., 18/3, 99, 1987. ELENCO Anno 1988 1. G.Cimino, G. Sodano e A. Spinella. Occurrence of olepupuane in two Mediterranean nudibranchs: a protected form of polygodial. J. Nat. Prod., 51, 1010, 1988. 2. G. Cimino, M.Gavagnin, G.Sodano, R.Puliti, C.A.Mattia e L.Mazzarella. Verrucosin-A and -B diterpenoic acid glycerides with a new carbon skeleton from the dorid nudibranch Doris verrucosa. Tetrahedron, 44, 2301, 1988. 3. G. Cimino, A. Crispino, A. Spinella and G. Sodano. Two ichthyotoxic diacylglycerols from the opisthobranch mollusc Umbraculum mediterraneum. Tetrahedron Lett., 29, 3613, 1988. 4. J. C. Braekman., D. Daloze, G. Cimino and E. Trivellone. 2D-NMR study of petrosins: revised structure for petrosin-A. Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 519, 1988. 5. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, G. Cimino, M. Gavagnin, G. Sodano and V. Zappia. Characterization and biogenesis of 5'-methylthioxylofuranosyl adenine, a new natural analog of 5'-methylthioadenosine. Prog. Polyam. Res., eds. Zappia V. and Pegg, 219, 1988. 6. M. De Rosa, A. Gambacorta, W. D. Grant, V. Lanzotti and B. Nicolaus. Polar lipids and glycine betaine from haloalkaliphilic archaebacteria. J. Gen. Microbiol., 134, 205, 1988. 7. A. Gulik, V. Luzzati, M. De Rosa and A. Gambacorta. Tetraether lipid components from a thermoacidophilic archaebacterium. Chemical structure and physical polymorphism. J. Mol. Biol., 201, 429, 1988. 8. B. Nicolaus, A. Gambacorta, A. L. Basso, R. Riccio. M. De Rosa and W. D. Grant. Trehalose in archaebacteria. Syst. Appl. Microbiol., 10, 215, 1988. 9.M. De Rosa and A. Gambacorta. The lipids of archaebacteria. Prog. Lipid Res., 27,153, 1988. 10. G. Marino, G. Nitti, M. I. Arnone, G. Sannia, A. Gambacorta and M. De Rosa. Purification and characterization of aspartate-aminotransferase from the thermoacidophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. J. Biol. Chem., 263, 2305, 1988. 11. A. Trincone, M. De Rosa, A. Gambacorta, V. Lanzotti, B. Nicolaus, J. E. Harris and W. D. Grant. A simple chromatographic procedure for the detection of cyclized archaebacterial glycerol-bisdiphytanyl-glicerol tetraether core lipids. J. Gen. Microbiol., 134, 3159, 1988. 12. M. De Rosa, A. Gambacorta, R. Huber, V. Lanzotti, B. Nicolaus, K. O. Stetter and A. Trincone. A new 15,16-dimethyloxytriacontanoic acid from lipids of Thermotoga maritima. J. Chem. Soc. Chem. Comm., 1300, 1988. 106 13. A. Motta, D. Picone, T. Tancredi and P.A. Temussi. Low Temperature NMR Studies of Leu-Enkephalins in Cryoprotective Solvents. Tetrahedron, 44, 975, 1988. 26. R. De Pasquale, C. Circosta, F. Occhiuto, S. De Stefano and S. De Rosa. Central nervous system activity of terpenoids from marine sponge. Pharm. Res. Comm., 20, 23, 1988. 14. A. Motta, T. Tancredi, G. Borin, F. Marchiori, E. Peggion and P.A. Temussi. 1 H NMR Studies of the 20-31 Fragment of Calmodulin and of its Cyclic Analogue. Biopolymers, 27, 789, 1988. 27. G.Zanotti, G.D'auria, L.Paolillo and E.Trivellone. Synthetic Amatoxin Analogues.II: A proton nmr study of Sdeoxo-Ile3-(L)Ala5 and S-deoxo-Ile3-(D)Ala5-amaninamide. Int. J. Peptide Protein Res. 32, 9, 1988. 15. S. Andini, L. Ferrara, F. Infante, B. Merrifield and T. Tancredi. Synthesis, Purification, NMR Characterization and Interaction with Nucleotides of a Fragment of Fish Protamines. Gazz. Chim. It., 118, 551, 1988. 16. M.A. Castiglione-Morelli, T. Tancredi, E. Trivellone, G. Balboni, M. Marastoni, S. Salvadori, R. Tomatis and P.A. Temussi. Structure Activity Relationship of Tetrapeptides Related to Dermorphin. A 500 MHz 1H NMR Study. Biopolymers, 27, 1353, 1988. 17. V. Di Marzo, J.R. Tippins and H.R. Morris. PAF-mediated leukotriene biosynthesis in lungs: control by the neuropeptidergic system. New Trends Lipid Med. Res., 2, 99, 1988. 18. V. Di Marzo, A. Lopez-Bernal, J.R. Tippins. H.R. Morris and A.C. Turnbull. Leukotriene release by human fetal membranes, placenta and decidua in relation to parturition. M.C.P. Rees, J. Endocrinol., 118, 497, 1988. 19. H. Erdjument, D.A. Lane, M. Panico, V.Di Marzo and H.R. Morris. Single amino acid substitutions in the reactive site of antithrombin leading to thrombosis. J. Biol. Chem., 263, 5589, 1988. 20. V. Di Marzo, J.R. Tippins, S.H.I. Galadari and H.R. Morris. Neuropeptides and leukotriene biosynthesis: the effect of calcitonin, peptide histidine valine-42, helodermin, neuropeptide Y and galanin. Neuropeptides, 11, 169, 1988. 21. V. Di Marzo, J.R. Tippins and H.R. Morris. Bradykinin- and chemotactic peptide-induced leukotriene biosynthesis in rat lungs and its inhibition by vasoactive intestinal peptide. Biochem. Int., 17, 235, 1988. 22. J.M. Conlon,J. Domin, L. Thim, V. Di Marzo, H. R. Morris and S.R. Bloom. Primary structure of Neuromedin U from the rat. J. Neurochem., 51, 988, 1988. 23. H. Erdjument, D.A. Lane, H. Ireland, V. Di Marzo, M. Panico, H. R. Morris, A. Tripodi and P.M. Mannucci. Antithrombin Milano: single aminoacid substitution at the reactive site, Arg 393 to Cys. Thrombosis and Haemostasis, 60, 471, 1988. 24. S. De Rosa, S. De Stefano, P. Scarpelli and N. Zavodnik. Terpenes from the red alga Sphaerococcus coronopifolius of the north Adriatic sea. Phytochemistry, 27, 1875, 1988. 25. S. De Rosa, S. De Stefano and N. Zavodnik. Cacospongionolide: a new antitumoral sesterterpene, from the marine sponge Cacospongia mollior. J. Org. Chem., 53, 5020, 1988. 28. C. Di Bello, L.Gozzini, M.Tonellato, M.G.Corradini, G.D'Auria, L.Paolillo and E.Trivellone. 500 MHz NMR Characterization of Synthetic Bombesin and Related Peptides in DMSO-d6 by Two dimensional Tecniques. FEBS Lett., 237(1-2), 85, 1988. 29. M.A.Castiglione Morelli, B.Hartrodt, K.Neubert, P.A.Temussi and E.Trivellone. Conformational Analysis of Morphiceptin by NMR Spectroscopy. Biochem. Biophis. Res. Comm., 152, 512, 1988. 30. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, T. Romano, A. Gambacorta and V. Zappia. Purification and characterization of S-adenosylmethionine decarboxylase from Sulfolobus solfataricus an extreme thermophilic archaebacterium. In: Perspectives in polyamine research, A. Perin, G. Scalabrino, A.Sessa, and M.E. Ferioli, eds., Wichting Editor, Milano, Italy, 25, 1988. 31. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, M. Cartenì-Farina, and A. Gambacorta. S-adenosylmethionine synthetase in the thermophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Purification and characterization of two isoforms. Eur. J. Biochem., 177, 273, 1988. 32. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, Cartenì Farina, M., T. Romano, A. Gambacorta and V. Zappia. Studies on S-adenosylmethionine decarboxylase from Sulfolobus solfataricus an extreme thermophilic archaebacterium Ital. J. Biochem., 37, 179, 1988. 33. G. A. Doss, C. Margot, G. Sodano and C. Djerassi. Biosynthetic studies of marinelipids 21. Experimental demonstration of a biosynthetic interconversion of cyclopropene sterols in the sponge Calyx nicacensis. Tetrahedron Lett., 29, 6051, 1988. 34. V. Lanzotti, B. Nicolaus, A. Trincone and W. D. Grant. The glycolipid of halobacterium saccharovorum. FEMS Microbial Lett., 55, 223, 1988. 35. D. Picone, P.A. Temussi, M. Marastoni, R. Tomatis and A. Motta. A 500-MHz study of peptide T in A MSO solution. Febs Lett., 231, 159, 1988. 36. G. Zanotti, G. D‘Auria, L. Paolillo and E. Trivellone. Synthetic amatoxin analogues. II A patron NMR study of S-deoxoIle3-(D)Ala5-amaninamide. Biochem. and Biophjs. Res. Comm., 152, 512, 1988. 37. C.A. Mattia, L. Mazzarella, R. Riccio, R. Puliti and L. Minale. Structure and Stereochemistry of (24R)-27-Nor-5α-cholestane3β,4β,5,6α,7β,8,14,15α,24-nonaol: a higly hydroxylated marine steroid from the starfish Archaster typicus. Acta Cryst., 44C, 2170, 1988. 38. R. Puliti, C. A. Mattia and G. Barone. 107 Crystal structure of 2-deoxy-β-D-arabino-hexose (2-deoxy-β-Dglucose). Carbohydrate Res., 182, 148, 1988. 39. C. Verde, A. Malorni and A. Parente. The NH2-terminal amino acid residue of the coat protein of Papaya Mosaic Virus is acetylated. It. J. Biochem., 37, 329A, 1988. 40. R. De Biasi, D. Spiteri, M. Caldora, R. Iodice, P. Pucci, A. Malorni, P. Ferranti and G. Marino. Identification by fast atom bombardment mass spectrometry of (beta 112 (G14) CYS – Arg) hemoglobin (Hemoglobin Indianapolis) in a family from Naples (Italy). Hemoglobin, 12, 323, 1988. 41. R. Porta, C. Esposito, S. Metafora, P. Pucci, A. Malorni and G. Marino. Substance P as a transglutaminase substrate: identification of the raction products by Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry. Anal. Biochem., 172, 499, 1988. 42. P. Pucci, A. Malorni, G. Marino, S. Metafora, C. Esposito and R. Porta. Beta-Endorphin modification by transglutaminase in vitro: identification by Fab Mass spectrometry of glutamine-11 and lysine-29 as acyl donor and acceptor sites. Biochem. Biophys. Res. Comm., 154, 735, 1988. 43. P. Pucci, A. Malorni, G. Marino, S. Metafora, C. Esposito and R. Porta. Fab mass spectrometry detection of gamma (glutamyl) polyamine derivatives produced by transglutaminase in vitro. Ital. J. Biochem., 37,198, 1988. 44. P. Pucci, A. Malorni, G. Marino, S. Metafora, C. Esposito, R. Porta and G. Ravagnan. Characterization of the transglutaminase-modified CNBr fragments of a protein (SV-IV) secreted from rat sminal vescicles. Ital. Biochem., 37, 343, 1988. 45. R. Capasso, P. Pucci, A. Malorni and G. Randazzo. Fast atom bombardment (FAB) and chemical ionization (CI) mass spectrometry of gamma-carboxyglutamic acid, 5-substituted-4, 4dicarboxyprolines and their monodecarboxyderivatives glutamic acid and 5-substituted-4-carboxyprolines. Can. J. Chem., 66, 2177, 1988. 46. G. Monfregola, E. M. Procaccini, A. Viteritti, S. De Stefano e P. Santoianni. Effetto fototossico e livelli plasmatici di 8 MOP. G. I. Dermatologia e Venereologia, 123, 393, 1988. 47. M. P. Carrino and A. Malorni. Potenzialità della spettrometria di massa in chimica clinica. Mezz. San., 11, 75, 1988. ELENCO Anno 1989 Tetrahedron, 45, 3863, 1989. 3. G. Cimino, R. Puliti, G. Scognamiglio, A. Spinella, E. Trivellone, C. A. Mattia and L.Mazzarella. Amazing new alkaloid skeletons from the marine sponge Reniera sarai. Pure and Appl. Chemistry, 61, 535, 1989. 4. G. Cimino, A. De Giulio, S. De Rosa and V. Di Marzo. High molecular weight polyacetylenes from Petrosia ficiformis: further structural analysis and biological activity. Tetrahedron Lett., 30, 3563, 1989. 5. G. Cimino, A. De Giulio, S. De Rosa and S. De Stefano. New sterpurane sesquiterpenoid from the Mediterranean Alcyonum acaule: structure of 3-acetoxy sterpurene. Tetrahedron, 45, 6479, 1989. 6. G. Cimino, A. Spinella, A. Scopa and G. Sodano. Umbraculumin-B, an unusual 3-hydroxybutyric acid ester from the opisthobranch mollusc Umbraculum mediterraneum. Tetrahedron Lett., 30, 1147, 1989. 7. G. Cimino, A. Spinella and G. Sodano. Naturally occurring prostaglandin-1,15-lactones. Tetrahedron Lett., 30, 3589, 1989. 8. G. Cimino, A. Spinella and G. Sodano. Potential alarm pheromones from the Mediterranean opisthobranch Scaphander lignarius. Tetrahedron Lett., 30, 5003, 1989. 9. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, G. Cimino, M. Gavagnin, G. Sodano and V. Zappia. Biosynthesis and metabolism of 9-{5'}-deoxy-5'-(methylthio)-β-Dxylofuranosyl adenine, a novel natural analogue of methylthioadenosine. Biochem. J., 263, 635, 1989. 10. G. Cimino and G. Sodano. The chemical ecology of Mediterranean opisthobranchs. Chemica Scripta, 29, 389, 1989. 11. V. Lanzotti, B. Nicolaus, A. Trincone, M. De Rosa, W. D. Grant and A. Gambacorta. A complex lipid with a cyclic phosphate from the archaebacterium Natronococcus occultus. Biochim. Biophys. Acta, 1001, 31, 1989. 12. V. Lanzotti, B. Nicolaus, A. Trincone, M. De Rosa, W. D. Grant and A. Gambacorta. An isoprenoid ether analogue of phosphatidic acid from a halophilic archaebacterium. Biochim. Biophys. Acta, 1002, 398, 1989. 13. B. Nicolaus, V. Lanzotti, A. Trincone, M. De Rosa, W. D. Grant and A. Gambacorta. Glycine betaine and polar lipids composition in response to growth in different salt concentrations halophilic archaebacteria. FEMS Microbiol. Lett., 59, 157, 1989. 1. G. Cimino, A. Spinella and E. Trivellone. Isosarain-1: a new alkaloid from the Mediterranean sponge Reniera sarai. Tetrahedron Lett., 30, 133, 1989. 14. M. De Rosa and A. Gambacorta. Archaebacterial lipids: a new chapter of lipid biochemistry. Chimica Oggi, 7, 37, 1989. 2. G. Cimino, C. A. Mattia, L. Mazzarella, R. Puliti, G. Scognamiglio, A. Spinella and E.Trivellone. Unprecedented alkaloid skeleton from the Mediterranean sponge Reniera sarai: X-ray structure of an acetate derivative of sarain-A. 15. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, A. Gambacorta, T. Romano and M. De Rosa. S-Adenosylmethionine decarboxylase from the thermophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. In: Progress in polyamine research: novel biochemical, pharmacol- 108 ogical and clinical aspects. Plenum Press. NY. 91, 1989. 16. M. De Rosa, V. Lanzotti, B. Nicolaus, A. Trincone and A. Gambacorta. Lipids of archaebacteria: structural and biosynthetic aspects. In: Microbiology of Extreme Environments and its Potential for Biotechnology. Elsevier Applied Science, 131, 1989. 28. G. Marino, P. Pucci, A. Malorni, C. Esposito, R. Porta. Detenction by FAB mass spectrometry of transglutaminase (Tgase) reaction products. Adv. Mass Spectrom., 11, 1406, 1989. 29. R. Porta, C. Esposito, P. Pucci, R. Siciliano,G. Ravagnan, G. Peluso, S. Metafora. Transglutaminase as imunosuppressive co-factor in rat semen. Biomedical aspects of the imunopathology of reproduction. Acta Medica Ed., 93, 1989. 17. A. Trincone, A. Gambacorta, M. De Rosa, C. Scolastico, A. Sydimov and D. Potenza. Mechanism of cyclopentane ring formation in thetraether lipids of S.solfataricus. In: Microbiology of Extreme Enviroments and its Potential for Biotechnology. Elsevier Applied Science, 180, 1989. 30. P. Pucci, P. Ferranti, G. Marino, A. Malorni. Spettrometria di Massa FAB nello studio delle emoglobinopatie. G. I. Chim. Clin., 14, 115, 1989. 18. M. De Rosa, A. Gambacorta, R. Huber, V. Lanzotti, B. Nicolaus, K. O. Stetter and A. Trincone. Lipid structures in Thermotoga maritima. In: Microbiology of Extreme Environments and its Potential for Biotechnology. Elsevier Applied Science, 167, 1989. 31. M. Giuliani, S. Ricci, G. Ratti, P. Pucci, G. Marino, A. Malorni C. Ceccarini, B. Terrana, M. Tecce. Synthesis and characterization of recombinat fragment of human alpha-fetoprotein with antigenic selectivity versus albumin. Protein Eng., 2, 605, 1989. 19. V. Lanzotti, A. Trincone, B. Nicolaus, W. Zillig, M. De Rosa and A. Gambacorta. Complex lipids of Pyrococcus and AN1, thermophilic members of archaebacteria belonging to Thermococcales. Biochim. Biophys. Acta, 1004, 44, 1989. 32. G. Zanotti, T. Tancredi, F. Rossi, E. Benedetti, C. Pedone and P.A. Temussi. Ala Analogues of the Cyclolinopeptide A. Biopolymers, 28, 371, 1989. 20. A. Trincone, V. Lanzotti, B. Nicolaus, W. Zillig, M. De Rosa and A. Gambacorta. Comparative lipid composition of aerobically and anaerobically grown Desolfurolobus ambivalens, an autotrophic thermophilic archaebacterium. J. Gen. Microbiol., 135, 2751, 1989. 21. P. Quesada, M.R. Faraone Mennella, M. De Rosa, A. Gambacorta B. Nicolaus and B. Farina. ADP-Ribosylating Activity in Sulfolobus solfataricus. In: ADP-Ribose transfer Reactions. Mechanisms and Biological Significance, M.M. Jacobson and E.C. Jacobson eds, SpringerVerlag, 101, 1989. 22 T. Tancredi, A. Motta, D. Picone and P.A. Temussi. 1H-NMR of Leu-Enkephalin in Cryoprotective Mixtures. In: Peptides 1988, G. Jung and E. Bayer Eds., W. de Gruyter & Co., Berlin, FRG, 501, 1989. 23. R. Puliti, C. A. Mattia, G. Barone, G. Della Gatta and D. Ferro. Crystal structure and thermodynamics of phase transitions of the Nacethyl-L-valinamide. Thermochimica Acta, 162, 229, 1989. 24. A. Motta, D. Picone, P. A. Temussi, M. Marastoni and R. Tomatis. Conformational Analysis of Peptide T and of Its C-Pentapeptide Fragment. Biopolymers, 28, 479, 1989. 33. T. Tancredi, G. Zanotti, F. Rossi, E. Benedetti, C. Pedone and P.A. Temussi. Comparison of the Conformations of Cyclolinopeptide A in the Solid State and in Solution. Biopolymers, 28, 513, 1989. 34. P.A. Temussi, D. Picone, M.A. Castiglione Morelli, A. Motta and T. Tancredi. Bioactive Conformation of Linear Peptides in Solution: an Elusive Goal? Biopolymers, 28, 91, 1989. 35. P.A. Temussi, D. Picone, T. Tancredi, R. Tomatis, S. Salvadori, M. Marastoni and G. Balboni. Conformational Properties of Deltorphin: New Features of the δ-opioid Receptor. FEBS Lett., 247, 283, 1989. 36. B. Di Blasio, F. Rossi, E. Benedetti, V. Pavone, C. Pedone, P.A. Temussi, G. Zanotti and T. Tancredi. Bioactive Peptides: Solid State and Solution Conformation of Cyclolinopeptide A. J. Amer. Chem. Soc., 111, 9089, 1989. 37. V. Di Marzo, J.R. Tippins and H. R. Morris. The role of cyclic AMP in the inhibition of leukotriene biosynthesis by neuropeptides. Eur. J. Pharmacol., 162, 115, 1989. 25. C. Romano, A. Malorni, M. Esposito. Accertamento medico-legale del danno fisico da traffico urbano. Nuovo Bollettino di Farmacologia Clinica, 1, 28, 1989. 38. H. Erdjument, D.A. Lane, A. Flynn, V. Di Marzo, M. Panico, H.R. Morris, M. Greaves, G. Dolan and F.E. Preston. Antithrombin Sheffield: aminoacid substitution at the reactive site (Arg393 to His) causing thrombosis. Br. J. Haematology, 71, 91, 1989. 26. G. Marino, R. Siciliano, P. Pucci, P. Ferranti, A. Malorni. Assignment of post-translational modification sites by FAB mass spectrometry. Chimica oggi, 49, 1989. 39. V. Di Marzo, J.R. Tippins and H.R. Morris. Neuropeptides and inflammatory mediators: bi-directional regulative mechanisms. Trends Pharmacol. Sci., 10, 91, 1989. 27. P. Pucci, P. Ferranti, G. Marino, A. Malorni. Mass spectrometric analysis of human hemoglobin variants. Chimica oggi, 57, 1989. 40. D.A. Lane, H. Erdjument, E. Thompson, M. Panico, V. Di Marzo, H.R. Morris, G. Leone, V. De Stefano and S.L. Thein. A novel aminoacid substitution in the reactive site of a congenital 109 variant antithrombin. Antithrombin Pescara, Arg 393 to Pro caused by a CGT to CCT mutation. J. Biol. Chem., 264, 10200, 1989. 41. P.B. Garlick, G.D. Mashiter, V. Di Marzo, J.R. Tippins, H.R. Morris and M.N. Maisey. Synthesis, release and action of leukotrienes in the isolated unstimulated buffer-perfused rat hearts. J. Mol. Cell. Cardiol., 21, 1101, 1989. 42. H. Erdjument, D.A. Lane, M. Panico, V. Di Marzo, H.R. Morris, K. Bauer and R.D. Rosemberg. Antithrombin Chicago: aminoacid substitution of Arginine 393 to Histidine. Thrombosis Res., 54, 613, 1989. 43. G. Huber, C. Spinnler, A. Gambacorta and K.O. Stetter. Metallosphaera sedula gen. Sp, nov. represents a new genus of aerobic-mobilizing, thermoacidophilic archaebacteria Syst. Appl. Microbiol. 12, 38, 1989. 44. A. Crispino, A. De Giulio, S. De Rosa and G. Strazzullo. A new bioactive derivative of avarol from the marine sponge Dysidea avara. J. Nat. Prod., 52, 646, 1989. 45. A. De Giulio, S. De Rosa, G. Di Vincenzo and N. Zavodnik. Terpenoids from the North Adriatic sponge Spongia officinalis. J. Nat. Prod., 52, 1258, 1989. 46. C.Di Bello, A.Scanelli, M.G.Corradini, L.Paolillo, E.Trivellone, A.Scatturin, G.Vertuani, Gozzini and R.de Castiglione. Conformation Studies on Bombesin Receptor Antagonist: 500 MHz NMR and CD Characterization of Synthetic (D-Phe12, Leu 14Bombesin). Biochem. Biophis. Res. Comm., 161, 987, 1989. 47. C.Di Bello, L.Gozzini, M.Tonellato, M.G.Corradini, G.D'Auria, L.Paolillo,and E.Trivellone. Mono and Two-Dimensional 500-MHz Characterization of Synthetic Bombesin and Related Peptides in DMSO and DMSO-Water. Biopolymers, 28, 421, 1989. 48. G.Zanotti, F.Pinnen, G.Lucente, L.Paolillo, G.D'Auria, E.Trivellone and M.D'Alagni. Bicyclic Peptides: Solution Conformation and Ca+ Binding of the Heterodetic Bicyclic Decapeptide Cyclo(Glu1-Leu2-Pro3-Gly4-Ser5Ile6-Pro7-Ala8)-Cyclo(1g - 5b)Phe9-Gly10. Biopolymers, 28, 305, 1989. 49. M. Gavagnin, G. Sodano. Conversion of methylthioadenosine into its naturally occuring 3’isomer. Nucleosides & Nucleosides, 8, 1319, 1989. 50. A. Motta, M. A. Castiglione Morelli, A. Goud, P.A. Temussi. Sequential 1H NMR Assignment and Secondary Structure Determination of Salmon Calcitonin in Solution. Biochemistry, 28, 7996, 1989. 4,4-dicarboxy-5-(pyridoxyl-5’-phosphate)-proline, of 4-carboxy-5(pyridoxyl-5’-phosphate)-proline and 4,4-dicarboxy-5pyridoxylproline. Biomed. Env. Mass Spectrom., 18, 995, 1989. 54. C. Verde, A. Malorni, A. Parente. The primary structure of Papaya Mosaic Virus Coat Protein: a revision. J. Prot. Chem., 8, 795, 1989. 55. P. Pucci, P. Ferranti, G. Marino, A. Malorni. Identification by Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry of Hemoglobin Indianapolis in a family from Naples (Italy). Adv. Mass Spectrom., 11, 1428, 1989. ELENCO Anno 1990 1. G. Cimino, C. Crispino, M. Gavagnin and G. Sodano. Diterpenes from the nudibranch Chromodoris luteorosea. J. Nat. Prod., 59, 102, 1990. 2. G. Cimino, A. Crispino, V. Di Marzo, M. Gavagnin and J. Ros. Oxitoxins, bioactive molecules produced by the marine opisthobranch Oxynoe olivacea from a diet-derived percursor. Experientia, 46, 767, 1990. 3. G. Cimino, A. De Giulio, S. De Rosa and V. Di Marzo. Minor bioactive polyacetylenes from Petrosia ficiformis. J. Nat. Prod., 53, 345, 1990. 4. G. Cimino, G. Sodano and G. Villani. Studio su basi chimiche dei comportamenti biologici di molluschi opistobranchi. Atti del 2° Congresso Italiano di Malacologia, 23, 229, 1990. 5. J. C. Garcia-Gomez, G. Cimino and A.Medina. Studies on the defensive behaviour of Hypselodoris species. Ultrastructure and chemical analysis of mantle dermal formations. Marine Biology, 106, 245, 1990. 6. C. Avila, M. Ballesteros, G. Cimino, A.Crispino, M.Gavagnin and G. Sodano. Biosynthetic origin and anatomical distribution of the main secondary metabolites in the nudibranch mollusc Doris verrucosa. Comp. Biochem. Physiol., 97, 363 1990. 7. G. Cimino, A.Crispino, C. A. Mattia, L. Mazzarella, R. Puliti, E. Trivellone and M. J.Uriz. A new triterpenoid skeleton from the Mediterranean sponge Raspaciona aculeata: structure of raspacionin. Tetrahedron Lett., 31, 6565, 1990. 8. V. Di Marzo, G. Cimino, G. Sodano, A. Spinella and G. Villani. A novel prostaglandin metabolic pathway from a marine mollusc: prostaglandin-1,15-lactones. Adv. in Prostaglandin, Thromboxane and Leukotriene Res., 21, 129, 1990. 51. R. Puliti, C. A. Mattia, G. Barone, C. Gianicola. Crystal structure of some N-acetylamides of amino acidis. Acta Cryst., C45, 1554, 1989. 9. M. Gavagnin, A. Spinella, G. Cimino and G. Sodano. Stereochemistry of ichthyotoxic diacylglycerols from opisthobranch molluscs. Tetrahedron Lett., 31, 6093, 1990. 52. P. Pucci, P. Ferranti, G. Marino, A. Malorni. Characterization of abnormal human haemoglobins by Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry. Biomed. Env. Mass. Spectrom., 18, 20, 1989. 10. G. Cimino, G. Scognamiglio, A. Spinella and E.Trivellone. Structural studies on sarain-A. J. Nat. Prod., 53, 1519, 1990. 53. R. Capasso, P. Pucci, G. Randazzo, A. Ritieni, A. Malorni. Analysis by Fast Atom Bombardment (FAB) Mass Spectrometry of 11. F.M. Pisani, R.Rella, C. A. Raia, C. Rozzo, R. Nucci, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Rossi. 110 Thermostable ß-galactosidase from the archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Purification properties. Eur. J. Biochem., 187, 321, 1990. 12. A. Trincone, L. Lama, B. Lanzotti, B. Nicolaus, M. De Rosa, M. Rossi and A. Gambacorta. Asymmetric reduction of ketones with resting cells of Sulfolobus solfataricus. Biotech. Bioen., 35, 559, 1990. 13. B. Nicolaus, A. Trincone, E. Esposito, M. R. Vaccaro, A. Gambacorta and M. De Rosa. Calditol tetraether lipids of the archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Biosynthetic studies. Biochem. J., 266, 785, 1990. 14. G. Catapano, M. Filosa, G. Iorio, E. Drioli, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Demma. Capillary polysulphone membranes with entrapped whole cells: influence of cell loading and filler molecular weigth on membrane mechanical and kinetic performance. J. Molec. Catalysis, 58, 277, 1990. 23. A. Motta, T. Tancredi, E. Trivellone, P. Lorenzoni, C. Ceccarini, D. Lamba and A.L. Segre. Complete Analysis of the 1H and 13C NMR Spectra of a Complex High-Mannose Glycopeptide of Hen Ovalbumin. Gazz. Chim. It., 120, 255, 1990. 24. D. Picone, A. D'Ursi, A. Motta, T. Tancredi and P.A. Temussi. Conformational Preferences of [Leu5]enkephalin in Biomimetic Media. Investigation by 1H NMR. Eur. J. Biochem., 192, 433, 1990. 25. D.F. Mierke, C. Pattaroni, N. Delaet, A. Toy, M. Goodman, T. Tancredi, A. Motta, P.A. Temussi, L. Moroder, G. Bovermann and E. Wünsch. Cyclic Hexapeptides Related to Somatostatin. Conformational Analysis Employing 1H NMR and Molecular Dynamics. Int. J. Peptide Protein Res., 36, 418, 1990. 26. M. Zaidi, S.D. Brain, J.R. Tippins, V. Di Marzo, B.S. Moonga, T. J. Chambers, H. R. Morris and I. MacIntyre. Structure-activity relationship of human calcitonin gene-related peptide. Biochem. J., 269, 775, 1990. 15. L. Lama, B. Nicolaus, A. Trincone, P. Morzillo, M. De Rosa and A. Gambacorta Starch conversion with immobilized thermophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Biotechnology Lett., 12, 431, 1990. 27. S.H.I. Galadari, H.R. Morris and V. Di Marzo. Novel second messenger interactions in rat basophilic leukaemia (RBL-1) cells. Biochem. Int., 22, 379, 1990. 16. Z. Mirgani, D. Bertoia, A. Gliozzi, M. De Rosa and A. Gambacorta. Monopolar-bipolar lipids interactions in model membrane systems. Chem. Phys. Lipids, 55, 85, 1990. 28. S. Burggraf, H.W.Jannasch, B. Nicolaus and K.O. Stetter. Archaeoglobus profundus sp. nov., Represent a New Species within the Sulfate-reducing Archaebacteria- System. Appl. Microbiol., 13, 24, 1990. 17. A. Trincone, G. Palmieri, L. Lama, B. Nicolaus, M. De Rosa and A. Gambacorta. Kinetic resolution of aminoacid ester with immobilized cells of Sulfolobus solfataricus. Biotecnology Lett., 12(10), 717, 1990. 29. A. Trincone, L. Lama, R. Rella, A. D'Auria, C. Raia and B. Nicolaus. Determination of hydride transfer stereospecificity of NADHdependent alcohol-aldehyde/ketone oxidoreductase from Sulfolobus solfataricus. Biochim. et Biophys. Acta, 1041, 94, 1990. 18. A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama, M. De Rosa A. Gambacorta and W. D. Grant. The glycolipid of Halobacterium sodomense. J. of Gen. Microb., 136, 2327, 1990. 19. M.A. Castiglione Morelli, F. Lelj, F. Naider, M. Tallon, T. Tancredi and P.A. Temussi. Conformation Activity Relationship of Sweet Molecules. Comparison of Aspartame and Sulfonaphtoimidazoles. J. Med. Chem., 33, 514, 1990. 20. G. Zanotti, F. Rossi, B. Di Blasio, C. Pedone, E. Benedetti, K. Ziegler and T. Tancredi. Structure-activity Relationship in Cytoprotective Peptides. In: Peptides. Chemistry, Structure and Biology, J. Rivier and G.R. Marshall, Eds., ESCOM Science Publisher B.V., Leiden, 118, 1990. 21. P.A. Temussi, D. Picone, T. Tancredi, R. Tomatis, S. Salvadori, M. Marastoni and G. Balboni. m to d Selectivity of Opioid Peptides: a Comparison of Dermorphin and Deltorphins. In: Peptides. Chemistry, Structure and Biology, J. Rivier and G.R. Marshall, Eds., ESCOM Science Publisher B.V., Leiden, 321, 1990. 22. G. Balboni, M. Marastoni, D. Picone, S. Salvadori, T. Tancredi, P.A. Temussi and R. Tomatis. New Features of the δ Opioid Receptor: Conformational Properties of Deltorphin I Analogues. Biochem. Biophys. Res. Comm., 169, 617, 1990. 30. R. Rella, C.A. Raia, F.M. Pisani, S. D’Auria, R. Nucci, A. Gambacorta, M. De Rosa and M. Rossi. Purification and properties of a thermophilic and thermostable DNA polymerase from the archaebacterium Sulfolobus solfataricus. Ital. J. biochem., 39, 83, 1990. 31. R. Cozzolino, A. De Giulio, S. De Rosa, G. Strazzullo, M.J. Gasić, D. Sladić and M. Zlatović. Biological activities of avarol derivatives. I: amino-derivatives. J. Nat. Prod., 53, 699, 1990. 32. R. Puliti, S. De Rosa, C.A. Mattia and L. Mazzarella. Structure and stereochemistry of an acetate derivative of cacospongionolide, a new antitumoral sesterterpenoid from marine sponge Cacospongia mollior. Acta Cryst., C46, 1533, 1990 33. S. De Rosa, N. Zavodnik, S. De Stefano, R. Fiaccavento and A. Travizi. Seasonal changes of biomass and soluble carbohydrates in the seagrass Zostera noltii Hornem. Botanica Marina, 33, 411, 1990. 34. A. De Giulio, S. De Rosa, G. Di Vincenzo and G. Strazzullo. Further bioactive derivative of avarol from Dysidea avara. Tetrahedron, 46, 7971, 1990. 35. A. De Giulio, S. De Rosa, G. Di Vincenzo, G. Strazzullo and N. Zavodnik. 111 Norsesterterpenes from the north Adriatic sponge Ircinia oros. J. Nat. Prod., 53, 1503, 1990. 36. G. Zanotti, T.Wieland, G.D'Auria, L.Paolillo and E.Trivellone. S-Deoxo-Abu1,Ile3-Amaninamide, an Inactive Amatoxin Analogue. Int. J. Peptide protein Res., 35, 263, 1990. 37. S.Cirillo, F.DiSalle, L.Simonetti, E.Trivellone, R.Spaziante, P.Esposito, R.Elefante, F.Smaltino. Relazioni tra segnale RM e composizione molecolare. Rivista di Neuroradiologia, 3, 185, 1990. 38. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, G. Cimino, M. Gavagnin, G. Sodano, V. Zappia. Metabolic studies on 5’-methylthioxylofuranosyl adenine, a natural analog of 5’-methylthioadenosine. Ital. J. Biochem., 39, 273A, 1990. 39. R. Racioppi, M. Gavagnin, G. Strazzullo e G. Sodano. Stereochemistry and synthesis of bursatellin from chloramphenicol. Tetrahedron Lett., 31, 573, 1990. 40. R. Puliti, C. A. Mattia, G. Barone, G. Della Gatta and D. Ferro. Crystal structure and thermodynamics of phase transitions of the Nacethyl-L-valinamide. Thermoch. Acta, 162, 229, 1990. 41. P. Pucci, P. Ferranti, A. Malorni and G. Marino. Fab mass spectrometric analysis of haemoglobin variants: use of V-8 protease in the identification of Hb M Hyde Park and Hb San Josè. Biomed. Environ. Mass Spectrom., 19, 568, 1990. 42. P. Pucci, R. Siciliano, P. Ferranti, A. Malorni and G. Marino. Mass spectrometric characterization of recombinant human interleukins 1-b. Biotech. Appl. Biochem., 12, 357, 1990. 43. F. Frigeri, A. Camera, P. Ferranti, A. Malorni, G. Pandolfi, R. Rotoli, P. Pucci. Hb G-San Josè: identification by mass spectrometry. Clin. Chem. Enzym. Comm., 3, 289, 1990. 44. P. Ferranti, A. Malorni, G. Marino e P. Pucci. Ruolo della Spettrometria di Massa nella caratterizzazione strutturale di Emoglobine varianti. In: Fisiopatologia Endocrina e Diagnostica di Laboratorio. G. Giacchetto e V. Macchia Eds. Bios Ed., Cosenza, 79, 1990. 45. M. P. Carrino, P. Ferranti, A. Malorni, A. Milone, L. Pacelli. La Spettrometria di Massa nello studio degli errori congeniti del metabolismo: nuove opportunità in Chimica Clinica. In: Fisiopatologia Endocrina e Diagnostica di Laboratorio. G. Giacchetto e V. Macchia Eds. Bios Ed., Cosenza, 85, 1990. 3. P. Orlando, F. Carretta, P. Grippo, G. Cimino, S. De Stefano and G. Strazzullo. Kelletinin I and kelletinin A from the marine mollusc Buccinulum corneum are inhibitors of eukaryotic DNA polymerase a. Experientia, 47, 64, 1991. 4. G. Cimino, A. Crispino, V. Di Marzo, G. Sodano, A. Spinella and G. Villani. A marine mollusc provides the first example of in vivo storage of prostaglandins: prostaglandin-1,15-lactones. Experientia, 47, 56 1991. 5. V. Di Marzo, G. Cimino, A. Crispino, C. Minardi, G. Sodano and A. Spinella. A novel multi-functional metabolic pathway in a marin mollusc leads to unprecedented prostaglandin derivatives: prostaglandin-1,15lactones. Biochem. J., 273, 593, 1991. 6. C. Avila, G. Cimino, A. Crispino and A. Spinella. Drimane sesquiterpenoids in Mediterranean Dendrodoris nudibranchs: anatomical distribution and biological role. Experientia, 47, 306, 1991. 7. G. Cimino, A. Crispino, V. Di Marzo, A. Spinella and G. Sodano. Prostaglandin-1,15-lactones of the F series from the nudibranch mollusc Tethys fimbria. J. Org. Chem., 56, 2907,1991. 8. L. De Petrocellis, V. Di Marzo, B. Arcà, M. Gavagnin, R. Minei, G. Cimino. The effect of diterpenoidic diacylglycerols on tentacle regeneration in Hydra vulgaris. Comp. Biochem. Physiol., 100C, 603,1991. 9. R. Vardaro, V. Di Marzo, A. Crispino and G. Cimino. Cyercenes, novel polypropionate pyrones from the autotomizing Mediterranean mollusc Cyerce cristallina. Tetrahedron, 47, 5569, 1991. 10. V. Di Marzo, R. Vardaro, L. De Petrocellis, G. Villani, R. Minei and G. Cimino. Cyercenes, novel pyrones from the ascoglossan mollusc Cyerce cristallina: tissue distribution biosynthesis and possible involvement in defense and regenerative processes. Experientia, 47, 1221, 1991. 11. A. Marin, V. Di Marzo and G. Cimino. A histological and chemical study of the cerata of the opisthobranch mollusc Tethys fimbria. Mar. Biol., 111(3), 253, 1991. ELENCO Anno 1991 12. G. Cimino, A. Fontana, A. Madaio, G. Scognamiglio and E. Trivellone. Application of Two-Dimensional Shift Correlated NMR Techniques to the Structure Determination of an Unusual Marine Alkaloid, Isosaraine-2. Magn. Reson. Chemistry, 29, 327, 1991. 1. C. Avila, G. Cimino, A. Fontana, M. Gavagnin, J. Ortea and E. Trivellone. Defensive strategy of two Hypselodoris nudibranchs from Italian and Spanish coasts. J. Chem. Ecol., 17, 625, 1991. 13. R. Puliti, E. Trivellone, A. Crispino, G. Cimino, C. A. Mattia and L. Mazzarella. Raspacionin, a new tetracyclic triterpenoid from sponge Raspaciona aculeata: crystal structure containing disordered solvent. Acta Cryst., C47, 2609, 1991. 2. G. Cimino, A. Passeggio, G. Sodano, A. Spinella and G.Villani. Alarm pheromones from the Mediterranean opisthobranch Haminoea navicula. Experientia, 47, 61 1991. 14. M. Masullo, G. Raimo, A. Parente, A. Gambacorta, M. De Rosa and V. Bocchini Properties of the elongation factor 1 α in the thermoacidophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. FEBS Eur. J. Biochem., 199, 529, 1991. 112 Ital. J. Food Sci., 159, 1991. 15. M. De Rosa, A. Trincone, B. Nicolaus and A. Gambacorta. Archaebacteria: Lipids, membrane structures, and adaptation to environmental stresses. In: Life under extreme conditions. G. di Prisco ed. Springer-Verlag, 61, 1991. 16. A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama, P. Morzillo, M. De Rosa and A. Gambacorta. Enzyme-catalyzed synthesis of alkyl ß-D-glycosides with crude homogenate of Sulfolobus solfataricus. Biotechnology Lett., 13(4), 235, 1991. 17. V. Consalvi, R. Chiaraluce, L. Politi, A. Gambacorta, M. De Rosa and R. Scandurra. Glutamate dehydrogenase from the thermoacidophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus. FEBS Eur. J. Biochem., 196, 459, 1991. 18. G. Cacciapuoti, M. Porcelli, M. De Rosa, A. Gambacorta, C. Bertoldo and V. Zappia S-Adenosylmethionine decarboxylase from the thermophilic archaebacterium Sulfolobus solfataricus: purification, molecular properties and studies on the covalently-bound pyruvate. Eur. J. Biochem., 199, 395, 1991. 19. M.A. Castiglione Morelli, A. Pastore, C. Pedone, P.A. Temussi, G. Zanotti and T. Tancredi. Conformational Study of Cyclolinopeptide A. A Distance Geometry and Molecular Dynamics Approach. Int. J. Peptide Protein Res., 37, 81, 1991. 20. T. Tancredi, P.A. Temussi, D. Picone, P. Amodeo, R. Tomatis, S. Salvadori, M. Marastoni, V. Santagata and G. Balboni. New Insights on µδ Selectivity of Opioid Peptides: Conformational Analysis of Deltorphins Analogues. Biopolymers, 31, 751, 1991. 21. G. Villani. Mediatori chimioci nelle comunicazioni inter ed intra-specifiche di molluschi opistobranchi del Mediterraneo. Iberus, 10(1), 59, 1991. 22. R. Puliti, C. A. Mattia, G. Barone and C. Giancola. Crystal structures of N2-acetyl-DL-alaninamide and N2-acetyl-DLleucinamide. Acta Cryst., C47, 1658, 1991. 23. R. Porta, C. Esposito, S. Metafora, P. Pucci, R. Siciliano, A. Malorni and G. Marino. Mass spectrometric identification of the amino donor and acceptor sites in a transglutaminase protein substrate secreted from rat seminal vesicles. Biochemistry, 30, 3114, 1991. 24. R. Arcone, P. Pucci, F. Zappacosta, V. Fontaine, A. Malorni, G. Marino and G. Ciliberto. Single step purification and structural characterization of human interleukin 6 produced in E. coli from T7 RNA polymerase expression vector. Eur. J. Biochem., 198, 541, 1991. 25. G. Marino, P. Ferranti, A. Malorni, P. Pucci, A. Di Luccia and L. Ferrara. FAB-OVERLAPPING: a strategy for sequencing homologous proteins. Int. J. Mass Spectrom. Ion. Proc., 111, 287, 1991. 26. L. Chianese, F. Addeo, P. Ferranti, A. Malorni and P. Pucci. Amino acid substitutions in bovine para-K-casein C. 27. P. Ferranti, A. Malorni, P. Pucci, S. Fanali, A. Nardi and L. Ossicini. Capillary zone electrophoresis and mass spectrometry for the characterization of genetic variants of human hemoglobin. Anal. Biochem., 194(1), 1991. 28. G. Marsh, G. Marino, P. Ferranti, A. Malorni, P. Pucci, J. Kaeda, J. Marsh and L. Luzzato. A third instance of the high-oxigen affinity haemoglobin, HB heathow (αAβ2103Phe-Leu): identification of mutation by mass spectrometry and by DNA analysis. Hemoglobin, 15, 43, 1991. 29. T. Tancredi, E. Benedetti, M. Grimaldi, C. Pedone, F. Rossi, M. Saviano, P.A. Temussi and G. Zanotti. Ion-binding of Cyclolinopeptide A. A NMR and CD Conformational Study. Biopolymers, 31, 761, 1991. 30. P.A. Temussi, F. Lelj and T. Tancredi. Conformation Activity Relationship of Sweet Molecules. In: ACS Symposium Series n°450, Sweeteners: Discovery, Molecular Design, and Chemoreception, E.D. Walters, F.T. Orthoefer, and G.E. DuBois, Eds., 143, 1991. 31. P.A. Temussi, D. Picone, T. Tancredi, S. Salvadori and R. Tomatis. Conformation Activity Relationship of Opioid Peptides: a New Insight in Selectivity. In: QSAR: Rational Approaches to the Design of Bioactive Compounds, C. Silipo and A. Vittoria, Eds., Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 361, 1991. 32. B. Di Blasio, G. Zanotti, A. Maione, F. Rossi, T. Tancredi, M. Saviano and C. Pedone. Cystine as Molecular Tool for the Design of Hepatoprotecting Cyclic Peptides. In: Peptides 90, E. Giralt and D. Andreu, Eds., ESCOM Science Publisher B.V., Leiden, 541, 1991. 33. T. Tancredi, P. Amodeo, D. Picone, P.A. Temussi, G. Balboni, M. Marastoni, S. Salvadori and R. Tomatis. Conformational Properties of Analogues of Deltorphins. In: Peptides 90, E. Giralt and D. Andreu, Eds., ESCOM Science Publisher B.V., Leiden, 516, 1991. 34. D. Picone, A.M. D'Ursi, M. Saviano, P.A. Temussi and T. Tancredi. Conformational Studies of Melittin in Acetonitrile Solution. In: Peptides 90, E. Giralt and D. Andreu, Eds., ESCOM Science Publisher B.V., Leiden, 551, 1991. 35. P. Amodeo, A. Motta, D. Picone, G. Saviano, T. Tancredi and P.A. Temussi. Viscosity as a Conformational Sieve. NOE of Linear Peptides. In: Cryoprotective Mixtures. J. Magn. Reson., 95, 201, 1991. 36. V. Di Marzo, S.H.I. Galadari, J.R. Tippins and H.R. Morris. Interactions between second messengers: cyclic AMP and phospholipase A2 and phospholipase C metabolites. Life Sci., 49, 247, 1991. 37. M.R. Faraone-Mennella, F. De Lucia,P. Quesada, M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus, and B. Farina. Heterogeneity of ADP-Ribosylation reaction in Sulfolobus solfataricus. In: ADP-Ribosylation Reactions. Guy Poirier and P. Moreau eds., Springer- Verlag, New York, 101, 1991. 113 38. A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama, F. Marsiglia, A. Gambacorta. Production of 4-chloro3-hydroxy ethyl butanoates with resting cells of Sulfolobus solfataricus. Biotechnology Lett., 13, 31, 1991. 39. B. Nicolaus, F. Marsiglia, E. Esposito, A. Trincone, L. Lama, R. Sharp, G di Prisco, A. Gambacorta. Isolation of five strains of thermophilic eubacteria in Antarctica. Polar Biology, 11, 425, 1991. 40. I. Romano, B. Nicolaus, L. Lama, A. Trincone, A. Gambacorta. Gerlite plate technique for culturing Sulfolobus solfataricus, a thermoacidophilic archaebacterium. Biotech. Techn., 5(1), 29, 1991. 41. L. Lama, B. Nicolaus, A. Trincone, P. Morzillo, V. Calandrelli and A. Gambacorta. Thermostable amylolytic activity from Sulfolobus solfataricus. Biotech. Forum Europe, 4, 201, 1991. 42. B. Nicolaus, A. Trincone, L. Lama, I. Romano, F. Marsiglia, and A. Gambacorta. Adaptation of Sulfolobus solfataricus on minimal media. Biotechnology Lett., 13, 667, 1991. 43. A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama, A. Gambacorta. Stereochemical Studies of Enzymatic Transglycosilation using Sulfolobus solfataricus. J. Chem. Soc. Perkin Trans., I, 2841, 1991. 44. Pley, J. Schipka, A. Gambacorta, H.W. Jannasch, H. Fricke, R. Rachel and K. O. Stetter Pyrodictium abissy sp. Nov. Represents a novel heterotrophic marine archaeal hyperthermophilic growing at 110°C System. Appl. Microbiol., 14, 245, 1991. 45. S. De Rosa. Terpenoids of marine plants. In: Ecological chemistry and biochemistry of plant terpenoids ed. J.B. Harborne and F.A. Tomas-Barberan. 28, 1991. 46. R. De Pasquale, C. Circosta, F. Occhiuto, S. De Rosa and S. De Stefano. Pharmacological studies on terpenoids from marine sponges: Analgesic and muscle relaxant effects. Phytoth. Res., 5, 49, 1991. 47. M.A. Belisario, R. Pecce, A.R. Arena, A. De Giulio, G. Strazzullo and S. De Rosa. Effect of avarol, avarone and nine of their natural and synthetic derivatives on microsomal drug-metabilizing enzymes. Toxicology Lett., 57, 183, 1991. 48. A. De Giulio, S. De Rosa, G. Strazzullo, L. Diliberto, P. Obino, M.E. Marongiu, A. Pani and P. La Colla. Synthesis and evaluation of cytostatic and antiviral activities of 3'and 4'-avarone derivatives. Antiviral Chemistry and Chemotherapy, 2, 223, 1991. 49. N. Zavodnik and S. De Rosa. Concentration of pigments in some Northern Adriatic littoral seaweeds. Oebalia, 17(suppl. 2), 615, 1991. 50. S. De Rosa, A. De Giulio and G. Strazzullo. Biologically active metabolites from marine organisms and some semi-synthetic derivatives. In: Trends in Organic Chemistry, 127, 1991. 51. C.Di Bello, A.Scatturin, G.Vertuani, G.D'Auria, M.Gargiulo, L.Paolillo,E.Trivellone, L.Gozzini and R.De Castiglione. Conformational Studies on Bombesin Antagonists. CD and NMR Characterization of (Thr6, Leu13, Y(CH2NH)-Met14) Bombesin (614). Biopolymers, 31, 1397, 1991. 52. C.Di Bello, A.Scatturin, G.D'Auria, M.Gargiulo, L.Paolillo, E.Trivellone and R.De Castiglione. Fluorescence, CD, and NMR Studies on Spantide, a Bombesin and Substance P Antagonist. Biopolymers, 31, 643, 1991. 53. A. H. Abon-Donia, A De Giulio, A. Evidente, M. Gaber, A. Hobil, R. Lanzetta and A. A. Scif el Din. Narciclasine-4-O-β-D-glucopyranoside, a glucosyloxy amidic phenanthridone derivative from Pancratium maritimum. Phytochemistry, 30, 3445, 1991. 54. M. Adinolfi, R. Lanzetta, C. E. Marciano, M. Parrilli and A. De Giulio. A new class of anthraquinone-anthrone-C-glycosides from Asphodelus ramosus tubers. Tetrahedron, 47, 4435, 1991. 55. A. Pani, M. E. Marongiu, P. Obino, M. Gavagnin, P. La Colla. Antimicrobial and antiviral activity of xylosyl-methylthio-adenosine, a naturally occurring analogue of methylthio-adenosine from Doris verrucosa. Experientia, 47, 1228, 1991. 56. I. Silvestri, P. Sinibaldi, V. Manzari, P. Orlando, F. Carretta, G. Strazzullo and P. Grippo. Inhibition of cell division and viral production in HTLV1 infected MT2 cell by a natural drug: kelletinin A. Eur. J. Cell. Biol. Suppl.35, 55, 41, 1991. 57. M. Kurr, R. Huber, H. Konig, H. W. Jannasch, H. Fricke, A. Trincone, J. K. Kristjansson, K. O. Stetter. Methanopyrus-kandleri, gen. and sp. nov represents a novelgroup of hyperthermophilic methanogens, growing at 110° C. Archiv. Microbiol., 156, 239, 1991. 58. A. H. Segerer, A. Trincone, M. Gahrtz and K. O. Stetter. Stygiolobus Azoricus Gen-Nov, Sp-Nov represents a novelgenus of anaerobic, extremely thermoacidophilic archaebacteria of the order Sulfolobales. Int. J. Syst. Bacteriol., 41, 495, 1991. 59. A. Pastore, R. De Francesco, G. Barbato, M. A. Castiglione Morelli, A. Motta and R. Cortese. 1 H-Resonance Assignment and Secondary Structure Determination of the Dimerisation Domain of the Transcription Factor LFB1. Biochemistry, 30, 148, 1991. 60. A. Motta, P. A. Temussi, E. Wünsch, and G. Bovermann. A 1H-NMR Study of Human Calcitonin in Solution. Biochemistry, 30, 2364, 1991. 61. G. Saviano, P. A. Temussi, A. Motta, C. A. Maggi, and P. Rovero. Conformation-Activity Relationship of Tachykinin Neurokinin A (410) and of Some [Xaa8] analogues. Biochemistry, 30, 10176, 1991. 62. A. Motta, A. Pastore, N. A. Goud and M. A. Castiglione Morelli. Solution Conformation of Salmon Calcitonin in Sodium Dodecyl Sulfate as Determined by 2D-NMR and Distance Geometry Calculations. Biochemistry, 30, 10444, 1991. 114 63. N. Niccolai, A. Bonci, M. Rustici, M. Scarselli, P. Neri, G. Esposito, P. Mascagni, A. Motta and H. Molinari. NMR Delineation of Inner and Outer Protons from Paramagnetic Relaxation Perturbations in 1D and 2D Spectra of Peptides. J. C. S. Perkin Trans., 2, 1453, 1991. 10. R. Vardaro, V. Di Marzo, A. Marin and G. Cimino. α- and β-pyrone-polypropionates from the Mediterranean ascoglossan mollusc Ercolania funerea. Tetrahedron, 48, 9561, 1992. 64. A. Acampora, P. Ferranti, A. Malorni and A. Milone. Mass Spectrometry in forensic chemistry. 1. Pigment identification by direct mixture analysis in a case of banknote falsification. J. Forensic Sci., 36, 579, 1991. 11. A. Trincone, B. Nicolaus, G. Palmieri, M. De Rosa, R. Huber, G. Huber, K. O. Stetter and A. Gambacorta. Distribution of Complex and Core Lipids within New Hyperthermophilic Members of the Archaea Domain. Syst. Appl. Microbiol., 15, 11, 1992. 65. P. Pucci, R. Siciliano, A. Malorni, G. Marino, M. F. Tecce, C. Ceccarini and B. Terrana. Human alpha-Fetoprotein primary structure: a mass spectrometric study. Biochemistry, 30, 5061, 1991. 12. P. Ferranti, A. Malorni, G. Marino, P. Pucci, G.H.Goodwin, G. Manfioletti and V. Giancotti. Mass spectrometric methodologies for the analysis of biotechnologically produced pharmaceuticals. J. Biol. Chem., 267, 22486, 1992. ELENCO Anno 1992 13. A. Malorni. Mass spectrometric methodologies for the analysis of biotechnologically produced pharmaceuticals. Il Farmaco, 47, 723, 1992. 1. A. Spinella, M. Gavagnin, A. Crispino, G. Cimino, E. Martinez, J. Ortea and G. Sodano. 4-Acetyl-Aplykurodin-B and Aplykurodinone-B two Ichthyotoxic Degraded Sterols from the Mediterranean Mollusk Aplysia fasciata. J. Nat. Prod., 55, 989, 1992. 2. M.Gavagnin, R.R. Vardaro, C. Avila, J. Ortea and G. Cimino. Ichthyotoxic diterpenoids from the Cantabrian nudibranch Chromodoris luteorosea. J. Nat. Prod., 55, 368, 1992. 3. A. Fontana, F. Antoniazzi, G. Cimino, G. Mazza, E. Trivellone and B. Zanone. High Resolution NMR detection of Cholesterol Oxides in SprayDried Egg Yolk. J. of Food Science, 57(4), 869, 1992. 4. J. Urbanczyk, A. Zabza, Z. Cichacz, G. Cimino and J. Szafranek. Neutral Lipids of the fungus Zoophthora (Erynia) ovispora (Nowakowski) Batko. J. Basic Microbiol., 32, 347, 1992. 5. R. Vardaro, V. Di Marzo and G. Cimino. Placidenes: cyercene-like polypropionate γ-pyrones from the mediterranean Ascoglossan mollusc Placida dendritica. Tetrahedron Lett., 33, 2875, 1992. 6. V. Caprioli, G. Cimino, A. De Giulio, A. Madaio, G. Scognamiglio and E. Trivellone. Selected biological activities of saraines. Comp. Biochem. Physiol., 103B, 293, 1992. 7. V. Di Marzo, C. Minardi, R. R. Vardaro, E. Mollo and G. Cimino. Prostaglandin F-1,15-lactone fatty acyl esters: a prostaglandin lactone pathway branch developed during the reproduction and early larval stages of a marine mollusc. Comp. Biochem. Physiol., 101B, 99, 1992. 8. R. Puliti, M. Gavagnin, G. Cimino, C. A. Mattia and L. Mazzarella. Structure of chelonaplysin C: a spongiane diterpenoid from nudibranch Chromodoris luteorosea. Acta Cryst., C48, 2145, 1992. 9. G. Cimino, A. Crispino, R. de A. Epifanio, A. Madaio, C. A. Mattia, L. Mazzarella, R. Puliti, E. Trivellone and M. Uriz. Raspacionin-A: a novel rearranged triterpenoid from the Mediterranean sponge Raspaciona aculeata. Tetrahedron, 48(41), 9013, 1992. 14. P.A. Temussi, D. Picone, G. Saviano, P. Amodeo, A. Motta, T. Tancredi, S. Salvadori and R. Tomatis. Conformational Analysis of an Opioid Peptide in Solvent Media that Mimic Cytoplasm Viscosity. Biopolymers, 32, 367, 1992. 15. P. Amodeo, A. Motta, T. Tancredi, S. Salvadori, R. Tomatis, D. Picone, G. Saviano and P.A. Temussi. Solution Structure of Deltorphin I at 265 K: A Quantitative NMR Study. Peptide Res., 5, 48, 1992. 16. P. Amodeo, A. Motta, T. Tancredi, D. Picone, G. Saviano, P.A. Temussi, S. Salvadori and R. Tomatis. Conformation Activity Relationship of Deltorphin I: a NMR Study in Viscous Media. In: Peptides. Chemistry and Biology, J. A. Smith and J. E. Rivier, Eds., ESCOM Science Publisher B.V., Leiden, 115, 1992. 17. B. Di Blasio, F. Rossi, E. Benedetti, V. Pavone, M. Saviano, C. Pedone, G. Zanotti and T. Tancredi. Bioactive Peptides: X-Ray and NMR Conformational Study of [Aib5,6-D-Ala8]cyclolinopeptide A. J. Amer. Chem. Soc., 114, 8277, 1992. 18. T. Tancredi, H. Iijima, G. Saviano, P. Amodeo and P. A. Temussi. Structural Determination of the Active Site of a Sweet Protein. A 1H NMR Investigation of pMNEI. FEBS Lett., 310, 27, 1992. 19. J. Kamphuis, F. Lelj, T. Tancredi, C. Toniolo and P. A. Temussi. SAR of Sweet Molecules: Conformational Analysis of Two Hypersweet and Two Conformationally Restricted Aspartame Analogues. Quant. Struct. Act. Relat., 11, 486, 1992. 20. P.A. Temussi, D. Picone, P. Amodeo and T. Tancredi. Solution Structure of Bioactive Peptides in Biomimetic Media. Acta Pharm., 42, 323, 1992. 21. S.H.I. Galadari, H.R. Morris and V. Di Marzo. The effect of cAMP on Ca2+ ionophore-, antigen- and agonistinduced inositolphosphate release in rat basophilic leukaemia (RBL1) cells. Biochim. Biophys. Acta, 1133, 218, 1992. 22. V. Di Marzo and D. Piomelli. 115 Participation of prostaglandin E2 in dopamine D2 receptor-dependent potentiation of arachidonic acid release. J. Neurochem., 59, 379, 1992. 23. B. Nicolaus, A. Trincone, L. Lama, G. Palmieri, and A.Gambacorta. Quinone composition in Sulfolobus solfataricus grown under different conditions. Syst. Appl. Microb., 15, 18, 1992. 24. M.C. Manca, B. Nicolaus, V. Lanzotti, A. Trincone, A. Gambacorta, JP Katalinic, H. Egge, R. Huber and KO Stetter. Glycolipids from Thermotoga marittima, a hyperthermophilic microorganism belonging to Bacteria domain. Bioch. Biophys. Acta, 1124, 249, 1992. 25. B. Nicolaus, F. Marsiglia, E. Esposito, L. Lama, A. Trincone G. di Prisco, A. Gambacorta, M.J. Valderrama, and W.D. Grant. Isolation of extremely halotolerant cocci from Antarctica. Fems Microbiol. Lett., 99, 145, 1992. 26. G. Esposito, A. M. Lesk, H. Molinari, A. Motta, N. Niccolai and A. Pastore. Probing Protein Structure by Solvent Perturbation of NMR Spectra: I. NMR Spectral Editing and Topological Mapping in Proteins by Paramagnetic Relaxation Filtering. J. Mol. Biol., 224, 659, 1992. 27. M. A. Castiglione Morelli, A. Pastore and A Motta. Dynamic Properties of Salmon Calcitonin Bound to Sodium Dodecyl Sulfate Micelles: A Restrained Molecular Dynamics Study from NMR Data. J. Biomolec. NMR, 2, 335, 1992. 28. A. Motta, A. Pastore, N. A Goud and M. A. Castiglione Morelli. Calcitonin (Salmon). Macromolecular Structures,W. A. Hendrickson and K. Wüthrich Eds., Current Biology Ltd, London, England, 42, 1992. 28. S. De Rosa and G. Di Vincenzo. Isochelidonine, a benzophenanthridine alkaloid from Chelidonium majus. Phytochemistry, 31, 1085, 1992. 30. M.A. Belisario, M. Maturo, R. Pecce, S. De Rosa and G.R.D. Villani. Effect of avarol and avarone on in vitro-induced microsomal lipid peroxidation. Toxicology, 72, 221, 1992. 31. A. De Giulio, S. De Rosa, G. Di Vincenzo and G. Strazzullo. Extraction and bioassay-directed fractionation of the cytotoxic metabolites from Chelidonium majus. Phytoch. Analysis, 3, 122, 1992. 32. A. Soriente, G. Sodano, , A. Gambacorta, and A. Trincone. Structure of the ”heterocyst glycolipids” of the marine cyanobacterium Nodularia harveyana Tetrahedron 48, 5375, 1992. 33. F. Cavagnetto, A. Relini, Z. Mirgani, A. Ghiozzi, D. Bertoia and A. Gambacorta. Molecular packing parameters of bipolar lipids. Biochim. Biophys. Acta, 1106, 273, 1992. 34. R. Huber, T. Wilharm, D. Huber,A. Trincone, S. Burggraf, H. Konig, R. Rachel, I. Rockinger, H. Fricke, K.O. Stetter. Aquifex-Pyrophilus gen-nov sp-nov represents a novel group of marine hyperthermophilic hydrogen oxidizing bacteria. Syst. and Appl. Microbiol., 15, 340, 1992. 35. I. Romano, V. Calandrelli, E. Pagnotta, E. Esposito, and R. Di Maso. Whey as medium for biomass production of Sulfolobus solfataricus. Biotech. Techn., 6, 391, 1992. 36. R. Puliti, C. A. Mattia and T. H. Lilley. Structure of N-acethyl-L-leucyl-L-prolinamide monohydrate. Acta Cryst., C48, 709, 1992. 37. G. Barone, C. Giancola, T. H. Lilley, C. A. Mattia and R. Puliti. Enthalpies and entropies of fusion of some substituted dipeptides comparison with crystal data. J. Thermal Anal., 38, 2771, 1992. 38. P. Ferranti, A. Di Luccia, A. Malorni, P. Pucci, M. Ruoppolo, G. Marino and L. Ferrara. River buffalo (Bubalus bubalis L.) AA phenotype haemoglobins: characterization by immobiline polyacrilamide gel electrophoresis and high performance liquid chromatography and determination of the primary structure of the constitutive chains by mass spectrometry. Comp. Biochem. Physiol., 101B, 91, 1992. 39. M. De Angioletti, G. Maglione, P. Ferranti, C. De Bonis, G. Lacerra, A. Scarallo, L. Pagano, G. Fioretti, R. Cutolo, A. Malorni, P. Pucci and C. Carestia. Hb City of Hope [b69(E13)Gly->Ser] in Italy: association of the gene with aplotype IX. Hemoglobin, 16, 27, 1992. 40. M. F. Tecce, R. Petracca, M. Giuliani, M. Ruoppolo, G. Marino, A. Malorni and P. Pucci. Characterization by mass spectrometry of a recombinant hepatits d virus antigen and its proteolytic products. Eur. J. Biochem., 204, 512, 1992. 41. P. Caccia, G. Nitti, O. Cletini, P. Pucci, M. Ruoppolo, F. Bertolero, B. Valsasina, F. Roletto, C. Cristiani, G. Cauet, P. Sarmientos, A. Malorni and G. Marino. Stabilization of recombinant human basic fibroblast growth factor by chemical modification of cysteine residues. Eur. J. Biochem., 204, 649, 1992. 42. M. De Caterina, P. Esposito, E. Grimaldi, G. Di Maro, F. Scopacasa, P. Ferranti, A. Parlapiano, A. Malorni, P. Pucci and G. Marino. Characterization of Hb Lepore variants using advanced mass spectrometry. Clin. Chem., 38, 1444, 1992. 43. F. Addeo, L. Chianese, A. Salzano, R. Sacchi, U. Cappuccio, P. Ferranti and A. Malorni. Characterization of the 12% trichloroacetic acid-insoluble oligopeptides of Parmigiano-reggiano cheese. J. Dairy Res., 59, 401, 1992. 44. P. Ferranti, V. Carbone, N. Sannolo, I. Fiume, A. Milone, M. Ruoppolo, M. Gallo and A. Malorni. Study of interaction of styrene oxyde with Angiotensin by mass spectrometry. Carcinogenesis, 13, 1397, 1992. 45. R. Capasso, A. Malorni and A. Milone. Fast Atom Bombardment, Electron Ionization and Chemical Ionization Mass Spectrometry of 1,2,3-Benzenetricarboxylic Acids, Inhibitors of the Mitochondrial Tricarboxylate Carrier. Biological Mass Spectrom., 21, 642, 1992. 46. M.R. Faraone-Mennella, F. De Lucia, P. Quesada, M. De Rosa, A. Gambacorta, B. Nicolaus and B. Farina Heterogeneity of ADP-ribosylation reaction in Sulfolobus solfatari- 116 cus. In: ADP-ribosylating reactions, G.G. Poirier and P. Moreau eds. Springer-Verlag, New York, 369, 1992 ELENCO Anno 1993 Iberus, 11, 15, 1993. 13. G. Cimino, A. Crispino, M. Gavagnin, E. Trivellone, E. Zubia, E. Martinez and J. Ortea. Archidorin: a new ichthyotoxic diacylglicerol from the atlantic dorid nudibranch Archidoris tuberculata. J. Nat. Prod., 56, 1642, 1993. 1. M. Gavagnin, A. Spinella, A. Crispino, R. Epifanio, A. Marin and G. Cimino. Chemical components of the Mediterranean ascoglossan Thuridilla hopei. Gazz. Chim. It., 123, 205, 1993. 14. M. L.Ciavatta, E. Trivellone, G. Villani and G. Cimino. Membrenones: new polypropionates from the skin of the mediterranean mollusc Pleurobranchus membranaceus. Tetrahedron Lett., 34, 6791, 1993. 2. A. Fontana, C. Avila, E. Martinez, J. Ortea and G. Cimino. Defensive allomones in three species of Hypselodoris from the Cantabrian Sea. J. Chem. Ecol., 19, 339, 1993. 15. G. Cimino, R. de A. Epifanio, A. Madaio, R. Puliti and E. Trivellone. Absolute stereochemistry of raspacionin, the main triterpenoid from the marine sponge Raspaciona aculeata. J. Nat. Prod., 56, 1622, 1993. 3. G. Cimino, A. Crispino, A. Madaio, E. Trivellone and M. Uriz. Raspacionin-B, a further triterpenoid from the Mediterranean sponge Raspaciona aculeata. J. Nat. Prod., 56, 534, 1993. 16. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, C. Gianfrani and G. Cimino. Biosynthesis, structure elucidation and biological activity of hydroxyeicosatetraenoic acid (HETE's) in Hydra vulgaris. Biochem. J., 295, 23, 1993. 4. L. De Petrocellis, V. Di Marzo and G. Cimino. The possible involvement of protein kinase C and phospholipase A2 in Hydra tentacle regeneration. Experientia, 49, 57, 1993. 17. V. Di Marzo, C. Gianfrani, L. De Petrocellis, A. Milone, G. Villani, and G. Cimino. Biosynthesis of hydroxyeicosatetraenoic acid (HETE's) in marine and freshwater hydroids. Comp. Biochem. Physiol., 106B, 901, 1993. 5. E. Zubía, M. Gavagnin, A. Crispino, E. Martínez, J. Ortea and G. Cimino. Diasteroisomeric ichthyotoxic acylglycerols from the dorsum of two geographycally distinct populations of Archidoris nudibranchs. Experientia, 49, 268, 1993. 6. A. Spinella, L.A. Alvarez, A. Passeggio and G. Cimino. New 3-Alkylpyridines from Three Mediterranean Cephalaspidean Molluscs: Structure,Ecological Role and Taxonomic Relevance. Tetrahedron, 49, 1307, 1993. 7. A. Spinella, L.A. Alvarez and G. Cimino. Predator - Prey Relationship between Navanax inermis and Bulla gouldiana: a chemical approach. Tetrahedron, 49, 3203, 1993. 8. G. Cimino, A. Fontana, F. Giménez, A. Marin, E. Mollo, E. Trivellone and E. Zubia. Biotransformation of a dietary sesterterpenoid in the Mediterranean nudibranch Hypselodoris orsini. Experientia, 49, 582, 1993. 9. V. Di Marzo, A. Marin, R.R. Vardaro, L. De Petrocellis, G. Villani and G. Cimino. Histological and Biochemical Bases of Defense Mechanisms in Four Species of Polybranchiodea Ascoglossan Molluscs. Mar. Biol., 117, 367, 1993. 18. A. Fontana, F. Antoniazzi, M. L. Ciavatta, E. Trivellone and G. Cimino. 1H-NMR study of cholesterol autooxidation in egg powder and cookies exposed to adverse storage. J. Food Science, 58, 1286, 1993. 19. V. Di Marzo, L. De Petrocellis and G. Cimino. Hydra tentacle regeneration: a model for the study of the involvement of protein kinase C and phospholipase A2 in cell differentiation. In: Eicosanoids and other bioactive lipids in cancer, inflammation and radiation injury. Kluwer Academic Publishers, 209, 1993. 20. M. Porcelli, G. Cacciapuoti, S. Fusco, G. Iacomino, A. Gambacorta, M. De Rosa and V. Zappia. S-adenosylhomocysteine hydrolase from the thermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus: purification, physico-chemical and immunological properties. Bioch. Bioph. Acta, 1164, 179, 1993. 21. P. Ferranti, A. Malorni, P. Pucci, G. Marino, A. Di Luccia, L. Ferrara. Electrospray-mass spectrometric analysis of river buffalo hemoglobins. Re-examinati of a1 and a3 globin chain sequences. Comp. Biochem. Physiol., 105B, 573, 1993. 10. R. Puliti, A. Fontana, G. Cimino, C. Mattia and L. Mazzarella. Structure of a keto derivative of 9,11-dihydrogracilin-A. Acta Cryst., C49, 1373, 1993. 22. M. Ruoppolo, G. Nitti, B. Valsasina, A. Malorni, P. Pucci and G. Marino. Disulphide isoform intermediates in the reoxidation of recombinant human basic fibroblast growth factor. Biochemistry, 32, 4991, 1993. 11. G. Cimino and G. Sodano. Biosynthesis of Secondary Metabolites in Marine Molluscs. In: Topics in Current Chemistry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Marine Natural Products - Diversity and Biosynthesis, ed. P. Scheuer 167, 77, 1993. 23. G. Raimo, M. Masullo, A. Dello Russo, A. Parente, A. Gambacorta and V. Bocchini. Properties of the purified factor-2 in the thermophilic archaebacterium Sulfolobus sofataricus. Ital. J. Biochem., 42, 1, 1993. 12. E. Martinez, M. Ballesteros, C. Avila, L. Dantart, and G. Cimino. The family Aglajidae (Opisthobranchia: Cephalaspidea) in the Iberian Peninsula. 24. L. A. Alvarez, E. Martinez, J. Cigarria, E. Rolan and G. Villani. Haminaea callidegenita Gibson and Chia, 1989 (Opisthobranchia: Cephalaspidea), a Pacific species introduced in European coasts. 117 Iberus, 11, 59, 1993. 25. G. Lembo, C. Patruno, N. Balato, S. De Stefano, F. Ayala. Stability of patch test allergens. Contact Dermatis, 29, 95, 1993. 26. A. Parente, C. Verde, A. Malorni, P.C. Montecucchi, F. Aniello and G. Geraci. Aminoacid sequenceof the dimeric myoglobin from radular muscles of the marine gastropod Nassa mutabilis. Biochim. Biophys. Acta, 1162, 1, 1993. 27. R. Arcone, G. Arpaia, M. Ruoppolo, A. Malorni, P. Pucci, G. Marino, A. Ialenti, M. Di Rosa and G. Ciliberto. Structural characterization of a biologically active human lipocortin 1 expressed in Escherichia Coli. Eur. J. Biochem., 211, 347, 1993. 28. P. Ferranti, A. Parlapiano, A. Malorni, P. Pucci, G. Marino, G. Cossu, L. Manca and B. Masala. Hemoglobin Ozieri: a new a-chain variant [a71(E20)Ala->Val]. Characterization using FAB-and electrospray-mass spectrometric techniques. Comp. Biochem. Physiol., 105B, 573, 1993. 29. Volkl, R. Huber, E. Drobner, R.l. Rache, S. Burgraf, A. Trincone and K. O. Stetter. Pyrobaculum aerophilum sp. nov., a novel nitrate-reducing hyperthermophilic archaeum. Appl. Env. Microbiol., 59, 2918, 1993. 30. G. Zanotti, A. Maione, F. Rossi, M. Saviano, C. Pedone and T. Tancredi. Bioactive Peptides: Conformational Study of a Cystinyl Cycloheptapeptide in its Free and Calcium Complexed Forms. Biopolymers, 33, 1083, 1993. 31. D. Piomelli and V. Di Marzo. Dopamine D2 receptor signaling via the arachidonic acid cascade: modulation by cAMP-dependent protein kinase A and prostaglandin E2. J. Lipid Med., 6, 433, 1993. 32. L. De Petrocellis, V. Di Marzo, C. Gianfrani and R. Minei. Arachidonic acid, protein kinase C activators and bud formation in Hydra vulgaris. Comp. Biochem. Physiol., 105C, 219, 1993. 33. V. Di Marzo, D. Vial, P. Sokoloff, J.-C. Schwartz and D. Piomelli. Selection of alternative Gi-mediated signaling pathways at the dopamine D2-receptor by protein kinase C. J. Neurosci., 13, 4846, 1993. 34. A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama and A. Gambacorta. Potential application of Sulfolobus solfataricus as catalyst in organic synthesis. Indian J. Chem. Sect. B, 32, 25, 1993. 35. I. Romano, M.C. Manca, L. Lama, B. Nicolaus and A. Gambacorta. Method for antibiotic assay on Sulfolobales. Biotechnol. Techn., 7, 439, 1993. 36. B. Nicolaus, M.C. Manca, I. Romano and L. Lama. Production of an exopolysaccharide from two thermophilic archaea belonging to the genus Sulfolobus. Fems Microbiol. Lett., 109, 203, 1993. 37. A. Trincone, E. Trivellone, B. Nicolaus, L. Lama, E. Pagnotta, W.D. Grant and A. Gambacorta. The glycolipid of Halobacterium trapanicum. Biochim. Biophys. Acta, 1210, 35, 1993. 38. R. Puliti, C.A. Mattia & T. H. Lilley. Structure of N-acetyl-L-prolyl-glycinamide. Acta Cryst., C49, 2173, 1993. 39. G. Esposito, A. M. Lesk, H. Molinari, A. Motta, N. Niccolai and A. Pastore. Probing Protein Structure by Solvent Perturbation of NMR Spectra. II. Determination of Surface and Buried Residues in Homologous Proteins. Biopolymers, 33, 839, 1993. 40. A. Evidente, A. Motta and L. Sparapano. Seiricardines B and C, Phytotoxic Sesquiterpenes from Three Species of Seiridium Pathogenic for Cypress. Phytochemistry, 33, 69, 1993. 41. A. Soriente, A. Gambacorta, A. Trincone, C. Sili, M. Vincenzini and G. Sodano. Heterocyst glycolipidis of the cyanobacterium Cyanospira rippkae. Phytochemistry., 33, 393, 1993. ELENCO Anno 1994 1. M. Gavagnin, A. Marin, E. Mollo, A. Crispino, G. Villani and G. Cimino. Secondary metabolites from Mediterranean Elysioidea: origin and biological role. Comp. Biochem. Physiol., 108B, 107, 1994. 2. M. Gavagnin, A. Spinella, F. Castelluccio, G. Cimino and A. Marin. Polypropionates from the Mediterranean mollusc Elysia timida. J. Nat. Prod., 57, 298, 1994. 3. V. Di Marzo, C. Gianfrani, L. De Petrocellis, A. Milone and G. Cimino. Polyunsaturated fatty acid oxidation in Hydra: regioselectivity, substrate-dependent enantioselectivity and possible biological role. Biochem. J., 300, 501, 1994. 4. G. Cimino and G. Sodano. Transfer of sponge secondary metabolites to predators. In: Sponges in Time and Space, Eds. R. W. M. Von Soest , T. M. G. Van Kenpen, J. C.Braekman, A. A. Balkema. Rotterdam, 459, 1994. 5. E. Zubia, A. Spinella, G. B. Giusto, A. Crispino and G. Cimino. A new diterpenoid skeleton from the Mediterranean octocoral Alcyonum palmatum: structure of palmatol. Tetrahedron Lett., 35, 7069, 1994. 6. M. Gavagnin, A. Marin, F. Castelluccio, G. Villani and G. Cimino. Defensive relationships between Caulerpa prolifera and its shelled sacoglossan predators. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 175, 197, 1994. 7. A. Fontana, E. Trivellone, E. Mollo, G. Cimino, C. Avila, E. Martinez and J.Ortea. Further chemical studies of Mediterranean and Atlantic Hypselodoris nudibranchs: a new furanosesquiterpenoid from Hypselodoris webbi. J. Nat. Prod., 57, 510, 1994. 8. A. Fontana, F. Giménez, A. Marin, E. Mollo and G. Cimino. Transfer of secondary metabolites from the sponges Dysidea fragilis 118 and Pleraplysilla spinifera to the mantle dermal formations (MDF's) of the nudibranch Hypselodoris webbi. Experientia, 50, 510, 1994. 9. G. Cimino, A. Madaio, E. Trivellone and M. Uriz. Minor triterpenoids from the Mediterranean sponge: Raspaciona aculeata. J. Nat. Prod., 57, 784, 1994. 10. E. Zubia, M. Gavagnin, G. Scognamiglio, G. Cimino and G.B. Giusto Spongiane and ent-isocopalane diterpenoids from the Mediterranean sponge Spongia zimocca. J. Nat. Prod., 57, 725, 1994. 11. A. Spinella, L. A. Alvarez, C. Avila and G. Cimino. New acetoxy-ent-pallescensin-A sesquiterpenoids from the skin of the porostome nudibranch Doriopsilla areolata. Tetrahedron Lett., 35, 46, 1994. 12. M. L. Ciavatta, E. Trivellone, G. Cimino. Chemical diversity in the Mediterranean sponge Raspaciona aculeata: structure and absolute stereochemistry of blanesin. Tetrahedron Lett., 35, 42, 1994. 13. Y. W. Guo, M. Gavagnin, E. Trivellone and G. Cimino. Absolute stereochemistry of petroformynes, high molecular polyacetylenes from the marine sponge Petrosia ficiformis. Tetrahedron Lett., 46, 1994. 14. V. Di Marzo, A. Fontana, H. Cadas, S. Schinelli, G. Cimino. J. C. Schwartz and D. Piomelli. Formation and inactivation of endogenous cannabinoid anandamide in central neurons. Nature, 372, 686, 1994. 15. M. De Rosa and A. Gambacorta. Archaeal lipids. Chemical Methods in Prokaryotic Systematics, edited by M. Goodfellow and A.G. O'Donnel, 197, 1994. 16. A. Gambacorta, A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama and M. De Rosa. Unique features of lipids of Archaea. Syst. App. Microbiol., 16, 518, 1994. 16. F. Rossi, M. Saviano, B. Di Blasio, G. Zanotti, A. Maione, T. Tancredi and C. Pedone. Bioactive Peptides: Solid State, Solution and Molecular Dynamics Studies of a Cystinyl Cyclopentapeptide. Biopolymers, 34, 273, 1994. 17. P.A. Temussi, S. Salvadori, P. Amodeo, C. Bianchi, R. Guerrini, R. Tomatis, L.H. Lazarus, D. Picone and T. Tancredi. Selective Opioid Dipeptides. Biochem. Biophys. Res. Comm., 198, 933,1994. 20. T. Leitz, W. Muller, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Enantiospecific synthesis of bioactive hydroxy-eicosatetraenoic acids (HETEs) in Hydra magnipapillata. Biochim. Biophys. Acta, 1213, 215,1994. 21. L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Aquatic invertebrates open up new perspectives in eicosanoid research: biosynthesis and bioactivity. Prostagl. Leukotr. Essent. Fatty Acids, 51, 215, 1994. 22. A. Gambacorta, A. Trincone, B. Nicolaus, L. Lama and M. De Rosa. Unique features of lipids of Archaea. Syst. Appl. Microbiol., 16, 518, 1994. 23. B. Nicolaus, E. Esposito, L. Lama, F. Marsiglia, G. di Prisco and A. Gambacorta. Thermophilic isolates from Antarctica. Proceedings of the 2nd meeting on "Antarctic Biology". Scienza e Cultura, Edizioni Universitarie Patavine, B. Battaglia, P.M. Bisol and V. Varotto eds., 147, 1994. 24. S. De Rosa, R. Puliti, A. Crispino, A. De Giulio, C. A. Mattia and L. Mazzarella. A new scalarane sesterterpenoid from the marine sponge Cacospongia mollior. J. Nat. Prod., 57, 256, 1994. 25. R. Puliti, S. De Rosa and C. A. Mattia. Avarol, a sesquiterpene hydroquinoic from Dysidea avara. Acta Cryst., C50, 830, 1994. 26. M.L. Ferrándiz, M.J. Sanz, G. Bustos, M. Payá, M.J. Alcaraz and S. De Rosa. Avarol and avarone, two new anti-inflammatory agents of marine origin. Eur. J. Pharmacol., 253, 75, 1994. 27. M.A. Belisario, R. Pecce, M. Maturo and S. De Rosa. Arylation of sulfhydryl groups in vitro by the naturally occurring sesquiterpenoid benzoquinone, avarone. Toxicology, 86, 89, 1994. 28. S. De Rosa, A. De Giulio, C. Iodice and N. Zavodnik. Sesquiterpenes from the brown alga Taonia atomaria. Phytochemistry, 37, 1327, 1994. 29 A. Crispino, A. De Giulio, S. De Rosa S. De Stefano, A. Milone and N. Zavodnik. A sulfated normonoterpenoid from the ascidian Polycitor adriaticus. J. Nat. Prod., 57, 1575, 1994. 30. S. De Rosa, A. De Giulio and C. Iodice. Biological effects of prenylated hydroquinones: structure-activity relationships studies in antimicrobial, brine shrimp, and fish lethality assays. J. Nat. Prod., 57, 1711, 1994. 18. T. Tancredi, S. Salvadori, P. Amodeo, D. Picone, L.H. Lazarus, S.D. Bryant, R. Guerrini, G. Marzola and P.A. Temussi. Conversion of enkephalin and dermorphin into δ-selective opioid antagonists by single residue substitution. Eur. J. Biochem., 224, 241, 1994. 31. S. De Rosa, A. Milone, A. De Giulio and C. Iodice. Composizione degli acidi grassi della Chenopodiaceae Arthrocnemum glaucum. Studi Urbinati Atti del 7° Convegno SIF, 36C, 141, 1994. 19. T. Leitz, H. Beck, M. Stephan, W.-D. Lehmann, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. The possible involvement of arachidonic acid and eicosanoids in metamorphic events in Hydractinia echinata (Coelenterata, Hydrozoa). J. Exp. Zool., 269, 422,1994. 32 . G. Esposito, A. M. Lesk, H. Molinari, A. Motta, N. Niccolai, and A. Pastore. Probing Protein Structure by Solvent Perturbation of NMR Spectra. III. Combination of Experiment and Theory. In: Protein Structure by Distance Analysis, H. Bohr and F. Brunak Eds., IOS Press, Amsterdam 51, 1994. 119 33. P. Amodeo, M. A. Castiglione Morelli, and A. Motta. Multiple Conformations and Proline Cis-Trans Isomerization in Salmon Calcitonin.: A Combined Nuclear Magnetic Resonance, Distance Geometry and Molecular Mechanics Study. Biochemistry, 33, 10754, 1994. 34. R. Puliti and C. A. Mattia. Structure of N-acetyl-glycyl-L-alaninamide and N-acetyl-L-alanyl-Lalaninamide. Acta Cryst., C51, 1994. 35. C. A. Mattia, O. Ortona, R. Puliti, G. L. Cascarano and C. Giacovazzo. Structure of hexafluorosilicate of acridine orange tetrahydrate. J. Mol. Struct., 1994. 36. A. Trincone, A. Gambacorta, A. Soriente, S. Sodano. Improved methods for assignment of the relative configuration of 1,3 diols, by using 13C-enriched acetonides. Tetrahedron: Asymmetry, 5, 1453, 1994. 37. A. Trincone, R. Improta, R. Nucci, M. Rossi, A. Gambacorta. Enzymatic synthesis of carbohydrate derivatives using β-glycosidase of Sulfolobus solfataricus. Biocatalysis, 10, 195, 1994. 38. A. Trincone, R. Improta, A. Gambacorta. Enzymatic synthesis of polyol-and masked polyol-glycosides using β -glycosid Sulfolobus solfataricus. Biocatalysis, 11, 1, 1994. 39. G. Fantin, M. Fogagnolo, P. Giovannini, A. Medici, E. Pagnotta, E. Pedrini, A. Trincone. Synthesis of homochiral syn-and anty-α-(hydroxyethyl)-γbutyrolactones via microbial reduction. Tetrahedron: Asymmetry, 5, 1631, 1994. 40. M. Moracci, M. Ciaramella, R. Nucci, L.H. Pearl, L.H. Sanderson, A. Trincone, M. Rossi. Thermostable β-glycosidase from Sulfolobus solfataricus. Biocatalysis, 11, 89, 1994. 41. A. Gliozzi, A. Relini, R. Rolandi, S. Dante, A. Gambacorta. Organization of bipolar lipids in monolayers at the air-water interface. Thin Solid Films, 242, 208, 1994. 46. M. De Rosa, A. Morana, A. Riccio, A. Gambacorta, A. Trincone, G. Incani. Lipids of Archaea: a new tool for bioelectronics. Bios. and Bioelect., 9, 669, 1994. 47. F. Addeo, L. Chianese, R. Sacchi, S. Spagna Russo, P. Ferranti and A. Malorni. Characterization of the oligopeptides in Parmigiano-Reggiano cheese solublein 1.20 g trichloroacetic acid. J. Dairy Res., 61, 365, 1994. 48. B. Nicolaus. Gli archeobatteri terza linea evolutiva degli esseri viventi. Biologi Italiani, 1994. ELENCO Anno 1995 1. C. Gianfrani, V. Di Marzo, L. De Petrocellis and G. Cimino. Hydra vulgaris ω10-lipoxygenase is used in vivo to synthesize new alinolenic acid metabolites. Experientia, 51, 48, 1995. 2. A. Fontana, M. Gavagnin, E. Mollo, E. Trivellone, J. Ortea and G. Cimino. Chemical studies of Cadlina molluscs from Cantabrian Sea (Atlantic Ocean). Comp. Biochem. Physiol., 111B, 283, 1995. 3. Y. W. Guo, M. Gavagnin, E. Trivellone and G. Cimino. Further structural studies of petroformynes. J. Nat. Prod., 58, 712, 1995. 4. M. Gavagnin, E. Trivellone, F. Castelluccio, G. Cimino and R. Vietti-Cattaneo. Glyceryl ester of a new halimane diterpenoic acid from the skin of the Antarctic nudibranch Austrodoris kerguelenensis. Tetrahedron Lett., 36, 7319, 1995. 5. M. L. Ciavatta,G. Villani, E. Trivellone and G. Cimino. Two new labdane aldehydes from the skin of the notaspidean Pleurobranchaea meckelii. Tetrahedron Lett., 36, 8673, 1995. 42. A. Trincone, E. Pagnotta, G. Sodano. Chemoenzymatic synthesis and stereochemistry of aleppotrioloside, a natural occurring glucoside. Tetrahedron Lett., 35, 1415, 1994. 6. S. De Rosa, G. Cimino, A. De Giulio, A. Milone, A. Crispino and C. Iodice. A new bioactive eunicellin-type diterpene from the gorgonian Eunicella cavolini. Nat. Prod. Lett., 7, 259, 1995. 43. A. Relini, D. Cassinadri, Z. Mirghani, O. Brandt, A. Gambacorta, A. Trincone, M. De Rosa, A. Gliozzi. Calcium-induced interaction and fusion of archaebacterial lipid vesicles: a fluorescent study. Bioch. Biophys. Acta, 1194, 17, 1994. 7. G. Zanotti, A. Maione, F. Rossi, M. Saviano, C. Pedone, P. Fucile, G. Saviano and T. Tancredi. Solution structure of cyclopeptides inhibiting the cholate uptake in hepatocytes. In: Peptides 94, H.L.S. Maia, Ed., ESCOM, Leiden , 559, 1995. 44. M. R. Faraone Mennella, F. De Lucia, A. De Maio, A. Gambacorta, P. Quesad, M. De Rosa, B. Nicolaus, B. Farina. ADP-ribosylation reactions in Sulfolobus solfataricus, a thermophilic archaeon. Bioch. Biophys. Acta, 1246, 151, 1994. 8. S. Salvadori, D. Picone, P. Amodeo, O. Crescenzi, P.A. Temussi, L.H. Lazarus, S.D. Bryant, R. Guerrini, R. Tomatis and T. Tancredi. Conformational analysis of deltorphin I analogs containing alpha disubstituted residues in the message domain. In: Peptides 94, H.L.S. Maia, Ed., ESCOM, Leiden, 630, 1995. 45. P. E. Jansonn, B. Lindberg, M. C. Manca, W. Nimmich, G. Wildman. Structural studies of the capsular polysaccharide from Klebsiella type 38: a reinvestigation. Carbohydrate Res., 261, 111, 1994. 9. M.R. Ciajolo, G. Balboni, D. Picone, S. Salvadori, T. Tancredi, P.A. Temussi and A. Tuzi. Solution and solid state structure of the diketopiperazine of tyrosyltetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid. Int. J. Peptide Protein Res., 46, 134, 1995. 120 10. G. Zanotti, F. Rossi, M. Saviano, T. Tancredi, G. Saviano, A. Maione, M. Filizola, B. Di Blasio and C. Pedone. A Potent Cyclolinopeptide A Analogue: Solid State and Solution Conformation of cyclo[Pro-Phe-Phe-Ala-Glu(OtBu)]2. J. Amer. Chem. Soc., 117, 8651, 1995. 11. S. Salvadori, M. Attila, G. Balboni, C. Bianchi, S.D. Briant, O. Crescenzi, R. Guerrini, D. Picone, T. Tancredi, P.A. Temussi and L.H. Lazarus. δ Opioidmimetic Antagonists: Prototypes for Designing a New Generation of Ultraselective Opioid Peptides. Molecul. Med., 1, 678, 1995. 12. P. Amodeo, G. Balboni, O. Crescenzi, R. Guerrini, D. Picone, S. Salvadori, T. Tancredi and P.A. Temussi. Conformational Analysis of Potent and Very Selective d Opioid Dipeptide Antagonists. FEBS Lett., 377, 363, 1995. 13. T. Tancredi, G. Saviano, P. Fucile and G. Zanotti. Bioactive Peptides: Solution Structure Determination, by NMR Methods, of Cyclodecapeptides inhibiting the Cholate Uptake in Hepatocytes. Bull. Magn. Reson., 17, 192, 1995. 14. V. Di Marzo and A. Fontana. Anandamide, an endogenous cannabinomimetic eicosanoid: "killing two birds with one stone". Prostagl. Leukotr. Essent. Fatty Acids, 53, 1, 1995. 15. V. Di Marzo. Arachidonic acid and eicosanoids as targets and effectors in second messenger interactions. Prostagl. Leukotr. Essent. Fatty Acids, 53, 239, 1995. 16. L. Borrelli, V. Carginale, A. Capasso, T. Schneider, T. Leitz, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Phospholipase A2 and protein kinase C activities and their interactions in Hydra vulgaris. Comp. Biochem. Physiol., 111B, 211, 1995. N-acetyl-glycyl-L-alaninamide and N-acetyl-L-alanyl-Lalaninamide. Acta Cryst., C51, 336, 1995. 23. R. Puliti, S. De Rosa and C.A. Mattia. Crystal studies of avarol derivatives: 5’-acetyl avarol from Dysidea avara. Acta Cryst., C51, 1195, 1995. 24. C.A. Mattia, O. Ortona, R. Puliti, G. Cascarano and C. Giacovazzo. Structure of acridine orange hexafluorosilicate tetrahydrate. J. Mol. Struct., 350, 63, 1995. 25. R. Puliti, C.A. Mattia and L. Mazzarella. Scalaradial, a sesterterpenoid metabolite from the marine sponge Cacospongia mollior. Acta Cryst., C51, 1703, 1995. 26. R. Puliti, S. De Rosa and C.A. Mattia. Studies of avarol derivatives: 2',5’-diacetylavarol from Dysidea avara. Acta Cryst., C51, 2163, 1995. 27. S. De Rosa, R. Puliti, A. Crispino, A De Giulio, C. De Sena, C. Iodice and C.A. Mattia. 25-Deoxycacospongionolide B and cacospongionolide C. Two new terpenoids from the sponge Fasciospongia cavernosa. Tetrahedron, 51, 10731, 1995. 28. M. Gautel, M. A.Castiglione Morelli, M. Pfuhl, A. Motta and A Pastore. A Calmodulin-Binding Sequence in the C-Terminus of Human Cardiac Titin Kinase. Eur. J. Biochem., 230, 752, 1995. 29. A. Motta, B. Bremnes, M. A. Castiglione Morelli, R. W. Frank, G. Saviano and O. Bakke. Structure-Activity Relationship of the Leucine-Based Sorting Motifs in the Cytosolic Tail of the MHC-Associated Invariant Chain. J. Biol. Chem., 270, 27165, 1995. 17. A. Fontana, V. Di Marzo, H. Cadas and D. Piomelli. Analysis of anandamide, an endogenous cannabinoid substance, and of other natural N-acyl-ethanolamines. Prostagl. Leukotr. Essent. Fatty Acids , 53, 301, 1995. 30. S. De Rosa, A. De Giulio, C. Iodice, M.J. Alcaraz and M. Payá. Long chain aldehydes from the red alga Corallina Mediterranea. Phytochemistry, 40, 995 1995. 18. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, T. Bisogno and S. Maurelli. Pharmacology and physiology of the endogenous cannabimimetic mediator anandamide. J. Drug Devl. Clin. Pract., 7, 199, 1995. 31. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice and A. Milone. Sulfated polyprenyl-hydroquinones from the sponge Ircinia spinosula. J. Nat. Prod., 58, 1450, 1995. 19. L. De Petrocellis, P. Orlando and V. Di Marzo. Anandamide, an endogenous cannabinomimetic substance, modulates rat brain protein kinase C in vitro. Biochem. Mol. Biol. Int., 36, 1127, 1995. 32. B. Gil, M.J. Sanz, M.C. Terencio, A. De Giulio, S. De Rosa, M.J. Alcaraz and M. Payá. Effects of marine 2-polyprenyl-1,4-hydroquinones on phospholipase A2 activity and some inflammatory responses. Eur. J. Pharmacol., 285, 281, 1995. 20. S. Maurelli, T. Bisogno, L. De Petrocellis, A. Di Luccia, G. Marino and V. Di Marzo. Two novel classes of neuroactive fatty acid amides are substrates for mouse neuroblastoma 'anandamide amidohydrolase'. FEBS Lett., 377, 82, 1995. 33. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice, R. Pronzato and N. Zavodnik. Cacospongionolide B, a new sesterterpene from the sponge Fasciospongia cavernosa. J. Nat. Prod., 58, 1776, 1995. 21. B. Nicolaus, M.C. Manca, L. Lama, E. Esposito and A. Gambacorta. Effects of growth temperature on the polar lipid pattern and fatty acid composition of seven thermophilic isolates from the Antarctic Continent. Syst. Appl. Microbiol., 18, 32, 1995. 34. B. Nicolaus, L. Lama, E. Esposito, M.C. Manca, G. di Prisco, A. Gambacorta. Bacillus thermoantarcticus sp. nov., from Mount Melbourne, Antarctica: a novel thermophilic species. Polar Biol., 14, 1995. 22. R. Puliti and C.A. Mattia 35. A. Trincone, R. Improta, A. Gambacorta. 121 Enzymatic synthesis of polyol- and masked polyol-glycosides using β -glycosidase of Sulfolobus solfataricus. Biocatal. and Biotransf., 12, 77, 1995. 36. A. Trincone, E. Pagnotta. Efficient chemoselective synthesis of 3,4-dihydroxypropiophenoneglucoside by thermophilic β-glycosidase from Sulfolobus solfataricus. Biotechnology Lett., 17, 45, 1995. 37. A. Gambacorta, A. Gliozzi, M. De Rosa. Archaeal lipids and their biotechnological applications. World J. Microbiol. Biotechnol., 11, 115, 1995. 38. A. Soriente, T. Bisogno, A. Gambacorta, I. Romano, C. Sili, A. Trincone, G. Sodano. Reinvestigation of heterocyst glycolipids from the cyanobacterium Anabaena cylindrica. Phytochemistry, 38, 641, 1995. 39. Q. Fan, A. Relini, A. Gambacorta, A. Gliozzi. Stability against temperature and external agents of vesicles composed of archaeal bolaform lipids and egg PC. Biochim. Biophys. Acta-Biomembranes., 1240, 83, 1995. 48. M. A. Belisario, R. Pecce, M. Maturo, G. Avagnale, N. Sannolo and A. Malorni. Erythrocyte-mediated toxification of 1,8-dinitropyrene. I. Reduction. J. Biol. Res., 71, 27, 1995. 49. M. A. Belisario, A. Garofalo, M. Maturo, G. Avagnale, N. Sannolo and A. Malorni. Erythrocyte-mediated toxification of 1,8-dinitropyrene. II. Covalent bind to erythrocyte-proteins. J. Biol. Res., 71, 35, 1995. 50. L. Chianese, G. Garro, P. Ferranti, A. Malorni, F. Addeo, A. Rabasco and P. M. Pons. Discrete phosphorylation generates the electrophoretic Heterogeneity of ovine β-casein. J. Dairy Res., 62, 89, 1995. 51. P. Ferranti, A. Malorni, G. Nitti, P. Laezza, R. Pizzano, L. Chianese and F. Addeo. Primary structure of ovine as 1-caseins: localization of phosphorylation sites and characterization of genetic variants A, C and D. J. Dairy Res., 62, 281, 1995. 40. A. Gambacorta, A. Soriente, A. Trincone, G. Sodano. Biosynthesis of heterocyst glycolipids in the cyanobacterium Anabaena cylindrica. Phytochemistry, 39, 771, 1995. 52. C. Napoli, A. Postiglione, M. Triggiani, G. Corso, G. Palumbo, V. Carbone, A. Ruocco, G. Ambrosio, S. Montefusco, A. Malorni, M. Condorelli and M. Chiariello. Oxidative structural modifications of low density lipoprotein in homozygous familial hypercholesterolemia. Atherosclerosis, 118, 259, 1995. 41. C. Jeanthon, A. L. Reysenbach, S. L’Haridon, A. Gambacorta, N. R. Pace, P. Glènat, D. Prieur. Thermatoga subterranea sp. nov., a new thermophilic bacterium isolated from a continental oil reservoir. Archiv. Microbiol., 164, 91, 1995. 53. P. Pucci, A. Malorni and G. Marino. What massa spectrometry can do for you. Biochim. in Italia, 2, 56, 1995. 42. A. Soriente, M. De Rosa, A. Trincone, G. Sodano. Enzymatic regio- and diasteroselective hydrolysis of peracetylated glycerol- and erythritol-β-glucosides. Bioorg. and Medic. Chem. Lett., 5, 2321, 1995. 43. E. Maccioni, P. Mariani, F. Rustichelli, H. Delacroix, V. Troitsky, A. Riccio, A. Gambacorta, M. De Rosa. X-ray diffraction structural analysis of langmuir-blodgett films by using a pattern recognition approach. Thin Solid Films, 265, 74, 1995. 44. M. C. Manca, A. Weintraub, G. Wilmalm. Structural studies of the Escherichia coli O26 O-antigen polysaccharide. Carbohydrate Res., 346, 1995. 45. C. Schleper, G. Puehler, I. Holz, A. Gambacorta, D. Janekovic, U. Santarius, H. P. Klenk and W. Zillig. Picrophilus gen. nov., fam. nov.: A novel aerobic, hetetotrophic, thermoacidophilic genus and family comprising Archaea capable of growth around pH O. J. Bacteriol., 177, 7050, 1995. 46. P. Ferranti, P. Pucci, G. Marino, I. Fiume, B. Terrana, C. Ceccarini and A. Malorni. Human a-fetoprotein produced from hep g2 cell line: structure and heterogeneity of the oligosaccharide moiety. J. Mass Spectrom., 30, 632, 1995. 47. N. Sannolo, V. Carbone, P. Ferranti, I. Fiume, G. Mamone and A. Malorni. Mass spectrometric analysis of haemoglobin adducts formed by methyl bromide in vitro. J. Chromatogr. B, 670, 349, 1995. ELENCO Anno 1996 1. V. Di Marzo, R. R. Vardaro, L. De Petrocellis and G. Cimino. ω10-Lipoxygenase products of α-linolenic acid are esterified to phospholipids in Hydra vulgaris. Experientia, 52, 120, 1996. 2. N. Ungur, M. Gavagnin and G. Cimino. Synthesis of diastereoisomeric ent-isocopalic acid glycerides. Tetrahedron Lett., 37, 3549, 1996. 3. Y. Guo, A. Madaio, E. Trivellone, G. Scognamiglio and G. Cimino. Structure and stereochemical studies of saraines: macrocyclic alkaloids of the sponge Reniera sarai. Tetrahedron, 52, 8341, 1996. 4. M. L. Ciavatta, E. Trivellone, G. Villani and G. Cimino. Prenylphenols from the skin of the aeolid mollusc Cratena peregrina. Gazz. Chim. Ital., 126, 707 1996. 5. A. Fontana, L. Albarella, G. Scognamiglio, M. Uriz and G. Cimino. Structural and stereochemical studies of C-21 terpenoids from Mediterranean Spongiidae sponges. J. Nat. Prod., 59, 869, 1996. 6. A. Casapullo, A. Fontana and G. Cimino. Coriacenins: a new class of long alkyl chain amino alcohols from the Mediterranean sponge Clathrina coriacea. J. Org. Chem., 61, 7415, 1996. 7. M. Gavagnin, E. Mollo, G. Cimino and J. Ortea. 122 A new γ-dihydropyrone-propionate from the caribbean sacoglossan Tridachia crispata. Tetrahedron Lett., 37, 4259, 1996. 8. N. Ungur, M. Gavagnin and G. Cimino. Synthesis of (-)-12-deacetoxyscalaradial. Nat. Prod. Lett., 8, 275, 1996. 9. M.L. Ciavatta, M. Gavagnin, R. Puliti, G. Cimino, E. Martinez, J. Ortea, C.A. Mattia. Dolabriferol: a new polypropionate from the skin of the Anaspidean mollusc Dolabrifera dolabrifera. Tetrahedron, 52, 12831, 1996. 10. Y. W.Guo, M. Gavagnin, E. Mollo, E. Trivellone G. Cimino, N.A. Hamdy, I. Fakhr and M. Pansini. A new norsesterterpene peroxide from a red sea sponge. Nat. Prod. Lett., 9, 105, 1996. 11. Y. W.Guo, A. Madaio, E. Trivellone, G. Scognamiglio and G. Cimino. Further studies of alkaloids from Reniera sarai; structures of saraine3 and isosaraine-3; absolute stereochemistry of saraine-1 and saraine2. Tetrahedron, 52, 14961, 1996. 12. V. Di Marzo, M. Ventriglia, E. Mollo, M. Mosca, and G. Cimino. Occurrence and biosyntesis of 11(R)-hydroxy-eicosatetraenoic acid (11-R-HETE) in the Carribean soft coral Plexaurella dichotom. Experientia, 52, 834, 1996. 13. L. De Petrocellis, P. Orlando, M. Gavagnin, M. Ventriglia, G. Cimino and V. Di Marzo. Novel diterpenoid diacylglycerols from marine molluscs: potent morphogens and protein kinase C activators. Experientia, 52, 874, 1996. 14. O. Crescenzi, P. Amodeo, G. Cavicchioni, R. Guerrini, D. Picone, S. Salvadori, T. Tancredi, P.A. Temussi. δ Selective Opioid Peptides Containing a Single Aromatic Residue in the Message Domain. A NMR Conformational Analysis. J. Peptide Sci., 2, 290, 1996. 15. F. Rossi, M. Saviano, P. Di Talia, B. di Blasio, C. Pedone, G. Zanotti, M. Mosca, G. Saviano, T. Tancredi, K. Ziegler and E. Benedetti. Solution and Solid State Structure of an Aib-Containing Cyclodecapeptide Inhibiting the Cholate Uptake in Hepatocytes. Biopolymers, 40, 465, 1996. 16. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, N. Sepe and A. Buono. Biosynthesis of anandamide and related acyl-ethanolamides in mouse J774 macrophages and N18 neuroblastoma cells. Biochem. J., 316, 977, 1996. 17. F. Descalzi Cancedda, M. Malpeli, C. Gentili, V. Di Marzo, P. Bet, M. Carlevaro, S. Cermelli and R. Cancedda. The developmentally regulated avian Ch21 lipocalin is an extracellular fatty acid binding protein (Ex-FABP). J. Biol. Chem., 271, 20163,1996. 18. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, T. Sugiura and K. Waku. Potential biosynthetic connections between the two cannabimimetic eicosanoids, anandamide and 2-arachidonoyl-glycerol, in mouse neuroblastoma cells. Biochem. Biophys. Res. Comm., 227, 281, 1996. 19. B. Nicolaus, L. Lama, E. Esposito, M.C. Manca, G. di Prisco and A. Gambacorta. Bacillus thermoantarcticus sp. nov., from Mount Melbourne, Antarc- tica: a novel thermophilic species. Polar Biol., 16, 101, 1996. 20. M.R. Faraone Menella, A. Gambacorta, B. Nicolaus and B. Farina. Immunochemical detection of ADP-ribosylating enzymes in the archaeon Sulfolobus solfataricus. FEBS Lett., 178, 199, 1996. 21. L. Lama, B. Nicolaus, V. Calandrelli, M.C. Manca, I. Romano and A. Gambacorta. Effect of growth conditions on exo-and endopolymer biosynthesis in Anabaena cylindrica 10C. Phytochemistry, 42, 655, 1996. 22. M.C. Manca, L. Lama, E. Esposito R. Improta A. Gambacorta and B. Nicolaus. Chemical Composition of two exopolysaccharides from Bacillus thermoantarcticus. Appl. Env. Microbiol., 62, 3265, 1996. 23. I. Romano, B. Nicolaus, L. Lama, M.C. Manca, and A. Gambacorta. Characterization of haloalkalophilic strictly aerobic bacterium isolated from Pantelleria island. Syst. and Appl. Microbiol., 19, 326, 1996. 24. L. Lama, B. Nicolaus, V. Calandrelli, E. Esposito, A. Gambacorta. XylanaseProduced by Bacillus thermoantarcticus, a new thermophilic bacillus. Enz. Engin. XIII, 799, 285, 1996. 25. R. Puliti, C. De Sena and C.A. Mattia. N-acetyl-L-phenylalanyl-L-alaninamide. Acta Cryst., C52, 1820, 1996. 26. R. Puliti, G. Barone,C. Giancola and C.A. Mattia. Structural characterization of N-acetylglycyl-L-prolinamide: an Xray and thermodynamic study. J. Mol. Struct., 382, 197, 1996. 27. S. De Rosa, A. De Giulio and G. Tommonaro. Aliphatic and aromatic glycosides from the cell cultures of Lycopersicon esculentum. Phytochemistry, 42, 1031, 1996. 28. S. De Rosa, A. Milone, A. De Giulio, A. Crispino and C. Iodice. Sulfated furanosesterterpenes from two sponges of the genus Ircina. Nat. Prod. Lett., 8, 245, 1996. 29. R. Cholbi, M.L. Ferrándiz, M.C. Terencio, S. De Rosa, M.J. Alcaraz and M. Payá. Inhibition of phospholipase A2 activities and some inflammatory responses by the marine product ircinin. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol., 354, 677, 1996. 30. M.A. Belisario, M. Maturo, G. Avagnale, S. De Rosa, F. Scopacasa and M. De Caterina. In vitro effect of avarone and avarol, a quinone/hydroquinone couple of marine origin, on platelet aggregation. Pharmac. and Toxic., 79, 300, 1996. 31. A. Evidente, L. Sparapano, A. Motta, F. Giordano, O. Fierro, and S. Frisullo. A Phytotoxic Piramane Diterpene of Spaeropsis Sapinea f. sp. Cupressi, the Pathogen of a Canker of Disease of Cypress. Phytochemistry, 42, 1541, 1996. 32. A. Evidente, A. Motta, R. Capasso, A. Andolfi, M. Vurro, M. C. 123 Zonno, and A. Bottalico. Toxic Metabolites from Phytopathogenic Ascochyta Species. Boll. Chim. Farm., 135, 199, 1996. 33. M. Santin, A. Rosso, A. Sada, G. Peluso, R. Improta, A. Trincone. Enzymatic synthesis of 2-β-D-galactopyranosyloxy ethyl metacrylate (GalEMA) by the thermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus. Biotechnol. and Bioengin., 49, 217, 1996. 34. A. Trincone. Thermophilic glycosidases, a tool for the enzymatic synthesis of glycosides. J. Cyber Chem., 1996 http://netsci-journal.com/97v1/index.htm 35. A. Trincone, E. Pagnotta, M. Fantin, M. Fogagnolo. Enzymatic routes for the synthesis of rhododendrin and epirhododendrin. Biocat. and Biotransf., 13, 245, 1996. 36. A. Gliozzi, M. Robello, L. Fittabile, A. Relini, A. Gambacorta. Valinomycin acts as a channel in ultrathin lipid membranes. Biochim. Biophys. Acta-Biomembranes, 1283, 1, 1996. 37. A. Trincone, E. Pagnotta. Facile chemo-enzymatic access to monoglycosyl derivatives of 2,3oxirane dimethanol. Tetrahedron: Asymmetry, 7, 2733, 1996. 38. A. Gambacorta, I. Romano, A. Trincone, A. Soriente, M. Giordano, G. Sodano. Heterocyst glycolipids from five nitrogen-fixing cyanobacteria. Gazz. Chim. Ital., 126, 653, 1996. 39. G. Sodano, A. Soriente, A. Gambacorta, A. Trincone. Structure, biosynthesis and synthesis of glycolipids from the heterocysts of nitrogen fixing cyanobacteria. Korean J. of Med. Chem., 6, 290, 1996. ELENCO Anno 1997 1. M. Gavagnin, N. Ungur, F. Castelluccio and G. Cimino. Novel verrucosins from the skin of the Mediterranean nudibranch Doris verrucosa. Tetrahedron, 53, 1491, 1997. 2. Y. W.Guo, M. Gavagnin, E.Mollo, G. Cimino, N. A. Hamdy, I. Fakhr, and M. Pansini. Hurghamides A-D, new n-acyl-2-methylene-β-alanine methyl esters from red sea Hippospongia sp. Nat. Prod. Lett., 10, 143, 1997. 3. T. Bisogno, M. Ventriglia, A. Milone, M. Mosca, G. Cimino and V. Di Marzo. Occurrence and metabolism of anandamide and related acylethanolamides in ovaries of the sea urchin Paracentrotus lividus. Biochem. Biophys. Acta, 1345, 338,1997. 4. M. Gavagnin, E. Mollo, F. Castelluccio, D. Montanaro, J. Ortea and G. Cimino. A novel dietary sesquiterpene from the marine sacoglossan Tridachia crispata. Nat. Prod. Lett., 10, 151, 1997. 5. A. Casapullo, G. Scognamiglio and G. Cimino. Mucosin: a new bicyclic eicosanoid from the Mediterranean sponge Reniera mucosa. Tetrahedron Lett., 38, 3643, 1997. 6. A. Fontana, N. Ungur, M. Gavagnin, C. Salierno and G. Cimino. Regioselective synthesis of diterpenoid 1,2-diacyl-sn-glycerides. Tetrahedron Lett., 38, 4145, 1997. 7. A. Fontana, E. Mollo, D. Ricciardi, I. Fakhr and G. Cimino. Chemical studies of egyptian opistobranchs: spongian diterpenoids from Glossodoris atromarginata. J. Nat. Prod., 60, 444, 1997. 40. H. Parolis, L.A.S. Parolis, I. F. Boàn, F. Rodriguez Valera, G. Widmalm, M. C. Manca, P.E. Jansson, I. W. Sutherland.. The structure of the exopolysaccharide produced by the halophilic archaeon Haloferax mediterranei strain R4 (ATCC 33500). Carbohydr. Res., 295, 147, 1996. 8. A. Fontana, G. Scognamiglio and G. Cimino. Dendrinolide, a new degraded diterpenoid from the Antarctic sponge Dendrilla membranosa. J. Nat. Prod., 60, 475, 1997. 41. M.A. Belisario, R. Pecce, A. Garofalo, N. Sannolo and A. Malorni. Erythrocyte enzymes catalyze 1-nitropyrene and 3-nitrofluoranthene nitroreduction. Toxicology, 108, 101, 1996. 9. A. Spinella, E. Zubia, E. Martinez, J. Ortea and G. Cimino. Structure and stereochemistry of aplyolides A-E, lactonized dihydroxy fatty acids from the skin of the marine mollusk Aplysia depilans. J. Org. Chem., 62, 5471, 1997. 42. P. Ferranti, N. Sannolo, G. Mamone, I. Fiume, V. Carbone, M. Tornqvist, A. Bergman and A. Malorni. Structural characterization by mass spectrometry of hemoglobin adducts formed after in vitro exposure to methyl bromide. Carcinogenesis, 17, 2661, 1996. 10. A. Spinella, E. Mollo, E. Trivellone and G. Cimino. Testudinariol A and B, two unusual triterpenoids from the skin and the mucus of the marine mollusc Pleurobrancus testudinarius. Tetrahedron, 53, 16891, 1997. 43. B. Nicolaus. Microorganismi termofili in Antartide. Biologi Italiani XXVI, 9, 6 1996. 11. A. Marin, M. D. Lopez Belluga, G. Scognamiglio and G. Cimino. Morphological and chemical camouflage of the mediterranean nudibranch Discodoris indecora on the sponges Ircinia variabilis and Ircinia fasciculata. J. Mol. Stud., 63, 431, 1997. 44. L. Casula, S. De Stefano, A. Milone, E. M. Procaccini, A. Crispino, E. Masturzo and G. Monfrecola. Valutazione in vitro dell’efficacia dei filtri solari attraverso l’isomerizzazione dell’acido urocanico. Annal. It. Derm. Clin. Sper., 50(2), 62, 1996. 12. A. Fontana, M. L. Ciavatta, M. Gavagnin and G. Cimino. Chemical and Biochemical studies of Antarctic benthic invertebrates. Proceed. of the Third Meeting on Antarctic Biology, 157, 1997. 13. M. L. Ciavatta, M. Gavagnin, R. Puliti, G. Cimino, E. Martinez, J. Ortea and C. A. Mattia. Dactylallene: a new dietary C15 bromoallene from the Atlantic anaspidean mollusc Aplysia dactylomela. 124 Tetrahedron, 53, 17343, 1997. 14. P. Ruzza, A. Calderan, M. Carrara, T. Tancredi and G. Borin. Antamanide and its Gly or Tyr Analogues: Synthesis and Pharmacological Properties. Curr. Topics Pept. Prot. Res., 2, 21, 1997. 15. S. Salvadori, D. Picone, T. Tancredi, R. Guerrini, R . Spadaccini, L.H. Lazarus, D. Regoli and P.A. Temussi. Solution Conformation of Nociceptin. Biochem. Biophys. Res. Comm., 233, 640, 1997. 16. O. Crescenzi, F. Fraternali, D. Picone, T. Tancredi, G. Balboni, R. Guerrini, L.H. Lazarus, S. Salvadori and P.A. Temussi. Design and Structure of an Opioid Lacking the Basic Center. Models of Antagonism. Eur. J. Biochem., 247, 66, 1997. 17. P. Pierobon, L. De Petrocellis, R. Minei and V. Di Marzo. Arachidonic acid as an endogenous signal for the glutathione-induced feeding response in Hydra. Cell. Mol. Life Sci. (formerly Experientia), 53, 61, 1997. 18. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, T. Bisogno and S. Maurelli. The endogenous cannabimimetic eicosanoid, anandamide, induces arachidonate release in J774 mouse macrophages. Adv. Exp. Med. Biol., 407, 341, 1997. 26. T. Bisogno, N. Sepe, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Biosynthesis of 2-arachidonoyl-glycerol, a novel cannabimimetic eicosanoid, in mouse neuroblastoma cells. Adv. Exp. Med. Biol., 433, 201, 1997. 27. L. De Petrocellis, D. Melck, N. UedaY. Kurahashi, T. Bisogno, S. Yamamoto and V. Di Marzo. Brain and peripheral anandamide amidohydrolase and its inhibition by synthetic arachidonate analogues. Adv. Exp. Med. Biol., 433, 259, 1997. 28. P. Pierobon, L. De Petrocellis, R. Minei and V. Di Marzo. Arachidonic acid and eicosanoids in Hydra: possible endogenous signals involved in chemoreception and modulation of the feeding behaviour. Adv. Exp. Med. Biol., 433, 363, 1997. 29. R. Mechoulam, E. Fride, L. Hanus, T. Sheskin, T. Bisogno, V. Di Marzo, M. Bayewitch and Z. Vogel. Anandamide may mediate sleep induction. Nature, 389, 25, 1997. 30. M. R. Faraone Menella, F. De Lucia, A. De Maio, A. Gambacorta, B. Nicolaus, B. Farina. ADPribosylation reaction by free ADPribose in Sulfolobus solfataricus, a thermophilic archaeon. J. Cell. Biochem., 65, 1, 1997. 19. T. Bisogno, N. Sepe, D. Melck, S. Maurelli, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Biosynthesis, release and degradation of the novel endogenous cannabimimetic metabolite 2-arachidonoyl-glycerol in mouse neuroblastoma cells. Biochem. J., 322, 671, 1997. 31. B. Nicolaus, L. Lama, E. Esposito, M.C. Manca, R. Improta, V. Calandrelli, G. di Prisco and A. Gambacorta. Bacillus thermoantarcticus: a new thermophilic antarctic microorganism able to produce exopolysaccharides and exo-xylanolytic enzymes. In: Proceedings of the third Meeting on Antarctic Biology 13-15 December ,121, 1997. 20. T. Bisogno, S. Maurelli, D. Melck, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Biosynthesis, uptake and degradation of anandamide and palmitoylethanolamide in leukocytes. J. Biol. Chem., 272, 3315, 1997. 32. G. Corso, E. Trivellone, A. Motta, A. Postiglione, F. P. Mancini, V. Carbone and C. Napoli. Effect of Low Density Lipoprotein Fatty Acid composition on Copper-induced Peroxidation: 1H-Nuclear Magnetic Resonance Analysis. Clin. Chim. Acta, 258, 193, 1997. 21. L. De Petrocellis, D. Melck, N. Ueda, S. Maurelli, Y. Kurahashi, S. Yamamoto, G. Marino and V. Di Marzo. Novel inhibitors of brain, neuronal and basophilic anandamide amidohydrolase. Biochem. Biophys. Res. Comm., 231, 82, 1997. 22. V. Di Marzo and L. De Petrocellis. The endogenous cannabinoid system: chemistry, biochemistry and physiology. Internet J. Sci-Biol. Chem., 1, Location: http://www.netscijournal.com, 1997. 33. A. Evidente, O. Fierro, L. Sparapano, G. Bruno, F. Giordano and A. Motta. Sphaerodopsins B and C, Phytotoxic Piramane Diterpenes from Sphaeropsis Sapinea f. sp. Cupressi and Diplodia Mutila. Phytochemistry, 45, 705, 1997. 34. A. Motta, P. Amodeo, P. Fucile, M. A. Castiglione Morelli, B. Bremnes, and O. Bakke. A New Triple-Stranded α-Helical Bundle in Solution: the Assembling of the Cytosolic Tail of the MHC-Associated Invariant Chain. Structure, 5, 1453, 1997. 23. T. Bisogno, N. Sepe, L. De Petrocellis, R. Mechoulam and V. Di Marzo. The sleep inducing factor oleamide is produced by mouse neuroblastoma cells. Biochem. Biophys. Res. Comm., 239, 473, 1997. 35. S. De Rosa, A. De Giulio and G. Tommonaro. Triterpenoids and sterol glucoside from the cell cultures of Lycopersicon esculentum. Phytochemistry, 44, 861, 1997. 24. G. Caliendo, P. Grieco, E. Perissutti, V. Santagata, G. Saviano, T. Tancredi and P.A. Temussi. Conformational Analysis of three NK1 Tripeptide Antagonists. A 1H NMR Study. J. Med. Chem., 40, 594, 1997. 36. S. De Rosa, A. De Giulio, A. Crispino, C. Iodice and G. Tommonaro. Palinurin and fasciculatin sulfates from two Tyrrhenian sponges of the genus Ircinia. Nat. Prod. Lett., 10, 7, 1997. 25. C. Castellano, S. Cabib, A. Palmisano, V. Di Marzo and S. Puglisi-Allegra. The effects of anandamide on memory consolidation in mice involve both D1 and D2 dopamine receptors. Behav. Pharmacol., 8, 707, 1997. 37. S. De Rosa, A. Milone, A. Crispino, A. Jaklin and A. De Giulio. Absolute configuration of 2,6 dimethylheptyl sulfate and its distribution in Ascidiacea. J. Nat. Prod., 60, 462, 1997. 38. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice and G. Tommo- 125 naro. Cavernosolide, a new sesterterpene from a Tyrrhenian sponge. J. Nat. Prod., 60, 844, 1997. Observation of non- covalent interactions between beauvericin and oligonucleotides using electrospray ionization mass spectrometry. Rapid Comm. Mass Spectrom., 11, 265, 1997. 39. S. De Rosa, A. De Giulio, A. Crispino, C. Iodice and G. Tommonaro. Further bioactive sesterterpenes from the Tyrrhenian sponge Fasciospongia cavernosa. Nat. Prod. Lett., 10, 267, 1997. 52. F. Gentile, P. Ferranti, G. Mamone, A. Malorni and G. Salvatore. Identification of hormonogenic tyrosines in fragment 1218-1591 of bovine thyroglobulin by mass spectrometry. J. Biol. Chem., 272, 639, 1997. 40. R. Puliti, C. De Sena and C. Giancola. Crystal structures and melting thermodynamics of Nacetylsarcosinamide and N-acetyl-L-isoleucinamide. J. Thermal Anal., 48, 1249, 1997. 41. R. Puliti, C. A. Mattia, C. De Sena and G. Barone. N-acetyl-L-leucyl-glycinamide: X-ray structure, energy minimizzation and calorimetric determinations. J. Mol. Struct., 440, 10, 1997. 42. A. Soriente, A. Della Rocca, G. Sodano, A. Trincone. Chemoenzymatic synthesis of rengyoside -A, -B, isorengyoside and synthesis of their aglycones. Tetrahedron, 53, 4693, 1997. 43. Mirjana Gelo-Pujic, Eryka Guibè-Jampel, Andrè Loupy and A. Trincone. Enzymatic glycosidation in dry media under microwave irradiation. J.C.S. Perkin Trans I, 1001, 1997. 44. F. Canganella, W. J. Jones, A. Gambacorta and G. Antranikian. Biochemical and phylogenetic characterization of two novel deep-sea Thermococcus isolates with potential biotechnological applications. Arch. Microbiol., 167, 233, 1997. 45. V. T. Marteinsson, P. Moulin, J. L. Birrien, A. Gambacorta, M. Vernet, D. Prieur. Physiological responses to stress conditions and barophilic behavior of the hyperthermophilic vent archaeon Pyrococcus abyssi. Appl. Environ. Microbiol., 63, 1230, 1997. 46. A. Trincone. Synthesis of glycoconjugates catalyzed by thermophilic glycosidases. Biochemistry On-Line, Internet paper January 1997. http://biochem.arach-net.com/essays/trincone/title.html 47. P. Ferranti, N. Sannolo, G. Mamone, I. Fiume, V. Carbone, M. Tornqvist, A. Bergman and A. Malorni. Structural characterization by mass spectrometry of hemoglobin adducts formed after in vitro exposure to methyl bromide. Carcinogenesis, 17, 266, 1997. 48. P. Ferranti, N. Sannolo, G. Sindona, G. Mamone, K. Athanassopoulos, S. Cundari, G. Pocsfalvi and A. Malorni. Monitoring of human exposure to environmental xenobiotics by isotope dilution mass spectrometry. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 36, A142, 1997. 49. V. Carbone, A. Salzano, P. Pucci, I. Fiume, G. Pocsfalvi, N. Sannolo, G. Di Landa and A. Malorni. In vitro reactivity of the antineoplastic drug carmustin and acrolein with model peptides. Int. J. Peptide Protein Res., 49, 586, 1997. 50. P. Ferranti, G. Mamone, A. Malorni, N. Sannolo and G. Marino. Characterization of S-Nitrosohaemoglobin by mass spectrometry. Febs Lett., 400, 17, 1997. 51. G. Pocsfalvi, G. Di Landa, P. Ferranti, A. Ritieni, G. Randazzo and A. Malorni. 53. G. Pocsfalvi, A. Ritieni, P. Ferranti, G. Randazzo, K. Vèkey and A. Malorni. Microheterogeneity characterization of a paracelsin mixture from Trichoderma reesei using high-energy collision induced dissociation tandem mass spectrometry. Rapid Comm. Mass Spectrom., 11, 922, 1997. 54. P. Ferranti, G. Mamone, A. Malorni, J. Guardiola, P. Stiuso and S. Metafora. Structural heterogeneity, post-translational modifications and biological activities of SV-IV, a major protein secreted from the rat seminal vescicle epithelium. Rapid Comm. Mass Spectrom., 11, 1007, 1997. 55. P. Ferranti, F. Addeo, L. Chianese, A. Malorni, C. Leroux and P. Martin. Differential splicing of pre-messenger RNA produces multiple forms of caprine αs1-casein. Eur. J. Biochem., 249, 1, 1997. 56. P. Ferranti, E. Itolli, F. Barone, A. Malorni, G. Garro, G. Garro, P. Laezza, L. Chianese, F. Migliaccio, V. Stingo and F. Addeo. Combined high resolution separation techniques and mass spectrometry-based identification to monitor casein proteolysis. Le Lait, 77, 683, 1997. 57. L. Chianese, P. Laezza, P. Ferranti, Caira, F. Addeo and A. Malorni. The oligopeptides of sweet and acid cheese whey. Le Lait, 77, 699, 1997. 58. S. De Rosa. Da una spugna nuovi farmaci antiinfiammatori e antidolorifici. Ricerca e futuro, 4, 1997. 59. A. De Giulio e S. De Rosa. Il Mare: Fonte di nuovi farmaci. Biologi Italiani, 10, 1997. 60. M. Ruoppolo, P. Pucci, A. Malorni and G. Marino. Integration of mass spectrometry in bio-chemical research. Chimica e Industria, 79, 1041, 1997. ELENCO Anno 1998 1. A. Spinella, L. A. Alvarez and G. Cimino. Alkylphenols from the Cephalaspidean Mollusc Haminoea callidegenita. Tetrahedron Lett., 39, 2005, 1998. 2. Y. W. Guo, M. Gavagnin, C. Salierno and G. Cimino. Further Petroformynes from both Atlantic and mediterranean Populations of the Sponge Petrosia ficiformis. J. Nat. Prod., 61, 333, 1998. 3. Y. W. Guo, E. Trivellone, G. Scognamiglio and G. Cimino. Absolute Stereochemistry of Isosaraine-1 and Isosaraine-2. Tetrahedron Lett., 39, 463, 1998. 126 4. N. Sepe, L. De Petrocellis, F. Montanaro, G. Cimino, V. Di Marzo. Bioactive long chain N-acylethanolamines in five species of edible bivalve molluscs. Possible implications for mollusc physiology and sea food industry. Biochim. Biophys. Acta, 1389, 101, 1998. 5. A. Fontana, M.L. Ciavatta and G. Cimino. Cladocoran A and B: two Novel g-Hydroxybutenolide Sesterterpenes from the Mediterranean Coral Cladocora cespitosa. J. Org. Chem., 63, 2485, 1998. 6. Y. Guo, E. Trivellone, G. Scognamiglio and G. Cimino. Misenine, a Novel Macrocyclic Alkaloid with an Unusual Skeleton from the Mediterranean Sponge Reniera sp. Tetrahedron, 54, 541, 1998. 7. G. Cimino and T. Ghiselin. Chemical Defense and Evolution in the Sacoglossa (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia). Chemoecology, 8, 51, 1998. 8. K. Iken, C. Avila, M. L. Ciavatta A., Fontana, and G. Cimino. Hodgsonal, a new drimane sesquiterpene from the mantle of the Antarctic Nudibranch Bathydoris hodgsoni. Tetrahedron Lett., 39, 5635, 1998. 9. Y. W. Guo, M. Gavagnin, E. Mollo, E. Trivellone, G. Cimino. Structure of the pigment of the Red Sea Nudibranch Hexabranchus sanguineus. Tetrahedron Lett., 39, 2635, 1998. 10. A. Fontana, C. Muniain and G. Cimino. First Chemical Study of Patagonian Nudibranchs: a new seco-11,12spongiane, Tyrinnal, from the Defensive Organs of Tyrinna nobilis. J. Nat. Prod., 61, 1027, 1998. 11. V. Di Marzo. 2-Arachidonoyl-glycerol as an ‘endocannabinoid’: limelight for a formerly neglected metabolite. Biochemistry (Moscow), 63, 13, 1998. 12. V. Di Marzo, T. Bisogno, T. Sugiura, D. Melck and L. De Petrocellis. The novel endogenous cannabinoid 2-arachidonoylglycerol is inactivated by neuronal- and basophil-like cell: connections with anandamide. Biochem. J., 331, 15, 1998. 13. V. Di Marzo. Endocannabinoids and other fatty acid derivatives with cannabimimetic properties: biochemistry and possible physio-pathological relevance. Biochim. Biophys. Acta, 1392, 153, 1998. 14. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, T. Bisogno and D. Melck. Exogenous and endogenous cannabimimetic metabolites. La Chimica e l’Industria, 80, 323, 1998.. 15. L. De Petrocellis, D. Melck, A. Palmisano, T. Bisogno, C. Laezza, M. Bifulco and V. Di Marzo. The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast cancer cell proliferation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95, 8375, 1998. 16. T. Bisogno, K. Katayama, D. Melck, N. Ueda, L. De Petrocellis,S. Yamamoto and V. Di Marzo. Biosynthesis and degradation of bioactive fatty acid amides in human breast cancer and rat pheochromocytoma cells. Implications for cell proliferation and differentiation. Eur. J. Biochem., 254, 634, 1998. 17. S. Ben-Shabat, E. Fride, T. Sheskin, T. Tamiri, M.H. Rhee, Z. Vogel, T. Bisogno, L. De Petrocellis, V. Di Marzo and R. Mechoulam. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. Eur. J. Pharmacol., 353, 23, 1998. 18. V. Di Marzo, D. Melck, T. Bisogno and L. De Petrocellis. Endocannabinoids: endogenous cannabinoid receptor ligands with neuromodulatory action. Trends Neurosci., 21, 521, 1998. 19. T. Bisogno, D. Melck, L. De Petrocellis, M. Yu. Bobrov, N.M. Gretskaya, V.V. Bezuglov, N. Sitachitta, W.H. Gerwick and V. Di Marzo. Arachidonoylserotonin and other novel inhibitors of fatty acid amide hydrolase. Biochem. Biophys. Res. Comm., 248, 515, 1998. 20. V. Di Marzo, T. Bisogno, D. Melck, R. Ross, H. Brockie, L. Stevenson, R. Pertwee and L. De Petrocellis. Interactions between synthetic vanilloids and the endogenous cannabinoid system. FEBS Lett., 436, 449, 1998. 21. V.V. Bezuglov, M.Yu. Bobrov, N.M. Gretskaya, A.V. Archakov, I.V. Serkov, A.P. Fedenyuk, E.Yu. Verevochkina, G.S. Kogteva, O.Yu. Titova, D.M. Marvanov, L. De Petrocellis, T. Bisogno, V. Di Marzo and Y. Manevich. Arachidonoylethyleneglycol and its nitroester as new cannabimimetics: Oxydation by 15-lipoxygenase and hydrolysis by fatty acid amide hydrolase. Russian J. Biorg. Chem., 24, 833, 1998. 22. C. Laezza, V. Di Marzo and M. Bifulco. v-K-ras leads to preferential farnesylation pf p21ras in FRTL-5 cells: interference at multiple levels with the isoprenoid pathway. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95, 13646, 1998. 23. R. Mechoulam, E. Fride and V. Di Marzo. Endocannabinoids. Eur. J. Pharmacol., 359, 1, 1998. 24. V. Di Marzo and D.G. Deutsch. Biochemistry of the endogenous ligands of cannabinoid receptors. Neurobiol. Dis., 5, 386, 1998. 25. V. Di Marzo, N. Sepe, L. De Petrocellis, A. Berger, G. Crozier, E. Fride and R. Mechoulam. Trick or treat from food endocannabinoids? Nature, 396, 636, 1998. 26. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, T. Bisogno, D. Melck and N. Sepe. Cannabimimetic fatty acid derivatives: biosynthesis and catabolism. Proceedings of the Fourth International Congress on Essential Fatty Acids and Eicosanoids (R. A. Riemersma, R. Armstrong, R. W. Kelly and R. Wilkins eds.), AOCS Press, 358, 1998. 27. B. Nicolaus, R. Improta, M.C. Manca, L. Lama, E. Esposito, A. Gambacorta. Alicyclobacilli from an unexplored geothermal soil in Antarctica: Mount Rittmann. Polar Biology, 19, 133, 1998. 28. M.R. Faraone Menella, A. Gambacorta, B. Nicolaus, B. Farina. Purification and biochemical characterization of a poly(ADP-ribose) polymerase-like enzyme from the thermopìhilic archaeon Sulfolobus solfataricus. 127 Biochem J., 15, 335, 1998. 29. A. Scaloni, N. Miraglia, S. Orrù, P. Amodeo, A. Motta, G. Marino and P. Pucci. Topology of the Calmodulin-Melittin Complex. J. Mol. Biol., 277, 945, 1998. 30. A. Evidente, R. Capasso, A. Cutignano, O. Taglialatela Scafati, M. Vurro, M. C. Zonno and A. Motta. Ascaulitoxin, a Phytotoxic Bis-Amino Acid N-Glucoside from Ascochyta Caulina. Phytochemistry, 48, 1131, 1998. 31. A. Evidente, L. Sparapano, O. Fierro, G. Bruno, F. Giordano and A. Motta. Sphaeropsidone and Episphaeropsidone, Phytotoxic Dimedone Methyl Ethers Produced by Sphaeropsis Sapinea f. sp. Cupressi Grown in Liquid Culture. Phytochemistry, 48, 1139, 1998. 32. P. Amodeo, P. Fucile, M. A. Castiglione Morelli and A. Motta. The Cytosolic Tail of Invariant Chain is Able to Form Large Aggregates Whose Basic Unit is a Trimer. In: Peptides 1996, 201, 1998. R. Ramage and R. Epton Eds., Mayflower Scientific Ltd, Kingswinford, UK. 33. A. Motta, G. Andreotti, P. Amodeo, G. Strazzullo and M. A. Castiglione Morelli. Solution Structure of Human Calcitonin in Membrane-Mimetic Environment: the Role of the Amphipathic Helix. Proteins: Structure, Function, and Genetics, 15, 314, 1998. 34. M. Vurro, A. Evidente, A. Andolfi, M. C. Zonno, F. Giordano and A. Motta. Brefeldin A and α,β-Dehydrocurvularin, Main Phytotoxins from Alternaria Zinniae, a Biocontrol Agent of Xanthium Occidentale. Plant Sci., 138, 67, 1998. 35. S. De Rosa, A. De Giulio, G. Tommonaro and M.A. Belisario. Acylglucosyl-isofucosterols from cell cultures of Lycopersicon esculentum. Phytochemistry, 48, 103, 1998. 36. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice, G. Tommonaro and N. Zavodnik. A new dimethylscalarane derivative from the sponge Cacospongia scalaris. Tetrahedron, 54, 6185, 1998. 37. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice, R. Benrezzouk, M.C. Terencio, M.L. Ferrándiz, M.J. Alcaraz and M. Payá. A new cacospongionolide inhibitor of human secretory phospholipase A2 from a Tyrrhenian sponge Fasciospongia cavernosa and absolute configuration of cacospongionolides. J. Nat. Prod., 61, 931, 1998. 38. M.C. Terencio, M.L. Ferrándiz, I. Posadas, E. Roig, S. De Rosa, A. De Giulio, M. Payá and M.J. Alcaraz. Suppression of leukotriene B4 and tumour necrosis factor necrosis factor alpha release in acute inflammatory responses by novel prenylated hydroquinone derivatives. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol., 357, 565, 1998. Seasonal variations in the rate of photosynthetic activity and chemical composition of the seagrass Cymodocea nodosa (Ucr.) Asch. Scientia Marina, 62, 301, 1998. 41. R. Puliti, S. De Rosa and C.A. Mattia. Crystal structure of 4'-Methylamino avarone from Dysidea avara. Acta Cryst., C54, 1954, 1998. 42. R. Puliti, C.A. Mattia, C. De Sena and G. Barone. N-acetyl-L-prolyl-L-leucyl-glycinamide: X-ray structure, energy minimization and calorimetric determinations. J. Mol. Struct., 442, 1, 1998. 43. R. Puliti, C.A. Mattia and L. Paduano. Crystal structure of a new-a-cyclodextrin hydrate form. Molecular geometry and packing features: disordered solvent contribution. Carbohydr. Res., 310, 1, 1998. 44. P. Amodeo, G. Saviano, G. Borin, A. Calderan, P. Ruzza and T. Tancredi. Solution Conformational Analysis of Sodium Complexed [Gly6]and [Gly9]-Antamanide Analogs J. Peptide Res., 51, 180, 1998. 45. P. Amodeo, F. Naider, D. Picone, T. Tancredi and P.A. Temussi. Conformational Sampling of Bioactive Conformers: a Low Temperature NMR Study of 15N-Leu-enkephalin. J. Peptide Sci., 4, 253, 1998. 46. T. Tancredi, G. Saviano, C. Pedone, F. Rossi, M. Saviano, K. Ziegler, H. Kemmer, D. F. Mierke and G. Zanotti. Structure Activity Relationships of Cyclodecapeptides Inhibiting the Cholate Uptake in Hepatocytes. In: Peptides 1996, R. Ramage and R. Epton, Eds., Mayflower Scientific Ltd, Kingswinford, 821, 1998. 47. A. D'Ursi, S. Albrizio, T. Tancredi and P.A. Temussi. Environmental Constraints in the Study of Flexible segments of Proteins. J. Biomol. NMR, 11, 415, 1998. 48. G. Zanotti, M. Saviano, G. Saviano, T. Tancredi, F. Rossi, C. Pedone and E. Benedetti. Crystal and Solution Conformation of the Cyclo(Phe-Phe-Aib-LeuPro). J. Peptide Res., 51, 460, 1998. 49. A. Fontana, M. Ishibashi and J. Kobayashi. New polyketide peroxide from Okinawan Marine Sponge Plakortis sp Tetrahedron, 54, 2041, 1998. 50. A. Marin, M.D. Lopez, M.A. Esteban, J. Mesenguer, J. Munoz and A. Fontana. Anatomical and ultrastructural studies of chemical defence in the sponge Dysisdea fragilis. Marine Biology, 131, 639, 1998. 51. A. Fontana, M. Ishibashi, H. Shigemori and J. Kobayashi. New cyclic polyketide peroxide from Okinawan Marine Sponge Plakortis sp. J. Nat. Prod., 61, 1427, 1998. 39. A. Szallasi, T. Bíró, S. Modarres, L. Garlaschelli, M. Petersen, A. Klusch, G. Vidari, M. Jonassohn, S. De Rosa, O. Sterner, P.M. Blumberg and J. Krause. Dialdehyde sesquiterpenes and other terpenoids as vanilloids. Eur. J. Pharmacol., 356, 81, 1998. 52. A. Gambacorta, E. Pagnotta, I. Romano, G. Sodano and A. Trincone. Heterocyst glycolipids from nitrogen-fixing cyanobacteria other than Nostocaceae. Phytochemistry, 48, 801, 1998. 40. N. Zavodnik, A. Travizi and S. De Rosa. 53. S. L’Haridon, V. Cilia, P. Massner, G. Raguènes, A. Gambacorta, 128 U.B. Sleytr, D. Prieur and C. Jeanthon. Desulfurobacterium thermolithotrophum gen. nov., sp. nov., a novel autotrophic, sulphur-reducing bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent. Int. J. Syst. Bact., 48, 70, 1998. 54. F. Canganella, W.J. Jones, A. Gambacorta and G. Antranikian. Thermococcus guayamasensis sp. nov. and Thermococcus aggregans sp. nov., two novel thermophilic isolated from the Guayamas basin hydrothermal vent site. Int. J. Syst. Bact., 48, 1181, 1998. 55. M. Moracci, A. Trincone, G. Perugino, M. Ciaramella and M. Rossi. Restoration of the active site-site mutants of the hyperthermophilic βglycosidase from Sulfolobus solfataricus: dependence of the mechanism on the action of external nucleophiles. Biochemistry, 37, 17272, 1998. 56. G. Barone and R. Puliti. Correlation between phase transition thermodinamics and crystal features of small peptides. J. Thermal Analysis, 55, 249, 1998. 57. G. Pocsfalvi, F. Scala, A. Ritieni, G. Randazzo, M. Lorito, P. Ferranti, K. Vèkey and A. Malorni. Microheterogeneity Characterization of a Trichorzianine-A mixture from Trichoderma harzianum. J. Mass Spectrom., 33, 154, 1998. 58. G. Mamone, A. Malorni, A. Scaloni, N. Sannolo, A. Basile, G. Pocsfalvi and P. Ferranti. Analysis and Quantitative Evaluation of Modifications Produced in Human Hemoglobin by Methyl Bromide Using Mass Spectrometry and Edman Degradation. Rapid Comm. Mass Spectrom., 12, 1, 1998. 59. P. Ferranti, L. Chianese, A. Malorni, F. Migliaccio, V. Stingo and F. Addeo. The co-presence of deleted protein species generates the structural heterogeneity of ovine αs1-casein. J. Agr. Food Chem., 46, 411, 1998. 60. A. Scaloni, E. Pieragostini, A. Malorni, L. Ferrara and A. Di Luccia. Bovine hemoglobin α-globin chain polymorphism: primary structure determination of two new genetic variants by mass spectrometry and amino acid sequencing. Biochemie, 80, 333, 1998. 61. R. Improta e B. Nicolaus. Sistemi idrotermali ed origine della vita. Biologi Italiani, XXVIII, 15, 1998. 62. B. Nicolaus. Il servizio di produzione di biomassa. I Servizi Tecnico-scientifici dell’area di Ricerca di Napoli ed. G. Quagliarotti, F. Jannuzzi, 193, 1998. 63. M.R. Faraone-Mennella, A. Discenza, A. Gambacorta, B. Nicolus and B. Farina Modulation of the ADPribosylating activity in S. solfataricus by DNA and oligonucleotides J. Biol. Reguulat. Homeost. Agent 12, 133, 1998 ELENCO Anno 1999 1. A. Fontana, M. L.Ciavatta, P. Amodeo and G. Cimino. Single solution phase conformation of new antipoliferative cem- branes. Tetrahedron, 55, 1143, 1999. 2. A. Fontana, M. L. Ciavatta, T. Miyamoto, A. Spinella e G. Cimino. Biosynthesis of Drimane terpenoids in dorid molluscs: pivotal role of 7-deacetoxyolepupuane in two species of Dendrodoris nudibranchs. Tetrahedron, 55, 5937, 1999. 3. M. L. Ciavatta, A. Fontana, R. Puliti, G. Scognamiglio and G. Cimino. Structures and absolute sterochemistry of isocyanide and isothiocyanate amphilectenes from the Caribbean sponge Cribochalina sp. Tetrahedron, 55, 12629, 1999. 4. M. Gavagnin, A. De Napoli, F. Castelluccio and G. Cimino. Austrodorin-A and –B: first tricyclic diterpenoid 2’-monoglyceryl esters from an Antarctic nudibranch. Tetrahedron Lett., 40, 8471, 1999. 5. N. Ungur, M. Gavagnin, A. Fontana and G. Cimino. Absolute stereochemistry of natural sesquiterpenoid diacylglycerols. Tetrahedron: Asymmetry, 10, 1263, 1999. 6. A. Marin, L. A. Alvarez, G. Cimino and A. Spinella. Chemical defence in cephalaspideans: origin, anatomical location and ecological roles. J. Mol. Stud., 65, 121, 1999. 7. M. Gavagnin, A. De Napoli, G. Cimino, K. Iken, C. Avila and F. J. Garcia. Absolute configuration of diterpenoid diacylglycerols from the Antarctic nudibranch Austrodoris kerguelenensis. Tetrahedron: Asymmetry, 10, 2647, 1999. 8. N. Ungur, M. Gavagnin, E. Mollo and G. Cimino. Absolute stereochemistry of anisodorin 5. Tetrahedron: Asymmetry, 10, 1635, 1999. 9. A.Fontana, M. L. Ciavatta, E. Mollo, C. G. Naik, S. Wahidulla, L. D’Souza and G.Cimino. Volvatellin, caulerpenyne-related product from the sacoglossan Volvatella sp. J. Nat. Prod., 62, 931, 1999. 10. Y.W. Guo, M. Gavagnin, E. Mollo, E. Trivellone and G. Cimino. Three new butenolide lipids from the Caribbean gorgonian Pterogorgia anceps. J. Nat. Prod., 62, 1194, 1999. 11. A.Fontana, P. Cavaliere. N. Ungur, L. D’Souza, P. S. Parameswaram and G. Cimino. New scalaranes from the nudibranch Glossodoris atromarginata and its sponge prey. J. Nat. Prod., 62, 1367, 1999. 12. M. Gavagnin, N. Ungur, F. Castelluccio, C. Muniain and G. Cimino. New minor diterpenoid diacylglycerols from the skin of the nudibranch Anisodoris fontaini. J. Nat. Prod., 62, 269, 1999. 13. G. Cimino, A. Fontana and M. Gavagnin. Marine opisthobranch molluscs: chemistry and ecology in Sacoglossans and Dorids. Curr. Org. Chem., 3, 327, 1999. 14. G. Cimino and M. T. Ghiselin. Chemical defense and evolutionary trends in biosynthetic capacity among dorid nudibranchs (Mollusca: Gastropoda: Opisthobranchia). Chemoecology, 9, 187, 1999. 129 Nature, 400, 452, 1999. 15. F. Berrendero, N. Sepe, J.A. Ramos, V. Di Marzo and J.J. Fernandez-Ruiz. Analysis of cannabinoid receptor binding and mRNA expression and endogenous cannabinoid contents in the developing brain during late gestation and early postnatal period in rats. Synapse, 33, 181, 1999. 16. T. Bisogno, D. Melck, L. De Petrocellis and V. Di Marzo. Phosphatidic acid as the biosynthetic precursor of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol in intact mouse neuroblastoma cells stimulated with ionomycin. J. Neurochem., 72, 2113, 1999. 17. T. Bisogno, F. Berrendero, G. Ambrosino, M. Cebeira, J.A. Ramos, J.J. Fernandez-Ruiz and V. Di Marzo. Brain regional distribution of endocannabinoids: implications for their biosynthesis and biological function. Biochem. Biophys. Res. Comm., 256, 377, 1999. 18. V. Di Marzo. Biosynthesis and inactivation of ‘endocannabinoids’: relevance to their proposed role as neuromodulators. Life Sci., 65, 645, 1999. 19. L. De Petrocellis, D. Melck, T. Bisogno, A. Milone and V. Di Marzo. Finding of the endocannabinoid signalling system in Hydra, a very primitive organism: role in the feeding response. Neuroscience, 92, 377, 1999. 20. V. Di Marzo, T. Bisogno, L. De Petrocellis, D. Melck and B.R. Martin. Cannabimimetic fatty acid derivatives: the anandamide family and other ‘endocannabinoids’. Curr. Med. Chem., 6, 715, 1999. 21. D.M. Lambert and V. Di Marzo. The palmitoylethanolamide and oleamide enigmas: are these two fatty acid amides cannabimimetic. Curr. Med. Chem., 6, 739, 1999. 22. V. Di Marzo, L. De Petrocellis, T. Bisogno and D. Melck. Metabolism of anandamide and 2-arachidonoylglycerol: an historical overview and some recent developments. Lipids, 34, S319, 1999. 23. N. Ueda, K. Katayama, Y. Kurahashi, M. Suzuki, H. Suzuki, S. Yamamoto, I. Katoh, V. Di Marzo and L. De Petrocellis. Enzymological and molecular biological studies on anandamide amidohydrolase. Adv. Exp. Med. Biol., 469, 513, 1999. 24. S. Gonzalez, J. Manzanares, F. Berrendero, T. Wenger, J. Corchero, T. Bisogno, J. Romero, J.A. Fuentes, V. Di Marzo, J.A. Ramos and J.J. Fernandez-Ruiz. Identification of endocannabinoids and cannabinoid CB1 receptor mRNA in the pituitary gland. Neuroendocrinology., 70, 137, 1999. 25. V. Di Marzo, T. Bisogno, L. De Petrocellis, D. Melck, P. Orlando, J. A. Wagner and G. Kunos. Biosynthesis and inactivation of the endocannabinoid 2arachidonoylglycerol in circulating and tumoral macrophages. Eur. J. Biochem., 264, 258, 1999. 26. P.M. Zygmunt, J. Petersson, D.A. Andersson, H. Chuang, M. Sorgard, V. Di Marzo, D. Julius and E.D. Hogestatt. Vanilloid receptors on sensory nerves mediate the vasodilator action of the endocannabinoid anandamide. 27. D. Melck, T. Bisogno, L. De Petrocellis, H. Chuang, M. Bifulco, D. Julius and V. Di Marzo. Unsaturated long chain N-acyl-vanillyl-amides (N-AVAMs). Vanilloid receptor ligands that inhibit anandamide facilitated transport and bind to CB1 cannabinoid receptors. Biochem. Biophys. Res. Comm., 262, 275, 1999. 28. T. Bisogno, I. Vandenbroucke, A. Milone, M. Lagarde and V. Di Marzo. Biosynthesis and inactivation of N-arachidonoyl-ethanolamine (anandamide) and N-docosahexanoyl-ethanolamine in bovine retina. Arch. Biochem. Biophys., 370, 300, 1999. 29. D. Melck, D. Rueda, I. Galve-Roperh, L. De Petrocellis, M. Guzman and V. Di Marzo. Inhibition of the cAMP/protein kinase A pathway and stimulation of mitogen-activated protein kinase underlie the anti-proliferative effects of anandamide in human breast cancer cells. FEBS Lett., 463, 235, 1999. 30. P. Amodeo, A. Motta, G. Strazzullo, and M. A. Castiglione Morelli. Conformational Flexibility in Calcitonin: the Dynamic Properties of Human and Salmon Calcitonin in Solution. J. Biomolec. NMR, 13, 161, 1999. 31. A. Evidente, L. Sparapano, O. Fierro, G. Bruno and A. Motta. Sapinofuranones A and B, Two New 2(3H)-Dihydrofuranones Produced by Sphaeropsis Sapinea, a Common Pathogen of Conifers. J. Nat. Prod., 62, 253, 1999. 32. R. Lamanna, A. Motta, R. Romano, G. Rainaldi, F. Flamma, M. Pentimalli, T. Tancredi, P. L. Indovina and M. T. Santini. Forced Adhesive Growth of K562 Leukemic Cells that Normally Grow in Suspension Induces Variations in Membrane Lipids and Energy Metabolism: A Proton NMR Study. J. Biomed. Mat. Res., 46, 171, 1999. 33. A. Evidente, A. H. Abou-Donia, F. A. Darwish, M. E. Amer, F. F. Kassem, , H.A.M. Hammoda and A. Motta. Nobilisitine A and B, Two Masanane-Type Alkaloids from Clivia Nobilis. Phytochemistry, 51, 1151, 1999. 34. B. Nicolaus, L. Lama, MC Manca, A. Gambacorta. Extremophiles: Polysaccharides and enzymes degrading polysaccharides Recent Res. Devel. Biotech. and Bioeng., 2, 37, 1999. 35. B. Nicolaus, A. Panico, L. Lama, I.Romano, MC Manca, A. De Giulio, A. Gambacorta. Chemical composition and production of exopolysaccharides from representative members of heterocystous and non-heterocystous cyanobacteria. Phytochemistry, 52, 639, 1999. 36. B. Nicolaus, L. Lama, E. Esposito, MC Manca, R. Improta, MR Bellitti, AW Duckworth, WD Grant and A. Gambacorta. Haloarcula spp able to biosynthesize exo-and endopolymers. J. Ind. Microbiol. Biotech., 23(6), 489, 1999. 37. P.G. Pastor, S. De Rosa, A. De Giulio, M. Payá and M.J. Alcaraz. Modulation of acute and chronic inflammatory processes by cacospongionolide B, a novel inhibitor of human synovial phospholipase A2. Br. J. Pharmacol., 126, 301, 1999. 130 38. S. De Rosa, A. De Giulio, A. Crispino, C. Iodice and G. Tommonaro. New 9,11-secosterol from the Tyrrhenian sponge Fasciospongia cavernosa. Nat. Prod. Lett., 13, 15, 1999. 39. S. De Rosa, A. Milone, S. Popov and St. Andrev. Sterol composition of the Black Sea Hydrozoan, Obelia longissima (Pallas 1766). Comp. Biochem. Physiol., 123B, 229, 1999. 40. S. De Rosa, A. Milone and S. Popov. Sterol composition of the sponge Fasciospongia cavernosa, collected from Adriatic, Aegean and Tyrrhenian Seas. Comp. Biochem. Physiol., 123B, 235, 1999. 41. S. De Rosa, C. Iodice, M. Khalaghdoust, S. Oryan and A. Rustaiyan. Spatane diterpenoids from the brown alga Stoechospermum marginatum (Dictyotaceae). Phytochemistry, 51, 1009, 1999. 42. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice, P. Amodeo and T. Tancredi. A new cacospongionolide derivative from the sponge Fasciospongia cavernosa. J. Nat. Prod., 62, 1316, 1999. 43. S. De Rosa, A. Crispino, A. De Giulio, C. Iodice, G. Tommonaro, R. Pronzato and M. Sidri. A novel C21 terpene lactone from the sponge Fasciospongia cavernosa. Tetrahedron, 55, 13805, 1999. 44. G. Barone and R. Puliti. Correlation between phase transition thermodynamics and crystal features of solid small peptides. J. Thermal Anal. Cal., 57, 119, 1999. 45. R. Puliti and C.A. Mattia. ent-Isocopal-12-ene-15,16-dialdehyde from Spongia officinalis. Acta Cryst., C55, 2160, 1999. 46. P. Ruzza, A. Calderan, B. Biondi, M. Carrara,T. Tancredi and G. Borin. Ion-Binding and Pharmacological Properties of Tyr6 and Tyr9 Antamanide Analogs. J. Peptide Res., 53, 442, 1999. 47. R. Spadaccini, O. Crescenzi, D. Picone, T. Tancredi and P.A. Temussi. Conformational Analysis in Solution Structure of Dynorphin A (117): a NMR Study in a Cryoprotective Solvent Mixture at 278 K. J. Peptide Sci., 5, 306, 1999. 48. G. Saviano, O. Crescenzi, D. Picone, P.A. Temussi and T. Tancredi. Solution Structure of Human -Endorphin in Helicogenic Solvents: An NMR Study. J. Peptide Sci., 5, 410, 1999. 49. E. Benedetti, C. Pedone, F. Rossi, M. Saviano, T. Tancredi and G. Zanotti. Structure-Activity Studies of Cyclolinopeptide A: Inhibitor, Immunosuppressant or Else? In: Perspectives in Structural Biology. A volume in honour of G.N. Ramachandran, M.Vijayan, N. Yathindra and A.S. Kolaskar, Eds. Universities Press, 496, 1999. 50. A. Fontana, I. Fakhr, E. Mollo and G. Cimino. (-)Wistarin from the marine sponge Ircina sp.: the first case of enantiomeric sesterteepenes. Tetrahedron: Asymmetry, 10, 3869, 1999. 51. A. Valdes, E. Mollo and J. Ortea. Two new species of Chromodoris (Mollusca, Nudibranchia, Chromodorididae) from Southern India, with a redescription of Chromodoris trimarginata (Winckworth, 1946). Proceed. of the California Acad. of Sciences, 51, 461, 1999. 52. S. De Stefano, R. Nicoletti, A. Milone, S. Zambardino. 3-O-methylfunicone, a fungitoxic metabolite produced by the fungus Penicillium pinophilum. Phytochemistry, 52, 1399, 1999. 53. S. De Stefano, R. Nicoletti. Isolamento dell’acido 2-metil-4-idrossibenzoico estere metilico dal fungo Penicillium pinophilum. Suo possibile ruolo nella biogenesi dei composti a scheletro funiconico. Il Tabacco, 7, 25, 1999. 54. S. De Stefano, R. Nicoletti. Pachibasina e crisofanolo, due antrachioni prodotti dal fungo Trichoderma aureoviride. Il Tabacco, 7(2), 21, 1999. 55. V.T. Marteinsson, J.L. Birrien, A.L. Reysenbach, M. Vernet, M. Domonique, A. Gambacorta, P. Messner, U.B. Sleytr and D. Prieur. Thermococcus barophilus sp. nov., a new barophilic and hyperthermophilicarchaeon isolated under high hydrostatic pressure from a deep-sea hydrothermal vent. Int. J. Sys. Bacteriol., 49, 351, 1999. 56. M.R. Faraone Mennella, A. Discenza, A. Gambacorta, B. Nicolaus and B. Farina. Structural analysis of the ADP-ribosylating enzyme from Sulfolobus solfataricus. J. Biol. Regulat Homeost Agent, 13, 257, 1999. 57. A. Gambacorta, A. Trincone, A. Soriente and G. Sodano. Chemistry of glycolipids from the heterocysts of nitrogen-fixing cyanobacteria. Curr. Top. in Phytochemistry, 2, 145, 1999. 58. M. Moracci, G. Perugino, A. Trincone, M. Ciaramella and M. Rossi. Protein engineering of the β-glycosidase from the hyperthermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus: mechanism of glycoside hydrolysis. In: Rec. Advan. in Carbohydr. Engin., eds.by H.J. Gilbert, G. Davies, B. Henrissat, B. Svensson Royal Society of Chemistry, 25, 1999. 59. A. Di Maro, P.Valbonesi, A. Bolognesi, F. Stirpe, P. De Luca, G. Siniscalco Gigliano, L. Gaudio, P. Delli Bovi, P. Ferranti, A. Malorni and A. Parente. Isolation and characterization of four type-1 ribosome-inactivating proteins, with polynucleotide: adenosine glycosidase activity, from leaves of phytolacca dioica L. Planta, 208, 125, 1999. 60. N. Sannolo, G. Mamone, P. Ferranti, A. Malorni and A. Basile. Biomonitoring of Human Exposure to Methyl Bromide by Isotope Dilution Mass Spectrometry of Peptide Adducts. J. Mass Spectrom., 34, 1028, 1999. 61. G. Mamone, N. Sannolo, A. Malorni and P. Ferranti. In vitro formation of S-nitrosohemoglobin in red cells by inducible nitric oxide synthase. FEBS Lett., 462, 241, 1999. 131 62. A. Scaloni, P. Ferranti,G. De Simone, G. Mamone, N. Sannolo and A. Malorni. Probing the reactivity of nucleophilic residues in human 2,3diphosphoglycerate/deoy-hemoglobin complex by aspecific chemical modifications. FEBS Lett., 452, 190, 1999. 63. A. Malorni, P. Ferranti, N. Miraglia, A. Acampora, M. Biglietto and N. Sannolo. Monitoraggio biologico dell’esposizione a cancerogeni: il ruolo innovativo della spettrometria di massa. In: Esposizione ad agenti genotossici – Valutazione del rischio verso un approccio globale alla tutela della salute a cura di G. Castello. Ed. Scient. Cuzzolin, 204, 1999. ELENCO Anno 2000 1. A. Fontana, M.C. Gonzalez, M. Gavagnin, J. Templado and G. Cimino. Structure and absolute stereochemistry of stolonoxide A, a novel cyclic peroxide from the marine tunicate Stonolica socialis. Tetrahedron Lett., 41, 429, 2000. 2. A. Fontana, G. Villani and G. Cimino. Terpene biosynthesis in marine molluscs: incorporation of glucose in drimane esters of Dendrodoris nudibranchs via classical mevalonate pathway. Tetrahedron Lett., 41, 2429, 2000. 3. N. Ungur, M. Gavagnin, A. Fontana and G. Cimino. Synthetic studies on natural diterpenoid glyceryl esters. Tetrahedron, 56, 2503, 2000. 4. A. Fontana, E. Mollo, J. Ortea, M. Gavagnin and G. Cimino. Scalarane and homoscalarane compounds from the nudibranchs Glossodoris sedna and Glossodoris dalli: chemical and biological properties. J. Nat. Prod., 63, 527, 2000. 5. D. Melck, L. De Petrocellis, P. Orlando, T. Bisogno, C. Laezza, M. Bifulco, and V. Di Marzo. Suppression of trk and prolactin receptor levels by endocannabinoid leads to inhibition of human breast and prostate cancer cell proliferation. Endocrinology, 141, 118, 2000. 6. P.M. Zygmunt, D. Julius, V. Di Marzo and E. Hogestatt. Anandamide the other side of the coin. Trends Pharmacol. Sci., 21, 43, 2000. 7. V. Di Marzo, M.P. Hill, T. Bisogno, A.R. Crossman and J.B. Brotchie. Enhanced levels of endogenous cannabinoids in the globus pallidus are associated with a reduction in movement in an animal model of Parkinson’s disease. FASEB J., 14, 1432, 2000. 8. V. Di Marzo, F. Berrendero, T. Bisogno, S. Gonzalez, P. Cavaliere, J. Romero, M. Cebeira, J.A. Ramos and J.J. Fernandez-Ruiz Enhancement of anandamide formation in the limbic forebrain and reduction of endocannabinoid contents in the striatum of ∆ 9tetrahydrocannabinol-tolerant rats. J. Neurochem., 74, 1627, 2000. 9. V. Di Marzo, D. Melck, L. De Petrocellis and T. Bisogno. Cannabimimetic fatty acid derivatives in cancer and inflammation. Prostagl. Other Lipid Mediat., 61, 43, 2000. 10. V. Di Marzo, T. Bisogno and L. De Petrocellis. Endocannabinoids: new targets for drug development. Curr. Pharm. Design, 6, 1361, 2000. 11. L. Longobardo, D. Melck, R. Siciliano, A. Santini, V. Di Marzo and G. Cammarota. β-Casomorphins: substitution of phenylalanine with β-homophenylalanine increases the µ-type opioid receptor affinity. Bioorg. Med. Chem. Lett., 10, 1185, 2000. 12. P. Beaulieu, T. Bisogno, S. Punwar, W. P. Farquhar-Smith, G. Ambrosino, V. Di Marzo and A.S.C. Rice. Role of the endogenous cannabinoid system in the formalin test of persistent nociception in the rat. Eur. J. Pharmacol., 396, 85, 2000. 13. S. Gonzalez, T. Bisogno, T. Wenger, J. Manzanares, A. Milone, F. Berrendero, V. Di Marzo, J.A. Ramos and J. Fernandez-Ruiz. Sex steroid influence on CB1 receptor mRNA and endocannabinoid levels in the anterior pituitary gland. Biochem. Biophys. Res. Comm., 270, 260, 2000. 14. M. Maccarrone, M. Bari, T. Lorenzon, T. Bisogno, V. Di Marzo and A. Finazzi-Agro’. Anandamide uptake by human endothelial cells and its regulation by nitric oxide. J. Biol. Chem., 275, 13484, 2000. 15. V. Di Marzo. Regulation of endocannabinoid levels under physiological and pathological conditions. A mini-review. Pharm. Pharmacol. Comm., 6, 235, 2000. 16. B. R. Martin, I. Beletskaya, G. Patrick, R. Jefferson, R. Winckler, D. G. Deutsch, V. Di Marzo, O. Dasse, A. Mahadevan and R.K. Razdan. Cannabinoid properties of methylfluorophosphonate analogs. J. Pharm. Exp. Ther., 294, 1209, 2000. 17. V. Di Marzo, C. Breivogel, T. Bisogno, D. Melck, G. Patrick, Q. Tao, A. Szallasi, R.K. Razdan and B.R. Martin. Neurobehavioral activity in mice of N-vanillyl-arachidonyl-amide (arvanil). Eur. J. Pharmacol., 408, 363, 2000. 18. L. De Petrocellis, D. Melck, T. Bisogno and V. Di Marzo. Endocannabinoids and fatty acid amides in cancer, inflammation and related disorders. Chem. Phys. Lipids, 108, 191, 2000. 19. V. Di Marzo, M. Bifulco and L. De Petrocellis. Endocannabinoids and multiple sclerosis: a blessing from the ‘inner bliss’? Trends Pharmacol. Sci., 21, 195, 2000. 20. V. Di Marzo, C.S. Breivogel, Q. Tao, D.T. Bridgen, R.K. Razdan, A.M. Zimmer, A. Zimmer and B.R. Martin. Levels, metabolism and pharmacological activity of anandamide in CB1 receptor knockout mice. Evidence for non-CB1, non-CB2 receptor-mediated actions of anandamide in mouse brain. J. Neurochem., 75, 2434, 2000. 21. M. Salzet, C. Breton, T. Bisogno and V. Di Marzo. Comparative biology of the endocannabinoid system. Possible role in the immune response. Eur. J. Biochem., 267, 4917, 2000. 22. T. Bisogno, D. Melck, Y. Bobrov, L. De Petrocellis, N.M. Gretskaya, V.V. Bezuglov and V. Di Marzo. N-acyl-dopamines: novel synthetic CB1 cannabinoid receptor ligands and inhibitors of anandamide inactivation with cannabimimetic activ- 132 ity in vitro and in vivo. Biochem. J., 351, 817, 2000. rivale. Phytochemistry, 54, 751, 2000. 23. A. Szallasi and V. Di Marzo. New perspectives on enigmatic vanilloid receptors. Trends Neurosci., 23, 491, 2000. 35. S. De Rosa, A. De Giulio, G. Tommonaro, S. Popov and A. Kujumgiev. A β-amino acid containing tripeptide from a Pseudomonas/ Alteromonas bacterium associated with a Black Sea sponge. J. Nat. Prod., 63, 1454, 2000. 24. L. De Petrocellis, T. Bisogno, J.B. Davis, R.G. Pertwee and V. Di Marzo. Overlap between the ligand recognition properties of the anandamide transporter and the VR1 vanilloid receptor: first inhibitors of anandamide uptake with negligible capsaicin-like activity. FEBS Lett., 483, 52, 2000. 25. O. Dasse, A. Mahadevan, L. Han, B.R. Martin, V. Di Marzo and R.J. Razdan. The synthesis of N-vanillyl-arachidonoyl-amide (arvanil) and its analogues: an improved procedure for the synthesis of the key synthon methyl-14-hydroxy-(all-cis)-5,8,11tetradecatrienoate. Tetrahedron, 56, 9195, 2000. 26. A. Evidente, A. Andolfi, Vurro, M. C. Zonno and A. Motta. Trans-4-Aminoproline, a Phytotoxic Metabolite with Potential Herbicide Activity Produced by Ascochyta Caulina Phytochemistry, 53, 231, 2000. 27. A. Evidente, L. Sparapano, A. Andolfi, G. Bruno, F. Giordano and A. Motta. Chlorosphaeropsidone and Epichlorosphaeropsidone, two new chlorinated dimedone methyl ethers isolated from liquid cultures of Sphaeropsis sapinea f. sp. Cupressi. Phytopathol. Medit., 39, 299, 2000. 28. A. Evidente and A. Motta. Phytotoxins Produced by Fungi Pathogenic for Agrarian, Forestall and for Weedy Plants. In: Bioactive Natural Products: Isolation, Structure Elucidation and Biology Properties, C. Tringali, Ed. Taylor and Francis, London., 473, 2000. 29. G. Andreotti, E. Trivellone, R. Lamanna, A. Di Luccia, and A. Motta. Milk Identification of Different Species:13C Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy of Triacylglycerols from Cows and Buffaloes’ Milks. J. Dairy Sci., 83, 2432, 2000. 30. A. Soriente, A. Crispino, M. De Rosa, S. De Rosa, A. Scettri, G. Scognamiglio, R. Villano and G. Sodano. Stereochemistry of antiinflammatory marine sesterterpenes. Eur. J. Org. Chem., 947, 2000. 31. S. De Rosa, A. Milone, A. Kujumgiev, K. Stefanov, I. Nechev and S. Popov. Metabolites from a marine bacterium Pseudomonas/ Alteromonas, associated with the sponge Dysidea fragilis. Comp. Biochem. Physiol., 126B, 391, 2000. 32. S. De Rosa, M. Mitova, N. Handjieva, S. Popov and M. Anchev. Rivaloside A and B, two 19-oxo triterpenoid saponins from Galium rivale. J. Nat. Prod., 63, 1012, 2000. 33. W.E.G. Müller, M. Böhm, R. Batel, S. De Rosa, G. Tommonaro, I. M. Müller and H. C. Schröder. Application of cell culture for the production of bioactive compounds from sponges: synthesis of avarol by primmorphs from Dysidea avara. J. Nat. Prod., 63, 1077, 2000. 34. S. De Rosa, C. Iodice, M. Mitova, N. Handjieva, S. Popov and M. Anchev. Triterpenoid saponins and iridoid glucosides from Galium 36. I. Posadas, M.C. Terencio, S. De Rosa and M. Payá. Cavernolide a new inhibitor of human sPLA2 sharing unusual chemical features. Life Sciences, 67, 3007, 2000. 37. M.R. Faraone Mennella, A. Discenza, P. De Luca, S. Castellano, A. Gambacorta, B. Nicolaus and B. Farina. Structural analysis of the ADP ribosylating enzyme from Sulfolobus solfataricus. The Journal of Biological Regulators and Homeostatic agents. Wichtig ed., 257, 2000. 38. I. Romano, M.R. Bellitti, B. Nicolaus, L. Lama, M.C. Manca, E. Pagnotta, A. Gambacorta. Lipid profile: a useful chemotaxonomic marker for classification of a new cyanobacterium in Spirulina genus. Phytochemistry, 54, 289, 2000. 39. B. Nicolaus, A. Panico, M. C. Manca, L. Lama, A. Gambacorta, T. Maugeri, C. Gugliandolo and D. Caccamo. A thermophilic Bacillus isolated from an eolian shallow hydrothermal vent, able to produce exopolysaccharides. Syst. Appl. Microbiol., 23, 426, 2000. 40. B. Nicolaus, L. Lama, E. Esposito, M.R. Bellitti, R. Improta, A. Panico, A. Gambacorta. Extremophiles in Antarctica. Ital. J. Zool., 1, 169, 2000. 41. M.R. Faraone Mennella, A. Discenza, P. De Luca, S. Castellano, A. Gambacorta, B. Nicolaus and B. Farina. Comparison of ADP-ribosylating thermozyme from Sulfolobus solfataricus and the mesophilic poly(ADP-ribose) polymerases. Fems Microb.Lett., 192, 9, 2000. 42. R. Puliti and C.A. Mattia. Conformational stability of avarol-type molecules. Crystal structure of 3’-Methylamino-avarone, a metabolite from Dysidea avara. J. Mol. Struct., 516, 31, 2000. 43. R. Puliti and C.A. Mattia. Ammonium N-acetyl-L-threoninate and methylammonium N-acetylL-threoninate. Acta Cryst., C56, 496, 2000. 44. R. Puliti, C.A. Mattia, C. Giancola and G. Barone. Crystal structure and conformational stability of N-acetyl-L-prolyl-L -leucinamide. Comparison between structural and thermophysical data. J. Mol. Struct., 553, 117, 2000. 45. O. Crescenzi, R. Guerrini, D. Picone, S. Salvadori, T. Tancredi and P.A. Temussi. Solution Structure of Nocistatin, a New Peptide Analgesic. Biopolymers, 53, 257, 2000. 46. P. Amodeo, B. López Méndez, R. Guerrini, S. Salvadori, P.A. Temussi and T. Tancredi. Pain Peptides: Solution Structure of OrphaninFQ2. Febs Lett., 473, 157, 2000. 133 47. P. Amodeo, M.A. Castiglione morelli, P. Fucile, G. Strazzullo, M. Gautel and A. Motta. Kinase Recognition by Calmodulin: Modeling the Interaction with the Autoinhibitory Region of Human Cardiac Titin Kinase. J. of Mol. Biol., 306, 81, 2000. 48. C. Avila, K. Iken, A. Fontana and G. Cimino. Chemical ecology of the Antartic nudibranch Bathydoris hodgsoni Eliot, 1907: defensive role and origin of its natural products. J. of Exper. Marine Biol. and Ecol., 252, 27, 2000. 49. M.R. Faraone Mennella, A. Discenza, A. Gambacorta, B. Nicolaus and B. Farina. Purification of the ADPribosylating enzyme from Solfulobus solfataricus by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and electroelution. Prepar. Biochem. and Biotec., 30, 61, 2000. 50. A. Fontana, P. Cavaliere, S. Wahidulla, G.N. Chandrakant and G. Cimino. A new antitumor isoquinoline alkaloid from the marine nudibranch Jorunna funebris. Tetrahedron, 56, 7305, 2000. 51. A. Fontana, R. Messina, A. Spinella, G. Cimino. Simple and versatile synthesis of branched polyols: (+)-2-Cmethylerythritol and (+)-2-C-methylthreitol. Tetrahedron Lett., 41, 7559, 2000. 52. G. Pòcsfalvi, A. Malorni, I. Mancini, G. Guella and F. Pietra. Molecular Characterization of a Highly Heterogeneous Mixture of Glucosylceramides from a Deep-water mediterranean Scleractinian Coral. Rapid Comm. in Mass Spectr., 14, 2247, 2000. 53. G. Pòcsfalvi, A. Ritieni, G. Randazzo, A. Dobò and A. Malorni. Interaction of Fusarium Mycotoxins, Fusaproliferin and Fumonisin B1, with DNA Studies by Electrospray Ionization Mass Spectrometry. J. of Agric. and Food Chem., 48, 5794, 2000. 54. M. Gavagnin, A. Fontana. Diterpenes from marine opisthobranch molluscs. Curr. Org. Chem., 5, 1201, 2000. 55. M. Gavagnin, A. Fontana, M.L. Ciavatta and G. Cimino. Chemical studies on Antarctic nudibranch molluscs. It. J. of Zool., Sup.1, 101, 2000. 56. M. Gavagnin, E. Mollo, D. Montanaro, J. Ortea and G. Cimino. Chemical studies of Carribean sacoglossans: dietary relationships with green algae and ecological implications. J. of Chem. Ecol., 26, 1563, 2000. 57. V. Kulcitki, N. Ungur, P.F. Vlad, M. Gavagnin, F. Castelluccio and G. Cimino. Superacidic cyclization of all-trans-ω-acetoxyfarnesol benzyl ether. Synt.-Stuttgart, 3, 407, 2000. 58. M. Moracci, B. Ponzano, A. Trincone, A. Fusco, S. De Rosa, M. van der Oost, J. Sensen, C.W. Cherlebois R. L., M. Rossi. Identification and molecular characterization of the first alphaxylosidase from an archaeon. J. of Biol. Chem., 29, 22082, 2000. 59. M.T. Santini, R. Romano, G. Rainaldi, P. Filippini, E. Bravo, L. Porcu, A. Motta, A. Calcabrini, S. Meschini, P.L. Indovina and G. Arancia. The Relationship Between 1H-NMR Mobile Intensity and Cholesterol in two Human Tumor Multidrug Resistent Cell Lines (MCF-7 and LoVo). Biochim. et Biophis. Acta, 1531, 111, 2000. 60. A. Trincone, G. Perugino, M. Rossi, M. Moracci. A Novel thermophilic glycosynthase which effects branching glycosylation. Bioorg. and Med. Chem. Lett., 10, 365, 2000. 61. F. Canganella, A. Gambacorta, C. Kato, K. Horikoshi. Effects of hydrostatic pressure and temperature on physiological traits of Thermococcus guayamasensis and Thermococcus aggregans growing on starch. Microb. Res., 154, 297, 2000. 62. A. Trincone, M. Moracci, M. Rossi. Glicosintasi: nuovi enzimi per la sintesi degli oligosaccaridi. Biotec, 1, 53, 2000. 63. G. Cimino, M.L. Ciavatta, A. Fontana and M. Gavagnin Metabolites of marine opistobranchs: chemistry and biological activity. In: Bioactive Natural Products: Isolation, Structure Elucidation and Biology Properties, C. Tringali, Ed. Taylor and Francis, London., 578, 2000. 134 Tesi di Laurea Numerose tesi di laurea sono state svolte nei laboratori sotto la guida dei ricercatori nei vari reparti. L’elenco che segue può essere parziale. Anche la lettura dei titoli, come è naturale, è un percorso scientifico di trenta anni di attività dell’Istituto. Isolamento e struttura dell’aeroplysinina-1, un nuovo bromocomposto isolato dalla spugna Aplysina aerophoba F. Cafieri Giugno 1970 Feomelanine ed eumelanine da nuove fonti naturali O. Porcelli Giugno 1970 Modelli sintetici in relazione alla struttura delle feomelanine G. Martone Giugno 1970 Biogenesi delle feomelanine S. Forenza Giugno 1970 Struttura della nitenina e della diidronitenina, due nuovi furanoterpeni isolati dalla Spongia nitens L. Forte Ottobre 1970 Sulla strutura e sul meccanismo di azione del fitocromo M. Misitano a.a. 69-70 Caratterizzazione di un bacillo termo –acidofilo e analisi dei componenti lipidici: isolamento, struttura e biosintesi degli acidi grassi omega—cicloesilici D. Capurso a.a. 70-71 Isolamento di alcuni derivati prenilici della spugna Ircinia spinosula e determinazione della loro struttura E. Bianco Dicembre 1971 Sui furanoterpeni presenti in più piccola quantità nelle spugne Spongia officinalis e Hippospongia communis E. Mancusi Dicembre 1971 Nuovi sesquiterpeni dalla spugna Pleraplysilla spinifera A. Giliberti a.a. 71-72 Isolamento di due nuovi sesterterpeni lineari dalla spugna Ircinia oros e determinazione della loro struttura P. Abrescia Marzo 1972 Isolamento del 2-tetraprenil-1,4-benzochinone, dal corrispondente idrochinone e dell’acido 3-tetraprenil-4ossibenzoioco dalla spugna Ircinia muscarum M. Lignitto Marzo 1972 Steroli con una insolita catena laterale isolati dalla spugna Aplysina (=Verongia) aerophoba P. De Luca Luglio 1972 Struttura della aeroplysinina-2, un dibromolattone isolato dalla spugna Aplysina (=Verongia) aerophoba A. Lama Luglio 1972 Nuovi bromocomposti isolati dalla spugna Agelas oroides R. Riccio Luglio 1972 Sesquiterpeni isonitrilici dalla spugna Acanthella acuta W. Taccone Dicembre 1972 135 Produzione, isolamento e caratterizzazione di amilasi da Bacillus acidocaldarius C. Caporale a.a. 72-73 Isoagatolattone, un diterpene naturale con uno scheletro nuovo D. De Rosa Marzo 1973 ...è stata definita la struttura dell’avarolo da Dysidea avara con un cospicuo lavoro chimico e spettroscopico; attualmente è in corso di investigazione attiva la stereochimica...Rapporto di attività 1974 Avarolo HO Distribuzione di steroli a scheletro aplystanico in alcune spugne marine A. Montefusco Marzo 1973 OH Nuovi sesquiterpeni dalla spugna Pleraplysilla spinifera A. Giliberti Giugno 1973 Isolamento e struttura dell’avarolo, insolito sesquiterpenoide della spugna Dysidea avara S. De Rosa Luglio 1974 Nuovi furanosesquiterpeni da spugne marine A. Guerriero Luglio 1974 Specificità nella biosintesi degli acidi grassi da Bacillus acidocaldarius G. Grasso 1974 3-Alchil e 3-Alchenil-pirrol-2-aldeidi dalla spugna marina Oscarella labularis M. Pomposelli 1975 Alcuni aspetti del metabolismo degli steroli nelle spugne. Biosintesi dei 19-nor-steroli e 3-β-idrossimetil-A-norsteroli nella Axinella polypoides e Axinella verrucosa G. Amato 1975 Isolamento e caratterizzazione di un microorganismo estremamente termoacidofilo. Fisiologia e morfologia. C. Principie 1975 Analisi dei componenti lipidici del Bacillus acidocalcarius biogeneticamente relazionati all’acido mevalonico: isolamento e biosintesi degli isoprenoidi E. Sepe a.a. 74-75 Un’inducibile α-amilasi da Bacillus acidocaldarius A. Abruzzese Saccardi 1975 Biosintesi del calysterol nella spugna Calyx nicaensis O. Scalona Dicembre 1976 12-Episcalarina e 12-epideoxoscalarina, due nuovi sesterterpeni dalla spugna Spongia nitens L. Sansone Dicembre 1976 Sulla struttura di due sesterterpenoidi ossiidrochinonici isomerici isolati dalla spugna Microciona toxystila A. De Rosa Dicembre 1976 Isolamento di due nuovi diterpeni della ghiandola digestiva del mollusco Apylsia depilans e determinazione della loro struttura B. Danise Giugno 1977 Studi su alcuni sesterterpeni lineari da spugne G. Alfano Luglio 1977 136 Sul meccanismo di restringimento dell’anello A del colesterolo durante la biosintesi di 3-β-idrossimetil-A-nor-sterani nella spugna Axinella verrucosa L. Bibolino Luglio 1977 Strutture delle spiniferine-1 e -2, furanosesquiterpeni della spugna Pleraplysilla spinifera R. Giorgio Dicembre 1977 Isolamento e sintesi di un nuovo steroide da Eunicella cavolini B. Desiderio Dicembre 1977 Identificazione e biosintesi di nuove poliammine in un batterio estremo termofilo A. Alfano Giugno 1977 Diglicerol tetraetere da Caldariella acidophila, un batterio estremo termofilo A. M. Formicola Luglio 1977 Studio mediante la spettroscopia di risonanza 13C di istoni di timo di vitello C. Fournier Febbraio 1977 Arricchimento selettivo in 13C delle metionine dell’istone H2B di timo di vitello e suo uso in studi conformazionali G. Di Pascale Dicembre 1977 Sul meccanismo di conversione biologico del colesterolo nel 19-nor-colestanolo nella spugna Axinella polypoides D. Persico Luglio 1978 12-Epi-scalaradiale, 12,18-diepi-scalaradiale e scalarolo butenolide, tre nuovi sesterterpeni dalla spugna Spongia nitens A. Di Luccia Ottobre 1978 Influenza dell’habitat sul metabolismo secondario della Petrosia ficiformis P. Laezza a. a. 78-79 Studio su basi chimiche delle interazioni tra il nudibranco Peltodoris atromaculata e la spugna Peltodoris ficiformis : isolamento e caratterizzazione d’insoliti carbinoli lineari ad alto peso molecolare D. Castiello Dicembre 1979 Su alcuni intermedi della trasformazione del colesterolo in 3-β-idrossi-A-nor-colestano nella spugna Axinella verrucosa A. De Stefano Dicembre 1979 Isolamento e caratterizzazione di alcuni metaboliti polari degli invertebrati marine Gorgonie del golfo di Napoli R. Mauriello Dicembre 1979 Studi sul trasporto della citidinfosfocolina doppiamente marcata G. Cocchiara a.a. 79-80 La beta-galattosidasi da Caldariella acidophila come biocatalizzatore in sistemi a flusso continuo O. Sgambati a.a. 79-80 Influenza dell’habitat sul metabolismo secondario della Petrosia ficiformis D. Laezza Aprile 1980 Isolamento, parziale caratterizzazione strutturale, proprietà farmacologiche e proprietà analitiche di alcuni composti isolati dalla spugna Reniera sarai C. Calabrese 1981 Isolamento e purificazione di uteroglobina. Interazione con progestinici A. Bazzocchi 1981 137 Fitoregolatori ed altri composti di origine marina G. Lanza Luglio 1981 Steroli poliossigenati dalla gorgonia Leptogorgia sarmentosa R. Benvegnù Luglio 1982 Nuovi metaboliti dalla spugna Petrosia ficiformis A. De Giulio Ottobre 1982 Modificazioni microbiologiche di steroidi operate con cellule di Caldariella acidophila, un archeobatterio termofilo F. Capasso a.a. 80-81 Differenti sistemi di immobilizzazione di cellule di Caldariella acidophila, un microorganismo estremo termofilo. Studi sulla β-galattosidasi marker del patrimonio enzimatico cellulare L. Lama 1982 Chimica e comportamento di difesa di molluschi nudibranchi R. Morrone Giugno 1983 Biosintesi proteica negli archeobatteri. Studi di inibizione con differenti antibiotici L. Del Piano 1983 Simulazione di ambienti recettoriali in soluzione: studio di RMN di complessi di amminoacidi peptidi con etere corona C.A. Beretta a.a. 82-83 Biogenesi lipidica negli archeobatteri A. Trincone a.a. 83-84 Struttura e funzione dei flagelli negli eubatteri C. Tammaro a.a. 83-84 Aspetti patogenetici dell’infezione da micoplasma pneumoniae A. Borelli a.a. 84-85 Aldeidi terpenoidiche di sapore piccante: studi biomimetici sul meccanismo di azione biologica e sulla relazione attività-struttura S. De Falco Gennaio 1985 Le saraine: una nuova classe di alcaloidi dalla spugna Reniera sarai. Isolamento e primi studi strutturali G. Raimo Febbraio 1985 Alterazioni nella permeabilità della membrana esterna dei batteri gram-negativi G. Castoria a.a. 84-85 La membrana batterica: importanza nella sopravvivenza della cellula C. Riviezzo a.a. 85-86 Nuova classe di chinoni neglil archeobatteri termofili appartenenti al genere Sulfolobus M.R. Vaccaro 1986 I lipidi degli archeobatteri: marker tassonomico di questa nuova linea evolutiva A. Fierro 1986 Studi sulla struttura primaria della protammina Chaetoporus variopedatus R. Arcone 1986 138 Potenzialità della spettrometria di massa in chimica clinica M. Carrino Proprietà ittiotossiche di alcuni metaboliti di difesa di molluschi opistobranchi M.V. Andalò a.a. 87-88 Bromoditerpeni dell’alga rossa Sphaerococcus coronopifolius del Nord Adriatico e loro attività farmacologica P. Scarpelli 1987 Struttura e attività biologiche di metaboliti da un prosobranco (Buccinulum corneum) F. Carretta 1988 Valutazione dell’attività citotossica ed antitumorale su derivati naturali e sintetici dell’avarolo R. Cozzolino a.a. 87-88 Revisione della struttura della bursatellina, metabolita azotato da opistobranchi Bursatella sp M.R. Caldarelli 1988 Riduzione asimmetrica di chetoni con un’alcool deidrogenasi da Sulfolobus solfataricus D. Mirella a.a. 88-89 Meccanismi di difesa dei molluschi Opistobranchi del Mediterraneo: caratterizzazione chimica dei feromoni d’allarme da Bullomorfi A. Passeggio a.a. 88-89 Moluscos gasteropodos del sudeste espanol. Faunistica, ecologia y estudio de la simbiosis con algas (Dottorato in Biologia Universidad de Murcia) A.M. Atucha 1989 Definizione strutturale dei lipidi di membrana delle Therotogales M.C. Manca 1990 Lipidi da Archeobatteri M. Puglia 1990 Mediatori chimici di molluschi opistobranchi G. Villani 1990 Sintesi enzimatica di alchil glucosidi R. Improta 1991 Il Dr. Sandro De Falco in una vignetta subito dopo la laurea Interazione molecolare tra cancerogeni e macromolecole cellulari V. Carbone 1991 La spettrometria di massa in biotecnologia M. D’Orsi 1991 Caratterizzazioe strutturale di varianti genetiche dell’emoglobina umana mediante MS M. Pisaturo 1991 Caratterizzazione strutturale mediante MS di due varianti genetiche dell’emoglobina umana: HbM Hyde Park e Hb San José G.S. Nahid 1991 Caratterizzazione strutturale di alcune interleuchine-1-β umane ricombinanti mediante MS G.S. Afsaneh 1991 Estudio sistematico y ecologico de los Poriferos del sureste iberico (Dottorato in Biologia Universidad de Murica) 139 A.M. Martinez Ingles 1991 Origine, distribuzione e funzione biologica di prostaglandin-1,15 lattoni nel mollusco marino Tethys fimbria C. Minardi a.a. 90-91 Studi su basi chimiche delle strategie di difesa del mollusco anaspideo Aplysia fasciata C. Gianfrani a.a. 91-92 Gli ascoglossi: uno straordinario modello per studiare, su basi bio-chimiche, l’evoluzione dei molluschi opistobranchi E. Mollo a.a. 91-92 Contributi biochimici alla tassonomia ed all’ecologia dei Chromodorididae. Opistobranchia: Mollusca M.T. Grieco a.a. 91-92 Utilizzo del Sulfolobus solfataricus, un archeobatterio termoacidofilo nelle reazioni di glicosidazione F. Macchiarolo a.a.92-93 Studio chimico delle spugne ceractinomorpha da coste catalane L. Albarella 1993 Sustancias naturales de moluscos opistobranquios: estudio de su estructura, origen y funcion en ecosistemas bentonicòs (Dottorato in Scienze Biologiche Universidad de Barcelona) C.A. Escartin 1993 Applicazioni nel campo della bioelettronica dei lipidi di Sulfolobus solfataricus ceppo DSM 1617 purificati e modificati chimicamente A. Riccio a.a. 93-94 Relaciones inter e intraespecificas en Molusco del orden Cephalaspidea: una aproximacion biologica y quimica (Dottorato in Biologia Universidad de Sevilla) L.A. Alvarez Olive 1994 Chemical studies on some organophosphorus insecticides (Degree of Master of Science in Chemistry Cairo University) H.A-G. Hassan 1995 Studi chimici sulle petroformine, inusuali poliacetileni ad alto peso molecolare dalla spugna Petrosia ficiformis C. Salierno a.a. 94-95 Biosintesi dell’anandamide in cellule di mammifero N. Sepe a.a. 94-95 Studio su basi bio-chimiche della ecologia di molluschi ascoglossi caraibici D. Montanaro a.a. 94-95 Ciclopeptidos y ciclodepsipeptidos bioactivos. Aislamiento, elucidation y sintesis (Dottorato Universidad de Santiago) R. F. Rodriguez 1995 Isolamento, caratterizzazione strutturale e attività biologiche delle verrucosine, nuovi diacilgliceroli diterpenoidici dal nudibranco Doris verrucosa G. De Luca a.a. 95-96 Sintesi enzimatica di glicosidi naturali con enzimi termofili M. Ottonello a.a. 95-96 140 Valutazione dell’effetto antiossidante dei flavonoidi contenuti nei vini rossi utilizzando come modello sperimentale cellule intestinali in coltura M. Russo a.a. 96-97 El orden Anaspidea (Mollusca: Opistobranchia) en el Atlantico y Mediterraneo proximo. Revision taxonomica y estudio de los metabolitos secundarios en algunas especies (Dottorato di Ricerca in Biologia Universidad de Oviedo) E.M. Martinez Cueto-Felgueroso 1995 Nuovi metaboliti secondari biologicamente attivi da invertebrati bentonici: isolamento e caratterizzazione strutturale (Dottorato di ricerca in “Sostanze naturali farmacologicamente attive X Ciclo 1994-1997) Yuewei Guo Ottobre 1997 New Schiff bases of 5-nitrobenzo [b] thiophene-2-carboxyaldehyde of expected biological activity (Master Degree of Science in Chemistry Cairo University) M.A..A. Radwan 1997 Moluscos opistobranquios de Argentina: revision taxonomica y relacion de ecologia quimica en algunas especies patagonicas (Dottorato in Biologia Universidad de Oveido) C. Minian Pèrez 1997 Isolamento e caratterizzazione di un microorganismo estremofilo da sabbie dell’isola di Pantelleria, capace di biosintetizzare poliidrossi alcanoati C. Vicinanza 1997 Protezione chimica in nudibranchi Chromodorididae e Dorididae A. De Napoli a.a. 97-98 Metaboliti da microorganismi aloalcalofili D. Trabasso 1999 L’ecologia chimica come versatile mezzo per l’individuazione di molecole bioattive: studio di molluschi marini di opistobranchi P.M. Cavaliere 1999 Studi chimici su invertebrati bentonici R.M. Fontana 1999 Produzione di polisaccaridi da nuovi termofili marini V.M. Schiano Moriello 1999 Caratterizzazione strutturale della proteina invariant chain associata al complesso maggiore di istocompatibilità di classe II M. De Julio a.a. 98-99 Metaboliti secondari di origine marina: chimica ed attività biologica G. D’Ippolito a.a. 99-00 Biosintesi di metaboliti secondari da organismi marini R. Messina a.a. 99-00 Estudio quimico de los organismos marinos Cacospongia scalaris, Spongia agaricina, y Plexaurella grisea: estructura y citotoxicidad de nuoevos terpenos y esteroides (Dottorato in scienze chimiche Universidad de Cadiz) A. Rueda Campos 2000 L’anandamide e il recettore dei vanilloidi VR1: riconoscimento molecolare e regolazione I. Brandi a.a. 00-01 141 Il personale attuale dell’Istituto Questo è un percorso storico delle assunzioni all’Istituto; le date riportate sono quelle ufficiali della presa di servizio di ognuno dei dipendenti. Per alcuni di essi la presenza in Istituto risale a momenti precedenti: tesi di laurea, borse di studio, leggi speciali per l’occupazione (285, etc.). Non sono riportati i dipendenti che non svolgono più servizio presso l’Istituto oggi. E’ interessante notare come per circa un decennio (1973-1983) ci sia stato il buio riguardo l’ingresso di nuovo 1969 2001 CRISPINOAntonio coll. tecnico 1.2.1969 BUONOMOAntonio Op.amm.vo 1.10.1994 ESPOSITOEnrico col,. tecnico 1.2.1969 DEPRISCORocco Primo Ric. 1.6.1996 (1.11.62) SCOGNAMIGLIOGennaro coll. tecnico 1.2.1969 MOLLOErnesto Ricercatore 16.2.1998 AMODEOPietro Ricercatore 4.1.1999 TRABUCCOAntonio Op. tecnico 1.2.1969 CIAVATTALetizia Ricercatore 18.1.1999 TURCORaffaele Coll. tecnico 1.2.1969 FONTANAAngelo Ricercatore 18.1.1999 VILLANI Guido Tecnologo 16.2.1999 MATTODaniela Op. tecnico 1.2.2001 OGNIBENEBarbara Coll. Amm.vo 16.7.2001 CIMINOGuido Dirirg. ricerca 1.5.1969 DEROSASalvatore Primo ricercatore 1.5.1969 DI PINTOCorrado coll,. tecnico 1.5.1969 TRIVELLONEEnrico Dirig. tecnologo 1.5.1969 GAMBACORTA Agata Dirirg. ricerca 16.6.1969 VACCAROM. Rosaria Coll. Amm.vo 1.11.1969 DI MICCOCiro Op. Amm.vo 1.2.1970 MILONEAfredo PULITI Raffaella Ricercatore 1990 CALANDRELLI Valeria Coll. tecnico 1.9.1990 IODICECarmine Coll. tecnico 1.9.1990 RICCIARDI Desiderata Coll. tecnico 1.9.1990 ZAMBARDINOSalvatore Coll. tecnico 1.9.1990 ZAMBARDINOUmberto Coll. tecnico 1.9.1990 15.12.1971 Primo ricercatore 15.6.1970 (1.7.1962 ) TANCREDI Teodorico Dirirg. ricerca 16.1.1973 SALZANOPasqualina Op. tecnico 1.8.1973 LOPEZAniello Op. tecnico 16.11.1973 NICOLAUSBarbara Primo Ricercatore 16.6.1982 ROMANOIda Coll. tecnico 29.4.1983 TRINCONEAntonio Ricercatore 29.4.1983 SALZANOLoredana Coll.amm.vo 1.4.1984 1984 MAIELLOAntonio Op. tecnico 1.12.1987 DI MARZOVincenzo Primo ricercatore 1.4.1988 CASTELLUCCIOFrancesco Coll. tecnico 1.9.1988 PAGNOTTAEduardo Coll. tecnico 1.12.1988 LAMALicia Ricercatore 30.12.1988 GAVAGNIN Margherita Primo ricercatore 1.1.1985 MOTTAAndrea Primo ricercatore 1.1.1985 DEGIULIO Alfonso Ricercatore 1.4.1986 MIRRAVincenzo Op. tecnico 1.4.1986 STRAZZULLOGiuseppe Ricercatore 1.4.1986 ZAMPAMaurizio Coll. tecnico 1.4.1986 142 Pensionati e trasferiti Nel capitolo “L’attività del personale ex-ICMIB” sono riportati brevemente i curriculum storicoscientifici del personale ex-ICMIB ancora in attività: Mario De Rosa, Virginia Lanzotti, Antonio Malorni, Raffaele Riccio e Aldo Spinella. Qui si vogliono invece ricordare tre persone: Vincenzo Calandrelli, Alfonso Cantilena ed infine Salvatore De Stefano. Vincenzo Calandrelli è stato assunto presso l’Istituto il 1.10.1969 e ha lasciato con la pensione il 1.7.1989 registrandosi come primo pensionato dell’I.C.M.I.B. Ha curato con altri l’officina e per lungo tempo ha fatto parte dello staff dell’amministrazione. Alfonso Cantilena è una delle persone presente con gli altri già nel 1969. Vincenzo CalanE’ stato assunto il 15.9.1969. E’ stato il primo responsabile dell’officina che in quegli drelli e Raffaele anni, ma anche successivamente, ha contribuito in modo massiccio alla costruzione Turco quasi nel senso letterale del termine, dei laboratori. Vi sono testimonianze nei primi verbali dalle quali risultano gli interventi eseguiti: vasche, lavori idraulici particolari, adattamenti delle strutture per renderle idonee a svolgere attività di ricerca, etc. Cantilena ha ottenuto il trasferimento all’IMOF di Portici il 1.3.1984, Dal 1998 Alfonso è in pensione. Salvatore De Stefano nel suo studio e di lato con B. Nicolaus alla vita del laboratorio. Amava la vita del laboratorio, e la “pratica del banco” non è mai mancata fino a poco tempo prima della pensione quando personalmente lo ricordo impegnato con me in una ricerca su alcuni metaboliti da funghi il cui lavoro è ancora in corso di pubblicazione. Maggiori dettagli sulla statura scientifica sono rintracciabili nella storia del reparto Sostanze Naturali. Gli scherzi sulla statura di Salvatore De Stefano sono invece leggendari Salvatore De Stefano è stato uno dei primi dipendenti dell’Istituto, assunto il 1.1.1969; insieme a Guido Cimino, Luigi Minale e Guido Sodano ha iniziato il lavoro sulle sostanze naturali da organismi marini. Ha fatto parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto per lungo tempo e ha pubblicato numerosissimi lavori; anche un rapido sguardo agli elenchi dei lavori pubblicati dall’Istituto nel corso degli anni rende testimonianza del contributo fondamentale di Salvatore De Stefano 143 I servizi Alcune attività comuni nell’ambito dell’Istituto sono organizzate in servizi, qui di seguito sono riportati i servizi presenti oggi nell’ambito dell’Istituto. E’ da menzionare, dal punto di vista storico il Servizio Officina di cui il primo responsabile è stato il Sig. Alfonso Cantilena trasferitosi nel 1984 e oggi in pensione.Tale servizio, come quelli di oggi, è stato di grande aiuto all’inizio delle attività scientifiche del Laboratorio per la Chimica e Fisica di Molecole di interesse biologico. Una serie di lavori importanti sono stati eseguiti e registrati nel rapporti di attività del Direttore R. A. Nicolaus nel 1970. Essi vanno dall’installazione di impianti elettrici per i vari laboratori alla messa in opera di varie apparecchiature, autoclavi, fermentatori, stufe, etc. Una serie di servizi tecnico scientifici sono stati realizzati dal personale dell’istituto nell’ambito dell’Area di ricerca di Napoli tra essi ricordiamo: Il centro internazionale di Spettrometria di Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare - Responsabile Andrea Motta Parole chiave: NMR, spettroscopia, tecniche multidimensionali, determinazione strutturale Applicazione della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare alla determinazione strutturale di sostanze naturali, peptidi e proteine, e al metabolismo cellulare e a polimerici sintetici. Introduzione di nuove tecniche multidimensionali. Servizio di Analisi Strumentale - Responsabile Gennaro Scognamiglio Parole chiave: HPLC, gascromatografia, infrarosso Il Servizio di Analisi Strumentale ha avuto come obiettivo: 1)la risoluzione di miscele complesse di metaboliti provenienti da invertebrati marini mediante l'ausilio di metodi cromatografici su colonna solido- liquido e liquido-liquido (HPLC) e gas-cromatografici, 2)la determinazione dei gruppi funzionali presenti in tali metaboliti mediante spettroscopia infrarossa ed ultravioletta ed infine 3) la determinazione della stereochimica per mezzo del potere ottico rotatorio e del dicroismo circolare. Servizio di Fermentazione - Responsabile Esposito Enrico Parole chiave: archeobatteri, estremofili, cianobatteri Gli obiettivi del servizio sono stati l'arricchimento e l' isolamento di estremofili da campioni di suolo ed acque provenienti da svariate parti del mondo: dall' Antartide a zone di differenti province della Regione Campania. Parallelamente si sono migliorate le rese di ceppi in precedenza già isolati e caratterizzati. Servizi Generali - Responsabile Antonio Trabucco Parole chiave: servizi generali, utenze generiche, problematiche comuni all’Istituto Gli obiettivi del servizio rientrano nella cura dei servizi generali, delle comuni utenze e nella risoluzione delle problematiche comuni all’Istiuto dal punto di vista tecnico. Questo servizio ha curato il trasloco delle attività di laboratorio dalla sede di Arco Felice in Via Toiano, 6 al Comprensorio ex-Olivetti facendosi carico di tutti i problemi derivanti da questa attività. 144 Curiosità Esposito Enrico Ah! Lo sciopero. Probabilmente erano gli inizi degli anni 80, non un ricordo che risale alla notte dei tempi; il sindacato e noi tutti decidemmo di attuare una forma di protesta per così dire originale: una Veglia della Ricerca, come fu chiamata. Passammo qualche notte in laboratorio e, tra il lavoro che effettivamente la maggior parte di noi svolgeva, veniva anche fame non dormendo. La biblioteca fu Scognamiglio Gennaro Peli di capra. Nel 1969 -70 una delle tematiche di ricerca del Laboratorio era lo studio delle feomelanine; ricordo con curiosità il reperimento delle fonti naturali da cui ottenere i prodotti da studiare. Una di queste fonti erano i peli di capra che ci procuravamo La Veglia della Ricerca. Un momento di discussione per l’organizzazione. Crispino Antonio “’O sole mio”. Eravamo tutti molto giovani in laboratorio nel 69-70 e ricordo di quell’epoca una volta in cui lavorando al banco canticchiavo come sono solito fare mentre esplico attività manuali. Mi lasciai evidentemente trasportare dall’entusiasmo della canzone attirando anche altri colleghi. All’inizio non mi accorsi di nulla ma alle mie spalle c’era il Prof. Nicolaus; appena lo vidi zittii immediatamente. Ma ricordo con piacere la bonarietà con la quale mi esortò a continuare a cantare: “Faccia, faccia pure sig. Crispino” mi disse “mi piace sentirvi cantare mentre si lavora” cosa che allievò immediatamente la paura di stare per prendermi una sonora, è il caso di dirlo, ramanzina. Di Pinto Corrado Trasformazioni. Necessità di lavoro, entusiasmo, apprendimento, crescita culturale propria, continua ed aggiornata, e di tutto il team dell’Istituto, grazie a strumentazione inizialmente all’avanguardia in Europa (NMR per il 13 C) hanno creato un percorso ascendente verso traguardi riconosciuti a livello internazionale, nonostante le condizioni bioecodisastrose in cui si è operato. I rapporti interpersonali a tutti i livelli, qualunque siano stati i canali e le funzioni di ognuno, hanno permesso una coesione di interessi e di vedute fin quando il ricambio verificatosi in tempi molto Lina Salzano Ma ci sono stati anche altri scioperi, mica solo la Veglia della ricerca!! Ricordo di un corteo che prese inizio proprio dall’ingresso dell’Area di Ricerca di Arco Felice e proseguì per le strade adiacenti. Parteciparono molti lavoratori dell’area, io me li ricordo tutti lì. Turco Raffaele Una nottata con “La bambolona”. Ancor prima della famosa Veglia della Ricerca proprio nei primissimi anni vi furono altre veglie probabilmente meno urgenti ma forse non meno necessarie, chi lo può dire? A Gennaio 1970 Pozzuoli e Arco Felice furono investite del fenomeno del bradisismo famoso nei Campi Flegrei. Il Rione Terra, popolato dai pescatori di Pozzuoli, fu evacuato in fretta e c’era pericolo di occupazioni abusive da parte di famiglie senza alloggi. Ecco, forse era un impeto di protezione il nostro, ma qualche notte ricordo di averla trascorsa anche io in laboratorio, magari dopo essere stato con altri tecnici a cinema la sera; si, si quella Trabucco Antonio Il telegramma della “felicità”. 1° Febbraio 1969 arriva un telegramma ufficiale di assunzione di una serie di tecnici tra cui il mio nome. Il momento è solenne e in qualche modo va festeggiato; avevo una vespa e nonostante il freddo salto su, arrotolo la sciarpa intorno al collo e parto a velocità sostenuta. Questa felicità dura pochi chilometri però: a poca distanza dal laboratorio fui tamponato da un autoveicolo con fratture nella zona del bacino; così il mio inizio del periodo lavorativo ufficiale corrisponde ad un periodo ospedaliero. La “felicità” ritornò ad essere felicità quando capii, riuscedomi a rimettere in piedi, che avrei continuato a camminare sulle mie gambe; tornai a lavoro dopo qualche tempo e quello Tombolata di Natale, Inizio anni ‘80, Biblioteca I.C.M.I.B. Da sinistra Vincenzo Calandrelli, Rosaria Vaccaro, Luisa De Piano, Annalisa Basso, Gennaro Raimo, Ricciardi Desiderata e Sandro De Falco. Vaccaro Maria Rosaria Tombolata di Natale. Spesso in Istituto nella giornata della vigilia di Natale ci si riuniva in biblioteca, abitudine che ancora esiste, per mangiare il panettone e scambiare gli auguri con i colleghi. All’inizio degli anni 80 si organizzava anche la tombolata con premi per i vincitori. Nella foto Festa d’addio per il trasferimento di Alfonso Cantilena. Da sinistra: Aniello Lopez, Giuseppe Strazzullo, Antonio Malorni, Mario De Rosa, Ciro Di Micco, Guido Sodano che legge una dedica, Alfonso Cantilena, Angelo Capezio, Salvatore Sodano, Giuseppe Pernicola e Barbara Nicolaus. In primo piano dietro lo striscione si distinguono, fra gli altri: Raffaele Turco e Lina Salzano. 145
Scarica