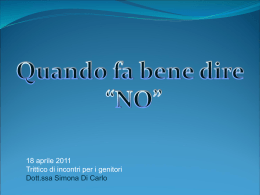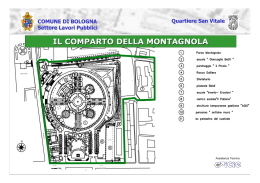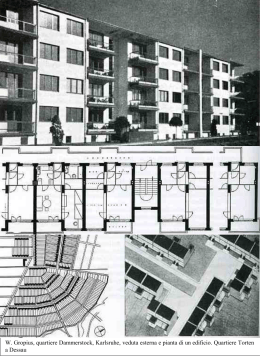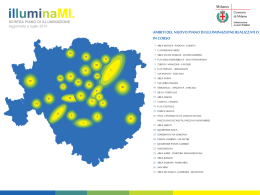A Nicola Schingaro Ma. . . perché non sono un delinquente? Un’autoetnografia come metodo della ricerca sociale Introduzione di Daniele Petrosino Copyright © MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Quarto Negroni, Ariccia (RM) () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: giugno …ad Alice e a Domenico, con la speranza di un futuro migliore. Questa non è una nozione mitica di marginalità. Essa deriva dall’esperienza vissuta (…). Non vivo più in quel mondo segregato (…). [Ma] centrale alla vita in quel mondo era la continua consapevolezza della necessità di un’opposizione. hooks bell, Yearning: Race, Gender and Cultural Politics Indice 11 Introduzione di Daniele Petrosino 15 Capitolo I Ma … perché non sono un delinquente? Prologo, 15 – Scena I: La produzione del mio spazio periferico, 27 – Scena II: I miei “occhi quadrati”, 57 – Scena III: Etichette, stigmi e cerimoniali di deterioramento di status, 70 – Scena IV: “Look in their eyes Mom you’ll see me”, 104 – Epilogo, 111 141 Capitolo II L’autoetnografia come metodo della ricerca sociale 2.1. Dietro le quinte: le origini del mio lavoro, 141– 2.2. Che cos’è l’autoetnografia?, 153 – 2.3. “Auto” (il Sé) come “io-cheesperisce”, 155 – 2.4. “Etno” (la cultura) nel continuum “culturaspazio/luogo-identità”, 158– 2.5. “Grafia” (la scrittura) come “processo”, 201 – 2.6. Il metodo di ricerca del Sé autoetnografico, 214 – 2.7. L’euristica e il suo utilizzo, 222 – 2.8. Questioni di legittimità o fondatezza, 223 – 2.9. Ma … perché condividere la mia storia con voi?, 226 235 Bibliograa 249 Ringraziamenti 9 Introduzione di Daniele Petrosino 1 Non è facile introdurre una ricerca di cui si è, seppure marginalmente, in qualche modo responsabili e coinvolti. Probabilmente non ho fatto un buon servizio all’autore stimolandolo ad un’autoriflessione e ad una forma di ricerca un po’ eterodossa. Nonostante decenni di riflessione intorno ai “metodi” nelle scienze sociali ed una crescente attenzione verso la dimensione qualitativa dei fenomeni, la cittadinanza di ricerche come quella condotta da Schingaro continua ad essere contestata in nome di alcuni principi che si ritiene debbano guidare le ricerche sociali: rappresentatività, distanza, “oggettività”. Già sostenere che si possano fare buone ricerche con interviste in profondità e osservazione etnografica incontra resistenze, certo non tra gli scienziati sociali, ma nei colleghi di altre discipline più dure, pensiamo una ricerca che assuma come oggetto e soggetto lo stesso autore e la sua esperienza. Personalmente lavoro con metodi più tradizionali (survey, interviste, ecc.), ma l’insoddisfazione verso molti dei risultati 1 Daniele Petrosino è Professore Associato di Sociologia generale, Sociologia delle migrazioni e delle relazioni interculturali e di Metodi e tecniche della ricerca sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’. 11 18 12 Ma … perché non sono un delinquente? Introduzione che ricaviamo seguendo i sentieri già battuti, mi porta a guardare con attenzione a strade che a prima vista possono sembrare contraddire tutto ciò che ci hanno insegnato (o che mi hanno insegnato) in tanti corsi di metodologia. Bisogna anche dire che, per quanto in nicchie un po’ marginali, ormai le autoetnografie hanno una storia di più decenni (e trovano la loro origine in testi classici della tradizione sociologica, come Hobo di Anderson) e articoli e volumi, soprattutto nel mondo anglosassone sono ampiamente diffusi, per cui parliamo di qualcosa che affonda le proprie basi in una letteratura ed in una riflessione che ha un significativo spessore (come viene ampiamente analizzato nella seconda parte di questo volume), ciò nonostante le resistenze sono molte, quasi che tale metodo metta in discussione la legittimità stessa della ricerca sociale. Vediamo perché. L’autoetnografia porta a compimento un cortocircuito che è fin dalle origini presente tanto nella ricerca sociale che in quella etnografica. Uno dei nodi più dibattuti nella riflessione metodologica del ‘900 è il rapporto che si istituisce tra l’osservatore e l’oggetto osservato, ovvero se essi siano separati oppure siano entrambi compresi nello stesso sistema di osservazione e quanto dell’osservazione dipenda dalla relazione che si istituisce tra osservatore ed oggetto osservato. È una riflessione che non appartiene solo alle scienze sociali, ma che con Heisemberg ha fatto irruzione nelle scienze più dure. Paradossalmente nella storia della metodologia delle scienze sociali il rapporto tra il ricercatore e il mondo sociale osservato ha costituito non solo un oggetto di grandi discussioni, ma lo stimolo per ricerche di grande fascino ed interesse. È solo con l’affermazione del paradigma neo-positivista e della quantofrenia che questa relazione viene considerata il vulnus da combattere. La ricerca dell’oggettività e il tentativo di neutralizzare la presenza e l’influenza dell’osservatore hanno occupato decenni di ricerca metodologica. Introduzione 19 13 Solo con il progressivo affermarsi del paradigma costruttivista è apparso chiaro come ogni operazione di ricerca “costruisca” il proprio oggetto ed i propri dati, che non sono esterni ad esso, ma il prodotto di processi di delimitazione e significazione interni al sistema osservante. Da un altro versante, quello propriamente etnografico, vi è una progressiva consapevolezza della presenza dell’altro come soggetto a cui la ricerca deve dare la parola e non semplicemente usare come un mero dato osservativo. Il rapporto con l’altro si pone non come mera restituzione della ricerca, ma come riconoscimento della soggettività e della sua irriducibilità nella relazione che si costruisce attraverso l’osservazione etnografica. L’osservato che diventa protagonista della narrazione rompe lo schema classico del racconto etnografico, perché introduce la sua propria riflessione. Il passaggio all’autoetnografia si consuma in questo cortocircuito, l’osservato diventa l’io narrante e precipita il processo di ricerca in una complessa relazione ermeneutica. Quale soggetto migliore dello stesso ricercatore, che così fonde in sé osservatore ed osservato. Certo l’attenzione autoriflessiva non è nuova nelle scienze sociali, e l’uso della biografia e dell’autobiografia ha trovato ampio spazio, ma con l’autoetnografia si sviluppa un tentativo complesso di usare l’individuale come strumento di comprensione di una realtà più generale. Nel caso di questo lavoro il tema stesso evoca un quesito classico delle scienze sociali. Perché coloro che vivono in certe condizioni, con certe esperienze, non agiscono nello stesso modo? È solo l’indeterminatezza dell’agire individuale o vi è qualcosa che si intreccia nelle esperienze vissute, nell’elaborazione soggettiva, nella connessione con un tessuto sociale, che rende diverse le risposte, comprensibili seppure non determinabili. Il saggio di Schingaro ci pone chiaramente di fronte a questi quesiti, sviluppando una trama narrativa, in cui memoria, 20 14 Ma … perché non sono un delinquente? Introduzione osservazione, analisi sociale si fondono in un racconto suggestivo, che non perde, però, mai di vista la sua natura etnografica. Le emozioni evocate sono la scintilla per produrre una penetrazione empatica nel mondo di un ragazzino, simile a tanti altri, cresciuto in una periferia urbana, simile a tante altre, e che le statistiche, le interviste non riescono a farci comprendere perché non ne possono esprimere il senso profondo, come può il racconto autoetnografico. Ciò che chiediamo ad un’autoetnografia è di aprirci un mondo che pur nella sua individualità ci restituisca la sua dimensione sociale e possa farci entrare in una condizione umana e sociale che non è solo individuale. Come il lettore vedrà, scrivere un’autoetnografia non è facile, così come non lo è svolgere una ricerca etnografica, non lo è non solo per le evidenti difficoltà epistemiche, ma per la profonda invasività che tale metodo ha. Esso più di altri comporta un processo di cambiamento nel ricercatore ed una profonda disponibilità a mettersi in discussione. Sarebbe imprudente pensare che un’autoetnografia possa da sola farci compiere tutti i passaggi della conoscenza sociale, essa, piuttosto, va considerata come un’altra prospettiva che si affianca a quelle più tradizionali e che ci permette di rileggere i fenomeni attraverso una diversa rifrazione. Ciò che chiediamo ad una ricerca è di farci comprendere qualcosa in più del mondo che ci circonda, di farlo con onestà intellettuale e di essere attendibile, certo ci sono i protocolli e le metodologie consolidate, ma più di tutto dovrebbe esserci il desiderio e la curiosità di conoscere. Ed è questa sincera curiosità, lo sforzo di accompagnarci in una conoscenza profonda ed emozionante, il pregio ed il valore aggiunto di questa ricerca, che continua il viaggio di Schingaro nelle periferie e che, credo, costituisca un punto fermo nelle sue ricerche e nelle ricerche sulle periferie urbane. Capitolo I Ma … perché non sono un delinquente? Prologo Molte volte provo ancora a guardarmi allo specchio. E tutte le volte sono in grado di scorgere tratti che ancora potrebbero difendere certe ipotesi provenienti dalle teorie biopsico-sociali contenute nel framework dei meccanismi interni. Ho sempre avuto naso ritorto, zigomi larghi e pronunciati, orecchie considerevoli, braccia lunghe, capelli folti ed abbondanti e poi anche barba sparsa e rada. Così, rispetto alla mia fisionomia, potremmo discutere sin d’ora di queste mie peculiarità. E se anche voi aveste la possibilità di scrutarmi, forse, ne rintraccereste pure di altre. Tuttavia, non so se davvero posso essere considerato come una persona atavica o geneticamente inferiore a causa di queste mie caratteristiche fisiche. E analogamente non so neppure se in realtà sono fisicamente e geneticamente superiore alle persone criminali (Hooton 1939). Per di più, sono sempre stato un individuo mesomorfo; e forse questo mio somatotipo potrebbe ancora essere un buon predittore di un mio possibile comportamento deviante (Sheldon 1949). Ho sempre avuto una dimensione del corpo più grande e sono sempre stato fisicamente più mascolino rispetto agli altri; 15 22 16 Ma … perché non sono un delinquente? Ma... perché non sono un delinquente? e senza dubbio anche questo potrebbe essere un importante fattore per supporre certi atti di delinquenza minorile (Gluecks e Sheldon 1950) che potrei aver commesso. Nondimeno, venti o venticinque anni fa, possedevo certamente tantissima energia fisica, impulso psicologico e bisogno di stimolazione. Praticavo pure molto sport e la mia carriera, come atleta, richiedeva senz’altro tantissima forza e stamina. E quindi, anche da questo punto di vista, possedevo di certo tutti i requisiti necessari per intraprendere una carriera deviante (Gove 1985; 1995). Così, tutte le volte che mi guardo allo specchio, ancora non so se sono un “delinquente nato” (Lombroso 1911). E come conseguenza, non so neppure se alla fine devo solo ringraziare la mia buona stella2. D’altra parte, sono nato e cresciuto in un C.E.P. Era il quartiere “San Paolo”, a Nord-Ovest di Bari. Esso non era solo la periferia estrema di una città media dell’Italia meridionale, ma era anche e soprattutto un quartiere povero, un ghetto, uno slum. Di conseguenza, nell’immaginario comune, evocava quasi esclusivamente un’immagine negativa: era solo un covo per lo più ricolmo di individui poveri e criminali. Se non proprio per tutti tra coloro che abitavano ‘in’ città; per la stragrande maggioranza di loro, era senz’altro questa la principale caratteristica identificativa del mio quartiere. E si fosse trattato propriamente di un individuo anziché di un quartiere, esattamente in questa immagine, lo stesso Becker (1991) avrebbe di certo individuato il suo “master status”. D’altra parte, come tanti altri nel mio quartiere, naturalmente anch’io provenivo dalle classi inferiori. Ero lì, nel 2 Per quanto riguarda le altre teorie bio-psico-sociali contenute nel framework dei meccanismi interni, vedi anche: Jacobs et al. (1965), Hirschi e Hindelang (1977), Wilson e Herrnstein (1985), Rowe (1986), Fishbein (1990), Gove e Wilmoth (1990), Booth e Osgood (1993), Wood et. al. (1997), ed Ellis (1987; 1991; 1996). I. Ma... perché non sono un delinquente? 23 17 mezzo, tra il proletariato e il sottoproletariato urbano della mia città. E una combinazione di tutti questi fattori ancora implica un mucchio di cose, sia dal punto di vista delle differenti teorie della devianza e del crimine, sia da quello della società in generale. Intanto, per le teorie della tensione3, sarei un criminale per una generale dislocazione tra le mete della società e i mezzi per raggiungerle. Come membro delle classi urbane più basse, potrei cioè non riuscire a raggiungere le mete desiderate attraverso i mezzi prescritti. Pertanto, da un lato, potrei accettare le mete della società, ma potrei non avere accesso ai mezzi legittimi per raggiungerle; oppure, dall’altro lato, potrei rifiutare i mezzi legittimi per raggiungere quelle mete legittime che la società pone. E di conseguenza, potrei infrangere le norme anche con una certa facilità. Allo stesso modo, se provassimo a cercare tra le ipotesi provenienti dalle teorie del conflitto culturale4, quasi certamente, sarei un deviante o un criminale. Vi erano diverse gang di delinquenti nel mio quartiere. E molti giovani erano inseriti, integrati, dentro subculture devianti. Queste subculture mantenevano valori che favorivano esplicitamente la devianza. A loro volta, questi valori erano facilmente appresi attraverso la socializzazione. E quindi era abbastanza facile che ciò potesse accadere anche a me. 3 In particolare, riguardo alle teorie della tensione strutturale e della frustrazione di status, vedi: Durkheim (1951), Merton 1938; 1949), Hirschi (1969), Jensen (1995), Tittle e Mier (1990), ed Agnew (1992). 4 Per quanto riguarda le teorie contenute nel framework del conflitto culturale, vedi: Sutherland (1939), Cressey (1953), Sykes e Matza (1957) per ciò che concerne le teorie del conflitto normativo e dell’associazione differenziale; Burgess e Akers (1966), ed Akers et al. (1979) per quanto riguarda la teoria dell’apprendimento; e infine, Cohen (1955), Miller (1958), Wolfgang e Ferracutti (1982), Anderson (1990), e Felson et. al. (1994) per quanto attiene alle teorie subculturali. 24 18 Ma … perché non sono un delinquente? Ma... perché non sono un delinquente? Inoltre, il mio quartiere era figlio di un modo di produzione capitalista dello spazio. Era un luogo dove la devianza riusciva ad emergere come una normale risposta alla competizione e al conflitto su risorse scarse. Da questo punto di vista, quindi, anche per le teorie del conflitto5 potrei essere un individuo deviante o criminale. Come membro delle classi inferiori, cioè, io potrei essere condotto alla devianza e/o alla criminalità per soddisfare bisogni di base ed esprimere così frustrazione. Nondimeno, ho vissuto da sempre - ed ancora vivo - in condizioni di vita complessivamente precarie. E così, anche secondo la prospettiva utilitaristica6, sarei un potenziale delinquente. Come un decision maker razionale, ancora adesso, io potrei calcolare tra costi e benefici prima di impegnarmi in un comportamento illecito. Pertanto, potrei scegliere un comportamento deviante o criminale come quello realmente in grado di fornirmi i massimi benefici con i minimi costi. E alla fine, potrei dunque intravedere il profitto maggiore nel prendere parte ad un’attività criminale. D’altro canto, anche per le teorie del controllo7, potrei essere altresì un deviante o un criminale per una probabile carenza o per una totale assenza di controllo sociale intorno a me. 5 Per quanto riguarda le teorie del conflitto, vedi: Bonger (1916), Quinney (1970), Chambliss (1964), Gusfield (1963), Liazos (1972), Spitzer (1975), Hagan et al. 1985; 1987), e Tittle (1995). 6 All’interno della prospettiva utilitarista, sulla teoria della deterrenza, vedi: Schneider e Ervin (1990), Wright (1984), Paternoster et. al. (1983), Geerken e Gove (1975), ed Akers (2000); inoltre, per quanto riguarda la teoria della scelta razionale, vedi: Cornish e Clarke (1986); e infine, per ciò che concerne la teoria dell’opportunità e delle attività routinarie, vedi: Cohen e Felson (1979), Cohen, Kluegel e Land (1981), Miethe et. al. (1987), e Jensen e Brownfield (1986). 7 Nel framework delle teorie del controllo, vedi: Thomas e Zananiecki (1918), Park, Burgess e McKenzie (1925), e Faris e Dunham (1939) per I. Ma... perché non sono un delinquente? 25 19 Nel corso della mia vita, cioè, potrei non aver avuto la possibilità di fare affidamento su di un set di forze e di processi in grado di incoraggiare la conformità - includendo l’autocontrollo, il controllo informale e il controllo formale. Pertanto, da un lato, potrei essere carente o privo delle forme del controllo sociale informale - come nel caso dell’autocontrollo esercitato per paura di ciò che gli altri potrebbero pensare di me. Oppure, dall’altro lato, potrei non dare importanza ai controlli sociali formali, in altre parole, alle sanzioni amministrative, quali ad esempio le multe o l’arresto. In particolar modo, però, tre sono le cose che hanno fatto soffrire più profondamente il mio Sé, la mia identità e la mia vita: un’etichetta, uno stigma ed un cerimoniale di deterioramento di status. E certamente, esse mi hanno tormentato a causa del mio quartiere. Noi - io e il mio quartiere - abbiamo condiviso molte cose. In particolar modo, tutte le volte che la nostra reciproca appartenenza era svelata in pubblico: esso era identificato semplicemente come un “ghetto” e/o uno “slum”, ed evocava l’immagine di un luogo come coacervo di miseria e di criminalità; mentre io ero etichettato semplicemente come un individuo “povero” e/o “criminale”. Era un’etichetta costruita socialmente all’esterno del mio quartiere. Etichettandomi come un deviante, anche su base quotidiana, la società al di fuori del quartiere sembrava quasi impegnarsi affinché io finissi per interiorizzare quell’etichetta, cadendo così in una “devianza secondaria” (Lemert 1951). A causa della mia provenienza, ero un individuo deviante semplicemente perché ero uno al quale quell’etichetta era stata applicata. Quasi come dei “moral entrepreneurs” (Becker 1991:147163), le persone al di fuori del mio quartiere tendevano ad quanto riguarda la teoria della disorganizzazione sociale; Nye (1958), Hirschi (1969), Gottfredson e Hirschi (1990), e Sampson e Laub (1993) per ciò che concerne la teoria del legame sociale. 26 20 Ma … perché non sono un delinquente? Ma... perché non sono un delinquente? isolarmi come una persona diversa, come un “outsider”, o persino come un soggetto da sottoporre quasi o del tutto ad un controllo sociale. Pertanto, mentre il mio quartiere viveva la sua “stigmatizzazione territoriale” (Wacquant 2007), io vivevo la mia vita come individuo stigmatizzato. E quindi noi - sempre io e il mio quartiere - soffrivamo tutte le volte, e quasi inevitabilmente, i nostri molteplici cerimoniali di deterioramento. Quasi come un individuo al di sotto dei normali standard societari, ero quindi escluso da una piena accettazione sociale. Semplicemente, ero una persona con uno stigma, vale a dire, una non del tutto umana; e quindi, dovevo costantemente adattarmi ad un’identità sociale precaria (Goffman 1986). Come individuo stigmatizzato, ero sottoposto a varie forme di discriminazione, esclusione, rifiuto e disapprovazione. Mentre ero etichettato come deviante, e soffrivo a causa di questa stigmatizzazione, simultaneamente, andavo acquisendo un’identità alterata, danneggiata; e così, ero tagliato fuori da una piena inclusione sociale. In particolar modo, questa riduzione, questa degradazione nello status sociale - da un Sé precedente ad un nuovo Sé alterato e deturpato - era avviata attraverso una procedura formale, vale a dire, un “cerimoniale di deterioramento di status” (Garfinkel 1956). Tutte le volte che un accusatore riconosciuto come “una figura pubblica, che fa affidamento su un’esperienza comunitariamente accettata e verificata ... s’investiva del diritto di parlare nel nome di questi ultimi valori”, e dava così inizio al rituale denunciandomi o condannandomi in pubblico; allora, la mia identità originaria era distrutta, demolita e rimpiazzata da un’altra di minor valore; ed io ero posto fuori, messo da parte, come uno strano, uno diverso (ibidem: 421-423). Simultaneamente, però, ero tormentato - ed anche in questo caso su base quotidiana - da una differente etichetta: una che a sua volta era pure prodotta socialmente ma all’interno del mio quartiere.
Scaricare