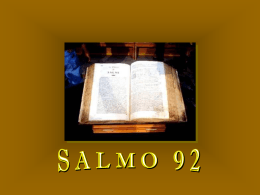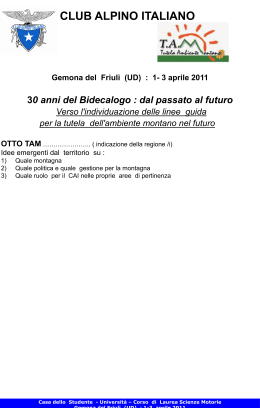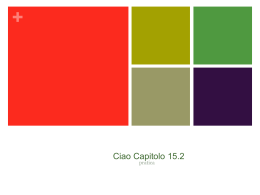ti scriverò dai confini del cielo Tanis rideout ti scriverò dai confini del cielo Traduzione di Anna Rusconi Titolo originale: Above all things Copyright © 2012 by Tanis Rideout. Published by arrangement with McClelland & Stewart, a division of Random House of Canada Ltd. and Marco Vigevani Agenzia Letteraria. La traduzione italiana di questo libro è stata pubblicata grazie al sostegno del Canada Council for the Arts. Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni dell’autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono quindi utilizzati in modo fittizio. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è puramente casuale. Redazione: Edistudio, Milano ISBN 978-88-566-2663-6 I Edizione 2014 © 2014 - EDIZIONI PIEMME Spa, Milano www.edizpiemme.it Anno 2014-2015-2016 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1920 «Raccontami la storia dell’Everest» disse lei, un sorriso radioso che le si allargava sul viso increspandole gli angoli degli occhi. «Dimmi di questa montagna che ti porta via da me.» George e Ruth sedevano per terra nello studio. Erano brilli e ridevano, e intanto la cena si raffreddava in tavola nella stanza accanto. Ruth gli stava di fronte a gambe incrociate, la gonna grigia tirata sulle ginocchia. Prese il foglio di pesante carta color avorio che teneva in grembo e tornò a leggere l’invito del Mount Everest Committee, il neonato Comitato per l’Everest. «Mio marito, esploratore di fama mondiale.» Nella stanza illuminata sollevò il bicchiere e lui la imitò. Brindarono facendo tintinnare il cristallo. Ruth traboccava di felicità. «Suona bene» commentò George, cercando di immaginare che cosa avrebbe provato il giorno in cui la gente avesse parlato di lui e quali porte gli avrebbe spalancato il successo sull’Everest. «Potrei smettere di insegnare e magari mettermi a scrivere a tempo pieno. Potremmo viaggiare» disse. «Vivere le nostre avventure.» Ruth gli porse l’invito e si rialzò barcollante, bevendo un altro sorso di vino. Mentre attraversava lo studio diretta alla libreria, lui rilesse: «Ci auguriamo che vorrà partecipare alla missione di ricognizione sul monte Everest 9 per la conquista dell’ultimo Polo, in onore di Sua Maestà e di tutto il paese». Alzandosi sulle punte dei piedi nudi Ruth si allungò a prendere l’atlante dal ripiano più alto. «Fammi vedere» disse poi, rimettendosi seduta vicino a George. Con il dorso della mano allontanò dalla fronte i capelli sfuggiti alle forcine, che le disegnavano un’aureola intorno al capo. George appoggiò il Times Atlas of the World sul tappeto turco dalle variegate sfumature azzurre: acqua e aria, neve e ghiaccio. Quando ebbe trovato la pagina giusta prese la mano di Ruth e le guidò l’indice a disegnare una linea intorno all’Europa, la rotta di una nave che superava la Francia doppiando capi e circumnavigando strette isole fino alla Grecia, per poi infilarsi nel canale che divideva in due il deserto e costeggiava la terra di Lawrence d’Arabia. Insieme, le loro mani descrissero un viaggio avventuroso che attraversava longitudini e latitudini, sfiorando hic sunt leones e le schiene di draghi marini dipinti nel blu dell’oceano Indiano, fino ad approdare nel porto di Bombay. George proseguì tracciando percorsi nelle pianure indiane, intorno a villaggi e bazar, a coltivazioni di tè e vacche sacre, e si spinse fino alla dorsale inarcata dell’Himalaya, con i suoi altipiani e i colli pedemontani. «Ma non c’è niente» esclamò Ruth, quando raggiunsero il punto in cui doveva trovarsi l’Everest. Solo una serie di nomi, senza rilievi né tracce di creste o giogaie. Solo parole che galleggiavano in uno spazio vuoto, uno spazio che aspettava di essere conquistato da lui. «Nessuno l’ha ancora mappata. È proprio questo che faremo, Ruth: una ricognizione che ci regalerà le sue forme.» Le spinse il dito ad accarezzare la cartina, quasi che attraverso la pagina potesse esplorare la regione e indovinarne le vette. «Sono le montagne 10 più alte del mondo.» Almeno con la voce voleva comunicarle il senso di soggezione, e sempre sfiorando la pagina prese a recitare dei nomi, prima di spostarsi dall’atlante alla sua pelle, sotto le pieghe della sua gonna. «Prova a immaginare, da ovest a est… Cho Oyu, Gyangchungkang, Everest, Makalu, Kangchenjunga.» Erano come spezie saporite sulla lingua, piccanti nelle loro bocche. Avvolta dal profumo del sapone alla lavanda e dei chiodi di garofano per il mal di denti, Ruth si strinse al marito ricordandogli la cena a base di curry che li aspettava nell’altra stanza. «Dovrai scrivermi e raccontarmi tutto nei dettagli» disse. «Così sarà come essere lì con te.» Un filo scucito del colletto le ricamava una sottile riga di colore sulla gola pallida. «Ma tu sarai davvero con me» disse George. «A ogni passo che farò.» «Everest» ripeté Ruth. «Che strano nome.» Lui tornò a prenderle la mano, risalendo le linee del palmo. «Viene da George Everest, topografo generale del Survey of India. Morì senza nemmeno riuscire a vederlo: ucciso dalla malaria, per la precisione, dopo essere diventato cieco e paralitico e avere sofferto di attacchi di follia. Pare fosse un prepotente che trattava malissimo i suoi uomini. Con le sue mappe voleva imporre una forma di ordine al mondo. Partì dal basso e risalì tutta l’India, facendo rilevamenti sistematici.» Poi le sussurrò sul collo parole come trigonometrico e triangolazione, facendole pulsare più forte la vena sotto l’orecchio. Con il dorso delle dita ispezionò il lungo pendio della sua gola, percorrendo la via della clavicola fino al salto che conduceva sotto la camicetta. «L’Everest è stato misurato dal limite dell’orizzonte.» Le tracciò la curvatura della Terra lungo l’incavo dello 11 stomaco, quindi la risospinse sul tappeto azzurro per continuare a esplorarle il corpo. «Si spostavano di collina in collina, costruendo torri d’osservazione e calcolando gli angoli di elevazione. Bastava una frazione di grado per sbagliare tutto.» Le era sopra. La prese per le anche, attirandola a sé. Sotto di lei l’atlante si increspò, le pagine incollate alla pelle sudata. Dopo qualche minuto Ruth rotolò su un fianco, rannicchiandosi nell’incavo del suo torace e incuneandogli la testa nell’ascella. Gli sentiva addosso il proprio odore. «I rilevamenti incontravano tre ordini di difficoltà. Le correzioni, tutte di natura matematica. La curvatura della Terra, la rifrazione della luce attraverso l’aria più rarefatta e le temperature più basse. Infine, la massa stessa della montagna.» Nonostante il velo di sudore che la ricopriva, sulla pelle nuda l’aria era fredda e Ruth cominciò a tremare. Si tirò allora a sedere davanti a George, le ginocchia strette al petto. Era incredibilmente felice e orgogliosa del fatto che avessero scelto lui. «La massa della montagna?» ripeté, inalando il suo profumo. La luce sempre più fioca scontornava i loro profili blu scuro. George si alzò e andò alla finestra, dove gettò un’occhiata in direzione delle torri di Charterhouse, mentre Ruth si rincantucciava nella giacca buttata per terra poco più in là. Dopo aver chiuso bene i vetri lui tornò a inginocchiarsi sul tappeto e le diede una tiratina ai baveri per stringerle meglio la giacca intorno alle spalle. «Sì. È talmente grande che influisce sulla gravità circostante. Nonostante avessero usato dei teodoliti, la forza d’attrazione della montagna alterò i rilevamenti dei topografi. Riesci a immaginare qualcosa di più potente? 12 Quel gigante è una presenza straordinaria. Quando decise di andare a prendergli le misure, Everest se ne rendeva conto, ma non riuscì neanche ad avvicinarglisi. Non arrivò neppure a vederlo.» Ruth chiuse gli occhi, appoggiandosi alla sua spalla, e immaginò la vetta frastagliata della montagna. «Ottomilaottocentoquaranta metri.» Un sussurro che era un’invocazione. Una preghiera. Sognò il momento in cui avrebbe ricevuto le sue lettere dall’Himalaya, quando sarebbe andata a raggomitolarsi davanti al camino per leggerle. Poi pensò al giorno in cui George sarebbe tornato a casa vittorioso e un nuovo sorriso le si allargò sul volto, stirandole le guance sin quasi a farle male. Impossibile resistere a una felicità simile. Si sforzò solo di non pensare che la lontananza sembrava romantica solo quando si era ancora insieme. «Ma come fanno?» chiese. «Come fanno a sapere quanto è alta, se non ci è mai salito nessuno?» George allungò un braccio e lei gli tese la mano per prendere la sua. Voleva farlo alzare e condurlo di sopra, in camera da letto, ma di nuovo le sue dita incontrarono quel vuoto sull’atlante in attesa di essere colmato. Più tardi, pensò. Avrebbe pazientato ancora un po’, mentre lui faceva progetti e sognava la montagna e il futuro. «Come fanno?» ripeté. «Magari non è davvero la più alta.» «Deve esserlo» rispose George, le dita che indugiavano sull’atlante. «Deve esserlo per forza.» 13 viaggio di andata Sul livello del mare 1924 Ricordava ancora la prima volta. Era stato un colpo di fulmine. Nel 1921 i membri della spedizione avevano calcolato il punto in cui più o meno l’avrebbero avvistata, ma giunti sul passo himalayano si erano trovati davanti una distesa di nuvole da cui spuntavano soltanto le vette più vicine. Avevano comunque allestito il campo e sul far della sera l’Everest si era lentamente svelato. Nella luce morente, erano rimasti a contemplare la montagna che si spogliava del suo mantello di nubi. «Eccola!» aveva gridato qualcuno quando infine era apparsa anche la cima, un’enorme zanna conficcata nella vastità del cielo, più alta di qualunque altra cosa. Avevano trascorso la notte lì, sul passo, e il mattino seguente l’avevano vista ricomparire. Erano rimasti a osservare il gioco di luci e l’instabilità atmosferica che la circondava e nel pomeriggio le nubi erano tornate a coprirla. Il gruppo era già arrivato dove nessun uomo si era mai spinto prima. La prima volta, pensò Mallory, il successo era stato suo prima ancora di partire. Al ritorno dalla seconda spedizione, invece, il «Times» lo stava già accusando del disastro che aveva repentinamente posto fine al tentativo del 1922. Un’ingiustizia, 15 ma nel bene e nel male il suo nome era ormai diventato sinonimo di Everest. All’epoca, mentre viaggiava verso Parigi per incontrare Ruth, lo animava la certezza di aver chiuso per sempre con quella montagna e in albergo le aveva promesso che non ci sarebbe tornato mai più. «Era l’ultima volta, giuro. Non è di questo che ho bisogno, ma di te.» E ci credeva davvero. Così come aveva continuato a crederci anche l’anno successivo, persino dopo che Arthur Hinks, presidente del Mount Everest Committee, gli aveva chiesto di riprovarci ancora nel 1924, per la terza volta, benché nel frattempo stessero valutando altre candidature e formando un corpo di spedizione alternativo, in cui lui non figurava. Aveva cercato di togliersi l’Everest dalla testa, ma quella montagna era il primo pensiero con cui si svegliava al mattino e l’ultimo con cui si coricava alla sera. Un pensiero che non lo aveva certo abbandonato mentre i giornali annunciavano i nomi dei componenti della vecchia spedizione destinati a cimentarsi di nuovo nell’impresa – «il colonnello Edward (Teddy) Norton e il dottor Howard Somervell» – e che tanto meno se n’era andato mentre immaginava i compagni conquistare la sua vetta. Poi, un giorno, Ruth gli aveva detto: «Stai pensando di tornarci». Non era una domanda. Se ne stava davanti alla finestra rigata di pioggia, in sottofondo il picchiettio delle gocce sui vetri e il gorgoglio dell’acqua nelle grondaie. Lui avrebbe dovuto negare oppure tacere, ma era già troppo tardi. «Credo che la cosa meriti una riflessione. In fondo la mia esperienza è preziosa, nessuno c’è mai stato più volte di me. Se dovessero farcela e io non… Ricordi quante cose abbiamo sognato insieme, quando me lo proposero la prima volta?» 16 «Teddy. Teddy ci è già andato» aveva ribattuto Ruth. «E anche il dottor Somervell. Tu ci sei stato solo una volta più di loro, George. E poi adesso le tue responsabilità sono qui: insegni a Cambridge, e non credo che i bambini sopporterebbero l’idea di vederti partire di nuovo.» Aveva cercato di non pensare a quando, al suo rientro nel ’22, John l’aveva addirittura respinto. Ma allora era piccolissimo, mentre adesso ormai avevano avuto modo di trascorrere tempo insieme e di conoscersi. Stavolta sarebbe stato diverso. «Avevi detto che avevi chiuso. L’avevi giurato» aveva insistito lei in tono tagliente. Poi, dopo un respiro profondo: «Ti conosco, George: stai solo aspettando il mio via libera per partire». «No» aveva protestato lui debolmente, ma Ruth aveva ragione e lo sapevano entrambi. Alla fine lei aveva accettato di valutare quella possibilità e lui le aveva promesso che avrebbero preso la decisione insieme. Quando però da Hinks era arrivato l’invito definitivo, George non era riuscito a trattenersi e aveva risposto di sì senza consultarla. Poi aveva atteso per giorni di trovare il momento migliore per dirglielo. Un pomeriggio, dopo una riunione al college, era rientrato deciso a parlarne. Lei era seduta in sala da pranzo, una silhouette perfetta stagliata sullo sfondo del crepuscolo dietro ai vetri. Gli era venuta subito voglia di baciarla e di sollevarla in un abbraccio, ma la sua immobilità e la piega triste delle sue labbra glielo avevano impedito. «Sapevo che non avresti permesso a nessun altro di scalarla» aveva esordito lei senza guardarlo, il suo profilo un cameo che avrebbe tanto voluto portare via con sé. «Nonostante i tuoi proclami e le tue promesse, fin da quando il Comitato ha deciso di ritentare sono stata 17 certa che ci saresti stato anche tu. Bastava solo che me lo dicessi.» Aveva ragione, e lui non avrebbe mai voluto che venisse a saperlo così. Il telegramma spiccava chiaro e luminoso sul tavolo di legno. Immaginarne il contenuto non era stato difficile: Felice di averLa di nuovo con noi. Maledetto Hinks. «Mi dispiace, Ruth» aveva replicato. «È che devo andare. Devo, è la mia montagna. Non puoi non capire.» Lei aveva scosso la testa, come per dire che no, invece non capiva, non poteva proprio capire. «Questa sarà davvero l’ultima volta. L’ultima.» «L’avevi già detto, George, e io ti avevo creduto. Non so se posso farlo ancora.» «Ruth…» «Zitto, non peggiorare le cose.» Si era alzata, e lo spostamento d’aria aveva fatto volare il telegramma per terra. Quando lui aveva risollevato lo sguardo dal punto in cui era caduto, Ruth lo stava fissando, gli occhi quasi invisibili nella luce ormai fioca. Si era portata le mani alla bocca. Poi: «Dovrai trovare il modo di dirlo ai bambini. Clare sarà molto delusa» aveva aggiunto, passandogli accanto per dirigersi alla porta. Delusa. Sapeva che sua figlia si sarebbe sentita così: soprattutto delusa, delusa e tradita. Con una smorfia aveva cercato di cancellare quella parola. «Quando parti?» Ruth era ferma sulla soglia e gli dava le spalle. «Andrà tutto bene, vedrai. Solo questa volta ancora, e mai più.» «Quando parti?» aveva ripetuto lei. I mesi successivi erano stati difficili. Ruth era apparsa silenziosa e chiusa in se stessa, e quando parlava era solo per esprimergli un educato sostegno. Mallory aveva sentito la sua mancanza ancora prima di mettersi in viaggio. 18 La sera prima della partenza avevano fatto l’amore nell’estraneità di una stanza d’albergo e lei si era avvinghiata al suo corpo con una disperazione simile a quella del vento sulla montagna, lottando contro di lui fino a lasciarlo esausto e boccheggiante. Entrambi erano arrivati all’addio diversi: la separazione imminente li aveva cambiati, li aveva resi più audaci. Il mattino seguente a bordo dell’rms California lei lo aveva salutato con un bacio, poi aveva annuito con forza e si era girata per ridiscendere la passerella, i fianchi ondeggianti sotto la gonna lunga. Dio, perché non gli credeva quando le diceva che era bella? Perché scuoteva la testa e si copriva la bocca con le mani, in quel gesto che la rendeva ancora più bella? Mallory aveva sentito le lacrime pizzicargli le palpebre e un dolore sordo serrargli la gola. Deglutendo a fatica, l’aveva guardata allontanarsi. E mentalmente aveva contato. Sei mesi, forse anche di più, prima di poterla rivedere. Ormai erano passate settimane. Adesso, sul ponte del California, spaziava con lo sguardo sull’oceano Indiano in direzione del punto in cui immaginava trovarsi l’orizzonte, là dove un’ora prima era stato inghiottito dal tramonto. Impossibile rimettere a posto le cose fra lui e Ruth se non mantenendo la promessa ripetutale per anni: conquistare l’Everest e poi lasciarselo alle spalle per sempre. Nella lettera che aveva iniziato a scriverle nel pomeriggio aveva tentato di spiegarglielo di nuovo, di farle capire perché quel bisogno di partire, perché non c’entrava nulla con l’amore che provava per lei. Ma non era riuscito a trovare le parole giuste. «Mia Ruth adorata, so che per te è stato difficile, ma per me sei importantissima e saperti lì ad attendere il mio trionfo e il mio ritorno mi dà la forza per andare avanti; in questo 19 modo, ogni giorno che mi vede più lontano da te diventa un giorno in cui il nostro ricongiungimento si avvicina.» Sotto di lui il piroscafo rollava dolcemente e dalle catene e dalle scialuppe di salvataggio si sollevava un coro di cigolii metallici. Ignorando il rumore, Mallory estrasse il diario dalla tasca dello smoking. Nella semioscurità le date in grassetto in cima alle pagine erano a stento visibili. Si sporse dal parapetto per intercettare un po’ della luce riflessa dall’acqua e contò i giorni: altre due notti, poi il subcontinente indiano, il calore cocente e la confusione esotica e fiammeggiante prima di addentrarsi nel nulla delle cartine. Non vedeva l’ora di liberarsi le narici dalla salsedine, dall’odore di pesce e di alghe. L’aria dell’oceano era densa e pesante, gli si appiccicava addosso, gli intasava i polmoni. «Disturbo?» Mallory sollevò gli occhi. «Nient’affatto» rispose, mentre Sandy Irvine lo raggiungeva. Richiuse il diario, cercando di rammentare in che termini nelle sue lettere avesse parlato di lui a Ruth. Probabilmente commentandone la stazza poderosa. «La nostra scalata verso il superuomo», ecco che cosa aveva scritto. Rimise il diario in tasca, prese le sigarette e gliene offrì una, ma Irvine scosse la testa e si appoggiò al parapetto. Alle loro spalle la sala da pranzo era illuminata a giorno, e i camerieri intenti a sparecchiare si scambiavano battute senza più abbassare la voce come facevano in presenza dei passeggeri. «Oggi pomeriggio al tabellone dello shuffleboard 1 abbiamo sentito la sua mancanza.» «Non è un gioco che fa per me, mi dispiace.» 1 Gioco simile alle bocce e al curling, molto in uso negli Stati Uniti e originario probabilmente dell’Inghilterra dove era noto sin dal Cinquecento. Si pratica su un campo di legno o piastrelle di circa 16 metri per 2 e l’obiettivo è lanciare con un bastone un disco di 15 centimetri di diametro verso un oggetto determinato. [N.d.T.] 20 «Io invece ho vinto.» Ma certo, pensò Mallory mentre il giovane si lanciava in un’appassionata descrizione della partita, le sfide di ordine fisico erano il suo pane. Irvine era il più prestante dell’intero gruppo, non il più alto ma palesemente il più robusto fra gli scalatori. «Rappresenta il tentativo da parte del Comitato di iniettare una dose di gioventù nel nostro corpo di spedizione» gli aveva spiegato mesi prima Teddy Norton, quando lui gli aveva chiesto ragione della sua presenza. «Di controbilanciare la nostra, come dire, esperienza.» Nel pronunciare quella parola, aveva inarcato un sopracciglio. «In altre parole, pensano che quel che ci serve sia la forza bruta» aveva ribattuto Mallory. «Ma tu e io sappiamo bene che per arrivare lassù non bastano i muscoli, e come scalatore non mi sembra un granché. Troppo grosso. Troppo pesante per affrontare le pendenze forti.» «Ti aspettavi qualcuno di più simile a te, insomma» lo aveva stuzzicato Norton. Il fatto era che, sotto il profilo fisico, gli alpinisti migliori erano davvero più simili a lui. E a Teddy, aveva pensato Mallory. Alti e sottili, con arti lunghi e una buona presa. Ora, sul ponte accanto a Irvine, si raddrizzò in tutta la sua altezza e si passò una mano fra i capelli, sgranchendo i muscoli della schiena. Se avesse continuato ad affinare le sue capacità, però, anche quel ragazzo avrebbe potuto fare la sua parte in montagna. «Si è esercitato con i nodi che le ho mostrato?» gli chiese. «Li conoscevo già.» «Un po’ di pratica serve sempre, mi creda. Quando ti ritrovi con le dita congelate e il cervello sfrigolante per 21 mancanza di ossigeno, preghi che il tuo corpo si ricordi da solo quel che deve fare. Ci dia dentro, Sandy.» «Non è la prima volta che arrampico. A Spitsbergen con Odell non me la sono cavata male, anzi.» «Questa impresa non ha niente a che vedere con quello che ha fatto fino a oggi. Potremmo morire tutti dieci volte prima ancora di raggiungere la meta: malaria, animali selvatici, burroni. E poi c’è lei, la montagna.» Improvvisamente stava parlando come se fosse in classe alla Charterhouse School, con davanti le facce annoiate degli studenti. Dopo una pausa ripartì all’attacco. «È che non si può mai sapere come si reagirà. Non a quelle altitudini. Ottomilaottocentoquaranta metri: neanche i Camel ci arrivano, e senza maschera a ossigeno i piloti svengono. Mio fratello Trafford era un pilota. Volare era la sua passione, ma mi confidò che le prime volte aveva avuto paura di morire di nausea e vertigini. Sull’Everest è così dall’inizio alla fine, come se avessi addosso la peggiore influenza della tua vita, un mostro piantato sul petto che cerca di squartarti. Ti fa male tutto. Le articolazioni, le ossa, persino la pelle. E l’unico modo perché finisca è raggiungere quella maledetta vetta.» «Capisco.» Irvine si girò a guardarlo dritto negli occhi. I suoi erano piatti, di un celeste sconvolgente, troppo chiaro, come la luce riflessa da uno specchio d’acqua stagnante. «E allora mi dica perché ci andiamo.» Allungò una mano a mollargli un colpetto affettuoso sulla spalla, più una spinta che non un pugno. Poi sorrise e il viso intero gli si illuminò spazzando via l’impressione di piattezza, mentre lo sguardo e l’azzurro degli occhi si facevano più intensi. «Scherzavo» disse. «Non vorrei trovarmi da nessun’altra parte al mondo.» Tornò a contemplare la distesa dell’oceano. 22 Dietro di loro, attraverso la finestra del salotto del capitano, Mallory udiva il tintinnio dei bicchieri e le risate e il chiacchiericcio degli altri membri del gruppo: il capo della spedizione Edward “Teddy” Norton; Howard Somervell, il medico, e Noel Odell, il geologo. Insieme a lui e a Irvine formavano il nucleo degli scalatori, mentre a Bombay li attendevano altri due uomini, Shebbeare e Hazard, soldati aggregati ai reggimenti Gurkha ed esperti (anche più di Norton) degli idiomi e degli usi e costumi tibetani, che avrebbero fatto loro da interpreti e da guide. Di quando in quando lo schiocco e il lampo del flash della macchina di John Noel, il fotografo, tracimavano sul ponte inframmezzando il mormorio della conversazione. Mallory non riusciva a distinguere le parole ma immaginava facilmente ciò che si stavano dicendo ed era già stanco di quelle chiacchiere trite e ritrite: scorte, ossigeno, strategia. Le sbrodolate di Norton. La condiscendenza di Somervell. L’insistenza di Odell, convinto di saperla sempre più lunga di tutti. «Guardi» disse Irvine, indicando l’acqua torbida e nera della scia del California: appena al disotto della superficie sbocciava una fosforescenza verdognola. «Sono alghe» disse Mallory, osservando la coda luminescente allungarsi davanti a loro. «È incredibile.» La voce del giovane, quasi un sussurro ora, si mescolava al ronzio dei motori proveniente dalle viscere del piroscafo. «Odell me ne aveva parlato mentre andavamo a Spitsbergen. Tutte le sere salivamo apposta sul ponte, ma non avevo mai avuto fortuna. Che strane. Mi ricordano l’aurora boreale che vedemmo una volta in Groenlandia.» Mallory si sporse per guardare meglio. Dall’oceano, venticinque metri più in basso, spirava aria fresca. Non 23 aveva mai visto l’aurora boreale, ma questo colore era troppo carico e vischioso per evocargli la luce. Semmai gli faceva tornare in mente i gas nelle trincee e nelle buche aperte dalle granate nella terra di nessuno: si diffondevano nello stesso modo, srotolandosi umidi, più densi e pesanti dell’aria in cui viaggiavano, pronti a addensarsi all’interno di sacche mortali, venendoti incontro quasi sapessero dove stanarti. Era una specie di inseguimento. Mentre l’odore della maschera antigas gli invadeva le narici, tornò a raddrizzarsi per inalare a fondo l’aroma della salsedine, della nafta, della sigaretta che gli ardeva fra le dita. Scosse la testa per liberarsi di quelle immagini e fece un altro tiro. Irvine era troppo giovane per ricordare la guerra. «Quanti anni ha detto che ha?» Lo sentì rizzare il pelo al suo fianco. «Ventuno. Lo so cosa pensa, ma sono pronto. L’Everest sarà anche una cosa diversa, come dice lei, ma nemmeno a Spitsbergen è stata una passeggiata. Fa un freddo che si gela. La neve ci si scioglieva negli scarponi e giù per il colletto, eravamo costantemente bagnati. È stata l’impresa più difficile che abbia mai affrontato, però era bellissimo sentire che quel che facevo era importante, che gli altri contavano su di me. Come adesso. Non è così anche per lei? Dobbiamo riuscire. Dobbiamo. Contano tutti su di noi.» Dal fondo del ponte giunse la risata di una donna: intensa, ma il tono era forzato. Chi si trovava in sua compagnia non doveva essere per niente divertente, ma lei voleva fargli credere il contrario. George lanciò il mozzicone in mare. «Lo dice anche mia madre» proseguì Irvine «che sono troppo giovane. Ha paura che ci lasci la pelle. “Non sono già morti abbastanza ragazzi?” Le ho risposto che io ce la farò, ma quando sono partito non mi ha detto neanche 24 una parola. Mi ha abbracciato, ma non mi ha detto una sola parola.» Afferrò il parapetto e se ne staccò con una spinta, come a incitare il piroscafo a fare presto. Come se con quel gesto potesse decidere l’esito della spedizione. «Ma quando saremo lassù,» riprese «quando arriveremo in cima all’Everest, allora anche lei capirà perché dovevamo farlo.» Mallory gli lanciò un’occhiata. Quel ragazzo era davvero convinto che non potessero fallire. «Poi ci fanno l’abitudine» gli rispose. «Le madri, dico.» Infilò le mani in tasca. «La mia non si preoccupa nemmeno più tanto. “Mi domando solo come fai” dice, e mi piace l’idea che se lo chieda.» Suo padre invece, pensò. Ai commenti tonanti di suo padre, avrebbe preferito enormemente il silenzio della madre di Irvine. Tacquero, mentre una coppia li superava abbracciata stretta, le voci basse e il tono intimo. Irvine li osservò, tornando a parlare solo quando il rumore dei loro passi fu svanito. «Sì, immagino che alla fine ci si faccia l’abitudine. Ma anche alla lontananza?» Come rispondere a quella domanda? Era chiaro che il giovane Sandy aveva bisogno di essere rassicurato, ma lui non era certo di poterlo aiutare. «No, a quella no» disse infine. «O, almeno, io non mi ci sono mai abituato.» Anche in quel preciso momento si sentiva lacerato. Ma se da una parte odiava restare lontano da Ruth e dai bambini, dall’altra odiava se stesso per quella forma di sentimentalismo, perché era una debolezza. D’altro canto la libertà della separazione era anche un lusso, e lontano da Ruth e dalla quotidianità si sentiva diverso, perciò alla fine non sapeva più chi fosse veramente e chi volesse essere. Da qualche parte sul ponte una porta si aprì e si richiuse, lasciando fuoriuscire una cascata di note. Per 25 un attimo al suo fianco Irvine si mise a canticchiare il motivo, poi tacque. Lo faceva anche Ruth: raccoglieva e canticchiava brandelli di canzoni sentite per caso o inventate, e quando lui glielo faceva notare rideva. «Non è vero,» lo punzecchiava «sei tu che ti sogni le cose.» Dio, come gli mancava! «Comunque sono contento di essere qui.» Irvine lo disse in fretta, quasi temesse di poter essere frainteso circa i timori dei suoi cari. «Insomma, le sono grato di avermi scelto per la spedizione.» «In realtà non è stata una scelta mia» disse Mallory, e a quelle parole ebbe la sensazione che il giovane si ritraesse. Ma non intendeva offenderlo. «Odell è un brav’uomo. Si è già cimentato con altre grandi montagne ed è anche un ottimo geologo e naturalista. È tornato a casa con almeno dieci o quindici nuove specie vegetali, e stavolta spera in qualche fossile. Le sue raccomandazioni meritavano di essere tenute in gran conto, e così è stato» proseguì. «Vuole dimostrare che un tempo l’Everest si trovava sul fondo dell’oceano. Ma ci pensa?» Mallory fissò le onde che si allontanavano dalla nave, sforzandosi di immaginare la profondità di quella massa d’acqua: un abisso equivalente all’altezza dell’Everest. «Una cosa assurda.» «E a noi che importa?» «Infatti.» «Quel che conta è che sia lì.»2 Mallory gli lanciò un’occhiata sbieca e Irvine gli sorrise: la citazione era soltanto una bonaria presa in giro. «Ma dài! Questa non l’avevo mai sentita.» 2 Nel 1923 George Mallory andò negli Stati Uniti per raccogliere fondi a favore della spedizione del 1924. A quanti gli chiedevano perché volesse scalare l’Everest rispondeva: «Because it’s there» (perché è lì). Irvine allude proprio a questa frase, passata alla storia dopo essere stata pubblicata dal «New York Times» in occasione di un’intervista. [N.d.T.] 26 «Mi scusi, non ho resistito.» Irvine guardò il cielo notturno, le sagome di costellazioni sconosciute. L’umidità gli si era depositata sui baveri della giacca sotto forma di una leggera spolverata di sale. Sullo sfondo più luminoso del cielo, agli occhi di Mallory appariva come un’ombra affascinante. Alle loro spalle una nuova esplosione di voci, seguita da quella che sembrava la risata di Somervell. Irvine si girò. «Rientriamo?» «Vada pure. Io ho da finire di scrivere alcune lettere. E poi son sempre le stesse chiacchiere.» «Come preferisce.» Ma, prima di allontanarsi, lanciò un’ultima occhiata dal parapetto. «Andate» disse in tono deluso. Per un attimo Mallory non capì bene a che cosa si riferisse, poi notò una nuova oscurità nell’acqua, un nero più compatto di quello osservato solo pochi minuti prima. Le alghe erano scomparse, la fluorescenza verde svanita; restava solo il rimescolio scuro del mare. «Le racconterò quel che si sarà perso.» Irvine fece una breve pausa, forse in attesa di una risposta, poi si mosse verso il salotto. Mallory sapeva che in quei giorni il ragazzo lo aveva osservato parecchio per prendergli le misure. Ma che cosa aveva visto? Un vecchio? Trentasette anni non erano poi tanti, ed era ancora forte e in forma. «Un soggetto perfetto per la spedizione», recitava il suo profilo medico. Anche gli altri, del resto. E come avrebbero potuto non essere in forma? Nessuno di loro batteva certo la fiacca, anche se Odell era decisamente magro: la montagna non avrebbe potuto spolparlo più di così. Ma Irvine… Irvine sembrava il più forte di tutti. Tornò a girarsi verso l’oceano e con lo sguardo provò a risalire le creste delle onde, una dopo l’altra, fin dove riusciva a vedere. 27
Scaricare