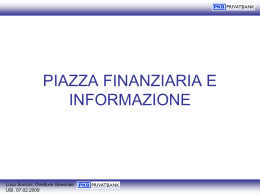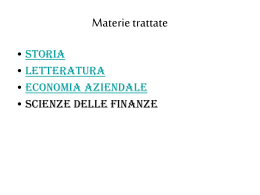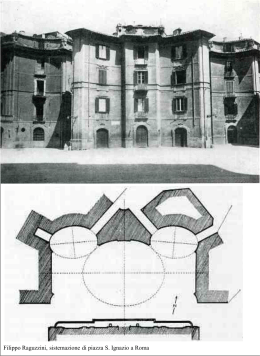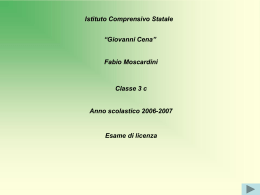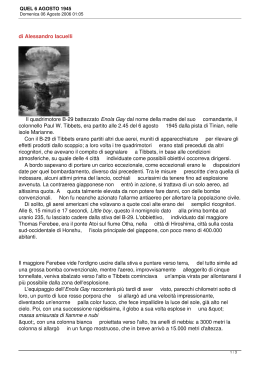mi r ia m m a fa i il lungo freddo Storia di Bruno Pontecorvo, lo scienziato che scelse l’Urss Proprietà letteraria riservata © 2012 RCS Libri S.p.A., Milano Published by arrangement with Marco Vigevani Agenzia Letteraria ISBN 978-88-17-06119-3 Prima edizione BUR Saggi ottobre 2012 Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu Prologo Piazza Verdi, agosto 1950 L’uomo, seduto sullo sgabello davanti alla Casa dell’Automobile, si faceva vento con un giornale ripiegato. Sudava. Di tanto in tanto allontanava, con un gesto infastidito della mano, le mosche. L’asfalto rovente mandava un odore acido. Piazza Verdi, a Roma, tra via Bellini e via Cimarosa, alle spalle di Villa Borghese, era più che una piazza uno slargo, un grande spazio vuoto. A quell’ora – era il primo pomeriggio di un giorno di fine agosto – i ragazzi venivano costretti in casa, dietro le persiane accostate. Solo più tardi, quando il ponentino avesse cominciato a soffiare sulla città, sarebbero usciti per andare a mangiare un gelato, fare una corsa fino a Villa Borghese, o giocare per la strada una partita di pallone. Sulla piazza incombeva l’edificio bianco del Poligrafico dello Stato. Il gran silenzio estivo era interrotto soltanto dallo sferragliare dei tram lungo il viale alberato che si snodava al di là della piazza e che, stringendo il quartiere come in un anello, ne definiva i confini. Rolando B. conosceva da tempo immemorabile quel quartiere e i clienti della Casa dell’Automobile. Li conosceva uno per uno: erano medici, avvocati, notai, funzionari dello Stato, che abitavano lì attorno, nelle vecchie ville di via Salaria (tutte con il loro bel giardino davanti e una torretta merlata) o nei lussuosi condomini costruiti poco prima della guerra sulla collina verde dei Parioli. La nuova Lancia Aurelia era la macchina preferita dai suoi clienti, ma non tutti la possedevano. Era la fine di agosto del 1950. I ricchi erano partiti in ritardo per le vacanze. Alla fine di giugno era scoppiata la guerra in Corea, e con la guerra si era diffusa una incertezza che as- 6 Il lungo freddo somigliava al panico. Qualcuno aveva pensato di riprendere, come una volta, la via della Svizzera. Poi il barometro si era fissato al bello e il quartiere si era svuotato: via tutti al mare, con mogli bambini cameriere e bambinaie, a Capri a Rapallo a Viareggio o in montagna a Cortina e a Chamonix. Al Lido di Venezia Barbara Hutton, la miliardaria americana giunta al suo ottavo matrimonio, si esibiva in un costume da bagno rigorosamente nero e rigorosamente intero; a Capri la splendida Consuelo O’Connor sposata Crespi passeggiava a piedi nudi, un filo d’oro attorno alla caviglia, in un due pezzi assolutamente scandaloso; a Viareggio per la cerimonia del premio si erano rivisti, dopo molti anni, signori in smoking e signore in abito da sera. Tra un paio di settimane, a metà settembre, lentamente, il quartiere avrebbe ripreso la sua vita di sempre: le bambinaie sarebbero tornate a spingere le carrozzine verso il Parco dei Daini, le signore sarebbero tornate a bere un aperitivo al bar di piazza Ungheria e a frequentare, la domenica, la Messa nella stessa chiesa mentre Rolando B. sarebbe tornato a salutare, ogni mattina, i suoi clienti. L’uomo continuava a cacciare le mosche e a sventolarsi in attesa del ponentino quando sulla piazza deserta irruppe una macchina inglese, che si fermò a pochi passi da lui con un esagerato stridore di gomme. Gli inglesi non erano simpatici a Rolando B. e nemmeno gli americani, ma erano quelli che lasciavano le mance più cospicue e quindi andavano trattati con riguardo. Dunque smise di sventolarsi e si alzò per andare incontro al cliente straniero. L’uomo scese dalla macchina, che in verità a guardarla bene era piuttosto malandata e coperta di polvere come se avesse fatto un lungo viaggio, e gli si rivolse, giocando con le chiavi che teneva in mano, in perfetto italiano. Era giovane, abbronzato, i capelli neri e lisci pettinati all’indietro, gli occhi chiari. Indossava pantaloni di lino bianco e una maglietta aperta sul collo, non portava calze, aveva sandali impolverati e sporchi ai piedi nudi. Conosceva questa macchina?, chiese lo sconosciuto. Poteva revisionare il mo- Prologo 7 tore, lavarla e ingrassarla, cambiare l’olio? Certo che poteva, assicurò Rolando che si impegnò a restituirgli la macchina perfettamente in ordine in un paio di giorni. Lo straniero (ma era davvero uno straniero?) sembrò soddisfatto. Gli lasciò le chiavi e lo salutò con un cenno cordiale della mano mentre si allontanava a piedi verso viale Liegi. Il giorno dopo, verso le quattro del pomeriggio, tornò, questa volta accompagnato da un bambino di una decina d’anni, i capelli biondi tagliati cortissimi. Si trattenne solo qualche minuto: lo guardò lavorare, ritirò qualcosa da una tasca laterale dello sportello della macchina e si raccomandò, ancora una volta, che l’olio fosse quello da lui richiesto. Il giorno dopo all’ora fissata la Vanguard targata H.V.C.744 era pronta ingrassata e pulita, l’olio cambiato e il motore revisionato, una gran bella macchina, dopotutto, anche se mal tenuta. Ma nessuno venne a ritirarla. Nessuno venne nemmeno nei giorni seguenti, e nemmeno nella prima settimana di settembre e nemmeno nella seconda. Fino a quando il meccanico decise che non era prudente tenere in garage una macchina di cui non conosceva il proprietario, e che poteva anche essere stata rubata. Alla fine si rivolse al commissariato di zona. Nella tasca interna della macchina non c’erano più i documenti, ma non fu difficile risalire dalla targa al nome del proprietario. L’uomo che il 29 agosto aveva portato la Vanguard alla Casa dell’Automobile di piazza Verdi, che era tornato il giorno dopo per sollecitare il lavoro, e che non era più tornato a ritirarla, si chiamava Bruno Pontecorvo. Aveva trentasette anni un sorriso accattivante, grandi occhi chiari e l’aspetto di uno sportivo, di un uomo abituato a vivere molto all’aria aperta. Era invece un fisico, abituato a passare la maggior parte delle sue giornate al chiuso di un laboratorio, a studiare i misteri del nucleo e delle particelle elementari. Originario di Pisa, aveva fatto parte, nei primi anni Trenta, della celebre Scuola di via Panisperna sotto la direzione di Enrico Fermi. Poi, nel 1936, si era trasferito a Parigi per lavorare al Centro 8 Il lungo freddo di energia nucleare di Joliot-Curie. Da lì era fuggito per raggiungere l’America poche ore prima che la capitale francese venisse occupata dai tedeschi. A guerra finita era tornato in Europa, per lavorare nel Centro atomico di Harwell, in Inghilterra. Da due anni era cittadino inglese. Tutti questi e altri particolari vennero accertati dalle competenti autorità, nel corso delle prime settimane di settembre. Ma nessuno denunciò la sua scomparsa. In altri tempi la sua sparizione sarebbe stata considerata un fatto puramente privato, senza rilevanza, ma da quando, il 6 agosto del 1945, la prima bomba atomica era scoppiata su Hiroshima, da allora i fisici erano considerati, in tutto il mondo, personaggi di grande importanza, la risorsa militare fondamentale di cui uno Stato potesse disporre. La politica e la scienza militare avevano bussato con violenza alla porta della fisica moderna, si erano impadronite dei laboratori, degli uomini che vi lavoravano e della loro intelligenza, ne avevano messo sotto controllo le vite, gli esperimenti e i pensieri. Quanto valeva, dunque, in quel momento Bruno Pontecorvo? Conosceva o no la formula della bomba atomica? Di quali segreti era entrato in possesso? Quali misteri era in grado di svelare? E quale Stato se ne sarebbe servito a partire da quel 29 agosto 1950, quando aveva abbandonato la sua macchina a Roma, nel garage di piazza Verdi? prima parte 1 Il segreto della bomba La prima bomba atomica del mondo assomigliava «a un bidone della spazzatura allungato e con le pinne». Così l’aveva descritta Paul Tibbets, il comandante del B 29 che la portò a destinazione. Lunga poco più di tre metri e con un diametro di 74 cm, tutta di opaco acciaio brunito, aveva l’aspetto di un cilindro corazzato con un muso leggermente arrotondato. Pesava 4200 chilogrammi. Venne sganciata sulla città giapponese di Hiroshima dall’aereo che lo stesso Tibbets aveva battezzato, in onore della sua mamma, Enola Gay. Erano le 8 e 15 del mattino del 6 agosto 1945. Dopo 43 secondi esatti esplose a 570 metri dal suolo, sopra l’ospedale Shima, 170 metri a sud-est del ponte Aioi. «Eravamo a diciotto chilometri e mezzo in linea d’aria dall’esplosione atomica, ma tutto l’aereo scricchiolò e cigolò per il colpo» raccontò lo stesso Tibbets. «Ci girammo a guardare Hiroshima. La città era nascosta da quella nuvola orribile, ribollente, a forma di fungo, terribile e incredibilmente alta. Per un momento non parlò nessuno, poi si misero a parlare tutti...» Il mitragliere di coda incaricato di scattare le fotografie così descrisse la scena: «Il fungo era una visione spettacolare di per sé: una massa ribollente di fumo grigio rossastro, e si vedeva benissimo che dentro aveva un nucleo rosso nel quale tutto bruciava... Sembrava una colata di lava o di melassa che coprisse tutta la città e pareva che traboccasse e salisse per le colline... Intanto scoppiavano incendi dappertutto e così in poco tempo diventò difficile vedere qualcosa per via del fumo». 12 Il lungo freddo Quando era scoppiata la guerra Hiroshima aveva 400.000 abitanti, ma molti erano stati evacuati. All’inizio di agosto del 1945, la popolazione residente era di circa 280.000 civili, più 40.000 soldati: 320.000 persone in tutto. I morti di quel giorno furono almeno 100.000, molte altre decine di migliaia morirono nelle settimane e negli anni successivi per malattie ricollegabili alla bomba. La temperatura sul luogo dell’esplosione raggiunse quel giorno i 3000 gradi. Coloro che stavano all’aperto in un raggio di circa un chilometro ebbero gli organi interni vaporizzati e si ridussero a mucchietti di cenere fumigante. Tre giorni dopo una seconda atomica, familiarmente chiamata Fat Man, venne sganciata su Nagasaki. Esplose alle 11 di mattina del 9 agosto a 340 metri di altezza sulle colline della città. A Nagasaki morirono subito 70.000 persone e altrettante negli anni successivi per le conseguenze dell’esplosione. Il giorno dopo l’imperatore Hiro Hito offrì agli americani la resa. La Seconda guerra mondiale era finita ed era cominciata l’era del Terrore atomico. In Europa la guerra era finita già in primavera: il 25 aprile le truppe americane avevano incontrato quelle russe sull’Elba e l’8 maggio la Germania si era arresa. L’Italia aveva firmato l’armistizio due anni prima, nel settembre del 1943. Solo il Giappone dunque resisteva, sia pure in condizioni disperate: la sua produzione industriale era ridotta della metà, la flotta imperiale non era più in condizione di nuocere e la contraerea non riusciva nemmeno a difendere la capitale che, dai primi di marzo, veniva bombardata ogni notte. Di fatto il Giappone poteva considerarsi sconfitto. Proprio nelle settimane successive alla resa della Germania, in un deserto sperduto del Nuovo Messico venivano intensificati gli sforzi per portare a compimento il Progetto Manhattan. Si trattava di mettere a punto una nuova arma alla quale migliaia di scienziati, di tecnici, di ingegneri, di chimici di tutto il mondo stavano lavorando da quasi tre anni nel più assoluto segreto. Il test ebbe luogo il 16 luglio. Quel giorno, al confine tra l’Arizona e il Nuovo Messico, qualcuno notò sbalordito un
Scaricare