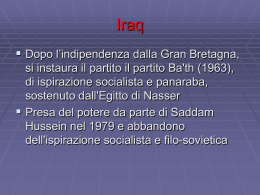ATTUALITÀ il nostro tempo Domenica 20 Aprile 2003 n. 15 7 soli venti giorni: un record. Il mestiere dell’inviato, con i suoi rischi e la sua difficile, talvolta impossibile ricerca della verità fra i contendenti le candeline al «Palestina» déi: come ieri sera, davanti al video, hai pensato di Riccardo Muti che dirigeva la paradisiaca Serenata «La gran partita» di Mozart a La Sapienza di Roma, dopo la chiassata pacifista degli studenti placata dalle parole del Maestro, semplici e dirette come lampi di luce (davanti a un Andreotti impassibile, seduto in prima fila). Poi il Tg3 delle undici, e il tuo umore tracolla: dicono che a Bagdad sono stati uccisi due giornalisti da un colpo di cannone partito da un carro armato americano e finito contro il «Palestine». E’ l’albergo dove gli inviati dei giornali e delle radio-tv di tutto il mondo rimasti nella capitale irachena si sono concentrati dopo che il Pentagono aveva chiesto loro di lasciare la precedente residenza, considerata un obiettivo militare. Con questi due, più uno di Al Jazeera ucciso da un missile nella sede della sua tv, fanno undici. INTERVISTA In venti giorni: un record. Compare sullo schermo la portavoce del Pentagono, Victoria Clarke, una bionda di mezza età dal volto duro, solitamente irritato e irritante. Chiede freddamente scusa ai colleghi dei caduti, ma avverte: «In guerra si muore». Vero, lo dice anche il Papa. Zapping. Su Raiuno c’è «Porta a porta». Vespa ha con sé un assistente, addirittura un generale, che tiene in mano una bacchetta e segnala su una cartina in rilievo di Bagdad i luoghi di cui si parla: il fiume Tigri, le residenze di Saddam (chissà dov’è finito il raìss, causa prima di tutto questo) l’albergo «Palestine». Sullo sfondo, dal «Palestine», Lilli Gruber con un giubbotto su cui è scritto «Press», come un salvacondotto. Parla e la voce le trema, dice che i giornalisti del «Palestine» non sono eroi, tutti hanno paura, ma è il loro mestiere, cercano di farlo il meglio possibile. Vespa appare preoccupato solo di farle raccontare il fatto del giorno, il colpo di cannone del tank, senza un minimo di emozione, senza un giudizio critico. Dal Pentagono sostengono, segnala a Lilli, che il colpo è stato sparato «per autodifesa», può essere vero? Lilli si trattiene, non vuole che qualcuno di An ripeta che lei, come Giovanna Botteri del Tg3, è una «velina di Saddam», un’«infiltrata di sinistra» nella Rai del centrodestra. Si trattiene, ma non può non dire che il Pentagono racconta una frottola: al «Palestine» non c’era in quel momento, né c’è mai stato, un cecchino pronto a sparare sugli americani. Fornisce la prova numero uno di quel che dice: nessuno nell’albergo ha sentito spari nei minuti precedenti il colpo di cannone. Prova numero due: il Pentagono sostiene che erano partiti proiettili dalla lobby al pianterreno dell’al- bergo, ma la lobby è dalla parte opposta al fiume, sulla cui sponda occidentale si trovava il tank. In studio c’è un altro generale, il generale Ramponi, deputato di Alleanza nazionale e presidente della commissione Difesa della Camera. Non fa nulla per nascondere il fastidio che prova per i discorsi di Lilli. Propone un’ipotesi: che l’addetto a quel cannone sul carro armato sia stato messo in allarme da quanto vedeva sporgere dai balconi del «Palestine», e cioè possibili armi da fuoco puntate proprio contro gli americani. Può cioè aver confuso telecamere e macchine fotografiche con kalashnikov. Sul volto di Lilli, a migliaia di chilometri di distanza, appare un’espressione insieme di sorpresa, disgusto, indignazione e commiserazione: come è possibile che il carrista non sapesse cos’era quel palazzo di diciotto piani, dall’altra parte del fiume? Un edificio da cui non venivano spari? E gli ordini impartiti di evitare danni collaterali e perdite fra i civili? E perché ha esploso un solo colpo, se riteneva tanto minaccioso quel parallelepido di cemento color crema e le presunte armi dei presunti cecchi- ni erano tante, appoggiate sulle ringhiere dei balconi? Il generale scuote il capo. Non gli passa nemmeno per la testa che Lilli possa aver ragione. Che l’America possa sbagliare (come i suoi carristi). Che se «in guerra si muore» sia meglio non fare la guerra. Che prima di fare una guerra presidenti, congressi, governi e ovviamente comandanti militari debbano leggere qualcosa; ad esempio «La prima guerra mondiale» dell’inglese B. H. Liddell Hart, un classico in materia di conflitti armati moderni. Quel libro si conclude con una pagina memorabile, in cui si spiega perché sia «assurdo chiedersi quale Paese vinse la guerra»: un elenco freddo e drammatico delle incongruenze e delle contraddizioni in cui ogni impresa di quel genere cade fatalmente, quando la cruda realtà della storia gioca con le velleità degli uomini. Con una lezione di modestia anche per superpotenze (allora il riferimento era la Germania imperiale che progettava l’assalto al potere mondiale): «In tempo di pace la tecnica militare è così potente da scatenare la guerra; in tempo di guerra è così impotente da non riuscire ad assicurarsi la vittoria». Zapping. Un Tg mostra Bush il Giovane e Tony Blair che escono dal loro summit irlandese e si presentano alla conferenza stampa; viene letto il comunicato finale, con quell’unico accenno al ruolo «vitale» lasciato all’Onu per il dopoguerra. Davanti alla domanda «Cosa vuol dire vitale?», George W. fa la stessa faccia stupita e infastidita del professor Kagan. «Vitale vuol dire vitale», è la secca risposta. Zapping. A «Porta a porta» si accende una piccola disputa su quella parola. L’ex premier e ministro degli Esteri Lamberto Dini, fino a quel momento confinato silenzioso in un angolo, sbotta: «Vitale significa che alle Nazioni unite l’America lascia il compito di portare all’Iraq generi alimentari e medicinali. Più vitale di così…». Il controllo del petrolio, gli equi- libri in Medio Oriente, la soluzione della questione palestinese, le altre guerre eventuali rimangono di spettanza americana. «Del resto è logico», conclude Dini sempre più imbronciato, «l’America ha fatto la guerra, l’America è giusto che faccia la pace». Zapping, zapping. Da qualche parte («Primo piano» su Raitre, La7?) irrompe la scena madre, inattesa, straziante: un gruppo di giornalisti sono scesi nel giardino del «Palestine» e accanto a un tendone accendono una candelina ciascuno e la posano su un tavolo. Uno di loro alza gli occhi al cielo e pronuncia i nomi dei colleghi uccisi dal proiettile del carro armato. Forse è spagnolo. Forse prega. Spegni l’audio e mentre la scena va in dissolvenza nel cielo notturno ti sembra di sentire in lontananza il triste walzer tzigano dello zingarello del pullman. Càndito: è l’ora della notizia ridotta a continuo spettacolo La seconda guerra del Golfo ha offerto nuovi e interessanti spunti di discussione sul mestiere dell’inviato. Ne abbiamo parlato con Mimmo Càndito, reporter de «la Stampa» e docente universitario. Da più di 25 anni segue e racconta i conflitti in ogni angolo del pianeta. In questi giorni è in Italia per presentare il suo ultimo libro, «L’apocalisse di Saddam», edito da Baldini & Castoldi. Iniziamo da una questione di deontologia professionale. Cosa pensa del licenziamen- to di Peter Arnett in seguito all’intervista rilasciata a un collega iracheno? Il sistema giornalistico americano è sottoposto a un notevole stress patriottico. Censura pesantemente qualsiasi voce che non sia conformista. Quello che ha detto Peter Arnett sulle strategie americane è la verità, ma nessuno si sentiva di dirla. Il risultato: un gravissimo colpo all’immagine del sistema giornalistico americano. Comunque Arnett è stato subito assunto da una testata inglese… Così è il mondo dell’informazione e per un certo verso quello dello spettacolo. Chiunque diventi un “personaggio” è appetibile dal punto di vista della produzione giornalistica, perché fa pubblicità. Per allestire la sala stampa in Qatar, il Pentagono ha speso 1,2 milioni di dollari, ingaggiando uno scenografo di Hollywood. Che dire? Siamo ormai all’interno della logica della comunicazione spettacolare. Ciò che conta per i produttori di informazione è raggiungere il massimo di efficacia possibile. Il piccolo schermo ha esigenze di spettacolarizzazione, la notizia si “consuma” in pochissimi minuti. Come lavora l’inviato della carta stampata? È consapevole di giocare un’altra partita. Sa perfettamente che il suo ruolo è un ruolo subordinato, al traino dell’informazione televisiva, ma cerca di guadagnarsi spazi che siano autenticamente suoi. Per onestà verso il lettore, ma anche per principio deontologico, deve resistere il più possibile alla pressione della spettacolarizzazione, anche se opera in una realtà dove il pubbli- co è condizionato da questo tipo di comunicazione. È cambiato il modo di “scrivere” la guerra? Oggi la scrittura tende ad essere più attenta alle esigenze della comunicazione visiva: il giornalista è consapevole che comunque la notizia si consuma per immagini. La tv è tornata a essere protagonista dopo il Vietnam? Sicuramente. La tv ci sta portando la guerra in casa. Fino all’Afghanistan la scelta era di tener lontano i giornalisti dal campo di battaglia. Adesso li si «incastra» (dal termine americano embedded) al se- guito delle truppe. L’obiettivo (almeno all’inizio) era di legittimare l’intervento attraverso sequenze di immagini corroboranti per il patriottismo e la retorica Usa. La prova sul campo ha deluso le aspettative di politici e militari, ma resta il fatto che siamo dinanzi a una guerra “televisiva”. Nel conflitto del 1991 nastia hashemita (rovesciata nel luglio 1958 da un cruento colpo di Stato militare, colpevolmente tollerato dagli inglesi) potrebbe sperare di impedirne l’esplosione. Ne verrebbe certo garantita la costituzione di un governo super partes, con un minimo di tolleranza (secondo la migliore tradizione hashemita) in mancanza di una vera democrazia, davvero difficile, se non impossibile, da instaurare in un Paese sostanzialmente tribale dai fondamenti islamici. Rebus sic stantibus proprio non vorremmo che di lì a qualche tempo gli iracheni “liberati” dovessero giustificatamente pronunciare l’abusata frase «si stava meglio quando si stava peggio». avrebbe dovuto insegnare qualcosa all’ingenuo George W. Bush degli americani dittatura del Viet-Minh, mentre in Cambogia spadroneggia il criminale Pol-Pot. 1979 - Figuraccia del democratico Carter che, dopo aver tradito il regime filo-occidentale dello scià, fallisce clamorosamente il tentativo di salvare alcuni prigionieri americani, finendo per rafforzare il brutale regime di Khomeini e consegnare di fatto la Casa Bianca al repubblicano Ronald Reagan. 1991 - Gli Stati Uniti costringono l’Iraq ad abbandonare il Kuwait, ma Bush sr. Non conclude l’opera lasciando indenni le strutture del regime totalitario di Saddam Hussein, che in compenso manda a morte mi- Dal 1917 a oggi, passando per la Russia di Stalin, la Corea, Nasser, il Vietnam, l’Iran dello Scià e di Khomeini: quante scelte sbagliate... gliaia di curdi e sciiti, finiti giustamente sul conto degli americani. Sono due etnie, sentenziano i nostri radio e telecronisti che, unitamente a una terza (i sunniti), danno vita all’Iraq. È una sciocchezza piramidale. Equivale a dire, per esempio, che in Germania ci sono attualmente tre etnie: turchi, luterani e cattolici. Gli americani tuttavia, notoriamente incolti e ignari della storia altrui, nulla sanno, a differenza degli inglesi, dell’intricata vicenda dell’Iraq, che venne inventato da Churchill dopo la Grande guerra ritagliandone i confini sulla carta geografica. Naturalmente tutto ciò ha pesato sul modo politicamente superficiale di affrontare questa guerra, senza cioè valutare appieno l’esistenza di secolari contenziosi sia di natura politico-religiosa fra sciiti e sunniti, sia etno-politici fra turchi e curdi, i quali sembrano intravedere finalmente l’agognata meta di un Kurdistan indipendente (o almeno autonomo nell’ambito di un presunto Iraq federale), ma anche trascurando l’esistenza di una minoranza turcomanna che guarda consapevolmente ad Ankara. Ci troviamo insomma dinanzi a un’autentica polveriera che finora controllata con il terrore di Saddam Hussein, oggi forse soltanto un’eventuale restaurazione (però improbabile) della di- 100 95 92,2 Kosovo Palestina 80 57,6 60 la stampa era imbrigliata. Oggi il Pentagono ha permesso a centinaia di giornalisti di seguire le truppe. Un passo avanti? Il guinzaglio non è meno corto, anzi. L’inviato embedded è subordinato agli ordini del comandante del battaglione in cui si trova: deve accettare di avere un orizzonte limitato. In qualche modo è come se si piegasse ad essere giornalista di agenzia, cioè a riportare soltanto una piccola parte di quello che sta avvenendo. Senza non pochi rischi, c’è comunque chi, spinto dalla voglia di conoscere e raccontare, viaggia da solo per il fronte e riesce ad avere una visione globale dell’evento. Cnn e Al Jazeera forniscono spesso notizie contrastanti. Dove finisce l’informazione e inizia la propaganda? Da tempo si dice che la Cnn è diventata il braccio televisivo della Casa Bianca e che Al Jazeera è mossa da uno spirito di fratellanza musulmana. La verità va ricercata nel confronto tra le due diverse fonti di informazione. Al Jazeera per prima ha mostrato le immagini dei soldati morti al fronte. Censura pesante oltre oceano, minore in Europa. Chi ha ragione? In Europa molte tv si sono trincerate dietro alla deontologia professionale e al diritto all’informazione. Le Colombia, Guinea Bissau, Angola, Sierra Leone, Sri Lanka 42,4 40 20 7,8 5 0 tv radio giornali SCHEDA Cronisti al fronte: quanto ci costano S E LA GUERRA in Iraq costa in media 300 milioni di dollari al giorno, le spese della copertura informativa non sono da meno: solo per il media center di Doha, in Qatar, il comando centrale Usa ha sborsato 1,2 milioni di dollari (circa due miliardi e mezzo di vecchie lire). Dotato di 24 grandi schermi televisivi ultra sottili al plasma, con impianto audio dolby hi-fi per assicurare la massima fedeltà alle veline del generale Tommy Franks, il centro è di fatto un set spettacolare progettato da George Allison, uno dei più noti direttori artistici di Hollywood, assoldato dal PentagoBambini a Baghdad davanti a un carro armato americano (Sir) e, nel riquadro, l’inviato de «La Stampa» Mimmo Càndito. In alto a sinistra, accanto al titolo, l’ingresso delle truppe statunitensi nella capitale irachena (Sir) e, nell’immagine piccola a destra, la giornalista del Tg3 Giovanna Botteri. A fondo pagina, una statua di Saddam Hussein presa a calci (Sir) Parla un “vecchio” del giornalismo più pericoloso CARLO VIGLIANI Percentuale di spazio riservato alle notizie su sette guerre-campione (dati Caritas, Italia, 1999-2001) tv Usa, invece, hanno dato priorità all’etica patriottica: d’altronde i morti erano tutti angloamericani. I media hanno ancora un forte potere sull’opinione pubblica? In astratto sì, in concreto no. Negli Stati Uniti c’è la campagna promozionale a favore della guerra è impressionante. Certo, non mancano le voci fuori dal coro: il «New York Times», ad esempio, ha chiaramente detto no alla guerra, però il quadro generale resta segnato da un forte spirito patriottico. Qual è oggi l’equipaggiamento standard di un inviato di guerra? Sicuramente il cellulare satellitare. E poi il video telefono, il computer portatile, un elmetto, un giubbotto anti proiettile, viveri di sussistenza, tanto denaro e, magari, una macchina da scrivere per quando manca l’elettricità. I diari su Internet (i cosiddetti blog) sono utili al processo dell’informazione? Temo che rispondano più che altro al processo di spettacolarizzazione cui accennavo sopra, perché sono espressione di sentimenti ed emozioni. Servono sicuramente a comprendere ciò che sta avvenendo in una realtà , ma non la rappresentano meglio di quanto possa fare il precorso tradizionale del giornalismo, che è invece un processo di analisi distaccata. no per 200 mila dollari. Nella corsa al war show anche i mass media non sfigurano. Fare una stima esatta dei costi diretti è pressoché impossibile: le variabili sono infinite, a cominciare dalla durata del conflitto. Tuttavia qualche conto in tasca si può fare. La Rai, ad esempio, ha in tutto sedici inviati: 7 per il Tg1 (tra cui Lilli Gruber, Monica Maggioni e Duilio Gianmaria), 4 per il Tg2 (tra loro Sandro Petrone e Angelo Figorilli), 5 per il Tg3 (compresi Giovanna Botteri, autrice dello scoop sul bombardamento in diretta a Baghdad, e Giovanni Buonavolontà). Non solo: ogni giornalista ha almeno un telecineoperatore al seguito. E per tutti: biglietti aerei, alberghi, assicurazioni, attrezzature. Solo i videotelefoni satellitari «Immarsat», i preziosi ritrovati tecnologici che trasmettono voci e immagini senza utilizzare i ripetitori di terra, costano 35 mila euro l’uno e ogni inviato ne ha in dotazione due. Insomma, la stima di viale Mazzini all’inizio delle ostilità si aggirava sui 5 milioni di euro totali, ma difficilmente sarà rispettata. E Mediaset? Gli inviati in tutto sono sette, tra cui Tony Capuozzo, Mimosa Martini, Pietro Suber e Silvia Brasca. Secondo i calcoli del presidente del Biscione, Piersilvio Berlusconi, la copertura della guerra dovrebbe costare circa 40 mila euro al giorno. Pesanti anche i costi indiretti dovuti ai mancati introiti pubblicitari. Negli Usa i guru del marketing hanno infatti bloccato gli investimenti e hanno revocato annunci pubblicitari per oltre 100 milioni di dollari. In Italia l’effetto della guerra sulla pubblicità è più lieve, ma ha comunque messo in allarme i grandi inserzionisti che già devono fare i conti con consumi debolissimi. L’imprenditore Diego Della Valle, ad esempio, ha chiesto a quotidiani e riviste di sospendere le inserzioni relative alle sue scarpe di lusso Tods. Altre marche (come Genertel, Tele2 e alcune case automobilistiche) hanno imposto ai creativi di eliminare dai messaggi le scene di incontrastata felicità urbana, per puntare su sconti e promozioni. Ma anche gli editori sono corsi ai ripari, come rivela Felice Lioy, direttore generale dei pubblicitari Upa: «Per favorire le aziende che non vogliono congelare o far slittare la pubblicità televisiva in un periodo cruciale come quello delle feste pre-pasquali, Rai e Mediaset hanno istituito una “zona franca” depurata dalle news di guerra, una sorta di riserva che va dalle 20 alle 22,30». Gli affari sono affari, anche sotto le bombe. [l.r.]
Scaricare