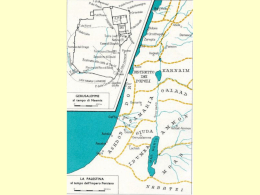IL ROMANZO Ishtar è ancora una fanciulla quando viene rapita da una spedizione di guerrieri ittiti. È lei – conosciuta da tutti come la camminatrice dei sogni per i suoi poteri straordinari – che la Profezia indica come la sola capace di sconfiggere la peste che da mesi semina morte tra la popolazione della Terra di Hatti, uno dei regni più potenti dell’antichità. Da qui, ha inizio un viaggio affascinate continuamente sospeso tra storia e mito che cambierà per sempre il destino di Ishtar e trascinerà il lettore in un’avventura entusiasmante tra intrighi di palazzo, lotte eroiche e battaglie epocali. L’AUTRICE Irene Grazzini è nata nel 1985 ad Arezzo e lavora come medico a Siena. Le sue passioni sono la musica, l'equitazione (ha un cavallo di nome Emilton), i viedeogiochi e la letteratura. Collabora con le riviste web Fantasy Magazine e Altrisogni. I signori dei cavalli di Irene Grazzini © 2014 Libromania S.r.l. Via Giovanni da Verrazzano 15, 28100 Novara (NO) www.libromania.net ISBN 9788898562237 Prima edizione eBook gennaio 2014 Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo elettronico, meccanico, in disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione, senza autorizzazione scritta dell’Editore. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione. Progetto grafico di copertina e realizzazione digitale NetPhilo S.r.l. Qualsiasi riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale e indipendente dalla volontà dell’autore. I signori dei cavalli PROLOGO I sette uomini attendevano in religioso silenzio. Avvolti in mantelli di lana nera, stavano in piedi di fronte alla grande porta chiusa. Sui battenti di legno si stagliavano in rilievo due tori che si fronteggiavano a testa bassa. Statuette di terracotta che li rappresentavano erano sparse ovunque tra le colonne, indicando come quel luogo appartenesse al dio della tempesta di Sarissa. Il vento che spirava da oriente spazzava il cortile con violenza, ma gli uomini non battevano ciglio. Muti e immobili, parevano anch’essi statue alla luce della luna che brillava sulle corazze di bronzo, sugli elmi rotondi e sull’elsa delle spade ricurve che portavano alla cintura. Il metallo era freddo a contatto con i loro corpi, ma tremare sarebbe stato sintomo di debolezza. I deboli morivano e i forti sopravvivevano. Persino gli dei rispettavano questa legge, feroce nella sua semplicità. Con l’avanzare della notte la temperatura si abbassò e la falce della luna cominciò a combattere con le nubi che cercavano di soffocarla. Qualche goccia di pioggia ticchettò sulle armature, ma gli uomini non si muovevano. Arrivò un altro guerriero. Anche lui era armato, ma teneva in mano l’elmo e il volto tradiva lo sforzo della corsa per arrivare fino a lì. Un uomo si staccò dal gruppo per andare ad accoglierlo. L’elsa della sua spada era placcata d’oro. Intendeva ostentare il suo rango perché aveva paura di perderlo. “È arrivato?” chiese in un sussurro, come temendo che il vento portasse le sue parole a orecchie indiscrete. “Sì, principe,” rispose il guerriero in fretta, “ti aspetta nelle stanze degli ospiti.” “Allora prendi il mio posto e di’ agli altri che devo sbrigare una breve incombenza” disse Urhitesup, figlio del re Muwatalli, signore della Terra di Hatti. Gettò una rapida occhiata alla scorta che attendeva alle porte. La pioggia si stava infittendo, era sottile e pungente. Sapeva che non si sarebbero mossi, fin quando il re non fosse uscito dalle sacre celle del dio Teshup, la Tempesta. Cercava una risposta da cui poteva dipendere il futuro della sua nazione. Se non era possibile trovarla tra gli uomini, non restava che rivolgersi agli dei. Ma non sempre gli dei erano in ascolto delle parole dei mortali. E Urhitesup temeva che neppure parlassero la stessa lingua. Erano due mondi che non potevano comprendersi. Attraversò a passo rapido il cortile pavimentato con mattoni di terracotta, con un colonnato ai due lati. L’intero complesso gli ricordava i templi della capitale, Hattusas, ma era più piccolo, raccolto. Più... intimo. Si respirava un’aria di quieto mistero e, mentre camminava tra le ceneri dei sacrifici che ancora ricoprivano il grande cortile, Urhitesup cominciò a provare un senso di inquietudine sottile. Quello non era il posto giusto per l’incontro che sua madre aveva programmato per lui. Ma ormai l’emissario era arrivato. Rimandarlo indietro non avrebbe mondato la sua coscienza davanti agli dei, né coronato i suoi sogni. Avrebbe soltanto vanificato tutti gli sforzi per ingraziarsi gli alleati del sud. Non era difficile, quando si promettevano potere e ricchezza. Un grido acuto riecheggiò nel tempio. Un grido di follia che non aveva nulla di umano. Urhitesup suo malgrado sussultò. La Profezia era iniziata. Allungò il passo, costeggiando la vasca in cui l’acqua lustrale era uno specchio scuro e insondabile. La pioggia lo increspava in minuscole onde concentriche. La montagna, ai cui piedi Sarissa era costruita, era ricca di acqua e poco lontano sgorgava il fiume Mirasantiya, il più importante del regno. Urhitesup lo aveva risalito pochi giorni prima insieme al re e alla sua scorta, spronando i cavalli fino a farli crollare di fatica. La situazione a Hattusas era grave e la fiducia del popolo cominciava a vacillare. I regni vicini aspettavano con impazienza l’evolversi degli eventi, tanti cani ringhianti in attesa di cogliere un attimo di debolezza per piombare sulla Terra di Hatti. Muwatalli sapeva che doveva agire subito, prima che lo scontento dilagasse. Per il momento, solo grazie al fratello il potere era ancora nelle sue mani. Urhitesup strinse il pugno e proseguì. Intorno al tempio erano sorti disordinatamente magazzini e altri locali per i sacerdoti e per i guerrieri, che sorvegliavano il complesso per paura degli incendi. Bastava che una scintilla guizzasse dai focolari per scatenare l’inferno sulla terra e l’ira degli dei. Era già successo e il tempio era stato ricostruito. Ma forse gli dei si erano offesi comunque. Il Morbo Nero però era una punizione troppo grande. La porta della sua stanza era accostata. Urhitesup era convinto di averla lasciata chiusa. Non che importasse, non aveva nulla di valore là dentro. Tutti i suoi averi li portava addosso ed era partito troppo in fretta per preparare il bagaglio. Come principe, era abituato ad agi maggiori nella capitale, ma per lo meno là era al sicuro dal pericolo del contagio. Anche sua madre si era temporaneamente trasferita in una tenuta fuori città, in attesa del responso divino. Tutto il regno lo aspettava con il fiato sospeso. Entrò nella stanza spoglia. Una torcia ardeva su un supporto metallico, lasciando un filo di fumo che si allungava verso la terrazza. Un’ombra si stagliava sotto la pioggia, assaporandola come un dono. Gli abitanti del Regno del Sole non erano abituati ad averla in abbondanza. “Salute, principe” la voce dell’uomo era bassa. Il suo ittita era scorrevole, ma indugiava sulle sibilanti come se gli risultasse difficile pronunciarle in quella lingua che non era la sua. Se a un esame superficiale poteva sembrare un membro della Terra di Hatti, la sua carnagione più scura e la pronuncia più dolce, lo palesavano come egiziano. Urhitesup fece una smorfia. Per lo meno l’emissario aveva rinunciato alla ridicola moda di truccarsi gli occhi e indossare parrucche come una donna. Gli uomini del sud erano delle femminucce. “Vieni dentro” sbottò Urhitesup. Doveva essere lui a condurre la conversazione. Si sentì quasi messo alle strette. Calma, si impose. Suo padre gli aveva insegnato che la calma era indispensabile per ogni trattativa. Anche per quelle rivolte contro di lui. L’egiziano accennò un sorriso. Si strinse nel mantello, sedendosi su una panca di legno. “La vostra terra è ricca di acqua, ma fredda.” Urhitesup non si curò di rispondere. In Egitto forse erano abituati a giochi di parole, ma per lui erano solo una perdita di tempo. “Cosa ne pensa il Faraone della mia proposta?” L’egiziano accavallò le gambe con un movimento sinuoso. Non portava la barba e il suo volto era completamente rasato. Oppure glabro. Osservandolo con attenzione mista a disprezzo, Urhitesup ebbe il dubbio che non fosse un uomo completo. Ma non aveva intenzione di alzargli la tunica per controllare l’integrità dei suoi testicoli. “Ramses II, Amon lo protegga sempre, signore del Sole, poiché il sovrano è Ptah˗a˗sud˗delle˗sue˗mura...” “Sì, sì, ho capito,” lo incalzò Urhitesup spazientito, “senti, non abbiamo molto tempo. Presto mio padre il re uscirà dalla cella del tempio e io dovrò essere là ad accoglierlo, e tu lontano da qui. E nessuno dei due ricorderà di aver parlato con l’altro, siamo intesi?” In caso contrario lui avrebbe negato tutto. Suo padre si sarebbe fidato. Forse. I suoi soldati avevano il compito di uccidere quell’uomo, se si fosse attardato a Sarissa più del necessario. Il sorriso dell’egiziano non ebbe tentennamenti. Sembrava dipinto sulla sua faccia. “Ramses è giovane, ma è come suo padre. Vuole che il suo Ka viva per sempre.” Notò che l’altro si era accigliato. “Il Ka è la sua anima immortale.” Urhitesup cominciava a pensare che niente fosse immortale. Il Morbo Nero lo aveva dimostrato. Gli uomini che un attimo prima erano sani cominciavano a sputare sangue, erano consumati dalla febbre, si gonfiavano come scrofe in calore e si coprivano di pustole sotto le ascelle e l’inguine. I guaritori non potevano nulla, anzi, erano stati i primi a morire, per il contatto con i malati. Il terrore dilagava. Il palazzo era stato isolato per tenere lontano il Morbo, ma era stato inutile. Era giunto e aveva cominciato a mietere vittime, costringendo la famiglia reale alla fuga. Urhitesup era uno dei pochi che ancora manteneva fiducia nel futuro e organizzava piani per quando il Morbo sarebbe finito. Il dio della tempesta avrebbe parlato a suo padre, svelando come espiare la colpa di cui il popolo si era macchiato. L’importante era sopravvivere fino a quel momento. E approfittare della debolezza dell’autorità paterna per aumentare la propria. “In poche parole, vuole la gloria” disse Urhitesup, annuendo. Prese una brocca e versò il vino. In un altro momento il principe avrebbe chiamato il coppiere per riempirgli il calice. Ma non dovevano esserci testimoni a quel colloquio. Altrimenti avrebbe dovuto perdere tempo a ucciderli. Troppi cadaveri erano ingombranti. L’egiziano sollevò il calice con un cenno di ringraziamento, ma non lo portò alle labbra. Aspettava che fosse l’altro a bere per primo. Era un uomo previdente, avvezzo alla vita di palazzo che, a sud o a nord, non era poi così diversa. “Voi abitanti della Terra di Hatti avete il dono della sintesi.” “E voi quello di indorare ogni parola che esce dalla vostra bocca, al pari dei pettorali del vostro faraone.” Urhitesup bevve un sorso. Non sentì nessun sapore, concentrato sull’uomo che gli stava davanti. Su ciò che poteva offrire. “Il faraone ha bisogno di soldi per mantenere il suo esercito. Quindi deve conquistare altre terre. Oppure ridurre le spese militari, assicurandosi l’amicizia dei regni vicini. Wassukanni è stata conquistata. Adesso che i mitanni e i popoli loro alleati sono sotto il nostro impero, non ci sono più cuscinetti che separino i due regni.” Urhitesup si accomodò meglio sullo sgabello. Ci teneva a ribadire cose che l’emissario già sapeva. Gli ittiti e l’Egitto stavano per scontrarsi. “Quadesh e Amurru sono sempre state egiziane” obiettò l’altro, osando un piccolo sorso. Era più dolce della shedeh, la bevanda popolare della sua gente fatta con melegrane o uva. “E adesso non lo sono.” Questa volta fu Urhitesup a sorridere. “Per il momento.” Si tese verso l’emissario, cercando di ignorare il suo lezzo di oli e profumi da donna, come l’egiziano cercava di ignorare il suo odore di sudore e di cavallo. Era uno sforzo per entrambi. “Tra poco saranno truppe a me fedeli a presidiare Amurru. Potrebbero ritirarsi, spaventati dal vostro esercito, senza farvi sprecare neppure un uomo.” L’emissario si accarezzò il mento, pensoso. Non intendeva far trapelare il proprio interesse. “Ma il resto dell’esercito è fedele a tuo padre. E a tuo zio!” Urhitesup tacque. Hattusili era un gran condottiero, ma aveva un difetto: era convinto che gli altri credessero nell’onore come lui. Era un difetto che costava caro. “Lascia che pensi io a lui.” L’ittita guardò negli occhi l’egiziano. “Tu riporta al faraone le mie parole. Amurru in cambio del suo appoggio. E in futuro, se avrò successo, potrei essere così riconoscente da regalare anche Quadesh e il regno di Yamhad, con le sue ricchezze.” Un territorio comunque difficilmente controllabile, soggetto a incursioni sempre più frequenti da parte della gente di Ahhiyawa, che per di più incoraggiava le ribellioni nelle terre di Arzawa contro il dominio ittita. Che gli egiziani si prendessero pure quella rogna e se la vedessero con i popoli del Mare Grande! A Urhitesup bastava diventare re. Quando l’emissario se ne fu andato il principe ittita indugiò nella stanza, sorseggiando il vino senza togliersi di bocca il vago sapore di vittoria. Tutto stava andando secondo i piani di sua madre. “I miei piani” si corresse in fretta. Posò il calice e uscì sulla terrazza, appoggiandosi al balcone. Aveva smesso di piovere e una nebbia sottile si alzava dalle pendici della montagna, srotolandosi nella città sacra. Urhitesup fece passare lo sguardo sull’acropoli e sugli edifici che la racchiudevano. Il muro di fortificazione era forte e delimitava un silo sufficiente per tutta la popolazione, circa cinquemila persone, per un anno intero. Quattro porte si aprivano in corrispondenza dei quattro punti cardinali, munite di alte torri. Un cavallo galoppava oltre la soglia, seguendo il sentiero che portava a sud. L’egiziano era partito con la sua risposta. Urhitesup si chiese se anche il padre ne avesse trovata una. Un ultimo grido proveniente dalla cella del dio. Era convulso e distorto e, per quanto si sforzasse, l’ittita non riuscì a coglierne le parole. Tornò in fretta nel cortile. Muwatalli gli aveva ordinato di vegliare sulle porte del sacrario e lui intendeva obbedirgli. Lo scontro era inevitabile, ma non si sentiva ancora pronto a farselo nemico. Un amico, per di più un parente stretto, era molto più pericoloso. Le porte si stavano aprendo. Una zaffata di fumo acre emerse dai battenti e il vento lo sputò contro gli uomini di guardia. Nel respirarlo, Urhitesup sentì il cuore battere più forte e i colori divenire più vividi. Lo scalpiccio degli stivali di cuoio del padre sulla pietra si fece più vicino e minaccioso. Al chiarore del Fuoco Profetico si stagliò la possente figura di Muwatalli, signore della Terra di Hatti, prediletto del dio della tempesta. Urhitesup strinse gli occhi e non riuscì a vederlo in volto. Si inchinò, insieme agli altri uomini, rimanendo in silenzio. In lontananza gli parve di udire un tuono, il cielo a nord era cupo. Cercò di non pensare, perché i suoi pensieri lo tradivano. Si impose di preoccuparsi del Morbo Nero e del motivo per cui erano giunti fino a lì. Muwatalli continuava a tacere, mentre scendeva lentamente gli scalini di pietra. Urhitesup si azzardò a sollevare la testa, sbirciando verso di lui. “Qual è il responso del dio della tempesta?” domandò, in un soffio. Muwatalli non rispose. Si limitò ad alzare lo sguardo sulla luna che illuminava e tagliava le nubi di tempesta. PARTE PRIMA LA CAMMINATRICE DI SOGNI 1 Il mondo sta cambiando. Lo sento nel fruscio del bosco intorno a me. Nel bubbolio del tuono lontano che lascia la mia terra e si sposta a Occidente, seguendo il sole crollato oltre la volta di un cielo troppo grande. Ricordo gli scoppi assordanti e il divampare dei fulmini che scavavano le nubi di tempesta. Solchi di luce con cui la mano di un dio artiglia il mondo. Non avevo paura. Non l’ho neppure adesso. Ma so che dovrei averla. Il mondo sta cambiando. La tempesta se ne è andata, rapida come è venuta, e sento il cambiamento nel mormorio dell’acqua che scorre sul terreno. Lo disseta e lo rende fertile. È vita, ma troppa può uccidere. Rammento cinque inverni fa, quando il torrente è uscito dal suo corso e ha portato via la capanna di Azan, il conciatore. Era costruita troppo vicino al fiume. Aveva offeso lo spirito dell’acqua ed era stato punito. Me lo ha detto mia madre. Non credo che sia così semplice. Niente è semplice, tanto più in questa notte in cui la luna mostra il suo volto perfettamente rotondo al mondo. Chiudi gli occhi, bambina, e apri quello nascosto... Scuoto la testa e mi spingo nel torrente, nel tentativo di lavare qualcosa che è impresso indelebile dentro di me. Ma in questo momento non so definirlo. Mi sfugge, come quando cerco di stringere in pugno l’acqua del fiume. Rimane solo un sottile strato umido sulla pelle, le gocce si sfaldano tra le mie dita e si riformano sempre nuove, eppure uguali a se stesse. Tutto cambia e rimane immutato. Non capisco. E non controllo l’acqua. Forse non controllo neppure me stessa. L’inquietudine senza nome rimane, sospesa in un limbo pulsante al ritmo del mio cuore. Cerco di non pensarci. L’acqua è fresca sotto le mie zampe. Questo mi confonde. C’è qualcosa di strano. Ma non nell’acqua. È in me. E nel mondo che sta cambiando. Lo sento nella miriade di odori che mi aggrediscono le narici. La pregnanza muschiata del bosco, l’umido grondante del torrente, il sentore nervoso del cinghiale femmina che accudisce i suoi piccoli, l’essenza selvatica di un predatore in agguato nella notte, il tanfo dei maiali nei recinti del villaggio e l’aroma delle capanne in cui il sonno veglia sulle anime stanche. Il vento della notte è prodigo di odori e rumori che mi riempiono e mi assorbono, rendendomi parte di un tutto che affonda le sue radici all’inizio del mondo. Non mi capita spesso di sentirmi così. Mi piace e mi spaventa. Di colpo mi immobilizzo. Sollevo la testa verso le fronde. Anche loro sono immobili, scure, sembrano in attesa. Tendo le orecchie, mentre i muscoli guizzano lungo il mio corpo snello. No, non mi sono sbagliata. Il rumore si ripete. Sordo, beccheggiante, quasi ritmico. Non riesco a identificarlo. Non l’ho mai sentito prima d’ora. Non dovrebbe essere in queste terre strette tra il mare scuro e i rocciosi altipiani del sud, un ventre boscoso che si dibatte fiero della propria libertà selvaggia. Non dovrebbe turbare questa notte in cui sogno e realtà si scontrano fino a rendere fin troppo sottile il confine che li separa. Ma il mondo cambia. Possiamo solo scegliere se rifiutarlo o accettarlo. E al mondo forse neppure interessa. Mi muovo rapida e guardinga seguendo il corso del torrente. La riva è sassosa e così lascio solo qualche impronta che si confonde con quella di uri, cinghiali e lupi che scendono dalle montagne orientali. Nessuno del mio popolo ha mai scalato le loro vette. Sono sacre, quindi oltre l’umano. Si dice che sulla cima più alta sia incatenato un gigante e che un’aquila ogni notte giunga a mangiargli il fegato, che ricresce durante il giorno per rendere eterna la sua sofferenza. A volte, quando non riesco a dormire, mi sembra che il vento freddo che spira da quei monti porti con sé i lamenti del gigante prigioniero. O forse è solo l’eco dei miei. Chi lo ha incatenato ha la stessa crudeltà di chi mi incatena in questa esistenza che non è del tutto mia. D’un tratto vorrei gridare per la frustrazione, ma solo un ringhio sordo esce dalla mia gola. Lo trattengo. Non voglio sentirlo. E non sarebbe saggio rivelare la mia presenza a chiunque stia profanando la mia terra, producendo questo sciabordio. Le acque del torrente si gettano nel fiume, mescolandosi in un grumo di pece che scivola lento verso il mare. So che non è lontano. Una volta l’ho raggiunto e sorvolato, sorpresa di fronte a quella distesa immensa. Mia madre ha riso quando le ho raccontato la mia esperienza. Ha detto che quel mare scuro non è altro che una pozzanghera per il mondo e che esistono distese d’acqua molto più grandi e un uccello può volare per giorni e giorni senza vedere mai l’altra riva. Eppure non è un grosso uccello quello che mi sta davanti. Mi schiaccio nel sottobosco, le orecchie appiattite. Una nuvola ha coperto la luna, ma non mi impedisce di scorgere l’enorme sagoma che si staglia sul fiume. Un muto gigante d’ombra che galleggia magicamente sull’acqua. Sembra fatto di legno e questo ha una logica. Da piccola mi sono divertita a gettare foglie e pezzi di legno nel fiume, osservandoli galleggiare e fluire via, trascinati dalla corrente. Eppure questo gigante sta fermo. Non affonda, non scappa via. Si limita a oziare vicino alla riva e a produrre il rumore che ho sentito poco prima. Non sembra pericoloso, anche se qualcosa mi esorta a stare in guardia. Niente è mai quello che sembra. Un lago visto dall’alto sembra una piatta lamina di metallo e solo guardando sotto la sua superficie se ne comprende la vera natura e i pericoli che cela. Eppure non ho paura. Sono curiosa. Striscio cauta tra i fitti arbusti della riva. L’ombra dell’uccello di legno è una presenza costante che mi spinge alla prudenza. Cosa insolita per me. Mia madre dice che sono impulsiva. E non credo che lo intenda come un complimento. Ma in questo momento non penso a lei, non penso a niente. Solo a questa novità che ha infranto il Rituale. Adesso che sono vicina, vedo un albero altissimo partire dal ventre di legno e svettare verso il cielo. Larghe coperte sono tutt’intorno, alcune funi solcano il fianco del gigante e spariscono nelle acque scure. Guardando con più attenzione, mi accorgo che parte di quell’essere poggia sulla terraferma, immerso nella riva fangosa. E che ha vomitato fuori i suoi figli. Come una stella caduta dal cielo, un fuoco arde tra i sassi della spiaggia. L’odore del fumo mi pizzica le narici, mischiato al sentore più caldo di esseri umani che si stringono l’uno all’altro. Molti esseri umani. Stai attenta! Seguendo per una volta il consiglio della voce che mi parla dentro, che mia madre chiama spirito interiore e io semplicemente buon senso, mi soffermo a distanza di sicurezza. Non serve avvicinarsi di più. Sono controvento e l’aria mi porta tutto ciò che voglio sapere. L’odore del sudore, freddo, misto allo sconcerto e alla paura. Le voci nervose, sussurri appena accennati che subito il vento strappa via dalle labbra. Le loro parole sono mormorate in una lingua che non ho mai sentito. Anche se sono lontana capisco che non è quella del mio popolo. È più... dolce, quasi musicale. Rimango un po’ a osservarli, incuriosita, poi mi allontano senza far rumore. Uno di loro, sentinella rivolta verso la boscaglia, scruta ansioso nella mia direzione. Non mi ha visto, ma sente la minaccia. Stringe la lancia in pugno. Prima che sia pronto a scagliarla sono già lontana, trotterellando nel bosco. Una parte di me è dispiaciuta. Ero curiosa di capire chi fossero quegli uomini, da quale terra provenissero. E ho fame. Ma cosa sto pensando? D’un tratto ho molta fretta di andarmene. Un senso di urgenza mi spinge ad accelerare l’andatura. Ma non perché ho paura di quegli uomini. Perché ho paura di me stessa, di quello che potrei fare. Voglio tornare. Eppure l’odore degli stranieri non accenna a diminuire. Impronte nel fango, sul sentiero che anch’io sto percorrendo. Non tutti gli umani sono intorno al fuoco, stretti nelle loro coperte, al sicuro sotto l’ombra del gigante che li ha condotti fino a qui. Raggiungo un bivio nel sentiero, le strade si dividono. Un gruppo di stranieri è andato a destra. Soltanto un paio di orme prosegue inoltrandosi incautamente nel bosco, verso il mio villaggio. Prima di sapere quello che sto facendo, mi trovo a seguirle. Sono stanca. Da quanto tempo vago in un sogno che non mi lascia andare? Avverto in bocca il sapore dolciastro delle erbe che mia madre getta nel fuoco, salmodiando. I suoi occhi sono l’ultima cosa che vedo prima di addormentarmi. Mi sembra di risentire la sua litania nella testa, ma capisco che mi sbaglio. È il ringhio inferocito di un animale che protegge la sua prole. Non c’è avvertimento, non c’è possibilità di scampo. Il rumore della lotta mi giunge alle orecchie, attutito. Si sta alzando la nebbia dalle sponde del fiume e soffoca i rumori con il suo sudario grigio. Resta bassa, aleggiando tra i tronchi. O forse è solo nella mia testa. Mi viene da vomitare. I rumori finiscono rapidamente come sono iniziati. Solo allora mi azzardo a proseguire. Non sono così stupida da sfidare un cinghiale femmina che ha da poco partorito. L’odore dell’animale si sta allontanando in fretta, con una scia di feroce soddisfazione. Ma lascia dietro di sé il sentore ferrigno del sangue. Mi passo la lingua sulle labbra. Non farlo! Quell’odore è invitante, ma mi fermo. Una parte di me mi sta urlando che quello che sto per fare è tremendamente sbagliato. Barcollo, sono sempre più confusa. Un ceppo nodoso, quello che resta di un vecchio albero colpito dal fulmine due estati fa, mi riporta ricordi che galleggiano sotto la superficie del mio essere. Lentamente, divento cosciente della pelliccia bruna che mi ricopre, delle quattro orme che lascio dietro di me sul terreno morbido, delle zanne affilate che snudo arricciando le labbra. No, non sono io a farlo. Così come non intendo permettere alla lupa di fare quello che sta pensando. Vattene! Ti prego, vattene! Mi volto e comincio a correre nella direzione opposta. Verso nord, verso le boscaglie più fitte e le montagne. Lontano dall’odore di sangue e da colui a cui appartiene. Adesso macchia una terra che non avrebbe dovuto vedere. E ci sono segni che niente può cancellare. Distorcono un disegno che pareva definito e costringono a crearne uno nuovo. Non so perché sto pensando queste cose. Penso cose strane, durante i Rituali. Non vorrei farli. Ma mia madre ha gettato l’erba nel fuoco e ha cantato. E sono qui. Adesso ho davvero paura. Corro più veloce, come se in questo modo potessi scappare anche da me stessa. Solo quando sono abbastanza lontana mi fermo e alzo la testa alla luna in un ululato frustrato. È tempo di tornare! Una tremenda sensazione di strappo fa a pezzi la mia anima per poi riformarla di nuovo. I miei pensieri si frammentano, separandosi da quelli del lupo. Ne ricordo solo uno. Il mondo sta cambiando. 2 Ishtar si svegliò di soprassalto, il respiro affannoso. All’inizio non riuscì a capire dove si trovasse. Pensare le risultava difficile e la testa le pulsava come se fosse sul punto di spaccarsi in due. Una volta Aieta, il capotribù, aveva portato come trofeo la testa mozzata di un ittita, per poi conficcarla in una picca davanti alla sua capanna. Una dimostrazione di potere per un paio di giorni, per poi tramutarsi in una nauseante fonte di cattivo odore e di mosche agguerrite. Su consiglio del guaritore del villaggio, nonché di tutti i vicini, Aieta l’aveva tolta e, sdegnato, l’aveva pestata con il tacco dello stivale. Ishtar era in disparte, appollaiata sul recinto dei maiali, ma aveva visto l’osso frantumarsi e una poltiglia grigiastra schizzare tutt’intorno. Non riusciva a capire come quella roba potesse contenere lo spirito di una persona, né tanto meno pulsare così forte. Emise un gemito e provò a sollevarsi. Era raggomitolata su una coperta di montone e il pelo ispido le faceva prudere la pelle nuda. Stava tremando, ma non di freddo. Anzi, l’aria nella capanna era fin troppo afosa. Le mozzava il respiro. Aveva la fronte sudata e un calore fastidioso le rallentava i movimenti. Si sentiva pesante, impacciata, come se dovesse abituarsi a riutilizzare il proprio corpo. Le succedeva sempre così, dopo il Rituale. L’ondata di nausea la colse a tradimento mentre lottava per alzarsi. Si piegò di lato e vomitò il poco cibo che si era costretta a mandare giù per cena. Tanto sapeva che sarebbe finita in quel modo. Ma sua madre aveva insistito, non bisognava affrontare quella notte in una condizione di debolezza. “E io faccio sempre quello che lei dice” mormorò Ishtar, pulendosi la bocca con il dorso della mano. Adesso il nodo allo stomaco si era trasformato in una pietra. Era passato. Per il momento. Ingoiò più volte, cercando di togliersi di bocca il sapore dolce e amaro che le ricordava la radice che aveva masticato prima di coricarsi. Quanto tempo era passato? Minuti? Ore? Non era facile quantizzare la durata del Rituale. Per quello che ne sapeva, poteva essere già l’alba. Eppure non un filo di luce filtrava dalla porta della capanna. Ishtar si allungò, strisciando verso la brocca d’acqua. La portò alle labbra e bevve tutto d’un fiato. Per un attimo temette che avrebbe vomitato anche quella e provò una punta di perversa soddisfazione pensando a sua madre che puliva la capanna dal vomito. Scosse la testa con una smorfia. No, avrebbe fatto da sola, prima che lei vedesse. E che pensasse che sua figlia era stata debole. La nausea non scomparve, ma si attenuò abbastanza per permetterle di mettersi a sedere. Incrociò le gambe. Era sola nella grande capanna circolare e gli ultimi bagliori del fuoco morente ansimavano tra le ceneri. Il fumo si era dissipato, fuggendo dall’apertura in cima al tetto e da sotto le pelli che costituivano la porta, unica separazione tra interno ed esterno. Ishtar si sentiva comunque in gabbia. Sua madre era scomparsa. La ragazza non riusciva a ricordare quando se ne fosse andata, comunque non era più lì. Ishtar non poté trattenere un sospiro di sollievo. Si era svegliata presto, questa volta. Afferrò la brocca e si rovesciò in faccia il contenuto. L’acqua fresca la fece sentire meglio. Era abituata alla debolezza che la coglieva dopo ogni Rituale, la spossatezza fisica e mentale che derivava dal varcare le barriere tra i mondi. Lasciò che la rabbia prendesse il suo posto. Perché devo farlo? A quanto pareva, nessuno si curava di rispondere. Doveva farlo e basta. Si alzò di scatto. Il mondo prese a rotearle attorno e dovette appoggiarsi per non cadere. La capanna era spoglia, se non per le pelli che tappezzavano le pareti e il tetto di paglia. Pareva più che altro la tana di un animale. Corna di montoni e palchi di cervi erano fissati a ogni superficie disponibile, zanne di cinghiale ornavano i rozzi vasi di terracotta disposti intorno al focolare, una buca scavata nel terreno al centro esatto della costruzione. Alcuni erano rovesciati e Ishtar temeva di esserne lei la causa, con qualche movimento incontrollato durante il sonno in cui era stata costretta. Ancora una volta. “Finirà mai?” si chiese, amaramente. Solo il silenzio le rispose e, scuotendo la testa, la ragazza si passò intorno al corpo una coperta di lana di capretto. Se la appuntò con una delle spille di bronzo che teneva tra i capelli. Rappresentava il muso di un cavallo ed era la sua preferita. Forse l’unica cosa veramente sua in quel posto. Gliela aveva regalata Tasadas. In un altro momento avrebbe sorriso al pensiero. Adesso non riusciva a togliersi dalle narici un vago sentore di sangue. Arrancò verso la porta e uscì all’aria aperta, inspirando a pieni polmoni. Si liberò degli ultimi strascichi dei fumi che le facevano bruciare gli occhi e le ovattavano la mente. Si stava schiarendo e tornava finalmente padrona di se stessa. Il cadavere di un corvo, sventrato e imbottito di sale, penzolava sulla soglia, fissandola con i ciottoli lucidi che aveva al posto degli occhi. L’aria della notte era pungente e Ishtar si strinse addosso la coperta, volgendo le spalle a quel lugubre corpo impagliato. Il villaggio era silenzioso e la luna lo tagliava in fette d’argento e di ombra. Le capanne crescevano in ordine sparso, tanti mucchi di legno e paglia che custodivano il sonno degli abitanti. Erano rettangolari, a differenza di quella da cui era uscita Ishtar. Per i Rituali era necessario utilizzare la figura più sacra e perfetta, il cerchio. Doveva ricordare a tutti che non c’era una fine o un inizio, ma soltanto un continuo ripetersi dell’equilibrio che reggeva il mondo. Ripetendo i soliti gesti, Ishtar avrebbe dovuto rientrare e coricarsi, aspettando il mattino al sicuro nella Casa Sacra, pronta a raccontare alla madre quanto aveva visto, perché ne fossero tratti i presagi per il bene della tribù. Invece la ragazza si avviò a passo svelto verso la boscaglia, prima di avere il tempo di ripensarci. Sapeva di stare commettendo una grave infrazione alle legge del suo popolo e del Rituale. Era questo che la spaventava di più, perché poteva schernire le leggi degli uomini, ma non quelle degli dei. Tuttavia, ragionò, nessun dio si era mai presentato alla porta della sua capanna a ordinarle qualcosa. Lo avevano fatto sua madre e gli abitanti del villaggio. Dicevano di parlare per bocca del dio. Ma era vero? In punta di piedi, Ishtar superò il recinto dei maiali e corse lungo i pascoli accompagnata dal chiarore della luna. Era una sensazione simile a quella che aveva provato poco prima, nel bosco... scosse la testa. Sembrava un sogno, ma non lo era. Almeno, non del tutto. Era parte del Rituale. Rallentò soltanto quando raggiunse la protezione degli alberi. Là nessuno poteva vederla. Si appoggiò a un tronco, raccogliendo le idee. La corteccia era ruvida sotto la sua pelle e portava i segni del tempo e degli animali che l’avevano toccata. Lupi, cinghiali, stranieri... il bosco era un luogo pericoloso. Ishtar si maledisse per non aver pensato a portare un coltello o un arco. Un’arma qualsiasi che le permettesse di difendersi. Erano rimasti nel villaggio e sapeva che, se fosse tornata indietro, non avrebbe più avuto il coraggio di allontanarsi. E lui sarebbe morto. “Forse è già morto,” si corresse con uno sbuffo, “e io sto perdendo tempo.” Eppure riprese a camminare, circospetta, tagliando la nebbia che si faceva quasi solida, come a sospingerla indietro. Ricordava il luogo in cui doveva arrivare, lo aveva già visto. Si era impresso nella sua anima e sarebbe stato in grado di ritrovarlo anche a occhi chiusi. Il verso lugubre di un uccello la fece sussultare, uno sfarfallio tra i rami. Ishtar ebbe la spiacevole sensazione che fosse il corvo impagliato che sua madre teneva davanti alla Casa Sacra, custode dei suoi segreti. L’aveva seguita per ricondurla a casa? Non ci sarebbe riuscito. Si mise a correre, le mani strette intorno alla coperta, incurante del freddo e delle sagome minacciose degli alberi che non capivano il suo comportamento. Non lo capiva neppure lei. Non faceva parte del Rituale e del cerchio. Ma era qualcosa di suo. Raggiunse il ceppo nodoso in mezzo al sentiero, emerse dalla nebbia di colpo. Le fece uno strano effetto vederlo. Poco prima l’aveva guardato con gli occhi della lupa bruna. Non era la stessa cosa. Cioè, il ceppo era sempre lo stesso, ma cambiava in base all’essere che interagiva con esso. Ishtar sentì che il cuore le accelerava i battiti. Era vicina. Ed era sicura di volerlo fare? Fare cosa? Non ne aveva un’idea chiara. Era incuriosita dalla propria reazione. Insomma, era arrivata fino a lì, rischiando le ire della madre e la punizione della tribù... per cosa? Per chi? Un lamento la riscosse dalle sue riflessioni. Dopo un’ultima esitazione, Ishtar si decise a seguire quel rumore. L’uomo era accasciato con la schiena contro il tronco di un albero. Faticava a respirare e si teneva la mano premuta sulla coscia, da cui il sangue continuava a zampillare. Stava formando una pozza scura intorno a lui, macchiando la tunica e la corazza di cuoio che gli avvolgeva il torace muscoloso. Al suo fianco giaceva una lancia spezzata. Ishtar non aveva bisogno di grande immaginazione per capire come era andata. Il cinghiale aveva caricato. Lo sventurato si era difeso con la lancia, ferendolo, ma il legno si era spezzato. L’animale gli aveva squarciato una coscia con le zanne. La domanda giusta era: perché l’uomo si era allontanato dai suoi compagni? “Stupido” mormorò la ragazza. L’uomo dovette sentirla. Sollevò la testa. Qualche filo d’argento penetrava le fronde nebbiose e scivolava sul volto pallido, su cui le ciocche castane ricadevano disordinatamente. Il sudore le appiccicava sulla fronte, mescolandosi al sangue che continuava a fluire, inesorabile. Ishtar mosse un passo verso di lui, poi si fermò. Quell’uomo stava morendo e lei non era una guaritrice. Forse Iskhan lo Sciamano avrebbe potuto fare qualcosa con le sue erbe, forse sua madre... ma avrebbero aiutato uno straniero? Sua madre li odiava. No, con ogni probabilità gli avrebbero tagliato la gola, ponendo così fine alle sue sofferenze. Stranamente la cosa le suscitava raccapriccio. Era abituata alla morte, in ogni sua forma. I membri della sua tribù morivano ogni giorno, chi per malattia, chi per vecchiaia, chi in battaglia. Quando le giornate si facevano più corte trovava i gusci di insetti morti tra le coperte. Gli uccellini che cadevano dal nido diventavano minuscoli scheletri che si sbriciolavano al vento. Sua madre le aveva raccontato di certe farfalle che nascevano e morivano nell’arco di un solo giorno. La morte era parte della vita, la sua naturale prosecuzione nel cerchio infinito. Eppure il pensiero che quell’uomo morisse le sembrava tremendamente sbagliato. Se non poteva portarlo al villaggio, c’era un altro modo. Rischioso, ma c’era. Ishtar raggiunse lo straniero e si inginocchiò al suo fianco. Fece per toccarlo, ma si accorse di essere spaventata, come quando la sua mente era volata via per la prima volta dal corpo. Forse di più. Non sapeva nulla di lui. Poteva essere un mostro come quelli delle storie del vecchio Harnu. E se la sua pelle fosse stata velenosa? L’uomo disse qualcosa, ma Ishtar non conosceva la sua lingua. Scosse la testa, affranta, mentre lui la scrutava. Aveva gli occhi chiari, cerchiati di un viola livido per la sofferenza. Tuttavia in essi la ragazza scorse le sfumature del cielo d’estate che si mischiavano al muschio d’inverno. Per un attimo si lasciò catturare da quello sguardo, persa tra gli interrogativi che si facevano strada nelle pieghe di sentimenti che non aveva mai provato. “Non capisco” mormorò. E non si riferiva solo a quelle parole. L’uomo corrugò la fronte, ansimando. Restare cosciente era uno sforzo. Ishtar comprese che non c’era un secondo da perdere. Strappò un brandello della tunica insanguinata e lo strinse intorno alla coscia dell’uomo, nel tentativo di fermare l’emorragia. Non sarebbe bastato, ma era il meglio che poteva fare. “Aggrappati a me” gli ordinò, e si passò il suo braccio intorno alle spalle, “dobbiamo sbrigarci!” Lo aiutò a sollevarsi. Era pesante e l’armatura non le facilitava il compito. Chi mai poteva mettersi addosso quell’affare ingombrante? E perché? Intralciava soltanto i movimenti. Quegli stranieri erano degli sciocchi. Sciocchi e imprudenti. Non sapevano che non bisognava sfidare il bosco di notte, tanto più da soli? Per fortuna lei era robusta, una donna dei kaskas, ed era abituata a sollevare gli agnelli e le matasse di lino. Stringendo i denti, cominciò a trascinare l’uomo nella boscaglia. Non era un kaskas, Ishtar non aveva dubbi. A parte la lingua, aveva un aspetto diverso. La mascella meno prominente, il taglio degli occhi delicato. La ragazza non aveva mai visto nessuno come lui. Un viaggiatore sospinto là dalla tempesta. L’unica possibilità era riportarlo dai suoi compagni. Si concentrò sul mettere un passo dietro l’altro. La testa dell’uomo cominciava a ciondolare e lei sentiva i suoi capelli solleticarle il collo. Ciononostante si sforzava di camminare, appoggiandosi a lei e alla gamba sana. L’altra era soltanto un peso che si trascinava dietro. Ishtar diede un’occhiata alla benda. Una macchia scura si allargava sempre di più. Non poteva morire proprio adesso, non dopo tutti i suoi sforzi! Tutto inutile. Le sembrava di sentire la voce della madre. Si era accorta della sua assenza? La stava cercando? Cosa avrebbe pensato, se la figlia avesse rivelato la sua presenza, e quindi quella della tribù, a stranieri potenzialmente pericolosi? Ishtar non dimenticava che quegli uomini avevano armi con sé. “Resisti, siamo vicini” mormorò. Un gemito fu l’unica risposta. L’uomo stava perdendo conoscenza. Fu un sollievo quando raggiunsero il limitare del boschetto. Oltre gli arbusti Ishtar intravedeva il chiarore del fuoco e i mormorii degli stranieri. Forse si erano accorti che un compagno mancava all’appello. Lo avrebbero cercato presto, o per lo meno se lo augurava. Lei aveva fatto abbastanza. Adagiò il corpo del ferito su un morbido tappeto di foglie. Il suo respiro usciva irregolare dalle labbra esangui e il petto si alzava e si abbassava a fatica. Ishtar pensava che fosse svenuto e quindi si stupì quando lui le afferrò il polso. Una scossa sorpresa le attraversò tutto il braccio, riempiendola di sconcerto. Non era abituata al contatto fisico. Nella tribù era qualcosa di intimo, riservato soltanto ai familiari più stretti. E si stupì ancora di più quando comprese le parole dell’uomo. “Chi... sei...?” rantolò, in un ittita stentato. La lingua del nemico. Eppure lui non era ittita. Ishtar esitò, mentre la mano dell’uomo risaliva fino a sfiorarle il volto e allontanare una ciocca ribelle. Lo sentì trasalire, mentre toccava ciò che i suoi ricci nascondevano sulla fronte. Il segno che la marchiava. Avrebbe voluto strapparselo e cristallizzare la sua vita in quel piccolo attimo di libertà, in cui stava facendo qualcosa per se stessa invece che per la tribù. Rubare un po’ di tempo al cerchio del mondo che la circondava. Era così sbagliato? Se fosse rimasta, rivelando a quell’uomo il suo nome e quindi la sua anima, sarebbe riuscita a fuggire al destino che era stato scritto per lei? La scelta non le fu concessa. Il tramestio di passi le rivelò che infine gli stranieri avevano abbandonato la sicurezza del fuoco e della gigantesca tazza galleggiante per venire a cercare il compagno. Doveva essere qualcuno di importante per loro. Ishtar si liberò con un gesto fin troppo brusco. Continuava a sentire il tocco di quell’uomo sulla pelle, mentre i suoi occhi la seguivano. Non si fidava a parlare, neppure in ittita. Aveva paura di quello che avrebbe detto o sentito. Corse via, scomparendo nella boscaglia e nella nebbia. Quella era la sua casa, conosceva ogni albero e ogni arbusto. Non l’avrebbero mai trovata. Doveva allontanarsi dagli stranieri e da ciò che rappresentavano. Il destino di quell’uomo non era più nelle sue mani. Neppure il proprio. Non lo era mai stato. Superò di corsa il ceppo nodoso e si fermò soltanto quando raggiunse il vecchio pino che da anni era guardiano silenzioso del suo villaggio. Ishtar si precipitò contro il tronco, abbracciandolo. La coperta di lana le era scivolata ai piedi, macchiata di sangue, ma non le importava. Il contatto della corteccia ruvida contro la pelle non riuscì a calmare i suoi brulicanti pensieri. Era stata drogata durante il Rituale, la sua mente scagliata nel corpo di un lupo, aveva trascinato un uomo ferito attraverso la foresta rischiando di essere scoperta da stranieri che, era certa, non avrebbero dovuto essere lì. Era troppo. Tutta la tensione si sciolse e si radunò sulle ciglia, premendo per uscire. Lacrime calde e inaspettate le sgorgarono dagli occhi. L’attimo di libertà era finito. E in quella notte di luna piena non era sicura che non fosse stato solo un sogno.
Scaricare