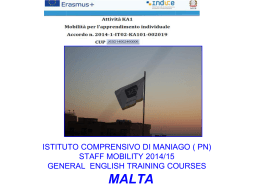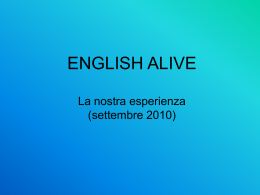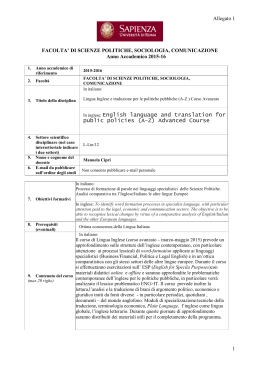Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari BROCHURE DEI CORSI Test per i Corsi di Studio del DISAFA Printed by Campusnet - 31/01/2016 05:45 Indice Indice 1 Abilità informatiche (Anno Accademico 2015/2016) 15 COMPUTER SKILLS Abilità informatiche (Anno Accademico 2015/2016) 18 COMPUTER SKILLS Acarologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) 21 VINEYARD MITE CONTROL Agro-environmental economics (Anno Accademico 2015/2016) 25 Agro-environmental economics Agro-environmental economics and agronomy - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 29 AGRO-ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND AGRONOMY Agro-environmental economics (Anno Accademico 2015/2016) 29 Agro-environmental economics Environmental agronomy (Anno Accademico 2015/2016) 33 Environmental agronomy Agrochimica ambientale (Anno Accademico 2015/2016) 37 ENVIRONMENTAL AGROCHEMISTRY Agronomia (Anno Accademico 2015/2016) 40 AGRONOMY Alimentazione dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) 45 RUMINANT FEEDING AND NUTRITION Alimentazione e nutrizione umana (Anno Accademico 2015/2016) 48 FOOD AND HUMAN NUTRITION Allevamento dei monogastrici I (Anno Accademico 2015/2016) 52 PIG AND POULTRY PRODUCTION Allevamento dei monogastrici II (Anno Accademico 2015/2016) 57 FISH AND RABBIT PRODUCTION Allevamento dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) 62 RUMINANT PRODUCTION AND FARMING SYSTEM Allevamento e alimentazione dei ruminanti - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 65 RUMINANT PRODUCTION AND FEEDING Alimentazione dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) 65 RUMINANT FEEDING AND NUTRITION Allevamento dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) 69 RUMINANT PRODUCTION AND FARMING SYSTEM Alpicoltura 1 (Anno Accademico 2015/2016) 72 ALPINE GRASS AND RANGELAND MANAGEMENT Alpicoltura 2 (Anno Accademico 2015/2016) 77 ALPINE LIVESTOCK FARMING Ampelografia (Anno Accademico 2015/2016) 82 AMPELOGRAPHY Analisi chimiche degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 85 FOOD CHEMICAL ANALYSIS Analisi chimiche enologiche e strumentali (Anno Accademico 2015/2016) 89 CHEMICAL AND INSTRUMENTAL OENOLOGICAL ANALYSIS Analisi chimico-agrarie (Anno Accademico 2015/2016) 93 Agricultural chemical analysis Analisi dei prodotti della ristorazione (Anno Accademico 2015/2016) 97 QUALITY CONTROL OF CATERING PRODUCTS Analisi e gestione genetica della biodiversità animale (Anno Accademico 2015/2016) 101 GENETIC ANALYSIS AND MANAGEMENT OF ANIMAL BIODIVERSITY Analisi ecologica del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) STUDIO -1- 105 Analisi enologiche avanzate (Anno Accademico 2015/2016) 108 Analisi enologiche avanzate Analisi fisiche e sensoriali degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 111 PHYSICAL AND CHEMICAL FOOD ANALYSES Apicoltura (Anno Accademico 2015/2016) 115 BEEKEEPING Application of agro-ecosystem models to field crops (Anno Accademico 2015/2016) 120 Application of agro-ecosystem models to field crops Applicazioni di analisi sensoriale I (Anno Accademico 2015/2016) 123 APPLIED SENSORY ANALYSIS 1 Applicazioni di analisi sensoriale II (Anno Accademico 2015/2016) 126 APPLIED SENSORY ANALYSIS 2 Applicazioni di analisi sensoriali II (Anno Accademico 2015/2016) 129 APPLIED SENSORY ANALYSIS 2 Applicazioni/tirocinio di Enologia (Anno Accademico 2015/2016) 132 PRACTICES IN ENOLOGY Applicazioni/tirocinio di Viticoltura (Anno Accademico 2015/2016) 135 PRACTICES IN VITICULTURE Approfondimenti di controllo qualità degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 137 INSIGHTS INTO QUALITY FOOD CONTROL Approfondimenti di entomologia (Anno Accademico 2015/2016) 144 ADVANCED GRAPEVINE ENTOMOLOGY Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) 148 INSIGHTS INTO GRAPEVINE PATHOLOGY Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) 151 ADVANCED GRAPEVINE PATHOLOGY Approvvigionamento dei prodotti di origine animale per la ristorazione (Anno Accademico 2015/2016) 154 SUPPLY AND SAFETY OF ANIMAL FOOD Approvvigionamento, qualità e trasformazione dei prodotti di origine animale (Anno Accademico 2015/2016) 158 SUPPLY, QUALITY AND PROCESSING OF ANIMAL PRODUCTS Arboricoltura (Anno Accademico 2015/2016) 162 ARBORICULTURE Arboricoltura ornamentale (Anno Accademico 2015/2016) 167 ORNAMENTAL ARBORICULTURE Aspetti applicativi delle biotecnologie vegetali (Anno Accademico 2015/2016) 170 Applied plant biotechnologies Aspetti normativi ed etici delle applicazioni biotecnologiche 173 nd Assestamento forestale e pianificazione antincendi (Anno Accademico 2015/2016) 175 FORESTRY AND WILDFIRE MANAGEMENT Biochimica degli Alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 179 FOOD BIOCHEMISTRY Biochimica e metodologie (Anno Accademico 2015/2016) 184 BIOCHEMISTRY AND METHODOLOGIES Biodiversità genetica vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 185 PLANT GENETIC BIODIVERSITY Bioinformatica e statistica (Anno Accademico 2015/2016) 189 Statistics and bioinformatics Biologia cellulare e del differenziamento (Anno Accademico 2015/2016) 195 PLANT CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY Biologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) 199 Biologia della vite Biologia e biodiversità nei vegetali (Anno Accademico 2015/2016) 202 PLANT BIODIVERSITY Biologia e genetica della vite - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) BIOLOGY OF GRAPEVINE -2- 208 Biologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) 208 Biologia della vite Genetica della vite (Anno Accademico 2015/2016) 212 Genetica della vite Biologia generale e botanica (insegnamento per L- Scienze e tecnologie agrarie) (Anno Accademico 2015/2016) 215 GENERAL BIOLOGY AND BOTANY Biologia generale e botanica (insegnamento per L- Scienze forestali e ambientali) (Anno Accademico 2015/2016) 219 GENERAL BIOLOGY AND BOTANY Biologia generale e fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 223 GENERAL BIOLOGY AND PLANT PHYSIOLOGY Biologia molecolare (Anno Accademico 2015/2016) 227 MOLECULAR BIOLOGY Biologia molecolare vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 228 Plant Molecular Biology Biotecnologie genetiche - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 232 GENETIC BIOTECHNOLOGY Aspetti applicativi delle biotecnologie vegetali (Anno Accademico 2015/2016) 232 Applied plant biotechnologies Trasformazione genetica (Anno Accademico 2015/2016) 236 Genetic transformation of plants Biotecnologie microbiche (Anno Accademico 2015/2016) 241 MICROBIAL BIOTECHNOLOGY Biotecnologie microbiche in enologia (Anno Accademico 2015/2016) 244 MICROBIAL BIOTECHNOLOGY IN OENOLOGY Botanica forestale (Anno Accademico 2015/2016) 248 FOREST BOTANY Caratteristiche chimiche dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 252 CHEMICAL CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK MANURE Chimica agraria (Anno Accademico 2015/2016) 255 AGRICULTURAL CHEMISTRY Chimica delle vinificazioni (Anno Accademico 2015/2016) 259 Chimica delle vinificazioni Chimica e biochimica agraria (Anno Accademico 2015/2016) 262 AGRICULTURAL CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Chimica forestale (Anno Accademico 2015/2016) 267 FOREST CHEMISTRY Chimica forestale ed elementi di fisiologia vegetale - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 271 FOREST CHEMISTRY AND VEGETAL PHYSIOLOGY Chimica forestale (Anno Accademico 2015/2016) 271 FOREST CHEMISTRY Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 275 PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 278 PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Chimica generale (Anno Accademico 2015/2016) 282 GENERAL CHEMISTRY Chimica generale e analisi chimico agrarie - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 286 GENERAL CHEMISTRY AND AGRICULTURAL CHEMICAL ANALYSIS Analisi chimico-agrarie (Anno Accademico 2015/2016) 286 Agricultural chemical analysis Principi di chimica (Anno Accademico 2015/2016) 291 General chemistry Chimica organica (Anno Accademico 2015/2016) 296 ORGANIC CHEMISTRY Chimica organica (Anno Accademico 2015/2016) 300 ORGANIC CHEMISTRY -3- Ciclo della sostanza organica (Anno Accademico 2015/2016) 303 CYCLE OF ORGANIC MATTER Coltivazioni erbacee (Anno Accademico 2015/2016) 307 HERBACEOUS CROPS Colture frutticole (Anno Accademico 2015/2016) 314 Fruit and nut crops Colture orto-floricole (Anno Accademico 2015/2016) 318 Vegetable and ornamental crops Costruzioni (Anno Accademico 2015/2016) 322 BUILDING Costruzioni ed impianti per l'allevamento - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 327 LIVESTOCK HOUSING AND EQUIPMENTS Costruzioni per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) 327 LIVESTOCK HOUSING Impianti per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) 331 LIVESTOCK EQUIPMENTS Costruzioni forestali (Anno Accademico 2015/2016) 336 FOREST BUILDING Costruzioni per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) 341 LIVESTOCK HOUSING Dendrometria (Anno Accademico 2015/2016) 344 DENDROMETRY Destino ambientale degli agrofarmaci (Anno Accademico 2015/2016) 348 ENVIRONMENTAL FATE OF PESTICIDES Difesa biologica e integrata (Anno Accademico 2015/2016) 351 BIOLOGICAL AND INTEGRATED DISEASE MANAGEMENT Difesa del suolo - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 357 SOIL CONSERVATION Prevenzione dell'erosione del suolo, delle frane e delle valanghe (Anno Accademico 2015/2016) 357 PREVENTION OF SOIL EROSION, LANDSLIDES AND SNOW AVALANCHES Telerilevamento e fotointerpretazione (Anno Accademico 2015/2016) 361 OPTICAL REMOTE SENSING AND IMAGE INTERPRETATION Difesa della vite - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 365 VINE PROTECTION Approfondimenti di entomologia (Anno Accademico 2015/2016) 365 ADVANCED GRAPEVINE ENTOMOLOGY Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) 369 ADVANCED GRAPEVINE PATHOLOGY Difesa delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) 372 Disease management of ornamental trees Difesa e gestione delle specie vegetali - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 376 DISEASE MANAGEMENT OF ORNAMENTAL TREES Difesa delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) 376 Disease management of ornamental trees Lotta ai nemici animali delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) 380 Control of the pests of the ornamental plants Diritto amministrativo (Anno Accademico 2015/2016) 383 ADMINISTRATIVE LAW Diritto amministrativo (Anno Accademico 2015/2016) 387 ADMINISTRATIVE LAW Diritto amministrativo (Anno Accademico 2015/2016) 391 ADMINISTRATIVE LAW Diritto dell'ambiente e del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) 395 LAW Disegno dell'architettura (Anno Accademico 2015/2016) 399 ARCHITECTURAL DESIGN -4- Ecologia agraria (Anno Accademico 2015/2016) 404 AGRICULTURAL ECOLOGY Ecologia del verde urbano (Anno Accademico 2015/2016) 409 STUDIO Ecologia forestale e selvicoltura (Anno Accademico 2015/2016) 413 FOREST ECOLOGY AND SILVICULTURE Ecologia, igiene e benessere degli animali in allevamento (Anno Accademico 2015/2016) 418 ECOLOGY, HYGIENE AND WELFARE IN LIVESTOCK FARMING Economia agraria e forestale - STA (Anno Accademico 2015/2016) 422 AGRICULTURAL AND FOREST ECONOMICS Economia e gestione aziendale - TAL (Anno Accademico 2015/2016) 426 ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Economia e gestione aziendale - VE (Anno Accademico 2015/2016) 430 WINEMAKING FIRMS ECONOMICS AND MANAGEMENT Economia e politica agraria, alimentare e ambientale (Anno Accademico 2015/2016) 434 AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY Economia e politica agroalimentare (Anno Accademico 2015/2016) 438 AGRI-FOOD ECONOMY AND POLICY Economics of food safety and nutrition (Anno Accademico 2015/2016) 442 Economics of food safety and nutrition Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 444 PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 447 PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Elementi di nutrizione umana (Anno Accademico 2015/2016) 451 ELEMENTS OF HUMAN NUTRITION Enography (Anno Accademico 2015/2016) 455 ENOGRAPHY Enologia (Anno Accademico 2015/2016) 458 ENOLOGY Enologia in clima caldo-arido (Anno Accademico 2015/2016) 463 ENOLOGY IN WARM AND DRY CLIMATE Entomologia alimentare ed animali infestanti (Anno Accademico 2015/2016) 466 PROTECTION OF FOODSTUFF BY PESTS Entomologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) 470 GRAPEVINE ENTOMOLOGY Entomologia generale e applicata - SFA (Anno Accademico 2015/2016) 474 GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY Entomologia generale e applicata - STA (Anno Accademico 2015/2016) 478 GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY Environmental agronomy (Anno Accademico 2015/2016) 482 Environmental agronomy Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) 486 INTERDISCIPLINARY TRAINING Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) 490 INTERDISCIPLINARY TRAINING Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) 492 INTERDISCIPLINARY TRAINING Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) 496 INTERDISCIPLINARY FIELD ACTIVITY Esercitazioni interdisciplinari - STA (Anno Accademico 2015/2016) 500 INTERDISCIPLINARY TRAINING Estimo forestale (Anno Accademico 2015/2016) 505 FOREST VALUATION Etichettatura dei prodotti alimentari (Anno Accademico 2015/2016) FOOD LABELLING -5- 510 Farming system for energy production and energy balance (Anno Accademico 2015/2016) 513 FARMING SYSTEM FOR ENERGY PRODUCTION AND ENERGY BALANCE Fermentation microflora and territorial characterization (Anno Accademico 2015/2016) 516 FERMENTATION MICROFLORA AND TERRITORIAL CHARACTERIZATION Filiera dei prodotti di origine animale (Anno Accademico 2015/2016) 520 ANIMAL PRODUCTS CHAINE Filiera dei prodotti frutticoli (Anno Accademico 2015/2016) 524 FRUIT CHAINE Filiera legno - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 528 WOOD INDUSTRY Industria del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) 528 WOOD INDUSTRY AND BY-PRODUCTS Mercato del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) 532 WOOD MARKET AND BY-PRODUCTS Filiera post-raccolta in ortoflorofrutticoltura - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 536 STORAGE AND POST HARVESTING OF CROPS Colture frutticole (Anno Accademico 2015/2016) 536 Fruit and nut crops Colture orto-floricole (Anno Accademico 2015/2016) 540 Vegetable and ornamental crops Filiere cerealicole e delle colture industriali erbacee (Anno Accademico 2015/2016) 544 CEREAL AND HERBACEOUS CROPS CHAIN Filiere e qualità dei prodotti orticoli (Anno Accademico 2015/2016) 548 HORTICULTURAL QUALITY AND CHAIN Fisica (Anno Accademico 2015/2016) 552 PHYSICS Fisica (Anno Accademico 2015/2016) 559 PHYSICS Fisiologia delle piante (Anno Accademico 2015/2016) 566 PLANT PHYSIOLOGY Fisiologia e qualità della produzione viticola in clima caldo arido (Anno Accademico 2015/2016) 570 PHYSIOLOGY AND QUALITY OF GRAPEVINE PRODUCTION IN WARM AND DRY CLIMATE Fisiologia molecolare delle piante (Anno Accademico 2015/2016) 574 PLANT MOLECULAR PHYSIOLOGY Floricoltura (Anno Accademico 2015/2016) 578 FLORICULTURE AND ORNAMENTAL ARBORICULTURE Foraggicoltura (Anno Accademico 2015/2016) 582 FODDER CULTIVATION Fotointerpretazione e strumenti informatici per analisi e rappresentazione del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) 587 Image Interpretation and Digital Tools for Landscape Analysis and Representation Fruit and grapevine cropping systems - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 591 FRUIT AND GRAPEVINE CROPPING SYSTEMS Fruit and grapevine pest management (Anno Accademico 2015/2016) 591 Fruit and grapevine pest management Orchard management for fruit quality (Anno Accademico 2015/2016) 595 Orchard management for fruit quality Orchard management for fruit quality II (Anno Accademico 2015/2016) 599 Orchard management for fruit quality II Fruit and grapevine pest management (Anno Accademico 2015/2016) 602 Fruit and grapevine pest management Frutticoltura e qualità delle produzioni frutticole (Anno Accademico 2015/2016) 605 FRUIT PRODUCTION AND QUALITY Genetica della vite (Anno Accademico 2015/2016) 609 Genetica della vite Genetica e miglioramento genetico (Anno Accademico 2015/2016) GENETICS AND GENETIC IMPROVEMENT -6- 612 Genetica forestale (Anno Accademico 2015/2016) 616 FOREST GENETICS Genomica vegetale (Anno Accademico 2015/2016) 621 PLANT GENOMICS Germoplasma e risorse ambientali in viticoltura (Anno Accademico 2015/2016) 626 PLANT MATERIAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES IN VITICULTURE Gestione dei fitofagi in ambiente urbano (Anno Accademico 2015/2016) 629 STUDIO Gestione del vigneto (Anno Accademico 2015/2016) 632 VINEYARD MANAGEMENT Gestione del vigneto in ambiente mediterraneo a clima caldo-arido (Anno Accademico 2015/2016) 638 VINEYARD MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN WARM AND ARID AREA Gestione della qualità nell'industria alimentare (Anno Accademico 2015/2016) 643 QUALITY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY Gestione e trattamento dei reflui zootecnoci (Anno Accademico 2015/2016) 648 MANAGEMENT AND TREATMENT OF LIVESTOCK MANURE Gestione e tutela delle risorse idriche (Anno Accademico 2015/2016) 652 MANAGEMENT AND PROTECTION OF WATER RESOUCES Gestione zootecnica e caratteristiche chimiche dei reflui zootecnici - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 656 LIVESTOCK MANAGEMENT AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF MANURE Caratteristiche chimiche dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 656 CHEMICAL CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK MANURE Strategie zootecniche per il miglioramento quanti-qualitativo dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 660 ZOOTECHNICAL STATEGIES FOR IMPROVING QUANTITY AND QUALITY OF LIVESTOCK MANURE Grapevine ecophysiology (Anno Accademico 2015/2016) 663 GRAPEVINE ECOPHYSIOLOGY Impianti per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) 669 LIVESTOCK EQUIPMENTS Industria del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) 674 WOOD INDUSTRY AND BY-PRODUCTS Informatica applicata all'elaborazione statistica dei dati (Anno Accademico 2015/2016) 678 COMPUTATIONAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS Ingegneria delle produzioni alimentari industriali (Anno Accademico 2015/2016) 681 FOOD PRODUCTION ENGINEERING Innovazioni in enologia - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 685 ADVANCED TECHNOLOGIES IN WINE-MAKING PROCESS Analisi enologiche avanzate (Anno Accademico 2015/2016) 685 Analisi enologiche avanzate Innovazioni tecnologiche in enologia (Anno Accademico 2015/2016) 689 Innovazioni tecnologiche in enologia Innovazioni nei sistemi viticoli (Anno Accademico 2015/2016) 693 INNOVATIONS IN THE VITICULTURAL SYSTEMS Innovazioni tecnologiche in enologia (Anno Accademico 2015/2016) 697 Innovazioni tecnologiche in enologia Insetti pronubi e tecniche di impollinazione (Anno Accademico 2015/2016) 701 POLLINATING INSECTS AND POLLINATION TECHNIQUES Iscrizioni al Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) - 25/10/2013 704 Laboratorio CAD-GIS (Anno Accademico 2015/2016) 705 CAD-GIS LABORATORY Laboratorio di analisi chimico agrarie (Anno Accademico 2015/2016) 709 AGRICULTURAL CHEMICAL ANALYSES Laboratorio di analisi e valutazione degli alimenti zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 713 ANALYSES AND EVALUATIONS OF ANIMAL FEED Laboratorio di analisi genetiche degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 716 GENETIC CHARACTERIZATION OF FOOD Laboratorio di analisi, valutazione e rappresentazione del paesaggio - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) -7- 719 STUDIO Analisi ecologica del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) 719 STUDIO Fotointerpretazione e strumenti informatici per analisi e rappresentazione del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) 723 Image Interpretation and Digital Tools for Landscape Analysis and Representation Valutazione della potenzialità dei suoli (Anno Accademico 2015/2016) 727 STUDIO Laboratorio di arboricoltura da legno: aspetti colturali, tecnologici e di mercato (Anno Accademico 2015/2016) 730 LABORATORY OF TREE FARMING: GROWING TECHNIQUES, WOOD TECHNOLOGY AND MARKET Laboratorio di colture asettiche e tecnologie di propagazione in ortofloricoltura (Anno Accademico 2015/2016) 733 LABORATORY OF ASEPTIC CULTURES AND PROPAGATION TECHNOLOGIES IN HORTICULTURE Laboratorio di ecologia del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) 736 LABORATORY OF LANDSCAPE ECOLOGY Laboratorio di Ecologia e gestione dei disturbi abiotici in foresta (Anno Accademico 2015/2016) 740 ABIOTIC DISTURBANCE ECOLOGY AND MANAGEMENT LAB Laboratorio di geobotanica e fitosociologia (Anno Accademico 2015/2016) 745 LABORATORY OF GEOBOTANY AND PHITOSOCIOLOGY Laboratorio di microbiologia delle fermentazioni alimentari (Anno Accademico 2015/2016) 748 LABORATORY OF FOOD FERMENTATION MICROBIOLOGY Laboratorio di pratiche di allevamento (Anno Accademico 2015/2016) 751 BREEDING PRACTICES Laboratorio di progettazione ambientale urbana - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 754 STUDIO Ecologia del verde urbano (Anno Accademico 2015/2016) 754 STUDIO Laboratorio di progettazione del paesaggio - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 758 LANDSCAPE DESIGN STUDIO Scelta delle specie vegetali per il paesaggio 758 LANDSCAPE DESIGN STUDIO Laboratorio di progettazione del verde in aree antropizzate (Anno Accademico 2015/2016) 762 LABORATORY OF DESIGN OF GREEN AREAS Laboratorio di progettazione e gestione del verde urbano - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 765 STUDIO Gestione dei fitofagi in ambiente urbano (Anno Accademico 2015/2016) 765 STUDIO Laboratorio di qualità dei prodotti frutticoli (Anno Accademico 2015/2016) 769 EVALUATION OF FRUIT PRODUCE QUALITY Laboratorio di restauro dei giardini e del paesaggio - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 772 STUDIO Patologia e Risanamento Conservativo delle Piante Storiche (Anno Accademico 2015/2016) 772 STUDIO Laboratorio di rilevamento pedologico (Anno Accademico 2015/2016) 776 SOIL SURVEY LABORATORY Laboratorio di riqualificazione dei paesaggi culturali - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 779 STUDIO Recupero della fertilità delle aree dismesse (Anno Accademico 2015/2016) 779 STUDIO Laboratorio di tecniche di analisi genetica (Anno Accademico 2015/2016) 782 GENETIC ANALYSIS TECHNIQUES Laboratorio di tecniche vivaistiche (Anno Accademico 2015/2016) 785 NURSERY TECHNIQUES Laboratorio di valutazione dei prodotti di origine animale (Anno Accademico 2015/2016) 789 ANALYSES AND EVALUATIONS OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN Laboratorio di valutazioni economiche (Anno Accademico 2015/2016) 793 LABORATORY Legislazione alimentare (Anno Accademico 2015/2016) 796 -8- Food legislation Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici (Anno Accademico 2015/2016) 799 Legislation in the wine sector Legislazione vitivinicola (Anno Accademico 2015/2016) 804 VITICOLTURE AND ENOLOGY POLICY Lingua Inglese 1 (Anno Accademico 2015/2016) 806 ENGLISH 1 Logistica della filiera agroalimentare (Anno Accademico 2015/2016) 808 DISTRIBUTION LOGISTICS Lotta ai nemici animali delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) 811 Control of the pests of the ornamental plants Lotta biologica e integrata (Anno Accademico 2015/2016) 814 BIOLOGICAL AND INTEGRATED PEST MANAGEMENT Macchine e impianti dell'industria alimentare (Anno Accademico 2015/2016) 818 MACHINES AND PLANTS FOR FOOD INDUSTRY Macchine e layout per la ristorazione (Anno Accademico 2015/2016) 824 MACHINES AND LAYOUT FOR CATERING Malerbologia (Anno Accademico 2015/2016) 828 WEED SCIENCE Marketing dei prodotti agroalimentari (Anno Accademico 2015/2016) 833 Marketing of food products Marketing dei prodotti agroalimentari (Anno Accademico 2015/2016) 837 MARKETING OF FOOD PRODUCTS Marketing dei prodotti viticoli ed enologici (Anno Accademico 2015/2016) 841 Marketing of wine and oenological products Marketing e legislazione dei prodotti viticoli ed enologici - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 845 MARKETING AND LEGISLATION OF VITICULTURE AND ENOLOGY PRODUCTS Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici (Anno Accademico 2015/2016) 845 Legislation in the wine sector Marketing dei prodotti viticoli ed enologici (Anno Accademico 2015/2016) 851 Marketing of wine and oenological products Marketing per la valorizzazione dei vini siciliani (Anno Accademico 2015/2016) 855 MARKETING STRATEGIES TO IMPROVE SICILIAN WINES Matematica (Anno Accademico 2015/2016) 859 MATHEMATICS Matematica (Anno Accademico 2015/2016) 863 MATHEMATICS Meccanica agraria (Anno Accademico 2015/2016) 869 AGRICULTURAL MECHANICS Meccanica e meccanizzazione (Anno Accademico 2015/2016) 873 MECHANICS AND FORESTRY MECHANIZATION Meccanizzazione della viticoltura e macchine enologiche (Anno Accademico 2015/2016) 877 VINEYARD MECHANIZATION AND ENOLOGICAL MACHINES Meccanizzazione e impiantistica avanzata per la viticoltura e l'enologia (Anno Accademico 2015/2016) 881 ADVANCED MACHINERY AND PLANT ENGIREERING IN VITICULTURE AND ENOLOGY Mecchanic for precision viticulture (Anno Accademico 2015/2016) 883 MECCHANIC FOR PRECISION VITICULTURE Mercato del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) 887 WOOD MARKET AND BY-PRODUCTS Metabolismo secondario delle piante (Anno Accademico 2015/2016) 891 PLANT SECONDARY METABOLISM Metaboliti bioattivi delle piante (Anno Accademico 2015/2016) 895 Plant Bioactive Metabolites Meteorologia e nivologia (Anno Accademico 2015/2016) 899 METEOROLOGY AND SNOW SCIENCE Metodi statistici per la ricerca (Anno Accademico 2015/2016) 902 -9- STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH Microbiologia agraria (Anno Accademico 2015/2016) 906 AGRICULTURAL MICROBIOLOGY Microbiologia alimentare applicata (Anno Accademico 2015/2016) 910 APPLIED FOOD MICROBIOLOGY Microbiologia degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 913 FOOD MICROBIOLOGY Microbiologia degli starter enologici (Anno Accademico 2015/2016) 917 WINE STARTER MICROBIOLOGY Microbiologia generale (Anno Accademico 2015/2016) 921 GENERAL MICROBIOLOGY Microbiologia generale ed enologica (Anno Accademico 2015/2016) 925 GENERAL AND WINE MICROBIOLOGY Miglioramento genetico degli animali di interesse zootecnico (Anno Accademico 2015/2016) 928 GENETIC IMPROVEMENT OF ANIMALS OF ZOOTECHNICAL INTEREST Morfofisiologia e valutazione degli animali di interesse zootecnico (Anno Accademico 2015/2016) 932 MORPHOPHYSIOLOGY AND EVALUATION OF ANIMALS OF ZOOTECHNICAL INTEREST Nutrient cycling in soil-plant systems (Anno Accademico 2015/2016) 937 Nutrient cycling in soil-plant systems Nutrizione e alimentazione degli animali di interesse zootecnico (Anno Accademico 2015/2016) 940 NUTRITION AND FEEDING OF ANIMALS OF ZOOTECHNICAL INTEREST Orchard management for fruit quality (Anno Accademico 2015/2016) 943 Orchard management for fruit quality Orchard management for fruit quality II (Anno Accademico 2015/2016) 947 Orchard management for fruit quality II Organizzazione dei cantieri e sicurezza del lavoro (Anno Accademico 2015/2016) 950 FORESTRY YARDS ORGANISATION AND OPERATOR SAFETY Orticoltura (Anno Accademico 2015/2016) 956 HORTICULTURE Parchi e giardini (Anno Accademico 2015/2016) 959 LABORATORY OF ARCHITECTURAL DESIGN Patologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) 963 GRAPEVINE PATHOLOGY Patologia delle derrate alimentari (Anno Accademico 2015/2016) 969 POST-HARVEST PATHOLOGY Patologia e Risanamento Conservativo delle Piante Storiche (Anno Accademico 2015/2016) 972 STUDIO Patologia vegetale - SFA (Anno Accademico 2015/2016) 975 PLANT PATHOLOGY Patologia vegetale - STA (Anno Accademico 2015/2016) 980 PLANT PATHOLOGY Pedologia (Anno Accademico 2015/2016) 983 PEDOLOGY Pedologia forestale (Anno Accademico 2015/2016) 987 FOREST PEDOLGY Pedologia forestale - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 991 FOREST PEDOLOGY Ciclo della sostanza organica (Anno Accademico 2015/2016) 991 CYCLE OF ORGANIC MATTER Pedologia forestale (Anno Accademico 2015/2016) 996 FOREST PEDOLGY Pedologia generale e fisica del suolo (Anno Accademico 2015/2016) 1000 PEDOLOGY AND SOIL PHYSICS Pianificazione faunistica (Anno Accademico 2015/2016) 1005 PLANNING OF WILDLIFE SYSTEMS Pianificazione pastorale - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) - 10 - 1009 PASTURE MANAGEMENT AND PLANNING Pianificazione pastorale I (Anno Accademico 2015/2016) 1009 RANGELAND MANAGEMENT PLANNING 1 Pianificazione pastorale II (Anno Accademico 2015/2016) 1014 PASTURE MANAGEMENT AND PLANNING II Pianificazione pastorale I (Anno Accademico 2015/2016) 1018 RANGELAND MANAGEMENT PLANNING 1 Pianificazione pastorale II (Anno Accademico 2015/2016) 1022 PASTURE MANAGEMENT AND PLANNING II Plant ecophysiology (Anno Accademico 2015/2016) 1026 Plant ecophysiology Plant growth regulators (Anno Accademico 2015/2016) 1029 Plant growth regulators Plant protection (Anno Accademico 2015/2016) 1031 Plant protection Prevenzione dell'erosione del suolo, delle frane e delle valanghe (Anno Accademico 2015/2016) 1033 PREVENTION OF SOIL EROSION, LANDSLIDES AND SNOW AVALANCHES Principi di chimica (Anno Accademico 2015/2016) 1036 General chemistry Principi di dietetica e nutrizione umana (Anno Accademico 2015/2016) 1041 APPLIED DIETOLOGY Principi di economia ed elementi di statistica (Anno Accademico 2015/2016) 1044 PRINCIPLES OF ECONOMY AND ELEMENTS OF STATISTICS Principi di genetica - TAL (Anno Accademico 2015/2016) 1050 APPLIED GENETICS TO FOOD PRODUCTION Principi di genetica - VE (Anno Accademico 2015/2016) 1055 GENETICS APPLIED TO VITICULTURE AND OENOLOGY Principles of pedology (Anno Accademico 2015/2016) 1059 Principles of pedology Produzioni animali (Anno Accademico 2015/2016) 1062 ANIMAL PRODUCTION Produzioni sementiere (Anno Accademico 2015/2016) 1068 SEED PRODUCTION Produzioni sementiere, insetti pronubi e tecniche di impollinazione - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1073 SEED PRODUCTION, POLLINATING INSECTS AND POLLINATION TECHNIQUES Insetti pronubi e tecniche di impollinazione (Anno Accademico 2015/2016) 1073 POLLINATING INSECTS AND POLLINATION TECHNIQUES Produzioni sementiere (Anno Accademico 2015/2016) 1077 SEED PRODUCTION Protezione dagli incendi boschivi (Anno Accademico 2015/2016) 1082 FOREST FIRE PROTECTION Recupero della fertilità delle aree dismesse (Anno Accademico 2015/2016) 1085 STUDIO Rilievo e rappresentazione del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) 1088 LANDSCAPE SURVEY AND REPRESENTATION Scelta delle specie vegetali per il paesaggio 1092 LANDSCAPE DESIGN STUDIO Secondary metabolites in grapevine (Anno Accademico 2015/2016) 1095 Secondary metabolites in grapevine Selvicoltura di protezione e di montagna (Anno Accademico 2015/2016) 1100 MOUNTAIN AND PROTECTION SILVICULTURE Selvicoltura speciale (Anno Accademico 2015/2016) 1104 SPECIAL SILVICULTURE Sicurezza dei prodotti di origine animale per la ristorazione (Anno Accademico 2015/2016) 1109 SUPPLY AND SAFETY OF ANIMAL FOOD Sicurezza e igiene dei prodotti alimentari (Anno Accademico 2015/2016) - 11 - 1112 FOOD PRODUCTS SAFETY AND HYGIENE Sistemazioni idraulico-forestali (Anno Accademico 2015/2016) 1115 HYDRAULIC ASSESSMENT Sistemi energetici ed energie rinnovabili (Anno Accademico 2015/2016) 1120 ENERGY SYSTEMS AND RENEWABLE ENERGY Sistemi informativi per l'industria alimentare (Anno Accademico 2015/2016) 1124 INFORMATION TECHNOLOGIES FOR FOOD INDUSTRY Soil plant climate system modeling 1 - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1128 SOIL PLANT CLIMATE SYSTEM MODELING 1 Nutrient cycling in soil-plant systems (Anno Accademico 2015/2016) 1128 Nutrient cycling in soil-plant systems Principles of pedology (Anno Accademico 2015/2016) 1131 Principles of pedology Soil plant climate system modeling 2 - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1134 SOIL PLANT CLIMATE SYSTEM MODELING 2 Application of agro-ecosystem models to field crops (Anno Accademico 2015/2016) 1134 Application of agro-ecosystem models to field crops Plant ecophysiology (Anno Accademico 2015/2016) 1138 Plant ecophysiology Water cycling in soil-plant-climate system (Anno Accademico 2015/2016) 1141 Water cycling in soil-plant-climate system Specie vegetali per il progetto (Anno Accademico 2015/2016) 1144 ORNAMENTAL PLANTS FOR PARKS AND GARDENS Statistica applicata - SA (Anno Accademico 2015/2016) 1148 APPLIED STATISTICS Statistica applicata - ZOO (Anno Accademico 2015/2016) 1152 APPLIED STATISTICS Statistica e bioinformatica (Anno Accademico 2015/2016) 1156 STATISTICS AND BIOINFORMATICS Storia della vite e del vino nell'alimentazione (Anno Accademico 2015/2016) 1162 FOOD HISTORY Strategie zootecniche per il miglioramento quanti-qualitativo dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 1166 ZOOTECHNICAL STATEGIES FOR IMPROVING QUANTITY AND QUALITY OF LIVESTOCK MANURE Studio degli ambienti viticoli (Anno Accademico 2015/2016) 1169 STUDIES ON VINEYARD ENVIRONMENTS Tablegrape innovation (Anno Accademico 2015/2016) 1172 Tablegrape innovation Tablegrape processing (Anno Accademico 2015/2016) 1174 Tablegrape processing Tablegrape protected cultivation (Anno Accademico 2015/2016) 1178 Tablegrape protected cultivation Tablegrape soiless cultivation (Anno Accademico 2015/2016) 1183 Tablegrape soiless cultivation Tecnica enologica e gestione della qualità (Anno Accademico 2015/2016) 1185 OENOLOGICAL TECHNIQUE AND QUALITY MANAGEMENT Tecniche analitiche avanzate per l'enologia (Anno Accademico 2015/2016) 1190 ADVANCED ANALYTICS IN WINE CHEMISTRY Tecniche avanzate per il controllo degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) 1193 ADVANCED OF FOOD CONTROL TECHNIQUES Tecniche di diagnosi e analisi molecolari 1 (Anno Accademico 2015/2016) 1197 DIAGNOSTIC AND MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES 1 Tecniche di diagnosi e analisi molecolari 2 (Anno Accademico 2015/2016) 1201 DIAGNOSTICS AND MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES 2 Tecniche di gestione dei suoli in ambiente caldo-arido (Anno Accademico 2015/2016) 1205 SOIL MANAGEMENT IN WARM-ARID ENVIRONMENTS Tecniche di laboratorio integrate - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) - 12 - 1208 INTEGRATED LABORATORY TECHNIQUES Tecniche di diagnosi e analisi molecolari 1 (Anno Accademico 2015/2016) 1208 DIAGNOSTIC AND MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES 1 Tecniche di diagnosi e analisi molecolari 2 (Anno Accademico 2015/2016) 1212 DIAGNOSTICS AND MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES 2 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali (Anno Accademico 2015/2016) 1216 FORESTRY ACTIVITIES AND WOOD TECHNOLOGIES Tecnologia della ristorazione e gestione della qualità (Anno Accademico 2015/2016) 1221 CATERING TECHNOLOGY AND QUALITY MANAGEMENT Tecnologia per la gestione degli agrofarmaci (Anno Accademico 2015/2016) 1224 TECHNOLOGY FOR THE MANAGEMENT OF PESTICIDES Tecnologie agroalimentari (Anno Accademico 2015/2016) 1227 AGRI-FOOD TECHNOLOGIES Tecnologie alimentari 1 (Anno Accademico 2015/2016) 1232 FOOD TECHNOLOGIES 1 Tecnologie alimentari 2 (Anno Accademico 2015/2016) 1236 FOOD TECHNOLOGIES 2 Tecnologie dei prodotti alimentari territoriali (Anno Accademico 2015/2016) 1241 TERRITORIAL FOOD PRODUCT TECHNOLOGY Tecnologie e chimica enologica (Anno Accademico 2015/2016) 1244 WINE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Tecnologie enologiche per le zone calde e aride degli ambienti mediterranei (Anno Accademico 2015/2016) 1248 OENOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR MEDITERRANEAN WARM AND ARID ZONES Tecnologie informatiche per le filiere alimentari - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1251 INFORMATION TECHNOLOGIES FOR FOOD SUPPLY CHAINS Informatica applicata all'elaborazione statistica dei dati (Anno Accademico 2015/2016) 1251 COMPUTATIONAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS Sistemi informativi per l'industria alimentare (Anno Accademico 2015/2016) 1255 INFORMATION TECHNOLOGIES FOR FOOD INDUSTRY Telerilevamento e fotointerpretazione (Anno Accademico 2015/2016) 1259 OPTICAL REMOTE SENSING AND IMAGE INTERPRETATION Topografia (Anno Accademico 2015/2016) 1263 TOPOGRAPHY Topografia e cartografia (Anno Accademico 2015/2016) 1267 LAND SURVEY AND CARTOGRAPHY Trasformazione genetica (Anno Accademico 2015/2016) 1273 Genetic transformation of plants Trattamento e uso agronomico dei reflui zootecnici - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1278 TREATMENT AND AGRONOMIC USE OF MANURE Gestione e trattamento dei reflui zootecnoci (Anno Accademico 2015/2016) 1278 MANAGEMENT AND TREATMENT OF LIVESTOCK MANURE Uso agronomico dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 1283 AGRONOMIC USE OF LIVESTOCK MANURE Uso agronomico dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) 1287 AGRONOMIC USE OF LIVESTOCK MANURE Uso sostenibile degli agrofarmaci - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1291 SUSTAINABLE USE OF PESTICIDES Destino ambientale degli agrofarmaci (Anno Accademico 2015/2016) 1291 ENVIRONMENTAL FATE OF PESTICIDES Tecnologia per la gestione degli agrofarmaci (Anno Accademico 2015/2016) 1295 TECHNOLOGY FOR THE MANAGEMENT OF PESTICIDES Valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio (Anno Accademico 2015/2016) 1298 TERRITORIAL FOOD PRODUCT VALORISATION Valorizzazione e legislazione dei prodotti alimentari - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) 1301 VALORISATION AND LEGISLATION OF FOOD PRODUCTS Legislazione alimentare (Anno Accademico 2015/2016) 1301 - 13 - Food legislation Marketing dei prodotti agroalimentari (Anno Accademico 2015/2016) 1304 Marketing of food products Valutazione della potenzialità dei suoli (Anno Accademico 2015/2016) 1308 STUDIO Vineyard management, vine development and secondary metabolites in grape (Anno Accademico 2015/2016) 1311 VINEYARD MANAGEMENT, VINE DEVELOPMENT AND SECONDARY METABOLITES IN GRAPE Viticoltura (Anno Accademico 2015/2016) 1315 VITICULTURE Viticoltura di territorio (Anno Accademico 2015/2016) 1319 TERRITORY VITICULTURE Viticultural pedology (Anno Accademico 2015/2016) 1322 VITICULTURAL PEDOLOGY Water cycling in soil-plant-climate system (Anno Accademico 2015/2016) 1326 Water cycling in soil-plant-climate system Zoologia e parassitologia (Anno Accademico 2015/2016) 1329 ZOOLOGY AND PARASITOLOGY Zootecnica generale (Anno Accademico 2015/2016) 1332 GENERAL ZOOTECHNICS - 14 - Abilità informatiche (Anno Accademico 2015/2016) COMPUTER SKILLS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0020 Docente: Ing. Paolo GAY (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708620, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: INF/01 - informatica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Prova pratica PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone di fornire una introduzione generale all'informatica ed all'uso dei calcolatori, e le nozioni fondamentali per utilizzare in modo autonomo i pacchetti applicativi per l'elaborazione di testi, la creazione di presentazioni, fogli elettronici, basi di dati, navigazione nella rete Internet, posta elettronica. English The objective of the course is to provide a general introduction to computer science and personal computer usage, such as basic notions to autonomously work on popular sofware packages: word processor, spreadsheets, slide presentation, data bases, internet browsing and email. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione delle abilità necessarie per poter lavorare in modo professionale con il personal computer. English Acquisition of basic skills to work with the personal computer in a professional and autonomous way. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English - 15 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica in itinere dell'apprendimento avviene rispondendo a domande analoghe a quelle incontrate all'esame e con lo svolgimento di simulazioni di esame con pacchetti software appositi. English The runtime check of the learning process is accomplished by answering questions analogous to those found in the exam, and by exam simulations using ad-hoc software packages. PROGRAMMA Italiano Modulo 1 - Concetti di base dell'ICT Modulo 2 - Uso del computer e gestione dei file Modulo 3 - Elaborazione testi Modulo 4 - Fogli elettronici Modulo 5 - Uso delle basi di dati Modulo 6 - Strumenti di presentazione Modulo 7 - Navigazione e comunicazione in rete Simulazioni di esame English Module 1 - Concepts of ICT Module 2 - Using the Computer and Managing Files Module 3 - Word Processing Module 4 - Spreadsheets Module 5 - Using Databases Module 6 - Presentation Module 7 - Web Browsing and Communication Exam simulations TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - 16 - I testi base consigliati per il corso sono: La guida McGraw- Hill alla Patente Europea del Computer – Syllabus 5.0, McGraw-Hill, disponibile in varie versioni a seconda del sistema operativo/famiglia di programmi Office utilizzata. Sono di seguito indicati siti internet di interesse: http://www.ecdl.it/ http://www.ecdl.unito.it/ http://www.di.unito.it/~garetto/ecdl/ English La guida McGraw- Hill alla Patente Europea del Computer – Syllabus 5.0, McGraw-Hill, available in various editions depending on operating system and office version. Web sites: http://www.ecdl.it/ http://www.ecdl.unito.it/ http://www.di.unito.it/~garetto/ecdl/ NOTA Italiano Esame a quiz al calcolatore per ciascuno dei sette moduli del corso English One practical test for each of the seven modules of the course. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d00c - 17 - Abilità informatiche (Anno Accademico 2015/2016) COMPUTER SKILLS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0025 Docente: Ing. Paolo GAY (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708620, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia [f001-c703] L - Tecnologie alimentari [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 1° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: INF/01 - informatica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Prova pratica PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone di fornire una introduzione generale all'informatica ed all'uso dei calcolatori, e le nozioni fondamentali per utilizzare in modo autonomo i pacchetti applicativi per l'elaborazione di testi, la creazione di presentazioni, fogli elettronici, basi di dati, navigazione nella rete Internet, posta elettronica. English The objective of the course is to provide a general introduction to computer science and personal computer usage, such as basic notions to autonomously work on popular sofware packages: word processor, spreadsheets, slide presentation, data bases, internet browsing and email. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione delle abilità necessarie per poter lavorare in modo professionale con il personal computer. English Acquisition of basic skills to work with the personal computer in a professional and autonomous way. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 18 - English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica in itinere dell'apprendimento avviene rispondendo a domande analoghe a quelle incontrate all'esame e con lo svolgimento di simulazioni di esame con pacchetti software appositi. English The runtime check of the learning process is accomplished by answering questions analogous to those found in the exam, and by exam simulations using ad-hoc software packages. PROGRAMMA Italiano Modulo 1 - Concetti di base dell'ICT Modulo 2 - Uso del computer e gestione dei file Modulo 3 - Elaborazione testi Modulo 4 - Fogli elettronici Modulo 5 - Uso delle basi di dati Modulo 6 - Strumenti di presentazione Modulo 7 - Navigazione e comunicazione in rete Simulazioni di esame English Module 1 - Concepts of ICT Module 2 - Using the Computer and Managing Files Module 3 - Word Processing Module 4 - Spreadsheets Module 5 - Using Databases Module 6 - Presentation Module 7 - Web Browsing and Communication Exam simulations TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA - 19 - Italiano I testi base consigliati per il corso sono: La guida McGraw- Hill alla Patente Europea del Computer – Syllabus 5.0, McGraw-Hill, disponibile in varie versioni a seconda del sistema operativo/famiglia di programmi Office utilizzata. Sono di seguito indicati siti internet di interesse: http://www.ecdl.it/ http://www.ecdl.unito.it/ English La guida McGraw- Hill alla Patente Europea del Computer – Syllabus 5.0, McGraw-Hill, available in various editions depending on operating system and office version. Web sites: http://www.ecdl.it/ http://www.ecdl.unito.it/ NOTA Italiano Esame a quiz al calcolatore per ciascuno dei sette moduli del corso English One practical test for each of the seven modules of the course. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=idnx - 20 - Acarologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) VINEYARD MITE CONTROL Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0507 Docente: Prof. Antonella Marta Di Palma (Affidamento esterno) Contatti docente: 0881589323, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Con riferimento alle competenze scientifiche e tecniche che il laureato deve possedere per la gestione dei processi della produzione in campo, questo corso intende fornire le conoscenze sulle problematiche legate alla presenza di Acari su Vite in ambiente mediterraneo guardando alle possibili interazioni con la gestione del vigneto. Inoltre verranno forniti gli strumenti tecnici necessari per un corretto riconoscimento di quei gruppi e specie che vengono considerati dannosi per la Vite. Infine il corso intende fornire le conoscenze necessarie alla gestione delle problematiche di monitoraggio e controllo di questi artropodi in osservanza dei disciplinari di produzione integrata. English Within the scientific and technical knowledge necessary to a sustainable production, the course provides knowledge on the morphology, biology and ecology of mites living on grapevine in the Mediterranean area and the problems connected with the vineyard management, possible damages, monitoring and integrated pest control programs. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà conoscere le caratteristiche morfologiche, biologiche ed ecologiche peculiari delle specie di Acari trattate. Inoltre dovrà comprendere le interazioni fitofago/pianta e saper riconosce in campo la sintomatologia ed i danni provocati dalle diverse specie su Vite. Dovrà conoscere ed essere in grado di organizzare programmi di monitoraggio ed operazioni di controllo integrato sulla base delle conoscenze di biologia ed ecologia apprese nel - 21 - corso. Avere la capacità di applicare i disciplinari di produzione integrata regionali English The student must be able to recognize in the field the presence of different mite species, symptoms and damage and hence be able to organize an integrated pest management program. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 36 ore di lezione frontale e 5 ore dedicate ad eservitazioni di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 36 hours of lectures and 6 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher will use slide presentations athat will be available for the students MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento avviene mediante prova orale della durata di circa 20 minuti. Saranno poste 4 domande su argomenti del programma d'insegnamento e sulle esercitazioni. Almeno due domande riguarderanno argomenti della parte generale del programma ed almeno due argomenti della parte speciale. Durante l'esame saranno discussi anche aspetti riguardanti il riconoscimento morfologico degli Acari. La commissione, composta dal docente ufficiale e da un altro componente, accerterà con accuratezza il livello delle conoscenze specifiche raggiunto dallo studente, valuterà la capacità di orientarsi nelle problematiche trattate nonché le competenze acquisite in merito alla proposizione di soluzioni alle problematiche oggetto di studio. Verrà valutata, altresì, la chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio. English The final exam is an oral exam of about 20 minutes with questions on at least four topics of the program. PROGRAMMA Italiano Programma dettagliato dell'insegnamento: Parte Generale (Per la parte generale studio sui testi: Zangheri L. Pellizzari Scaltriti G. – Parassitologia animale dei vegetali. C.L.E.U.P. Padova; AA.VV. - Manuale di Zoologia Agraria. Antonio Delfino e su materiale didattico distribuito a lezione) 1.Caratteristiche generali del Phylum Artropoda - 22 - 2.Caratteristiche della Classe Arachnida, Ordine Acarina 3.Aspetti di morfologia esterna ed anatomia interna degli acari (esoscheletro, apparati boccali, organizzazione generale, sistemi muscolare, nervoso, apparati digerente, circolatorio, respiratorio, riproduttore, secretore), Riproduzione e sviluppo (embrionale e post-embrionale), Etologia (diffusione delle specie, fotoperiodismo, diapausa e quiescenza). 4.Gli acari in rapporto alle piante ed alla Vite in particolare: interazioni pianta-fitofago, concetto di danno, cenni di ecologia applicata al controllo dei fitofagi, dinamica di popolazione (stima della dimensione e sue fluttuazioni) tecniche di campionamento e monitoraggio, fattori di contenimento biotici ed abiotici, soglie d'intervento, metodi e mezzi di controllo demografico: naturale, biologico, bio-tecnico, chimico, integrato, altri metodi di controllo. 5. Acari predatori e biofabbriche Parte speciale (Per la Parte speciale studio sui testi: Zangheri L. Pellizzari Scaltriti G. – Parassitologia animale dei vegetali. C.L.E.U.P. Padova.; AA.VV. - Manuale di Zoologia Agraria. Antonio Delfino Editore; e su materiale didattico distribuito a lezione). Acari della vite: Tetranychidae: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini, Tenupalpidae: Brevipalpus lewisis, Eriophyidae: Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis, Eriophyes oculivitis. Predatori: Phytoseiidae. Esercitazioni e visite guidate 1. Identificazione dei principali gruppi di Acari e specie trattate nel corso. Svolgimento in aula. 2. Esempi di tipi di danni da parte di Acari su Vite. Svolgimento in aula. English Teaching programme (summary): General part Phylum Artropoda: general morphology and biology. Phylogeny and Classification. Arachnida and Acarina: general morphology, internal anatomy, biology, ethology, ecology, reproduction, embryonic e post-embryonic development. Vineyard Mites: damage, ecology, population dynamic, monitoring, IPM Predatory mites and Suppliers of Natural Enemies Systematic Vineyard Mites: Tetranychidae: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini, Tenupalpidae: Brevipalpus lewisis, Eriophyidae: Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis, Eriophyes oculivitis. Predators: Phytoseiidae. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - 23 - Ragusa S. Tsolakis H. La difesa della vite dagli artropodi dannosi. Università degli studi di Palermo. Zangheri L. Pellizzari Scaltriti G. – Parassitologia animale dei vegetali. C.L.E.U.P. Padova. AA.VV. - Manuale di Zoologia Agraria. Antonio Delfino Editore. Appunti presi autonomamente a lezione. Materiale didattico fornito a lezione dal docente, su specifici argomenti English Ragusa S. Tsolakis H. La difesa della vite dagli artropodi dannosi. Università degli studi di Palermo. Zangheri L. Pellizzari Scaltriti G. – Parassitologia animale dei vegetali. C.L.E.U.P. Padova. AA.VV. - Manuale di Zoologia Agraria. Antonio Delfino Editore. Lecture notes. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Foggia English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p8uu - 24 - Agro-environmental economics (Anno Accademico 2015/2016) Agro-environmental economics Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0171 Docente: Silvia NOVELLI (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708723, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti un approccio economico ai problemi ambientali in agricoltura Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English To provide students with an economic approach to environmental issues in agriculture The course is fully delivered in English language only RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiranno gli strumenti analitici necessari ad interpretare i problemi agro-ambientali in una prospettiva economica; saranno in grado di esaminare in questo quadro le politiche agro-ambientali della UE. English Students will achieve the analytical tools needed to interpret agri-environmental issues in an economic perspective; they will be able to discuss in this framework agricultural and agri-environmental policies of the EU. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate ad esercitazioni in aula e visite presso aziende - 25 - agricole. Per le lezioni frontali la docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The module consists of 30 hours of lectures and 10 hours devoted to practical lessons and farm visits. Classes are held using Power Point slides, available to students on the web. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine di ciascuna parte del programma (Parte 1, 2 e 3) la docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica mediante discussioni in aula sugli argomenti trattati, senza valore per la valutazione finale, ma utile agli studenti per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale (in inglese) che prevede tre domande, una per ciascuna parte del corso (Parte 1, 2 e 3), che mira a verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English At the end of each part of the program (Part 1, 2 and 3) the lecturer will test the teaching effectiveness through discussions in class. The intermediate verifications are not valid for the final evaluation, but helpful to the students to estimate their degree of learning. The final exam is an oral exam (taken in english). The students will be asked three questions that cover the three parts of the syllabus (Part 1, 2 and 3), in order to assess their understanding of the connections among the different areas of study. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e gestione. Il programma si articola in tre parti: PARTE 1 Revisione dei concetti economici di base. Il mercato come meccanismo efficiente di allocazione delle risorse. Ottimo di Pareto. Efficienza ed equità. Il principio di compensazione di Kaldor-Hicks. Fallimenti di mercato: beni pubblici, esternalità, risorse ad accesso libero. Esternalità come ragione del non-raggiungimento dell'ottimo sociale. Livello ottimale di esternalità. Interventi di politica economica rispetto alle esternalità: definizione dei diritti di proprietà, standard, tasse, sussidi, permessi negoziabili. PARTE 2 Agricultura ed ambiente. Esternalità positive e negative prodotte dall'agricoltura. Evoluzione strutturale e tecnica dell'agricoltura e suoi impatti sull'ambiente. Agricoltura sostenibile e agricoltura multifunzionale. La Politica Agricola Comune e l'ambiente. Le misure agro-ambientali e il "rinverdimento" della PAC. PARTE 3 Beni pubblici. La misurazione economica dei benefici prodotti dai beni pubblici. Metodi di valutazione dei benefici prodotti dai beni pubblici. English - 26 - The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of production and management. The syllabus is divided into three units of study: PART 1 Revision of basic economics. Market as an efficient resource allocation mechanism. Pareto optimum. Efficiency and equity. Kaldor-Hicks compensation principle. Market failures: public goods, externalities, open access resources. Externalities. Externalities as a reason for not reaching a social optimum. Optimal level of externalities. Policy interventions on externalities: property right definition, standards, taxes, subsidies, marketable permits. PART 2 Agriculture and environment. Positive and negative externalities associated to agricultural production. Structural and technical evolution of agriculture and its impact on environment. Sustainable agriculture and multifunctional agriculture. The Common Agricultural Policy and the environment. Agro-environmental measures and the greening of the CAP. PART 3 Public goods. The economic measurement of benefits from public goods. Valuation methods of the benefits of public goods. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni Power-Point del corso, caricate a inizio corso sulla piattaforma Campusnet Unito. Testi consigliati: Un testo generale di Economia Ambientale: Pearce D.W, Turner K.R., Economia delle risorse naturali e dell'ambiente, Il Mulino, Bologna Un testo più specifico sull'agricoltura: Zilberman D., Marra M., Agricultural Externalities, in G.A. Carlson, D. Zilberman and J.A. Miranowski (eds) Agricultural and Environmental Resource Economics, New York, Oxford University Press, 1993 English PowerPoint presentations. The presentations will be uploaded to the platform Campusnet Unito at the beginning of the course. Recommended textbooks: A general textbook on Environmental economics: Pearce D.W, Turner K.R., Economics of Natural Resources and the Environment, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990 A more specific textbook on agriculture: Zilberman D., Marra M., Agricultural Externalities, in G.A. Carlson, D. Zilberman and J.A. Miranowski (eds) Agricultural and Environmental Resource Economics, New York, Oxford University Press, 1993 NOTA Italiano Il corso viene interamente svolto in lingua inglese - 27 - English The course is fully delivered in English language only Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cb6d - 28 - Agro-environmental economics and agronomy - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) AGRO-ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND AGRONOMY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0171 Docente: Silvia NOVELLI (Affidamento interno) Dott. Francesco VIDOTTO (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708723, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Agro-environmental economics (Anno Accademico 2015/2016) Environmental agronomy (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k7bj Agro-environmental economics (Anno Accademico 2015/2016) Agro-environmental economics Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0171 Docente: Silvia NOVELLI (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708723, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 29 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti un approccio economico ai problemi ambientali in agricoltura Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English To provide students with an economic approach to environmental issues in agriculture The course is fully delivered in English language only RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiranno gli strumenti analitici necessari ad interpretare i problemi agro-ambientali in una prospettiva economica; saranno in grado di esaminare in questo quadro le politiche agro-ambientali della UE. English Students will achieve the analytical tools needed to interpret agri-environmental issues in an economic perspective; they will be able to discuss in this framework agricultural and agri-environmental policies of the EU. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate ad esercitazioni in aula e visite presso aziende agricole. Per le lezioni frontali la docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The module consists of 30 hours of lectures and 10 hours devoted to practical lessons and farm visits. Classes are held using Power Point slides, available to students on the web. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine di ciascuna parte del programma (Parte 1, 2 e 3) la docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica mediante discussioni in aula sugli argomenti trattati, senza valore per la valutazione finale, ma utile agli studenti per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale (in inglese) che prevede tre domande, una per ciascuna parte del corso (Parte 1, 2 e 3), che mira a verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English - 30 - At the end of each part of the program (Part 1, 2 and 3) the lecturer will test the teaching effectiveness through discussions in class. The intermediate verifications are not valid for the final evaluation, but helpful to the students to estimate their degree of learning. The final exam is an oral exam (taken in english). The students will be asked three questions that cover the three parts of the syllabus (Part 1, 2 and 3), in order to assess their understanding of the connections among the different areas of study. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e gestione. Il programma si articola in tre parti: PARTE 1 Revisione dei concetti economici di base. Il mercato come meccanismo efficiente di allocazione delle risorse. Ottimo di Pareto. Efficienza ed equità. Il principio di compensazione di Kaldor-Hicks. Fallimenti di mercato: beni pubblici, esternalità, risorse ad accesso libero. Esternalità come ragione del non-raggiungimento dell'ottimo sociale. Livello ottimale di esternalità. Interventi di politica economica rispetto alle esternalità: definizione dei diritti di proprietà, standard, tasse, sussidi, permessi negoziabili. PARTE 2 Agricultura ed ambiente. Esternalità positive e negative prodotte dall'agricoltura. Evoluzione strutturale e tecnica dell'agricoltura e suoi impatti sull'ambiente. Agricoltura sostenibile e agricoltura multifunzionale. La Politica Agricola Comune e l'ambiente. Le misure agro-ambientali e il "rinverdimento" della PAC. PARTE 3 Beni pubblici. La misurazione economica dei benefici prodotti dai beni pubblici. Metodi di valutazione dei benefici prodotti dai beni pubblici. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of production and management. The syllabus is divided into three units of study: PART 1 Revision of basic economics. Market as an efficient resource allocation mechanism. Pareto optimum. Efficiency and equity. Kaldor-Hicks compensation principle. Market failures: public goods, externalities, open access resources. Externalities. Externalities as a reason for not reaching a social optimum. Optimal level of externalities. Policy interventions on externalities: property right definition, standards, taxes, subsidies, marketable permits. PART 2 Agriculture and environment. Positive and negative externalities associated to agricultural production. Structural and technical evolution of agriculture and its impact on environment. Sustainable agriculture and multifunctional agriculture. The Common Agricultural Policy and the environment. Agro-environmental measures and the greening of the CAP. PART 3 Public goods. The economic measurement of benefits from public goods. Valuation methods of the benefits of public goods. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA - 31 - Italiano Presentazioni Power-Point del corso, caricate a inizio corso sulla piattaforma Campusnet Unito. Testi consigliati: Un testo generale di Economia Ambientale: Pearce D.W, Turner K.R., Economia delle risorse naturali e dell'ambiente, Il Mulino, Bologna Un testo più specifico sull'agricoltura: Zilberman D., Marra M., Agricultural Externalities, in G.A. Carlson, D. Zilberman and J.A. Miranowski (eds) Agricultural and Environmental Resource Economics, New York, Oxford University Press, 1993 English PowerPoint presentations. The presentations will be uploaded to the platform Campusnet Unito at the beginning of the course. Recommended textbooks: A general textbook on Environmental economics: Pearce D.W, Turner K.R., Economics of Natural Resources and the Environment, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990 A more specific textbook on agriculture: Zilberman D., Marra M., Agricultural Externalities, in G.A. Carlson, D. Zilberman and J.A. Miranowski (eds) Agricultural and Environmental Resource Economics, New York, Oxford University Press, 1993 NOTA Italiano Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English The course is fully delivered in English language only Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cb6d - 32 - Environmental agronomy (Anno Accademico 2015/2016) Environmental agronomy Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0171 Docente: Dott. Francesco VIDOTTO (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 670 8781, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Analizzare le principali relazioni fra sistemi produttivi agricoli e l'ambiente, con particolare riguardo agli effetti dell'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura. Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English To analyze the main interconnections between agricultural production systems and the environment, with a special emphasis on the effects of the use of Plant Protection Products (PPPs) on water bodies. The course is fully delivered in English language only RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti disporranno delle conoscenze necessarie a comprendere e mettere in opera le principali misure agronomiche per la mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente legati all'impiego dei prodotti fitosanitari. Gli studenti saranno in grado di svolgere una diagnosi a livello di bacino del rischio di trasferimento di prodotti fitosanitari alle acque superficiali dovuto al ruscellamento e di proporre misure di mitigazione adeguate. English Students will obtain an understanding of the agronomic techniques that can be applied profitably to mitigate the potential adverse effects of use of PPPs on the environment. Students will be able to perform a diagnosis of the risk - 33 - of transfer of pesiticides to water bodies due to runoff at water cactchment scale and to propose the correct mitigation measures to be adopted. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti sarà valutato di volta in volta nel corso delle esercitazioni pratiche. English Levels of learning acquired by the students will be evaluated regularly during practical lessons. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Durante il corso sono previste una o più uscite in campo in un bacino dimostrativo (Valle del Tiglione) per l'acquisizione di elementi indispensabili al completamento della diagnosi a scala di bacino del rischio di ruscellamento. English One or more field excursions will be perfomed to collect data for the runoff risk diagnosis at catchment level (Tiglione Valley). PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e gestione. In particolare, il contenuti del corso consentono lo sviluppo di competenze nell'interpretazione di complessi problemi riferiti ai rapporti agricoltura-ambiente e alle filiere produttive agricole. Stato dell'ambiente nell'Unione Europea. Attività umane che determinano i maggiori impatti sull'ambiente. Introduzione allo stato dell'ambiente e importanza delle acque superficiali nella regione pan-europea. Impatti sulla biodiversità: specie vegetali esotiche invasive (Ambrosia artemisiifolia (common ragweed), Sicyos angulatus (burcucumber), Solanum carolinense (carolina horsenettle), Pueraria montana (kudzu). Lo schema DPSIR per l'interpretazione dell'impatto ambientale Direttiva europea quadro sulle acque (European Water Framework Directive – WFD – 2000/60/EC); indici di vulnerabilità ai nitrati e ai prodotti fitosanitari; legislazione nazionale e regionale correlata. Definizione di prodotto fitosanitario secondo il Regolamento (EC) N° 1107/2009. Descrizione e analisi della Direttiva 2009/128/EC sull'uso sostenibile dei pesticidi. - 34 - Impatto dell'uso di prodotti fitosanitari: sorgenti di inquinamento puntiformi e diffuse; destino ambientale; misure di mitigazione di tipo agronomico del rischio di inquinamento delle acque superficiali. Diagnosi del rischio di trasferimento da ruscellamento in un bacino dimostrativo (Valle del Tiglione). Analisi delle informazioni territoriali disponibili attraverso l'impiego di strumenti GIS. Applicazione delle linee guida TOPPS-Prowadis per la classificazione del rischio. Validazione di campo. Elaborazione e proposta di misure di mitigazione. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of production and management. In particular, the subjects will allow the students to acquire skills in the field of issues related to agriculture-environment interactions. State of the enivronment in the EU. Factors of human activity that drive the major impacts on the environment. Introduction to environmental status and importance of inland waters in pan-EU region. A threat to biodiversity: invasive alien plant species (Ambrosia artemisiifolia (common ragweed), Sicyos angulatus (burcucumber), Solanum carolinense (carolina horsenettle), Pueraria montana (kudzu). Environmental effects of agriculture; the DPSIR scheme for the interpretation of the environmental impact. The water compartment and legislative framework (European Water Framework Directive – WFD – 2000/60/EC; vulnerability indices to nitrates and pesticides; national and local policies). Definition of PPP according to Regulation (EC) N° 1107/2009 Concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC. Description and analysis of the Directive 2009/128/EC establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides Impact of use of pesticides; point and diffuse pollution-sources; environmental fate; agronomical practices for mitigation of contamination of water and other compartments. Runoff diagnosis on a pilot catchment basin (Tiglione Valley). Territorial data analysis with GIS tools, TOPPS_Prowadis diagnosis guidelines and risk classification. Field validation. Elaboration of proposed mitigation measures. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni PowerPoint, dispense del corso e articoli per le letture critiche distribuiti dopo ogni lezione. Tutte le presentazioni sono rilasciate secondo una licenza reative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Altro materiale consigliato: -TOPPS-Prowadis: Best Management Practices to reduce water pollution with plant protection products from runoff and erosion (fornito durante il corso) - "Think soils" manual (disponibile all'indirizzo http://www.ahdb.org.uk/projects/documents/ThinkSoils.pdf) - 35 - English The recommended basic texts for the course are: PowerPoint presentations, lecture notes and articles for critical readings distributed during the course. All PowerPoint presentations are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Other suggested literature: -TOPPS-Prowadis: Best Management Practices to reduce water pollution with plant protection products from runoff and erosion (provided during the course) - "Think soils" manual (available at http://www.ahdb.org.uk/projects/documents/ThinkSoils.pdf) NOTA Italiano Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English The course is fully delivered in English language only Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wu2d - 36 - Agrochimica ambientale (Anno Accademico 2015/2016) ENVIRONMENTAL AGROCHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0241 Docente: Prof. Franco AJMONE MARSAN (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708519, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti, che posseggono lauree di primo livello di diverso tipo, un inquadramento generale dei sistemi ambientali con particolare riferimento al suolo; offrire una descrizione di dettaglio degli inquinanti più comuni, della loro origine e del loro destino per mettere gli studenti in grado di identificare le tecniche e le strategie più adatte alla loro gestione. English The aim is to provide the students, who usually have a diversity of backgrounds, with a general description of environmental systems with particular reference to soil; to offer a detailed description of the most common contaminants of their origin and fate so to allow the students to identify the most appropriate techniques for their remediation. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di identificare gli indicatori necessari a descrivere i sistemi agricoli, individuare le fonti di inquinamento di origine agricola, misurarne gli effetti e definire le azioni di bonifica. English The course guides the students to indentify the environmental indicators that describe agricultural systems, recognize sources of contamination in agriculture, measure its effects and define remediation strategies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 37 - English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame orale English Oral exam esame orale PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e gestione. - L'ambiente: indicatori semplici e complessi - Il suolo come elemento dell'ambiente: Ripresa di alcune definizioni e concetti. Il suolo come corpo naturale, ruolo nell'ambiente Fasi solida, liquida e gassosa e composizione elementare - I componenti minerali e organici del suolo e le loro proprietà: Il significato ambientale dei componenti del suolo Le proprietà chimico-fisiche del suolo di rilevanza ambientale - Il ciclo biogeochimico di alcuni elementi Ciclo del carbonio, dell'azoto, del fosforo e loro implicazioni ambientali - La contaminazione Contaminanti inorganici (metalli pesanti) Contaminanti organici. Fitofarmaci, idrocarburi, diossine, PCB La contaminazione puntuale e diffusa Contaminazione del suolo, dell'aria e dell'acqua. Aspetti tecnici e normativi - Il laboratorio ambientale. English - The environment: simple and complex indicators - The soil as an element of the environment Basic concepts and definitions The soil as a natural body, its role in the environment The solid, liquid and gaseous phases and elemental composition - Mineral and organic components - 38 - The environmental role of soil components Physic-chemical properties of environmental importance - The biogeochemical cycle of some lements The cycle of carbon, nitrogen and phosphorus in the environment - Contamination Inorganic contaminants Organic contaminants: pesticides, hydrocarbons, dioxins, PCBs Point and diffuse contamination Soil water and air contamination Legislative and technical aspects - The laboratory for the environment TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Manahan S. Chimica dell'ambiente. Piccin Editore. English NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=36fa - 39 - Agronomia (Anno Accademico 2015/2016) AGRONOMY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0084 Docente: Prof. Carlo GRIGNANI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708777, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Vengono fornite le conoscenze fondamentali per avere un'elevata capacità di comprensione delle relazioni multifunzionali tra produzione vegetale in agricoltura e fattori antropici e non antropici che la condizionano. In particolare sono presentati i principali meccanismi che determinano l'influenza di suolo e clima sulle colture. Vengono descritte e studiate le azioni messe in atto in agricoltura per favorire la coltivazione: opere di sistemazione del terreno, di modifica dell'impatto climatico, lavorazioni del suolo, irrigazione e drenaggio, fertilizzazione, gestione residui colturali e sovescio, controllo della flora infestante, combinazione delle colture e cover crop nello spazio e nel tempo. Il corso introduce inoltre allo studio dei rapporti tra agricoltura e ambiente, della gestione del territorio agricolo e degli effetti di diverse forme di agricoltura, quale quella biologica, convenzionale ed ecocompatbile. L'agronomia pone le basi propedeutiche perché tutti i successivi corsi riguardanti i vari campi delle scienze delle coltivazioni (erbacee, arboree, orto-floricole), e gli studi della meccanizzazione agricola, l'idraulica e la meteorologia agraria, la malerbologia possano concentrarsi sulla parte specialistica. English The Agronomy course is the introductory study of the relationships between the agricultural crop production and the several human and natural factors that determine and control crop production. A detailed analyses is given to the classification and comprehension of the mechanisms through which climate and soil influence crop growth. production. The variety of possible actions applied in agriculture to favor crop cultivation is presented: systems to control soil slope and infiltration/runoff, to modify crop micro-climate, to manage soil tillage, irrigation and drainage, fertilization, crop residues managment, green manuring, weed management, rotation and cover crops management. This course is also an introduction to the study of the relationships between agriculture and the environment, of the agricultural land management, of the characterization of the different forms of agriculture (conventional, sustainable, organic). The Agronomy course is a base for other more specialized disciplines on the different aspect of plant cultivations (field crops, forage crops, vegetable and fruit plants), more specifically for the agricultural mechanization, hydraulic and irrigation, agro-meteorology, weed science. - 40 - RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Fornire agli studenti un appropriato ed aggiornato vocabolario e linguaggio tecnico relativamente ai problemi agronomici. Presentare agli studenti i fattori ambientali e i concetti fondamentali dell'agronomia con riferimento al complesso sistema clima-suolo-pianta, rendendoli capaci di spiegarne il significato e l'importanza. Addestrare gli studenti all'analisi delle relazioni tra fattori ambientali e concetti fondamentali dell'agronomia, per interpretare le cause delle scelte tecniche operate in agricoltura al fine di porre in essere il processo di coltivazione. Individuare le strategie per massimizzare l'efficienza delle agrotecniche. Addestrare gli studenti alla soluzione di semplici problemi di calcolo per sviluppare la loro capacità di trovare soluzioni numeriche nell'analisi delle relazioni citate. Stimolare l'approccio agro-sistemico per lo studio delle complesse relazioni multifunzionali che determinano le scelte di agrotecnica. Fornire una sufficiente gamma di esempi in cui il miglioramento della tecnica agronomica ha consentito di risolvere problemi di coltivazione e ambientali. English Students must acquire a specific and updated technical vocabulary and must learn to present agronomic problems with a correct and proper technical language. Students must be able to understand the meaning of the main environmental and technological factors that influence the soil-plant systems and must be able to explain their importance for agriculture and describe the expected relationships. Students must be able to explain the main reasons that back the choices of different agronomic managements frequently adopted by farmers. They must be able to solve simple calculations about soil, soil hydrology, irrigation, meteorology , fertilization. Students must be able to give examples for possible alternatives to choose the most appropriate management strategies and they must be able to discuss reasons for performing such choices depending on different soil-climate scenarios. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di circa 60 ore di lezione frontale e circa 20 ore dedicate a attività di esercitative in classe (calcoli e problemi) e visite in campo. English The course consists of about 60 hours of lectures and about 20 hours devoted to numerical excersices, problem solving and field visits. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Ogni giorno viene dedicato del tempo a stimolare domande da parte degli studenti. Vengono forniti esercizi risolti, anche pubblicati sulla pagina web. Circa 20 ore sono dedicate ad esercizi in classe. L'esame finale è uno scritto seguito subito da un colloquio orale. Nella prima parte ad ogni studente viene sottoposto un test scritto con domande aperte, a risposta multipla ed esercizi numerici. La parte orale del colloquio include la correzione del test scritto, la verifica della preparazione del candidato su altre domande e l'esame di un elaborato numerico preparato dallo studente nel corso delle esercitazioni. English - 41 - Every day some time is spent to collect questions from students. Examples of solved exercise is published on the Web. About 20 hours of the overall contact time is used for practical work in class. The final examination is written and oral. During the written intial part a number of open and multiple choices questions, as well as numerical problems are given to the candidate. In the oral part of the examination the written part is corrected and immidately evaluated, other more general questions are posed to the student who has also to present and discuss the numerical excercise he has developed during the practical work in class. Scritto e orale (normalmente nello stesso giorno)/ Oral and written (normally the two tests are in the same day) ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Visita ad aziende agricole e centro sperimentale Dipartimento English Visits to farms and experimental center of the Department PROGRAMMA Italiano Introduzione (2 ore): significati e obiettivi dell'Agronomia, Agronomia ed evoluzione dell'agricoltura, rapporti con le altre discipline, struttura del corso (lezioni, esercitazioni, esami), libri di testo, siti web. Suolo (8 ore e 5 esercitazione): definizioni, stratigrafia, strati di inibizione, composizione granulometrica, struttura, densità. Biologia del suolo (2 ore): cenni e importanza agronomica. Acqua nel suolo (6 ore e 4 esercitazione): potenziale idrico, umidità del terreno, bilancio idrico, cenni di dinamica dell'acqua nel suolo. Clima (5 ore): Condizioni meteorologiche e climatiche, radiazione, fotoperiodismo, temperatura dell'aria e del suolo, idrometeore, stazione meteorologica. Evapotraspirazione (4 ore e 4 esercitazioni): funzioni dell'acqua; coefficiente di ET, tipi di ET;coefficiente colturale; stima dell'ET. Regimazione dell'acqua in campo (6 ore): ristagno idrico, ruscellamento ed erosione, frane. Difesa dal ristagno: sistemazione dei terreni in piano; drenaggio sottosuperficiale. Difesa dai flussi superficiali veloci: sistemazioni di pendio. & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; Irrigazione (5 ore e 6 di esercitazione): scopi e tipologie. Idoneità dei terreni. Fabbisogno irriguo. Efficienza dell'irrigazione. Cenni a: Consumo idrico, variabili irrigue, e metodi di irrigazione per sommersione, scorrimento, infiltrazione laterale, irrigazione ipogea, per aspersione, microirrigazione; bilanci idrici; sistemi irrigui. Lavorazioni (6 ore): scopi e tipi di lavorazioni, profondità della lavorazione principale, alternative all'aratura. Fertilizzazione (6 ore): definizioni di legge e agronomiche; letame, liquame, pollina; sovescio totale e parziale; concimi chimici semplici, composti, complessi, da miscelazione, organici, organo-minerali; correttivi. Concimi con - 42 - elementi minori. Distribuzione dei fertilizzanti. Cenni al piano di concimazione; Lotta alle infestanti (6 ore): Danni arrecati alle colture. Classificazione delle infestanti. Diffusione. Mezzi di lotta preventivi. Mezzi fisici. Mezzi biologici. Diserbo chimico: sostanze chimiche, applicazione, azione, selettività. Sistemi colturali, avvicendamento e rotazione (6 ore): storia dei sistemi adottati, criteri classici, impostazioni moderne. English Introduction (2 h): meaning and objectives of Agronomy; Agronomy and evolution of Agriculture; relations with other disciplines; organization of the course (front lectures, practical works, examinations), text books, web-sites. Soil (8 h and 5 practical work): definitions, soil profile, inhibitions horizons, texture, soil structure, soil density. Soil biology (2 h): introductory elements. Soil hydrology (6 h and 4 practical work): water potential, water in the soil, water balance, water movements in the soil. Climate (5 h): Meteorology and climate, radiation, photoperiodi, air and soil temperature, rain and other precipitations, weather station. Evapotranspiration (4 h and 4 practical work): water and his function in agriculture; ET and types of ET; crop coefficients; estimation of evapotranspiration. Regulations of water movements in the field (6 h): soil saturation and effects, runoff, erosion, soil flow. Ways to prevent impacts : surface and deep drainage. Solutions for flat fields (plain) or the slope (hill and mountains). Irrigation (5 h and 5 practical work): objectives of fertilization. Different soils and irrigation. Water requirements of different crops. Irrigation efficiency. Water consumption. Submersion, surface irrigation, lateral flow, subirrigation, rain irrigation, microirrigation. Calculation of water balance. Soil tillage and soil cultivation (6 h): types, objectives, tillage depth, alternative options to ploughing. Fertilization (6 h): type of fertilizers and public regulations; solid and liquid manure, chicken manure, green manuring, mineral fertilizers, simple and complex fertilizers; new and slow release fertilizers, control of soil pH. Trace elements. Fertilizer distribution. Fertilization plan Weed control (6 h): Effects of weeds. Main weed types. Diffusion of weeds. Prevention. Control with physical methods. Biological methods. Chemical weed control: types, timing, actions, selectivity. Agricultural systems and rotation (6 h): short history of agricultural systems, criteria for managing rotations, recent solutions and examples TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Giardini L., 2002 Agronomia generale, ambientale e aziendale. 5a edizione, Patron Ed. Bologna o (meglio) edizioni successive. E' fortemente consigliato l'utilizzo del materiale didattico scaricabile dal sito http://agrariacdl.campusnet.unito.it/cgi-bin/didattica.pl English - 43 - Proposed text books are: Giardini L., 2002 Agronomia generale, ambientale e aziendale. 5a edizione, Patron Ed. Bologna or following editions (if possible). It is highly recommended to use the didactic files available at: http://agrariacdl.campusnet.unito.it/cgi-bin/didattica.pl NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rq0f - 44 - Alimentazione dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) RUMINANT FEEDING AND NUTRITION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0351 Docente: Prof. Riccardo FORTINA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708580, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/18 - nutrizione e alimentazione animale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso è finalizzato a fornire allo studente gli strumenti per individuare le problematiche e per formulare soluzioni idonee relativamente al settore della nutrizione dei ruminanti, anche attraverso visite e colloqui con allevatori di aziende a diverso indirizzo produttivo. English The course is aimed to give to the student the proper tools to evaluate the problems and to choose the adequate solutions to the nutritional problems of ruminant feeding, also through the visit to different types of animal farms. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà essere in grado di formulare razioni bilanciate per ruminanti e di stimare le performance zootecniche utilizzando programmi computerizzati English The student will be able to formulate balanced diets for ruminants and to predict animal performances using computerized programs MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English - 45 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Test di razionamente e discussione finale orale English Diet formulation test and final oral discussion orale PROGRAMMA Italiano Il programma comprende: a) analisi chimiche degli alimenti: carboidrati (NDF e peNDF; ADF e ADL; zuccheri e amidi), grassi e proteine (degradabili e indegradabili); il frazionamento dei carboidrati e delle proteine: il modello Cornell (CNCPS). b) studio del metabilismo ruminale; velocità di transito ed escape ruminale; la produzione di AGV e il loro destino; la digeribilità intestinale e l'assorbimento dei nutrienti; c) il calcolo dei fabbisogni e dell'energia netta degli alimenti secondo il modello NRC d) il razionamento con modelli dinamici (Spartan e CNCPS) e) visite aziendali per la raccolta dei dati produttivi e la simulazione delle performance degli animali con il modello CNCPS (indicare anche area di apprendimento della scheda SUA) English The program include: a) chemical analysis of feeds: carbohydrates (NDF and peNDF; ADF and ADL; sugar and starch), fats and proteins (degradable and undegradable); protein and carbohydrates fractiions according to the Cornell model (CNCPS) b) the rumen metabolism; rumend degradation and escape; the production of VFAs and their destiny; the intestinal digestibilty and the absorption of nutrients c) the animal requirements and the energy value of feeds according to the NRC model d) diet formulation with dynamic models (Spartan e CNCPS) e) visits to animals breedings for data collection and simulation of animal performances with the CNCPS model Italiano Il corso comprende: a) richiami di nutrizione e alimentazione degli animali con approfondimenti sul metabolismo ruminale e la digestione intestinale nei ruminanti - 46 - b) approfondimenti sulle caratteristiche nutritive dei principali alimenti zootecnici c) l'utilizzo di modelli dinamici di razionamento e di stima delle performance degli animali d) visite ad allevamenti di bovini da latte e da carne, di ovini e di caprini English The course include: a) notes on animal nutrition and feeding with deepening on rumen metabolism and intestinal digestion b) deepening on characteristics of main feeds c) use of dinamic models for diet formulation and animal performance prediction d) visits to dairy cattle, beef cattle, sheep and goat breedings TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition, 2001. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Dell'Orto V., Savoini G. - 2005 - Alimentazione della vacca da latte. Edagricole. ISBN 88-506-4570-8 English National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition, 2001. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Dell'Orto V., Savoini G. - 2005 - Alimentazione della vacca da latte. Edagricole. ISBN 88-506-4570-8 NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=joub - 47 - Alimentazione e nutrizione umana (Anno Accademico 2015/2016) FOOD AND HUMAN NUTRITION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0384 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Ilaria Galasso (Supplente) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscernze sui principi alimentari e nutritivi in rapporto ai bisogni dell'organismo umano, la loro digestione e metabolismo, le proprietà nutrizionali ed energetiche dei principali alimenti di origine animale e vegetale, i fondamenti di dietologia, le trasformazioni chimico-fisico degli alimenti in cottura. English To provide principles in relation to food and nutritional needs of the human organism, their digestion and metabolism, the nutritional and energy content of the main foods of animal and vegetable origin, the foundations of dietetics, chemical and physical transformations of foods in cooking. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà conoscere i principi alimentari e nutritivi in rapporto ai bisogni dell'organismo umano, la loro digestione e metabolismo, le proprietà nutrizionali ed energetiche dei principali alimenti di origine animale e vegetale, i fondamenti di dietologia, le trasformazioni chimico-fisico degli alimenti in cottura. English Student will learn principles in relation to food and nutritional needs of the human organism, their digestion and metabolism, the nutritional and energy content of the main foods of animal and vegetable origin, the foundations of - 48 - dietetics, chemical and physical transformations of foods in cooking. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Si procederà alla verifica dell'apprendimento attraverso una discussione tematica al termine di ogni argomento English Completed each topic it will be carried out the learning assessment by a thematic discussion Orale PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati durante il corso appartengono all'area "QUALITA' E SICUREZZA" I principi alimentari e nutritivi e loro funzioni. Linee guida per un'alimentazione corretta- R.D.A. Metabolismo: generalità e metabolismo basale. I glucidi: suddivisione, fonti dietetiche. I glucidi: caratteristiche nutrizionali ed energetiche. Metabolismo e digestione dei glucidi semplici e complessi. Glicemia. Le razioni dietetiche. Le fibre nell'alimentazione umana. I principali dolcificanti non calorici naturali, artificiali e di sintesi: vantaggi e svantaggi. Le proteine: suddivisione, caratteristiche nutrizionali, gli aspetti alimentari e le fonti dietetiche. Metabolismo e digestione delle proteine. Cenni sugli enzimi. I lipidi: suddivisione e cenni sulle proprietà chimico-fisiche, caratteristiche nutrizionali e fonti dietetiche. Metabolismo e digestione dei lipidi. Colesterolemia e particolarità su HDL e LDL. Chetonemia. Gli A.G.E. e gli ω 3. I principali macro e micro elementi e loro funzioni. Le principali vitamine lipo e idrosolubili e loro caratteristiche alimentari. L'acqua: cenni sulle proprietà chimico-fisiche e funzione nell'organismo umano. L'acqua negli alimenti (aw) e potabilità Fondamenti di Dietologia. Determinazione di calcolo. Razione alimentare. Gruppi di alimenti ed equivalenze. La cottura dei principali alimenti e trasformazioni chimico-fisico-organolettiche. Approfondimento delle proprietà nutrizionali dei principali alimenti di origine animale e vegetale. English - 49 - Program topics concern the area "QUALITY AND SAFETY" Food and nutrients principles and their functions. Guidelines for proper feeding-RDA Metabolism: general and basal metabolism. Carbohydrates: subdivision, dietary sources. Carbohydrates: nutritional and energy. Metabolism and digestion of simple and complex carbohydrates. Blood sugar. The dietary rations. The fibers in the human diet. The main non-caloric sweeteners, natural and synthetic: advantages and disadvantages. Proteins: subdivision, nutritional characteristics, aspects of food and dietary sources. Metabolism and protein digestion. Work on enzymes. Lipids: subdivision and outline their physico-chemical properties, nutritional and dietary sources. Metabolism and digestion of lipids. Cholesterol and particularities of HDL and LDL. Ketone. The A.G.E. and ω 3. The main macro and micro elements and their functions. The main and lipo-soluble vitamins and their food characteristics. Water: notes on the physico-chemical properties and function in the human body. The water in food (aw) and potability. Fundamentals of Nutrition. Determination of calculation. Food ration. Food groups and equivalences. The firing of the main food and chemical, physical and organoleptic changes. Deepening of the nutritional properties of the main foods of animal and vegetable origin. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano S.M. Borsarelli - G. Sicheri - Scienza dell'alimentazione - 2aedizione – Hoepli – Milano -1997 S.M. Borsarelli - G. Sicheri - Alimentazione, Ia edizione - Hoepli- Milano - 2004 P. Cappelli - V. Vannucchi - Chimica degli alimenti - 2aedizione – Zanichelli - Bologna-1998 English S.M. Borsarelli - G. Sicheri - Scienza dell'alimentazione - 2aedizione – Hoepli – Milano -1997 S.M. Borsarelli - G. Sicheri - Alimentazione, Ia edizione - Hoepli- Milano - 2004 P. Cappelli - V. Vannucchi - Chimica degli alimenti - 2a edizione – Zanichelli - Bologna-1998 NOTA Italiano sede dell'insegnamento: Cuneo English - 50 - sede dell'insegnamento: Cuneo Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1ike - 51 - Allevamento dei monogastrici I (Anno Accademico 2015/2016) PIG AND POULTRY PRODUCTION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0352 Docente: Prof. Ivo ZOCCARATO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708568, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/20 - zoocolture Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente la preparazione tecnico-scientifica necessaria per affrontare e risolvere i più importanti problemi dell'allevamento, dell'alimentazione e della gestione dell'allevamento dei suini e delle diverse produzioni avicole (carne e uova) comprese quelle non convenzionali. English The aim of the course is providing a balanced technical scientific competence so that students will be competent in dealing with the most important problems of pig production and of poultry industries (meat and egg) and unconventional avian species. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiranno le conoscenze teorico pratiche relative alla gestione della riproduzione, all'alimentazione nelle diverse fasi produttive per quanto riguarda la produzione della carne suina con particolare riferimento alle implicazioni per l'industria di trasformazione. Per quanto attiene le specie avicole gli studenti acquisiranno le conoscenze teorico pratiche relative alla gestione della riproduzione; all'alimentazione nei diversi momenti - 52 - produttivi sia per quanto riguarda la produzione della carne sia delle uova destinate al consumo o alla riproduzione. Saranno sviluppate le competenze relative alle tecniche di allevamento delle diverse specie ponendo particolare attenzione ai problemi relativi al benessere animale e all'impatto ambientale derivante dall'allevamento. English The students will be competent in dealing with the requirements of pig production specifically on reproduction management, feeding in different productive phases, pork production and meat transformation industry. As regard poultry industries students are competent on reproduction management, feeding in different meat and eggs production. Skills will be developed with particular attention to animal welfare and environmental pollution due to intensive farming of different species. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività esercitative e/o visite in azienze zootecniche. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course is organized in 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and/or to visit pig and/or poultry farming. Lectures' different topics will be supported by slides that will be available to students at the end of course. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al fine di verificare la capacità di apprendimento e applicazione delle competenze acquisite, in itinere, gli studenti saranno invitati ad affontare, e proporre soluzioni, problemi di ordine pratico applicativo in tema di gestione dell'allevamento e valutazione delle condizioni di benessere degli animali unitamente a formulazione di piani di alimentazione e razionamento per le diverse specie oggetto del programma del corso. Esame finale: orale, con l'obiettivo di verificare la capacità dello studente di collegare gli aspetti fiosiologici e comportamentali dell'animale con gli obiettivi di produzione English In order to verify the ability of learning and the application of skills acquired during the course, students will be invited to evaluate and propose solutions to problems of practical application in the field of livestock management and evaluation of the welfare conditions of farming; moreover, students will be invited to formulate diets and plans of feedstuffs distribution to different species covered by the program of the course. Final examination: oral, the questions will verify the skill of the student in corelate the physiological and behavioural parameter with the productive aims. - 53 - PROGRAMMA Italiano Gli argomenti, ascrivibili all'area zootecnica e delle produzioni animali, oggetto del programma sono: La situazione della suinicoltura in Italia e in Europa; origine, descrizione e caratteristiche produttive delle principali razze. Alimentazione e utilizzazione dei principi nutritivi nel suino Allevamento e gestione dei riproduttori. Allevamento dei suinetti. Produzione del suino leggero da macelleria. Produzione del suino pesante da salumeria ed il regolamento per la produzione dei prosciutto di Parma. Allevamento biologico e all'aperto Rapporti tra tecniche di allevamento e impatto ambientale Rapporti tra tecniche di allevamento e benessere animale. Visite ed incontri con tecnici presso impianti produttivi del settore suinicolo Richiami di anatomia e fisiologia degli uccelli Razze e "ibridi commerciali" oggetto di allevamento Riproduzione, incubazione e gestione dell'incubatoio Principi di alimentazione del pollame Allevamento dell'ovaiola e produzione delle uova Allevamento del pollo e produzione della carne Allevamento del tacchino Allevamento della faraona Allevamento degli anatidi Allevamento dello struzzo allevamento biologico Visite ed incontri con tecnici presso impianti produttivi del settore avicolo English The topics, in the area of livestock production, covered by the program are: Feeding of pig Reproduction and management of boar and sow Weaner farming Bacon production Heavy pig production and POD Parma ham rules Pig farming and environmental pollution Pig farming and welfare condition Organic farming Field trips to local production units Anatomy and physiology of birds Common breeds and "commercial hybrids" Reproduction, hatching and hatchery management Poultry feeding Hen farming and eggs production Chicken farming and meat production Turkey farming Guinea fowl farming Ducks and geese farming Ostrich farming Organic farming - 54 - Field trips to local production units TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Bertacchini F., Campani I. Manuale di allevamento suino, Ed agricole, Bologna, 2001 Monetti P.G., Appunti di suinicoltura, Giraldi Ed., Bologna, 1997 Whittemore C. The Science and Practice of Pig Production, Longman, Harlow (UK), 1993 Lewis A.J., Southern L.L. Swine Nutrition 2nd edition, CRC Press, Boca Raton (USA), 2001 Perez J.M., Mornet P., Rerat, A., Le porc et son élevage : bases scientifiques et techniques, Maloine, Paris, 1986 Cerolini S., Marzoni Fecia di Cossato M., Romboli I. Schiavone A. Zaniboni L. Avicoltura e Coniglicoltura. Point Veterinaire Italie, Milano, 2008 Bell D., Weawer W. Commercial Chicken meat and egg production, Kluwer Ac. Pub., Norwel USA, 2002 Abad J.C. at al., Reproducion e Incubation en avicoltura, Real Escuela de avicoltura, Barcelona 2003 Castello et al., Producion de carne de pollo, Real Escuela de avicoltura, Barcelona, 2002 Castello et al., Producion de Huevos, Real Escuela de avicoltura, Barcelona, 1989; Anderloni G., Manuale sull'allevamento dello struzzo, Edagricole, Bologna, 2000. Le Coz-Douin J. L'elevage de la pintade, Ed. Point Vétérinaire, Maisons Alfort, 1992 Nau F. et al. Science et technologie de l'œuf, vol 1. Production et qualité. Tec& Doc Lavoisier , Paris, 2010 English Whittemore C. The Science and Practice of Pig Production, Longman, Harlow (UK), 1993 Lewis A.J., Southern L.L. Swine Nutrition 2nd edition, CRC Press, Boca Raton (USA), 2001 Perez J.M., Mornet P., Rerat, A., Le porc et son élevage : bases scientifiques et techniques, Maloine, Paris, 1986 Bell D., Weawer W. Commercial Chicken meat and egg production, Kluwer Ac. Pub., Norwel USA, 2002 Abad J.C. at al., Reproducion e Incubation en avicoltura, Real Escuela de avicoltura, Barcelona 2003 Castello et al., Producion de carne de pollo, Real Escuela de avicoltura, Barcelona, 2002 Castello et al., Producion de Huevos, Real Escuela de avicoltura, Barcelona, 1989; Le Coz-Douin J. L'elevage de la pintade, Ed. Point Vétérinaire, Maisons Alfort, 1992 Nau F. et al. Science et technologie de l'œuf, vol 1. Production et qualité. Tec& Doc Lavoisier , Paris, 2010 NOTA Italiano - 55 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=foqj - 56 - Allevamento dei monogastrici II (Anno Accademico 2015/2016) FISH AND RABBIT PRODUCTION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0353 Docente: Dott. Laura GASCO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708574, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/20 - zoocolture Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni generali dell'acquacoltura (in acqua salata e dolce) e della coniglicoltura con particolare riferimento alle diverse tecnologie di allevamento, all'alimentazione, alla riproduzione e alla qualità delle produzioni. Verranno forniti agli studenti le conoscenze e gli strumenti per affrontare e risolvere le problematiche relative alla gestione degli allevamenti intensivi. English The course aims to provide knowledge on Aquaculture (salt and freshwater fish) and Rabbits production with particular reference to breeding and farming, nutrition, reproduction and product quality RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente acquisisce le basi per la gestione degli allevamenti intensivi (pesci e conigli). English Student will acquire the basis for the management of aquaculture and rabbits companies MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 57 - English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Le modalità di verifica dell'apprendimento tengono conto dell'applicazione costante dello studente a tutte le fasi del processo formativo. Attraverso l'attiva interazione durante le lezioni frontali vengono valutati l'apprendimento delle nozioni teoriche erogate nel corso delle lezioni precedenti, le nozioni pratiche acquisite attraverso le attività di esercitazione nonché lo sviluppo del senso critico. English The assessment methods take into account the consistent application of the student in all phases of the training process. Through active interaction during lectures, students are evaluated on the acquisition of theoretical concepts, on the practical knowledge acquired through practical activities as well as the development of a critical mind Orale ATTIVITÀ DI SUPPORTO Visita di alcune aziende di pesci e conigli. Esercitazioni pratiche presso l'azienda sperimentale sita in Carmagnola PROGRAMMA Italiano APPARTENENZA: Area zootecnica e delle produzioni animali ACQUACOLTURA Introduzione all'acquacoltura: situazione italiana ed internazionale. Caratteristiche delle acque usate per l'acquacoltura. Costruzione e manufatti Alimentazione Riproduzione delle specie ittiche. Manipolazioni genetiche Gestione degli allevamenti (trota, carpa, spigola ed orata, …) CONIGLICOLTURA Introduzione alla coniglicoltura. Situazione italiana ed internazionale Tassonomia, origine e razze allevate. Anatomia e morfologia del coniglio. - 58 - Riproduzione: gestione dei maschi e delle femmine, inseminazione artificiale Alimentazione. Fabbisogni nutrizionali e razionamento Allevamento, ciclizzazione. Produzione del coniglio da pelliccia e coniglio d'angora Principali patologie del coniglio. English The topics, in the area of livestock production, covered by the program are: AQUACULTURE Introduction to aquaculture: Italian and international situation. Water quality in aquaculture. Fish farming design and construction Reproduction, genetic manipulations Fish nutrititon Main farmed species in aquaclture (trout, carp, sea bass, sea bream, ...) Fish diseases RABBITS Introduction to rabbits. Italian and international situation Taxonomy, origin and breeds. A natomy and morphology of the rabbit. Reproduction: Management of males and females, artificial insemination Rabbit nutrition and breeding Production of rabbit fur and angora rabbit Major diseases of the rabbit Italiano Il corso fornisce conoscenze scientifiche di base di carattere biologico e tecnologico applicativo inerenti ai settori dell'acquacoltura e della coniglicoltura. Lo studente sarà in grado di operare su vari aspetti delle loro produzione in aziende zootecniche o in imprese che operano nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti ottenuti da queste tipologie di allevamento. English The course provides biological and technological knowledge related to aquaculture and rabbit production. The student will be able to operate on different aspects of their production. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano G. Baruchelli, Tecniche di allevamento e trasformazione della trota, Istituto Agrario San Michele all'Adige, 2007 - 59 - J. Guillaume et al. Nutrition et alimentation des poissons et crustacés, INRA, Paris, 1999 J. Shepherd & N. Bromage, Intensive Fish farming, BSP Professional Books, Oxford, 1988. W. Steffens, Principles of Fish Nutrition, J. Wiley & Sons (eds.), New York, 1989. L. Horováth et al., Carp and pond fish culture, Fishing New Books, Oxford, 1992 D. Swift, Aquaculture training manual, 2nd edition, Fishing New Books, Oxford, 1993. N. Bromage & R. Roberts, Broodstock management and egg and larval quality, Blackwell Science,Oxford, 1995. Cerolini S., Marzoni Fecia di Cossato, Romboli I., Schiavoni A, Zaniboni L. Avicoltura e Coniglicoltura. Le Point Vétérinaire ItalieSrl, 2008. ANCI-AIA, Razze cunicole: standard italiano, ANCI-AIA, Roma, 1990. Balasini D. Zootecnica applicata: avicunicoli, Edagricole, Bologna, 2001. Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. Tecniche di produzione animale, Liviana Ed., Padova, 1993. Duranti G., Mondini S., Duranti A., Le malattie del coniglio, Edagricole, Bologna, 1993. Falaschini A., Zootecnica speciale, Edagricole, Bologna, 1996 English G. Baruchelli, Tecniche di allevamento e trasformazione della trota, Istituto Agrario San Michele all'Adige, 2007 J. Guillaume et al. Nutrition et alimentation des poissons et crustacés, INRA, Paris, 1999 J. Shepherd & N. Bromage, Intensive Fish farming, BSP Professional Books, Oxford, 1988. W. Steffens, Principles of Fish Nutrition, J. Wiley & Sons (eds.), New York, 1989. L. Horováth et al., Carp and pond fish culture, Fishing New Books, Oxford, 1992 D. Swift, Aquaculture training manual, 2nd edition, Fishing New Books, Oxford, 1993. N. Bromage & R. Roberts, Broodstock management and egg and larval quality, Blackwell Science,Oxford, 1995. Cerolini S., Marzoni Fecia di Cossato, Romboli I., Schiavoni A, Zaniboni L. Avicoltura e Coniglicoltura. Le Point Vétérinaire ItalieSrl, 2008. ANCI-AIA, Razze cunicole: standard italiano, ANCI-AIA, Roma, 1990. Balasini D. Zootecnica applicata: avicunicoli, Edagricole, Bologna, 2001. Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. Tecniche di produzione animale, Liviana Ed., Padova, 1993. Duranti G., Mondini S., Duranti A., Le malattie del coniglio, Edagricole, Bologna, 1993. Falaschini A., Zootecnica speciale, Edagricole, Bologna, 1996 NOTA Italiano Modalità di verifica/esame: l'esame al termine del corso riguarderà tutti gli aspetti trattati durante lezioni e si - 60 - svolgerà con delle domande orali English The final test will be an oral examination Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8e53 - 61 - Allevamento dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) RUMINANT PRODUCTION AND FARMING SYSTEM Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0351 Docente: Prof. Antonio MIMOSI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708581, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Lo scopo del corso è fornire agli studenti le conoscenze approfondite sulle tecniche gestionali (di allevamento e di razionamento) dei ruminanti. Saranno illustrate le relazioni che intercorrono tra la composizione della dieta e la produzione quanti-qualitativa del latte e della carne al fine di migliorare la redditività dell'allevamento. Verranno inoltre analizzate le principali problematiche legate alla produzione dei bovini e degli ovi- caprini (ipofertilità, mastite e laminite) ed i relativi criteri di prevenzione. English The aim of the course is to provide students with in-depth knowledge on management techniques (breeding and ration balancing) of ruminants. Will be explored the relationship between chemical composition of diet and yield and quality of milk and meat to improve the productivity and profitability of farm. Also will be analyzed the main issues of producing of cattle, sheep and goats (reproductive failure, mastitis and laminitis) and the prevention systems. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti dovranno aver acquisito competenze tecnico-scientifiche per poter realizzare una corretta gestione dell'allevamento dei ruminanti (bovini da latte e da carne, pecore e capre). English Students should have acquired technical and scientific skills to be able to achieve a correct management of ruminant livestock (dairy and beef cattle, sheep and goats). - 62 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 40 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di campo con visite in allevamento. Per le lezioni frontali il docente si avvale di diapositive e lucidi che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 40 hours of lectures and 20 hours devoted to the pratical lessons in farming. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il livello di apprendimento raggiunto dagli sudenti e l'efficacia didattica saranno verificati nel corso delle esercitazioni in allevamento con domande orali individuali. L'esame finale è orale. English The level of learning achieved by students and the efficacy teaching will be verified through individual oral questions during the practical lessons in farming. The final examination is oral. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del corso appartengono alle aree della conoscenza di Zootecnica e delle Produzioni Animali. Nel corso verranno approfondite le conoscenze su: Principali razze bovine e ovi-caprine allevate Sistemi di allevamento e gestione dei ruminanti Fattori che influenzano la produzione e la composizione del latte e della carne Formulazione di razioni per bovine, pecore e capre Malattie della produzione (ipofertilità, mastiti e zoppie) Pratiche gestionali per migliorare l'efficienza riproduttiva (tassi di inseminazione, concepimento e di gravidanza). English The course forms part of the filed of knowledgeof Zootechnical and Animal Production. The course will in-depth knowledge of: Main breeds of cattle, sheep and goats reared Farming systems and management of ruminants - 63 - Factors affecting the yield and composition of milk and meat Formulating rations for cattle, sheep and goats Production diseases in farm animals (repeat breeding, mastitis and laminitis) Management practices to improve breeding efficiency (heat detection rate, conception rate and pregnancy rate) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Tecniche di produzione animale di Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. - Editore: Liviana, 2005. - La bovina da latte (a cura di Claudia Molinari – Edagricole, de Il Sole 24 ORE Srl, Bologna 2006. - Gli articoli scientifici e il materiale didattico utilizzato sarranno forniti dal docente a inizio corso. English - Tecniche di produzione animale di Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. - Editore: Liviana, 2005. - La bovina da latte (a cura di Claudia Molinari) – Edagricole, de Il Sole 24 ORE Srl, Bologna 2006. - Scientific articles and teaching materials used will be provided by the teacher at the beginning of the course. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9hxo - 64 - Allevamento e alimentazione dei ruminanti - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) RUMINANT PRODUCTION AND FEEDING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0351 Docente: Prof. Antonio MIMOSI (Affidamento interno) Prof. Riccardo FORTINA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708581, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 12 SSD attvità didattica: AGR/18 - nutrizione e alimentazione animale AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Alimentazione dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) Allevamento dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mxi6 Alimentazione dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) RUMINANT FEEDING AND NUTRITION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0351 Docente: Prof. Riccardo FORTINA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708580, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/18 - nutrizione e alimentazione animale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 65 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso è finalizzato a fornire allo studente gli strumenti per individuare le problematiche e per formulare soluzioni idonee relativamente al settore della nutrizione dei ruminanti, anche attraverso visite e colloqui con allevatori di aziende a diverso indirizzo produttivo. English The course is aimed to give to the student the proper tools to evaluate the problems and to choose the adequate solutions to the nutritional problems of ruminant feeding, also through the visit to different types of animal farms. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà essere in grado di formulare razioni bilanciate per ruminanti e di stimare le performance zootecniche utilizzando programmi computerizzati English The student will be able to formulate balanced diets for ruminants and to predict animal performances using computerized programs MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Test di razionamente e discussione finale orale English Diet formulation test and final oral discussion orale PROGRAMMA Italiano Il programma comprende: a) analisi chimiche degli alimenti: carboidrati (NDF e peNDF; ADF e ADL; zuccheri e amidi), grassi e proteine (degradabili e indegradabili); il frazionamento dei carboidrati e delle proteine: il modello Cornell (CNCPS). - 66 - b) studio del metabilismo ruminale; velocità di transito ed escape ruminale; la produzione di AGV e il loro destino; la digeribilità intestinale e l'assorbimento dei nutrienti; c) il calcolo dei fabbisogni e dell'energia netta degli alimenti secondo il modello NRC d) il razionamento con modelli dinamici (Spartan e CNCPS) e) visite aziendali per la raccolta dei dati produttivi e la simulazione delle performance degli animali con il modello CNCPS (indicare anche area di apprendimento della scheda SUA) English The program include: a) chemical analysis of feeds: carbohydrates (NDF and peNDF; ADF and ADL; sugar and starch), fats and proteins (degradable and undegradable); protein and carbohydrates fractiions according to the Cornell model (CNCPS) b) the rumen metabolism; rumend degradation and escape; the production of VFAs and their destiny; the intestinal digestibilty and the absorption of nutrients c) the animal requirements and the energy value of feeds according to the NRC model d) diet formulation with dynamic models (Spartan e CNCPS) e) visits to animals breedings for data collection and simulation of animal performances with the CNCPS model Italiano Il corso comprende: a) richiami di nutrizione e alimentazione degli animali con approfondimenti sul metabolismo ruminale e la digestione intestinale nei ruminanti b) approfondimenti sulle caratteristiche nutritive dei principali alimenti zootecnici c) l'utilizzo di modelli dinamici di razionamento e di stima delle performance degli animali d) visite ad allevamenti di bovini da latte e da carne, di ovini e di caprini English The course include: a) notes on animal nutrition and feeding with deepening on rumen metabolism and intestinal digestion b) deepening on characteristics of main feeds c) use of dinamic models for diet formulation and animal performance prediction d) visits to dairy cattle, beef cattle, sheep and goat breedings TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - 67 - National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition, 2001. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Dell'Orto V., Savoini G. - 2005 - Alimentazione della vacca da latte. Edagricole. ISBN 88-506-4570-8 English National Research Council. Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition, 2001. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Dell'Orto V., Savoini G. - 2005 - Alimentazione della vacca da latte. Edagricole. ISBN 88-506-4570-8 NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=joub - 68 - Allevamento dei ruminanti (Anno Accademico 2015/2016) RUMINANT PRODUCTION AND FARMING SYSTEM Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0351 Docente: Prof. Antonio MIMOSI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708581, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Lo scopo del corso è fornire agli studenti le conoscenze approfondite sulle tecniche gestionali (di allevamento e di razionamento) dei ruminanti. Saranno illustrate le relazioni che intercorrono tra la composizione della dieta e la produzione quanti-qualitativa del latte e della carne al fine di migliorare la redditività dell'allevamento. Verranno inoltre analizzate le principali problematiche legate alla produzione dei bovini e degli ovi- caprini (ipofertilità, mastite e laminite) ed i relativi criteri di prevenzione. English The aim of the course is to provide students with in-depth knowledge on management techniques (breeding and ration balancing) of ruminants. Will be explored the relationship between chemical composition of diet and yield and quality of milk and meat to improve the productivity and profitability of farm. Also will be analyzed the main issues of producing of cattle, sheep and goats (reproductive failure, mastitis and laminitis) and the prevention systems. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti dovranno aver acquisito competenze tecnico-scientifiche per poter realizzare una corretta gestione dell'allevamento dei ruminanti (bovini da latte e da carne, pecore e capre). English Students should have acquired technical and scientific skills to be able to achieve a correct management of ruminant livestock (dairy and beef cattle, sheep and goats). - 69 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 40 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di campo con visite in allevamento. Per le lezioni frontali il docente si avvale di diapositive e lucidi che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 40 hours of lectures and 20 hours devoted to the pratical lessons in farming. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il livello di apprendimento raggiunto dagli sudenti e l'efficacia didattica saranno verificati nel corso delle esercitazioni in allevamento con domande orali individuali. L'esame finale è orale. English The level of learning achieved by students and the efficacy teaching will be verified through individual oral questions during the practical lessons in farming. The final examination is oral. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del corso appartengono alle aree della conoscenza di Zootecnica e delle Produzioni Animali. Nel corso verranno approfondite le conoscenze su: Principali razze bovine e ovi-caprine allevate Sistemi di allevamento e gestione dei ruminanti Fattori che influenzano la produzione e la composizione del latte e della carne Formulazione di razioni per bovine, pecore e capre Malattie della produzione (ipofertilità, mastiti e zoppie) Pratiche gestionali per migliorare l'efficienza riproduttiva (tassi di inseminazione, concepimento e di gravidanza). English The course forms part of the filed of knowledgeof Zootechnical and Animal Production. The course will in-depth knowledge of: Main breeds of cattle, sheep and goats reared Farming systems and management of ruminants - 70 - Factors affecting the yield and composition of milk and meat Formulating rations for cattle, sheep and goats Production diseases in farm animals (repeat breeding, mastitis and laminitis) Management practices to improve breeding efficiency (heat detection rate, conception rate and pregnancy rate) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Tecniche di produzione animale di Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. - Editore: Liviana, 2005. - La bovina da latte (a cura di Claudia Molinari – Edagricole, de Il Sole 24 ORE Srl, Bologna 2006. - Gli articoli scientifici e il materiale didattico utilizzato sarranno forniti dal docente a inizio corso. English - Tecniche di produzione animale di Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M. - Editore: Liviana, 2005. - La bovina da latte (a cura di Claudia Molinari) – Edagricole, de Il Sole 24 ORE Srl, Bologna 2006. - Scientific articles and teaching materials used will be provided by the teacher at the beginning of the course. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9hxo - 71 - Alpicoltura 1 (Anno Accademico 2015/2016) ALPINE GRASS AND RANGELAND MANAGEMENT Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0363 Docente: Prof. Giampiero LOMBARDI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708791, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Pur non essendo previste propedeuticità, il conseguimento degli obiettivi richiede buone conoscenze di botanica sistematica e di fisiologia vegetale. Per la redazione del piano di gestione pastorale richiesta per l'esame sono consigliate conoscenze di base sull'uso del GIS. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Conoscenza dello stato, del funzionamento e dei criteri per la gestione dei principali agro-ecosistemi alpini, con particolare riferimento a quelli prato-pascolivi e pascolivi, al fine di pianificarne un'utilizzazione razionale con obiettivi produttivi, ambientali, paesaggistici e fruitivi. English Knowledge of the state and operation, and ability to plan and manage alpine agro-ecosystems, with particular reference to pasture-lands (meadows and pastures), in order to set their appropriate exploitation for different purposes (production, environment, landscape and recreation). RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiranno la preparazione necessaria per: - analizzare i principali sistemi agroforaggeri nord-occidentali italiani con particolare riferimento alle risorse pastorali montane; - riconoscere le problematiche di gestione agronomica e pastorale di maggior rilievo per gli ambienti alpini e alto collinari; - organizzare la gestione multiuso dei sistemi agropastorali. English - 72 - Students will get the qualification: - to analyze forage and pastoral systems of north-west Italy with special reference to mountain environments; - to recognize the most important agronomic and pastoral management issues concerning hills and high altitude environments; - to plan multifunctional agro-pastoral management. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Lezioni frontali (60 ore) ed esercitazioni sul terreno (20 ore). Le esercitazioni sul terreno sono parte integrante dell'insegnamento. Gli studenti che non potranno presenziare alle attvità sul terreno sono pregati di contattare il docente all'inizio delle attività in aula al fine di concordare un programma alternativo. English Hall lectures (60 hours) and in-field practice (20 hours). In-field practice is essential to reach the goals of the course. Student not attending practice are kindly requested to contact their professor at beginning of the semester to discuss possible alternatives. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante l'insegnamento, il numero relativamente limitato di partecipanti consente un'interazione continua tra gli studenti e il docente che può in questo modo verificare "in tempo reale" il livello dell'apprendimento dell'intera classe. All'inizio di ciascuna lezione saranno eseguite veriìfiche puntuali sui contenuti delle lezioni precedenti. Numerose lezioni in aula e tutte le esercitazioni dell'insegnamento coinvolgono direttamente gli studenti nelle attività formative. L'esame sarà costituito da uno scritto per la verifica delle conoscenze di base (4 domande a risposta aperta alle quali gli studenti dovranno rispondere in 60'), seguito da un orale al quale avranno acceso gli studenti che risponderanno in modo suffciente alle domande dello scritto. Durante l'orale, che verterà sui contenuti dell'insegnamento e sulle esperienze maturate sul terreno, sarà anche discusso il piano di gestione di un sistema pastorale redatto con i dati acquisiti nel corso delle esercitazioni. English During the course, because of the limited number of students generally attending the it, students will intereract frequently with the teacher who will "real time" check their knowledge, especially at the beginning of each lecture. Students will be directly involved in several lectures and will be key players during field practice. The exam will consist of a written test to test the student basic knowledge (4 open questions in 60') followed by an oral test for the students getting the passing grade. The oral test will deal with course topics and the discussion of the pastoral plan draft ont the basis of the data gathered during on-field practice. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti affrontati nell'insegnamento sono tutti riferibili all'Area della pianificazione e gestione delle risorse - 73 - pastorali, zootecniche e faunistiche. - Obiettivi dell'alpicoltura per la gestione, la conservazione territoriale e per la produzione agricola sulle Alpi e in montagna. - Importanza dell'agricoltura e della zootecnia in Italia e, in particolare nelle zone montane. - Morfologia, sviluppo e crescita delle specie da foraggio con particolare riferimento alle famiglie delle graminee e delle leguminose. - Fattori ambientali della crescita delle foraggere e interventi antropici di condizionamento. - Elementi di fisiologia delle specie foraggere - Significato agronomico di longevità, precocità, alternatività e rifiorenza. - Sistemi foraggeri prato-pascolivi montani. - Popolamenti vegetali erbacei dell'ambiente montano: prato-pascoli permanenti. - Criteri per la valutazione delle cotiche permanenti e la scelta degli interventi gestionali. - Utilizzazione dei foraggi prativi: foraggiamento verde, fienagione, insilamento. - Sistemi pastorali. - Popolamenti vegetali erbacei dell'ambiente montano: pascoli. - Vegetazione pastorale: principali tipi pastorali delle Alpi. - Approcci di studio della vegetazione pastorale: approccio quantitativo fitopastorale. - Concetti di tipo e facies pastorale. - Criteri per l'interpretazione delle facies pastorali più significative delle Alpi occidentali. - Utilizzazione dei pascoli. - Pascolamento: * ruolo agronomico e ambientale del pascolamento; * relazioni erba-animale-suolo; * azioni degli animali sul suolo, sulla fertilità, sulla vegetazione (specie indicatrici dell'azione pascoliva); * interventi e tecniche di regolazione delle restituzioni animali; * carico animale, definizione e significati; * intensità di pascolo, efficienza del pascolamento; * relazioni fra vegetazione pastorale e carico animale; * tecniche di pascolamento; * organizzazione del pascolamento; miglioramento dei pascoli. - Popolamenti vegetali erbacei dell'ambiente montano e collinare: erbai e prati avvicendati. - Specie graminee e leguminose foraggere. - Principali colture agrarie alpine: cereali, leguminose da granella, patata. Attività sul terreno (4 giorni in area alpina) - Riconoscimento delle principali graminee. - Esame di differenti vegetazioni prative e pastorali alpine: osservazione, rilievo e interpretazione della vegetazione e valutazione della gestione pastorale in un comprensorio pastorale alpino e dei suoi effetti sulla vegetazione . Esercitazione è integrata con l'insegnamento di Alpicoltura 2 durante i giorni 3 e 4. English All the lecture topics of the course are ascribable to the "Area della pianificazione e della gestione delle risorse pastorali, zootecniche e faunistiche". - Alpine pasture-land management purposes: agricultural productions and land conservation in mountain areas. - Organization of agro-pastoral systems in Italy, with particular reference to mountain areas. - Mountain rangelands: history and current perspectives. - Morphology and growth of forage species, with particular reference to grasses and legumes. - Environmental factors and management practices influencing forage species yield and development. - Elements of physiology of forage species - Longevity, precocity, alternativity, regrowth, and re-flowering of grasses - 74 - - Grassland growth models: growth rate and trend. - Meadows and pastures in mountain areas. - Permanent grassland management goals and techniques. - Grassland type identification. - Forage crop exploitation: green forage, hay, silage, grazing. Plant species growth in temporary and permanent grasslands: management principles. - Mountain and alpine pasture systems. - Study approaches to pasture vegetation: phyto-pastoral point-intercept method - Classification of pastoral vegetation: pastoral types and sub-types. - Important vegetation types in the western Italian Alps : origin and characteristics. - Grazing-land exploitation: agronomical and environmental purposes. - Grazing management: * grass-animal-soil relationships; * livestock effects on soil, pasture fertility and vegetation (plant species marking grazing effects); * manure management in pastures: control of animal dejections; * animal stocking rate; * grazing intensity and grazing efficiency; * relationships between animal stocking rate and pastoral vegetation; * grazing management techniques and grazing organization; * pasture improvement and renovation; * relationships between crops and pastoral systems; * principles of pasture management planning: ordinary techniques and improvement. - Mountain and hill temporary grasslands. - Poaceae and Fabaceae forage species. - Main alpine food and fodder crops: cereals, grain legumes, potato. Field practice - Identification of the main Poaceae species. - Pasture management planning in mountain areas. Vegetation surveys and analysis of the grazing management of a summer pasture (4 days of fieldwork to get technical data and information). Field practices integrated with the course of Mountain agro-pastoral management II (on day 3 and 4). TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Le diapositive delle lezioni e diversi appunti sintetici sugli argomenti trattati sono disponibili attraverso le pagine web dell'insegnamento su piattaforma Campusnet. Si consigliano inoltre: - Giardini L. et al., 2002. Coltivazioni erbacee - Foraggere e tappeti erbosi (Capitoli: Specie foraggere Gramineae e Leguminosae; Consociazioni e associazioni prative; Pascoli). Ed. Patron, Bologna. - Cavallero A., Aceto P., Gorlier A., Lombardi G., Lonati M., Martinasso B., Tagliatori C., 2007. I tipi pastorali delle Alpi Piemontesi. Vegetazione e gestione dei pascoli delle Alpi occidentali. Alberto Perdisa Editore, Bologna, 486 pp. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: - Giardini L.,1992. Agronomia generale e ambientale. Ed. Patron, Bologna. - Dorée A., 1995. Flore pastorale de montagne. Tome 1. Les graminées. Editions Boubées & Cemagref Editions. - Dorée A., 2000. Flore pastorale de montagne. Tome 2. Légumineuses et autres plantes fourragères. Cemagref Editions. - 75 - English Course slides and several course notes are downloadable from the course web pages on Campusnet platform. However the use of the following texts is suggested: - Giardini L. et al., 2002. Coltivazioni erbacee - Foraggere e tappeti erbosi (Capitoli: Specie foraggere Gramineae e Leguminosae; Consociazioni e associazioni prative; Pascoli). Ed. Patron, Bologna. - Cavallero A., Aceto P., Gorlier A., Lombardi G., Lonati M., Martinasso B., Tagliatori C., 2007. I tipi pastorali delle Alpi Piemontesi. Vegetazione e gestione dei pascoli delle Alpi occidentali. Alberto Perdisa Editore, Bologna, 486 pp. - Giardini L.,1992. Agronomia generale e ambientale. Ed. Patron, Bologna. - Dorée A., 1995. Flore pastorale de montagne. Tome 1. Les graminées. Editions Boubées & Cemagref Editions. - Dorée A., 2000. Flore pastorale de montagne. Tome 2. Légumineuses et autres plantes fourragères. Cemagref Editions. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4cp0 - 76 - Alpicoltura 2 (Anno Accademico 2015/2016) ALPINE LIVESTOCK FARMING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0364 Docente: Prof. Luca Maria BATTAGLINI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708577, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Formazione di un laureato specialistico che abbia acquisito e sia in grado di applicare conoscenze sugli allevamenti montani finalizzate alla conservazione delle risorse animali e all'ottenimento di produzioni locali e tipiche, per la comprensione del ruolo produttivo, territoriale e ambientale anche in chiave multifunzionale dei diversi sistemi zootecnici. Conoscenza delle principali risorse dell'allevamento di alta-collina e montagna. Elementi sugli aspetti gestionali e produttivi di maggior rilievo nell'ambito dei sistemi zootecnici per consentire scelte tecniche appropriate al fine di risolvere gli inerenti aspetti critici. Aspetti conoscitivi per la conservazione della salute e del benessere degli animali di interesse zootecnico in relazione alle caratteristiche dell'ambiente di allevamento alto-collinare e montano. English Realization of a specialized graduate who has acquired and is able to apply knowledge on mountain livestock farming aimed at the conservation of animal resources and for the obtaining local products, the understanding of the productive, territorial and environmental role of the different systems also through a multi-functional activity. Knowledge of the main resources of livestock farming in high-hills and mountains. Management and production systems information of the most relevant farming systems to allow proper techniques in order to solve the inherent critical issues. Elements of knowledge for the preservation of the health and welfare of farm animals in relation to the characteristics of less favoured areas breeding. - 77 - RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il laureato magistrale, con questo insegnamento, sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite per: - realizzare piani di gestione zootecnica attraverso le conoscenze dello stato, del funzionamento e dei criteri per la gestione dei principali sistemi zootecnici montani per un'utilizzazione razionale e con obiettivi produttivi, ambientali, paesaggistici, fruitivi-ricreativi; - progettare e coordinare filiere per le produzioni lattiero-casearie e di carne e derivati a livello aziendale; - progettare la costituzione di imprese zootecniche aventi finalità produttiva, turistica-ricreativa e multifunzionale in genere; - collaborare, in contesti multidisciplinari, alla redazione di strumenti di gestione a diversa scale territoriale (dal livello comunale a quello regionale e nazionale); - progettare interventi e svolgere consulenza per aziende o amministrazioni che intendono intraprendere un processo valorizzazione delle produzioni ottenibile anche a fronte di una riduzione dell'impronta ecologica. English Realization of a specialized graduate who has acquired and is able to: - Apply knowledge related to main resources of livestock farming in high-hills and mountain environments; - Implement plans through the knowledge of criteria for the management of mountain livestock systems for an efficient use and with production, environmental, landscape, and recreational fruition objectives; - Planning and coordinating systems for dairy and meat production in these environments; - Collaborating in multidisciplinary contexts and create management tools at different spatial scales (from the municipal level to the regional and national); - Designing consultancy work for farms or administrations with the objective to upgrade obtainable products values with a reduction of the ecological footprint. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano 60 ore di lezione frontale in aula e 20 ore di esercitazioni in campo English 60 hours of hall lectures and 20 hours of on-field activity MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Ad intervalli regolari e comunque opportuni in funzione della posizione nel programma svolto, nel corso delle lezioni e delle esercitazioni, verranno sviluppati momenti di richiamo alle nozioni somministrate al fine di collegare i diversi argomenti e far cogliere l'armonizzazione delle tematiche nello sviluppo del programma medesimo. L'esame finale sarà orale con domande sui contenuti del corso e sulle esperienze maturate sul terreno anche con dati acquisiti nel corso delle esercitazioni. - 78 - English At regular intervals and in appropriate positions of the program development, during lessons and the in field didactical activities, moments of recall of the given notions will be spent, in order to connect the different topics and to understand the harmonization of the issues in the development of the program itself. Oral final test on hall lecture topics and in field training activity even through analysis of the data gathered during onfield practice. PROGRAMMA Italiano Le funzioni economiche dell'allevamento zootecnico. I fattori che influenzano la produttività animale. Le categorie degli animali. Bovini. Ovini e Caprini. Altre specie. Fattori genetici. Specie. Razza. Individualità. Ascendenti. Prospettive di miglioramento. Organizzazione dei Controlli (AIA - APA). Libri genealogici. Registri anagrafici. Fattori zootecnici. Sistemi zootecnici. Modalità di allevamento. Strutture. La lattazione: ordine, stadio, stagione. La mungitura. L'alimentazione. Valutazione chimico-nutrizionale degli alimenti. Il valore nutritivo (metodi di stima) per ruminanti. Il razionamento degli animali di interesse zootecnico. Il pascolamento: aspetti zootecnici. L'allevamento bovino. Principali tecnologie e razze allevate : Piemontese, Valdostana, Barà-Pustertaler, P.R. d'Oropa, Rendena, Grigia Alpina, Bruna Italiana, Pezzata Rossa Italiana, Bruna Alpina, Frisona, altre razze L'allevamento del vitello. L'allevamento secondo la linea vacca - vitello. L'allevamento ovino. Generalità. I sistemi di allevamento. L'allevamento caprino. Generalità. I sistemi di allevamento. Fattori igienico-sanitari. Principali norme di igiene. Patologie e profilassi: le malattie infettive ed il risanamento. Le malattie parassitarie e la disinfestazione. Malattie dismetaboliche, carenziali, tossicologiche. Stress e benessere animale. Comportamento degli animali al pascolo. Ruolo multifunzionale dell'allevamento. Visite tecniche ad allevamenti ed ambienti pastorali rappresentativi. Esercitazioni sul campo integrate con il corso di Alpicoltura 1. English Economic functions of livestock farming. Factors influencing animal productivity (cattle, sheep and goats) Genetic factors Livestock systems. Milk production. Lactation: order, stadium, season. Milking. Breeds: Piemontese, Aosta RP, BP,C, Bara-Pustertaler, Oropa RP, Italian Brown, Italian Simmental, other breeds - 79 - Chemical and nutritional evaluation of feedstuffs Livestock requirements and diet formulation. Pasture systems. The cow – calf system Sheep and goat farming. Animal hygiene. Diseases and prophylaxis of infectious diseases and sanitation. Parasitic diseases and pest control. Metabolic diseases. Toxicology. Stress and animal welfare. Multifunctional role of farming. Technical visits to representative farms and pastoral environments. Field practices will be integrated with the course of Alpine grass and rangeland management. Italiano Gli argomenti del corso appartengono all'area di apprendimento della pianificazione e gestione delle risorse pastorali, zootecniche e faunistiche. English The topics of the course belong to the learning of the planning and management of pastoral resources, livestock and wildlife TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M., 2005. Tecniche di produzione animale, Liviana Scolastica. Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M., Fondamenti di Zootecnica, Liviana Editrice, 1990. Siti internet di interesse: www.sozooalp.it Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini ("Quaderni") www.amamont.eu Associazione amici degli alpeggi e della montagna www.ruralpini.it Materiale didattico utilizzato durante lo svolgimento del corso sarà reso disponibile sulla piattaforma Campusnet. English Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M., 2005. Tecniche di produzione animale, Liviana Scolastica. Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M., Fondamenti di Zootecnica, Liviana Editrice, 1990. - 80 - WEB: www.sozooalp.it Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini ("Quaderni") www.amamont.eu Associazione amici degli alpeggi e della montagna www.ruralpini.it Reference documents will be targeted more directly and delivered, in a printed or electronic form, relevantly to specific themes developed during the course, and available on the Campusnet platform NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kktv - 81 - Ampelografia (Anno Accademico 2015/2016) AMPELOGRAPHY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0300 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Avere acquisito le conoscenze inerenti le materie della filiera biologico-colturale (Biologia, Genetica e Viticoltura) OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Approfondire conoscenze generali e specifiche (storiche, genetiche, normative, colturali, ecc.) sulle diverse forme di vite con particolare riferimento alle cultivar. Fornire gli strumenti metodologici teorici e pratici per la descrizione, la caratterizzazione e l'identificazione delle varietà di vite. English Increase the general and specific knowledge (history, genetics, use regulations, cultural traits, etc.) on grapevines with special reference to grape cultivars. Provide theoretical and practical methodological tools for the description, characterization and identification of grape varieties. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisire informazioni generali sui vitigni Conoscere le diverse metodologie in uso nel settore ampelografico Applicare metodi di riconoscimento varietale pratico in campo Acquisire abilità nel distinguere e nel riconoscere le cultivar in base ai caratteri morfologici delle piante English Aquire general information on grape cultivars. - 82 - Knowing the different methodologies used in ampelography Apply practical variety recognition in the field Acquire the ability to distinguish and recognize grape cultivars in the field from vine's morphological traits MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante le lezioni frontali si dedica tempo a momenti di confronto (risposte a domande dirette e dibattito) Durante le esercitazioni espressamente previste vengono ripetutamente verificate le abilità acquisite nel riconoscimento pratico dei vitigni English During lectures, time is devoted to confrontations (answers to direct questions and discussion) During practical training in the field the aquired abilities on grape variety recognition are repeatedly verified Prova pratica (riconoscimento campioni vegetali) e prova teorica (solitamente test scritto) ATTIVITÀ DI SUPPORTO Esercitazioni in vigneti e in campi collezione PROGRAMMA Italiano Questo corso appartiene all'area di apprendimento 2 (produzione e qualità delle uve e gestione dei vigneti). Aspetti generali: Principali scopi dell'ampelografia. Cenni di sistematica della vite. Origine delle cultivar di vite. Aspetti normativi. Principali vitigni nel mondo, in Italia, in Piemonte. Metodi morfo-descrittivi e biometrici: Schede ampelografiche. Iconografia, erbari. Terminologia ampelografica. Metodi ampelometrici. Elaborazione statistica ed interpretazione dei dati (tecniche di statistica multivariata applicate all'ampelografia). Metodi chemio-tassonomici e molecolari: Significato ampelografico dei composti fenolici. Marcatori genetici e molecolari per fingerprinting e studi di parentele (isoenzimi, RFLP, RAPD, SSR, AFLP, SNP). Tecniche di identificazione: Comparazioni e riferimenti, chiavi di determinazione, banche dati. Riconoscimento pratico in campo di vitigni portinnesti e ad uva da vino. English General aspects: major aims of ampelography. Grapevine systematic in short. Origins of the grape cultivars. Legislations on the use of grape cultivars. The major grape varieties in the world, in Italy, in the region of Piedmont. Morphological and biometrical methodologies: Ampelographic descriptor lists. Images and herbarium. Ampelographic vocabulary. Biometrical methods. Statistical processing of the data (examples of multivariate analyses applied to ampelography). - 83 - Chemio-taxonomy and molecular ampelography: ampelography and grape phenolics. Genetic and molecular markers for fingerprinting and grape kinship studies (isoenzymes, RFLP, RAPD, SSR, AFLP, SNP). Identification techniques: Data comparison and true to type references, databases. Practical recognition in the field of rootstocks and wine grape scions. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano materiale fornito dal docente English Material provided by the teacher NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=atut - 84 - Analisi chimiche degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) FOOD CHEMICAL ANALYSIS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0074 Docente: Dott. Manuela GIORDANO Contatti docente: 0116708817, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Una parte del corso fornisce conoscenze sui principali macro- e micro-nutrienti presenti nelle matrici alimentari, le caratteristiche chimico-fisiche e la reattività di tali componenti chimici. In parallelo il corso consiste nell'apprendere capacità teoriche e pratiche nell'analisi chimica merceologica (parametri chimici) per il controllo della qualità degli alimenti, delle caratteristiche chimico-fisiche e nutrizionali, anche in relazione alle possibili modificazioni che possono avvenire durante il processo produttivo. English First part of the course provides knowledge on the main macro- and micronutrients present in different food matrices, their physical-chemical characteristics and chemical reactivity. In parallel, theoretical and practical skills of the chemical analyses ( chemical parameters) on food matrices will be learned in order to a food quality control, even in relation to possible modifications that could occur during the productive process. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione di conoscenze riguardanti le analisi chimiche merceologiche applicate agli alimenti. Lo studente alla fine del corso acquisirà conoscenze del ruolo delle molecole presenti negli alimenti ai fini composizionali, nutrizionali, tecnologici ed i metodi di analisi di base, ufficiali e non, per controllo qualità alimenti. English Acquisition of the basic notion of food compositional analysis. The course enables students to achieve knowledge - 85 - on the role of the molecules present in different foods (compositional, nutritional and technological importance) and the related methods of analyses to detect them in order to a food quality control. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di lezioni frontali ed ore dedicate ad attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of hours of lectures and hours devoted to chemical laboratory. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine del programma dedicato allo studio delle principali metodiche di analisi merceologiche per differenti categorie alimentari, il docente procederà ad una verifica dell'efficacia didattica mediante un test a risposte multiple, senza valore per la valutazione finale. L'esame finale è una prova scritta (sia domande a risposta multipla che a risposta aperta) riguardante la determinazione di parametri chimici per il controllo analitico degli alimenti, che sono stati trattati nel corso ed in parte applicati durante esercitazioni. English At the end of the program devoted to the study of the main classic chemical methods for food quality control on different food categories, the teacher will proceed to a verification of the effectiveness teaching by a multiple choice test, not value for the final evaluation. The final exam is a written test (both a multiple choice test than open questions) regarding the determination of chemical parameters for the analytical food control. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati afferiscono all'Area Qualità e Sicurezza. Composizione (macro- e microcomponenti) degli alimenti. Qualità, sicurezza e tipicità dei prodotti alimentari. Etichettatura nutrizionale degli alimenti. Step principali di una analisi chimica merceologica di una matrice alimentare ed il controllo qualità merceologico. Gestione del dato analitico di base. Modificazioni chimiche, chimicofisiche e sensoriali dei componenti chimici in relazione ai processi di trasformazione e conservazione. Adulterazione. Sofisticazione. Falsificazione. Contraffazione. Denaturazione. Acqua. La sua interazione con altri componenti degli alimenti, acqua legata, attività dell'acqua (aw), umidità relativa %, analisi chimiche. Lipidi di origine vegetale ed animale: trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, acidi grassi trans, sistemi coniugati, indici chimici merceologici. Ossidazione ed idrolisi delle sostanze grasse. Rancidità, formazione di off-flavour. Metodi strumentali cromatografici e spettrofotometrici. Il latte: composizione chimica quali-quantitativa, determinazioni ed effetto di trattamenti termici su tali componenti, parametri fisici di genuinità e freschezza.. Metodi rapidi mediante tecniche strumentali spettroscopiche. Il formaggio: modificazioni chimiche a carico dei lipidi (lipolisi), delle proteine (proteolisi), a carico - 86 - degli zuccheri e formazione di metaboliti volatili (flavour) durante stagionatura. Analisi chimiche per la determinazione della frazione grassa, azotata e proteica, contenuto zuccheri. Burro: composizione quali-quantitativa e analisi chimiche sul burro. Cenni sui cereali e derivati: composizione chimica degli sfarinati; analisi chimiche degli sfarinati: umidità, acidità, azoto totale, glutine, idrati di carbonio. Bevande alcoliche fermentate: composizione chimica del mosto, vino, aceti e analisi chimiche relazionate a tali matrici (acidi organici fissi, titolo alcolometrico volumico, componenti chimici minori: composti volatili prodotti durante fermentazione; aceto: bioossidazione acetica, marker chimici di invecchiamento). Applicazione di analisi merceologiche su differenti matrici alimentari (analisi potenziometriche, analisi chimiche gravimetriche, volumetriche, metodi analitico-strumentali spettrofotometrici). English All topics covered in this course belong to Area Quality and Safety. 1.Food chemical composition: macro- and micronutrients. Quality, safety and typicality of food products. Principal steps of the chemical analysis for a food quality control . Food nutritional labelling. Sanitary protection of food. Evaluation of analytical data. Physico-chemical modification in relation to food processing and storage. Food adulteration. 2. Water: structure and its interaction with other food components, water activity (aw), relative humidity %, determination of food humidity and dry matter. 3.Lipids of vegetal and animal origin. Vegetable oils: principal chemical analysis for labeling and lipid chemical indices. Oxidation of lipids: production of off-flavours. Instrumental chromatographic and spectrophotometric methods. 4. Milk: quali-quantitative components of these matrices. Effects of thermal treatment on lipids and physical parameters. Rapid spectroscopic methods. Cheese: chemical composition and modification of lipids (lipolysis), proteins (proteolysis), sugars and formation of volatile metabolites (flavour) during maturation. Chemical analyses on acidity, lipid fraction, protein content, total and dry weight, ashes. 5. Cereals and derivatives: chemical composition of principal cereals, classification, property; flour: chemical analysis. 6. Fermented alcoholic beverages: chemical composition of the must, wine, vinegar and related chemical analyses (volatile and total acidity, alcoholic content, fixed acids, reducing sugars, total dry matter, ashes, total and free sulfur dioxide bioxidation, biochemical markers of ageing). TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano S. Nielsen, Food Analysis (Fourth Edition), 2010, Springer. P. Cabras, C. I. G. Tuberoso, Analisi dei prodotti alimentari, Ed. Piccin, 2014. F. Tateo, M. Bonomi, Guida all'analisi Chimica degli Alimenti, vol 1, 3, 4, 5. ARS Ed. informatiche srl, 2004. English F. Tateo, M. Bonomi, Guida all'analisi Chimica degli Alimenti, vol 1, 3, 4, 5. ARS Ed. informatiche srl, 2004. S. Nielsen, Food Analysis (Fourth Edition), 2010, Springer. P. Cabras, C. I. G. Tuberoso, Analisi dei prodotti alimentari, Ed. Piccin, 2014. NOTA Italiano - 87 - Il corso si svolge nella sede di Grugliasco. English The location of the course is Grugliasco. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hbti - 88 - Analisi chimiche enologiche e strumentali (Anno Accademico 2015/2016) CHEMICAL AND INSTRUMENTAL OENOLOGICAL ANALYSIS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0338 Docente: Prof. Luca ROLLE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708558, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 3° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le conoscenze fondamentali per il controllo analitico della maturità delle uve e la gestione del processo di vinificazione. English Furnushing fondamental knowledge for analytical control of grape ripening and the wine-making process management. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Capacità nella esecuzione delle principali analisi chimiche enologiche e strumentali. Capacità nella interpretazione dei dati analitici per la valutazione della maturità delle uve e la gestione del processo di vinificazione. English Capability of carrying out the principal chemical oenological and instrumental analysis. Capability of interpreting the analytical data for the evaluation of grape ripening and the management of wine- making process. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 64 ore di lezione frontale e 16 ore dedicate a attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il - 89 - docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 64 hours of lectures and 16 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verifica scritta in itinere. Verifica scritta finale con domande aperte e esercizi (6-8 domande). English Written test ongoing. Final written test with 6-8 open questions and exercise. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Esercitazioni in laboratorio. English Laboratory exercises. PROGRAMMA Italiano Corso inserito nell'area SUA Enologia e gestione della qualità. La sicurezza in laboratorio. Le unità di misura delle analisi chimiche. Valutazione della qualità delle uve: metodi analitici e strumentali per la determinazione della maturità tecnologica, fenolica, aromatica e strutturale. Determinazione analitica di zuccheri, acidi, composizione fenolica di bucce, polpa e vinaccioli, composizione sostanze volatili libere e legate, proprietà meccaniche delle bucce e dei vinaccioli, valutazione del colore (coordinate CIELab, con colorimetro di superficie) delle uve. Utilizzo del FT-NIR per la valutazione della qualità dell'uva. Controllo analitico del processo di vinificazione: determinazione dell'acidità totale e della composizione acida per cromatografia su carta e HPLC; determinazione degli zuccheri per via chimica e per HPLC; determinazione dell'acidità volatile e del titolo alcolometrico volumico per distillazione e per ebulliometria; determinazione dell'estratto totale e ridotto, delle ceneri e dell' alcalinità delle ceneri. Utilizzo del pHmetro per l'esecuzione della disacidificazione. Determinazione delle solforosa libera e totale dei vini. Determinazione del glicerolo per HPLC. - 90 - Determinazione dell'acido gluconico con kit enzimatici. Metodi spettofotometrici per la valutazione della composizione fenolica del vino: antociani totali, flavonoidi totali, proantocianidine, flavani reattivi alla vanillina. Valutazione del colore con gli indici di Glories e con le coordinate CIELab. Determinazione delle antocianidine per HPLC. Valutazione della stabilità tartarica dei vini. English SUA area course: Enology and quality management. Safety in the laboratory. Standards of measurements used in the chemical analysis. Grape quality evaluation: analytical and instrumental methods for the technological, phenolic, aromatic and texture maturity. Instrumental and analytical methods for the assessment of sugars, acid, phenolic composition (skins and seeds), color evaluations (CIELab coordinates, by colorimeter) of the grapes. Use of FT-NIR for the grape quality evaluation. Analytical control of winemaking processes: titratable acidity and acid profile by chromatography (HPLC), sugars content by chemical analysis and HPLC, volatile acidity, alcohol content by distillation and ebullioscopy, total and dry matter, ash and alkalinity of ash. Use pHmeter for the wine deacidification. Determination of total and free SO2. Glycerol determination by HPLC. Gluconic acid determination by enzymatic kit. Spectrophotometric methods for the wine phenolic composition: total anthocyanins and flavonoids, flavanols vanillin assay, proanthocyanidins. Wine color by Glories indices and CIELab parameters. Anthocyanidins profile by HPLC. Tartaric stability evaluation. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Recueil des methodes internationales d'analyse des vins et des mouts (scaricabile dal sito internet dell'OIV). PAVANELLO F. – Guida alle analisi enologiche. Metodi di prova definiti in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2000. Durante il corso il docente fornirà fotocopie/files PDF di articoli scientifici riportanti i metodi analitici spiegati a - 91 - lezione. English Recueil des methodes internationales d'analyse des vins et des mouts (scaricabile dal sito internet dell'OIV). PAVANELLO F. – Guida alle analisi enologiche. Metodi di prova definiti in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2000. During the course the teacher will supply photocopies/files PDF of scientific articles reporting the analytical methods explained during lesson. NOTA Italiano sede dell'insegnamento: Alba (CN). English location of teaching: Alba (CN). Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ir9u - 92 - Analisi chimico-agrarie (Anno Accademico 2015/2016) Agricultural chemical analysis Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0395 Docente: Prof. Valter BOERO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708510, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Prova pratica PREREQUISITI Aver frequentato la prima parte del corso di Chimica generale PROPEDEUTICO A Tutti i laboratori di Chimica e biologia. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Consolidare le conoscenze del corso di Chimica generale e fornire familiarità con il laboratorio di chimica. Acquisire le capacità di utilizzare in modo corretto la vetreria e la strumentazione di base del laboratorio di chimica. English Consolidate the knowledge of the general chemistry course and provide familiarity with the chemistry lab. Acquire the ability to make correct use of the glassware and instrumentation basic chemistry lab RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Familiarità con il laboratorio chimico, con la vetreria essenziale e la strumentazione di base. Capacità di eseguire alcune analisi di base del laboratorio chimico agrario, valutare e presentare i risultati delle analisi. English Familiar with the chemical laboratory glassware with essential and basic instrumentation. - 93 - Ability to perform some basic analysis of the agricultural chemical laboratory, evaluate, and present the results of the analysis. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Sono fornite 7 lezioni frontali in aula di 2h che includono anche la presentazione dell'attività che sarà svolta in laboratorio; a seguire 7 esercitazioni in laboratorio di 2 ore nette. Ogni studente accede ad una postazione del laboratorio di chimica da solo o in coppia. Al termine del laboratorio si reca in una aula per 1h per ordinare il quaderno di laboratorio, effettuare i calcoli e le elaborazioni necessarie e per preparare la relazione relativa alla esercitazione. English The course is organized in 7 lectures 2h each that include the presentation of the activities that will be carried out in the laboratory; each lecture is followed by 2 hours in the laboratory. Every student has his place in the chemistry laboratory alone or in pairs. At the end of the laboratory the students have 1h in classroom for calculations, data processing and to prepare a report. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Per ogni esercitazione è richiesta la preparazione di una relazione che permette di comprendere e valutare l'apprendimento dello studente. Al termine del corso è realizzata una prova individuale in laboratorio con analisi di un composto e preparazione di una breve relazione. L'esito di questa analisi, la valutazione delle relazioni presentate al temine di ogni esercitazione, la valutazione sul quaderrno di laboratorio permettono di valutare il grado di apprendimento dell'allievo e di esprimere un voto. Su richiesta dell'allievo o del docente viene svolto anche un colloquio orale inerente il programma svolto per definire la valutazione finale English For lab is required the preparation of a report that allows you to understand and evaluate student learning. At the end of the course it is made of an individual test in the laboratory with analysis of a compound and preparation of a short report. The outcome of this analysis, the evaluation of the reports submitted to the end of each lab, the evaluation of the laboratory notebook are the factors used to assess the degree of learning of the students. On specific request (student or professor) an oral colloquium could be undertaken to complete the final evaluation. PROGRAMMA Italiano Introduzione al laboratorio: nozioni di sicurezza, vetreria e strumentazione di base. - 94 - • Trattamento dei dati e presentazione dei risultati: quaderno di laboratorio, nozione di errore, valutazione dell'accuratezza, della ripetibilità e delle sensibilità di un metodo analitico. • Calibrazione degli strumenti. • Titolazioni: acido-base, ossido-riduzione, complessometria. • Preparazione di soluzioni a titolo noto. • Preparazione di soluzioni di acidi e basi (concentrazione in peso, normalità, molarità). • Titolazioni acido-base: applicazione alla determinazione dell'acidità dell'aceto e del limone. • Titolazione di ossido riduzione: applicazione alla determinazione della concentrazione di una soluzione di Fe (II). • Titolazione complessometrica: applicazione alla determinazione della durezza dell'acqua • Preparazione di standard analitici, calibrazione di alcuni strumenti. Questo corso appartiene all'area di apprendimento SUA 8 Area tecnica speciale. English Activity in classroom Introduction to laboratory principles of safety, glassware and basic instruments Data processing and presentation of results of laboratory notebook, the concept of error, evaluation of the accuracy, repeatability and sensitivity of an analytical method. Symbols, formulas and nomenclature. Molecules, moles, chemical reactions, valence, number of oxidation Balancing chemical equations, yield of reaction, stoichiometric calculations. Solutions: preparation, concentration, dilution. Calibration of instruments Lab activity • Preparation of solutions of primary standards • Preparation of solutions of acids and bases (concentration by weight, normality, molarity, molality) • Acid-base titrations: application to the determination of the acidity of vinegar and lemon • pH meter: principle and application to the determination of pH of some alimentary liquids • redox titration: application to the determination of the concentration of a solution of Fe (II). • complexometric titration: application to the determination of water hardness • Preparation of analytical standards, calibration of instruments: application to the determination of the concentration of phosphorus in aqueous solution with a colorimetric method. Italiano Consolidamento delle conoscenze del corso di Chimica generale e familiarità con il laboratorio di chimica. English Consolidation of the knowledge of the general chemistry course and familiarity with the chemistry lab. - 95 - TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Carmine Rubino, Italo Venzaghi, Renato Cozzi Stechio & Lab Le basi dell'analisi chimica 1-Stechiometria 2-Principi e Metodologia Ed. Zanichelli English Carmine Rubino, Italo Venzaghi, Renato Cozzi Stechio & Lab Le basi dell'analisi chimica 1-Stechiometria 2-Principi e Metodologia Ed. Zanichelli NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s3m2 - 96 - Analisi dei prodotti della ristorazione (Anno Accademico 2015/2016) QUALITY CONTROL OF CATERING PRODUCTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0387 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le principali conoscenze per l'applicazione delle analisi chimiche per il controllo dei prodotti alimentari e per il monitoraggio dei processi di trasformazione e preparazione degli alimenti.Nel corso è previsto di dare ampio spazio allo sviluppo di casi studio e alle esercitazioni di laboratorio. English To provide main knowledges to apply the chemical analysis to the foodstuffs control and to monitor the transformation process and the food preparation,The course aims to provide a wide space to the development of study cases and laboratory exercises. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione di nozioni di base riguardanti l'applicazione delle analisi chimiche per il controllo degli alimenti ed i processi di trasformazione. English Attainment of basic concepts of chemical analysis for the food control and transformation industry. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 97 - English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Scritto e orale English Written and oral PROGRAMMA Italiano - I principali grassi animali e vegetali impiegati negli alimenti. Il controllo delle caratteristiche qualitative e di eventuali alterazioni attraverso le analisi chimico-fisiche. - Valutazione del contenuto di antiossidanti naturalmente presenti negli alimenti e aggiunti. Il caso della vitamina C nei succhi di frutta (ACE) e negli agrumi. - Le micotossine negli alimenti. Principali alimenti effetti da micotossine e modalità di determinazione. Il caso dell'OTA nel caffè e il controllo qualità nelle filiera produttiva. Determinazione dell'OTA mediante test ELISA. - La presenza di allergeni negli alimenti per effetto dell'impiego di coadiuvanti tecnologici. Modalità di controllo mediante saggio immunologico per gli allergeni dell'uovo e delle caseine. - Esempi di alcuni contaminanti negli alimenti: il caso degli inibenti del latte e dei residui di detergenti e sanificanti. Principali analisi chimiche e test rapidi per la determinazione. - Il controllo del processo produttivo delle conserve vegetali nelle aziende agricole. Richiami teorici per la produzione di conserve e per il controllo di processo. Modalità per il monitoraggio ed il controllo dei punti critici del processo. - Applicazione di differenti metodiche analitiche per la determinazione degli zuccheri degli alimenti e contenuto in alcol. - determinazione della fibra dietetica (metodo enzimatico) totale, solubile, insolubile English Main animal fats and vegetable oils in foods. Qualitative characteristics control and possible alterations by means of chemical and physical analysis. Main gaschromatographic methods of the fat substances industry Evaluation of antioxidant contents naturally present into foods and added. The vitamin C case into fruit juices (ACE) and citrus fruits. Mycotoxins into foods. - 98 - Main foods affected with mycotoxins and determination methods The case of OTA into wine and the quality control at the weaving factoryOTA determination through ELISA test. The allergen presence into foods as a result of technological coadjuvants employment. Control methods by means of immunological sample for egg and casein allergens. Examples of some contaminants into foods: the inhibiting elements case of milk and of detergent and sanifying residual wastes. Main chemical analysis and rapid tests for the determination. The productive process control of vegetal preserves in farm business. Theorical revisions for the preserve production and for the process control. Monitoring and control methods of the critical points of the process: on-line control and recording of the thermal processing, the concentration into dry substance and the pH. Application of different analytical methods for the determination of sugars and alcohol in foods. - Determination of dietary fiber (enzymatic method), total, soluble, insoluble TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano R. Giuliano, M.L. Stein, Quaderni di Chimica degli Alimenti, volume I, II, III, IV, V, Ed. Bulzoni, Roma. Balestrieri Marini, Metodi di analisi chimica dei prodotti alimentari, vol I, II, III, Ed Monolite. H.D. Blitz, W. Grosch, P. Schieberle, Food Chemistry, Springer-Verlag Ed., (Berlin, Germany, 3rd revised edition). Tateo: Analisi dei prodotti alimentari volume 1 volume 2 Chiriotti editore Cozzi, Protti Ruaro, Analisi Chimica Strumentale Vol A,B,C Ed Zanichelli Bologna. Caudana A. Acquati A. (2007). Aspetti microbiologici, tecnologici e produttivi delle conserve alimentari. Manuale edito dalla Coldiretti, Asti. English R. Giuliano, M.L. Stein, Quaderni di Chimica degli Alimenti, volume I, II, III, IV, V, Ed. Bulzoni, Roma. Balestrieri Marini, Metodi di analisi chimica dei prodotti alimentari, vol I, II, III, Ed Monolite. H.D. Blitz, W. Grosch, P. Schieberle, Food Chemistry, Springer-Verlag Ed., (Berlin, Germany, 3rd revised edition). Tateo: Analisi dei prodotti alimentari volume 1 volume 2 Chiriotti editore Cozzi, Protti Ruaro, Analisi Chimica Strumentale Vol A,B,C Ed Zanichelli Bologna. Caudana A. Acquati A. (2007). Aspetti microbiologici, tecnologici e produttivi delle conserve alimentari. Manuale - 99 - edito dalla Coldiretti, Asti. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s6ge - 100 - Analisi e gestione genetica della biodiversità animale (Anno Accademico 2015/2016) GENETIC ANALYSIS AND MANAGEMENT OF ANIMAL BIODIVERSITY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0354 Docente: Prof. Alfredo PAUCIULLO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708598, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/17 - zootecnica generale e miglioramento genetico Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Conoscenze di genetica generale e di miglioramento genetico OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Gli studenti dovranno essere in grado di applicare i principi e gli strumenti della genetica al fine di analizzare e salvaguardare la biodiversità animale, con speciale riferimento alle specie in allevamento. English Students should be able to apply the genetic principles and tools for the analysis and conservation of animal biodiversity, with a special focus on farmed animals. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisire le conoscenze necessarie per salvaguardare specie e razze animali come entità dinamiche, applicando gli strumenti più idonei alle diverse situazioni. English To acquire the knowledge useful to preserve animal species and breeds as dynamic entities, exploiting the genetic tools appropriate for any specific situation. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Lezioni frontali ed esercitazioni - 101 - English Lectures and exercises MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento sarà effettuata attraverso la continua interazione durante lezioni, simulazioni al computer e analisi critica di casi pratici. Relazione scritta + esame orale English The knowldge acquired by the students will be assessed through the continous interaction during lectures, computer simulations and critical analysis of study cases. PROGRAMMA Italiano I contenuti del corso, di seguito esplicitati, si inseriscono nell'area di apprendimento zootecnica e delle produzioni animali e hanno collegamenti con altre discipline dell'area, quali quelle relative alle modalità di allevamento e alla qualità dei prodotti. Programma Origine della biodiversità. Definizione di popolazione e di razza. Genetica di popolazione e fattori che influiscono sulla variabilità genetica. Mutazione, migrazione, selezione. Simulazioni con il software Allele A1. Grandezza della popolazione. Deriva genetica. Simulazioni con il software PopG. Bottleneck. Founder effect. Misura della variabilità. Calcolo delle frequenze alleliche. Verifica dell'equilibrio di Hardy-Weinberg. Variabilità entro razza: grado di eterozigosi, diversità allelica, n. effettivo di alleli, alleli privati. Variabilità fra razze: distanze genetiche, alberi filogenetici, statistiche F. Software per analisi di genetica di popolazione: Popgen32. Consanguineità. Alberi genealogici. Coeff. di parentela e coeff. di consanguineità: significato e modalità di calcolo. Effetti della consanguineità sui caratteri qualitativi e quantitativi. Gestione della biodiversità. Cause di riduzione e motivazioni per la salvaguardia. Categorie di rischio. Criteri per scegliere le razze da salvaguardare. Ne e fattori che la condizionano: rapporto sessi, varianza delle famiglie, fluttuazioni, intervallo fra generazioni. Come aumentare Ne. Strategie di conservazione. In situ. Prodotti tradizionali, rintracciabilità. Ex situ. Tipi di germoplasma da conservare e relativi vantaggi e svantaggi: seme, ovocellule, embrioni, tessuti, DNA. Ex situ live. Scelta della strategia da utlizzare. Regolamenti CE sulla salvaguardia della biodiversità. Esercitazioni: utilizzo di software dedidati. Analisi per evidenziare il polimorfismo del DNA. English The contents of the course, listed below, are part of the animal science area and are linked to other subjects of the area, including breeding systems and quality of the productions. Program Biodiversity. Origin of biobiversity. Population and breed definition. Population genetics and factors affectingt variability. Mutation, migration, selection. Computer simulations using Allele A1 software. Population size, genetic drift. Computer simulations using PopG software. Bottleneck, founder effect. Describing diversity. Ccensus: data collection, aims. Phenotypic description: data collection. Qualitative traits: frequency distribution. Quantitative traits: descriptive statistics, correlation, regression. Partioning of phenotypic variance. Heritability: meaning and estimating - 102 - procedures. Genetic description. Polymorphism. Types of markers: visible, protein, molecular. Mitochondrial DNA. PCR-RFLP technique. Procedure to analyse a specific mutation. Genome. basic of sequencing. Genetic maps, physical maps. Measuring variability. allele frequencies. hardy-Weinberg equilibrium. Within-breed variability: heterozygosity, allele diversity, effective number of alleles, private alleles. Between-breed variability: genetic distances, phylogenetic trees, F statistics. Inbreeding. pedigrees. Inbreeding and kinship coefficients: meaning and calculation. Inbreeding effects on qualitative and quantitative traits. Managing biodiversity. causes of reduction and reasons for conservation. Risk categories. Criteria for selecting breeds for conservation. Ne and affecting factors: sex ratio, family variance, size change over generations, generation interval. How to increase Ne. Conservation strategies: In situ. Links between products and breeds, traceability. Ex situ. Types of germplasm, advantages and disadvantages: semen,oocytes, embryos, somatic cells, DNA. Ex situ live. Choosing the conservation strategy. CE regulations on biodiversity conservation. Practical activity: computer simulations. Laboratory work for DNA analysis. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Frankham R., Ballou J.D., Briscoe D.A. Fondamenti di genetica della conservazione. Zanichelli. J.C. Avise. Molecular markers, natural history and evolution.Sinauer. Articoli di AA vari (forniti dal docente). Siti internet di interesse: http://dad.fao.org/ http://efabis.tzv.fal.de/ http://www.aia.it http://www.assonapa.it http://www.associazionerare.it/ English Frankham R., Ballou J.D., Briscoe D.A. Fondamenti di genetica della conservazione. Zanichelli. J.C. Avise. Molecular markers, natural history and evolution.Sinauer. Articoli di AA vari (forniti dal docente). Siti internet di interesse: http://dad.fao.org/ http://efabis.tzv.fal.de/ http://www.aia.it http://www.assonapa.it http://www.associazionerare.it/ NOTA - 103 - Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8vli - 104 - Analisi ecologica del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) STUDIO Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 65725 Docente: Prof. Amedeo REYNERI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708778, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Acquisizione delle competenze necessarie per Valutare e Analizzare il Paesaggio da un punto di vista ecologico, attraverso l'esame dei processi dinamici che governano gli ecosistemi e le loro interazioni. Miglioramento delle capacità di lettura ecologica del paesaggio, anche attraverso strumenti informatici e numerici, per inserire più correttamente gli interventi progettuali a diverse scale spaziali, temporali e di contesto. English The aim of the course is the knowledge on the analysis and the evaluation of the landscape, considering the ecological aspects, through the ecosystem relationships between the dynamics processes and gradients. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Miglioramento delle capacità di lettura ecologica del paesaggio, anche attraverso strumenti informatici e numerici, per inserire più correttamente gli interventi progettuali a diverse scale spaziali, temporali e di contesto. English The student will improve the capacity to read and understand the landscape ecology, also through GIS and other information and qualitative technologies. The capacity will be focused on the analysis of the impact of the project in the landscape ecology considering different scales of approach. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 105 - Italiano Il corso consiste in 16 ore di lezioni frontali, di 8 ore di studio coordinato con esame collegiale di casi di studio, di 8 ore di visite tecniche in campo e di 16 ore di assistenza alla preparazione dell'elaborato progettuale. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide a disposizione degli studenti. English The course concerns 16 hours of classroom lectures, 16 hours of case study analysis, 8 hours of fields visits and 16 hours of assisted activity related with the preparation of the book project. For the classroom lecture slides will be employed and dispensed to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica sarà effettuata in itinere mediante test sulle nozioni sulla parte del programma svolta. La verifica finale avverrà mediante la presentazione di un elaborato su un caso di studio relativo ad un tema originale a scelta dello studente e quindi mediante un esame orale. English The learning test will be carry on during the course on the part of program already presented. The final test will be organized through the presentation of a case study originally selected by the student and then an oral examination. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Nessuna / None PROGRAMMA Italiano Il corso affronterà i seguenti argomenti: La struttura e il funzionamento degli ecosistemi Un richiamo sulle relazioni tra le comunità biotiche e i fattori abiotici La struttura dell'ecomosaico (macchie, matrici e corridoi) Il dinamismo dell'ecomosaico e i gradienti Strumenti e metodi di analisi dell'ecomosaico Metodi di valutazione dell'ecomosaico Approccio critico alla progettazione in sistemi ecologici complessi English The Course will consider the following topics: The structure and the functioning of the ecosystems A summary of the relationship among the biotic communities and the abiotic factors The structure of the landscape ecomosaic The dynamism and the gradient of the landscape ecomosaic The instruments and the methods of the analysis - 106 - The evaluation method of the landscape ecomosaic The critical approach to the project in complex landscape ecomosaic TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Turner G., Gardner R, O'Neill R. Landscape Ecology In theory and practice. Springer, 401 pp. Ingegnoli V., Giglio E. Ecologia del Paesaggio. Sistemi editoriali – Esselibri. 685 pp. Ferrari C., Pezzi G. L'ecologia del paesaggio. Il Mulino. 152 pp. English Turner G., Gardner R, O'Neill R. Landscape Ecology In theory and practice. Springer, 401 pp. Ingegnoli V., Giglio E. Ecologia del Paesaggio. Sistemi editoriali – Esselibri. 685 pp. Ferrari C., Pezzi G. L'ecologia del paesaggio. Il Mulino. 152 pp. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=94h1 - 107 - Analisi enologiche avanzate (Anno Accademico 2015/2016) Analisi enologiche avanzate Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0041 Docente: Prof. Luca ROLLE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708558, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscenze per valutare report analitici al fine di saper gestire le diverse fasi del processo produttivo. Fornire conoscenze per eseguire una analisi strumentale partendo dalle informazioni contenute in un articolo scientifico. English Providing knowledge to evaluate analytical reports in order to be able to manage the different phases of the productive process. Providing knowledge to perform an instrumental analysis on the basis of the information contained in a scientific article. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Capacità di valutare report analitici al fine di saper gestire le diverse fasi del processo produttivo. Capacità di eseguire una analisi strumentale partendo dalle informazioni contenute in un articolo scientifico. English Ability to assess analytical reports in order to be able to manage the different phases of the production process. Ability to perform an instrumental analysis on the basis of the information contained in a scientific article. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 20 ore di lezione frontale con seminari specialistici e 20 ore dedicate a attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di articoli scientifici e slides che sono a disposizione degli studenti. English - 108 - The course consists of 20 hours of lectures with seminars and 20 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher makes use of scientific papers and slides that are available to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verifica scritta e/o test di laboratorio in itinere. Verifica scritta finale con domande aperte (3-5 domande) e/o test di laboratorio. English Written test and/or laboratory test ongoing. Final written test with 3-5 open questions and/or laboratory test. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Uso delle banche dati Scopus, Web of Knowdlege. English Use of scientific data banks: Scopus, Web of Knowdlege. PROGRAMMA Italiano Metodi strumentali per la determinazione delle proprietà meccaniche e acustiche delle uve da vini e da tavola (Texture Analysis). Metodiche FT-NIR per la valutazione della qualità delle uve. Preparazione del campione e metodiche HPLC per la determinazione degli zuccheri, della composizione acidica e del profilo antocianico di uve e vini. Preparazione del campione (fluoroglucinolisi) e metodiche HPLC per la determinazione delle sostanze tanniche in mosti e vini. Preparazione del campione e metodiche HPLC per la determinazione delle ammine biogene nei vini. Metodiche analitiche per la determinazione dei metalli pesanti nei vini. Preparazione del campione e metodiche GC per la determinazione delle sostanze volatili nei vini. Metodiche analitiche per la determinazione di indici colorimetrici nei vini. English Instrumental methods for mechanical and acoustic determination in table and winegrapes (Texture Analysis). FT-NIR methods for evaluation of grapes quality. Sample preparation and HPLC methods for sugars, acids and anthocyanin profiles determinations in grapes and wines. Sample preparation (fluoroglucinolisis) and HPLC methods for tannin determinations in grapes and wines. Sample preparation and HPLC methods for biogenic ammine determinations in wines. - 109 - Instrumental methods for heavy metal determination in wines. Sample preparation and GC methods for volatile compound determinations in wines. Analytical methods for wine chromatic characteristics determination. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Files acquisiti dalla letteratura scientifica. English Files acquirered by data banks NOTA Italiano Sedi dell'insegnamento: Asti e Alba. English Locations course: Asti and Alba. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pcrj - 110 - Analisi fisiche e sensoriali degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) PHYSICAL AND CHEMICAL FOOD ANALYSES Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0619 Docente: Dott. Alessandra DEL CARO (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente le conoscenze teoriche e pratiche e gli strumenti più idonei atti a caratterizzare i prodotti alimentari. La conoscenza delle principali analisi fisiche e delle diverse metodologie sensoriali fornirà allo studente gli strumenti necessari alla caratterizzazione degli alimenti sia nell'ambito del controllo di qualità sia per l'identità dei prodotti stessi. English Provide students with theoretical and practical knowledge and the most appropriate instruments designed to characterize a foodstuff. Knowledge of the main physical analyses and the different sensory techniques provide the students with the tools necessary for food characterization both in quality control and for the product identity. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza e capacità di comprensione Lo studente, alla fine del corso, acquisirà delle conoscenze di base e avanzate riguardo il ruolo delle analisi fisiche e sensoriali sulle caratteristiche di qualità dei prodotti alimentari. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Lo studente sarà in grado di fornire alla aziende delle soluzioni relativamente all'applicazione di tecniche di valutazione sensoriale dei prodotti. Autonomia di giudizio - 111 - Acquisirà autonomia di giudizio partecipando personalemente alle problematiche incontrate dalle aziende relativamente alla trasformazione e conservazione del prodotto. Abilità comunicative L'abilità di comunicazione verrà acquisita dallo studente attraverso la sollecitazione del docente, in particolare durante le esercitazioni, a partecipare al lavoro di gruppo in aula. Capacità di apprendimento Lo studente, alla fine del corso, avrà acquisito piena autonomia nell'apprendimento della materia oggetto di studio. English MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Valutazione orale English Oral assessment PROGRAMMA Italiano 1. Aspetti introduttivi (1h). 1a Importanza del ruolo delle analisi fisiche e sensoriali nel controllo di qualità e di processo degli alimenti. Applicazione delle analisi fisiche e sensoriali alla qualità degli alimenti. 2. Analisi sensoriale (18h). 2a. Introduzione all'analisi sensoriale. 2b. Fisiologia degli organi di senso. Psicofisiologia della percezione: soglie di percezione, risposte agli stimoli, diverse sensibilità, errori di origine fisiologica e psicologica. 2c. Attributi sensoriali degli alimenti. Il laboratorio di analisi sensoriale. I giudici di analisi sensoriale: selezione e addestramento. Uso delle scale di misura. 2d. Metodi di analisi sensoriale: test discriminanti, descrittivi e affettivi. Test di preferenza ed accettabilità. Tecniche statistiche di base e avanzate applicate all'analisi sensoriale degli alimenti. Applicazione e problemi di analisi sensoriale nelle aziende. 3. Analisi del colore dei prodotti alimentari (5h). - 112 - 3a. La percezione del colore. Luce ed interazione con gli alimenti. Spazi colorimetrici: sistema C.I.E., Munsell, Yxy. 3b. Misurazione strumentale del colore e delle differenze cromatiche, cause di variabilità cromatica. 3c. Strumentazione colorimetrica: colorimetria tristimolo e spettrofotometria. 3d. Colore degli alimenti e cambiamenti durante i processi di trasformazione e conservazione. 4. Correlazioni fra misurazioni fisiche e valutazioni sensoriali (2h). 5. Analisi dell'immagine (Image analysis) (2h): obiettivi, strumentazione e applicazione su matrici alimentari. 6. Naso elettronico e lingua elettronica (2h): funzionamento e applicazione su matrici alimentari. English TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Appunti e materiale didattico distribuito dal docente M.Bourne. Food texture and viscosity. Concept and measurement. 2nd Edition. 2002. Academic Press. Meilgaard, Civille and Carr. Sensory Evaluation Techniques. 3th Edition. 1999. CRC. Kemp, Hollowood, Hort. Sensory Evaluation. A practical handbook. Wiley. Blackwell. 2009. J. Houtchings. Food color and appearance. 2nd Edition. 1999. Aspen. Schanda Janos. Colorimetry. Undestanding the CIE System. 2007. Wiley. R.S. Jackson. Wine tasting: A Professional Handbook. 2002. Elsevier. Academic Press. English M. Bourne. Food texture and viscosity. Concept and measurement. 2nd edition, 2002. Academic Press. Meilgaard, Civille & Carr. Sensory Evaluation Techniques. 3rd Edition, 1999. CRC Kemp, Hollowood, Hort. Sensory evaluation. A practical handbook. Wiley-Blackwell, 2009. John Hutchings. Food color and appearance. 2nd Edition. 1999. Aspen. Schanda Janos. Colorimetry. Understanding the CIE System. Wiley, 2007. R.S. Jackson. Wine testing. A professional handbook. Wiley- Blackwell. 2009. NOTA Italiano English - 113 - Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fjuc - 114 - Apicoltura (Anno Accademico 2015/2016) BEEKEEPING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0383 Docente: Dott. Marco PORPORATO (Affidamento interno) Contatti docente: (+39) 011 670 8584, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso intende fornire le basi teorico-pratiche necessarie per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti dell'alveare, e per contrastare le avversità che minacciano il patrimonio apistico. Esso si rivolge principalmente agli studenti che abbiano interesse sia per attività imprenditoriali o di assistenza tecnica sia in campo apistico. English Learning objectives The course intends to provide the theoretical-practical bases necessary for the conduct of the apiary, processing and marketing of the products of the hive and to counter the adversities that threaten ther apicultural heritage. It is aimed primarily at students who have an interest in business or technical assistance in beekeeping field. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Fornire agli studenti una preparazione idonea per operare nel settore dell'apicoltura sia in proprio, sia come tecnico/funzionario/consulente di associazioni, cooperative o aziende. English Aims To provide students with fit preparation for working in the field of beekeeping both independently and as a - 115 - technical officer / consultant associations, cooperatives or companies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 50 ore di lezione frontale e 30 ore dedicate a esercitazioni in laboratorio e apiario, e visite di aziende apistiche. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 50 hours of lectures and 30 hours dedicated to laboratory exercises and visits in apiary, and technical visits to beekeeping concerns. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento sarà eseguita durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche nel corso delle quali gli studenti avranno occasione di mettere in pratica le informazioni fornite in aula e con l'esame finale in una data di appello. English The learning process will be checked on the occasion of practical training during which students have the chance to put the theoretical information into practice. Scritto PROGRAMMA Italiano Il corso fa parte delle aree della conoscenza della zootecnica e delle produzioni animali. Origini, sviluppo e importanza dell'apicoltura. Sistematica della superfamiglia Apoidea. Specie e sottospecie del genere Apis. Organizzazione della società della api. Poliformismo e polietismo. Morfologia, anatomia e fisiologia dell'ape. Esame morfologico e dissezione di operaie, fuchi, regine. Sviluppo preimmaginale. Determinismo del sesso e delle caste. Feromoni. Orientamento e linguaggio. Arnia, alveare, apiario. Evoluzione delle arnie, modelli maggiormente utilizzati. Attrezzatura apistica. Montaggio dei fogli cerei. Ciclo stagionale delle colonie di api. Tecniche di conduzione degli alveari per la produzione di miele, polline, gelatina reale e il servizio di impollinazione delle colture. La cera: tecniche di estrazione. Apicoltura stanziale e nomade. - 116 - Scelta delle postazioni e sistemazione degli apiari. Deriva e saccheggio. Visite in apiario: tecniche di conduzione degli alveari e valutazione dello sviluppo delle famiglie. Allevamento di api regine. Stazioni di fecondazione. Inseminazione strumentale. Marcatura. Sostituzione delle regine. Preparazione di nuclei e pacchi d'api. Genetica dell'ape. Selezione e ibridazione. Conservazione della biodiversità. Avversità e nemici dell'ape. Patologia apistica. Osservazione di materiale patologico. Avvelenamenti. L'ape come indicatore dell'inquinamento ambientale. Nettare e melata. Principali specie botaniche di interesse apistico. Ruolo dell'ape per l'impollinazione. Produzione, composizione, utilizzazione e commercializzazione di miele, polline, propoli, cera, gelatina reale e veleno. Caratterizzazione fisico-chimica, botanica e organolettica dei mieli. Esame melissopalinologico e organolettico di mieli. Normative concernenti l'apicoltura. Disciplinare relativo all'apicoltura biologica. Organizzazione dell'apicoltura in Italia e all'estero. Visite tecniche in aziende apistiche. English The course forms part of the filed of knowledge of livestock and livestock products. Origins, development and importance of beekeeping. Systematics of the superfamily Apoidea. Species and races of the genus Apis Organization of bee society. Polymorphism and work division. Bee morphology, anatomy and physiology Morphological examination and dissection of worker bees, drones and queens. Duration of the juvenile stages. Sex and caste determinism. Pheromones. Orientation and language. Hive, bee colony, apiary. Main models of rational hives. Drift and pillage. Beekeeping equipment. Assembly of comb foundations.Seasonal cycle of honey bee colonies. Management for honey, pollen, royal jelly production and crop pollination service. Wax: extraction techniques. Sedentary and migratory beekeeping Choice of locations and arrangement of the apiaries. Visits in apiary: management of colonies and their evaluation. Queen rearing. Mating stations. Instrumental insemination. Marking the queen. Preparation of bee nuclei and packages. - 117 - Bee genetics. Selection and hybridization. Biodiversity conservation. Adversities and enemies of honey bees. Bee diseases. Observation of the pathological specimens. Poisoning. Bees as environmental pollution indicators. Nectar and honeydew. Main botanical species for bee forage. Role of the bee in pollination.Foraging behavior of bees and pollination. Production, composition, use and marketing of honey, pollen, propolis, wax, royal jelly and venom. Physical, chemical, botanical, and organoleptic characterization of honeys. Pollen and organoleptic analysis of honeys. Beekeeping laws and regulations. Disciplinary rules concerning biological beekeeping. Beekeeping organisation in Italy and in foreign countries. Technical visits to beekeeping concerns. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano J. Tautz – Il ronzio delle api - Springer, Milano, 2009 - ISBN 978-88-470-0860-1; Formato17x21; Illustrazioni 213; pp. 306 A. Contessi – Le api. Biologia, allevamento, prodotti dell'alveare. - Edagricole, Bologna, 2004 (ristampa 2012) - ISBN 88-506-4957-6; Formato17x24; Illustrazioni 260; pp. 528 A. Pistoia – Apicoltura tecnica e pratica – Edizioni l'Informatore Agrario, Verona, 2a edizione - ISBN88-7220-069-5; Formato17x24; Illustrazioni 350; pp. 304. F. Casucci - Dizionario europeo dell'apicoltura – Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 - ISBN 88-495-0723-2; Formato15x22; pp. 288. F. Frilli, R. Barbattini, N. Milani - L'ape. Forme e funzioni - Edagricole, Bologna, 2001 - ISBN 88-206-4755-9; Formato18x23; Illustrazioni 130; pp. X+112. I.N.A. - Attività apistica. Legislazione e normative dei prodotti dell'alveare – Edizioni Avenue Media, Bologna, 2001. AA.VV. – L'apiculture, une fascination. Edition VDRB, Winikon (CH), 2003 - ISBN 3-9522157-7-5; Formato17x26; Illustrazioni 569; pp. 561. E. Carpana, M. Lodesani - Patologie e avversità dell'alveare - Springer, 2014, Ca. 450 pagg. 125 figg., 100 figg. a colori. J. Tauz - The Buzz about Beese - Springer, 1st ed. 2008. Corr. 2nd printing 2009, XIV, 284 p., 230 illus. in color. E. Crane - Bees and Beekeeping. Science, practice and world resources – Heinemann Newnes, Oxford, 1990 – Size 21x28; Illustrations; pp. XVI+614. L. Goodman – Form and Function in the Honey Bee - IBRA, Cardiff, 2003 – Size 24x34, 340 illustrations, pp. 220. J. M. Graham Ed. – The hive and the honey bee – Dadant & Sons, Hamilton, Illinois, 1992 - ISBN 0-915698-09-9; Size 16x23,5; Illustrations; pp. 1324. - 118 - English J. Tauz - The Buzz about Beese - Springer, 1st ed. 2008. Corr. 2nd printing 2009, XIV, 284 p., 230 illus. in color. E. Crane - Bees and Beekeeping. Science, practice and world resources – Heinemann Newnes, Oxford, 1990 – Size 21x28; Illustrations; pp. XVI+614. L. Goodman – Form and Function in the Honey Bee - IBRA, Cardiff, 2003 – Size 24x34, 340 illustrations, pp. 220. J. M. Graham Ed. – The hive and the honey bee – Dadant & Sons, Hamilton, Illinois, 1992 - ISBN 0-915698-09-9; Size 16x23,5; Illustrations; pp. 1324. A. Contessi – Le api. Biologia, allevamento, prodotti dell'alveare. - Edagricole, Bologna, 2004 (ristampa 2012) - ISBN 88-506-4957-6; Formato17x24; Illustrazioni 260; pp. 528 A. Pistoia – Apicoltura tecnica e pratica – Edizioni l'Informatore Agrario, Verona, 2a edizione - ISBN88-7220-069-5; Formato17x24; Illustrazioni 350; pp. 304. F. Casucci - Dizionario europeo dell'apicoltura – Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 - ISBN 88-495-0723-2; Formato15x22; pp. 288. F. Frilli, R. Barbattini, N. Milani - L'ape. Forme e funzioni - Edagricole, Bologna, 2001 - ISBN 88-206-4755-9; Formato18x23; Illustrazioni 130; pp. X+112. I.N.A. - Attività apistica. Legislazione e normative dei prodotti dell'alveare – Edizioni Avenue Media, Bologna, 2001. AA.VV. – L'apiculture, une fascination. Edition VDRB, Winikon (CH), 2003 - ISBN 3-9522157-7-5; Formato17x26; Illustrazioni 569; pp. 561. E. Carpana, M. Lodesani - Patologie e avversità dell'alveare - Springer, 2014, Ca. 450 pagg. 125 figg., 100 figg. a colori. NOTA Italiano Insegnamento A LIBERA SCELTA (Crediti liberi) degli Studenti Le date di appello Sono Visibili al link "Appelli" della Pagina WEB dell'Università Si segnala che nel primo fine settimana di marzo, a Piacenza, si svolge APIMELL, Mostra Mercato Nazionale di Apicoltura (www.apimell.it) English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7e87 - 119 - Application of agro-ecosystem models to field crops (Anno Accademico 2015/2016) Application of agro-ecosystem models to field crops Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0415 Docente: Prof. Dario SACCO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708787, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano The aim of this module will be to show to the students the main structure of some cropping system simulation models and to apply them to case studies on intensive cropping systems. English The aim of this module will be to show to the students the main structure of some cropping system simulation models and to apply them to case studies on intensive cropping systems. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Within this module the students will integrate the knowledge acquired in the other modules through the application of cropping system simulation models dealing with plant growth and crop production. English Within this module the students will integrate the knowledge acquired in the other modules through the application of cropping system simulation models dealing with plant growth and crop production. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano The module consists of 20 hours of lectures. PowerPoint presentation and already solved exercises, used during lessons, are available to students. - 120 - English The module consists of 20 hours of lectures. PowerPoint presentation and already solved exercises, used during lessons, are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Levels of learning acquired by the students will be evaluated: - through questions related to topics already taught during the course - during numerical applications. Final exam will consists of a model application to be solved on a PC and of a oral part to assess theoretical knowledge of the student. English Levels of learning acquired by the students will be evaluated: - through questions related to topics already taught during the course - during numerical applications. Final exam will consists of a model application to be solved on a PC and of a oral part to assess theoretical knowledge of the student. PROGRAMMA Italiano Soil hydrology: theoretical aspects of water dynamics into the soil. Practical calculation of water flows into the soil. Modeling: Presentation of a cropping system simulation model Description of the different components in cropping system simulation models Application of a cropping system simulation model to a case study English Soil hydrology: theoretical aspects of water dynamics into the soil. Practical calculation of water flows into the soil. Modeling: Presentation of a cropping system simulation model Description of the different components in cropping system simulation models Application of a cropping system simulation model to a case study TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA - 121 - Italiano D. Hillel, 1998. Environmental Soil Physics. Academic Press, 771 pp.(available at the Library of ULF Agronomy). Selected literature from scientific international journals. English D. Hillel, 1998. Environmental Soil Physics. Academic Press, 771 pp.(available at the Library of ULF Agronomy). Selected literature from scientific international journals. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1fmw - 122 - Applicazioni di analisi sensoriale I (Anno Accademico 2015/2016) APPLIED SENSORY ANALYSIS 1 Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0295 Docente: Prof. Giuseppe ZEPPA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708705, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Analisi Sensoriale II OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso ha lo scopo di far conoscere agli studenti le basi teoriche dell'analisi sensoriale e tutti gli elementi che concorrono alla sua effettuazione. Si tratta di un corso di tipo teorico che si svolge completamente in aula e che trova nel Laboratorio di Analisi sensoriali II il suo naturale completamento. English The course aims to introduce students with the theoretical bases of sensory and all items that contribute to its execution. It is a theoretic course which takes place entirely in the classroom and that is in the Laboratory of Sensory Analysis Lab II its natural complement. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà conoscere la fisiologia dei sensi nonchè tutti gli elementi che concorrono alla esecuzione di un test sensoriale e di un test sul consumatore English The student will learn the physiology of the senses as well as all the elements that contribute to the execution of a sensory test and a consumer test - 123 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 20 ore di lezione frontale. Per le lezioni il docente si avvale di slides che sono a disposizione degli studenti English The course consists of 20 hours of lectures. For lectures the teacher makes use of slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verranno effettuate delle verifiche orali in classe durante le lezioni. L'esame finale è un elaborato scritto formato da 4 domande aperte English They will be made an oral tests in class during lessons. The final examen is a writen paper consits of 4 open questions PROGRAMMA Italiano Sulla base di quanto previsto nella scheda SUA-TAL (Quadro A4.b) il programma del corso si sviluppa nell'ambito della qualità e sicurezza. Gli argomenti trattati sono: L'analisi sensoriale e l'assaggio: differenze e similitudini. La struttura per l'assaggio: la sala, le cabine, i contenitori. Il trattamento del campione. Cenni di fisiologia dei sensi. L'udito. La vista. L'olfatto. Il gusto. Il tatto. La sensazione e la percezione. L'immagine sensoriale. La selezione e la formazione degli assaggiatori. I test del consumatore: la scelta dei consumatori, la definizione dei luoghi di assaggio. I test di assaggio: i test discriminanti qualitativi, i test discriminanti quali-quantitativi, i test descrittivi. La preparazione dei test, l'esecuzione dei test, l'elaborazione dei risultati. English According to SUA-TAL (Quadro A4.b) the course work in the "Quality and safety" field. Particularly the capters are: Sensory analysis and sampling: differences and similarities. The structure for the tasting: the room, cabins, containers. The treatment of the sample. The physiology of the senses. Hearing. Sight. Smell. Taste. Touch. The sensation and perception. The sensory image. The selection and training of assessors. The tests of the consumer: consumer choice, the definition of places of taste. The taste test: tests discriminating quality, the discriminatory tests and quantitative, descriptive tests. Test preparation, test execution, processing of the results. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano J.R. Piggott. "Statistical procedures in food research". Ed. Elsevier Applied Science, Londra, 1986; - 124 - S. Porretta. "L'analisi sensoriale". ED. Tecniche Nuove, Milano, 1992; S. Porretta. "Analisi sensoriale & Consumer Science". Ed Chiriotti, Pinerolo (TO), 2000; SSHA - ISHA. "Evaluation sensorielle. Manuel méthodologique". ED. Tec & Doc Lavoisier, Parigi, 1990; M. Ubigli. "I profili del vino. Introduzione all'analisi sensoriale". ED. Edagricole, Bologna, 1998. E. Pagliarini. "Valutazione sensoriale". Ed. Hoepli, Milano, 2002 E' fortemente cosigliato l'utilizzo delle slides fornite dal docente all'inizio del corso sulla pagina www.giuseppezeppa.it. English J.R. Piggott. "Statistical procedures in food research". Ed. Elsevier Applied Science, Londra, 1986; S. Porretta. "L'analisi sensoriale". ED. Tecniche Nuove, Milano, 1992; S. Porretta. "Analisi sensoriale & Consumer Science". Ed Chiriotti, Pinerolo (TO), 2000; SSHA - ISHA. "Evaluation sensorielle. Manuel méthodologique". ED. Tec & Doc Lavoisier, Parigi, 1990; M. Ubigli. "I profili del vino. Introduzione all'analisi sensoriale". ED. Edagricole, Bologna, 1998. E. Pagliarini. "Valutazione sensoriale". Ed. Hoepli, Milano, 2002 It is also necessary to use slides furnished by professor in site www.giuseppezeppa.it. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Grugliasco English The location of the course is Grugliasco Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j99s - 125 - Applicazioni di analisi sensoriale II (Anno Accademico 2015/2016) APPLIED SENSORY ANALYSIS 2 Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0296 Docente: Prof. Giuseppe ZEPPA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708705, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 2° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Prova pratica PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Conoscere la consumer science e le dinamiche che orientano le scelte dei consumatori English To know the consumer science and the reason of consumer choise RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Rendere capace lo studente di gestire un test di consumer science English Make the student capable of organizing a consumer test MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 20 ore di lezione frontale. Per le lezioni il docente si avvale di slides che sono a disposizione degli studenti English The course consists of 20 hours of lectures. For lectures the teacher makes use of slides that are available to - 126 - students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verranno effettuati dei test orali durante le lezioni. L'esame finale consiste in un elaborato formato da 3 domande aperte English They will be made an oral tests in class during lessons. The final examen is a writen paper consits of 3 open questions PROGRAMMA Italiano Il corso si sviluppa nell'ambito di quanto previsto dalla scheda SUA_TAL (Quadro A4.b) ossia della qualità e della sicurezza. Gli argomenti trattati sono: I principi della consumer science. Le relazioni fra gusto e preferenza. Il disgusto. Le preferenze dei consumatori. I test di consumer science. English The course is according to the card SUA_TAL (Part A4.b) or of quality and safety. The topics covered are: The consumer science: principle. Correlation between taste and preference. The repugnance. The consumer preferences. The consumer tests TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano J.R. Piggott. "Statistical procedures in food research". Ed. Elsevier Applied Science, Londra, 1986 S. Porretta. "L'analisi sensoriale". ED. Tecniche Nuove, Milano, 1992. S. Porretta. "Analisi sensoriale & Consumer Science". Ed Chiriotti, Pinerolo (TO), 2000 SSHA - ISHA. "Evaluation sensorielle. Manuel méthodologique". ED. Tec & Doc Lavoisier, Parigi, 1990 M. Ubigli. "I profili del vino. Introduzione all'analisi sensoriale". ED. Edagricole, Bologna, 1998. E. Pagliarini. "Valutazione sensoriale". Ed. Hoepli, Milano, 2002 Materiale didattico fornito dal docente e disponibile ad inizio corso alla pagina www.giuseppezeppa.it - 127 - English J.R. Piggott. "Statistical procedures in food research". Ed. Elsevier Applied Science, Londra, 1986 S. Porretta. "L'analisi sensoriale". ED. Tecniche Nuove, Milano, 1992. S. Porretta. "Analisi sensoriale & Consumer Science". Ed Chiriotti, Pinerolo (TO), 2000 SSHA - ISHA. "Evaluation sensorielle. Manuel méthodologique". ED. Tec & Doc Lavoisier, Parigi, 1990 M. Ubigli. "I profili del vino. Introduzione all'analisi sensoriale". ED. Edagricole, Bologna, 1998. E. Pagliarini. "Valutazione sensoriale". Ed. Hoepli, Milano, 2002 Material provided by the teacher and available at the start of the course on www.giuseppezeppa.it NOTA Italiano Il corso si svolge presso la sede di Grugliasco English The location of the course is Grugliasco Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9pbw - 128 - Applicazioni di analisi sensoriali II (Anno Accademico 2015/2016) APPLIED SENSORY ANALYSIS 2 Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0296 Docente: Prof. Vincenzo GERBI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708552, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 3° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente le nozioni di analisi sensoriale applicata necessarie a individuare pregi e difetti dei vini, valutarne le carateristiche e descrivere i prodotti. English Provide to the students the pratical knowledge of sensory analysis necessary to identify defect and quality of the wines and verify, evalute and describe the characters of some italian and international wines RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente acquisisce la capacità di descrivere un vino e cercare su di esso, sulle banche dati, le informazione scientifiche necessarie alla sua caratterizzazione English The student acquires the capacity to describe the wines and to search, on the scientific databases, the information necessary to their characterizazion. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste in una serie di esercitazioni nel corso delle quali una prima parte è dedicata all'inquadramnento (vitigno, modalità di produzione, importanza commerciale) dei vino che verranno assaggiati. Nella seconda parte gli studenti sono guidati nell'assaggio dei vini e nell individuazione dei caratteri sensoriali più importanti. - 129 - English The course consists of a series of tutorials in which a first part is dedicated to classification (grape variety, production methods, commercial importance) of wine that will be tasted. In the second part the students are guided in tasting of wines and in the identification of the most important sensory characteristics MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano A ciascuno studente al termine del corso è assegnata una parola chiave, attinente la conoscenza dei caratteri sensoriali dei vini. Lo studente deve trovare, sulle banche dati a lui accessibili, un elenco di pubblicazioni scientifiche inerenti la paorola chiave. Al momento dell'esame, che si svolge oralmente, per l'approvazione il docente valuta l'attinenza e la consistenza dell'elenco bibliografico proposto, nonché la comprensione dell'importanza della parola chiave assegnata nella caratterizzazione dei vini. English At the end of the course to each student is assigned a keyword, relevant for the knowledge of the sensory characteristics of the wines. The student must find, in the databases accessible to him, a list of scientific publications related to the keyword. At the moment of the exam, which takes place orally, for the approval the teacher evaluates the relevance and consistency of the proposed bibliography list, as well as the understanding of the importance of keyword assigned in the characterization of wines PROGRAMMA Italiano Questo corso appartiene all'area di apprendimento delle conoscenze applicate. Gli argomenti affrontati nella parte teorica sono i seguenti: Gli strumenti dell'assaggio richiami di fisiologia approccio metodologico all'assaggio dei vini I caratteri di pregio e i difetti dei vini Nella parte pratica del corso per ciascun vino: Riconoscimento di pregi e difetti .Assaggio, commento e valutazione Lavoro individuale sulla caratterizzazione di vini. English This course belongs to the area: application of learned knowledges. Topics covered in the theoretical part are as follows: Tools for tasting recalls of physiology methodological approach to tasting wines The characters of merit and defects of wines - 130 - In the practical part of the course for each wine: Description of charecters of wines Taste, comment and evaluation Individual work on the characterization of wines. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Ubigli M. - I profili del Vino - 2009 - Edagricole Il sole 24 ore, Bologna English E Peynaud, J Blouin, M Schuster, M Broadbent - 1996 - The taste of wine: the science and art of wine appreciation. Wiley, New York NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Alba English The course takes place in Alba Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mz6g - 131 - Applicazioni/tirocinio di Enologia (Anno Accademico 2015/2016) PRACTICES IN ENOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0412 Docente: Prof. Vincenzo GERBI Contatti docente: 0116708552, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Consentire allo studente di sviluppare, attraverso una esperienza aziendale, una conoscenza diretta delle operazioni di vinificazione. English Allow the student to develop, through a corporate experience, direct knowledge of the operations of winemaking. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente deve saper descrivere con proprietà di linguaggio un processo di vinificazione valutando con spirito critico le operazioni osservate in cantina. English The student must be able to describe, with properties of language, a process of winemaking considering critically the operations observed in the cellar. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Si tratta di una attività di tutoraggio: è prevista la condivisione del programma di stage tra il docente e il tutor aziendale - 132 - English It is an activity of tutoring is expected to share the internship program between the teacher and the company tutor. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano I crediti previsti per questa attività a scelta dello studente si considerano acquisiti, i sede di esame, se il docente considera accettabile la relazione di stage prodotto dallo studente e si riceve un giudizio positivo da parte del tutor aziendale, English The university credits required for this activity, chosen by the student, are considered acquired when, at the examination, the teacher considers acceptable the report produced by the student internship and receive a positive assessment by the company tutor. PROGRAMMA Italiano Questo corso appartiene all'area di apprendimento della applicazione delle conoscenze Lo studente frequenta un'azienda enologica convenzionata, partecipando all'attività dell'azienda medesima, normalmente nel corso del periodo vendemmiale. Al termine compila una breve relazione dell'attività svolta e la discute con il docente al fine dell'approvazione. English This course belongs to the area of application of the learned knowledge. The student in a conventioned cellar (a producer that have signed an agreement with the University of Turin), participate in the activity of the company, normally during the harvest period. After compile a brief report of activities, discussed with the teacher. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Ribéreau Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A.. Trattato di Enologia I e II. Ed. 2007, Edagricole, Bologna. English P. Ribéreau-Gayon, D. Dubourdieu, A. Lonvaud - 2006- Handbook of enology. Wiley & Sons, Chichester, UK NOTA Italiano - 133 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=42ru - 134 - Applicazioni/tirocinio di Viticoltura (Anno Accademico 2015/2016) PRACTICES IN VITICULTURE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0411 Docente: Prof. Silvia GUIDONI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708659, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Dare allo studente la possibilità di familiarizzare con i problemi concreti della gestione del vigneto. English To give to students the opportunity to familiarize with the concrete problems of vineyard management. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione di conoscenze pratiche inerenti le operazioni di conduzione del vigneto. English To acquire practical knowledges on vineyard management tecniques . MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Le attività vengono svolte presso aziende convenzionate seguendo un progetto formativo indicato dal docente English The activities take place in viticultural farms following a simple educational project proposed by the teacher MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO - 135 - Italiano Al termine delle attività in azienda lo studente compila una breve relazione (max 12000 caratteri spazi inclusi, font 11 o 12, interlinea 1, margini 2 ) sull'attività svolta, la invia al docente una settimana prima dell'appello, e la discute oralmente il giorno dell'appello. English At the end of the activities the student writes a short report (max 12000 character, font 11o 12, space 1, margin 2 cm) concerning the practical activities he made, he sent it to the teacher some days before the exam and discusses it orarly with the theacher for the evaluation. PROGRAMMA Italiano 6. Applicazioni delle conoscenze. Lo studente si reca in un'azienda viticola convenzionata per partecipare alle attività della medesima in vari periodi dell'annata. English The students goes in a farm where he partecipates to the practical activities in vineyard in different periods of the year. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Eynard I., Dalmasso G. (1990) Viticoltura moderna. IX Ed. HOEPLI Milano, 778 pp. M. Fregoni (2005) Viticoltura di qualità. II Ed., Phytoline Verona, 819 pp. English Winkler A.J. et al. (1975). General Viticulture. University of California Press.710 pp. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7vog - 136 - Approfondimenti di controllo qualità degli alimenti (Anno Accademico 2015/2016) INSIGHTS INTO QUALITY FOOD CONTROL Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0386 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 2° anno 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Vengono forniti gli elementi per la comprensione dei processi e tecnologie alla base della produzione agroalimentare e i controlli necessari per garantire, durante tutta la filiera produttiva, la sicurezza e la qualità degli alimenti English We provide the elements for the understanding of the processes and technologies that are at the base of food production and the checks and controls necessary to ensure security and quality of food products during the entire production chain. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza dei concetti di base relativi alla valutazione qualitativa dei prodotti alimentari, sia durante i processi produttivi (controllo qualità in produzione) sia sul prodotto finito. - 137 - English Knowledge of basic concepts related to qualitative evaluation of the food, both during the production processes (quality control during production) and on the finished product itself. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al completamento di ogni argomento del programma (circa ogni 6-9 ore di lezione) viene consegnato agli studenti copia dello specifico materiale formativo preparato dal docente e viene effettuata una verifica dell'apprendimento con domande agli studenti ed eventuali approfondimenti English At completion of each topic of the program (about every 6-9 hours of teaching), the students are given a copy of the specific training materials prepared by the teacher and a check is made to assess the students' learning, with questions and further study where necessary. orale PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del programma appartengono all'area "Qualità e Sicurezza". 60 ore complessivamente modulo tematico1 La sicurezza nella produzione agroalimentare: tracciabilità e controlli.: l'assicurazione della qualità; la sicurezza sanitaria. La salubrità di un alimento. La garanzia della sicurezza nella produzione agroalimentare: controllo della filiera; tracciabilità e controlli. La necessità di conoscenze multidisciplinari. prodotti per la prima infanzia. Normativa. Esempi di gestione della filiera di omogeneizzati di frutta: trattamenti antiparassitari controllati, problemi connessi alla persistenza dei pesticidi, metaboliti. Controlli sui frutteti. Problemi connessi all'analisi di tracce di fitofarmaci. L'analisi dei prodotti biologici. Fitormoni. modulo tematico 2 Problematiche connesse agli allergeni, ogm e contaminazioni: - 138 - Problemi connessi agli allergeni e agli organismi geneticamente modificati: prodotti "free" e i controlli necessari. Aspetti relativi alla qualità dei prodotti alimentari; qualità organolettica, legale, nutrizionale, microbiologica. Le frodi alimentari. Alcuni approfondimenti relativi alle contaminazioni degli alimenti. Contaminazione primaria di un alimento. Problemi connessi alle micotossine. Valutazione del rischio di tossinfezioni alimentari e piani di autocontrollo. Modulo tematico 3 Aspetti normativi: Normative generali: additivi, aromi, allergeni, ogm, contaminanti, etichetattura, etichettatura nutrizionale, claims nutrizionali. Normative specifiche: confetture e marmellate, nettari e succhi di frutta. Modulo tematico 4 Organizzazione dei controlli nell'industria alimentare: I controlli di produzione. La necessità di controlli rapidi. Ottimizzazione dei processi produttivi. I controlli nel laboratorio CQ. Controllo di qualità in produzione e in laboratorio .Come si scrive una specifica tecnica di una materia prima agroalimentare. La valutazione delle materie prime.. I controlli nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie. Modulo tematico 5 Principali tecnologie di trasformazione, prodotti, organizzazione dei controlli di qualità e di produzione: i principali processi di trasformazione e conservazione e le analisi necessarie al controllo del processo produttivo. Produzioni asettiche: controllo dell'asetticità del prodotto e della sterilità degli impianti. Problemi connessi al re inquinamento degli impianti. Esempi: processo produzioni puree di frutta, succhi frutta, confetture; processo produzione vegetali disidratati; processo produzione yoghurt. Modulo tematico 6 Ricerca e sviluppo nell'industria alimentare: innovazione di prodotto e di processo. Nuove tecnologie: processi di sterilizzazione a bassa temperatura. L'alta pressione idrostatica. Le fasi dello sviluppo di un nuovo alimento. Controlli Shelf life. Modulo tematico 7 L'acqua nell'industria alimentare: caratteristiche dell'acqua per necessità tecnologiche; acqua a contatto dell'alimento. Influenza dell'acqua sulle caratteristiche degli alimenti. Processi di conservazione legati alla riduzione del - 139 - contenuto di acqua. Aw. Isoterme di assorbimento e desorbimento di umidità. Intermediate moisture foods. Modulo tematico 8 Il colore dei prodotti alimentari: l'analisi del colore. I metodi e le strumentazioni utilizzate nelle industrie alimentari. Esempi: analisi del colore di succhi di frutta, vegetali disidratati, prodotti carnei, farine, prodotti da forno, confetture e caramelle … Nuove tecniche di Image analysis. Approfondimenti di laboratorio 1 Nettari e succhi di frutta, loro ingredienti, puree di frutta, zuccheri: Valutazione degli ingredienti di base: puree di frutta, zucchero e sciroppi di glucosio, additivi. Valutazione di prodotti di mercato. Formulazione teorica di un succo di frutta. Suddivisione in gruppi di lavoro e realizzazione di alcuni campioni di prodotti, analisi, valutazioni qualitative Approfondimenti di laboratorio 2 Frutta disidratata, liofilizzati di frutta: Valutazione di prodotti di mercato Frutta in povere disidratata e liofilizzata, ingredienti, additivi Frutta disidratata in pezzi, ingredienti, additivi Suddivisione in gruppi di lavoro e esecuzione di test applicativi e di valutazione della qualità dei prodotti Approfondimenti di laboratorio 3 Derivati del pomodoro, verdure disidratate: Valutazione di prodotti di mercato Concentrati di pomodoro Altri derivati Ingredienti, additivi Suddivisione in gruppi di lavoro e esecuzione di test applicativi e di valutazione della qualità dei prodotti Approfondimenti di laboratorio 4 Nuove tecniche di analisi del colore: Esempi con strumentazione di image analysis Preparazione di campioni Acquisizione delle immagini Elaborazione dei dati Calcolo di differenze di colore nella spazio colore Lab Esempi applicativi - 140 - English The topics of the program belong to the "Quality and Security" area. 60 hours total Theme Module 1 Security in agro-industrial production: traceability and controls: quality assurance; health security. Healthiness of a food. Ensuring security in agro-industrial production: control of the supply chain; traceability and controls. Need for multidisciplinary knowledge. Products for early childhood. Regulations. Examples of supply chain management. Homogenized fruit: controlled pesticide treatments, problems connected with the persistence of pesticides and metabolites. Controls on orchards. Problems connected with the analysis of traces of pesticides. Analysis of organic products. Phytohormones. Theme Module 2 Issues related to allergens, GMOs and contamination: Problems related to allergens and genetically modified organisms: products "free" and necessary controls. Aspects connected with the quality of food; organoleptic, legal, nutritional and microbiological quality. Food fraud. Some insights pertaining to contamination of foods. Primary contamination of food. Problems related to mycotoxins. Assessing the risk of food poisoning and self-control plans. Theme Module 3 Regulatory aspects: General requirements: additives, flavors, allergens, GMOs, contaminants, labeling, nutrition labeling, nutritional claims. Specific regulations: jams and marmalades, fruit juices and nectars. Theme Module 4 Organization of checks and controls in the food industry: Production controls. Need for quick checks. Optimization of production processes. Controls in QC laboratory. Quality control during production and in laboratory. How to write a technical specification for an agro-industrial raw material. Evaluation of raw materials. Controls in the development of new products and technologies. Theme Module 5 Main processing technologies, products, organization of quality and production controls: main processes of transformation and preservation and analyses necessary to control the production process. Aseptic production: check of product asepticity and sterility of the plants. Problems related to repollution of the plants. Examples: productions process: fruit purees, fruit juices, jams; production process: dehydrated vegetables; yoghurt production process. Theme Module 6 - 141 - Research and development in the food industry: product and process innovation. New technologies: sterilization processes at low temperature. High hydrostatic pressure. Development phases of a new food. Shelf life controls. Theme Module 7 Water in the food industry: characteristics of the water for technological needs; water in contact with food. Influence of water on characteristics of foods. Preservation processes related to the reduction of water content. Aw. Moisture adsorption and desorption isotherms. Intermediate moisture foods. Theme module 8 The color of food products: color analysis. Methods and equipment used in the food industry. Examples: color analysis of fruit juices, dehydrated vegetables, meat products, flours, baked goods, jams and candies ... New techniques of Image analysis. Laboratory in-depth analysis 1 Fruit nectars and fruit juices, their ingredients, fruit puree, sugars: Evaluation of basic ingredients: fruit puree, sugar and glucose syrups, additives. Assessment of market products. Theoretical formulation of a fruit juice. Division of the students into working groups and creation of some product samples, analysis, qualitative assessments. Laboratory in-depth analysis 2 Dehydrated fruit, freeze-dried fruit: Assessment of market products. Dehydrated and freeze-dried powder fruit, ingredients, additives. Dehydrated fruit pieces, ingredients, additives. Division of the students into working groups and execution of application tests and evaluation of the quality of the products. Laboratory in-depth analysis 3 Tomato derivatives, dehydrated vegetables: Assessment of market products. Tomato pastes. Other derivatives. Ingredients, additives. Division of the students into working groups and execution of application tests and evaluation of the quality of the products. Laboratory in-depth analysis 4 New techniques for color analysis: Examples with image analysis instrumentation. Preparation of samples. Image acquisition. Data processing. Calculation of color differences in the Lab color space. Application of examples. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Materiale preparato dal docente - 142 - English Training documentation prepared by the teacher NOTA Italiano sede dell'insegnamento: Cuneo English based study: Cuneo Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9q2r - 143 - Approfondimenti di entomologia (Anno Accademico 2015/2016) ADVANCED GRAPEVINE ENTOMOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0608 Docente: Prof. Alberto ALMA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708534, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscenze di morfologia e di bio-etologia concernenti gli insetti (indigeni ed esotici) dannosi alla vite. Competenze sulle strategie di difesa e sui metodi alternativi all'uso dei prodotti chimici, quali lotta preventiva basata su principi ecologici, lotta naturale con ruolo di siepi e incolti, lotta biologica e lotta integrata, controllo simbiotico. English The aim is to provide knowledge of morphology and bio-ethology concerning insects (indigenous and exotic) damaging grapevine. Expertise on defense strategies and alternative methods to the use of chemicals, such as preventive control based on ecological principles, natural control with the role of hedges and uncultivated lands, biological control and integrated pest management, symbiotic control. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti dovranno essere in grado, attraverso le competenze fornite dal corso, di riconoscere le più importanti specie d'insetti, indigeni ed esotici di temuta introduzione, che causano danno diretto e trasmetto agenti eziologici di malattie d'interesse economico alla vite. Essere in grado di valutare l'influenza dell'ambiente sull'epidemiologia e impostare adeguate strategie di difesa, con particolare riguardo alle tecniche a basso impatto ambientale. English The students should be able, through the skills provided by the course, to recognize the most important species of insects, indigenous and exotic, with a high risk of introduction, which cause direct damage and transmit etiologic agents of diseases of economic interest to grapevine. They should be able to evaluate the influence of the environment on the epidemiology, and set up appropriate defense strategies, with particular emphasis on - 144 - techniques with a low environmental impact. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 24ore di lezione frontale e 16 ore dedicate ad attività di laboratorio e in vigneto. A fine corso sarà effettuata una uscita didattica in aziende viticole piemontesi. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni PowerPoint che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 24 hours of lectures and 16 hours devoted to laboratory and vineyard activities. At the end of the course, there will be an educational trip to wine-producing farms of Piedmont. For the lectures, the teacher makes use of PowerPoint presentations that are available to the students and articles for critical readings. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine dellelezioni frontali il docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica attraverso domande orali sui principali argomenti svolti, al fine di evidenziare gli eventuali problemi di apprendimento. Il colloquio non ha valore per la valutazione finale, ma è utile allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale con domande sugli argomenti trattati e sulle attività di campo e di laboratorio svolte durante le esercitazioni. Il colloquio ha il fine di verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English At the end of the lectures the teacher will conduct a test of the teaching efficacy through oral questions on the main arguments in order to highlight any learning problem. The interview has no value for the final evaluation, but it is helpful to the student to estimate the learning level. The final exam is an oral exam with questions on the topics discussed and on the field and laboratory activities carried out during the training. The interview aims to verify the capacity of reasoning and connecting the knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e qualità dell'uva. Presentazione del corso e modalità d'esame. Parte generale L'agroecosistema vigneto e gli insetti. Ecologia, etologia e cicli biologici. Rapporti tra fitofagi, piante ospiti spontanee e vite. Processi di nutrizione. Sintomatologia. Cause che favoriscono le pullulazioni dei fitofagi. Campionamento delle popolazioni. Trasmissioni di agenti fitopatogeni quali, virus, fitoplasmi e batteri. Rapporti tra agenti patogeni e vettori. Insetti di temuta introduzione. - 145 - Lotta integrata. Biotecnologie. Biocontrollo attraverso l'impiego dei simbionti. Parte speciale Sistematica degli Hemiptera. Insetti fitomizi e fitofagi. Esercitazioni Le attività saranno svolte in laboratorio e in campo. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of grape cultivation and quality. Presentation of the course and the examination General Section The vineyard agro-ecosystem and insects. Ecology, ethology and biological cycles. Relations between pests, wild host plants and grapevine. Nutrition processes. Symptomatology. Causes that may favour pest outbreaks. Sampling of populations. Transmission of plant pathogens, such as viruses, phytoplasmas and bacteria. Relationships between pathogens and vectors. Insects with a high risk of introduction. Integrated pest management. Biotechnology. Biocontrol by using symbionts. Special Section Systematic of Hemiptera. Plant-sucking and plant-chewing insects. Training The activities will be carried out in the laboratory and in the field. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Articoli scientifici e materiale didattico (presentazioni PowerPoint) fornito dal docente verranno caricati sulla piattaforma CampusNet. English The recommended basic texts for the course are: Scientific papers and materials (PowerPoint presentations) provided by the teacher will be loaded on the platform CampusNet. NOTA - 146 - Italiano Il corso si svolge nella sede di Asti. English The location of the course is Asti. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1nre - 147 - Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) INSIGHTS INTO GRAPEVINE PATHOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0627 Docente: Dott. Vanda Assunta PROTA (Affidamento esterno) Contatti docente: +39.079 229315, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Patologia della vite OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti conoscenze sulle più diffuse ampelopatie sistemiche in vivaio e pieno campo; dare loror insegnamenti sulle metodiche di miglioramento sanitario, sulla selezione sanitaria ed il risanamento, è far acquisire agli studenti pratiche di campo e di laboratorio per lavorare in autonomia; in tal senso si lavorerà col docente migliortando le loro conoscenze in tal senso curando aspetti paritcolario di questi patogeni quali: sintomatologia, diagnosi, epidemiologia, lotta preventiva e risanamento. Gli studenti acquisiranno in laboratorio tecniche diagnostiche per migliorare lo sato sanitario applicando i metodi di selezione sanitariae di risanamento tramite espianto meristematico valido ica per l'eradicazione dei virus della vite. English Give to the students knowledges aboute the most widespread grapevine sistemic diseases in nursery and in field and give them the knowledge to improve the sanitary status, with the sanitary selection methods, and to recover the grapevine by meristem culture. Students improve their practical knowledge regarding the most widespread grapevine systemic disease and the course provides them concepts about major pathogen agents, as phytovirus, phytoplasmas and their disease patterns. Further, field aspects will consist in: symptomathology, diagnosis, epidemiology, preliminary control and sanitation. In the laboratory students will exercise diagnostic techniques in order to improve crop sanitary status applying the sanitary selection method and to recover grapevines by meristem culture. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano - 148 - Lo studente dovrà raggiungere delle solide conoscenze scientifiche, con buona padronanza dei metodi scientifici, e capacità di comprensione di problematiche legate alle ampelopatie (malattie dela vite) ed alla protezione integrata. English The student will have to gain a solid scientific knowledge and be able to use scientific methods, to be able to understand the problems connected to the grapevine diseases and the integrated plant protection . MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano In accordo con gli studenti a fine corso ci sarà una verifica con prova orale sui principali dei concetti trattati English In students agreement a final oral exam will evaluate the comprehension of the main concepts of the course ESAME ORALE ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Sarà approfondito lo studio dei sintomi, che verranno poi osservati direttamente in campo dagli stessi studenti, dell'epidemiologia (trasmissione per materiale di propagazione, per vettori etc.), dell'eziologia. Si lavorerà, in laboratorio, seguendo i protocolli operativi per una corretta diagnosi eziologica, indispensabile, negli iter di certificazione sanitaria. Verranno anche eseguiti espianti meristematici per il risanamento da entità virali. Si eseguirà un monitoraggio dei vettori. Si imposterà un piano di difesa anticrittogamica in base all'andamento climatico e fenologico. English Deepening in symptomatology, etiology, epidemiology and crop protection. Monitoring in the field will provide a practical idea of field diagnosy, latency and recovery phenomenons. Futher, students will exercise in laboratory diagnostic techniques in order to detect the most dangerous grapevine pathogens (phytovirus and phytoplasmas) and their vectors. Meristem tip culture aimed to recover grapevine and eradicate virus agents will be acquired. Development of a disease control plan depending on weather and fenology. PROGRAMMA Italiano Verranno ripresi argomento generali sulle principali affezioni descritte nel corso di Patologia viticola, in particolare su agenti responsabili di virosi e fitoplasmosi; sarà approfondito lo studio dei sintomi, che verranno poi osservati direttamente in campo dagli stessi studenti, dell'epidemiologia (trasmissione per materiale di propagazione, per - 149 - vettori etc.), dell'eziologia. Si parlerà di selezione sanitaria e clonale. Si lavorerà, in laboratorio, seguendo i protocolli operativi per una corretta diagnosi eziologica, indispensabile, negli iter di certificazione sanitaria. Verranno descritte ed applicate le tecniche più in uso per l'identificazione dei patogeni sistemici, alle quali gli studenti, parteciperanno attivamente. Si riprenderanno nozioni di contenimento delle affezioni in esame: prevenzione e miglioramento sanitario; verranno anche eseguiti espianti meristematici per il risanamento da entità virali. Si eseguirà un monitoraggio dei vettori. Si imposterà un piano di difesa anticrittogamica in base all'andamento climatico e fenologico. English General information about the grapevine sanitary status, specific information on systemic diseases (viruses and phytoplasmas diseases) and deepening in symptomatology, etiology, epidemiology and crop protection. Monitoring in the field will provide a practical idea of field diagnosy, latency and recovery phenomenons. Futher, students will exercise in laboratory diagnostic techniques in order to detect the most dangerous grapevine pathogens (phytovirus and phytoplasmas) and their vectors. Meristem tip culture aimed to recover grapevine and eradicate virus agents will be acquired. Development of a disease control plan depending on weather and fenology. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Presentazioni in PowerPoint degli argomenti trattati durante le lezione e delle immagini più significative delle più importanti affezioni descritte. - G. Belli. Elementi di Patologia vegetale, Piccin Ed., Padova, 2007. English - PowerPoint presentations of the main topics will be provide to students, focusing on images of the general notions of the course and of the most important disease simptoms. - G. Belli. Elementi di Patologia vegetale, Piccin Ed., Padova, 2007. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q2l1 - 150 - Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) ADVANCED GRAPEVINE PATHOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0608 Docente: Prof. Piero Attilio BIANCO (Affidamento interno) Contatti docente: 02 250316794, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PROPEDEUTICO A nessun esame OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Apprendere le modalità con le quali le ampelopatie causano danni alla produzione e utilizzare gli strumenti più idonei a prevenirne l'insorgenza e a contenerne la diffusione, attraverso programmi di gestione integrata. English To learn how the disease causes crop loss and how to prevent its early event and spread applying suitable integrated pest management programs. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza delle malattie della vite, dei patogeni che le causano e delle modalità di diffusione in vigneto. Riconoscimento dei sintomi e applicazione delle principali tecniche diagnostiche per l'identificazione dei patogeni della vite English Knowledge of grapevine diseases, of their causal agents and their pattern of spread in vineyards. To recognise the - 151 - disease symptoms and to apply the diagnostic techniques for identification of the pathogens of grapevine MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame orale English Oral examination Orale ATTIVITÀ DI SUPPORTO riconoscimento visivo delle sintomatologia della principali malattie della vite PROGRAMMA Italiano Le malattie della vite: ripresa delle principali ampelopatie con particolare riferimento a quelle di carattere epidemico. La selezione sanitaria della vite e sua importanza per il settore vivaistico. La diagnostica fitopatologica e le principali innovazioni tecnologiche (sierologiche e molecolari) nella individuazione e caratterizzazione dei patogeni della vite. Nuove acquisizioni sul controllo e la gestione delle malattie fungine: i modelli matematici e le loro applicazioni nella gestione delle malattie della vite. Nuove acquisizioni sul controllo e la gestione delle malattie: le nuove tecnologie in materia di prevenzione delle malattie e utilizzo di principi attivi a contenuto impatto ambientale. English The diseases of grapevine: a review of the main maladies of grapevine and in particular for those with epidemic pattern. The sanitary selection of grapevine and its importance for the nursery industry. The plant pathogen detection e the main innovations in serology and molecular biology for identification and characterization of grapevine pathogens. Novel achievements for the containment and the management of the fungal diseases: the expert systems and their use for the disease management. Novel achievements for the containment and the management of the diseases: new technologies and regulation - 152 - protocols for the disease prevention and use of chemicals of lower impact for the environment. Italiano elementi di gestione delle malattie della vite English elements of grapevine disease management TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Belli G. 2011. Elementi di Patologia Vegetale, Piccin editore -Articoli e rassegne su diversi argomenti concernenti il Corso fornite dal docente English - Belli G. 2011. Elementi di Patologia Vegetale, Piccin editor - Supplied review and articles concerning the topics of the course. NOTA Italiano English Mutuato da: nessun esame Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mf6d - 153 - Approvvigionamento dei prodotti di origine animale per la ristorazione (Anno Accademico 2015/2016) SUPPLY AND SAFETY OF ANIMAL FOOD Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0336 Docente: Prof. Alberto Brugiapaglia (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708573, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 3° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente le conoscenze relative alla tipologia di produzione degli animali di interesse zootecnico, all'approvvigionamento degli alimenti di origine animale, alle loro caratteristiche merceologiche e qualitative, all'industria di trasformazione e conservazione, alla relazione tra fattori produttivi e qualità dei prodotti. Il corso ha anche lo scopo di fornire allo studente le conoscenze necessarie per valutare la qualità degli alimenti di origine animale mediante analisi strumentali e sensoriali. English The course will provide students the basic knowledge in livestock productions, supply of foods of animal origin, quality characteristics of foods of animal origin, marketing and industry of foods of animal origin. The course will also provide students the analytical methods useful to assess the quality of foods of animal origin. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente al termine del corso avrà acquisito le conoscenze di base relative all'allevamento ed alle caratteristiche produttive degli animali di interesse zootecnico, all'approvvigionamento, alla conservazione e trasformazione dei prodotti e alla qualità degli alimenti di origine animale. Lo studente dovrà inoltre conoscere i metodi di valutazione della qualità dei prodotti di origine animale. English - 154 - After finishing the course, students are expected to know the basic knowledge in livestock productions, supply and processing of foods of animal origin and quality characteristics of foods of animal origin. The student must also know the methods useful to assess the quality of foods of animal origin. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate ad esercitazioni e visite presso le industrie alimentari. Per le lezioni frontali il docente si avvarrà di presentazioni PowerPoint. Il materiale didattico proiettato sarà reso disponibile su carta. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours of laboratory works and in study visits to food of animal origin industries. For lectures the teacher will use PowerPoint presentations. Students will be provided with a hard copy of all slides. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante un'interazione continua con gli studenti durante le lezioni ed attraverso un riesame critico dei temi trattati. L'esame è orale e consiste nel somministrare al candidato tre domande dirette a verificarne, oltre alla preparazione, la capacità di gestione/risoluzione di problemi connessi alla qualità degli alimenti di origine animale. English The knowledge acquired by the students will be assessed through the continuous interaction between students and Lecturer during lectures and by critical re-examination of the considered topics. In the oral examination students are expected to answer three questions related to quality problems of foods of animal origin and how to prevent/solve them. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Presentazioni in PowerPoint, Filmati, Articoli di riviste scientifiche, Libri di testo. English Power Point Slides, Films, Scientific Publications, Recommended Books. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del corso si inseriscono nell'area di apprendimento qualità e sicurezza dei prodotti di origine animale e hanno collegamenti con altre discipline dell'area. L'approvvigionamento dei prodotti di origine animale. Il consumo degli alimenti di origine animale. La produzione e la commercializzazione degli alimenti di origine animale. Le fonti dell'approvvigionamento: allevamenti (bovini, ovicaprini, suini, avicoli e cunicoli). Le filiere produttive degli alimenti di origine animale. La carne bovina, ovina, - 155 - caprina, suina e avicunicola. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica della carne. Industria delle carni. Classificazione delle carcasse e delle carni. Conservazione della carne. Industria salumiera. Il latte bovino e ovicaprino. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica del latte. Risanamento e trattamenti tecnologici del latte. Industria lattiero casearia. I prodotti del caseificio. Il pesce e i prodotti ittici. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica dei prodotti della pesca. Conservazione e trasformazione dei prodotti ittici. Le uova e gli ovoprodotti. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica delle uova. Conservazione e trasformazione delle uova. Il miele e i prodotti dell'alveare. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica del miele e dei prodotti dell'alveare. Legislazione degli alimenti di origine animale. Valutazione della qualità degli alimenti di origine alimentare. Analisi strumentali e sensoriali dei prodotti di origine animale. English The topics of the course are part of quality and safety of foods of animal origin and are linked to other subjects of the area. Supply of foods of animal origin. Consumption of foods of animal origin. Production and marketing of foods of animal origin. Foods of animal origin supply chains. Livestock supply: cattle, sheep, goat, pigs, poultry and rabbits. Nutritional, organoleptic and technological qualities of meat (beef, lamb, goat, pork, poultry and rabbit). Meat and meat products industry. Beef, lamb and pork carcass grading and meat cuts. Meat storage. Cow, sheep and goat milk. Nutritional, technological and organoleptic qualities of milk. Milk treatments. Milk and dairy products industry. Fish and fish products. Nutritional, technological and organoleptic qualities of fish and fish products. Fish and fish products storage and processing. Eggs and egg products. Nutritional, technological and organoleptic qualities of eggs. Eggs storage and processing. Honey and hive products quality. Nutritional, technological and organoleptic qualities of honey and hive products. Foods of animal origin laws and marketing regulations. Quality evaluation of foods of animal origin. Instrumental and sensory analysis of foods of animal origin. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Warriss P.D. Meat Science, CABI Publishing, Wallingford, UK, 2000. Lawrie R.A. Scienza della carne, Edagricole, Bologna, 1983. Corradini C. Chimica e tecnologia del latte, Tecniche Nuove, Milano, 1995. Alais C. Scienza del latte. Tecniche Nuove, Milano 1988. Sauver B. Reproduction des volailles et production doeufs. INRA, 1988.Hus H. Quality and quality changes in fresh fish. FAO, Rome, 1995. Persano Oddo L., Piana L., Sabatini A.G. Conoscere il miele. Guida all'analisi sensoriale. Avenue Media Bologna, 1995. Cabras P., Tuberoso C.I.G. Analisi dei prodotti alimentari. Piccin, Padova, 2014. Società Italiana di Scienze Sensoriali. Atlante sensoriale dei prodotti alimentari. Tecniche Nuove, Milano, 2012. Il materiale didattico proiettato sarà reso disponibile su carta. English Warriss P.D., Meat Science, CABI Publishing, Wallingford, UK, 2000. Lawrie R.A., Scienza della carne, Edagricole, Bologna, 1983. Corradini C., Chimica e tecnologia del latte, Tecniche Nuove, Milano, 1995. - 156 - Alais C. Scienza del latte. Tecniche Nuove, Milano 1988. Sauver B. Reproduction des volailles et production doeufs. INRA, 1988. Hus H. Quality and quality changes in fresh fish. FAO, Rome, 1995. Persano Oddo L., Piana L., Sabatini A.G. Conoscere il miele. Guida all'analisi sensoriale. Avenue Media, Bologna, 1995. Cabras P., Tuberoso C.I.G. Analisi dei prodotti alimentari. Piccin, Padova, 2014. Società Italiana di Scienze Sensoriali. Atlante sensoriale dei prodotti alimentari. Tecniche Nuove, Milano, 2012. PowerPoint lessons will be provided as a hard copy. NOTA Italiano Il corso si svolge a Grugliasco. English The location of the course is Grugliasco. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g2bo - 157 - Approvvigionamento, qualità e trasformazione dei prodotti di origine animale (Anno Accademico 2015/2016) SUPPLY, QUALITY AND PROCESSING OF ANIMAL PRODUCTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0313 Docente: Prof. Alberto Brugiapaglia (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708573, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente gli elementi necessari per la conoscenza degli aspetti connessi con l'approvvigionamento, l'industria di trasformazione, la qualità e la valutazione della qualità degli alimenti di origine animale, nonché dei fattori di filiera che influenzano la qualità dei prodotti. English Students are required to study in depth the supply chain of foods of animal origin, the quality and quality evaluation of the foods of animal origin, as well as the factors influencing the products quality. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente al termine del corso avrà acquisito le conoscenze necessarie per affrontare criticamente i problemi riguardanti l'approvvigionamento, l'industria di trasformazione e di conservazione, la qualità e la valutazione della qualità degli alimenti di origine animale. English After finishing the course, students are expected to critically analyse the problems concerning the supply chain of foods of animal origin, the foods conservation and processing industry, the quality and quality evaluation of the foods of animal origin. - 158 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate ad esercitazioni e visite presso le industrie alimentari. Per le lezioni frontali il docente si avvarrà di presentazioni PowerPoint. Il materiale didattico proiettato sarà reso disponibile su carta. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours of laboratory works and in study visits to food of animal origin industries. For lectures the teacher will use of PowerPoint presentations. Students will be provided with a hard copy of all slides. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante un'interazione continua con gli studenti durante le lezioni ed attraverso un riesame critico dei temi trattati. L'esame è orale e consiste nel somministrare al candidato tre domande dirette a verificarne, oltre alla preparazione, la capacità di gestione/risoluzione di problemi connessi alla qualità degli alimenti di origine animale. English The knowledge acquired by the students will be assessed through the continuous interaction between students and Lecturer during lectures and by a critical re-examination of the considered topics. In the oral examination students are expected to answer three questions related to quality problems of foods of animal origin and how to prevent/solve them. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Presentazioni in PowerPoint, Filmati, Articoli di riviste scientifiche, Libri di testo. English Power Point Slides, Films, Scientific Publications, Recommended Books. PROGRAMMA Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento delle produzioni animali ed hanno collegamenti con altre discipline dell'area. Richiedono conoscenze nelle discipline di base. L'approvvigionamento dei prodotti di origine animale. La produzione, la commercializzazione ed il consumo degli alimenti di origine animale. Le filiere produttive degli alimenti di origine animale. La carne bovina, ovina, caprina, suina e avicunicola. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica della carne. Fattori ante e post-mortem che influenzano la qualità della carne. Industria delle carni. Tecniche di macellazione. Classificazione delle carcasse e delle carni. Conservazione e trasformazione della carne. Tecniche di confezionamento. Industria salumiera. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti carnei. Il latte bovino e ovicaprino. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica del latte. Fattori endogeni ed esogeni che influenzano la qualità del latte. Industria lattiero casearia. Risanamento e trattamenti tecnologici del latte. I prodotti del caseificio. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti lattiero caseari. Il pesce e i prodotti ittici. Qualità - 159 - nutrizionale, tecnologica e organolettica dei prodotti della pesca. Fattori che influenzano la composizione e la qualità dei prodotti ittici provenienti da attività di pesca o di allevamento. Conservazione e trasformazione dei prodotti ittici. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici. Le uova e gli ovoprodotti. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica delle uova. Fattori che influenzano la qualità delle uova. Conservazione e trasformazione delle uova. Tracciabilità ed etichettatura delle uova. Il miele e i prodotti dell'alveare. Qualità nutrizionale, tecnologica e organolettica del miele e dei prodotti dell'alveare. Fattori che influenzano la composizione e la qualità del miele. Etichettatura e commercializzazione del miele. Disposizioni legislative che regolano la produzione. Valutazione della qualità degli alimenti di origine alimentare. Analisi strumentali e sensoriali dei prodotti di origine animale. English The topics of the course are part of the area of animal production and are linked to the other topics of the area. They require knowledge of the preparatory courses. Foods of animal origin supply chains. Production, market and consumption of food of animal origin. Meat and meat products. Nutritional, organoleptic and technological qualities of meat (beef, lamb, goat, pork, poultry and rabbit). Ante-mortem and post-mortem factors that affect meat quality. Meat and meat products industry. Slaughter techniques. Beef, lamb and pork carcass grading and meat cuts. Meat storage and preservation. Traceability and labeling system of meat. Cow, sheep and goat milk. Nutritional, technological and organoleptic qualities of milk. Endogenous and exogenous factors that affect milk quality. Milk and dairy products industry. Milk preservation. Traceability and labeling system of milk. Fish and fish products. Nutritional, technological and organoleptic qualities of fish and fish products. Factors affecting fish composition and fish quality from fishing or farming. Fish and fish products storage and processing. Seafood industry. Traceability and labeling system of fish. Eggs and egg products. Nutritional, technological and organoleptic qualities of eggs. Factors affecting egg quality. Eggs storage and processing. Traceability and labeling system of eggs. Honey and hive products. Nutritional, technological and organoleptic qualities of honey and hive products. Factors influencing honey composition and quality. Foods of animal origin laws and marketing regulations. Quality evaluation of foods of animal origin. Instrumental and sensory analysis of foods of animal origin. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Warriss P.D. Meat Science, CABI Publishing, Wallingford, UK, 2000. Lawrie R.A. Scienza della carne, Edagricole, Bologna, 1983. Kerry J., Kerry J., Ledward D. Meat processing, CRC Press, 2005. Corradini C. Chimica e tecnologia del latte, Tecniche Nuove, Milano, 1995. Alais C. Scienza del latte. Tecniche Nuove, Milano 1988. Sauver B. Reproduction des volailles et production doeufs. INRA, 1988. Hus H. Quality and quality changes in fresh fish. FAO, Rome, 1995. Persano Oddo L., Piana L., Sabatini A.G. Conoscere il miele. Guida all'analisi sensoriale. Avenue Media Bologna, 1995. Cabras P., Tuberoso C.I.G. Analisi dei prodotti alimentari. Piccin, Padova, 2014. Società Italiana di Scienze Sensoriali. Atlante sensoriale dei prodotti alimentari. Tecniche Nuove, Milano, 2012. Il materiale didattico proiettato sarà reso disponibile su carta. - 160 - English Warriss P.D., Meat Science, CABI Publishing, Wallingford, UK, 2000. Lawrie R.A., Scienza della carne, Edagricole, Bologna, 1983. Kerry J., Kerry J., Ledward D. Meat processing, CRC Press, 2005. Corradini C., Chimica e tecnologia del latte, Tecniche Nuove, Milano, 1995. Alais C. Scienza del latte. Tecniche Nuove, Milano 1988. Sauver B. Reproduction des volailles et production doeufs. INRA, 1988. Hus H. Quality and quality changes in fresh fish. FAO, Rome, 1995. Persano Oddo L., Piana L., Sabatini A.G. Conoscere il miele. Guida all'analisi sensoriale. Avenue Media, Bologna, 1995. Cabras P., Tuberoso C.I.G. Analisi dei prodotti alimentari. Piccin, Padova, 2014. Società Italiana di Scienze Sensoriali. Atlante sensoriale dei prodotti alimentari. Tecniche Nuove, Milano, 2012. PowerPoint lessons will be provided as a hard copy. NOTA Italiano Il corso si svolge presso la sede di Grugliasco. English The location of the course is Grugliasco. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fcml - 161 - Arboricoltura (Anno Accademico 2015/2016) ARBORICULTURE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0113 Docente: Prof. Cristiana PEANO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708660, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Illustrare i principali scenari, le problematiche e il ruolo dell'arboricoltura a livello internazionale e locale. Fare conoscere le influenze reciproche e le relazioni tra colture arboree e ambiente. Fornire le basi scientifiche e tecniche sulla gestione dei sistemi frutticoli, con riferimento agli aspetti morfologici, fisiologici ed agronomici. Descrivere le tecniche frutticole per l'ottenimento di produzioni di qualità delle principali specie coltivate dei climi temperati. English To describe the main scenarios, problems andimportance of arboriculture at international and local level. To clear the influences and relations between arboriculture and environment. To give scientific and technical information on orchard management .To describe the main agro techniques. to obtain quality productions of fruit and nut species of the temperate zone. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscere gli scenari e le problematiche dell'arboricoltura e dei principali sistemi frutticoli. Acquisire gli elementi fondamentali di tecnica frutticola. - 162 - English To know scenarios and problems concerning arboriculture and the main orchard systems. To acquire the fundamental agrotechniques regarding fruit growing. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di laboratorio e visite sul territorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and visits. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano saranno effettuate verifiche orali. Il colloquio orale finale (esame) prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English oral tests will verify the learning process. The final evaluation will take a penalty for each question wrong. PROGRAMMA Italiano Introduzione al corso, aree geografiche di coltura delle piante arboree, statistiche nazionali e mondiali. Inquadramento agronomico, pomologico e sistematico delle specie arboree ed arbustive coltivate. Organografia. Apparato ipogeo: funzioni e sviluppo, estensione. Apparato epigeo: fusto, chioma, branche, rami, gemme, foglie, fiori e frutti. Ciclo annuale della pianta. Accrescimento dei germogli e dominanza apicale. Accrescimento e sviluppo delle piante. Stadio giovanile, adulto e di senescenza. Dormienza e fabbisogno in freddo Ciclo di fruttificazione. Induzione e differenziazione a fiore. Fecondazione. Colatura. Partenocarpia. Sterilità. Allegagione. Cascola. Accrescimento dei frutti. Climaterio e maturazione. Clima e piante arboree. Effetti di temperatura e umidità. Avversità climatiche e difesa. Suolo e piante arboree. Ruolo degli elementi minerali. Esigenze nutrizionali e idriche. Riproduzione: dormienza e germinazione dei semi; trattamenti per favorire la germinazione. Propagazione vegetativa: talea. Interventi per favorire la radicazione (mist, fog, riscaldamento basale, fitoregolatori). Propaggine e margotta. Micropropagazione. Innesto: istogenesi. Affinità e disaffinità. Influenza tra i bionti. Tipi di innesto. Cura alle piante innestate. Reinnesto. Generalità sui portinnesti. &n bsp; Tecnica colturale: impianto e gestione dell'arboreto. Vocazione ambientale. Progettazione e impianto, sesti, architettura della pianta e dell'arboreto. Fabbisogni nutritivi. Diagnostica fogliare. Fabbisogni idrici delle piante arboree. Effetti dell'acqua sulla produttività delle piante e sulla qualità dei frutti. Stress idrici. & nbsp; Principi di potatura. Tipi di potatura. Potatura di formazione e di produzione. Forme di allevamento. - 163 - Gestione del suolo. Inerbimento. Pacciamatura. Raccolta. Determinazione dell'epoca con l'uso di indici di maturazione. Tecniche di raccolta manuale, meccanica, agevolata. Conservazione del prodotto. Rosacee da frutto maggiori: melo, pero, pesco, susino, ciliegio, albicocco. Frutta secca: mandorlo, nocciolo, noce, castagno, pistacchio. Piccoli frutti: lampone, rovo, ribes, mirtillo. Fruttiferi minori Visite tecniche ad impianti specializzati. English Introduction to the course, species distribution, production areas and statistics Species and varieties: systematic Botany: physiology, flowering, pollination and fruit set, fruit growth and thinning General environment and climate Establishing the planting: spacing and layout Cultural practices: soil plant complex, nutrient availability, fertilizer practice, irrigation, mulching Plant efficiency: growth and yield Crop maturity, harvest, post harvest storage, nutritional value Species description: major pome and stone fruits Nuts: almond, hazelnut, walnut, chestnut, pistachio Berryfruit and minor fruit species Technical visits Italiano Introduzione al corso, aree geografiche di coltura delle piante arboree, statistiche nazionali e mondiali. Inquadramento agronomico, pomologico e sistematico delle specie arboree ed arbustive coltivate. Organografia. Apparato ipogeo: funzioni e sviluppo, estensione. Apparato epigeo: fusto, chioma, branche, rami, gemme, foglie, fiori e frutti. Ciclo annuale della pianta. Accrescimento dei germogli e dominanza apicale. Accrescimento e sviluppo delle piante. Stadio giovanile, adulto e di senescenza. Dormienza e fabbisogno in freddo Ciclo di fruttificazione. Induzione e differenziazione a fiore. Fecondazione. Colatura. Partenocarpia. Sterilità. Allegagione. Cascola. Accrescimento dei frutti. Climaterio e maturazione. Clima e piante arboree. Effetti di temperatura e umidità. Avversità climatiche e difesa. Suolo e piante arboree. Ruolo degli elementi minerali. Esigenze nutrizionali e idriche. Riproduzione: dormienza e germinazione dei semi; trattamenti per favorire la germinazione. Propagazione vegetativa: talea. Interventi per favorire la radicazione (mist, fog, riscaldamento basale, fitoregolatori). Propaggine e margotta. Micropropagazione. Innesto: istogenesi. Affinità e disaffinità. Influenza tra i bionti. Tipi di innesto. Cura alle piante innestate. Reinnesto. Generalità sui portinnesti. &n bsp; Tecnica colturale: impianto e gestione dell'arboreto. Vocazione ambientale. Progettazione e impianto, sesti, architettura della pianta e dell'arboreto. Fabbisogni nutritivi. Diagnostica fogliare. Fabbisogni idrici delle piante arboree. Effetti dell'acqua sulla produttività delle piante e sulla qualità dei frutti. Stress idrici. & nbsp; Principi di potatura. Tipi di potatura. Potatura di formazione e di produzione. Forme di allevamento. Gestione del suolo. Inerbimento. Pacciamatura. Raccolta. Determinazione dell'epoca con l'uso di indici di maturazione. Tecniche di raccolta manuale, meccanica, agevolata. Conservazione del prodotto. Rosacee da frutto maggiori: melo, pero, pesco, susino, ciliegio, albicocco. Frutta secca: mandorlo, nocciolo, noce, castagno, pistacchio. - 164 - Piccoli frutti: lampone, rovo, ribes, mirtillo. Fruttiferi minori Visite tecniche ad impianti specializzati. English Introduction to the course, species distribution, production areas and statistics Species and varieties: systematic Botany: physiology, flowering, pollination and fruit set, fruit growth and thinning General environment and climate Establishing the planting: spacing and layout Cultural practices: soil plant complex, nutrient availability, fertilizer practice, irrigation, mulching Plant efficiency: growth and yield Crop maturity, harvest, post harvest storage, nutritional value Species description: major pome and stone fruits Nuts: almond, hazelnut, walnut, chestnut, pistachio Berryfruit and minor fruit species Technical visits TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Baldini E. - Arboricoltura generale. Ed. Clueb,Bologna. AA., VV.- Frutticoltura generale e speciale. REDA, Roma. Rieger M. - Introduction to fruit crops. Haworth Food & Agricultural Products Press.New York,London, Oxford., 2006. Sansavini S - Nuove frontiere dell'arboricoltura italiana, 2007. Sansavini S., Costa G., Gucci R., Inglese P., Ramina A., Xiloyannis C. – Arboricoltura generale. Pàtron Editore, Bologna, 2012. Sansavini S., Ranalli P. – Manuale di ortofrutticoltura. Innovazioni tecnologiche e prospettive di mercato. Edagricole, 2012. English Baldini E. - Arboricoltura generale. Ed. Clueb,Bologna. AA., VV.- Frutticoltura generale e speciale. REDA, Roma. Rieger M. - Introduction to fruit crops. Haworth Food & Agricultural Products Press.New York,London, Oxford., 2006. Sansavini S - Nuove frontiere dell'arboricoltura italiana, 2007. Sansavini S., Costa G., Gucci R., Inglese P., Ramina A., Xiloyannis C. – Arboricoltura generale. Pàtron Editore, Bologna, 2012. Sansavini S., Ranalli P. – Manuale di ortofrutticoltura. Innovazioni tecnologiche e prospettive di mercato. Edagricole, 2012. - 165 - NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c0cb - 166 - Arboricoltura ornamentale (Anno Accademico 2015/2016) ORNAMENTAL ARBORICULTURE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0325 Docente: Prof. Gabriele Loris BECCARO (Affidamento interno) Contatti docente: 011 6708802, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le nozioni fondamentali per la scelta e la gestione delle specie arboree ornamentali, comunemente impiegate in parchi, giardini ed alberate. English To give the basic information on the choice and the agrotechniques of ornamentale tree species, commonly used in parks and gardens. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà essere in grado di riconoscere le principali specie arboree di interesse ornamentale e paesaggistico nonché il loro impiego e le loro esigenze ai fini della progettazione di parchi e giardini. English The student will learn to recognize the main ornamental tree species and their use in the planning of parks and gardens. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 167 - Italiano Didattica frontale e di campo English In-room and in-field lessons MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Saranno effettuate periodiche verifiche orali e scritte English different evaluation moments will test the efficacy of the learning PROGRAMMA Italiano Introduzione al corso Inquadramento morfologico e fisiologico delle specie arboree ed arbustive Organografia. Apparato ipogeo: funzioni e sviluppo, estensione. Apparato epigeo: fusto, chioma, branche, rami, gemme, foglie, fiori e frutti. Ciclo annuale della pianta. Dal germogliamento alla caduta delle foglie. Dormienza e fabbisogno in freddo. Accrescimento dei germogli e dominanza apicale. Accrescimento e sviluppo delle piante. Stadio giovanile, adulto e di senescenza. Piante arboree e paesaggio. Botanica sistematica delle specie arboree di interesse ornamentale Tecnica colturale Terreno e specie arboree: interpretazione delle analisi del terreno, preparazione del terreno, concimazione di fondo e di mantenimento. Esigenze idriche ed irrigazione delle piante arboree. Elementi di progettazione degli impianti irrigui. La potatura: definizioni generali e fisiologia. Modalità di esecuzione dei tagli. La potatura in ambiente urbano: latifoglie arboree decidue e sempreverdi, conifere e arbusti. Strumenti e tecniche di potatura; cestelli e tree climbing. Impiego delle specie arboree nella progettazione del verde urbano. Gli alberi in ambiente urbano: sesti d'impianto, distanze di sicurezza e gestione del suolo, interventi ordinari e straordinari di gestione, controllo della stabilità delle alberate. Gli arbusti e le siepi in ambiente urbano. Scelta e corretto utilizzo delle specie in funzione della tipologia di verde: parametri per la scelta. Cenni sulla progettazione di viali e piazzali alberati, aree verdi autostradali, arboreti. Organizzazione vivaistica e propagazione. Il materiale vivaistico. Visita a parchi e giardini. English Introduction - 168 - Morphology and physiology of trees and shrubs Organography. Roots development and functions, tree morphology. Tree life cycle. Dormancy and winter chilling requirement. Development of the plant. Trees and landscape. Botany and classification of ornamental trees. Agrotechnique. Soil/plant complex: soil analysis, field preparation, nutrient availability. Water requirement and irrigation. Pruning: definition and physiology. Tree training in the urban environment. Pruning techniques and tree climbing. The tree in the urban environment. Plantation distances, soil management, tree care. Shrubs in the urban environment. Choice of the species: parameters. Planning the tree areas into urban and periurban environment. Nursery and propagation. Visit to nurseries and growers. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano AAVV Arboricoltura generale, 532 pp. Patron Editore, Bologna, 2012 D. Giorgi. Il giardino: manuale di progettazione. Dario Flacovio Editore, Palermo, 2009 A. Toccolini. Piano e progetto di area verde. Maggioli editore, 2007. C. Vezzosi, Vivaistica ornamentale, Edagricole, Bologna, 1998. English AAVV Arboricoltura generale, 532 pp. Patron Editore, Bologna, 2012 D. Giorgi. Il giardino: manuale di progettazione. Dario Flacovio Editore, Palermo, 2009 A. Toccolini. Piano e progetto di area verde. Maggioli editore, 2007. C. Vezzosi, Vivaistica ornamentale, Edagricole, Bologna, 1998. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ymo1 - 169 - Aspetti applicativi delle biotecnologie vegetali (Anno Accademico 2015/2016) Applied plant biotechnologies Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0520 Docente: Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708800, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente conoscenze sui principali aspetti applicativi delle biotecnologie con particolare riferimento al miglioramento genetico e allo studio delle specie arboree da frutto. Fornire allo studente conoscenze sulle basi genetiche di caratteri di interesse e delle principali strategie biotecnologiche per ottenere piante con caratteri migliorati. English To provide knowledge on the main practical aspects of biotechnologies with particular attention to breeding and studying fruit and nut crops. To provide knowledge on the genetic bases of traits of interest and of the main strategies to obtain plants with improved characters. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenze sulle applicazioni delle biotecnologie al miglioramento genetico e allo studio delle specie vegetali con particolare riferimento a quelle arboree da frutto English Knowledge on the application of biotechnologies to breeding and study of plant species with particular attention to fruit and nut tree species - 170 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Tradizionale English Traditional MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame sarà orale e prevede in linea di massima 3 domande su argomenti diversi; il docente potrà fare ulteriori domande qualora questo fosse necessario per la miglior valutazione della preparazione dello studente. Ogni domanda avrà uguale peso ai fini della formazione del voto finale. English Oral test. As general rule the exam is based on 3 questions on different arguments; the teacher may ask further questions in case this is considered necessary for the most appropriate evaluation of the student. Each question will have the same weight for the attribution of the final mark. PROGRAMMA Italiano Il corso fa interamente riferimento all'Area Formativa Biotecnologica Introduzione alla materia: principali applicazioni, sviluppi e prospettive delle biotecnologie per le specie arboree da frutto. Le tecniche di coltura in vitro: principi generali, micropropagazione, morfogenesi in vitro, coltura di protoplasti, fusione somatica, ottenimento di aploidi. Interesse applicativo di queste tecniche. La trasformazione genetica nelle piante arboree da frutto, sintesi delle tecniche. Applicazioni biotecnologiche dei marcatori molecolari: caratterizzazione genetica di cultivar, specie e cloni; riconoscimento varietale e delle produzioni; realizzazione di mappe; selezione assistita con marcatori (MAS). Basi genetiche e modificazioni dell'habitus vegeto-produttivo della pianta; interventi per modificare le dimensioni della pianta e la rizogenesi. Conoscenze genetiche sui meccanismi che portano alla fioritura e alla fruttificazione ed interventi che permettono il superamento della giovanilità e delle barriere di autoincompatibilità fiorale. Interventi per modificare il contenuto in lignina per le applicazioni industriali del legno. Strategie per favorire l'assorbimento e la traslocazione degli elementi minerali per la migliore utilizzazione delle risorse minerali e la biofortificazione. Modificazioni genetiche del sistema fotosintetico C3 e dei meccanismi di traslocazione ed accumulo dei fotosintetati per aumentare la produttività delle colture. Basi genetiche della qualità e modificazioni per migliorare le caratteristiche del frutto per quanto riguarda: profilo aromatico, contenuto in vitamina C, colore e sostanze di interesse nutraceutico, tessitura, contenuto in acidi organici e zuccheri, apirenia, imbrunimento ossidativo. Interventi per variare l'andamento della maturazione del frutto: riduzione e soppressione della sintesi di etilene. Allergeni vegetali e prospettive per la loro eliminazione tramite l'ingegneria genetica. English Main applications, developments and perspectives of fruit crops biotechnologies. - 171 - In vitro techniques and gene transfer in fruit tree species. Micropropagation, ovule and protoplast culture, somatic hybridization, obtaining aploids, morphogenesis (organogenesis, somatic embryogenesis). Applications and uses of molecular markers: genetic characterization of cultivars, species, clones; cultivar and crop identification; linkage map construction; marker assisted selection (MAS). Genetic bases and modifications of the vegetative and productive tree habit; interventions and studies for overcoming self-incompatibility and juvenility and for changing tree habit and rooting ability. Modifications of the lignin content for industrial applications. Strategies for improving the uptake and translocation of mineral elements for an optimal use of mineral resources in soil and for biofortification. Genetic engineering of the photosintetic system C3 and of mechanisms of translocation and storage of photosynthates to increase crop yield. Genetic bases of quality and modifications for improving fruit and nut quality traits: aroma, vitamin C content, pulp texture and softening, organic acids and sugars content, colour and antioxidant properties, browning aptitude, seedlessness. Genetic bases and modifications for controlling the ethylene methabolism and the ripening process. Allergenes in plants and perspectives of their elimination in food by genetic engineering. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Articoli e slides forniti del docente Altman A., Hasegawa P.M. 2012. Plant biotechnology and Agriculture. Academic Press Slater A., Scott W.N., Fowler M.R. 2008 Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants. Oxford University Press. AAVV 2012. Arboricoltura generale, Patron ed. Bologna English NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kpf3 - 172 - Aspetti normativi ed etici delle applicazioni biotecnologiche nd Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0529 Docente: Contatti docente: Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: IUS/14 - diritto dell'unione europea Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano English RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano English MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano - 173 - English PROGRAMMA Italiano English TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano English NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m4gi - 174 - Assestamento forestale e pianificazione antincendi (Anno Accademico 2015/2016) FORESTRY AND WILDFIRE MANAGEMENT Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0366 Docente: Prof. Giovanni BOVIO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705543, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/05 - assestamento forestale e selvicoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Raggiungere la competenza per realizzare la pianificazione forestale a scale diverse e la pianificazione antincendi boschivi. English Reaching the expetise to carry out forest management plans of and forest fire management plans. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Comprendere le finalità dell'assestamento forestale.Applicare e collegare i criteri pianificatori assestamentali e antincendio in un contesto di area vasta regionale, territoriale e aziendale. Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per l'elaborazione e l'applicazione dei diversi strumenti di gestione forestale. Acquisire le conoscenze per l'elaborazione e l'applicazione di un piano antincendi boschivi. Applicare e collegare i criteri pianificatori assestamentali e di protezione antincendi a diverse scale territoriali English Apply the criteria and connect forest management plans MODALITA' DI INSEGNAMENTO l'insegnamento comprende 64 ore di lezione frontale e 16 ore di esercitazioni che si svolgeranno in due giorni - 175 - English The course includes 64 hours of lectures and 16 hours of exercises to be held in two days MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verifiche scritte durante il corso. L'esame è orale. Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali dell'assestamento forestale e della pianificazione antincendi. Lo studente deve quindi collegare tra loro queste due diverse attività pianificatorie. English Written test during the course. The exam is oral. The student must demonstrate that they have acquired the basic knowledge. PROGRAMMA Italiano Tutti gli argomenti del corso rientrano nelle aree di apprendimento della Gestione multifunzionale sostenibile delle risorse forestali e della Pianificazione forestale Aspetti istituzionali e caratteri dell'assestamento forestale, sue funzioni e utilità. Stato reale del bosco. Compartimentazione assestamentale. La compresa, la particella, la presa. Provvigione e incremento. Nuovi obiettivi assestamentali. Stato ideale dei boschi coetanei. Tavole alsometriche: finalità e applicazione. Incremento medio di maturità. Stato ideale dei boschi disetanei. Normalità del ceduo composto. Normalizzazione cronologica della conversione dei cedui. Ripresa e sua determinazione. Metodi planimetrici. Metodi provvigionali. Metodi colturali. Metodi combinati. Piano dei tagli e piano delle migliorie. Impostazione concettuale ed evoluzioni della pianificazione assestamentale. Influenza sulla pianificazione forestale delle politiche esterne ai tradizionali confini del settore. Gestione forestale sostenibile. Livelli di pianificazione forestale e loro rapporti reciproci. Pianificazione assestamentale aziendale. Struttura del piano di assestamento aziendale. Pianificazione forestale di area vasta. Piani forestali territoriali. Funzione multipla e approfondimenti relativi a esigenze produttive, paesaggistiche, ricreative. Impostazione concettuale della pianificazione antincendi boschivi. Caratteri ed esigenze della pianificazione in applicazione della L. 353/2000. Pianificazione antincendi boschivi di area vasta. Analisi del rischio. Struttura del piano antincendi. Piani antincendi delle aree protette. Rapporti tra pianificazione assestamentale e pianificazione antincendi. Si prevedono apposite esercitazioni in aree forestali. English All course topics cover the areas of sustainable multifunctional management of forest resources and forest planning. Valuing forest conditions. Forest management goals. Normal forest. Normal forest in coppice with standard. Sustained annual yield. Forest plan organisation. Cutting plan. Progress of forest management science. Forest planning and policy. Sustainable forest management. Different levels of forests plan. Forets plan of wide area. Multifunctional forest. Basic of fire management planning. Fire - 176 - management planning. Forets fire danger assestment. Fire management plans in protected areas. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano le slides presentate a lezione saranno a disposizione sulla piattaforma campusNet Testi consigliati BAGNARESI U., BERNETTI G., CANTIANI M., HELLRIGL B., 1986 - Nuove metodologie nell'elaborazione dei piani di assestamento dei boschi. ISEA. Bologna. CIANCIO O. (a cura di), 1996 - Il bosco e l'uomo. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze. CIANCIO O., NOCENTINI S., 2004 - Il bosco ceduo. Selvicoltura, Assestamento, Gestione. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze. CIANCIO O., 2014 - L'evoluzione del pensiero forestale. Selvicoltura Filosofia, Etica. Ed Rubbettino. CHANDLER G., CHENEY P., THOMAS P., TRABAUD L., WILLIAMS D. - 1983 - Fire in forestry. Vol 1, Vol. 2. John Wiley & Sons. NewYork. VELEZ R., 2000 – La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. Mc Graw Hill. Per approfondimenti: ONF,1996 - Manuale di assestamento. Traduzione di G. Bovio e O. la Marca.Editore Bosco e Ambiente. Frontone (Ps). JONSON E., MIYANISCHI K., 2001 – Forest fires behavior and ecological effects. Academic Press. MADRIGAL COLLAZO A., 1995 – Ordenacion de montes arbolados. ICONA. Madrid. PYNE J., ANDREWS P., 1996 -Introduction to Wildland Fire, 2nd EditionEditor: Jonh Wiley & Sons. English the slides presented during the lectures will be available on the platform campusNet Recommended texts : BAGNARESI U., BERNETTI G., CANTIANI M., HELLRIGL B., 1986 - Nuove metodologie nell'elaborazione dei piani di assestamento dei boschi. ISEA. Bologna. CIANCIO O. (a cura di), 1996 - Il bosco e l'uomo. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze. CIANCIO O., NOCENTINI S., 2004 - Il bosco ceduo. Selvicoltura, Assestamento, Gestione. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze. CIANCIO O., 2014 - L'evoluzione del pensiero forestale. Selvicoltura Filosofia, Etica. Ed Rubbettino. CHANDLER G., CHENEY P., THOMAS P., TRABAUD L., WILLIAMS D. - 1983 - Fire in forestry. Vol 1, Vol. 2. John Wiley & Sons. NewYork. VELEZ R., 2000 – La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. Mc Graw Hill. Further recommended texts ONF,1996 - Manuale di assestamento. Traduzione di G. Bovio e O. la Marca.Editore Bosco e Ambiente. Frontone (Ps). JONSON E., MIYANISCHI K., 2001 – Forest fires behavior and ecological effects. Academic Press. MADRIGAL COLLAZO A., 1995 – Ordenacion de montes arbolados. ICONA. Madrid. PYNE J., ANDREWS P., 1996 -Introduction to Wildland Fire, 2nd EditionEditor: Jonh Wiley & Sons. NOTA Italiano - 177 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l4rg - 178 - Biochimica degli Alimenti (Anno Accademico 2015/2016) FOOD BIOCHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0075 Docente: Prof. Luisella Roberta CELI Contatti docente: 0116708515, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano L'obiettivo principale è quello di fornire allo studente gli strumenti per approfondire le conoscenze sui composti biochimici di interesse alimentare, sulle principali reazioni cui sono sottoposti durante i processi di trasformazione e conservazione degli alimenti, e sui principali catabolismi e anabolismi biochimici. English This course is aimed to furnish to the students the tools for understanding the main characteristics of the biochemical compounds in food science, the main reactions that these compounds undergo during food transformation and conservation, and the main biochemical catabolisms and anabolisms RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il risultato atteso più importante è l'acquisizione di una conoscenza dei principali composti biochimici, delle loro proprietà chimico-fisiche, del loro metabolismo e della loro reattività. Lo studente acquisirà così le conoscenze necessarie per comprendere le proprietà biochimiche e nutrizionali degli alimenti. Avrà altresì la possibilità di comprendere le reazioni di degradazione e/o trasformazione dei diversi composti biochimici durante i processi di conservazione e trasformazione degli alimenti. - 179 - English The main objective is to reach a good knowledge on the main characteristics, chemical and physical properties, metabolic paths and reactivity of the biochemical compounds. The student will acquire the necessary knowledge for understanding food biochemical and nutritional properties. Moreover the student will have the possibility to learn the degradation and /or transformation reactions occurring during food processing and conservation. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso si svolgerà con lezioni frontali, lezioni interattive e esercitazioni English The course will include theoretical lectures, interactive lectures and exercises MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esercizi e test anonimo con domande a risposta multipla sugli argomenti trattati nell'ultimo periodo. Valutazione finale individuale English Exercises and anomymous test with questions and multiple choice answers on the topics presented in the last period. Final evaluation. prova scritta prova orale ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROGRAMMA Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento della qualità e sicurezza. Acqua: struttura chimica, comportamento liquido-solido, solvente, dissociazione, pH, attività e disponibilità per i - 180 - microrganismi (Qualità e Sicurezza) Chimica colloidale: sistemi colloidali, fattori che inducono alla dispersione o alla coagulazione del colloide, impiego dei colloidi nell'industria alimentare. Principali sistemi bifase (Qualità e Sicurezza) Zuccheri: Monosaccaridi, derivati ridotti e ossidati. Disaccaridi. Maltosio, lattosio, cellobiosio, trealosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, Pectine: loro proprietà, degradazione enzimatica, impiego delle pectine nell'industria degli alimenti. Potere dolcificante degli zuccheri. Impiego degli zuccheri nell'industria alimentare: saccarosio, zucchero invertito, amido (Qualità e Sicurezza) Amminoacidi: struttura molecolare e proprietà chimico-fisiche, comportamento in acqua, metodiche analitiche per il riconoscimento degli amminoacidi, legame peptidico (Formazione di base) Proteine. Principali caratteristiche delle proteine, struttura I, II, III e IV. (Formazione di base) Proprietà funzionali delle proteine degli alimenti, enzimi proteolitici, Qualità biologica delle proteine e valore proteico degli alimenti. Principali trasformazioni delle proteine in campo alimentare: Idrolisi, Denaturazione, formazione di ammine biogene, reazione di Maillard (Qualità e Sicurezza) Lipidi: Lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi, cere. Struttura e nomenclatura, grassi saturi e insaturi, irrancidimento dei lipidi, antiossidanti, idrogenazione catalitica. Lipidi non saponificabili: terpeni, eicosanoidi, steroidi (Formazione di base) Acidi nucleici: basi azotate, nucleosidi e nucleotidi. DNA e RNA (Formazione di base) Tannini: tannini idrolizzabili - tannini condensati - funzioni biologiche (Qualità e Sicurezza) Pigmenti: flavonoidi - pigmenti polifenolici e polipirrolici (Formazione di base) Vitamine: Principali vitamine, loro importanza come coenzimi, effetto del calore sulla struttura delle vitamine (Qualità e Sicurezza) Enzimi: reazioni enzimatiche, cinetica chimica e equazione di Michaelis-Menten, fattori che influenzano la velocità di reazione enzimatica, Inibitori enzimatici (Formazione di base) Imbrunimento non enzimatico: Substrati, Tipi di ossidazione, la reazione di Maillard, il riassestamento di Amadori, la degradazione di Strecker, la degradazione dell'acido ascorbico. Metodi per prevenire l'imbrunimento non enzimatico. (Qualità e Sicurezza) Imbrunimento enzimatico: substrati, principali reazioni e metodi per prevenirle (Qualità e Sicurezza) Metabolismi Glicolisi, Ciclo di Krebs, Catena respiratoria con Trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. Ciclo dell'acido fosfogluconico. Gluconeogenesi (Qualità e Sicurezza) Fermentazione alcolica. Fermentazione propionica. (Qualità e Sicurezza) Degradazione degli acidi grassi. Biosintesi degli acidi grassi (Qualità e Sicurezza) Metabolismo delle proteine e degli amminoacidi (Qualità e Sicurezza) Sintesi delle basi puriniche e pirimidiniche (Formazione di base) Biosintesi dei terpeni, dello squalene e del colesterolo (Qualità e Sicurezza) - 181 - Biosintesi dell'etilene (Qualità e Sicurezza) English The class focuses on subject that are configured in the learning context of quality and safety. Water chemistry: chemical structure, liqui/solid chemistry, solvent effect, dissociation, pH, activity and microbial availability Colloidal chemistry: colloidal systems, factors that cause particle dispersion/aggregation, use of colloids in food technology. Main bi-phase systems Saccharides: Monosaccharides, Reduced and oxidised derived compounds, Disaccharades: Maltose, lattose, cellobiose, trealose, saccharose. Polysaccharides: starch, glycogen, Pectins (properties, enzymatic degradation, use of pectins in food technology. Sweetening power and gel properties of starch Aminoacids: molecular structure and physical and chemical properties, behaviour in water, analytical procedure for the identification of aminoaicds, peptidic bonding Proteins. Main characteristics of proteins, I, II, III and IV structure. Functional properties of food proteins, proteolytic enzymes, Protein biological quality and food protein quality. Main reactions of proteins during food processing: hydrolysis, Denaturation, formation of biogenic amins, Maillard reaction Lipids: triacylglycerols, phospholipids, waxes. Structure and nomenclature, saturated and unsaturated fats, lipid degradation, antioxidants, catalytic hydrogenation. terpens, eicosanoids, steroids Nucleic acids: nitrogen bases, nucleosides and nucleotides. DNA and RNA Tannins: hydrolysable tannins – condensed tannins – biological functions Pigments: flavonoids – polyphenolic and polypyrolic pigments Vitamins: Main vitamins, their role as coenzymes, effect of food processing on the vitamin structure Enzymes: enzymatic reactions, kinetics and Michaelis-Menten equation, factors that affect the rate of enzymatic reaction, enzymatic inhibitors Non enzymatic Browning: Substrates, Types of oxidation, Maillard reaction, Amadori rearrangement, Strecker degradation, ascorbic acid degradation. Methods for preventing non-enzymatic browning. Enzymatic browning: substrates, main reactions and methods for limiting the process Metabolisms Glycolysis, Krebs cycle, Respiratory chain with electron transport and oxidative phosphorilation phosphogluconic acid cycle. Gluconeogenesis Alcoholic fermentation. Propionic fermentation. Omolactic and heterolactic fermentation Glicero-pyruvic fermentation - 182 - Fatty acid oxidation and biosynthesis Metabolism of proteins and aminoacids Biosynthesis of purinic and pirimidinic bases Biosynthesis of terpens and cholesterol Biosynthesis of etilene TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano La chimica degli alimenti, T.P. Coultate, Zanichelli Biochimica, A.L. Lehninger, Zanichelli English La chimica degli alimenti, T.P. Coultate, Zanichelli Biochimica, A.L. Lehninger, Zanichelli NOTA Italiano Le slides saranno disponibili sul sito campusnet del DISAFA a partire dall'inizio del corso Piccole variazioni del materiale caricato saranno possibili durante il corso English Slides will be available since the beginning of the course on the DISAFA website. Possible variations during the course may be done. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ny3o - 183 - Biochimica e metodologie (Anno Accademico 2015/2016) BIOCHEMISTRY AND METHODOLOGIES Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0133 Docente: Contatti docente: Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 9 SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Mutuato da: http://biologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b0fb Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mcsq - 184 - Biodiversità genetica vegetale (Anno Accademico 2015/2016) PLANT GENETIC BIODIVERSITY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0094 Docente: Dott. Alberto ACQUADRO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708813, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/07 - genetica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano - Fornire le competenze per l'utilizzo e l'applicazione di software per la costruzione di dendrogrammi di similarità, l'analisi della variabilità genetica e la valutazione della struttura genetica delle popolazioni - Fornire gli strumenti conoscitivi per operare nel settore della collezione, valutazione e salvaguardia delle risorse genetiche vegetali. English Aim of the course is to illustrate the main aspects of the evaluation and conservation of genetic variability and the main aspect of the utilization of the plant biodiversity. Moreover, softwares for similarity dendrogram construction of for evaluation of the genetic structure of the populations will be described and applied. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Sensibilizzare gli studenti nei confronti dei problemi della conservazione della biodiversità vegetale, con particolare riferimento alle specie di interesse agrario. Stimolare l'approccio critico alla materia, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla valutazione, alla gestione ed allo sfruttamento della variabilità genetica. English At the end of the course the student will know topics related to plant biodiversity conservation, with particular emphasis on cultivate crops, evaluation, characterization, methods of conservation and utilization of the genetic variability. - 185 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 50 ore di lezione frontale, 20 ore dedicate a attività di laboratorio e 10 ore dedicate a attività in aula informatica. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 50 hours of lectures 10 hours devoted to bioinformatics activities nd 20 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano All'inizio di ogni lezione il docente stimolerà la discussione con gli studenti sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti con il fine di chiarire eventuali dubbi e verificare lo stato di apprendimento della classe. L'esame sarà scritto con quatro-cinque domande teoriche e due esercizi pratici su tematiche che sono state trattate nel corso ed applicate durante esercitazioni. English At the beginning of each lesson the teacher will stimulate discussion with students on the topics covered in previous lessons with the aim to clarify any doubts and verify the state of learning in the class. The exam will be written with 4-5 theoretical question and 2 practical exercises which were covered in the course and applied during exercises. PROGRAMMA Italiano 1) Marcatori molecolari e loro applicazione per la caratterizzazione di germoplasma e fingerprinting varietale (Area delle produzioni vegetali). Richiamo sulle principali tecniche di biologia molecolare per l'applicazione dei marcatori molecolari: restrizione ed ibridazione; amplificazione PCR; elettroforesi su gel di agarosio e di acrilamide, elettroforesi capillare; sequenziamento (metodo Sanger). Definizione e classificazione dei marcatori molecolari. Marcatori basati su tecniche di restrizione ed ibridazione: RFLP e VNTR. Marcatori basti su tecniche di amplificazione PCR: RAPD, microsatelliti, Inter-SSR, AFLP e tecniche derivate, SNP, STS (marcatori CAPS e SCAR). Applicazione della tecnica 'PCR inversa' per estendere la sequenza di uno specifico marcatore molecolare. Strategie per il clonaggio di SSR: costruzione e screening di una libreria genomica; amplificazione di frammenti di restrizione con primer Inter-SSR in combinazione con primer AFLP. Confronto tra le tecniche di analisi molecolare: frequenza dei marcatori nel genoma; livello di polimorfismo (tasso di mutazione); specificità, multi-allelia, dominanza e co-dominanza; riproducibilità; quantità di DNA richiesta; laboriosità, competenze richieste e costi di applicazione; costi di sviluppo. Cenni ai principali utilizzi dei marcatori molecolari: identificazione varietale (fingerprinting); Studi di filogenesi; Realizzazione di mappe genetico-molecolari; Individuazione di regioni codificanti per caratteri di interesse agronomico e applicazione della selezione assistita da marcatori molecolari (MAS: Marker Assisted Selection) 2) Caratterizzazione di germoplasma, analisi filogenetiche e fingerprinting varietale (Area delle produzioni vegetali). - 186 - Richiamo sui principali coefficienti di similarita' (Nei e Li, Jaccard, Simple matching) e loro utilizzo in relazione ai marcatori molecolari impiegati. Costruzione di un dendrogramma di distanze con l'utilizzo del metodo UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean): terminologia impiegata nell'analisi filogenetica, alberi filogenetici (cladogrammi, alberi addittivi e dendrogrammi), rappresentazione grafica degli alberi filogenetici, teoria della condizione 'tre punti'; valutazione dell'affidabilità degli alberi filogenetici, bootstrap analysis ed ottenimento di alberi consenso; applicazioni pratiche mediante i softwares Excell, RAPDplot, Neighbour, NTSYSpc, Consense. 3) Origine ed evoluzione delle specie coltivate (Area delle produzioni vegetali). Origine delle specie coltivate, piante coltivate primarie e secondarie; La distribuzione della biodiversita' vegetale, centri di origine delle specie; Domesticazione e filogenesi delle principali specie coltivate: frumento, riso, mais, patata, erba medica; Meccanismi di domesticazione ed evoluzione delle specie coltivate: disseminazione spontanea, dormienza dei semi, habitus di crescita ed indice di raccolto, adattamento al fotoperiodo, dimensione e variabilità dei prodotti utilizzati, resistenze; Sindrome di domesticazione; Ruolo delle mutazioni dell'ibridazione e della poliploidizzazione nell'evoluzione delle piante coltivate, meccanismi fiorali che determinano l'auto e l'allofecondazione, concetto di pool genico (gene pool – gp). 4) Biodiversita' genetica vegetale (Area delle produzioni vegetali). Fonti di risorse genetiche naturali, ecotipi (local races), varietá locali (landraces), progenitori selvatici delle forme coltivate (wild relatives); Erosione genetica nelle specie coltivate; Collezione e valutazione del germoplasma, collezioni ex-situ, in-situ ed on-farm, articolazione delle collezioni ex situ, registrazione dati relativi alla località e all'ambiente di raccolta, dimensione del campione da collezionare, procedura di campionamento, collezioni di base e collezioni di lavoro, numero di semi da conservare, ringiovanimento dell'accessione; Rete internazionale di centri per la salvaguardia delle risorse genetiche vegetali, la Banca del Germoplasma del DIVAPRA Genetica Agraria; Utilizzazione e valorizzazione delle varieta' locali 5) Caratterizzazione della variabilità e della struttura genetica delle popolazioni (Area delle produzioni vegetali). Indici di variabilità genetica: numero osservato ed effettivo di alleli per locus, eterozigosi osservata ed attesa, indice di Shannon, indici di fissazione; marcatori co-dominanti e statistiche di Wright, effetti della deriva genetica e della frammentazione degli habitat; marcatori dominanti e statistiche di Nei; valutazione del flusso genico e delle distanze genetiche tra popolazioni; applicazioni pratiche mediante i softwares Popgene, AFLPsurv Neighbour, Consense. English Molecular markers and their application for germplasm characterization and varietal fingerprinting. Molecular biology techniques for molecular markers development and application: restriction and ligation, PCR amplification; electrophoresis on agaros and acrylamide gels, capillary electrophoresis, sequencing (Sanger method). Definition and classification of the molecular markers: makers based on restriction/ligation: RFLP and VNTR. Markers based on PCR amplification: RAPD, microsatellite, Inter-SSR, AFLP and derived techniques, SNP, STS (CAPS and SCAR markers). Inverse PCR technique application for marker extensions. Cloning strategies for SSR isolation: enriched genomic libraries and use of Inter-SSR primers in combination with AFLP primers. Molecular markers utilizations: molecular fingerprint; phylogenetic studies, molecular-map construction, and marker assisted selection (MAS) breeding method. Germplasm characterization, phylogenetic analyses and varietal fingerprinting. Use of the similarity coefficients (Nei and Li, Jaccard, Simple matching) in relation to the molecular markers applied. Dendrogram construction by means of the UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method: principles of the phylogenetic analyses, phylogenetic trees (cladograms, additive trees and dendrograms), graphic representation of the tree, three point condition, evaluation of the goodness of the phylogenetic trees, bootstrap analysis and consensus trees construction; utilization of the softwares Excell, RAPDplot, Neighbour, NTSYSpc, Consense. - 187 - Origin and evolution of the cultivated species. Origins of the cultivated species, primary and secondary crops; plant biodiversity distribution, centre of origin of the species . Phylogenesis and domestication of the main crops: wheat, maize, rice, potato and lucerne; mechanism of domestication and evolution; Role of mutation, ibridization and polyploidization in crop evolution. Gene pool – gp. Plant Biodiversity. Local races, Landraces and wild relatives as sources of plant biodiversity; genetic erosion of the crop; Germplasm collection and evaluation; ex-situ, in-situ and on-farm, collection, Evaluation criteria of the collection; Germplasm Bank at DIVAPRA Plant Genetics and Breeding section, Utilization and valorisation of local varieties Estimation of genetic variation and population structure. Genetic variability indexes: observed and effective number of alleles per locus, observed and expected heterozygosity, Shannon index, fixation indexes; co-dominant markers and Wright's statistics, genetic drift and habitat fragmentations effects on population structure; dominant markers and Nei's statistics; gene flow and evaluation of the genetic distances between populations; utilization of the software Popgene, GenPop, AFLPsurv Neighbour, Consense. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Barcaccia G., Falcinelli M. Genetica e genomica. Vol. II, III (cap. 10, 11, 12, 17, 20). Liguori Editore, Napoli. Verrà fornito dal docente il materiale didattico presentato a lezione, inerente gli argomenti trattati a lezione e durante le esercitazioni pratiche in laboratorio ed in Aula Informatica English BARCACCIA G., FALCINELLI M. Genetica e genomica, Volumi II e III, Liguori Editore. Articles from journals related to the topics covered in class and the software used during the practical exercises, will be provided by the teacher. The educational material presented in class will be worth made available to students. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3k8e - 188 - Bioinformatica e statistica (Anno Accademico 2015/2016) Statistics and bioinformatics Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0037 Docente: Dott. Alberto ACQUADRO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708813, [email protected] Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: SECS-S/02 - statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano -conoscere i principali database bioinformatici sede di informazione biologica -padroneggiare gli strumenti di "Sequence Retrieval" e gli strumenti di base per ricercare informazioni biologiche nei principali database. -acquisire autonomia nell'utilizzo di algoritmi di ricerca e analisi (genomica, trascrittomica e proteomica) dell'informazione biologica sia utilizzando strumenti on-line che programmi in locale. English Aim of the course is: -to know the principals sequence databases -to use sequence retrieval tools -to became autonomous in handling search algorithm (for genomics, transcriptomics and proteomics analyses) RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare il sistema operativo Linux, analizzare una sequenza genica ("single gene") e insiemi di sequenze ("whole genome"). Di seguito sono descritti i risultati nello specifico: Risultati inerenti l'uso del sistema operativo Linux - 189 - -Utilizzare il sistema operativo Linux e i comandi base di Linux da shell (cd, ls, cp, rm, rmd cat, grep, pipe, wc, etc) -Eseguire il download file, leggere e modificare i permessi di un file -Installare i piu comuni programmi di bioinformatica (file binari, .sh, .deb) -Eseguire delle analisi con i software MIRA, BWA, SamTools, Cufflinks -Lanciare script Perl (.pl) Risultati inerenti l'analisi "Single gene" -Analizzare database primari e secondarie (archival, curated) -Utilizzare gli operatori Booleiani (AND, OR, NOT) per il sistema genBank -effettuare una ricerca bibliografica utilizzando le piattaforme: "Web of Science" (WoS), e NCBI (Entrez) -Analizzare sequenze di DNA e proteiche dal punto di vista strutturale (primario e secondario); -utilizzare algoritmi di pattern recognition per il riconoscimento di introni/esoni, promotori/terminatori -isolare "in silico" sequenze ripetute (SSR); riconoscere e mascherare elementi ripetuti (CENSOR) -analizzare/predire le modificazioni post-traduzionali presenti in una proteina -allineare (LOCALE E GLOBALE) sequenze proteiche e nucleotidiche -Disegnare primer per analisi PCR (specifici e degenerati) Risultati inerenti l'analisi "Whole genome" -Eseguire una analisi semplificata di assembly di sequenze (genoma/trascrittoma) -Eseguire una analisi semplificata di SNP mining -Eseguire una analisi semplificata di dati RNAseq -Eseguire una analisi semplificata di dati microarray English At the end of the course the student will be able to use the OS Linux, analyse single gene and whole genome features. The specific learning results are reported in details below: Results on the use of the Linux operating system -Use the Linux operating system and basic Linux shell commands (cd, ls, cp, rm, rmd cat, grep, pipes, toilets, etc.) -Run the download file, read and modify the permissions of a file -Install the most common bioinformatics programs (binaries. Sh,. Deb) -Perform the analysis with the software MIRA, BWA, SamTools, Cufflinks -Launch Perl scripts (. Pl) Results on the use of single gene analyses - 190 - - Analyse primary and secondary sequence databases (archival and curated) using Boolean operator (AND, OR, NOT) - Analyse DNA and protein sequence and predict protein post-translational modifications -predict intron, exon and regulatory elements using pattern recognition algorithm -mine SNPs from sequence alignments -search repetitive elements from genomic database -design PCR primers (normal and degenerate) Results on the use of whole genome analyses -Perform a simplified assembly analysis of DNA/RNA sequences (genome / transcriptome) -Perform a simplified SNP mining analysis. -Perform a simplified RNAseq data analysis. -Perform a simplified microarray data analysis. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso sarà tenuto completamente in aula informatica utilizzando PC con sistema operativo linux. Per le lezioni il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course will be taught entirely in computer room using PCs with Linux operating system. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano All'inizio di ogni lezione il docente stimolerà la discussione con gli studenti sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti con il fine di chiarire eventuali dubbi e verificare lo stato di apprendimento della classe. L'esame sarà scritto con due domanda teoriche e quattro esercizi pratici su tematiche che sono state trattate nel corso ed applicate durante esercitazioni. English At the beginning of each lesson the teacher will stimulate discussion with students on the topics covered in previous lessons with the aim to clarify any doubts and verify the state of learning in the class. The exam will be written with two theoretical question and four practical exercises which were covered in the course and applied during exercises. ATTIVITÀ DI SUPPORTO -Il corso sarà svolto interamente in Aula informatica -Ogni studente avrà a disposizione un PC (sistemi operativi: Window e Linux) - 191 - -Ogni studente avrà a disposizione per il periodo di studio una USB pendrive con il una versione bootable di Ubuntu 12.04 PROGRAMMA Italiano Area di formazione generale - Introduzione alla bioinformatica. - Introduzione al sistema operativo Linux (Ubuntu GUI e shell di comando) - Comandi di base (cd, ls, cp, rm, rmd cat, grep, pipe, wc, etc), gestione permessi di un file - Installazione pacchetti e programmi di bioinformatica - Database primari, secondarie, archival, curated. Confrontro tra Refseq e Genbank, database proteici. - Uso degli operatori Booleiani (AND, OR, NOT); Sistemi di RETRIEVAL (Entrez, SRS). Rudimenti di ricerca bibliografica in Web of Science e "Trova unito" - Formati sequenze (descrizione e costruzione di file fasta e GBFF); Costruzione manuale di un file multi fasta; Visualizzazione e manipolazione cromatogrammi (sequence scanner e Bioedit); Sottomissione di sequenze (BANKIT); Formati sequenze NGS (illumina, 454 e Solid) - Analisi delle sequenze di DNA; Traduzione concettuale e caratterizzazione degli elementi di una sequenza di DNA genomico e di cDNA; Utilizzo del pattern recognition per il riconoscimento di introni, esoni, di promotori e terminatori; Riconoscimento e mascheramento di elementi ripetuti (CENSOR); SSR mining (Sputnik, misa) - Analisi delle sequenze proteiche; Identificazione di una proteina da elementi di sequenza; Analisi della sequenza; Modificazioni post-traduzionali; Predizione della struttura secondaria; strutture proteiche (PDB) - Disegno di oligo per mezzo del software Primer3 (single gene, in batch) - Ricerche per similarità. Allineamento locale (BLAST e le sue varianti). Allineamento globale (ClustalW di acidi nucleici e proteine). - Manipolazione di SRA (Sequence Reads Archival) – SRA tools - Assembly genomico e trascrittomico mediante MIRA3 - SNP mining con dati Sanger e formati NGS (454 e Illumina) - Allineamenti di sequenza mediante BWA (Burrel wheeler aligner); Transcodifica di formati (Samtools) - Analisi dati RNAseq mediante la suite Cufflinks; Analisi microarray (Genesis): clustering gerarchico e K-means; - Gene Ontology e arricchimenti nelle funzioni geniche - Brevi richiami di statistica descrittiva. Brevi richiami sull'introduzione del calcolo delle probabilità. - Popolazioni gaussiane (normali) e loro proprietà. Quantili. Problemi ed esempi di tipo biologico per popolazioni normali, uso dei relativi comandi Excel. Cenni su altre v.a. continue (t-Student, χ2) - I test statistici: ipotesi nulla, significatività, potenza; il p-value. I test t-Student. Esempi e uso dei relativi comandi Excel. - 192 - English - Introduction to bioinformatics - Introduction to Linux (Ubuntu GUI and command shell) - Basic commands (cd, ls, cp, rm, rmd cat, grep, pipes, toilets, etc.) - Managing permissions of a file - Installing packages and programs in bioinformatics - Primary, secondary, archival and curated databases. - Refseq vs GenBank, protein database. - Use of booleian operators (AND, OR, NOT); retrieval systems (Entrez, SRS); literature searching (Web of Science and "TROVA UNITO") - Sequence format (description and construction of fasta and GBF files) - Multi fasta file editing, viewing and manipulating chromatograms (Scan sequence and Bioedit); submission of sequences (via BANKIT) - Analysis of DNA sequences, conceptual translation; characterization of genomic DNA and cDNA sequence elements; pattern recognition for intron, exon, promoter and terminator mining. Recognition and masking of repetitive elements (Censor); SSR mining (Sputnik, Misa) - Analysis of protein sequences, post-translational modifications, secondary structure prediction and protein structures (PDB) - Oligo design Primer3 (single gene and in batch) - Searches for similarities. Local Alignment (BLAST and its variants) global alignment (ClustalW, for nucleic acids and proteins analyses) - SRA manipulation tools - Genomic/transcriptomic denovo assembly (MIRA3) - SNP mining (using Sanger and NGS data) - BWA alignment of sequences (Burrel Wheeler aligner) - Microarray analysis (Genesis): hierarchical clustering and K-means; - Gene Ontology and gene enrichment functions - Basics on descriptive statistics. - Quick reminders on the calculation of probability. - Confidence intervals - Gaussian populations (normal distribution) and their properties. Quantiles. - Problems and examples of biological populations (use of Excel commands). - The statistical tests: null hypothesis, significance and p-value. The Student t-test. Examples and use of Excel commands. Italiano Il corso intende illustrare i principali database bioinformatici sede di informazione biologica e gli strumenti di "Sequence Retrieval" collegatii e gli strumenti di base per ricercare informazioni biologiche. Il corso intende illustrare l'utilizzo dei principali algoritmi di ricerca e analisi genomica, trascrittomica e proteomica sia utilizzando strumenti on-line che programmi in locale. English The course aims to illustrate the major bioinformatics databases based on biological information and tools for "Sequence Retrieval" as well as the basic tools to investigate biological information. The course aims to illustrate the use of the main searching/analysing algorithms for genomics, transcriptomics and proteomics (using both remote web-based tools and local programs). TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA - 193 - Italiano :: INTRODUZIONE alla BIOINFORMATICA di Giorgio Valle, Manuela Helmer Citterich Marcella Attimonelli, Graziano Pesole (Zanichelli). :: Per approfondimenti e integrazioni è fortemente consigliato l'utilizzo del materiale messo a disposizione dal docente durante il corso. English :: INTRODUZIONE alla BIOINFORMATICA di Giorgio Valle, Manuela Helmer Citterich Marcella Attimonelli, Graziano Pesole (Zanichelli). :: For further details is strongly suggested to use of the material provided by the teacher during the course. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9eqt - 194 - Biologia cellulare e del differenziamento (Anno Accademico 2015/2016) PLANT CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0798 Docente: Prof. Andrea Genre Contatti docente: 0116705083, [email protected] Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: BIO/01 - botanica generale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Conoscenza approfondita di struttura e funzione dei principali comparti e meccanismi che caratterizzano la cellula vegetale e delle loro potenzialità biotecnologiche. Conoscenza dei meccanismi cellulari e molecolari alla base del differenziamento di tipi cellulari, tessuti e organi. Basi teoriche e pratica diretta di alcune tra le più moderne tecniche analitiche di biologia cellulare vegetale. English Knowledge of the structure and function of plant cell major components and mechanisms in a biotechnological perspective. Knowledge of cellular and molecular mechanisms controlling the development of plant cell types, tissues and organs. Theoretical bases and direct practice in some of the most advanced techniques in plant cell biology. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Biologia degli organismi vegetali Aspetti morfologici/funzionali Aspetti cellulari/molecolari Meccanismi di sviluppo dei vegetali Procedure metodologiche e strumentali per la ricerca biologica - 195 - Valutazione e interpretazione di dati sperimentali di laboratorio Consultazione di materiale bibliografico English Plant Biology Morphological and functional aspects Cellular and molecular aspects Mechanisms of plant development Methodological procedures for biological research Evaluation and interpretation of experimental data Access to bibliographic material MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione che comprendono anche attività di laboratorio presso il laboratorio di microscopie avanzae del DBIOS. Le slide e gli articoli scientifici utilizzati a lezione sono messi a disposizione degli studenti nel materiale didattico online. Gli studenti sono anche coinvolti nella lettura (a casa) e nel commento (in aula) di articoli scientifici di approfondimento. English The course covers 60 hours including lectures and practical activities in the Laboratory of Advanced Microscopy at DBIOS. Slides and scientific papers used for the lectures are available to the students as online materials. Students are also involved in reading (at home) and commenting (in the classroom) a selection of insight articles. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il livello di apprendimento degli studenti viene monitorato costantemente sia durante le esercitazioni, che si riferiscono sempre ad argomenti trattati nelle lezioni precedenti, sia in classe, attraverso domande dirette e discussioni aperte, nonché con il commento agli articoli che vengono via via proposti. L'esame finale è orale: dopo un commento ad un articolo di approfondimento scelto tra una selezione disponibile nei materiali didattici online, l'esame prosegue con alcune domande che coprono i principali ambiti ttrattati nel corso. Ad ogni risposta viene assegnata una valutazione e il voto finale viene calcolato come media delle singole valutazioni. English The student learning path is constantly monitored through questions and discussions during both classes and practical sessions, as well as through the comment to papers that are proposed throughout the course. The final exam is oral: starting from the comment to a scientific article selected from a list available online, the - 196 - student is asked a few questions that cover the major topics presented in the course. Each reply is evaluated and the final grade is calculated as the average of such evaluations. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati nel corso rientrano in larga misura nell'area biologico-molcolare. Le dinamiche della cellula alla base della plasticità dei vegetali. Caratteritiche strutturali e funzionali delle cellule vegetali. Lo studio della biologia cellulare in vivo: basi teoriche, tecnologie e applicazioni. Caratteri distintivi della cellula vegetale. I plastidi, il citoscheletro, la parete cellulare. Le membrane cellulari e il flusso di membrane Il nucleo Vie di segnalazione e messaggeri secondari nella cellula vegetale Elementi di biologia dello sviluppo dei vegetali. La crescita indeterminata. Divisione mitotica e regolazione del ciclo cellulare. Endoreduplicazione e morte cellulare programmata. Embriogenesi e organizzazione dei meristemi. Controllo del destino cellulare. Lo sviluppo della radice e quello del fusto. La biologia cellulare vegetale negli articoli scientifici: ruolo, presentazione dei dati, avanzamenti tecnologici. Lettura critica di un articolo scientifico. Laboratorio - Microscopia elettronica (fissazione, contrasto, inclusione, microtomia, osservazione in microscopia elettronica a trasmissione) Laboratorio - Microscopia confocale in vivo (esperimenti su campioni che esprimono marcatori fluorescenti - GFP) English Cell dynamics at the basis of plant plasticity. Structural and functional characteristics of plant cells. In vivo cell biology: theoretical bases, technologies and applications. Distinctive traits of the plant cell. Plastids, cytoskeleton, cell wall. Endocellular membranes and their fluxes. The nucleus. Signaling pathways and secondary messengers in plant cells. Elements of plant developmental biology. Indeterminate growth. Cell division and cell cycle control. Endoreduplication. Embryogenesis and meristem organization. Cell fate control. - 197 - Root and shoot development. Plant cell biology in scientific publications: role, data presentation, technical advances. Critical reading of a scientific paper. Laboratory - Electron microscopy (Fixation, contrast, embedding, microtomy, observation under transmitted electron microscope) Laboratory - In vivo confocal microscopy (experiments on samples expressing fluorescent protein markers) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Pasqua, Biologia cellulare e biotecnologie vegetali. Piccin, Padova - Altamura, Biondi, Colombo, Guzzo. Elementi di biologia dello sviluppo delle piante. EdiSES, Napoli English - Pasqua, Biologia cellulare e biotecnologie vegetali. Piccin, Padova - Altamura, Biondi, Colombo, Guzzo. Elementi di biologia dello sviluppo delle piante. EdiSES, Napoli NOTA Italiano L'esame finale comprende: - Commento critico di un articolo scientifico di argomento inerente al corso, precedentemente concordato con il docente - Domande sugli argomenti affrontati a lezione - Domande sull'attività svolta in laboratorio . English The final exam includes the discussion of a research paper previously agreed with the teacher; questions on the topics presented during the course; questions on the practical activities in the laboratory. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lm5s - 198 - Biologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) Biologia della vite Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0040 Docente: Prof. Osvaldo Umberto FAILLA (Affidamento interno) Contatti docente: 02 50316565, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Approfondire le conoscenze di fisiologia della vite relativamente alla fenologia, allo sviluppo e maturazione del frutto, al bilancio del carbonio e alla nutrizione idrica e minerale in relazione alle risorse ambientali e alle differenze varietali. English To increase the knowledge of the grapevines physiology in relation to phenology, development and maturation of the fruit, the carbon, nutritional and water balance, in relation to environmental resources and varietal differences. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza della fisiologia dello sviluppo e della fruttificazione della vite, della nutrizione idrica e minerale e del bilancio del carbonio in relazione al variare delle risorse ambientali e genetiche. English Knowledge of the physiology of grapevine development and fruiting, of the water and mineral nutrition and carbon balance in relation to changing environmental and genetic resources. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Lezioni frontali. - 199 - English Lectures. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame orale. English Oral examination. PROGRAMMA Italiano CFU I – Introduzione e richiami di morfologia della vite CFU II – Ecologia, ecofisiologia e fenologia della vite CFU III - Sviluppo e maturazione della bacca CFU IV – Bilancio del carbonio e nutrizione minerale CFU V – Bilancio idrico e stress ambientali English ETCS I - Introduction and recall of the grapevine morphology ETCS II - Ecology, ecophysiology and phenology of the grapevine ETCS III – Grapes development and ripening ETCS IV - Carbon balance and mineral nutrition ETCS V - Water balance and environmental stresses TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Keller M. 2010 The Science of Grapevine. Elsievier. Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A., 2004 Trattato di Enologia I (capitolo 10), Edagricole, Bologna,. Altro materiale bibliografico sarà indicato dal docente in relazione ai diversi punti del programma. Testi propedeutici Alpi, Pupillo, Rigano. Fisiologia delle piante. EdiSES - 200 - Salisbury, Ross. Fisiologia vegetale. Zanichelli Taiz, Zeiger. Fisiologia vegetale. Piccin English Keller M. 2010 The Science of Grapevine. Elsievier. Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A., 2004 Trattato di Enologia I (capitolo 10), Edagricole, Bologna,. Other bibliographic material will be indicated by the teacher in relation to the various points of the program. Introductory texts Alpi, Pupillo, Rigano:. Fisiologia delle piante. EdiSES Salisbury, Ross: Fisiologia vegetale. Zanichelli Taiz, Zeiger: Fisiologia vegetale. Piccin NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fkoa - 201 - Biologia e biodiversità nei vegetali (Anno Accademico 2015/2016) PLANT BIODIVERSITY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0025 Docente: Prof. Paola Bonfante (Affidamento interno) Dott. Elena Martino (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705965, [email protected] Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: BIO/01 - botanica generale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si articola in due moduli. Il primo si propone di illustrare i grandi gruppi degli organismi vegetali, seguendo le attuali linee sistematiche. Vengono evidenziate le loro unicità, considerando gli aspetti evolutivi a partire dall'emersione dall'acqua, i cicli vitali, e il piano organizzativo cellulare. Il secondo modulo si propone di fornire, grazie all'integrazione di lezioni teoriche ed esercitazioni, le basi dell'istologia e dell'anatomia vegetale. English The course is divided into two modules. The first one is aimed to illustrate the main groups of photosynthetic organisms, according to the current systematic and highlighting their unique features. Special focus will be given to life cycles, discussed under an evolutionary perspective, and the cellular organization level. Aim of the second module is to provide, through the integration of theory and practice, the basis of plant histology and anatomy. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Ci si aspetta che gli studenti raggiungano una buona conoscenza della biodiversità e della biologia vegetale, acquisendo nozioni e strumenti che complementino i saperi tradizionali della botanica con alcune delle informazioni più recenti e ricevendo pertanto le basi per affrontare gli insegnamenti più avanzati previsti dal corso di studi. English It is expected that students will reach a good knowledge of plant biodiversity and biology, acquiring notions and - 202 - tools which could complement the traditional knowledge of botany with some of the most recent information therefore acquiring the basis for tackling the more advanced teachings provided by the course of study. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di due moduli. Il modulo 1 (Biodiversità vegetale) prevede 24 ore di lezione frontale e 6 ore di esercitazioni (costruzione di alberi filogenetici, visita erbario). Il modulo 2 (Anatomia vegetale) prevede 22 ore di lezione frontale e 8 ore di esercitazioni (preparazione di vetrini a partire da materiale vegetale fornito dal docente ed osservazioni al microscopio ottico). Per le lezioni frontali i docenti si avvalgono di presentazioni power point che vengono messe a disposizione degli studenti sulla pagina web del corso. English The course is divided into two modules. The first one (Plant biodiversity) includes 24 hours of lectures and 6 hours of practical works (phylogenetic trees construction, herbarium visit) The second one (Plant anatomy) includes 22 hours of lessons and 8 hours of practical works (slides preparation starting from plant materials given by the teacher and observations at the light microscope). During the lectures teachers make use of power point presentations that are available for the students on the course web page. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine di ciascun argomento presentato a lezione il docente proporrà una discussione in aula sui temi trattati per verificare la comprensione da parte degli studenti di quanto esposto anche avvalendosi di domande riconducibili a quelle che saranno proposte all'esame finale. L'esame finale consiste di una prova scritta comprendente 10 domande aperte, 5 per ciascuno dei due moduli. Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio massimo di 6 punti ed il voto finale deriva dalla media dei voti in trentesimi delle prove relative a ciascuno dei due moduli. Segue una prova orale che prevede una discussione/integrazione di quella scritta. English At the end of each topic presented in class the teacher will propose to the students a discussion on the main covered subjects to verify the comprehension level also asking questions related to those that will be proposed at the final exam. The final exam is a written test consisting of 10 opened questions, 5 for each one of the two modules. To each question is attributed a maximum of 6 points and the final mark comes from the average of the marks coming from the two modules. An oral discussion/integration of the written test follows. PROGRAMMA Italiano Area di formazione generale Modulo 1: Biodiversità 1) Parte generale. Organismi vegetali: peculiarità, strategie, biodiversità. Fotosintesi. Multicellularità, differenziamento. Comunicazioni a breve/lunga distanza. Adattamenti. 2) Biodiversità: evoluzione, approcci genetici, ecofisiologia. Concetti di tassonomia, sistematica, evoluzione, filogenesi. Linneo: classificazione, nomenclatura binomia. Darwin: evoluzione/filogenesi. Concetto di specie, convergenze evolutive, cladistica. Da anatomia a sequenziamento di genomi. Geni ribosomali. Da regni a domini. K. Woese. - 203 - 3) Sistematica e Tassonomia: la proposta del 2005 (6 regni per eucarioti) non ha retto alle analisi filogenetiche. Parametri per identificare le alghe. Origine dei plastidi. Endosimbiosi primaria e secondaria. Euglena e Dinoflagellati. Alghe gialle e brune. Alghe verdi. Dalle alghe alle briofita. Da Chlamydomonas alle carofita: formazione delle pareti cellulari. Conquista delle terre emerse: embrione, sistema vascolare, semi, fiori. Streptofita: Carofita e Briofita. Epatiche (marker di cambiamenti climatici, tallo, gametangi, ciclo cellulare); Muschi e Antocerotali: gametofito/sporofito. Physcomitrella: pianta modello. Sfagni/torba: aspetti ecologicoapplicativi. Tracheophyta: elementi xilematici; lignina, cutina, cere. Piante fossili: Rhyniophyta. Fossili e funghi AM. Da Rhyniophyta a Licofita; microfille; Selaginella, Isoetes. Eterosporia. Pteridofita e macrofille: ritorno alle isospore, Psilotum, sporangi e isosporia; ciclo della felce maschio. Protogimonosperme. Da spore a semi. Contributo dei fossili. Felci a semi. Ciclo. Caratteri arcaici e moderni. Sviluppo di gametofito maschile e femminile. Le gimnosperme: Cycadales, Gingkoales, Coniferales, Gnetales. Il mistero delle Angiosperme: Archeofructus in Cina: prima presenza di fiori. Filogenesi attuale: Amborella alla base di tutte le piante; ninfee e anice stellato : gruppi basali; cluster delle monocotiledoni, magnolie alla base delle eucotiledoni. Caratteri distintivi delle Angiosperme. Il fiore. 4) Il plant microbiota: dalla biomedicina al plant microbiota. Un esempio: il riso. Esercitazioni : 1) Ricerche basate su campioni d'erbario, campioni "typus". Collezioni aperte/chiuse. 2) Identificazione di una pianta tramite sistemi on line. 3) Costruzione di alberi filogenetici: UPGMA, Neighbor Joining, massima parsimonia, massima somiglianza, metodi Bayesiani. Modulo 2: Anatomia 1) Tessuti: meristematici, parenchimatici, tegumentali, conduttori, meccanici, secernenti (caratteristiche citologiche/funzionali). 2) Organi: Fusto. Meristema apicale: tunica/corpus; zona centrale/periferica. Geni regolatori. Bozze fogliari e primordi dei rami (pomodoro, Arabidopsis). Dominanza apicale. Mais e teosinte. Internodi: mutanti nani, gene Le di pisello, mutante gai (Arabidopsis). Portamento monopodiale e simpodiale. Zone di crescita: apice, zona di determinazione, differenziamento, struttura primaria. Eustele, atactostele. Fusti modificati. Accrescimento secondario. Cambio subero-fellodermico e cribro-vascolare. Attività dipleurica. Sistemi assiale/radiale. Xilema secondario (legno omoxilo ed eteroxilo). Floema secondario. Dendrocronologia. Foglia. Morfologia ed anatomia (foglie bifacciali, isofacciali, unifacciali, centriche). Controllo formazione/disposizione di stomi/tricomi. Foglie modificate. Senescenza ed abscissione fogliare (ruoli etilene, citochinina, auxina). Radice. Arabidopsis: sistema modello per lo sviluppo della radice. Segnali di posizione/identità cellulare, geni coinvolti. Organizzazione esterna/interna. Meristema primario, centro quiescente, cuffia (gravitropismo), zona di meristemi determinati, differenziamento, struttura primaria. Actinostele. Radici laterali. Accrescimento secondario. Specializzazioni/adattamenti. Noduli. Micorrize. Esercitazioni: preparazione di vetrini, colorazione, osservazioni al microscopio. 1) Parenchimi, epidermide. 2) Tessuti meccanici, conduttori. 3) Foglia 4) Fusto in struttura primaria/secondaria. English General formation area Module 1: Plant biodiversity - 204 - 1) General part. Plant organisms: features, strategies, biodiversity. Photosynthesis. Multicellularity, differentiation. Short/long distance communications. Adaptations. 2) Biodiversity: evolution, genetic approaches, eco-physiology. Concepts of taxonomy, systematics, evolution, phylogeny. Linnaeus: classification, binomial nomenclature. Darwin: evolution/phylogeny. Concept of species, evolutionary convergence, cladistics. From the anatomy to the genome sequencing. Ribosomal genes. From kingdoms to domains. K. Woese. 3) Systematics and Taxonomy: The 2005 proposal (6 kingdoms for eukaryotes) has not held up to the phylogenetic analysis. Parameters for algae identification. Origin of plastids. Primary and secondary endosymbiosis. Euglena and Dinoflagellates. Yellow and brown algae. Green algae. From algae to bryophyta. From Chlamydomonas to carophyta: cell walls formation. Emerged lands colonization: embryo, vascular system, seeds, flowers. Streptophyta: Carophyta and bryophyta. Liverworts (climate change markers, thallus, gametangia, cell cycle); Mosses and Antocerotales: gametophyte/sporophyte. Physcomitrella: a model plant. Sphagnum/peat: ecological and practical aspects. Tracheophyta: xylem elements; lignin, cutin, waxes. Fossil plants: Rhyniophyta. Fossils and AM fungi. From Rhyniophyta to Licophyta; microleaves; Selaginella, Isoetes. Heterospory. Pteridophyta and macroleaves: return to isospores, Psilotum, sporangia and isosporia; the male fern cycle. Protogymnosperms. From spores to seeds. Contribution of fossils. Seed Ferns. Cycle. Archaic and modern characters. Development of male and female gametophyte. Gymnosperms: Cycad, Gingkoales, Coniferales, Gnetales. The mystery of angiosperms: Archeofructus in China: first presence of flowers. Current phylogeny: Amborella at the basis of all plants; lilies and star anise: basal groups; cluster of monocots, magnolias at the basis of eudicots. Distinctive features of Angiosperms. The flower. 4) The plant microbiota: from biomedicine to plant microbiota. An example: the rice. Practical part: 1) Research based on herbarium specimens, "typus" samples. Open/closed collections. 2) Plant identification through online systems. 3) Construction of phylogenetic trees: UPGMA, Neighbor Joining, maximum parsimony, maximum likelihood, Bayesian methods. Module 2: Plant anatomy 1) Plant tissues: parenchyma, epidermal, support, vascular, secretory tissues (cytological and functional features). 2) Plant organs: Stem. Apical meristem: tunica/corpus; central/peripheral zones. Regulatory genes. Branches and leaf primordia (tomato, Arabidopsis). Apical dominance. Maize and teosinte. Internodes: dwarf mutants, pea Le gene, gai mutant (Arabidopsis). Monopodiale and sympodial habit. Growth zones: apical meristems, determination zone, differentiation zone, primary structure zone. Eustele, atactostele. Modified stems. Secondary growth. Cork and cribro-vascular cambium activity. Bifacial activity. Longitudinal/radial systems. Secondary xylem (homogeneous and heterogeneous wood). Secondary phloem. Dendrochronology. Leaf. Morphology and anatomy (bifacial, isofacial, unifacial, centric leaves). Control of the stomata/trichomes formation and arrangement. Modified leaves. Leaf senescence and abscission (ethylene, cytokinin, auxin roles). Root. Arabidopsis: a model system for the study of root development. Position/cell identity signals, genes involved. Internal/external structure. Primary meristem, quiescent center, root cap (gravitropism), determined meristems zone, differentiation zone, primary structure zone. Actinostele. Lateral roots. Secondary growth. Modified roots. Nodules and mycorrhiza. Practical parts: slides preparation, staining, microscope observations. 1) parenchyma, epidermis. 2) Support and transport tissues. 3) Leaves. 4) Primary/secondary shoots. - 205 - TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Il materiale didattico presentato a lezione sarà disponibile sul sito internet: http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/. I testi base consigliati per il corso sono: Smith et al. 2011, Biologia delle piante, Ed. Zanichelli, edizione italiana a cura di D. Chiatante. Pasqua, Abbate, Forni. Botanica generale e Biodiversità, Ed. Piccin. Mauseth. Botanica, Fondamenti di Biologia delle Piante, Edizione Italiana, Nuova Editoriale Grasso. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: Appunti presi a lezione Sono di seguito indicati altri siti internet di interesse: http://www.bioveg.unito.it/atlanteme/ http://www.atlantebotanica.unito.it/ English The slides will be available at: http://agraria-offdid.campusnet.unito.it/. The suggested books for the exam preparation are: Smith et al. 2011, Biologia delle piante, Ed. Zanichelli, edizione italiana a cura di D. Chiatante. Pasqua, Abbate, Forni. Botanica generale e Biodiversità, Ed. Piccin. Mauseth. Botanica, Fondamenti di Biologia delle Piante, Edizione Italiana, Nuova Editoriale Grasso. It is strongly suggested to use the lesson notes for the exam preparation Other internet useful sites: http://www.bioveg.unito.it/atlanteme/ http://www.atlantebotanica.unito.it/ NOTA Italiano Il corso si svolge il martedi' presso i locali della sede di Grugliasco ed il mercoledi' presso i locali del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, sede di Viale Mattioli 25 English The course will take place on Tuesday at the Grugliasco seat and on Wednesday at the Life Sciences and Systems Biology Department, seat of Viale Mattioli 25 Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uqzy - 206 - - 207 - Biologia e genetica della vite - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) BIOLOGY OF GRAPEVINE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0040 Docente: Prof. Osvaldo Umberto FAILLA (Affidamento interno) Carlo Massimo Pozzi (Affidamento interno) Contatti docente: 02 50316565, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 10 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/07 - genetica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Biologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) Genetica della vite (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9qwe Biologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) Biologia della vite Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0040 Docente: Prof. Osvaldo Umberto FAILLA (Affidamento interno) Contatti docente: 02 50316565, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 208 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Approfondire le conoscenze di fisiologia della vite relativamente alla fenologia, allo sviluppo e maturazione del frutto, al bilancio del carbonio e alla nutrizione idrica e minerale in relazione alle risorse ambientali e alle differenze varietali. English To increase the knowledge of the grapevines physiology in relation to phenology, development and maturation of the fruit, the carbon, nutritional and water balance, in relation to environmental resources and varietal differences. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza della fisiologia dello sviluppo e della fruttificazione della vite, della nutrizione idrica e minerale e del bilancio del carbonio in relazione al variare delle risorse ambientali e genetiche. English Knowledge of the physiology of grapevine development and fruiting, of the water and mineral nutrition and carbon balance in relation to changing environmental and genetic resources. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Lezioni frontali. English Lectures. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame orale. English Oral examination. PROGRAMMA Italiano CFU I – Introduzione e richiami di morfologia della vite - 209 - CFU II – Ecologia, ecofisiologia e fenologia della vite CFU III - Sviluppo e maturazione della bacca CFU IV – Bilancio del carbonio e nutrizione minerale CFU V – Bilancio idrico e stress ambientali English ETCS I - Introduction and recall of the grapevine morphology ETCS II - Ecology, ecophysiology and phenology of the grapevine ETCS III – Grapes development and ripening ETCS IV - Carbon balance and mineral nutrition ETCS V - Water balance and environmental stresses TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Keller M. 2010 The Science of Grapevine. Elsievier. Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A., 2004 Trattato di Enologia I (capitolo 10), Edagricole, Bologna,. Altro materiale bibliografico sarà indicato dal docente in relazione ai diversi punti del programma. Testi propedeutici Alpi, Pupillo, Rigano. Fisiologia delle piante. EdiSES Salisbury, Ross. Fisiologia vegetale. Zanichelli Taiz, Zeiger. Fisiologia vegetale. Piccin English Keller M. 2010 The Science of Grapevine. Elsievier. Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A., 2004 Trattato di Enologia I (capitolo 10), Edagricole, Bologna,. Other bibliographic material will be indicated by the teacher in relation to the various points of the program. Introductory texts Alpi, Pupillo, Rigano:. Fisiologia delle piante. EdiSES - 210 - Salisbury, Ross: Fisiologia vegetale. Zanichelli Taiz, Zeiger: Fisiologia vegetale. Piccin NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fkoa - 211 - Genetica della vite (Anno Accademico 2015/2016) Genetica della vite Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0040 Docente: Carlo Massimo Pozzi (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/07 - genetica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Lo studente è messo in grado di comprendere i metodi di miglioramento genetico della vite, soprattutto nella loro declinazione più moderna e genomica. Lo studente acquisisce informazioni circa l'applicazione di tecniche molecolari alla caratterizzazione varietale ed al breeding. Le più moderne indicazioni circa le modalità di domesticazione della vite sono interpretate mediante strumenti molecolari. Inoltre vengono fornite le basi per comprendere il miglioramento della vite tramite transgenesi e cisgenesi. English The student will be able to understand the modern methods used in grape breeding, especially those involving the usage of molecular and genomics breeding. The student will acquire competencies and techniques to be used in grape cultivars molecular characterization and breeding. The student will be exposed to the most recent theories about grape domestication supported by molecular evidences. The student will be able to understand the basis of grape breeding through transgenesis and cisgenesis. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà essere in possesso della capacità di comprendere il disegno sperimentale di piani di miglioramento genetico della vite, e per questo dovrà essere in grado di avvalersi di nozioni di genetica di base, di genetica molecolare, biochimica e genetica delle popolazioni. Lo studente inoltre dovrà essere in grado di interpretare criticamente esperimenti di miglioramento della vite mediante applicazione di tecnologie transgeniche. English The student will have to be able to understand the design of experiments in grape breeding programs. To this end, the student will have to master basic genetics, molecular genetics, biochemistry and population genetics. The student will have to be able to critically interpret the experiments in grape breeding using transgenetic technologies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 212 - Il corso consiste di 40 ore di lezione frontale. Il docente di avvale di presentazioni/slide che sono a disposizione degli studenti. English The course is composed of 40 hours of lectures. The teacher uses power point presentations, which will be made available to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano A metà semestre verrà proposto un test scritto per verificare il grado di apprendimento e di chiarezza della didattica. L'esame finale è un colloquio orale. English Half way during the course a written test will be proposed to verify both the learning-curve progress and the clarity of the lectures. The final exam is oral. PROGRAMMA Italiano Introduzione al corso Richiami di genetica di base e di genetica quantitativa Genetica mendeliana e sue leggi Genetica quantitativa e introduzione alle sue basi statistiche Richiami di genetica di popolazioni Speciazione e formazione di popolazioni spontanee isolate geneticamente Varietà, cloni, piante spontanee e coltivate in viticoltura Caratterizzazione molecolare della biodiversità varietale e clonale Marcatori molecolari: tipologie, tecniche Marcatori molecolari per la caratterizzazione varietale e clonale Investigazione con strumenti molecolari della domesticazione della vite Genomica della vite Strategie e strumenti di sequenziamento dei genomi vegetali Sequenziamento del genoma della vite Uso delle tecniche di sequenziamento nel breeding: esempi in vite Genetical genomics, chemical genetics ed eQTLs Miglioramento genetico moderno della vite Cenni sulla storia del miglioramento genetico della vite Ibridazione e autofecondazione Ideotipi per la vite Marcatori molecolari e miglioramento genetico Genetica molecolare e genomica per Il mappaggio e la clonazione di QTL Il mappaggio mediante linkage disequilibrium La selezione assistita da marcatori Programmi di miglioramento genetico della vite Miglioramento genetico basato su variabilità interspecifica Trasformazione e rigenerazione di vite Programmi di miglioramento genetico interspecifico English Introduction to the course Elements of genetics and quantitative genetics - 213 - Mendelian genetics Quantitative genetics and introduction to genetical statistics Elements of population genetics Speciation and formation of spontaneous populations genetically isolated Cultivars, clones, and spontaneous plants cultivated in viticulture Molecular characterization of grape biodiversity Molecular markers: types, techniques Molecular markers for the characterization of biodiversity Molecular tools for the investigation of grape domestication Grape genomics Strategies and techniques for plant genomes sequencing Grape genome sequencing Sequencing techniques and plant breeding: applications in grape New frontiers: genetical genomics, chemical genetics and eQTLs Grape modern breeding Elements of grape breeding history Grape ideotypes Molecular markers and breeding Molecular genetics and genomics Molecular genetics and genomics for: QTL mapping and cloning Linkage disequilibrium mapping Marker assisted selection Examples of breeding plan in grape Molecular breeding based on interspecific variability: Grape transformation and regeneration Breeding programs based on transgenesis and cisgenesis. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Genetica e genomica (3 vol). G. Barcaccia, M. Falcinelli (Liguori Editore) Presentazioni e articoli forniti durante il corso. English Genetica e genomica (3 vol). G. Barcaccia, M. Falcinelli (Liguori Editore); slides, texts, and papers which will be provided during the lectures. NOTA Italiano Il corso si volge nella sede di Asti English The course is held at the facility in Asti. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g1vy - 214 - Biologia generale e botanica (insegnamento per L- Scienze e tecnologie agrarie) (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL BIOLOGY AND BOTANY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0007 Docente: Dott. Deborah ISOCRONO (Affidamento interno) Contatti docente: +39 0116708948, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: BIO/03 - botanica ambientale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Questo corso ha come scopi quelli di: -acquisire conoscenze teoriche di base sulla biologia e sull'anatomia vegetale con particolare riferimento alle relazioni fra struttura e funzione. -introdurre gli studenti alla diversità degli organismi vegetali, fornire le conoscenze necessarie all'identificazione delle specie vegetali integrandole con note sull'ecologia delle specie spontanee e sugli usi principali di quelle coltivate. English This course aims to: - Improve botanical literacy by learning the basic facts, principles and concepts in plant biology - Improve technical literacy by learning and how to use taxonomy and nomenclature rules to understand ecology and uses of spontaneous and cultivated species. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione della capacità di comprensione della biologia di base, di descrizione e riconoscimento delle strutture anatomico/istologiche delle piante superiori e della identificazione delle principali specie vegetali. - 215 - English Students will learn basic facts about biology and plant taxonomy. They should be able to critically describe plant structures (e.g. anatomical, histological and cytological structures), identify spontaneous and cultivated species, describe plant families. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 80 ore tra lezione frontale, attività di laboratorio ed attività di riconoscimento specie. Il materiale didattico (slide) utilizzato è a disposizione degli studenti. English The course consists of 80 hours (both lectures and laboratory -plant identification sessions). Didactic materials will be available for students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti sarà valutato di volta in volta con discussioni critiche al termine di ogni argomento in classe e durante le esercitazioni pratiche. L'esame finale consta di un pre-test con domande a risposta multipla che se superato da accesso al colloquio orale. Quest'ultimo prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. È inoltre obbligatoria la presentazione di un erbario di 30 esemplari, corredato dai propri recapiti, da consegnare presso lo studio del docente almeno 15 giorni prima della data d'appello. English Levels of learning acquired by the students will be evaluated regularly through periodic discussions at the end of each topic during class and lab lessons. The final exam consists of: - a written multiple choice test which has to be passed before the oral exam - an oral exam devoted to verify the candidate's ability to reason and connect between different topics - the evaluation of an herbarium (30 specimens) prepared at home. The herbarium has to be delivered to the teacher 15 days before the exam. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area delle conoscenze propedeutiche. Introduzione alla Botanica e cenni di Sistematica. Organizzazione e caratteristiche dei vegetali. Etero ed autotrofia. Domini e Regni, principali rapporti filogenetici tra gli organismi. Tallo e cormo: adattamenti per la vita in ambiente - 216 - terrestre. Citologia: la cellula vegetale. Morfologia, accrescimento e differenziamento cellulare. Struttura dei principali organuli citoplasmatici. Approfondimenti su parete cellulare (citodieresi, crescita, funzioni e composizione della parete, lamella mediana, parete primaria e parete secondaria, modificazioni), vacuoli e sistema plastidiale. Riproduzione cellulare. Istologia vegetale. Caratteristiche, funzioni e localizzazione dei tessuti. Meristemi primari e secondari. Tessuti definitivi (tessuti tegumentali, parenchimatici, segregatori, meccanici, conduttori). Fasci cribro-vascolari. La stele e la sua evoluzione. Organografia: struttura primaria e secondaria degli apparati caulinare e radicale. Tipi di ramificazione; tipi di apparato radicale. La foglia: origine ed evoluzione; anatomia del microfillo; anatomia dei principali tipi di macrofillo. Adattamenti di radice, fusto, foglie e habitus dei vegetali in relazione a differenti condizioni ambientali.Cenni sui sistemi di classificazione e categorie tassonomiche. Nomenclatura botanica attuale (codici internazionali per le specie spontanee e coltivate). I processi di identificazione degli organismi: chiavi dicotomiche e erbari. Gimnosperme caratteri generali e descrizione di Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta (Taxaceae, Cupressaceae, Pinaceae) Magnoliopsida e Liliopsida Descrizione (morfologia, caratteri generali, sistematica e distribuzione) delle principali famiglie di interesse agrario e dei generi più rappresentativi, caratteri per il riconoscimento, importanza ecologica ed economica. English Plant cellular biology: basic knowledge and organelle structure. Advanced examination of the morphology and function of cell wall, plastids, vacuoles. Cell division. Plant tissues: position, morphology and location. Primary and secondary meristems: growth and function. Epidermis, parenchyma, wood, phloem, collenchyma, sclerenchyma, secretion tissues. Vascular boundless and relation with organs. Anatomy. Stem and root differentiation and growth. Primary and secondary structure. Leaf anatomy description of basic leaf types. Root, stem and leaf modification. Reproduction. Life cycles. Individual reproductive unit in Gymnoperms and Angiosperms. Seed structure and functions and germination. Fruit anatomy and development. Systematic and phylogenetics: classification systems, taxonomic ranks, APG system. Plant scientific nomenclature. Identification tools for plants. Herbaria. Evolution and diversity of angiosperms and relationships with acquatic and terrestrial habitat. Gymnosperm: general morphology and ecology. Descriptions of Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta (Taxaceae, Cupressaceae, Pinaceae) Angiosperm families. Magnoliopsida general morphology and ecology. Families: Magnoliaceae, Lauraceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Moraceae, Juglandaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, Violaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Vitaceae, - 217 - Apiaceae, Convolvulaceae, Solanaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Oleaceae, Asteraceae. Other families (minor remarks). Liliopsida: general morphology and ecology. Families: Poaceae, Arecaceae, Zingiberaceae, Musaceae, Liliaceae, Iridaceae. Other families (minor remarks). TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Stern Kingsley R., Bidlack James E., Jansky Shelley H. 2009 Introduzione alla biologia vegetale McGraw-Hill Companies Pasqua G., Abbate G., Forni C., 2007 Botanica generale e diversità vegetale. Ed. PICCIN Gerlach, Lieder, Atlante di Anatomia vegetale, Ed. Muzio, 1986. English Stern Kingsley R., Bidlack James E., Jansky Shelley H. 2009 Introduzione alla biologia vegetale McGraw-Hill Companies Pasqua G., Abbate G., Forni C., 2007 Botanica generale e diversità vegetale. Ed. PICCIN Gerlach, Lieder, Atlante di Anatomia vegetale, Ed. Muzio, 1986 NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fl9a - 218 - Biologia generale e botanica (insegnamento per L- Scienze forestali e ambientali) (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL BIOLOGY AND BOTANY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0007 Docente: Da Nominare DOCENTE Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: BIO/03 - botanica ambientale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Le informazioni fornite mirano a far raggiungere le conoscenze di base sull'anatomia vegetale con correlazioni fra strutture e funzioni indispensabili per la comprensione dei metabolismi fondamentali. Si sottolineano le modalità di adattamento delle strutture per la sopravvivenza in diverse situazioni ambientali. Per le Briofite e Pteridofite vengono presentati anche i caratteri sistematici, mentre per le Spermatofite sono forniti i caratteri generali e le regole nomenclaturali propedeutiche per il programma da svolgere nel successivo corso di sistematica al secondo anno. English The course aims to make students reach standard knowledge on plant anatomy and understand correlations among structures, functions and fundamental metabolisms. Systematic of moss and fern are developed while only basic concepts and nomenclature rules are given for Spermatophytes intending to deepen in the following courses. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione della capacità di riconoscimento e descrizione delle strutture secondo il criterio anatomico/istologico/ citologico; acquisizione dei concetti generali sui principali metabolismi (fotosintesi, respirazione, regolazione della crescita). English - 219 - Students may be able to recognize and describe plant structures at anatomical, histological and cytological levels. They will be asked also to describe major physiological metabolisms and plant needs (photosynthesis, cellular respiration and growth controls). MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 80 ore di lezioni frontali ed attività in laboratorio di microscopia. Il materiale didattico (slide) utilizzato è a disposizione degli studenti. English The course consists of 80 hours (both lectures and laboratory sessions). Didactic materials will be available for students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti sarà valutato durante le esercitazioni pratiche e con discussioni critiche al termine di ogni argomento. L'esame finale consta di un pre-test scritto con domande a risposta multipla che se superato da accesso al colloquio orale. Quest'ultimo prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite (riconoscimento di un preparato anatomico/istologico/citologico presentato in immagine, discussione di argomenti trattati nelle lezioni frontali; verifica sull'acquisizione delle nozioni base di nomenclatura botanica). English Levels of learning acquired by the students will be evaluated regularly during lab lessons and through periodic discussions at the endo of each topic. The final exam consists of a written multiple preliminary choice test which has to be passed before the oral exam plus an oral exam devoted to verify the candidate's ability to reason and connect between different topics (identification of a microscopic slide or image, discussion on plant structres and function and on botanical nomenclature rules). PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area delle conoscenze propedeutiche. I vegetali: loro caratteristiche e livelli di organizzazione: dai procarioti alle cormofite. Citologia: la cellula vegetale e le sue peculiarità morfologiche e fisiologiche. Siti per la fotosintesi (C3, C4, CAM) e la respirazione cellulare. Descrizione generale dei due processi metabolici. Istologia: meristemi primari e secondari, loro collocazione, morfologia e caratteristiche fisiologiche, regolazione della funzionalità. Meccanismi di risposta a ferite accidentali e non (potature, innesti). Tessuti definitive: morfologia e principali funzioni. Invecchiamento e morte dei diversi tessuti e ricadute sulla pianta in toto. - 220 - Organografia: struttura primaria e secondaria degli apparati caulinare e radicale. Assorbimento e traslocazione dei fluidi. La foglia: origine ed evoluzione; anatomia del microfillo; anatomia dei principali tipi di macrofillo. Modificazioni ed adattamenti di foglie, radici, fusti. Habitus dei vegetali in relazione alle situazioni ambientali. Caratteristiche per il superamento della stagione sfavorevole: forme biologiche. Strutture per la moltiplicazione vegetativa e sessuale. Passaggio dalla vita vegetativa alla fase riproduttiva: fattori endogeni ed esogeni (fotoperioidismo e termoperioidismo, ormoni vegetali). Cicli riproduttivi. Formazione del seme in Gimnosperme ed Angiosperme: significato ecologico. Formazione del frutto in Angiosperme. Specie monocarpiche e policarpiche. Tallofite, Briofite, Pteridofite (caratteri sistematici ed ecologici). I sistemi di classificazione botanica, regole di nomenclatura. English The main topics are: The main morphological organization levels in plants: prokaryotes, eukaryotes; thallophyte, cormophyte. Plant cell and its organization (morphology and function). Basic concepts on photosinthesis (C3, C4, CAM) and cell respiration. From cells to tissues in different structures and functions. Morphological aspects and functions of meristems and tissues, their development, aging and death. The root, stem and leaf anatomy and functions in Spermatophytes. Root, Stem and leaf modification and habitus related to ecological conditions. Biological types with reference to the adaption of plants to survive the unfavourable season. Reproduction and reproductive structures in Spermatophytes. Plant life cycles. Seed and fruit stuctures, ecology meaning and classification. Systematic and ecological characters of Algae, Bryophyta and Pterydophyta. Classification and Systematics. Types of classification systems: Levels of taxonomic categories. International code of nomenclature. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Evert, Eichhorn, 2013 - La biologia delle piante di Raven. Zanichelli Editore Purves W., Sadava D. et al. – Biologia. La Biologia delle piante. Zanichelli, 2009 Stern Kingsley R., Bidlack James E., Jansky Shelley H. 2009 Introduzione alla biologia vegetale McGraw-Hill Companies Mauseth J. D. Botanica (parte generale). II edizione italiana, Idelson Gnocchi, Napoli, 2006 Atlanti di anatomia Gerlach, Lieder –Atlante di Anatomia vegetale. Ed. Muzio, 2002 Speranza A. G.L. Calzoni Struttura delle piante in immagini 1996 http://www.atlantebotanica.unito.it/page.asp http://www.dipbot.unict.it/tavole/index.html http://botweb.uwsp.edu/anatomy/ English - 221 - Evert, Eichhorn, 2013 - La biologia delle piante di Raven. Zanichelli Editore Purves W., Sadava D. et al. – Biologia. La Biologia delle piante. Zanichelli, 2009 Stern Kingsley R., Bidlack James E., Jansky Shelley H. 2009 Introduzione alla biologia vegetale McGraw-Hill Companies Mauseth J. D. Botanica (parte generale). II edizione italiana, Idelson Gnocchi, Napoli, 2006 Atlas of Plant Anatomy Gerlach, Lieder –Atlante di Anatomia vegetale. Ed. Muzio, 2002 Speranza A. G.L. Calzoni Struttura delle piante in immagini 1996 http://www.atlantebotanica.unito.it/page.asp http://www.dipbot.unict.it/tavole/index.html http://botweb.uwsp.edu/anatomy/ NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w53k - 222 - Biologia generale e fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL BIOLOGY AND PLANT PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0027 Docente: Prof. Francesca CARDINALE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708875, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Partendo da nozioni di base in chimica generale, fisica e biologia, si vuole portare lo studente a sviluppare la capacità di interpretare le strategie che gli organismi hanno adottato nel corso dell'evoluzione per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali. Il corso quindi mira a fornire gli strumenti indispensabili per comprendere il funzionamento della biosfera, con enfasi sugli organismi vegetali (soprattutto di interesse alimentare). English Starting from basic chemistry, physics and biology concepts, the student will develop the ability to interpret and understand the strategies living beings adopted throughout evolution to fulfil their vital needs. The course therefore aims to give the students the tools indispensable to understand how the biosphere works, focusing on edible plants. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Comprensione del funzionamento di base delle "macchine" biologiche, con enfasi sugli organismi vegetali English Understanding of the workings of cells and organisms, focusing on plants MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a esercitazioni e attività di laboratorio. Per le lezioni - 223 - frontali il docente si avvale di presentazioni che non saranno a disposizione degli studenti con l'eccezione del materiale didattico caricato su campusnet. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and visits the wine establishments. The teacher makes use of presentations that are not made available to the students but for the "materiale didattico" available on campusnet. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Interazione continua con gli studenti in classe, nel corso delle lezioni frontali e specialmente delle esercitazioni pratiche. Test scritto non verbalizzante + esame orale verbalizzante a fine corso. Il test scritto consiste di 15 domande a risposta chiusa sull'intero programma. L'idoneità al test scritto è un prerequisito per l'ammissione all'esame orale, che copre l'intero programma e comprende l'osservazione microscopica di preparati anatomici vegetali. English Continuous student-teacher interaction during class, and especially practical work in the lab. Written test + oral exam at the end of the course. The written text consists of 15 multiple-choice questions, covering the whole programme. Passing the test (yes/no outcome) is a prerequisite for admission to the oral examination, which will cover the whole programme and include microscope observation of botanical slides. PROGRAMMA Italiano Questo corso appartiene all'area di apprendimento 1 (formazione di base). Principali caratteristiche degli esseri viventi, livelli di organizzazione biologica e principi di tassonomia. Principi fondamentali di evoluzione biologica: il Darwinismo. Principali tipi di legame chimico e gruppi funzionali rilevanti in biologia. Caratteristiche dell'acqua e loro influenza sulla biosfera. Equilibrio osmotico. Componenti organiche e inorganiche della cellula. Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. ATP ed enzimi. Metabolismo: flussi di energia, significato biologico di anabolismo e catabolismo. Glicolisi, respirazione, fermentazione, fotosintesi (C3, C4, CAM). Cellule procariotiche ed eucariotiche, animali, fungine e vegetali. Struttura, morfologia e componenti cellulari. Organizzazione delle cellule in tessuti ed organi. Duplicazione del DNA. Il codice genetico, la sintesi proteica e il controllo dell'espressione genica negli eucarioti. Struttura ed organizzazione dei cromosomi. Cariotipo. Crescita e divisioni cellulari: mitosi e meiosi. Livelli di ploidia. Cicli vitali di diversi organismi. Riproduzione sessuale e propagazione vegetativa. Cenni di genetica Mendeliana. Elementi di tassonomia vegetale ed organizzazione anatomica delle angiosperme Meccanismi di trasporto e nutrizione nelle piante. Regolazione ormonale dello sviluppo vegetale e interazioni con l'ambiente. Sviluppo del fiore e dell'embrione, anatomia di seme e frutto. Germinazione del seme. Microscopia: la struttura e il funzionamento di M.O., SEM e TEM. Preparazione, osservazione al M.O. ed analisi di funghi microscopici e cellule, tessuti ed organi vegetali. - 224 - English This course belongs to the education sector 1 (basic training). The class focuses on subjects that are configured in the learning context of training and basic concepts. Main characteristics of living beings, biological organization levels and taxonomical principles. Fundamentals in evolution: Darwin's theory. Main kinds of chemical bonds and functional groups relevant in biology. Water characteristics and their influence on our environment. Osmotic balance. Organic and inorganic components in the cell. Biological macromolecules: carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. ATP and enzymes. Metabolism: energy flows, biological meaning of anabolism and catabolism. Glycolysis, respiration, fermentation, photosynthesis (C3, C4 and CAM). Prokaryotic and eukaryotic, plant, fungal and animal cells. Cell structure, morphology and components, organization in tissues and organs. DNA duplication. The genetic code, protein synthesis and the control of gene expression in eukaryotes. Structure and organization of chromosomes. Karyotype. Cell growth and division processes: mitosis and meiosis. Ploidy levels. Life cycles of different organisms. Sexual and asexual reproduction. Basics in Mendelian genetics. Fundamentals in plant taxonomy and anatomical organization in angiosperms. Transport mechanisms and nutrition in plants. Hormonal regulation of plant development and interactions with the environment. Flower and embryo development. Fruits and seed anatomy. Seed germination. Microscopes: the structure and functioning of M.O., SEM and TEM. Preparation, M.O. observation and analysis of microscopic fungi, plant organs, tissues and cells. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Testi base consigliati per il corso: HILLIS DM, SADAVA D, HELLER HC, PRICE MV. FONDAMENTI DI BIOLOGIA. Zanichelli. ISBN: 9788808195340 GERLACH D, LIEDER J. ANATOMIA VEGETALE AL MICROSCOPIO. Muzzio Scuola ed., Padova Per approfondimenti e integrazioni è fortemente consigliato l'utilizzo del materiale didattico disponibile su campusnet dall'inizio del corso English Recommended textbooks: HILLIS DM, SADAVA D, HELLER HC, PRICE MV. PRINCIPLES OF LIFE. Feeman WH & Co, NY. GERLACH D, LIEDER J. ANATOMIA VEGETALE AL MICROSCOPIO. Muzzio Scuola Ed., Padova. ISBN 88-7021-590-3 For further research material, please refer to the "materiale didattico" made available on campusnet at the beginning of the course - 225 - NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=57wb - 226 - Biologia molecolare (Anno Accademico 2015/2016) MOLECULAR BIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0132 Docente: Contatti docente: Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: BIO/11 - biologia molecolare Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Mutuato da: http://biologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d965; Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0rt6 - 227 - Biologia molecolare vegetale (Anno Accademico 2015/2016) Plant Molecular Biology Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0797 Docente: Prof. Luisa Lanfranco Contatti docente: +39 011 6705969, [email protected] Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: BIO/01 - botanica generale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone di fornire le conoscenze sui meccanismi molecolari alla base di alcune attività cellulari nei sistemi vegetali. In particolare, verranno fornite conoscenze sulle caratteristiche dei genomi nucleari, mitocondriali e plastidiali e sulle attività di regolazione dell'espressione genica. English Deep knowledge on the features of plant genomes (nuclear, mitochondrial and plastid DNAs) and on the regulation of gene expression. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano - Competenze culturali nel settore biomolecolare (organizzazione del genoma e regolazione dell'espressione genica) e preparazione scientifica avanzata a livello morfologico/funzionale e cellulare/molecolare dei sistemi vegetali - Competenze applicative in riferimento al metodo scientifico di indagine, alla capacità di eseguire un protocollo sperimentale per un'analisi molecolare su acidi nucleici (in particolare un'analisi di espressione genica) - Competenze nella valutazione, interpretazione e rielaborazione di dati di letteratura - Capacità di illustrare i risultati della ricerca e di lavorare in gruppo English - 228 - Advanced knowledge on molecular mechanisms at the bases of some cellular actvities in plant systems (genome organization and regulation of nuclear and organellar gene expression). Skills on experimental methods for the analysis of nucleic acids (in particular gene expression). Autonomy in the evaluation and elaboration of literature data Skills to present data, ability to work in a team MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 48 ore di lezione frontale e 12 ore dedicate a attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. Sono previste presentazioni da parte degli studenti di pubblicazioni scientifiche inerenti gli argomenti trattati. English The course consists of 48 hours of lectures and 12 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. Students will be asked to give oral presentations on selected scientific publications. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame finale è un colloquio orale che prevede di affrontare almeno 2 temi tra quelli trattati nelle lezioni teoriche in cui il docente si avvarrà di domande specifiche volte a verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. Un'ulteriore domanda verterà sugli approcci sperimentali di analisi dell'espressione genica presentati a lezione e durante le esercitazioni in laboratorio. English The final exam is an oral exam on at least two topics among those presented during the theoretical lessons. The interview includes the verification of the ability to make connections between the knowledge acquired. A further question will concern the experimental approaches for the analysis of gene expression presented during lectures and practical training. PROGRAMMA Italiano Area di formazione generale L'informazione genetica nella cellula vegetale. Il genoma nucleare; la struttura del gene nelle piante - confronto con organismi animali e fungini-. Il fenomeno della poliploidia. Le sequenze ripetute; l'organizzazione di centromeri e telomeri. Gli elementi trasponibili. I progetti genoma nel Regno Piante: sintenia e colinearità, considerazioni di carattere evolutivo. Il trasferimento genico orizzontale. I genomi degli organelli DNA mitocondriale (evoluzione, struttura, organizzazione; il fenomeno della CMS) - 229 - DNA plastidiale (evoluzione, struttura, organizzazione, ruolo nelle biotecnologie -plastid genetic engineering-). Il trasferimento genico tra organelli. L'espressione genica negli organelli, l'RNA editing. Area biologico-molecolare Il controllo dell'espressione genica: elementi cis e trans (le famiglie di fattori trascrizionali); cenni sui piccoli RNA. Meccanismi epigenetici di controllo dell'espressione genica: metilazione del DNA, modificazioni a carico delle proteine istoniche; chromatin modelling proteins. Tecniche di analisi dell'espressione genica (Northern blot, RT-PCR semi-quantitativa e quantitativa); studio dell'espressione genica in tipi cellulari specifici: ibridazione in situ; piante transgeniche che esprimono costrutti di fusione promotore/gene reporter; la microdissezione laser. Approcci sperimentali per la caratterizzazione di fattori trascrizionali: gel shift, Chromatin immunoprecipitation (ChIP). Presentazione da parte degli studenti e discussione di pubblicazioni scientifiche inerenti gli argomenti trattati. Esercitazioni Estrazione di RNA, analisi quali- e quantitativa, reazione di RT-qPCR. Microdissezione laser. English General formation area The genetic information in the plant cell. The nuclear genome; gene structure in plants (comparison with fungi and animals). Polyploidy. Repeated sequences (organization of centromeres and telomeres). Transposable elements. Genome projects in the Plant kingdom: sinteny and colinearity, evolutionary aspects. Horizontal gene transfer. The genomes of organelles Mitochondrial DNA (evolution, structure, organization, the cytoplasmic male sterility -CMS-) Plastid DNA (evolution, structure, organization, role in biotechnology -plastid genetic engineering-). Gene transfer between organelles. Gene expression in plant organelle genomes; RNA editing. Biological and molecular area Regulation of gene expression: cis elements, trans elements (family of transcription factors); small RNAs. Epigenetic mechanisms (DNA methylation, modification of histones; chromatin remodelling proteins) Techniques for targeted gene expression analysis (Northern blot, RT-PCR semi-quantitative and quantitative); celltype specific gene expression analyses: in situ hybridization; transgenic plants (promoter/gene reporter fusion construct); laser microdissection. Experimental approaches to characterize transcription factors: gel shift, Chromatin immunoprecipitation (ChIP). Signal transduction: overview of main components;receptors, membrane microdomain; second messangers (cyclic nucleotides, reactive species of oxygen and nitrogen). - 230 - Oral presentation and discussion of scientific publications by students. Practical training RNA extraction, quali- and quantitative analysis, RT-qPCR reaction. Laser microdissection. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano G. PASQUA. BIOLOGIA CELLULARE E BIOTECNOLOGIE VEGETALI. 2011 Casa editrice PICCIN ISBN: 978-88-299-2124-9 COD: 1600280 BUCHANAN BB , GRUISSEM W , JONES RL.. BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE 2003, Ed. Zanichelli. Verranno fornite dal docente pubblicazioni scientifiche tratte da riviste internazionali English G. PASQUA. BIOLOGIA CELLULARE E BIOTECNOLOGIE VEGETALI. 2011 Casa editrice PICCIN ISBN: 978-88-299-21249 COD: 1600280 BUCHANAN BB , GRUISSEM W , JONES RL.. BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE 2003, Ed. Zanichelli. Recent scientific publications from international journals will also be provided. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=snwk - 231 - Biotecnologie genetiche - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) GENETIC BIOTECHNOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0520 Docente: Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Dott. Andrea MOGLIA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708800, [email protected] Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 12 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/07 - genetica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Aspetti applicativi delle biotecnologie vegetali (Anno Accademico 2015/2016) Trasformazione genetica (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0s59 Aspetti applicativi delle biotecnologie vegetali (Anno Accademico 2015/2016) Applied plant biotechnologies Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0520 Docente: Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708800, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale - 232 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente conoscenze sui principali aspetti applicativi delle biotecnologie con particolare riferimento al miglioramento genetico e allo studio delle specie arboree da frutto. Fornire allo studente conoscenze sulle basi genetiche di caratteri di interesse e delle principali strategie biotecnologiche per ottenere piante con caratteri migliorati. English To provide knowledge on the main practical aspects of biotechnologies with particular attention to breeding and studying fruit and nut crops. To provide knowledge on the genetic bases of traits of interest and of the main strategies to obtain plants with improved characters. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenze sulle applicazioni delle biotecnologie al miglioramento genetico e allo studio delle specie vegetali con particolare riferimento a quelle arboree da frutto English Knowledge on the application of biotechnologies to breeding and study of plant species with particular attention to fruit and nut tree species MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Tradizionale English Traditional MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame sarà orale e prevede in linea di massima 3 domande su argomenti diversi; il docente potrà fare ulteriori domande qualora questo fosse necessario per la miglior valutazione della preparazione dello studente. Ogni domanda avrà uguale peso ai fini della formazione del voto finale. English Oral test. As general rule the exam is based on 3 questions on different arguments; the teacher may ask further questions in case this is considered necessary for the most appropriate evaluation of the student. Each question will have the same weight for the attribution of the final mark. - 233 - PROGRAMMA Italiano Il corso fa interamente riferimento all'Area Formativa Biotecnologica Introduzione alla materia: principali applicazioni, sviluppi e prospettive delle biotecnologie per le specie arboree da frutto. Le tecniche di coltura in vitro: principi generali, micropropagazione, morfogenesi in vitro, coltura di protoplasti, fusione somatica, ottenimento di aploidi. Interesse applicativo di queste tecniche. La trasformazione genetica nelle piante arboree da frutto, sintesi delle tecniche. Applicazioni biotecnologiche dei marcatori molecolari: caratterizzazione genetica di cultivar, specie e cloni; riconoscimento varietale e delle produzioni; realizzazione di mappe; selezione assistita con marcatori (MAS). Basi genetiche e modificazioni dell'habitus vegeto-produttivo della pianta; interventi per modificare le dimensioni della pianta e la rizogenesi. Conoscenze genetiche sui meccanismi che portano alla fioritura e alla fruttificazione ed interventi che permettono il superamento della giovanilità e delle barriere di autoincompatibilità fiorale. Interventi per modificare il contenuto in lignina per le applicazioni industriali del legno. Strategie per favorire l'assorbimento e la traslocazione degli elementi minerali per la migliore utilizzazione delle risorse minerali e la biofortificazione. Modificazioni genetiche del sistema fotosintetico C3 e dei meccanismi di traslocazione ed accumulo dei fotosintetati per aumentare la produttività delle colture. Basi genetiche della qualità e modificazioni per migliorare le caratteristiche del frutto per quanto riguarda: profilo aromatico, contenuto in vitamina C, colore e sostanze di interesse nutraceutico, tessitura, contenuto in acidi organici e zuccheri, apirenia, imbrunimento ossidativo. Interventi per variare l'andamento della maturazione del frutto: riduzione e soppressione della sintesi di etilene. Allergeni vegetali e prospettive per la loro eliminazione tramite l'ingegneria genetica. English Main applications, developments and perspectives of fruit crops biotechnologies. In vitro techniques and gene transfer in fruit tree species. Micropropagation, ovule and protoplast culture, somatic hybridization, obtaining aploids, morphogenesis (organogenesis, somatic embryogenesis). Applications and uses of molecular markers: genetic characterization of cultivars, species, clones; cultivar and crop identification; linkage map construction; marker assisted selection (MAS). Genetic bases and modifications of the vegetative and productive tree habit; interventions and studies for overcoming self-incompatibility and juvenility and for changing tree habit and rooting ability. Modifications of the lignin content for industrial applications. Strategies for improving the uptake and translocation of mineral elements for an optimal use of mineral resources in soil and for biofortification. Genetic engineering of the photosintetic system C3 and of mechanisms of translocation and storage of photosynthates to increase crop yield. Genetic bases of quality and modifications for improving fruit and nut quality traits: aroma, vitamin C content, pulp texture and softening, organic acids and sugars content, colour and antioxidant properties, browning aptitude, seedlessness. Genetic bases and modifications for controlling the ethylene methabolism and the ripening process. Allergenes in plants and perspectives of their elimination in food by genetic engineering. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - 234 - Articoli e slides forniti del docente Altman A., Hasegawa P.M. 2012. Plant biotechnology and Agriculture. Academic Press Slater A., Scott W.N., Fowler M.R. 2008 Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants. Oxford University Press. AAVV 2012. Arboricoltura generale, Patron ed. Bologna English NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kpf3 - 235 - Trasformazione genetica (Anno Accademico 2015/2016) Genetic transformation of plants Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0520 Docente: Dott. Andrea MOGLIA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708810, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/07 - genetica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il modulo ha come scopo quello di fornire conoscenze sulle metodiche di trasformazione genetica, principali obiettivi e applicazioni della trasformazione genetica vegetale, diffusione OGM a livello globale, metodiche di analisi sperimentale per la tracciabilità di OGM nelle filiere produttive e aspetti normativi legati all'immissione di OGM. English This course will provide knowledge about experimental methods and objectives of plant genetic transformation, on the current status of transgenic crops, on the regulation of GM plants and methods of experimental analysis for the traceability of GMOs in the food chains. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Attraverso le attività formative gli studenti acquisiranno competenze teoriche e operative relative agli aspetti applicativi delle biotecnologie che interessano le piante di interesse agroalimentare ed industriale con particolare riferimento alla trasformazione genetica vegetale. English Through the educational activities the students will acquire theoretical and practical skills related to applied aspects of biotechnology involving plants of agri-food and industrial interest and mainly related to plant genetic transformation. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 236 - Italiano Il corso consiste di 48 ore di lezioni frontali e 12 ore dedicate ad attività di laboratorio/esercitazioni. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 48 hours of lectures and 12 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'apprendimento sarà verificato in classe attraverso domande volte a valutare il grado di comprensione degli argomenti trattati. Inoltre, attraverso la presentazione di lavori di gruppo saranno verificate non solo le capacità di analisi e di comprensione di un lavoro tecnico scientifico ma anche le abilità comunicative. L'esame finale è scritto e consiste in 10 domande aperte sull'intero programma svolto. English Learning is verified during the lesson through questions aimed to verify student's comprehension. The applying knowledge and the communication skills will be developed and evaluated by the presentation of group works. The final exam is a written exam composed of 10 open-ended questions that covers the whole program carried out. PROGRAMMA Italiano Il corso fa interamente riferimento all'Area Formativa Biotecnologica. Lezioni teoriche: -Trasformazione genetica mediata da Agrobacterium tumefaciens: descrizione del batterio, caratteristiche del plasmide Ti e dei geni VIR, meccanismo di trasferimento del T-DNA da Agrobacterium. -Tecniche di trasformazione vegetale mediante metodi diretti: biolistica, mediata da Polyethilene-glicole, elettroporazione, Silicon carbide fibres, Bioactive beads, microiniezione. -Costruzione di vettori per la trasformazione genetica: caratteristiche generali, tipologie (vettore cointegrativo/binario), preparazione, sviluppo ed ottimizzazione. -Protocolli di trasformazione genetica: co-coltura, agroinfiltrazione, floral dip. -Trasformazione cloroplastica. -Definizione e ottenimento di piante cisgeniche e intrageniche. -Silenziamento genico mediato da virus (VIGS): caratteristiche dei vettori per il VIGS ed esempi di applicazioni. -Ottenimento di piante marker free: utilizzo di geni marcatori alternativi ad antibiotici/erbicidi, Co-trasformazione, Multi autotransformation, sistema di ricombinazione cre/lox, sistema di ricombinazione FLP/FRT, AC/DS transposon system. -New Plant Breeding technologies: Reverse Breeding, Grafting on GM rootstock, Oligonucleotide directed mutagenesis, Target genome editing (Zinc Finger Nucleases, Talen, Homing Endonucleases, Engineered CRISPR-Cas system). - 237 - -Situazione attuale delle coltivazioni di varietà GM nel mondo. -Obiettivi e applicazioni della trasformazione genetica: Tolleranza ad erbicidi: modificazione genetica per tolleranza al glifosate, glufosinate, inibitori acetolattato sintasi. Principali eventi GM per tolleranza ad erbicidi. Rischio di formazione delle super weeds e strategie di prevenzione. Resistenza ad insetti: struttura, funzione e meccanismo di azione delle cry proteins. Piante geneticamente modificate per la resistenza a insetti basati sull'utilizzo dei geni Cry e altri geni insetticidi. Tolleranza a stress abiotici: strategie di ingegneria genetica basato sull'uso di sostanze osmoprotettive, modificazione genetica per la tolleranza allo stress salino, da freddo e da calore. Esempi di piante GM per la tolleranza allo stress idrico. Miglioramento di caratteri agronomici: intervento sulla maturazione del frutto e sulla riduzione di composti tossici (es. acrilamide). Plant biofortification: modificazione del contenuto di provitamina A, arricchimento nel contenuto di amminoacidi, folati, ferro e zinco, metaboliti secondari mediante strategie di ingegeneria genetica. Plant molecular farming: produzione di composti ad uso medico /farmaceutico/ industriale. Modificazione della via biosintetica dell'amido e degli acidi grassi. Utilizzo di piante GM per la produzione di bioplastiche e di biofuels. Piante GM per la produzione di proteine farmaceutiche, enzimi ad uso industriale, anticorpi e vaccini in pianta. -Analisi di laboratorio per il rilevamento di OGM. Norme per l'etichettatura. Tracciabilità nelle filiere produttive di OGM. Tecniche per l'identificazione, rilevamento e quantificazione di OGM. -Normativa sulla sperimentazione, coltivazione e commercializzazione di varietà vegetali GM. -Valutazione dei rischi per la salute delle varietà GM rispetto alle colture tradizionali. Esercitazioni di laboratorio: messa a punto di vettori per la trasformazione genetica mediante clonaggio Gateway, trasformazione genetica transiente in N. benthamiana e in carciofo (tramite VIGS). English The course topics fall entirely within the Biotechnologic Educational Area. Lectures: -Plant genetic transformation mediated by Agrobacterium tumefaciens: description of bacterium, features of Ti plasmid and vir genes, transfer mechanism of T-DNA from Agrobacterium. -Direct-gene transfer: biolistic method, Polyethilene-glicole mediated, electroporation, Silicon carbide fibres, Bioactive beads, microinjection. -Vectors for plant transformation: features, types (co-integrative vs binary), setting up, development and optimization. -Protocols for plant genetic transformation: co-colture, agroinfiltration, floral dip. -Chloroplast transformation -Cisgenic and Intragenic plants -Virus Induced gene silencing (VIGS) - 238 - -Marker free plants: marker genes alternatives to antibiotics/herbicides, Co-transformation, Multi autotransformation, recombination system cre/lox, recombination system FLP/FRT, AC/DS transposon system. -New Plant Breeding technologies: Reverse Breeding, Grafting on GM rootstock, Oligonucleotide directed mutagenesis, Target genome editing (Zinc Finger Nucleases, Talen, Homing Endonucleases, Engineered CRISPR-Cas system). -The current status of transgenic crops. -Goal and application of plant transformation: Herbicides tolerance: glyphosate, glufosinate, inhibitor of acetolactate synthase. Main examples of GM plants tolerant to herbicides. Risk of super weeds formation and prevention mechanism. Pest resistance: structure, function and mechanism of action of cry proteins. Genetically modified plants based on the use of cry protein and other genes. Abiotic stress tolerance: engineering strategies based on the use of osmoprotectant, and to give tolerance to salt, cold and heath shock stresses. Examples of GM plants for drought tolerance. Agronomic trait improvement: ripening modification and reduction of toxic compounds (e.g. acrylamide). Plant biofortification: modification of provitamin A content, enrichment in the content of aminoacids, iron and zinc, folic acid and secondary metabolites. Plant molecular farming: production of pharmaceutically relevant and industrial relevant compounds. Modification of starch and fatty acids pathway. GM plants for biofuels and bioplastic production. Production of pharmaceuticals proteins, industrial enzymes, antibody and vaccines in GM plant. -GMO detection and traceability in the food chain. -The regulation of GM crops and products. -Evaluation of the risk for human of GM crops as compared to conventional crops. Practical training: -preparation of plant genetic transformation vector through Gateway technology and setting up of transient transformation of N. benthamiana and VIGS in artichoke. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Slater A., Scott N., Fowler M.-Plant Biotechnology: The genetic manipulation of plants. 2008. Oxf. Univ.Press. Altman A., Hasegawa P.M. Plant Biotechnology and Agriculture 2012 Academic Press Articoli e materiale fornito dai docenti English Altman A., Hasegawa P.M. Plant Biotechnology and Agriculture 2012 Academic Press Slater A., Scott N., Fowler M.-Plant Biotechnology: The genetic manipulation of plants. 2008. Oxf. Univ.Press. Papers and material provided by the teachers NOTA Italiano - 239 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tl8f - 240 - Biotecnologie microbiche (Anno Accademico 2015/2016) MICROBIAL BIOTECHNOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0618 Docente: Prof. Ilaria Maria MANNAZZU (Affidamento esterno) Contatti docente: 079 229385, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/16 - microbiologia agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per la gestione di processi fermentativi innovativi (fermentazioni in continuo con cellule libere o immobilizzate, fermentazioni batch con riciclo di biomassa, utilizzo di starter misti di fermentazione). Verrà inoltre trattato il funzionamento di processi biotecnologici destinati alla produzione di starter, enzimi e antimicrobici naturali di utilizzo nell'industria enologica. English The main objective of the course is to provide students with the theoretical and practical notions necessary for the management of innovative fermentative processes (continuous fermentation with free or immobilized starters, cell recycle batch fermentation, utilization of mixed starters). In addition, the biotechnological processes aimed at the production of starters, enzymes and natural antimicrobials of use in wine industry will be treated in depth. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studio e la comprensione dei più recenti sviluppi riguardanti la vinificazione in continuo o in batch e l'utilizzo degli starter o di metaboliti microbici in campo enologico forniranno agli studenti le conoscenze necessarie per sperimentare, e trasferire alle realtà locali, procedure innovative finalizzate al miglioramento della gestione del processo fermentativo e della qualità del vino. - 241 - English The study and elucidation of recent developments in continuous and batch fermentations and the use of starters or microbial metabolites in winemaking biotechnology will provide students with specific knowledge necessary to experiment and transfer innovative procedures aimed at improving the management of the fermentative process and wine quality to local productive realities. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame orale English Oral exam Esame Orale PROGRAMMA Italiano Introduzione al corso. Sviluppo di nuove biotecnologie fermentative. Processi batch e continui. Starter liberi e immobilizzati. Colture multistarter in vinificazione. Impiego simultaneo di lieviti e batteri lattici. Metaboliti microbici in vinificazione. Enzimi. Tossine killer. Esercitazioni. Produzione di starter microbici in pasta. Produzione e parziale purificazione di tossine killer. Vinificazione in batch e in continuo. Analisi dei vini prodotti English Introduction.Development of innovative biotechnologies. Batch and continuous processes. Starters: utilization of free or immobilized cells. Multistarter cultures in winemaking. Simultaneous inoculation of yeast and lactic bacteria. Microbial metabolites in winemaking. Enzymes. Killer toxins. Lab classes: Production of microbial starters. Production and partial purification of killer toxins. Batch and continuous winemaking. Analyses of wines. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Biodiversity and Biotechnology of wine yeasts (2002) M. Ciani (Ed) , Research Signpost, Trivandrum, India Microbiologia del vino (2005) M.Vincenzini, P Romano, GA Farris (Eds) Casa editrice ambrosiana, Milano. Sarà cura del docente fornire pubblicazioni inerenti gli argomenti trattati e altro materiale ritenuto utile. English Biodiversity and Biotechnology of wine yeasts (2002) M. Ciani (Ed) , Research Signpost, Trivandrum, India - 242 - Microbiologia del vino (2005) M.Vincenzini, P Romano, GA Farris (Eds) Casa editrice ambrosiana, Milano. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y3of - 243 - Biotecnologie microbiche in enologia (Anno Accademico 2015/2016) MICROBIAL BIOTECHNOLOGY IN OENOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0616 Docente: Dott. Ileana Vigentini (Contratto) Contatti docente: 0250319165, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/16 - microbiologia agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano La finalità del corso è fare acquisire conoscenze sull'identità, sugli aspetti genetici e sul ruolo dei microrganismi che possono intervenire nella filiera vinicola. Oggetto di studio sono i lieviti e i batteri di principale interesse per il processo di vinificazione. Saranno forniti allo studente strumenti conoscitivi per isolare, identificare e caratterizzare i microrganismi per il monitoraggio del processo di vinificazione e per il riconoscimento e la prevenzione delle alterazioni microbiche del vino. Inoltre, verranno trattate le nozioni di base sulle biotecnologie microbiche e l'uso di microrganismi geneticamente modificati in enologia. English Aim of the course is to give basic knowledge for understanding the identity, the genetic traits and the role of wine microorganisms with particular attention to lactic acid bacteria and yeasts, as well as the microorganisms that can modify the final product. In addition, the course will release information on microbial biotechnology and the use of genetically modified microorganisms in winemaking. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente, alla fine del corso, acquisirà delle conoscenze di base e avanzate nell'ambito della genetica dei microrganismi enologici e della biologia molecolare. In generale, i risultati dell'apprendimento attesi riguarderanno: i) identificazione e tipizzazione delle specie microbiche associate all'ambiente enologico; ii) tecnologia del DNA ricombinante. Lo studente sarà in grado di elaborare consulenze/soluzioni relativamente all'applicazione di tecniche di identificazione e caratterizzazione molecolare dei microrganismi. Acquisirà autonomia di giudizio partecipando personalmente ad esercitazioni - 244 - pratiche incentrate su punti chiave della trasformazione enologica (inoculo/ceppi starters, monitoraggio della fermentazione/identificazione e caratterizzazione dei ceppi dominanti, deterioramento del prodotto/identificazione di microrganismi contaminanti). English At the end of the course, the student will acquire basic and advanced knowledge regarding genetics and molecular biology of wine microorganisms. In general, the expected learning outcomes will include: i) identification and typing of microbial species associated with wine environment; ii) recombinant DNA technology; iii) GMM in oenology. The student will be able to provide advice/solutions for the implementation of molecular techniques useful for the identification and typing of microorganisms. The student will improve her/his judgment thanks to the participation to practical lessons focusing on key points in wine transformation (inoculum/starter strains, monitoring of fermentation/identification and characterization of the dominant strains, wine spoilage/identification of spoilage microorganisms). MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Journal Club: preparazione di una presentazione orale e scritta sulla base di una pubblicazione scientifica avanzata e internazionale. Domande orali sui temi della pubblicazione e su quelli trattati durante il corso. English Journal Club: oral presentation on the available international scientific literature. Esame scritto e orale PROGRAMMA Italiano Lezioni teoriche Sistematica di lieviti e batteri lattici basata su criteri molecolari Filogenesi dei microrganismi di interesse enologico Il genoma di S. cerevisiae Il genoma di O. oeni Dinamica dei genomi di lieviti e batteri Lieviti non-Saccharomyces in enologia Analisi genetica di microrganismi di interesse enologico - 245 - Tecniche di estrazione di acidi nucleici da matrici enologiche Sequenziamento del DNA Strumenti molecolari d'identificazione della specie Strumenti molecolari di tipizzazione Le biotecnologie microbiche La tecnologia del DNA ricombinante Applicazioni biotecnologiche in enologia Esercitazioni Isolamento di lieviti da mosto Estrazione e purificazione del DNA degli isolati Amplificazione PCR delle regioni ITS e separazione elettroforetica dei prodotti di PCR Tipizzazione attraverso amplificazione PCR delle regioni Interdelta di S. cerevisiae e digestione enzimatica del DNA mitocondriale di lievito Separazione su gel di agarosio dei prodotti di amplificazione e digestione Clonaggio genico in S. cerevisiae: disegno di primers con adeguati siti di restrizione, ligazione del gene di interesse in un vettore shuttle E. coli/S. cerevisiae, trasformazione di E. coli, Miniprep da E. coli trasformati, trasformazione di lievito e verifica per PCR. English Lessons Yeast and Lactic Acid Bacteria (LABs) Systematics Phylogenesis of the microorganisms with oenological interest Genetics of S. cerevisiae Genetics of O. oeni Dynamic of Yeast and LABs Populations during must/wine fermentation Non-Saccharomyces wine yeasts Bimolecular Analysis of the microorganisms with oenological interest: Nucleic acids extraction from oenological substrates DNA sequencing: Sanger and Pyrosequencing approaches Molecular tools for the yeasts and LABs identification Molecular tools for the typing of yeasts and LABs Microbial Biotechnology Recombinant DNA technology Wine Biotechnology Laboratory classes Yeast isolation from musts Extraction and purification of DNA - 246 - PCR of the ribosomal regions ITS and Typing of the S. cerevisiae species electrophoretic separation of the PCR products on agarose gel Gene cloning in S. cerevisiae: design of the primers, gene ligation in a shuttle vector E. coli/S. cerevisiae, E. coli transformation, Mini-preps from recombinant colonies of E. coli, S. cerevisiae transformation, cloning confirmation by PCR. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Materiale del docente distribuito durante le lezioni Vincenzini M., Romano P., Farris G.A. Microbiologia del Vino. Casa editrice Ambrosiana. Helmut K., Gottfried U., Jürgen F. Biology of Microorganisms on Grape, in Must and in Wine. Springer English SOSTITUIRE QUESTO TESTO CON LA DESCRIZIONE IN INGLESE NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z4pj - 247 - Botanica forestale (Anno Accademico 2015/2016) FOREST BOTANY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0059 Docente: Dott. Michele LONATI (Affidamento interno) Contatti docente: 0039 011 6708765, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: BIO/03 - botanica ambientale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Acquisizione della capacità di determinazione e di riconoscimento delle principali piante superiori (Gimnosperme e Angiosperme), con approfondimenti sulle loro caratteristiche sistematiche ed ecologiche. English Determination and identification of the main gymnosperms and angiosperms, with emphasis on their systematic and ecological characteristics. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Le informazioni fornite mirano a far raggiungere le conoscenze di base sul riconoscimento delle principali famiglie e specie (legnose ed erbacee) di interesse agro-silvopastorale. Sono trattati con maggiore dettaglio le piante superiori (Gimnosperme e Angiosperme), fornendo i caratteri generali utili per un loro riconoscimento e informazioni relative alla loro corologia, autoecologia e sinecologia. Sono inoltre descritti i principali metodi di studio della vegetazione e delle comunità vegetali, in particolare il metodo di rilevamento fitosociologico. English The course aims to identify the main families and species (both woody and herbaceous) of interest in natural and semi-natural habitats. The gymnosperms and angiosperms are described in detail, providing the general characteristics useful for their identification with particular regard to their chorology, autoecology and synecology. The key study methods of vegetation and plant communities are also described, in particular the phytosociological - 248 - method. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di esercitazione. Le esercitazioni sono volte alla determinazione di specie vegetali portate in aula dal docente. Per le lezioni frontali il docente si avvale di una presentazione, a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work. For lectures the teacher makes use of a presentations that is available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante lo svolgimento del corso il docente procede periodicamente a una verifica dell'apprendimento degli studenti mediante: (a) Lettura individuale delle chiave di determinazioni durante le esercitazioni, con scelta da parte dello studente della dicotomia a suo parere corretta, (b) Determinazioni individuali durante lo svolgimento del corso. La verifica mira a capire il rado di apprendimento degli studenti sotto il punto di vista della terminologia, della capacità critica di descrizione di una specie e di interpretazione dei caratteri sistematici salienti utili al riconoscimento. Modalità di esame. Prova orale, accesso subordinato alla consegna preventiva (almeno 10 giorni dalla data dell'orale) dell'erbario al docente. Erbario. E' necessario allestire un erbario di 100 piante (di cui 10 montate con su appositi fogli con striscioline di carta, 90 in fogli di giornale), tutte complete di cartellino. Ciascun erbario deve essere accompagnato da un elenco, redatto in ordine sistematico, degli esemplari presentati in cui sarà riportato il nome della famiglia di appartenenza e il nome della specie (comprensivo di autore). L'elenco dovrà riportare i riferimenti del testo utilizzato per la determinazione, il nome dello studente e il suo indirizzo e-mail. Famiglie obbligatorie: Caryophyllaceae (almeno 5 specie), Ranunculaceae (almeno 5 specie), Cruciferae (almeno 5 specie), Rosaceae (almeno 5 specie), Leguminose (almeno 5 specie), Umbelliferae (almeno 5 specie), Labiatae (almeno 5 specie), Compositae (almeno 5 specie), Liliaceae (almeno 5 specie), Gramineae (almeno 10 specie). Tutti i dettagli per la realizzazione dell'erbario sono riportati nel materiale didattico fornito agli studenti. Consegna dell'erbario al docente almeno 10 giorni prima (tassativi) della data dell'appello orale. L'erbario sarà riconsegnato il giorno dell'orale con le eventuali correzioni. Criteri generali per la valutazione degli erbari: ogni errore comporta una penalizzazione espressa in centesimi. Il voto finale è espresso in trentesimi: -1/100: genere giusto, specie sbagliata -3/100: genere sbagliato, famiglia giusta -5/100: famiglia sbagliata (-7/100 se si tratta di una famiglia obbligatoria) -0.5/100: campione senza radice, senza bulbi o senza caratteri sistematici (con i limiti legati alle dimensioni della pianta) -0.25/100: errori ortografici, maiuscole/minuscole, corsivi, grassetti, ecc. English During the course, the teacher will proceed to a verification of the teaching efficacy by: (a) Individual reading of dichotomic key, (b) individual determinations during the course. Procedures for the exam. At least 10 days before the oral exam, the student must deliver a herbarium to the - 249 - teacher. Herbarium. It is necessary to deliver a herbarium of 100 plants. Each herbarium must be associated with a list, compiled in systematic order. The list must indicate the references of the text used for the determination, the name and the e-mail address of the student. Mandatory families: Caryophyllaceae (at least 5 species), Ranunculaceae (at least 5 species), Cruciferae (at least 5 species), Rosaceae (at least 5 species), Leguminosae (at least 5 species), Umbelliferae (at least 5 species), Labiatae (at least 5 species ), Compositae (at least 5 species), Liliaceae (at least 5 species), Gramineae (at least 10 species). All the details for the implementation of the herbarium are shown in the materials provided to the students. The herbarium must be delivered to the teacher at least 10 days before the oral exam. The day of the exam, the herbarium will be given back to the student with all the corrections. PROGRAMMA Italiano Parte I: 'Botanica Forestale' (Area di apprendimento Selvicolturale e Ambientale) Divisione Pinophyta. Sottodivisione Cycadiceae: Cycadaceae, Zamiaceae. Sottodivisione Pinicae: Podocarpaceae, Araucariaceae, Cupressaceae, Pinaceae: descrizione dei generi e delle specie più significative di Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga, Pinus. Taxodiaceae, Taxaceae, Ginkgoaceae. Sottodivisione Gneticae: Ephedraceae, Gnetaceae, Welwitschiaceae. Divisione Magnoliophyta. Classe Magnoliopsida: Magnoliaceae, Lauraceae, Nympheaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Platanaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae (descrizione in dettaglio di Fagus, Quercus, Castanea), Cactaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Tiliaceae, Sterculariaceae, Malvaceae, Droseraceae, Cucurbitaceae, Salicaceae, Brassicaceae, Ericaceae, Ebenaceae, Primulaceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Cornaceae, Loranthaceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Euphorbiaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Simaroubaceae, Rutaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Solanaceae, Labiatae, Oleaceae, Campanulaceae, Rubiaceae, Caprifoliaceae, Asteraceae. Classe Liliopsida: Arecaceae, Lemnaceae, Juncaceae, Cyperaceae, poaceae, Bromeliaceae, Musaceae, Cannaceae, Liliaceae, Agavaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, Orchidaceae. Parte II: 'Cenni di Geobotanica e Fitosociologia' (Area di apprendimento Selvicolturale e Ambientale) Concetto di vegetazione e di comunità vegetale. Metodi di studio della vegetazione. Zone floristiche e fasce di vegetazione. Metodo di rilevamento fitosociologico: specie caratteristiche, specie differenziali, specie compagne. Concetto di associazione vegetale. Aspetti sintassonomici e nomenclaturali. English Part I. Systematic Botany Pinophyta. Cycadiceae: Cycadaceae, Zamiaceae. Pinicae: Podocarpaceae, Araucariaceae, Cupressaceae, Pinaceae (Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga, Pinus), Taxodiaceae, Taxaceae, Ginkgoaceae. Gneticae: Ephedraceae, Gnetaceae, Welwitschiaceae. Magnoliophyta. Magnoliopsida: Magnoliaceae, Lauraceae, Nympheaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Papaveraceae, Platanaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae (Fagus, Quercus, Castanea), Cactaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Tiliaceae, Sterculariaceae, Malvaceae, Droseraceae, Cucurbitaceae, Salicaceae, Brassicaceae, Ericaceae, Ebenaceae, Primulaceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Cornaceae, Loranthaceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Euphorbiaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Simaroubaceae, Rutaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Solanaceae, Labiatae, Oleaceae, Campanulaceae, Rubiaceae, Caprifoliaceae, Asteraceae. Classe Liliopsida: Arecaceae, Lemnaceae, Juncaceae, Cyperaceae, Poaceae, Bromeliaceae, Musaceae, Cannaceae, Liliaceae, Agavaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, Orchidaceae. - 250 - Part II: Vegetation and community. Vegetation study methods. Vegetation zone and vegetation belt. Phytosociology: character species, differential species, companion species. Phytosociological association. Syntaxonomy e nomenclature. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna. Gellini R., Grassoni P., 1996. Botanica Forestale. Volume I. Gimnosperme. CEDAM, Padova. Gellini R., Grassoni P., 2000. Botanica Forestale. Volume II. Angiosperme. CEDAM, Padova. Ubaldi D., 1997. Geobotanica e Fitosociologia. CLUEB, Bologna. Per facilitare la preparazione dell'esame è stata redatta una dispensa. La dispensa è disponibile in formato cartaceo e informatico presso la sede AUSF della Facoltà. Accertarsi di avere a disposizione il materiale didattico dell'anno accademico in corso (controllare la data dell'anno accademico). La dispensa (suddivisa in 4 blocchi, file in formato .pdf) è scaricabile nel materiale didattico del corso (piattaforma CampusNet). English Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna. Gellini R., Grassoni P., 1996. Botanica Forestale. Volume I. Gimnosperme. CEDAM, Padova. Gellini R., Grassoni P., 2000. Botanica Forestale. Volume II. Angiosperme. CEDAM, Padova. Ubaldi D., 1997. Geobotanica e Fitosociologia. CLUEB, Bologna. To facilitate the preparation of the exam a lecture note was prepared. After the registration, the lecture note is available for download at the beginning of the course on the course web pages (platform CampusNet). NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oma6 - 251 - Caratteristiche chimiche dei reflui zootecnici (Anno Accademico 2015/2016) CHEMICAL CHARACTERISTICS OF LIVESTOCK MANURE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0259 Docente: Prof. Michele NEGRE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708508, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente le competenze necessarie per una corretta gestione dei reflui zootecnici e per la loro valorizzazione in ambiente agricolo nel rispetto dell'ambiente. English To provide the basic knowledge for the evaluation of the quality of animal wastes and for their valorisation in agriculture taking into account the preservation of environmental integri RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione delle conoscenze necessarie per fare delle scelte riguardante il trattamento e l'applicazione in campo dei reflui zootecnici. English Required knowledge for making decisions concerning the treatment and field application of animal wastes MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a attività di laboratorio ed esercitazione in aula. Il docente si avvale di presentazioni di power point messe a disposizione degli studenti. English - 252 - The course includes 30 hours of lectures and 10 hours of laboratory and data elaboration practice . The course will be illustrated by power point presentations made available to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Interrogazione periodica sui principali argomenti. prova d'esame orale English Periodic oral examination on the main topics. oral examination ATTIVITÀ DI SUPPORTO esecitazione di laboratorio:caratterizzazione di campioni di reflui zootecnici possibilemnet forniti dagli studenti visita in azienda PROGRAMMA Italiano Tipologia di reflui zootecnici Parametri di caratterizzazione dei reflui zootecnici. Metodi di determinazione dei macro e micronutrienti Effetto dell'applicazione dei reflui zootecnici sulle caratteristiche del suolo Tecniche di trattamento dei liquami e dei letami (stoccaggio, essicazione, ossigenazione, depurazione aerobica, digestione anaerobica, produzione di biogas e di compost). Effetto delle tecniche di trattamento sulle caratteristiche dei reflui zootecnici Aspetti ambientali: zone vulnerabili da nitrati, processo di eutrofizzazione, contaminazione da metalli. English Classification of the animal wastes Parameters of characterization of the animal wastes Analytical determination of macro- and micronutrients Effect of the application of animal wastes on the soil properties - 253 - Animal wastes treatment plants: long term storage, drying, oxygenation, aerobic depuration , anaerobic digestion, biogas production, composting. Properties of the treated animal wastes Environmental aspects: vulnerable area, eutrophication, metal contamination. Visit of a composting and biogas production plant TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano C.R.P.A., Manuale per l'utilizzazione dei reflui zootecnici, Edizioni L'Informatore Agrario, 2001. Crovetto G.M., Sandrucci A. (a cura di), Allevamento animale e riflessi ambientali, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 2010 (disponibile on-line) English C.R.P.A., Manuale per l'utilizzazione dei reflui zootecnici, Edizioni L'Informatore Agrario, 2001. Crovetto G.M., Sandrucci A. (a cura di), Allevamento animale e riflessi ambientali, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 2010 NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xhh3 - 254 - Chimica agraria (Anno Accademico 2015/2016) AGRICULTURAL CHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0083 Docente: Prof. Elisabetta BARBERIS Contatti docente: 0116708504, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano L'obiettivo è fornire agli studenti una conoscenza di base dei costituenti del suolo e degli organismi viventi nonchè dei processi che regolano i cicli biogeochimici degli elementi nutritivi. Lo studente acquisirà così le conoscenze utili per comprendere le relazioni che esistono tra il suolo e la pianta e che sono indispensabili per il controllo della risorsa suolo in campo agronomico e ambientale. English The purpose is to give to the students a basic knowledge of soil and biota constituents and of main chemical and biochemical processes ruling the biogeochemistry behaviour of nutrient elements. That will permit to the students to understand the relathionships exisisting in the soil-plant system and to use this knowledge for selecting the best management practices. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiscono gli strumenti chimici e biochimici necessari per la comprensione del funzionamento del sistema suolo-pianta nonchè per la conoscenza dei processi metabolici che regolano la vita English The course provides an overview on chemical and biochemical processes that occur in the soil-plant system and a basic knowledge of plant metabolism. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 255 - Il corso consiste di 64 ore di lezione frontale e 16 ore dedicate a esercitazioni in aula. Per le lezioni frontali il docente si avvale di slides che sono a disposizione degli studenti. Italiano The course consists of 64 hours of lectures and 16 hours of practical work. For lectures the teacher makes use of slides that are available to students.English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Prova scritta seguita da orale. E' necessario superare la prova scritta per accedere all'orale English Written and oral test. To be admitted to the oral test it is necessary to pass written test PROGRAMMA Italiano Gli argomenti n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fanno riferimento all'area di apprendimento Produzioni vegetali mentre gli argomenti 2 e 3 fanno riferimento all'area: conoscenze di base 1.Introduzione: il sistema suolo-pianta: gli elementi costituenti il suolo ed il biota. 2.I costituenti: le biomolecole. 3. Reazioni metaboliche. Enzimi e reazioni enzimatiche. Cofattori; vitamine 4. I costituenti: i minerali e la sostanza organica del suolo. 5. Proprietà fisiche del suolo. 6. L'interfaccia suolo-soluzione. 7. Proprietà chimiche del suolo. 8. La rizofera. 9. Catabolismo dei glucidi: Glicolisi- metabolismi fermentativi - ciclo di Krebs - via dei pentoso-fosfati - processi bio-ossidativi. 10. L'organicazione del carbonio. Fotosintesi: fotofosforilazione non ciclica e ciclica. Ciclo di Calvin. Fotorespirazione. Piante C4 e CAM. Dai monosaccaridi ai polisaccaridi. 11. Metabolismo delle sostanze azotate. Sintesi degli aminoacidi. 12. I cicli degli elementi nutritivi. Azoto, Fosforo, Zolfo. Potassio, Calcio, Magnesio. I micronutrienti. 13. La fertilità del suolo e la nutrizione vegetale. - 256 - English Topics n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 belong to the learning area: crop production awhile topics n. 2, 3 to the learning area: basic knowledge 1. Introduction: the soil-plant system. 2. Soil and biota components: the biomolecules. 3. Metabolic reactions. Enzymes and enzymatic reactions. Cofactors and vitamins 4. Soil and biota components: soil minerals and soil organic matter. 5. Soil physical properties. 6. The soil-solution interface 7. Soil chemical properties. 8. The rhizosphere. 9. Catabolism of the carbohydrates. Glycolysis - Fermentative metabolisms- the Krebs cycle - Pentose phosphate pathway. Bio-oxidative processes. 10. Carbon fixation. Photosynthesis. Cyclic and noncyclic photophosphorylation. The Calvin cycle. Photorespiration. C4 andCAMplants. From monosaccharides to polysaccharides. 11. Metabolism of nitrogen-containing substances. Synthesis of the amino acids. 12. Nutrient cycling. Nitrogen, Phosphorus,Sulphur. Potassium, Calcium, Magnesium. and micronutrients. 13. Soil fertility and plant nutrition TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante. Edagricole . P. Sequi - Fondamenti di chimica del suolo, Pàtron . Nelson D.L., Cox M.M. Introduzione alla biochimica di Lehninger, Zanichelli. M. Bosetto, I. Lozzi. Elementi di biochimica agraria. Aracne Editrice English P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante. Edagricole . P. Sequi - Fondamenti di chimica del suolo, Pàtron . Nelson D.L., Cox M.M. Introduzione alla biochimica di Lehninger, Zanichelli. M. Bosetto, I. Lozzi. Elementi di biochimica agraria. Aracne Editrice - 257 - NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wjyl - 258 - Chimica delle vinificazioni (Anno Accademico 2015/2016) Chimica delle vinificazioni Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0039 Docente: Antonio Giovanni TIRELLI (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 9 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso è finalizzato a fornire approfondite conoscenze relativa alla composizione dell'uva e del vino, ai fenomeni di trasformazione nel corso della vinificazione, della maturazione del vino e della sua conservazione, agli interventi chimici dell'enologo. English The course is aimed to give knowledges concerning the composition of grape and wine, the transformations occuring during the wine making, wine ripening and storage, the chemical practices during the wine making RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente sarà in grado di valutare gli effetti delle condizioni di vinificazione e delle pratiche enologiche sul prodotto finale. Sarà in grado di individuare le partiche di vinificazione più idonee per conseguire il risultato di produzione ricercato English Students will be able to evaluate the effects of the wine making conditions and practices on the final product. He will be able to define the most suitable wine making practices to gain the final researched result. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 259 - Italiano Lezioni frontali con presentazioni power point English Lessons consist of oral communications supported by power point presentations MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Le conoscenze apprese dallo studente verranno valutate mediante verifica scritta con domande a risposta aperta English Written examination with open questions PROGRAMMA Italiano I costituenti dell'uva di interesse enologico: forme aromatiche, acidi, polifenoli, polisaccaridi. Evoluzione dei costituenti dell'uva in vinificazione. Gli enzimi di interesse enologico. Le forme aromatiche da lievito e la loro origine. Evoluzione delle forme polifenoliche in vinificazione ed affinamento dei vini rossi. Il ruolo dell'ossigeno nella vinificazione con o senza macerazione. Le modificazioni dell'acidità in vinificazione e stabilizzazione. La stabilizzazione dei vini. Le forme aromatiche di evoluzione. Il ruolo del legno in vinificazione. I difetti del vino. Interventi enologici di prevenzione e cura delle alterazioni da Dekkera. La SO2 e la sua gestione. Gli equilibri acidi in mosto e vino ed i fattori che li condizionano. English Grape constituents involved in wine making: acids, phenolics, mono and poly-saccharides, volatile compounds. Evolution of grape constituents in wine making. Enzymes involved in wine making. Flavor compounds from yeast and their origin. Evolution of phenolics in wine making and aging. The role of oxygen in wine making of red or white wine. Chemical equilibria of acids and salts in must and wine and the factors affecting them. Wine stabilizations. Flavor compounds from wine aging. The role of wood in wine making. Wine defects. Enological practices for preventing and limiting wine spoilage from Dekkera. SO2 and its use. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Ribereau-Gayon, Dubourdieu, Doneche, Lanvaud, Trattato di Enologia voll. 1 e 2. Il Sole 24 ore Edagricole (2007). Presentazioni proiettate nel corso. Materiale bibliografico fornito dal docente. English Ribereau-Gayon, Dubourdieu, Doneche, Lanvaud, Handbook of Enology vol. 1 and 2. (2006). Power point slides. Scientific literature proposed by the lecturer - 260 - NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g396 - 261 - Chimica e biochimica agraria (Anno Accademico 2015/2016) AGRICULTURAL CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0068 Docente: Prof. Michele NEGRE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708508, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Acquisizione di una conoscenza di base del sistema pianta- suolo e dei cicli biogeochimici dei principali elementi nutritivi allo scopo di capire i processi biochimici che regolano la vita e la produttività della pianta (vite) da un punto di vista quali-quantitativo. English To acquire the basic knowledge concerning the soil and plant system and the nutrients cycles in order to understand the biochemical processes regulating the plant productivity from a qualitative and quantitative point of view. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il corso fornisce gli strumenti per capire i processi che regolano la nutrizione vegetale e la fertilità del suolo attraverso la conoscenza del metabolismo vegetale e dei meccanismi d'interazioni suolo-pianta, in particolare per quanto riguarda la viticoltura English The course provides the capacity to understand the plant nutrition and soil fertility processes through the - 262 - knowledge of both the plant metabolism and the soil plant interaction mechanisms, in particular as far as viticulture is concerned. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 40 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di laboratorio ed esercitazione in aula. Il docente si avvale di presentazioni di power point messe a disposizione degli studenti. English The course includes 40 hours of lectures and 20 hours of laboratory and data elaboration practice . The course will be illustarted by power point presentations made available to the students.. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano simulazione prova d'esame scritto prova scritta: 10 domande aperte ammissione all'orale solo al superamento della prova scritta con 18/30. prova orale : discussione dello scritto + una domanda su un argomento non trattato nella prova scritta English simulated written test. The final examination includes a written test (10 questions). Students who reach score 18/30 are admitted to oral examination consisting of a discussion of the written test and a question not treated in the written test. ATTIVITÀ DI SUPPORTO esercitazione in laboratorio e elaborazione in aula di dati analitici . PROGRAMMA Italiano - 263 - Questo corso appartiene all'area di apprendimento 2 (produzione e qualità delle uve e gestione dei vigneti). Gli argomenti sviluppati riguardano -la biochimica vegetale: struttura, funzione, biosintesi e catabolismo delle biomolecole. -il suolo agrario e la nutrizione delle piante: caratteristiche fisico-chimiche, macro- e micronutrienti, interfaccia suolo-soluzione e suolo-radice. in particolare: Introduzione alla biochimica, bioenergetica e metabolismo Aminoacidi, peptidi e proteine (struttura e funzione) Struttura degli enzimi, catalisi enzimatica Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi). Lipidi (terpeni, fosfolipidi, triacilgliceroli) Nucleotidi e acidi nucleici Glicolisi e via del pentosio fosfato Ciclo TCA , catena di trasporto degli elettroni Gluconeogenesi Fotosintesi Metabolismo dei lipidi Metabolismo delle proteine Prodotti del metabolismo secondario I processi di formazione dei suoli Caratteristiche fisiche dei suoli Componenti minerali e organica dei suoli Il complesso di scambio Processi che regolano il pH del suolo Cicli dei principali elementi nutritivi Nutrizione vegetale English - 264 - Main processes regulating plant growth and the soil-plant system The topics are dealing with: -plant biochemistry: structure, function, biosynthesis and catabolism of biomolecules -agricultural soil and plant nutrition: soil physico-chemical characteristics, nutrients and micronutrients, soil-solution and soil-root interfaces, Introduction to biochemistry, bioenergetics and metabolism Aminoacids, peptides, and proteins (structure and role) Structure of enzymes, enzymatic catalysis Carbohydrates (monosaccharides, disaccharides, polysaccharides) Lipids (terpenes, phospholipids, triacylglycerols) Nucleotides and nucleic acids Glycolysis and pentose phosphate path TCA cycle, electron transport chain Gluconeogenesis Photosynthesis Lipids metabolism Proteins metabolism Product of secondary metabolism Processes of soil formation Physical characteristics of soil Inorganic and organic soil fractions Exchange complex Processes regulating soil pH Nutrients cycles Plant nutrition TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano D. L. Nelson, M.M.Cox. Introduzione alla biochimica di lehninger, Zanichelli (2011) P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante, Edagricole (2002) - 265 - M. Bosetto, I. Lozzi. Elementi di iochimica Agraria, Aracne (2006) P. Sequi. Fondamenti di Chimica del suolo .Pàtron(2005) English NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Alba English The location of the course is alba Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6216 - 266 - Chimica forestale (Anno Accademico 2015/2016) FOREST CHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Dott. Maria MARTIN (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708512, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il modulo ha l'obiettivo di trasmettere le conoscenze di base sulle proprietà chimico-fisiche del suolo, sui cicli biogeochimici degli elementi nutritivi (e contaminanti), le loro interrelazioni e implicazioni per lo sviluppo delle piante e la qualità dell'ambiente. English The objective of the module is to supply the basic knowledge on soil physicochemical properties, on the biogeochemical cycling of nutrient and contaminant elements, their interconnections and the implications for plant growth and environmental quality. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Al termine del modulo gli studenti devono essere in grado di valutare le caratteristiche chimiche di un suolo, interpretarle e comprenderne le implicazioni in ambito forestale e ambientale. English At the end of the lessons the students will be able to evaluate soil chemical characteristics, and understand their implication for forestry production and management and for environmental quality MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 267 - Il modulo consiste di 50 ore di lezione frontale e 10 dedicate ad esercitazioni in laboratorio e in aula. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slides che sono a disposizione degli studenti sul sito Campusnet. English The module consists in 50 hours of lectures and 10 hours of laboratory and classroom exercises. The slides used for the lectures are available to the students on the Campusnet website MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verifica in itinere: Il grado di apprendimento sarà verificato durante lo svolgimento del corso con domande e brevi esercizi relativi agli argomenti precedentemente trattati, affinché gli studenti imparino a utilizzare e collegare le conoscenze che vanno acquisendo e possano valutare il loro grado di preparazione. Esame finale: costituito da una prova scritta il cui superamento dà accesso al colloquio orale. English The degree of understanding and learning will be continuously verified during each lesson with questions and simple exercise on the already explained topics, with the aim to stimulate the interconnection among the knowledge that the students are acquiring and to make them aware of their learning degree. Final examination: written test; if th written test is passed, it is followed by oral examination Scritto e orale PROGRAMMA Italiano Tutti gli argomenti del programma appartengono all'area di apprendimento ambientale. Introduzione. Il suolo come comparto naturale, ruolo nell'ambiente. Descrizione del suolo. Fasi solida, liquida e gassosa e composizione elementare. Fattori di formazione del suolo. I componenti minerali del suolo. Le rocce. I minerali silicatici. I fillosilicati argillosi. Minerali non silicatici: ossidi, carbonati, fosfati, solfuri, solfati. Degradazione fisica e alterazione chimica dei minerali. La sostanza organica. Origini e costituzione della sostanza organica. Gli organismi del suolo e la biomassa microbica. Le sostanze umiche. Il ciclo del carbonio. Le proprietà fisiche del suolo. La tessitura, la struttura, la densità, la porosità, il colore, il calore. Le proprietà chimico-fisiche. I colloidi del suolo. Lo scambio cationico. Reazioni di adsorbimento e desorbimento. Il potere tampone. Il pH e la sua regolazione. L'Eh e la sua regolazione. La soluzione del suolo. Composizione chimica e mobilità dei nutrienti. Il ciclo biogeochimico di alcuni elementi. La disponibilità degli elementi nutritivi. Ciclo dell'azoto, del fosforo e del potassio. I microelementi. I suoli anomali: suoli acidi, suoli salini e sodici, suoli sommersi, suoli contaminati - 268 - English The arguments of the program belong to the Environment learning area Introduction. Soil as a natural compartment and its environmental role. Soil description. Solid, liquid and gas phases; elemental composition. Factors of soil formation. Soil mineral components. Rocks. Silicate minerals. Phyllosilicates in the clay fraction. Non-silicate minerals: oxides, carbonates, phosphates, sulphides, sulphates. Physical degradation and chemical alteration of minerals. Soil organic matter. Sources and composition of soil organic matter. Soil organisms and microbial biomass. Humic substances. Carbon cycling Soil physical properties. Texture, structure, density, porosity, color, thermal capacity. Soil physico-chemical properties. Soil colloids. Cation exchange. Adsorption-desorption reactions. Buffer capacity. Soil pH and its regulation. Soil Eh and its regulation Soil solution. Chemical composition of soil solution and nutrient mobility in soil. Biogeochemical cycling of selected elements. Nutrient availability. Nitrogen, phosphorus and potassium cycling. Micronutrients. Anomalies in soils. Acidic soils, saline and sodic soils, submerged soils, contaminated soils Italiano Il corso illustra le caratteristiche chimico-fisiche del suolo in relazione alle implicazioni ambientali e allo sviluppo delle piante English The course is focused on soil chemical (and physical) characteristics, their environmental consequences and implications for plant growth TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante. Edagricole (2002); oppure: P. Sequi – Fondamenti di Chimica del suolo. Pàtron (2005). Oppure: Kim H. Tan – Principles of soil chemistry- CRC Press (2010) Oppure: G. Sposito – The chemistry of soils. Oxford University Press (2008) English P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante. Edagricole (2002); or: P. Sequi – Fondamenti di Chimica del suolo. Pàtron (2005). or: Kim H. Tan – Principles of soil chemistry- CRC Press (2010) or: G. Sposito – The chemistry of soils. Oxford University Press (2008) - 269 - NOTA Italiano Il materiale didattico sarà reso disponibile sul sito Campusnet del DISAFA all'inizio delle lezioni. Sono possibili piccole modifiche in itinere del materiale precedentemente caricato, anche su richiesta degli studenti English The slides will be available on the website Campusnet, DISAFA at the beginning of the lessons. Some modification during the course of the previously uploaded material, also after students' requests Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kq36 - 270 - Chimica forestale ed elementi di fisiologia vegetale - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) FOREST CHEMISTRY AND VEGETAL PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Dott. Maria MARTIN (Affidamento interno) Prof. Claudio LOVISOLO (Affidamento interno) Phd. Francesca SECCHI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708512, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 12 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Chimica forestale (Anno Accademico 2015/2016) Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=50ul Chimica forestale (Anno Accademico 2015/2016) FOREST CHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Dott. Maria MARTIN (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708512, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa - 271 - Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il modulo ha l'obiettivo di trasmettere le conoscenze di base sulle proprietà chimico-fisiche del suolo, sui cicli biogeochimici degli elementi nutritivi (e contaminanti), le loro interrelazioni e implicazioni per lo sviluppo delle piante e la qualità dell'ambiente. English The objective of the module is to supply the basic knowledge on soil physicochemical properties, on the biogeochemical cycling of nutrient and contaminant elements, their interconnections and the implications for plant growth and environmental quality. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Al termine del modulo gli studenti devono essere in grado di valutare le caratteristiche chimiche di un suolo, interpretarle e comprenderne le implicazioni in ambito forestale e ambientale. English At the end of the lessons the students will be able to evaluate soil chemical characteristics, and understand their implication for forestry production and management and for environmental quality MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di 50 ore di lezione frontale e 10 dedicate ad esercitazioni in laboratorio e in aula. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slides che sono a disposizione degli studenti sul sito Campusnet. English The module consists in 50 hours of lectures and 10 hours of laboratory and classroom exercises. The slides used for the lectures are available to the students on the Campusnet website MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Verifica in itinere: Il grado di apprendimento sarà verificato durante lo svolgimento del corso con domande e brevi esercizi relativi agli argomenti precedentemente trattati, affinché gli studenti imparino a utilizzare e collegare le conoscenze che vanno acquisendo e possano valutare il loro grado di preparazione. Esame finale: costituito da una prova scritta il cui superamento dà accesso al colloquio orale. - 272 - English The degree of understanding and learning will be continuously verified during each lesson with questions and simple exercise on the already explained topics, with the aim to stimulate the interconnection among the knowledge that the students are acquiring and to make them aware of their learning degree. Final examination: written test; if th written test is passed, it is followed by oral examination Scritto e orale PROGRAMMA Italiano Tutti gli argomenti del programma appartengono all'area di apprendimento ambientale. Introduzione. Il suolo come comparto naturale, ruolo nell'ambiente. Descrizione del suolo. Fasi solida, liquida e gassosa e composizione elementare. Fattori di formazione del suolo. I componenti minerali del suolo. Le rocce. I minerali silicatici. I fillosilicati argillosi. Minerali non silicatici: ossidi, carbonati, fosfati, solfuri, solfati. Degradazione fisica e alterazione chimica dei minerali. La sostanza organica. Origini e costituzione della sostanza organica. Gli organismi del suolo e la biomassa microbica. Le sostanze umiche. Il ciclo del carbonio. Le proprietà fisiche del suolo. La tessitura, la struttura, la densità, la porosità, il colore, il calore. Le proprietà chimico-fisiche. I colloidi del suolo. Lo scambio cationico. Reazioni di adsorbimento e desorbimento. Il potere tampone. Il pH e la sua regolazione. L'Eh e la sua regolazione. La soluzione del suolo. Composizione chimica e mobilità dei nutrienti. Il ciclo biogeochimico di alcuni elementi. La disponibilità degli elementi nutritivi. Ciclo dell'azoto, del fosforo e del potassio. I microelementi. I suoli anomali: suoli acidi, suoli salini e sodici, suoli sommersi, suoli contaminati English The arguments of the program belong to the Environment learning area Introduction. Soil as a natural compartment and its environmental role. Soil description. Solid, liquid and gas phases; elemental composition. Factors of soil formation. Soil mineral components. Rocks. Silicate minerals. Phyllosilicates in the clay fraction. Non-silicate minerals: oxides, carbonates, phosphates, sulphides, sulphates. Physical degradation and chemical alteration of minerals. Soil organic matter. Sources and composition of soil organic matter. Soil organisms and microbial biomass. Humic substances. Carbon cycling Soil physical properties. Texture, structure, density, porosity, color, thermal capacity. Soil physico-chemical properties. Soil colloids. Cation exchange. Adsorption-desorption reactions. Buffer capacity. Soil pH and its regulation. Soil Eh and its regulation Soil solution. Chemical composition of soil solution and nutrient mobility in soil. - 273 - Biogeochemical cycling of selected elements. Nutrient availability. Nitrogen, phosphorus and potassium cycling. Micronutrients. Anomalies in soils. Acidic soils, saline and sodic soils, submerged soils, contaminated soils Italiano Il corso illustra le caratteristiche chimico-fisiche del suolo in relazione alle implicazioni ambientali e allo sviluppo delle piante English The course is focused on soil chemical (and physical) characteristics, their environmental consequences and implications for plant growth TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante. Edagricole (2002); oppure: P. Sequi – Fondamenti di Chimica del suolo. Pàtron (2005). Oppure: Kim H. Tan – Principles of soil chemistry- CRC Press (2010) Oppure: G. Sposito – The chemistry of soils. Oxford University Press (2008) English P. Violante - Chimica del Suolo e della nutrizione delle Piante. Edagricole (2002); or: P. Sequi – Fondamenti di Chimica del suolo. Pàtron (2005). or: Kim H. Tan – Principles of soil chemistry- CRC Press (2010) or: G. Sposito – The chemistry of soils. Oxford University Press (2008) NOTA Italiano Il materiale didattico sarà reso disponibile sul sito Campusnet del DISAFA all'inizio delle lezioni. Sono possibili piccole modifiche in itinere del materiale precedentemente caricato, anche su richiesta degli studenti English The slides will be available on the website Campusnet, DISAFA at the beginning of the lessons. Some modification during the course of the previously uploaded material, also after students' requests Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kq36 - 274 - Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Prof. Claudio LOVISOLO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708926, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti le cognizioni fondamentali sui processi che controllano la vita e la produzione delle piante dell'ambiente forestale. English To learn about the relationships between plant physiology and forest environment, upon both climate standards and abiotic limiting conditions. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti arrivano a fine corso a saper analizzare i meccanismi che permettono lo svolgersi dei principali processi fisiologici ed ecofisiologici delle piante in risposta agli stimoli ambientali dell'ambiente forestale. English The students will integrate the knowledge acquired both by following the course programme and by examining scientific literature. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO - 275 - Italiano Autovalutazioni anonime in itinere. English In-itinere anonymous self-assessments. scritto PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del programma appartengono all'area delle conoscenze propedeutiche e all'area della difesa delle foreste. Funzioni dell'acqua nella cellula e nella pianta; variazioni di potenziale idrico nel continuum suolo-pianta-atmosfera; psicrometro; camera a pressione trasporto xilematico; forze di tensione/coesione ed embolismi (danni e recupero); ruolo delle acquaporine; traspirazione fogliare. Cenni sulla sintesi proteica; cinetica enzimatica; potenziale elettro-chimico di un soluto - equazione di Nernst; permeabilità delle membrane; potenziale di membrana; trasporto passivo: diffusione semplice e facilatata; trasporto attivo primario; H+-ATPasi; trasporto attivo secondario (simporto, antiporto). Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura, fotosistemi, regolazione dell'organicazione del carbonio Lo spettro dell'energia solare; eccitazione dei pigmenti, riemissione di energia: dissipazione e trasferimento; assorbimento energetico della clorofilla; i fotosistemi del cloroplasto; schema Z della fotosintesi, trasporto di elettroni; trasporto transmembrana di H+ e sintesi dell'ATP nel cloroplasto; fotoinibizione, formazione de radicali liberi dell'H2O; confronto fotosintesi/respirazione per la sintesi di ATP; la RUBISCO; sintesi di amido primario nel cloroplasto; sintesi di saccarosio nel citosol; ripartizione del trioso-P tra cloroplasto e citosol; sintesi dell'amido secondario (amiloplasti). Elementi strutturali del floema: funzioni; floema: modello di flusso di massa da organi sorgenti a organi sink; caricamento floematico (simportatore di zuccheri); scaricamento floematico; ripartizione dei prodotti della fotosintesi, forza di un sink; effetti delle variazioni del rapporto sorgente/sink; transizione sorgente/sink. Regolazione della fotosintesi. Controllo ambientale dell'assorbimento della CO2: 1) regolazione stomatica; 2) competizione CO2/O2 per la Rubisco; 3) competizione tra la biosintesi di amido e quella del saccarosio; 4) allocazione dei fotosintati a differenti organi sink; 5) età delle foglie. Assimilazione carbonica: risposta alla luce e alla temperatura in foglie cresciute al sole ed all'ombra. English Water metabolism, xylem transport, transpiration Proteins, cell membrane metabolism Photosynthesis and regulation of carbon assimilation Phloem transport - 276 - Ecophysiology of water and nutrients in the whole plant Ecophysiology of light and CO2 in the whole plant TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net English Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zi3j - 277 - Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Phd. Francesca SECCHI (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti le conoscenze necessarie sui processi che controllano la fisiologia e la produzione delle piante dell'ambiente forestale e in particolare sui meccanismi di adattamento delle piante in risposta a diversi stimoli ambientali. English The course will provide students with the knowledge necessary to understand the relationships between plant physiology and forest environment and the mechanisms of plant acclimation and adaptation to environmental conditions. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti arrivano a fine corso a saper analizzare i meccanismi che permettono lo svolgersi dei principali processi fisiologici ed ecofisiologici delle piante in risposta agli stimoli ambientali dell'ambiente forestale. English The students will integrate the knowledge acquired both by following the course programme and by examining scientific literature. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 278 - Italiano Il corso consiste di 20 ore di lezione frontale per le quali il docente si avvale di presentazioni e slides che saranno a disposizione degli studenti. English The course consists of 20 hours of lectures. The teacher makes use of presentations and slides that will be available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Autovalutazioni anonime in itinere. English In-itinere anonymous self-assessments. scritto PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del programma appartengono all'area delle conoscenze propedeutiche e all'area della difesa delle foreste. - Assorbimento, trasporto e assimilazione di sostanze minerali - Modificazioni di soluzioni nutritive per valutare gli effetti di elementi minerali; movimento dei soluti nel terreno; trasporto apoplastico e cellulare degli elementi minerali; funzioni del trasporto di membrana nell'assorbimento ionico di sost. minerali - Auxina: esperimenti di inizio '900 e risvolti funzionali; saggio biologico e radio-immunologico delle auxine; forma libera e forma coniugata (implicazioni su trasporto ed utilizzo); trasporto apolare (floematico) e polare (parenchimatico) ; effetti dell'auxina: allungamento di fusti e radici; auxine e fototropismo; auxine e gravitropismo in fusti e radici; effetti fisiologici dell'auxina: regolazione dominanza apicale, formazione radici secondarie, differenziamento vascolare; meccanismo d'azione dell'auxina a livello cellulare; effetti fisiologici delle gibberelline; effetti fisiologici delle citochinine; etilene; acido abscisico. - Aspetti ecofisiologici: risposta allo stress: Stress idrico. Meccanismi di difesa delle piante allo stress idrico. Ad alto potenziale idrico. A basso potenziale idrico. Risposta isodrica ed anisoidrica allo stress idrico. Ruolo del messaggio ormonale e chimico. Limitazioni alla crescita della piante ascrivibili a squilibri del potenziale idrico. Osmoregolazione. Stress e shock da calore. Stress da freddo. Stress da congelamento. Stress salino. - 279 - English - Assimilation and uptake of mineral nutrients - Plant hormones: Identification, biosynthesis and metabolism of auxin, transport, cell elongation, phototropism and gravitropism. Developmental effects of auxin. Physiological effects of Gibberellins, Cytokinins and Ethylene. Abscisic acid - Stress Physiology: Water stress and Drought tolerance Heat stress and Heat Shock Chilling and Freezing Salinity Stress TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net English Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net - 280 - NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ofkp - 281 - Chimica generale (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL CHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0048 Docente: Prof. Valter BOERO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708510, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: CHIM/03 - chimica generale e inorganica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Chimica organica, biochimica, biologia, fisiologia. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Conoscenza delle principali leggi della chimica generale e loro applicazione alla soluzione di problemi di interesse per i corsi successivi. Fornire agli studenti gli strumenti chimici minimi richiesti nei corsi successivi, rispettando una sequenza logica e dando la possibilità di apprendere mediante ragionamento. English Knowledge of the main laws of general chemistry and their application to solving problems of interest to the following courses. Provide students with the minimum chemical tools required in the following courses, in a logical sequence and giving the opportunity to learn by reasoning. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza delle principali leggi della chimica generale e loro applicazione alla soluzione di problemi di interesse per i corsi successivi. English Knowledge of the main laws of general chemistry and their application to solving problems of interest to the following courses. - 282 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste in 60 ore di lezione. In ogni lezione vi è una parte di esercitazioni e possibilmente applicazioni pratiche inerenti l'agricoltura e l'ambiente. Vengono proiettate slide che schematizzano la tematica trattata o che svolgono alcuni esercizi. Sulla base di alcuni appunti presi a lezione si chiede allo studente lo sforzo di rivedere l'argomento su un testo consigliato e ripetere esercizi analoghi. English The course consists of 60 hours of lessons. In each lesson there is a part of exercises and possibly practical applications concerning agriculture and the environment. In each lesson are projected slides that depict the theme treated or who perform certain exercises. Based on the notes taken in class asking students the effort to review the topic on a text and repeating similar exercises. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano A metà programma è verificata l'apprendimento degli allievi mediante un test di 60 minuti con 15 domande di nomenclatura ed esercizi sulla base dei temi trattati a lezione. La correzione del test è fatta in aula. Al termine del corso test scritto su nomenclatura chimica (10 composti) e risoluzione di 6 problemi in 60 min. Possibilità di colloquio orale a richiesta. English Halfway through the program Assessment of students is carried out by a 60-minute test with 15 questions of nomenclature and exercises based on the topics covered in class. The correction of the test is done in the classroom. At the end of the course there is a written test on chemical nomenclature (10 compounds) and resolution of 6 problems in 60 min. Possibility of an oral examination if requested by the student or by the professor. PROGRAMMA Italiano Struttura dell'atomo: descrizione generale, struttura elettronica dell'idrogeno, struttura elettronica di atomi a molti elettroni, i numeri quantici Sistema periodico degli elementi: proprietà periodiche, raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività Legame chimico: legame ionico, legame covalente omopolare ed eteropolare, legame dativo regola dell'ottetto, strutture di Lewis, risonanza, geometria molecolare, orbitali atomici ibridi. Aspetti quali-quantitativi delle reazioni chimiche: masse atomiche e molecolari, distribuzione isotopica, definizione di mole e numero di Avogadro, formula minime e molecolari, bilanciamento delle reazioni, numero di ossidazione, reazioni redox, resa della reazione, calcoli stechiometrici. Nomenclatura. Stati di aggregazione della materia: stato gassoso (equazione di stato, legge di Dalton), stato liquido (tensione di vapore e temperatura di ebollizione), stato solido (relazioni tra struttura e proprietà), diagrammi di stato (acqua, biossido di carbonio). Soluzioni: generalità, concentrazioni delle soluzioni, proprietà colligative. - 283 - Cinetica chimica: velocità di reazione e fattori che la influenzano. Termodinamica chimica: reazioni spontanee. Equilibrio chimico: equilibri omogenei, costanti di equilibrio, legge di azione di massa, principio di Le Chatelier, equilibri eterogenei. Equilibri in soluzione acquosa: definizione di acidi e basi, prodotto ionico dell'acqua, pH, acidi e basi forti e deboli, titolazioni, indicatori, soluzioni tampone, idrolisi, solubilità, effetto ione comune. Elettrochimica: celle galvaniche, elettrolisi, potenziali di elettrodo, equazione di Nernst. Area di apprendimento scheda SUA: 1 Area delle conoscenze propedeutiche English Atomic structure: general description, electronic structure of hydrogen, electronic structure of multielectron atoms, quantum numbers, orbitals. Periodic table of elements periodic properties, atomic radius, ionization potential, electron affinity, electronegativity. Chemical bonding: ionic, covalent bond, dative bond, octet rule, Lewis structures, molecular geometry, intermolecular bonds. Symbols, formulas and nomenclature. Molecules, moles, chemical reactions, concepts of thermodynamics Balancing chemical equations, yield of reaction, stoichiometric calculations. States of matter: gaseous state (state equation, Dalton's law, vapor pressure and boiling temperature), solid state (relations between structure and properties), liquid (surface tension), the state diagram of water . Solutions: preparation, concentration, colligative properties. Chemical equilibrium: homogeneous and heterogeneous equilibrium, equilibrium constants, law of mass action, Le Chatelier principle Equilibrium in aqueous solution: acids and bases, ionic product of water, pH, buffer solutions, salts hydrolysis. Titrations: acid-base, redox, complexometric Equilibrium solubility, common ion effect. Electrochemistry: galvanic cells, electrolysis, electrode potentials, Nernst equation. Chemical kinetics: basic concepts TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Palmisano e Schiavello, Elementi di Chimica, EdiSES, Napoli, 2007. Petrucci, Harwood, Chimica Generale, PICCIN, Torino, 1995. Michelin Lausarot, Vaglio, Fondamenti di stechiometria, PICCIN, Torino, 1988. English Palmisano e Schiavello, Elementi di Chimica, EdiSES, Napoli, 2007. - 284 - Petrucci, Harwood, Chimica Generale, PICCIN, Torino, 1995. Michelin Lausarot, Vaglio, Fondamenti di stechiometria, PICCIN, Torino, 1988. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dd2j - 285 - Chimica generale e analisi chimico agrarie - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL CHEMISTRY AND AGRICULTURAL CHEMICAL ANALYSIS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0395 Docente: Prof. Valter BOERO (Affidamento interno) Dott. Raffaele BORRELLI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708510, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 10 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria CHIM/02 - chimica fisica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Analisi chimico-agrarie (Anno Accademico 2015/2016) Principi di chimica (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7qij Analisi chimico-agrarie (Anno Accademico 2015/2016) Agricultural chemical analysis Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0395 Docente: Prof. Valter BOERO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708510, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Prova pratica - 286 - PREREQUISITI Aver frequentato la prima parte del corso di Chimica generale PROPEDEUTICO A Tutti i laboratori di Chimica e biologia. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Consolidare le conoscenze del corso di Chimica generale e fornire familiarità con il laboratorio di chimica. Acquisire le capacità di utilizzare in modo corretto la vetreria e la strumentazione di base del laboratorio di chimica. English Consolidate the knowledge of the general chemistry course and provide familiarity with the chemistry lab. Acquire the ability to make correct use of the glassware and instrumentation basic chemistry lab RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Familiarità con il laboratorio chimico, con la vetreria essenziale e la strumentazione di base. Capacità di eseguire alcune analisi di base del laboratorio chimico agrario, valutare e presentare i risultati delle analisi. English Familiar with the chemical laboratory glassware with essential and basic instrumentation. Ability to perform some basic analysis of the agricultural chemical laboratory, evaluate, and present the results of the analysis. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Sono fornite 7 lezioni frontali in aula di 2h che includono anche la presentazione dell'attività che sarà svolta in laboratorio; a seguire 7 esercitazioni in laboratorio di 2 ore nette. Ogni studente accede ad una postazione del laboratorio di chimica da solo o in coppia. Al termine del laboratorio si reca in una aula per 1h per ordinare il quaderno di laboratorio, effettuare i calcoli e le elaborazioni necessarie e per preparare la relazione relativa alla esercitazione. English The course is organized in 7 lectures 2h each that include the presentation of the activities that will be carried out in the laboratory; each lecture is followed by 2 hours in the laboratory. Every student has his place in the chemistry laboratory alone or in pairs. At the end of the laboratory the students have 1h in classroom for calculations, data processing and to prepare a report. - 287 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Per ogni esercitazione è richiesta la preparazione di una relazione che permette di comprendere e valutare l'apprendimento dello studente. Al termine del corso è realizzata una prova individuale in laboratorio con analisi di un composto e preparazione di una breve relazione. L'esito di questa analisi, la valutazione delle relazioni presentate al temine di ogni esercitazione, la valutazione sul quaderrno di laboratorio permettono di valutare il grado di apprendimento dell'allievo e di esprimere un voto. Su richiesta dell'allievo o del docente viene svolto anche un colloquio orale inerente il programma svolto per definire la valutazione finale English For lab is required the preparation of a report that allows you to understand and evaluate student learning. At the end of the course it is made of an individual test in the laboratory with analysis of a compound and preparation of a short report. The outcome of this analysis, the evaluation of the reports submitted to the end of each lab, the evaluation of the laboratory notebook are the factors used to assess the degree of learning of the students. On specific request (student or professor) an oral colloquium could be undertaken to complete the final evaluation. PROGRAMMA Italiano Introduzione al laboratorio: nozioni di sicurezza, vetreria e strumentazione di base. • Trattamento dei dati e presentazione dei risultati: quaderno di laboratorio, nozione di errore, valutazione dell'accuratezza, della ripetibilità e delle sensibilità di un metodo analitico. • Calibrazione degli strumenti. • Titolazioni: acido-base, ossido-riduzione, complessometria. • Preparazione di soluzioni a titolo noto. • Preparazione di soluzioni di acidi e basi (concentrazione in peso, normalità, molarità). • Titolazioni acido-base: applicazione alla determinazione dell'acidità dell'aceto e del limone. • Titolazione di ossido riduzione: applicazione alla determinazione della concentrazione di una soluzione di Fe (II). • Titolazione complessometrica: applicazione alla determinazione della durezza dell'acqua • Preparazione di standard analitici, calibrazione di alcuni strumenti. Questo corso appartiene all'area di apprendimento SUA 8 Area tecnica speciale. - 288 - English Activity in classroom Introduction to laboratory principles of safety, glassware and basic instruments Data processing and presentation of results of laboratory notebook, the concept of error, evaluation of the accuracy, repeatability and sensitivity of an analytical method. Symbols, formulas and nomenclature. Molecules, moles, chemical reactions, valence, number of oxidation Balancing chemical equations, yield of reaction, stoichiometric calculations. Solutions: preparation, concentration, dilution. Calibration of instruments Lab activity • Preparation of solutions of primary standards • Preparation of solutions of acids and bases (concentration by weight, normality, molarity, molality) • Acid-base titrations: application to the determination of the acidity of vinegar and lemon • pH meter: principle and application to the determination of pH of some alimentary liquids • redox titration: application to the determination of the concentration of a solution of Fe (II). • complexometric titration: application to the determination of water hardness • Preparation of analytical standards, calibration of instruments: application to the determination of the concentration of phosphorus in aqueous solution with a colorimetric method. Italiano Consolidamento delle conoscenze del corso di Chimica generale e familiarità con il laboratorio di chimica. English Consolidation of the knowledge of the general chemistry course and familiarity with the chemistry lab. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Carmine Rubino, Italo Venzaghi, Renato Cozzi Stechio & Lab Le basi dell'analisi chimica 1-Stechiometria 2-Principi e Metodologia Ed. Zanichelli English Carmine Rubino, Italo Venzaghi, Renato Cozzi Stechio & Lab Le basi dell'analisi chimica 1-Stechiometria 2-Principi e Metodologia Ed. Zanichelli NOTA Italiano - 289 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s3m2 - 290 - Principi di chimica (Anno Accademico 2015/2016) General chemistry Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0395 Docente: Dott. Raffaele BORRELLI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708621, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: CHIM/02 - chimica fisica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti per la comprensione di base della struttura della materia e dei fenomeni chimici, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, consentendo di affrontare con conoscenze adeguante i corsi succesivi. English The course will provide basic understanding, at both qualitative and quantitative levels, of the structure of matter and of chemical phenomena. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano • Conoscenza del linguaggio, delle definizioni, dei concetti e dei modelli della chimica come sviluppati nel corso; • Capacità di risolvere problemi stechiometrici complessi English • Proper knowledge of chemical language, definitions and models as developed in the class • Ability to solve complex stoichiometric problems MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 291 - Italiano Il corso consiste di 80 ore di lezione frontale. Per le lezioni frontali il docente si avvale di Visual Presenter, rendendo disponibili in formato elettronico (pdf) i documenti prodotti durante lo svolgimento della lezione. English 80 hours of lectures . A Visual Presenter will be used allowing to produce pdf documents for each lesson, which will be available to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'apprendimento degli studenti verrà verificato mediane esercitazioni teoriche sia singole che di gruppo. Verrà inoltre utilizzata una piattaforma di e-learning mediante la quale gli studenti verranno stimolati e seguiti nella risoluzione di problemi inerenti il programma sviluppato durante il corso. L'esame finale consiste in un test scritto diviso in tre sezioni: i) domande a risposta multipla, ii) domande a risposta numerica e iii) domande a risposta aperta. English Students learning will be verified by individual as well as group exercises. An e-learning platform will also be used to encourage students to follow the class by continously testing their capability to solve problems concerning the program developed during the course. The final exam is a written test comprising three sections: i) multiple choice questions, ii) numeric questions, iii) open questions. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Il corso si avvale dell'utilizzo della piattaforma di e-learning Moodle per fornire sia i documenti prodotti durante la lezione (appunti del docente) sia le videoregistrazioni delle lezioni del corso. La piattaforma moodle verrà inoltre utilizzata per la creazione di forum e chat on-line per la discussione degli argomenti del corso. Usando tali strumenti gli studenti potranno interagire tra loro e con il docente per migliorare la comprensione di argomenti specifici. English An extensive use of the e-learning Moodle platform will be made. Moodle will be used to provide the documents produced in each lesson (teacher's notes) and the video recordings of the lessons. The e-learning system will also be used to create dedicated on-line forums and chat sessions where students can discuss specific chemistry topics, and interact with the teacher. PROGRAMMA Italiano Questo corso appartiene all'area di apprendimento 1 (formazione di base). • Le basi della chimica moderna: struttura dell'atomo e teoria atomica della materia. Numero atomico, numero di massa, isotopi. Massa atomica. - 292 - • Calcolo stechiometrico: massa formula, massa molecolare, massa equivalente, numero di Avogadro; concetto di mole e sue applicazioni. • Configurazione elettronica dell'idrogeno e di atomi a molti elettroni; numeri quantici, nozione di orbitale. • Sistema periodico degli elementi: proprietà periodiche di atomi e ioni, raggi atomici, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. • Molecole e composti, formule chimiche, simboli, definizioni e modelli molecolari. • Legame chimico: legame ionico, legame covalente, legame dativo, regola dell'ottetto, strutture con ottetto espanso; strutture di Lewis, forma e struttura molecolare, interazoni intermolecolari. • Nomenclatura delle molecole. • Reazioni chimiche; descrizone simbolica delle reazioni; reazioni di ossidoriduzione, reazione di combustione; bilanciamento delle reazioni, resa di reazione; • Cenni di termodinamica; primo e secondo primcipio, entalpia ed entropia; energia libera e spontaneità dei processi; legge di Hess; entalpie di legame; applicazioni di termochimica. • Cinetica chimica: velocità di reazione e fattori che la influenzano; cinetiche del primo ordine. • Stati di aggregazione della materia: stato gassoso (equazione di stato, legge di Dalton, tensione di vapore e temperatura di ebollizione); interazioni intermolecolari, stato solido, concetto di reticolo cristallino, stato liquido, diagramma di stato dell'acqua e di altri liquidi comuni. • Sistemi a più componenti; espressione della concentrazione; proprietà colligative: legge di Raoult, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica e fenomeni di osmosi; miscele azeotropiche. • Equilibrio chimico: legge di azione di massa, principio di Le Châtelier. equilibri omogenei ed eterogenei, costanti di equilibrio. • Equilibri in soluzione acquosa: definizione di acidi e basi, prodotto ionico dell'acqua, pH, acidi e basi forti e deboli, soluzioni tampone, idrolisi dei sali. • Equilibri di solubilità, effetto dello ione comune. • Elettrochimica: celle galvaniche, elettrolisi, potenziali di elettrodo, equazione di Nernst. English The class focuses on subject that are configured in the learning context of training and basic concepts. • Atomic structure, atomic theory of matter. Atomic number, mass number, isotopes; Atomic mass. • Stoichiometry: molar and equivalente mass, mole and Avogadro's number. • Electronic configuration of hydrogen atom, and of many-electron atoms; quantum numbers and the concenpt of atomic orbital. • Periodic system of the elements: periodicity in atomic and ionic properties: atomic radii, ionization potential, electron affinity, electronegativity. • Molecules and chemical compounds; chemical formulae, symbols, definitions and molecular models. - 293 - • Chemical bond: ionic bond, covalent bond, dative bond, octet rule, octet expansion; Lewis structure, shape and geometry of molecules. • Chemical nomenclature. • Chemical reactions; symbolic descriptios of reactions; balancing chemical reactions; common type of reactions: exchange, redox, combustion; reaction yield. • Basic concepts of thermodynamics: first and second principle, enthalpy, entropy, and free energy. Spontaneous processes. Hess' law; bond enthalpy; thermochemistry applications. • Chemical kinetics: reaction rate; first order reactions. • State of matter: gas state (equation of state, Dalton's law);liquid state (vaoupr tension, boiling point, freezing poing); solid state crystals and crystal lattice. Intermolecular interactions. • Many components systems; concentrations; colligative properties; Raoult's law, ebullioscopy, crioscopy, osmotic pressure; azeotrope. • Chemical equilibrium, mass action law, Le Chatelier principle. Homogeneous and heterogeneous equilibria, equibrium constants. • Equilibria in acqueous solution: acids and base, ionic product, pH, strong and weak acids and bases, buffer solutions, hydrolisys reactions. • Solubility equilibrium. • Basic principles and applications of electrochemistry, galvanic and electrolytic cells, electrode potentials, Nernst equation. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano • L. Palmisano, M. Schiavello Elementi di chimica, Ed. EdiSES • Elementi di Stechiometria, P. Giannoccaro e S. Doronzo, EdiSES • Stechiometria per la Chimica Generale, Paola Michelin Lausaro - Gian Angelo Vaglio, Piccin English • L. Palmisano, M. Schiavello Elementi di chimica, Ed. EdiSES • Elementi di Stechiometria, P. Giannoccaro e S. Doronzo, EdiSES • Stechiometria per la Chimica Generale, Paola Michelin Lausaro - Gian Angelo Vaglio, Piccin NOTA Italiano - 294 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=usjq - 295 - Chimica organica (Anno Accademico 2015/2016) ORGANIC CHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0012 Docente: Dott. Stefano Dughera (Contratto) Contatti docente: 0116707645, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: CHIM/06 - chimica organica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Avere sostenuto l'esame di Chimica generale e analisi chimico-agrarie PROPEDEUTICO A Biochimica degli alimenti e Chimica e Biologia agraria OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone di fornire le conoscenze di base riguardanti la struttura, la stereochimica e la reattività in Chimica Organica con particolare attenzione per i gruppi funzionali presenti nelle biomolecole e con l 'obiettivo di fornire gli strumenti per la comprensione dei processi biochimici English The aim of this course is to give basic knowledge about structure, stereoisomerism and reactivity in organic chemistry, with a particular attention with respect biomolecules RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti, al termine del corso, dovranno conoscere la struttura geometrica di una molecola organica, inclusa l'assegnazione delle configurazioni degli stereosiomeri. Dovranno inoltre sapere attribuire a tale molecola il nome IUPAC . Dovranno poi conoscere le principali caratteristiche strutturali e di reattività dei diversi composti organici in base ai gruppi funzionali presenti ed i principali meccanismi di reazione ed infine dovranno conoscere le principali classi delle biomolecole. English Students will be able to give IUPAC name to common organic structures; know structure and reactivity of main - 296 - functional groups in organic chemistry; know biomolecule structure. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano L'insegnamento verrà impartito con lezioni frontali in aula. English Classroom lectures MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame scritto sugli argomenti svolti a lezione. Inoltre si terranno delle esercitazioni mirate durante l'espletamento del programma di studio. Il voto sarà espresso in trentesimi. English Written examination and practice exercises during the course. The valutation will be in thirties. PROGRAMMA Italiano La struttura elettronica, il legame ionico e il legame covalente. Orbitali atomici.Ibridazione sp3 dell'atomo di carbonio. Angoli di legame e lunghezza di legame.Idrocarburi: gli alcani. Nomenclatura. Stereoisomeria conformazionale. Gli isomeri dell'etano e del butano.I cicloalcani. Stereoisomeria conformazionale del ciclobutano, ciclopentano e cicloesano.Ibridazione sp2 dell'atomo di carbonio. Gli alcheni. Stereoisomeria geometrica.Ibridazione sp dell'atomo di carbonio. Gli alchini.Chiralità e stereoisomeria ottica.Il fenomeno della coniugazione e risonanza . Il benzene e le molecole aromatiche.Gruppi funzionali: struttura e nomenclatura. Le reazioni organiche: tipologia di reazioni organiche e specie reattivi. I reattivi nucleofili ed elettrofili.Acidi e basi. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica (SN1 e SN2) negli alogenuri alchilici. I carbocationi.Gli alcoli. Reazioni con acidi alogenidrici; reazioni di ossidazione; il numero di ossidazione dell'atomo di carbonio. Gli epossidi. Reazioni di apertura dell'anello. Gli eteri. La sintesi di Williamson.Le ammine. Basicità delle ammine e loro sintesi.I tioli. Reazioni di eliminazione (E1 ed E2) negli alogenuri arilici. Disidratazione degli alcoli.Reazioni di addizione elettrofila al doppio legame. Idroalogenazione; la regola di Markovnikov. Addizione di acqua e di alogeni. L'idrogenazione e l'ossidazione di alcheni.Le reazioni e l'acidità degli alchini. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Alogenazione, nitrazione del benzene. L'acilazione di Friedel-Crafts. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica nei benzeni sostituiti: l'effetto elettronico del sostituente.I fenoli: acidità e reazioni di ossidazione. Le ammine aromatiche: basicità. Le aldeidi e i chetoni. Reazioni di addizione nucleofila. I reattivi organometallici e i carbanioni. Addizione di ammine; addizione di acqua; addizione di alcoli: emiacetali ed acetali. Riduzione ed ossidazione delle aldeidi. Acidi carbossilici e derivati. Le reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Acidità degli acidi carbossilici. Reazioni dei cloruri degli acidi. Esterificazione di Fisher e transesterificazione. Idrolisi degli esteri e delle ammidi.I nitrili: formazione e reazioni.Reazioni degli alcani: reazioni radicaliche e reazioni di ossidazione.Anioni enolato e loro reattività. - 297 - Condensazione aldolica; condensazione di claisen; sintesi acetoacetica e sintesi malonica. Biomolecole essenziali: glicidi, protidi e lipidi (struttura e reattività) English The electronic structure, ionic bonding and covalent bonding. Atomic orbitals. sp3 hybridization of the carbon. Bond angles and bond length. Hydrocarbons: alkanes. Nomenclature. Stereoisomerism conformational. Isomers of ethane and butane.Cycloalkanes. Stereoisomerism conformational cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane.sp2 Hybridization of the carbon. Alkenes. Stereoisomery geometric. sp Hybridization of the carbon. Alkynes.Chirality and optical stereoisomerism.Conjugation and resonance. Benzene and aromatic organic molecules.Functional groups: structure and nomenclatur Organic reactions: type of organic reactions and reactive species. The reactive nucleophiles and electrophiles. Acids and bases. Aliphatic nucleophilic substitution reactions (SN1 and SN2) in alkyl halides. Carbocations. Alcohols. Reactions with hydrogen halides; oxidation reactions; the number of oxidation of the carbon. Epoxides. Ring opening reactions. Ethers. Synthesis of Williamson.Amines. Basicity of amines and their synthesis. Thiols Elimination reactions (E1 and E2) in aryl halides. Dehydration of alcohols. Electrophilic addition reactions to the double bond. Markovnikov rule. Addition of water and halogen. The hydrogenation and oxidation of alkenes. Reactions and the acidity of the alkyne. Electrophilic aromatic substitution. Halogenation, nitration of benzene. Friedel-Crafts acylation. Reactions of electrophilic aromatic substitution in substituted benzenes: electronic effect of the substituent. Phenols: acidity and oxidation reactions. Aromatic amines: basicity. Aldehydes and ketones. Nucleophilic addition reactions. Organometallic reagents and the carbanions. Addition of amines; addition of water; addition of alcohol: hemiacetals and acetals. Reduction and oxidation of aldehydes. Carboxylic acids and derivatives. Nucleophilic acyl substitution. Acidity of carboxylic acids. Reactions of acid chlorides. Fisher esterification and transesterification. Hydrolysis of esters and amides. Nitriles: formation and reactions. Alkanes: radical and oxidation reactions. Enolate anions and their reactivity. Aldol condensation; Claisen condensation; acetoacetic and malonic synthesis. Biomolecules : glucides, proteins and lipids (structure and reactivity) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Paula Yurkanis Bruice, Elementi di Chimica Organica, EdiSES, Napoli J. Gorzynski Smith, Fondamenti di chimica organica, Mc Graw-Hill, 2014, II ed Bruno Botta, Chimica Organica Essenziale, Edi.Ermes, Milano W.H.Brown, T. Poon- Introduzione alla chimica Organica- Edises Per esercizi si consiglia il seguente testo: M. Valeria D'Auria, Orazio Taglialatela Scafati, Angela Zampella- Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organica- English Paula Yurkanis Bruice, Elementi di Chimica Organica, EdiSES, Napoli J. Gorzynski Smith, Fondamenti di chimica organica, Mc Graw-Hill, 2014, II ed - 298 - Bruno Botta, Chimica Organica Essenziale, Edi.Ermes, Milano W.H.Brown, T. Poon- Introduzione alla chimica Organica-EdiSES M. Valeria D'Auria, Orazio Taglialatela Scafati, Angela Zampella- Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organicaNOTA Italiano Potrebbe essere previsto lo svolgimento di un accertamento in itinere facoltativo sulla prima parte del programma (struttura e nomenclatura) English An ongoing examination could be carried out Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fip0 - 299 - Chimica organica (Anno Accademico 2015/2016) ORGANIC CHEMISTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0008 Docente: Dott. Margherita Barbero (Affidamento interno) Contatti docente: 0116707645, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: CHIM/06 - chimica organica Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone di fornire le conoscenze di base riguardanti struttura, stereochimica e reattività in chimica organica, con particolare attenzione per i gruppi funzionali presenti nelle biomolecole, con l'obiettivo di fornire gli strumenti per la comprensione dei processi biochimici. English The aim of this course is to give basic knowledge about structure, stereoisomerism and reactivity in organic chemistry, with a particular attention with respect to biomolecules RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti, al termine del Corso, dovranno essere in grado di attribuire il nome IUPAC ad un composto organico e dal nome risalire alla formula, inclusa l'assegnazione delle configurazioni di stereoisomeri; conoscere le principali caratteristiche strutturali e di reattività dei diversi composti organici in funzione dei gruppi funzionali presenti; conoscere le classi principali delle biomolecole. English Students will be able to give IUPAC name to common organic structures; know structure and reactivity of main functional groups in organic chemistry; know biomolecule structure and reactivity. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 300 - Italiano L'insegnamento consiste di 60 ore di lezioni frontali, per le quali il docente si avvale di slides a disposizione degli studenti. English Teaching methods: Lectures 60 hours, based on slides available for students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano A metà del programma, il docente procederà ad un accertamento in itinere, mediante la somministrazione di un test utile allo studente per valutare il proprio grado di apprendimento. Sono inoltre previste esercitazioni mirate durante l'espletamento del programma di studio. L'esame finale consiste in una prova scritta articolata in domande riguardanti struttura, nomenclatura e reattività delle principali classi funzionali e struttura e funzioni delle biomolecole studiate. Ogni domanda viene valutata in 30esimi, il voto finale corrisponde alla media matematica. English During the course, a written test will be done in order to allow students to verify their comprehension level. Practice exercises during the entire course will be done. The final exam consists of a written test structured in questions relating to structure, nomenclature and reactivity of organic functional groups, and structure and biological functions of the basic biomolecules. Each question is evaluated in 30th, the final grade corresponds to the average of the single marks. PROGRAMMA Italiano Tutti gli argomenti del programma appartengono all'area delle conoscenze propedeutiche. La struttura elettronica, il legame ionico e il legame covalente. Orbitali atomici, ibridi sp, sp2 e sp3, ioni isoelettronici, angoli di legame e lunghezza di legame. Acidi e basi. Gruppi funzionali in chimica organica: struttura e nomenclatura. Alcani, reattività. Isomeria conformazionale. Alcheni e alchini. Stereoisomeria. Reazioni di alcheni e alchini. Idrocarburi aromatici. Delocalizzazione elettronica. Reazioni dei composti aromatici. Chiralità. Isomeria ottica. Reazioni radicaliche negli alcani. Reazioni di sostituzione (SN1 e SN2) e reazioni di eliminazione negli alogenuri alchilici. Reazioni di alcoli, ammine, eteri ed epossidi. Composti carbonilici: nomenclatura, struttura. Reattività di acidi carbossilici e derivati. Reattività di aldeidi e chetoni. Composti carbonilici: reazioni del carbonio in α. Biomolecole essenziali: glicidi, protidi e lipidi (struttura, reattività, funzioni biologiche). Acidi nucleici. English Electronic structure, ionic and covalent bond, atomic orbitals, ibridization, isolectronic ions, bond and length angles. Acids and bases. Functional groups in organic chemistry: structure and nomenclature. Alkanes: structure and reactivity. Conformational isomers. Alkenes, alkynes: structure and reactivity. Stereoisomers. Aromatic hydrocarbons, aromaticity, reactivity. Chirality and optical isomerism. SN1 and SN2 substitution reactions, E1 and E2 elimination reactions. Alcohols, amines, ethers and epoxides. Carbonyl compounds: structure, nomenclature, - 301 - reactivity of carboxylic acids and derivatives, aldehydes and ketones. Biomolecules: glucides, proteins and lipids (structure, reactivity, biological activity); nucleic acids. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano J. GORZYNSKI SMITH, Fondamenti di chimica organica, Mc Graw-Hill, 2014, II ed. B. BOTTA, Chimica organica essenziale, Edi.ermes, 2012. W. H. BROWN, T. POON, Introduzione alla chimica organica, EdiSES, 2014, V ed. P. YURKANIS BRUICE, Elementi di chimica organica. V. D'AURIA, O. TAGLIALATELA, A. ZAMPELLA: Guida ragionata allo svolgimento di Esercizi di Chimica Organica, 2013, Loghia, III ed English J. GORZYNSKI SMITH, Fondamenti di chimica organica, Mc Graw-Hill, 2014, II ed. B. BOTTA, Chimica organica essenziale, Edi.ermes, 2012. W. H. BROWN, T. POON, Introduzione alla chimica organica, EdiSES, 2014, V ed. P. YURKANIS BRUICE, Elementi di chimica organica. V. D'AURIA, O. TAGLIALATELA, A. ZAMPELLA: Guida ragionata allo svolgimento di Esercizi di Chimica Organica, 2013, Loghia, III ed NOTA Italiano Il corso è equipollente con Chimica organica (3CFU) + Approfondimenti di chimica organica (3 CFU) English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=unsr - 302 - Ciclo della sostanza organica (Anno Accademico 2015/2016) CYCLE OF ORGANIC MATTER Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0362 Docente: Prof. Luisella Roberta CELI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708515, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il modulo si propone di fornire una conoscenza approfondita sulle dinamiche della sostanza organica e dei nutrienti, ai fini di permettere di comprendere i fattori che regolano la formazione e lo sviluppo dei suoli trattati nel modulo di pedologia forestale e la crescita vegetale in ecosistemi forestali , anche in funzione dei nuovi scenari in seguito al cambiamento climatico. English The course integrated with forest pedology will furnish a deep knowledge on soil organic matter and nutrient dynamics in order to undestrand the factors which drive soil formation and development and plant nutrition in different forest ecosystems, while considering also the new scenarios due to climate change RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano - 303 - Al termine del modulo lo studente avrà competenze approfondite sulle dinamiche della sostanza organica e dei nutrienti in suoli forestali, sui tipi di Humus che ne possono derivare, sulle relazioni tra proprietà nutrizionali del suolo e vegetazione ne diversi biomi forestali, anche in relazione alle pratiche selvicolturali English With this course the student will acquire a large competence on soil organic matter and nutrient dynamics in forest ecosystems, humus types, and interconnections between soil nutritional properties and forest management. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo si svolgerà in 60 ore suddivise tra lezioni teoriche, lezioni interattive, esercitazioni in aula e in campo, con una forte interazione con l'altro modulo English The course of 60 hours will include theoretical lectures, interactive lectures, class exercises and field excursions. It provides a strong interaction with he other course. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Alla fine di ogni argomento si svolgeranno esercitazioni con correzione e discussione in aula. Alla fine del modulo sarà effettuata una simulazione d'esame insieme al docente dell'altro modulo. Tutte le verifiche svolte durante il corso hanno puramente valore di autovalutazione. L'esame finale sarà integrato con l'altro modulo e consta di uno scritto comune in cui si devono svolgere test numerici, interpretazioni di dati e domande di conoscenza teorica. A questo seguirà un orale. Il superamento dell'esame scritto di entrambi i moduli è vincolante per l'orale. English At the end of each topic I will do exercises with correction and discussion. At the end of the module I will do an exam simulation with the teacher of the other module . All audits carried out during the course have value of purely self-assessment . The final exam will be integrated with the other module and consists of a joint written text where students have to perform numerical tests , interpretations of data and answer to questions of theoretical knowledge . This will be followed by an oral examination . Passing the written is mandatory for the oral. ATTIVITÀ DI SUPPORTO - 304 - PROGRAMMA Italiano Funzionalità dell'ecosistema forestale e cicli biogeochimici Lettiera e humus forestale: Classificazione degli humus forestali Ciclo dell'acqua e principali reazioni e processi guidati dall'acqua Ciclo del Carbonio e dinamiche della sostanza organica nei suoli forestali. Processi che regolano la decomposizione della sostanza organica nel suolo. Effetti della sostanza organica sulle proprietà chimiche, fisiche e biologiche del suolo Ciclo dell'azoto Ciclo del fosforo Ciclo dello zolfo Ciclo dei micronutrienti Le dinamiche dei nutrienti nell'ambiente rizosferico Influenza della gestione forestale sulle proprietà del suolo e dei nutrienti Esercitazione: uscita in campo integrata con l'altro modulo in cui verrà illustrato un particolare ecosistema forestale e la stretta connnessione tra vegetazione, suolo e ciclo dei nutrienti Tutti gli argomenti sono relativi alle seguenti aree di apprendimento: Area della gestione multifunzionale sostenibile delle risorse forestali e Area della difesa del suolo e della prevenzione dei rischi naturali English Functionality of the forest ecosystem and biogeochemical cycles. Forest floor and humus classification Water cycle and main soil reactions and processes driven by water Carbon cycle and soil organic matter dynamics. Processes that control soil organic matter decomposition. Effects of organic matter on chemical, physical and biological soil properties Nitrogen cycle Phosphorus cycle Sulfur cycle Micronutrient cycle Nutrient dynamics in the ryzosphere - 305 - Influence of forest management on soil and nutrient properties Field excursion integrated with the other module in which students will see a particular forest ecosystem and the tight connnection between vegetation, soil and nutrient cycling All topics are related to the following learning areas: Area of multifunctional sustainable forest management and area of soil protection and prevention of natural disturbances TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Giordano A. 2002. Pedologia forestale e conservazione del suolo. UTET Torino Nannipieri P. 1993. Ciclo della sostanza organica nel suolo. Patron Editore English Giordano A. 2002. Pedologia forestale e conservazione del suolo. UTET Torino Nannipieri P. 1993. Ciclo della sostanza organica nel suolo. Patron Editore NOTA Italiano Le slides verranno fornite prima dell'inizio delle lezioni. Alcune modifiche potrebbero essere possibili durante il corso. English Slides will be available since the beginning of the course. Possible variations could be done during the course. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iz22 - 306 - Coltivazioni erbacee (Anno Accademico 2015/2016) HERBACEOUS CROPS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0090 Docente: Prof. Aldo FERRERO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708780, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso ha la finalità di esaminare le colture erbacee alimentari e non alimentari di maggior interesse per l'agricoltura italiana, riservando alla trattazione di ciascuna uno spazio correlato all'importanza che essa assume nello scenario produttivo agricolo attuale o del prossimo futuro. Ogni coltura viene trattata considerando il ruolo che essa assume nell'economia agricola mondiale e nazionale, le esigenze ecologiche, il quadro delle pratiche agronomiche, le caratteristiche qualitative e l'utilizzazione delle produzioni e dei sottoprodotti. Ognuno di questi aspetti viene esaminato in relazione alle più aggiornate conoscenze scientifiche e delle esperienze pratiche, ponendo particolare attenzione alle relazioni esistenti tra gestione colturale e protezione dell'ambiente. English This course is aimed at examining food and no-food major field crops for Italian agriculture, giving each one a development correlated to the importance that it has at present or in the near future in the global productive scenario. Each crop is examined considering its role in the global and domestic agricultural economy, its ecological needs, the agricultural practices, the qualitative features and the use of the harvested products and by-products. All these aspects will be considered in relation to the most updated aquisitions and the practical experiences, paying particular attention to the relationships between cultural management and environment protection. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano A termine del corso lo studente disporrà delle conoscenze scientifiche e tecniche per l'organizzazione e la gestione - 307 - delle colture erbacee di pieno campo e dei sistemi colturali più significativi ,secondo i principi della produzione sostenibile e nella logica della produttività aziendale. Attraverso gli argomenti trattati lo studente avrà gli elementi per sviluppare, in modo integrato, le conoscenze acquisite nel corso di Agronomia per i diversi sistemi colturali, applicandole alla coltivazione delle principali specie erbacee. English At the end o f the course the student will be provided with the scientific and technical knowledge for the management of the major field crops and cultural systems according to the principles of the sustainable production and within the logic of the farm productivity. Through the topics examined in the lectures the student will be able to develop, in integrated way, the knowledge acquired in the course of Agronomy for different cultural systems, applying it to the major field crops. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso è previsto un test per accertare il livello di apprendimento delle tematiche trattate. L'esame al termine del corso riguarderà tutti gli aspetti trattati durante lezioni e si svolgerà con delle domande orali English A test to verify the level of learning of the students will be carried out during the course. The exam at the end of the course will be related to all aspects examined during the course and will be done with oral questions ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Per favorire la conoscenza diretta delle tecniche colturali , durante il corso sono previste una o più uscite in campo presso aziende agricole e presso l'azienda sperimentale del DISAFA . English During the course, one or more field excursions will be made in different farms and in the DISAFA experimental station to improve direct knowledge of crop practices. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento delle produzioni vegetali, individuata dagli insegnamenti necessari per acquisire conoscenze nel settore dell'agronomia e della chimica del suolo, delle coltivazioni erbacee, arboree e floricole, della microbiologia, delle relazioni tra fisiologia e pratiche colturali, - 308 - nonché del miglioramento genetico. Concetti generali Importanza territoriale delle coltivazioni erbacee Sistemi colturali Avvicendamento e rotazione: storia, principi, modelli di rotazione, evoluzione moderna. Influenza della politica agricola comunitaria. Caratteristiche dei principali sistemi produttivi: mercantili (maidicolo, risicolo, bieticolo), foraggeri (intensivi, semi-intensivi, estensivi) Cereali vernini Importanza e caratteristiche Frumento tenero e frumento duro Importanza. Caratteristiche generali. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici e fenologici. Esigenze. Miglioramento genetico. Criteri per la scelta varietale. Tecniche colturali. Caratteristiche qualitative. Utilizzazione. Gestione dei sottoprodotti Orzo Importanza. Caratteristiche generali. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici. Esigenze. Tecniche colturali. Utilizzazione. Cereali vernini minori (segale, avena) Importanza. Caratteristiche generali. Esigenze. Tecniche colturali. Utilizzazione Cereali estivi Importanza e caratteristiche Mais Caratteristiche generali. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici e fenologici. Esigenze. Miglioramento genetico. Criteri per la scelta varietale. Tecniche colturali. Utilizzazione della granella. Aspetti qualitativi e sanitari. Produzione e utilizzazione come foraggio. Conservazione della granella e del foraggio Riso Caratteristiche generali. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici e fenologici. Esigenze. Miglioramento genetico e scelta varietale. Tecniche colturali. Caratteristiche qualitative, processi tecnologici, gestione dei sottoprodotti Cereali estivi minori (sorgo, miglio e panico) Importanza. Caratteristiche generali. Esigenze. Tecniche colturali. Utilizzazione Proteaginose e oleaginose e Soia Importanza. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici e fenologici. Esigenze. Criteri per la scelta varietale. Metabolismo dell'azoto. Tecniche colturali. Utilizzazione. Girasole - 309 - Caratteristiche generali. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici e fenologici. Esigenze. Scelta varietale. Tecniche colturali. Utilizzazione Industriali Barbabietola da zucchero Importanza. Origine e classificazione. Aspetti morfologici, ecologici e fenologici. Esigenze. Criteri per la scelta varietale. Tecniche colturali. Tecniche industriali. Utilizzazione. Gestione dei sottoprodotti. Colture energetiche e da fibra Importanza, caratteristiche, aspetti energetici Colza Importanza. Aspetti morfologici. Esigenze. Tecniche colturali. Utilizzazione Canapa, Kenaf Importanza. Esigenze. Tecniche colturali. Utilizzazione Foraggere Importanza. Classificazione e inquadramento. Caratteristiche botaniche ed eco-fisiologiche delle graminacee e delle leguminose. Caratteristiche qualitative. Utilizzazione e conservazione: fienagione; disidratazione; insilamento Erbai Caratteristiche. Tipologie. Loietto italico: esigenze; tecniche colturali; utilizzazione Prati Caratteristiche. Tipologie. Erba medica, trifoglio violetto, trifoglio bianco, dattile, festuche: esigenze; tecniche colturali; utilizzazione Pascoli Caratteristiche. Tipologie. Tecniche colturali e utilizzazione Tappeti erbosi English The subjects, hereafter reported, are part of the learning area "plant production", which is included in the following discliplines agronomy, soil science, crop science, microbiology, plant physiology, plant breeding. Introduction Importance of herbaceous field crops Cropping systems - 310 - Rotations:origin, principles, types, modern evolution. Influence of the European agricultural policy Features of the main cultural systems: for the market (based on maize, rice, sugarbeet) for the forage production (intensive, semi-intensive, extensive) Winter cereals Importance and features Soft wheat and durum wheat Importance. General features: Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements. Breeding. Variety choice. Cultural practices. Qualitative features. Uses. Byproducts Barley Importance. General features: Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements. Cultural practices. Uses. Minor winter cereals (rye, oat) Importance. General features. Requirements. Cultural practices. Uses. Summer cereals Importance and features Maize Importance. Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements. Breeding. Variety choice. Cultural practices. Uses of the maize grain. Production and use as forage. Conservation of grain and forage Rice Importance. General features: Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements. Breeding. Variety choice. Cultural practices. Qualitative features. Technological processes. Uses. Byproducts Minor summer cereals (sorghum, millets ) Importance. General features: Requirements. Cultural practices. Uses. Protein and oil plants Soyabean Importance. Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements. Variety choice. N metabolsim. Cultural practices. Uses. Sunflower General features: Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements and variety choice. Cultural practices. Uses. Industrial crops Sugar beet Importance. Origin and classification. Mophological, ecological and phenological aspects. Requirements. Variety - 311 - choice. Cultural practices. Technological processes. Uses. Byproducts Energy and fiber crops Importance, features, energey aspects Oilseed rape Importance. Morphological aspects. Requirements. Cultural practices. Uses. Hemp, Kenaf Importance. Requirements. Cultural practices. Uses. Forage crops Importance. Classification. Botanical and eco-physiological features of grasses and pulses. Qualitative features. Uses and conservation: haymaking, dehydratation, ensiling Annual forage crops Features. Typologies. Lolium multiflorum : Requirements. Cultural practices. Uses. Pluriennial forage crops Features. Typologies. Medicagago sativa, Trifolium pratense, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Festuca spp. : Requirements. Cultural practices. Uses. Pastures Features. Typologies. Requirements. Cultural practices. Uses. Lawns Features. Typologies. Requirements. Cultural practices. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni PowerPoint, dispense del corso e articoli per le letture critiche distribuiti dopo ogni lezione. Remigio Baldoni, Luigi Giardini. Coltivazioni erbacee. Cereali e proteaginose. Patron Editore, Bologna, 2000. F. Bonciarelli, U. Bonciarelli. Coltivazioni erbacee da pieno campo. Edagricole, Bologna, 2001 AA, VV, 2008. Il riso. Coordinamento scientifico di Aldo Ferrero. Collana Coltura & Cultura, Ed. Script, Bologna, pagine 696. AA, VV, 2008. Il mais. Coordinamento scientifico di Tommaso Maggiore. Collana Coltura & Cultura, Ed. Script, Bologna, pagine 696. AA, VV, 2008. Il grano. Coordinamento scientifico di Natale di Fonzo. Collana Coltura & Cultura, Ed. Script, Bologna, pagine 307. N. Lampkin. Organic farming. Farming Press, Cambridge UK, 1992. http:/www.corn.org http:/faostat.fao.org English - 312 - The recommended basic texts for the course are: PowerPoint presentations, lecture notes and articles for critical readings distributed during the course. Other suggested literature: Remigio Baldoni, Luigi Giardini. Coltivazioni erbacee. Cereali e proteaginose. Patron Editore, Bologna, 2000. F. Bonciarelli, U. Bonciarelli. Coltivazioni erbacee da pieno campo. Edagricole, Bologna, 2001 AA, VV, 2008. Il riso. Coordinamento scientifico di Aldo Ferrero. Collana Coltura & Cultura, Ed. Script, Bologna, pagine 696. AA, VV, 2008. Il mais. Coordinamento scientifico di Tommaso Maggiore. Collana Coltura & Cultura, Ed. Script, Bologna, pagine 696. AA, VV, 2008. Il grano. Coordinamento scientifico di Natale di Fonzo. Collana Coltura & Cultura, Ed. Script, Bologna, pagine 307. N. Lampkin. Organic farming. Farming Press, Cambridge UK, 1992. http:/www.corn.org http:/faostat.fao. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ngbp - 313 - Colture frutticole (Anno Accademico 2015/2016) Fruit and nut crops Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0378 Docente: Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708800, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le conoscenze sulle tecniche di gestione del post-raccolta dei prodotti frutticoli in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei frutti, della loro fisiologia di maturazione e della destinazione d'uso. English To provide knowledge on the techniques used in the post-harvest management of horticultural crops based on their chemical and physical characteristics, the ripening physiology and decay, and the commercial use. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente acquisirà le conoscenze e le competenze necessarie per gestire il post-raccolta delle principali specie arboree da frutto con particolare riferimento a quelle dei climi temperati. English The student will acquire the knowledge and skills to manage the post -harvest of the main fruit species with particular reference to those of temperate climates. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Tradizionale English - 314 - Traditional MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame sarà orale e prevede in linea di massima 3 domande su argomenti diversi; il docente potrà fare ulteriori domande qualora questo fosse necessario per la miglior valutazione della preparazione dello studente. Ogni domanda avrà uguale peso ai fini della formazione del voto finale. English Oral test. As general rule the exam is based on 3 questions on different arguments; the teacher may ask further questions in case this is considered necessary for the most appropriate evaluation of the student. Each question will have the same weight for the attribution of the final mark. PROGRAMMA Italiano La frutta nel mercato globale. Importanza economica del settore. Principale normativa che riguarda la frutta: impiego del gas etilene; norme di qualità per i prodotti destinati al consumo fresco. Concetto di qualità nella filiera frutticola. Composizione chimica dei frutti e cambiamenti che si verificano durante la maturazione (respirazione, struttura, colore, composizione chimica, caratteristiche organolettiche). Ruolo dell'etilene e controllo genetico della maturazione. Possibilità di controllo della sintesi dell'etilene e dei processi di maturazione. Fattori di pre- e post-raccolta che influenzano la qualità dei frutti. Scelta dell'epoca e delle modalità di raccolta in base agli indici di maturazione. Filiera frutta fresca: campionatura e controlli di qualità (indici di qualità; metodi strumentali, sistemi semi automatici, valutazione sensoriale); condizionamento; metodi di selezione (calibratura, selezionatrici ottiche, prospettive di impiego di NIRS, NMR); pre-refrigerazione; trattamenti particolari (estetici, per la prevenzione di patogeni e fisiopatie); conservazione; imballaggio; trasporto. Prodotti di IV gamma Filiera frutta secca: preparazione per il mercato dei frutti in guscio o lavorazione per l'industria (pre-calibratura, sgusciatura, selezione, calibratura, conservazione, trasporto); produzione di semilavorati. Mantenimento della qualità mediante le tecniche di conservazione e la gestione della catena del freddo: controllo della temperatura; modificazione dell'atmosfera (AC, ULO); mantenimento dell'UR; rimozione dell'etilene. Caratteristiche delle celle di conservazione ed accorgimenti tecnici idonei a garantirne la funzionalità. Apparecchiature per la messa a regime delle celle. Principali alterazioni fisiologiche durante il post-raccolta. English Fruits in the global market. Economic importance of the sector. Main legislation concerning fruit handling and trading including allowed treatments with ethylene and the EU and National regulations on fruit marketing standards. Definition of fruit quality. Fruit chemical and physical traits and their changes during ripening. Role of ethylene and genetic control of ripening. Means for controlling fruit ripening and ethylene synthesis. Pre- and post-harvest factors that influence fruit quality. Choosing time and harvesting technique. The fresh fruit chain: sampling fruits and evaluating quality (quality indexes; instrumental methods, semi-automated - 315 - methods, sensory evaluation); fruit conditioning; fruit selection (sizing and sorting methods); pre-refrigeration; treatments on fruit (washing, waxing, treating to prevent disorders and pathogens); storage; packaging; transportation. The maintaining of fruit quality during storage. Management of refrigeration. Setting and management of modified atmosphere; management of relative humidity; ethylene removal. Technical characteristics of storage chambers. The nut crops chain: preparing nuts for the fresh market; preparing nuts for the processing industry (pre-calibration, shelling, selection, sizing, storage, transportation); production of paste and chopped nuts. Emphasis on the hazelnut chain. Main disorders of fruit and nuts occurring in post-harvest TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Kader A.(editor). 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California ANR . Pub. n. 3311. Terza edizione. Knee M. –2002 – Fruit quality and its biological basis. CRC Press. USA Kays J.K., Paull R.E. – 2004 – Postharvest biology. Exon Press. USA Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. English Kader A.(editor). 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California ANR . Pub. n. 3311. Terza edizione. Knee M. –2002 – Fruit quality and its biological basis. CRC Press. USA Kays J.K., Paull R.E. – 2004 – Postharvest biology. Exon Press. USA Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6upk - 316 - Colture orto-floricole (Anno Accademico 2015/2016) Vegetable and ornamental crops Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0378 Docente: Prof. Silvana NICOLA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708773, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/04 - orticoltura e floricoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Apprendere le informazioni necessarie per una gestione del post-raccolta dell'ortofrutta, sia relativamente ai prodotti freschi sia ai prodotti lavorati, al fine della più corretta gestione della filiera, dalla produzione alla tavola. English Capacity building for an independent and knowledgeable evaluation of postharvest fresh and ready-to-eat produce in terms of quality to enhance the food chain efficiency, from farm to the table. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Apprendere le basi tecniche e biologiche per la gestione post-raccolta. Sviluppare le conoscenze di base sui fattori relativi alla perdita di qualità degli ortaggi in post-raccolta e durante le lavorazioni. Lo studente riceverà le informazioni e gli strumenti per comprendere i criteri di base sia biologici sia tecnico-colturali e tecnologici con cui i prodotti orticoli vengono ottenuti in campo, gestiti in post-raccolta e disponibili per il consumatore finale. Lo studente potrà essere in grado di sviluppare la sua comprensione delle filiere orticole attraverso l'apprendimento e gli approfondimento di casi specifici di suo interesse e di casi affidati dal docente. English Learning the technical and biological bases for high quality vegetable post-harvest handling. Enhancing the basic knowledge related to the factors that affect quality decay during post-harvest handling and processing. The students shall receive the information and the tools to understand the fundamentals behind cultural, technical and technological practices that make up the raw material and its post-harvest handling up to the consumer. The students shall be able to better understand the fresh produce chain even through practical laboratory exercises and - 317 - case studies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The class includes 30 hours of lectures plus 10 hours of laboratory. Visul aids are used in power point format and available to students MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti viene valutato periodicamente durante il corso attraverso esercitazioni e discussioni in aula su argomenti trattati con assegnazione di quesiti verbali sulle tematiche. Reports in itinere Test finale Lavori di laboratorio/casi studio English Progress of students' learning is assessed in class periodically by interacting discussion and problem solving verbal assignment on the topics taught in the previous classes. Mid-term reports Final test Lab and case studies. PROGRAMMA Italiano Aree di apprendimento: Produzioni vegetali. Introduzione al corso, obiettivi, finalità, materiale, risultati attesi. Introduzione: importanza delle tecniche post-raccolta nel settore. Definizione degli standard qualitativi delle produzioni. Importanza delle produzioni sui mercati internazionali. Le tipologie e le categorie di ortaggi da un punto di vista botanico, organografico e commerciale. La gestione post-raccolta degli ortaggi in base all'organografia: problematiche fisiologiche, gestionali e commerciali Aspetti fisiologici della senescenza delle produzioni. Influenza delle tecniche gestionali in pre e post raccolta sulla qualità delle produzioni. Scelta dei tempi e modalità di raccolta. Mantenimento della qualità delle produzioni in postraccolta. Le problematiche post-raccolta degli ortaggi freschi (I gamma). Fisiologia, raccolta e gestione post-raccolta. Pratiche commerciali Le problematiche degli ortaggi freschi (IV gamma). Fisiologia, raccolta e gestione post-raccolta. - 318 - English Scope: Production of products of plant origin. Course introduction, objectives, means, course materials and methods, results expected. Introduction: role of postharvest in produce. Quality parameters. Market National and International facts and figures. Categories and typologies of vegetables. Organography. Botanical and commercial classifications. Postharvest physiology, handling and marketing based on edible organs involved. Senescence aspects. Pre-harvest factors affecting postharvest quality and handling. Harvesting optimal requirements. Quality maintenance and decay after harvest. Fresh produce: harvest and postharvest handling and physiology. Commercial practices Fresh-cut produce: harvest and postharvest handling and physiology. Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento della produzione dei vegetali. English Contents of the course are related to production fresh produce TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Diapositive presentate a lezione come supporto. I testi consigliati di approfondimento per il corso sono: W. J. Florkowski, S. E. Prussia, R. Shewfelt and B. Breuckner (Eds). 2009. Postharvest Handling. A systems Approach.. Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. W. J. Florkowski, R. Shewfelt, B. Breuckner and S. E. Prussia (Eds). 2014. Postharvest handling: a systems approach (Third ed.). Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. ISBN: 978-012-408137-6. pp. 564+xxii (624 pp). Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: Articoli e pubblicazioni forniti durante il corso. Infine sono di seguito indicati siti internet di interesse: - 319 - Siti istituzionali statistici italiani, europei ed internazionali. Portali delle filiere ortofrutticole nazionali di diversi Paesi. English Reading material: Slides presented in class. W. J. Florkowski, S. E. Prussia, R. Shewfelt and B. Breuckner (Eds). 2009. Postharvest Handling. A systems Approach.. Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. W. J. Florkowski, R. Shewfelt, B. Breuckner and S. E. Prussia (Eds). 2014. Postharvest handling: a systems approach (Third ed.). Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. ISBN: 978-012-408137-6. pp. 564+xxii (624 pp). Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. Material suggested in class Official websites to be consulted: Institutional statistical websites of Italy, EU, international, FAO. Portals related to produce at national and international level. NOTA Italiano Pre-requisiti: Chimica generale ed analitica; Chimica organica; Biologia. English Basic knowledge of chemistry and biology is required. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zbs4 - 320 - Costruzioni (Anno Accademico 2015/2016) BUILDING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0340 Docente: Barbara DRUSI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705521, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/10 - costruzioni rurali e territorio agroforestale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Nozioni sulle tecnologie costruttive, tradizionali e recenti, impiegate nel recupero edilizio; sugli aspetti procedurali della progettazione edilizia in attuazione al piano regolatore generale comunale e nel quadro della pianificazione settoriale e del paesaggio; acquisizione di conoscenze in merito al recupero energetico delle costruzioni; sviluppo di capacità critiche ed abilità progettuali finalizzate alla valorizzazione sostenibile delle risorse endogene del territorio agro-forestale attraverso l'analisi di esempi di "buona prassi" e l'esercitazione in aula; acquisizione di conoscenze in ordine alla valutazione ambientale di progetti, piani e programmi. Al termine del corso lo studente deve dimostrare di avere una buona conoscenza dei criteri di base per la progettazione delle varie categorie di edifici rurali, con particolare riferimento alle rispettive esigenze funzionali. Lo studente dovrà essere in grado di ipotizzare un percorso dell'iter progettuale considerando tutti gli elementi in esso coinvolti, sino alla realizzazione di un progetto di massima. English Basic knowledge about traditional or recent constructive techniques for building recovery; building planning procedural aspects in accomplishment to the municipal town-planning instrument and within both sector and landscape town-planning; acquisition of technical knowledge concerning building energetic reprofit; increase of both critical skills and planning abilities aiming at the sustainable enhancement of territory heritage; acquisition of knowledge as regards environmental evaluation procedures of projects, plans and programmes. - 321 - At the end of the course the student is expected to have a good knowledge of basic design criteria for the various classes of rural buildings, paying particular attention to their respective functional requirements. The student will have to be able to outline the phases of the project, taking account of every engaged element, in order to draw up a general project. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione di competenze in ordine ai caratteri tipologici, costruttivi e tecnologici degli edifici, al recupero edilizio ed alla pianificazione del paesaggio agro-forestale, alla valutazione ambientale di progetti, piani e programmi; conseguimento di capacità critiche e di abilità tecniche progettuali in sede di esercitazione per affrontare la progettazione del recupero edilizio ed energetico di un edificio esistente. Vengono fornite le conoscenze di base utili ai fini della progettazione e della realizzazione delle principali categorie di edifici agricoli. Le problematiche progettuali vengono affrontate sotto il profilo del dimensionamento spaziale, della stabilità strutturale e del controllo ambientale. Inoltre vengono passate in rassegna le tecniche costruttive più idonee ai diversi scopi. English Acquisition of competences concerning building typological, constructive and technologic aspects, building recovery and landscape town-planning, environmental evaluation procedures of projects, plans and programmes; achievement of both critical and technical abilities through a planning drill in the aim of coping with any project of energetic recovery of an existing building. The basic knowledge elements required for the design and the construction of the main categories of farm buildings are described. The design aspects involved are the spatial dimensioning, the structural stability and the environmental control. The constructive techniques suitable for each building category are generally outlined. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di lezioni per le quali il docente usa presentazioni che verranno messe a disposizione degli studenti a principio del corso. English The module consists of lectures for which the teacher will use presentations that will be available for students at the beginning of the course. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine della trattazione di ciascun argomento, si procederà alla verifica dell'apprendimento attraverso una discussione tematica in aula. L'esame verterà sulla discussione di una relazione progettuale di un ricovero per animali - oggetto del programma – e dei relativi fabbricati di esercizio. Il colloquio orale, oltre alla discussione della relazione progettuale, prevede la verifica della capacità di collegare le conoscenze acquisite. - 322 - English Once completed each topic, the effective learning assessment will be verified throughout a thematic debate developped within the class. The exam will have as a topic the discussion of the project report of a livestock house – topic of the program – and of the related operating buildings. The exame, in addition to the discussion of the project report, will contemplate the assesment of the ability to connect knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano Le costruzioni nel paesaggio agro-forestale: elementi di ruralistica, tipi edilizi, materiali e tecniche costruttive. Degrado dei materiali, problematiche di recupero edilizio e funzioni di riuso. Tecnologia delle costruzioni ed elementi di impiantistica. Controllo ambientale e del benessere animale nella progettazione degli edifici produttivi per l'allevamento. Il progetto edilizio: impostazione metodologica e fondamenti. Dal piano al progetto: i titoli abilitativi a costruire in attuazione della pianificazione operativa comunale. Casi studio ed esempi di "buona prassi" nel recupero edilizio e nella riqualificazione energetica degli edifici. Politiche di tutela integrata in Italia ed Europa. La pianificazione territoriale paesistica di livello regionale. La pianificazione di settore e delle aree protette: strumenti e contenuti. La pianificazione operativa di livello locale. Il piano regolatore generale comunale riformato ed il regolamento edilizio La valutazione di impatto ambientale dei progetti. La valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Tutti gli argomenti trattati all'interno del corso attengono all'area di apprendimento dell'ingegneria agraria. English Vernacular buildings within agricultural and forestry landscape: fundamentals of ruralistica, typologies, materials and building technologies. Material degradation, building recovery techniques and reuse functions. Building technologies and technical services. Environmental and animal welfare for the design of livestock housing. The building project: methodological approach and fundamentals. From town-planning to executive project: compulsory habilitating procedures in accomplishment to municipal townplanning. - 323 - Integrated safeguard policies inItalyandEurope. Regional landscape town-planning. Sector and protected area town-planning: instruments and contents. Operative municipal town-planning. Local general plan and building regulations. Environmental impact evaluation of projects. Environmental strategic evaluation of plans and programmes. Each topic being developped within the present teaching program dials with the learninbg area of agricultural engineering. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Peano A., Francalacci P. (a cura di), Parchi, piani, progetti. Ricchezza di risorse, integrazione di conoscenze, pluralità di politiche, Torino, Giappichelli, 2002 Mamoli M. (a cura di), Progettare nello spazio alpino. Manuale per la tutela, la conservazione ed il recupero del paesaggio, degli insediamenti e delle architetture tradizionali, Unione Europea e Regione Veneto, Belluno, s. e., 2002 (su CD-rom) Fabbri P. (a cura di), Paesaggio, pianificazione, sostenibilità, Firenze, Alinea, 2003 Mazzino F., Ghersi A. (a cura di), Per un atlante dei paesaggi italiani, Firenze, Alinea, 2003 Regione Piemonte, Criteri ed Indirizzi per la Tutela del Paesaggio, Torino, ed. a cura dell'Assessorato ai Beni Ambientali, 2003 Drusi B., La dimora alpina. Costruzioni rurali nel paesaggio agro-forestale, Roma, Aracne editrice, 2009 Amerio C., Canavesio G., Tecniche ed elementi costruttivi, SEI, Torino, 2006. Butera F., Dalla caverna alla casa ecologica, Milano, Edizioni Ambiente, 2007. Fabrizio E., Filippi M., Le fonti non rinnovabili, Le fonti rinnovabili, L'uso razionale dell'energia, La costruzione energeticamente sostenibile, in Stefanutti L. (a cura di), Manuale degli impianti di climatizzazione", capp. 6-7-8-10, Milano, Tecniche Nuove, 2008. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti ed integrazioni: appunti delle lezioni e dispense in formato .pdf fornite su CD-rom dal docente durante lo svolgimento del corso, comprensive anche di numerosi esempi di pianificazione commentati in aula. English The specialistic bibliography suggested as a support to the learning activity: Peano A., Francalacci P. (a cura di), Parchi, piani, progetti. Ricchezza di risorse, integrazione di conoscenze, pluralità di politiche, Torino, Giappichelli, 2002 Mamoli M. (a cura di), Progettare nello spazio alpino. Manuale per la tutela, la conservazione ed il recupero del paesaggio, degli insediamenti e delle architetture tradizionali, Unione Europea e Regione Veneto, Belluno, s. e., 2002 (su CD-rom) - 324 - Fabbri P. (a cura di), Paesaggio, pianificazione, sostenibilità, Firenze, Alinea, 2003 Mazzino F., Ghersi A. (a cura di), Per un atlante dei paesaggi italiani, Firenze, Alinea, 2003 Regione Piemonte, Criteri ed Indirizzi per la Tutela del Paesaggio, Torino, ed. a cura dell'Assessorato ai Beni Ambientali, 2003 Drusi B., La dimora alpina. Costruzioni rurali nel paesaggio agro-forestale, Roma, Aracne editrice, 2009 Amerio C., Canavesio G., Tecniche ed elementi costruttivi, SEI, Torino, 2006. Butera F., Dalla caverna alla casa ecologica, Milano, Edizioni Ambiente, 2007. Fabrizio E., Filippi M., Le fonti non rinnovabili, Le fonti rinnovabili, L'uso razionale dell'energia, La costruzione energeticamente sostenibile, in Stefanutti L. (a cura di), Manuale degli impianti di climatizzazione", capp. 6-7-8-10, Milano, Tecniche Nuove, 2008. Strongly suggested to deepen some topics are lesson notes and pdf format slides provided upon CD-rom by the teacher while developping the course topics. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zfub - 325 - Costruzioni ed impianti per l'allevamento - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) LIVESTOCK HOUSING AND EQUIPMENTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0355 Docente: Dott. Gianfranco AIROLDI (Affidamento interno) Prof. Angela CALVO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705524, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 1° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/09 - meccanica agraria AGR/10 - costruzioni rurali e territorio agroforestale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Costruzioni per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) Impianti per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b3ai Costruzioni per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) LIVESTOCK HOUSING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0355 Docente: Dott. Gianfranco AIROLDI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705524, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/10 - costruzioni rurali e territorio agroforestale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 326 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Al termine del corso lo studente deve dimostrare di avere una buona conoscenza dei criteri di base per la progettazione delle varie categorie di edifici ad uso zootecnico, con particolare riferimento alle rispettive esigenze funzionali. Lo studente dovrà essere in grado di ipotizzare un percorso progettuale considerando tutti gli elementi in esso coinvolti. English At the end of the course the student is expected to have a good knowledge of basic design criteria for the various classes of livestock buildings, paying particular attention to their respective functional requirements. The student will have to be able to outline the phases of the project, taking account of every engaged element, in order to draw up a general project. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Vengono fornite le conoscenze di base utili ai fini della progettazione di edifici per la zootecnica. Le problematiche progetuali vengono affrontate sotto il profilo del demensionamento spaziale e del controllo ambientale e sotto l'aspetto normativo della pianificazione urbanistica di livello locale. English The basic knowledge elements required for the design and the construction of the main categories of livestock housing systems are described. The design aspects involved are the spatial dimensioning, the structural stability and the environmental control. The constructive techniques suitable for each building category are generally outlined. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di lezioni per le quali il docente usa presentazioni che saranno a disposizione degli studenti all'inizio del corso. English The module consists of lectures for which the teacher use presentations that will be available for students at the beginning of the course. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Alla fine di ogni argomento si procederà alla verifica dell'apprendimento attraverso una discussione tematica. L'esame verterà sulla discussione di una relazione progettuale di un ricovero per animali - oggetto del programma – e dei relativi fabbricati di esercizio. Il colloquio orale, oltre alla discussione della relazione progettuale, prevede la verifica della capacità di collegare le conoscenze acquisite. - 327 - English Completed each topic it will be carried out the learning assessment by a thematic debate. The exam will have as a topic the discussion of the project report of a livestock house – topic of the program – and of the related operating buildings. The exame, in addition to the discussion of the project report, will contemplate the assesment of the ability to connect knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano La progettazione di un centro aziendale zootecnico. Requisiti che influenzano la progettazione: normativa e strumenti urbanistici - PRG (obiettivi e contenuti, zonizzazione, NTA, standard e indici urbanistici). Criteri di progettazione di un edificio zootecnico: aspetti funzionali ed economici, l'iter progettuale, la sicurezza. Le stalle delle più diffuse specie e categorie allevate: stalle per bovini da latte e da carne, stalle per i suini, stalle per avicoli e cunicoli. Aspetti ambientali dell'allevamento e l'importanza del benessere degli animali nella progettazione dei ricoveri zootecnici. Le dispersioni termiche di un edificio. Calcolo del fabbisogno di riscaldamento e di raffrescamento di un edificio. Tecniche di ventilazione e di controllo ambientale; calcolo delle portate di ventilazione e criteri di scelta degli impianti per il controllo ambientale in una stalla. Edifici e strutture per la conservazione fieni, paglie, insilati e granelle. Strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici. Gli argomenti del programma appartengono all'area dell'ingegneria agraria. English Planning of a livestock farmstead. Requirements conditioning planning: urban requirements, regulations and territorial planning; municipal plans (objectives and contents, zoning, technical rules, urban standards and parameters, types of construction licence and their request procedures). Planning criteria of a rural building. Functional and economic consideration, the project, safety aspects. Livestock structures: housing of cattle, dairy and beef, housing of pigs, housing of poultry and rabbit. Environmental and animal welfare aspects in building planning. Fundamentals of heat transfer, animal heat environment, heat and moisture control in buildings. Heating and cooling, ventilation systems in animal buildings. - 328 - Buildings and structures for storage of hay, straw, silage and grains. Livestock wastes storages. Program topics concern agricultural engineering area. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Roberto Chiumenti – Costruzioni Rurali – Edagricole – Edizioni Agricole della Calderini – Bologna. English Roberto Chiumenti – Costruzioni Rurali – Edagricole – Edizioni Agricole della Calderini – Bologna. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rk6r - 329 - Impianti per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) LIVESTOCK EQUIPMENTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0355 Docente: Prof. Angela CALVO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708592, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/09 - meccanica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Il corso non richiede propedeuticità specifiche, ma la conoscenza degli elementi di Fisica I semplifica la comprensione di alcuni concetti / Any prerequisites are required, but the basic knowledge of the first course of Physic advantages the understanding of some arguments. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le conoscenze di base su macchine ed impianti usate negli allevamenti zootecnici, con la descrizione del loro funzionamento e considerando l'evoluzione tecnologica. Verrà anche dedicato tempo al loro utilizzo in sicurezza, conformemente alle norme ed ai decreti legislativi vigenti. English Furnish the fundamental knowledge of breeding machineries and plants, with their operational features and the technical evolution. Time will be also dedicated to their utilization in safety conditions, considering the standards and the current laws. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente al termine del corso dovrà essere in grado di apprezzare le diverse caratteristiche delle macchine e degli impianti usati in un'azienda zootecnica. Inoltre dovrà essere in grado di poter maneggiare le unità di misura e le equazioni che entrano in gioco nella meccanica e di individuare le relazioni per scegliere le attrezzature più consone all'azienda considerata. Lo studente dovrà inoltre effettuare la scelta migliore dal punto di vista tecnico operativo e di sicurezza. English At the end of the course the student will be able to appreciate the different technical characteristics of the machines and plants used in a breeding farm. He will be moreover able to use the measurement units and equations used in - 330 - the agricultural mechanization and to manage the relations among them to choice the more suitable tools for the farm. He will also be able to make the best choice considering both the technical operating characteristics as well as the safety requirements. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consta di 32 ore di lezione frontale e di esercitazione in aula suddivise per macro argomenti (trattrice agricola, macchine per la fienagione, macchine per il sollevamento, macchine per l'alimentazione animale, impianti di mungitura) e di 2 ore per la verifica delle conoscenze acquisite. 6 ore saranno dedicate alla visita di un'azienda zootecnica, di cui verranno calcolati gli indici di meccanizzazione e della quale verranno valutati gli aspetti di sicurezza relativi alle macchine presenti in azienda. English The course consists of 32 hours of lectures and exercises divided by macro arguments (agricultural tractor, hay making machines, loaders, breeding machines, milking plants), 2 hours devoted to the check of the acquired knowledge and 6 hours used to visit machineries and plants of a breeding farm. During the visit, the mechanization indices will be calculated and the safety requirements of the machines will be checked. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine di ciascun macro argomento (trattrice agricola, macchine per la fienagione, macchine per il sollevamento, macchine per l'alimentazione animale, impianti di mungitura) verrà effettuata la verifica dell'apprendimento con una serie di domande a risposta chiusa e con esercizi. Nel caso in cui si verificassero delle lacune, il programma verrà ripreso nelle parti considerate critiche. L'esame finale consta di una prova orale, preliminarmente introdotta con test ed esercizi (del tipo di quelli usati per la verifica dell'apprendimento durante il corso). Lo studente potrà sostenere l'orale qualunque sia l'esito del test iniziale. Il colloquio orale, oltre alla discussione del test iniziale, prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English At the end of each macro argument (agricultural tractor, hay making machines, loaders, breeding machines, milking plants), the learning control will be performed, using tests and exercises. In the case of noticeable gaps, the lessons will be again resumed in their more critical parts. The final exam is an oral proof, preliminary carried out with a test and exercises (as during the course verifications). The oral discussion will follow and will be possible whatever is the test result, with a discussion of the test and with the check of the reasoning skills of the student and of his ability to discuss and join the arguments. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Si farà in modo di dedicare una lezione agli aspetti normativi e legislativi per l'uso di macchine e attrezzature delle aziende zootecniche in sicurezza, in collaborazione con un esperto esterno (da individuarsi all'occorrenza). - 331 - English A lesson will be practised to the standards and the current laws for a safety use of machines and plants of a breeding farm, in collaboration with an external expert (to be identified each time). PROGRAMMA Italiano Area dell'ingegneria agraria LA TRATTRICE AGRICOLA Classificazione delle trattrici Componenti e funzionamento Stabilità trasversale e longitudinale Aderenza Elementi di ergonomia e sicurezza delle trattrici Indici di meccanizzazione MACCHINE E IMPIANTI PER LA FIENAGIONE Falcia-trincia-caricatrici Falciatrici Volta-spandi foraggio Ranghinatori Raccoglimballatrici Elementi di sicurezza delle macchine per la fienagione Essiccatoi per foraggio MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO I caricatori frontali I sollevatori telescopici Aspetti di sicurezza MACCHINE PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE Carri desilatori e carri miscelatori Carri trinciamiscelatori Elementi di sicurezza MACCHINE E IMPIANTI PER LA MUNGITURA Principio di funzionamento della mungitura meccanica - 332 - Macchine e impianti per la mungitura Elementi di sicurezza di macchine e impianti per la mungitura English Agricultural engineering area The agricultural tractor Tractor types and characteristics Elements and functionality Transversal and longitudinal stability Grip Tractor safety implements Mechanization indices Hay-making machines and plants Mowers Hay turners Hay rakings Balers Harvesting machines Self-propelled forage harvester Safety elements of hay making machines Hay driers Loading machines Front loaders Telehandlers Safety aspects Machines for animal feeding Mixing and/or chopping and distributing machines - 333 - Safety principles Milking machines and plants Mechanical milking operational principles Milking plants Milking machines safety devices TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Calvo A., Deboli R. 2007. Meccanica e meccanizzazione agricola. De Agostini - Liviana. Novara. Dispense del corso disponibili sul sito di Campusnet English Calvo A., Deboli R. 2007. Meccanica e meccanizzazione agricola. De Agostini - Liviana. Novara. Course notes available at Campuset site NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eymv - 334 - Costruzioni forestali (Anno Accademico 2015/2016) FOREST BUILDING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0360 Docente: Barbara DRUSI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705521, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/10 - costruzioni rurali e territorio agroforestale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Apprendimento degli aspetti tecnici e tecnologici dell'ingegneria come supporto per la progettazione di strutture per la difesa dai dissesti, per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e le utilizzazioni forestali, per la viabilità forestale, per il riuso e la riqualificazione energetica dei fabbricati rurali. Acquisizione di conoscenze specifiche nell'ambito della progettazione e realizzazione di manufatti con caratteri tipologici, costruttivi e tecnologici specifici per l'inserimento nell'ambiente forestale. English Learning both the technical and technological aspects of engineering as a support for the project of buildings aiming at the defence against slope landslides, the sustainable management of forestry heritage and forest exploitation, forest roads, the reuse and the energy improvement of rural buildings. Acquisition of specific knowledge as regards both the project and the realization of buildings being characterized by specific typology, frame and technologies in the aim of inserting them within forest environment. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Le conoscenze acquisite sviluppano competenze per: a) la costruzione di opere edilizie e la progettazione di opere di protezione o consolidamento dei versanti e dei tratti spondali b) la progettazione di opere ingegneristiche per la salvaguardia dei versanti, il tracciamento, il drenaggio e la manutenzione della viabilità forestale - 335 - c) l'attuazione delle norme procedurali relative alla progettazione edilizia sia in attuazione dei Piani Regolatori Comunali, sia nel quadro della pianificazione delle aree protette, settoriale e paesistica, sia nell'ambito delle procedure di VIA d) la progettazione e la riqualificazione energetica delle costruzioni rurali. English Acquired knowledge develop skills for: a) the construction of buildings and the project of both protection and slope stabilization works b) the project of engineering works designed to slope safeguard and to the tracking, the drainage and the maintenance of forestry roads c) the implementation of procedural rules concerning building project in compliance with both municipal regulation planning and with protected area, sector and landscape planning and within VIA procedures d) the energy project and improvement of vernacular architecture. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore di esercitazione progettuale su temi da concordarsi con gli studenti dopo l'acquisizione delle nozioni tecniche indispensabili. A supporto delle lezioni il docente utilizzerà presentazioni in formato .pdf che verranno messe a disposizione degli studenti su piattaforma moodle al principio del corso. English The teaching consists of 60 hours of lectures and 20 hours of project tutorials concerning thematic proposal to be agreed with the students after their acquiring necessary, technical notions. As a support to the lectures the teacher is going to use pdf presentations being available for the students on a moodle platform since the beginning of the course. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine della trattazione di ciascun argomento si procederà alla verifica dell'apprendimento attraverso un dibattito tematico in aula. Il colloquio orale prevederà la discussione dell'elaborato progettuale sviluppato nel corso dell'esercitazione, nonché due domande intese a verificare le conoscenze tecniche acquisite nei campi della statica delle costruzioni, delle tecnologie e dei materiali costruttivi, della progettazione edilizia e della riqualificazione energetica. English After treating each topic learning level will be verified through a thematic, classroom debate. The oral exam will consist of the discussion of the project being developed during tutorials, as well as two questions aiming at verifying acquired technical knowledge within the topics of structure science, building technologies and - 336 - materials, building project and energy improvement. PROGRAMMA Italiano Le costruzioni nel paesaggio agro-forestale: elementi di ruralistica, tipi edilizi, materiali e tecniche costruttive tradizionali. Sistemi costruttivi tradizionali, evoluti ed industrializzati. Strutture verticali e strutture orizzontali. Criteri progettuali ed esempi di opere-tipo Elementi di statica delle costruzioni. Opere di fondazione e murature contro terra. Criteri progettuali ed esempi di opere-tipo. I materiali da costruzione: caratteristiche tecniche, proprietà e comportamento in opera. I materiali lapidei – i laterizi e i materiali ceramici – il legno – le malte e i leganti – il calcestruzzo – i metalli – il calcestruzzo armato – le materie plastiche – i materiali isolanti. Tecnologia delle costruzioni ed elementi di impiantistica. Principi di termofisica e di efficientamento energetico. Il progetto edilizio: impostazione metodologica, studio di fattibilità e computo metrico-estimativo. Elementi per il tracciamento della viabilità forestale. Problemi progettuali e manutentivi. La pianificazione territoriale e paesistica, settoriale e comunale. Cenni alla valutazione di impatto ambientale dei progetti ed alla valutazione di incidenza in zone soggette a speciale salvaguardia. Esercitazione progettuale. Tutti gli argomenti sviluppati nel corso attengono all'area di apprendimento dell'ingegneria forestale. English Vernacular buildings within agricultural and forestry landscape: fundamentals of ruralistica, typologies, materials and building technologies. Material degrade, building recovery techniques and reuse functions. Building technologies and technical services. Thermal building physic fundamentals. The building project: methodological approach, feasibility study and metrical estimate. From town-planning to executive project: compulsory habilitating procedures in accomplishment to municipal townplanning. The regulatory requirements on the matter of public works: fundamentals. Integrated safeguard policies in Italy and Europe. Regional landscape town-planning. Sector and protected area town-planning: instruments and contents. Environmental incidence evaluation within special safeguard zones. - 337 - Environmental impact evaluation of projects. Environmental strategic evaluation of plans and programmes. Every topic being deepened within the course dials with the learning area of forestry engineering. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Peano A., Francalacci P. (a cura di), Parchi, piani, progetti. Ricchezza di risorse, integrazione di conoscenze, pluralità di politiche, Torino, Giappichelli, 2002 Fabbri P. (a cura di), Paesaggio, pianificazione, sostenibilità, Firenze, Alinea, 2003 Regione Piemonte, Criteri ed Indirizzi per la Tutela del Paesaggio, Torino, ed. a cura dell'Assessorato ai Beni Ambientali, 2003 Drusi B., La dimora alpina. Costruzioni rurali nel paesaggio agro-forestale, Roma, Aracne editrice, 2010 Amerio C., Canavesio G., Tecniche ed elementi costruttivi, SEI, Torino, 2006. Butera F., Dalla caverna alla casa ecologica, Milano, Edizioni Ambiente, 2007. Fabrizio E., Filippi M., Le fonti non rinnovabili, Le fonti rinnovabili, L'uso razionale dell'energia, La costruzione energeticamente sostenibile, in Stefanutti L. (a cura di), Manuale degli impianti di climatizzazione", capp. 6-7-8-10, Milano, Tecniche Nuove, 2008. È fortemente raccomandato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti ed integrazioni: appunti delle lezioni e dispense in formato .pdf messe a disposizione su piattaforma moodle al del principio del corso. English Peano A., Francalacci P. (a cura di), Parchi, piani, progetti. Ricchezza di risorse, integrazione di conoscenze, pluralità di politiche, Torino, Giappichelli, 2002 Fabbri P. (a cura di), Paesaggio, pianificazione, sostenibilità, Firenze, Alinea, 2003 Regione Piemonte, Criteri ed Indirizzi per la Tutela del Paesaggio, Torino, ed. a cura dell'Assessorato ai Beni Ambientali, 2003 Drusi B., La dimora alpina. Costruzioni rurali nel paesaggio agro-forestale, Roma, Aracne editrice, 2010 Amerio C., Canavesio G., Tecniche ed elementi costruttivi, SEI, Torino, 2006. Butera F., Dalla caverna alla casa ecologica, Milano, Edizioni Ambiente, 2007. Fabrizio E., Filippi M., Le fonti non rinnovabili, Le fonti rinnovabili, L'uso razionale dell'energia, La costruzione energeticamente sostenibile, in Stefanutti L. (a cura di), Manuale degli impianti di climatizzazione", capp. 6-7-8-10, Milano, Tecniche Nuove, 2008. The use of the following sources is strongly recommended both for integrating and deepening diverse topics: lecture notes and course handouts being available for the students on a moodle platform since the beginning of the course. NOTA - 338 - Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gpdo - 339 - Costruzioni per l'allevamento (Anno Accademico 2015/2016) LIVESTOCK HOUSING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0355 Docente: Dott. Gianfranco AIROLDI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705524, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/10 - costruzioni rurali e territorio agroforestale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Al termine del corso lo studente deve dimostrare di avere una buona conoscenza dei criteri di base per la progettazione delle varie categorie di edifici ad uso zootecnico, con particolare riferimento alle rispettive esigenze funzionali. Lo studente dovrà essere in grado di ipotizzare un percorso progettuale considerando tutti gli elementi in esso coinvolti. English At the end of the course the student is expected to have a good knowledge of basic design criteria for the various classes of livestock buildings, paying particular attention to their respective functional requirements. The student will have to be able to outline the phases of the project, taking account of every engaged element, in order to draw up a general project. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Vengono fornite le conoscenze di base utili ai fini della progettazione di edifici per la zootecnica. Le problematiche progetuali vengono affrontate sotto il profilo del demensionamento spaziale e del controllo ambientale e sotto l'aspetto normativo della pianificazione urbanistica di livello locale. English The basic knowledge elements required for the design and the construction of the main categories of livestock housing systems are described. The design aspects involved are the spatial dimensioning, the structural stability and the environmental control. The constructive techniques suitable for each building category are generally outlined. - 340 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di lezioni per le quali il docente usa presentazioni che saranno a disposizione degli studenti all'inizio del corso. English The module consists of lectures for which the teacher use presentations that will be available for students at the beginning of the course. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Alla fine di ogni argomento si procederà alla verifica dell'apprendimento attraverso una discussione tematica. L'esame verterà sulla discussione di una relazione progettuale di un ricovero per animali - oggetto del programma – e dei relativi fabbricati di esercizio. Il colloquio orale, oltre alla discussione della relazione progettuale, prevede la verifica della capacità di collegare le conoscenze acquisite. English Completed each topic it will be carried out the learning assessment by a thematic debate. The exam will have as a topic the discussion of the project report of a livestock house – topic of the program – and of the related operating buildings. The exame, in addition to the discussion of the project report, will contemplate the assesment of the ability to connect knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano La progettazione di un centro aziendale zootecnico. Requisiti che influenzano la progettazione: normativa e strumenti urbanistici - PRG (obiettivi e contenuti, zonizzazione, NTA, standard e indici urbanistici). Criteri di progettazione di un edificio zootecnico: aspetti funzionali ed economici, l'iter progettuale, la sicurezza. Le stalle delle più diffuse specie e categorie allevate: stalle per bovini da latte e da carne, stalle per i suini, stalle per avicoli e cunicoli. Aspetti ambientali dell'allevamento e l'importanza del benessere degli animali nella progettazione dei ricoveri zootecnici. Le dispersioni termiche di un edificio. Calcolo del fabbisogno di riscaldamento e di raffrescamento di un edificio. Tecniche di ventilazione e di controllo ambientale; calcolo delle portate di ventilazione e criteri di scelta degli impianti per il controllo ambientale in una stalla. Edifici e strutture per la conservazione fieni, paglie, insilati e granelle. Strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici. - 341 - Gli argomenti del programma appartengono all'area dell'ingegneria agraria. English Planning of a livestock farmstead. Requirements conditioning planning: urban requirements, regulations and territorial planning; municipal plans (objectives and contents, zoning, technical rules, urban standards and parameters, types of construction licence and their request procedures). Planning criteria of a rural building. Functional and economic consideration, the project, safety aspects. Livestock structures: housing of cattle, dairy and beef, housing of pigs, housing of poultry and rabbit. Environmental and animal welfare aspects in building planning. Fundamentals of heat transfer, animal heat environment, heat and moisture control in buildings. Heating and cooling, ventilation systems in animal buildings. Buildings and structures for storage of hay, straw, silage and grains. Livestock wastes storages. Program topics concern agricultural engineering area. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Roberto Chiumenti – Costruzioni Rurali – Edagricole – Edizioni Agricole della Calderini – Bologna. English Roberto Chiumenti – Costruzioni Rurali – Edagricole – Edizioni Agricole della Calderini – Bologna. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rk6r - 342 - Dendrometria (Anno Accademico 2015/2016) DENDROMETRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0328 Docente: Antonio NOSENZO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705539, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/05 - assestamento forestale e selvicoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Finalità: Fornire le conoscenze per la determinazione del volume dei principali assortimenti legnosi e dei principali parametri dendrometrici caratterizzanti i popolamenti forestali. Applicare le metodologie e gli strumenti di base dell'indagine dendrometrica per la descrizione dei soprassuoli forestali. English Knowledge base for determining the volume of the main timber assortments and the main parameters characterizing the forest stands. Acquisition of implementation capacity and technical expertise to properly apply and use the main methods and tools of forest inventory. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenze di base per la determinazione del volume dei principali assortimenti legnosi e dei principali parametri dendrometrici caratterizzanti i popolamenti forestali. Acquisizione della capacità di esecuzione e della competenza tecnica per applicare ed utilizzare correttamente i principali metodi e gli strumenti di indagine dendrometrica. - 343 - English Provide the knowledge to determine the volume of the main timber assortments and the main parameters characterizing the forest stands. Apply the methodologies and tools based survey for description of forest stands. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 48 ore di lezioni frontali e di 12 ore dedicate a esercitazioni in bosco. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slides che sono a disposizione degli studenti English The course consists of 48 hours of lectures and 12 hours devoted to forest exercises. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are avaliable to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esecuzione di esercizi da parte degli studenti sotto la supervisione del docente, sulla parte di programma svolta fino ad allora. Riproposizione di argomenti risultati di difficile comprensione alla maggior parte degli studenti. Modalità di esame: l'esame prevede una prova scritta con esercizi relativi ai principali argomenti trattati nel corso e finalizzati pricipalmente alla determinazione della provvigione legnosa di un popolamneto forestale, e un colloquio orale (a cui si accede solo se la prova scritta è stata valutata positivamente). English Execution of exercises on parts of program already carried out by students, under the control of the lecturer. Repetition of topics non properly understood by the majority of students. Mode of examination: the exam includes a written test with exercises related to the main topics covered in the course and primarily aimed at determining the forest stand, and a interview (which can be accessed only if the written test was assessed positively). PROGRAMMA Italiano Aree della conoscenza: Area Selvicolturale: analisi quantitativa di un popolamento forestale e modalità per misurare i principali parametri utilizzati per descrivere i popolamenti forestali. Area del legno: le nozioni dendrometriche specifiche utili per la valorizzazione tecnologica della materia prima legno; le caratteristiche degli assortimenti legnosi. PROGRAMMA: I fondamenti della dendrometria, Precisione, accuratezza, errori di misura. Misura del fusto e funzioni di rastremazione, Volume degli assortimenti legnosi, La stima della qualità degli assortimenti su piante in piedi. Misurazione del diametro e delle superfici circolari, casi particolari. La misura dell'altezza: metodi diretti, trigonometrici, geometrici. Altezza dominante, Statura, feracità stazionale. I rilievi dendrometrici su interi soprassuoli. L'area basimetrica. La curva ipsometrica e le curve di frequenza. Caratteri generali degli Inventari forestali. Il campionamento statistico. Strategie di ottimizzazione del campionamento. Le unità campionarie. La teoria - 344 - relascopica. Il campionamento relascopico. Le tavole di cubatura. La stima della provvigione mediante le tavole di cubatura. Le funzioni stereometriche. I caratteri generali per la costruzione delle tavole di cubatura. Le leggi dell'auxonomia. Gli incrementi di volume. Il rilievo auxometrico. English Knowledge areas: Silvicultural area: quantitative analysis of a forest stand and how to measure the main parameters used to describe the forest stands. Wood area: dendrometric specific notions useful for the enhancement of technological raw material wood; the characterists of wood assortments. PROGRAM Why measure forest, Accuracy, bias and precision: Stem wood measurement, Sectional. Volume formulae, Timber assortments volume, Merchantable volume. Estimated timber assortments of standing trees. Stem diameter measurement. Tree height measurement: by direct methods, by trigonometric methods, geometric methods. Dominant height, site productive capacity. Stand measurements. Stand basal area. Hipsometric and distribution functions. Forest inventory characters. Sampling theory and techniques. Sampling with varying probabilità of selection, stratified random sampling. Sample plots. Angle-count sampling theory. Application of angle-count sampling. Volume tables. Total volume estimated from diameter and height. Volume functions. Volume tables costruction. Forest growth modelling. Current and mean annual increments. Growth sampling. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano LA MARCA O. - 1999 - Elementi di Dendrometria. Patron Editore, Bologna, pp. 512. Il materiale didattico fornito dal docente sarà caricato nella pagina del corso sul sito del dipartimento. English HUSH B., MILLER C.I., BEERS T.W. - 1982 – Forest Mensuration. John Wiley & sons,New York, pp. 401. Teaching materials provided by the teacher will be loaded on the couse page on the website of the department NOTA Italiano Esercitazioni in bosco con soggiorno nella sede estiva di Ormea (CN) English Exercises in forest with living in the summer seat of Ormea (CN) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1rou - 345 - Destino ambientale degli agrofarmaci (Anno Accademico 2015/2016) ENVIRONMENTAL FATE OF PESTICIDES Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0376 Docente: Prof. Michele NEGRE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708508, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/13 - chimica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze sul comportamento ed il destino degli agrofarmaci nell'ambiente in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche delle molecole e delle condizioni pedoclimatiche in cui si opera. English The objectives of the course is to provide basic knowledge concerning the behaviour and fate of pesticides in the environment related to the physical chemical properties of the molecule and to the pedoclimatic conditions. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Le conoscenze acquisite consentiranno di effettuare scelte operative adeguate per la salvaguardia dell'integrità ambientale English The acquired knowledge will help to make operational decisions suitable for the preservation of environmental integrity. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 346 - Italiano Il corso consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a attività di laboratorio ed esercitazione in aula. Il docente si avvale di presentazioni di power point messe a disposizione degli studenti English The course includes 30 hours of lectures and 10 hours of laboratory and data elaboration practice . The course will be illustarted by power point presentations made available to the student MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Interrogazione periodica sui principali argomenti Prova d'esame orale English periodic oral examination on the main topics Final oral examination ATTIVITÀ DI SUPPORTO esercitazione di laboratorio:tecniche di determinazione di agrofarmaci in suolo, acqua e vegetali. Seminari PROGRAMMA Italiano Classificazione degli agrofarmaci Diffusione degli agrofarmaci nell'ambiente Il processo di revisione (Direttiva Europea 91/414 CE) Interazione degli agrofarmaci con le superfici del suolo Degradazione chimica e biologica degli agrofarmaci Trasporto degli agrofarmaci in fase liquida e gassosa Interazione degli agrofarmaci con le piante Valutazione della tossicità egli agrofarmaci per l'uomo e per l'ambiente Aspetti analitici del controllo dei residui degli agrofarmaci English Classification of pesticides - 347 - Pesticides environmental pollution The revision process (European directive 91/414 CE)… Interaction of pesticides with soil surfaces Chemical and biological degradation of pesticides Transport of pesticides in liquid and gaseous phase Plant pesticides interactions Evaluation of the human and environmental toxicity of pesticides Analytical aspects of control of the pesticides residues TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano M. Gennari e M. Trevisan. Agrofarmaci, conoscenze per un uso sostenibile Perdisa Ed. English M. Gennari e M. Trevisan. Agrofarmaci, conoscenze per un uso sostenibile Perdisa Ed. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4q3o - 348 - Difesa biologica e integrata (Anno Accademico 2015/2016) BIOLOGICAL AND INTEGRATED DISEASE MANAGEMENT Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0247 Docente: Dott. Massimo PUGLIESE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708545, [email protected] Corso di studio: [f001-c501/102] LM - Scienze agrarie curr. Gestione sostenibile Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Obiettivo principale è quello di valutare i problemi fitosanitari delle diverse colture in pieno campo o in ambiente protetto e proporre tecniche di lotta per la loro gestione. Il corso affronta aspetti relativi alla difesa delle colture ed è costituito da due parti: la prima ha come obiettivo quello di illustrare le più comuni malattie delle piante, fornendo allo studente indicazioni sulla epidemiologia e sulle tecniche di lotta impiegabili; la seconda ha lo scopo di illustrare praticamente alcune strategie di difesa e i mezzi di lotta disponibili con ampi riferimenti ai diversi sistemi colturali. English Primary objective is to evaluate the phytosanitary aspects of different crops, both in open field and under protection, and to select crop protection strategies for disease control. The course addresses issues related to crop protection and consists of two parts. The first aims to illustrate the most common plant diseases, providing students with information on epidemiology and control strategies. The second aims to practically illustrate some control strategies and means available, with references to the different cropping systems. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente acquisirà competenze e conoscenze riguardanti i problemi fitopatologici delle piante, le strategie di contenimento delle malattie e sulla conduzione di attività di ricerca e sperimentazione in fitopatologia. Area di apprendimento: Area della difesa. - 349 - English Students will acquire skills and knowledge relating to plant diseases, control of plant pathogens and on research in phytopathology. Teaching area: Area of crop protection. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate ad attività di laboratorio ed esercitazioni. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and experimental training activities. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il programma il docente procederà a verificare l'efficacia didattica, mediante test orali, senza valore per la valutazione finale ma utili allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale viene fatto attraverso domande orali agli studenti su quanto spiegato a lezione e durante le esercitazioni. Inoltre viene richiesto un elaborato scritto su un piano di difesa a scelta dello studente e che ha valore per la valutazione finale. English During the program, the teacher will proceed to a verification of the efficacy teaching by administration of oral tests, not valid for the final evaluation, but helpful to the student to estimate its degree learning. The final exam is done through oral questions to the students on what has been explained in class and through the trainings. A written report about a plant disease management plan is also required and valid for the final evaluation. PROGRAMMA Italiano Il corso fa parte dell'area della conoscenza della DIFESA e prevede di acquisire preliminarmente informazioni sugli agenti patogeni per poi meglio soffermarsi sulle strategie di difesa biologica e integrata. Parte generale. Vengono approfondite le conoscenze su: - Importanza delle coltivazioni ortofrutticole e ornamentali. Caratteristiche delle colture ortofrutticole e ornamentali e loro incidenza nella gravità delle malattie. Sintomatologia. - Malattie batteriche: sintomatologia, diagnosi, epidemiologia e metodi di lotta (cenni). Le principali malattie batteriche di colture ortofrutticole e ornamentali. - Malattie fungine causate da oomiceti: sintomatologia, diagnosi, epidemiologia e metodi di lotta (cenni). Le - 350 - alterazioni fogliari (Peronospora spp.) e radicali (Pythium sp., Phytophthora sp,) di colture ortofrutticole, ornamentali, da fiore reciso e vaso fiorito. - Malattie fungine causate da funghi appartenenti al gruppo degli ascomiceti: sintomatologia, diagnosi, epidemiologia e metodi di lotta (cenni). Le alterazioni fogliari (I mal bianchi, gli agenti di antracnosi, …) e radicali (le tracheomicosi, gli agenti di marciumi basali, …) di colture ortofrutticole, ornamentali, da fiore reciso e vaso fiorito. - Malattie fungine causate da funghi appartenenti al gruppo degli basidiomiceti: diagnosi, epidemiologia e metodi di lotta. - Malattie da virus: Generalità su virus, viroidi e fitoplasmi e descrizione delle alterazioni da essi causate su colture ortofrutticole e ornamentali. - Alterazioni non parassitarie Parte speciale Vengono approfondite le conoscenze su: - Difesa delle colture nei paesi industrializzati (prospettive, aspetti critici, ruolo delle politiche agrarie, … ) e in quelli in via di sviluppo (disponibilità di mezzi tecnici). - Modelli previsionali. Simulazione di epidemie e sistemi di avvertimento. - Lotta: misure agronomiche, preventive, mezzi fisici. Evoluzione del concetto di difesa delle colture. Importanza e ruolo della difesa delle colture con particolare riferimento ai sistemi colturali intensivi (pieno campo, serra, …). Strategie di difesa: esclusione, profilassi, eradicazione. - Pratiche colturali, esempi in coltura protetta e in pieno campo. - Difesa fisica. Termoterapia, disinfezione con vapore e mediante radiazioni. Solarizzazione. Atmosfera controllata. Esempi di applicazione in orticoltura. - Difesa genetica. Impiego di cultivar resistenti, ibridi resistenti di prima generazione, varietà composte, portainnesti resistenti. Possibilità e limiti. Sistemi per la valutazione della resistenza, sensibilità, specializzazione biologica. Esempi di applicazione in orticoltura e frutticoltura. - Lotta chimica e integrata. Mezzi chimici. Criteri seguiti nella sintesi e ricerca di nuove molecole. Fungicidi e fumiganti. Formulazione dei fungicidi. Spettro di azione dei principali gruppi di fungicidi. Modalità di azione. Fungicidi sistemici: caratteristiche e criteri di impiego. Struttura chimica dei principali gruppi di fungicidi. Effetti collaterali negativi: fitotossicità, e resistenza. Strategie anti-resistenza. Esempi di gestione del fenomeno della resistenza ai fungicidi. Manipolazione e classificazione delle formulazioni. Impostazione di una prova di lotta chimica. Resistenza ai fungicidi. Tecniche di monitoraggio della resistenza. Cenni di legislazione relativi alla registrazione ed estensione di etichetta. - Lotta biologica. Mezzi biologici e naturali. Microrganismi attivi contro funghi fitopatogeni: sviluppo e possibilità di impiego. Produzione, formulazione e impiego di mezzi biologici. Prodotti naturali. Agricoltura biologica. Criteri di difesa, prodotti disponibili, normative di riferimento. Mezzi biologici e concia delle sementi. Manipolazione e classificazione delle formulazioni. - Impostazione ed esecuzione di una prova di lotta biologica. - Terreni e substrati repressivi. - Malattie delle colture orticole e ornamentali in contenitore e delle colture fuori suolo (indicazioni di difesa). - Casi di studio. Fuori suolo (filtrazione su sabbia come sistema integrato biologico, fisico e agronomico); colture in ambiente protetto (gestione climatica, difesa chimica e difesa biologica); colture orticole (uso dell'innesto e - 351 - necessità di combinazione a strategie di difesa chimica); colture minori. - Evoluzione della difesa delle piante nel contesto dei cambiamenti climatici. - Cenni di legislazione e quarantena. Introduzione inaspettata di nuovi patogeni: esempi pratici e strategie di soluzione. Specie aliene invasive. - Difesa di piante ornamentali e dei tappeti erbosi (parte generale: spiegazione delle principali specie da tappeto erboso. Parte speciale: descrizione delle principali malattie fungine, con indicazioni riguardanti la difesa soprattutto agronomica, e poi chimica). English The course forms part of the field of knowledge of CROP PROTECTION and provides information on plant pathogens and more details on biological and integrated control of plant diseases. General Part Importance of vegetable and ornamental crops. Characteristics of vegetable and ornamental crops in relation to their effect on disease incidence. Symptomatology. Bacterial diseases: symptoms, diagnosis, epidemiology and control. The major bacterial diseases of vegetable and ornamental crops. Fungal diseases caused by oomycetes: symptoms, diagnosis, epidemiology and control. Leaf (Peronospora spp.) and root (Pythium sp. Phytophthora sp) diseases of vegetable crops, ornamentals, cut and potted flowers. Fungal diseases caused by fungi belonging to the group of Ascomycota: symptoms, diagnosis, epidemiology and control. Leaf (powdery mildew...) and root (wilt, basal and stem rot...) diseases of vegetable crops, ornamentals, cut and potted flowers. Fungal diseases caused by fungi belonging to the group of Basidiomycota: diagnosis, epidemiology and control. Virus diseases: general characteristics about viruses, viroids and phytoplasmas and description of alterations caused by them on vegetable and ornamental crops. Non-parasitic diseases. Special part Crop protection in industrialized countries (perspective, critical issues, the role of agricultural policies, ...) and in developing countries (availability of technical means…). Forecasting models. Simulation of epidemics and warning systems. Control: agronomic practices, preventive, physical means. Evolution of the concept of crop protection. Importance and role of crop protection with particular reference to intensive cropping systems (full field, greenhouse, ...). Control strategies: exclusion, prevention, eradication. Cultural practices, examples for protected crops and in open field. Physical control methods. Thermotherapy, steam and radiations. Solarisation. Controlled atmosphere. Examples of application in vegetable crops. - 352 - Genetic control. Use of resistant cultivars, first-generation hybrids, resistant rootstocks. Possibilities and limitations. Systems for assessing resistance, sensitivity and biological specialization. Examples of application in horticulture. Chemical and integrated control. Chemical products. Criteria used in the synthesis and research of new molecules. Fungicides and fumigants. Formulation of fungicides. Mode of action of the main groups of fungicides. Systemic fungicides: characteristics and criteria for use. Chemical structure of the main groups of fungicides. Negative effects: phytotoxicity and resistance. Anti-resistance strategies. Examples of management of resistance to fungicides. Handling and classification of formulations. Set up of a chemical control trial. Resistance to fungicides. Monitoring techniques of resistance. Legislation about registration and extension of the label. Biological control. Natural and biological products. Antagonists against fungal pathogens: development and opportunities. Production, formulation and use of biological means. Natural products. Organic farming. Criteria for control, products available, legislation. Biological products and seed coating. Handling and classification of formulations. Diseases of vegetable and ornamental crops, under protected environment and soil-less cultivation. Set up and management of a biological control trial. Suppressive soils and substrates. Case Studies. Soil-less crops (slow sand filtration as a biological, physical and agronomical integrated system); protected crops (environmental management, chemical and biological control); vegetable crops (use of grafting and integration with chemical strategies); minor crops. Evolution of the crop protection in the context of climate changes. Legislation and quarantine. Introduction of new pathogens: examples and control strategies. Invasive alien species. Diseases of ornamentals and turfgrass (general part: explanation of the main turf species. Special part: description of the major fungal diseases, including information related to their control, especially agronomical and chemical). Teaching area: Area of crop protection. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Agrios G.N., (1997), Plant Pathology, 4th Edition, Academic Press, 635 pagine. Albajes R., Gullino M.L., Van Lenteren J., Elad Y. (1999) Integrated Pest and Disease Management in Greenhouse Crops. Kluwer Academic Publishers, 568 pagine. Garibaldi A., Gullino M.L., Lisa V. (1999) Malattie delle piante ornamentali. Edagricole, Bologna, 574 pagine. Gullino M. L. (2010) Plant Pathology in the 21st Century: Contributions to the 9th International Congress. Springer Verlag, 1150 pagine. Gullino M.L., Mocioni M., Zanin G., Alma A. (2000) La difesa dei tappeti erbosi. Edizioni L'Informatore agrario, Verona, 192 pagine. Matta A. (1996) Fondamenti di patologia vegetale. Patròn Editore, XVI-496 pagine. ISBN: 8855523848 English Agrios G.N., (1997), Plant Pathology, 4th Edition, Academic Press, 635 pagine. - 353 - Albajes R., Gullino M.L., Van Lenteren J., Elad Y. (1999) Integrated Pest and Disease Management in Greenhouse Crops. Kluwer Academic Publishers, 568 pagine. Garibaldi A., Gullino M.L., Lisa V. (1999) Malattie delle piante ornamentali. Edagricole, Bologna, 574 pagine. Gullino M. L. (2010) Plant Pathology in the 21st Century: Contributions to the 9th International Congress. Springer Verlag, 1150 pagine. Gullino M.L., Mocioni M., Zanin G., Alma A. (2000) La difesa dei tappeti erbosi. Edizioni L'Informatore agrario, Verona, 192 pagine. Matta A. (1996) Fondamenti di patologia vegetale. Patròn Editore, XVI-496 pagine. ISBN: 8855523848 Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=804j - 354 - Difesa del suolo - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) SOIL CONSERVATION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0368 Docente: Prof. Michele FREPPAZ (Affidamento interno) Ing. Enrico Corrado BORGOGNO MONDINO (Affidamento interno) Contatti docente: 011 6708514, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/14 - pedologia ICAR/06 - topografia e cartografia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Prevenzione dell'erosione del suolo, delle frane e delle valanghe (Anno Accademico 2015/2016) Telerilevamento e fotointerpretazione (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xxlp Prevenzione dell'erosione del suolo, delle frane e delle valanghe (Anno Accademico 2015/2016) PREVENTION OF SOIL EROSION, LANDSLIDES AND SNOW AVALANCHES Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0368 Docente: Prof. Michele FREPPAZ (Affidamento interno) Contatti docente: 011 6708514, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/14 - pedologia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 355 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Conoscenza delle caratteristiche e delle modalità d'innesco dei fenomeni erosivi e delle frane superficiali. Presentazione delle corrette strategie di gestione del suolo per ridurne la vulnerabilità ai fenomeni erosivi. Comprensione dei fattori predisponenti il distacco delle valanghe e delle tecniche utilizzabili per ridurre l'esposizione a tale pericolo naturale (es. Carta di localizzazione probabile delle valanghe, tecniche di distacco artificiale). English Knowledge of the triggering mechanisms of shallow landslides and soil erosion processes. Introduction to the best soil management practices for the reduction of the erosion risk. Analysis of the triggering mechanisms of snow avalanches and introduction to the techniques to mitigate snow avalanche hazard (e.g. snow avalanche hazard mapping, artificial triggering of avalanches). RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Alla fine del modulo gli studenti avranno acquisito piena comprensione dei meccanismi alla base dell'innesco dei fenomeni erosivi, dei movimenti superficiali del suolo e delle valanghe. Inoltre avranno appreso le principali tecniche di prevenzione e mitigazione di tali fenomeni. English This module provides an introduction to the triggering mechanisms of soil erosion, shallow landslides and snow avalanches. Moreover the course will introduce the students to the techniques for prevention and mitigation of such natural hazards. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di 32 ore di lezione frontale in aula ed 8 ore di esercitazioni in campo. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni multimediali che sono a disposizione degli studenti English The module consists of 32 houres of lectures and 8 hours devoted to field work. For lectures the teacher makes use of presentations which are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Quiz anonimo a risposta multipla dopo 20 ore di lezione, senza valore per la valutazione finale, ma utile allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale consiste in un colloquio orale, volto alla verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite in questo modulo e nel modulo di Telerilevamento e Fotointerpretazione. Il superamento dell'esame avviene soltanto se si raggiunge la sufficienza in entrambi i moduli. - 356 - English Anonymous multiple choice quiz after 20 hours of lectures, not valid for the final evaluation, but helpful to the student in order to estimate the degree of learning. The final exam is an oral exam. It involves the verification of the ability to acquire, elaborate and express knowledge both in this module and in the integrated module Optical remote sensing and Image interpretation. In order to pass the examination the students have to get the pass mark in both modules. PROGRAMMA Italiano Il modulo fa parte delle aree della conoscenza della Difesa del suolo e della prevenzione dei rischi naturali e dell'Ingegneria forestale Classificazione delle frane Valutazione dei fattori predisponenti il distacco di frane superficiali Metodi per la valutazione della vulnerabilità del suolo all'erosione Classificazione delle valanghe Il Bollettino Valanghe Tecniche di riduzione dell'esposizione al pericolo valanghe English The module is part of the learning areas Soil conservation and natural hazards prevention and Forest engineering Landslides classification Triggering mechanisms of shallow landslides Soil properties influencing erodibility Snow avalanche classification Snow and avalanche bullettin Techniques for the snow avalanche hazard mitigation TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano McClung D., Schaerer P. Manuale delle Valanghe, Ed. Zanichelli Morgan R.P.C. Soil Erosion and Conservation, Ed. Wiley-Blackwell English McClung D., Schaerer P. Manuale delle Valanghe, Ed. Zanichelli Morgan R.P.C. Soil Erosion and Conservation, Ed. Wiley-Blackwell NOTA - 357 - Italiano Il materiale didattico sarà caricato sulla piattaforma CampusNet nel corso dello svolgimento del modulo. English The didactic material will be uploaded in CampusNet during the development of the module. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=roeh - 358 - Telerilevamento e fotointerpretazione (Anno Accademico 2015/2016) OPTICAL REMOTE SENSING AND IMAGE INTERPRETATION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0368 Docente: Ing. Enrico Corrado BORGOGNO MONDINO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705523, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: ICAR/06 - topografia e cartografia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Italiano Benchè nessuna propedeuticità sia prevista in modo formale, è auspicabile comunque che lo studente affronti il modulo dotandosi dei fondamenti irrinunciabili di Analisi Matematica (studio di funzione, derivate totali e parziali, integrali), di Fisica (elettromagnetismo e ottica), di Statistica (trattamento delle osservazioni), di Topografia/Cartografia e GIS. English No requirement is strictly due for this module but, it is warmly suggested to face it having basics of Mathematics, Physics, Statistics, GIS and Survey OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Formazione di base nell'ambito del telerilevamento ottico multispettrale finalizzato alla produzione di carte tematiche di copertura e uso del suolo e all'utilizzo di indici spettrali da utilizzarsi come indicatori ambientali. In particolare l'attenzione verrà posta sui dati satellitari gratuiti a media risoluzione spaziale utili per indagini alla scala territoriale e di paesaggio. English Fundamentals of mulstispectral optical remote sensing aimed at the generation of land use/land cover maps and at the exploitation of spectral indices related to environmental indicators. The focus is on the free available image datasets having a middle geometric resolution, useful for investigations at the territorial and landscape scale. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Alla fine del modulo lo studente sarà in grado di interpretare un'immagine satellitare multi-spettrale e di comprenderne le fasi si processamento che la trasformano da dato grezzo in prodotto cartografico tematico. Le competenze consegnate allo studente riguardano: a) capacità di selezionare la tipologia di dato satellitare utile ai fini di una specifica applicazione sula base delle sue caratteristiche geometriche, spettrali, radiometriche e temporali; - 359 - b) capacità di leggere con competenza tutti i dati di accuratezza (metrica e semantica) che riguardano una carta tematica derivata da satellite; c) capacità di interpretare i principali indici spettrali derivabili da dati telerilevati; d) capacità di generare carte tematiche e valutarne la qualità attraverso l'adozione di classificatori assistiti e automatici. English At the end of the module students will be skilled in multispectral satellite image interpretation and processing aimed at thematic map generation. Acquired skills will be the able to: a) select the most suitable satellite data to face a specific application on the basis of its spectral, radiometric, geometric and temporal features; b) evaluate and define the accuracy (position and content) of generated results; c) generate and interpret spectral indices useful to map landscape properties; d) generate thematic maps by supervised and unsupervised approaches. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo si sviluppa per l'intera durata attraverso l'erogazione di lezioni frontali (36 ore), nel corso delle quali il docente procede anche all'esemplificazione pratica (esercitaioni, 4 ore) dei concetti espressi ed in particolare al processamento dei dati. In questa fase gli studenti vengono addestrati all'utilizzo di software freeware (SAGA GIS e QGIS) per l'esecuzione dell'intero flusso di lavoro che permette di estrarre informazioni territoriali dai dati satellitari utilizzati come esempio. Sulla base delle competenze acquisite gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, procedono, al di fuori dell'orario di lezione, al processamento di dati campione e redigono un report tecnico che illustra una applicazione territoriale attinente la difesa del suolo e concordata con il docente del modulo di "Prevenzione dell'erosione del suolo, delle frane e delle valanghe ", in cui il telerilevamento costituisca la metodologia di indagine. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni multimediali che sono a disposizione degli studenti tramite piattaforma CAMPUSNET. English The module is made of frontal lessons (36 hours) where theoretical aspects are coupled with practical examples (exercises, 4 hours) concerning operational processing of satellite data. Students are trained on the basic use of free processing software (SAGA GIS and QGIS) useful for the extraction of territorial information from satellite data. Once trained, students operate in working groups to face a practical application dealing with soil preservationdecided together with the teacher of the module of "PREVENTION OF SOIL EROSION, LANDSLIDES AND SNOW AVALANCHES". They will be required to producie a technical report describing the operational workflow and professional considerations about obtained results. Students will be provided with slides and data that the teacher uses during lessons through the CAMPUSNET system. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'efficacia delle lezioni viene verificata procedendo, all'inizio di ciascuna lezione (10 minuti) , ad un limitato dibattito riguardante i contenuti della lezione precedente, nel corso del quale gli studenti sono invitati a rispondere a domande e sollecitati a proporne. Tale azione non contribuisce alla valutazione finale, ma costituisce un utile strumento per lo studente di autovalutare il proprio grado di apprendimento. L'appello d'esame è subordinato alla redazione di un report tecnico scritto, realizzato per gruppi, relativo ad un caso studio attinente i contenuti del corso e sviluppato con l'utilizzo di dati telerilevati forniti dal docente e con software di settore ottenibili gratuitamente dagli studenti. IL docente, a cui il documento verrà consegnato almeno 3 giorni prima dell'appello, procede alla sua valutazione che contribuirà per un terzo a quella finale del modulo. Il - 360 - report costituisce anche il punto di partenza del colloquio orale che intende verificare le competenze scientifiche e le basi teoriche acquisite. L'esame sarà condotto congiuntamente con il docente del modulo di "Prevenzione dell'erosione del suolo, delle frane e delle valanghe" per verificare come le nozioni trasmesse siano state recepite e trasefrite nell'ambito specifico di intervento territoriale (erosione suolo, frane e valanghe). Il superamento dell'esame avviene soltanto se si raggiunge la sufficienza in entrambi i moduli. Il punteggio finale risulta dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti sui due moduli. English Effectiveness of lessons is verified by discussing with the students at the beginning of a new lesson (10 minutes), the content of the last preceding one. In this context students are invited to answer some technical questions and proposing their own ones. Final exam can be given only if a technical report, composed by a group of students, concerning a case study based on the use of remotely sensed data. The report has to be sent to professor at least 3 days before exam date. Professor evaluate it; its wieght on final score is one third of the total. During exam the report is the starting point from which theoretical and sccientific questions will start. Oral exam will be done together with the teacher of the module of "PREVENTION OF SOIL EROSION, LANDSLIDES AND SNOW AVALANCHES", to check how information concerning remote sensing is applied to the practical application of soil erosion, landslides and snow avalanches. Exam is passed only if the score is positive for both evaluated modules. Final score is the mathematical mean. PROGRAMMA Italiano Il corso fa parte delle aree della conoscenza dell'INGEGNERIA FORESTALE, della GESTIONE MULTIFUNZIONALE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI e della DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAI RISCHI NATURALI Introduzione al Telerilevamento: definizioni e leggi fisiche fondamentali ,(Ingegneria forestale). Interazione tra energia elettromagnetica e superfici: riflettanza, trasmittanza, assorbanza, emittanza. Rugosità delle superfici e geometria dell'illuminazione, (Ingegneria forestale). Firme spettrali; interazione tra atmosfera e radiazione elettromagnetica: finestre atmosferiche e diffusione (Ingegneria forestale) Tipologie di satelliti per l'Osservazione della Terra: geostazionari ed elio-sincroni; Principali missioni. Schema di sensore; L'immagine digitale: definizione numerica e caratteristiche operative (risoluzioni), (Ingegneria forestale). Processamento dell'immagine: istogramma di frequenza, contrasto, scatterogrammi, filtri digitali e operatori matriciali: indici spettrali (Ingegneria forestale). &nb sp; Le immagini a colori: cenni di colorimetria e foto interpretazione; il flusso di lavoro di un telerilevatore, (Ingegneria forestale). &nb sp; ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; Pre-processamento radiometrico delle immagini: calibrazione in radianza e riflettanza, correzione atmosferica, correzione topografica, (Ingegneria forestale) La georeferenziazione delle immagini, (Ingegneria forestale). La classificazione delle immagini: assistita e automatica; principali algoritmi (Gestione multifunzionale sostenibile delle risorse forestali) Verifica dell'accuratezza della classificazione: matrice d'errore e parametri di prestazione (Gestione multifunzionale sostenibile delle risorse forestali) English Introduction to Remote Sensing: definitions and main physical laws - 361 - Interaction between surfaces and electromagnetic radiation: reflectance, transmittance, absorbance, emittance. Surface roughness and geometry of lighting. ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; &nb sp; Surface Spectra; interaction between atmosphere and electromagnetic radiation: atmospheric windows and scattering Satellites for Earth Observation: geostationary and sun-synchronous. Main missions, Sensor scheme, digital image: numerical definition and operational features (resolutions). &n bsp; &nbs p; Image processing: histogram, contrast enhancement, scatter plots, digital filters, matrix operators: spectral indices from satellite imagery. &n bsp; &nbs p; &n bsp; &nbs p; &n bsp; Color images: basics of colorimetry and image interpretation; the remote sensing workflow Radiometric pre-processing: radiance/reflectance calibration, atmospheric correction, topographic correction. Image georeferencing &n bsp; &nbs p; &n bsp; &nbs p; &n bsp; Image classification: supervised and unsupervised classifiers Classification Accuracy: confusion matrix and statistical parameters TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano [1] Principi e Metodi di Telerilevamento (Brivio, Lechi, Zilioli, 2006), Città Studi Edizioni [2] Telerilevamento: Informazione Territoriale mediante immagini da satellite, A. Dermanis, L.Biagi, Casa Editrice Ambrosiana [3] Elementi di Geomatica, M.A. Gomarasca, Ed. AIT, 2004. English [1] Principi e Metodi di Telerilevamento (Brivio, Lechi, Zilioli, 2006), Città Studi Edizioni [2] Telerilevamento: Informazione Territoriale mediante immagini da satellite, A. Dermanis, L.Biagi, Casa Editrice Ambrosiana [3] Elementi di Geomatica, M.A. Gomarasca, Ed. AIT, 2004. NOTA Italiano Il materiale didattico sarà caricato sulla piattaforma CampusNet nel corso dello svolgimento del modulo. English Didactic material will be available for students through the CampusNet distribution system Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zrnx - 362 - Difesa della vite - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) VINE PROTECTION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0608 Docente: Prof. Alberto ALMA (Affidamento interno) Prof. Piero Attilio BIANCO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708534, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 10 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Approfondimenti di entomologia (Anno Accademico 2015/2016) Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ue51 Approfondimenti di entomologia (Anno Accademico 2015/2016) ADVANCED GRAPEVINE ENTOMOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0608 Docente: Prof. Alberto ALMA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708534, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 363 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscenze di morfologia e di bio-etologia concernenti gli insetti (indigeni ed esotici) dannosi alla vite. Competenze sulle strategie di difesa e sui metodi alternativi all'uso dei prodotti chimici, quali lotta preventiva basata su principi ecologici, lotta naturale con ruolo di siepi e incolti, lotta biologica e lotta integrata, controllo simbiotico. English The aim is to provide knowledge of morphology and bio-ethology concerning insects (indigenous and exotic) damaging grapevine. Expertise on defense strategies and alternative methods to the use of chemicals, such as preventive control based on ecological principles, natural control with the role of hedges and uncultivated lands, biological control and integrated pest management, symbiotic control. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti dovranno essere in grado, attraverso le competenze fornite dal corso, di riconoscere le più importanti specie d'insetti, indigeni ed esotici di temuta introduzione, che causano danno diretto e trasmetto agenti eziologici di malattie d'interesse economico alla vite. Essere in grado di valutare l'influenza dell'ambiente sull'epidemiologia e impostare adeguate strategie di difesa, con particolare riguardo alle tecniche a basso impatto ambientale. English The students should be able, through the skills provided by the course, to recognize the most important species of insects, indigenous and exotic, with a high risk of introduction, which cause direct damage and transmit etiologic agents of diseases of economic interest to grapevine. They should be able to evaluate the influence of the environment on the epidemiology, and set up appropriate defense strategies, with particular emphasis on techniques with a low environmental impact. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 24ore di lezione frontale e 16 ore dedicate ad attività di laboratorio e in vigneto. A fine corso sarà effettuata una uscita didattica in aziende viticole piemontesi. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni PowerPoint che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 24 hours of lectures and 16 hours devoted to laboratory and vineyard activities. At the end of the course, there will be an educational trip to wine-producing farms of Piedmont. For the lectures, the teacher makes use of PowerPoint presentations that are available to the students and articles for critical readings. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine dellelezioni frontali il docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica attraverso domande orali sui principali argomenti svolti, al fine di evidenziare gli eventuali problemi di apprendimento. Il colloquio non ha - 364 - valore per la valutazione finale, ma è utile allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale con domande sugli argomenti trattati e sulle attività di campo e di laboratorio svolte durante le esercitazioni. Il colloquio ha il fine di verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English At the end of the lectures the teacher will conduct a test of the teaching efficacy through oral questions on the main arguments in order to highlight any learning problem. The interview has no value for the final evaluation, but it is helpful to the student to estimate the learning level. The final exam is an oral exam with questions on the topics discussed and on the field and laboratory activities carried out during the training. The interview aims to verify the capacity of reasoning and connecting the knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e qualità dell'uva. Presentazione del corso e modalità d'esame. Parte generale L'agroecosistema vigneto e gli insetti. Ecologia, etologia e cicli biologici. Rapporti tra fitofagi, piante ospiti spontanee e vite. Processi di nutrizione. Sintomatologia. Cause che favoriscono le pullulazioni dei fitofagi. Campionamento delle popolazioni. Trasmissioni di agenti fitopatogeni quali, virus, fitoplasmi e batteri. Rapporti tra agenti patogeni e vettori. Insetti di temuta introduzione. Lotta integrata. Biotecnologie. Biocontrollo attraverso l'impiego dei simbionti. Parte speciale Sistematica degli Hemiptera. Insetti fitomizi e fitofagi. Esercitazioni Le attività saranno svolte in laboratorio e in campo. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of grape cultivation and quality. Presentation of the course and the examination General Section The vineyard agro-ecosystem and insects. Ecology, ethology and biological cycles. - 365 - Relations between pests, wild host plants and grapevine. Nutrition processes. Symptomatology. Causes that may favour pest outbreaks. Sampling of populations. Transmission of plant pathogens, such as viruses, phytoplasmas and bacteria. Relationships between pathogens and vectors. Insects with a high risk of introduction. Integrated pest management. Biotechnology. Biocontrol by using symbionts. Special Section Systematic of Hemiptera. Plant-sucking and plant-chewing insects. Training The activities will be carried out in the laboratory and in the field. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Articoli scientifici e materiale didattico (presentazioni PowerPoint) fornito dal docente verranno caricati sulla piattaforma CampusNet. English The recommended basic texts for the course are: Scientific papers and materials (PowerPoint presentations) provided by the teacher will be loaded on the platform CampusNet. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Asti. English The location of the course is Asti. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1nre - 366 - Approfondimenti di patologia viticola (Anno Accademico 2015/2016) ADVANCED GRAPEVINE PATHOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0608 Docente: Prof. Piero Attilio BIANCO (Affidamento interno) Contatti docente: 02 250316794, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PROPEDEUTICO A nessun esame OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Apprendere le modalità con le quali le ampelopatie causano danni alla produzione e utilizzare gli strumenti più idonei a prevenirne l'insorgenza e a contenerne la diffusione, attraverso programmi di gestione integrata. English To learn how the disease causes crop loss and how to prevent its early event and spread applying suitable integrated pest management programs. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza delle malattie della vite, dei patogeni che le causano e delle modalità di diffusione in vigneto. Riconoscimento dei sintomi e applicazione delle principali tecniche diagnostiche per l'identificazione dei patogeni della vite English Knowledge of grapevine diseases, of their causal agents and their pattern of spread in vineyards. To recognise the - 367 - disease symptoms and to apply the diagnostic techniques for identification of the pathogens of grapevine MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Esame orale English Oral examination Orale ATTIVITÀ DI SUPPORTO riconoscimento visivo delle sintomatologia della principali malattie della vite PROGRAMMA Italiano Le malattie della vite: ripresa delle principali ampelopatie con particolare riferimento a quelle di carattere epidemico. La selezione sanitaria della vite e sua importanza per il settore vivaistico. La diagnostica fitopatologica e le principali innovazioni tecnologiche (sierologiche e molecolari) nella individuazione e caratterizzazione dei patogeni della vite. Nuove acquisizioni sul controllo e la gestione delle malattie fungine: i modelli matematici e le loro applicazioni nella gestione delle malattie della vite. Nuove acquisizioni sul controllo e la gestione delle malattie: le nuove tecnologie in materia di prevenzione delle malattie e utilizzo di principi attivi a contenuto impatto ambientale. English The diseases of grapevine: a review of the main maladies of grapevine and in particular for those with epidemic pattern. The sanitary selection of grapevine and its importance for the nursery industry. The plant pathogen detection e the main innovations in serology and molecular biology for identification and characterization of grapevine pathogens. Novel achievements for the containment and the management of the fungal diseases: the expert systems and their use for the disease management. Novel achievements for the containment and the management of the diseases: new technologies and regulation - 368 - protocols for the disease prevention and use of chemicals of lower impact for the environment. Italiano elementi di gestione delle malattie della vite English elements of grapevine disease management TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Belli G. 2011. Elementi di Patologia Vegetale, Piccin editore -Articoli e rassegne su diversi argomenti concernenti il Corso fornite dal docente English - Belli G. 2011. Elementi di Patologia Vegetale, Piccin editor - Supplied review and articles concerning the topics of the course. NOTA Italiano English Mutuato da: nessun esame Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mf6d - 369 - Difesa delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) Disease management of ornamental trees Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 61253 Docente: Prof. Paolo GONTHIER (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708697, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 3 SSD attvità didattica: AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Acquisizione dei fondamenti per il riconoscimento delle principali malattie delle piante ornamentali, sulla base del quadro sintomatologico. Fornire le conoscenze di base sulle strategie di lotta con particolare riguardo alle tecniche a basso impatto ambientale. English Learn the ropes for the diagnosis of the main diseases of ornamental plants, based on symptoms. Provide insights on control strategies against diseases, with special enphasis on low impact strategies. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Competenze necessarie per saper impostare e applicare criteri di gestione fitosanitaria del verde ornamentale e di recupero del verde storico. English Knowledge on how to desing and adopt management strategies to control diseases of ornamental plants. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Lezioni frontali; esercitazioni in laboratorio English - 370 - Lectures; laboratory trainings MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'apprendimento dei principali concetti del corso e delle relazioni tra i diversi argomenti sarà verificata in itinere mediante domande poste dal docente all'intera classe o a studenti scelti a caso, seguendo un modello didattico il più possibile interattivo. English Learning of the main concepts of the course and the connections among topics will be verified continuously through questions asked by the teacher to the entire class or to randomly selected students, according to an interactive learning model. PROGRAMMA Italiano Malattie abiotiche di origine climatica, edafica e da inquinamenti Malattie infettive da virus, fitoplasmi, batteri e funghi. Patogenesi ed epidemiologia. Sintomatologia: alterazioni del colore, della forma, sintomi fogliari, rameali e del tronco. Patogenesi delle malattie infettive: contaminazione, infezione, incubazione, disseminazione, latenza. Orientamenti di lotta contro gli agenti patogeni del verde ornamentale - Lotta chimica: prodotti fitosanitari, modalità di distribuzione ed impiego. - Lotta agronomica, biologica ed integrata. Miglioramento genetico. Malattie aspecifiche: Rosellinia spp., Armillaria complex e altri agenti di marciume radicale Le carie su piante in piedi - Caratteristiche dei funghi agenti di carie. - Le fasi di degradazione del legno. Carie bianca o fibrosa e carie bruna o cubica. - I meccanismi di reazione della pianta: la teoria della compartimentazione (C.O.D.I.T.). Malattie specifiche trattate per matrice Conifere: cancri, malattie dei getti e dei rami e malattie degli aghi. Latifoglie: cancri, necrosi corticali, antracnosi, malattie rameali, malattie fogliari e malattie vascolari. Cenni sulla valutazione della stabilità degli alberi: il Visual Tree Assessment. Tecniche diagnostiche strumentali per la valutazione della stabilità degli alberi English - 371 - Biotic causes of diseases: viruses, phytoplasmas, bacteria, fungi. Parasitism and pathogenicity. Principles of disease management: avoidance, exclusion, eradication, protection and resistance. Biology and management of ornamental plant diseases. Root rot agents and wood decay fungi. The C.O.D.I.T. theory. Diseases of conifers: cankers, needle blights. Diseases of broadleaves: cankers, bark necrosis, foliar and vascular diseases. The Visual Tree Assessment and the diagnostic tools for tree inspection. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano CAPRETTI P., RAGAZZI A. 2009. Elementi di patologia forestale. Pàtron Editore, Bologna, pp. 432. GONTHIER P., NICOLOTTI G. 2013. Infectious forest diseases. CAB International, Wallingford, UK, pp. 704. GULLINO M.L., MOCIONI M., ZANIN G., ALMA A. 2000. La difesa dei tappeti erbosi. Malattie fungine, nemici animali e infestanti. Ed. L'Informatore Agrario. HOWARD LYON H., WARREN T. J. 1987. Diseases of trees and shrubs. Cornell University Press. MATTHECK C., BRELOER H. 1998 La stabilità degli alberi. Fenomeni meccanici e implicazioni legali dei cedimenti degli alberi. Il Verde Editoriale. NICOLOTTI G., DELLA BEFFA, MONDINO G.P., PALENZONA M. 2002. Alberi monumentali in Piemonte. Presenze e Avversità. Priuli & Verlucca Editore. STROUTS R.G., WINTER T.G. 1994. Diagnosis of ill-health in trees. Forestry Commission, Department of the Environment. English CAPRETTI P., RAGAZZI A. 2009. Elementi di patologia forestale. Pàtron Editore, Bologna, pp. 432. GONTHIER P., NICOLOTTI G. 2013. Infectious forest diseases. CAB International, Wallingford, UK, pp. 704. GULLINO M.L., MOCIONI M., ZANIN G., ALMA A. 2000. La difesa dei tappeti erbosi. Malattie fungine, nemici animali e infestanti. Ed. L'Informatore Agrario. HOWARD LYON H., WARREN T. J. 1987. Diseases of trees and shrubs. Cornell University Press. MATTHECK C., BRELOER H. 1998 La stabilità degli alberi. Fenomeni meccanici e implicazioni legali dei cedimenti degli alberi. Il Verde Editoriale. NICOLOTTI G., DELLA BEFFA, MONDINO G.P., PALENZONA M. 2002. Alberi monumentali in Piemonte. Presenze e Avversità. Priuli & Verlucca Editore. STROUTS R.G., WINTER T.G. 1994. Diagnosis of ill-health in trees. Forestry Commission, Department of the Environment. NOTA - 372 - Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=97pf - 373 - Difesa e gestione delle specie vegetali - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) DISEASE MANAGEMENT OF ORNAMENTAL TREES Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 60993 Docente: Prof. Paolo GONTHIER (Affidamento interno) Dott. Chiara FERRACINI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708697, [email protected] Corso di studio: [f001-c001] LM - Progettazione delle aree verdi e del paesaggio Anno: 1° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Difesa delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) Lotta ai nemici animali delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l4uv Difesa delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) Disease management of ornamental trees Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 61253 Docente: Prof. Paolo GONTHIER (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708697, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 3 SSD attvità didattica: AGR/12 - patologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 374 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Acquisizione dei fondamenti per il riconoscimento delle principali malattie delle piante ornamentali, sulla base del quadro sintomatologico. Fornire le conoscenze di base sulle strategie di lotta con particolare riguardo alle tecniche a basso impatto ambientale. English Learn the ropes for the diagnosis of the main diseases of ornamental plants, based on symptoms. Provide insights on control strategies against diseases, with special enphasis on low impact strategies. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Competenze necessarie per saper impostare e applicare criteri di gestione fitosanitaria del verde ornamentale e di recupero del verde storico. English Knowledge on how to desing and adopt management strategies to control diseases of ornamental plants. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Lezioni frontali; esercitazioni in laboratorio English Lectures; laboratory trainings MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'apprendimento dei principali concetti del corso e delle relazioni tra i diversi argomenti sarà verificata in itinere mediante domande poste dal docente all'intera classe o a studenti scelti a caso, seguendo un modello didattico il più possibile interattivo. English Learning of the main concepts of the course and the connections among topics will be verified continuously through questions asked by the teacher to the entire class or to randomly selected students, according to an interactive learning model. PROGRAMMA Italiano - 375 - Malattie abiotiche di origine climatica, edafica e da inquinamenti Malattie infettive da virus, fitoplasmi, batteri e funghi. Patogenesi ed epidemiologia. Sintomatologia: alterazioni del colore, della forma, sintomi fogliari, rameali e del tronco. Patogenesi delle malattie infettive: contaminazione, infezione, incubazione, disseminazione, latenza. Orientamenti di lotta contro gli agenti patogeni del verde ornamentale - Lotta chimica: prodotti fitosanitari, modalità di distribuzione ed impiego. - Lotta agronomica, biologica ed integrata. Miglioramento genetico. Malattie aspecifiche: Rosellinia spp., Armillaria complex e altri agenti di marciume radicale Le carie su piante in piedi - Caratteristiche dei funghi agenti di carie. - Le fasi di degradazione del legno. Carie bianca o fibrosa e carie bruna o cubica. - I meccanismi di reazione della pianta: la teoria della compartimentazione (C.O.D.I.T.). Malattie specifiche trattate per matrice Conifere: cancri, malattie dei getti e dei rami e malattie degli aghi. Latifoglie: cancri, necrosi corticali, antracnosi, malattie rameali, malattie fogliari e malattie vascolari. Cenni sulla valutazione della stabilità degli alberi: il Visual Tree Assessment. Tecniche diagnostiche strumentali per la valutazione della stabilità degli alberi English Biotic causes of diseases: viruses, phytoplasmas, bacteria, fungi. Parasitism and pathogenicity. Principles of disease management: avoidance, exclusion, eradication, protection and resistance. Biology and management of ornamental plant diseases. Root rot agents and wood decay fungi. The C.O.D.I.T. theory. Diseases of conifers: cankers, needle blights. Diseases of broadleaves: cankers, bark necrosis, foliar and vascular diseases. The Visual Tree Assessment and the diagnostic tools for tree inspection. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano CAPRETTI P., RAGAZZI A. 2009. Elementi di patologia forestale. Pàtron Editore, Bologna, pp. 432. GONTHIER P., NICOLOTTI G. 2013. Infectious forest diseases. CAB International, Wallingford, UK, pp. 704. GULLINO M.L., MOCIONI M., ZANIN G., ALMA A. 2000. La difesa dei tappeti erbosi. Malattie fungine, nemici animali e - 376 - infestanti. Ed. L'Informatore Agrario. HOWARD LYON H., WARREN T. J. 1987. Diseases of trees and shrubs. Cornell University Press. MATTHECK C., BRELOER H. 1998 La stabilità degli alberi. Fenomeni meccanici e implicazioni legali dei cedimenti degli alberi. Il Verde Editoriale. NICOLOTTI G., DELLA BEFFA, MONDINO G.P., PALENZONA M. 2002. Alberi monumentali in Piemonte. Presenze e Avversità. Priuli & Verlucca Editore. STROUTS R.G., WINTER T.G. 1994. Diagnosis of ill-health in trees. Forestry Commission, Department of the Environment. English CAPRETTI P., RAGAZZI A. 2009. Elementi di patologia forestale. Pàtron Editore, Bologna, pp. 432. GONTHIER P., NICOLOTTI G. 2013. Infectious forest diseases. CAB International, Wallingford, UK, pp. 704. GULLINO M.L., MOCIONI M., ZANIN G., ALMA A. 2000. La difesa dei tappeti erbosi. Malattie fungine, nemici animali e infestanti. Ed. L'Informatore Agrario. HOWARD LYON H., WARREN T. J. 1987. Diseases of trees and shrubs. Cornell University Press. MATTHECK C., BRELOER H. 1998 La stabilità degli alberi. Fenomeni meccanici e implicazioni legali dei cedimenti degli alberi. Il Verde Editoriale. NICOLOTTI G., DELLA BEFFA, MONDINO G.P., PALENZONA M. 2002. Alberi monumentali in Piemonte. Presenze e Avversità. Priuli & Verlucca Editore. STROUTS R.G., WINTER T.G. 1994. Diagnosis of ill-health in trees. Forestry Commission, Department of the Environment. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=97pf - 377 - Lotta ai nemici animali delle piante ornamentali (Anno Accademico 2015/2016) Control of the pests of the ornamental plants Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 61254 Docente: Dott. Chiara FERRACINI (Affidamento interno) Contatti docente: 011/6708700, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 3 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Acquisire i fondamenti per il riconoscimento delle principali malattie e dei nemici animali delle piante ornamentali, sulla base del quadro sintomatologico. Fornire le conoscenze di base sulle strategie di lotta con particolare riguardo alle tecniche a basso impatto ambientale. English The course will enable the student to recognize the most important pests of the ornamental plants, with particular regard to the main control strategies with low environmental impact. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisire le competenze necessarie per impostare e applicare criteri di gestione fitosanitaria del verde ornamentale e di recupero del verde storico. English To acquire the expertise in order to plan and apply the right strategies to contain the pests of the urban green. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio con visione di scatole entomologiche. English - 378 - The course consists of lectures and laboratory activities, during which entomological drawers will be examined. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso, al termine della trattazione di ogni argomento, sarà organizzata una discussione comune sul tema. Le esercitazioni pratiche rappresenteranno un'ulteriore occasione di verifica dell'apprendimento. English During classes, at the end of the presentation of each topic, a discussion section will be held. Practicals will be a further occasion to evaluate the level of learning. PROGRAMMA Italiano Modulo: Lotta ai nemici animali delle piante ornamentali Rapporti tra fitofagi e piante ospiti. Processi di nutrizione, danni diretti e indiretti. Sintomatologia. Cause che favoriscono le pullulazioni dei fitofagi. Tecniche di campionamento. Fitofagi indigeni, acquisiti ed esotici. Fitofagi di temuta introduzione problemi e prospettive. Metodi di lotta con particolare attenzione alle strategie a basso impatto ambientale. Endoterapia. Lotta naturale e biologica. Principali fitofagi dannosi in ambiente urbano: per ogni specie trattata saranno fornite le linee guida per le strategie di difesa da adottare. English Unit: Control methods against animal pests of ornamental plants. Relationships between pests and host plants. Nutrition processes, direct and indirect damage. Symptoms. Causes that favour the proliferation of pests. Sampling techniques. Autochthonous pests, acquired and exotic. Plant pests of feared introduction, problems and perspectives. Control methods. Endotherapic techniques. Natural and biological control. Arthropods harmful to: broadleaf trees, shrubs, bushes and hedges, conifers; lawns, exotic plants TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni PowerPoint e articoli per le letture critiche saranno caricati sulla piattaforma Campusnet. - 379 - English Power point slides and scientific papers concerning the main topics will be provided on the Campusnet platform. NOTA Italiano Esame orale English Oral examination Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9s4z - 380 - Diritto amministrativo (Anno Accademico 2015/2016) ADMINISTRATIVE LAW Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0108 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: IUS/10 - diritto amministrativo Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone si offrire allo studente, non giurista, la conoscenza di base del diritto amministrativo italiano, europeo e internazionale, con particolare riferimento alla legislazione in materia ambientale e forestale. English The course aims at providing the student, not jurist, the basic knowledge of the Italian administrative law, European and international level, with particular reference to environmental and forest legislation. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il corso si propone si offrire la basi conoscitive del diritto forestale e ambientale interno, tenendo conto dei rapporti sempre più rilevanti con il diritto internazionale e comunitario. English The course aims to provide basic knowledge of the forest and environmental law, especially with regard to relations with the International and Community law. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English - 381 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Orale English Oral PROGRAMMA Italiano I contenuti del programma appartengono all'area di apprendimento economico-giuridica. Parte generale di diritto amministrativo: – Il diritto amministrativo italiano e le sue fonti normative. I principi del diritto internazionale e la loro rilevanza nel diritto amministrativo interno. Il diritto europeo e le sue fonti normative. Elementi di diritto amministrativo comunitario. Regolamenti e direttive. Le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il diritto amministrativo: diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso, etc. – La funzione amministrativa: i principi costituzionali ed europei. Il funzionamento, l'organizzazione e le attività della pubblica Amministrazione. Il procedimento amministrativo. L'atto amministrativo e i suoi elementi. Il provvedimento amministrativo: caratteri, tipologie e classificazioni. Il silenzio amministrativo. Le patologie dell'atto amministrativo. Le autotutele della pubblica amministrazione. L'esercizio consensuale dei poteri amministrativi: i c.d. gli accordi amministrativi. L'attività negoziale della pubblica amministrazione. I beni della pubblica amministrazione e i provvedimenti limitativi della proprietà privata. La responsabilità civile, penale e amministrativa di funzionari e dipendenti pubblici e delle istituzioni pubbliche d'appartenenza. – Il sistema amministrativo a livello centrale: il Governo, i ministeri e gli organi ausiliari (Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). Il sistema amministrativo delle autonomie locali: regioni, province e comuni. Il nuovo Titolo V della Costituzione italiana. Il sistema della giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi e la giurisdizione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi. Parte speciale di legislazione forestale e ambientale: – I principi generali del diritto forestale e ambientale internazionale e comunitario (precauzione, prevenzione, sussidiarietà, chi inquina paga). Il quadro costituzionale. Il diritto di proprietà e i beni pubblici. I diritti reali e il possesso. – Il bene forestale come bene di produzione. Il bene forestale come bene di protezione e difesa del suolo. Il regime vincolistico ed autorizzativo. Il regime delle acque e la gestione delle risorse idriche. Il bene forestale come bene naturalistico (parchi e riserve naturali). – Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico. Il paesaggio naturale. Regime vincolistico ed autorizzativi. I regimi sanzionatori. English General Section of Administrative Law: – The Italian administrative law and its regulations. The principles of international law and their relevance in the domestic administrative law. European Law and its normative sources. European Administrative Law – basic notions. - 382 - Regulations and Directives. The subjective legal situations relevant to the administrative law: subjective right, legitimate interest, widespread interest, etc. – The administrative function: Constitutional and European principles. Functioning, Organisation and Activities of the Public Administration. The administrative Procedure. The administrative act and its elements. The administrative measure: characters, types and classifications. The administrative silence. The diseases of administrative act. The self-defenses of the public administration. The exercise of consensual administrative powers: the so-called administrative agreement. The negotiating activity of public institutions. The assets of the public administration and the measures restricting private property. The civil, criminal and administrative liability of the officials and civil servants and of the public institutions. – The administrative system at the central level: the Government, ministries and subsidiary bodies (Court of Auditors, the Council of State, etc.). The current system of local government: Regions, Provinces and Municipalities. New Title V of the Italian Constitution. The system of administrative justice: the administrative appeals and the jurisdiction of the ordinary courts and administrative courts. Special section of forest and environmental legislation: – Forest Law: general principles, international and EU scenario. Italian Constitution: right of private property and public goods. The rights relating to things and possession of things. – The forest as source of productivity. The forest as forest floor to be protected. Legal constraints and authorisations. Regulation and management of public water. The forest as natural source. – The forest as cultural heritage. Natural landscape: legal constraints and authorisations. Sanctions. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (tutto, ad esclusione dei capp. XV, XVI, XXI e XXII) A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008, esclusivamente i seguenti capitoli: - cap. I (tutto); - cap. II, parte I (solo i paragrafi 1 e 2), parte II (tutto, tranne i paragrafi 5 e 6), parte III (tutto, tranne il paragrafo 3), parte IV (tutto); - cap. IV (tutto); - cap. V (solo parte prima); - cap. VI (solo paragrafi da 1 a 5 compreso); - cap. VII (tutto). N.B. Questo programma vale anche per gli studenti iscritti nei precedenti a.a. il cui carico didattico sia pari a 8 CFU. English - 383 - The basic books recommended for the course are: A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (everything, except the chapters XV, XVI, XXI e XXII); A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008, only the followingchapters: - cha. I (entire chapter); - cha. II, part I (only paragraphs 1 e 2), part II (entire chapter,exceptparagraphs 5 and 6), part III (entire chapter,exceptparagraph 3), part IV (entire chapter); - cha. IV (entire chapter); - cha. V (only the first part); - cha. VI (only paragraphs from 1 to 5 included); - cha. VII (entire chapter). This program also applies to students enrolled in the previous academic years whose teaching load is equal to 8 CFU. NOTA Italiano La frequenza al corso, pur facoltativa, è fortemente consigliata. English The attendance during the lessons, taught optional, is strongly recommended. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=scc6 - 384 - Diritto amministrativo (Anno Accademico 2015/2016) ADMINISTRATIVE LAW Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0393 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 1° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: IUS/10 - diritto amministrativo Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone si offrire allo studente, non giurista, la conoscenza di base del diritto amministrativo italiano, europeo e internazionale, con particolare riferimento alla legislazione in materia ambientale e forestale. English The course aims at providing the student, not jurist, the basic knowledge of the Italian administrative law, European and international level, with particular reference to environmental and forest legislation. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il corso si propone si offrire la basi conoscitive del diritto forestale e ambientale interno, tenendo conto dei rapporti sempre più rilevanti con il diritto internazionale e comunitario. English The course aims to provide basic knowledge of the forest and environmental law, especially with regard to relations with the International and Community law. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English - 385 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Orale English Oral PROGRAMMA Italiano I contenuti del programma appartengono all'area di apprendimento economico-giuridica. Parte generale di diritto amministrativo: – Il diritto amministrativo italiano e le sue fonti normative. I principi del diritto internazionale e la loro rilevanza nel diritto amministrativo interno. Il diritto europeo e le sue fonti normative. Elementi di diritto amministrativo comunitario. Regolamenti e direttive. Le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il diritto amministrativo: diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso, etc. – La funzione amministrativa: i principi costituzionali ed europei. Il funzionamento, l'organizzazione e le attività della pubblica Amministrazione. Il procedimento amministrativo. L'atto amministrativo e i suoi elementi. Il provvedimento amministrativo: caratteri, tipologie e classificazioni. Il silenzio amministrativo. Le patologie dell'atto amministrativo. Le autotutele della pubblica amministrazione. L'esercizio consensuale dei poteri amministrativi: i c.d. gli accordi amministrativi. L'attività negoziale della pubblica amministrazione. I beni della pubblica amministrazione e i provvedimenti limitativi della proprietà privata. La responsabilità civile, penale e amministrativa di funzionari e dipendenti pubblici e delle istituzioni pubbliche d'appartenenza. – Il sistema amministrativo a livello centrale: il Governo, i ministeri e gli organi ausiliari (Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). Il sistema amministrativo delle autonomie locali: regioni, province e comuni. Il nuovo Titolo V della Costituzione italiana. Il sistema della giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi e la giurisdizione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi. Parte speciale di legislazione forestale e ambientale: – I principi generali del diritto forestale e ambientale internazionale e comunitario (precauzione, prevenzione, sussidiarietà, chi inquina paga). Il quadro costituzionale. Il diritto di proprietà e i beni pubblici. I diritti reali e il possesso. – Il bene forestale come bene di produzione. Il bene forestale come bene di protezione e difesa del suolo. Il regime vincolistico ed autorizzativo. Il regime delle acque e la gestione delle risorse idriche. Il bene forestale come bene naturalistico (parchi e riserve naturali). – Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico. Il paesaggio naturale. Regime vincolistico ed autorizzativi. I regimi sanzionatori. English General Section of Administrative Law: – The Italian administrative law and its regulations. The principles of international law and their relevance in the domestic administrative law. European Law and its normative sources. European Administrative Law – basic notions. - 386 - Regulations and Directives. The subjective legal situations relevant to the administrative law: subjective right, legitimate interest, widespread interest, etc. – The administrative function: Constitutional and European principles. Functioning, Organisation and Activities of the Public Administration. The administrative Procedure. The administrative act and its elements. The administrative measure: characters, types and classifications. The administrative silence. The diseases of administrative act. The self-defenses of the public administration. The exercise of consensual administrative powers: the so-called administrative agreement. The negotiating activity of public institutions. The assets of the public administration and the measures restricting private property. The civil, criminal and administrative liability of the officials and civil servants and of the public institutions. – The administrative system at the central level: the Government, ministries and subsidiary bodies (Court of Auditors, the Council of State, etc.). The current system of local government: Regions, Provinces and Municipalities. New Title V of the Italian Constitution. The system of administrative justice: the administrative appeals and the jurisdiction of the ordinary courts and administrative courts. Special section of forest and environmental legislation: – Forest Law: general principles, international and EU scenario. Italian Constitution: right of private property and public goods. The rights relating to things and possession of things. – The forest as source of productivity. The forest as forest floor to be protected. Legal constraints and authorisations. Regulation and management of public water. The forest as natural source. – The forest as cultural heritage. Natural landscape: legal constraints and authorisations. Sanctions. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (tutto, ad esclusione dei capp. XV, XVI, XXI e XXII) A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008, esclusivamente i seguenti capitoli: - cap. I (tutto); - cap. II, parte I (solo i paragrafi 1 e 2), parte II (tutto, tranne i paragrafi 5 e 6), parte III (tutto, tranne il paragrafo 3), parte IV (tutto); - cap. IV (tutto); - cap. V (solo parte prima); - cap. VI (solo paragrafi da 1 a 5 compreso); - cap. VII (tutto). N.B. Questo programma vale anche per gli studenti iscritti nei precedenti a.a. il cui carico didattico sia pari a 8 CFU. English The basic books recommended for the course are: A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (everything, except the chapters XV, XVI, XXI e XXII); - 387 - A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008, only the followingchapters: - cha. I (entire chapter); - cha. II, part I (only paragraphs 1 e 2), part II (entire chapter,exceptparagraphs 5 and 6), part III (entire chapter,exceptparagraph 3), part IV (entire chapter); - cha. IV (entire chapter); - cha. V (only the first part); - cha. VI (only paragraphs from 1 to 5 included); - cha. VII (entire chapter). This program also applies to students enrolled in the previous academic years whose teaching load is equal to 8 CFU. NOTA Italiano La frequenza al corso, pur facoltativa, è fortemente consigliata. English The attendance during the lessons, taught optional, is strongly recommended. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e2an - 388 - Diritto amministrativo (Anno Accademico 2015/2016) ADMINISTRATIVE LAW Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0251 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: IUS/10 - diritto amministrativo Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone si offrire allo studente, non giurista, la conoscenza di base del diritto amministrativo italiano, europeo e internazionale, con particolare riferimento alla legislazione in materia ambientale e forestale. English The course aims at providing the student, not jurist, the basic knowledge of the Italian administrative law, European and international level, with particular reference to environmental and forest legislation. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il corso si propone si offrire la basi conoscitive del diritto forestale e ambientale interno, tenendo conto dei rapporti sempre più rilevanti con il diritto internazionale e comunitario. English The course aims to provide basic knowledge of the forest and environmental law, especially with regard to relations with the International and Community law. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English - 389 - MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Orale English Oral PROGRAMMA Italiano I contenuti del programma appartengono all'area di apprendimento economico-giuridica. Parte generale di diritto amministrativo: – Il diritto amministrativo italiano e le sue fonti normative. I principi del diritto internazionale e la loro rilevanza nel diritto amministrativo interno. Il diritto europeo e le sue fonti normative. Elementi di diritto amministrativo comunitario. Regolamenti e direttive. Le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il diritto amministrativo: diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso, etc. – La funzione amministrativa: i principi costituzionali ed europei. Il funzionamento, l'organizzazione e le attività della pubblica Amministrazione. Il procedimento amministrativo. L'atto amministrativo e i suoi elementi. Il provvedimento amministrativo: caratteri, tipologie e classificazioni. Il silenzio amministrativo. Le patologie dell'atto amministrativo. Le autotutele della pubblica amministrazione. L'esercizio consensuale dei poteri amministrativi: i c.d. gli accordi amministrativi. L'attività negoziale della pubblica amministrazione. I beni della pubblica amministrazione e i provvedimenti limitativi della proprietà privata. La responsabilità civile, penale e amministrativa di funzionari e dipendenti pubblici e delle istituzioni pubbliche d'appartenenza. – Il sistema amministrativo a livello centrale: il Governo, i ministeri e gli organi ausiliari (Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). Il sistema amministrativo delle autonomie locali: regioni, province e comuni. Il nuovo Titolo V della Costituzione italiana. Il sistema della giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi e la giurisdizione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi. Parte speciale di legislazione forestale e ambientale: – I principi generali del diritto forestale e ambientale internazionale e comunitario (precauzione, prevenzione, sussidiarietà, chi inquina paga). Il quadro costituzionale. Il diritto di proprietà e i beni pubblici. I diritti reali e il possesso. – Il bene forestale come bene di produzione. Il bene forestale come bene di protezione e difesa del suolo. Il regime vincolistico ed autorizzativo. Il regime delle acque e la gestione delle risorse idriche. Il bene forestale come bene naturalistico (parchi e riserve naturali). – Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico. Il paesaggio naturale. Regime vincolistico ed autorizzativi. I regimi sanzionatori. English General Section of Administrative Law: – The Italian administrative law and its regulations. The principles of international law and their relevance in the domestic administrative law. European Law and its normative sources. European Administrative Law – basic notions. - 390 - Regulations and Directives. The subjective legal situations relevant to the administrative law: subjective right, legitimate interest, widespread interest, etc. – The administrative function: Constitutional and European principles. Functioning, Organisation and Activities of the Public Administration. The administrative Procedure. The administrative act and its elements. The administrative measure: characters, types and classifications. The administrative silence. The diseases of administrative act. The self-defenses of the public administration. The exercise of consensual administrative powers: the so-called administrative agreement. The negotiating activity of public institutions. The assets of the public administration and the measures restricting private property. The civil, criminal and administrative liability of the officials and civil servants and of the public institutions. – The administrative system at the central level: the Government, ministries and subsidiary bodies (Court of Auditors, the Council of State, etc.). The current system of local government: Regions, Provinces and Municipalities. New Title V of the Italian Constitution. The system of administrative justice: the administrative appeals and the jurisdiction of the ordinary courts and administrative courts. Special section of forest and environmental legislation: – Forest Law: general principles, international and EU scenario. Italian Constitution: right of private property and public goods. The rights relating to things and possession of things. – The forest as source of productivity. The forest as forest floor to be protected. Legal constraints and authorisations. Regulation and management of public water. The forest as natural source. – The forest as cultural heritage. Natural landscape: legal constraints and authorisations. Sanctions. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (tutto, ad esclusione dei capp. XV, XVI, XXI e XXII) A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008, esclusivamente i seguenti capitoli: - cap. I (tutto); - cap. II, parte I (solo i paragrafi 1 e 2), parte II (tutto, tranne i paragrafi 5 e 6), parte III (tutto, tranne il paragrafo 3), parte IV (tutto); - cap. IV (tutto); - cap. V (solo parte prima); - cap. VI (solo paragrafi da 1 a 5 compreso); - cap. VII (tutto). N.B. Questo programma vale anche per gli studenti iscritti nei precedenti a.a. il cui carico didattico sia pari a 8 CFU. English The basic books recommended for the course are: A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (everything, except the chapters XV, XVI, XXI e XXII); - 391 - A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008, only the followingchapters: - cha. I (entire chapter); - cha. II, part I (only paragraphs 1 e 2), part II (entire chapter,exceptparagraphs 5 and 6), part III (entire chapter,exceptparagraph 3), part IV (entire chapter); - cha. IV (entire chapter); - cha. V (only the first part); - cha. VI (only paragraphs from 1 to 5 included); - cha. VII (entire chapter). This program also applies to students enrolled in the previous academic years whose teaching load is equal to 8 CFU. NOTA Italiano La frequenza al corso, pur facoltativa, è fortemente consigliata. English The attendance during the lessons, taught optional, is strongly recommended. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=05xf - 392 - Diritto dell'ambiente e del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) LAW Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 60990 Docente: Da Nominare DOCENTE (Contratto) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f001-c001] LM - Progettazione delle aree verdi e del paesaggio Anno: 1° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: IUS/10 - diritto amministrativo Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si propone si offrire allo studente, non giurista, la conoscenza di base del diritto amministrativo italiano, europeo e internazionale, con particolare riferimento alla legislazione in materia ambientale e forestale. English The course aims at providing the student, not jurist, the basic knowledge of the Italian administrative law, European and international level, with particular reference to environmental and forest legislation. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il corso si propone si offrire la basi conoscitive del diritto forestale e ambientale interno, tenendo conto dei rapporti sempre più rilevanti con il diritto internazionale e comunitario. - 393 - English The course aims to provide basic knowledge of the forest and environmental law, especially with regard to relations with the International and Community law. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Modalità di verifica/esame: orale English Assessment methods/examination: oral PROGRAMMA Italiano I contenuti del programma appartengono all'area di apprendimento economico-giuridica. Parte generale di diritto amministrativo: – Il diritto amministrativo italiano e le sue fonti normative. I principi del diritto internazionale e la loro rilevanza nel diritto amministrativo interno. Il diritto europeo e le sue fonti normative. Elementi di diritto amministrativo comunitario. Regolamenti e direttive. Le situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il diritto amministrativo: diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso, etc. – La funzione amministrativa: i principi costituzionali ed europei. Il funzionamento, l'organizzazione e le attività della pubblica Amministrazione. Il procedimento amministrativo. L'atto amministrativo e i suoi elementi. Il provvedimento amministrativo: caratteri, tipologie e classificazioni. Il silenzio amministrativo. Le patologie dell'atto amministrativo. Le autotutele della pubblica amministrazione. L'esercizio consensuale dei poteri amministrativi: i c.d. gli accordi amministrativi. L'attività negoziale della pubblica amministrazione. I beni della pubblica amministrazione e i provvedimenti limitativi della proprietà privata. La responsabilità civile, penale e amministrativa di funzionari e dipendenti pubblici e delle istituzioni pubbliche d'appartenenza. – Il sistema amministrativo a livello centrale: il Governo, i ministeri e gli organi ausiliari (Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). Il sistema amministrativo delle autonomie locali: regioni, province e comuni. Il nuovo Titolo V della Costituzione italiana. Il sistema della giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi e la giurisdizione dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi. Parte speciale di legislazione forestale e ambientale: – I principi generali del diritto forestale e ambientale internazionale e comunitario (precauzione, prevenzione, - 394 - sussidiarietà, chi inquina paga). Il quadro costituzionale. Il diritto di proprietà e i beni pubblici. I diritti reali e il possesso. – Il bene forestale come bene di produzione. Il bene forestale come bene di protezione e difesa del suolo. Il regime vincolistico ed autorizzativo. Il regime delle acque e la gestione delle risorse idriche. Il bene forestale come bene naturalistico (parchi e riserve naturali). – Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico. Il paesaggio naturale. Regime vincolistico ed autorizzativi. I regimi sanzionatori. English General Section of Administrative Law: – The Italian administrative law and its regulations. The principles of international law and their relevance in the domestic administrative law. European Law and its normative sources. European Administrative Law – basic notions. Regulations and Directives. The subjective legal situations relevant to the administrative law: subjective right, legitimate interest, widespread interest, etc. – The administrative function: Constitutional and European principles. Functioning, Organisation and Activities of the Public Administration. The administrative Procedure. The administrative act and its elements. The administrative measure: characters, types and classifications. The administrative silence. The diseases of administrative act. The self-defenses of the public administration. The exercise of consensual administrative powers: the so-called administrative agreement. The negotiating activity of public institutions. The assets of the public administration and the measures restricting private property. The civil, criminal and administrative liability of the officials and civil servants and of the public institutions. – The administrative system at the central level: the Government, ministries and subsidiary bodies (Court of Auditors, the Council of State, etc.). The current system of local government: Regions, Provinces and Municipalities. New Title V of the Italian Constitution. The system of administrative justice: the administrative appeals and the jurisdiction of the ordinary courts and administrative courts. Special section of forest and environmental legislation: – Forest Law: general principles, international and EU scenario. Italian Constitution: right of private property and public goods. The rights relating to things and possession of things. – The forest as source of productivity. The forest as forest floor to be protected. Legal constraints and authorisations. Regulation and management of public water. The forest as natural source. – The forest as cultural heritage. Natural landscape: legal constraints and authorisations. Sanctions. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (tutto, ad esclusione dei capp. XXI e XXII) A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008 (tutto, ad esclusione dei capp. II e III) - 395 - English The basic books recommended for the course are: A. Crosetti – A. Giuffrida, Elementi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012 (everything, except the chapters XXI e XXII) A. Crosetti – N. Ferrucci, Manuale di diritto forestale e ambientale, Giuffrè, Milano, 2008 (everything, except the chapters II e III) NOTA Italiano La frequenza al corso, pur facoltativa, è fortemente consigliata. English The attendance during the lessons, taught optional, is strongly recommended. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z3bd - 396 - Disegno dell'architettura (Anno Accademico 2015/2016) ARCHITECTURAL DESIGN Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0131 Docente: Dott. Enrico FABRIZIO (Affidamento interno) Contatti docente: 011/6705525, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: ICAR/17 - disegno Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso intende fornire gli strumenti, le regole e le convenzioni del linguaggio grafico-assistito che consentono sia la lettura e la comprensione degli elaborati grafici comunemente adottati in ambito architettonico e urbanistico, sia la redazione autonoma di semplici elaborati grafici. English The course is intended to provide the tools, rules and conventions of graphic language that allow both the reading and understanding of the drawings that are commonly used in architecture and urban planning and the autonomous drafting of simple technical drawings. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Capacità di visualizzare e rappresentare le forme dello spazio a tre dimensioni attraverso gli strumenti del linguaggio grafico. Allenamento e sviluppo delle capacità di rappresentazione grafica. Capacità di redigere, attraverso strumenti informatici, semplici elaborati grafici progettuali secondo le normative e le convenzioni. English Ability to visualize and represent the architectural and landscape forms of the three-dimensional space through the - 397 - tools of graphic language. Training of the drawings capabilities. Doing simple drawings by means of CAD. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste in circa 60 ore di lezioni e applicazioni grafiche guidate e circa 20 ore di esercitazioni svolte a mano libera o con l'ausilio di strumenti informatici. Le dimostrazioni grafiche delle lezioni vengono svolte direttamente alla lavagna, mentre per argomenti più discorsivi o tecnici il docente si avvale di presentazioni e slide a disposizione degli studenti all'inizio corso. Gli studenti sono invitati a stampare le slide da impiegare come supporto per gli appunti. English The course consists of approx 60 hours of lectures and guided graphical applications and approx 20 hours of exercises done by hand or at the pc. Drawings during the lessons are carried out directly on the blackboard, while for more discursive or technical topics the teacher makes use of slides already available to students at the beginning of the course. Students are encouraged to print the slides and to use them to take notes. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Valutazione periodica delle esercitazioni, svolte in aula, di applicazione delle nozioni apprese. Modalità di esame 1. Per l'ammissione all'esame è richiesto lo svolgimento delle esercitazioni, periodiche e CAD, svolte durante il corso. 2. L'esame consiste nella discussione orale dei temi presentati nelle lezioni, comprese le dimostrazioni grafiche a mano libera, e nella valutazione degli elaborati svolti durante il corso, ovvero: le esercitazioni periodiche e l'elaborato finale realizzato attraverso strumenti informatici. Il colloquio è teso a verificare la conoscenza delle nozioni apprese durante il corso, la capacità di ragionamento e collegamento tra le nozioni acquisite e l'allenamento delle capacità grafiche individuali. 3. E' inoltre richiesto al singolo allievo, quale utile corredo alla valutazione finale, il quaderno personale degli appunti delle lezioni. English Periodic evaluation of the short classroom exercises carried out applying the concepts learned. Final exam 1. Periodic and CAD exercises, carried out during the course, are required in order to take the exam. 2. The exam consists in an oral discussion of the topics presented during the lectures, including graphic demonstrations, and in the evaluation of the works carried out during the course, namely: the various exercises and the final work carried out in CAD. - 398 - 3. The notebook of the lectures of each student is also required as a useful complement to the final score. PROGRAMMA Italiano Il corso appartiene alle aree di apprendimento 1 (Area delle conoscenze propedeutiche) e 8 (Area tecnica). Lezioni a) Introduzione e generalità del disegno. Percezione visiva e linguaggio grafico. La luce come fenomeno fisico e percettivo. Le leggi della percezione. Gli elementi primari e secondari del linguaggio grafico. Strumentazione, scritturazione e costruzioni geometriche fondamentali. b) Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva. Enti geometrici fondamentali: punto, retta, piano. Estensione dei postulati di geometria euclidea; punto improprio e retta impropria. Le operazioni di proiezione e sezione. La prospettività. L'omologia. Proiezioni ortogonali; condizioni di appartenenza, parallelismo, intersezione, perpendicolarità; rappresentazione di solidi; falde di ugual pendenza; ricerca della vera forma; codificazione delle viste; poligoni, poliedri, prismi, coni, cilindri, sezioni coniche, superfici di rotazione. Proiezioni assonometriche; genesi spaziale ed elementi di riferimento; assonometrie ortogonali; assonometrie oblique. Proiezioni prospettiche; genesi spaziale ed elementi di riferimento; tipi di prospettiva; fughe di rette e di piani. Teoria delle ombre (cenni). Ogni tema di questa parte del corso viene seguito dallo svolgimento in aula di brevi esercitazioni di applicazione delle nozioni apprese (Esercitazioni periodiche) che saranno valutate di volta in volta. c) Disegno e architettura. Il disegno per il progetto: scale metriche, formati, norme UNI, planimetrie/piante/sezioni/prospetti, sistemi di quotatura, disegno tecnico edile, codifiche simboliche, elementi di antropometria ed ergonometria, il disegno di paesaggi (UNI EN ISO 11091). Le proporzioni. Archi, volte, cupole. Profilo storico dei linguaggi formali (ordini, stili). Disegno e forma urbana: l'iconografica storica di Torino e del territorio foraneo. Disegno e colore: la teoria del colore d) Disegno assistito dal computer. Apprendimento dei comandi fondamentali in ambiente CAD e svolgimento di un'esercitazione progettuale. Esercitazioni periodiche Rette e piani in doppia proiezione (2 esercitazioni) Rappresentazione di solidi in doppia proiezione (1 esercitazione) Rappresentazioni assonometriche (1 esercitazione) Prospettiva centrale e accidentale (1 esercitazione) Esercitazione CAD Svolgimento di un'esercitazione progettuale su un tema fornito. L'esercitazione progettuale è svolta in gruppi da 3 a 4 studenti. Visita tecnica Svolgimento di una visita tecnica (lettura della forma urbana e delle architetture) English The course falls within the 1 (Area of Fundamentals) and 8 (Technical area) education sectors. Lectures - 399 - a) Introduction and generalities. The visual perception. Light as a physical and perceptive phenomenon. The laws of perception. The primary and secondary elements of the graphic language. Instrumentation, writing and basic geometric constructions. b) Fundamentals of descriptive geometry. Basic geometric entities: point, line, plane. Projection. Perspectivity. Homology. Orthogonal projections, representation of solids; pitched roof of equal slope. Coding of the views; polygons, polyhedrons, prisms, cones, cylinders, conical sections, surfaces of revolution. Axonometric projections. Perspective. Theory of the shadows (hints). Each topic of section b) will be followed by the classroom execution of short exercises on the application of concepts learned that will be evaluated regularly. c) Drawings and the architeture. The drawing for the architectural and urban design: metric scales, standards, planimetrics/plans/sections/elevations, dimensioning systems, technical drawing construction, symbols, elements of ergonomics and anthropometry. The proportions. Historical profile of formal languages; orders and styles. Arches, vaults and domes. Design and urban form: the iconographic history of Turin and its sourrounding. Design and color: color theory. d) Computer aided design and design exercise. Learning of the basic commands of CAD and execution of an exercise. Regular exercises Straight lines and planes in double projections (2 esercitazioni) Solids representation in double projections (1 esercitazione) Axonometric (1 esercitazione) Central and vanishing point perspective (1 esercitazione) CAD Exercise Development of a computer aided drawing on a specific topic. The exercise will be conducted in groups of 3 to 4 students. Technical tour Technical tour (example of understanding of the urban form and architectures) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Dispense delle lezioni Per la parte di Fondamenti di geometria descrittiva e disegno per il progetto: - M. Docci, Teoria e pratica del disegno, Editori Laterza - M. Docci, M. Gaiani, D. Maestri, Scienza del disegno, Città Studi English - Lecture notes For the Fundamentals of descriptive geometry and drawing for the architectural project: - 400 - - Mario Docci, Teoria e pratica del disegno, Editori Laterza - M. Docci, M. Gaiani, D. Maestri, Scienza del disegno, Città Studi NOTA Italiano E' fortemente consigliata la frequenza, in particolare alle attività didattiche grafiche (parti b) e d) del programma) ed alle attività esercitative. English Frequency to the course is strongly recommended, particularly for the graphical exercises (parts b) and d) of the course programme) and for the training computer activities. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ffh6 - 401 - Ecologia agraria (Anno Accademico 2015/2016) AGRICULTURAL ECOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0343 Docente: Prof. Amedeo REYNERI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708778, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie [f001-c501/101] LM - Scienze agrarie curr. Agroingegneria gestionale del territorio [f001-c501/102] LM - Scienze agrarie curr. Gestione sostenibile Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso tratta delle influenze reciproche fra produzione agraria ed ambiente, e definisce le metodologie di analisi e di pianificazione agronomica dell'uso agricolo dei mezzi tecnici e del territorio; individuati i principali effetti del sistema colturale agricolo sull'ambiente, si accenna alle reti di monitoraggio ambientale disponibili o mancanti in Piemonte ed in Italia, le tecniche scientifiche disponibili per quantificare l'impatto dell'agricoltura, le tecniche agronomiche che possono ridurre o risolvere i rischi di impatto. English This course analyzes the reciprocal influences between agricultural production and the environment. It introduces the student to the methods for the analysis and management of crop and animal husbandry at the farm and territorial scale. The most important network of data on environment monitoring are analyzed. Emphasis is given on the methods for discovering and collecting available data or for identifying missing data in Piedmont and in Italy. The scientific techniques for quantify agricultural impacts on the environment are presented. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano - 402 - Lo studente acquisisce la capacità di analizzare il sistema colturale e derivarne le valutazioni sulle sue ampie valenze ambientali positive e negative. Si classificheranno e si utilizzeranno indicatori ambientali, e di sostenibilità agronomica per giudicare delle attività agricole. Per l'intero corso si conserva una costante attenzione ai riferimenti legislative necessari per capire le politiche ambientali interessanti per l'agricoltura. English The student will be trained towards the ability for proposing the best available techniques able to mitigate or solve environmental problems. The student will be able to list and comment positive or negative externalities produced by agricultural systems. Environmental and agronomical indicators for judging the agriculture in Piedmont and Itlay will be used. Students will be trained to continuously refer to legislation that influences environmental policies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Esame scritto e orale, che include domande aperte e brevi problemi di calcolo English The final exam will have a written part (including open and multiple choice questions, as well as short problems that requires simple calculations) and then a short oral part. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica sarà effettuata in itinere mediante test sulle nozioni sulla parte del programma svolta. English The learning tests will be carry on during the course on the part of program already presented. Scritto e orale PROGRAMMA Italiano Lezioni Esercitazioni Argomenti trattati ore Introduzione: significati e obiettivi dell'Agronomia Ambientale. Territorio nazionale ed agricoltura. Tipi di agricoltura ed obiettivi politici comunitari. Agricoltura convenzionale, integrata e biologica. Struttura del corso (lezioni, esercitazioni, esami), libri di testo Gli effetti ambientali dell'agricoltura: risposte ambientali delle attività agricole, modelli numerici e concettuali, indici di rilascio potenziale, di vulnerabilità e di rischio, scala delle valutazioni, indicatori di stato dell'ambiente in Piemonte, modello DPSIR, esempi di impatto - 403 - ore 2 6 6 di agricoltura; tutela risorse idriche come problema centrale, legislazione ed impatto dell'agricoltura; il problema dei nitrati come esempio tipico di impatto Sistemi agricoli estensivi e pastorali: origine ed evoluzione. Relazioni con l'ambiente. Loro inserimento nel quadro delle produzioni biologiche e di quelle integrate. Analisi di casi. 4 Sistemi agricoli in ambienti aridi e tropicali e mediterranei. cenni sulla loro origine ed evoluzione. Relazioni con l'ambiente e gli stress. Loro inserimento nel quadro delle produzioni biologiche e di quelle integrate. Analisi di casi. 4 Sistemi agricoli intensivi in ambienti temperati: cenni sulla loro origine ed evoluzione. Relazioni con l'ambiente e la meccanizzazione. Allevamenti intensivi. Loro inserimento nel quadro delle produzioni biologiche e di quelle integrate. Analisi di casi. 8 2 8 Perdite gassose e protocolli internazionali : Ozono, inquinamento transfrontaliero, ciclo N ed emissioni gassose, ammoniaca genesi ed impatti, protocollo di Kyoto, tasso di CO2, 4 emissioni di CH4, Autorizzazione integrata ambientale : quadro normativo, soggetti coinvolti, input necessari, criteri adeguamento, autorizzazione, casi applicativi 4 2 Valutazioni ambientali associate all'uso degli agrofarmaci: riassunto sui fattori influenti, le fonti dati, esempi di impatto, tecniche agronomiche per la riduzione dell'impatto, cenni alla 4 modellistica relativa al destino dei principi attivi dei diserbanti La legislazione sulla qualità delle acque: inquadramento generale, codici di buona pratica agricola, riferimenti alle zone vulnerabili ai nitrati e fitofarmaci 6 La legislazione sui reflui zootecnici : inquadramento generale, esame delle seguenti leggi e regolamenti: direttiva nitrati, regolamento 9/R e 10/R Regione Piemonte 4 Sistemi agricoli in aree sensibili: sistemi agricoli conservativi o per la gestione di ambienti 4 protetti. Creazione e gestione di reti ecologiche. Biodiversity vision. Agricoltura e paesaggio. Stato del suolo e bilancio agronomico della sostanza organica: Riassunti dei fattori influenti sul suolo e applicazione di un semplice modello agronomico per il calcolo del bilancio della sostanza organica 2 2 Impatto delle misure agro-ambientali sui sistemi colturali, sulle filiere e sui mercati: interazione tra misure ambientali e aspetti di sicurezza alimentare, qualitativi e sanitari, cenni 6 sull'impatto organizzativo e gestionale sull'organizzazione delle filiere. Prospettive. 2 Totale 22 58 English Lectures Topics hours Practical work hours Introduction: The organization of the course. Books and supporting documents. Meaning and aims of the Environmental Agronomy. The national soil use and agriculture. Types of agriculture. 1 The PAC and its effects. Conventional and organic farming. Environmental effects of Agriculture: the environmental effects of agriculture, numerical and conceptual models, indicators, vulnerability and risk assessment, the scale of the evaluation, the situation in Piedmont, the DPSIR model, examples of impact in Piedmont Extensive agricultural systems and pastoral farming: origin and diffusion. Relationship with the - 404 - 5 5 Extensive agricultural systems and pastoral farming: origin and diffusion. Relationship with the environment. Role in the livestock organic and conventional production. Case analysis. Dryland, mediterranean and tropical farming: origin and diffusion. Relationship with the environment and the stress. Role in the food chain. Case analysis. Intensive agriculture in temperate regions: origin and diffusion. Relationship with the environment and the mechanization. Intensive livestock production. Case analysis. 4 Gaseous losses and international protocols: Ozone, transboundary pollution, the N cycle and N emission, N2O emissions, NH3 sources and impacts, the Kyoto protocol and 3 the greenhouse gasses production, CO2 concentration and trends, CH4 emission IPPC legislation : the legislation and the examples to big stocking farms, authorization process 4 2 Environmental legislation and the use of pesticides: the influencing driving forces, the available data, example of impacts, agronomical techniques to mitigate the impact, the simplified model 4 to predict the fate of some herbicides Legislation on the quality of surface and deep water : the evolution of the legislation, the codes of good agricultural practices, nitrate and pesticides vulnerable zones. 5 Legislation on animal manure: the modern problem of excessive manure production. The nitrate directive. The Italian and regional legislation. The effect on the environment and farm organization. 3 Agricultural systems in weak environments: conservation agriculture for the management of the protected areas. Ecological networks. Biodiversity vision. Agriculture and landscape. The quality of soil and organic matter content: agronomic driver forces influencing the C cycle; use of a simple agronomic model to predict the evolution of SOM. 2 2 58 22 Impact of the greening measures on crop systems, food and feed chains and on the markets: interaction among greening and food safety, security and quality; effects on the organization and management of the food chains. Outlook. Total TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Giardini L., 2000 Agronomia generale, ambientale e aziendale. 4a edizione, Patron Ed. Bologna. ARPA – Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Piemonte, 2010 (www.arpa.piemonte.it) Dal sito www.regione.piemonte.it/acqua/zone/index.htm - 405 - English Giardini L., 2000 Agronomia generale, ambientale e aziendale. 4a edizione, Patron Ed. Bologna. ARPA – Rapporto sullo stato dell'Ambiente in Piemonte, 2010 (www.arpa.piemonte.it) Dal sito www.regione.piemonte.it/acqua/zone/index.htm NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bt55 - 406 - Ecologia del verde urbano (Anno Accademico 2015/2016) STUDIO Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 65816 Docente: Dott. Federica LARCHER (Affidamento interno) Contatti docente: 0039 011 6708793, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 3 SSD attvità didattica: AGR/04 - orticoltura e floricoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il modulo intende fornire le conoscenze teoriche per l'analisi e la valutazione dei caratteri ecosistemici del verde urbano con particolare riferimento alle funzioni ambientali assolte dalla vegetazione in tali contesti. Attraverso il laboratorio, ed in sinergia con le componenti tecnologica e botanica, verranno quindi forniti gli strumenti per una progettazione e gestione degli spazi urbani in chiave ecologica e sostenibile. Servizi ecosistemici, biodiversità, urban ecology, smart cities saranno alcune delle parole chiave intorno alle quali si svilupperanno i contenuti del corso. Si farà uso di indicatori di stato e trasformazione per la valutazione della qualità ambientale del sistema verde urbano; si proporranno approcci ed usi innovativi degli spazi verdi e verranno proposti esempi significativi a livello nazionale ed internazionale. English The module aims to provide the theoretical knowledge for the analysis and evaluation of the character of urban green ecosystem with particular reference to environmental functions sorted by the vegetation in these contexts. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiranno le competenze per operare scelte progettuali in ambiente urbano nel rispetto dei valori ecologici e ambientali. Gli studenti potranno verificare attraverso l'esercizio progettuale anche metodi di valutazione ambientale del progetto stesso in linea con le più recenti richieste professionali. Obiettivi specifici per il lavoro progettuale Comprendere e descrivere le caratteristiche dell'ecosistema urbano in cui si inserisce l'area di studio Valutare la qualità di tale ecosistema ed individuarne criticità e valori - 407 - Prevedere interventi progettuali che ne limitino le criticità e ne esaltino i valori Dimostrare attraverso l'applicazione di indicatori opportunamente scelti che il progetto migliora la qualità ambientale del sito. English Students will acquire the skills to operate in urban planning choices in respect of the ecological and environmental issues. Students will also occur through the exercise design methods for environmental assessment of the project in line with the latest professional demands. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Elaborazione di un progetto e discussione orale English Design exercise and oral presentation Orale PROGRAMMA Italiano Principali argomenti trattati nelle lezioni teoriche Ecologia urbana ed Ecosistema urbano : principi, key words e definizioni Background culturale: i servizi ecosistemici Stato dell'arte nella ricerca La biodiversità urbana e le funzioni della vegetazione nell'ecosistema urbano Approcci di progettazione (dal minimo intervento all'uso delle tecnologie innovative) Principi di gestione (dall'agricoltura urbana agli habitat naturali) Esempi di approccio progettuale sostenibile in ambito nazionale e internazionale (Stati Uniti, Austria, Germania, Francia, Italia) Indicatori di valutazione della qualità dell'ecosistema urbano English Major topics covered in the lectures: - Urban Ecology and Urban Ecosystem: Principles, key words and definitions - Cultural background: the ecosystem services - State of the art in research - The urban biodiversity and the functions of vegetation in the urban ecosystem - 408 - - Design approaches (minimum intervention from the use of innovative technologies) - Principles of Management (from agriculture to urban habitats) - Examples of sustainable design approach at the national and international (United States, Austria, Germany, France, Italy) - Indicators for assessing the quality of the urban ecosystem TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Riferimenti bibliografici DINETTI M. 2009. BIODIVERSITA' URBANA. Conoscere e gestire habitat, piante e animali nelle città. TIPOGRAFIA BANDECCHI E VIVALDI – PONTEDERA GISOTTI G., 2007. AMBIENTE URBANO. Introduzione all'ecologia urbana. DARIO FLACCOVIO EDITORE – PALERMO DINETTI M., 2000. INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE. Manuale pratico per progettare e costruire le opere urbane ed extraurbane nel rispetto della conservazione della biodiversità. IL VERDE EDITORIALE-MILANO MILONE L., 2003. IL VERDE URBANO. Tra natura, arte, storia, tecnologia e architettura. LIGUORI EDITORENAPOLI MARZLUFF J.M. et al.,2008. URBAN ECOLOGY An international perspective on the interaction between humans and nature. SPRINGER- NY USA Serie di articoli scientifici e documenti pdf consegnati a lezione English DINETTI M. 2009. BIODIVERSITA' URBANA. Conoscere e gestire habitat, piante e animali nelle città. TIPOGRAFIA BANDECCHI E VIVALDI – PONTEDERA GISOTTI G., 2007. AMBIENTE URBANO. Introduzione all'ecologia urbana. DARIO FLACCOVIO EDITORE – PALERMO DINETTI M., 2000. INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE. Manuale pratico per progettare e costruire le opere urbane ed extraurbane nel rispetto della conservazione della biodiversità. IL VERDE EDITORIALE-MILANO MILONE L., 2003. IL VERDE URBANO. Tra natura, arte, storia, tecnologia e architettura. LIGUORI EDITORENAPOLI MARZLUFF J.M. et al.,2008. URBAN ECOLOGY An international perspective on the interaction between humans and nature. SPRINGER- NY USA Serie di articoli scientifici e documenti pdf consegnati a lezione NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8l7b - 409 - Ecologia forestale e selvicoltura (Anno Accademico 2015/2016) FOREST ECOLOGY AND SILVICULTURE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0063 Docente: Prof. Renzo MOTTA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705538, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/05 - assestamento forestale e selvicoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None Anche se non ci sono formali prerequisiti gli studenti devono avere acquisito i concetti e le principali conoscenze relative agli insegnamenti di Dendrometria, Botanica forestale e Diritto Amministrativo. PROPEDEUTICO A Tutti i corsi di carattere ecologico forestale del Corso di Laurea triennale e del Corso di Laurea magistrale OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti le conoscenze necessarie per 1) la comprensione delle leggi e dei processi ecologici che sono alla base delle dinamiche forestali e costituiscono il supporto teorico per le applicazioni selvicolturali; 2) la conoscenza di strutture e dinamiche dei popolamenti forestali naturali, semi-naturali e di origine artificiale e 3) la capacità di applicare le basi ecologiche e selvicolturali alla gestione sostenibile dei popolamenti forestali al fine di conservare e valorizzare i servizi ecostemici. English The course is aimed to provide knowledge and expertise 1) to understand the need for forest ecology as the foundation of silviculture and forest management; 2) for understanding structure and functions of natural seminatural and artificial forests and 3) to gain expertise in applying the main silvicultural systems used in Italy aimed to develop a sustainable forest management for a variety of commodity and non-commodity values. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà acquisire le conoscenze ecologiche di base che sono propedeutiche agli insegnamenti di carattere ecologico-forestale dell'intero Corso di Laurea; una conoscenza più approfondita degli argomenti pertinenti alla Ecologia forestale ed in particolare alle successioni ed alla dinamica forestale; la conoscenza dei metodi e dei parametri di descrizione dei popolamenti forestali, dei principi della selvicoltura, dei diversi sistemi selvicolturali e delle tecniche di governo e trattamento dei boschi. - 410 - English Students completing the course will have a basic understanding of forest ecology and silviculture principles in the context of natural resources management. They will be able to describe, analyse and compare forest stand structures and their present and potential silvicultural management and to analyse and compare different management approaches, with the principle of the sustainable forest management, in order to provide commodity and non-commodity values. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano L'insegnamento consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di laboratorio ed esercitazioni in bosco. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slides che sono a disposizione degli studenti. Le esercitazioni (due escursioni nel mese di maggio e le esercitazioni estive ad Ormea nel mese di giugno) sono una parte importante dell'insegnamento sia per quanto riguarda il completamento della didattica e sia per quanto riguarda la verifica dell'apprendimento. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory and field work. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. Field trips (two field trips in may and the final field trip to Ormea in June) are an important element of the course and will help visualize basic ecological and silvicultural concepts. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il livello di apprendimento raggiunto e la relativa capacità di comunicarlo sono costantemente monitorate attraverso domande e discussioni che sono propedeutiche all'inizio di ogni singola lezione. Un monitoraggio più accurato è effettuato al termine dei principali argomenti svolti e, infine, una revisione finale del livello di apprendimento è svolto durante le esercitazioni in classe ed in bosco che permetteranno di svolgere eventuali modifiche ed integrazioni dell'apprendimento prima dell'esame finale. Lo studente durante le esercitazioni di Ormea dovrà svolgere delle attività pratiche (in collegamento con l'insegnamento di Dendrometria) e preparare una relazione basata in parte su un lavoro di gruppo, svolto nel corso delle esercitazioni di Ormea, ed in parte su di un lavoro individuale. Questa relazione contribuisce anche all'area della comunicazione L'esame prevede una prova scritta ed un colloquio orale (a cui si accede solo se la prova scritta é stata valutata positivamente (>16/30). Nel test scritto ad ogni studente vengono sottoposte 24 domande (12 ecologia forestale e 12 selvicoltura, 50% a risposta chiusa e 50% a risposta aperta con penalizzazione per ogni domanda a risposta chiusa errata). Il colloquio orale, oltre alla discussione del test iniziale, prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. - 411 - English Level of learning acquired and student learning outcomes are constantly monitored at the beginning of each lecture and at the end of each main arguments through questioning students during to check their understanding of the material being taught and conducting periodic reviews (at the end of the main arguments of the course) with students to confirm their grasp of learning material and identify gaps in their knowledge and understanding. An additional role in this perspective is played by practical lessons and field excursions where student performances will be reviewed and used to make needed adjustments in instruction and lecture development. During the final excursion to Ormea the students, grouped in small working groups, will be provided with measurement equipments (in collaboration with Dendrometry). Each group will be asked to analyse forests stands and to mimic silvicultural tendings. At the end of the field work each student will have to write a report, including a small amount of individual work. This activity is also part of the learning area of comunication The final exam is a writen test followed by an oral exam. The student may support the oral after achieving a positive outcome (>16/30) of the test. The written test is based on 24 multiple choice (50%) and open questions (50%). There is a penalty for each multiple choice question wrong. The interview, in addition to the discussion of the initial test, involves the verification of the ability to reason and connection between the knowledge acquired. ATTIVITÀ DI SUPPORTO - Esercitazioni estive presso la sede di Ormea (Giugno 2015) - Laboratori ed esercitazioni in Aula (Modellistica forestale, dendroecologia) - Seminari tematici (Natura2000, Regolamento forestale regione Piemonte, Crediti di carbonio) PROGRAMMA Italiano L'insegnamento fa parte delle aree della conoscenza AMBIENTALE (Ecologia forestale) e SELVICOLTURALE (Selvicoltura generale). I principali argomenti affrontati sono i seguenti: Ecologia forestale Elementi di ecologia generale, fattori ecologici, biomi, montagne Clima, fattori climatici e rapporti tra vegetazione e clima Ecologia delle popolazioni, competizione Il ciclo del carbonio, cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto Successioni e dinamica forestale, disturbi naturali Stabilità, biodiversità Relazioni fauna-foresta Dendrocronologia e dendroecologia Selvicoltura generale Concetti generali e definizioni selvicolturali Descrizione dei popolamenti forestali (analisi struttura e composizione) Sistemi selvicolturali, governo e trattamento dei boschi Il governo ad alto fusto Il governo a ceduo ed il governo misto Conversione e trasformazione, selvicoltura d'albero, tagli colturali Competizione e modelli - 412 - Servizi ecosistemici, Aree protette, Natura 2000 Necromassa (CWD) e "retention" Arboricoltura e short-rotation forestry Regolamento forestale Regione Piemonte Crediti di carbonio Due escursioni giornaliere nel corso del mese di maggio Una escursione finale di tre giorni ad Ormea (CN) nel corso del mese di giugno English The course contributes to the fields of ENVIRONMENT (Forest ecology) and SILVICULTURE (Silviculture) Forest ecology Principles of ecology Climate and climate-vegetation relationships Populations and competitition Carbon cycle, climate change and Kyoto protocol Successione, forest dynamics and natural disturbances Stability and biodiversity Forest-wildlife relationships Dendrochronology and dendroecology Silviculture Introduction to the silviculture Forest structure and stand description Silvicultural systems High forests Coppices, mixed regeneration Conversion and transformations, single tree silviculture Competition, Models and their applications to forestry Ecosystem services, nature protection and Natura 2000 Coarse woody debris and retention Regional forest regulations Arboriculture, short rotation forestry Two one day excursion in May, one final excursion (three days) to Ormea (CN) in June. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Piussi P, Alberti G (eds) (2015) Selvicoltura generale. Boschi, società e tecniche colturali. Compagnia delle Foreste, Arezzo. Le diapositive ed altro materiale didattico fornito dal docente verrà caricato sul sito web dell'insegnamento (piattaforma Campusnet) English Piussi P, Alberti G (eds) (2015) Selvicoltura generale. Boschi, società e tecniche colturali. Compagnia delle Foreste, - 413 - Arezzo. Slides and other supplemental readings provided by the teachers will be made available at the course web site. NOTA Italiano Anche se non ci sono formali prerequisiti gli studenti devono avere acquisito i concetti e le principali conoscenze relative agli insegnamenti di Dendrometria, Botanica forestale e Diritto Amministrativo. Le esercitazioni prevedono l'utilizzo di strumenti dendrometrici e l'utilizzo di fogli di scrittura e fogli di calcolo (Abilità informatiche). Parte del materiale didattico è in inglese. Studenti con disabilità che impediscono la partecipazione alle esercitazioni in bosco devono contattare al più presto il docente. Studenti che non possono partecipare alle esercitazioni del mese di maggio e alle esercitazioni finali di Ormea nel mese di giugno devono contattare il docente il più presto possibile (non più tardi di tre mesi prima degli esami) per l'assegnamento di un programma alternativo. Le relazioni finali (sia quella di gruppo che quella individuale) devono essere consegnate almeno una settimana prima dell'esame. English Though there are no formal prerequisites, students should be familiar with the concepts and information in Dendrometry, Forest botany and Administrative Law. The field exercises will require basic knowledge of Dendrometry, and the use of wordprocessing and spreadsheets. Some of the documents provided by the teacher are in English. Students with documented disabilities that are able to attend the field excursions should make an appointment with the instructor as early as possible. Students that can't attend the field excursions should make an appointment with the instructor as early as possible (no later than three months before the exam) in order to arrange alternative testing. Group and individual Reports must be delivered to the teacher no later than a week before the exam. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rq7l - 414 - Ecologia, igiene e benessere degli animali in allevamento (Anno Accademico 2015/2016) ECOLOGY, HYGIENE AND WELFARE IN LIVESTOCK FARMING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0356 Docente: Prof. Luca Maria BATTAGLINI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708577, [email protected] Corso di studio: [f001-c502] LM - Scienze zootecniche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire elementi di conoscenza sull'ecologia e sull'ambiente di allevamento delle principali specie di interesse zootecnico, sulle principali pratiche igienico-sanitarie da adottare anche al fine di un minor impatto ambientale dell'attività zootecnica e sulle indicazioni per il rispetto del benessere degli animali da reddito. English Provide information on livestock ecology, hygiene and sanitation practices, environmental implication for reducing impact of livestock and indications for the respect of animal welfare. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano L'acquisizione di elementi di conoscenza sull'ambiente di allevamento delle specie di interesse zootecnico, sulle principali pratiche igienico-sanitarie e sulle indicazioni da considerare al fine di assicurare il benessere animale consentirà di applicare opportune tecniche d'allevamento al fine di ottenere produzioni di origine animale di qualità e con limitato impatto ambientale English Acquiring knowledge on : environment for livestock farming, basic hygiene and sanitation practices, indications to ensure animal welfare, for implementing appropriate farming techniques with the aim to reach quality of productions and a limited environmental impact. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 415 - Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Ad intervalli regolari e comunque opportuni in funzione della posizione nel programma svolto, nel corso delle lezioni e delle esercitazioni, verranno sviluppati momenti di richiamo alle nozioni somministrate al fine di collegare i diversi argomenti e far cogliere l'armonizzazione delle tematiche nello sviluppo del programma medesimo English At regular intervals and in appropriate positions of the program development, during lessons and the in field didactical activities, moments of recall of the given notions will be spent, in order to connect the different topics and to understand the harmonization of the issues in the development of the program itself. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del corso appartengono all'area di apprendimento di zootecnica e delle produzioni animali. Presentazione del corso: significato dell'ecologia, igiene e del benessere animale nelle attività zootecniche Ecologia zootecnica: il macro ed il microambiente di allevamento I fattori ambientali (terreno, aria, luce, umidità, temperatura). Parametri bioclimatici. Acqua e fabbisogni idrici. Gestione alimentare finalizzata al miglioramento del benessere animale Sostenibilità economica dell'azienda (IOFC ed Milk/feed ratio) Stima del bilancio azotato dell'allevamento Impatto ambientale degli allevamenti: metodi di valutazione e normative Fattori igienico sanitari influenzanti la produttività animale. Principali norme di igiene. Disinfezione e igiene dei ricoveri. Cenni su malattie parassitarie e disinfestazione. Impatto ambientale degli allevamenti: metodi di valutazione e normative. Generalità sull'etologia e sul benessere animale . Espressione del comportamento sociale, riproduttivo e alimentare. Benessere animale. Monitoraggio e metodi di stima, Cenni di legislazione italiana ed UE. Visite tecniche dimostrative in azienda. - 416 - Esame orale. English The topics discussed belong to the area learning of zootechnical and animal production. Presentation of the course: meaning of ecology, hygiene and animal welfare in livestock activities Animal ecology: the macro and the micro-environment Environmental factors (soil, air, light, humidity, temperature). Bioclimatic parameters. Water requirements. Dietary management aimed at improving animal welfare Economic sustainability company (IOFC and milk / feed ratio) Estimation of nitrogen balance Environmental impact of farming: evaluation methods and standards Factors influencing the hygiene and sanitary status. Parasitic diseases and pest control. Environmental impact of farming: evaluation methods and standards. Ethology. Expression of social behavior, reproductive and food. Animal welfare. Monitoring and estimation methods. Italian and EU legislation. Technical visits and trips. Oral test. Italiano Gli argomenti del corso appartengono all'area di apprendimento di zootecnica e delle produzioni animali. English The topics discussed belong to the area learning of zootechnical and animal production. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Montemurro N., 2002. Igiene Zootecnica: come favorire la salute e il benessere degli animali in allevamento, Edagricole. Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M., 2005. Tecniche di produzione animale, Liviana Scolastica. Napolitano F., De Rosa G., Grasso F., 2007. Comportamento e benessere degli animali in produzione zootecnica. Aracne Ed. Documenti di riferimento più mirato saranno consegnati direttamente dal docente sotto forma cartacea o messi a - 417 - disposizione sul sito Infine sono di seguito indicati siti internet di interesse: www.sozooalp.it (Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini pubblica i "Quaderni" Sozooalp) Centro di referenza per il benessere animale IZS Brescia http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp? idPagina=408 English Montemurro N., 2002. Igiene Zootecnica: come favorire la salute e il benessere degli animali in allevamento, Edagricole. Bittante G., Andrighetto I., Ramanzin M., 2005. Tecniche di produzione animale, Liviana Scolastica. Napolitano F., De Rosa G., Grasso F., 2007. Comportamento e benessere degli animali in produzione zootecnica. Aracne Ed. Reference documents more focused will be delivered directly by the teacher in the form printed or made available on the site. Websites of interest: www.sozooalp.it (Society for the study and development of livestock systems in Alpine region: "Quaderni" Sozooalp) Reference center for animal welfare IZS Brescia http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=408 NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k61t - 418 - Economia agraria e forestale - STA (Anno Accademico 2015/2016) AGRICULTURAL AND FOREST ECONOMICS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0323 Docente: Prof. Angela MOSSO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708633, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Pur non essendo previste propedeuticità, sono opportune le conoscenze acquisite nel corso di Isituzioni di Economia/ OBIETTIVI FORMATIVI Italiano L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire agli studenti la capacità di conoscere, comprendere e utilizzare i principi e gli strumenti della gestione aziendale, con particolare riferimento alle imprese del settore agricolo. English The course aims to give students the ability to learn, understand and use the principles and tools of business management, with particular reference to firms of the agricultural sector. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Al termine dellinsegnamento gli studenti saranno in grado di utilizzare gli strumenti operativi della gestione aziendale, di determinare i risultati di bilanci globali e parziali e di analizzare i relativi risultati. English At the end of the course, students will be able to use the operational tools of business management, to determine the results of global and partial budgets and analyze its results. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 419 - L'insegnamento è formato da 60 ore di lezione frontale e 20 ore di esercitazione in aula, principalmente dedicate allo studio di casi reali. Le lezioni frontali sono svolte con il parziale supporto di slide e nelle esercitazioni viene fornito il materiale oggetto di studio, messo anche a disposizione sul sito di campusnet. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours of classroom training, primarily dedicated to the study of real cases. The lectures are conducted with the partial support of slides and exercises comes with the material under study, which is also available on the website of campusnet. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Le esercitazioni serviranno anche per testare il grado di apprendimento raggiunto attraverso lavori di gruppo. Esse non danno origine a valutazione. L'esame finale consiste in un colloquio orale che inizia con una domanda su un argomento di ampio respiro corrispondente a quelli indicati nel programma. A questa seguono una - due domande più di dettaglio. L'obiettivo è di verificare la capacità di orientamento e collegamento e il livello di conoscenze specifiche. Il voto finale, espresso in trentesimi, tiene conto di tutte le risposte. English The exercises will also be used to test the level of learning achieved through group work. They do not give rise to evaluation. The final exam consists an oral exam that begins with a question on a topic broadly corresponding to those listed in the program. This was followed by one - two questions of detail. The objective is to verify the ability of orientation and connection and the level of specific knowledge. The final vote, out of thirty, takes into account all the answers. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati in questo insegnamento afferiscono all'area delle competenze economiche, gestionali e giuridiche Presentazione del corso e delle modalità di esame Ripasso dei concetti fondamentali di economia dell'impresa e collegamenti con il corso di Istituzioni di Economia. Classificazione delle imprese Le aree funzionali dell'impresa Analisi di gestione e relativi strumenti - 420 - Il bilancio economico Il bilancio contabile Il Business plan Costi di produzione Valore e prezzo di trasformazione Costo d'uso di un macchinario Costo del lavoro Capitale fondiario e modalità di acquisizione Capitale agrario e modalità di reperimento Lavoro e modalità di gestione Modalità di finanziamento delle imprese Il regime fiscale con particolare riferimento al settore agricolo Analisi degli investimenti Estimo generale: giudizio di stima, aspetti economici di un bene, metodo di stima La stima analitica di un fondo rustico Il Catasto dei terreni English Topics of this course concern to economic, management and juridical area Presentation of course and examination Revision of business economics basic concept and link with course of Institutes of Economics Firm classification Functional areas of firms Management analysis and its tools Balance sheet Accounting Business plan Production costs Transformation value and price Use cost of machinery Labour cost - 421 - Land capital and how to acquire it Exercise capital and how to acquire it Labour and its management Firm financing Tax regulation with particular reference to agricultural sector Investments analysis General appraisal: valutation trial, economic aspects of good, evaluation method Analytical evaluation of land property Register of landed property TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Iacoponi L.-Romiti R., Economia e Politica agraria, Edagricole , Bologna AAVV, Lezioni di Economia aziendale, Giappichelli editore, Torino Gallerani V-Zanni G.-Viaggi D.,Manuale di Estimo, McGraw-Hill. Milano English Iacoponi L.-Romiti R., Economia e Politica agraria, Edagricole , Bologna AAVV, Lezioni di Economia aziendale, Giappichelli editore, Torino Gallerani V-Zanni G.-Viaggi D.,Manuale di Estimo, McGraw-Hill. Milano NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=141p - 422 - Economia e gestione aziendale - TAL (Anno Accademico 2015/2016) ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0017 - TAL Docente: Simonetta MAZZARINO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708629, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Mista Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si proprone di fornire allo studente i meccanismi generali di funzionamento di un'economia di mercato, soffermandosi sugli strumenti utilizzabili per comprendere i punti di forza e di debolezza di un'impresa, valutabili anche attraverso l'esame di dati economici, patrimoniali e finanziari desumibili dal bilancio (imprese familiari, cantine sociali). English Main goals are to know and to understand the functioning of economic system and markets, how to account costs and revenues of a business and how to evaluate an investment. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Comprendere il significato e gli effetti delle decisioni di politica economica adottate dai governi. Comprendere la struttura dei costi di produzione di un'impresa. Interpretare i dati di un bilancio. Valutare i punti di forza e di debolezza delle imprese e del comparto vitivinicolo nazionale. English To make informed about economic policy choices and their effects; to understand the origin of costs for firms and farms and their proper accounting; to read the data in a balance; to assess the strengths and the weaknesses of a company in winemaking sector. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 423 - Italiano Il corso è organizzato in lezioni da tre ore nelle quali a concetti teorici si alternano esercitazioni numeriche. Ai fini di un migliore apprendimento si utilizza lo strumento Moodle, che permette di mettere a disposizione di ogni studente materiale didattico utilizzato a lezione, esercizi e la registrazione delle lezioni in formato MP3 English The course is organized into three hours classes, with theoretical concepts alternate to numerical exercises. Moodle is used to improve the learning, providing each student with materials used in class, exercises and recording of lectures in MP3 format MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame si articola in una prova scritta intermedia e un esame finale orale. Nel corso delle lezioni il docente verifica lo stato di apprendimento degli studenti attraverso domande mirate e test individuali, in modo da monitorare in itinere il grado di preparazione ed il livello di apprendimento raggiunto dalla classe. English The exam consists of a written interim and a final oral examination. During the lessons the teacher asks the students on different skills, even using individual tests, so she can suggest, if necessary, to read and study proper books. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano E' prevista a fine corso un'uscita didattica presso un'azienda vitivinicola dell'Albese (prov. di Cuneo), per verificare in campo le problematiche tecniche e gestionali affrontate durante le lezioni. English PROGRAMMA Italiano Macroeconomia I sistemi economici. Produzione, Consumo, Investimento. Il concetto di ammortamento. Modalità di funzionamento delle economie di mercato. I fattori della produzione. Il lavoro autonomo e dipendente. Il costo del lavoro per l'impresa. Patrimonio e reddito. Reddito degli operatori, tipi di reddito. Il prelievo fiscale in Italia. Il Bilancio dello Stato. Offerta aggregata e domanda aggregata. Produzione e consumo attraverso i dati di contabilità nazionale. Valori in termini nominali e reali. Il PIL e il suo utilizzo quale indicatore di sviluppo di un'economia. Il deflatore del PIL. Numeri indice. L'indice dei prezzi al consumo. Risparmio e investimenti. Il tasso di interesse, tassi nominali e reali. La moneta. L'inflazione e le sue possibili cause. La Bilancia dei Pagamenti e i rapporti di un'economia con il Resto del Mondo. Microeconomia L'imprenditore puro e l'obiettivo della massimizzazione del profitto. Le scelte dell'imprenditore puro su come, cosa e quanto produrre. La determinazione del profitto. Produttività totale, media e marginale in termini fisici ed economici. Ottimo impiego di un fattore variabile. Cenni sull'ottima combinazione di più fattori. Il costo di produzione in termini globali e unitari. L'ottima dimensione di produzione. Domanda e offerta collettiva o di mercato. L'elasticità - 424 - della domanda e dell'offerta. Forme di mercato e formazione del prezzo. Il controllo politico dei prezzi. Matematica finanziaria Posticipazione e anticipazione di valori monetari. Somma finanziaria. Reintegrazione e ammortamento finanziario. Media finanziaria. Organizzazione e gestione aziendale L'imprenditore concreto e i suoi apporti all'impresa. Forme giuridiche e organizzative delle imprese. L'imprenditore agricolo (art. 2135 C.C. e sue rivisitazioni). Modalità di finanziamento delle imprese in rapporto alla forma giuridica. Le imprese che caratterizzano il comparto enologico: imprese viticole, vitivinicole, le cantine sociali, le industrie enologiche. Logiche di azione. I capitali dell'azienda agraria e di quella agroindustriale. La contabilità e i principi contabili. Tipi di bilancio. Il bilancio economico della piccola impresa vitivinicola e sua interpretazione ex-post. L'uso dei bilanci preventivi nelle scelte ex ante di breve e di lungo periodo, con riferimento al settore enologico. I bilanci parziali di impiego nel settore enologico: costo di produzione, prezzo di trasformazione, costo unitario di impiego di una macchina (imbottigliatrice). Documenti fondamentali di un bilancio contabile consuntivo e loro lettura. Il bilancio della cantina cooperativa e interpretazione dei risultati a bilancio. Riclassificazione e indici di bilancio. English Macro e Microeconomics. Economic models, relations between economic agents. The economic circular flow. main macroeconomic indicators: GDO, GNP. Money and monetary policy. Inflation, nominal and real interest rates, GDP deflactor and IPC. The producer, the firm, the farm, inputs and profit maximization. Product function: average and marginal productivity; tecnically feasible combinations. Demand. Demand elasticity. Monopoly, types of monopoly, equilibrium. Other markets and their equilibrium. Public intervention against monopoly and oligopoly. Costs in long and short run. Financial Mathematics. Firm and farm management. Farm and firm organization models with regard to wine production. Functional areas of business. Main legal definitions about wine-making producers. Value chain in wine sector. Main stakeholders in winemaking. Main assets in the family farm and in agriindustrial companies. Operating revenue, costs, incomes. Farm and firm financing ways. Main issues about labour management. Accountancy, types of accounting and their use. Balance sheet, income statement. management control in wine-making processes. Costs accounting. Choises in short and long run. Producer choices evaluations. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Paul Krugman, Robin Wells, Kathryn Graddy, 2012, L'essenziale di economia, Zanichelli David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, 2010, Economia, McGraw-Hill Paul Samuelson, William Nordhaus, Carlo Andrea Bollino, Economia, 2014, McGraw-Hill Giovanni Fraquelli, Maria Teresa Carelli, Antonella Capriello, Elena Regazzi, 2010, Il bilancio per i manager, Casa Editrice Ambrosiana English Paul Krugman, Robin Wells, Kathryn Graddy, 2012, L'essenziale di economia, Zanichelli David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, 2010, Economia, McGraw-Hill - 425 - Paul Samuelson, William Nordhaus, Carlo Andrea Bollino, Economia, 2014, McGraw-Hill Giovanni Fraquelli, Maria Teresa Carelli, Antonella Capriello, Elena Regazzi, 2010, Il bilancio per i manager, Casa Editrice Ambrosiana NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dgq3 - 426 - Economia e gestione aziendale - VE (Anno Accademico 2015/2016) WINEMAKING FIRMS ECONOMICS AND MANAGEMENT Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0017 Docente: Simonetta MAZZARINO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708629, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A La seconda parte del corso, relativa all'organizzazione e gestione dell'azienda del comparto vitivinicolo, necessita di conoscenze tecniche sulla gestione agronomica del vigneto e sulle modalità di vinificazione e di affinamento utilizzate in cantina. Purtroppo la collocazione di questo corso al primo anno rende difficile la realizzazione di questa condizione. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si proprone di fornire allo studente i meccanismi generali di funzionamento di un'economia di mercato, soffermandosi sugli strumenti utilizzabili per comprendere i punti di forza e di debolezza di un'impresa, valutabili anche attraverso l'esame di dati economici, patrimoniali e finanziari desumibili dal bilancio (imprese familiari, cantine sociali). English Main goals are to know and to understand the functioning of economic system and markets, how to account costs and revenues of a business and how to evaluate an investment. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Comprendere il significato e gli effetti delle decisioni di politica economica adottate dai governi. Comprendere la struttura dei costi di produzione di un'impresa. Interpretare i dati di un bilancio. Valutare i punti di forza e di debolezza delle imprese e del comparto vitivinicolo nazionale. - 427 - English To make informed about economic policy choices and their effects; to understand the origin of costs for firms and farms and their proper accounting; to read the data in a balance; to assess the strengths and the weaknesses of a company in winemaking sector. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso è organizzato in lezioni da tre ore nelle quali a concetti teorici si alternano esercitazioni numeriche. Ai fini di un migliore apprendimento si utilizza lo strumento Moodle, che permette di mettere a disposizione di ogni studente materiale didattico utilizzato a lezione, esercizi e la registrazione delle lezioni in formato MP3 English The course is organized into three hours classes, with theoretical concepts alternate to numerical exercises. Moodle is used to improve the learning, providing each student with materials used in class, exercises and recording of lectures in MP3 format MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame si articola in una prova scritta intermedia e un esame finale orale. Nel corso delle lezioni il docente verifica lo stato di apprendimento degli studenti attraverso domande mirate e test individuali, in modo da monitorare in itinere il grado di preparazione ed il livello di apprendimento raggiunto dalla classe. English The exam consists of a written interim and a final oral examination. During the lessons the teacher asks the students on different skills, even using individual tests, so she can suggest, if necessary, to read and study proper books. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E' prevista a fine corso un'uscita didattica presso un'azienda vitivinicola dell'Albese (prov. di Cuneo), per verificare in campo le problematiche tecniche e gestionali affrontate durante le lezioni. PROGRAMMA Italiano Macroeconomia I sistemi economici. Produzione, Consumo, Investimento. Il concetto di ammortamento. Modalità di funzionamento delle economie di mercato. I fattori della produzione. Il lavoro autonomo e dipendente. Il costo del lavoro per l'impresa. Patrimonio e reddito. Reddito degli operatori, tipi di reddito. Il prelievo fiscale in Italia. Il Bilancio dello Stato. Offerta aggregata e domanda aggregata. Produzione e consumo attraverso i dati di contabilità nazionale. Valori in termini nominali e reali. Il PIL e il suo utilizzo quale indicatore di sviluppo di un'economia. Il deflatore del PIL. Numeri indice. L'indice dei prezzi al consumo. Risparmio e investimenti. Il tasso di interesse, tassi nominali e reali. La moneta. L'inflazione e le sue possibili cause. La Bilancia dei Pagamenti e i rapporti di un'economia con il Resto del Mondo. Microeconomia L'imprenditore puro e l'obiettivo della massimizzazione del profitto. Le scelte dell'imprenditore puro su come, cosa e quanto produrre. La determinazione del profitto. Produttività totale, media e marginale in termini fisici ed economici. Ottimo impiego di un fattore variabile. Cenni sull'ottima combinazione di più fattori. Il costo di produzione - 428 - in termini globali e unitari. L'ottima dimensione di produzione. Domanda e offerta collettiva o di mercato. L'elasticità della domanda e dell'offerta. Forme di mercato e formazione del prezzo. Il controllo politico dei prezzi. Matematica finanziaria Posticipazione e anticipazione di valori monetari. Somma finanziaria. Reintegrazione e ammortamento finanziario. Media finanziaria. Organizzazione e gestione aziendale L'imprenditore concreto e i suoi apporti all'impresa. Forme giuridiche e organizzative delle imprese. L'imprenditore agricolo (art. 2135 C.C. e sue rivisitazioni). Modalità di finanziamento delle imprese in rapporto alla forma giuridica. Le imprese che caratterizzano il comparto enologico: imprese viticole, vitivinicole, le cantine sociali, le industrie enologiche. Logiche di azione. I capitali dell'azienda agraria e di quella agroindustriale. La contabilità e i principi contabili. Tipi di bilancio. Il bilancio economico della piccola impresa vitivinicola e sua interpretazione ex-post. L'uso dei bilanci preventivi nelle scelte ex ante di breve e di lungo periodo, con riferimento al settore enologico. I bilanci parziali di impiego nel settore enologico: costo di produzione, prezzo di trasformazione, costo unitario di impiego di una macchina (imbottigliatrice). Documenti fondamentali di un bilancio contabile consuntivo e loro lettura. Il bilancio della cantina cooperativa e interpretazione dei risultati a bilancio. Riclassificazione e indici di bilancio. English Macro e Microeconomics. Economic models, relations between economic agents. The economic circular flow. main macroeconomic indicators: GDO, GNP. Money and monetary policy. Inflation, nominal and real interest rates, GDP deflactor and IPC. The producer, the firm, the farm, inputs and profit maximization. Product function: average and marginal productivity; tecnically feasible combinations. Demand. Demand elasticity. Monopoly, types of monopoly, equilibrium. Other markets and their equilibrium. Public intervention against monopoly and oligopoly. Costs in long and short run. Financial Mathematics. Firm and farm management. Farm and firm organization models with regard to wine production. Functional areas of business. Main legal definitions about wine-making producers. Value chain in wine sector. Main stakeholders in winemaking. Main assets in the family farm and in agriindustrial companies. Operating revenue, costs, incomes. Farm and firm financing ways. Main issues about labour management. Accountancy, types of accounting and their use. Balance sheet, income statement. management control in wine-making processes. Costs accounting. Choises in short and long run. Producer choices evaluations. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Paul Krugman, Robin Wells, Kathryn Graddy, 2012, L'essenziale di economia, Zanichelli David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, 2010, Economia, McGraw-Hill Paul Samuelson, William Nordhaus, Carlo Andrea Bollino, Economia, 2014, McGraw-Hill Giovanni Fraquelli, Maria Teresa Carelli, Antonella Capriello, Elena Regazzi, 2010, Il bilancio per i manager, Casa Editrice Ambrosiana English Paul Krugman, Robin Wells, Kathryn Graddy, 2012, L'essenziale di economia, Zanichelli - 429 - David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, 2010, Economia, McGraw-Hill Paul Samuelson, William Nordhaus, Carlo Andrea Bollino, Economia, 2014, McGraw-Hill Giovanni Fraquelli, Maria Teresa Carelli, Antonella Capriello, Elena Regazzi, 2010, Il bilancio per i manager, Casa Editrice Ambrosiana NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c2lm - 430 - Economia e politica agraria, alimentare e ambientale (Anno Accademico 2015/2016) AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0339 Docente: Dott. Teresina MANCUSO (Affidamento interno) Contatti docente: 116708724, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze di base: -delle politiche che riguardano l'agricoltura e il sistema agroindustriale: le politiche agricole, creditizie, fondiarie, ambientali e commerciali; -dei mercati delle produzioni agricole. English In the first part of the course we update the recent choices made at different level of government –at international, EU, national and regional level – about the agricultural and trade policies. In the second part, we study some subjects of economics, interesting the agricultural and food sector. In the third part we analyze the evolution of the European environmental policy. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente acquisisce le basi per analizzare e seguire lo sviluppo delle politiche riguardanti il sistema agricolo e agroindustriale e per valutare l'impatto economico che deriva dalla loro applicazione. English Students will be able to analyse the agricultural and trade policies at the international, european, national and regional level and to evaluate their economic impacts. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 431 - Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Circa a metà del corso è previsto di proporre in aula una serie di quesiti sulla parte del programma svolto, per permettere agli studenti e alla docente di valutare il processo di apprendimento. English An informal mid-term assessment either written or oral based on what has been presented in the course will be held to check the learning process. PROGRAMMA Italiano Area di apprendimento della produzione e gestione Parte I – Economia e Politica agraria e agro-industriale -Introduzione al corso. Ruolo dell'agricoltura e sua evoluzione nel tempo. I condizionamenti esterni alle scelte dell'imprenditore. Generalità sull'importanza degli interventi di politica agraria e sul loro evolversi nel tempo. -La Comunità Europea, i suoi successivi ampliamenti e le relative problematiche. Confronto strutturale tra i vari Paesi europei. Le Istituzioni della U.E. Il bilancio dell'U.E.: provenienza delle fonti ed impieghi tra i diversi settori (agricoltura, industria, ricerca, coesione, etc.). Fondi strutturali e fondi per l'agricoltura: FESR, FSE, FEASR, FEAGA. -La politica agricola comune (PAC). La politica dei prezzi e delle strutture. La revisione della politica agricola comunitaria attraverso le riforme: gli obiettivi, gli strumenti. La politica di sviluppo rurale. La PAC 2014-2020: pagamenti diretti, PSR Regione Piemonte, OCM unica. -La figura dell'imprenditore agricolo. Le forme giuridiche delle imprese. Il Credito agrario. - Il coordinamento degli operatori nelle filiere agroalimentari: Organizzazioni di Produttori, cooperative agroalimentari, contratti quadro, intese di filiera, distretti, contratti di rete. -Certificazioni di qualità dei prodotti agricoli (DOP, IGP, biologico, etc.), etico; ottenimento e uso di marchi privati e collettivi. Responsabilità sociale di impresa. -Beni pubblici, politiche fondiarie, consumo di suolo, land grabbing, water grabbing. -La cooperazione allo sviluppo in campo agricolo. Parte II – I mercati delle produzioni agricole -I mercati delle commodities agricole e le filiere agroindustriali: produzioni, consumi, stock, borse merci, contratti, prezzi. -Gli accordi sul commercio internazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari: WTO, accordi multilaterali, plurilaterali, bilateriali. Gli strumenti della politica commerciale: barriere tariffarie e non. Parte III – Le politiche agro-ambientali -L'evoluzione della politica agro-ambientale comunitaria, cenni. - 432 - -Bilancio ambientale e certificazioni ISO e EMAS. -Aspetti economici della tutela di risorse naturali: esempi. Esercitazioni -Analisi benefici-costi in ottica di collettività e per l'impresa privata. English Part I- Agricultural and food economics and policy -Introduction. Role of agriculture and its evolution in the time. Choices of farmers and external pressures. Importance of agricultural policy and its evolution. -Economic European Community (European Union, EU) history (1950-2014). Structural comparison among European Countries. EU Institutions. Annual EU budget resources and payments for heading (agriculture, citizenship, research, etc.). European Union Funds 2014-2020: the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Agricultural Fund for Direct Payments. -The Common Agricultural Policy (CAP). Reform of the CAP: evolution of objectives and tools. EU rural development policy. The Common Organisation of the Markets for several agricultural products, brief introduction. CAP 20142020: direct payments, Regional Development Rural Programme (Piedmont Region), Common Organisation of the single market. -Legal status of farmer; types of legal status of companies in Italy. Agricultural financing tools. -Coordination of agents in the agri-food supply chains. Agricultural cooperatives, Producer Organisations, Contract agreements, agricultural districts, companies network. - Food quality certification schemes for agricultural products quality (geographical indication, organic, etc.), ethic standards, trade marks. Social responsibility of farms. - Common goods, land policy, soil consumption, land grabbing, water grabbing. -Development cooperation: development indexes, relationship between Italy and LDC. Part II - Market of agricultural products Commodities markets and the agribusiness supply chains: productions, consumptions, stock, commodity exchanges, contracts, prices. International agriculture and food trade: negotiations and multilateral/bilateral agreements; WTO. Part III – Environmental policy Some environmental aspects of EU agricultural policy and its evolution. Balance sheet for green company activities and types of International schemes. Training activities Feasibility study. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA - 433 - Italiano -Vieri S., Politica agraria comunitaria, nazionale, regionale, Edagricole, Bologna, 2001. - Krugman P. R.- Obstfeld M. Economia internazionale. -Il sistema agroalimentare in Italia (2009), di Fanfani R., Edagricole. -Oskam, EU policy for agriculture, food and rural areas. Wageningen Academic Publisher, 2010. -Diapositive. -Articoli selezionati e proposti in aula. English -Vieri S., Politica agraria comunitaria, nazionale, regionale, Edagricole, Bologna, 2001. -Krugman P. R.- Obstfeld M. Economia internazionale. -Il sistema agroalimentare in Italia (2009), di Fanfani R., Edagricole. -Oskam, EU policy for agriculture, food and rural areas. Wageningen Academic Publisher, 2010. - Slides and selected references will be supplied to students. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f4e4 - 434 - Economia e politica agroalimentare (Anno Accademico 2015/2016) AGRI-FOOD ECONOMY AND POLICY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0347 Docente: Dott. Teresina MANCUSO (Affidamento interno) Contatti docente: 116708724, [email protected] Corso di studio: [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Scopo del corso è di svolgere le opportune valutazioni economiche di problemi complessi riguardanti il settore alimentare e di individuare soluzioni sostenibili e praticabili nei diversi contesti in cui si trova ad operare il tecnologo alimentare. English The aim of this course is to develop economic evaluations of different aspect of problems related to the food sector and identifying sustainable solutions in different working contexts. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione di conoscenze, padronanza di strumenti di analisi e di tecniche di gestione per comprendere i fenomeni attinenti al settore alimentare che avvengono in una economia globale; delineare e attuare politiche alimentari; individuare soluzioni economicamente sostenibili per imprese, istituzioni e associazioni. English Students will be able to use analysis tools and management techniques to understand main facts related to food sector; outline and implement food policies in a global economic context; identify sustainable solutions for companies, authorites and associations. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 435 - Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Circa a metà del corso è previsto di proporre in aula una serie di quesiti sulla parte del programma svolto, per permettere agli studenti e alla docente di valutare il processo di apprendimento. English An informal mid-term assessment either written or oral based on what has been presented in the course will be held, to check the learning process. PROGRAMMA Italiano Area di apprendimento: Economia e Marketing Lezioni -Gli operatori e i dati fondamentali nel settore alimentare, in Italia, in Unione Europea, nel mondo. -Politiche alimentari, agricole, commerciali applicate ai diversi livelli, comunitario, nazionale ed internazionale. La Politica Agricola Comunitaria. Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. Il quadro internazionale degli accordi internazionali che riguardano il comparto agroalimentare; percorsi di internazionalizzazione delle imprese agroalimentari e problematiche (deposito marchi, etc). -Le politiche di supporto al settore alimentare: finanziamenti pubblici e credito bancario, ricerca di base e applicata, competitività, innovazione tecnologica. Fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR). -Il coordinamento degli operatori nelle filiere agroalimentari, l'Associazionismo: Cooperative di produzione agroalimentare, di consumo alimentare. Le Organizzazioni di Produttori. Distretti agroalimentari e reti. -Consumi alimentari in Italia. -I mercati e i luoghi di contrattazione, i mercati a termine, le borse merci: produzioni, consumi, stock, contratti, prezzi. -Processi produttivi, programmi alimentari, sicurezza alimentare e valutazioni economiche: analisi dei costi e sostenibilità economica, studi di fattibilità, pianificazione a livello di impresa privata, di ente pubblico, di Istituzioni. Esercitazioni -Studio di casi sugli argomenti sviluppati a lezione: responsabilità sociale e ambientale di impresa; impatto economico e sociale di programmi di educazione alimentare a livello di Paese; valutazione del bilancio di approvvigionamento a livello di prodotto e di Paese. -Sviluppo di una idea progettuale originale attraverso la costruzione di un business plan, da presentare all'esame. English Learning subjects: Economics and Marketing - 436 - Lessons Lessons - Economic food sector, in Italy, in EU, in World: key data; - Food, agricultural and trade policies, applied at national, international and EU level; - European policies supporting food sector: financial system, research, competitiveness, innovation technology; - coordination of economic agents in food chains: cooperatives system, type of contracts in the Italian economic system; - institutional Funds and credit system to financing food sector; - food consumption in Italy; - commodities market, agribusiness chains: productions, consumptions, stock, commodity exchanges, contracts, prices; - production processes, food programs planning, food security and economic evaluations; costs analysis and sustainable processes, feasibility studies, planning food systems at community, regional, local levels. Training -Analysis of case studies of food sector. -Development of an original business plan (exam). TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano -Diapositive. Articoli selezionati e proposti in aula. -Economia del mercato agro-alimentare (2010), di Messori F. e Ferretti F., Edagricole, seconda edizione. -Il sistema agroalimentare in Italia (2009), di Fanfani R., Edagricole. -Oskam, EU policy for agriculture, food and rural areas. Wageningen Academic Publisher, 2010. English -Slides and selected references will be supplied to students. -Economia del mercato agro-alimentare (2010), di Messori F. e Ferretti F., Edagricole, seconda edizione. -Il sistema agroalimentare in Italia (2009), di Fanfani R., Edagricole. -Oskam, EU policy for agriculture, food and rural areas. Wageningen Academic Publisher, 2010. NOTA Italiano - 437 - English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w4ab - 438 - Economics of food safety and nutrition (Anno Accademico 2015/2016) Economics of food safety and nutrition Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0049 Docente: Prof. Antonio Stasi (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano English RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano English MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano - 439 - English PROGRAMMA Italiano English TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano English NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ee3b - 440 - Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Prof. Claudio LOVISOLO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708926, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti le cognizioni fondamentali sui processi che controllano la vita e la produzione delle piante dell'ambiente forestale. English To learn about the relationships between plant physiology and forest environment, upon both climate standards and abiotic limiting conditions. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti arrivano a fine corso a saper analizzare i meccanismi che permettono lo svolgersi dei principali processi fisiologici ed ecofisiologici delle piante in risposta agli stimoli ambientali dell'ambiente forestale. English The students will integrate the knowledge acquired both by following the course programme and by examining scientific literature. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO - 441 - Italiano Autovalutazioni anonime in itinere. English In-itinere anonymous self-assessments. scritto PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del programma appartengono all'area delle conoscenze propedeutiche e all'area della difesa delle foreste. Funzioni dell'acqua nella cellula e nella pianta; variazioni di potenziale idrico nel continuum suolo-pianta-atmosfera; psicrometro; camera a pressione trasporto xilematico; forze di tensione/coesione ed embolismi (danni e recupero); ruolo delle acquaporine; traspirazione fogliare. Cenni sulla sintesi proteica; cinetica enzimatica; potenziale elettro-chimico di un soluto - equazione di Nernst; permeabilità delle membrane; potenziale di membrana; trasporto passivo: diffusione semplice e facilatata; trasporto attivo primario; H+-ATPasi; trasporto attivo secondario (simporto, antiporto). Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura, fotosistemi, regolazione dell'organicazione del carbonio Lo spettro dell'energia solare; eccitazione dei pigmenti, riemissione di energia: dissipazione e trasferimento; assorbimento energetico della clorofilla; i fotosistemi del cloroplasto; schema Z della fotosintesi, trasporto di elettroni; trasporto transmembrana di H+ e sintesi dell'ATP nel cloroplasto; fotoinibizione, formazione de radicali liberi dell'H2O; confronto fotosintesi/respirazione per la sintesi di ATP; la RUBISCO; sintesi di amido primario nel cloroplasto; sintesi di saccarosio nel citosol; ripartizione del trioso-P tra cloroplasto e citosol; sintesi dell'amido secondario (amiloplasti). Elementi strutturali del floema: funzioni; floema: modello di flusso di massa da organi sorgenti a organi sink; caricamento floematico (simportatore di zuccheri); scaricamento floematico; ripartizione dei prodotti della fotosintesi, forza di un sink; effetti delle variazioni del rapporto sorgente/sink; transizione sorgente/sink. Regolazione della fotosintesi. Controllo ambientale dell'assorbimento della CO2: 1) regolazione stomatica; 2) competizione CO2/O2 per la Rubisco; 3) competizione tra la biosintesi di amido e quella del saccarosio; 4) allocazione dei fotosintati a differenti organi sink; 5) età delle foglie. Assimilazione carbonica: risposta alla luce e alla temperatura in foglie cresciute al sole ed all'ombra. English Water metabolism, xylem transport, transpiration Proteins, cell membrane metabolism Photosynthesis and regulation of carbon assimilation Phloem transport - 442 - Ecophysiology of water and nutrients in the whole plant Ecophysiology of light and CO2 in the whole plant TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net English Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zi3j - 443 - Elementi di fisiologia vegetale (Anno Accademico 2015/2016) PRINCIPLES OF PLANT PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0061 Docente: Phd. Francesca SECCHI (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire agli studenti le conoscenze necessarie sui processi che controllano la fisiologia e la produzione delle piante dell'ambiente forestale e in particolare sui meccanismi di adattamento delle piante in risposta a diversi stimoli ambientali. English The course will provide students with the knowledge necessary to understand the relationships between plant physiology and forest environment and the mechanisms of plant acclimation and adaptation to environmental conditions. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti arrivano a fine corso a saper analizzare i meccanismi che permettono lo svolgersi dei principali processi fisiologici ed ecofisiologici delle piante in risposta agli stimoli ambientali dell'ambiente forestale. English The students will integrate the knowledge acquired both by following the course programme and by examining scientific literature. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 444 - Italiano Il corso consiste di 20 ore di lezione frontale per le quali il docente si avvale di presentazioni e slides che saranno a disposizione degli studenti. English The course consists of 20 hours of lectures. The teacher makes use of presentations and slides that will be available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Autovalutazioni anonime in itinere. English In-itinere anonymous self-assessments. scritto PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del programma appartengono all'area delle conoscenze propedeutiche e all'area della difesa delle foreste. - Assorbimento, trasporto e assimilazione di sostanze minerali - Modificazioni di soluzioni nutritive per valutare gli effetti di elementi minerali; movimento dei soluti nel terreno; trasporto apoplastico e cellulare degli elementi minerali; funzioni del trasporto di membrana nell'assorbimento ionico di sost. minerali - Auxina: esperimenti di inizio '900 e risvolti funzionali; saggio biologico e radio-immunologico delle auxine; forma libera e forma coniugata (implicazioni su trasporto ed utilizzo); trasporto apolare (floematico) e polare (parenchimatico) ; effetti dell'auxina: allungamento di fusti e radici; auxine e fototropismo; auxine e gravitropismo in fusti e radici; effetti fisiologici dell'auxina: regolazione dominanza apicale, formazione radici secondarie, differenziamento vascolare; meccanismo d'azione dell'auxina a livello cellulare; effetti fisiologici delle gibberelline; effetti fisiologici delle citochinine; etilene; acido abscisico. - Aspetti ecofisiologici: risposta allo stress: Stress idrico. Meccanismi di difesa delle piante allo stress idrico. Ad alto potenziale idrico. A basso potenziale idrico. Risposta isodrica ed anisoidrica allo stress idrico. Ruolo del messaggio ormonale e chimico. Limitazioni alla crescita della piante ascrivibili a squilibri del potenziale idrico. Osmoregolazione. Stress e shock da calore. Stress da freddo. Stress da congelamento. Stress salino. - 445 - English - Assimilation and uptake of mineral nutrients - Plant hormones: Identification, biosynthesis and metabolism of auxin, transport, cell elongation, phototropism and gravitropism. Developmental effects of auxin. Physiological effects of Gibberellins, Cytokinins and Ethylene. Abscisic acid - Stress Physiology: Water stress and Drought tolerance Heat stress and Heat Shock Chilling and Freezing Salinity Stress TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano I testi base consigliati per il corso sono: Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net English Taiz, Zeiger. Elementi di Fisiologia vegetale. Piccin 2013 Rascio N., Elementi di fisiologia vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Siti internet di interesse: http://5e.plantphys.net - 446 - NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ofkp - 447 - Elementi di nutrizione umana (Anno Accademico 2015/2016) ELEMENTS OF HUMAN NUTRITION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: SAF0013 Docente: Prof. Paolo SIMONETTI (Affidamento interno) Contatti docente: 02 503 16724, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente le conoscenze necessarie per conoscere: - i processi di digestione e assorbimento dei nutrienti; - la funzione dei macro e micro nutrienti nell'organismo umano; - il ruolo dell'etanolo e dei composti bioattivi della dieta sullo stato di salute; - le caratteristiche nutrizionali degli alimenti in relazione alle esigenze del consumatore. English The course will provide students with the knowledge necessary to understand: - the processes of digestion and absorption of nutrients; - the functions of macro and micronutrients in the human body; - the role of ethanol and bioactive compounds in the diet; - the nutritional properties of food in relation to the needs of the consumer. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente al termine del corso dovrà possedere una conoscenza di base: - della composizione corporea e della fisiologia del sistema digestivo; - 448 - - dei principi nutritivi (proteine, lipidi, carboidrati, fibra, minerali e vitamine), dell'etanolo, dei composti bioattivi e del loro ruolo sullo stato di salute; - del fabbisogno energetico e delle esigenze nutrizionali di diverse fasce di popolazione; - della composizione in nutrienti e composti di interesse nutrizionale degli alimenti e bevande della dieta della popolazione italiana. English Students completing the course will have a basic knowledge of: - body composition and physiology of the digestive system; - nutrients (proteins, lipids, carbohydrates, fiber, minerals and vitamins), ethanol, bioactive compounds and their role on health status; - energy requirements and nutritional needs of different groups of the population; - composition (nutrients and bioactive compounds) of foods and drinks of the diet of the Italian population. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 40 ore di lezione frontale. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 40 hours of lectures. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'apprendimento verrà verificato con periodiche discussioni sugli argomenti proposti. L'esame finale consiste in una discussione generale orale sugli argomenti trattati durante il corso supportata dalla presentazione di una relazione riguardante un argomento dettagliato, a scelta dello studente, e concordato con il docente. English The student learning will be evaluated by periodical discussions about the lecture subjects. The final exam consists of an oral test supported by a presentation of a report regarding a detailed topic, chosen by the student and agreed by the professor. PROGRAMMA Italiano Sulla base di quanto previsto nella scheda SUA (Quadro A4.b) il programma del corso si sviluppa nell'ambito Economia, marketing, cultura enologica. - La composizione del corpo umano: indice di massa corporea, massa corporea lipidica e alipidica (2ore) - Caratteristiche anatomiche e fisiologiche dell'apparato digerente: bocca, stomaco, intestino tenue e crasso, - 449 - pancreas e fegato (3ore) - Meccanismi di digestione ed assorbimento delle proteine, dei carboidrati e dei lipidi (4ore) - Il metabolismo energetico: metabolismo basale, termogenesi indotta dagli alimenti, termogenesi per attività fisica, cenni sui metodi di valutazione del dispendio energetico (3ore) - L'acqua e le sue funzioni: bilancio idrico, osmolalità ed equilibrio acido-base (2ore) - Ruolo nutrizionale delle proteine: proteine alimentari, azoto non proteico (2ore) - Ruolo nutrizionale dei lipidi: lipidi alimentari, colesterolo, catabolismo e sintesi degli acidi grassi, lipoproteine, omega3 e omega6 (2ore) - Ruolo nutrizionale dei carboidrati: carboidrati semplici e complessi, indice glicemico, fruttosio, glicogeno (2ore) - Relazioni metaboliche tra glucidi, proteine e lipidi (2ore) - Caratteristiche chimico-fisiche e ruolo nutrizionale della fibra (2ore) - Caratteristiche e ruolo nutrizionale di vitamine e minerali (2ore) - Assorbimento e metabolismo dell'etanolo (2ore) - I composti bioattivi presenti nella dieta (4ore) &n bsp; - Caratteristiche nutrizionali degli alimenti e loro impiego in una dieta equilibrata (4ore) - Ruolo delle bevande alcoliche sullo stato di salute (4ore) English The class focuses on subject that are configured in the learning context of Processing technologies wine Economics, marketing, wine culture. - Body composition: body mass index, fat and fat-free mass (2hours) - Anatomy and physiology of the digestive tract: mouth, stomach, small intestine and large intestine, pancreas and liver (3hours) - Mechanisms of digestion and absorption of proteins, carbohydrates and lipids (4hours) - Energy metabolism: basal metabolic rate, diet induced thermogenesis, exercise-associated thermogenesis and methods for assessing energy expenditure (3hours) - Water and its functions: water balance, osmolality and acid-base balance (2hours) - Nutritional role of proteins: food proteins, non-protein nitrogen (2hours) - Nutritional role of lipids: dietary lipids, cholesterol, catabolism and synthesis of fatty acids, lipoproteins, omega3 and omega6 (2hours) - Nutritional role of carbohydrates: simple and complex carbohydrates, blood glucose and glycemic index, fructose, glycogen (2hours) - Metabolic relations between carbohydrates, proteins and lipids (2hours) - Physical and chemical characteristics and nutritional role of fiber (2hours) - 450 - - Nutritional role of vitamins and minerals (2hours) - Absorption and metabolism of ethanol (2hours) - The bioactive compounds of the diet (4hours) - Nutritional characteristics of foods and their significance in a balanced diet (4hours) - Role of alcohol from different beverages on health (4hours) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Gerard J. Tortora, Brian Derrickson – Principi di Anatomia e Fisiologia – Casa Editrice Ambrosiana. (Milano), 2011 - Aldo Mariani Costantini, Carlo Cannella, Gianni Tomassi - Alimentazione e nutrizione umana Seconda edizione, Il Pensiero Scientifico Editore, Novembre 2006 English - Gerard J. Tortora, Brian Derrickson – Principi di Anatomia e Fisiologia – Casa Editrice Ambrosiana. (Milano), 2011 - Aldo Mariani Costantini, Carlo Cannella, Gianni Tomassi - Alimentazione e nutrizione umana Seconda edizione, Il Pensiero Scientifico Editore, Novembre 2006 NOTA Italiano Il corso si svolge a Milano English The location of the course is Milan Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rhzk - 451 - Enography (Anno Accademico 2015/2016) ENOGRAPHY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0613 Docente: Prof. Vincenzo GERBI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708552, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Lo studente deve acquisire un metodo di studio delle caratteristiche chimiche ed organolettiche dei vini, nazionali ed internazionali, esaminando le le loro condizioni produttive viticole, i metodi di vinificazione, la storia e la loro diffusione. English The student must acquire a method of study of chemical and organoleptic characteristics of wines, italian and international, evaluating the conditions of the viticulture in the country of productiion, the wine-making techniques utilizzate , the history and the diffusion in the world of the studied wines. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti approfondiscono le loro capacità di descrizione sensoriale dei vini e la loro abilità nel trovare informazioni scientifiche sull'origine geografica, sui caratteri ampelografici del/dei vitigni utilizzati, e sulle possibili tecnologie di produzione. English The students gain insight into their skills in sensory description of wines and their ability to find scientific information on the geographical origin, on ampelographic characteristics of the grape/ grapes used, and the possible production technologies. - 452 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Le lezioni si svolgono in una aula attrezzata per l'analisi sensoriale (una postazione per ciascun studente). Ciascuna lezione prende in esame i vini di una o più regioni (italiane o di altri Paesi vitivinicoli). Nella prima parte sono descritte le caratteristiche principali dei vitigni utilizzati, l'evoluzione della tecnica di produzione enologica, i principali contributi scientifici che ne hanno evidenziato i caratteri salienti. Nella seconda parte vengono sottoposte ad assaggi diverse tipologie dello stasso vino, quando possibile prodotti in diversi Paesi del mondo, evidenziando i caratteri che li distinguono. English Classes take place in a classroom equipped for sensory analysis (a position for each student). Each lesson examines the wines of one or more regions (Italian or other wine countries). The first part describes the main characteristics of the grape varieties used, the evolution of the technology of wine production, the main scientific contributions that have highlighted the salient features. In the second part the students taste different wines, produced with the same grapes in various parts of the world, highlighting the characters that allow their distinction. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine del corso a ciascun studente è assegnato il nome di un vino, sul quale dovrà svolgere una ricerca bibliografiaca sulle banche dati. Sulla base delle citazioni trovate lo studente preparerà una presentazione che verrà esposta in sede di esame orale. La valutazione sarà assegnata sulla base della capacità dimostrata di trovare lavori scientifici, comprenderne il contenuto, esporre con chiarezza il lavoro di ricerca svolto. English At the end of the course to each student is assigned the name of a wine, on which it will perform a literature search in databases. Based on the citation founded the student will prepare a presentation that will be exposed in the oral examination. The evaluation will be assigned on the basis of demonstrated capacity to find scientific papers, understand its contents, clarity and competence demonstrated during exposure. PROGRAMMA Italiano Il corso appartiene all'area delle conoscenze TECNOLOGIE DELLA TRASFORMAZIONE ENOLOGICA. Nella parte teorica di ciascuna lezione vengono trattatati: Richiami di Enologia, chimica enologica e microbiologia necessari alla comprensione del soggetto tratattato. Quindi sono descritti i fondamentali contributi scientifici utili alla conoscenza dei vini descritti, che possono essere così riassunti: enografia dei vini bianchi internazionali: Francia, Germania, Italia e nuovo mondo. enografia del vini rossi internazionali: Italia, francia Spagna, California, Australia, Nuova Zelanda. I vini autoctoni italiani Alcuni vini speciali nazionali e internazionali English The course belongs to the area of knowledge TECHNOLOGIES PROCESSING WINE. In the theoretical part of each - 453 - lesson they are treated: Recalls of Enology, oenological chemistry and microbiology necessary for an understanding of the subject. Then are described the fundamental scientific contributions useful to the knowledge of wines described, which can be summarized as follows: Enography white wines International: France, Germany, Italy and the New World. Enography of international red wines: Italy, Spain France, California, Australia, New Zealand. The native Italian wines Some special wines national and international. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano E' consigliato l'accesso alle banche dati English The access to data base of University of Turin is recommended NOTA Italiano Ilcorso si svolge nella sede di Asti English The location of the course is ASTI Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ju1m - 454 - Enologia (Anno Accademico 2015/2016) ENOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0098 Docente: Prof. Vincenzo GERBI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708552, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 3° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente le conoscenze necessarie a conoscere e controllare i processi raccolta delle uve, di vinificazione per la produzione delle principali tipologie di vino, di stabilizzazione, affinamento e econservazione dei vini. Lo studente dovrà inoltre acquisire gli elementi per valutare la sostenibilità dei processi di produzione dei vini, conoscere le possibilità di recupero e valorizzazione dei sottoprodotti, acquisire i principi di etica professionale necessari a svolgere la professione di enologo. English The course will provide students with the knowledge necessary to understand and control the processes of harvesting grapes, wine-making for the production of the main types of wine, stabilization, aging and econservazione wine. The student will also acquire the elements to assess the sustainability of production processes of wine, knowing the chances of recovery and valorization of by-products, to acquire the principles of professional ethics required to practice as a winemaker. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente al termine del corso dovrà possedere una perfetta capacità di collegamento tra le nozioni di chimica, biochimica, microbiologia e tecnologia necessarie per saper realizzare il controllo dei processi di vinificazione, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare e della legislazione vigente. Dei processi studiati lo studente dovrà essere capace di descrivere il bilancio di massa e stimare le necessità enrgetiche. Lo studente deve inoltre conoscere i parametri che consentono di definire la qualità, la sicurezza e il valore di dei principali prodotti enologici. - 455 - English Students completing the course will have a perfect ability to link between the knowledge of chemistry, biochemistry, microbiology and technology necessary to know how to achieve control of the winemaking process, while respecting the principles of food security and current legislation. About the processes studied, the student should be able to describe the mass balance and estimate energy needs. The student must also know the parameters that define the quality, safety and the level of value of the main wine-making products. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di laboratorio e visite il stabilimenti enologici. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and visits the wine establishments. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine della parte del programma dedicata allo studio dei processi di vinificazione il docente procederà ad una verifica dell'efficacia didattica, mediante la somministrazione di un test a risposte multiple, senza valore per la valutazione finale, ma utile allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale all'inizio del quale ad ogni studente viene sottoposto un test scritto di tre esercizi di calcolo riguardanti la determinazione di parametri per il controllo di processo di vinificazione, che sono stati trattati nel corso ed applicati durante esercitazioni. Lo studente potrà sostenere l'orale qualunque sia l'esito del test iniziale. Il colloquio orale, oltre alla discussione del test iniziale, prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. la valutazione finale terrà conto anche dell'esito del test iniziale prevedendo una penalizzazione di 2 punti per ciascuna domanda errata. English At the end of the part of the program devoted to the study of the processes of vinification, the teacher will proceed to a verification of the efficacy teaching, by administration of a multiple choice test, not valid for the final evaluation, but helpful to the student to estimate its degree learning. The final exam is an oral exam. At the beginning each student shall be given a written test three calculation exercises concerning the determination of parameters for the control of the winemaking process, which were covered in the course and applied during exercises. The student may support the oral in any case, even in case of negative outcome of the test. The interview, in addition to the discussion of the initial test, involves the verification of the ability to reason and connection between the knowledge acquired. The final evaluation will take into account the outcome of the initial test by providing a penalty of 2 points for each question wrong. PROGRAMMA Italiano - 456 - Il corso fa parte delle aree della conoscenza dell'ENOLOGIA e del CONTROLLO QUALITA' e prevede di acquisire preliminarmente informazioni sull'importanza del settore enologico italiano e sulla sua collocazione internazionale. Succesivamente vengono approfondite le conoscenze su: Composizione e caratteristiche del grappolo, valori ponderali delle diverse parti del grappolo, resa della produzione in mosto. Richiami sulla composizione del mosto: componenti in soluzione molecolare e ionica. Componenti dell'uva e loro importanza nella trasformazione enologica: esosi, pentosi , pectine. Loro importanza e destino nella trasformazione, acidi, sali minerali, sostanze azotate, aromi, componenti minori. La componente fenolica delle uve: natura, reazioni caratteristiche, classificazione. La fermentazione alcolica, reazione, bilancio, prodotti secondari.La gestione della fermentazione alcolica: lieviti autoctoni e selezionati, importanza della carica microbica e del monitoraggio del processo fermentativo. La fermentazione malo lattica, chimismo, bilancio chimico ed energetico, prodotti principali ed accessori aspetti gestionali, induzione ed inibizione. Parametri di controllo. Colture starter e loro impiego. Successivamente vengono applicate le conoscenze acquisite alla trattazione dei processi di vinificazione, stabilizzazione e conservazione dei vini: Il processo di vinificazione per macerazione carbonica: fenomeni chimico-fisici e biologici. Modalità di vinificazione. Caratteristiche dei vini, campo di applicabilità. Schematizzazione dei processi di vinificazione, individuazione delle operazioni unitarie. I fattori che influiscono sul miglioramento della qualità: vendemmia manuale e meccanica. Il bilancio di massa della vinificazione. Interpretazione degli indici di maturità tecnologica e fenolica delle uve- Prime fasi della vinificazione: vendemmia e locali di cantina. Diraspatura, movimentazione vinaccia, condizioni di macerazione. I recipienti di fermentazione, materiali, tecnologie, difetti. Principi e operazioni fondamentali della vinificazione in bianco. Correzione dei mosti: norme, pratiche, evoluzione. Considerazioni tecniche ed economiche sulle correzioni. Ossigeno e vino: aspetti teorici e pratici. Teorica e tecnica della microssigenazione. I recipienti di legno. Acidificazione e Disacidificazione dei vini. Stabilità tartarica dei vini. Trattamenti fisici e chimici di stabilizzazione dei vini. La filtrazione dei vini (principi e tecniche ortogonali e tangenziali). Alterazioni e difetti dei vini. I vini speciali con e senza spuma. Tecniche di riempimento e chiusura dei vini. Valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria enologica Criteri per la valutazione della sostenibilità ambientale dei processi di vinificazione Visita a fiera attrezzature enologiche e a tre stabilimenti o cantine. English The course forms part of the filed of knowledge of enology and wine quality control, and is provided a preliminary information on the importance of the Italian wine industry and international position. Subsequently are thorough knowledge of: • Composition and characteristics of the bunch, the weighting values of the different parts of the bunch and volumetric yield in must. • Review on the composition of the must: components in molecular and ionic solution. Components of grapes and their importance in the transformation of wine: hexoses, pentoses, pectins. Their importance in the transformation and fate, acids, mineral salts, nitrogenous substances, flavorings, minor components. • The phenolic component of the grapes: nature, typical reactions, classification. - 457 - • The alcoholic fermentation reaction, budget, secondary products . The management of the alcoholic fermentation: native yeasts and selected, and the importance of the microbial monitoring of the fermentation process. • The malolactic fermentation, chemistry, chemical and energy budget, major products and accessories management aspects, induction and inhibition. Control parameters. Starter cultures and their use. Then apply the acquired knowledge to the treatment of the vinification process, stabilization and conservation of wines: • The process of carbonic maceration vinification: chemical, physical and biological phenomena. How to winemaking.Characteristics of the wines, the applicability domain. • Outline of the vinification process, identification of unit operations. The factors that affect the improvement of the quality manual and mechanical harvesting. The mass balance of winemaking. • Interpretation of the indices of technological maturity of the grapes and phenolic-Early stages of winemaking: harvest and local winery. Stripping, handling pomace maceration conditions. • Containers of fermentation, materials, technologies, defects. Principles and fundamental operations of white vinification. Correction of musts: norms, practices and evolution. • Technical and economic considerations about the fixes. Oxygen and wine: theoretical and practical aspects. Theory and technique of micro-oxygenation. • The wooden containers. Acidification and deacidification of wines. Tartaric stability of wines. Physical and chemical treatments of stabilization of wines. The filtration of wines (principles and techniques orthogonal and tangential). • Alterations and defects of wines. • Special wines with and without foam. • Techniques for filling and closing of the wines. Valorisation of by-products of winemaking Appraised criteria for environmental sustainability processes of winemaking Visit to exhibition-making equipment and three factories and cellars. Visit to exibition of winemaking equipment and three cellars. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Ribéreau Gayon P. , Dubourdieu D., Donéche P., Lavaud A. -2007- Trattato di Enologia Vol. I e II. , Edagricole- Il sole24ore, Bologna. Articoli scientifici indicati dal docente e materiali didattico fornito dal docente verranno caricati a inizio corso sulla piattaforma moodle English Ribéreau-Gayon P., Glories Y., Maujean A., Dubourdieu D. -2006- Handbook of enology vol. I and II - John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, England. Scientific papers indicate by the teacher and materials provided by the teacher, at the beginning of the course will be loaded on the platform Moodle NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Alba - 458 - English The location of the course is Alba Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9yfe - 459 - Enologia in clima caldo-arido (Anno Accademico 2015/2016) ENOLOGY IN WARM AND DRY CLIMATE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0499 Docente: Dott. Sandra Pati (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano L'obiettivo del corso è fornire allo studente le conoscenze necessarie ad affrontare le problematiche enologiche relative alla vinificazione di uve provenienti da vigneti allevati in clima caldo-arido, con particolare attenzione all'utilizzo di tecnologie di vinificazione innovative. English The objective of the course is to provide students with the knowledge necessary to deal with issues relating to the enology in a warm and dry climate, particularly focusing on the use of innovative winemaking technologies. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti al termine del corso dovranno avere conoscenze e competenze nel settore dell'enologia applicata in ambiente caldo-arido, con particolare attenzione alle tecnologie innovative di vinificazione utili alla risoluzione delle relative problematiche enologiche. English Students will show knowledge and skills in enology in warm and dry climate, with particular attention to the innovative winemaking technologies which can be effective for the relative problem solving. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 460 - Il corso consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a visite di stabilimenti enologici. Per le lezioni frontali il docente si avvale di diapositive che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 30 hours of lectures and 10 hours devoted to visit the wine establishments. For lectures the teacher makes use of slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame finale è un colloquio orale della durata di circa 30 minuti durante il quale sono valutati il livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi dall'insegnamento, la capacità di collegamento tra le conoscenze acquisite, la chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio. English The final exam is an oral exam of about 30 min. The evaluation will take into account the achieved level of results expected from the course, the ability to connection between the knowledge acquired, the reporting clarity and the correct use of language. PROGRAMMA Italiano Richiami sulla maturità tecnologica, fenolica e aromantica delle uve Acidità e precipitazioni tartariche. Correzioni di acidità. Tecnologie a membrana. Gestione delle fermentazioni in clima caldo-arido. Tecnologia del freddo. Strategie tecnologiche per l'estrazione dei composti fenolici. Termovinificazione. English Review on technological, phenolic and aromatic maturities of grape Acidity and tartaric precipitations. Acidity corrections. Technologies on membrane. Management of fermentations for the enology in warm and dry climate. Cold technology. Technological strategies for the extraction of phenolic compounds. Thermovinification. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Ribéreau Gayon P. , Dubourdieu D., Donéche P., Lavaud A. -2007- Trattato di Enologia Vol. I e II. , Edagricole- Il sole24ore, Bologna. Articoli scientifici indicati dal docente. English - 461 - Ribéreau Gayon P. , Dubourdieu D., Donéche P., Lavaud A. -2007- Trattato di Enologia Vol. I e II. , Edagricole- Il sole24ore, Bologna. Scientific papers suggested by the teacher. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Foggia English The location of the course is Foggia Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7bz1 - 462 - Entomologia alimentare ed animali infestanti (Anno Accademico 2015/2016) PROTECTION OF FOODSTUFF BY PESTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0332 Docente: Dott. Marco PORPORATO (Affidamento interno) Contatti docente: (+39) 011 670 8584, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le conoscenze di biologia, etologia ed ecologia utili ad individuare e riconoscere, anche attraverso le tracce, le principali specie di acari, insetti e roditori dannosi alle derrate alimentari. Presentare, con riferimento alle diverse specie di animali, i diversi tipi di danno, diretto e indiretto, causati; fornire indicazioni sulle tecniche di monitoraggio e sulle strategie di difesa e lotta che consentono di preservare la qualità degli alimenti. English Educational objectives Provide knowledge of biology ethology and ecology useful to identify and recognize the tracks through the main species of mites, insects and rodents damaging foods to make with regard to different species of animals, different types of direct and indirect damage caused to provide guidance on technical monitoring and defence strategies and the fight to help preserve food quality. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione di una preparazione sufficiente per operare nel controllo di qualità di industrie alimentari, come tecnici o come verificatori delle buone condizioni igieniche delle derrate immagazzinate e delle industrie trasformatrici. English Learning outcomes Acquisition of an adequate training to operate in quality control of food industry as technicians or as verifier of good hygiene and stored product processing industries. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 463 - Italiano Il corso consiste di 50 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a esercitazioni in laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 50 hours of lectures and 10 hours dedicated to laboratory exercises. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento sarà eseguita durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche, nel corso delle quali gli studenti avranno occasione di maneggiare e riconoscere infestanti delle derrate, e con l'esame in una data di appello. English The learning process will be checked on the occasion of practical training, during which students will handle and recognize foodstuff pest preparations, and final examination. Scritto PROGRAMMA Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento: filiere e qualità delle materie prime. Concetto di derrata alimentare. Tipologie ed entità di danno provocate dall'attacco di animali. Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica. Insetti: morfologia, anatomia, sviluppo post-embrionale. Entomologia: Bio-etologia delle principali specie appartenenti agli ordini Dermaptera, Collembola, Thysanura, Psocoptera, Blattodea, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera. Acari: cenni di morfologia ed etologia delle specie. Muridae: morfologia ed etologia delle specie più preoccupanti. Difesa: prevenzione e monitoraggio per individuare e contrastare le infestazioni di parassiti animali. Lotta: mezzi fisici e mezzi chimici. Prove di riconoscimento, con l'impiego di chiavi dicotomiche semplificate, di insetti dannosi alle derrate. Esame di alimenti danneggiati. English The class focuses on subject that are configured in the learning context of quality control and safety of the raw - 464 - materials. Concept of foodstuff. Types and amount of damage resulted from attack by animals. International Code of Zoological Nomenclature. Insects: morphology, outline of anatomy and development. Entomology: Bio-ethology of the main species of the orders Dermaptera, Collembola, Thysanura, Psocoptera, Blattodea, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera. Mites: outline of morphology and ethology. Muridae: morphology and ethology of the species most worrisome. Defence: prevention and monitoring for detection and contrast of animal parasite infestations. Control: physical and chemical means. Practical recognition, with the use of simplified dichotomous keys, of harmful foodstuff insects. Examination of damaged food. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Süss L., Locatelli D.P. 2001- I parassiti delle derrate. Calderini Edagricole, Bologna. pp. 363. Süss L., Pezzato G. 2002 - Prevenzione delle infestazioni nelle industrie alimentari. Manuale per la progettazione e la manutenzione dei reparti e degli impianti. Chiriotti Editori, Pinerolo (TO). pp. 119. Trematerra P., Gentile P., 2008 - Gli infestanti in molini e pastifici e la loro gestione. Chiriotti Editori, Pinerolo. pp. 104. Trematerra P., Süss L. 2007 - Prontuario di entomologia merceologica e urbana. Con note morfologiche, biologiche e di gestione delle infestazioni. pp. 160. Domenichini G., 1996. Protezione degli alimenti. Contaminazione biologica e sanità ambientale nell'industria alimentare. Etas Libri. pp. 235 Ulteriori informazioni sono reperibili al sito: www.ministerosalute.it English Süss L., Locatelli D.P. 2001- I parassiti delle derrate. Calderini Edagricole, Bologna. pp. 363. Süss L., Pezzato G. 2002 - Prevenzione delle infestazioni nelle industrie alimentari. Manuale per la progettazione e la manutenzione dei reparti e degli impianti. Chiriotti Editori, Pinerolo (TO). pp. 119. Trematerra P., Gentile P., 2008 - Gli infestanti in molini e pastifici e la loro gestione. Chiriotti Editori, Pinerolo. pp. 104. Trematerra P., Süss L. 2007 - Prontuario di entomologia merceologica e urbana. Con note morfologiche, biologiche e di gestione delle infestazioni. pp. 160. Domenichini G., 1996. Protezione degli alimenti. Contaminazione biologica e sanità ambientale nell'industria - 465 - alimentare. Etas Libri. pp. 235 NOTA Italiano Gli studenti iscritti al corso devono registrarsi, in modo da poter essere inseriti nella mailing list, per ricevere informazioni e/o materiale didattico utili allo svolgimento del corso stesso. English Students enrolled at the course must be registered in such a way as to be included on time in the mailing list to receive information and/or teaching material useful for the progress of the course. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pbs3 - 466 - Entomologia della vite (Anno Accademico 2015/2016) GRAPEVINE ENTOMOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0071 Docente: Prof. Alberto ALMA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708534, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscenze di morfologia e di bio-etologia relative agli insetti e acari dannosi alla vite. Nozioni su insetti vettori di agenti fitopatogeni, con particolare riguardo per gli auchenorrinchi vettori di fitoplasmi. Applicazione di tecniche di diagnosi molecolare di fitoplasmi nei vettori e nella vite. Competenze sulle strategie di difesa e sui metodi alternativi all'uso dei prodotti chimici, quali lotta preventiva basata su principi ecologici, lotta naturale con ruolo di siepi e incolti, lotta biologica e lotta integrata attraverso l'azione di artropodi utili. English The aim is to provide knowledge of morphology and bio-ethology related to insects and mites harmful to grapevine. Notions of insect vectors of plant pathogens, particularly with regard to the Auchenorrhyncha vectors of phytoplasmas. Application of techniques of molecular diagnosis of phytoplasmas in vectors and in grapevine. Expertise on defense strategies and alternative methods to the use of chemicals, such as preventive control based on ecological principles, natural control with the role of hedges and uncultivated lands, biological control and integrated pest management through the action of beneficial arthropods. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti dovranno essere in grado di individuare e riconoscere i principali nemici della vite e le malattie trasmesse da alcuni insetti fitomizi. Applicare i saggi biologici e le tecniche molecolari di base per la diagnosi dei vettori. Impostare strategie di difesa, con particolare riguardo alle tecniche a basso impatto ambientale. English - 467 - Students should be able to identify and recognize the main pests of grapevine and the diseases transmitted by certain plant-sucking insects. They should be able to apply the biological assays and basic molecular techniques for the diagnosis of vectors and set up defense strategies, with particular emphasis on techniques with a low environmental impact. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate ad attività di laboratorio e in vigneto. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni PowerPoint che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory and vineyard activities. For the lectures, the teacher makes use of PowerPoint presentations that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine della parte generale e speciale del programma il docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica attraverso domande orali sui principali argomenti svolti, al fine di evidenziare gli eventuali problemi di apprendimento. Il colloquio non ha valore per la valutazione finale, ma è utile allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale con domande sulla parte generale, speciale e sulle attività di campo e di laboratorio svolte durante le esercitazioni. Il colloquio ha il fine di verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English When the general and special parts of the programme are completed, the teacher will conduct a test of the teaching efficacy through oral questions on the main arguments dealt with in order to highlight any learning problem. The interview has no value for the final evaluation, but it is helpful to the student to estimate the learning level. The final exam is an oral exam with questions on the general and special parts and on the field and laboratory activities carried out during the training. The interview aims to verify the capacity of reasoning and connecting the knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione, qualità delle uve e gestione dei vigneti. Presentazione del corso e modalità d'esame. Parte generale Morfologia e sviluppo postembrionale Ecologia, etologia e cicli biologici. Apparati boccali. Rapporti tra fitofagi, piante ospiti spontanee e vite. Processi di nutrizione. Fitopatie. Sintomatologia. Trasmissioni di agenti fitopatogeni quali, virus, fitoplasmi e batteri. Rapporti tra agenti patogeni e vettori. - 468 - Tecniche di diagnosi molecolare di fitoplasmi nei vettori. Cause che favoriscono le pullulazioni dei fitofagi. Campionamento delle popolazioni. Limitatori naturali ed equilibrio biologico. Metodi di lotta agronomici, fisici, chimici, biologici. Lotta integrata. Biotecnologie. Fitofagi di temuta introduzione. Parte speciale Acari: tetranichidi ed eriofidi. Insetti fitomizi: tisanotteri e rincoti eterotteri; rincoti omotteri auchenorrinchi (flatidi, cixiidi, aphrophoridi, cicadellidi), pseudococcidi,coccidi, diaspididi. Insetti fitofagi: microlepidotteri, cochilidi, tortricidi, geometridi, nottuidi; ditteri cecidomiidi; coleotteri scarabeidi, bostrichidi, cerambicidi, crisomelidi, curculionidi. Esercitazioni Campo: riconoscimento dei sintomi su vite e dei principali artropodi dell'agroecosistema vigneto. Laboratorio: esame del materiale raccolto in campo e osservazione di collezioni di artropodi fitofagi e zoofagi. Esame di modelli morfo-anatomici di insetti di interesse viticolo. Applicazione di tecniche molecolari per la diagnosi di insetti vettori. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of cultivation, grape quality and vineyard management. Presentation of the course and the examination. General Morphology and postembryonic development. Ecology, ethology and life histories. Mouthparts. Relations between pests, host plants and grapevine. Nutrition processes. Plant diseases. Symptoms. Transmissions of phytopathogenic agents, such as viruses, phytoplasmas, and bacteria. Relationships between pathogenin agents and vectors. Molecular diagnostic techniques of phytoplasmas in vectors. Causes that promote the proliferation of pests. Sampling of populations. Natural enemies and biological balance. Agronomic, physical, chemical, biological control methods. IPM. Biotechnologies. Pests of feared introduction. Special Acari: Tetranichidae and Eriophyidae. Plant-sucking insects: Tysanoptera and Hemiptera Heteroptera; Hemiptera Homoptera Auchenorrhyncha (Flatidae, Cixiidae, Aphrophoridae, Cicadellidae), Pseudococcidae, Coccidae, Diaspididae. Plant-eating insects: Microlepidoptera, Cochilidae, Tortricidae, Geometridae, Noctuidae; Diptera Cecidomyidae; Coleoptera Scarabaeidae, Bostrychidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae. Training Field: recognition of symptoms on grapevine and of the main arthropods of the vineyard agro-ecosystem. - 469 - Laboratory examination of material collected in the field and observations and collection of plant pest and predatory arthropods. Examination of morpho-anatomical models of insects of grapevine concern. Application of molecular techniques for the diagnosis of insect vectors. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Articoli scientifici e materiale didattico (presentazioni PowerPoint) fornito dal docente verranno caricati sulla piattaforma CampusNet. Tremblay E. (1985). Entomologia applicata. Vol. I Generalità e mezzi di controllo. Liguori, Napoli. Lucchi A. (2014) Note di Entomologia Viticola. Pisa, University Press. English Scientific papers and materials (PowerPoint presentations) provided by the teacher will be loaded on the platform CampusNet. The recommended basic texts for the course are: Tremblay E. (1985). Entomologia applicata. Vol. I Generalità e mezzi di controllo. Liguori, Napoli. Lucchi A. (2014) Note di Entomologia Viticola. Pisa, University Press. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Alba English The location of the course is Alba Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wief - 470 - Entomologia generale e applicata - SFA (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0324 Docente: Dott. Chiara FERRACINI (Affidamento interno) Contatti docente: 011/6708700, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Conoscenze di base sui principali insetti dannosi in campo forestale, sulla loro morfologia, anatomia, fisiologia, bioetologia e sulle problematiche indotte, nonché conoscenza dei mezzi e delle strategie di lotta a basso impatto ambientale, in ambiente di foresta, urbano, vivaio e arboreto da legno. English The aim is to provide basic knowledge of morphology, anatomy, physiology, bio-ethology and ecology of the main insects that attack plants in forestry, urban environment, nursery and wood plantations, and supply the ability to set up and develop control plans using the most appropriate strategies with low environmental impact. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano I fruitori del corso conseguiranno la capacità di gestire correttamente le principali problematiche legate alla presenza di insetti fitofagi in foresta e altre cenosi, in vivaio e arboreto da legno e in ambiente urbano, con riferimento sia a piante ornamentali sia a legno in opera, valutando l'opportunità e la tipologia di interventi di prevenzione e di contenimento. English Students should be able, through the skills provided by the course, to identify and recognize the main insects in forestry, nursery, wood plantations and in the urban environment, and to set up appropriate control strategies using all available techniques and exploiting the limiting action of beneficial arthropods in the full respect and protection - 471 - of the environment and of consumers. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate alle esercitazioni di laboratorio. English The course consists of lectures (60hrs) and laboratory activities (20 hrs). MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti sarà valutato di volta in volta nel corso delle esercitazioni pratiche. English Levels of learning acquired by the students will be evaluated regularly during practical lessons. PROGRAMMA Italiano Classe degli insetti: origine, caratteri generali e affinità con altri artropodi. Morfologia e anatomia degli insetti. Fisiologia. Sviluppo embrionale e post-embrionale. Cicli biologici. Dinamica di popolazione degli insetti in ambiente di foresta. Principali tecniche di campionamento. Relazione degli insetti forestali con altri organismi. Mezzi di lotta ai fitofagi e strategie di intervento eco-compatibili negli ambienti forestali. Predatori, parassiti e parassitoidi di fitofagi. Principali specie di insetti fitofagi di interesse forestale. Fauna e gestione delle foreste. Specie esotiche e di temuta introduzione. Aspetti entomologici negli arboreti da legno e nei vivai. Aspetti entomologici degli alberi ornamentali in ambiente urbano. Esercitazioni e uscite didattiche. - 472 - English Origin of insects, general features and affinity with other arthropods. Insects anatomy and morphology. Physiology and development. Life cycles. Population dynamics of insects in forestry. Sampling methods and techniques. Relationships of insects of the forest environment with other organisms. Insect pests management and ecologically sustainable plant protection measures in forest and urban environments. Predators, parasites and parasitoids of phytophagous pests. Characteristics of the main orders and families of insects and other invertebrates pests damaging forest, urban and nursery plants. Fauna and management of forests. Exotic and threatening species. Entomological aspects in nurseries and wood plantations. Entomological aspects of the ornamental plants in the urban environment. Practical lessons and didactical field trips. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni PowerPoint, dispense del corso e articoli per le letture critiche verranno caricati sulla piattaforma Campusnet. Fiori G., Bin F., Sensidoni A. (1983) – Atlante entomologico. Morfologia esterna. Galeno Editrice, Perugia. Masutti L., Zangheri S. (2001) - Entomologia generale e applicata. CEDAM, Padova. Pollini A. (1998) – Manuale di entomologia applicata: Edagricole, Bologna. Battisti A, De Battisti R, Faccoli M, Masutti L, Paolucci P, Stergulc F, (2013) - Lineamenti di zoologia forestale. Padova University Press, Padova, pp. 442. English PowerPoint presentations, lecture notes and articles on the subjects for critical reading will be provided on the Campusnet platform. Fiori G., Bin F., Sensidoni A. (1983) – Atlante entomologico. Morfologia esterna. Galeno Editrice, Perugia. Masutti L., Zangheri S. (2001) - Entomologia generale e applicata. CEDAM, Padova. Pollini A. (1998) – Manuale di entomologia applicata: Edagricole, Bologna. Battisti A, De Battisti R, Faccoli M, Masutti L, Paolucci P, Stergulc F, (2013) - Lineamenti di zoologia forestale. Padova University Press, Padova, pp. 442. NOTA - 473 - Italiano Esame orale English Oral examination Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g26g - 474 - Entomologia generale e applicata - STA (Anno Accademico 2015/2016) GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0324 Docente: Prof. Alberto ALMA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708534, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscenze di base di morfologia, anatomia, fisiologia, bio-etologia ed ecologia relative ai principali insetti che attaccano le piante coltivate e utili (predatori, parassitoidi, impollinatori). Capacità di riconoscimento delle specie dannose più comuni e delle alterazioni da queste provocate nei vegetali e di accertare i livelli di infestazione attraverso campionamenti diretti e/o indiretti. Capacità di impostare e sviluppare piani di difesa utilizzando le strategie più opportune e nel rispetto della normativa vigente. English The aim is to provide basic knowledge of morphology, anatomy, physiology, bio-ethology and ecology of the main insects that attack crops and beneficial insects (predators, parasitoids, pollinators). Supply the ability to recognize the most common pests and alterations caused by them in plants and to assess infestation levels through direct and/or indirect sampling. Supply the ability to set up and develop defense plans using the most appropriate strategies and in accordance with local regulations. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti dovranno essere in grado, attraverso le competenze fornite dal corso, di individuare e riconoscere i principali insetti di interesse agrario, accertarne la densità di popolazione e quindi la dannosità. Impostare adeguate strategie di difesa utilizzando tutte le tecniche disponibili e sfruttando l'azione limitatrice degli artropodi utili nel pieno rispetto e salvaguardia dell'ambiente e dei consumatori. English - 475 - Students should be able, through the skills provided by the course, to identify and recognize the main insects of agricultural interest, determine their population density and therefore their harmfulness. Set up appropriate defense strategies using all available techniques and exploiting the limiting action of beneficial arthropods in the full respect and protection of the environment and of consumers. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate ad attività di laboratorio e in campo. A fine corso sarà effettuata una uscita didattica in aziende frutticole piemontesi. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni PowerPoint che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory and field activities. At the end of the course there will be an educational trip to fruit farms in Piedmont. For the lectures, the teacher makes use of PowerPoint presentations that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine della parte generale e speciale del programma il docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica attraverso domande orali sui principali argomenti svolti, al fine di evidenziare gli eventuali problemi di apprendimento. Il colloquio non ha valore per la valutazione finale, ma è utile allo studente per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale con domande sulla parte generale, speciale e sulle attività di campo e di laboratorio svolte durante le esercitazioni. Il colloquio ha il fine di verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English When the general and special parts of the programme are completed, the teacher will conduct a test of the teaching efficacy through oral questions on the main arguments dealt with in order to highlight any learning problem. The interview has no value for the final evaluation, but it is helpful to the student to estimate the learning level. The final exam is an oral exam with questions on the general and special parts and on the field and laboratory activities carried out during the training. The interview aims to verify the capacity of reasoning and connecting the knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della difesa. Presentazione del corso e modalità d'esame GENERALE Gli insetti: origine e affinità con altri artropodi Sistema tegumentale e colori. - 476 - Morfologia esterna. Capo, antenne, apparato boccale; torace, zampe, ali; addome, appendici dell'addome. Morfologia interna: sistema muscolare, nervoso, digerente, respiratorio, circolatorio, escretore, secretore, riproduttore. Riproduzione, uova e ootassi. Sviluppo embrionale e postembrionale. Mute, metamorfosi, stadi preimmaginali, adulto. Ecologia degli insetti. Fattori abiotici. Fattori trofici. Regimi alimentari e specializzazioni, sintomatologia. Vettori di agenti fitopatogeni, interazioni patogeno-vettore-pianta. Diffusione delle specie e dinamica delle popolazioni. Gli insetti esotici. Gli insetti utili: impollinatori e limitatori naturali (predatori e parassitoidi). Metodi e tecniche di campionamento. Mezzi e metodi di controllo degli insetti. Mezzi preventivi, agronomici o colturali, meccanici, fisici. Mezzi chimici. La legislazione italiana sui prodotti fitosanitari e sulla lotta contro gli insetti dannosi. Il controllo integrato nell'ambiente agrario. Lotta biologica. Biotecniche. SPECIALE La classificazione degli insetti. Ordini di insetti apterigoti, esopterigoti ed endopterigoti. Principali famiglie di interesse agrario. Bio-etologia di specie (casi studio), indigene ed esotiche, infestanti le colture erbacee e arboree, le derrate, gli animali di interesse agrario. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of plant protection. Presentation of the course and examination procedures GENERAL Insects: origins and affinities with other arthropods. Integument system and colours. External morphology. Head, antennae, mouth parts, thorax, legs, wings, abdomen, abdominal appendages. Internal morphology: muscular , nervous, digestive, respiratory, circulatory, excretory, secretory, and reproductive system. Reproduction, eggs and ootaxis. Embryonic and postembryonic development. Moults, metamorphosis, preimaginal stages, adult. Ecology of insects. Abiotic factors. Trophic factors. Diets, specializations, symptoms. Vectors of phytopathogenic agents, vector-pathogen-plant interactions. Spread of species and population dynamics. Exotic insects. Useful insects: pollinators and natural enemies (predators and parasitoids). - 477 - Sampling methods and techniques. Means and methods of controlling insects. Preventive means, agronomic or cultural, mechanical, physical. Chemical means. Italian legislation on plant protection products and on the control of harmful insects. Integrated pest management in agriculture. Biological control. Biotechniques. ADVANCED The classification of insects. Orders of Apterygota, Exopterygota, and Endopterygota. Main families of agricultural interest. Bio-ethology of the species (study cases), native and exotic, infesting tree and herbaceous crops, foodstuffs, animals of agricultural interest. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Articoli scientifici e materiale didattico (presentazioni PowerPoint) fornito dal docente verranno caricati sulla piattaforma CampusNet. Fiori G., Bin F., Sensidoni A. (1983) – Atlante entomologico. Morfologia esterna. Galeno Editrice, Perugia. Masutti L., Zangheri S. (2001) - Entomologia generale e applicata. CEDAM, Padova. Pollini A. (1998) – Manuale di entomologia applicata: Edagricole, Bologna. Tremblay E. (1981, 1985, 1986, 1991, 1994, 1997, 2000) - Entomologia applicata. Voll. I, II/1,2, III/1,2,3, IV, 1. Liguori, Napoli. English Scientific papers and materials (PowerPoint presentations) provided by the teacher will be loaded on the platform CampusNet. The recommended basic texts for the course are: Fiori G., Bin F., Sensidoni A. (1983) – Atlante entomologico. Morfologia esterna. Galeno Editrice, Perugia. Masutti L., Zangheri S. (2001) - Entomologia generale e applicata. CEDAM, Padova. Pollini A. (1998) – Manuale di entomologia applicata: Edagricole, Bologna. Tremblay E. (1981, 1985, 1986, 1991, 1994, 1997, 2000) - Entomologia applicata. Vols. I, II/1,2, III/1,2,3, IV, 1. Liguori, Napoli. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Grugliasco. English The location of the course is Grugliasco. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zmba - 478 - Environmental agronomy (Anno Accademico 2015/2016) Environmental agronomy Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0171 Docente: Dott. Francesco VIDOTTO (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 670 8781, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Analizzare le principali relazioni fra sistemi produttivi agricoli e l'ambiente, con particolare riguardo agli effetti dell'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura. Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English To analyze the main interconnections between agricultural production systems and the environment, with a special emphasis on the effects of the use of Plant Protection Products (PPPs) on water bodies. The course is fully delivered in English language only RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti disporranno delle conoscenze necessarie a comprendere e mettere in opera le principali misure agronomiche per la mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente legati all'impiego dei prodotti fitosanitari. Gli studenti saranno in grado di svolgere una diagnosi a livello di bacino del rischio di trasferimento di prodotti fitosanitari alle acque superficiali dovuto al ruscellamento e di proporre misure di mitigazione adeguate. English Students will obtain an understanding of the agronomic techniques that can be applied profitably to mitigate the potential adverse effects of use of PPPs on the environment. Students will be able to perform a diagnosis of the risk - 479 - of transfer of pesiticides to water bodies due to runoff at water cactchment scale and to propose the correct mitigation measures to be adopted. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti sarà valutato di volta in volta nel corso delle esercitazioni pratiche. English Levels of learning acquired by the students will be evaluated regularly during practical lessons. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Durante il corso sono previste una o più uscite in campo in un bacino dimostrativo (Valle del Tiglione) per l'acquisizione di elementi indispensabili al completamento della diagnosi a scala di bacino del rischio di ruscellamento. English One or more field excursions will be perfomed to collect data for the runoff risk diagnosis at catchment level (Tiglione Valley). PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della produzione e gestione. In particolare, il contenuti del corso consentono lo sviluppo di competenze nell'interpretazione di complessi problemi riferiti ai rapporti agricoltura-ambiente e alle filiere produttive agricole. Stato dell'ambiente nell'Unione Europea. Attività umane che determinano i maggiori impatti sull'ambiente. Introduzione allo stato dell'ambiente e importanza delle acque superficiali nella regione pan-europea. Impatti sulla biodiversità: specie vegetali esotiche invasive (Ambrosia artemisiifolia (common ragweed), Sicyos angulatus (burcucumber), Solanum carolinense (carolina horsenettle), Pueraria montana (kudzu). Lo schema DPSIR per l'interpretazione dell'impatto ambientale Direttiva europea quadro sulle acque (European Water Framework Directive – WFD – 2000/60/EC); indici di vulnerabilità ai nitrati e ai prodotti fitosanitari; legislazione nazionale e regionale correlata. Definizione di prodotto fitosanitario secondo il Regolamento (EC) N° 1107/2009. Descrizione e analisi della Direttiva 2009/128/EC sull'uso sostenibile dei pesticidi. - 480 - Impatto dell'uso di prodotti fitosanitari: sorgenti di inquinamento puntiformi e diffuse; destino ambientale; misure di mitigazione di tipo agronomico del rischio di inquinamento delle acque superficiali. Diagnosi del rischio di trasferimento da ruscellamento in un bacino dimostrativo (Valle del Tiglione). Analisi delle informazioni territoriali disponibili attraverso l'impiego di strumenti GIS. Applicazione delle linee guida TOPPS-Prowadis per la classificazione del rischio. Validazione di campo. Elaborazione e proposta di misure di mitigazione. English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of production and management. In particular, the subjects will allow the students to acquire skills in the field of issues related to agriculture-environment interactions. State of the enivronment in the EU. Factors of human activity that drive the major impacts on the environment. Introduction to environmental status and importance of inland waters in pan-EU region. A threat to biodiversity: invasive alien plant species (Ambrosia artemisiifolia (common ragweed), Sicyos angulatus (burcucumber), Solanum carolinense (carolina horsenettle), Pueraria montana (kudzu). Environmental effects of agriculture; the DPSIR scheme for the interpretation of the environmental impact. The water compartment and legislative framework (European Water Framework Directive – WFD – 2000/60/EC; vulnerability indices to nitrates and pesticides; national and local policies). Definition of PPP according to Regulation (EC) N° 1107/2009 Concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC. Description and analysis of the Directive 2009/128/EC establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides Impact of use of pesticides; point and diffuse pollution-sources; environmental fate; agronomical practices for mitigation of contamination of water and other compartments. Runoff diagnosis on a pilot catchment basin (Tiglione Valley). Territorial data analysis with GIS tools, TOPPS_Prowadis diagnosis guidelines and risk classification. Field validation. Elaboration of proposed mitigation measures. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni PowerPoint, dispense del corso e articoli per le letture critiche distribuiti dopo ogni lezione. Tutte le presentazioni sono rilasciate secondo una licenza reative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Altro materiale consigliato: -TOPPS-Prowadis: Best Management Practices to reduce water pollution with plant protection products from runoff and erosion (fornito durante il corso) - "Think soils" manual (disponibile all'indirizzo http://www.ahdb.org.uk/projects/documents/ThinkSoils.pdf) - 481 - English The recommended basic texts for the course are: PowerPoint presentations, lecture notes and articles for critical readings distributed during the course. All PowerPoint presentations are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Other suggested literature: -TOPPS-Prowadis: Best Management Practices to reduce water pollution with plant protection products from runoff and erosion (provided during the course) - "Think soils" manual (available at http://www.ahdb.org.uk/projects/documents/ThinkSoils.pdf) NOTA Italiano Il corso viene interamente svolto in lingua inglese English The course is fully delivered in English language only Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wu2d - 482 - Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) INTERDISCIPLINARY TRAINING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0255 Docente: Dott. Teresina MANCUSO (Affidamento interno) Dott. Massimo BLANDINO (Affidamento interno) Prof. Stefano Ferraris (Affidamento interno) Dott. Fabrizio Stefano GIOELLI (Affidamento interno) Dott. Davide BIAGINI (Affidamento interno) Contatti docente: 116708724, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee AGR/08 - idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali AGR/09 - meccanica agraria AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Obbligatoria Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Nell'ambito delle attività di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee nelle ZVN in Piemonte ai sensi della Direttiva 91/676, gli studenti condurranno uno studio delle potenziali pressioni di origine agricola prossime ad alcuni pozzi della rete regionale di monitoraggio caratterizzati da anomalie nel tenore di nitrati, valutando l'opportunità di suggerire eventuali interventi migliorativi. English The objective of the interdisciplinary training (EI) is to tackle complex problems with the use of an integrated approach of the disciplines studied in the graduate program. The assessment of economic and environmental sustainability of specific actions in local agricultural systems will be objects of EI 2015. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Agli studenti, riuniti in piccoli gruppi, saranno forniti una ampia bibliografia sull'argomento per approfondire i principali elementi tecnici, normativi, economici riguardanti il progetto da sviluppare, sulla base dei quali, con la guida dei docenti, dovranno essere eseguite le elaborazioni di seguito descritte. Il risultato del lavoro svolto dovrà - 483 - concretizzarsi nella redazione di un elaborato per illustrare e dettagliare il progetto. English Students will be asked to work in small groups. By a series of seminars they will be provided with information, data and specific papers revolving around the subjects of the task. The didactic material and seminars will enable them to analyze thoroughly the normative, technological, agronomical and economical aspects of the feasibility study. At the end of the activity they will be asked to produce a final technical and economic report focusing on the different topics of the interdisciplinary practices. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante lo svolgimento del lavoro di gruppo sono previsti incontri con gli studenti. Si potra' verificare che le soluzioni tecniche ed economiche del progetto di fattibilita' ideate dai singoli gruppi siano appropriate e proporre discussioni circa aspetti particolari del progetto stesso. English Encounters with students will be held regularly while the students are working on their reports, to verify that suitable solutions to problems proposed by each group are feasible. Discussions about the project will also be held. Scritto e orale. PROGRAMMA Italiano Area di apprendimento: tecnico-professionale Analisi delle cause di peggioramento dello stato di acque sotterranee attraverso indagini a livello aziendale e proposte di interventi di mitigazione L'esercitazione si compone di alcuni seminari tematici, necessari per lo sviluppo in autonomia delle attività proposte: ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; seminario iniziale di inquadramento della problematica -quadro conoscitivo dell'areale e della relativa rete di monitoraggio delle acque sotterranee- e presentazione della scheda di rilievo; seminari tematici; rilievo (in campo e presso le aziende agricole coinvolte) degli elementi agronomici, zootecnici e gestionali di interesse nell'intorno di uno o più pozzi, sulla base di apposite schede di rilevamento; incontri di metà percorso tra docenti, funzionari regionali e studenti; stesura della relazione finale: valutazione degli elementi di pressione puntuale e diffusa nell'intorno del pozzo per la proposta di eventuali interventi migliorativi. Calendario delle attività: - Gli studenti saranno informati del calendario delle attività previste (seminari, uscite, aula, appelli, etc.) ad inizio - 484 - febbraio 2016. Le informazioni aggiornate verranno inviate sulla mail istituzionale agli studenti registrati alla pagina del corso. English Learning Practical subjetcs Analysis of the causes of deterioration of the groundwater status through surveys at farm level and proposals for mitigation Students must prepare a technical report which proves the ability to work in teams, to distribute the assignments and to share data, choices and results, using expertise gained during the studies to identify innovative and original solutions (problem solving). The activities are divided into: - some seminars offered in the classroom, to outline the selected issues, suggest tools and techniques of analysis and calculation, provide educational materials and literature; - field visits for direct observation of the case studies proposed; - meetings with experts and observers of the examined issues. The EU Commission created groundwater monitoring stations nitrate levels in the EU members states. The tutorial consists of several thematic seminars, useful for developing the proposed activities: -first seminar about the network of monitoring underground water at the territorial district level and presentation of the survey form; -other thematic seminars; -relief -in the field and at the farms involved- of the agronomic, farming and management elements of interest around some wells, based on a specific survey form; -mid-term meetings among teachers, regional officials and students; the final report: assessment of the punctual and widespread pressure around the well to propose possible improvement actions. Timetable of activities: students must consult this section at the begin of February 2016. Classroom to be defined and other information to be communicated by institutional email. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Diapositive predisposte dai docenti. -Articoli e testi selezionati e proposti in aula. Text: Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles Brussels Conference Proceedings (18 Nov 2014), download to http://mineral-cycles.eu/sites/default/files/Brussels%20Conference_Proceedings.p df and consultation of the Section: http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html - 485 - English - Slides and selected references will be supplied to students. Text: Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles Brussels Conference Proceedings (18 Nov 2014), download to http://mineral-cycles.eu/sites/default/files/Brussels%20Conference_Proceedings.p df and consultation of the Section: http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html NOTA Italiano -A inizio febbraio 2016 consultare questa sezione per il calendario dettagliato delle attività. -Gli studenti devono registrarsi alla pagina del corso entro gennaio 2016. -La valutazione è data come Approvato/Non Approvato. Se Approvato, la valutazione è fornita con l'indicazione dicon l'indicazione di ottimo, buono, sufficiente: il punteggio acquisito (rispettivamente 1 punto, 0,5 e 0), concorre al voto di laurea. English -The timesheet of activities will be available from February 2016. -Students must register them to course page from January 2016. -The Interdisciplinary training is approved or not. If approved, the final mark attributed to each student will be Excellent "Ottimo" (score = 1), Good "Buono" (score = 0,5), Sufficient "Sufficiente" (score = 0). These scores will contribute to the graduation mark. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wvc8 - 486 - Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) INTERDISCIPLINARY TRAINING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0103 Docente: Prof. Silvia GUIDONI (Affidamento interno) Prof. Luca ROLLE (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708659, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia Anno: 3° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 2 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/15 - scienze e tecnologie alimentari Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Obbligatoria Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano English RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano English MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO - 487 - Italiano English PROGRAMMA Italiano English TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Nessuno. English None NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yf93 - 488 - Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) INTERDISCIPLINARY TRAINING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0382 Docente: Dott. Teresina MANCUSO (Affidamento interno) Dott. Massimo BLANDINO (Affidamento interno) Prof. Stefano Ferraris (Affidamento interno) Dott. Fabrizio Stefano GIOELLI (Affidamento interno) Dott. Davide BIAGINI (Affidamento interno) Contatti docente: 116708724, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 12 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee AGR/08 - idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali AGR/09 - meccanica agraria AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Obbligatoria Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Nell'ambito delle attività di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee nelle ZVN in Piemonte ai sensi della Direttiva 91/676, gli studenti condurranno uno studio delle potenziali pressioni di origine agricola prossime ad alcuni pozzi della rete regionale di monitoraggio caratterizzati da anomalie nel tenore di nitrati, valutando l'opportunità di suggerire eventuali interventi migliorativi. English The objective of the interdisciplinary training (EI) is to tackle complex problems with the use of an integrated approach of the disciplines studied in the graduate program. The assessment of sustainability of specific actions in local agricultural systems will be objects of EI 2015. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Agli studenti, riuniti in piccoli gruppi, sarà fornita una ampia bibliografia sull'argomento per approfondire i principali elementi tecnici, normativi, economici riguardanti il progetto da sviluppare, sulla base dei quali, con la guida dei docenti, dovranno essere eseguite le elaborazioni di seguito descritte. Il risultato del lavoro svolto dovrà - 489 - concretizzarsi nella redazione di un elaborato per illustrare e dettagliare il progetto. English Students will be asked to work in small groups. By a series of seminars they will be provided with information, data and specific papers revolving around the subjects of the task. The didactic material and seminars will enable them to analyze thoroughly the normative, technological, agronomical and economical aspects of the feasibility study. At the end of the activity they will be asked to produce a final technical and economic report focusing on the different topics of the interdisciplinary practices. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante lo svolgimento del lavoro di gruppo sono previsti incontri con gli studenti. Si potrà verificare che le soluzioni tecniche ed economiche del progetto di fattibilità ideate dai singoli gruppi siano appropriate e proporre discussioni circa aspetti particolari del progetto stesso. English Encounters with students will be held regularly while the students are working on their reports, to verify that suitable solutions to problems proposed by each group are feasible. Discussions about the project will also be held. PROGRAMMA Italiano Area di apprendimento: tecnico-professionale Analisi delle cause di peggioramento dello stato di acque sotterranee attraverso indagini a livello aziendale e proposte di interventi di mitigazione L'esercitazione si compone di alcuni seminari tematici, necessari per lo sviluppo in autonomia delle attività proposte: ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; seminario iniziale di inquadramento della problematica -quadro conoscitivo dell'areale e della relativa rete di monitoraggio delle acque sotterranee- e presentazione della scheda di rilievo; seminari tematici; rilievo (in campo e presso le aziende agricole coinvolte) degli elementi agronomici, zootecnici e gestionali di interesse nell'intorno di uno o più pozzi, sulla base di apposite schede di rilevamento; incontri di metà percorso tra docenti, funzionari regionali e studenti; stesura della relazione finale: valutazione degli elementi di pressione puntuale e diffusa nell'intorno del pozzo per la proposta di eventuali interventi migliorativi. Calendario delle attività: -Gli studenti saranno informati del calendario delle attività previste (seminari, uscite, aula, appelli, etc.) ad inizio - 490 - febbraio 2016. Le informazioni aggiornate verranno inviate sulla mail istituzionale agli studenti registrati alla pagina del corso. English Learning Practical subjetcs Analysis of the causes of deterioration of the groundwater status through surveys at farm level and proposals for mitigation Students must prepare a technical report which proves the ability to work in teams, to distribute the assignments and to share data, choices and results, using expertise gained during the studies to identify innovative and original solutions (problem solving). The activities are divided into: - some seminars offered in the classroom, to outline the selected issues, suggest tools and techniques of analysis and calculation, provide educational materials and literature; - field visits for direct observation of the case studies proposed; - meetings with experts and observers of the examined issues. The EU Commission created groundwater monitoring stations nitrate levels in the EU members states. The tutorial consists of several thematic seminars, useful for developing the proposed activities: -first seminar about the network of monitoring underground water at the territorial district level and presentation of the survey form; -other thematic seminars; -relief -in the field and at the farms involved- of the agronomic, farming and management elements of interest around some wells, based on a specific survey form; -mid-term meetings among teachers, regional officials and students; the final report: assessment of the punctual and widespread pressure around the well to propose possible improvement actions. Timetable of activities: students must consult this section at the begin of February 2016. Classroom to be defined and other information to be communicated by institutional email. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano - Diapositive predisposte dai docenti. -Articoli e testi selezionati e proposti in aula. Text: Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles Brussels Conference Proceedings (18 Nov 2014), download to http://mineral-cycles.eu/sites/default/files/Brussels%20Conference_Proceedings.p df and consultation of the Section: http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html English - Slides and selected references will be supplied to students. - 491 - Text: Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles Brussels Conference Proceedings (18 Nov 2014), download to http://mineral-cycles.eu/sites/default/files/Brussels%20Conference_Proceedings.p df and consultation of the Section: http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html NOTA Italiano -A febbraio 2016 consultare questa sezione per il calendario dettagliato delle attività. -Gli studenti devono registrarsi alla pagina del corso a Gennaio 2016. -La valutazione è data come Approvato/Non Approvato. Se Approvato, la valutazione è fornita con l'indicazione di Ottimo (1 punto), Buono (0,5 punti), Sufficiente (0 punti): il punteggio acquisito concorre al voto di laurea. English -The timesheet of activities will be available from February 2016. -Students must register them to course page from January 2016. -The Interdisciplinary training is approved or not. If approved, the final mark attributed to each student will be Excellent "Ottimo" (score = 1), Good "Buono" (score = 0,5), Sufficient "Sufficiente" (score = 0). These scores will contribute to the graduation mark. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yodv - 492 - Esercitazioni interdisciplinari (Anno Accademico 2015/2016) INTERDISCIPLINARY FIELD ACTIVITY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0329 Docente: Prof. Renzo MOTTA (Affidamento interno) Antonio NOSENZO (Affidamento interno) Prof. Roberto ZANUTTINI (Affidamento interno) Prof. Filippo BRUN (Affidamento interno) Prof. Michele FREPPAZ (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705538, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali Anno: 3° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale AGR/05 - assestamento forestale e selvicoltura AGR/06 - tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/14 - pedologia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Obbligatoria Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None Anche se non ci sono formali prerequisiti gli studenti devono avere acquisto i concetti e le principali conoscenze relative ai corsi di Selvicoltura, Dendrometria, Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali, Principi di Economia e statistica, Pedologia e Diritto Amministrativo. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano L'obiettivo dell'insegnamento è di utilizzare un approccio integrato allo sviluppo di un caso di studio, evidenziando il legame esistente tra le diverse discipline affrontate nel triennio di studi e la necessità di un approccio interdisciplinare per l'applicazione di una gestione sostenibile e per la conservazione delle risorse naturali. Il soggetto delle Esercitazioni interdisciplinari è la Filiera legno. C'è un crescente interesse per la produzione in modo sostenibile di prodotti legnosi che possono creare opportunità economiche nei settori economicamente marginali e la contemporanea produzione di servizi ecostemici che migliorano la qualità della vita degli abitanti e dei portatori di interesse e rafforzano il legame tra le foreste ed il territorio. Inoltre l'uso sostenibile delle risorse naturali disponibili è in alcuni casi l'unica alternativa all'abbandono del territorio che, in assenza di presidio antropico, può degradare con gravi problemi di dissesto. La possibilità di coniugare queste diverse opzioni e la sostenibilità economica/ecologica dei diversi scenari verrà analizzata e discussa. English This course is aimed to provide an integrated approach in order to demonstrate the linkages among various - 493 - disciplines and the need for interdisciplinary approaches to apply a sustainable management of natural resources and their long-term conservation. The subject of the interdisciplinary field excursion is the wood chain. There is currently a growing interest towards forest products which meet sustainability goals through reduced impact on the forest ecosystems, improvement of human well being and a strong link to the territory; this concerns notably the demand for wood and wood biomass for energy use. Indeed, sustainable forest management is not in conflict with a productive use of forestland, without which abandonment and land neglection could further occur. To meet these new societal demands and to supply a variety of forest goods and services while maintaining economic viability is a true challenge. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Le esercitazioni interdisciplinari sono un insegnamento applicativo e integrato di più discipline, svolto al termine del percorso formativo triennale. Al termine delle esercitazioni gli studenti saranno in grado di applicare le conoscenze ed abilità acquisite ad un caso di studio. Saranno inoltre in grado di raccogliere, analizzare e presentare in una relazione scritta i risultati di diversi ambiti di studio (dendrometrico, selvicolturale, delle utilizzazioni forestali e tecnologia del legno, pedologico, economico, entomologico e patologico) lavorando in gruppo e individualmente. English The interdisciplinary field excursion integrates concepts of natural resources sustainable management using a case study. Class project will focus on providing teaching tools, visual aids, mapping techniques, methods of data analysis, and lecture. Participants will collect and interpret evidence regarding forest stand structure and biomass, current dynamics, disturbances and diseases, forestry operations and wood technology, soil conservation and Economical budget of the woody chain and will analise the potential impact of different resorces management scenarios regarding their sustainability and their economic results. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano L'insegnamento consiste di 12 ore di lezione frontali e 24 ore dedicate ad esercitazioni in bosco. Per le lezioni frontali i docenti utilizzeranno presentazioni e slides che sonanno messe a disposizione degli studenti. Altro materiale didattico sarà messo a disposizione sul sito web del corso. Le esercitazioni interdisciplinari avranno luogo ad Ormea nella prima metà del mese di giugno ed hanno una durata prevista di 5 giorni. English The course consists of 12 hours of lectures and 24 hours devoted to field work. For lectures the teachers make use of presentations and slides that will be available to students. Other supplemental reading materials will be available at the course web site. The field trip to Ormea will last 5 days and is scheduled for the first half of June. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano - 494 - Durante le esercitazioni interdisciplinari, il grado di apprendimento e comprensione acquisito dagli studenti sarà valutato costantemente nelle attività svolte sia in campo sia in aula. Le esercitazioni interdisciplinari prevedono la relazione finale sul progetto analizzato (in gruppo di 4-5 persone). Il progetto è realizzato dal gruppo ma ogni componente sarà referente di un capitolo. La valutazione finale sarà effettuata sulla base di una discussione del progetto ed un esame orale individuale. Il voto finale sarà individuale. La valutazione sarà così espressa: sufficiente D, discreto C, buono B, ottimo A. La valutazione contribuirà a determinare il voto di Laurea. English In the Interdisciplinary training, levels of learning and comprehension acquired by the students will be evaluated regularly during field surveys and classroom activities.Attendace to the field trip is required. As a final output each group will have to write a report where each component of the group will be in charge for a chapter. The evaluation of the quality of the report will be applied to the whole team with an individual special reference to the individual chapter. Final grades will be based on the discussion of the Report and on a individual oral examination. The final mark will be individual. Grading policy: final grades will be: sufficient D, fair C, good B and excellent A. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Attività svolta nella sede di Ormea nel mese di giugno 2015. L'attività sarà svolta in parte con il supporto dei docenti ed in parte come lavoro di gruppo. Al termine della settimana dovrà essere predisposto un elaborato da parte di ogni gruppo di studenti. PROGRAMMA Italiano L'insegnamento fa parte dell'Area didattica del tirocinio formativo e di orientamento (in relazione all'acquisizione di professionalità) e dell'area didattica della comunicazione (in relazione alla preparazione ed alla presentazione della Relazione finale). Selvicoltura sostenibile Misura delle biomasse legnose Utilizzazioni forestali e tecnologia del legno Misure di conservazione del suolo Bilancio economico della filiera legno English The interdisciplinary training is part of the learning areas of communication and of extension (practical learning area). Sustainable silviculture Reliable estimates for stand biomass - 495 - Forestry activities and wood technology Soil conservation Economical budget of the woody chain TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Materiale didattico fornito dai docenti verrà caricato sul sito web del corso. English Slides and other supplemental readings provided by the teachers will be made available at the course web site. NOTA Italiano Anche se non ci sono formali prerequisiti gli studenti devono avere acquisto i concetti e le principali conoscenze relative ai corsi di Selvicoltura, Dendrometria, Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali, Principi di Economia e statistica, Pedologia e Diritto Amministrativo. Le esercitazioni prevedono l'utilizzo di strumenti dendrometrici e l'utilizzo di fogli di scrittura e fogli di calcolo (Abilità informatiche). Parte del materiale didattico è in inglese. La partecipazione alle esercitazioni interdisciplinari è obbligatoria. Se lo studente dovesse assentarsi per un breve periodo per motivi di forza maggiore (non più di un giorno) deve contattare il docente per l'assegnazione di un lavoro sostitutivo. Le relazioni finali devono essere consegnate entro una settimana dal termine delle esercitazioni English Though there are no formal prerequisites, students should be familiar with the concepts and information in Silviculture, Dendrometry, Principles of Economy and Statistics, Forestry activities and wood technology, Pedology and Administrative Law. If you must miss a session (no more than one day), please check with the teacher to turn in any assignments. The field exercises will require basic knowledge of Dendrometry, and the use of wordprocessing and spreadsheets. Some of the documents provided by the teachers are in English. Reports must be delivered to the teachers no later than a week after the end of the excursion. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=32qf - 496 - Esercitazioni interdisciplinari - STA (Anno Accademico 2015/2016) INTERDISCIPLINARY TRAINING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0327 Docente: Prof. Giorgio BORREANI (Affidamento interno) Prof. Cristiana PEANO (Affidamento interno) Dott. Mario TAMAGNONE (Affidamento interno) Prof. Luciana TAVELLA (Affidamento interno) Prof. Elisabetta BARBERIS (Affidamento interno) Prof. Ivo ZOCCARATO (Affidamento interno) Dott. Federica LARCHER (Affidamento interno) Dott. Massimo PUGLIESE (Affidamento interno) Prof. Angela MOSSO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708783, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: F - Altre attività Crediti/Valenza: 9 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 - orticoltura e floricoltura AGR/09 - meccanica agraria AGR/11 - entomologia generale e applicata AGR/12 - patologia vegetale AGR/13 - chimica agraria AGR/17 - zootecnica generale e miglioramento genetico Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Obbligatoria Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Gli obiettivi delle esercitazioni interdisciplinari sono: - portare gli studenti a contatto diretto con la realtà delle aziende agricole e/o delle aree verdi pubbliche, facendo loro analizzare nel dettaglio gli aspetti organizzativi, gestionali e produttivi; - chiamare gli studenti all'organizzazione e alla gestione autonoma di un lavoro di gruppo, al cui interno dovranno essere selezionate e coordinate le specifiche competenze per dar luogo a un lavoro unitario; richiedere al gruppo la redazione di una relazione tecnica, preparata coordinando le singole competenze, giustificando opportunamente le scelte effettuate nelle valutazioni tecniche, fornendo informazioni di sintesi relative alla massa di dati raccolti. English - 497 - The objectives of the Interdisciplinary training are: - to let students directly meet farms and/or public green areas, to analyze in details the management, organizational and productive aspects; - to lead students to organize and manage by themselves a teamwork, where all specific skills will have to be selected and organized to produce a homogeneous work; - to require the group to draw up a technical report, properly coordinating all individual skills, justifying the choices made in the technical evaluation, and synthesizing the information drawn from the data collection. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti saranno in grado di affrontare la redazione di una relazione tecnica, in analogia a quanto potrebbe essere necessario produrre nell'attività professionale per descrivere gli aspetti caratterizzanti l'azienda nel suo complesso, evidenziando i motivi di particolari scelte colturali e/o gestionali e valutando problemi, difficoltà tecniche ed economiche, prospettive future. Lavorando in gruppo, gli studenti impareranno a gestire l'attività collettiva sul lungo periodo e a rispettare una scadenza concordata per la consegna del lavoro. English Students will be able to write a technical report, comparable to the formal documents they could produce during their future professional activity. They will learn how to describe all the aspects that characterize the farm, to explain cropping and management choices, to evaluate technical and economic problems and perspectives, and to address the future strategies. Working in team will help students to learn how to manage and coordinate the common activity in the long term and to meet the established deadlines. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Le esercitazioni interdisciplinari comprendono attività in campo (visite in un'azienda agricola o in un'area verde) e attività in aula. In campo i docenti accompagneranno e guideranno gli studenti nelle attività di rilevamento delle informazioni e dei dati. In aula i docenti, prima delle visite, forniranno agli studenti gli strumenti necessari per le attività in campo e, dopo le visite, li aiuteranno a gestire ed elaborare criticamente le informazioni e i dati raccolti in campo. English The Interdisciplinary training includes field activities (surveys in a farming system or in a green area) and classroom activities. In the field, the teachers will take and lead the students in the survey and collection of information and data. In the classroom, before the field surveys, the teachers will provide the students with the necessary tools; after the field surveys, they will help the students to manage and analyze critically field collected information and data. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante le esercitazioni interdisciplinari, il grado di apprendimento e comprensione acquisito dagli studenti sarà valutato costantemente nelle attività svolte sia in campo sia in aula. Il giudizio finale sarà espresso come: sufficiente 'D' (=0 punti), discreto 'C' (=1 punti), buono 'B' (=2 punti), ottimo 'A' (=3 punti). I punti così acquisiti saranno sommati ai punti assegnati all'esame finale e contribuiranno al voto di laurea. Il giudizio sarà attribuito sulla base delle seguenti valutazioni: - impegno e attenzione nelle attività in campo e nella stesura del testo; - qualità della prima versione di relazione; - qualità della relazione finale e incremento qualitativo rispetto alla prima versione; - esame orale conclusivo. - 498 - Le valutazioni in merito alla qualità dei testi prodotti sono riferite all'intero gruppo. Il voto finale sarà individuale. English In the Interdisciplinary training, levels of learning and comprehension acquired by the students will be evaluated regularly during field surveys and classroom activities. The final mark attributed to each student will be sufficient 'D' (score = 0), fair 'C' (score = 1), good 'B' (score = 2) or excellent 'A' (score = 3). These scores will be added to the score deriving from the final examination and will contribute to the graduation mark. The mark will be based on the following evaluations: - attention and involvement in field activities and report drafting; - quality of the first draft of the report; - quality of the final version of the report and its quality improvement relative to the first draft; - final oral examination. The evaluation of the quality of the report will be applied to the whole team. The final mark will be individual. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati nel corso delle esercitazioni interdisciplinari rientrano nell'area tecnica di apprendimento. Le esercitazioni interdisciplinari saranno così articolate: - giornate introduttive (presentazione delle attività, informazioni sulla sicurezza; distribuzione del materiale ai gruppi; presentazione della documentazione e della cartografia disponibili; analisi delle schede da utilizzare in campo per i rilievi; inquadramento morfologico, climatico e ambientale dell'area in esame); - attività di campo, che consisterà in sopralluoghi in realtà agricole o aree verdi piemontesi per seguirne le attività nel periodo da marzo a maggio. Durante i sopralluoghi, gli studenti eseguiranno rilievi diretti in campo e raccolta di informazioni aziendali tramite interviste ai gestori. Le attività saranno condotte dai singoli gruppi sotto la guida dei docenti, ma con una progressiva autonomia durante il periodo. Le principali tematiche sviluppate e approfondite (con alcune differenze in funzione delle realtà esaminate) riguarderanno gli argomenti trattati nei corsi di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee, Arboricoltura, Chimica agraria, Economia aziendale, Entomologia agraria, Patologia vegetale, Fisiologia e Miglioramento genetico, Meccanica agraria, Parchi e giardini, Zootecnica. Poiché molte delle informazioni e dei commenti tecnici saranno aspetti concreti osservati in campo o raccolti nelle interviste agli operatori aziendali, è necessaria una partecipazione sempre attiva e attenta durante tutte le uscite. - attività in aula, dove gli studenti, lavorando sia sotto la guida dei docenti sia autonomamente, potranno consultare i documenti e le basi dati disponibili per l'area di studio (cartografici, meteorologici, ecc.) e per le realtà esaminate, elaborare e discutere criticamente le informazioni e i dati raccolti in campo; - stesura della relazione, che richiederà impegno di tempo e di energie da parte del gruppo di lavoro, in termini sia di elaborazione dei dati, sia di redazione formale del testo e che dovrà in generale estrapolare in forma sintetica, dalla grande massa di informazioni raccolte, i caratteri distintivi delle realtà considerate, formulando un giudizio tecnico ed evidenziando i punti critici e le strategie di miglioramento. English The subjects are included in the practical learning area. The Interdisciplinary training will be structured as follows: - 499 - - Opening days, with the presentation of the activities, giving necessary safety information; distribution of the material to the groups; explanation of the available documentation and cartography, and of the forms for field data collection; description of the geomorphologic, climatic and environmental framework of the surveyed area. - Field activities, consisting in surveys in different farming systems or green areas of Piedmont (NW Italy), in the period from March to May. During field surveys, the students will collect data by direct field sampling and by interviews to the farmers or park managers. The activities will be carried out under the teachers' supervision, but an increasing autonomy of the groups is expected during the period. The main subjects (with some differences in relation to the surveyed systems) will deal with the knowledge acquired during the courses of Agronomy and Herbaceous crop cultivations, Agricultural chemistry, Animal husbandry, Farm economics, Agricultural entomology, Plant pathology, Plant physiology and breeding, Pomology, Parks and gardens, Agricultural machinery. Since most practical observations and technical comments will be collected directly in the field or by interviews, a constant active and careful participation to all the field surveys is required. - Classroom activities. The students will work both with the help of the teachers and by themselves utilizing the available documents and databases (e.g., cartography, meteorological data, etc.) regarding the surveyed areas and systems, and starting a critical evaluation of the field collected data. - Report writing. This activity will require time and energy by the work team both for the data analysis and discussion, and for writing the text. The report must synthesize the collected information stressing the main aspects of the farms under exam, leading to a technical evaluation and explaining the main problems, and suggesting strategies for improvement. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Materiale didattico utile per il rilevamento e l'analisi dei dati sarà disponibile prima delle attività in campo sul Portale della didattica del DISAFA (campusnet.unito.it). Manuali sulle pratiche agronomiche e di allevamento, Manuali per il riconoscimento dei principali patogeni, fitofagi e infestanti delle colture considerate. Siti web. English Educational material useful for the survey and analysis of data will be available on Campusnet platform before the field activities. Handbook on crop management and on livestock farming. Handbook on main plant pathogens, crop pests, and weeds. Websites. NOTA Italiano Obiettivi formativi, risultati dell'apprendimento e programma sono stati concordati congiuntamente dai docenti responsabili. English Formative objectives, learning assessment and syllabus are set jointly by all the involved teachers. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jnot - 500 - Estimo forestale (Anno Accademico 2015/2016) FOREST VALUATION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0359 Docente: Prof. Filippo BRUN (Affidamento interno) Contatti docente: 011 670 8628, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Non sono previste propedeuticità. E' tuttavia utile che gli studenti abbiano chiare le conoscenze economiche acquisite nei corsi di istituzioni di economia e economia agraria e forestale o di analoghi corsi economici di base. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire allo studente la conoscenza dei principali metodi e strumenti di valutazione, che stanno alla base dell'attività professionale. Sviluppare la capacità critica indispensabile per una lettura economica del settore forestale. English The educational goal is the understanding of the main evaluation methods and tools at the base of the profession, providing graduates with the critical skills necessary for the economic understanding of the forestry sector. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Alla fine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito la comprensione e la capacità di impiego dei principali metodi e strumenti di valutazione in campo forestale, agrario e ambientale. Sarà in grado di produrre una relazione estimativa di tipo professionale. Avrà piena padronanza degli strumenti di matematica finanziaria e di valutazione degli investimenti e capacità di valutazione degli interventi pubblici in materia di politica agraria, forestale e montana. Avrà infine capacità di lavorare in gruppo e di presentare i risultati ottenuti. - 501 - English At the end of the course the students will acquire the understanding and the ability to use main assessment tools in forestry, agriculture and environment. They will also be able to produce a professional evaluation report. The students will have full mastery of financial mathematics tools and investments valuation and assessment capabilities of public interventions in the field of agricultural policy, forest and mountain. They will finally have the ability to work in groups and to present the results. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale, 10 ore dedicate ad esercitazioni in classe e 10 ore in raccolta ed elaborazioni di dati in campo. I materiali didattici utilizzati a lezione vengono distribuiti in forma cartacea o messi a disposizione sulla piattaforma campusnet. Fra questi sono presenti una dispensa sulla realizzazione della stima del prezzo di macchiatico ed alcuni esempi dei testi di matematica finanziaria di sessioni precedenti. Le esercitazioni avvengono con materiali e strumenti forniti dal docente, organizzando il lavoro in gruppi. English The course consists of 60 hours of lectures, 20 hours devoted to practical activities in classroom and 10 in the field. The teaching materials used in class are distributed in hard copy or available on the platform campusnet. Among these, a guide to the realization of the stumpage price assessment and examples of financial mathematics tests of previous sessions are available. The exercises are made with materials and tools provided by the teacher, organizing work in groups. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Colloqui al termine delle lezioni e test senza valore di esame servono per valutare il grado di preparazione degli studenti durante il corso. L'esame finale prevede: - una prova scritta di matematica finanziaria, superata la quale si può accedere all'orale; - la redazione di una stima del prezzo di macchiatico, realizzata con i dati raccolti durante l'esercitazione in campo, o con dati originali. La stima può essere presentata dagli studenti in gruppi di 2 e deve essere stampata; - un colloquio orale durante il quale ogni studente risponde a domande sugli aspetti metodologici della stima presentata e a domande sugli argomenti del programma. Nel colloquio vengono valutate sia le nozioni acquisite sia le capacità di ragionamento e di collegamento delle conoscenze. La valutazione finale in trentesimi tiene conto della qualità della stima presentata (25%) e delle risposte (75%) English Discussions after class and test (worthless for examination) are used to assess the knowledge of the students during the course. The final exam requires: - 502 - - To pass a written test of financial mathematics before the oral exam; - The submission of a valuation report of stumpage price, with data collected during the field exercitation or with original data. The report may be made by students in groups of two and must be printed - An oral examination during which each student discusses the content of the written report, describing the methodological aspects and answering to questions on program topics. At the same time the skill to elaborate the contents and to link the different topics will be tested. The final evaluation takes into account the quality of the evaluation report (25%) and of the answers (75%). PROGRAMMA Italiano Il corso fa parte delle aree: (A) Area della gestione multifunzionale sostenibile delle risorse - Estimo generale: concetti fondamentali; Il valore dei beni, natura del giudizio di stima; aspetti economici tradizionali; aspetti economici particolari; processo estimativo; metodo e momento di stima; procedimenti estimativi: stime sintetiche ed analitiche; principio dell'ordinarietà. - Strumenti di Matematica finanziaria. Valutazione degli investimenti. - Stime forestali. Stima del suolo nudo, dei boschi, dei soprassuoli non maturi. Stima del valore e del prezzo di macchiatico. Stima delle risorse ambientali. - Stime legali: espropriazioni e servitù prediali coattive. - Impostazione di una relazione di stima. - Catasto rustico italiano. - Il flusso circolare del reddito, i soggetti delle politiche, obiettivi e misura dei risultati delle politiche pubbliche. - La Politica agricola comunitaria, le politiche rurali e il quadro generale delle leggi forestali (B). Area della difesa del suolo e della prevenzione dei rischi naturali Stima dei danni. Assicurazioni. Strumenti di Matematica finanziaria. Valutazione degli investimenti. Impostazione di una relazione di stima. (C). Area dell'utilizzazione della materia prima legno e dei suoi derivati Strumenti di Matematica finanziaria. Valutazione degli investimenti. Stime forestali (soprassuolo maturo, non maturo). Stima del valore e del prezzo di macchiatico. - 503 - English A. Area of multifunctional management of sustainable resources General appraisal: Basic concepts; The value of goods, the nature of the judgment of estimation; traditional and new economic aspects; estimation process, method and time of estimation, synthetic and analytical estimates; principle of ordinariness. Tools of Financial Mathematics. Valuation of investments. Forest assessment. Estimation of bare soil, forests, young stands. Estimate of the stumpage value and price. Assessment of environmental resources. Legal Estimates: coercive expropriation and easements. Setting a valuation report. Cadastre rustic. The circular flow of income, the subjects of policies, objectives and measurement of results of public policies. The Common Agricultural Policy, general framework of the forest lows. B. Area of soil and of natural hazards prevention Damage assessment. Insurances. Tools of Financial Mathematics. Valuation of investments. Setting a valuation report. C. Area of use of wood raw material and its products Forest assessment. Estimate of the stumpage value and price. Tools of Financial Mathematics. Valuation of investments. Setting a valuation report. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Michieli I; Michieli M., Trattato di Estimo, (2002), Edagricole Bologna. Merlo M., Elementi di Economia ed estimo forestale-ambientale, (1991), CUSL Nuova Vita, Padova. F. Brun, B. Giau, C. Magnani e S. Blanc, "Appunti per la stesura della stima del prezzo di macchiatico e per la redazione della parcella del professionista" DEIAFA, 2009. B. Giau, Obiettivi e strumenti di politiche agrarie e forestali in Italia e in Europa, CELID, Torino, 2015. Articoli e materiali didattici indicati dal docente verranno caricati sulla piattaforma campusnet - 504 - English Michieli I; Michieli M., Trattato di Estimo, (2002), Edagricole Bologna. Merlo M., Elementi di Economia ed estimo forestale-ambientale, (1991), CUSL Nuova Vita, Padova. F. Brun, B. Giau, C. Magnani e S. Blanc, "Appunti per la stesura della stima del prezzo di macchiatico e per la redazione della parcella del professionista" DEIAFA, 2009. B. Giau, Obiettivi e strumenti di politiche agrarie e forestali in Italia e in Europa, CELID, Torino, 2015. Materials provided by the teacher will be loaded on the campusnet platform NOTA Italiano La frequenza delle lezioni e delle esercitazioni, pur non obbligatoria è caldamente suggerita. English The frequency of the lessons and exercitations, while not mandatory, is strongly recommended. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n729 - 505 - Etichettatura dei prodotti alimentari (Anno Accademico 2015/2016) FOOD LABELLING Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0389 Docente: Prof. Erica Varese (Affidamento interno) Contatti docente: 011 - 670 57 91, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 2° anno 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: SECS-P/13 - scienze merceologiche Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso permette di acquisire conoscenze e capacità di comprensione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. English The course will provide students with an advanced knowledge of food labeling. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiscono la capacità di collegare gli argomenti trattati nel corso con le principali tematiche relative all'etichettatura. English Students will use their knowledge in direct application evaluating food labelling issues. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consite di 60 ore di didattica frontale. - 506 - English The course conists of 60 hours of lectures. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica in itinere dell'apprendimento avviene rispondendo a domande analoghe a quelle dell'esame, senza valore per la valutazione finale, ma utili allo studente per valutare il personale grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale. English The runtime check of the learning process is accomplished by answering questions analogous to those found in the exam, not valid for the final evaluation, but helpful to the student to estimate his learning degree. The final exam is oral. PROGRAMMA Italiano A) La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: - Disposizioni generali; - Principi generali delle informazioni sugli alimneti; - Requisiti generali relativi all'informazione sugli alimenti e responsabilità degli operatori del settore alimentare; - Informazioni obbligatorie sugli alimenti; - Informazioni volontarie sugli alimenti. B) Etichettatura di secifici alimenti (uova, olio, cacao e cioccolato etc.) C) Pubblicità ed etichettatura dei prodotti alimentari (Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM - e Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria - IAP) D) Commercializzazione di prodotti agroalimentari: principi English A) The provision of food information to consumers: - General provisions; - General principles on food information; - General food information requirements and responsibilities of food business operators; - 507 - - Mandatory food information; - Voluntary food information. B) "Vertical" labelling legislation on specific products (eggs, oil, cocoa and chocolate ...) C) Marketing communication and food labelling (Antitrust Authority – AGCM - and Institute of Marketing Communication Self-Regulation – IAP) D) Agro food trade: first principles. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano L'indicazione dei testi sarà fornita all'inizio del corso. English NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Cuneo. English The course is held in Cuneo. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y216 - 508 - Farming system for energy production and energy balance (Anno Accademico 2015/2016) FARMING SYSTEM FOR ENERGY PRODUCTION AND ENERGY BALANCE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0373 Docente: Dott. Fabrizio Stefano GIOELLI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708844, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/09 - meccanica agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente un quadro delle fonti di energia rinnovabile applicabili al settore agricolo, con particolare riferimento al settore della digestione anaerobica, delle normative vigenti e gli strumenti per una loro valutazione energetica ed ambientale English The course is aimed at providing the students with an overview of the existing sources of renewable energy, with special regards to anaerobic digetion, the tools to compute energy and environmental balances and knowledge of technologies for biogas production from agricultural feedstocks. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Al termine del corso lo studente avrà un quadro delle opzioni attualmente disponibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura, dei loro costi ambientali e gli strumenti per la scelta ed il dimensionamento di un impianto di digestione anaerobica. English At the end of the course, students will have the basic knowledge of the existing options for energy production through renewable sources and of their environmental sustainability. They will be provided with the necessary tools to correctly choose and dimension an anaerobic digestion plant. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 509 - Italiano Lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio English Lectures and laboratory MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine di ogni gruppo di argomenti sarà promossa una discussione aperta con gli studenti in modo da stimolare l'approccio critico alle tematiche trattate. English At the end of each topic a discussion with the students will enhance their ability to retain and comprehend the basic concepts of the lectures. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Technical visits to anaerobic digestion plants. PROGRAMMA Italiano Introduzione ed obbiettivi del corso Le problematiche ambientali legate all'impiego dei combustibili fossili La richiesta energetica del settore agricolo. Le fonti di energia rinnovabile: il solare, l'eolico e le biomasse. Tipologie di biomassa e loro caratterizzazione. La digestione anaerobica di biomasse agricolo-zootecniche e la produzione di biogas: tipologie impiantistiche, criteri di dimensionamento degli impianti, la cogenerazione, gestione del digerito, scelta delle biomasse di input e loro pretrattamenti per incrementarne le rese produttive, bilancio ambientale di un impianto di digestione anaerobica. La normativa vigente sulle fonti di energia rinnovabile e i sistemi di incentivazione. Visite tecniche ed esercizi su casi di studio English Course introduction and goals. Fossil fuels and environmental pollution - 510 - Overview of energy consumption in agriculture. The sources of renewable energy: solar, wind power, biomasses. Biomass definition and characterization Bio-chemical conversion of biomasses: overview and details on anaerobic digestion (plant typologies and dimensioning criteria, cogeneration units, digestate management). Choice of feedstocks and feedstocks pretreatment to increase the methane yield of an anaerobic digestion plant. Environmental assessment of an anaerobic digestion plant Technical visits and exercises on some case studies TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano The state of renewable energies in Europe (2010) – 10th EurObserv'ER Report Slide del corso fornite dal docente English The state of renewable energies in Europe (2010) – 10th EurObserv'ER Report Slides from the lectures provided by the teacher. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mrj7 - 511 - Fermentation microflora and territorial characterization (Anno Accademico 2015/2016) FERMENTATION MICROFLORA AND TERRITORIAL CHARACTERIZATION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0615 Docente: Da Nominare DOCENTE (Affidamento interno) Contatti docente: [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/16 - microbiologia agraria Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano L'obietivo formativo del corso è fornire allo studente le conoscenze necessarie che permeteranno: - lo studio dell'ecologia microbica durante le fermentazioni per la produzione di varie tipologie di vino; l'utilizzo di nuove metodiche, basate sulla biologia molecorale, per identificare e caraterizzare ceppi d'interesse enologico e per studiare il loro comportamento durante le fermentazione per la produzione di vino; - lo sviluppo di nuove colture starter di origine territoriale. English The teaching objective of the course is to provide to the student necessary knowledge that will allow: - the study of microbial ecology during fermentations for the production of various types of wines; the use of new methods, based on molecular biology, for the identification and characterization of strains of interest to the wine sector and for the study of their behavior during fermentation for wine production; - the development of starter of territorial origin. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano L'importanza del fattore microbico nelle fermentazioni per la produzione del vino é ben instaurata. Grazie a nuovi approcci per lo studio del microbiota durante le fermentazioni, il settore enologico scopre nuove possibilita per migliorare e standardizzare i sui prodotti, sfruttando la naturale biodiversità microbica, spesso legata al territorio e - 512 - associata alle uve e al mosto. Lo studente comprenderà l'importanza della biodiversità microbica e la sua impronta sul prodotto finale e acquisirà le conoscenze per monitorare lo sviluppo delle popolazioni microbiche durante le fermentazione e per intervenire per guidarle ed ottenere prodotti con caratteristiche desiderate. English The importance of the microbial factor in the wine fermentations is well documented. Based on new approaches that can be applied for the study of the microbiota during fermentations, the wine sector is discovering new possibilities to improve and standardize its products, employing the natural microbial biodiversity, often linked to the territory and associated to grapes and musts. Students will comprehend the importance of microbial biodiversity and its trademark on the final product. They will acquire knowledge in order to monitor the development of microbial populations during fermentation, to intervene and guide these populations, with the final purpose of obtaining products with desired characteristics. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso è suddiviso in 24 ore di lezioni frontali e 16 ore di esercitazioni pratiche. English The class is divided in 24 hours of lectures and 16 hours of lab class activities MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Sessioni di discussione sui temi trattati sono previsti durante tutto il corso per verificare l'apprendimento da parte degli studenti. Inoltre, durante le esercitazioni c'è la possibilità di approfondire vari argomenti e verificare la capacità di compressione del materiale didattico da parte degli studenti. English Discussion sections are foreseen throuthout the course in order to evaluate the students' understanding. Furthermore, during the lab classes time is dedicated for verifying students' understanding through questions (and further discussion) on subjects presented during the lectures. PROGRAMMA Italiano L'area di apprendimento di questo corso è tecnologie della trasformazione enologica. Il corso è diviso in sessioni di lezioni teoriche (24 ore) e attività di esercitazioni (16 ore) per un totale di 40 ore. I principali argomenti delle lezioni teoriche sono: -Introduzione al corso: la fermentazione alcolica e malo lattica (2 ore) - Microbiota autoctono della fermentazione per la produzione di vini (2 ore) - Applicazione di starter microbici in ambito enologico: pro e contro (2 ore) - 513 - - Le metodiche molecolari applicate in ambito enologico: PCR convenzionale e quantitativa (4 ore) - Le metodiche di caratterizzazione molecolare (PFGE, RAPD, Restrizione enzimatica di DNA mitocondriale, minisatelliti) (6 ore) - Le metodiche coltura-indipendenti (DGGE, FISH, librerie geniche) (4 ore) - Nuove tendenze e sviluppo di starter autoctoni (4 ore) Le attività delle esercitazioni sono: - Estrazione del DNA da batteri lattici e amplificazione PCR (4 ore) - Elettroforesi su gel d'agarosio, valutazione dei profili elettroforetici per la caratterizzazione di batteri lattici (4 ore) - Costruzione di librerie geniche (4 ore) - Elettroforesi DGGE (4 ore) English The class focuses on subjects that are configured in the learning context of tecnologies for wine making. The class is organized in lecture sessions (24 hours) and laboratory sessions (16 hours). The main subjects of the lectures are the following: - Introduction: alcoholic and malolactic fermentation (2 hours) - Autochthonous microbiota for wine production (2 hours) - Starter culture application in wine production:advantages and disadvantages (2 hours) - Molecular methods applied in wine microbiology: PCR and quantitative PCR (4 hours) - Molecular characterization methods (PFGE, RAPD, Restriction enzyme analysis of mitochondrial DNA, minisatellites (6 hours) - Culture independent methods (DGGE, FISH, genomic libraries) (4 hours) - New trends and development of autochthonous starters (4 hours) The activities in the laboratory are the following: - DNA extraction from lactic acid bacteria and PCR amplification (4 hours) - Agarose gel electrophoresis and evaluation of electrophoresis profiles for lactic acid bacteria strain characterization (4 hours) - Genomic libraries (4 hours) - DGGE method (4 hours) TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Diapositive del corso. Il materiale è disponibile sul sito del corso. - 514 - English Class notes available on the webpage of the class. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=annk - 515 - Filiera dei prodotti di origine animale (Anno Accademico 2015/2016) ANIMAL PRODUCTS CHAINE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0385 Docente: Dott. Davide BIAGINI (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708711, [email protected] Corso di studio: [f001-c703] L - Tecnologie alimentari [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 2° anno 3° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/19 - zootecnica speciale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Descrivere le caratteristiche delle filiere produttive dei prodotti di origine animale. Analizzare i fattori che condizionano la qualità dei prodotti di origine animale. English Describe the characteristics of animal products chains. Analyze the factors that affect the quality of foods of animal origin. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisizione da parte dello studente delle competenze necessarie ad individuare ed affrontare gli aspetti della filiera produttiva che agiscono sulla qualità degli alimenti di origine animale. English Students will gain the skills necessary to identify and to tackle the production chain aspects that affect the quality of foods of animal origin. - 516 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 45 ore di lezione frontale e 15 ore dedicate a attività esercitative e visite ad aziende che operano nell'ambito delle prodotti di origine animale. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 45 hours of lectures and 15 hours devoted to visits establishments that produce food based on animal products . For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento avverrà mediante l'attiva interazione degli studenti durante le lezioni per valutare l'apprendimento delle nozioni teoriche erogate nel corso delle lezioni precedenti. Per l'esame finale gli studenti dovranno portare un approfondimento scritto di un argomento trattato a lezione. L'esame finale è un colloquio orale per la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English The knowledge acquisition will be assessed through students' active interaction during lectures for evaluate the acquisition of theoretical concepts explained in the previous lessons. For the final exam the students will prepare a thorough analysis written of a topic of the lessons. The final exam involves the oral verification of the ability to reason and connection between the knowledge acquired. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del corso si inseriscono nell'area di apprendimento FILIERE E QUALITA' DELLE MATERIE PRIME. Significato di filiera. Le filiere zootecniche. L'integrazione di filiera e la qualità dei prodotti alimentari di origine animale. Filiera carne. I canali di approvvigionamento dei fattori produttivi. L'allevamento. I canali di vendita e trasformazione. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti carnei. Disposizioni legislative che regolano la produzione. La qualità della carne. Fattori che influenzano la qualità della carne. Fattori genetici, biologici (età e sesso), alimentari e tecnologici di allevamento. Movimentazione e trasporto degli animali. Miopatie. Fattori post mortem. Tecniche di macellazione. Trasformazione e conservazione (refrigerazione e congelamento). Tecniche di confezionamento. Filiera latte. I canali di approvvigionamento dei fattori produttivi. L'allevamento. I canali di vendita e trasformazione. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti lattiero caseari. Disposizioni legislative che regolano la produzione. Qualità del latte. Fattori che influenzano la qualità del latte. Fattori genetici, biologici, alimentari e tecnologici di allevamento. Effetto dei trattamenti e delle lavorazioni sulla qualità del latte. Filiera uova. I canali di approvvigionamento dei fattori produttivi. L'allevamento. I canali di vendita e trasformazione. Tracciabilità ed etichettatura delle uova. Disposizioni legislative che regolano la produzione. Qualità delle uova. Fattori che influenzano la qualità delle uova. Effetto dei trattamenti e delle lavorazioni sulla qualità delle uova e degli ovoprodotti. - 517 - Filiera ittica. Qualità dei prodotti ittici provenienti da attività di pesca o di allevamento. Fattori che influenzano la qualità del pesce. Effetto dei trattamenti e delle lavorazioni sulla qualità del pesce. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici. Disposizioni legislative che regolano la produzione. English The topics of the course are part of FOODS SUPPLY CHAIN AND QUALITY . Definition of supply chain. Animal products supply chains. Supply chain integration and quality of foods of animal origin. Meat supply chain. Livestock supply chains. Rearing. Selling and processing chains for meat products. Traceability and labelling system of meat. Meat laws and marketing regulations. Factors affecting meat quality: genetic, biological (age and sex), dietary and rearing. Handling and transport of animals. Myopathies. Postmortem factors influencing meat quality. Slaughter techniques. Meat processing industry. Chilling and freezing of meat. Meat packaging. Milk supply chain. Livestock supply chains. Rearing. Selling and processing chains for milk products. Traceability and labelling system of dairy products. Milk laws and marketing regulations. Milk quality. Factors affecting milk composition: species, breed, age, season, milking interval, yield, lactation effect, exercise, feeding. Dairy industry and dairy products. Effect of processing treatments on milk quality. Egg supply chain. Livestock supply chains. Rearing. Selling and processing chains for milk products. Traceability and labelling system of eggs and eggs products. Eggs laws and marketing regulations. Egg quality. Factors affecting eggs quality. Effect of processing treatments on eggs and eggs products quality. Fish supply chain. Fish and fish products quality from fishing or farming. Factors affecting fish quality. Seafood industry. Effect of processing treatments on fish quality. Traceability and labelling system of fish products. Fish laws and marketing regulations. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Kerry J, Kerry J., Ledward D. Meat processing, CRC Press, 2005. Lawrie R.A., Ledward D.A. Lawrie's Meat Science, Woodhead Publishing Limited, 2006. Mead G.C. Poultry meat processing and quality, CRC Press, 2004. Richardson R.I,. Mead G.C. Poultry meat science, CABI Publishing, 1999. Warris P.D., Meat science. An introductory test, CABI Publishing, 2000. Il materiale didattico proiettato verrà reso disponibile. English Kerry J, Kerry J., Ledward D. Meat processing, CRC Press, 2005. Lawrie R.A., Ledward D.A. Lawrie's Meat Science, Woodhead Publishing Limited, 2006. Mead G.C. Poultry meat processing and quality, CRC Press, 2004. Richardson R.I,. Mead G.C. Poultry meat science, CABI Publishing, 1999. Warris P.D., Meat science. An introductory test, CABI Publishing, 2000. The slide of the lesson will be provided. NOTA - 518 - Italiano Il cosrso si svolge nella sede di Cuneo English The location of the course is Cuneo Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ed18 - 519 - Filiera dei prodotti frutticoli (Anno Accademico 2015/2016) FRUIT CHAINE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0345 Docente: Prof. Cristiana PEANO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708660, [email protected] Corso di studio: [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire gli strumenti per operare scelte autonome nel campo dell'approvvigionamento e della gestione di prodotti frutticoli. English The course is designed to give a comprehensive overview of the scientific and technical aspects of physiological processes related to maturation and senescence of fruits and their responses to postharvest stresses food packaging. Course content includes functions, terminology, materials, properties, manufacture, design, applications, trends and environmental and legal issues of postharvest thecnology RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Applicazione delle principali analisi di routine sui frutti; conoscenza e gestione del post-raccolta delle specie frutticole maggiori; valutazione della qualità dei frutti English Students will learn how to describe all the aspects that characterize the fresh fruit supply chain, to explain management choices, to evaluate technical and economic problems and perspectives, and to address the future strategies in the packinghouse. - 520 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate a attività di laboratorio e visite sul territorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and visits. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Sessioni di dicussione critica periodiche (mensili) sugli argomenti trattati. Il colloquio orale finale prevede la verifica della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English Peridic discussions focusing on subjects already studied in the previous period of class. The final evaluation will take a penalty for each question wrong. orale ATTIVITÀ DI SUPPORTO Visite a centrali frutticole del territorio PROGRAMMA Italiano Area di apprendimento: Filiere e qualità delle materie prime Produzione mondiale di frutta: aree di produzione, specie coltivate, stagionalità di produzione. Consumi di frutta: evoluzione e diversificazioni. Sistemi di commercializzazione dei prodotti frutticoli. Struttura, composizione chimica e valore nutritivo dei frutti. Classificazione botanica, organografica e commerciale dei frutti. Curva di accrescimento dei frutti, fisiologia della maturazione. Indici di raccolta e di qualità. Respirazione dei frutti e biochimismo della respirazione. Biosintesi, funzioni ed azione dell'etilene sui frutti. Conservazione frigorifera: effetti della temperatura, dell'umidità della composizione dell'atmosfera. Principali fisiopatie della conservazione.Impianti di lavorazione dei prodotti frutticoli, strutture e metodi di conservazione frigorifera Esercitazioni Riconoscimento varietale Analisi chimico-fisiche dei frutti Visite ad impianti di lavorazione e conservazione della frutta English - 521 - Learning context: supply chain and quality An overview of the postharvest biology of horticultural crops Marketing fresh produce: socioeconomic and environmental considerations Morphology, growth and development of harvested products Composition and nutritional value of harvested products Measurement of product quality Composition--sugars, acids, phytonutrients, aroma volatiles, Color, Texture, Taste Physics and technologies of cooling Psychrometrics and water loss Modified and controlled atmosphere Postharvest disorders Responses to postharvest stress (chilling injury, high temperature stress, water stress) Postharvest metabolic processes and respiration Ripening control and ethylene Cooling prior to shipment: methods, evaluation of efficiency Storage: methods, facilities, equipment, management of environmental conditions including controlled atmospheres Transport: systems, loading patterns, environmental control, use of modified atmospheres TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Kader A. 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California ANR . Pub. n. 3311. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: Materiale fornito dal docente Infine sono di seguito indicati siti internet di interesse: http://postharvest.ucdavis.edu/ English Kader A. 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California ANR . Pub. n. 3311. http://postharvest.ucdavis.edu/ - 522 - NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Cuneo English The location of the course is Cuneo Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bsu0 - 523 - Filiera legno - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) WOOD INDUSTRY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0371 Docente: Dott. Corrado CREMONINI (Affidamento interno) Silvia NOVELLI (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6705542, [email protected] Corso di studio: [f001-c504] LM - Scienze forestali e ambientali Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale AGR/06 - tecnologia del legno e utilizzazioni forestali Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Industria del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) Mercato del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0wya Industria del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) WOOD INDUSTRY AND BY-PRODUCTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0371 Docente: Dott. Corrado CREMONINI (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6705542, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/06 - tecnologia del legno e utilizzazioni forestali Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto - 524 - PREREQUISITI Competenze di base sulla materia prima legno OBIETTIVI FORMATIVI Italiano l modulo è parte del corso integrato "Filiera Legno", finalizzato alla preparazione di laureati con competenze specifiche di carattere tecnico, gestionale, normativo ed economico, con particolare riferimento al settore delle lavorazioni industriali e della commercializzazione del legno massiccio e dei prodotti a base di legno. English The module is part of the integrated course "wood supply chain", in order to prepare graduates with specific technical, managerial, regulatory and economic skills, with particular reference to the field of industrial manufacturing and marketing of solid wood and wood-based products. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisire conoscenze tecniche ed economiche sui principali prodotti a base di legno e sul loro mercato, sui processi di trasformazione, sulla normativa tecnica di settore e sui sistemi di certificazione della filiera legno. English Acquire technical knowledge on the main wood-based products and their market, on the transformation processes, on the technical standards of the industry and the certification systems of the wood supply chain. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 40 ore di lezione frontale inclusa visita d industrie di prima e seconda trasformazione del legno. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The module consists of 40 hours of lectures and visits to first and second wood processing industry. For lectures the teacher makes use of presentations and slides that are available to students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Interviste dirette degli studenti, senza valore per la valutazione finale, verranno effettuate a campione in una fase intermedia del modulo al fine di verificare i risultati dell'apprendimento che dovranno risultare congrui con quelli attesi. English - 525 - Interviews to students, not valid for the final evaluation, will be conducted on a sample basis at an intermediate stage of the module in order to check the learning results and to verify if they meet those expected. Il metodo di accertamento prevede una prova scritta. La prova conterrà una serie di domande a risposta multipla finalizzate ad accertare la conoscenza teorica sugli argomenti affrontati a lezione. Essa comprenderà inoltre una domanda aperta inerente uno specifico aspetto teorico o applicativo. In alternativa potrà essere previsto una prova orale. ATTIVITÀ DI SUPPORTO Italiano Visita a imprese di prima e/o seconda trasformazione con analisi di processi/prodotti, dei principali schemi di certificazione di prodotto/sistema e degli aspetti inerenti la commercializzazione del legno. English Visit at enterprises of first and / or second transformation with analysis of the processes / products, the main certification schemes of product / system and the aspects related to the marketing of wood. PROGRAMMA Italiano Area di conoscenza: area dell'utilizzazione della materia prima legno e dei suoi derivati.Principali processi di trasformazione del legno. Prodotti a base di legno e loro impieghi. Normativa tecnica di settore e principali schemi di certificazione della filiera. Visita ad imprese di prima e/o seconda trasformazione con analisi di processi/prodotti e di problematiche inerenti i principali schemi di certificazione di prodotto e sistema. English Area of knowledge: utilization of wooden raw material and derived products. Main processes of wood transformation.Wood-based products and their uses. Technical standards and certification schemes of reference for the the wood supply chain.Visit at enterprises of first and / or second transformation with analysis of the processes / products, the main certification schemes of product / system and the aspects related to the marketing of wood. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano AA.VV. Wood Handbook. Wood as an Engineering Material (2010). General Technical Report FPL-GTR-190. Madison. Edito da "USDA - Forest Products Laboratory – United States Department of Agriculture Forest Service. Madison (Wisconsin): 509 pp. Berti S., Piazza M., Zanuttini R. (2002). Strutture di legno per un'edilizia sostenibile. Materie prime e prodotti. Progettazione e realizzazione. Collana: "Manuali dell'edilizia. Strumenti per progettisti e imprese". Ed. Il Sole 24 ore: 320 pp. Bulian F.(2011). Materiali e tecnologie dell'industria del mobile. Ed. L'Informa Professional: 308 pp. Cremonini C., Zanuttini R. (2009). Metrologia e gestione della strumentazione per il settore legno-arredo. Ed. Lampi di Stampa: 204 pp. Masiero M., Zorzi G.M. (2006) Qualità e certificazione nella filiera del legno. La catena di custodia. Ed. CCIAA di - 526 - Padova, PST Galileo, CNA Prov.le di Padova: 148 pp. Pettenella D., Secco L., Zanuttini R. (2000). La certificazione della gestione aziendale e dei prodotti nel sistema forestalegno. Ed. Regione Veneto, Direzione Foreste ed Economia Montana, maggio 2000: 252 pp. Mayo J. (2015). Solid Wood: Case Studies in Mass Timber Architecture, Technology and Design. Ed. Routledge. ISBN978-0415725293, 358 pp. English AA.VV. Wood Handbook. Wood as an Engineering Material (2010). General Technical Report FPL-GTR-190. Madison. Edito da "USDA - Forest Products Laboratory – United States Department of Agriculture Forest Service. Madison (Wisconsin): 509 pp. Berti S., Piazza M., Zanuttini R. (2002). Strutture di legno per un'edilizia sostenibile. Materie prime e prodotti. Progettazione e realizzazione. Collana: "Manuali dell'edilizia. Strumenti per progettisti e imprese". Ed. Il Sole 24 ore: 320 pp. Bulian F.(2011). Materiali e tecnologie dell'industria del mobile. Ed. L'Informa Professional: 308 pp. Cremonini C., Zanuttini R. (2009). Metrologia e gestione della strumentazione per il settore legno-arredo. Ed. Lampi di Stampa: 204 pp. Masiero M., Zorzi G.M. (2006) Qualità e certificazione nella filiera del legno. La catena di custodia. Ed. CCIAA di Padova, PST Galileo, CNA Prov.le di Padova: 148 pp. Pettenella D., Secco L., Zanuttini R. (2000). La certificazione della gestione aziendale e dei prodotti nel sistema forestalegno. Ed. Regione Veneto, Direzione Foreste ed Economia Montana, maggio 2000: 252 pp. Mayo J. (2015). Solid Wood: Case Studies in Mass Timber Architecture, Technology and Design. Ed. Routledge. ISBN978-0415725293, 358 pp. NOTA Italiano Il corso si svolge nella sede di Grugliasco English The location of the course is Grugliasco Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wbn5 - 527 - Mercato del legno e dei suoi derivati (Anno Accademico 2015/2016) WOOD MARKET AND BY-PRODUCTS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0371 Docente: Silvia NOVELLI (Affidamento interno) Contatti docente: +39 011 6708723, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/01 - economia ed estimo rurale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il modulo è parte del corso integrato "Filiera Legno", finalizzato alla preparazione di laureati con competenze specifiche nei processi di trasformazione del legno di carattere tecnico, gestionale, normativo ed economico, con particolare riferimento al settore delle lavorazioni industriali e della commercializzazione del legno massiccio e dei prodotti a base di legno. English The module is part of the course "chain Wood", in order to prepare graduates with specific skills in the processes of transformation of the wood of a technical, managerial, regulatory and economic conditions, with particular reference to the field of industrial manufacturing and marketing of solid wood and wood-based products. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Acquisire conoscenze tecniche ed economiche sui principali prodotti a base di legno e sul loro mercato, sui processi di trasformazione, sulla normativa tecnica di settore e sui sistemi di certificazione di filiera. English To acquire technical knowledge and economic information on major wood-based products and their market, the processes of the woodworking industries, their technical standards and the certification systems of the supply chain. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 528 - Italiano Il modulo consiste di 32 ore di lezione frontale e 8 ore dedicate visite presso imprese di prima e/o seconda trasformazione del legno. Per le lezioni frontali la docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. A seguito della visita in campo, gli studenti dovranno redigere una breve relazione su quanto osservato in azienda. English The module consists of 32 hours of lectures and 8 hours devoted to wood industry visits. Classes are held using Power Point slides, available to students on the web. After the field trip, students are asked to write a short report about their observations during the industry visits. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Al termine di ciascuna parte del programma (Parte 1 e 2) la docente procederà a una verifica dell'efficacia didattica mediante discussioni in aula sugli argomenti trattati, senza valore per la valutazione finale, ma utile agli studenti per stimare il proprio grado di apprendimento. L'esame finale è un colloquio orale. L'esame prevede due domande, una per ciascuna parte del corso (Parte 1 e 2), e una breve discussione della relazione sulle visite in azienda, mirata a verificare la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English At the end of each part of the syllabus (Part 1 and 2) the lecturer will test the teaching effectiveness through discussions in class. The intermediate verifications are not valid for the final evaluation, but helpful to the students to estimate their degree of learning. The final exam is an oral exam. The students will be asked two questions that cover the two parts of the syllabus (Part 1 and 2) and a short discussion of field visit report, in order to assess the understanding of the connections among the different areas of study. PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento della utilizzazione della materia prima legno e dei suoi drivati. Il programma si articola in due parti: PARTE 1 - le filiere e le aziende: Il sistema foresta-legno/filiere La domanda e la produzione dei prodotti legnosi La contabilità operativa delle imprese di trasformazione del legno PARTE 2 - il mercato del legno: Il mercato internazionale dei prodotti legnosi Il settore foresta-legno in Italia Il quadro regionale Cambiamenti strutturali e nuove tendenze nel mercato del legno - 529 - English The subjects, hereafter reported, are included in the learning area of tecnological processes in working wood. The syllabus is divided into two units of study: PART 1 - Wood chains and industries: The forests and wood-processing system/chain The demand and supply of wood products Study of the costs in the industrial enterprises of the wood industry PART 2 - Wood market: The international market for wood products The wood and forest-based sector in Italy The regional market for wood products Structural changes and current trends in the wood market TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Presentazioni Power-Point del corso, caricate a inizio corso sulla piattaforma Campusnet Unito. Testi consigliati: - Bernetti I., Romano S. (2007), Economia delle Risorse Forestali, Liguori Editore, Napoli - Merlo M. (1992), Elementi Economia ed Estimo Forestale ed Ambientale, Patron editore, Padova - Pettenella D. (2009), Le nuove sfide per il settore forestale. Mercato, nergie, ambiente e politiche. Ed. Tellus, Roma English PowerPoint presentations. The presentations will be uploaded to the platform Campusnet Unito at the beginning of the course. Recommended textbooks: - Bernetti I., Romano S. (2007), Economia delle Risorse Forestali, Liguori Editore, Napoli - Merlo M. (1992), Elementi Economia ed Estimo Forestale ed Ambientale, Patron editore, Padova - Pettenella D. (2009), Le nuove sfide per il settore forestale. Mercato, energie, ambiente e politiche. Ed. Tellus, Roma NOTA Italiano English - 530 - Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=utxc - 531 - Filiera post-raccolta in ortoflorofrutticoltura - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) STORAGE AND POST HARVESTING OF CROPS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0378 Docente: Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Prof. Silvana NICOLA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708800, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 - orticoltura e floricoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Colture frutticole (Anno Accademico 2015/2016) Colture orto-floricole (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jq1r Colture frutticole (Anno Accademico 2015/2016) Fruit and nut crops Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0378 Docente: Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708800, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale - 532 - PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire le conoscenze sulle tecniche di gestione del post-raccolta dei prodotti frutticoli in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei frutti, della loro fisiologia di maturazione e della destinazione d'uso. English To provide knowledge on the techniques used in the post-harvest management of horticultural crops based on their chemical and physical characteristics, the ripening physiology and decay, and the commercial use. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente acquisirà le conoscenze e le competenze necessarie per gestire il post-raccolta delle principali specie arboree da frutto con particolare riferimento a quelle dei climi temperati. English The student will acquire the knowledge and skills to manage the post -harvest of the main fruit species with particular reference to those of temperate climates. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Tradizionale English Traditional MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'esame sarà orale e prevede in linea di massima 3 domande su argomenti diversi; il docente potrà fare ulteriori domande qualora questo fosse necessario per la miglior valutazione della preparazione dello studente. Ogni domanda avrà uguale peso ai fini della formazione del voto finale. English Oral test. As general rule the exam is based on 3 questions on different arguments; the teacher may ask further questions in case this is considered necessary for the most appropriate evaluation of the student. Each question will have the same weight for the attribution of the final mark. PROGRAMMA Italiano - 533 - La frutta nel mercato globale. Importanza economica del settore. Principale normativa che riguarda la frutta: impiego del gas etilene; norme di qualità per i prodotti destinati al consumo fresco. Concetto di qualità nella filiera frutticola. Composizione chimica dei frutti e cambiamenti che si verificano durante la maturazione (respirazione, struttura, colore, composizione chimica, caratteristiche organolettiche). Ruolo dell'etilene e controllo genetico della maturazione. Possibilità di controllo della sintesi dell'etilene e dei processi di maturazione. Fattori di pre- e post-raccolta che influenzano la qualità dei frutti. Scelta dell'epoca e delle modalità di raccolta in base agli indici di maturazione. Filiera frutta fresca: campionatura e controlli di qualità (indici di qualità; metodi strumentali, sistemi semi automatici, valutazione sensoriale); condizionamento; metodi di selezione (calibratura, selezionatrici ottiche, prospettive di impiego di NIRS, NMR); pre-refrigerazione; trattamenti particolari (estetici, per la prevenzione di patogeni e fisiopatie); conservazione; imballaggio; trasporto. Prodotti di IV gamma Filiera frutta secca: preparazione per il mercato dei frutti in guscio o lavorazione per l'industria (pre-calibratura, sgusciatura, selezione, calibratura, conservazione, trasporto); produzione di semilavorati. Mantenimento della qualità mediante le tecniche di conservazione e la gestione della catena del freddo: controllo della temperatura; modificazione dell'atmosfera (AC, ULO); mantenimento dell'UR; rimozione dell'etilene. Caratteristiche delle celle di conservazione ed accorgimenti tecnici idonei a garantirne la funzionalità. Apparecchiature per la messa a regime delle celle. Principali alterazioni fisiologiche durante il post-raccolta. English Fruits in the global market. Economic importance of the sector. Main legislation concerning fruit handling and trading including allowed treatments with ethylene and the EU and National regulations on fruit marketing standards. Definition of fruit quality. Fruit chemical and physical traits and their changes during ripening. Role of ethylene and genetic control of ripening. Means for controlling fruit ripening and ethylene synthesis. Pre- and post-harvest factors that influence fruit quality. Choosing time and harvesting technique. The fresh fruit chain: sampling fruits and evaluating quality (quality indexes; instrumental methods, semi-automated methods, sensory evaluation); fruit conditioning; fruit selection (sizing and sorting methods); pre-refrigeration; treatments on fruit (washing, waxing, treating to prevent disorders and pathogens); storage; packaging; transportation. The maintaining of fruit quality during storage. Management of refrigeration. Setting and management of modified atmosphere; management of relative humidity; ethylene removal. Technical characteristics of storage chambers. The nut crops chain: preparing nuts for the fresh market; preparing nuts for the processing industry (pre-calibration, shelling, selection, sizing, storage, transportation); production of paste and chopped nuts. Emphasis on the hazelnut chain. Main disorders of fruit and nuts occurring in post-harvest TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Kader A.(editor). 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California ANR . Pub. n. 3311. Terza edizione. - 534 - Knee M. –2002 – Fruit quality and its biological basis. CRC Press. USA Kays J.K., Paull R.E. – 2004 – Postharvest biology. Exon Press. USA Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. English Kader A.(editor). 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California ANR . Pub. n. 3311. Terza edizione. Knee M. –2002 – Fruit quality and its biological basis. CRC Press. USA Kays J.K., Paull R.E. – 2004 – Postharvest biology. Exon Press. USA Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6upk - 535 - Colture orto-floricole (Anno Accademico 2015/2016) Vegetable and ornamental crops Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0378 Docente: Prof. Silvana NICOLA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708773, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 4 SSD attvità didattica: AGR/04 - orticoltura e floricoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Apprendere le informazioni necessarie per una gestione del post-raccolta dell'ortofrutta, sia relativamente ai prodotti freschi sia ai prodotti lavorati, al fine della più corretta gestione della filiera, dalla produzione alla tavola. English Capacity building for an independent and knowledgeable evaluation of postharvest fresh and ready-to-eat produce in terms of quality to enhance the food chain efficiency, from farm to the table. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Apprendere le basi tecniche e biologiche per la gestione post-raccolta. Sviluppare le conoscenze di base sui fattori relativi alla perdita di qualità degli ortaggi in post-raccolta e durante le lavorazioni. Lo studente riceverà le informazioni e gli strumenti per comprendere i criteri di base sia biologici sia tecnico-colturali e tecnologici con cui i prodotti orticoli vengono ottenuti in campo, gestiti in post-raccolta e disponibili per il consumatore finale. Lo studente potrà essere in grado di sviluppare la sua comprensione delle filiere orticole attraverso l'apprendimento e gli approfondimento di casi specifici di suo interesse e di casi affidati dal docente. English Learning the technical and biological bases for high quality vegetable post-harvest handling. Enhancing the basic knowledge related to the factors that affect quality decay during post-harvest handling and processing. The students shall receive the information and the tools to understand the fundamentals behind cultural, technical and technological practices that make up the raw material and its post-harvest handling up to the consumer. The students shall be able to better understand the fresh produce chain even through practical laboratory exercises and - 536 - case studies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il modulo consiste di 30 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The class includes 30 hours of lectures plus 10 hours of laboratory. Visul aids are used in power point format and available to students MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti viene valutato periodicamente durante il corso attraverso esercitazioni e discussioni in aula su argomenti trattati con assegnazione di quesiti verbali sulle tematiche. Reports in itinere Test finale Lavori di laboratorio/casi studio English Progress of students' learning is assessed in class periodically by interacting discussion and problem solving verbal assignment on the topics taught in the previous classes. Mid-term reports Final test Lab and case studies. PROGRAMMA Italiano Aree di apprendimento: Produzioni vegetali. Introduzione al corso, obiettivi, finalità, materiale, risultati attesi. Introduzione: importanza delle tecniche post-raccolta nel settore. Definizione degli standard qualitativi delle produzioni. Importanza delle produzioni sui mercati internazionali. Le tipologie e le categorie di ortaggi da un punto di vista botanico, organografico e commerciale. La gestione post-raccolta degli ortaggi in base all'organografia: problematiche fisiologiche, gestionali e commerciali Aspetti fisiologici della senescenza delle produzioni. Influenza delle tecniche gestionali in pre e post raccolta sulla qualità delle produzioni. Scelta dei tempi e modalità di raccolta. Mantenimento della qualità delle produzioni in postraccolta. Le problematiche post-raccolta degli ortaggi freschi (I gamma). Fisiologia, raccolta e gestione post-raccolta. Pratiche commerciali Le problematiche degli ortaggi freschi (IV gamma). Fisiologia, raccolta e gestione post-raccolta. - 537 - English Scope: Production of products of plant origin. Course introduction, objectives, means, course materials and methods, results expected. Introduction: role of postharvest in produce. Quality parameters. Market National and International facts and figures. Categories and typologies of vegetables. Organography. Botanical and commercial classifications. Postharvest physiology, handling and marketing based on edible organs involved. Senescence aspects. Pre-harvest factors affecting postharvest quality and handling. Harvesting optimal requirements. Quality maintenance and decay after harvest. Fresh produce: harvest and postharvest handling and physiology. Commercial practices Fresh-cut produce: harvest and postharvest handling and physiology. Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento della produzione dei vegetali. English Contents of the course are related to production fresh produce TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Diapositive presentate a lezione come supporto. I testi consigliati di approfondimento per il corso sono: W. J. Florkowski, S. E. Prussia, R. Shewfelt and B. Breuckner (Eds). 2009. Postharvest Handling. A systems Approach.. Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. W. J. Florkowski, R. Shewfelt, B. Breuckner and S. E. Prussia (Eds). 2014. Postharvest handling: a systems approach (Third ed.). Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. ISBN: 978-012-408137-6. pp. 564+xxii (624 pp). Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: Articoli e pubblicazioni forniti durante il corso. Infine sono di seguito indicati siti internet di interesse: - 538 - Siti istituzionali statistici italiani, europei ed internazionali. Portali delle filiere ortofrutticole nazionali di diversi Paesi. English Reading material: Slides presented in class. W. J. Florkowski, S. E. Prussia, R. Shewfelt and B. Breuckner (Eds). 2009. Postharvest Handling. A systems Approach.. Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. W. J. Florkowski, R. Shewfelt, B. Breuckner and S. E. Prussia (Eds). 2014. Postharvest handling: a systems approach (Third ed.). Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. ISBN: 978-012-408137-6. pp. 564+xxii (624 pp). Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. Material suggested in class Official websites to be consulted: Institutional statistical websites of Italy, EU, international, FAO. Portals related to produce at national and international level. NOTA Italiano Pre-requisiti: Chimica generale ed analitica; Chimica organica; Biologia. English Basic knowledge of chemistry and biology is required. Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zbs4 - 539 - Filiere cerealicole e delle colture industriali erbacee (Anno Accademico 2015/2016) CEREAL AND HERBACEOUS CROPS CHAIN Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0344 Docente: Prof. Amedeo REYNERI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708778, [email protected] Corso di studio: [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Approfondire la conoscenza del settore produttivo delle grandi coltivazioni erbacee (commodities) con riferimento agli aspetti che influenzano la qualità di tali colture, le relazioni tra ambiente e qualità, gli usi agro-industriali. Si esaminerà nel dettaglio la valorizzazione dei prodotti in un'ottica di tracciabilità dell'intera filiera agro-alimentare, fornendo l'occasione applicativa per sviluppare progetti volti al controllo della qualità globale delle produzioni sull'insieme del processo dei prodotti finali. English The aim of the course is the knowledge of the commodity (cereals) productions system; the relationships between the technological aspects, the environment and the processes will be focused. In details the products valorization will be examined considering the food system and the traceability of the products through the chains. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Disporre delle nozioni fondamentali per la valutazione qualitativa delle produzioni erbacee di rilevante impiego nell'agroindustria. Conoscenza degli approcci critici per la valutazione delle filiere esistenti e per la messa a punto di nuove e più aggiornate filiere. English - 540 - The student will learn the basic information for the qualitative and technological aspects of the most diffuse commodities utilized in the agro-industry. The knowledge will be focused on the analysis of the constrains of the food chains and of the possibility to introduce innovation. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste in 36 ore di lezioni frontali, di 16 ore di studio coordinato con esame colegiale di casi di studio e di 8 ore di visite tecniche in campo e in stabilimenti cerealicoli. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide a disposizione degli studenti. English The course concerns 36 hours of classroom lectures, 16 hours of case study analysis and 8 hours of fields and cereal plants visits. For the classroom lecture slides will be employed and dispensed to the students. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica sarà effettuata in itinere mediante test sulle nozioni sulla parte del programma svolta. La verifica finale avverrà mediante la presentazione di un elaborato su un caso di studio relativo ad un tema originale a scelta dello studente e quindi mediante un esame orale. English The learning test will be carry on during the course on the part of program already presented. The final test will be organized through the presentation of a case study originally selected by the student and then an oral examination. PROGRAMMA Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento delle filiere e della qualità delle materie prime. I seguenti argomenti saranno trattati Introduzione del corso: obiettivi, relazioni con altri corsi, organizzazione del corso e dell'esame, libri di testo. Le Commodities alimentari: rilevanza,mercati, caratteri delle filiere, evoluzione recente L'approccio di filiera: aspetti delle filiere delle grandi colture, organizzazione, mercati, trasformazione, concetto di qualità La filiera del Frumento: rilevanza in Italia, UE e nel mondo, produzioni, cenni sulla tecnologia di produzione. Prodotti, sottoprodotti, qualità, tecnologia di conservazione, trasformazione, struttura della filiera. Caso di studio: Frumento duro e qualità. La pasta: qualità e materia prima. Evoluzione della qualità del frumento e dei sistemi colturali ad esso legati. Soluzionie prospettive. La filiera del mais: rilevanza in Italia, UE e nel mondo, produzioni, cenni sulla tecnologia di produzione. Prodotti, sottoprodotti, qualità, tecnologia di conservazione, trasformazione, struttura della filiera. - 541 - Caso di studio: controllo e gestione delle micotossine e altri contaminanti definizioni, aspetti normativi e tossicologici. Controllo delle tossine lungo la filiera. Controlli di filiera e regolamenti HACCP. La filiera degli oli e delle proteine vegetali: rilevanzain Italia, UE e nel mondo, produzioni, cenni sulle tecnologie di produzione. Prodotti, sottoprodotti, qualità, tecnologia di conservazione, struttura della filiera. Caso di studio: Coesistenza tra filiere OGM e convenzionali: il problema del flusso genico e delle contaminazioni, le esigenze del mercato alimentare e zootecnico. Normative e piani di coesistenza. La filiera del Riso: rilevanza in Italia, UE e nel mondo, produzioni, cenni sulla tecnologia di produzione. Prodotti, sottoprodotti, qualità, tecnologia di conservazione, trasformazione, struttura della filiera. Caso di studio: Alimenti funzionali a base di cereali. Componenti con valenza funzionale e bioattiva. English The class focuses on subject that are configured in the learning context of supply chain and raw material quality. Introduction: objective, relationship with other courses, organization, evaluation, references. The food commodity: relevance, market, trade, food systems The food chain approach: general aspects, chain organization, transformation, quality concept The wheat food chain: relevance, market and trade in Italy, UE and world, trade, food systems. Products and byproducts, technology of conservation and processing. Case study: durum wheat and pasta quality in Italy The maize food chain: relevance, market and trade in Italy, UE and world, trade, food systems. Products and byproducts, technology of conservation and processing. Case study: management and control of the mycotoxins on cereal and maize food chains The soybean and sunflower food chains: relevance, market and trade in Italy, UE and world, trade, food systems. Products and byproducts, technology of conservation and processing. Case study: coexistence among GM crops and conventional crop The rice food chain: relevance, market and trade in Italy, UE and world, trade, food systems. Products and byproducts, technology of conservation and processing. Case study: enrichment of bioactive compounds in cereal products TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano 1) AAVV. Il mais (Coord. Angelini) Ed. ART, Bologna 2008 (Bayer Crop Science) 2) AAVV. Il grano (Coord. Angelini) Ed. ART, Bologna 2008 (Bayer Crop Science) 3) Giardini. Colture erbacee: oliaginose. Patron, Padova 4) Cinquetti. Industria del mais. Chiriotti Editori. Pinerolo - 542 - English 1) AAVV. Il mais (Coord. Angelini) Ed. ART, Bologna 2008 (Bayer Crop Science) 2) AAVV. Il grano (Coord. Angelini) Ed. ART, Bologna 2008 (Bayer Crop Science) 3) Giardini. Colture erbacee: oliaginose. Patron, Padova 4) Cinquetti. Industria del mais. Chiriotti Editori. Pinerolo NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u4to - 543 - Filiere e qualità dei prodotti orticoli (Anno Accademico 2015/2016) HORTICULTURAL QUALITY AND CHAIN Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0349 Docente: Prof. Silvana NICOLA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708773, [email protected] Corso di studio: [f001-c503] LM - Scienze e tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: AGR/04 - orticoltura e floricoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Apprendere le informazioni necessarie per una autonoma valutazione delle caratteristiche qualitative dei principali ortaggi impiegati nella alimentazione umana, sia relativamente ai prodotti freschi sia ai prodotti lavorati, al fine della più corretta gestione della filiera, dalla produzione alla tavola. English Capacity building for an independent and knowledgeable evaluation of fresh and ready-to-eat produce in terms of quality to enhance the food chain efficiency, from farm to the table. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Apprendere le basi tecniche e biologiche per la produzione di ortaggi di qualità e per la gestione post-raccolta. Sviluppare le conoscenze di base sui fattori relativi alla perdita di qualità degli ortaggi in post-raccolta e durante le lavorazioni. Lo studente riceverà le informazioni e gli strumenti per comprendere i criteri di base sia biologici sia tecnico-colturali e tecnologici con cui i prodotti orticoli vengono ottenuti in campo, gestiti in post-raccolta e disponibili per il consumatore finale. Lo studente potrà essere in grado di sviluppare la sua comprensione delle filiere orticole attraverso l'apprendimento ed i laboratori di approfondimento di casi specifici di suo interesse e di casi affidati dal docente. English Learning the technical and biological bases for high quality vegetable production and post-harvest handling. - 544 - Enhancing the basic knowledge related to the factors that affect quality decay during post-harvest handling and processing. The students shall receive the information and the tools to understand the fundamentals behind cultural, technical and technological practices that make up the raw material and its post-harvest handling up to the consumer. The students shall be able to better understand the fresh produce chain even though practical laboratory exercises and case studies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 50 ore di lezione frontale e 10 ore dedicate a attività di laboratorio. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e slide che sono a disposizione degli studenti. English The class includes 50 hours of lectures plus 10 hours of laboratory. Visul aids are used in power point format and available to students MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il grado di apprendimento raggiunto dagli studenti viene valutato periodicamente durante il corso attraverso esercitazioni e discussioni in aula su argomenti trattati con assegnazione di quesiti verbali sulle tematiche. English Progress of students' learning is assessed in class periodically by interacting discussion and problem solving verbal assignment on the topics taught in the previous classes. PROGRAMMA Italiano Aree di apprendimento: filiere e qualità delle materia prime. Introduzione al corso, obiettivi, finalità, materiale, risultati attesi. Introduzione: importanza delle tecniche post-raccolta nel settore. Definizione degli standard qualitativi delle produzioni. Importanza delle produzioni sui mercati internazionali. Le tipologie e le categorie di ortaggi da un punto di vista botanico, organografico e commerciale. Le caratteristiche qualitative degli ortaggi. La gestione post-raccolta degli ortaggi in base all'organografia: problematiche fisiologiche, gestionali e commerciali Aspetti fisiologici della senescenza delle produzioni. Influenza delle tecniche gestionali in pre e post raccolta sulla qualità delle produzioni. Scelta dei tempi e modalità di raccolta. Mantenimento della qualità delle produzioni in postraccolta. Le problematiche post-raccolta degli ortaggi freschi (I gamma). Fisiologia, raccolta e gestione post-raccolta. Pratiche commerciali. - 545 - Le problematiche degli ortaggi freschi (IV gamma). Fisiologia, raccolta e gestione post-raccolta. English Scope: Production and supply chain and quality of fresh produce. Course introduction, objectives, means, course materials and methods, results expected. Introduction: role of postharvest in produce. Quality parameters. Market National and International facts and figures. Categories and typologies of vegetables. Organography. Botanical and commercial classifications. Qualitative characteristics of vegetables. Postharvest physiology, handling and marketing based on edible organs involved. Senescence aspects. Pre-harvest factors affecting postharvest quality and handling. Harvesting optimal requirements. Quality maintenance and decay after harvest. Fresh produce: harvest and postharvest handling and physiology. Commercial practices. Fresh-cut produce: harvest and postharvest handling and physiology. Italiano I contenuti del corso rientrano nell'area di apprendimento delle filiere e qualità delle materia prime, in particolare della produzione e della gestione degli ortaggi. English Contents of the course are related to production and supply chain and quality of fresh produce, particularly on the production and postharvest handling of fresh produce TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Diapositive presentate a lezione come supporto. I testi consigliati di approfondimento per il corso sono: W. J. Florkowski, S. E. Prussia, R. Shewfelt and B. Breuckner (Eds). 2009. Postharvest Handling. A systems Approach.. Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. W. J. Florkowski, R. Shewfelt, B. Breuckner and S. E. Prussia (Eds). 2014. Postharvest handling: a systems approach (Third ed.). Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. ISBN: 978-012-408137-6. pp. 564+xxii (624 pp). Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. E' fortemente consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: Articoli e pubblicazioni forniti durante il corso. - 546 - Infine sono di seguito indicati siti internet di interesse: Siti istituzionali statistici italiani, europei ed internazionali. Portali delle filiere ortofrutticole nazionali di diversi Paesi. English Slides presented in class. Reading material: W. J. Florkowski, S. E. Prussia, R. Shewfelt and B. Breuckner (Eds). 2009. Postharvest Handling. A systems Approach.. Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. W. J. Florkowski, R. Shewfelt, B. Breuckner and S. E. Prussia (Eds). 2014. Postharvest handling: a systems approach (Third ed.). Academic Press / Elsevier, San Diego, CA, USA. ISBN: 978-012-408137-6. pp. 564+xxii (624 pp). Beni C. Iannicelli V., Di Dio C. – 2001 – Il condizionamento dei prodotti ortofrutticoli. Calderini Edagricole. Material suggested in class Official websites to be consulted: Institutional statistical websites of Italy, EU, international, FAO. Portals related to produce at national and international level. NOTA Italiano Pre-requisiti: Chimica generale ed analitica; Chimica organica; Biologia. English Basic knowledge of chemistry and biology is required Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q6ns - 547 - Fisica (Anno Accademico 2015/2016) PHYSICS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0051 Docente: Maria Margherita OBERTINO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708602, [email protected] Corso di studio: [f001-c711] L - Scienze forestali e ambientali [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: FIS/01 - fisica sperimentale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso intende fornire gli elementi necessari per la comprensione dei principali fenomeni fisici e delle leggi che li regolano. Si approfondiranno maggiormente gli aspetti di base considerati utili per la comprensione degli argomenti che lo studente incontrerà nel proseguimento dei suoi studi. La trattazione formale sarà integrata con la presentazione di applicazioni a casi concreti, con particolare riferimento al settore agro-forestale quando possibile. English The course is meant to provide the basic elements necessary for the understanding of natural physical phenomena and their laws. It is focused on the concepts necessary for a better understanding of the arguments that students encounter in their carrier, and is carried out with particular reference to applications, specifically in the agroforestry sector whenever possible. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Il corso fornisce allo studente le basi del metodo scientifico che sono comuni a tutte le discipline sperimentali, assieme ad una scelta significativa di argomenti della fisica classica, presentati anche mediante esperienze di vita quotidiana. Lo studente apprenderà, inoltre, le metodologie per analizzare un semplice problema e per giungere alla definizione di adeguate strategie di soluzione. - 548 - English The course provides the student with the basis of the scientific method common to all experimental disciplines, together with a significant choice of topics in classical physics, including examples from everyday life. Students will be able to analyse basic problems and find adeguate solution strategies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezioni frontali durante le quali vengono trattati tutti gli argomenti in programma. Per favorire la comprensione i concetti presentati vengono applicati alla risoluzione di esercizi di cui si illustra in dettaglio lo svolgimento. Per le lezioni frontali la docente si avvale di presentazioni e slide disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle. English The course is organized in frontal lectures (60 hours) where the various topics are presented and explained. The most relevant concepts are applied to the detailed solution of exercises and specific problems. Slides used by the professor during lectures are made available to students on the e-learning Moodle system. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'apprendimento viene verificato costantemente durante tutto il corso attraverso domande a scelta multipla commentate con gli studenti ed esercizi svolti dagli studenti in aula. Sono inoltre previsti, a metà e al termine del corso, due test con struttura simile alla prova scritta d'esame. Tali test, il cui esito non ha alcun peso sulla valutazione finale, consentiranno agli studenti di verificare il proprio grado di apprendimento e di comprendere appieno le modalità della prova scritta d'esame. L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale facoltativa. La prova scritta è costituita da un test con 15 domande a risposta multipla e 4 esercizi di cui verrà valutato l'intero svolgimento. Solo gli studenti che avranno superato la prova scritta con votazione minima di 18/30 potranno richiedere di sostenere il colloquio orale (facoltativo). In tal caso il voto finale sarà la media aritmetica delle votazioni ottenute nelle due prove, orale e scritta, con arrotondamento all'intero più vicino. English To insure the comprehension before new topics are introduced, learning is verified by means of discussion on multiple choice questions and exercises solved by students in class. Moreover, two tests, with a strucure similar to the one of the written exam, are foreseen in the middle and at the end of the course. These tests are meant to be mainly self-evaluation tools for students; their result will not affect the final evaluation. The final exam is organized as a written and an optional oral part. The written exam consists of a multiple choice tests (15 questions) and 4 exercises. Only students who have passed the written exam (grade greater or equal to 18/30) will qualify for the oral exam (optional). In thi case the final grade will be the average of the grades obtained in the written and oral part, rounded to the nearest whole number. ATTIVITÀ DI SUPPORTO - 549 - Italiano Per ogni argomento in programma vengono resi disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle test di autovalutazione costituiti da domande a scelta multipla. Sono previste sessioni di tutorato (circa 20 ore, facoltative) in cui gli studenti vengono aiutati nel risolvere gli esercizi proposti al termine di ogni macro-argomento del programma. English Multiple choice self-evaluation tests are made available for each topic on Moodle e-learning system. A tutor will help students to solve the exercises proposed at the end of each topic (optional; 20 hours in total) PROGRAMMA Italiano Tutti gli argomenti del programma afferiscono all'area delle conoscenze propedeutiche. 1. Grandezze fisiche e unità di misura Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Unità di misura. Il sistema internazionale. Analisi dimensionale. Conversione di unità di misura. Notazione scientifica. Calcoli di ordini di grandezza. 2. Grandezze scalari e vettoriali Grandezze scalari. Grandezze vettoriali. Uguaglianza di due vettori. Somma e differenza di vettori. Versori. Componenti di un vettore. Moltiplicazione di un vettore per uno scalare. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. 3. Cinematica Sistema di riferimento. Posizione, traiettoria. Velocità media e istantanea. Accelerazione media, istantanea, tangenziale e radiale. Diagramma del moto. Moto unidimensionale. Moto rettilineo, moto uniforme, moto uniformemente accelerato. Caduta di un grave. Moto in due dimensioni. Moto parabolico. Moto periodico, periodo e frequenza. Moto armonico semplice. Moto circolare uniforme. Posizione, velocità e accelerazione angolare; relazioni fra grandezze rotazionali e traslazionali. 4. Dinamica: forze e leggi di Newton Concetto di forza. Le tre leggi di Newton. Forza gravitazionale. Differenza tra massa e peso. Condizione di equilibrio traslazionale. Reazioni vincolari. Forza centripeta e centrifuga. Forza elastica. Attrito statico e dinamico. 5. Dinamica: lavoro ed energia Lavoro meccanico. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica. Forze conservative e energia potenziale. Energia meccanica e sua conservazione. Lavoro delle forze non conservative. Potenza. 6. Quantità di moto e urti Impulso di una forza e quantità di moto. Sistemi isolati e conservazione della quantità di moto. Urti elastici ed anelastici in una dimensione. 7. Corpi rigidi in rotazione e statica Energia cinetica rotazionale. Momento d'inerzia. Momento di una forza. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Baricentro. Esempi di corpi rigidi in equilibrio statico. Momento angolare e sua conservazione. 8. Meccanica dei fluidi: idrostatica - 550 - Densità. Pressione. Principio di Pascal. Pressione idrostatica e legge di Stevino. Legge di Archimede e galleggiamento. 9. Meccanica dei fluidi: fluidodinamica Fluidi ideali. Portata di un fluido. Equazione di continuità. Equazione di Bernoulli e sue applicazioni. Fluidi reali. Viscosità. Resistenza idrodinamica. Flusso laminare e turbolento. Forza di attrito viscoso e legge di Stokes. Sedimentazione. Centrifugazione. 10. Temperatura e gas perfetti Temperatura ed equilibrio termico. Descrizione macroscopica dei gas perfetti e loro equazione di stato. Miscele di gas. Pressione parziale. Equilibrio gas-liquido. Legge di Henry. 11. Calorimetria e termodinamica Calore. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di fase e calore latente. Meccanismi di trasmissione del calore: convezione, conduzione ed irraggiamento. Lavoro in una trasformazione termodinamica. Energia interna. Il primo principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche: trasformazione isobara, isocora, isotermica ed adiabatica. Macchine termiche e il secondo principio della termodinamica. Rendimento termodinamico. Processi reversibili ed irreversibili. Macchine frigorifere. 12. Elettricità e magnetismo Carica elettrica, legge di Coulomb. Campo elettrico. Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrico e differenza di potenziale. Corrente elettrica. Resistenza elettrica e prima legge di Ohm. Resistività e seconda legge di Ohm. Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata. Potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Resistenze in serie e parallelo. Capacità elettrica e condensatori. Condensatori in serie e parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Circuiti RC. Campo magnetico. Forza di Lorentz. Spettrometro di massa. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti: filo rettilineo, spira e solenoide. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-Lenz. 13. Onde meccaniche e suono Caratteristiche di un'onda: frequenza, periodo, lunghezza d'onda, velocità. Onde longitudinali e trasversali. Onde acustiche, infrasuoni, suoni e ultrasuoni. 14. Onde elettromagnetiche Caratteristiche principali delle onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Natura corpuscolare delle onde elettromagnetiche; il fotone. English All the arguments are included in the area of introductory studies. 1. Physics and measurement Fundamental and derived quantities. Units of measurement. The international System of units (SI system). Dimensional analysis. Convertion of units. Scientific notation. Order-of-magnitude calculations. 2. Vectors and scalars - 551 - Vector and scalar quantities. Equality of two vectors. Adding and subtracting vectors. Unit vectors. Components of a vector. Product of a scalar and vector. Scalar and vector product of two vectors. 3. Kinematics Coordinate systems. Position and trajectory. Average and instantaneous velocity. Average and instantaneous, centripetal and tangential acceleration. Motion diagrams. One-dimensional motion. Rectilinear motion. Onedimensional motion at a constant velocity. One-dimensional motion at a constant acceleration. Freely falling objects. Two-dimensional motion. Parabolic motion. Periodic motion, period and frequency. Simple harmonic motion. Uniform circular motion. Angular position, velocity and acceleration. Relation between angular and linear quantities. 4. Dynamics: forces and laws of motion The concept of force. Newton's laws. Gravitational force. Mass and weight. Translational Equilibrium. Centripetal and centrifugal force. Elastic force. Force of static and kinetic friction. 5. Dynamics: energy and work Work done by a force. Kinetic energy and work-kinetic energy theorem. Conservative forces and potential energy. Mechanical energy and its conservation. Work of non-conservative forces. Concept of power. 6. Linear momentum and collisions Impulse and linear momentum. Isolated systems and linear momentum conservation. Elastic and inelastic collisions in one dimension. 7. Rotation of rigid objects and statics Rotational kinetic energy. Moment of inertia. Torque. Conditions of static equilibrium. The center of gravity. Examples of rigid object in static equilibrium. Angular momentum and its conservation. 8. Hydrostatics Density. Pressure. Pascal's law. Variation of pressure with depth. Archimede's principle. 9. Fluid dynamics Ideal fluid. Flow rate. Equation of continuity. Bernoulli's equation. Applications of Bernoulli's equation. Real fluid. Viscosity. Hydrodynamic resistance. Laminar and turbulent flow. Viscous resistance and Stokes' law. Sedimentation. Centrifugation. 10. Temperature and gases Temperature and thermal equilibrium. Macroscopic description of an ideal gas. Equation of state for an ideal gas. Mixture of gases. Partial pressure. Liquid-gas equilibrium. Henry's Law. 11. Heat and laws of thermodynamics Heat. Heat capacity and specific heat. Phase changes and latent heat. Mechanisms of heat transfer: convection, conduction and radiation. Work in a thermodynamic process. Internal energy. The first law of Thermodynamics. Isobaric, isovolumetric, isothermal and adiabatic processes. Heat engines and the second law of thermodynamics. Thermodynamic efficiency. Reversible and irreversible processes. Refrigerators. - 552 - 12. Electricity and magnetism Electric charge. Coulomb's law. Electric field. Electric potential energy, electric potential and potential difference. Electric current. Resistance and the first Ohm's law. Resistivity and the second Ohm's law. Direct and alternating current. Electrical power. Joule effect. Resistors in series and in parallel. Capacitance and capacitors. Capacitors in series and in parallel. Energy stored in a charged capacitor. RC circuits. Magnetic field. Lorentz force. Mass spectrometer. Magnetic force acting on a current-carrying conductor. Magnetic field generated by a current-carrying conductor. Magnetic field flux. Faraday-Lenz's law. 13. Mechanical waves and sound Main characteristics: frequency, period, wavelength, velocity. Longitudinal and transverse waves. Sound waves, ultrasound, infrasound. 14. Electromagnertic waves Main characteristics of electromagnetic waves. The spectrum of electromagnetic waves. The dual nature of light; the photon. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Serway - Jewett: Principi di Fisica, EdiSES Editore, Napoli Walker: Fondamenti di Fisica, Pearson Lucidi delle lezioni, esercizi ed altro materiale disponibile sulla piattaforma e-learnig Moodle English Serway - Jewett: Principi di Fisica, EdiSES Editore, Napoli Walker: Fondamenti di Fisica, Pearson Slides, exercises and other material available on the Moodle e-learning system NOTA Italiano English Mutuato da: Nessuno / None Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q554 - 553 - Fisica (Anno Accademico 2015/2016) PHYSICS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0016 Docente: Ing. Davide RICAUDA AIMONINO (Affidamento interno) Prof. Roberto Cirio (Affidamento interno) Contatti docente: 011 670 8890, [email protected] Corso di studio: [f001-c702] L - Viticoltura ed enologia [f001-c703] L - Tecnologie alimentari Anno: 1° anno Tipologia: A - Di base Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: FIS/01 - fisica sperimentale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None PROPEDEUTICO A Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Vengono forniti gli elementi di base per la comprensione dei fenomeni fisici appartenenti sia ai processi naturali che alle principali applicazioni tecnologiche con particolare riferimento al settore agro-alimentare. Lo studio viene articolato in modo da sviluppare le capacità di formalizzazione matematica dei fenomeni. Il corso viene svolto con particolari riferimenti applicativi, aggiungendo all'aspetto formale l'applicazione a casi di studio. English Basic elements and concepts about physic phenomena as well as analysis ability of a problem in order to achieve effective solution strategies will be provide during the course, with particular care to the main technological applications in food production sector. The course will carry out considering a number of case studies beside theoretical concepts. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza di base dei concetti fondamentali relativi alla cinematica, alla dinamica dei corpi, alla meccanica dei fluidi ed alla trasmissione del calore propedeutici alle materie professionalizzanti. Lo studente apprenderà, inoltre, le metodologie per analizzare un semplice problema per giungere alla definizione di adeguate strategie di soluzione. - 554 - English Basic knowledge of fundamental concepts about kinematics, dynamics, fluids mechanics and heat transfer, which are preparatory to subsequent specialist courses. The student will be able to analyse basic problems achieving adequate solution strategies. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso prevede 60 ore di lezione frontale durante le quali il docente si avvarrà di presentazioni che verranno rese disponibili agli studenti sulla piattaforma e-learning di ateneo Moodle. Durante le lezioni verranno, inoltre, svolti esempi ed esercizi per agevolare la comprensione degli argomenti trattati. English The course includes 60 hours of lectures during which slides will be presented together other materials (e.g. short clips). All materials will be available on Moodle e-learning platform. Exercises and examples undertaken will be also proposed to help comprehension about the different arguments. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso gli studenti potranno verificare progressivamente la loro preparazione mediante test ed esercizi di autovalutazione disponibili su piattaforma e-learning Moodle. Verranno inoltre proposti esercizi svolti e commentati in aula con gli studenti al termine di ciascun argomento. L'esame finale è in forma scritta costituito un test a risposta multipla e da alcuni esercizi (3-5) di calcolo relativi ai diversi argomenti svolti. Se l'esito della prova scritta è positivo lo studente può richiedere un colloquio orale opzionale, durante il quale, oltre alla discussione della prova scritta, prevede la verifica approfondita della capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite. English During the course students can verify their knowledge by self-evaluation tests and exercises available on Moodle elearning platform. Exercises will be also carried out and discussed with students at the end of each topic. The final exam is in writing and consists in a test with multiple choice and some exercises (3-5) about the different arguments of the course. If the written exam is positive, student can require an oral during which, beyond the discussion of the written test, the ability to reason and connection among the knowledge acquired will be verified. PROGRAMMA Italiano Tutti gli argomenti trattati durante il corso appartengono all'area "FORMAZIONE E STRUMENTI DI BASE" Grandezze fisiche Grandezze scalari e vettoriali. Unità di misura; analisi dimensionale. Cenni di algebra vettoriale (componenti di un vettore, somma di vettori, prodotto scale e prodotto vettoriale). - 555 - Moto rettilineo Posizione, spostamento, legge oraria, traiettoria. Velocità media ed istantanea. Accelerazione media ed istantanea. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato. Dinamica del moto rettilineo Definizione di forza e leggi fondamentali della dinamica. Peso e massa. Risultante di forze. Leggi di Newton, principio d'inerzia e principio di azione e reazione. Forze di attrito, spazio e tempo di arresto in presenza di attriti. Forze variabili: forze elastiche. Lavoro ed energia Lavoro di una forza. Energia cinetica e energia potenziale. Forze conservative e non conservative. Principio di conservazione dell'energia. Conservazione dell'energia in presenza di forze d'attrito e/o forze esterne. Concetto di potenza e rendimento. Quantità di moto e urti Quantità di moto e impulso di una forza. Seconda legge di Newton per una particella. Principio di conservazione della quantità di moto. Urti. Moto in due dimensioni Moto nel piano (traiettoria, vettori spostamento e velocità, accelerazione). Moto parabolico. Grandezze angolari Moto circolare uniforme: velocità angolare, frequenza e periodo nei moti circolari, relazione tra velocità periferica ed angolare, accelerazione centripeta. Moto circolare accelerato: accelerazione angolare e tangenziale. Sistemi di trasmissione. Dinamica dei corpi in rotazione Corpi rigidi. Momento meccanico. Energia cinetica di un corpo rigido in rotazione e momento d'inerzia. Legge di Newton per i corpi in rotazione Macchine semplici (leve, carrucole, piano inclinato). - 556 - Meccanica dei fluidi. Proprietà dei fluidi. Pressione e unità di misura delle pressioni; densità e peso specifico. Fluidi in quiete: Principi di Pascal, di Stevino e di Archimede; manometri differenziali; torchio idraulico. Regime di moto dei fluidi: equazione di continuità, equazione di Bernoulli e loro applicazioni. Viscosità e fluidi reali. Tensione superficiale; capillarità. Termologia e termodinamica. Temperatura, equilibrio termico e scale termometriche. Calore specifico e capacità termica; calore latente e passaggi di stato. Propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. Leggi dei gas perfetti, equazione di stato dei gas perfetti. Sistema termodinamico, stato di equilibrio. Lavoro in una trasformazione termodinamica. Esperienza di Joule. Energia interna e Primo Principio della Termodinamica. Applicazione del Primo Principio della termodinamica a trasformazioni adiabatiche, isoterme, isobare e isocore. Trasformazioni cicliche e Secondo Principio della Termodinamica. Fenomeni elettrici Legge di Coulomb Campo elettrico Potenziale elettrico Resistenze e capacità Circuiti elettrici Carica e scarica di un condensatore Magnetismo Campo magnetico Moto di particelle cariche in campo magnetico Il ciclotrone English Physical quantities Vector and scalar quantities. Measurement units; dimensional analysis. Basic concepts of vector algebra (sum of vectors, scalar and vector product). Linear motion - 557 - Position, displacement, trajectory. Average and instantaneous velocity. Average and instantaneous acceleration. Linear motions with constant velocity and constant acceleration. Linear motion dynamics Definition of force and fundamental laws of dynamic Mass and weight. Newton laws: law of inertia, second law and law of reciprocal actions. Friction forces: static and dynamic friction, motion in presence of frictions. Variable forces: elastic force. Work and energy Work of a force. Kinetic Energy and Potential Energy. Total mechanical energy conservation theorem. Energy conservation with friction forces and/or external forces Concepts of power and efficiency. Linear momentum and collisions Linear momentum of a system; Newton second law. Conservation of linear momentum. Collisions Two dimensions motion Projectile motion. Angular quantities. Circular motion: angular rate, frequency and time in circular motion; relation between peripheral velocity and angular rate, centripetal acceleration. Non-uniform circular motion (angular and tangential acceleration). Dynamics of rotating bodies. Rigid body. Moment of a force. Kinetic energy of a rotating body and moment of inertia. Newton law for rotating bodies. Simple machines (lever, pulley, wedge). Fluid mechanic. - 558 - Fluids features. Pressure and pressure unity of measurements; density and specific weight. Hydrostatics: Pascal's law, Stevin's law and Archimedes' principle; differential manometer; hydraulic jack. Fluid dynamics: Continuity equation, Bernoulli law and their applications. Viscosity and real fluids. Surface tension; capillarity Temperature and thermodynamics. Temperature, thermal equilibrium and thermometric scales. Specific heat and thermal mass; latent heat and phase transitions Heat transfer: conduction, convection and thermal radiation. Ideal Gas laws and ideal gas equation of state. Thermodynamic system, equilibrium of a system. Work in a thermodynamic transformation: Joule experimentation Internal Energy and First Law of Thermodynamics. Application of the First Law of Thermodynamics to thermodynamic transformations (adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric). Second Law of Thermodynamics. Electrical phenomena Coulomb law Electric field Electric potential Resistors and capacitors Electric circuits Charge and discharge of a capacitor Magnetism Magnetic field Motion of charged particles in a magnetic field The cyclotron TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Lucidi delle lezioni, esercizi ed altro materiale (scaricabile dalla piattaforma e-learnig Moodle) Serway - Jewett: Principi di Fisica (5 edizione), EdiSES Editore, Napoli English Slides, exercises and other materials (available on Moodle e-learning platform) Serway - Jewett: Principles of Physics - 559 - NOTA Italiano Il corso sarà svolto in co-affidamento, in particolare i primi 5 CFU saranno tenuti dal dr. Davide Ricauda Aimonino, mentre 1 CFU (parte finale del corso) sarà tenuto dal Prof. Roberto Cirio. English The course will be carried out by two teachers, in particular the fist part of the course (5 CFU) will be taught by dr. Davide Ricauda Aimonino, whereas the last one (1 CFU) will be taught by Prof. Roberto Cirio. Mutuato da: Nessuno / None Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=24o3 - 560 - Fisiologia delle piante (Anno Accademico 2015/2016) PLANT PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0086 Docente: Prof. Claudio LOVISOLO Contatti docente: 0116708926, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 2° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI La trattazione degli argomenti in programma si baserà su una pregressa conoscenza della biologia cellulare e vegetale, della chimica, della biochimica, della fisica e della matematica, al fine della impostazione scientifica per la comprensione dei meccanismi fisiologici. OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Arrivare a capire le relazioni tra la fisiologia delle piante e la pratica colturale, sia in condizioni ottimali che in condizioni limite dal punto di vista ambientale. English To learn about the relationships between plant physiology and inputs from agriculture practices, upon both cultivation standards and abiotic limiting conditions. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti impareranno ad integrare le lezioni teoriche del programma con conoscenze acquisite dalla letteratura scientifica del settore. English The students will integrate the knowledge acquired both by following the course programme and by examining scientific literature. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano - 561 - English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano prove scritte anoninime in itinere English anonimous in itinere written tests scritto PROGRAMMA Italiano Gli argomenti del programma appartengono all'area delle conoscenze propedeutiche e all'area delle produzioni vegetali. Funzioni dell'acqua nella cellula e nella pianta; variazioni di potenziale idrico nel continuum suolo-pianta-atmosfera; psicrometro; camera a pressione trasporto xilematico; forze di tensione/coesione ed embolismi (danni e recupero); ruolo delle acquaporine; traspirazione fogliare. Cenni sulla sintesi proteica; cinetica enzimatica; potenziale elettro-chimico di un soluto - equazione di Nernst; permeabilità delle membrane; potenziale di membrana; trasporto passivo: diffusione semplice e facilatata; trasporto attivo primario; H+-ATPasi; trasporto attivo secondario (simporto, antiporto). Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura, fotosistemi, regolazione dell'organicazione del carbonio Lo spettro dell'energia solare; eccitazione dei pigmenti, riemissione di energia: dissipazione e trasferimento; assorbimento energetico della clorofilla; i fotosistemi del cloroplasto; schema Z della fotosintesi, trasporto di elettroni; trasporto transmembrana di H+ e sintesi dell'ATP nel cloroplasto; fotoinibizione, formazione de radicali liberi dell'H2O; confronto fotosintesi/respirazione per la sintesi di ATP; la RUBISCO; sintesi di amido primario nel cloroplasto; sintesi di saccarosio nel citosol; ripartizione del trioso-P tra cloroplasto e citosol; sintesi dell'amido secondario (amiloplasti). Elementi strutturali del floema: funzioni; floema: modello di flusso di massa da organi sorgenti a organi sink; caricamento floematico (simportatore di zuccheri); scaricamento floematico; ripartizione dei prodotti della fotosintesi, forza di un sink; effetti delle variazioni del rapporto sorgente/sink; transizione sorgente/sink. Assorbimento, trasporto e assimilazione di sostanze minerali. Modificazioni di soluzioni nutritive per valutare gli effetti di elementi minerali; movimento dei soluti nel terreno; trasporto apoplastico e cellulare degli elementi minerali; funzioni del trasporto di membrana nell'assorbimento ionico di sost. minerali; assorbimento del P (micorrize ectotrofiche e vescicolo-arbuscolari); riduzione del nitrato ad ammonio; organicazione dell'ammonio in aminoacidi (ciclo GS-GOGAT e sintesi AA); fissazione dell'N2 atmosferico ad opera di microrganismi; simbiosi rizobi/leguminose. Auxina: esperimenti di inizio '900 e risvolti funzionali; saggio biologico e radio-immunologico delle auxine; forma libera e forma coniugata (implicazioni su trasporto ed utilizzo); trasporto apolare (floematico) e polare (parenchimatico) ; effetti dell'auxina: allungamento di fusti e radici; auxine e fototropismo; auxine e gravitropismo in fusti e radici; effetti fisiologici dell'auxina: regolazione dominanza apicale, formazione radici secondarie, - 562 - differenziamento vascolare; meccanismo d'azione dell'auxina a livello cellulare; effetti fisiologici delle gibberelline; effetti fisiologici delle citochinine; etilene; acido abscisico. Aspetti ecofisiologici: risposta allo stress &n bsp; Stress idrico. Meccanismi di difesa delle piante allo stress idrico. Ad alto potenziale idrico. A basso potenziale idrico. Risposta isodrica ed anisoidrica allo stress idrico. Ruolo del messaggio ormonale e chimico. Limitazioni alla crescita della piante ascrivibili a squilibri del potenziale idrico. Osmoregolazione. Stress da freddo. Stress da congelamento. Stress salino. Regolazione della fotosintesi. Controllo ambientale dell'assorbimento della CO2: 1) regolazione stomatica; 2) competizione CO2/O2 per la Rubisco; 3) competizione tra la biosintesi di amido e quella del saccarosio; 4) allocazione dei fotosintati a differenti organi sink; 5) età delle foglie. Assimilazione carbonica: risposta alla luce e alla temperatura in foglie cresciute al sole ed all'ombra. English Water potential, xylem transport, transpiration Proteins, cell membrane metabolism Photosynthesis and regulation of carbon assimilation Phloem transport Mineral uptake and assimilation Plant hormones Ecophysiology of water and nutrients in the whole plant Ecophysiology of light and CO2 in the whole plant TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Alpi A., Pupillo P., Rigano C., Fisiologia delle Piante, EdiSES, Napoli, 2000. Rascio N., Elementi di Fisiologia Vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. English Taiz L., Zeiger E., Fisiologia vegetale, PICCIN, Padova, 2008. Alpi A., Pupillo P., Rigano C., Fisiologia delle Piante, EdiSES, Napoli, 2000. - 563 - Rascio N., Elementi di Fisiologia Vegetale, EdiSES, Napoli, 2012. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y1lu - 564 - Fisiologia e qualità della produzione viticola in clima caldo arido (Anno Accademico 2015/2016) PHYSIOLOGY AND QUALITY OF GRAPEVINE PRODUCTION IN WARM AND DRY CLIMATE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0504 Docente: Prof. Laura De Palma (Affidamento interno) Contatti docente: 0881-589221, [email protected] Corso di studio: [f290-c511] LM - Scienze viticole ed enologiche Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 5 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Con riferimento alle competenze scientifiche e tecniche che il laureato deve possedere per la gestione della produzione agraria, l'insegnamento approfondisce le relazioni tra comportamenti fisiologici della vite e qualità delle produzioni, al fine di elaborare una visione critica dei risultati quali-quantitativi conseguibili e guidare le scelte viticolo-enologiche negli ambienti caldo-aridi mediterranei. English Within the scientific and technical knowledge that the plant technologist must have to manage the crop production, this teaching programme analyzes on depth the relationships between grapevine physiology and grape quality, in order to elaborate a critical view of the viticultural results and drive the technical choices. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente, richiamando e sviluppando le conoscenze sui comportamenti fisiologici della vite in rapporto ai fattori agro-ambientali, dovrà: - apprendere come utilizzare gli indicatori degli stati di stress biologico; - comprendere l'influenza della gestione del vigneto sullo stato fisiologico della vite; saper elaborare strategie colturali per migliorare i risultati qualitativi della produzione viticola in ambiente caldo-arido. - 565 - English The student, by recalling previous knowledge of plant physiology as related to agro-environmental conditions, must: - learn how to use indicators of biological stress conditions; - understand the influence of the vineyard management on the vine physiological status - be able to elaborate growing strategies to improve grape quality under semi-arid environmental conditions. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano L'insegnamento si articola in 4 CFU di lezioni ex cathedra e 1 CFU di esercitazioni pratiche. English The teching program is divided into 4 Credits of lectures and 1 Credit of practical activities MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano La verifica dell'apprendimento consiste in un esame orale in cui verranno poste due domande principali ed domande di chiarimento e/o di approfondimento. Lo studente dovrà dimostrare di conoscere e aver compreso i contenuti teorici degli argomenti e, inoltre, saperli applicare per indirizzare i comportamenti fisiologici della vite verso l'ottenimento di soddisfacenti risultati qualitativi in ambiente caldo-arido. La valutazione considererà, in parti uguali, il grado di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati, la capacità critica dimostrata dallo studente, la sua proprietà di linguaggio tecnico e la capacità espositiva. English Individual oral examination. The student will answer to two main questions and to minor questions in order to provide details. The student will have to demonstrate knowledge and understanding of the lecture theoretical topics, capacity to apply the knowledge to address the vine physiological behaviours toward the obtaining of satisfying quality results in warm growing environments. PROGRAMMA Italiano Lezioni in aula (4 CFU) 1. Richiami sulle esigenze fisiologiche della vite e sugli indicatori della qualità dell'uva. 2. Aridità e sue implicazioni sullo sviluppo della vite e sulla conduzione del vigneto. Dinamiche giornaliere e stagionali dei principali parametri ecofisiologici, in relazione allo stato idrico. Alimentazione idrica e qualità dell'uva - 566 - negli ambienti caldo-aridi. 3. Richiami sulle dinamiche delle produzioni fenoliche nell'uva. Influenze dei fattori ambientali sugli accumuli fenolici. Effetti di luce e temperatura su flavonoidi, antociani e tannini. 4. Stress ambientali multipli (idrico-termo-luminosi) e risposte dei vitigni. Esercitazioni pratiche (1 CFU) Misura di parametri di valutazione dell'attività fisiologica in viti soggette a stati di stress ambientale. Misura di parametri di valutazione della funzionalità del vigneto. Analisi di parametri qualitativi dell'uva. Luogo di svolgimento: Laboratorio didattico di Biologia. Campi dimostrativi e/o aziende viticole. . English Lectures (4 Credits) 1. Recalling the grapevine physiological requirements and the indicators of grape quality. 2. Drought and its implications on vine growth and vineyard management. Diurnal and seasonal dynamics of the main eco-physiological parameters, as related to the water status. Water nutrition and grape quality in semi-arid environments. 3. Recalling the dynamics of phenol production in grapes. Influence of environmental factors on phenol accumulation. Effects of light ant temperature on flavonoids, anthocyanins and tannins. 4. Multiple stress (hydrical-thermal-radiative) and response ov grapevine varieties. Canopy microclimate, vine water status and grape quality under semi-arid environmental conditions (effects of). Practical activities (1 Credit) Assessment of physiological parameters in vines under environmental stress. Assessment of parameters related to vineyard fuctionality. Analyses of grape quality parameters. Facilities: Laboratory of Biology; Laboratory of Arboriculture; Experimental fields; Private farms. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Fregoni M., Viticoltura di Qualità. Ed. Phytoline, 2005. Carbonneau A., Deloire A., Jaillard B., 2007. La vigne. Dunod, Paris. Articoli tecnici e scientifici forniti dal docente - 567 - English Fregoni M., Viticoltura di Qualità. Ed. Phytoline, 2005. Carbonneau A., Deloire A., Jaillard B., 2007. La vigne. Dunod, Paris. Technical and scientific paper provided by the teacher. NOTA Italiano Le lezioni vengono svolte con il supporto della videoproiezione. Le esercitazioni vengono svolte utilizzando materiali vegetali e strumentazioni portatili da campo. English The lectures are supported by videoprojections Practical activities are supported by plant materials and scientific portable instruments . Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=afgh - 568 - Fisiologia molecolare delle piante (Anno Accademico 2015/2016) PLANT MOLECULAR PHYSIOLOGY Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: INT0525 Docente: Prof. Andrea SCHUBERT Contatti docente: 0116708654, [email protected] Corso di studio: [f056-c502] LM - Biotecnologie vegetali Anno: 1° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: BIO/04 - fisiologia vegetale Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Fornire conoscenze approfondite e aggiornate sui meccanismi molecolari di base (a livello sia di acidi nucleici che di proteine) del funzionamento delle cellule vegetali. Presentare i principali meccanismi di interazioni proteine/ligandi, proteine/proteine e proteine/acidi nucleici nelle cellule vegetali., illustrandoli con casi studio relativi ad importanti segnali ambientali e fisiologici. Discutere "nuovi" meccanismi di controllo dell'espressione genica e proteica, basati sulla degradazione controllata delle proteine e sull'azione dei piccoli RNA. Effettuare esercitazioni su tecniche di analisi di interazioni proteine/proteine e di piccoli RNA. English To supply current and detailed knowledge on the basic molecular mechanisms (involving both nucleic acids and proteins) allowing functioning of plant cells. To present mechanisms of protein/ligand, protein/protein and of protein/nucleic acid interactions in plant cells, illustrating them with case studies relative major environmental and physiological signals. To discuss "novel" mechanisms of the control of gene and protein expression, such as those based on protein controlled degradation and on small RNA action. To practice in techniques for the study of protein/protein interactions and of small RNAs. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Conoscenza di meccanismi di regolazione molecolare dell'espressione genica e proteica, in particolare basati su interazioni delle proteine con ligandi, e sull'azione di RNA non codificanti. Conoscenza e capacità di utilizzare tecniche analitiche relative al loro studio e alla loro applicazione biotecnologica. - 569 - English Knowledge of the molecular mechanisms of gene and protein expression, in particular based on the interaction of proteins with ligands, and on the action of non-coding RNAs. Knowledge and ability to use analytical techniques relative to their study and biotechnological application. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano English MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Lettura e commento critico di pubblicazioni scientifiche relative agli argomenti trattati English Reading and critical comment of scientific papers concerning the subjects treated Esame orale PROGRAMMA Italiano Struttura delle proteine, relazioni struttura/funzione, tecniche di analisi della struttura di proteine ore lezione 4 Interazioni proteina/proteina e proteina/ligando, domini di interazione, tecniche di analisi del legame proteina/proteina(Y2H, pull-down, CoiP, split-YFP e split-ubiquitin) e proteina/DNA (ChIP, Y1H) ore lezione 6 Ubiquitinazione e degradazione controllata delle proteine, segnalazione di ormoni basata su enzimi E3 (auxina, gibberellina, acido giasmonico) ore lezione 6 Fosforilazione di proteine, trasduzione di segnali basati su proteine kinasi ibride (etilene, citikinina) e proteina fosfatasi (ABA). Interazione di proteine con lipidi e fosfolipidi ore lezione 8 Piccoli RNA, silenziamento trascrizionale e post-trascrizionale, proteine coinvolte nella biogenesi. I miRNA: modalità di azione, funzioni dei miRNA più noti, tecniche di studio e applicazioni biotecnologiche ore lezione 8 & nbsp; siRNA endogeni ed esogeni, biosintesi e modalità di azione, soppressori virali di silenziamento, siRNA eterocromatici e modifiche del DNA e degli istoni. Diffusione del silenziamento. Long siRNAs. ore lezione 10 Splicing alternativo nelle piante ore lezione 2 & nbsp; Tecniche di analisi di RNA ore esercitazione 9 Tecniche di silenziamento genico ore esercitazione 7 Totale ore lezone 44 ore esercitazione 16 - 570 - ; English Protein structure, structure/function relationships, protein structure analysis techniques hrs theory 4 nbsp; & Protein/protein and protein/ligand interactions, interaction domains, analytical techniques for demonstration of protein/protein (Y2H, pull-down, CoIP, split-YFP, split-ubiquitin) and protein/DNA (ChIP, Y1H) binding hrs theory 6 & nbsp; Ubiquitination and controlled degradation of proteins. Hormone signaling based on E3 enzymes (auxin, gibberellin, jasmonic acid) hrs theory 6 Protein phosphorylation, signal transduction based on hybrid kinases (ethylene, cytokinin) and protein phosphatases (ABA). Interactions of proteins with lipids and phospholipids hrs theory 8 & nbsp; sp; ; & nbsp; &nb sp; ; & nbsp; &nb sp; &nb Small RNAs, transcriptional and post-transcriptional gene silencing, proteins involved in small RNA biogenesis. miRNAs: mechanisms of action, function of selected miRNAs, identification and analytical techniques, biotechnological applications hrs theory 8 & nbsp; Endogenous and exogenous siRNAs, biosynthesis and mechanisms of action, viral suppressors of silencing, heterochromatic siRNAs and DNA and histone modifications. Spreading of silencing. Long siRNAs hrs theory 10 Alternative splicing in plants hrs theory 2 & nbsp; RNA analysis techniques hrs practice 9 Techniques of gene silencing hrs practice 7 Total hrs theory 44 hrs practice 16 TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Buchanan, Gruissem, Jones. Biochimica e Biologia Molecolare delle Piante. Zanichelli, 2003 Slide lezioni English Buchanan, Gruissem, Jones. Biochimica e Biologia Molecolare delle Piante. Zanichelli, 2003 Slides NOTA Italiano English - 571 - Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yku9 - 572 - Floricoltura (Anno Accademico 2015/2016) FLORICULTURE AND ORNAMENTAL ARBORICULTURE Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0326 Docente: Dott. Valentina SCARIOT (Affidamento interno) Contatti docente: 0116.708.932, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: C - Affine o integrativo Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/04 - orticoltura e floricoltura Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il Corso si propone di fornire nozioni fondamentali sulla floricoltura, i settori merceologici di cui si compone, le principali tecniche colturali e post-raccolta, le principali specie di interesse e le innovazioni di processo e di prodotto. English The course aims to provide basic knowledge on floriculture, cultivation and post-harvest techniques and main species. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Lo studente dovrà acquisire le conoscenze di base nel campo della floricoltura e comprendere gli strumenti per poterle applicare; dovrà altresì essere in grado di riconoscere le principali specie di interesse florovivaistico e di conoscerne impiego ed esigenze. Al termine del corso dovrà saper applicare le conoscenze acquisite a casi studio specifici, esprimere giudizi in modo autonomo ed aver sviluppato capacità comunicative. English The student will acquire basic knowledge in the field of floriculture and tools to apply them; must also be able to recognize the main species of horticultural interest and to know their use and requirements. At the end of the course the student will know how to apply their knowledge to specific case studies, make judgments independently and have developed communication skills - 573 - MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso consiste di 60 ore di lezione frontale e 20 ore dedicate ad attività di laboratorio e/o visite ad aziende florovivaistiche, parchi e giardini. Le nozioni fondamentali del corso verranno spiegate dal docente. Gli approfondimenti verranno trattati stimolando l'argomentazione e la discussione tra gli studenti. La metodologia dell'insegnamento reciproco verrà applicata nell'analisi delle principali specie di interesse florovivaistico. English The course consists of 60 hours of lectures and 20 hours devoted to laboratory work and visits to ornamental nurseries, parks and gardens. The basic notions of the course will be explained by the teacher. Insights will be treated by stimulating the argumentation and discussion among students. The mutual teaching methodology will be applied in analyzing the main species of horticultural interest. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Durante il corso, la capacità di ragionamento e di collegamento tra le conoscenze acquisite verrà verificata e valutata attraverso un elaborato che ogni studente produrrà e presenterà relativamente alla tecnica colturale di una specie di interesse florovivaistico. L'esame finale è un colloquio orale con test scritto preliminare, composto da cinque domande a risposta aperta e sei domande a risposta multipla. Lo studente potrà sostenere l'orale previo superamento del test scritto. Il colloquio orale consisterà nella discussione del test iniziale. La valutazione finale terrà conto anche dell'esito dell'elaborato sulla tecnica colturale di una specie di interesse florovivaistico presentato dallo studente durante il corso, secondo una media ponderata (peso esame finale = 2, peso elaborato tecnica colturale = 1). English During the course, the reasoning and linking skills will be tested and evaluated by the analysis that each student will conduct and present regarding the cultivation techinique of a floricultural species. The final exam is an oral exam with written preliminary test consisting of five open-ended questions and six multiplechoice questions. Students can take the oral upon passing the written test. The oral examination consists of the discussion of the initial test. The final evaluation will also take account of the outcome of the analysis of the cultivation technique of a floricultural species presented by the student in the classes, according to a weighted average (weight final exam= 2 , weight analysis cultivation technique = 1). PROGRAMMA Italiano Gli argomenti trattati, di seguito riportati, rientrano nell'area di apprendimento delle produzioni vegetali. Settori merceologici di cui si compone la floricoltura: fiori recisi, fronde, vaseria fiorita, piante da appartamento, piante da giardino, arbusti; distribuzione geografica, superfici, evoluzione e tendenza del settore; commercializzazioni e mercati. Fiori recisi: fisiologia e tecniche post-raccolta; tecniche di conservazione e produzione di fiori e fronde essiccati e - 574 - colorati; le specie principali. Vaseria fiorita: substrati, fitoregolatori, contenitori, fertilizzanti, metodi di irrigazione, trattamenti alle piante madri, conservazione dei vasi fioriti; le specie principali. Piante verdi da appartamento: generalità, distribuzione, propagazione, tecnica colturale, esigenze termiche, commercializzazione e acclimatazione; le specie principali. Piante da giardino e arbusti: generalità; tecniche vivaistiche; le specie principali. Esercitazioni presso il mercato dei fiori, vivai, aziende di supporto ed istituti di ricerca. English Sectors that make up the floriculture: cut flowers, foliage, flower pots, house plants, garden plants, shrubs; geographical distribution, surfaces, and development trend of the industry; commercialization and markets. Cut flowers: physiology and post-harvest techniques; main species. Flower pots: substrates, plant growth regulators, containers, fertilizers, irrigation methods, treatments to parent plants, maintenance of flower pots; main species. House plants: information, distribution, propagation, cultivation technique, thermal requirements, marketing and acclimatization; main species. Garden plants and shrubs: information; nursery techniques; main species. Visits at the flower market, nurseries, support companies and research institutes. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Agli studenti verrà fornita della bibliografia dal docente durante il Corso. Il materiale utilizzato per le lezioni sarà disponibile su CampusNet prima delle stesse. I testi consigliati - di seguito elencati - sono disponibili per consultazione presso l'ufficio del docente. Accati E. (1993) Trattato di Floricoltura. Ed. Agricole Accati E. e Pergola G. (1994) Fiori essiccati: tecnica di coltivazione e lavorazione. Ed. Agricole, Bologna Reid M. e Ferrante A (2002) Conservazione di fiori e fronde recise. Fisiologia e tecnologia postraccolta di prodotti floricoli freschi. Arsia Tesi R. (2008) Colture Protette. Ed. Edagricole English Students will received bibliography by the teacher during the course. The material used for the lessons will be available on CampusNet before the lessons. The recommended books listed below are available for inspection at the teacher's office. - 575 - Accati E. (1993) Trattato di Floricoltura. Ed. Agricole Accati E. e Pergola G. (1994) Fiori essiccati: tecnica di coltivazione e lavorazione. Ed. Agricole, Bologna Reid M. e Ferrante A (2002) Conservazione di fiori e fronde recise. Fisiologia e tecnologia postraccolta di prodotti floricoli freschi. Arsia Tesi R. (2008) Colture Protette. Ed. Edagricole NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ob7d - 576 - Foraggicoltura (Anno Accademico 2015/2016) FODDER CULTIVATION Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0121 Docente: Prof. Giorgio BORREANI (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708783, [email protected] Corso di studio: [f001-c717] L - Scienze e tecnologie agrarie Anno: 3° anno Tipologia: B - Caratterizzante Crediti/Valenza: 8 SSD attvità didattica: AGR/02 - agronomia e coltivazioni erbacee Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Scritto ed orale PREREQUISITI Nessuno / None OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Il corso si pone l'obbiettivo di fornire le conoscenze di base sulla foraggicoltura, sui sistemi foraggeri nei diversi areali agricoli italiani, sulla eco-fisiologia delle specie foraggere, sulle relazioni tra produzione dei foraggi, qualità e problematiche della conservazione dei foraggi nell'azienda zootecnica. Il corso integra è approfondisce le coltivazioni foraggere trattate nell'ambito delle coltivazioni erbacee approfondendo gli aspetti legati alla conservazione, utilizzazione delle risorse foraggere e sistemi foraggeri nella zootecnia intensiva delle aree di pianura e della zootecnia estensiva degli areali marginali. Valutazione degli impatti dei sistemi foraggeri nelle aziende zootecniche intensive. English The course has the objective to provide the basic knowledge on the grassland, on cropping systems in different areas of Italian agriculture, on eco-physiology of forage species, on the relationship between production of animal feed, quality and problems of forage conservation in livestock farms. The course integrates and deepens the forage crops and conservation treated as part of the herbaceous crop course deepening aspects of forage conservation, utilization of forage resources and livestock intensive cropping systems in the lowland areas and extensive livestock farms in marginal areas. Evaluation of the environmental impacts of cropping systems in intensive dairy farms. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti saranno in grado di poter analizzare in dettaglio le problematiche relative alla gestione dei sistemi colturali delle aziende zootecniche intensive con particolare enfasi sui diversi aspetti della gestione agronomica, della raccolta e conservazione dei foraggi con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali e massimizzare l'efficienza del sistema colturale in relazione alla tipologia di animali allevati in azienda. Imparare a impostare dei sistemi colturali che tengano in considerazione non solo le efficienze agronomiche, ma anche i fabbisogni degli animali - 577 - allevati con lo scopo di massimizzare l'autosufficienza alimentare aziendale anche in relazione alle variazioni dei prezzi delle commodities che influenzano i costi di produzione delle principali filiere zootecniche dei ruminanti. English Students will be able to analyze in detail the problems related to the management of cropping systems of intensive livestock farms with emphasis on different aspects of agronomic management, the harvesting and conservation of forages in order to minimize environmental impacts and maximize the efficiency of the farming system in relation to the type of animals present in the farm. Furthermore, they learn to set cropping systems that take into account not only the agronomic efficiencies, but also the needs of the animals with the scope to maximize the farm selfsufficiency also in relation to the changes in the commodity prices which influence the production costs of the main ruminant livestock systems. MODALITA' DI INSEGNAMENTO Italiano Il corso si articola in una serie di lezioni frontali relative agli argomenti riportati nel programma dettagliato, integrate da esercitazioni pratiche in aziende zootecniche commerciali con raccolta di campioni di foraggi che saranno analizzati presso i laboratori del Dipartimento. English The course consists of a series of lectures on the topics listed in the detailed program, supplemented by visits on commercial livestock farms with sampling of conserved forages that will be analyzed at the laboratories of the Department. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano Il grado di apprendimento e comprensione acquisito dagli studenti sarà valutato attraverso la stesura di una relazione scritta inerente ai dati raccolti durante le visite aziendali e un esame orale che partirà dal commento critico della relazione scritta. Il giudizio finale sarà espresso in trentesimi. English The level of learning and understanding acquired by the students will be evaluated through the drafting of a written report relating to the data collected during the visits on farms and by an oral examination which will start from the critical commentary of the written report. The final judgment will be out of thirty. PROGRAMMA Italiano La foraggicoltura: cenni sulla storia e l'evoluzione della produzione e conservazione dei foraggi. Importanza dei foraggi nell'alimentazione dei ruminanti. Principali specie foraggere, tipologie colturali e loro diffusione sul territorio nazionale. Morfologia e fisiologia delle graminacee foraggere: morfologia epigea e ipogea delle graminacee. Fasi di sviluppo della coltura: fase vegetativa, accestimento, passaggio dalla fase vegetativa alla riproduttiva e modificazioni dell'apice meristematico. Crisi di accestimento. Morfologia e fisiologia delle leguminose: morfologia epigea e - 578 - ipogea delle leguminose. Esigenze di temperatura, luce, suolo ed elementi nutritivi. Modalità di crescita e ritmo di taglio nelle diverse tipologie di leguminose. Elementi di agrotecnica delle colture foraggere: epoca e modalità di semina, gestione del piano di concimazione. Gestione della concimazione delle colture dell'azienda zootecnica: asporti dei principali elementi da parte delle colture foraggere, curve di diluizione dell'azoto; valorizzazione aziendale dei fertilizzanti organici (liquame e letame), piano di concimazione delle colture foraggere. Valore nutritivo dei foraggi: Metodi per la valutazione della qualità dei foraggi. Fattori ambientali e genetici di variazione della qualità dei foraggi. Influenza dello stadio di sviluppo della pianta sulle caratteristiche dell'erba e momento di effettuazione del taglio. Effetto delle concimazioni sulla qualità dei foraggi prativi. Conservazione dei foraggi: generalità sulla conservazione dei foraggi. Tipologie di conservazione per via umida e per via secca. Perdite di conservazione. La fienagione: Il processo di essiccazione dei foraggi in campo. Tasso di essiccazione, quantità di acqua presente nella pianta da evaporare, resistenze alla perdita dell'acqua dovute alla pianta e allo strato in essiccamento. Condizionamento meccanico dei foraggi. Perdite per respirazione, meccaniche, per lisciviazione per graminacee e leguminose. L'essiccazione artificiale dei foraggi. L'insilamento: Principi biochimici dell'insilamento. Caratteristiche di insilabiltà delle diverse specie foraggere: caso del silomais, del loglio italico e dell'erba medica. Attività enzimatiche e fermentazioni. Microrganismi implicati nelle fermentazioni e nel deterioramento degli insilati. Il ciclo dei clostridi. Perdite durante l'insilamento con particolare riferimento al deterioramento aerobico. Additivi degli insilati. Analisi chimica e valore nutritivo degli insilati. La pratica dell'insilamento. Implicazioni della tipologia di conservazione dei foraggi sulla filiera lattiero-casearia. Sistemi foraggeri intensivi: Organizzazione dei sistemi foraggeri aziendali in funzione delle superfici aziendali e delle esigenze nutrizionali della mandria. Massimizzazione della produzione aziendale di sostanza secca e di proteina. Le filiere lattiero casearie: implicazioni della tipologia di conservazione dei foraggi sulla filiera lattiero-casearia, micotossine, batteri dannosi alla tecnologia e patogeni; effetto di foraggi verdi e conservati sulla qualità della componente lipidica e sulla frazione volatile del latte. ESERCITAZIONI Riconoscimento e analisi della morfologia e dello stadio di sviluppo delle principali foraggere graminacee e leguminose nelle diverse tipologie colturali da erbaio, da prati avvicendati e permanenti (in campo). Visita di due-tre aziende zootecniche da latte nella pianura piemontese. Studio delle colture foraggere in atto nell'azienda e dei foraggi conservati presenti. Tipologie di sili aziendali. L'analisi termografica di insilati aziendali di mais o altre foraggere, quale strumento di rilievo del deterioramento aerobico (in un'azienda zootecnica del cuneese). Prelievo di campioni di foraggi secchi e insilati per le analisi. Preparazione ed analisi dei campioni di insilato prelevati durante le visite aziendali. English Forage production: History of forage production and conservation. Forages in ruminant nutrition. Main forage specie, cropping systems and their diffusion. Morphology and ecophysiology of grasses (Poaceae): epigeal and hypogeal morphology of grasses. Seed structure, germination and plant development. Vegetative phase¸ tillering and plant growth at vegetative phase. Floral induction and apex modifications. Morphology and ecophysiology of legumes (Fabacee): epigeal and hypogeal morphology of legumes. Temperature - 579 - light and soil requirements. Legume seed structure and germination. Plant growth and cutting frequency for different legume specie. Forage crop cultivation: soil tillage, seeding time, and fertilization of forage crops. Crop fertilization: uptake of the main elements by the crops; dilution curves of nitrogen; organic and mineral fertilizing; fertilization plan of the crops. Nutritive value of forages: Methods for forage quality evaluation. Effects of environmental, climatic and specie factors on pre-harvest forage quality. Influence of morphological stage on pre-harvest forage quality. Effects of nitrogen fertilization on forage crops. Forage conservation: Methods of forage conservation through wet and dry pathways. Conservation losses. Haymaking: Field drying process. Drying rate, water forage content to be evaporate, plant resistance to water evaporation. Mechanical treatments during field forage drying. Losses during drying for grasses and legumes. Postharvest deterioration of hays. Artificial drying of forages. Ensiling of forages: Biochemistry principles of ensiling. Silage fermentation and enzymatic activities during ensiling. Microorganisms involved in fermentations and aerobic deterioration of silages. Clostridia cycle in dairy farm. Losses during ensiling and feed-out phase. Silage additives. Nutritive values and chemical analyses of silages. Intensive forage systems: management of forage systems in intensive dairy farms in relation with farm surfaces and nutritional demand of the herd. Maximizing home-grown forages for DM and protein yield. Grazing systems: introduction to grazing methods, managing grazing surface and animals in different environments. Intensive and extensive management of grazing systems in temperate and Mediterranean areas. Forage crops in extensive livestock systems: role of forage in marginal areas; Yield and forage quality evolution of permanent meadows and natural pastures in relation to altitude; Managing forage crops in mountain dairy farms; Forage conservation methods alternative to traditional haymaking. Managing and utilizing of conserved forages for winter feeding in mountain dairy farms producing typical cheeses. Implications of forage for food chains: Effects of forage conservation strategies on dairy chains; fresh and conserved forage on fatty acids and volatile components of milk and cheese. PRACTICAL ACTIVITIES Determination of morphological stage of grasses and legumes in the field. Visits from two to three intensive dairy farms and extensive mountain farms in Piedmont to study their forage systems and forage conservation techniques adopted. Thermographic analysis of maize silages in farms, to judge aerobic deterioration. Sampling of dry forages and silages for the analyses. Analyses of forage samples collected during visits of commercial farms. TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano 1) Borreani G., Tabacco E., 2007. Il Silomais: guida pratica. Regione Piemonte, Torino. 2) Baldoni, R., Giardini L., 2000. Coltivazioni erbacee: Foraggere e tappeti erbosi, III volume. Pàtron Editore, Bologna. 3) Fahey, G.C. (Ed.) 1995. Forage quality, evaluation and utilization. ASA-CSSA-SSSA Publishers, Madison, Wisconsin. 5) Van Soest, P.J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornell University Press, Ithaca, New York. - 580 - Consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: 6) Articoli dalle riviste: L'Informatore Agrario, 2005-2015. English 1) Borreani G., Tabacco E., 2007. Il Silomais: guida pratica. Regione Piemonte, Torino. 2) Baldoni, R., Giardini L., 2000. Coltivazioni erbacee: Foraggere e tappeti erbosi, III volume. Pàtron Editore, Bologna. 3) Fahey, G.C. (Ed.) 1995. Forage quality, evaluation and utilization. ASA-CSSA-SSSA Publishers, Madison, Wisconsin. 5) Van Soest, P.J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornell University Press, Ithaca, New York. Consigliato l'utilizzo del seguente materiale per approfondimenti e integrazioni: 6) Articoli dalle riviste: L'Informatore Agrario, 2005-2015. NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fh9o - 581 - Fotointerpretazione e strumenti informatici per analisi e rappresentazione del paesaggio (Anno Accademico 2015/2016) Image Interpretation and Digital Tools for Landscape Analysis and Representation Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: 65727 Docente: Ing. Enrico Corrado BORGOGNO MONDINO (Affidamento interno) Contatti docente: 0116705523, [email protected] Anno: Tipologia: Crediti/Valenza: 6 SSD attvità didattica: ICAR/06 - topografia e cartografia Erogazione: Tradizionale Lingua: Italiano Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno OBIETTIVI FORMATIVI Italiano Trasferimento delle conoscenze di base per la gestione e il processamento dei dati geografici e delle immagini aeree/satellitari digitali all'interno di sistemi GIS free/open source finalizzate all'analisi e rappresentazione del paesaggio in un contesto di pianificazione/riqualificazione territoriale English Fundamentals of digital geographical data and aerial/satellite imagery processing and management by GIS tools, with particular regard to procedures aimed at landscape analysis and representation for territory planning purposes. RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI Italiano Gli studenti acquisiranno le competenze di base necessarie alla lettura ragionata, al processamento e alla gestione delle principali tipologie di dati geografici digitali all'interno dei sistemi GIS con particolare attenzione al problema della corretta gestione dei sistemi di riferimento, della natura informatica dei dati e delle procedure avanzate per la derivazione di indici paesaggistici e la formalizzazione di funzioni di costo spazio dipendenti utili all'indirizzamento delle politiche pianifcatorie e di valorizzazione territoriali. English Basic skills for interpretation, processing and management of digital geofraphical data by GIS tools. In particular the focus is on proper management of data coordinate systems, properties and format of digital data and advanced procedures for spatial dependent landscape/ecological indices and cost functions definition. These are retained useful to address territory planning and recovering actions. MODALITA' DI INSEGNAMENTO - 582 - Italiano Il corso si sviluppa per l'intera durata attraverso l'erogazione di lezioni frontali, nel corso delle quali il docente procede anche all'esemplificazione pratica dei concetti espressi ed in particolare al processamento dei dati. In questa fase gli studenti vengono addestrati all'utilizzo di software freeware (SAGA GIS e QGIS) per l'esecuzione dell'intero flusso di lavoro necessario al laboratorio. Sulla base delle competenze acquisite gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, procedono al processamento dei dati relativi alla loro area di indagine e procedono alla redazione di composizioni cartografiche di supporto alla relazione finale prevista dal laboratorio. English The course is made of frontal lessons where theoretical aspects are coupled with practical examples concerning operational processing of geographicaldata. Students are trained on the basic use of free processing software (SAGA GIS and QGIS) useful for the extraction of territorial information needed by the task thy have been assigned within the laboratory. Once trained, students operate in working groups to face the practical application over their study area, producing maps useful to integrate and support the final report they have to produce for the entire laboratory. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO Italiano L'efficacia delle lezioni viene verificata procedendo, all'inizio di ciascuna lezione (10 minuti), ad un limitato dibattito riguardante i contenuti della lezione precedente, nel corso del quale gli studenti sono invitati a rispondere a domande e sollecitati a proporne. L'appello d'esame è costituito da un colloquio orale congiunto con gli altri docenti del Laboratorio in cui gli elaborati prodotti durante il corso vengono discussi e costituiscono la base per domande di carattere più teorico. English Effectiveness of lessons is verified by discussing with the students at the beginning of a new lesson (10 minutes), the content of the last preceding one. In this context students are invited to answer some technical questions and proposing their own ones. Final exam is an oral one and it is carried out togeher with other lecturers of the course. PROGRAMMA Italiano Introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali - Tipologie di carte: tecniche e tematiche - Formato dei dati geografici digitali:vettoriali e raster - Ortofoto digitali e Modelli Digitali del Terreno - Cenni di Geostatistica - Il concetto di precisione dei dati geografici - Sistemi di riferimento nei GIS: Ellissoide, Datum e Proiezione - 583 - - Georeferenziazione dei dati raster: aspetti teorici - definizione operativa di GIS - Concetti base del database relazionale: campi, record e relazioni Utilizzo di QGIS 2.x e SAGA GIS 2.x - Importazione, Visualizzazione e Georeferenziazione di dati raster - Importazione di dati vettoriali e alfanumerici: gestione e tematizzazione dei layer, generazione di nuovi layer - Tabelle di attributi: editing, automazione nel calcolo di campi e collegamento a dati esterni - Interrogazioni per attributo e per posizione - Relazioni tra tabelle - Editing geometrico di dati vettoriali - Gestione dei sistemi di riferimento in QGIS - Importazione di dati puntuali (X, Y data) - Geoprocessing: operazioni geometriche tra layer - Operazioni tra dati raster: formalizzazione delle funzioni spazio-dipendenti - Processaemnto dei Modelli Digitali del Terreno - Generazione dei layout di stampa - Applicazione dei concetti al caso studio previsto dal Laboratorio English Introduction to GIS - Types of maps: technical and thematical cartography - Geographical digital data format: vector and raster - Digital orthoimages and Digital Terrain Models (DTM) - Basics of geostatistics: point data interpolation - Accuracy of maps - Reference systems of data : Ellipsoid, Datum and Projection - Raster data georeferencing: theoretical aspects - GIS definition - Introduction to relational database Introduction to QGIS 2.x e SAGA GIS 2.x - Import, Visualization and georeferencing of raster data - Vector data import, management and visulaization - 584 - - Attribute tables: editing, filling and field calculation - Attribute and spatial query - Table relationship (join and relate) - Geometric editing of vector data - Reference systems management in QGIS - X, Y text data import - Geoprocessing: clip, merge, union, buffer, difference fo vector layers -Raster claculator: spatial dependent function formalization for landscape/ecological purposes - DTM processing - Print layout - Case study TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA Italiano Dainelli-Bonechi – Cartografia Numerica – Flaccovio Ed. www.darioflaccovio.it T. Bernhardsen – Geographic Information System – an introduction – John wiley M.Ioannilli, U.Schiavoni – Fondamenti di Sistemi informativi Geografici – TexMat – M.A. Gomarasca – Elementi di Geomatica – AIT English T. Bernhardsen – Geographic Information System – an introduction – John wiley M.A. Gomarasca – Basics of Geomatics – AIT NOTA Italiano English Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=phbl - 585 - Fruit and grapevine cropping systems - C.I. (Anno Accademico 2015/2016) FRUIT AND GRAPEVINE CROPPING SYSTEMS Anno accademico: 2015/2016 Codice attività didattica: AGR0173 Docente: Prof. Domenico BOSCO (Affidamento interno) Dott. Alessandra FERRANDINO (Affidamento interno) Prof. Roberto BOTTA (Affidamento interno) Contatti docente: 0116708529, [email protected] Corso di studio: [f001-c501] LM - Scienze agrarie Anno: 2° anno Tipologia: D - A scelta dello studente Crediti/Valenza: 9 SSD attvità didattica: AGR/03 - arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/11 - entomologia generale e applicata Erogazione: Tradizionale Lingua: Inglese Frequenza: Facoltativa Tipologia esame: Orale PREREQUISITI Nessuno / None Moduli didattici: Fruit and grapevine pest management (Anno Accademico 2015/2016) Orchard management for fruit quality (Anno Accademico 2015/2016) Orchard management for fruit quality II (Anno Accademico 2015/2016) Pagina web del corso: http://agraria10.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=74gd Fruit and grapevine pest management (Anno Accademico 2015/2016)
Scarica