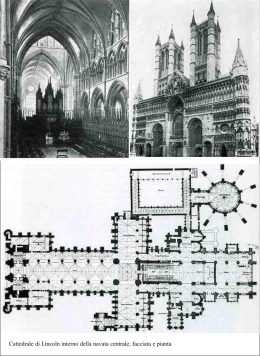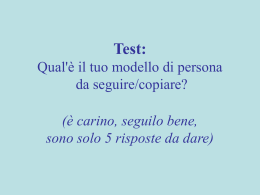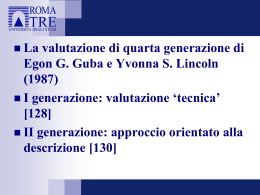1860. Novembre. Mancano poche ore al risultato delle elezioni per il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America e a Washington la tensione è altissima. Le strade brulicano di uomini che fanno la spola fra taverne e alberghi in cerca di notizie o si assiepano davanti alle porte dell’ufficio del telegrafo. Le sale dei circoli che costellano il quartiere della Casa Bianca sono già piene di passanti accorsi numerosi per approfittare del whisky offerto gratuitamente. Soltanto una donna di colore, Elizabeth Keckley, si affretta a tornare alla sua pensione di mattoni rossi stringendo al petto il suo cesto da cucito. È una sarta specializzata in eleganti abiti femminili alla moda. A Saint Louis, dopo anni di sacrifici e risparmi, è riuscita a comprare la libertà per sé e per il figlio George, studente in una lontana università dell’Ohio. Si è trasferita a Washington, la capitale federale dell’Unione, animata da un solo intento: continuare a garantire al figlio quell’istruzione che a lei è stata preclusa. Nonostante il clima teso a causa delle dispute legate all’abolizione della schiavitù e ai propositi secessionisti del Sud, Lizzie lavora alacremente. Non importa se per orlare le tende di un hotel malandato riceva soltanto due dollari e mezzo o se, per ultimare il vestito della moglie del senatore Davis, rientri così tardi da avere a malapena il tempo per un pasto e un bagno. Bravissima a confezionare i corpetti complicati e aderenti per i quali le dame del tempo impazziscono, Lizzie vede la sua fama accrescersi e farsi largo a poco a poco tra i circoli più in vista della città. Finché un giorno non si trova al cospetto di una donna sulla quarantina dai capelli scuri, con una bella carnagione e limpidi occhi azzurri che denotano acume e intelligenza: Mrs Mary Lincoln, la moglie del presidente appena eletto, la first lady nota per le sue bizze e i suoi improvvisi accessi d’ira. Lizzie le sistema magnificamente un abito rosa di moiré antico che Mary sfoggia con successo al primo grande ricevimento in onore dell’insediamento del marito. Da quel momento diviene non soltanto la sarta personale di Mrs Lincoln, colei che si occupa di vestirla e acconciarla per balli, cene e ricevimenti, ma anche la ex schiava cui l’inquieta, volubile Mary confida le sue angustie e i suoi rancori, il suo disappunto di first lady oggetto di malevolenze, invidie e gelosie. Un sodalizio che da parte della fedele Lizzie non verrà mai meno, neanche quando Mary Lincoln, sola e abbandonata da tutti, dopo aver perso il figlio Willie, a causa di una malattia, e poi il marito, vittima di un attentato, rivolgerà il suo risentimento contro di lei, scambiando un estremo gesto d’amore per un insulto alla sua dignità di ex first lady dell’Unione. Con uno stile avvincente e una trama arricchita da splendide descrizioni che restituiscono tutto il fascino dell’epoca, La sarta di Mary Lincoln, New York Times bestseller, «porta alla luce, con stile, grazia e rispetto, gli scatti dimenticati di un’America passata» (Book Reviews), raccontandoci la storia vera di Elizabeth Keckley: ex schiava, sarta della Casa Bianca e autrice di un libro di memorie che scandalizzò l’intera nazione. Jennifer Chiaverini insegna scrittura alla Pennsylvania State University e all’Edgewood College. È autrice di numerosi bestseller e della fortunata serie Elm Creek Quilts. Attualmente vive a Madison, in Wisconsin, con il marito e due figli. I NARRATORI DELLE TAVOLE JENNIFER CHIAVERINI La sarta di Mary Lincoln traduzione di Maddalena Togliani Titolo originale: Mrs. Lincoln’s Dressmaker © 2013 by Jennifer Chiaverini All rights reserved including the right of re production in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Dutton, a member of Penguin Group (Usa) Inc. © 2014 Neri Pozza Editore, Vicenza www.neripozza.it Edizione digitale: maggio 2014 ISBN 978-88-545-0874-3 Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. A Marty, Nicholas e Michael con amore e gratitudine 1. Novembre 1860 - gennaio 1861 Il giorno delle elezioni, a metà pomeriggio, Elizabeth Keckley si affrettò a tornare alla sua pensione, un edificio di mattoni rossi in Twelfth Street dove aveva preso in affitto due stanzette sul retro. Quando usciva di casa portava sempre con sé il documento comprovante la sua condizione di schiava affrancata, ma il giorno dell’elezione presidenziale desiderava trovarsi al sicuro, al chiuso, molto prima del coprifuoco. La città era invasa da un’agitazione febbrile, anche se i cittadini bianchi della città di Washington, distretto di Columbia, non avevano il diritto di voto. In questo erano sullo stesso livello dei residenti neri della capitale, schiavi o liberi che fossero; Elizabeth, sempre prudente, evitava di discutere l’argomento con le mogli degli esponenti dell’élite politica e sociale della città per le quali confezionava splendidi abiti da indossare a balli e ricevimenti. Le sue clienti adottavano un unanime atteggiamento di diffidenza e sdegno nei confronti del candidato repubblicano, un avvocato dell’Illinois, uno zotico provinciale venuto dall’Ovest, abolizionista radicale. Le divergenze di opinione tra loro si manifestavano al momento di decidere quale dei suoi tre rivali sarebbe dovuto succedere al presidente Buchanan, il quale, pur essendosi dimostrato un inetto, almeno non aveva danneggiato i loro stati e la “peculiare istituzione” schiavista del Sud. Se la popolazione avesse cominciato a sfilare per le vie della città e il corteo fosse degenerato, come succedeva fin troppo spesso in quel periodo, Elizabeth voleva trovarsi al riparo dai disordini. Le strade si stavano già riempiendo di uomini che facevano la spola di corsa fra taverne e alberghi in cerca di notizie sull’elezione, formavano capannelli agli angoli delle strade e scoccavano occhiate ostili ai loro rivali, o si assiepavano davanti alle porte dell’ufficio del telegrafo in Fourteenth Street, anche se i risultati erano attesi solo diverse ore dopo. Molti dei passanti dovevano avere approfittato del whisky distribuito gratuitamente dai vari circoli politici che costellavano il quartiere della Casa Bianca, e di tanto in tanto gli scoppi di risa sguaiate coprivano perfino il continuo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli e il fischio dei treni di passaggio, in lontananza. Tornando a casa dopo aver fatto la prova di un abito, Elizabeth strinse più forte il cesto da cucito e cercò di mostrarsi serena e composta; sussultò una sola volta, quando un giovanotto che indossava una spilla con l’immagine di Breckinridge la spintonò per la fretta di arrivare alla bacheca fuori dal National Hotel. Fece un sospiro di sollievo quando giunse infine nel suo quartiere tranquillo, un rifugio in quella che solo pochi mesi prima era una città sconosciuta. Dopo aver trascorso qualche settimana a Baltimora, quella primavera la difficoltà di trovare lavoro l’aveva convinta a trasferirsi a Washington. Non molto prima aveva abitato a Saint Louis, dove era riuscita a comprare la libertà per sé e per il figlio dopo anni di sacrifici e risparmi. Adesso George studiava all’università di Wilberforce, nell’Ohio, e lei era un’eccellente sarta specializzata nella realizzazione di mantua1, una donna d’affari dall’ottima reputazione, libera e indipendente. Sapere che il suo unico figlio stava ricevendo l’istruzione che a lei era stata preclusa, e che non aveva un padrone, le rendeva più facile sopportarne la lontananza. Virginia Lewis, sua padrona di casa e cara amica, doveva averla vista arrivare dalla finestra perché la aspettava sulla porta. «Ci sono novità?» le chiese apprensiva, studiando la sua espressione come per leggervi la risposta. «So cosa dicono le tue dame. Se c’è qualcuno che sa cosa sta succedendo sono proprio loro». «Temo che non ne sappiano più di noi». Elizabeth posò il cesto da cucito e si tolse lo scialle. «Non c’è nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo saputo stamattina. Lincoln è ancora il favorito, ma non avremo certezze finché non avranno finito il conteggio dei voti». «Immagino che alle tue clienti non piacerebbe Lincoln come presidente». «No, per niente. La maggior parte dei mariti parteggia per Breckinridge, e loro fanno lo stesso. Qualcuna sostiene invece Bell». Elizabeth abbassò la voce con tono da cospiratrice. «Temono che Lincoln voglia liberare tutti gli schiavi». Risero insieme. «Che Dio lo benedica, se è così!» esclamò Virginia. «Se è vero, prego perché vinca». Elizabeth annuì, ma nutriva qualche dubbio. Checché ne dicessero i partigiani del Sud residenti in città, Abraham Lincoln, a quanto sapeva, non aveva mai promesso di mettere fine alla schiavitù, solo di impedirne la diffusione. Ma anche se avesse posato una mano sulla Bibbia giurando di essere un abolizionista convinto, i pochi mesi trascorsi a Washington le avevano insegnato che i candidati spesso facevano promesse che erano incapaci di mantenere dopo l’elezione. Qualunque fossero le intenzioni di Lincoln, favorevoli o deleterie per Elizabeth, per i Lewis e gli altri neri del posto, quando i suoi sostenitori fossero entrati in città per prendere il potere avrebbero inevitabilmente rimpiazzato i seguaci di Buchanan, tra i quali si trovavano i mariti di alcune delle sue clienti migliori. Lei poteva solo auspicare che ne restasse almeno qualcuna, tanto da garantirle lavoro a sufficienza. Non osava sperare che la nuova first lady amasse vestirsi con eleganza e di riuscire in qualche modo a farsi notare da lei. Mezzanotte era già passata da un pezzo quando fu svegliata di soprassalto dalle grida per le strade, da canti e discorsi trionfali e, poco dopo, da spari e vetri infranti. Si rizzò a sedere sul letto e tese le orecchie, al buio, cercando di interpretare quell’accozzaglia di suoni e urla concitate. Alla fine capì che i voti erano stati contati e che il risultato dell’elezione era stato divulgato. Abraham Lincoln sarebbe diventato il sedicesimo presidente degli Stati Uniti. Elizabeth era arrivata a Washington senza denaro, né amici, né casa, ma presto aveva trovato lavoro come aiuto sarta per due dollari e mezzo al giorno, e aveva preso una stanza in una pensioncina. Aveva deciso quasi subito di mettersi in proprio, e si era procurata un’insegna e dei biglietti da visita. La sua specialità, aveva fatto sapere in giro, erano i mantua: era bravissima a confezionare i corpetti complicati e aderenti per i quali le dame eleganti impazzivano. Poco per volta si era creata un giro di clienti che l’avevano raccomandata alle amiche. Una signora generosa, intima del sindaco, lo aveva persuaso a esentarla dalla tassa per la licenza che, come tutte le donne nere libere sopra i quattordici anni, Elizabeth avrebbe avuto l’obbligo di procurarsi entro trenta giorni dal suo arrivo se desiderava trattenersi in città. In effetti aveva già deciso di restare, anche se lo spettacolo cui assisteva quotidianamente, di schiavi incatenati trascinati lungo le strade fangose dal cantiere navale alla casa d’aste, e le restrizioni imposte agli schiavi emancipati, come la licenza e il coprifuoco, le davano talvolta l’impressione di non essere davvero libera. In ottobre, qualche settimana prima dell’elezione che causò tanto scompiglio a Washington, Elizabeth aveva confezionato un abito per la moglie di un ufficiale di cavalleria, il colonnello Robert E. Lee. «Non badate a spese» aveva detto il colonnello a Elizabeth consegnandole cento dollari destinati all’acquisto di pizzi, bottoni e fiocchi per il vestito della consorte. Elizabeth era stata ben felice di obbedire, e quando Mrs Lee aveva sfoggiato l’abito a una cena privata alla Casa Bianca in onore del principe di Galles, le altre signore presenti, colpite dalla sua bellezza e dal taglio perfetto, si erano affrettate ad accaparrarsi Elizabeth. La sua reputazione era cresciuta a mano a mano che le clienti, una più soddisfatta dell’altra, la raccomandavano alle amiche, e in breve si era ritrovata con tanto di quel lavoro da non riuscire quasi a sbrigarlo. Poco dopo l’elezione, una signora per la quale lavorava la suggerì a una vicina, Varina Davis, moglie del senatore Jefferson Davis del Mississippi. Sapendo che i Davis amavano dormire fino a tardi, Elizabeth propose di recarsi nella loro casa di I Street di pomeriggio invece che di primo mattino. Così facendo poteva lavorare per la famiglia del senatore dopo pranzo, mentre al mattino sarebbe stata libera di occuparsi delle altre sue clienti. Mrs Davis accettò la proposta, e i giorni autunnali passarono in modo sereno e produttivo, nonostante la tensione crescente in città, che sembrava essersi esacerbata invece che calmata dopo l’elezione. La residenza dei Davis era il centro nevralgico delle attività sudiste: politici e statisti del Sud arrivavano di corsa a qualsiasi ora e scomparivano nello studio del senatore Davis per riunioni clandestine tenute a bassa voce. Ma di tanto in tanto si udivano grida irate, e a ogni scoppio di collera le labbra di Mrs Davis si stringevano in modo impercettibile; di solito però si limitava a lanciare un’occhiata alla porta e a far finta di niente. Se era di buonumore azzardava una battuta sugli uomini e il loro brutto carattere, ma Elizabeth sospettava che fosse preoccupata quanto loro per il divario che si stava ingigantendo tra Nord e Sud. A Elizabeth piacevano i Davis. Il senatore le pareva un gentiluomo cortese e dignitoso, e sua moglie – bruna, grandi occhi castani e una pelle troppo scura per i dettami della moda – era istruita e spiritosa, e sembrava avere amici dappertutto, tra i repubblicani come tra i democratici. Mrs Davies dimostrava una trentina d’anni, dieci meno di Elizabeth. Amava leggere e citare poesie, e quando Elizabeth arrivava di solito la trovava intenta a scrivere una lettera, leggere un libro o ricevere un’amica. Un grigio pomeriggio di dicembre, Elizabeth arrivò dai Davis appena in tempo per vedere una delle amiche della signora, la graziosa e vivace moglie di Samuel Phillips Lee, andarsene in fretta e con aria irritata. «Non sembra contenta» mormorò la sarta a Jim, il portiere nero, uno schiavo che era venuto a Nord dal Mississippi al seguito dei Davis. «Ho quasi paura di entrare per scoprirne il motivo. Hanno litigato?» Jim annuì. «Non per molto e senza gridare, però sì, hanno bisticciato. Ho sentito dire a Mrs Davis che non vuole più avere niente a che fare con i repubblicani». «Ma perché? Che sciocchezza». Elizabeth spostò la borsa nell’altra mano e fece un gesto di saluto all’amica di Mrs Davis che si allontanava con cautela lungo la strada. Il freddo invernale aveva gelato il fango, che si era indurito creando solchi profondi e rendendo pericolosi gli spostamenti a piedi. Difficile capire cosa fosse peggio, se il fango denso e molle che insozzava le sottane e risucchiava le scarpe, o quello congelato che provocava storte e cadute. «Mrs Davis ha molti amici repubblicani». «Non vengono quasi più». Jim si guardò alle spalle e si sporse verso di lei, prendendo un tono confidenziale. «Sapete quanti democratici inferociti riescono a stiparsi nello studio di Mr Davis?» «Dieci?» azzardò Elizabeth curiosa. «Una dozzina?» «Il doppio, l’ho visto con i miei occhi. Sono arrivati ieri al tramonto, senatori, ministri e tutti gli altri, alla spicciolata, discreti, e sono rimasti fino alle tre di stamattina a parlare di secessione». Il cuore di Elizabeth iniziò a battere veloce. La prima volta che aveva sentito quella parola era stata costretta a domandarne il significato al suo padrone di casa, Walker Lewis, e sentirla pronunciare non mancava mai di spaventarla. «Hanno parlato anche della guerra?» «Parlare dell’una di solito porta a parlare anche dell’altra, non è vero?» Elizabeth annuì. Era proprio vero. «Forse non si arriverà a tanto. Forse sono solo spacconerie dei politici». Sapeva che il senatore Davis lavorava giorno e notte per convincere gli stati che praticavano ancora lo schiavismo a restare nell’Unione. Sperava che i suoi sforzi fossero destinati al successo, ma le divergenze fra le due parti erano tanto marcate che un accordo sembrava improbabile. «Può darsi» disse Jim facendola entrare, ma lei sapeva che era solo una formula di cortesia. Forse lui la voleva, la guerra, se gli avesse garantito la libertà. Non poteva dargli torto. Trovò Mrs Davis in salotto, con un libro in grembo e lo sguardo assente. «Buongiorno, signora» la salutò. «Ho finito di imbastire la fodera del vestito da giorno, se volete provarlo». Mrs Davis alzò lo sguardo trasalendo. «Certo, Elizabeth». Si alzò e fece segno alla sarta di seguirla di sopra, nel suo salottino privato. La moglie del senatore rimase in silenzio mentre Elizabeth la aiutava a infilare il corpetto e la gonna di mussola. La sarta era dell’opinione che investire tempo e fatica per tagliare e provare la fodera fosse il segreto per un abito ben riuscito, e considerava con occhio critico le sue colleghe che non dedicavano la necessaria cura a quella fase dell’operazione. Per prima cosa Elizabeth creava un modello per la fodera appuntando con gli spilli la mussola a buon mercato o la carta sul corpo della cliente. Poi staccava i vari pezzi e li imbastiva. La cliente provava questa prima versione dell’abito, che Elizabeth poi modificava e adattava prima di un’altra serie di prove; queste terminavano solo quando la sarta si considerava pienamente soddisfatta. Soltanto allora si azzardava ad avvicinare le forbici al raso, alla seta o al tessuto moiré, ben più preziosi, che avrebbero costituito lo strato esterno del vestito. A quel punto il modello ormai perfetto era l’unico supporto che le serviva per confezionare l’abito, un’operazione che compiva nelle proprie stanze, in privato. Il processo era lungo e laborioso, ma Elizabeth insisteva nell’affermare che era l’unico modo per avere un abito perfetto. Si chiedeva cos’avrebbero pensato le sue clienti se avesse detto loro che aveva imparato la tecnica del tagliare direttamente il materiale sul corpo dalle schiave nere in Virginia; non perché fossero fanatiche della moda, naturalmente, ma per non sprecare neppure un pezzetto del ruvido cotone fornito dalla padrona. Mentre Elizabeth creava delle piegoline nella parte posteriore del corpetto e le fissava con cura con gli spilli, Mrs Davis sospirò e disse: «Mi chiedo... Mi chiedo se avrei dovuto scegliere un tessuto più adatto all’estate nel Sud». «Il raso vi dona particolarmente, e farà molto caldo solo per pochi giorni». Studiando il corpetto, Elizabeth staccò altri due spilli dal puntaspilli e li appuntò. «Perché vi preoccupate? Pensate di andare in Mississippi per l’estate?» «Sì, andiamo a casa» rispose Mrs Davis con una breve risata. «Sono nata in Mississippi, ma il mio cuore è a Washington. Mi dispiacerebbe molto andarmene, anche se prendessero il sopravvento i repubblicani». «Anche a me dispiacerebbe molto vedervi partire». Elizabeth ripensò alla moglie di Samuel Phillips Lee, con i lineamenti fini deformati dalla collera mentre usciva frettolosamente da casa Davis. «E anche alle vostre amiche, ne sono sicura». «Dubito che le mie amiche si tratterranno qui. Alcune di loro hanno già dichiarato di volersi trasferire in stati dove riceveranno un’accoglienza migliore. Nessuna di noi ha molta scelta, d’altronde». Con un sospiro Mrs Davis permise a Elizabeth di allargarle le braccia per poter sistemare le maniche dell’abito. «Il dovere di una moglie è accompagnare il proprio consorte. Se i nostri decidono di restare nell’Unione, e quindi a Washington, restiamo. In caso contrario...» Mrs Davis lasciò la frase in sospeso e agitò la mano come a chiudere il discorso, con un movimento convulso che strappò la manica di mussola dalle mani di Elizabeth. «Insomma, andremo dove ci toccherà, che ci piaccia o no». «Se dovrete andare, e lo credo improbabile» replicò Elizabeth, «sarete la dama meglio vestita del Mississippi, sempre se state ferma e mi lasciate finire». Suo malgrado Mrs Davis rise. Diede un colpetto amichevole alla mano che l’altra donna le aveva posato su un fianco, ma da quel momento in poi rimase perfettamente immobile finché Elizabeth non ebbe terminato. Durante il mese di dicembre l’argomento della guerra fu sollevato spesso a casa Davis, tanto dalla signora quanto dal senatore. Questi lavorava sempre di più e a tutte le ore, e sua moglie, quando non si occupava dei figli piccoli, si distraeva scrivendo lettere, leggendo libri e ricevendo amiche dalle quali probabilmente pensava di doversi congedare quanto prima per non rivederle mai più. Un’agitazione profonda, che nessuno osava manifestare esplicitamente, serpeggiava per la città; si viveva con l’impressione che il tempo a disposizione stesse per scadere, ed Elizabeth lo avvertiva in particolar modo a casa Davis. All’avvicinarsi delle feste di fine anno, Mrs Davis diede parecchio lavoro alla sarta, chiedendole di cucire abiti per tutti i giorni per lei e le figlie, e un indumento speciale per suo marito, una splendida vestaglia di seta che gli avrebbe regalato a Natale. Siccome la moglie voleva fargli una sorpresa, chiese a Elizabeth di tenerla nascosta ogni volta che il senatore era a casa. Una volta Mrs Davis si precipitò nella stanza dove Elizabeth era impegnata a cucire e le gettò addosso una trapunta – che coprì gli scampoli di seta, il cesto da cucito ed Elizabeth stessa dalle spalle alla punta delle scarpe – solo qualche istante prima che il senatore Davis facesse il suo ingresso, essendo tornato dal Campidoglio più presto del solito. Non ci fu il tempo di sistemare la trapunta perché avesse un’aria meno ridicola, così Elizabeth si limitò a salutare con un cenno del capo, senza muoversi, mentre Mrs Davis andava a baciare il marito cercando di distrarlo. Il senatore ricevette il benvenuto della moglie, ma poi lanciò un’occhiata curiosa dietro di lei, alla sarta. «Avete freddo, Lizzie?» «Ora non più, Mr Davis» replicò lei. Mrs Davis fece un rapido sorriso complice e trascinò il marito fuori dalla stanza, chiedendogli come fosse andata la giornata. Elizabeth, soffocando una risata, si tolse di dosso la trapunta, piegò la seta e la nascose nel cesto prima che il senatore tornasse. Fu uno dei rari momenti sereni in un periodo di tensioni e preoccupazioni crescenti. Alcuni giorni prima di Natale tutta Washington fu scossa dalle notizie provenienti dal Sud: il South Carolina aveva votato la secessione dall’Unione. A casa Davis, dove fino a quel momento Elizabeth aveva sentito dibattere se fosse o meno legale o giusto dissolvere l’Unione, cominciarono a fare congetture su quali stati avrebbero seguito il South Carolina ed entro quanto tempo. Mentre gli appelli alla secessione si facevano più pressanti, Mrs Davis manteneva un atteggiamento ambiguo. Un giorno si faceva paladina della causa dei diritti dei singoli stati ed elogiava lo schiavismo, e l’indomani confidava a un’amica che non sopportava l’idea di andarsene da Washington, dove aveva abitato a lungo e creato legami molto forti. «Preferisco restare a Washington e farmi mettere i piedi in testa piuttosto che andare a sud e diventare la moglie del presidente» dichiarò. Quando l’amica reagì con un’esclamazione sorpresa, Mrs Davis le assicurò che lo pensava davvero. Sembrava certo che altri stati del Sud avrebbero seguito l’esempio del South Carolina, uscendo dall’Unione. In mezzo a tutto quel fermento, Elizabeth faticava a trovare il tempo per confezionare la vestaglia del senatore Davis. Dopo settimane di lavoro clandestino, frettoloso e spesso interrotto, alla vigilia di Natale il regalo non era ancora pronto. Anche se Mrs Davis non la rimproverò, Elizabeth sapeva che avrebbe tanto desiderato poter impacchettare la vestaglia finita per donarla al marito la mattina di Natale. «Se volete resto a finirla» propose Elizabeth nel tardo pomeriggio, anche se era stanca dopo una lunga giornata a cucire, con le dita indolenzite, la testa e la schiena che le dolevano. Mrs Davis accettò felice e piena di gratitudine, ed Elizabeth riprese quindi a cucire punti veloci e precisi alla luce del lume a gas del salottino, mentre la sua cliente decorava l’albero di Natale in soggiorno. Pensò a suo figlio, che trascorreva le vacanze con un compagno di studi a Cleveland. Era il primo Natale che non trascorrevano insieme. Elizabeth aveva mandato a George un pacchetto regalo con dei dolci, un libro e due camicie eleganti, ma non aveva avuto sue notizie. Guardando Mrs Davis indaffarata a preparare i festeggiamenti con la famiglia, ebbe ancora più nostalgia del suo George. Quando era giovane, la sua bellezza e grazia naturale avevano attirato l’attenzione di un bianco potente, Alexander Kirkland, e non c’era stato modo di scoraggiarlo. Il padrone di Elizabeth non aveva fatto nulla per proteggerla, e così era stato concepito George, il bambino che lei non aveva voluto ma che aveva finito per amare con tutto il cuore. Il rumore di una porta che si chiudeva in un’altra ala della casa la destò dalle sue fantasticherie, e quando diede un’occhiata all’orologio su un tavolo vide che mancava un quarto a mezzanotte, e che il coprifuoco per la gente di colore, fissato alle dieci di sera, era quindi già passato da un pezzo. Non poteva tornare a casa a piedi, anche se avesse avuto il coraggio di aggirarsi per la città a un’ora tanto tarda: la criminalità era aumentata parecchio persino in un quartiere elegante di bianchi come quello dei Davis e nella zona piccolo borghese di neri dove abitava lei. Decise che, quando avesse finito la vestaglia, l’avrebbe consegnata a Mrs Davis e le avrebbe chiesto di poter dormire in soffitta con la servitù. Con un po’ di fortuna sarebbe riuscita a riposare qualche ora e a partecipare alla celebrazione natalizia alla Union Bethel Church l’indomani. Virginia e Walker Lewis le avevano proposto di unirsi a loro e alle figlie per il pranzo di Natale, ed Elizabeth era stata ben felice di accettare. Era abituata a trascorrere molto tempo da sola – dopo più di trentasette anni da schiava, privata di qualunque forma di solitudine, potersi isolare dagli altri continuava a parerle un lusso –, ma il giorno della nascita del Signore voleva festeggiare in compagnia di amici. Stava sistemando la cintura a cordoncino della vestaglia quando udì il senatore Davis nel corridoio tra il soggiorno e il salotto. «Che aria di festa avete saputo creare, mia cara» lo udì elogiare la moglie, anche se la voce non tradiva alcuna contentezza. «Ai bambini brilleranno gli occhi di gioia quando vedranno quell’albero». Si appoggiò allo stipite della porta e lanciò un’occhiata nel salottino. «Siete voi, Lizzie?» chiese, avvicinandosi. «Perché siete ancora qui, così tardi? Spero che Mrs Davis non pretenda troppo da voi». «No, signore» rispose, impressionata dalla sua aria stanca e sciupata. Elizabeth sapeva che aveva dieci anni più di lei e che non godeva di buona salute, ma evidentemente gli eventi delle ultime settimane l’avevano fatto invecchiare anzitempo. Essendo stata colta di sorpresa, non ebbe modo di nascondere la vestaglia. Fu così costretta a spiegarsi, anche se cercò di mostrare il meno possibile pur senza mentire. «Mrs Davis desiderava proprio che finissi questa vestaglia entro stasera» gli disse, lanciando uno sguardo verso il soggiorno per assicurarsi che la moglie non udisse, «e mi sono offerta di rimanere per terminarla». «Allora dev’essere urgente». Il senatore attraversò la stanza e prese in mano l’orlo della sua sorpresa di Natale. «Di che colore è? Questo lume non è sufficiente per i miei occhi ormai vecchi». «È seta cangiante verde oliva, signore». Stava per aggiungere che era un colore splendido e che gli avrebbe donato molto, ma decise di lasciare che lo scoprisse da solo quando avesse aperto il regalo, il giorno dopo, e l’avesse ammirato alla luce del sole. Lui annuì, fece un sorriso enigmatico, lasciò andare l’orlo e uscì dalla stanza senza aggiungere altro. Elizabeth sapeva che aveva indovinato che si trattava del regalo di Natale da parte della moglie, e che non voleva rovinarle la sorpresa. Si sentì toccata dalla sua sensibilità. Non avrebbe mai potuto trovarsi d’accordo con le sue idee riguardo lo schiavismo o la secessione, ma certamente lo ammirava per i piccoli gesti affettuosi nei confronti della moglie. Finì la vestaglia proprio mentre l’orologio suonava la mezzanotte. In modo del tutto inatteso le tornò in mente suo marito, che l’aveva ingannata e delusa finché non si era vista costretta ad annunciargli che sarebbe andata a stare per conto proprio. James Keckley, il quale aveva finto di essersi affrancato per indurla a sposarlo, era invece uno schiavo fuggitivo che viveva nascosto a Saint Louis, se non era ancora morto a forza di bere. Piegò con cura la vestaglia e ricacciò in un angolo della mente i pensieri sul marito ormai lontano. Era Natale, e in quel giorno benedetto non avrebbe augurato nulla di brutto a nessuno, in particolare non all’uomo che un tempo aveva amato. Subito prima di mezzanotte, il 31 dicembre, le campane della Trinity Church tra Third Street e C Street suonarono Hail, Columbia e Yankee Doodle per dare il benvenuto all’anno nuovo, ma le ultime possibilità di riconciliazione tra Nord e Sud facevano ormai parte del passato. Capodanno di solito era una giornata di festa in città, o questo almeno aveva assicurato a Elizabeth chi ci abitava da sempre, ma il primo giorno del 1861 non c’era folla a festeggiare in locande e taverne, e ben pochi fecero visita ai vicini. Chi si presentava sulla soglia in quella mattina limpida e fredda aveva un’espressione ansiosa e turbata, e pareva spinto a uscire da un impegno irrevocabile piuttosto che dal desiderio di scambiarsi gli auguri. Un vicino, ex schiavo che lavorava come maggiordomo alla Casa Bianca, disse più tardi ai Lewis che al tradizionale ricevimento di Capodanno si erano presentati meno ospiti del solito. Gli invitati erano cortesi tra loro come richiedeva l’etichetta, ma alcuni sfoggiavano sul cappello insolenti coccarde inneggianti all’Unione o alla secessione, in modo che fosse ben chiaro da che parte stavano. Neppure il presidente Buchanan sfuggì a frecciate e commenti pungenti quando strinse la mano agli invitati, ma essendo l’anfitrione oltre che il presidente, anche se solo per poche settimane ancora, reagì con tatto e diplomazia. Il 9 gennaio il Mississippi votò la secessione, e Jefferson Davis comunicò alla moglie che era deciso a seguire il suo amato stato fuori dall’Unione. Poi il senatore si ammalò e dovette restare a letto alcuni giorni, e fu proprio in camera sua che un flusso ininterrotto di amici, politici e statisti andò a trovarlo per discutere la situazione. Elizabeth era certa che la pressione esercitata dal ruolo di leader dei democratici del Sud avesse contribuito non poco al suo stato di salute. La moglie lo accudì amorevolmente, e quando la sarta elogiò la sua disinvoltura e sicurezza nel curare il malato, Mrs Davis si limitò a replicare: «Ho fatto molta pratica». Una sera, mentre Elizabeth la vestiva per uno dei pochi ricevimenti ai quali partecipò la coppia quel triste autunno, Mrs Davis disse a un tratto: «Sapete, siete così brava che vorrei portarvi con me». Qualcosa nel suo tono di voce suggerì a Elizabeth che non si trattava di un complimento gratuito. «Quando partirete per il Sud, Mrs Davis?» chiese. «Oh, non so ancora di preciso, ma presto. Sapete che scoppierà la guerra, vero?» Lei lo sospettava da tempo, ma la sua cliente sembrava averne la certezza; essendo la moglie del senatore Davis, era probabile che parlasse con cognizione di causa. «La guerra? Non direte sul serio...» «Sì, ve l’assicuro. La gente del Sud non tollererà le richieste umilianti del partito abolizionista. Si batterà». Elizabeth si sforzò di mantenere un tono di voce pacato mentre allacciava gli ultimi bottoni. «E chi vincerà, secondo voi?» «Il Sud, naturalmente» replicò Mrs Davis. «Il Sud è impulsivo, e i soldati sudisti ce la metteranno tutta per vincere. Il Nord si troverà costretto a cedere quando vedrà che il Sud è determinato, invece di lasciarsi coinvolgere in un conflitto lungo e sanguinoso». Impulsivo e determinato forse, ma Elizabeth non pensava che bastasse per vincere una guerra. Credeva anche, sebbene non avesse l’impudenza di dirlo ad alta voce, che Mrs Davis sottovalutasse la determinazione dei nordisti. Quelli di sua conoscenza non sembravano particolarmente arrendevoli, né spaventati più dei sudisti alla prospettiva di combattere. «Mrs Davis» disse invece, con il tono di voce più ragionevole che poté, «siete sicura che ci sarà la guerra?» «Sì, ne sono certa». A un tratto si voltò sulla sedia e afferrò la mano della sarta. «Vi conviene venire al Sud con me. Mi prenderò cura di voi». Elizabeth fu colta alla sprovvista e d’istinto sottrasse la mano. Mrs Davis non sembrò accorgersi del gesto poco garbato. «Quando scoppierà la guerra, i neri soffriranno, qui al Nord. La gente vi considererà responsabili del conflitto, e temo che in preda all’esasperazione finirà per prendersela con voi». Elizabeth fu costretta, suo malgrado, a condividere l’opinione della cliente con un cenno del capo. La secessione avrebbe causato la guerra, e la responsabilità ricadeva sui delegati dei vari stati che avevano votato per uscire dall’Unione. Ma anche lei temeva che in un modo o nell’altro la colpa sarebbe stata attribuita alla gente della sua razza, come spesso accadeva ingiustamente. «Forse tornerò a Washington tra qualche mese e mi stabilirò alla Casa Bianca» fantasticò Mrs Davis mentre si girava per osservare i drappeggi dell’abito allo specchio. «I sudisti parlano di eleggere presidente mio marito. Anzi, sembra ormai assodato che sarà lui il presidente. Non appena arriveremo nel Sud e ci separeremo dagli altri stati, riuniremo un esercito e marceremo su Washington, e io andrò ad abitare alla Casa Bianca». «Mrs Davis» intervenne Elizabeth, «sono molto onorata per la fiducia che mi accordate. Però...» Dovette fermarsi per fare un respiro e riflettere un attimo. «Devo pensare alla mia attività. Qui ho la mia chiesa, gli amici». «Anche al Sud abbiamo delle chiese, come forse ricorderete, e molte donne di colore che sarebbero felici di diventare vostre amiche». Un lieve sorriso divertito le sollevò gli angoli della bocca. «Per quanto riguarda la vostra attività, sono sicura che andrà benissimo anche laggiù. Io continuerò ad avere parecchio lavoro per voi e, se non bastasse, con la mia raccomandazione credo che non avrete difficoltà a trovare molte nuove clienti a Montgomery». Allora i Davis progettavano di trasferirsi in Alabama, non in Mississippi. Elizabeth si chiese come mai la sua cliente non gliel’avesse detto prima. «Ecco... non so cosa dire. Vi prego di perdonare le mie esitazioni. Vi ringrazio per l’alta opinione che avete del mio lavoro». «Anche di voi, non solo del vostro lavoro». Mrs Davis cercò il suo sguardo nello specchio e la guardò fissa. «Promettetemi di riflettere sulla mia proposta, anche se il tempo stringe. Dovrete rispondermi in breve tempo». Quello Elizabeth poteva farlo. «Lo prometto». Mantenne la parola, e meditò sull’offerta della sua cliente. Ebbe la tentazione di accettare: la famiglia Davis le piaceva, e il ragionamento della signora sembrava plausibile. Ma tornare nel profondo Sud, nella terra dove regnava ancora la schiavitù... Pur essendosi ormai affrancata, sapeva che la vita sarebbe stata difficile per lei, molto più che nel distretto di Columbia, dove pure si praticava ancora lo schiavismo. Per quanto apprezzasse Mrs Davis, era più affezionata ai Lewis, e le sarebbero mancati troppo gli amici che frequentavano l’Union Bethel Church. Inoltre era possibile che i nordisti, come ipotizzava Mrs Davis, incolpassero i neri per l’inevitabile conflitto e sfogassero la propria rabbia su di loro; ma i sudisti non avrebbero fatto lo stesso? Dopo avere riflettuto a lungo sulla questione, sapendo che il momento di dare una risposta si avvicinava, Elizabeth chiese aiuto agli amici. Tutti loro, nati liberi o schiavi affrancati, le suggerirono di restare a Washington. Non si capacitavano del fatto che la moglie del senatore Davis le avesse rivolto un’offerta del genere pur conoscendola da così poco tempo. La sarta lavorava per loro da meno di tre mesi, e Mrs Davis si aspettava che lasciasse casa sua e affrontasse rischi inimmaginabili in una terra che, a suo dire, stava per essere devastata dalla guerra? Contrariamente a lei non credevano che la proposta di Mrs Davis fosse generosa. «Non andare» la implorò Virginia una sera, dopo essere rimasta a parlare con lei in soggiorno fino a tarda ora. «Se cambiassi idea, forse non ti sarebbe più possibile tornare a casa». Elizabeth sapeva che i suoi amici avevano ragione. Sapeva anche che il Nord era molto più forte di quanto Mrs Davis sembrasse credere: il popolo del presidente Lincoln era determinato e assetato di vittoria, e la sarta non pensava che avrebbe rinunciato agli stati meridionali senza combattere o che avrebbe ceduto di fronte alle prime resistenze del Sud. Alla fine, dopo tante riflessioni, domande e preghiere, prese la sua decisione basandosi su un unico fatto irrefutabile: era una donna di colore, e sarebbe stato più saggio per lei restare con la gente del Nord, che almeno in parte appoggiava l’abolizionismo, piuttosto che unirsi ai sudisti, i quali avrebbero preferito vederla in catene. Qualche giorno dopo Elizabeth non aveva ancora comunicato la sua decisione a Mrs Davis. Arrivando alla residenza del senatore scoprì che la sua cliente era uscita più presto del solito, quella mattina, per acquistare diversi metri di chintz a fiori, grazioso ma meno prestigioso dei tessuti che usava di solito. «Vorrei che mi confezionaste due abiti da casa» esordì Mrs Davis, sciorinando gli scampoli e disponendoli sul divano. «Di chintz?» «Sì, Elizabeth, di chintz». Mrs Davis fece un sorriso forzato, come se stesse per mettersi a piangere. «Devo rinunciare agli abiti costosi per un po’. Ora che la guerra è imminente, devo diventare un esempio di frugalità per la gente del Sud». «Certo». La sarta raccolse le stoffe. «Comincio subito». «Grazie». Dopo un istante aggiunse: «Elizabeth?» «Sì, Mrs Davis?» «Credo...» Lasciò la frase in sospeso, e fece un respiro profondo. «Meglio essere prudenti. Sarebbe bene che li finiste al più presto». Elizabeth capì al volo. Il destino dei Davis era ormai irrevocabile, solo una questione di tempo. La sarta terminò di confezionare gli abiti pochi giorni prima che la famiglia Davis lasciasse Washington. Quando le presentò gli indumenti finiti, Mrs Davis li ammirò poi li mise da parte e consegnò a Elizabeth alcuni suoi ricami particolarmente difficili che voleva affidare alla sarta perché li portasse a termine. «Potete mandarmeli tramite il servizio postale quando avete finito» la istruì, poi tacque e fece un sorriso speranzoso. «Oppure potete venire nel salotto della mia nuova casa e consegnarmeli di persona. Forse non avrete molta strada da fare. Sono sicura che, ovunque ci stabiliremo, troveremo una stanza per voi nella nostra residenza». Elizabeth non poteva più rimandare. «Mi dispiace molto, Mrs Davis. Sono ben contenta di finire il ricamo, ma dovrò inviarvelo. Ho deciso di restare a Washington». La signora strinse le labbra e annuì, come se si fosse preparata al rifiuto di Elizabeth ma non volesse ancora rassegnarsi del tutto. «Non vi tenta per niente la prospettiva di diventare la sarta personale di una first lady?» Elizabeth fece una risata nervosa. «Certo che sì, ma non abbastanza da rinunciare al posto dove vivo. Vi prometto, signora, che se tornerete a Washington sarò ben lieta di ricominciare a lavorare per voi. Più che lieta: ne sarei felicissima». «Oh, Elizabeth». Mrs Davis la guardò con un’espressione triste e affettuosa. «Vi siete appena tradita. Avete detto se ritorno, non quando». Il 21 gennaio, Jefferson Davis e diversi altri senatori del Sud rinunciarono al proprio incarico e partirono da Washington, legando la propria sorte a quella dei rispettivi stati. Più tardi Elizabeth lesse sui giornali che il senatore Davis aveva espresso il proprio amore per l’Unione e un desiderio di pace, ma aveva anche ribadito il diritto a possedere degli schiavi e il diritto di secessione da parte degli stati meridionali. «Certo non provo nessuna ostilità nei vostri confronti, senatori del Nord» aveva detto in Senato. «E non c’è nessuno, per quanto le discussioni tra noi possano essere state aspre, al quale non auguri, al cospetto del Dio in cui credo, ogni bene». Poco dopo Mrs Davis lasciò Washington con il marito, i figli e gli schiavi. Gli stati del Sud elessero Jefferson Davis presidente, e Varina Davis divenne first lady della Confederazione. 1. Ampio ed elegante abito femminile le cui origini risalgono al diciottesimo secolo (N.d.T.). 2. Febbraio-marzo 1861 Tutta Washington fremeva d’impazienza e, in certi ambienti, di apprensione per l’arrivo del presidente Lincoln. Si stava avvicinando alla capitale con la sua famiglia seguendo un percorso ferroviario tortuoso, per salutare più sostenitori possibile durante il tragitto, e per evitare che qualcuno tentasse di fargli del male. «Non ha ancora assunto le sue funzioni e i secessionisti stanno già minacciando di ucciderlo» commentò Walker Lewis un mattino, offendo a Elizabeth il giornale, disgustato dalle notizie. «Non vogliono neppure aspettare di vedere cosa farà una volta insediato. Lo odiano per principio». Anche il conflitto sempre più aspro per il controllo di Fort Sumter nel porto di Charleston era sulla bocca di tutti. Fin dal 26 dicembre, quando il maggiore Robert Anderson aveva trasferito il posto di comando dal vulnerabile Fort Moultrie di Sullivan’s Island alle fortificazioni più robuste e facilmente difendibili che si affacciavano sul porto, le poche truppe federali che vi si trovavano erano praticamente sotto assedio. All’inizio di gennaio, lo stesso giorno della secessione del Mississippi dall’Unione, le forze del South Carolina avevano fatto fuoco sulla Star of the West, una nave mercantile disarmata che il presidente Buchanan aveva inviato al maggiore Anderson e ai suoi uomini con aiuti e rifornimenti. La nave era stata costretta a fare dietrofront, e le notizie che giungevano da Fort Sumter erano sempre più critiche, a mano a mano che gli uomini esaurivano le scorte di cibo, munizioni e altri generi di prima necessità. Anche se molti repubblicani chiedevano un intervento militare immediato, Buchanan sembrava invece incline a temporeggiare per le ultime settimane della sua presidenza e a lasciare che a risolvere il problema fosse il suo successore Abraham Lincoln. Le mogli di alcuni ufficiali si erano insediate a Sullivan’s Island con i mariti, ma quando il maggiore Anderson aveva spostato le truppe da Fort Moultrie a Fort Sumter, le signore erano state dirottate su Charleston perché non corressero rischi. Lì però avevano trovato solo porte chiuse. Nessuna pensione aveva accettato di accoglierle, e la proprietaria di una locanda aveva dichiarato senza mezzi termini che se avesse ospitato le mogli degli ufficiali avrebbe perso tutti gli altri clienti. Scoraggiate e furiose, le donne erano state costrette a lasciare i mariti asserragliati a Fort Sumter e a cercare rifugio al Nord. Al loro arrivo a Washington, amareggiate e piene di risentimento, si erano viste accogliere con grande calore dai repubblicani ed erano state celebrate come le prime martiri della guerra. «Non riesco a immaginare come si siano sentite» dichiarò una sera una delle clienti di Elizabeth mentre la sarta la vestiva per un ricevimento alla Casa Bianca. Margaret Sumner McLean era figlia del maggior generale Edwin Vose Sumner, nato in Massachusetts, e moglie del capitano Eugene McLean, originario del Maryland, che non faceva mistero delle proprie simpatie sudiste. Il cugino di suo padre era il senatore abolizionista Charles Sumner, che cinque anni prima era stato picchiato selvaggiamente e quasi ucciso in Senato da un collega del South Carolina, offeso da uno dei suoi discorsi contro lo schiavismo; la violenza della reazione non sorprendeva, visto che l’orazione traboccava di insulti personali. Affermare che in quel periodo di crisi Mrs McLean si sentisse combattuta era un eufemismo. «Mandare via donne inermi, lasciarle senza casa e senza protezione! Sono scandalizzata dalla cosiddetta cavalleria meridionale!» «Ho sentito dire che alcuni gentiluomini del Sud hanno offerto alle signore una stanza nella propria casa» fece osservare Elizabeth, sistemando la balza di pizzo attorno alle spalle della sua cliente. «Le signore hanno declinato». Mrs McLean reagì scoppiando a ridere, quasi a sottolineare l’assurdità della situazione. «Non avevano scelta, e i gentiluomini di Charleston lo sapevano bene. Come potevano accettare l’ospitalità di uomini che avevano dichiarato apertamente la propria ostilità nei confronti dei loro mariti? Posso immaginare la piega che avrebbero preso i negoziati: “Sentite, maggiore Anderson, sicuri di volerlo ancora, Fort Sumter? Perché abbiamo qui le mogli dei vostri uomini”». «Pensate che i cittadini di Charleston avrebbero fatto del male alle signore?» «Oh, probabilmente no. Erano gentiluomini, non plebaglia. Ma anche se la loro sicurezza fosse stata garantita, le signore non potevano certo mettere i propri mariti in una simile posizione nei confronti del nemico. Né si sarebbe dovuti arrivare a tanto. Che fine avevano fatto le buone vedove di Charleston, gli onesti affittacamere? Come si sarebbero sentiti se le loro donne fossero state trattate con una simile mancanza di rispetto a Washington o a New York?» «Immagino che non l’avrebbero apprezzato». «No, infatti. L’avrebbero considerato un gesto ostile». Mrs McLean, con l’abito e i capelli perfettamente a posto, congedò Elizabeth con un ringraziamento e la promessa di trasmettere i saluti della sarta nella prossima lettera che avrebbe scritto a Varina Davis, una cara amica che le mancava molto. La società di Washington non era più la stessa, adesso che se n’era andata, e l’entusiasmo suscitato dalle nuove conoscenze era un sostituto ben scialbo alla compagnia delle amiche fidate di vecchia data. Elizabeth rivide Mrs McLean solo due settimane dopo, quando la cliente si presentò senza preavviso alla pensione dei Lewis. Elizabeth stava cucendo nella sua stanza e udì dei passi e il fruscio delle gonne col cerchio in corridoio. Alzò interdetta gli occhi dal suo lavoro e si vide davanti Mrs McLean, che la guardava con aria di superiorità da sopra un pacchetto avvolto nella mussola e stretto da uno spago. Elizabeth si sentì contrariata, ma mantenne un’espressione sorridente. Non le piaceva che le clienti andassero a casa sua, in particolare se non la avvisavano prima. Era più appropriato alla loro condizione sociale – e più rispettoso della sua vita privata – se era lei a recarsi da loro. «Elizabeth, sono stata invitata a cena al Willard domenica prossima» esordì la visitatrice a mo’ di saluto. «Non ho nulla da mettermi per l’occasione. Ho appena comprato la stoffa, dovete mettervi subito al lavoro». Elizabeth riuscì a trattenere un sospiro di esasperazione. «Ho più lavoro di quanto riesca a sbrigarne» replicò senza scomporsi. «È impossibile che vi confezioni un abito per domenica prossima». «Pff! Niente è impossibile». Mrs McLean si guardò attorno, come per sottolineare che non c’era nessun’altra cliente a richiedere i servizi di Elizabeth in quel momento. «Devo avere l’abito per domenica». «Mi dispiace...» «Non ditemi ancora di no. Dovete confezionarmelo, il vestito». Levò una mano, come per porre un freno alle possibili obiezioni di Elizabeth. «Vi ho sentito dire spesso che vorreste lavorare per le dame della Casa Bianca. Ebbene, è in mio potere procurarvi questo privilegio. Conosco bene Mrs Lincoln, e avrete l’occasione di farle un abito, sempre che finiate il mio in tempo per la cena di domenica». Per un attimo Elizabeth si chiese come mai la moglie nata in Massachusetts di un simpatizzante sudista del Maryland conoscesse la nuova first lady, cresciuta nell’Illinois e non ancora arrivata a Washington. Poi si ricordò che il padre della sua cliente era uno degli ufficiali di cavalleria che si erano offerti di accompagnare i Lincoln da Springfield alla capitale. Forse le famiglie erano amiche dai tempi in cui Lincoln era nel Congresso. Chissà, magari Mrs McLean era davvero in grado di mantenere una simile promessa. Elizabeth non ebbe bisogno di altri incoraggiamenti. «Molto bene» disse, mettendo da parte l’abito che stava ricamando per un’altra cliente, una dolce signora dal viso buono, che non si sarebbe mai sognata di lamentarsi se avesse finito il vestito con uno o due giorni di ritardo. Elizabeth si sentiva in colpa, ma non poteva permettere che un’opportunità così rara e promettente le sfuggisse. Decise che si sarebbe fatta perdonare dall’altra cliente, anche se non sapeva bene come. Ma non prima della domenica successiva. Elizabeth persuase Mrs McLean a fare subito le prove per cominciare a tagliare la fodera, assicurandole che era l’unico modo per finire in tempo il vestito. Si rividero il giorno dopo a casa della cliente, di fronte al Willard’s Hotel, e di nuovo l’indomani; da quel momento in poi, Elizabeth aveva fatto abbastanza progressi da poter continuare da sola. In realtà non fece tutto da sola: per rispettare la scadenza ingaggiò due ragazze come assistenti, sarte abili sebbene prive di esperienza, dalle quali si era già fatta aiutare in passato per piccoli lavoretti. Anche con il loro contributo, però, Elizabeth fu costretta a lavorare tutto il giorno e fino a notte inoltrata, concedendosi a malapena una pausa per mangiare, dormire qualche ora ed eliminare l’indolenzimento da collo, schiena e dita. Ci volle un piccolo miracolo, ma in qualche modo, dopo tanta fatica e ansia, il giorno della cena Elizabeth riuscì a completare l’abito. A metà mattina, non appena ebbe dato l’ultimo punto, corse a casa McLean, lo fece provare alla cliente, e realizzò piccole modifiche che nessuno, all’infuori di un’altra sarta specializzata in mantua, avrebbe notato. Il vestito era pronto. «Elizabeth, siete una meraviglia» dichiarò Mrs McLean, ammirandosi nello specchio intero. Aveva un bel fisico, e il corpetto le aderiva come una seconda pelle, mentre le pallide rose di seta conferivano una calda eleganza alla sua carnagione di alabastro. «Un’occhiata a questo abito da parte di Mrs Lincoln varrà tutte le raccomandazioni del mondo». «Vi sarei comunque molto grata» puntualizzò Elizabeth «se voleste mettere una buona parola per me». La sua cliente la guardò nello specchio da sopra la spalla, pienamente soddisfatta per l’ottimo taglio del corpetto e la perfezione della balza. «Sono tentata di tenervi tutta per me... sarete il mio piccolo segreto». Vide l’espressione dell’altra donna nello specchio e si affrettò ad aggiungere: «Stavo solo scherzando. Certo che parlerò di voi alla first lady. Avete mantenuto la vostra parte dell’accordo, ora sta a me mantenere la mia». Elizabeth mormorò parole di ringraziamento, nascondendo la delusione. A quanto pareva lei e Mrs McLean ricordavano l’accordo in modo diverso: Elizabeth non aveva lavorato tanto duro, dormendo così poco, solo perché la cliente menzionasse fuggevolmente il suo nome alla moglie del presidente. «Avrete l’occasione di farle un abito» erano state le parole esatte della donna. Era sembrata molto sicura di sé. Ora, però, Elizabeth si chiedeva se avesse davvero il potere di realizzare il suo sogno più grande. Elizabeth custodiva gelosamente tutte le preziose lettere che George le mandava dall’università di Wilberforce. Si gustava ogni parola: la descrizione degli studi, i nuovi amici, gli scherzi innocenti, le lunghe ore trascorse in biblioteca. Dopo aver risposto alle molte domande della madre, gliene rivolgeva altrettante su Washington; voleva avere notizie sull’elezione, il passaggio di potere, i personaggi famosi che lei incontrava. «Le tue notazioni suscitano l’invidia dei miei compagni di corso» le scriveva. «Loro devono accontentarsi delle notizie che leggono sul giornale, mentre io ricevo di prima mano i tuoi resoconti esaurienti e regolari. Gli amici vengono da me quando hanno domande sugli avvenimenti della capitale (non preoccuparti, mamma, non divulgo mai i pettegolezzi sulle tue clienti), e sono ben felice di rispondere. Non condividerò mai con nessuno le belle camicie che hai confezionato per me, ma quando si tratta di informazioni posso anche dimostrarmi altruista». Le canzonature bonarie di George la facevano sorridere, così come i suoi elogi generosi. La mancanza di istruzione era sempre stata fonte di dispiacere per lei, ma sapeva di essere già fortunata a saper leggere e scrivere. Erano due attività illegali per gli schiavi, ma nessuno dei proprietari di Elizabeth aveva mai proibito ai suoi schiavi di istruirsi se erano abbastanza intelligenti da imparare da soli o aiutandosi a vicenda nel tempo libero. Elizabeth non si considerava brava a scrivere, perciò quando l’amatissimo figlio definiva “esaurienti” le sue lettere non poteva evitare di sentirsi lusingata. Stava ridendo della descrizione comica, fatta da George, di una battaglia di palle di neve nel cortile principale dell’università quando sentì bussare alla porta. Era una domenica insolitamente calda di inizio marzo, che preannunciava la primavera, e lei e Virginia avevano progettato di andare a fare una passeggiata per vedere i preparativi della cerimonia dell’insediamento che doveva tenersi il giorno dopo. Si affrettò ad aprire, aspettandosi di vedere l’amica; si trovò invece di fronte in corridoio un giovane messaggero, un ragazzino nero di quattordici anni circa, senza fiato per la corsa e con una lettera in mano. «Devo aspettare la risposta, signora» disse annaspando. Elizabeth, curiosa, aprì la lettera, lesse la prima riga e si lasciò sfuggire un sospiro che sembrava quasi una risata. «Mia cara Elizabeth» aveva scritto Mrs McLean. «Abbiate la cortesia di passare da me oggi alle quattro. Con i miei migliori saluti, Mrs McLean». Scuotendo il capo, la sarta lesse di nuovo la breve missiva, come se con la semplice forza di volontà potesse far apparire altre parole. «Non ha detto nient’altro?» chiese al ragazzo. «Il motivo di questa convocazione, per esempio?» E di tutta quella fretta, stava per aggiungere, ma si trattenne. «No, signora» rispose lui, scuotendo il capo. «Mi ha ordinato solo di portare la lettera a Mrs Elizabeth Keckley alla pensione Lewis in Twelfth Street». «Hai svolto il tuo compito, allora». Ripiegò la lettera, se la infilò in tasca e diede una moneta al messaggero. «Per favore, torna da Mrs McLean e dille che la ringrazio per il suo biglietto, e che passerò da lei domattina appena potrò». Lui annuì e scappò via, e lei richiuse la porta. La domenica era il suo giorno libero, e le clienti lo sapevano. Era libera, quindi libera anche di non dare retta alle richieste importune. Lunedì mattina avrebbe potuto andare da Mrs McLean, qualunque cosa volesse. In caso contrario sarebbe stata libera di cercarsi un’altra sarta, anche se Elizabeth, forse immodestamente, credeva che avrebbe faticato a trovarne una brava e conciliante come lei. La mattina dell’insediamento di Abraham Lincoln era fredda e nuvolosa, le strade affollate erano sature della polvere sollevata da un vento leggero e intermittente. Non erano ancora le nove quando Elizabeth uscì dalla pensione e si unì ai gruppi di persone che si aggiravano per le vie in attesa dell’evento. Non vide neppure un volto familiare tre le migliaia di individui che incrociò nei pochi isolati che la separavano dalla casa di Mrs McLean. Lungo il tragitto vide che i visitatori venuti da fuori città non erano riusciti a trovare posto negli alberghi di Washington, e avevano trascorso la notte per strada, su una specie di giaciglio di fortuna fatto di assi di legno, e ora facevano la fila per lavarsi a una pompa d’acqua pubblica. Una folla in preda all’agitazione si era radunata davanti al Willard’s Hotel, ed Elizabeth dovette farsi strada a fatica per arrivare alla casa dei McLean, dall’altra parte della via. Col fiato in gola bussò forte alla porta d’ingresso, senza sapere se l’avessero sentita. Poco dopo il portiere venne ad aprire; quando disse il suo nome e spiegò il motivo della visita, le fu comunicato che Mrs McLean non era a casa. Proprio mentre si stava chiedendo se fosse il caso di aspettare o di provare a tornare a casa, comparve uno degli aiuti del colonnello McLean e le spiegò che doveva andare al Willard. Perplessa, Elizabeth attraversò la strada fendendo di nuovo la calca, e riuscì a fatica a varcare la soglia dell’hotel. «Eccovi!» esclamò una voce, e una mano le si posò sulla spalla, costringendola a voltarsi. Era Mrs McLean, che la squadrò contrariata e incredula. «Perché non siete venuta ieri, come vi avevo chiesto?» «Il vostro biglietto non diceva che era urgente» le ricordò la sarta. «Alla vigilia dell’insediamento poteva forse non esserlo?» La bocca della cliente si strinse in una smorfia di disapprovazione. «Mrs Lincoln voleva vedervi, ma ora temo che sia troppo tardi». «Mrs Lincoln voleva vedere me?» Mrs McLean annuì, facendo la sostenuta. «Una settimana fa, qualcuno ha rovesciato del caffè sull’abito che la moglie del presidente voleva indossare oggi. Le serviva una sarta, così le ho parlato di voi. E pensate un po’: conosceva già il vostro nome. A quanto sembra avete lavorato per alcune sue amiche di Saint Louis. Ma ormai non ha più importanza». «Mi dispiace, Mrs McLean» disse Elizabeth, profondamente abbattuta. Se la moglie del presidente aveva richiesto una sarta, perché mai la sua cliente aveva aspettato una settimana a mandarla a chiamare? «Non avevate precisato perché volevate vedermi, quindi ho pensato che sarebbe stato lo stesso venire oggi». «Sareste dovuta venire ieri» ripeté l’altra donna in tono di rimprovero, per poi ammansirsi un poco. «Andate nella stanza di Mrs Lincoln. Può darsi che abbia ancora bisogno di voi». Elizabeth si precipitò in cerca della suite numero sei. Quando bussò alla porta, una voce allegra la invitò a entrare, e avanzando nella stanza si trovò faccia a faccia con una donna sulla quarantina dai capelli scuri, leggermente appesantita ma con una bella carnagione e limpidi occhi azzurri che denotavano acume e intelligenza. Era circondata da signore eleganti che la stavano aiutando a prepararsi per l’insediamento. La signora con i capelli scuri non si presentò perché non ce n’era bisogno. «Voi siete Elizabeth Keckley, credo». Elizabeth annuì. «La sarta suggeritami da Mrs McLean?» «Sissignora». «Benissimo». Mrs Lincoln tornò alla toilette e si esaminò il viso allo specchio, toccandosi la pelle sottile sotto gli occhi e aggrottando le sopracciglia per qualche ruga appena scoperta o solo immaginata. «Ora non ho tempo di parlarvi, ma vorrei che veniste alla Casa Bianca domattina alle otto». Voltandosi sulla sedia, incrociò lo sguardo di Elizabeth e la guardò fissa. «Da domani abiterò lì». Il breve incontro era finito. Elizabeth uscì inchinandosi a ritroso e tornò a casa, senza più curarsi della folla crescente, dell’assembramento di uomini e cavalli per la sfilata ufficiale, delle note di marce militari che le giungevano all’orecchio da lontano. Solo pochi anni prima aveva vissuto in schiavitù a Saint Louis, e aveva lavorato fino allo sfinimento, chiedendosi se sarebbe mai riuscita a guadagnare abbastanza denaro per acquistare la libertà per sé e per il figlio. Adesso era stata invitata alla Casa Bianca per incontrare la first lady, un’ottima opportunità per inserirla tra le sue clienti. Avrebbe tanto voluto che George fosse lì per accompagnarla alla Casa Bianca. Voleva ricordare ogni dettaglio per poi descrivergli tutto, ogni particolare, ogni parola della conversazione, riempiendo pagine e pagine se necessario, per fargli vivere l’esperienza quasi in prima persona, istante per istante. Trascorse il resto della giornata da sola in camera sua; quando riusciva a concentrarsi cuciva, ma più spesso fantasticava sull’incontro dell’indomani con Mary Lincoln. Più tardi gli amici le avrebbero raccontato dell’emozionante cerimonia d’insediamento, di come il cielo avesse finito per schiarirsi e la cavalleria gonfia d’orgoglio avesse circondato la carrozza del presidente entrante mentre avanzava con un’andatura solenne sull’acciottolato di Pennsylvania Avenue verso il Campidoglio. Le avrebbero detto di Mrs Lincoln, impettita, che ammirava la cerimonia con la sua famiglia dalla tribuna eretta sui gradini del Campidoglio. Elizabeth avrebbe sorriso nel sentire la descrizione del presidente, alto e magrissimo, che aveva fatto un passo avanti, si era tolto il cappello e poi si era fermato di colpo, rendendosi conto solo allora che non aveva nessun posto dove metterlo mentre prestava giuramento. Il suo ex avversario, il senatore democratico dell’Illinois Stephen A. Douglas, gliel’aveva preso cavallerescamente e l’aveva tenuto in mano finché l’altro non aveva finito di parlare. Elizabeth si sarebbe commossa nel leggere la trascrizione del discorso del presidente Lincoln, in cui a proposito dei contrasti fra nordisti e sudisti diceva: «Non siamo nemici ma amici. Non dobbiamo essere nemici. Anche se le passioni possono averci messo a dura prova, non devono spezzare i nostri legami di affetto. Le corde mistiche della memoria, che si tendono da ogni campo di battaglia e tomba di patriota a ogni cuore vivente e a ogni focolare su tutta la nostra vasta terra, confluiranno nel coro dell’Unione quando saranno toccate, come certo accadrà, dagli angeli migliori della nostra natura». Adesso, nella solitudine delle sue stanze in Twelfth Street, Elizabeth udì il cupo boato dei cannoni che fecero fuoco quando Abraham Lincoln divenne il sedicesimo presidente degli Stati Uniti. Più di trentamila persone si erano assiepate sul terreno recintato attorno al Campidoglio per assistere a quell’evento storico, ma Elizabeth, persa nei suoi pensieri e assorbita da quello che sarebbe potuto diventare il giorno più importante della sua vita, non era tra loro. 3. Marzo-aprile 1861 Qualche minuto prima delle otto, il giorno dopo l’insediamento, Elizabeth percorse a piedi il mezzo chilometro che la separava dalla Casa Bianca, attraversando Lafayette Square e passando davanti alla statua di bronzo di Thomas Jefferson nel viale di accesso a semicerchio. Quando giunse in fondo al colonnato che conduceva alla porta principale della residenza presidenziale, l’anziano portiere irlandese, basso e robusto, la fece entrare nell’ingresso, dove qualche istante dopo vide una persona dall’aria familiare che le andava incontro percorrendo un corridoio ampio. «Buongiorno, Mrs Keckley» la accolse il maggiordomo. «Benvenuta alla Casa Bianca». «Grazie, Mr Brown» replicò lei, felice e stranamente riconfortata dalla presenza di quel viso amico. Come lei, Peter Brown era uno schiavo affrancato. Lui e la sua famiglia vivevano a soli tre isolati da Elizabeth, e si erano conosciuti tramite i Lewis. «Sono venuta a rendere visita a Mrs Lincoln per sapere se vuole assumermi come sarta. Avete qualche consiglio da darmi?» Peter Brown ridacchiò e la scortò fino al piano superiore lungo una scalinata centrale con un grande viavai. Uomini di tutti i tipi salivano e scendevano a grande velocità, quasi sicuramente in cerca di un lavoro proprio come lei, desiderosi di assicurarsi un posto presso la nuova amministrazione. «Non conosco la first lady abbastanza bene da saper giudicare cosa le piace e cosa no» le confidò Peter sottovoce. Si fermò un attimo sul pianerottolo per lasciar passare altra gente. «Posso però darvi un suggerimento: qualunque cosa vediate, non lasciatevi turbare». Elizabeth, perplessa, si chiese cosa potesse voler dire, ma quando il maggiordomo la fece entrare in una sala d’attesa arredata con mobili di mogano dall’aria frusta, e altre tre donne benvestite alzarono lo sguardo sentendoli arrivare, capì. Avrebbe dovuto immaginare che la first lady avrebbe chiesto a diverse conoscenti di suggerirle una sarta, e naturalmente sarebbero state tutte ansiose di entrare nelle sue grazie raccomandandole la propria. Mentre le sarte in attesa si scambiavano cenni di saluto, Elizabeth sentì su di sé il loro sguardo: stavano studiando com’era vestita, proprio come lei stava esaminando loro. Nessuno si fidava di una sarta che non indossava l’abito più elegante che poteva permettersi. Era contenta di avere scelto il suo vestito più nuovo e raffinato, di ottima lana scozzese blu, rossa e marrone chiaro e dal taglio impeccabile. La corrispondenza tra le linee colorate era così perfetta che l’abito sembrava ricavato da un unico scampolo di tessuto dal corpetto all’orlo della gonna. «Mrs Lincoln sta ancora facendo colazione» le disse Peter, indicandole una sedia. «Vi farà entrare tra poco. Forza e coraggio». Elizabeth lo ringraziò con un sorriso, ma si accasciò sulla sedia con il morale sotto i piedi. Non si era aspettata di trovarsi faccia a faccia con delle concorrenti, e dubitava che sarebbe stata scelta al posto di sarte quasi certamente più conosciute di lei a Washington. A peggiorare le cose, avevano tutte l’evidente vantaggio di essere bianche. Ma non poteva fare nulla per cambiare la situazione, così si rizzò a sedere, serena e paziente, finché finalmente non apparve una delle dame che Elizabeth aveva visto con Mrs Lincoln al Willard e chiamò la prima sarta in una sala adiacente. Elizabeth fu convocata per ultima. Fu accompagnata in un salotto ovale con il soffitto alto e grandi finestre affacciate sul prato della Casa Bianca, che scendeva dolcemente fino a un imponente cancello di metallo e a uno stagno, oltre il quale scorreva il Potomac. Mrs Lincoln era in piedi accanto a una finestra e chiacchierava con un’amica che Elizabeth non riconobbe, ma alzò lo sguardo all’ingresso della sarta e si avvicinò per accoglierla. «Eccovi qui, finalmente» le disse con calore. «Grazie per avermi ricevuta, signora» rispose Elizabeth. Frugò nella borsa ed estrasse diverse carte, che aveva protetto da strappi e piegature inserendole tra due fogli rigidi di cartone. «Vi ho portato alcune lettere di raccomandazione delle mie clienti di Saint Louis». «Sì, conosco bene la vostra reputazione». Mrs Lincoln scorse rapidamente le lettere, annuì soddisfatta e gliele restituì. «Per chi avete lavorato qui a Washington?» «Tra le altre, la moglie del senatore Davis è stata una delle mie clienti più assidue». La moglie del presidente alzò le sopracciglia. «Mrs Davis? Avete lavorato per lei? È stata soddisfatta del vostro operato?» «Certo, signora». «Benissimo. Pensate di poter lavorare per me?» «Certo, Mrs Lincoln» le assicurò la sarta con enfasi. «C’è molto da fare?» Mrs Lincoln si portò una mano al mento, come riflettendo sulla questione. «Questo, Mrs Keckley, dipende interamente dalle vostre tariffe. Spero che chiediate somme ragionevoli. Non posso permettermi di scialacquare». Lanciò uno sguardo mesto alla sua compagna, che scosse il capo in segno di solidarietà. «Siamo appena arrivati dall’Ovest e siamo poveri. Se non chiedete somme esagerate, credo che potrei affidare a voi tutti i lavori di sartoria». «Credo che le mie tariffe non vi creeranno problemi, Mrs Lincoln». Elizabeth sapeva per esperienza che le dame bianche come la first lady non avevano la sua stessa idea di “povertà”. «Pratico prezzi ragionevoli». «Bene, se non chiedete troppo avrete parecchio da fare». La fronte leggermente aggrottata sembrava smentire il tono leggero e disinvolto. «Non posso permettermi di spendere molto, meglio che lo sappiate fin da subito». Giunsero in fretta a un accordo soddisfacente per entrambe, e solo allora la moglie del presidente precisò che voleva che Elizabeth cominciasse subito. A un suo cenno, l’amica mostrò un abito rosa vivace di moiré antico che la first lady voleva indossare al primo grande ricevimento in onore dell’insediamento del marito, il venerdì seguente. Le descrisse le modifiche che desiderava, di poco conto, cosicché Elizabeth, pur avendo solo tre giorni a disposizione, le assicurò che l’abito sarebbe stato pronto in tempo. Dopo avere preso le misure della sua cliente, portò a casa con sé il vestito, e ci lavorò fino a notte fonda. Sapeva che l’indumento, pur non essendo stato confezionato da lei e di fattura mediocre, era una sorta di prova. Se l’avesse superata Mrs Lincoln le avrebbe commissionato un abito e forse molti altri a seguire. Se invece le modifiche non fossero state di suo gradimento, non avrebbe avuto una seconda possibilità. Il giorno dopo Elizabeth tornò alla Casa Bianca per altre prove e trovò Mrs Lincoln di ottimo umore, al centro di un gruppo vivace di signore, parenti venute dall’Illinois, dal Kentucky e da altri stati per partecipare ai festeggiamenti della capitale. La first lady indossava un abito da casa di cashmere con un inserto di stoffa trapuntata sul davanti e aveva un’acconciatura semplice, mentre le altre dame portavano abiti da mattina. Chiacchieravano e si prendevano in giro scherzosamente mentre Elizabeth aiutava la sua cliente a indossare l’abito e apportava alcune modifiche necessarie. Mrs Lincoln le parve così allegra che Elizabeth si chiese cosa potesse aver alimentato le dicerie che circolavano sul suo temperamento. Aveva sentito alcune sue clienti – tutte del Sud, a dire la verità – definire la first lady una campagnola ignorante e volgare priva di buone maniere, ma a lei non sembrava una descrizione calzante. Elizabeth avrebbe fatto meglio a fidarsi del proprio spirito di osservazione, senza dare ascolto a commenti tanto malevoli, senz’altro frutto di gelosie e giochi politici. Più tardi, di ritorno nelle sue stanze, Elizabeth lavorò alacremente all’abito, adornandolo di perle e di una mantella di pizzo. Il giovedì pomeriggio fu sorpresa dalla nuova convocazione alla Casa Bianca, ma dopo la brutta esperienza dell’incontro mancato organizzato da Mrs McLean, si affrettò a prendere l’abito e la cesta da cucito e si precipitò subito alla residenza della coppia presidenziale. Di sopra, nel salotto ovale, Mrs Lincoln le comunicò che il ricevimento era stato spostato al martedì successivo, ma prima che Elizabeth potesse tirare un sospiro di sollievo la sua cliente le disse che voleva qualche altra modifica all’abito. La sarta nascose il proprio sconcerto quando Mrs Lincoln le descrisse ciò che voleva: era evidente che non si trattava di semplici dettagli, ma erano necessari cambiamenti significativi dello stile dell’abito. La sarta pensava comunque di avere il tempo necessario, e quando la first lady le commissionò anche una fascia azzurra di seta moiré da portare in vita per la cugina, Mrs Grimsley, Elizabeth accettò. «Sarà tutto pronto, avrete tempo a sufficienza per prepararvi per il ricevimento, martedì» promise Elizabeth, e se ne andò il prima possibile, sapendo di non avere un minuto da perdere. Per giorni e giorni cucì senza sosta, alzandosi presto e andando a dormire tardi, fermandosi appena qualche istante per mangiare, per andare in chiesa e per leggere l’ultima lettera di George. Diede gli ultimi punti il martedì a fine pomeriggio, ed ebbe appena il tempo di piegare con cura l’abito, di unirvi la fascia per Mrs Grimsley e di portare il tutto di corsa alla Casa Bianca. Peter Brown l’accolse all’ingresso, ma ormai lei conosceva bene la strada e la lasciò salire da sola. Trovò Mrs Lincoln in vestaglia, in uno stato di agitazione terribile, sebbene le amiche cercassero in tutti i modi di calmarla. «Non posso scendere!» esclamò, divincolandosi dall’abbraccio di una cugina. «Come potrei? Non ho nulla da indossare. Immaginate cosa direbbe la gente! Pensate a come si prenderebbe gioco di me». «Nessuno ti prenderà in giro» obiettò paziente Mrs Edwards, la sorella maggiore, che indossava un abito sobrio di broccato marrone. «Metti l’abito di velluto grigio» propose Mrs Grimsley, che portava un vestito di seta moiré azzurro con uno strascico lungo tempestato di turchesi e perle, e un’acconciatura con rose bianche. «È molto elegante, e nessuno l’ha ancora visto». Proprio allora, la più giovane delle donne presenti vide Elizabeth che indugiava incerta sulla porta. «Eccola, è qui!» esclamò indicandola con un gesto, e tutte si girarono a guardare la sarta. «Ecco!» esclamò Mrs Edwards sollevata. «Non ti avevamo detto che sarebbe venuta?» Mrs Lincoln, con le labbra strette, fece due passi verso Elizabeth prima di fermarsi di colpo. «Mrs Keckley, mi avete deluso parecchio. Mi avete tradita». Aveva il volto pallido per la collera, gli occhi cerchiati di rosso. «Perché mi portate l’abito così tardi?» Elizabeth trasse un respiro profondo e aprì il vestito con cura, tenendo appoggiato sul braccio il capo, meno ingombrante, destinato a Mrs Grimsley. «Perché ho appena finito, e pensavo di essere in orario». «Invece siete in ritardo, Mrs Keckley». La moglie del presidente scosse il capo, si torse le mani e cominciò a camminare avanti e indietro. «Mi avete deluso profondamente. Ora non ho tempo per vestirmi, e in ogni caso non intendo farlo. Non scenderò». Le altre donne protestarono e si avvicinarono per confortarla a gesti, ma lei le allontanò bruscamente. «Mi dispiace se vi ho deluso, Mrs Lincoln, perché pensavo di arrivare in tempo». Umiliata, Elizabeth si sforzò di parlare con pacatezza, a voce bassa. Non capiva la ragione di quel trambusto. Aveva tutto il tempo per preparare la sua cliente al ricevimento, se solo si fosse decisa a lasciarglielo fare. «Mi permettete di aiutarvi a vestirvi? Avremo finito in pochi minuti». «No, non mi vesto». Mrs Lincoln si fermò, lanciò un’occhiata fuori dalla finestra e levò le mani in un gesto d’impotenza. «Resterò in camera mia. Mr Lincoln potrà andare giù con le altre signore». «Ma c’è tempo a sufficienza per prepararti, Mary» le fece notare Mrs Grimsley. «Lasciati aiutare dalla sarta» la implorò sua sorella. «Vedrai che non ci metterà molto». Mary, incerta, spostò lo sguardo dalla sorella alla cugina. «E va bene» capitolò. «Può provarci». Elizabeth cominciò subito ad aiutare la sua cliente a sfilarsi la vestaglia e a infilare l’abito di moiré antico prima che cambiasse idea. Acconciò i capelli scuri con delle rose rosse che richiamavano il colore del vestito. L’abito era splendido, e quando Mary Lincoln si osservò allo specchio, fu come se un venticello fresco spazzasse via le nubi minacciose di poco prima, perché divenne radiosa e sorridente, felice del suo aspetto. Era davvero molto elegante nell’abito rosa, messo abilmente in risalto da collana, orecchini e braccialetti di perle. Si sentì bussare alla porta ed entrò il presidente Lincoln in persona, seguito dai piccoli Tad e Willie. Salutò le signore con parole cortesi e sorrisi, poi si buttò sul divano senza tante cerimonie, incurante delle pieghe che si sarebbero inevitabilmente formate nel suo abito da sera. I bambini gli saltarono subito addosso, lottando e ridendo, e lui finse di volersi difendere da loro, senza smettere di scherzare. Elizabeth, divertita, soffocò un sorriso. Non avrebbe mai immaginato che il capo dello stato si azzuffasse con i suoi figli come qualunque altro padre affettuoso. Di lì a poco Mrs Lincoln osservò: «Forse è ora che i bambini la smettano». «No, mamma!» obiettò Willie. «Non siamo ancora stanchi». Il presidente scoppiò a ridere. «Forse voi no, ma vostro padre sì». Tolse le gambe dal divano e si alzò mentre i figli andavano a giocare altrove. Infilandosi i guanti, citò qualche verso di una poesia sui giochi spensierati di un ragazzino scalzo, e altre strofe di un poema su un fabbro che grazie al duro lavoro si era guadagnato una notte di riposo. Le signore presenti parevano affascinate, ma sua moglie tratteneva a stento l’impazienza. «Sembrate di umore poetico, stasera». «Sì, mamma, è un’epoca poetica, la nostra». Il sorriso gli si allargò guardandola. «Siete elegantissima con quell’abito. Mrs Keckley ha fatto un lavoro eccellente». Mentre porgeva i suoi complimenti alle altre dame – Mrs Grimsley con l’abito di seta moiré azzurra, Mrs Edwards con un sobrio abito marrone e nero, Miss Edwards vestita di scarlatto, Mrs Baker di rosa pallido e Mrs Kellogg di seta giallo limone – Elizabeth arrossì di piacere e orgoglio. Il presidente in persona aveva elogiato il suo operato chiamandola per nome, quando lei pensava che Mr Lincoln non la conoscesse neanche. «Scendiamo, mamma?» chiese il presidente a sua moglie. «Tra un attimo» rispose lei, accigliandosi mentre cercava qualcosa sulla toilette. «Non riesco a trovare il mio fazzoletto di pizzo». Erano tutte pronte a giurare di averlo visto sul tavolo pochi istanti prima, ma nessuna sapeva che fine avesse fatto. Elizabeth si mise a cercare con le altre, ma dopo qualche minuto si udì di nuovo la risata sonora del presidente, che con un gesto della mano dalle dita affusolate mandò un servo a cercare Tad e Willie. Quando i bambini furono di nuovo al cospetto dei genitori – Willie serio e obbediente, Tad tutto sorrisi birichini – non ci volle molto a indovinare cosa fosse accaduto al fazzoletto. Alla fine il ladro mattacchione fu convinto a restituire il maltolto che tornò nelle mani della legittima proprietaria. Solo allora Mrs Lincoln sorrise, prese il braccio del marito e precedette le altre dame al piano inferiore per presenziare al ricevimento, elegante e regale come una vera regina. Per un lungo istante Elizabeth rimase a guardarli, faticando ancora a digerire tutto quello che aveva visto. «George non ci crederà mai» mormorò stringendosi addosso lo scialle e prendendo la borsa. Eppure l’aveva visto con i suoi occhi. Quella sera, seppe più tardi Elizabeth, un presidente Lincoln cordiale e premuroso aveva stretto la mano per più di due ore a centinaia di persone andate a congratularsi, riservando agli sconosciuti l’accoglienza di solito destinata agli amici e salutando molte persone per nome. Alcune delle clienti storiche di Elizabeth erano state invitate alla festa, ma quasi tutte le signore originarie del Sud, sempre presenti nel panorama mondano della capitale, non si erano viste. Un affronto calcolato che non poteva essere sfuggito all’attenzione della first lady. I presenti, nordisti o sudisti che fossero, socializzarono con disinvoltura, ma sotto la vernice amichevole i dissapori non erano mai troppo lontani, soprattutto ora che nei loro stati di provenienza si stavano formando delle milizie e gli uomini del maggiore Anderson erano sempre più in difficoltà a Fort Sumter. Mentre tutti gli occhi erano puntati sui Lincoln – sguardi scrutatori, indagatori – nel guardaroba incustodito accadde l’impensabile: quando gli ospiti si apprestarono ad andarsene, scoprirono che i loro mantelli e soprabiti erano stati mescolati o in qualche caso rubati, tant’è che, a detta di un burlone, solo un ospite su dieci ripartì con gli stessi indumenti di quando era arrivato. Mrs Lincoln fu molto soddisfatta della sua prima serata di gala, avendo forse dimenticato la collera e l’agitazione delle ore immediatamente precedenti l’evento. Molto meno entusiasta appariva la mattina successiva alla prima cena di stato del presidente in onore dei membri del governo, qualche settimana dopo. Elizabeth l’aveva vestita con un abito di seta di un blu magnifico, impreziosito da ricami, e l’aveva guardata prendere felice il braccio del marito e scendere la scalinata, maestosa come se si preparasse a una splendida serata. Il giorno dopo, però, tornando alla Casa Bianca per sottoporre alla first lady diversi nastri per una cuffia nuova, la trovò in uno stato di agitazione estrema. La sera prima, quando gli ospiti erano stati sul punto di andarsene, la figlia del ministro del Tesoro, la splendida Kate Chase, una ventenne dai capelli castano ramato, aveva umiliato Mrs Lincoln davanti agli ospiti. «Anche di fronte ai giornalisti» si lagnò Mrs Lincoln. «Così il suo sgarbo sarà sulla bocca di tutti». Impietosita, Elizabeth decise di non farle notare che se davvero era accaduto qualcosa di deliziosamente scandaloso i pettegoli avrebbero provveduto a diffondere la notizia ben più velocemente degli organi di stampa. Miss Chase era una delle giovani donne più in vista dell’alta società di Washington, elogiata per il suo fascino, per l’intelligenza arguta oltre che per la bellezza, e se aveva davvero offeso la first lady la storia non avrebbe mancato di fare scalpore. «Cos’ha fatto?» «Ebbene...» Mrs Lincoln esitò. «A raccontarlo sembra sciocco». «Allora forse non è successo niente di grave». «Sì, invece». La moglie del presidente raccolse un rocchetto di nastro, se lo rigirò tra le mani e lo ripose quasi senza vederlo. «Stavo accomiatandomi dagli ospiti, e quando è arrivato il turno di Miss Chase le ho detto: “Sarò lieta di ricevervi quando lo desiderate, Miss Chase”. E lei ha risposto, con aria di superiorità: “Mrs Lincoln, venite pure voi da me quando volete”. Capite come mi sminuisce? Sono io a dover andare da lei. Non intende disturbarsi a farmi visita». Elizabeth si accigliò. La risposta di Miss Chase era vagamente sfrontata, però la giovane aveva la reputazione di essere sì ambiziosa, ma soprattutto adorabile e piena di qualità. «Non è stato carino da parte sua». «Non è stato carino? Molto peggio, direi. Impertinente e inappropriato per una signora». Mrs Lincoln si alzò per avvicinarsi alla finestra che si affacciava sul Potomac e, sull’altra sponda, mostrava le verdi colline della Virginia. «Immagino che non ci si debba aspettare di meglio dalla figlia del ministro Chase. Sapete che lei e suo padre volevano che il partito repubblicano candidasse lui invece di mio marito?» «No, non lo sapevo». Mrs Lincoln voltò le spalle alla finestra con un cenno di assenso. «È vero, e siccome sua madre è morta, se il padre fosse stato eletto presidente Miss Chase sarebbe stata la sua accompagnatrice ufficiale. È convinta che il loro posto sia qui, alla Casa Bianca, e che lei dovrebbe essere la first lady». «Ebbene» intervenne Elizabeth con tatto, «lui non è stato designato e lei non è la first lady». Dopo un attimo Mary Lincoln scoppiò a ridere. «Sì, è vero. Sono certa però che continua a sperarlo». Da quel momento in poi, Mrs Lincoln e Miss Chase furono rivali in società; ciascuna si considerava la dama più importante tra la gente che contava a Washington, e mal sopportava i tentativi dell’altra di dimostrare la superiorità del proprio rango. Miss Chase aveva la bellezza, la popolarità, il fascino e i legami di lunga data con l’élite della capitale, ma Mrs Lincoln aveva il presidente, la Casa Bianca e il titolo di first lady. E poi, come Elizabeth amava ripetersi con fierezza, aveva il vantaggio di una sarta particolarmente brava che le avrebbe sempre consentito di presentarsi in pubblico – o in battaglia, come talvolta si aveva l’impressione che facesse – vestita in modo impeccabile. Elizabeth, infatti, era diventata la sarta personale di Mrs Lincoln, e durante la primavera del 1861 avrebbe confezionato più di quindici abiti per la first lady. Spesso si occupava anche di vestirla e di acconciarla per balli, cene e ricevimenti. Una sera il presidente osservò la perizia con cui si occupava della moglie, e chiese a Elizabeth se avesse il coraggio di provare a domare i suoi riccioli ribelli. «Se non continuaste a passarci le mani, non sarebbero tanto spettinati» lo rimproverò la moglie. Il presidente si limitò a sorridere e si sedette in poltrona. «Allora, Mrs Elizabeth» chiese, «volete provare a domare questa chioma intrattabile stasera?» «Certo, signor presidente» replicò lei, prendendogli dalle mani pettine e spazzola. Quando ebbe finito, lui si guardò allo specchio e dichiarò che i suoi capelli sembravano avere imparato una lezione. Rimase così soddisfatto che diventò un’abitudine per lui chiedere a Elizabeth di pettinarlo quando aveva finito con sua moglie, ed Elizabeth lo acconciava come poteva. Con il passare delle settimane, Elizabeth assunse altri incarichi alla Casa Bianca, come sbrigare commissioni per Mrs Lincoln oppure occuparsi di Willie e Tad quando erano malati, somministrando loro i soliti rimedi da bambini; ma il suo ruolo principale rimase quello di sarta per la first lady. Pian piano scoprì che Mrs Lincoln preferiva vestirsi di bianco, ma che amava anche il rosa, il rosso porpora, il giallo intenso, il viola e il blu. Le piaceva portare perle sulla pelle e fiori tra i capelli, e prediligeva scollature profonde con abiti a maniche corte per mostrare il collo e le spalle di cui andava fiera, ignorando i commenti, bisbigliati a mezza voce, sul fatto che uno stile del genere fosse adatto a donne più giovani. Elizabeth imparò presto che le critiche feroci nei confronti della sua ultima e principale cliente non cessavano mai, e anzi piovevano abbondanti da ogni dove, con grande costernazione e afflizione dell’interessata che non poteva far nulla per arginare quel fiume in piena. La mattina del 12 aprile Washington fu svegliata di soprassalto da resoconti sconvolgenti e spesso contraddittori che provenivano da Charleston. Quel giorno, prima dell’alba, i cannoni della Confederazione avevano fatto fuoco contro Fort Sumter. No, al contrario: le due fazioni erano ancora impegnate in negoziati frenetici. Eh, magari si fossero limitate a discutere... avevano sparato, eccome. Nessuno sapeva cosa credere. Era in corso una battaglia cruenta, oppure il maggiore Anderson si era arreso? Il forte era stato distrutto, i suoi difensori massacrati, oppure le truppe dell’Unione, esauste e affamate, erano uscite sventolando la bandiera bianca ed erano state fatte prigioniere? Gli abitanti di Washington affollavano uffici del telegrafo e alberghi, chiedendo notizie e diffondendo dicerie, ma nessuno sapeva con precisione cosa stesse accadendo e cosa fosse eventualmente già successo. I secessionisti, che dall’insediamento del presidente Lincoln e della sua amministrazione avevano mantenuto un profilo basso, ora celebravano apertamente l’inizio della guerra. I simpatizzanti del Sud reclutavano senza più nascondersi soldati per l’esercito degli stati confederati, mentre gli uomini leali all’Unione correvano ad arruolarsi nelle milizie. Per la strada le discussioni sfociavano in zuffe, e proprio allora la notizia più allarmante di tutte si diffuse per la città: i ribelli stavano marciando su Washington con un esercito di ventimila soldati. Alla fine si seppe la verità su Fort Sumter: dopo che le sue truppe erano state impegnate per trentaquattro ore in uno scambio di tiri incrociati con i soldati della Confederazione, il maggiore Robert Anderson era stato costretto ad arrendersi. Il 14 aprile altre cinque compagnie militari di Washington furono richiamate in servizio attivo, per un totale di circa duemilacinquecento soldati del posto distribuiti nell’intero distretto. Soldati a cavallo furono posizionati in tutti i punti strategici d’accesso alla città. Venti cavalieri proteggevano la Casa Bianca, e centinaia di essi erano collocati negli immediati dintorni e al Campidoglio, al ministero del Tesoro e all’ufficio postale. L’indomani il presidente Lincoln fece un appello nazionale per l’arruolamento di settantacinquemila reclute, assegnando una quota a ogni stato. Quelle truppe, che si sarebbero arruolate per un periodo di novanta giorni, sarebbero certamente state sufficienti per soffocare la ribellione. Mentre Washington aspettava i rinforzi dal Nord, e cresceva la paura di un attacco imminente da parte dei confederati, i giovani neri del quartiere borghese agiato dove abitava Elizabeth, così come i meno fortunati che vivevano nelle zone più povere, erano ansiosi quanto i bianchi di prendere le armi per difendere la città. Perfino il figlio undicenne di Peter Brown, che lavorava come lustrascarpe davanti al ministero del Tesoro, annunciò orgoglioso a Elizabeth che aveva intenzione di arruolarsi come tamburino non appena avesse compiuto dodici anni. Ma ogni ragazzo nero che cercava di unirsi all’esercito, indipendentemente dall’età, dal ceto sociale e dalla prestanza fisica, veniva respinto. «O il bisogno di soldati è molto limitato, o la stupidità di chi si occupa dell’arruolamento per conto del presidente Lincoln è enorme» commentò Virginia Lewis parlando con Elizabeth, una domenica pomeriggio durante l’abituale passeggiata, scoprendo alcuni soldati della milizia che venivano addestrati sul terreno antistante il Campidoglio. La città aveva preso le sembianze di un accampamento militare, e dappertutto l’apprensione cresceva. Anche se era la capitale dell’Unione, Washington era essenzialmente una città del Sud, tra lo stato schiavista del Maryland e quello della Virginia, che aveva proclamato la propria secessione dopo che il presidente aveva fissato le quote di reclutamento. Solo il Potomac la separava da quest’ultimo. Qualche giorno prima, al marito di una delle clienti preferite di Elizabeth, il colonnello Robert E. Lee, un virginiano, era stato assegnato il comando di tutto l’esercito degli Stati Uniti, ma questi, dopo un’attenta riflessione, aveva rifiutato ed era tornato a casa, nella sua piantagione di Arlington, sull’altra sponda del fiume. Elizabeth aveva appreso dalle conversazioni udite alla Casa Bianca che il presidente Lincoln aveva fatto di tutto per tenere la Virginia nell’Unione, e sapeva dai commenti di Mrs Lee fatti in sua presenza che neanche suo marito aveva auspicato la secessione della Virginia. Per ogni guerrafondaio convinto, sembrava che ci fossero due o tre persone trascinate nel conflitto controvoglia, ma comunque decise a fare il loro dovere meglio che potevano. E siccome lo schiavismo era il punto cruciale del conflitto, era forse strano che i neri volessero contribuire a loro volta al trionfo dell’Unione? «Chi seleziona le reclute deve pensare di avere abbastanza volontari bianchi da raggiungere la quota richiesta» rispose Elizabeth. «Se i combattimenti durano più del previsto, forse in seguito permetteranno anche ai neri di arruolarsi». Nonostante la giornata fosse calda, Virginia rabbrividì. «Spero che la guerra finisca prima di quel giorno. Immagini che bagno di sangue sarebbe se settantacinquemila uomini non bastassero a mettere fine al conflitto?» Elizabeth trasse un respiro impaurito, e gli odori penetranti dei rifiuti degli accampamenti e del fumo di carbone le fecero bruciare e lacrimare gli occhi. «Lo immagino fin troppo bene». Prese a braccetto Virginia e si voltarono per tornare verso casa. Anche se trovava inaudito che gli uomini neri non potessero unirsi all’esercito, era segretamente sollevata che suo figlio non dovesse mettere la propria vita al servizio del paese. Si chiese se suo marito James avrebbe tentato di arruolarsi. Da giovane era stato molto combattivo, e dopo l’attacco fallito all’arsenale di Harpers Ferry da parte di John Brown aveva dichiarato che, se fosse stato lì, avrebbe preso le armi e fomentato la rivolta di schiavi voluta da Brown. A un tratto il viso di James le apparve nella mente con tanta chiarezza che le sembrò di averlo davanti, non delirante e ubriaco com’era stato negli ultimi anni, ma sorridente, coraggioso e bello come quando si erano conosciuti. Si lasciò sfuggire un grido soffocato e si fermò, profondamente turbata da quella visione. Erano settimane, forse addirittura mesi che non pensava a suo marito. Perché le tornava in mente proprio in quel momento? «Elizabeth?» Virginia si era fermata quando l’amica aveva smesso bruscamente di camminare. «Cosa succede? Sembra che tu abbia visto un fantasma». Elizabeth riuscì a fare una risatina poco convinta. «No, non mi pare. Non di recente, almeno». Virginia sorrise incerta a quel tentativo di dissipare l’improvvisa tensione. «Cosa ti turba, allora?» Elizabeth esitò. Virginia sapeva che era sposata e che lei e il marito si erano separati, ma lei non amava parlare male di James, e di conseguenza non aveva raccontato molto all’amica. Non sapeva bene perché, ma era riluttante a confessarle di aver appena pensato al marito. Indicò invece con un cenno i preparativi per la difesa della città attorno a loro, che parevano del tutto inadeguati alla portata della minaccia. «Non abbiamo forse ragione di essere tutti quanti turbati, di questi tempi?» Virginia annuì. Guardarono le manovre ancora per qualche istante prima di riprendere il cammino verso casa. Di lì a poco Elizabeth ebbe ragione di chiedersi se non fosse stato proprio lo spettro irrequieto di James a renderle visita. Solo due giorni dopo la passeggiata con Virginia, le fu recapitata una lettera dal Missouri, scritta con applicazione ma con mano tremante, piena di errori e di scuse. Cara Mrs Keckley, mi dispiace scrivervi per dirvi che vostro marito James è morto in febbraio per una malattia al fegato. Non ha sofferto molto e non è morto da solo. Non c’erano soldi per il funerale ed è stato seppellito nel campo degli schiavi, spero non vi dispiaccia. Un bel funerale cristiano con preghiere e canti. So che eravate separati ma ve lo volevo dire perché siete sua moglie e l’unica parente. Era un brav’uomo a modo suo come sapete, e mancherà agli amici. Mi dispiace non avervelo detto prima ma non sapevo dove eravate. La vostra vecchia padrona di casa mi ha dato questo indirizzo e spero che la lettera vi arrivi. Con tutti i miei omaggi, Ephraim Johnson Elizabeth strinse la lettera tra le mani un lungo istante prima di piegarla con cura e di infilarla nella busta. Era contenta di sapere che James non aveva patito a lungo, ma le dispiaceva che avesse comunque sofferto. Si chiese chi fosse Ephraim Johnson. Non conosceva nessuno con quel nome. Non le venne da piangere, e si chiese cosa rivelasse quella mancanza di emozione. Non aveva lacrime per piangere un uomo che un tempo aveva amato profondamente. La notizia della sua morte la intristiva, ma non provava nessun dolore profondo, forse perché sapere che James fosse finalmente in pace le procurava un certo sollievo. Il suo tormento su questa terra era finito. «Ecco» mormorò alla stanza vuota. «Ora sono vedova». Desiderava che le colpe di James fossero seppellite con lui. Non voleva pensare male del marito, adesso che era scomparso. Gli abitanti di Washington aspettarono preoccupati di vedere chi sarebbe arrivato prima, le compagnie militari addestrate del Nord o gli invasori del Sud. Le truppe dell’Unione, che si stavano avvicinando alla capitale dagli stati del Nord, viaggiavano in treno, e avrebbero dovuto attraversare Baltimora, circa sessanta chilometri a nordest della capitale. Ciò non avrebbe dovuto costituire un problema, perché anche se era uno stato schiavista, il Maryland era rimasto nell’Unione. Ma si mormorava che migliaia di abitanti, simpatizzanti dei sudisti, stessero progettando di bloccare il passaggio delle truppe nordiste attraverso la città, e siccome Baltimora era nota per la violenza delle sue bande di criminali quelle voci non potevano essere ignorate. A complicare le cose c’era una particolarità del sistema ferroviario della città: i treni diretti a Washington arrivavano alla stazione di President Street, ma poi dovevano essere trainati dai cavalli per diversi isolati verso occidente fino alla stazione di Camden, dove potevano riprendere il loro viaggio sulle rotaie. Il sistema, scomodo in tempo di pace, era potenzialmente catastrofico in periodo di guerra. La mattina del 19 aprile il Sesto Reggimento Massachusetts partì da Filadelfia su un treno diretto a Washington e arrivò a Baltimora con le armi già cariche. Gli uomini, sul chi vive, speravano di poter attraversare la città senza ostacoli; sapevano però che durante il tragitto fra le due stazioni probabilmente sarebbero stati insultati e forse anche aggrediti, ma che dovevano assolutamente ignorare gli attacchi. Anche se i provocatori avessero aperto il fuoco contro di loro non dovevano rispondere, a meno che non fossero gli ufficiali a ordinarlo. Il treno con a bordo il Sesto Reggimento Massachusetts arrivò a Baltimora senza clamore, e i vagoni che trasportavano le prime sette compagnie attraversarono la città senza problemi. Ma la notizia della presenza dei soldati si diffuse rapidamente, e gli abitanti si riversarono subito nelle strade urlando insulti e minacce. La folla inferocita divelse le rotaie e bloccò la strada con pesanti ancore prese sulle banchine di Pratt Street, obbligando così le ultime quattro compagnie del Sesto Reggimento ad abbandonare i vagoni e ad attraversare la città a piedi. Quasi subito i soldati furono circondati da diverse migliaia di uomini e ragazzi che li aggredirono lanciando sassi e mattoni, mentre dalle finestre dei piani superiori piovevano loro addosso piatti e bottiglie. Quando la collera della calca si fece più violenta, qualcuno scassinò un’armeria, e da un punto non ben precisato i soldati udirono dei colpi di pistola. Le compagnie accelerarono l’andatura, ma quando la folla inferocita bloccò le strade davanti a loro, fecero fuoco. La calca arretrò, e i soldati riuscirono ad avanzare fino alla stazione di Camden Street; dopo avere riparato altri binari che erano stati sabotati nei tafferugli, il treno ripartì per Washington. Quando i soldati del Sesto Reggimento Massachusetts arrivarono a destinazione, malconci e insanguinati, il loro aspetto alimentò invece di placarle le paure dei cittadini che li avevano aspettati con ansia. Quattro soldati e almeno nove civili erano stati uccisi, e numerosi erano stati i feriti nelle strade di Baltimora; quando arrivarono le notizie di altre linee ferroviarie distrutte, di ponti bruciati, di linee telegrafiche tagliate, il panico si diffuse tra gli abitanti di Washington, che si resero conto di essere stati isolati dal Nord. Elizabeth, recandosi a piedi alla Casa Bianca, vide con sgomento gente che accatastava i propri averi su carri e in carrozze per fuggire dalla città. Nella residenza del presidente, Mrs Lincoln si sforzava di conservare un senso di calma e normalità. Espletò le proprie funzioni di ospite agli eventi ufficiali che le signore dell’élite cittadina snobbavano, iscrisse Willie e Tad ai corsi di catechismo della Fourth Presbyterian Sunday School e cercò di dissipare la malinconia del marito, che si faceva più marcata all’aggravarsi della crisi. «Comincio a credere che non esista nessun Nord» disse una volta il presidente al cospetto di Elizabeth; in effetti senza l’arrivo dei rinforzi, senza notizie tramite telegrafo, senza servizio postale, anche lei avvertiva quella strana cappa di isolamento, del sentirsi soli e circondati da nemici ostili e invisibili. Non contribuiva il fatto che i giornali sudisti riuscissero a penetrare a Washington facendosi beffe dei controlli. Il Richmond Examiner dichiarò a più riprese che Washington sarebbe stata una capitale perfetta per la Confederazione, osservando che quasi tutti gli abitanti della città venivano dalla Virginia o dal Maryland, e che quindi avrebbero accolto l’esercito degli stati confederati come una liberazione, con acclamazioni e fiori, ben felici di riunirsi con il loro amato Sud. Washington si preparò e rimase in attesa, finché a mezzogiorno del 25 aprile il Settimo Reggimento New York arrivò alla B&O Station. I cittadini, sollevati, li festeggiarono mentre i soldati marciavano fino alla Casa Bianca per mettersi a disposizione del presidente Lincoln. La paura di un’imminente invasione da parte dei confederati diminuì a mano a mano che arrivarono altre truppe dal Massachusetts, dal Rhode Island e da altri stati, per insediarsi all’interno del Parlamento e nella rotonda del Campidoglio, mentre gli ultimi arrivati si accamparono nella Casa Bianca, nell’ufficio brevetti e a Georgetown, o piantarono le tende nel prato a sud della residenza del presidente. I muratori del Massachusetts costruirono venti forni di mattoni nelle cantine del Campidoglio per cuocere pane a sufficienza per i soldati, e il rumore dei tamburi, delle trombe militari e delle esercitazioni col moschetto divenne così costante che Elizabeth arrivò quasi a dimenticare come fosse silenziosa Washington prima dell’avvento dei soldati. Mentre la città si trasformava attorno a lei, Elizabeth cuciva per Mary Lincoln, di solito alla Casa Bianca – come preferiva lei –, ma talvolta nelle proprie stanze, dove la first lady amava andare a fare le prove. Una dopo l’altra, le amiche e le parenti di Mrs Lincoln erano tornate tutte a casa loro, in Illinois o altrove, finché non era rimasta solo Mrs Grimsley, sempre leale e piena di buonsenso, che però non mancava di ribadire la sua nostalgia di casa. Siccome l’élite di Washington continuava a snobbarla, Mrs Lincoln si sentiva sempre più sola e isolata. Elizabeth, comprensiva e generosa, divenne la sua confidente, e non tardò a scoprire quanto la first lady si sentisse a disagio nel nuovo ambiente e nel ruolo tanto importante che pure aveva desiderato. Mai prima di allora aveva vissuto tra sconosciuti che non restavano per nulla colpiti dal suo cognome, sinonimo di grande influenza a Lexington per via degli uomini d’affari e dei politici importanti ai quali era legata da vincoli di parentela. Suo marito si circondava di uomini che consideravano importune e fastidiose le ingerenze della first lady a proposito di incarichi e linee politiche, cosicché doveva lottare contro i collaboratori del presidente perfino per poter avere voce in capitolo sugli eventi sociali della Casa Bianca. Esclusa dalla cerchia dei collaboratori intimi del presidente, piena di nostalgia per le sorelle e le cugine che erano partite, ignorata dalle dame più popolari di Washington, Mrs Lincoln ripeteva spesso a Elizabeth – a volte con tristezza, altre con tono di sfida – che la sarta era la sua unica vera amica nel raggio di cento chilometri. Elizabeth era stata accolta nell’élite nera di Washington in virtù della sua grazia e dignità naturali, dei suoi contatti altolocati in quanto habitué della Casa Bianca e, ironicamente, della prestigiosa famiglia di appartenenza tramite il padre ed ex padrone, il colonnello Armistead Burwell. Cercò di convincere con tatto la first lady a ingraziarsi l’alta società. Mentre cuciva per le altre clienti, aveva colto segnali favorevoli: alcune delle dame si mostravano inclini a un’apertura nei confronti di Mrs Lincoln. «Oggi le signore di Washington sono accomunate solo dall’ostilità verso Mrs Lincoln» aveva confidato alla sarta, durante le prove, Elizabeth Blair Lee, che era rimasta amica di Varina Davis nonostante le differenze di vedute politiche. «Almeno noi repubblicane dovremmo appoggiarla». Ma neppure l’amicizia della popolare, autoritaria e generosa moglie di Samuel Phillips Lee poteva redimere Mrs Lincoln agli occhi di chi la disprezzava, perché si comportava come se la nazione non fosse in guerra. Quando scoprì che il Congresso assegnava ventimila dollari per la decorazione della Casa Bianca a ogni nuova amministrazione, Mrs Lincoln si adoperò subito per spendere quella somma con una gioia che non si premurò neppure di celare. Elizabeth non avrebbe avuto problemi a confermare che la Casa Bianca avrebbe avuto bisogno di qualche intervento di restauro: perfino al tempo della sua prima visita, quando l’importanza dell’incontro imminente assorbiva ogni suo pensiero, non aveva potuto evitare di notare lo stato pietoso dei tappeti lisi, i mobili rotti, la carta da parati strappata, gli arazzi dai quali i cacciatori di oggetti ricordo avevano tagliato via dei pezzetti fino a ridurli a brandelli. Ma per quanto quelle spese fossero necessarie, non stava bene che la first lady spendesse tutto quel denaro in tappeti e porcellane quando i valorosi soldati dovevano fare a meno perfino di tende e coperte. Anche la lealtà di Mrs Lincoln nei confronti dell’Unione fu messa in dubbio, sebbene in modo del tutto infondato, come Elizabeth ben sapeva. «Perché dovrei parteggiare per i ribelli?» aveva chiesto una volta la sua cliente, gettando lontano da sé, rabbiosa, una copia della rivista Harper’s che insinuava il contrario. «Non sono forse miei nemici? Impiccherebbero mio marito domani, se potessero, e forse manderebbero alla forca anche me. Come posso simpatizzare con persone che muovono guerra a me e ai miei?» Anche se era vero che il fratello, i tre fratellastri e tre dei suoi cognati si erano arruolati nell’esercito della Confederazione, Mary Lincoln era una sostenitrice accanita dell’Unione, e sebbene fosse cresciuta in una famiglia che possedeva schiavi, era perfino più abolizionista del marito. Ciò non impedì ai giornali del Nord di pubblicare la notizia, del tutto inventata, che la sorellastra più giovane della first lady, Emilie, il cui marito era generale nell’esercito della Confederazione, avesse usato un lasciapassare presidenziale per far avere provviste ai ribelli oltre le linee dell’Unione. Solo i sudisti sapevano da che parte stava la moglie del presidente, e per questo la condannavano. La consideravano una traditrice che, ripudiando le sue origini meridionali, infangava il buon nome della sua famiglia. Unione e Confederazione la credevano entrambe fedele all’altra fazione, e nessuna delle due la considerava una dei loro. Sebbene la minaccia più immediata di un’invasione sembrasse per il momento scongiurata, l’esercito degli stati confederati non sembrava essere troppo lontano. Le milizie della Virginia si esercitavano ad Alexandria, sulla sponda opposta del fiume, e per ogni picchetto dell’Unione che faceva la guardia ai ponti che portavano a Washington c’erano militari della Virginia di guarnigione sull’altro lato. Una bandiera della Confederazione sventolava arrogante su un albergo di Alexandria, ben visibile da Washington per chiunque fosse nella posizione giusta e avesse buona vista o un cannocchiale. Elizabeth talvolta vedeva il presidente Lincoln, affacciato a una finestra della Casa Bianca, scrutare in silenzio la bandiera. Talvolta si sedeva in poltrona, posava i piedi sul davanzale e guardava le imbarcazioni sul Potomac con un cannocchiale, levando di tanto in tanto gli occhi alla bandiera dei ribelli. Se la considerava la provocazione suprema, non lo disse mai in presenza di Elizabeth. La guerra era molto vicina, e si sarebbe avvicinata ancora. Il servizio telegrafico e quello postale ripresero, e all’inizio di maggio Elizabeth ricevette una lettera che nei momenti critici delle settimane precedenti era rimasta bloccata. 24 aprile 1861 Cara mamma, spero che questa lettera ti trovi in ottima salute. Le notizie da Washington sono così allarmanti, di questi tempi, che posso solo pregare che i giornali esagerino come sempre. Scrivo di fretta e con una certa riluttanza, perché temo che ciò che sto per dirti ti dispiaccia. Madre mia, sono un soldato. Forse ti chiederai come sia possibile, dal momento che i neri non sono bene accolti nei ranghi dell’esercito dell’Unione. L’ho scoperto di prima mano quando io e alcuni amici siano andati ad arruolarci a Columbus e siamo stati respinti, tra le beffe e gli insulti delle reclute bianche che ci bruciavano nelle orecchie. I miei amici non hanno avuto scelta, sono tornati all’università, ma io ero troppo agitato per restare, quindi sono andato a casa a Saint Louis. Lì, da solo, senza i miei compagni con la pelle più scura della mia, nessuno aveva motivo di ritenermi nero, e così ho firmato. Madre mia, so che non sarai contenta che abbia lasciato l’università senza finire il semestre, e mi addolora darti un dispiacere, ma sono sicuro che potrò riprendere gli studi quando avrò terminato il servizio militare. Mi sono arruolato solo per tre mesi, ma dicono tutti che finirà molto prima, e non posso certo perdere quest’occasione per dare il mio contributo all’Unione. So bene che se non fosse per te sarei ancora uno schiavo, e sento quindi un obbligo preciso ad aiutare anche gli altri a liberarsi delle catene per conquistare la libertà. Sono disposto ad accordare a questa nobile causa i tre mesi che mi chiedono, e anche la mia vita se necessario. Per favore, scrivimi spesso e prega sempre per me. Il tuo affezionato figlio George W.D. Kirkland Soldato semplice Primo Reggimento Volontari del Missouri, Compagnia D Elizabeth si ritrovò in lacrime ben prima di arrivare alla fine della lettera. Suo figlio temeva di darle un dispiacere perché lasciava l’università prima della fine del semestre? Credeva che fosse quello ad addolorarla, e non il suo inganno, il suo arruolamento dovuto all’irruenza della gioventù, la possibilità che morisse sul campo di battaglia? Accecata dal pianto, in preda alle vertigini per l’ansia, brancolò alla cieca in cerca di una sedia e vi si lasciò cadere, appallottolando la lettera che teneva in mano. Strinse le labbra per soffocare i singhiozzi, prima che Virginia, Walker o un altro dei residenti udissero il suo dolore e accorressero a vedere cosa stava succedendo. Tremò in silenzio finché non si fu calmata, cercando disperatamente di cacciare dalla testa immagini del suo unico, preziosissimo figlio che giaceva ferito o morente in un campo nel lontano Sud. Nonostante la paura, però, era fiera di lui; profondamente fiera. George aveva ragione. Dio aveva accordato loro la possibilità di liberarsi dal tormento della schiavitù, e quindi erano entrambi costretti ad aiutare i molti altri della loro razza ancora privi di libertà. George lo faceva a modo suo, ma anche lei aveva una missione. Pregò il Signore di risparmiare suo figlio, ricompensando così il suo nobile desiderio di sacrificare la vita. 4. Maggio-agosto 1861 Durante l’inverno della secessione l’attività di Elizabeth era diminuita, perché molte delle sue migliori clienti erano partite verso sud, ma con l’arrivo della primavera anche il lavoro riprese. Nel frattempo Mrs Lincoln aveva sfoggiato molte sue creazioni a diversi ricevimenti alla Casa Bianca, e a un tratto Elizabeth si ritrovò a essere la sarta di mantua più celebre e ricercata tra le unioniste di Washington. Avendo più lavoro di quanto non riuscisse a sbrigarne, prese in affitto un laboratorio di fronte alla pensione e assoldò delle aiutanti. Le sue clienti capivano che Elizabeth doveva sempre dare la precedenza alla first lady, e si precipitavano a fare ordini quando Mary Lincoln era in viaggio. Mrs Lincoln non poteva neanche avventurarsi a fare una passeggiata lungo Pennsylvania Avenue senza che i giornalisti divulgassero la notizia via telegrafo, perciò quando lei e la cugina, Mrs Grimsley, andarono a New York a fare compere all’inizio di maggio, i reporter le tallonarono come segugi. Gli articoli sulle serate a teatro, la visita a un fabbricante di carrozze, le cene, le occasioni mondane e gli incontri con le personalità locali riempirono i giornali e stimolarono i commenti più malevoli. Quando Elizabeth lesse delle spese fatte da Mrs Lincoln per tappeti, porcellane, ornamenti per il camino e mobilio per la Casa Bianca, fece una smorfia addolorata, rimpiangendo che la sua cliente non fosse più discreta. La preoccupavano le somme spese dalla first lady, non solo perché i giornali la descrivevano come una scialacquatrice, ma anche perché non riusciva a immaginare come lo stanziamento del Congresso bastasse a pagare tutti quegli acquisti. Però era impossibile non lasciarsi contagiare dalla gioia della sua cliente di ritorno a Washington; piena di eccitazione, aspettava con impazienza che le consegnassero gli oggetti acquistati. «Sono decisa a trasformare la Casa Bianca in un luogo che rappresenti degnamente la nostra nazione» annunciò a Elizabeth mentre accompagnava lei e Mrs Grimsley da una stanza all’altra, descrivendo i diversi arredi e il modo in cui intendeva valorizzarli. Prima però, naturalmente, bisognava occuparsi di riparazioni e restauri, ma la first lady intendeva sfuggire al baccano e alla polvere, oltre che al caldo e alle malattie di Washington nei mesi estivi, portando Tad e Willie più a nord che poteva. «Mi piacerebbe portarci anche Mr Lincoln» confidò «se riuscissi a strapparlo alle riunioni del governo». Nessuno a Washington poteva dimenticare che la minaccia della Confederazione incombeva sempre più vicina. Per settimane la bandiera sudista aveva sventolato, spinta dalla brezza, su Alexandria, schernendoli e ricordando loro il rischio dell’invasione, creando un clima di nervosismo esacerbato e facendo lievitare i prezzi di farina, caffè e altri generi alimentari. Un mattino di fine maggio, Elizabeth si svegliò al suono delle campane della caserma dei pompieri, e quando scese a fare colazione seppe dai Lewis che poco dopo l’alba dieci reggimenti dell’Unione avevano attraversato silenziosamente il Potomac e conquistato Alexandria; il comandante del Reggimento Zuavi di New York, il colonnello Elmer Ellsworth, era stato colpito e ucciso, unica vittima della missione. Elizabeth rimase sconvolta. «Siete sicuri?» Aveva visto spesso il colonnello Ellsworth alla Casa Bianca, lo ricordava come uno dei collaboratori preferiti del presidente. Sapeva che prima dell’elezione il presidente Lincoln aveva incontrato quel giovane a Chicago e lo aveva incoraggiato a trasferirsi a Springfield per studiare diritto. Aveva fatto parte della guardia d’onore che aveva scortato il presidente in treno fino a Washington, e dopo la secessione Abraham Lincoln aveva usato la sua influenza per procurargli una posizione invidiabile nell’esercito. Aveva solo pochi anni più del figlio maggiore dei Lincoln, Robert. «Sì, purtroppo» le confermò Walker, scuotendo il capo con espressione cupa. «Il suo è il primo sangue versato sul terreno dei ribelli». «E non sarà l’ultimo» aggiunse Virginia a mezza voce. I pensieri di Elizabeth andarono subito a George, quasi coetaneo del colonnello, tanto ansioso di partecipare ai combattimenti. E poi pensò ai Lincoln. La moglie del presidente era affezionata al colonnello Ellsworth quasi quanto il marito. Avrebbe avuto il cuore a pezzi. Anche se non era attesa, quel giorno Elizabeth percorse veloce le strade fangose diretta alla Casa Bianca, per offrire alla first lady tutto il suo appoggio. Sulla soglia, Mr McManus annunciò con aria contrita che erano tutti in lutto. «Il presidente era in biblioteca con dei visitatori quando ha saputo della morte del colonnello» le confidò l’anziano portiere. «Peter Brown dice che era così turbato da non riuscire a parlare». «Meglio che vada dalla first lady» disse Elizabeth tirando dritto. La trovò nel suo salottino personale, con addosso un allegro abito da giorno a fiori, seduta alla toeletta a fissare il nulla. Alzò lo sguardo all’arrivo della sarta, e un’espressione sorpresa si fece strada per un attimo nella sua cappa di dolore. «Ah, Elizabeth» disse. «Come sapevate che avevo bisogno di voi?» «Ho sentito suonare le campane per il colonnello, e ho pensato che voleste vedermi». La sarta si diresse subito nel guardaroba e cominciò a passare in rassegna gli abiti della sua cliente, in cerca di un indumento più appropriato. A un tratto si rese conto che le avrebbero probabilmente chiesto di confezionare parecchi abiti neri nei mesi a venire, quando le sue clienti avessero perso mariti, figli e fratelli, e avessero deciso di indossare i vestiti scuri che la tradizione prescriveva. Allontanò il pensiero e vide un abito di seta nera che Mrs Lincoln doveva avere portato con sé dall’Illinois e glielo mostrò. «Cosa pensate di questo?» «Sono sicura che andrà benissimo». La sua cliente guardò appena l’abito. «Oggi pomeriggio io e il presidente andremo all’arsenale a vedere il corpo e rendergli omaggio. Dopo, credo che... che il colonnello sarà trasferito qui, dove gli verrà allestita la camera ardente nell’East Room». Elizabeth annuì e cominciò a slacciare il corpetto di Mrs Lincoln. «Quell’orribile bandiera era una provocazione insopportabile per lui» disse la sua cliente con voce distante. «Aveva promesso a mio marito che l’avrebbe tolta da lì, ed è proprio ciò che ha fatto. Ma quel gesto gli è costato la vita». «Ucciso per una bandiera?» chiese Elizabeth senza riflettere. Le pareva uno spreco enorme. «Non sarebbe dovuto accadere». Mrs Lincoln appallottolò il fazzoletto che teneva in grembo. «Per evitare spargimenti di sangue, l’esercito dell’Unione ha mandato un tenente ad Alexandria con la bandiera bianca per avvertire il comandante della Confederazione che le forze nemiche erano in superiorità numerica schiacciante, e che avevano tempo fino alle nove per abbandonare la città o arrendersi». Il comandante doveva avere scelto l’una o l’altra possibilità rinunciando a combattere, perché se i ribelli avessero deciso di resistere Elizabeth avrebbe udito il baccano dell’artiglieria dei due schieramenti. «Cos’hanno deciso?» «Di battere in ritirata. Il tenente ha riferito al colonnello Ellsworth che i ribelli non avrebbero reagito perché la città era piena di donne e bambini. Quasi tutte le truppe ribelli sono salite a bordo di un treno e hanno lasciato Alexandria prima dell’ultimatum, ma qualcuno è rimasto, non so perché. Sono stati catturati e rinchiusi nella prigione di un negriero». Mrs Lincoln sospirò mentre Elizabeth la aiutava a togliersi l’abito da giorno. «Devo avvisarvi che si tratta di informazioni che ho colto qua e là, e non di un resoconto ufficiale». Una traccia di collera le fece tremare la voce. «Mio marito ha sempre meno fiducia in me». «Ditemelo lo stesso» la incoraggiò con dolcezza Elizabeth raddrizzando la sottoveste della sua cliente. Voleva sapere cos’era successo al giovane ufficiale, e lo sforzo di raccontare la storia sembrava avere un effetto calmante sulla moglie del presidente. «Ebbene, da quanto ho capito il colonnello Ellsworth è partito con alcuni dei suoi uomini per occupare l’ufficio del telegrafo, ma è passato davanti all’albergo dal quale svettava la bandiera in tutta impunità. Sapeva quanto infastidiva mio marito, quanto gli facesse male vederla». «Dava noia a tutti qui a Washington» convenne Elizabeth, aiutando Mrs Lincoln a indossare l’abito di seta nera. La donna si mosse assecondando la sarta, docile come una bambola. «Forse pensava che il presidente stesse osservando l’albergo proprio in quel momento, o forse voleva dare il segnale che la città era stata occupata. Non lo sapremo mai. In ogni caso, il colonnello Ellsworth è entrato nello stabile ed è salito sul tetto, ha preso la bandiera e l’ha strappata. È tornato giù dai suoi uomini...» Mrs Lincoln si premette il fazzoletto contro le labbra, si fece forza e continuò: «Mentre portava giù la bandiera catturata, il proprietario dell’hotel gli è andato incontro all’improvviso e gli ha sparato al petto, da pochi passi di distanza». Elizabeth si bloccò mentre stava abbottonando il corpetto della cliente. «Che il Signore abbia pietà». «Uno dei soldati del colonnello Ellsworth l’ha subito vendicato, uccidendo il colpevole con una scarica di moschetto alla testa, ma era troppo tardi, sapete?» continuò lanciandole uno sguardo addolorato da sopra la spalla. «Troppo tardi per salvarlo». Elizabeth strinse le labbra e scrollò il capo. «Mi dispiace moltissimo, Mrs Lincoln. Voi e il presidente gli eravate tanto affezionati». «Certo». La first lady tacque mentre Elizabeth finiva di vestirla. «Credo che fosse come un figlio per mio marito. E per entrambi era uno di casa, capite? Pieno di giovinezza, di forza e di coraggio...» Inspirò bruscamente. «Dovrò scrivere a sua madre. Lo farà anche mio marito, naturalmente, ma devo scriverle anch’io. Anche se non riesco a immaginare cosa potrei dirle». Le si ruppe la voce e si lasciò ricadere contro lo schienale della sedia. «Mrs Lincoln» chiese Elizabeth con voce ferma, «c’è qualcosa, qualunque cosa, che posso fare per voi o per il presidente?» «Avete fatto ciò di cui avevo più bisogno, Elizabeth, come sempre». Le rivolse un sorriso triste e tirato. «A volte non so come riesco a sopportare la vita in questa...» Agitò una mano, come a indicare Washington. «Ecco, sapete anche voi com’è, e quanto abbia bisogno di voi». Una piccola vampata di orgoglio riscaldò il cuore di Elizabeth. Sì, lo sapeva. «Per me è un grande piacere, signora». Qualche giorno dopo, quando la moglie del presidente la chiamò di nuovo alla Casa Bianca, Elizabeth seppe che migliaia di persone erano andate a rendere omaggio al giovane colonnello, esposto nella camera ardente dell’East Room. Tra loro c’era Robert Lincoln, che aveva compiuto il viaggio da Harvard per condividere il lutto e il dolore dei genitori. Sembravano tutti scossi non solo dalla perdita personale subita, ma anche dall’impressione che quella morte prematura, violenta e improvvisa preannunciasse il sacrificio di molti uomini giovani e valorosi che sarebbero scomparsi nei mesi a venire. La bandiera che era costata la vita al colonnello Ellsworth fu offerta alla first lady. Mrs Lincoln ne fu onorata e profondamente commossa, e la conservò per sempre. La morte di quel soldato che conosceva appena creò in Elizabeth nuove apprensioni per la vita del militare che amava sopra ogni cosa. George scriveva spesso, almeno due volte alla settimana, e le raccontava gli aneddoti della vita da campo e le sue buffe disavventure di recluta alle prime armi. Elizabeth aveva visto abbastanza scene di vita militare a Washington per sapere che il figlio le dava una versione edulcorata e ottimista della sua esistenza, e che le cose dovevano essere ben più difficili per lui di quanto lasciasse immaginare. Stando a quel che gli risultava era l’unico nero del reggimento, composto quasi per intero da immigrati tedeschi, con qualche irlandese e americano tra loro. «Sono più bianco di quasi tutti i miei commilitoni» le scrisse in una delle prime lettere, «quindi non devi preoccuparti che mi faccia scoprire». Molti civili del Missouri non amavano i tedeschi, ma George apprezzava la loro operosità e lo stoicismo, oltre a condividerne le opinioni abolizioniste. Lo stato schiavista del Missouri era in una situazione particolare: aveva votato in marzo per restare nell’Unione, ma senza fornire uomini o armi a nessuna delle due parti. Quella decisione non aveva impedito a unionisti e secessionisti di formare milizie per conto proprio e di disputarsi il controllo delle varie armerie federali situate in diversi punti dello stato. Nel giro di qualche settimana dopo l’arruolamento di George, il Primo Reggimento del Missouri sotto il comando del capitano Nathaniel Lyon marciò su Camp Jackson, dove le milizie secessioniste dei volontari del Missouri conservavano l’artiglieria pesante e le munizioni sottratte dai confederati all’Unione e destinate all’assalto dell’arsenale di Saint Louis. Quasi settecento miliziani furono costretti ad arrendersi, ma quando rifiutarono di giurare fedeltà agli Stati Uniti il capitano Lyon decise di arrestarli e di farli marciare per le strade della città fino all’arsenale, dove progettava di rilasciare gli uomini, dopo averli umiliati, e di ordinare loro di disperdersi. L’esito disastroso di quella mossa del capitano Lyon, sebbene descritto da George con parole scelte con cura, ricordò a Elizabeth in modo impressionante l’incidente di Baltimora. Quando il Primo Reggimento Missouri scortò i secessionisti catturati attraverso la città, gli abitanti, indignati, si misero a urlare insulti e a gettare pietre e ciottoli contro i soldati. «Il ritornello “Maledetti olandesi!” è stato urlato contro i nostri commilitoni tedeschi tanto spesso e con tale astio che ho capito che c’è qualcuno di più odiato dei negri» scrisse George. A un certo punto, secondo una versione degli eventi, un civile ubriaco si parò davanti alle truppe che avanzavano, tirò un colpo di pistola e ferì mortalmente un capitano del Terzo Reggimento Missouri. I soldati risposero aprendo il fuoco, prima tirando sopra le teste dei civili, poi direttamente nella folla. Ventotto persone, tra cui donne e bambini, rimasero uccise, e altre cinquanta furono ferite. Seguirono diversi giorni di disordini, durante i quali l’odio antitedesco esplose a Saint Louis, i civili sparavano contro i soldati da dietro le finestre dei negozi e degli uffici, e le truppe reagirono ancora una volta facendo fuoco tra la folla nelle strade. Anche se George descrisse gli eventi senza darvi troppo peso, con la spavalderia della giovinezza, Elizabeth capì che era rimasto scosso. A metà giugno George le disse in un’altra lettera che il Primo Reggimento Missouri e altri reggimenti federali avevano marciato su Jefferson City e avevano scoperto che il governatore secessionista aveva abbandonato la capitale dello stato. Le forze dell’Unione conquistarono senza problemi la città e inseguirono il governatore e la sua guardia di stato fino a Boonville, un’ottantina di chilometri a nordovest. «È stata una schermaglia breve e poco cruenta» scrisse George, «ma abbiamo inflitto una bella batosta alla guardia di stato, abbiamo cacciato via i secessionisti e preso possesso a nome dell’Unione la valle del Missouri. Un buon lavoro, se posso dire la mia». Mentre le scriveva quella lettera erano accampati, e non sapeva quando e verso dove avrebbero ripreso a marciare. Le ingiunse di non preoccuparsi e le chiese di pregare per lui, promettendo a sua volta di scriverle il prima possibile. «Non dimentico mai il mio particolare dovere» concluse. «Nulla di ciò che subisco sul campo di battaglia ha la minima importanza se procura la libertà a tutta la nostra razza. Vorrei solo che i miei amici dell’università avessero il diritto di prendere le armi come ho fatto io. A volte, quando sento i miei commilitoni parlare della codardia e inferiorità dei neri, ho la tentazione di non limitarmi a parlare in loro difesa. Vorrei balzare in piedi e gridare: “Non ho forse combattuto valorosamente come voi? Non ho marciato, non ho sopportato gli stessi stenti? Se il mio sangue sarà versato, non sarà rosso come il vostro? Sì, sono nero anch’io, e vi sfido a mostrarmi perché mai non sarei un soldato coraggioso come voi!” Ma naturalmente non posso dire nulla, non ancora. Quando la guerra sarà finita dirò la verità, e nessun uomo potrà considerarsi superiore a me». Elizabeth era troppo orgogliosa di lui per tormentarlo con preoccupazioni e timori. George si era arruolato per dimostrare il proprio valore, per proteggere l’Unione, per liberare gli esseri umani della sua razza dalla schiavitù. Lei, che aveva vissuto quasi quarant’anni come schiava, sapeva bene che la sua missione era nobile e necessaria. E dire che quando si era scoperta incinta di lui, più di ventiquattro anni prima, era stata colta dallo sconforto. Non avrebbe voluto avere rapporti con Alexander Kirkland, e le faceva orrore la prospettiva di mettere al mondo un bambino destinato a una vita da schiavo. Ma dopo la nascita di George, la sua paura più grande era stata che glielo portassero via. Verso metà estate, i giornali si riempirono di notizie di battaglie, scaramucce, avanzate e ritirate nei pressi di città che Elizabeth non aveva mai sentito nominare. Furono presi prigionieri da entrambe le parti, ma il presidente Lincoln e i suoi consiglieri non sapevano cosa fare degli uomini catturati. Trattandosi di ribelli colpevoli di tradimento avrebbero dovuto essere impiccati, cosa impensabile visto il numero di prigionieri, e che oltretutto avrebbe causato rappresaglie contro i soldati dell’Unione catturati dai sudisti. Uno scambio di prigionieri, pratica corrente tra paesi in guerra, sarebbe stato interpretato come il riconoscimento della legittimità della Confederazione come stato sovrano, un passo che il presidente non aveva alcuna intenzione di compiere. Così i ribelli catturati erano tenuti prigionieri a tempo indeterminato, talvolta spostati da galere per schiavi a carceri militari di proprietà della Marina a prigioni civili a Washington, mentre Lincoln e i suoi consiglieri dibattevano su cosa fare di loro e dei beni dei ribelli che l’esercito dell’Unione aveva confiscato sull’altra sponda del Potomac. La piantagione di Arlington appartenente a Robert E. Lee era forse la proprietà terriera più preziosa della Virginia, e alcuni consiglieri di Lincoln gli suggerirono di venderla per contribuire a finanziare la guerra e come avvertimento nei confronti degli altri latifondisti. Elizabeth capì che il gentiluomo che un tempo le aveva sorriso mettendole in mano una banconota da cento dollari, dicendole di non badare a spese per la moglie, era ormai un ribelle; anzi, non un semplice ribelle ma il loro generale, eppure lei non riusciva a evitare di dispiacersi per la moglie, la sua ex cliente. La piantagione era stata ereditata dalla famiglia di lei, che discendeva da Martha Washington. il pensiero che Mrs Lee forse non avrebbe mai più rivisto la dimora dei suoi antenati addolorava Elizabeth. La sarta non aveva dimenticato altre clienti che erano fuggite da Washington per tornare nei propri stati una volta che questi avevano abbandonato l’Unione. In giugno completò il ricamo che le aveva affidato Varina Davis, ma non aveva idea di come farglielo avere. Il servizio postale aveva interrotto le consegne nella Confederazione il 1° giugno, e anche se Elizabeth aveva sentito parlare di contrabbandieri che trasportavano impunemente merci varie facendo la spola tra il Nord e il Sud, non aveva idea di come arrivarci, né si sarebbe sentita a suo agio a fidarsi di qualcuno impegnato in quell’attività. Alla fine affidò il ricamo a un’amica di Mrs Davis, Matilda Emory, moglie del maggiore William Emory. Questi, originario del Maryland, dopo essere stato di guarnigione alternativamente nel Territorio Indiano e nella capitale, in maggio aveva abbandonato l’esercito dell’Unione contro il volere della moglie. Mrs Emory, non contenta di protestare, aveva fatto reintegrare il marito recuperando lei stessa la lettera di dimissioni. Nonostante il suo forte attaccamento all’Unione era rimasta amica di Mrs Davis, e senza spiegarle come avrebbe portato a termine l’impresa assicurò a Elizabeth che avrebbe fatto pervenire il ricamo alla sua amica. Da quando se n’era andato da Washington, appena sei mesi prima, Davis era stato eletto presidente degli stati confederati e Mrs Davis era diventata la first lady. Talvolta Elizabeth ripensava ai mesi in cui aveva lavorato in casa Davis e si stupiva per i cambiamenti avvenuti da allora. Mrs Davis e il marito si erano spostati dall’Alabama alla Virginia, o almeno così dicevano i giornali, e ora abitavano in un’altra Casa Bianca a Richmond, la nuova capitale della Confederazione. La sarta si chiese se la sua ex cliente sperasse ancora che i confederati avrebbero espugnato Washington e di poter prendere possesso della vera Casa Bianca. Osservando le nuove guarnigioni disposte dall’Unione a difesa del distretto, la sarta pensava che la conquista della città non sarebbe stata facile come credeva Mrs Davis. L’attuale first lady, in ogni caso, avrebbe avuto qualcosa da ridire sulle dichiarazioni tanto ottimiste di Mrs Davis, se la sua sarta fosse stata così imprudente da parlargliene. Mrs Lincoln era, com’era sempre stata, una fervente unionista, e sebbene i ministri del presidente boicottassero sistematicamente i suoi tentativi di influenzare il marito o la politica, usava la propria posizione per sostenere la causa del Nord in altri modi. Organizzava cene per i personaggi in vista e, sperando di sollevare il morale del popolo, chiedeva alla banda della Marina di tenere concerti ogni mercoledì e sabato, quando il parco attorno alla Casa Bianca era aperto al pubblico. Visitava gli accampamenti militari e i soldati in ospedale, spesso distribuendo con le sue mani leccornie provenienti dalle cucine e dagli orti della Casa Bianca. Ottenne armi dal ministero della Guerra e le fece mandare a un colonnello dell’Unione nel suo stato natale del Kentucky con una lettera sincera e appassionata con cui gli professava la propria ammirazione per il suo patriottismo. Passava in rassegna le truppe con il marito, e rimase entusiasta quando un colonnello dell’esercito ruppe una bottiglia di champagne contro un carro per battezzare il campo dove bivaccavano gli uomini “Camp Mary”, in suo onore. Elizabeth avrebbe desiderato che gli sforzi di Mrs Lincoln ricevessero un po’ più di attenzione dai giornali, invece di miseri trafiletti di tanto in tanto. Purtroppo i giornalisti e i pettegoli erano molto più affascinati dalle vicende dei suoi parenti secessionisti e dalle sue spese esose per il baldacchino di raso a frange, il servizio di porcellana viola e oro con il sigillo degli Stati Uniti su ogni pezzo, e un altro servizio uguale con le proprie iniziali. La stampa la assillava senza darle tregua, perfino durante le trasferte per scappare dal caldo, dalle malattie e dagli sciami di mosche e zanzare che tormentavano Washington nei torridi giorni estivi. A fine luglio, quando cominciò a spargersi la voce che le truppe si stavano radunando vicino a Manassas Junction, in Virginia, Mary Lincoln era a casa. Migliaia di cittadini in cerca di distrazioni prepararono cestini da picnic e noleggiarono una carrozza per andare a vedere lo spettacolo. Politici desiderosi di vivere dal vero una pagina di storia, giornalisti a caccia di notizie, lavoratori curiosi, signore con i parasole, elettrizzate alla prospettiva di correre qualche rischio e di cogliere atti di eroismo, desideravano tutti stare a guardare mentre il generale di brigata Irvin McDowell e il suo fortissimo esercito della Virginia nordorientale infliggevano una sconfitta memorabile ai ribelli prima di marciare su Richmond e mettere rapidamente fine al conflitto. Diverse giovani assistenti di Elizabeth erano state invitate da alcuni soldati ad andare sul loro carro. «Venite con noi, Mrs Keckley» la esortò Emma Stevens, ex schiava del Maryland che occupava una stanzetta nella soffitta della pensione dei Lewis. Quando era piccola, a lei e a sua madre era stata donata la libertà alla morte della loro vecchia padrona, ma gli eredi della donna avevano ignorato il testamento. Le due donne erano rimaste in schiavitù altri dieci lunghi anni intanto che la causa intentata dalla madre di Emma contro gli eredi andava per le lunghe. Dopo aver vinto quasi miracolosamente la causa, e guadagnato la libertà, Emma e sua madre avevano adottato il cognome dell’avvocato che le aveva rappresentate con coraggio nell’aula di tribunale nonostante il clima ostile che vi regnava. Elizabeth sorrise e scosse il capo. «No, grazie». «Oh, venite, su» insistette Emma. «Ci sarà posto a sufficienza sul carro. E poi è domenica. Non dovreste lavorare di domenica». «Devo» rispose Elizabeth. «Mrs Lincoln ha bisogno che finisca l’abito da giorno bianco prima del suo viaggio al mare. Voi ragazze andate a divertirvi, ma state attente». Fece un sospiro di sollievo quando Emma reagì con una smorfia delusa e si avviò da sola, ritrovando però subito il buonumore al pensiero delle amiche e dei ragazzi che le avrebbero scortate. In realtà non voleva confessare alla ragazza, la sua collaboratrice prediletta, che non sopportava di assistere a una battaglia, poiché le ricordava quelle che George stava forse affrontando a sua volta, da qualche parte in Missouri. Cucì tutto il giorno in camera sua con finestre e porte aperte per far circolare l’aria, interrompendosi solo per il pranzo e per una passeggiata con Virginia lungo il fiume, dove il lezzo rovinò il piacere del venticello fresco. Udirono i rimbombi dell’artiglieria a ovest, e si chiesero come stesse andando la battaglia. «Forse ci pentiremo di esserci perse la scena» osservò Virginia. «Io no di certo» replicò Elizabeth. Lungo la strada del ritorno verso Twelfth Street passarono davanti a un ufficio del telegrafo, dove uomini e ragazzi aspettavano notizie dal campo di battaglia. I confederati erano in fuga, a giudicare dai discorsi, e le amiche udirono due uomini affermare che l’esercito dell’Unione sarebbe probabilmente giunto a Richmond nel giro di una settimana. Rassicurate dalle novità positive tornarono a casa e raccontarono a Walker ciò che avevano appreso. Rientrata nelle sue stanze, Elizabeth riprese a lavorare all’abito di Mrs Lincoln, infilò un filo nell’ago e si autorizzò a sperare che la guerra finisse entro l’autunno, per permettere a George di concludere il proprio periodo con l’esercito e di riprendere l’università all’inizio del semestre successivo. Le sue speranze furono annientate prima dell’alba. Durante la notte fu svegliata da rumori provenienti dall’esterno: ruote di carri, zoccoli di cavalli, voci concitate. Corse alle finestre, ma si affacciavano tutte sul giardino, e vide solo le facciate posteriori di altre case e un alone luminoso di qualche lanterna attraverso i vetri. A mano a mano che il chiasso aumentava, altre finestre si illuminarono. Elizabeth si vestì in fretta e uscì sul marciapiede davanti a casa, dove trovò Virginia, Walker e qualche altro vicino che guardavano esterrefatti il passaggio di carri, carrozze e uomini a cavallo; avanzavano più in fretta che potevano spronando al massimo i cavalli esausti, e avevano espressioni sofferenti e terrorizzate. «Cos’è successo?» chiese Elizabeth a Virginia, che si limitò a scuotere la testa, stringere le labbra e afferrarle il braccio. Restarono aggrappate l’una all’altra mentre quella sfilata spaventosa continuava, e capirono infine che si trattava degli spettatori partiti pieni di entusiasmo quel mattino per Centreville con il progetto di assistere alla battaglia. Infine Walker fermò un nero su un carretto trainato da un cavallo, che rallentò ma non si arrestò. «Un disastro» annunciò stando a cassetta. «Centinaia di morti. Compagnie intere sbaragliate. I soldati di McDowell stanno battendo in ritirata per tornare in città, se non sono ancora stati catturati o uccisi, e i ribelli li inseguono». Virginia si lasciò sfuggire un grido, ed Elizabeth avvertì un brivido. Emma e altre due delle sue protette si trovavano nel bel mezzo di tutto quel caos. «Sono rimasti feriti anche dei civili?» chiese all’uomo sul carretto, che però si era già allontanato. Per tutta la notte il fiume dei civili di ritorno non rallentò; erano scossi ed esausti, e raccontavano terrorizzati di come fossero riusciti a sfuggire a una morte certa. Si erano tenuti a una certa distanza dai combattimenti, vicino al fiume, e così erano stati i primi a tornare. La sarta aveva quasi abbandonato le speranze quando apparve Emma, scortata da un giovane che la affidò subito alle cure di Walker, Elizabeth e Virginia. «È stato un incubo» esordì la ragazza tremante, con gli occhi sbarrati. «Non avevo mai visto nulla del genere. Se non fossimo stati tra gli ultimi arrivati, e non ci fossimo trattenuti vicino al carro...» Scosse il capo e tacque mentre Virginia la accompagnava dentro. Solo all’alba i primi soldati arrivarono in città, con espressioni stranite, esausti, incuranti ormai del proprio rango. Nessuno si sognava più di agitare il vessillo del reggimento, o di suonare marce militari con tamburo e piffero. Affamati e stanchi, alcuni lasciarono cadere la loro roba sulla soglia delle case, sul marciapiede, davanti a lotti non edificati, e si coricarono a dormire. Alcuni curiosi, dopo essersi ripresi dallo stupore, corsero in casa e tornarono subito con pane, formaggio, mele e altro cibo da distribuire ai soldati di passaggio. Elizabeth e Virginia li imitarono, offrendo acqua in brocche e secchi dai quali i militari attingevano con un mestolo. Poi arrivarono i feriti, portati in città sui carri. Non c’erano abbastanza letti per tutti i soldati che ne avevano bisogno, e c’era penuria di bende, infermiere, cibo e ospedali. Prigionieri in uniforme grigia erano scortati da guardie armate. Alcuni cittadini urlarono insulti e gettarono pietre ai confederati catturati, mentre i simpatizzanti sudisti, senza alcun ritegno, gridarono loro parole di incoraggiamento lungo la strada verso il vecchio Campidoglio, trasformato in una prigione militare federale. Per ore la popolazione di Washington aspettò in preda al terrore che l’esercito della Confederazione sfruttasse la vittoria per espugnare la città, ma non ci fu alcuna invasione. Nei giorni che seguirono i nordisti volevano vendicarsi, e il presidente Lincoln pretendeva delle risposte. Mentre i volontari si assiepavano negli uffici di reclutamento, il presidente si riunì con i suoi collaboratori, deciso a scoprire perché la battaglia fosse finita in modo così tragico e ad assicurarsi che non succedesse mai più. La stampa aveva già ribattezzato la ritirata caotica dell’Unione dal campo di battaglia “la grande fuga”, umiliando i soldati del Nord e incoraggiando invece i loro nemici. «Erano truppe di giovani inesperti» disse Mrs Lincoln a Elizabeth, difendendo a spada tratta i soldati e, di riflesso, suo marito che li aveva mandati a combattere. «Ora non lo sono più. Non subiranno mai più una sconfitta tanto cocente». La sarta sperava che avesse ragione, e pensò subito a suo figlio. Nell’ultima lettera, George le aveva detto che il Primo Reggimento Missouri si stava apprestando a marciare su Springfield, ma non sapeva quando sarebbero partiti. Sua madre avrebbe voluto sapere se avevano già cominciato ad avanzare, se erano arrivati, se avevano combattuto e chi aveva vinto la battaglia. Anche George era ancora inesperto, pensò, sebbene il suo reggimento avesse dovuto combattere nelle strade di Saint Louis e nella scaramuccia di minore importanza di Boonville. Doveva ancora affrontare il tipo di battaglia che aveva visto impegnati gli uomini di McDowell nei pressi del torrente chiamato Bull Run, e si sentì morire immaginandolo sotto il fuoco dei fucili e cannoni ribelli. I giorni che passavano tra le lettere di George erano pieni di attesa e preoccupazione. L’arrivo di ogni lettera portava una gioia e un sollievo solo momentanei, perché pur assaporando ogni parola, Elizabeth sapeva che non garantivano la sua incolumità al momento della lettura, ma erano solo una prova del fatto che era ancora vivo quando le aveva scritte. Era già qualcosa, però. Elizabeth custodiva gelosamente le sue lettere in una scatola di legno di palissandro ricevuta dalla sua ex padrona come dono di addio quando era partita da Saint Louis. Ogni domenica sera leggeva le lettere nell’ordine in cui il figlio gliele aveva scritte, un rito che si allungava ogni settimana. Erano talismani che annullavano la distanza tra loro e, sperava, un giorno gliel’avrebbero restituito. I primi giorni di agosto furono caldissimi e umidi, e all’orizzonte non si prospettava alcun miglioramento. Dopo aver organizzato una cena di stato per il principe Napoleone III, Mrs Lincoln portò Willie, Tad e la cugina Mrs Grimsley in villeggiatura a Long Branch, a Manhattan e a nord dello stato di New York, ma la sua assenza non fece che procurare lavoro supplementare a Elizabeth, perché tutte le altre dame si precipitarono a farsi confezionare abiti. Lavorò per Mary Jane Welles, moglie del ministro della Marina; per Margaret Cameron, moglie del ministro della Guerra; e per Adele Douglas, la giovane vedova del senatore Stephen A. Douglas dell’Illinois. La graziosa Mrs Douglas osservava un lutto stretto ma con ottimo gusto, e nonostante la circostanza tragica le altre signore invidiavano la sua grazia e la sua bellezza. Verso metà mese, quando i temporali estivi saturarono l’atmosfera di umidità senza accordare sollievo dal caldo, Elizabeth ricevette una lettera dal Missouri vergata da una mano sconosciuta. Non poteva essere di George né della sua ex padrona, Anne Garland, la cui calligrafia conosceva bene. Aprì subito la busta. Con il cuore che batteva per un’apprensione improvvisa, aprì la lettera e la lesse lentamente, parola per parola, avendo paura di arrivare fino in fondo. Nei pressi di Springfield, Missouri 11 agosto 1861 A Mrs Elizabeth Keckley Washington DC Gentile signora, è con grande dolore che le scrivo per informarla della morte di suo figlio, George Kirkland. Grazie alla sua ottima condotta e al suo coraggio mentre era ai miei ordini, si è conquistato il rispetto mio e dei suoi commilitoni, e se fosse sopravvissuto avrebbe presto avuto una promozione. È stato ferito nella battaglia di Wilson’s Creek, dove le sue ultime parole sono state per la nostra nobile causa e per la necessità di lottare fino alla vittoria. È sepolto qui, accanto ai suoi compagni d’armi che sono caduti come lui quel giorno. Invierò a casa il prima possibile i suoi effetti personali. Distinti saluti, Charles W. Anderson Capitano, comandante della Compagnia D Primo Reggimento Volontari del Missouri Elizabeth sentì la stanza muoversi e girarle attorno, poi calò il buio. 5. Agosto 1861 - marzo 1862 Quando arrivarono gli effetti personali di George, una settimana dopo, Elizabeth li lasciò sullo scrittoio due giorni prima di avere il coraggio di esaminarli. Nel pacchetto trovò tutte le lettere che gli aveva scritto, legate con un nastro; un libro di salmi; il necessario da cucito che si poteva arrotolare e legare; una boccetta di inchiostro di palissandro; una tazza di stagno; una scatoletta di tabacco, anch’essa di stagno; due dadi di osso. Era felice che George avesse trovato conforto e ispirazione nelle Sacre Scritture mentre era in guerra, ma non le piaceva che avesse iniziato a fumare e a giocare. Comunque, non aveva più importanza. In mezzo a tanta sofferenza, Elizabeth trovò conforto in una lettera calorosa e piena d’affetto di Mrs Lincoln e nell’amicizia di Virginia, Walker ed Emma, i cui occhi brillavano di lacrime quando disse a Elizabeth che avrebbe tanto voluto conoscere il suo bel soldato eroico. Per un attimo Elizabeth si concesse di immaginare George ed Emma che si incontravano, si innamoravano, si sposavano, facevano dei figli... e poi cacciò per sempre quei pensieri. Era morto libero. Almeno era riuscita a fare quello per suo figlio. In autunno Mrs Lincoln tornò a Washington, e il dovere richiamò Elizabeth alla Casa Bianca. Il fronte del conflitto si era allontanato dalla periferia della città, ma ogni giorno arrivavano nuovi racconti di combattimenti violenti e scene terrificanti di morte e rovina. La guerra infieriva in diversi stati, e l’esercito dell’Unione subì una sconfitta demoralizzante dietro l’altra. A Washington un lungo periodo piovoso fece tracimare il Potomac, spingendo a valle i corpi dei soldati dell’Unione uccisi settimane prima, nella battaglia di Ball’s Bluff, finché non furono ripescati tra i ponti all’altezza di Fourteenth Street. Vicino al fiume e ai canali le fogne traboccavano riversandosi per le strade, e spargendo miasmi pestilenziali per interi isolati. I soldati erano accampati sulle colline circostanti, ammassati gli uni sugli altri in tende perennemente fradice, e il vaiolo e la febbre tifoidea ne uccisero molti. I soldati dell’Unione combattevano contro i confederati, medici e infermiere si battevano con le malattie, poliziotti e volontari cercavano di domare gli incendi che divampavano con allarmante regolarità, e il presidente combatteva con i suoi ministri e con il generale McClellan, che sembrava incapace di sfruttare il vantaggio sul campo di battaglia e perfino di riconoscerlo, quando ce l’aveva. Nel frattempo, Mrs Lincoln era impegnata su tutt’altro fronte. Il rifacimento della decorazione della Casa Bianca le aveva procurato violente critiche da parte della stampa ed era costato molto più della somma accordatale; Elizabeth scoprì con disappunto che il giardiniere, James Watt, le aveva insegnato a gonfiare le fatture e a nascondere certe spese inserendole nel conto di Watt stesso. Ignorando gli avvertimenti del commissario per gli edifici pubblici, che le comunicava che non aveva più soldi da spendere, Mrs Lincoln proseguì nell’accumulare debiti finché non divenne impossibile continuare a nasconderli al marito. Ci fu un furioso litigio il giorno del quarantatreesimo compleanno di lei, in seguito al quale la first lady implorò il commissario di intercedere in suo favore presso il marito. Lui ubbidì con riluttanza, e anche se Elizabeth non fu testimone diretta della replica esplosiva di Abraham Lincoln – «Giuro che non approverò mai le fatture per le inutili cianfrusaglie di questa maledetta casa!» – quella frase finì, dopo, sulla bocca di tutti. La reputazione di Mary Lincoln fu ulteriormente danneggiata dai personaggi di dubbia moralità che frequentavano di sera il suo salotto: una cricca di favoriti, quasi solo uomini, che la adulavano e, forse, tradivano la sua fiducia. Si diceva che uno dei frequentatori più assidui avesse fornito al New York Herald il messaggio annuale del presidente al Congresso, che fu pubblicato prima ancora che Lincoln lo pronunciasse. Dopo quella volta, il presidente mise in guardia la moglie contro le confidenze inopportune, vietò l’ingresso alla Casa Bianca al presunto responsabile dell’indiscrezione, licenziò il giardiniere e, con grande dispiacere di Mary, smise di confidarsi con lei sulle questioni politiche. Elizabeth scoprì presto sulla sua pelle quello che le disavventure di Mrs Lincoln le avevano già suggerito: c’erano persone senza scrupoli decise a insinuarsi, in un modo o nell’altro, alla Casa Bianca per i propri scopi disonesti. Non appena Elizabeth fu riconosciuta in tutta Washington come la sarta di Mrs Lincoln, perfetti sconosciuti cominciarono a cercarla fingendosi amici, sperando che usasse la sua influenza per procurare loro un lavoro, accordare un favore o rivelare informazioni utili. Un giorno una donna che Elizabeth non aveva mai visto si presentò da lei, le commissionò un vestito e insistette per lasciarle un anticipo. Per qualche tempo andò ogni giorno per prove e ritocchi, comportandosi sempre con educazione e gentilezza. Il giorno in cui l’abito fu terminato e si presentò per ritirarlo, esitò prima di chiedere: «Mrs Keckley, conoscete Mrs Lincoln?» «Sì» rispose lei, piegando con cura l’abito affinché la cliente potesse portarlo a casa. «Siete la sua sarta, vero?» «Sì». «La conoscete molto bene, quindi». Elizabeth mantenne un’espressione indifferente, ma si chiese dove volesse andare a parare la donna con le sue domande. «La vedo quasi ogni giorno». «Non pensate di avere un certo ascendente su di lei?» Ecco, era arrivata al dunque. «Non saprei. Mrs Lincoln, immagino, ascolterebbe i miei suggerimenti, ma sapere se i miei commenti potrebbero influenzarla è un’altra questione». «Sono sicura che ci riuscireste». La donna fece un sorriso per ingraziarsela. «Ho una proposta per voi, Mrs Keckley. Desidero più di ogni altra cosa lavorare alla Casa Bianca. Ho sentito tanto parlare della bontà del presidente Lincoln che vorrei stargli vicino, e se non trovo nessun altro modo per entrarvi sono disposta anche a fare la serva». Elizabeth tentò di intervenire, ma la donna riprese a parlare fingendo di non essersene accorta. «Mia cara Mrs Keckley, non potreste raccomandarmi a Mrs Lincoln, dicendo che sono una vostra amica senza lavoro, e chiederle di assumermi come cameriera? Se accettate, sarete ricompensata lautamente. Potrebbe fruttarvi diverse migliaia di dollari». Elizabeth la guardò esterrefatta. «Signora, mi avete giudicata male. Piuttosto che tradire la fiducia di un’amica mi getterei nel Potomac. Non sono tanto meschina. Scusatemi, ma quella è la porta, non tornate mai più!» La donna balzò in piedi, stupita e furiosa. «Benissimo!» sbottò attraversando la stanza per uscire. «Rimpiangerete questo vostro comportamento». «Mai e poi mai!» esclamò Elizabeth, sbattendo la porta quando l’altra se ne fu andata. Un attimo dopo sentì bussare dolcemente, e spalancando l’uscio si vide davanti Emma. La ragazza fece un cenno indicando il corridoio. «Perché se ne va arrabbiata?» «Oh, non è niente» rispose Elizabeth facendola entrare. È solo un’altra cacciatrice di opportunità. Afferma che il suo più grande desiderio è lavorare come cameriera per Mrs Lincoln». «Non ha l’aria di una cameriera» osservò Emma. «Ma ha un aspetto familiare». «Non l’avevo mai vista prima che ordinasse quel vestito, e spero di non rivederla più». Desiderava solo dimenticare l’incidente, ma la curiosità di Emma la spinse a fare qualche ricerca. Scoprì che la donna era un’attrice, e aveva raccontato agli amici che voleva introdursi alla Casa Bianca come cameriera, svelare i segreti dei suoi inquilini e pubblicarne un resoconto a fondo scandalistico. «Ha sottovalutato i vostri principi e la vostra lealtà» osservò Emma, orgogliosa di avere svelato l’inganno. «Che sia di lezione a entrambe». Elizabeth non avrebbe mai accettato di venire corrotta, ma sapeva che altre persone di sua conoscenza non si sarebbero fatte scrupoli. Quando ripensava al tempo e alla fatica necessari per guadagnare, sgobbando duro, i milleduecento dollari necessari ad acquistare la libertà per sé e per George, capiva che qualcun altro al posto suo avrebbe ceduto alla tentazione. Ma Mrs Lincoln non era più solo una cliente, e neppure semplicemente la first lady. Era diventata un’amica, ed Elizabeth sarebbe morta piuttosto di tradirla. Per Mary Lincoln l’autunno fu caratterizzato da cambiamenti di personale alla Casa Bianca, alcuni desiderati da lei, altri imposti. Dopo che tutte le scuole del distretto furono chiuse per via della guerra, la first lady decise di aprire una classe all’interno della Casa Bianca invece di mandare in collegio Willie e Tad. Ingaggiò un tutore, fece portare banchi e una lavagna, e invitò a seguire le lezioni anche i migliori amici dei suoi figli, Bud e Halsey Taft. Fino ad allora l’educazione dei figli più giovani dei Lincoln era stata trascurata parecchio da parte dei genitori, troppo indulgenti. Willie era portato per lo studio e spesso leggeva e componeva poesie, ma Tad sapeva a malapena leggere e scrivere, una lacuna alla quale Mrs Lincoln decise di porre rimedio. Entrambi i genitori davano grande importanza all’educazione, e speravano che i due figli imparassero ad amare il sapere quanto loro, e che seguissero un giorno le orme del fratello maggiore Robert che studiava ad Harvard. Elizabeth era segretamente entusiasta di quella novità, che, sperava, avrebbe inculcato nei due monelli un po’ di disciplina oltre alle nozioni scolastiche. Aveva rimpianto a lungo di non poter ricevere un’istruzione, e le dispiaceva che una simile opportunità andasse perduta per qualcun altro. Alcuni nuovi membri del personale della Casa Bianca avrebbero dovuto rassicurarla, invece ricordavano fastidiosamente a Elizabeth i pericoli che correva il presidente in quel periodo difficile. Nuovi portieri – alcuni di loro ufficiali della polizia metropolitana, vestiti in borghese ma armati, sebbene le pistole fossero nascoste – piantonavano i saloni pubblici, mentre sentinelle in uniforme montavano la guardia nei giardini circostanti. Nell’anno trascorso dalla sua elezione, il presidente aveva ricevuto tante di quelle lettere di minacce che era impossibile contarle, anche se la loro frequenza e violenza era aumentata dopo Bull Run. Mary Lincoln sembrava preoccuparsi della sicurezza del marito più di lui, e lo esortava a viaggiare senza annunciare in anticipo i propri trasferimenti e a farsi scortare dalle guardie quando si spostava in città. Lui considerava inutili tali misure e ignorò le richieste della moglie, che era quindi ancora più ansiosa. Mrs Lincoln aveva paura anche delle minacce dall’interno. Lei e il presidente parlavano spesso dei ministri in presenza di Elizabeth, che riteneva la first lady un’ottima conoscitrice dell’animo umano, le cui intuizioni sulla sincerità altrui erano spesso più accurate di quelle del marito. La sarta aveva scoperto quasi subito che Mary Lincoln detestava il ministro del Tesoro Salmon Chase, che definiva un politico egoista invece di un vero patriota, ma attribuiva tanto astio al fatto che fosse il padre della sua acerrima nemica in società, la bella Kate Chase. Mrs Lincoln non aveva una grande opinione neppure del segretario di Stato William Seward. Un mattino, Elizabeth arrivò alla Casa Bianca prima del solito e trovò il presidente seduto con il giornale in una mano mentre carezzava la testa del piccolo Tad con l’altra. Mentre stava imbastendo un abito, entrò una serva con una lettera per Mr Lincoln appena arrivata tramite un messo. Ruppe il sigillo e lesse la missiva in silenzio. «Di chi è la lettera, papà?» chiese la moglie. «Seward». Lincoln se la mise in tasca. «Devo andare a parlargli oggi». «Seward! Vorrei che non aveste nulla a che fare con quell’uomo. Non merita fiducia». Mr Lincoln la guardò con dolcezza, ma Elizabeth ebbe l’impressione che reprimesse un sorriso. «Dite lo stesso di Chase. Se vi dessi ascolto, presto resterei senza ministri». L’espressione di Mrs Lincoln diceva che l’avrebbe considerato un miglioramento non indifferente. «Meglio stare senza che fidarsi di alcuni di quegli uomini. Seward è peggio di Chase. Non ha principi». «Mamma, vi sbagliate». La scintilla di umorismo si era spenta. «I vostri pregiudizi sono così radicati che non vi fermate neppure a riflettere. Seward è un uomo abile, il paese può fidarsi di lui, e lo stesso vale per me». «Siete troppo onesto per questo mondo! Avreste dovuto nascere santo». Il presidente sbuffò infastidito, ma Mrs Lincoln insistette. «Mi pare normale diffidare di un politico frustrato e ambizioso. Mi intristisce vedere che subite e lasciate che quell’ipocrita di Seward faccia di voi ciò che vuole». «Inutile parlarne ancora, mamma». Mr Lincoln spostò lo sguardo sul giornale. «Non mi farete cambiare idea». Ma non per questo la moglie smise di provarci. Definì Andrew Johnson un demagogo e avvisò il marito che, se gli avesse accordato un ruolo importante, un giorno se ne sarebbe pentito. Quando il popolare generale McClellan fu promosso, Mary Lincoln dichiarò che era un imbroglione, perché parlava molto ma combinava poco. Mr Lincoln obiettò che era un patriota e un bravo soldato, e a quel punto la first lady replicò: «Dovrete trovare qualcuno in grado di prendere il suo posto, se volete conquistare il Sud». Il generale Ulysses S. Grant non era certo l’ufficiale che avrebbe scelto lei per sostituire McClellan. «È un macellaio» diceva spesso, «e non è adatto a capeggiare un esercito». Quando il marito le disse che aveva ottenuto molte vittorie in battaglia, lei protestò: «Sì, di solito riesce a rivendicare una vittoria, ma di che vittorie parliamo? Perde due uomini ogni volta che il nemico ne perde uno. Non ha nessun rispetto, nessuna considerazione per la vita. Se la guerra continuasse per altri quattro anni, e lui restasse alla testa dell’esercito, spopolerebbe il Nord». Scosse il capo, indignata e arrabbiata. «Potrei andarci io al suo posto in battaglia. Secondo la sua tattica, non c’è nulla da fare se non mandare file di uomini, una dopo l’altra, davanti alle trincee nemiche a farsi sparare finché il nemico non si stanca di massacrarli. Grant, lo ripeto, è uno stupido ostinato e un macellaio». «Ebbene, mamma, immaginiamo che vi assegni il comando dell’esercito» disse il presidente Lincoln con uno sguardo divertito. «Sicuramente ve la cavereste molto meglio di qualunque altro generale che ci ha provato prima di voi». Se si fosse trattato di un’offerta seria, Mrs Lincoln l’avrebbe accettata di sicuro. A quel punto il marito sarebbe stato costretto ad ascoltare i suoi consigli. La guerra intristì gli animi nel periodo natalizio, ma Mrs Lincoln era decisa a festeggiare. Elizabeth le confezionò un abito di velluto azzurro da indossare a uno spettacolo al National Theatre, e altri abiti per i ricevimenti pomeridiani e le serate di gala di Abraham Lincoln. I due figli piccoli erano felici, ma il presidente sembrava sempre malinconico, e non riusciva a liberarsi dei pensieri che gravavano come un peso su di lui. La moglie cercava di rallegrarlo, ma le tattiche che avevano sempre funzionato in passato ora sembravano avere perso efficacia. Robert Lincoln tornò a casa dall’università per le vacanze, e la sua presenza rasserenò il clima di quella che era stata una stagione di inaspettati trionfi per la first lady. Le ristrutturazioni tanto criticate avevano trasformato i saloni per i ricevimenti della Casa Bianca in vere e proprie attrazioni turistiche, guadagnandole elogi sperticati sui giornali e complimenti a denti stretti perfino da parte dei suoi detrattori più tenaci. Quanto a Elizabeth, festeggiò il Natale in modo tranquillo, andando a messa la vigilia e la mattina di Natale. Come l’anno prima, i Lewis la invitarono a partecipare al pranzo, e anche Emma fu loro gradita ospite. I suoi amici furono così gentili e premurosi con lei che solo più tardi Elizabeth si rese conto che avevano tutti tentato di divertirla e distrarla, sapendo che il primo Natale senza suo figlio sarebbe stato triste per lei. Rimase così commossa dalle loro attenzioni che si sforzò di essere allegra. Ricordò a se stessa che, grazie al Salvatore, la cui nascita celebravano quel giorno, suo figlio avrebbe goduto della vita eterna. Circondata dagli amici, confortata dalla certezza che lei e George – e anche i suoi genitori – si sarebbero ritrovati in cielo, un giorno, non poteva piangere il proprio lutto, almeno non quel giorno, il giorno di Natale. Il successo in società di cui godette Mrs Lincoln durante il periodo natalizio si protrasse fino a Capodanno. Migliaia di persone visitarono la Casa Bianca in occasione del tradizionale ricevimento del primo dell’anno, e sebbene alcuni ospiti continuassero a criticare le spese della first lady per i lavori di abbellimento e altri parlavano di scandalo e corruzione, la maggioranza dei visitatori dichiarò che la Casa Bianca rimodernata era elegante e sofisticata, molto più adatta a una nazione gloriosa. Poco dopo il ricevimento di Capodanno fu organizzata una grande serata di gala, e il mattino seguente Mrs Lincoln ne parlò in termini entusiastici mentre Elizabeth le prendeva le misure per un abito. «Ho un’idea» dichiarò. Anche se aveva parlato come per un’ispirazione improvvisa, la sarta ebbe l’impressione che avesse riflettuto a lungo su cosa dire. «Siamo in guerra, e dobbiamo spendere il meno possibile. Come sapete, è tradizione che il presidente tenga una serie di cene ufficiali ogni inverno». «Sì, certo». Elizabeth aveva vestito la first lady per quasi tutte quelle occasioni. «Sono cene costose». Mrs Lincoln scrollò il capo e sospirò, come se le parole non bastassero a descrivere le spese enormi. «Ho pensato che, se organizzo tre grandi ricevimenti, possiamo evitare le cene ufficiali. Cosa ne pensate?» Elizabeth rifletté. Un ricevimento in grande avrebbe permesso ai Lincoln di accogliere molti più ospiti a parità di costi, ma c’era da considerare cos’avrebbe pensato l’alta società di Washington se il presidente avesse abbandonato la tradizione. In ogni caso, Mrs Lincoln aveva già deciso, e in quei casi la cosa migliore era dichiararsi d’accordo. «Credo che abbiate ragione, Mrs Lincoln». La first lady si rasserenò in volto. «Sono felice di sentirvelo dire. Se riesco a persuadere mio marito, non incontrerò ostacoli alla realizzazione della mia idea». Prima che Elizabeth avesse finito di lavorare per quel giorno, il presidente le raggiunse con un’espressione esasperata. «Vengo dal capezzale del mio generale recalcitrante» disse sospirando con aria grave mentre si sedeva. «Almeno oggi può incolpare la febbre tifoidea della scarsa voglia di muoversi». La moglie mormorò parole di consolazione poi, per distrarlo da quell’umore cupo o forse perché non riusciva ad aspettare oltre, gli propose i cambiamenti nel calendario sociale. Il presidente rifletté, poi aggrottò le sopracciglia e disse: «Mamma, temo che il vostro piano non funzioni». «Funzionerà, invece, se siete voi a deciderlo». «È uno strappo alla tradizione» si limitò a osservare lui. In quelle occasioni l’etichetta era molto complessa, con regole di comportamento e un ordine scrupoloso degli ospiti per rango. Il presidente e il segretario di Stato si alternavano a organizzare ricevimenti serali dall’ultima settimana di gennaio fino a marzo, e la Casa Bianca doveva sobbarcarsi anche cene settimanali per diversi membri del governo, ufficiali dell’esercito, diplomatici e giudici della Corte Suprema. Mettere fine a quegli appuntamenti tradizionali rischiava di offendere qualcuno. «Dimenticate, papà, che siamo in guerra, e le abitudini vecchie o superate possono e dovrebbero essere accantonate» gli fece notare Mrs Lincoln. «L’idea permetterebbe di risparmiare, dovete ammetterlo». «Sì, mamma, però vanno considerati altri fattori oltre all’economia». Elizabeth nascose un sorriso. La questione dell’economia assillava entrambi i Lincoln, soprattutto per la nota liberalità con cui Mary sperperava il denaro, ma la frugalità era diventata uno strumento cui entrambi facevano ricorso quando tornava loro utile e che veniva invece passata sotto silenzio quando non ne avevano più bisogno. Mrs Lincoln di solito era la spendacciona e il marito quello più attento alle spese, ed era divertente vedere che si erano scambiati i ruoli. «Penso anche a un’altra cosa» insistette Mrs Lincoln. «I ricevimenti pubblici sono più democratici di quelle stupide cene di ufficali, e sono quindi più consoni alle istituzioni del nostro paese, come direste voi se doveste imbastire un discorso. In città ci sono molti forestieri, stranieri oppure no, che potremmo invitare ai ricevimenti ma non alle cene». Mr Lincoln ci pensò ancora. «Credo che abbiate ragione, mamma» dichiarò infine. «Avete difeso con abilità il vostro punto di vista. Credo che dovremo optare per i ricevimenti». Quando lo sguardo del marito si rivolse altrove, la first lady lanciò a Elizabeth un’occhiata trionfale. Quel giorno aveva vinto lei. Nonostante tutti i discorsi sul risparmio, per il primo ricevimento Mrs Lincoln decise di organizzare un grande ballo nell’East Room. Quando si diffuse la notizia della sua dispendiosa iniziativa, ancora una volta fu al centro delle critiche, non solo dei soliti che le davano addosso a ogni occasione, i giornalisti e gli appartenenti ai circoli popolari, ma anche dei segretari di gabinetto del marito, che cominciarono a chiamarla “strega” alle sue spalle ma al cospetto di Elizabeth. Quest’ultima non riferiva alla sua cliente di quell’aperta ostilità per non farla soffrire, ma sapeva che i commenti più crudeli di solito viaggiavano veloci dagli uffici fino all’oggetto di scherno, passando dagli alloggiamenti della servitù. Se le frecciate dell’entourage la ferirono, Mrs Lincoln finse indifferenza e si buttò a capofitto nei preparativi. Collaborò con Elizabeth per la confezione di un abito nuovo, di raso bianco, scollato e con le spalline basse, con balze di pizzo nero, fiocchi bianchi e neri e un lungo strascico elegante. Progettò un menu elaborato di tacchino arrosto, foie-gras, ostriche, manzo, anatra, quaglie, pernici e aspic, seguito da un assortimento di frutta, torte e gelati, e creazioni spettacolari di zucchero filato. Mandò settecento inviti a uomini di spicco del governo e consorti, oltre a certi amici cari, personaggi importanti di Washington e dignitari in visita. «Mezza città esulta per avere ricevuto l’invito» Elizabeth sentì dire al segretario particolare del presidente, «mentre l’altra metà è furiosa per essere rimasta tagliata fuori». Il clima di attesa si fece palpitante quando il New York Herald predisse che il ballo sarebbe stato «l’evento più spettacolare mai visto in America». Gli annunci pomposi della stampa non bastarono a conquistare tutti. I soliti detrattori, e molti altri, espressero il proprio stupore e disgusto per il trionfo della futilità rappresentato dal ballo e dalla padrona di casa. Molti inviti furono declinati, e quasi un centinaio furono rispediti al mittente con commenti indignati per quell’eccesso di frivolezza proprio mentre la nazione era sconvolta, angustiata e impoverita dalla guerra. «Sono allibita da una simile impertinenza da parte di un gentiluomo!» esclamò Mary Lincoln rivolta a Elizabeth un pomeriggio mentre leggeva la posta. «Sentite cosa scrive il senatore Benjamin Wade: “Il presidente e Mrs Lincoln sanno che è in corso una guerra civile? Se così non fosse, i coniugi Wade ne sono invece al corrente, e per questa ragione rifiutano di ballare e far festa”». Mrs Lincoln sbatté la lettera sul tavolo. «Se sappiamo che c’è una guerra? Ma se non pensiamo ad altro!» «Non riesco a immaginare qualcuno che sia più consapevole della guerra del presidente» commentò la sarta. Indignata, la first lady balzò in piedi e si avvicinò alla finestra a grandi passi. «Se annullare il ballo servisse a far terminare subito la guerra, o almeno ad accordare un’ora di riposo a un soldato stanco, sarei la prima a proporlo». Elizabeth mormorò parole di consolazione finché Mrs Lincoln non si fu calmata. Magari fosse stato così semplice porre termine al conflitto... Ma in quel momento, si accontentava di far cessare le tempeste che si scatenavano ogni volta che qualcuno offendeva la first lady. I critici giudicavano le sue azioni senza capire i motivi che le animavano, perciò le critiche erano sempre ingiuste e ben di rado accurate. Vista la situazione, che non pareva destinata a cambiare, la moglie del presidente avrebbe fatto bene a coltivare la calma e a imparare a ignorarle. Un silenzio dignitoso era spesso la reazione migliore alle chiacchiere malevole; ma Mrs Lincoln non era fatta così. Qualche tempo dopo, la first lady fu distratta dalla frenesia dei preparativi quando Willie si buscò un brutto raffreddore cavalcando il suo pony con il maltempo. Pochi giorni prima del ballo le sue condizioni peggiorarono, e gli venne la febbre. Elizabeth aveva accudito entrambi i bambini quando si erano ammalati di morbillo e di molte altre malattie, e anche questa volta Mrs Lincoln la chiamò al capezzale del figlio. Con amorevole efficienza, Elizabeth si occupò di Willie – un bambino dolce, educato, sensibile, adorato da tutti – e cercò di confortare la madre, che si preoccupava senza sosta, come faceva sempre quando uno dei suoi figli non stava bene. Aveva perso il secondogenito, Eddie, per colpa della tubercolosi prima che compisse quattro anni, e viveva nel terrore di veder morire un altro figlio. Presto apparve evidente che il bambino stava diventando sempre più debole. Un pomeriggio, Elizabeth era accanto al suo letto e gli premeva una pezza bagnata sulla fronte mentre Mary Lincoln indugiava nei paraggi, raccontando a Willie storielle divertenti sui suoi animali domestici; ma il piccolo era troppo intontito dalla febbre per prestarle attenzione. Mr Lincoln andò a chiedere notizie del figlio, come faceva spesso durante il giorno. «Come sta il mio ragazzo?» si informò. «Sembra stabile rispetto a stamattina» replicò Elizabeth. «Non è peggiorato ma neanche migliorato». «Forse si riprenderà presto» disse il presidente, ma i suoi occhi non si illuminarono di autentica speranza. Elizabeth cercò di fare un sorriso incoraggiante. «Ho visto bambini guarire da malanni ben più gravi». «Dovrei annullare il ballo» dichiarò angustiata la moglie. «È ridicolo pensare di organizzare un simile evento con nostro figlio malato. Posso annullare tutto, rimandare a dopo la sua guarigione». «No, il ricevimento si deve fare» dichiarò il presidente. «Avete già investito fin troppo tempo e denaro per annullare ora». «Non sarebbe un problema» insistette Mrs Lincoln con voce tesa. «I nostri ospiti capirebbero, ne sono sicura, e se mando un messaggio ai responsabili del banchetto non dovrebbero incontrare nessuna difficoltà a rimandare di una settimana o due». Il presidente sprofondò in un silenzio pensoso per qualche istante, poi propose: «Perché non consultiamo prima il dottor Stone?» Sua moglie si dichiarò d’accordo, così fu mandato a chiamare il medico di famiglia, che non molto tempo dopo si presentò per esaminare il paziente. «Vostro figlio sta nettamente meglio» annunciò il dottor Stone dopo aver verificato il polso del bambino, averne ascoltato la respirazione e avergli rivolto qualche domanda sui sintomi che avvertiva. «C’è ogni ragione di sperare che presto guarisca completamente». «Oh, grazie al cielo!» esclamò con enfasi Mrs Lincoln. «E cosa pensate del ricevimento?» «Non vedo perché non dovrebbe procedere come previsto» rispose il dottore, riponendo i suoi strumenti nella borsa. «Vi assicuro, presidente, signora, che nell’immediato vostro figlio non corre alcun pericolo». Mrs Lincoln giunse le mani come se volesse pregare e ringraziò calorosamente il dottor Stone, ma dopo la sua partenza il breve attimo di vivacità si spense. «Per quanto sia felice delle buone notizie, non ho nessuna voglia di danzare con Willie che sta così male». «Se non vi va di ballare, non ballerà nessuno» replicò il presidente. «Andiamo, mamma. Non saremo lontani. Possiamo venire di sopra a controllare come sta tutte le volte che volete, e sono sicuro che possiamo contare su Mrs Keckley perché lo assista in nostra assenza, vero?» «Certo» rispose Elizabeth. «Resterò anche tutta la notte, se volete». Rassicurata, Mary Lincoln accettò di procedere come convenuto e riprese a seguire l’organizzazione della serata. Anche dopo che Tad si ammalò a sua volta, i Lincoln tennero a mente la diagnosi del dottor Stone e andarono avanti con il programma prestabilito, sperando che i loro bambini si riprendessero alla svelta. La sera del ricevimento, Elizabeth arrivò presto per vestire la sua cliente e la trovò seduta al capezzale di Willie, tesa e pensierosa, con la manina del bambino tra le sue. «La febbre è aumentata da ieri» sussurrò a Elizabeth. «Il dottore insiste nel dire che non corre nessun pericolo, ma io credo che sia peggiorato». Il visetto dolce appariva effettivamente più accaldato di quanto non fosse parso a Elizabeth in precedenza, e il bambino aveva il respiro affannoso. «Come sta Tad?» «Non bene, ma meglio di suo fratello». La first lady sospirò e si alzò, premendosi il dorso della mano sulla fronte. «Meglio che mi vesta per il ballo. E dire che prima lo aspettavo con tanta impazienza...» Mrs Lincoln chiese a una domestica di restare con Willie mentre Elizabeth la aiutava a prepararsi per la serata. Nel suo salottino privato, la sarta aiutò la moglie del presidente a indossare l’abito di raso bianco con lo strascico lungo e le decorazioni nere e bianche, poi le fece una pettinatura con fiori bianchi e neri. Mrs Lincoln indossava altri fiori sul petto, un bouquet da mezzo lutto di mirto crespo in onore della regina Vittoria, vedova da poco. Mr Lincoln giunse per scortare al piano inferiore la moglie prima che questa fosse del tutto pronta, e mentre aspettava che i preparativi fossero ultimati volse le spalle al camino e si mise ad aspettare con le mani conserte dietro la schiena. Aveva un’espressione solenne e, sebbene tenesse lo sguardo fisso sul tappeto, sembrava molto lontano con i pensieri. Quando fu pronta, la first lady si ammirò allo specchio con il lungo strascico che ondeggiava sul pavimento. Il fruscio del raso destò il presidente dalle sue fantasticherie, e guardò la moglie per un attimo prima di fare un sorriso quasi impercettibile. «Accidenti! La nostra gatta ha la coda lunga, stasera». Mrs Lincoln lo guardò con le sopracciglia sollevate ma non fece altri commenti. «Mamma» disse, posando lo sguardo sulle braccia e il collo nudi, «ritengo che se quello strascico coprisse anche il busto, sarebbe meglio». Capitava di rado che Elizabeth non fosse d’accordo con il presidente, ma in quel caso non condivideva la sua opinione. Le spalle e il décolleté splendidi di Mary Lincoln erano il suo punto forte, e la scollatura profonda dell’abito li metteva in risalto. Mrs Lincoln volse le spalle al marito con l’aria offesa, ma poco dopo accettò il suo braccio e scesero insieme per accogliere gli ospiti. Elizabeth tornò nella stanza del bambino malato, dove Willie, madido di sudore, dormiva un sonno leggero e disturbato. Poco dopo udì la banda della Marina che cominciò a suonare nei saloni dove si svolgeva il ricevimento, al piano inferiore, e la musica si librò fin di sopra e lungo i corridoi come sussurri bassi e lontani di anime in pena. Durante tutta la sera Mary Lincoln lasciò spesso gli invitati per andare a controllare come stava il suo adorato figlio, talvolta accompagnata dal marito. Chiedeva con ansia a Elizabeth se c’erano stati cambiamenti, ma ogni volta la sarta rispondeva scrollando il capo. Poco prima della fine del ballo, Willie sembrò avere difficoltà a respirare, ma dopo un’ora particolarmente penosa la respirazione divenne più facile. Non appena gli ospiti se ne andarono, Mrs Lincoln raggiunse Elizabeth al capezzale del bambino e insieme lo vegliarono finché le prime luci dell’alba non fecero capolino oltre la linea dell’orizzonte. «Dovreste riposarvi, Elizabeth» disse la first lady con voce arrochita dalla stanchezza e dalla preoccupazione. «Sto bene, Mrs Lincoln» replicò la sarta con dolcezza. «Perché invece non andate voi a dormire?» «Non servirebbe, non potrei prendere sonno. No, Elizabeth, avete vegliato Willie più di me. Insisto perché andiate a riposare». Elizabeth sapeva che non sarebbe servito a niente discutere. «E va bene, Mrs Lincoln». Si alzò stancamente, inarcando la schiena per alleviare l’indolenzimento. «Dormirò un poco, ma tornerò qui non appena mi sarò svegliata, così potrò darvi il cambio». Mrs Lincoln annuì distrattamente, senza distogliere gli occhi dal figlio che soffriva. Elizabeth trovò il letto che le era stato preparato nell’ala riservata alla servitù, rimase in sottoveste e si sdraiò tirandosi il piumino fin sotto il mento. Dormì un sonno inquieto e si svegliò poco prima di mezzogiorno serbando un vago ricordo di terribili sogni premonitori. Qualcuno gentilmente le aveva lasciato un bricco d’acqua accanto alla bacinella, e dopo essersi lavata in fretta corse giù per dare il cambio a Mrs Lincoln, scoprendo che Willie non era migliorato in sua assenza. Nel corso dei giorni successivi Willie peggiorò inesorabilmente sotto lo sguardo dei genitori, che aspettavano pregando. Il presidente annullò una riunione con i ministri e la moglie una cena di gala per non allontanarsi dal capezzale del bambino. Il miglior amico di Willie, Bud Taft, andò a trovarlo e si addormentò sul pavimento, deciso com’era a non allontanarsi dal compagno di giochi preferito. Elizabeth si prese cura di tutti loro, senza trascurare neppure il piccolo Tad, che non stava male come il fratello ed era stato sistemato in un’altra stanza. Rimaneva anche la notte alla Casa Bianca quando c’era bisogno di lei, e correva a casa sua per riposare e cambiarsi d’abito quando potevano fare a meno dei suoi servigi. Nel frattempo Mrs Lincoln vegliava al capezzale del figlio, ossessionata senza dubbio dal ricordo dei giorni lontani e strazianti di più di dodici anni prima, quando aveva assistito al decesso di suo figlio Eddie. Il 20 febbraio, in una giornata calda e soleggiata, Willie esalò il suo ultimo respiro. Dopo tutte le ore in cui Elizabeth l’aveva vegliato, al momento della sua morte si trovava a casa propria, dove un messo andò subito a chiamarla. Si precipitò immediatamente alla Casa Bianca e chiese di vedere Mrs Lincoln, ma la first lady, inconsolabile e devastata, era a letto. Elizabeth si fermò a vedere come stesse Tad – il bambino aveva la febbre, era addolorato e spaventato – e poi andò ad aiutare a preparare Willie, che fu lavato, vestito e trasferito sul letto della Green Room, e gli coprì amorevolmente il viso con un lenzuolo bianco. Elizabeth lo stava vegliando da sola quando entrò Mr Lincoln, con il viso terreo e smunto, gli occhi rossi e tormentati. La sarta era troppo sconvolta e sofferente per parlargli, così gli fece un cenno rispettoso e si spostò ai piedi del letto per lasciarlo avvicinare. Non aveva mai visto un uomo tanto prostrato dal dolore, e ne aveva visti molti, così tanti da non riuscire neanche a contarli. Mr Lincoln levò il lenzuolo dal viso di suo figlio e lo guardò a lungo teneramente. «Il mio povero bambino, troppo buono per questa terra» mormorò. «Dio l’ha fatto tornare a casa. So che sta meglio in cielo, ma lo amavamo tanto... La sua morte è una tragedia!» Terribili singhiozzi gli impedirono di continuare. Elizabeth ebbe le lacrime agli occhi guardando il padre straziato nascondere il viso tra le mani, mentre il corpo angoloso era scosso dai singulti. Avrebbe voluto più di ogni altra cosa offrirgli parole di conforto, ma sapeva che nessuna frase sarebbe stata adeguata; non poté far altro che serbare il silenzio. Più tardi Elizabeth tenne compagnia a Mrs Lincoln nella sua stanza, dove le tende erano state tirate e gli specchi coperti. Tornò da lei l’indomani e la trovò in uno stato di prostrazione preoccupante. Si lamentava, piangeva, era inconsolabile, distrutta dal dolore, incapace di alzarsi dal letto e perfino di occuparsi di Tad, ancora convalescente. Mentre la Casa Bianca veniva addobbata di crespo nero in segno di lutto, la first lady fu vittima di crisi parossistiche, con grida e pianti violenti che spaventarono Tad e preoccuparono la sarta, incapace di aiutarla. Il dottor Stone prescrisse il laudano, ma quando il torpore indotto dal farmaco si dissipava, Mrs Lincoln sembrava stare peggio di prima. Elizabeth aveva assistito molte persone malate, ma non si era mai trovata di fronte un caso di isteria come quello della first lady, e non sapeva in che modo esserle d’aiuto. Con suo grande sollievo il presidente non ci mise molto a capire che la sarta non sapeva come muoversi, e prese disposizioni affinché Rebecca Pomroy, un’infermiera che lavorava in un ospedale militare, fosse trasferita alla Casa Bianca per occuparsi di Mrs Lincoln e di Tad. Grazie alle cure dell’infermiera Pomroy, Mrs Lincoln trovò la lucidità necessaria per scrivere a Mrs Taft, domandandole di lasciare a casa i bambini per il funerale perché vedere gli amici con cui il figlio aveva trascorso tanti momenti felici l’avrebbe devastata. Elizabeth non raccontò mai alla first lady che suo marito aveva permesso segretamente a Bud di andare alla Casa Bianca per vedere un’ultima volta Willie prima che fosse trasferito nella bara. Poco dopo Mrs Lincoln si alzò dal letto per andare a dirgli addio, in privato, insieme al marito e ai due figli che le restavano, nell’East Room, dove si sarebbe svolta la cerimonia più tardi, quello stesso giorno. Mary Lincoln stava troppo male per essere presente alla celebrazione, così si ritirò nelle sue stanze mentre membri del Congresso, segretari di gabinetto, diplomatici, generali e dignitari vari sfilarono per rendere omaggio e porgere le condoglianze. Una settimana dopo la morte di Willie il presidente si chiuse nella Green Room per stare da solo con i suoi pensieri, ricordare il figlio beneamato, pregare. Nelle settimane seguenti, ogni giovedì osservò quel rituale funebre privato, che sembrava dargli sollievo. Tad migliorò giorno dopo giorno sotto gli occhi attenti dell’infermiera Pomroy, ma siccome accettava di prendere le medicine solo da suo padre, il presidente doveva spesso assentarsi dalle riunioni per somministrare le dosi necessarie. Robert pianse la morte del fratellino ma si sforzò di mantenere un atteggiamento coraggioso e virile, e quel tentativo sembrò effettivamente dargli forza. Solo lo strazio di Mrs Lincoln non sembrava lenirsi col tempo. Passava da momenti di dolore paralizzante a una frenesia disperata, e gli scoppi improvvisi di pianto spaventavano Tad e allarmavano tutti gli occupanti della Casa Bianca. Elizabeth era presente il giorno in cui Mr Lincoln rivelò inavvertitamente di temere che la moglie non si riprendesse più da quelle crisi di nervi. La first lady era in preda a una delle sue crisi di pianto disperato; Mr Lincoln la prese dolcemente per un braccio, l’accompagnò alla finestra e indicò con un gesto solenne il St Elizabeths Hospital in lontananza. «Mamma» esordì, «vedete quel grande palazzo bianco, su quella collina laggiù?» Mrs Lincoln annuì con gli occhi sgranati. Tutti a Washington conoscevano l’ospedale psichiatrico, un edificio celebre e imponente. «Cercate di controllare il vostro dolore» continuò il presidente imperturbabile «o impazzirete e ci toccherà mandarvi là». Elizabeth soffocò un grido d’orrore. L’ipotesi di un simile destino per Mrs Lincoln era troppo terribile da concepire, e non poteva credere che il presidente parlasse in quel modo alla moglie sofferente. Ma nei giorni seguenti parve che quell’avvertimento la inducesse a riprendere il controllo dei nervi. Robert era così preoccupato dalla lentezza dei progressi materni che implorò la zia Elizabeth Edwards di tornare alla Casa Bianca, sperando che riuscisse a confortarla, sebbene le due sorelle avessero litigato l’autunno precedente. Al suo arrivo Mrs Edwards trovò la sorella minore a letto, incapace di reagire alla disperazione, e il nipote Tad in lacrime per la morte del fratello. La sarta si rese conto che la presenza di Mrs Edwards portò un immediato sollievo a tutta la famiglia. Fu lei che riuscì a persuadere la sorella ad alzarsi dal letto, vestirsi, e infine andare in chiesa per partecipare alle funzioni. Nonostante i lievi miglioramenti, però, la first lady era spesso sopraffatta dal dolore e trascorse gran parte del mese successivo asserragliata dentro la Casa Bianca. Elizabeth era spesso con lei, le confezionava il guardaroba per il lutto e le offriva tutto il sostegno di cui era capace. Una volta in cui Mrs Edwards non c’era, la moglie del presidente disse a un tratto: «Se Willie fosse vissuto, sarebbe stato la speranza e il bastone della mia vecchiaia». Aveva la voce bassa e lo sguardo assente. «Ma la Provvidenza non ha voluto risparmiarlo». La sarta, avendo a sua volta perso un figlio, la capiva benissimo. Aveva sperato che George facesse una carriera brillante per contare su di lui negli anni della vecchiaia, ma la Provvidenza non aveva risparmiato nemmeno lui. Con la stessa voce assente Mrs Lincoln aggiunse: «Sono convinta che la morte di Willie sia la punizione per i miei peccati, per la mia vanità e per aver assecondato le mie passioni». «Cosa?» esclamò Elizabeth. «Non parlerete sul serio!» «Ha cominciato a stare male la sera del mio grandioso ricevimento» ribadì la first lady amaramente. «Non è forse un chiaro segno del giudizio di Dio?» «Oh, no, Mrs Lincoln». Elizabeth scosse il capo. «No. Dio non è così crudele». «Davvero?» Mary Lincoln spinse lo sguardo fuori dalla finestra, ma Elizabeth non vide dove lo posò. Sul campanile della chiesa? Sugli ospedali pieni di soldati feriti? Sul St Elizabeths sull’altra sponda del fiume Anacostia? «Se il Suo castigo è giusto, chi siamo noi per considerarlo crudele?» 6. Marzo-aprile 1862 Nelle settimane che seguirono la morte di Willie, Mrs Lincoln lottò per affrontare e superare ogni singolo giorno. Evitava le apparizioni in pubblico e restava aggrappata alla sorella, Mrs Edwards, che spesso la sostituiva quando non si sentiva di ricevere visite. Evitava di entrare nella Green Room, dove era stata allestita la camera ardente del figlio, e non invitò mai più i due piccoli Taft alla Casa Bianca. Serbò i fiori che erano stati deposti sulla bara il giorno del funerale e la commovente orazione funebre del poeta Nathaniel Parker Willis, ma regalò tutti i suoi giocattoli. Non riusciva a sopportare qualunque cosa glielo ricordasse, eppure il figlio era sempre nei suoi pensieri. Anche Mr Lincoln soffriva per la morte di Willie, ma non poteva permettersi il lusso di isolarsi dal mondo. Al Congresso i dissidi non mancavano, la questione degli schiavi non era ancora stata risolta e il conflitto continuava. I confederati avevano rubato la fregata a vapore Merrimack dall’arsenale di Norfolk, avevano eliminato la parte superiore dello scafo, l’avevano rivestita di una corazza di ferro e ribattezzata Virginia prima di mandarla sul fiume James a sbaragliare la flotta dell’Unione. Il giorno dopo l’Unione si vendicò ricorrendo alla propria corazzata, la Monitor, che con la forma insolita del ponte e la torretta rotante stupì tutti coloro che assistevano alla battaglia dalle altre imbarcazioni di entrambi gli schieramenti o dalle due sponde. Nessuna delle due corazzate inflisse danni ingenti all’altra, ma il Nord riuscì a mantenere il blocco su Norfolk e Richmond, e a rivendicare quindi la vittoria. Qualche settimana dopo, all’inizio di aprile, l’Unione sconfisse gli stati confederati a Shiloh, in Tennessee. Fu la battaglia più sanguinosa di tutta la guerra fino a quel momento, con più di tredicimila uomini uccisi, feriti o dispersi per l’Unione e undicimila per il Sud. Tra i soldati che persero la vita vi fu il fratellastro della first lady, Samuel B. Todd, ufficiale che combatteva con il Ventiquattresimo Reggimento Louisiana. La sua morte ricordò ai detrattori della first lady dei suoi legami familiari con i secessionisti e risollevò le vecchie e sterili questioni sulla sua lealtà; secondo Elizabeth un gesto mostruoso in un momento simile, che denotava una grave mancanza di rispetto per il suo lutto. Dopo la faticosa vittoria, il generale Ulysses S. Grant fu criticato dalla stampa e molti esigevano la sua rimozione, ma il presidente Lincoln replicò: «Non posso fare a meno di quest’uomo, perché combatte». Anche il presidente Lincoln combatteva, su altri fronti. Le recenti conferenze contro la schiavitù alla Smithsonian Institution avevano suscitato un coro di richieste di emancipazione da parte degli abolizionisti e delle fazioni repubblicane più radicali al Congresso. Alcuni degli ufficiali militari avevano preso l’iniziativa di liberare gli schiavi in particolari circostanze, e non sempre con l’avallo del presidente. Da più di un anno gli abolizionisti sostenevano che l’Unione non poteva sperare di vincere la guerra se non avesse privato la Confederazione della sua forza lavoro emancipando gli schiavi. Frederick Douglass, ex schiavo e strenuo difensore dei neri che Elizabeth ammirava molto, contribuì alla causa scrivendo sul suo giornale: «Fermate la zappa in mano ai negri e soffocherete la ribellione sul nascere». Nel luglio 1861, il generale Benjamin Butler aveva messo a lavorare tre schiavi fuggiti a Fort Monroe, dichiarandoli “contrabbando di guerra” e negando di doverli restituire ai proprietari in base alla Fugitive Slave Law, la legge che regolamentava le sanzioni per gli schiavi fuggiaschi, perché venivano da uno stato che aveva abbandonato l’Unione. Il Congresso confermò la legittimità della decisione del generale Butler; da quel momento in poi altri ex schiavi “di contrabbando” ricevettero proposte di lavoro per contribuire allo sforzo bellico, e il loro numero aumentò rapidamente. Alla fine di agosto, e senza l’autorizzazione del presidente, il maggior generale John C. Frémont, comandante della Divisione Ovest dell’esercito, proclamò la liberazione degli schiavi della Confederazione nello stato del Missouri. Il presidente si infuriò quando apprese ciò che aveva fatto Frémont, e gli ordinò di revocare la decisione; quando Frémont rifiutò, Lincoln lo fece di persona, suscitando le ire degli abolizionisti del Nord e attirandosi molte critiche. L’evidente riluttanza di Lincoln a liberare gli schiavi stupiva e deludeva Elizabeth, ma più lavorava alla Casa Bianca e più lo conosceva, più capiva che desiderava abolire la schiavitù, ma con modi e tempi suoi. Il presidente, la sarta l’aveva capito, temeva che un’emancipazione immediata e totale avrebbe indotto gli stati schiavisti confinanti con il Nord a lasciare l’Unione per legarsi alla Confederazione; Elizabeth non gli invidiava quelle preoccupazioni. Ma all’inizio della primavera del 1862 gli atteggiamenti erano cambiati e si erano presentate delle opportunità. Incoraggiato dalle richieste sempre più pressanti dei cittadini, e ispirato forse dai rapporti dei suoi comandanti di campo che usavano gli ex schiavi fuggiaschi come uomini di fatica, cuochi o infermieri, il presidente Lincoln dovette decidere che era il momento di sostenere la causa abolizionista. Un mattino ai primi di marzo convocò alla Casa Bianca il senatore del Massachusetts Charles Sumner per leggergli la prima versione di una legge che avrebbe consentito ai singoli stati di procedere all’emancipazione all’interno del proprio territorio. I proprietari di schiavi sarebbero stati indennizzati per la perdita economica con fondi federali, e gli schiavi liberati avrebbero avuto l’opportunità di emigrare verso un certo numero di colonie in Africa o in America Centrale. In passato il senatore abolizionista aveva criticato quelle forme di compensazione, ma riconoscendo l’opportunità di un cambiamento reale e duraturo che la legge produceva, decise di appoggiarle. Nel giro di poche ore lui e il suo collega, il senatore del Massachusetts Henry Wilson, sottoposero al Congresso un progetto di legge che prevedeva l’emancipazione degli schiavi nel distretto di Columbia. Al cospetto dei senatori Henry Wilson parlò con grande eloquenza dei contributi che la popolazione nera libera aveva dato al distretto, del modo in cui si erano elevati e avevano creato scuole, chiese, imprese commerciali e organizzazioni caritatevoli. Tutti quei risultati erano stati realizzati nonostante le forme di discriminazione ingiuste che ne avevano limitato la vita e la libertà. Pagavano tasse per scuole che i loro figli non avevano il diritto di frequentare, un’ingiustizia terribile. Era ora che diventassero del tutto liberi, e nessun cittadino onesto aveva ragione di temere che gli schiavi emancipati non avrebbero seguito il loro illustre esempio, diventando membri operosi della società una volta liberi. Non tutti erano d’accordo con il senatore Wilson, naturalmente, o con un altro importante sostenitore della legge, Thaddeus Stevens, il leader della fazione radicale del partito repubblicano e l’avvocato che aveva rappresentato Emma e sua madre nella causa legale che aveva garantito loro la libertà tanto attesa. La corrente che più si opponeva al progetto era capeggiata da Clement Vallandigham dell’Ohio, dell’ala più estrema del partito democratico, e il dibattito durò diversi giorni. Walker Lewis e alcuni altri esponenti in vista della comunità nera di Washington si recarono ogni giorno al Senato, nella zona destinata al pubblico, per ascoltare i diversi interventi, suscitando il fastidio e anche la preoccupazione di alcuni senatori, in particolare Garret Davis del Kentucky, che interruppe un discorso violentemente contrario alla proposta di legge per protestare con astio: «Immagino che tra qualche mese affolleranno la tribuna al punto da cacciare le signore bianche!» Walker e i suoi compagni non si lasciarono intimidire e continuarono a seguire i dibattiti per poi aggiornare il resto della comunità di colore, che aspettava con grande impazienza e speranza che la legge passasse. I giornalisti seguivano la vicenda in veste più ufficiale; il National Republican elogiava il senatore Wilson ma l’Evening Star, quotidiano di Washington, avvertiva che il progetto della legge sull’emancipazione consisteva nell’imporre l’uguaglianza dei neri all’uomo bianco. A New York Horace Greeley, che per anni aveva criticato il presidente Lincoln dalle pagine del Tribune, fu talmente entusiasta per la proposta che ringraziò l’Onnipotente di avere reso Lincoln tanto saggio. Lincoln non commentò l’appoggio di Greeley in presenza di Elizabeth, ma la first lady non fece neppure lo sforzo di nascondere la propria diffidenza. «Oggi copre di complimenti mio marito» disse, agitando una mano con un gesto insofferente. «Domani potrebbe benissimo ricominciare con le critiche». A Elizabeth sembrava che a Washington la popolazione bianca non condividesse l’opinione di Mr Greeley sul presidente. In lettere e petizioni a membri del Congresso, direttori di giornali e altre persone influenti, molti domandavano che la legge venisse respinta. Chi possedeva schiavi era contrario al progetto per motivi superflui da spiegare, ma anche alcuni cittadini che non avevano mai avuto schiavi denunciavano la legge, perché secondo loro l’emancipazione avrebbe spalancato le porte a un’ondata di neri liberi che avrebbero rubato il lavoro ai bianchi; gli schiavi fuggiaschi si sarebbero rifugiati a Washington, diventando un peso per la comunità. In tempo di guerra, il governo non poteva permettersi di indennizzare i proprietari di schiavi del distretto con somme fino a trecento dollari per schiavo, come prevedeva la legge; sarebbe stato più prudente, più oculato, e complessivamente migliore, lasciare che fossero loro, per il momento, a occuparsi del mantenimento degli uomini di loro proprietà piuttosto che se lo accollasse lo stato. Gli oppositori del progetto potevano protestare e lamentarsi quanto volevano, ma il governo federale non aveva bisogno della loro approvazione per sottoporre la proposta al voto. Il 3 aprile il Senato approvò il provvedimento con ventinove voti a favore e quattordici contrari, e qualche giorno dopo anche la Camera dei rappresentanti si pronunciò a favore, con novantatré voti contro ventinove. A quel punto il presidente Lincoln aspettò quattro giorni, durante i quali ascoltò con rispetto gli argomenti dibattuti appassionatamente dai due schieramenti, e il 16 aprile, una bella giornata di primavera, promulgò la legge. Con qualche svolazzo di penna, aveva abolito per sempre la schiavitù nella capitale degli Stati Uniti. I residenti neri di Washington reagirono con slanci di gioia. In tutti i quartieri abitati da gente di colore si moltiplicarono le grida giubilanti e gli inni di ringraziamento: gli esponenti di rilievo della comunità, sapendo che ogni loro azione era osservata e giudicata, esortarono le persone a manifestare in modo contenuto e senza esagerare. Una tale discrezione veniva naturale a Elizabeth, ma perfino lei rise, esultò e si mise addirittura a ballare con Virginia in salotto quando apprese la notizia. «Se avessi saputo cosa ci aspettava, avrei risparmiato il mio denaro» commentò un altro residente della pensione, un vecchio calzolaio che si era comprato la libertà da poco. La battuta fu così comica che tutti quelli che erano a portata di orecchio scoppiarono a ridere, un suono squillante pieno di felicità, che faceva eco ad altri festeggiamenti in giro per la città. La fiducia nel presidente era stata rinnovata, così come la volontà di assistere all’abolizione della schiavitù ovunque, per tutti, per sempre. La domenica Elizabeth si unì agli altri fedeli alla Union Bethel Church, dove chi era nato libero, si era affrancato o aveva appena conquistato la libertà grazie alla legge ringraziò il Signore e celebrò l’avvenimento. La sarta apprezzò la predica del pastore, il quale pronunciò parole commosse di giubilo e di gratitudine per Dio, che li aveva liberati dalle catene. Eppure serpeggiava tra i fedeli un sentimento più amaro: non dimenticavano i moltissimi altri della loro razza che non avevano goduto della nuova legge, e capivano che la libertà comportava non poche responsabilità. «Dobbiamo impegnarci» dichiarò il pastore, come altri esponenti della Chiesa stavano indubbiamente facendo nelle altre chiese nere di tutta Washington «a ricorrere all’operosità, alla forza di carattere e alla dirittura morale per dimostrarci degni dello splendido privilegio appena ricevuto. Siamo sempre stati un popolo rispettoso della legge e obbediente, e anche in futuro dobbiamo tentare di vivere in modo tanto giusto ed esemplare da far dimenticare un giorno a chi oggi è deluso dalla promulgazione della legge del perché vi si fosse opposto». Le speranze di Elizabeth nei confronti dei cittadini bianchi di Washington, indignati dagli eventi, erano meno ambiziose. Non si augurava che dimenticassero addirittura le loro obiezioni, ma sperava almeno che accettassero l’emancipazione come un dato di fatto, e che dimostrassero una maggiore tolleranza per la gente nera che, come loro, si considerava a casa propria in quella città. Il giorno dopo la promulgazione della legge da parte del presidente, Elizabeth cuciva nella sua stanza, con la finestra spalancata per far entrare l’aria fresca della primavera e il cinguettio degli uccelli, quando qualcuno bussò alla sua porta. In corridoio si trovava una donna bianca di una trentina d’anni con i capelli scuri, vestita con un abito semplice di lana marrone. «Buon pomeriggio» la salutò la sarta. «Posso aiutarvi?» La nuova arrivata le rivolse uno sguardo speranzoso. «Siete Elizabeth Keckley, la sarta specializzata in mantua?» «Sì». «Piacere di conoscervi». La donna tese la mano ed Elizabeth gliela strinse. «Mi chiamo Mary Ames. Sono una giornalista». «Oh, Signore!» esclamò la sarta senza riflettere, perché la sorpresa l’aveva privata per un attimo del suo abituale autocontrollo. «Volevo dire... Perdonatemi, Mrs Ames. Il piacere è mio». «Va tutto bene, non fa niente». La donna lanciò uno sguardo oltre le spalle di Elizabeth, all’interno della stanza, e la sarta fu felice che Mrs Lincoln non avesse scelto proprio quel giorno per farle una visita a sorpresa per parlare di un nuovo abito. «Possiamo scambiare due chiacchiere?» «Mi dispiace molto, ma se siete a caccia di informazioni sul presidente e sua moglie...» «Oh, no, no, non è assolutamente questo il mio scopo» si affrettò a precisare Mrs Ames. «Voglio scrivere un articolo, ma il soggetto siete voi, non i Lincoln». «Perché mai vorreste parlare di me?» La curiosità indusse Elizabeth a spalancare la porta. «Chi mai vorrebbe leggere un articolo su di me?» «Per via della nuova legge sull’emancipazione, naturalmente. Tutti si chiedono quali saranno le conseguenze, per Washington e per i nuovi neri liberi. Vorrei scrivere un articolo per descrivere come se la cavano alcuni ex schiavi che hanno fatto fortuna da quando sono giunti in città». Fece un sorriso per ingraziarsela. «E chi ha avuto un successo più grande di quello della richiestissima sarta Elizabeth Keckley? Passare da una capanna di schiavi alla Casa Bianca è un cambiamento notevole». «Molto gentile da parte vostra». La sarta fece un sorrisetto incerto. «Ho sempre cercato di darmi da fare, e ho avuto la fortuna di incappare in clienti generose che mi hanno raccomandata alle loro conoscenti». «Oh, siete troppo modesta» protestò Mrs Ames. «Avete saputo imporvi grazie al talento e alla vostra reputazione. Dovete sapere quanto vi stimino le dame dell’alta società di Washington. Quando ho chiesto in giro di suggerirmi per un’intervista il nome di qualche ex schiavo che avesse fatto carriera, il vostro nome era quello più ricorrente». La sarta si esortò mentalmente a non cedere alle lusinghe, ma la sua fermezza vacillò. «Se accetto di farmi intervistare, dev’essere chiaro che non intendo diffondere pettegolezzi sulle mie clienti». «Certo». Un’ombra di disappunto oscurò per un istante l’espressione cordiale di Mrs Ames, ma si dissipò subito. «La discrezione è essenziale tra una sarta e la sua cliente, che viva alla Casa Bianca o dietro l’angolo». «Sono contenta che lo comprendiate». «Non intendo pubblicare un articolo scandalistico, Mrs Keckley» puntualizzò Mrs Ames, poi tacque per riflettere qualche istante. «Anche se il mio direttore lo preferirebbe. Dopotutto, gli scandali fanno vendere. Ma lo stesso vale per gli articoli stimolanti e capaci di ispirare i lettori, come quello che vorrei scrivere io. La vostra storia spingerà gli ex schiavi appena liberati a mettere in pratica frugalità, operosità e moralità per arrivare ad affermarsi proprio come avete fatto voi». Quindi aggiunse: «Può anche servire a rassicurare i cittadini bianchi di Washington sul fatto che non hanno nulla da temere. I cambiamenti repentini a volte fanno paura, sapete, e l’emancipazione comporta cambiamenti profondi». Elizabeth esitava ancora. «Immagino che non ci sarebbe nulla di male a parlarvi. L’articolo potrebbe perfino fare del bene». «Assolutamente sì» dichiarò Mrs Ames, mentre la padrona di casa la invitava a entrare. Elizabeth preparò il tè e si misero a parlare in salotto. All’inizio l’intervistata era un po’ a disagio, si esprimeva con mille riserve, chiedendosi come le sue clienti – Mrs Lincoln in particolare – avrebbero reagito a ogni sua parola. Alla seconda tazza di tè si rilassò rievocando i giorni della schiavitù, George, e la sua incredibile nuova vita a Washington, e si ritrovò a rivelare più di quanto non avesse voluto sulle sofferenze del passato. Solo quando la teiera si fu raffreddata e Mrs Ames ebbe riempito diverse pagine di appunti Elizabeth si chiese se avesse parlato troppo. «Quando sarà pubblicato l’articolo?» domandò la sarta accompagnando la giornalista alla porta. «Forse già domani, se mi impegno» replicò allegramente Mrs Ames. Elizabeth aveva il batticuore per il nervosismo quando la congedò. Si era immaginata di avere più tempo per... ecco, non esattamente per avvertire Mrs Lincoln, ma per informarla che sarebbe apparso quell’articolo, e per rassicurarla sul fatto che non aveva raccontato indiscrezioni a proposito della Casa Bianca. Non pensava di aver detto nulla di offensivo, ma talvolta era difficile immaginare come avrebbe reagito la first lady. Con un po’ di fortuna, sarebbe riuscita a leggere l’articolo prima della moglie del presidente... o forse Mrs Lincoln non l’avrebbe letto per niente. Il giorno dopo una delle vicine di Elizabeth nella pensione dei Lewis bussò alla sua porta e le consegnò l’ultima edizione dell’Evening Post. «So che dovete essere voi la “Lizzie” dell’articolo» commentò Miss Brown con gli occhi che le luccicavano per l’entusiasmo. «Congratulazioni, mia cara». «Grazie» disse Elizabeth prendendo il giornale. Chiacchierarono per qualche minuto, ma non appena Miss Brown se ne fu andata Elizabeth chiuse la porta, si lasciò sprofondare in poltrona e sollevò il giornale, ansiosa di leggere ciò che aveva scritto Mrs Ames. Trasse un respiro profondo e cominciò fissando subito lo sguardo sul titolo, Vite degli ex schiavi, e sul primo sottotitolo, “La storia di una ragazzina in catene”. La sarta scorse l’articolo su una bambina di nove anni giunta dal Congo e si fermò quando la colonna si interrompeva, subito prima di un altro sottotitolo, “Una donna nera di classe”. Si fece forza e continuò. Lizzie *** è una donna straordinaria ed elegante. È scura di pelle, ma ha lineamenti perfettamente regolari, occhi scuri e decisi, capelli neri dritti e lucidi. Un sorriso un po’ triste ma dolcissimo rende il suo viso subito simpatico a chi la guarda. È un viso forte, il suo, che denota intelligenza e profondità di sentimenti, con tratti che lasciano intuire una grande bellezza ora offuscata dai torti subiti e dal dolore. L’inizio non è male, si disse Elizabeth. Il suo nome era scritto con una grafia diversa da quella che usava lei, ma il direttore aveva rimosso il cognome per proteggerne l’anonimato, e forse anche il nome scritto in modo diverso serviva a quello. Era piacevole scoprire che conservava ancora tracce di bellezza alla sua età, pensò divertita riportando lo sguardo sul giornale. Il padre di Lizzie era un gentiluomo del Sud, e nelle vene di sua madre scorreva il miglior sangue della Virginia. Non posso raccontare i torti da lei subiti durante l’infanzia e la prima giovinezza; se ci provassi le mani si rifiuterebbero di scrivere inorridite, e il cuore indignato soffocherebbe le parole che mi verrebbero spontanee. Da ragazza fu venduta a una famiglia che la portò con sé in una grande città del Nordovest. Per anni il “signore”, la “signora” e i numerosi figli furono accuditi da questa giovane schiava che lavorò sodo per loro. Il grande talento di Lizzie e il suo gusto indubbio la trasformarono nella sarta più in voga in quella grande città. Guadagnò migliaia di dollari, che confluirono nelle borse della famiglia del suo padrone. Le ragazze della famiglia frequentavano la buona società con indosso gli abiti meravigliosi confezionati dalla giovane schiava che, tre volte più intelligente di loro e quasi altrettanto bella, aveva trascorso settimane e mesi chiusa in una stanza, in casa, consacrando al cucito ogni istante. Elizabeth cominciò ad avvertire una certa apprensione. Non aveva mai chiamato Armistead Burwell padre; quel titolo lo aveva sempre riservato al fedele marito di sua madre, George Hobbs, che aveva amato profondamente. Né aveva mai definito «gentiluomo» il colonnello Burwell; tale espressione usciva dritta dritta dalla penna di Mrs Ames. Ma non era quello il peggio. Non aveva mai affermato di essere «tre volte più intelligente» delle figlie dei suoi padroni. Non cucivano bene quanto lei, ma a essere sinceri ben poche donne avrebbero saputo tenerle testa con ago e filo. Erano ragazze intelligenti e argute, e lei provava affetto nei loro confronti, sebbene una certa tensione nei loro rapporti avesse sempre impedito la nascita di un rapporto d’amicizia vero e proprio. Cosa diavolo avrebbero pensato di lei se avessero creduto a quell’articolo in cui Elizabeth vantava la propria superiorità intellettuale? Poteva solo sperare che la frattura esistente nella nazione avrebbe impedito al giornale di finire nelle loro mani; oppure, se lo avessero letto, si augurava capissero che la loro ex schiava non aveva mai detto una cosa del genere ma era stata travisata dalla giornalista. L’articolo proseguiva con la descrizione delle tappe del successo di Elizabeth come sarta in quella «grande città del Nordovest», di come avesse acquistato la libertà, di come suo figlio fosse morto sul campo di battaglia indossando l’uniforme dell’Unione e portando con sé «l’ultima speranza terrena e l’ultimo conforto per il cuore di sua madre», e di come lei avesse «voltato le spalle all’Ovest, e fosse giunta qui, stanca e demoralizzata, per ricominciare da capo». Elizabeth reagì con una smorfia infastidita ad alcuni particolari sbagliati ed errori cronologici, ma nel complesso Mrs Ames aveva descritto abbastanza fedelmente le sue esperienze. Qualche piccola inesattezza poteva essere perdonata. L’articolo continuava elogiando i suoi successi da quando era giunta a Washington. È stata Lizzie a confezionare i meravigliosi abiti di Mrs Lincoln, la cui eleganza è stata ampiamente celebrata durante l’ultima stagione invernale. È stata lei a vestire la first lady per tutte le occasioni importanti. Carrozze lussuose attendono alla sua porta, mentre le altere proprietarie si sottopongono, docili come agnellini, al giudizio di Lizzie che dice loro cosa indossare. Lizzie è un’artista e ha il dono di rendere belle le donne, e nessuna si sognerebbe di mettere in dubbio i suoi consigli. Così lei dimentica i suoi dolori, si tuffa nel lavoro con ogni nuova cliente, come se vestirla fosse l’obiettivo più importante della sua esistenza. Ma di fronte a colei che le ha teso la mano come a una sorella è scoppiata in lacrime affermando: «Sono sola al mondo. Non ho più nulla per cui vivere. Cerco di lasciarmi assorbire da queste attività, ma non ci riesco». «Oh, mio Dio» mormorò Elizabeth rivolgendosi alla stanza vuota. Non le dava fastidio essere definita artista o genio, ma dubitava che le sue clienti sarebbero state felici di essere definite «altere», «docili come agnellini» e obbedienti a ogni suo ordine. La conclusione del paragrafo, poi, la lasciò del tutto sconcertata. All’inizio non capiva chi fosse la «donna che le aveva teso la mano come a una sorella»: forse Mrs Le Bourgois, che aveva organizzato l’intervento delle dame di Saint Louis in suo favore per aiutarla a comprarsi la libertà? Mrs Lincoln, forse? Poi intuì che la giornalista parlava di sé, rivendicando un ruolo di gran lunga troppo importante, giacché si conoscevano appena. Era incredibile anche apprendere che aveva pianto durante l’intervista, perché Elizabeth non aveva versato una sola lacrima. Poteva avere rivelato di vivere da sola, ma mai si era lagnata per il fatto di essere sola al mondo, né avrebbe mai affermato di non avere nulla per cui vivere. Aveva il suo lavoro, gli amici, la libertà, la fede: insomma, non si sarebbe mai abbandonata alla disperazione. Com’era imbarazzante pensare che ora amici e clienti l’avrebbero creduta in quelle condizioni... perché naturalmente l’avrebbero riconosciuta subito, così come aveva fatto Miss Brown. Cos’era venuto in mente a Mrs Ames di inventare frasi tanto sentimentali e di attribuirgliele? L’articolo proseguiva descrivendo l’abitazione di Elizabeth, anche se per fortuna evitava di precisare l’indirizzo esatto o di indicare che viveva presso i Lewis. Per ultima una frase che aveva la pretesa di fornire un giudizio drammatico e definivo sul soggetto: «Donna riflessiva e raffinata, dai sentimenti profondi e dalle aspirazioni elevate, si erge sola nella sua condizione di donna, sola nell’universo». Perché Mrs Ames voleva a tutti costi enfatizzare la sua solitudine? Elizabeth non era senza amici, senza risorse, abbandonata da tutti. Aveva perso suo figlio, ma in quello condivideva il destino di tante altre madri nel terribile periodo della guerra. Aveva molti amici. Godeva della protezione di Mrs Lincoln e di altre grandi dame a Washington. Non capiva cos’avesse detto o fatto per dare alla giornalista quell’impressione di solitudine profonda. «Se si vuole scrivere della vita di un’altra persona» sentenziò ad alta voce, alzandosi dalla poltrona con il giornale ancora stretto in mano «bisognerebbe attenersi sempre alla verità. Tutto il resto è solo uno spreco di carta, inchiostro e parole». Avrebbe dovuto gettar via il giornale e dimenticare tutta quella storia, ma un vago senso di orgoglio o di vanità la indusse a ripiegarlo con cura e a metterlo da parte nello stesso baule dove conservava i ritagli degli abiti che confezionava per Mrs Lincoln, gli scampoli troppo piccoli per essere usati che la first lady le permetteva generosamente di tenere. A un tratto Elizabeth si rese conto che l’articolo avrebbe potuto essere di gran lunga peggiore. Nonostante gli errori e le invenzioni, Mrs Ames non aveva scritto nulla di offensivo nei confronti di Mrs Lincoln, elogiandone anzi lo stile e l’eleganza. Questa era una fortuna non da poco, e chiudendo il baule la sarta si concesse un respiro di sollievo e decise che in futuro avrebbe evitato di parlare con i giornalisti. Non avrebbe tentato la sorte rischiando una seconda volta imbarazzo e scandali sulla carta stampata. 7. Maggio-ottobre 1862 In maggio, anche se soffriva ancora profondamente per la sua perdita, Mrs Lincoln fece uno sforzo per riprendere le vecchie abitudini e assolvere ai suoi doveri. Si costrinse a passeggiare nei giardini della Casa Bianca con le amiche che venivano a trovarla e a fare dei giri in carrozza. Inviò mazzi di fiori colti nella serra a conoscenti e dignitari importanti, e affidò all’infermiera Pomroy i manicaretti provenienti dalle cucine della Casa Bianca perché li distribuisse nelle corsie dell’ospedale militare. I figli che le restavano, Tad e Robert, quest’ultimo tornato a casa dall’università per l’estate, le fornirono la distrazione più efficace dal dolore. Per settimane aveva accennato al fatto che aria fresca e un cambiamento di panorama le avrebbero fatto bene, così Elizabeth non fu stupita quando Mrs Lincoln annunciò che a metà giugno tutta la famiglia si sarebbe stabilita nella residenza estiva. L’Anderson Cottage, raccontò alla sua sarta, era un edificio di due piani con tanto di timpano e stucchi situato sulla tenuta di duecentoquaranta acri del Soldiers’ Home, un sanatorio riservato alla convalescenza dei veterani feriti. Si trovava circa tre chilometri a nord della città, ed era un rifugio fresco, circondato dai boschi, isolato in cima a una collina, abbastanza distante dal Campidoglio e dalla Casa Bianca da poter essere un luogo di villeggiatura dove concedersi un po’ di riposo, ma abbastanza vicino da consentire al presidente di andare e venire in caso di bisogno. Sebbene Mr Lincoln tornasse in città quasi ogni giorno, la first lady e i figli non si mossero dal cottage, ed Elizabeth vide ben poco la moglie del presidente tra la fine della primavera e l’estate. Anche se molte altre signore agiate lasciavano Washington per sfuggire al caldo, agli insetti, alle malattie e ai fastidi visivi, olfattivi e sonori di una città invasa da migliaia di soldati malati o feriti, un numero sufficiente di clienti rimase a casa, dando abbastanza lavoro a Elizabeth che così si tenne occupata in assenza di Mary Lincoln. Certe volte anche lei avrebbe voluto fuggire in un luogo fresco per l’estate, ma faceva in modo di sfruttare i momenti meno caldi, il mattino presto e la sera, per passeggiare, assistere a delle conferenze o uscire con i Lewis. Una sera lei e Virginia stavano tornando a casa dal concerto di un coro alla Presbyterian Church in Fifteenth Street quando udirono una banda che suonava una musichetta allegra a pochi isolati di distanza. Incuriosite, rallentarono il passo per ascoltare. Si scambiarono un’occhiata ed Elizabeth espresse ad alta voce quello che entrambe stavano pensando: «Vuoi che andiamo a vedere di cosa si tratta?» Virginia acconsentì subito e seguirono la bella musica fino a casa di Mrs Farnham. Il giardino era rischiarato da una moltitudine di lanterne, e coppie bianche passeggiavano chiacchierando, godendosi la bella serata, i bicchieri di punch e la musica gradevole. Virginia prese a braccetto Elizabeth e, con un cenno, le indicò il maggiordomo nero che faceva la guardia alla porta. Come di tacito accordo attraversarono la strada e gli si avvicinarono. «Buonasera» lo salutò Elizabeth educatamente. «Potreste soddisfare la nostra curiosità? Cosa sta festeggiando Mrs Farnham?» «Si tratta di una sagra, di un evento di beneficenza per raccogliere fondi per i soldati malati e feriti». «Un evento di beneficenza?» gli fece eco Virginia. L’uomo di guardia annuì. «Sì, signora. Gli ospiti pagano venticinque cent per entrare, e possono comprare degli scontrini per farsi servire del punch e altre leccornie. In cambio di qualche altro scontrino possono chiedere il brano che vogliono all’orchestra. Tutto l’incasso sarà devoluto all’acquisto dei prodotti necessari, oggi troppo scarsi, per i soldati malati: medicine, bende, coperte, cibo buono». «Che bella idea!» esclamò Elizabeth. «Spero che abbia grande successo». Il maggiordomo le ringraziò e loro due tirarono dritto. Mentre lei e Virginia tornavano a casa, Elizabeth rifletté su quanto aveva visto. «Virginia» disse assorta quando imboccarono Twelfth Street, «sto pensando una cosa». «Cosa?» «Se i bianchi possono organizzare eventi di beneficenza per aiutare i soldati che soffrono, perché la gente di colore benestante non può darsi da fare a sua volta per alleviare le sofferenze dei neri?» «Non vedo perché no» confermò Virginia. «Dio sa che i neri in difficoltà non mancano, dalle nostre parti, e ne arrivano di nuovi ogni giorno». Era una triste realtà. Proprio come gli avversari del progetto di legge del presidente avevano previsto, dopo l’emancipazione Washington era diventata il rifugio di fuggiaschi ma anche di uomini ormai liberi che scappavano dagli stati dove era ancora in vigore lo schiavismo. Prima che la legge abolisse la schiavitù nel distretto, la popolazione di schiavi fuggiti dal Sud era di poche centinaia di anime; i nuovi arrivati si insediavano nelle casette lungo Duff Green’s Row in East Capitol Street ed erano assorbiti quasi spontaneamente dal tessuto cittadino. Con la legge sull’emancipazione, però, erano diventati migliaia. Arrivavano in città soli o con la famiglia, doloranti, affamati ed esausti, reduci da una vita di lavoro nei campi; non sapevano fare altro, ed erano quasi tutti analfabeti. Ben pochi di loro riuscivano a trovare, o potevano permettersi, un alloggio in case o pensioni per neri, e ancor meno numerosi erano quelli che erano partiti per la capitale con un’idea di ciò che avrebbero fatto una volta arrivati sul posto. All’inizio furono raggruppati tutti a Camp Barker, un complesso militare ormai vuoto che comprendeva caserma, scuderie e tende, ma quando il campo giunse a saturazione i rifugiati si costruirono baracche di fortuna con coperte, fango e pezzi di legno in accampamenti che sorsero spontaneamente vicino agli ospedali militari, dietro i forti alla periferia della città o perfino nei vicoletti del centro. Talvolta gli amministratori commettevano errori nella distribuzione delle razioni, e intere famiglie pativano la fame. Malattie come dissenteria, vaiolo e febbre tifoidea si propagavano nei campi sovraffollati e sudici, e i morti erano seppelliti in cimiteri improvvisati poco lontano. I bianchi di Washington, anche alcuni di quelli che avevano caldeggiato l’emancipazione, cominciarono ad allarmarsi per quell’afflusso incontrollato di rifugiati in condizioni di povertà estrema. Non erano gli unici. I neri ricchi e benestanti, desiderosi di non perdere la propria condizione privilegiata, già prima poco stabile, nella gerarchia sociale della città, erano ben decisi a distinguersi dai loro simili incolti, poveri, con la pelle più scura della loro. Nella comunità di colore di Washington, infatti, la posizione sociale era determinata dalla ricchezza, dalla distanza che ciascuno poteva vantare nei confronti della schiavitù e dal colore più chiaro della pelle. I neri nati liberi e ricchi erano in cima alla piramide; sotto venivano, nell’ordine, gli ex schiavi dalla pelle chiara, poi quelli con la pelle scura e infine, più giù, gli schiavi. Era un ordine che rispecchiava quello conosciuto da Elizabeth quando viveva con i suoi padroni, in cui le ragazze schiave che lavoravano in casa e avevano la pelle chiara – spesso figlie, nipoti o sorelle dei padroni – erano tenute in maggiore considerazione dei braccianti scuri di pelle. Le regole implicite erano osservate scrupolosamente anche all’interno della Casa Bianca, dove neppure il presidente era in grado di instaurare l’uguaglianza. Mrs Lincoln aveva raccontato dispiaciuta a Elizabeth di William Johnson, il domestico personale del presidente, dalla pelle scura, che li aveva seguiti a Washington da Springfield ma aveva dovuto andarsene poco dopo, prima che la sarta iniziasse a lavorare per loro. I servitori della Casa Bianca, più chiari di pelle, avevano snobbato William e lo avevano trattato con tale disprezzo che questi, dopo due giorni, aveva dato le dimissioni e chiesto al presidente di aiutarlo a trovare un altro impiego. Grazie al cielo la maggior parte degli abitanti neri borghesi di Washington superarono quei pregiudizi di classe e si misero ad aiutare i profughi. Agirono per compassione e anche per interesse personale, perché avevano ben presente che molti bianchi non vedevano alcuna differenza tra il ricco mercante di colore la cui moglie e le figlie si vestivano di seta e i fuggiaschi senza scarpe, che recavano ancora sul corpo le cicatrici lasciate dalla frusta e che fino a poche settimane prima erano stati schiavi. Il modo di vita dei più poveri tra loro avrebbe determinato il giudizio dato alla razza nel suo complesso, e quindi per il loro bene era essenziale mettere da parte lo snobismo e aiutare a innalzare il livello dei più derelitti. Elizabeth avrebbe voluto che tutti comprendessero spontaneamente che aiutare le persone nel bisogno era la cosa giusta da fare. La domenica successiva, incoraggiata da Virginia, Walker ed Emma, Elizabeth ebbe dal pastore il permesso di rivolgersi all’assemblea dei fedeli dopo la predica. Non era abituata a parlare davanti a un pubblico tanto folto, ma si fece coraggio, salì sul pulpito e si disse che la causa era troppo importante per cedere alla paura. «Abbiamo tutti assistito alla grande migrazione di schiavi appena liberati a Washington» esordì. «Giungono qui con il cuore gonfio di speranza e tutti i propri averi sulla schiena. Appena si liberano dalle catene della schiavitù abbandonano le regioni arretrate dove sono insediate le piantagioni e vengono nella capitale in cerca di libertà, ma molti di loro non sanno neppure dove cercarla. Molti buoni amici si sono prodigati per loro, animati da carità e compassione, ma per ogni parola gentile ne sono state dette due ostili». Alcune donne annuirono facendosi aria, i cappelli che ondeggiavano per sottolineare la loro approvazione. «I nuovi arrivati non sono stati accolti ma scacciati» proseguì Elizabeth, «e i loro fulgidi sogni di libertà stanno svanendo in presenza di quella signora severa animata da senso pratico, la realtà». Mormorii di assenso si udirono dai primi banchi. «Invece di sentieri fioriti, giorni di sole, pergolati carichi di frutti dorati, la strada è piena di ostacoli e il giardino irto di spine» continuò. «Le richieste di aiuto sono troppo spesso accolte con freddi rifiuti. Poveri figli della schiavitù, poveri uomini e donne della nostra razza: la transizione dalle catene alla libertà è stata troppo repentina! Non sono pronti alla nuova vita che ha preso forma davanti a loro, e ora le grandi masse del Nord guardano indifferenti la disperazione di quei derelitti. I vicini bianchi, che osservano i nostri fratelli giunti come rifugiati, hanno imparato a considerare tutta la nostra razza un popolo di pigri incapaci». Una risposta più marcata accolse queste sue ultime parole: cenni di assenso più decisi, alcuni “amen”, diversi incoraggiamenti a continuare. «È un dovere sacrosanto aiutare il nostro popolo» proseguì Elizabeth, «e questi poveri sfortunati sono proprio nostri fratelli. Nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato ad amare il prossimo. Ci ha detto che qualunque cosa facciamo all’ultimo dei suoi fratelli, è come se lo facessimo a Lui. Fratelli e sorelle, vi chiedo di lanciare uno sguardo nei campi dei rifugiati e di vedere il vostro prossimo. Vi chiedo di unirvi a me nel creare una società di neri con il compito di aiutare gli ex schiavi liberi in difficoltà». Un applauso scrosciante accolse le sue parole, e quando Elizabeth, dopo avere ringraziato con un cenno, tornò al suo banco, il pastore prese la parola e invitò tutti coloro che erano interessati alla fondazione di un’organizzazione umanitaria a trattenersi dopo la celebrazione per il primo incontro. Due settimane dopo fu fondata ufficialmente la Contraband Relief Association, con quaranta membri, tutti di sesso femminile, ed Elizabeth fu eletta presidentessa. Progettarono concerti e altri eventi a scopo di beneficenza, e organizzarono il lavoro dei volontari nei campi di ex schiavi. I loro membri più influenti sollecitarono donazioni presso i nordisti più facoltosi, bianchi e neri. Con i fondi raccolti acquistarono i prodotti di prima necessità per i campi – scarpe, indumenti, brande, cibo, attrezzi – e aiutarono gli schiavi liberati a costruirsi case più stabili. Elizabeth si recava spesso nei campi per insegnare il cucito, la lettura e le più fondamentali regole per tenere in ordine una casa alle donne che, in quelle condizioni squallide, cercavano di occuparsi della famiglia. Essendo colta e educata, nel suo ruolo di presidentessa dell’ente umanitario le autorità cittadine le chiedevano spesso di accompagnare i dignitari di passaggio a Washington che desideravano visitare i campi. In una di queste occasioni fece da guida a Miss Harriet Jacobs, un’ex schiava fuggita dal South Carolina, di pochi anni più anziana di lei, nota e influente abolizionista. Lo sguardo esperto e compassionevole di Miss Jacobs registrò ogni dettaglio mentre Elizabeth la accompagnava in giro e descriveva la situazione disperata degli schiavi fuggiti. «Sono dispostissimi a lavorare, ma non sono abituati a farsi pagare» spiegò Elizabeth mentre passavano accanto a un gruppo di giovani che ascoltavano attentamente un uomo di colore con gli occhiali, benvestito, che parlava loro dall’alto di una cassa rovesciata. A un tratto uno dei ragazzi incrociò le braccia, levò il mento e si mise a fissare con aria pensosa l’oratore; era così simile a George, il figlio che aveva perduto, che Elizabeth dovette distogliere lo sguardo con il cuore stretto dal dolore. «Dobbiamo insegnare loro a cercare un’occupazione retribuita, a negoziare una paga giusta e a rinunciare a un posto di lavoro in cui il padrone li tratti male». Miss Jacobs annuì, allontanandosi con la sua accompagnatrice ma senza smettere di osservare i giovani uomini. «Lavoro se ne trova?» «Oh, sì. La guerra ha creato molti posti». Elizabeth guidò Miss Jacobs dietro una tenda dove un soldato stava distribuendo filoni di pane a un gruppo di donne esangui e silenziose, alcune delle quali tenevano in braccio bambini vestiti di stracci. «Sapete della nuova legge del presidente Lincoln, quella che gli consente di ingaggiare “persone di discendenza africana” per combattere contro i ribelli?» Miss Jacobs annuì. «Allora forse saprete anche che, dopo la promulgazione della legge, il governo si è messo a tenere un registro degli ex schiavi e a distribuire razioni di cibo, vestiti e denaro in cambio del lavoro che svolgono a favore dell’Unione. Gli uomini dei campi tagliano legna da ardere, vanno a prendere l’acqua, scavano fossi, fanno la guardia davanti agli ospedali, costruiscono strade e qualunque altra cosa vada costruita, riparano ciò che è rotto». «E le donne?» «Lavorano come lavandaie e cuoche, e fanno i turni nel tenere d’occhio i bambini. Gli uomini ricevono un compenso di dieci dollari al mese. Le donne sole ne guadagnano quattro, quelle con un bambino due e mezzo o forse anche tre». A un tratto Elizabeth si arrestò e posò una mano sul braccio di Miss Jacobs, facendola fermare. «Che sia chiaro: i lavori più pesanti, quelli che nessuno vuole sobbarcarsi, ricadono sempre sugli ex schiavi: pulire latrine, seppellire cavalli e muli morti, rimuovere i rifiuti dalle corsie degli ospedali. Sono compiti importanti, necessari, ma anche pesanti, estenuanti, e non corrispondono a quello che si erano aspettati dalla libertà». «Le loro speranze sono andate deluse» osservò Miss Jacobs riprendendo a camminare. «È vero» concesse Elizabeth, affrettando il passo per raggiungerla, «ma prima di trascorrere del tempo con queste persone non mi ero resa conto di quanto fossero irrealistici i loro sogni, e di quanto si senta depresso chi li aveva coltivati». Qualcosa, forse l’imbarazzo o l’incertezza, impedì a Elizabeth di confidare alla donna che, quando visitava i campi, i rifugiati le si accalcavano intorno, lamentando la propria sofferenza e implorandola di aiutarli. Per alcuni la delusione era tale da far loro idealizzare i ricordi della schiavitù, cosicché rimpiangevano la vita precedente. Elizabeth era rimasta interdetta la prima volta che aveva sentito una vecchia dire che avrebbe preferito tornare a essere schiava nel Sud, dove tutto le era familiare e dove il padrone si occupava di lei, a quella miserabile libertà del Nord. Elizabeth disse a se stessa che l’anziana donna e quelli che la pensavano come lei non erano da criticare, e non si sarebbe adombrata per le loro parole. Dopo una vita di dipendenza, non conoscevano nient’altro, e le preoccupazioni e i pensieri legati alla povertà erano stati un pessimo inizio della loro vita da liberi. «Tutti i campi sono in questo stato?» volle sapere Miss Jacobs. «Tutto sembra scarseggiare, qui, a parte la malattia, la miseria e la fame... e il desiderio di sconfiggerle, il che mi riconforta». «Il bisogno di beni di prima necessità è grande ovunque» rispose Elizabeth, «ma ho sentito dire che le condizioni sono leggermente migliori dall’altra parte del fiume». «Sull’altra sponda, in Virginia?» «Sì. Parte della proprietà del generale Lee di Arlington è stata trasformata in un campo chiamato Freedman’s Village. Non l’ho visitato personalmente, ma voi dovreste farlo, se volete che il vostro rapporto sia completo. Ho sentito dire che tutti gli uomini e quasi tutte le donne lavorano e guadagnano. Hanno anche molto spazio a disposizione per muoversi all’aria aperta, un privilegio che a queste persone è negato». Miss Jacobs annuì pensierosa. «Sì, mi piacerebbe molto vederlo con i miei occhi». Al termine della visita, Elizabeth accompagnò l’ospite fino alla strada dove l’aspettava la carrozza. Fece per salutarla con la mano quando il cocchiere l’aiutò a salire, ma si bloccò esterrefatta quando la chiamò Miss Brent e lei gli rispose. «Vuol dire che non lo sapevate?» chiese un’altra volontaria a Elizabeth quando più tardi quest’ultima le raccontò lo strano episodio. «Harriet Ann Jacobs è Linda Brent». «La scrittrice, intendete?» «Esistono altre Linda Brent? Quando scrive usa uno pseudonimo per proteggersi, ma vi assicuro che sono la stessa persona». Elizabeth era così sbalordita che scoppiò a ridere. Aveva letto Incidents in the Life of a Slave Girl poco dopo la pubblicazione, ed era stata molto colpita dalla fuga coraggiosa al Nord dell’autrice e dei suoi sforzi instancabili per liberare anche i due figli. Molti aneddoti della vita di Miss Brent – di Miss Jacobs – erano dolorosamente noti a Elizabeth, e la sua vicenda le aveva occupato la mente a lungo anche dopo aver terminato il libro. Leggendolo era venuta voglia anche a lei di scrivere qualche appunto sulla propria infanzia in schiavitù e sui terribili anni della giovinezza, quando era stata insidiata da Alexander Kirkland e una padrona crudele alla quale era stata “prestata” aveva cercato di domarla picchiandola regolarmente. Un tempo aveva pensato di mostrare al figlio i propri scritti, ma dopo la morte di George non aveva più pensato al progetto. Forse doveva riprendere in mano la penna, un giorno o l’altro. Anche se non avesse mai pubblicato un libro di memorie come quello di Miss Jacobs, poteva sempre condividere la storia con gli amici più intimi. Nelle settimane che seguirono seppe che Miss Jacobs aveva effettivamente visitato il Freedman’s Village di Alexandria, e che era rimasta tanto colpita dalle disgrazie degli abitanti e dai progressi compiuti che aveva deciso di fermarsi lì a lavorare. Da parte sua, Elizabeth continuò a collaborare con il campo della capitale, impartendo insegnamenti fondamentali e dispensando consigli. Era incoraggiante vedere che, sebbene alcuni ex schiavi, delusi, rimpiangessero un passato che non era mai esistito, altri si mettevano a lavorare per migliorare le proprie condizioni. Costruirono casette solide per la famiglia e coltivarono un orto. Risparmiarono denaro e comprarono polli e maiali. Presero a frequentare la chiesa e mandarono i propri figli alle scuole del campo, dove gli insegnanti si stupirono dei loro progressi continui e ragguardevoli. Fieri, determinati e lucidi, si misero a programmare il futuro con buonsenso e fecero tutti i passi necessari alla realizzazione dei loro progetti. Con il passare dei mesi, i più esitanti e ansiosi tra loro cominciarono a seguire l’esempio degli altri, ed Elizabeth e gli altri volontari si felicitarono del fatto che la loro opera iniziava a produrre frutti. Il lavoro della Contraband Relief Association era fondamentale, infinito e dispendioso. Elizabeth donò tutto quello che poteva, ma sapeva che l’organizzazione doveva trovare altre fonti di finanziamento se voleva continuare a funzionare. Anche se Elizabeth si era recata solo di rado alla Casa Bianca quell’estate, perché Mrs Lincoln aveva trascorso quasi tutti i mesi caldi al Soldiers’ Home o in viaggio con Robert e Tad, conosceva ormai abbastanza da vicino il funzionamento dell’amministrazione del presidente Lincoln per sapere che si trovava in difficoltà. La guerra stava andando male. Le forze confederate del generale Stonewall Jackson, in inferiorità numerica, avevano bloccato l’esercito dell’Unione nella Shenandoah Valley, costringendolo a ripiegare verso il Potomac. Nella Battaglia dei Sette Giorni in Virginia, il generale McClellan aveva di nuovo battuto in ritirata, sebbene avesse sconfitto i confederati per tre giorni di seguito. Un attacco dell’Unione a Vicksburg fallì, vanificando il tentativo di acquistare il controllo sul fiume Mississippi. A Richmond, in Kentucky, le truppe degli stati confederati inflissero una sconfitta cocente a un piccolo contingente di soldati dell’Unione, che furono catturati quasi tutti. In una seconda battaglia presso il torrente Bull Run, il generale John Pope subì una sconfitta disastrosa, con più di quindicimila soldati uccisi, feriti, dispersi o catturati, e il resto dell’esercito respinto dall’altra parte del fiume verso Washington dal generale Robert E. Lee. Elizabeth provava pena per il presidente, ben sapendo che ogni sconfitta gli gravava sul cuore, ma fu meno solidale con un’altra battaglia condotta da Lincoln. In luglio il presidente aveva tentato in tutti i modi di convincere i membri del Congresso provenienti dagli stati confinanti a mettere in atto un programma per un’emancipazione progressiva e remunerata, e anche se non approdò a nessun risultato Elizabeth era certa che fosse un progetto che gli stava a cuore. Nel giro di qualche settimana, però, le dichiarazioni rilasciate alla stampa la indussero a chiedersi se non avesse frainteso la posizione del presidente sull’abolizione della schiavitù. Il 14 agosto Abraham Lincoln ricevette alla Casa Bianca una delegazione di leader della comunità di colore e presentò il suo progetto per la creazione di colonie di schiavi liberati in Africa o in America Centrale. La presenza della razza nera sul continente americano aveva provocato la guerra, dichiarò il presidente, e l’inimicizia tra le razze sarebbe perdurata, ne era certo, anche dopo la risoluzione del conflitto. Anche quando avessero cessato di essere schiavi, i neri non sarebbero mai stati uguali ai bianchi, perciò sarebbe stato meglio per tutti se fossero rimasti separati. La delegazione lasciò la Casa Bianca in preda alla collera e per nulla convinta, e si affrettò a condividere il risultato deludente di quell’incontro storico con i membri della stampa che stavano dalla sua parte. Qualche giorno dopo, in un articolo di fondo del New York Tribune intitolato La preghiera di venti milioni, Horace Greeley attaccò duramente il presidente per non aver rispettato la legge, non pretendendo dai suoi generali che obbedissero immediatamente alle disposizioni previste dal nuovo Confiscation Act. Accusò il presidente di lasciarsi influenzare eccessivamente «dai suoi consiglieri, dai rappresentanti degli stati, dalle minacce, da certi politici fossili degli stati schiavisti confinanti», e di essere disposto ad arrecare danno alla nazione pur di ingraziarseli. Nessun difensore della causa dell’Unione credeva che la ribellione potesse essere sedata a meno che non venisse abolita la schiavitù, che ne era la causa, insisteva Mr Greeley, avvertendo che «ogni ora di compiacenza nei confronti della schiavitù è un’ora in più di pericolo per l’Unione». Tre giorni dopo il presidente Lincoln rispose all’editoriale con una lettera concisa, che Greeley pubblicò il 25 agosto insieme alla sua lunga risposta. Scusando il «tono prepotente e dittatoriale» del giornalista in virtù dell’amicizia che li legava, il presidente dichiarò con grande enfasi che il suo scopo era solo salvare l’Unione. «Il mio obiettivo fondamentale in questa guerra è salvare l’Unione» scrisse, «e non salvare o distruggere la schiavitù. Se potessi salvare l’Unione senza liberare nessuno schiavo lo farei, e se potessi salvarla liberando tutti gli schiavi lo farei, e se potessi salvarla liberandone alcuni e senza curarmi degli altri, farei pure quello. Ciò che faccio nei confronti della schiavitù e della razza nera, lo faccio perché sono convinto che salvi l’Unione; e ciò che evito di fare, evito di farlo perché non sono sicuro che facendolo contribuirei a salvare l’Unione». Tutti a Washington ebbero modo di leggere lo scambio infuocato o ne sentirono parlare da amici e vicini. Gli unionisti che non erano troppo sicuri di parteggiare per l’emancipazione erano soddisfatti, perché il presidente aveva ribadito con chiarezza quali fossero le sue priorità, ma secondo Elizabeth erano i soli a essere contenti. Gli abolizionisti indignati sostenevano che il presidente sembrava incapace di capire che il modo più rapido e sicuro per vincere la guerra e salvare l’Unione stava nell’emancipare tutti gli schiavi, ovunque si trovassero, e nel permettere loro di indossare la divisa blu dell’Unione e di imbracciare le armi per difendere la nazione. Quanto a Elizabeth, desiderava l’abolizione della schiavitù ovunque. Voleva che gli uomini di colore potessero arruolarsi come aveva fatto suo figlio George. Ma voleva anche che gli ex schiavi liberati fossero ben nutriti, sani, istruiti, con un lavoro e benestanti, e sapeva che non bastava desiderarlo perché ciò si realizzasse: servivano invece duro lavoro e un’accurata pianificazione. Voleva credere che anche il presidente stesse lavorando sodo e pianificando con cura per realizzare ciò che desiderava, che avesse buoni motivi per temporeggiare, e che fosse per quello che non liberava tutti gli schiavi sofferenti, sebbene con pochi tratti di penna avrebbe potuto farlo. Voleva aver fiducia in lui, ma sperava che non rimandasse troppo a lungo. A metà settembre, in una battaglia estremamente sanguinosa lungo l’Antietam Creek in Maryland, il generale McClellan riuscì a respingere l’avanzata di Lee verso nord. Anche se il presidente era irritato dal fatto che McClellan avesse permesso all’esercito confederato sconfitto di battere in ritirata in Virginia senza inseguirlo, l’aver evitato l’avanzata nemica era quasi una vittoria, e servì a rinfrancarlo. Meno di una settimana dopo i giornali del Nord pubblicarono un proclama del presidente che dichiarava: «Il primo giorno di gennaio dell’anno di Nostro Signore 1863, tutti gli individui tenuti come schiavi in qualunque stato, o parte di stato, da proprietari in rivolta contro gli Stati Uniti saranno liberati e da quel momento liberi per sempre». Quando lesse per intero il Proclama di Emancipazione sul National Republican il 23 settembre, Elizabeth esultò, e ricominciò ad avere fiducia in Lincoln. Ora finalmente i dettagli che erano stati tenuti segreti cominciarono a trapelare, e la tattica temporeggiatrice del presidente acquistò un significato. Aveva sempre voluto liberare gli schiavi, insistevano i suoi sostenitori, nonostante le sue precedenti dichiarazioni secondo le quali la guerra era combattuta solo per preservare l’Unione. Aveva scritto il Proclama di Emancipazione settimane o mesi prima e l’aveva presentato ai suoi ministri, ma era stato costretto ad aspettare una vittoria decisiva per l’Unione prima di poterlo divulgare al popolo americano, altrimenti sarebbe apparso come un gesto disperato. Mr Lincoln aveva preso tempo anche per determinare se la liberazione degli schiavi fosse costituzionale, ed era giunto alla conclusione che era perfettamente legale per lui, in virtù dei suoi poteri di comandante in capo in periodo di guerra, liberare gli schiavi in zone ribelli. La comunità nera e gli abolizionisti di tutte le razze esultarono, ma nei giorni seguenti, a mano a mano che le parole del presidente furono discusse e dibattute, i motivi per gioire furono ridimensionati dalla preoccupazione che il gesto di Lincoln fosse stato troppo prudente. In effetti il proclama sanciva l’abolizione della schiavitù solo negli stati che erano ancora ribelli il 1° gennaio 1863, quindi in teoria se uno stato avesse accettato di tornare nell’Unione prima di quella data, la schiavitù avrebbe potuto continuare entro i suoi confini. Il proclama, poi, non si interessava minimamente al destino degli schiavi che vivevano negli stati fedeli all’Unione di Delaware, Kentucky, Maryland e Missouri, oltre al Tennessee e a parti della Louisiana, territorio della Confederazione che era finito sotto il controllo dell’Unione. A cosa serviva dichiarare liberi gli schiavi in regioni dove la popolazione non rispettava l’autorità del presidente e quindi, con ogni probabilità, non avrebbe obbedito ai suoi ordini? A Elizabeth pareva che Lincoln avesse emancipato gli schiavi dove l’Unione non poteva liberarli e li avesse tenuti schiavi in luoghi dove aveva invece il potere di garantire loro la libertà. Eppure, nonostante i suoi punti deboli, il proclama andava celebrato a testimonianza del fatto che la nazione procedeva con determinazione verso una maggiore libertà per tutti. La vecchia Unione era sparita per sempre. Quando la nazione fosse stata ricostruita, gli Stati Uniti ne sarebbero usciti rinnovati. Il giorno dopo la pubblicazione del proclama, una folla enorme con tanto di banda si riunì davanti alla Casa Bianca per dedicare un concerto al presidente e tenere discorsi encomiastici. Il presidente uscì a ringraziarli dicendo: «Non sono stato informato del motivo preciso per cui mi fate questo onore oggi, quindi immagino sia per via del proclama». La folla applaudì e confermò urlando. Il presidente proseguì con la consueta umiltà: «Quello che ho fatto, l’ho fatto dopo un’attenta riflessione, e animato da un fortissimo senso di responsabilità. Mi affido a Dio nella speranza di non aver commesso un errore». La calca reagì con trasporto, assicurandogli tra le urla che aveva fatto bene. Anche Elizabeth era convinta che non avesse commesso errori, e che sarebbero arrivate a ruota altre forme di libertà. Credeva anche che presto la sua Contraband Relief Association sarebbe diventata più essenziale che mai. Ai primi di settembre la first lady era partita da Washington alla volta di New York con Tad. In ottobre, afflitta da terribili cefalee intervallate da momenti di disperazione, e desiderando avere a fianco una compagna che le stesse vicino, chiese a Elizabeth di raggiungerla al Metropolitan Hotel di Manhattan. Elizabeth accettò di buon grado, non solo perché non era mai stata a New York e desiderava molto visitarla, ma anche perché il viaggio le avrebbe permesso di promuovere la sua causa presentandola a un pubblico nuovo. Armata di credenziali e di lettere di raccomandazione, prese il treno per Manhattan, si stabilì nell’hotel che aveva prenotato Mrs Lincoln e il mattino successivo parlò alla first lady del suo progetto. «Una causa nobilissima» dichiarò questa. Era vestita a lutto dalla testa ai piedi e aveva sofferto di diversi malesseri durante tutto il periodo in cui aveva viaggiato, ma per un attimo sembrò essere tornata quella di un tempo, piena di energia e di idee. «Insisto per unirmi al vostro elenco di sostenitori. Basterà un contributo di duecento dollari?» «Certo, Mrs Lincoln» rispose Elizabeth, felice di un dono tanto generoso. «Grazie mille». «È il minimo che possa fare dopo tutto quello che voi avete fatto per me» replicò la first lady, che si accinse subito a scrivere al marito per procurarsi la somma. Durante il periodo che trascorse a New York, la sarta frequentò la comunità nera, sollecitando e raccogliendo donazioni per comprare tutto ciò che mancava nei campi di ex schiavi. Fu presentata al reverendo Henry Highland Garnet, che animò una riunione per conto dell’associazione di Elizabeth alla Shiloh Presbyterian Church. Dopo che ebbe raccontato al sommelier del Metropolitan Hotel della sua missione, questi raccolse un’enorme somma di denaro dai camerieri di colore della sala da pranzo. Quando la first lady decise di approfittare della visita a New York per spingersi fino ad Harvard e far visita al figlio Robert, chiese a Elizabeth di accompagnarla, e lei ancora una volta colse l’occasione. A Boston fu presentata a Wendell Phillips, un avvocato, oratore e abolizionista tanto convinto che per anni aveva rifiutato di assaggiare lo zucchero di canna o di indossare indumenti di cotone perché entrambi erano frutto del lavoro degli schiavi. Lui e altri filantropi bostoniani contribuirono generosamente alla sua causa e le assicurarono il loro appoggio. Incontrò anche il reverendo Leonard A. Grimes, che organizzò un incontro aperto al pubblico nella chiesa battista di Twelfth Street, dove sua moglie aprì una filiale bostoniana della Contraband Relief Association. Il reverendo Grimes era un amico di Frederick Douglass, del quale Elizabeth era una fervente ammiratrice, e si offrì di scrivere al famoso abolizionista e oratore da parte sua. Dall’Inghilterra, dove stava effettuando una serie di conferenze, Mr Douglass non solo donò un contributo generoso all’associazione, ma raccolse anche denaro presso diverse organizzazioni britanniche abolizioniste. Durante i viaggi autunnali, e con l’incoraggiamento e il sostegno di Mrs Lincoln, Elizabeth lavorò instancabilmente alla raccolta di fondi per aiutare gli ex schiavi, tenendo sempre a mente la convinzione di George secondo cui, essendo loro stessi divenuti liberi, avevano l’obbligo di contribuire a liberare gli altri dalla schiavitù. Elizabeth era completamente d’accordo, ma credeva che l’obbligo di aiutare i bisognosi continuasse anche una volta spezzate le catene. Chi aveva già attraversato il fiume e si trovava in libertà era obbligato a voltarsi e a tendere una mano a chi compiva i primi, timidi passi sulla riva, ed Elizabeth decise di fare proprio quello. 8. Dicembre 1862 - maggio 1863 La sera del 31 dicembre, Elizabeth ed Emma si recarono alla Union Bethel Church per assistere a una veglia in favore della libertà, insieme a migliaia di altri fedeli di colore in centinaia di chiese nere di tutto il Nord. Al tramonto ogni banco era pieno, e mentre aspettavano che il pastore iniziasse i partecipanti pregavano, cantavano e raccontavano le proprie esperienze di schiavi. Alle dieci il pastore si presentò dinanzi alla congregazione, aprì una Bibbia molto vissuta e li invitò a pregare prima di tenere un’omelia su Dio, Satana, il presidente Lincoln e il giorno ormai imminente della libertà eterna. Chiese al Signore di benedire la mattina di Capodanno, cui mancavano solo poche ore, di benedire la mano del presidente Lincoln quando aveva stretto la penna per firmare il Proclama di Emancipazione. Celebrando quell’evento glorioso tanto vicino, parlò anche del significato di libertà per la gente della loro razza e ricordò ai presenti le nuove responsabilità che dovevano assumersi con energia e gioia. Poi, quasi come se i vicini bianchi e i capi del governo fossero in mezzo ai fedeli, si rivolse direttamente a loro: «Il vostro destino di uomini bianchi e il nostro di neri sono uguali!» esclamò. «Avanziamo tutti verso lo stesso obiettivo. Dateci quindi le stesse condizioni di vita, di libertà, e le occasioni di felicità che avete avuto voi dalla fondazione della nostra splendida nazione, e chiedete a noi lo stesso contributo che fornite voi per aiutare il governo». Un coro di amen si levò dalla congregazione. «Dateci il diritto di voto e delle armi per combattere!» continuò il pastore con voce stentorea. «Fateci indossare l’uniforme blu dell’Unione e imbracciare i fucili. Non anteponete il volgare pregiudizio alla necessità e alla salvaguardia del paese. Non rifiutate di accogliere proprio gli uomini che più di ogni altro tengono a sconfiggere i ribelli. Forse che gli uomini neri non sanno brandire una spada, sparare, marciare e obbedire agli ordini come chiunque altro?» I fedeli risposero che sì, certo, ne erano capaci. «Un uomo che vuole vincere una battaglia non avanza verso il nemico con una mano legata dietro la schiena!» tuonò il sacerdote. «Se casa vostra è in fiamme, e un uomo nero vi offre un secchio d’acqua, lo rifiutate, forse? Se state affogando e un uomo di colore tende la mano per tirarvi a riva, restate dove siete e sperate che un bianco passi di lì prima che finiate sott’acqua, oppure afferrate quel braccio scuro e decidete di vivere?» Un boato di approvazione accolse le sue parole. Elizabeth applaudì fino ad avere male alle mani, e le parole del ministro la indussero ad alzarsi, pervadendole le vene di determinazione, calda e forte come la vita stessa. Subito prima di mezzanotte il tono del prelato cambiò ancora. «In questo momento non voglio vedere nessuno che prega in piedi a capo chino!» esclamò. «Nessuna sorella seduta con la testa in avanti, nessun fratello con un solo ginocchio flesso perché ha i pantaloni troppo stretti. Voglio che ci inginocchiamo tutti completamente per ringraziare l’Altissimo per la libertà e per il presidente Lincoln». Elizabeth ed Emma, una di fianco all’altra, si misero in ginocchio. Con la coda dell’occhio Elizabeth vide le labbra dell’amica muoversi in una preghiera silenziosa. In chiesa calò il silenzio, rotto di tanto in tanto da un fedele che chiedeva aiuto al Signore, che li aveva guidati dall’epoca buia della schiavitù all’avvento di quella nuova libertà. Altri presenti implorarono il Signore di guidare anche il presidente Lincoln. Elizabeth, pur conservando un rispettoso silenzio, ripeté mentalmente quelle parole con tutto il cuore. Sebbene fosse andata a dormire molto tardi, il mattino dopo Elizabeth si alzò presto come sempre e andò alla Casa Bianca a vestire Mrs Lincoln per il tradizionale ricevimento di Capodanno, alle undici. La first lady, pallida e con il viso tirato, aveva già scelto un abito e una cuffia neri e stava aspettando la sarta nel suo salottino personale. «Non riesco a smettere di pensare a tutte le persone che ci hanno lasciato dall’ultimo Capodanno» mormorò mentre Elizabeth le allacciava il vestito sulla schiena. «Ogni giorno da adesso alla primavera sarà disseminato di anniversari tristi». La sarta sapeva che alludeva in particolare alla morte di Willie. «Per il primo anniversario della morte di mio figlio, ho fatto in modo di tenermi occupata» confidò alla first lady. In realtà il giorno in cui aveva sofferto di più non era l’anniversario della data in cui era stato ucciso ma del giorno in cui aveva ricevuto la lettera che ne annunciava la morte. «C’è sempre tanto da fare nei campi degli ex schiavi che non ho avuto difficoltà a tenere la testa impegnata per non pensare al mio dolore». «Forse dovrei fare anch’io qualcosa del genere» disse Mrs Lincoln. «I soldati hanno sempre bisogno di cure e di attenzione, soprattutto quelli che languono negli ospedali militari. Sembra che apprezzino quando scrivo per conto loro delle lettere a casa, se non sono in grado di farlo da sé». Si sforzò di accennare un sorriso, e sembrò sollevata alla prospettiva di avere un piano. «Farò come suggerite voi, Elizabeth, e mi distrarrò pensando ai bisogni degli altri. Anche se non lenisce il dolore, almeno mi permetterà di rendermi utile ai soldati». «Mi auguro che serva a entrambe le cose» osservò l’altra donna. Quando la first lady ebbe finito di vestirsi, chiese a un domestico se il presidente era pronto a scendere, e per tutta risposta le fu comunicato che stava scrivendo in ufficio. «Ancora?» esclamò, e aggiunse rivolta a Elizabeth: «Sta lavorando alla versione finale del proclama da ieri sera». «Il Proclama di Emancipazione?» chiese Elizabeth, improvvisamente a disagio. A cos’altro poteva alludere Mrs Lincoln? Dal momento in cui i giornali avevano pubblicato il decreto preliminare, il presidente era stato bombardato di critiche. I democratici più radicali del Nord avevano dichiarato che non intendevano combattere una guerra per liberare gli schiavi, e nelle elezioni di metà mandato chi osteggiava l’emancipazione aveva manifestato il proprio scontento eleggendo governatori e membri del Congresso democratici. I democratici temevano che nonostante l’apparente rifiuto della politica di Lincoln da parte del popolo alle urne, questi sarebbe andato comunque avanti per la sua strada e avrebbe trasformato in legge il proclama, mentre gli abolizionisti e i repubblicani radicali temevano che avrebbe rinunciato. Si diceva che i ministri lo esortassero ad apportare al documento cambiamenti dell’ultima ora, e a quanto pareva quelle voci di corridoio corrispondevano al vero. Elizabeth poteva solo pregare che i cambiamenti effettuati dal presidente – in quello stesso momento poco distante da lei – non intaccassero la natura stessa della nuova legge. La sarta se ne andò dalla Casa Bianca prima dell’arrivo del presidente Lincoln, e uscendo incrociò alcuni degli invitati al ricevimento. Avrebbe voluto vedere il presidente, non per interrogarlo a proposito del proclama, perché aveva già abbastanza problemi senza l’assillo delle domande della sarta, ma perché forse sarebbe riuscita a capire dalla sua espressione se i cambiamenti effettuati rappresentavano una buona o una cattiva notizia per la sua razza. Invece di dirigersi a casa, andò alla Union Bethel Church dove la veglia continuava. Lungo la strada notò un assembramento davanti all’ufficio del telegrafo; non appena fosse arrivato un messo dalla Casa Bianca a comunicare notizie sul proclama, l’informazione sarebbe stata diramata istantaneamente, grazie al mezzo di comunicazione elettrico, ai giornali di tutto il Nord. Altri uomini, bianchi e neri, si assiepavano davanti alla bottega di uno stampatore, dove gli operai erano in attesa della versione definitiva del proclama per stamparlo. Elizabeth sospettava che avrebbero dovuto aspettare a lungo, perché il ricevimento di Capodanno durava per tradizione tre ore. Il presidente si sarebbe recato nell’East Room dove avrebbe stretto mani e accolto i visitatori, dapprima i diplomatici stranieri, poi gli ufficiali e infine chiunque altro tra i presenti lo desiderasse. Dopo avere stretto tutte quelle mani forse non avrebbe più avuto la forza di reggere la penna. Quando Elizabeth giunse alla Union Bethel Church, il sacerdote e diversi fedeli, della ventina che si era riunita in chiesa a pregare, si interruppero per precipitarsi a interrogarla. Riferì loro ciò che sapeva, e cioè che bisognava aspettare ancora. Rassegnati, ripresero le preghiere o le conversazioni a mezza voce, ascoltando le campane che segnavano il passaggio delle ore, alzando rapidi lo sguardo ogni volta che si apriva la porta e subito dopo ricominciando l’attesa. Poi, a fine pomeriggio, un diacono si precipitò nella cappella, sudato e ansimante, con un foglio stretto nella mano destra che odorava ancora di inchiostro fresco. «Ci siamo!» annunciò. Era troppo affannato dalla corsa per leggere il proclama ad alta voce, così lo affidò al pastore che salì sul pulpito e lo lesse lentamente e con enfasi, affinché ogni parola risuonasse in tutta la chiesa. Elizabeth avvertì un’ondata di sollievo e di gioia, perché a ogni frase le appariva più chiaro che il presidente aveva apportato ben pochi cambiamenti al proclama preliminare, che lei aveva letto tante di quelle volte da saperlo ormai quasi a memoria. La lista di territori sotto il controllo dell’Unione era stata modificata perché nel frattempo l’esercito era avanzato, e soprattutto erano apparsi due nuovi paragrafi che non comparivano nella versione preliminare diffusa nell’autunno precedente. Nel primo il presidente Lincoln ingiungeva agli individui che il proclama aveva appena reso liberi di «astenersi da ogni forma di violenza, a meno che non si tratti di necessaria autodifesa». Un mormorio si diffuse nella congregazione quando il significato delle parole divenne chiaro. Mai prima di allora avevano avuto il permesso di difendersi fisicamente, di ribellarsi alle percosse inflitte loro da padroni particolarmente crudeli. Né potevano farsi valere e combattere per salvarsi la vita se l’occasione si presentava. Era una rivoluzione. Il secondo emendamento era ancora più sorprendente. «Dichiariamo inoltre e rendiamo pubblico che questi individui» – i neri appena emancipati – «se considerati abili saranno arruolati nelle forze armate degli Stati Uniti per presidiare forti, posizioni, basi e altri luoghi, e per condurre mezzi di trasporto di ogni genere nell’ambito dell’esercito». Si udirono acclamazioni e grida di stupore. Nei territori dei ribelli gli schiavi erano liberi e gli uomini di colore avrebbero avuto il diritto di combattere per l’Unione. Il giorno che molti di loro credevano non sarebbe mai arrivato era infine giunto. La congregazione rese grazie e intonò inni di gratitudine, poi si avviò compatta alla Casa Bianca, dove centinaia di altri cittadini giubilanti, bianchi e neri, cantavano e gridavano i loro ringraziamenti al presidente, che si mostrò qualche istante a una finestra per salutarli con un inchino solenne e umile. Più tardi Elizabeth si recò nei campi degli schiavi fuggiti, dove gli uomini liberi dimenticarono per un poco i loro problemi e festeggiarono l’alba di un nuovo giorno di libertà, il primo delle loro nuove vite in cui non avrebbero più temuto la frusta, né vissuto nel terrore delle aste dove venivano scambiati come merce, o spaventati alla prospettiva di essere venduti separatamente da coniuge e figli rischiando di non vederli mai più. La sera la folla si zittì quando il reverendo Danforth B. Nichols, responsabile degli uomini liberi del campo, lesse ad alta voce il Proclama di Emancipazione, pronunciando ogni parola con precisione e chiarezza; quando ebbe finito, e dopo che si furono placati gli applausi e le grida esultanti, levò le mani per attirare l’attenzione generale e ricordò ai presenti che la legge non era applicabile ovunque, per esempio non nel confinante Maryland. Ma neppure quella considerazione amara servì a smorzare la gioia. Finalmente la libertà era a portata di mano. L’anniversario della morte di Willie si avvicinava e Mrs Lincoln era sempre più agitata e irrequieta; investiva quell’energia debordante nei suoi doveri sociali di first lady. Riprese a ricevere visite il sabato pomeriggio, e pur continuando a osservare un lutto stretto lei e il presidente ricominciarono a uscire di sera per assistere a letture o rappresentazioni teatrali, lo svago preferito di Abraham Lincoln. Per Mrs Lincoln la consolazione maggiore erano i due figli che le restavano. Si illuminava tutte le volte che Robert andava a trovarli, ogni pochi mesi, e sebbene Elizabeth ritenesse che il ragazzo era un po’ troppo serio e permaloso, si felicitava anche lei della sua venuta per la gioia che dava ai genitori. Le sue visite, però, non erano sempre occasioni allegre, perché desiderava lasciare Harvard e arruolarsi e sfruttava sempre quei pochi giorni a casa per cercare di ottenere il permesso. Mrs Lincoln si opponeva strenuamente al progetto, come ripeteva spesso al marito quando erano soli, o meglio in compagnia di Elizabeth, che cuciva silenziosa in un angolo e stava ad ascoltare. «Abbiamo perso due figli, e non posso sopportare l’idea di perderne un altro, di compiere un altro sacrificio» dichiarò Mrs Lincoln un giorno verso metà febbraio quando l’argomento fu sollevato per l’ennesima volta. «Ma molte madri hanno rinunciato a tutti i loro figli, che amavano quanto noi amiamo il nostro» le fece notare il presidente. Elizabeth si aspettava quasi che a quel punto le lanciassero entrambi uno sguardo compassionevole, ma non accadde. La feriva vedere che sembravano aver dimenticato il suo lutto e perfino la sua presenza. «Sarà, ma non posso sopportare l’idea che Robert si metta in pericolo. I suoi servizi non sono necessari sul campo, e il suo sacrificio sarebbe inutile». «I servizi di ogni uomo desideroso di aiutare il suo paese sono necessari in tempo di guerra» replicò il marito. «Dovreste valutare la questione da un punto di vista liberale e non egoista, mamma». Mrs Lincoln voleva a tutti i costi che Robert continuasse gli studi, e siccome nessuno dei due riusciva a persuadere l’altro, lasciarono cadere il discorso; ci avrebbe pensato Robert a rimetterlo in campo. Anche se le discussioni erano terminate per il momento, le parole di Mr Lincoln continuavano a frullare in testa a Elizabeth. I servizi di ogni uomo erano necessari, aveva detto. Forse le bruciava ancora che i coniugi Lincoln non avessero pensato che una di quelle madri che aveva rinunciato a tutti i suoi figli per la causa dell’Unione fosse con loro, perché avvertiva un insolito desiderio di rimproverare il presidente. Ogni uomo che amava il suo paese, aveva detto. Era tentata di chiedergli se nel novero includesse anche gli uomini di colore. Perché non considerava anche i neri? Se davvero c’era un bisogno disperato di tutti gli uomini che amavano il loro paese, doveva calcolare tutti gli uomini di colore, non solo gli schiavi appena emancipati che vivevano nei territori del Sud riconquistati. La previsione di Elizabeth che la Contraband Relief Association sarebbe diventata ancora più fondamentale dopo l’emancipazione si dimostrò azzeccata. I bisogni di uomini, donne e bambini nei campi erano così enormi che perfino i contributi munifici degli amici desiderosi di aiutare erano insufficienti a procurare il minimo indispensabile. Per tutto l’inverno Elizabeth consacrò sempre più tempo e denaro, troppo denaro, all’associazione. Per la prima volta da quando si era insediata a Washington ebbe difficoltà a sbarcare il lunario, e non riusciva a sopportare la preoccupazione e l’incertezza che quella scarsità di risorse provocava in lei. Per gran parte della vita aveva lavorato per proprietari che non sapevano gestire il proprio denaro, si riempivano di debiti e si spostavano da una città all’altra nel futile tentativo di migliorare la loro condizione. Da schiava si era ripromessa che, se avesse ottenuto la libertà, mai sarebbe stata così poco oculata con i soldi. Ora sembrava invece che stesse seguendo i suoi ex padroni sul sentiero dello sperpero. Non cambiava nulla il fatto che i suoi debiti fossero causati dall’altruismo e non dal desiderio di uno stile di vita al di sopra dei suoi mezzi; la conseguenza, in altre parole la miseria, sarebbe stata la stessa. Le sarebbe piaciuto confidare i suoi problemi alle amiche, ma non voleva preoccupare inutilmente Emma con le difficoltà economiche del suo laboratorio, e non desiderava turbare Virginia che era incinta. Perciò si angosciava per conto suo, in segreto, o così credette fino a un certo giorno. Era alla Casa Bianca e stava passando in rassegna dei nastri per bordare un nuovo abito, rimuginando sui propri problemi, quando Mrs Lincoln esclamò a un tratto: «Santo cielo, Lizzie, perché lanciate quelle occhiate tetre ai nastri? Se proprio non vi piacciono potete andare nei negozi a cercarne altri, anche se non so cos’abbiano di nuovo in nero... Abbiamo già visto tutto!» «Perdonatemi» disse Elizabeth imbarazzata. «I nastri vanno benissimo, ma confesso che sono altrove col pensiero». «Sapevo che c’era qualcosa che non andava». La first lady le si sedette accanto e posò una mano sulla sua. «Ditemi tutto. Sono giorni che sospirate e vi accigliate. Siete scontenta? Non state bene?» «Sono solo preoccupata». Elizabeth esitò, ma si sentiva con le spalle al muro e sapeva di dover dare qualche spiegazione. «Vivo al di sopra dei miei mezzi». «Voi?» esclamò la first lady stupita. «Non ci credo. Non siete mai stata una scialacquatrice. Anzi, vi siete sempre dimostrata oculata con le spese». Elizabeth fece un sorriso tirato. «Non spendo per me, questo è vero, ma ultimamente, tolto quello che mi serve per mangiare e per l’affitto, dono tutto ai campi di ex schiavi». «Se è così...» disse Mrs Lincoln, cercando una soluzione per il problema della sua collaboratrice «dovete smetterla subito». «Ma hanno tanto bisogno». Elizabeth si fece forza e disse ciò che fino a quel momento aveva voluto nascondere anche a se stessa. «Devo guadagnare di più». La first lady sembrò sorpresa. «Lizzie, mia cara, mi piacerebbe aiutarvi ma non posso pagare i vestiti più di quanto faccia ora. Mio marito è dell’avviso che spenda già troppo; non negli abiti, intendo, ma in tutto il resto». Quanto a questo, Elizabeth era d’accordo con il presidente. «Oh, no, Mrs Lincoln. Non volevo suggerire che intendo aumentare le tariffe. Non mi sognerei mai di chiedere alle mie clienti di pagare più del giusto, e certo non a voi». Esitò. «Penso tuttavia di dover trovare un modo per guadagnare di più». «Potete accettare nuove clienti, confezionare più abiti?» La sarta ripensò a quegli anni lunghi e pesantissimi a Saint Louis quando aveva lavorato fin quasi ad ammalarsi per guadagnare di che acquistare la libertà per sé e George. Rabbrividì al ricordo del dolore, delle cefalee continue, del male alla schiena, della stanchezza agli occhi e dell’intorpidimento delle dita. «Non credo che potrei lavorare più di così». «Allora dev’esserci un altro modo per aumentare gli incassi» dichiarò Mrs Lincoln con ottimismo. «E ci devono essere altre possibilità per finanziare l’associazione, al di là del vostro stipendio. Non ci abbiamo riflettuto abbastanza. Qualcosa ci verrà in mente». Elizabeth la ringraziò e si sentì subito meglio, sebbene per il momento non avesse trovato nessuna soluzione. Era un piacere vedere Mrs Lincoln tornare quella di un tempo, efficiente e piena di spirito d’iniziativa. Qualche giorno dopo Mrs Lincoln si alzò all’arrivo della sarta e le strinse le mani. «Mia cara, credo di avere una soluzione». «Sarebbe un’ottima notizia» replicò Elizabeth, sorpresa e sollevata. La first lady spiegò che il ministero del Tesoro aveva bisogno di personale che tagliasse i grandi fogli stampati per dare alle banconote il loro formato normale. Le sarte erano particolarmente ricercate per questo lavoro, per via della loro abilità con le forbici. «Non è un lavoro difficile, e la paga è accettabile» spiegò Mrs Lincoln, palesemente soddisfatta di sé. «E soprattutto, non dovrebbe portar via tempo alla vostra attività principale». «Io... non so cosa dire» balbettò Elizabeth, completamente spiazzata. «Sembra perfetto». «Bene! Dovete fare domanda, naturalmente, ma penso che con la mia raccomandazione non avrete problemi». Mrs Lincoln esitò per un attimo e parve farsi forza. «C’è prima una piccola prova da superare, un compito ingrato e disonesto». La scelta degli aggettivi era così sconcertante che per un attimo Elizabeth la guardò senza riuscire a parlare. «Cosa intendete?» «Penso che vi faciliterebbe le cose essere presentata a Mr Chase prima di fare domanda». Parlava di Salmon P. Chase, ministro del Tesoro e padre della rivale di Mrs Lincoln in società, la bellissima Kate Chase. «Ma voi disprezzate il ministro Chase». La first lady sollevò il viso e respirò profondamente. «Metterò da parte il mio disprezzo il tempo necessario per organizzare l’incontro». E così avvenne. Più tardi, quel pomeriggio, quando Mr Chase giunse alla Casa Bianca per intrattenersi con il presidente, la moglie riuscì a farsi trovare fuori dall’ufficio del marito alla fine del colloquio. Dichiarandosi entusiasta per quell’incontro casuale, disse al ministro che desiderava presentargli qualcuno e lo condusse nel salotto privato, dove li aspettava Elizabeth. Quest’ultima aveva incrociato spesso Mr Chase, ma senza che nessuno li presentasse ufficialmente. Mise da parte il cucito e si alzò, mantenendo un’espressione neutra anche se il volto del visitatore denotava fastidio e impazienza. Tuttavia Mr Chase fece del suo meglio per essere amabile quando la first lady li presentò. «Mrs Keckley, naturalmente» disse lui stringendole la mano. «La celebre sarta. Mia figlia vi stima molto». «Grazie, signore» replicò l’interessata. «La stima è reciproca». Ignorò l’espressione scettica di Mrs Lincoln che, per fortuna, Mr Chase non notò. La first lady arrivò subito al dunque, e quando ebbe finito di spiegare lo scopo dell’incontro Mr Chase le lanciò uno sguardo indagatore e disse: «E così, Mrs Keckley, vorreste rinunciare al vostro lavoro di sarta per un posto al ministero a tagliare le banconote? Da quello che ho sentito, molte dame dell’alta società ci resteranno male». «Non intendo rinunciare al cucito, signore» rispose. «Voglio semplicemente aumentare i miei guadagni». «Nessuno nel distretto è più qualificato di Elizabeth nel maneggiare un paio di forbici» intervenne Mrs Lincoln. «Il ministero del Tesoro non dovrebbe avere problemi ad affidarle il compito di tagliare dei fogli di carta belli dritti. Il lavoro che svolge ogni giorno è ben più difficile». «Non ho dubbi». Mr Chase osservò Elizabeth per un momento. «Benissimo, Mrs Keckley. Se è ciò che desiderate, dovreste fare domanda al ministero del Tesoro. Dirò al mio assistente che abbiamo parlato, dopodiché sono sicuro che le vostre qualifiche sapranno essere convincenti». «Ve ne sono molto grata, signor ministro» disse la sarta. Lui si accomiatò con un cenno e uscì dalla stanza, con Mrs Lincoln che si affrettò a seguirlo come per ringraziarlo con mille premure. Quando tornò, promise all’amica che avrebbe scritto anche a George Harrington, per aggiungere la propria raccomandazione a quella di Mr Chase. La first lady si sedette subito con carta e penna, e di lì a breve concluse tamponando la lettera con la carta assorbente. «Gli ho assicurato che siete una donna piena di buona volontà che svolge il proprio lavoro con grande onestà» spiegò, soddisfatta del proprio operato. «L’ho anche informato del fatto che potrete cominciare a lavorare per lui solo dalla metà di aprile, alla fine della stagione degli eventi sociali, perché da quel momento in avanti avrò meno bisogno di voi. Spero che possa andarvi bene». «Il periodo sarebbe perfetto» confermò Elizabeth. «Grazie mille, Mrs Lincoln». La dama, felice, chiamò un servitore per affidagli la lettera. «E ora non ci resta che aspettare una risposta». Era solo questione di tempo, le assicurò Mrs Lincoln il giorno dopo, e poi di nuovo l’indomani. Forse Mr Chase non aveva ancora trovato un momento per affrontare la questione con Mr Harrington. Ogni ministero sbrigava le pratiche in corso meglio che poteva in periodo di guerra, ma talvolta anche le faccende più importanti subivano ritardi. Passò una settimana, poi un’altra. Le speranze di Elizabeth cominciarono a diminuire, ma si guardò bene dal lamentarsi. La first lady si era dimostrata molto gentile nel raccomandarla a Chase e Harrington, e lei non voleva apparire ingrata. La moglie del presidente, tuttavia, non si faceva nessuno scrupolo a protestare quando riteneva che le lagnanze fossero giustificate. Indignata per il fatto che il ministero non avesse usato né alla sua protetta né a lei stessa la cortesia di una risposta, dichiarò che ne avrebbe scoperto la ragione, anche se per farlo avesse dovuto recarsi di persona al ministero del Tesoro. Elizabeth seppe che aveva trovato la risposta quando una mattina arrivò alla Casa Bianca e vide Mrs Lincoln in atteggiamento pensoso davanti alla finestra, con un’espressione dispiaciuta e vagamente imbarazzata. «Avete avuto notizie dal ministero del Tesoro» indovinò Elizabeth. «Non ho avuto il lavoro». «Mi dispiace molto, Elizabeth» esordì la first lady. «Erano tutti d’accordo nel dire che le vostre qualifiche andavano benissimo, ma mi è stato detto che il supervisore di quel reparto aveva delle... riserve. Deve tener conto di come reagirebbero gli altri dipendenti». La sarta capì al volo, e si sentì umiliata per aver coltivato anche se brevemente la speranza di avere il posto. «Gli altri dipendenti non accetterebbero di lavorare accanto a una donna di colore». Mrs Lincoln attraversò la stanza e andò a posare le mani sulle spalle dell’amica. «È sbagliato, io lo so e mi dispiace infinitamente. Se dipendesse da me l’avreste voi, quel posto, e chiunque non fosse contento sarebbe libero di andarsene». «Purtroppo, invece, non dipende da voi». «No» convenne la moglie del presidente accigliandosi. «Anche se penso che, in quanto first lady, dovrei avere voce in capitolo». Elizabeth si lasciò cadere stancamente su una sedia. Era dai tempi della schiavitù che non si sentiva tanto ferita, demoralizzata e indignata. «Penseremo a qualcos’altro» la rincuorò l’amica con un sorriso. «Non arrendetevi, Elizabeth». «Non è mia abitudine arrendermi» replicò, ma non aveva idea di cos’altro fare. Per festeggiare il decimo compleanno di Tad, Mrs Lincoln propose una visita all’accampamento dell’Armata del Potomac vicino a Falmouth, in Virginia, sulla sponda settentrionale del Rappahannock. Sabato 4 aprile, nel bel mezzo di un’inaspettata tempesta di neve primaverile, il presidente, la sua consorte, Tad e un gruppetto di amici, alcuni responsabili dell’amministrazione e qualche membro fidato della stampa salirono a bordo dell’imbarcazione a vapore Carrie Martin. Navigarono verso sud, a valle, superando Alexandria e Mount Vernon, dove le campane del traghetto suonarono in omaggio a George Washington secondo la tradizione in uso lungo il fiume. La nevicata violenta e accecante costrinse il capitano a fermarsi in una cala riparata per la notte e, sebbene la tempesta si intensificasse, il mattino dopo proseguirono e giunsero nell’affollato porto mercantile di Aquia Creek il giorno di Pasqua. Il gruppo si trasferì su un treno sul quale sventolava la bandiera dell’Unione e che, sfidando venti impetuosi e altre forti nevicate, giunse alla stazione di Falmouth dove i visitatori furono accolti dal generale Hooker. Le condizioni meteorologiche ritardarono di un giorno il programma ufficiale, ma nella settimana successiva il presidente e la first lady ispezionarono le truppe, assistettero a una grandiosa sfilata della cavalleria, visitarono gli ospedali da campo e si avventurarono sulla riva del Rappahannock, da dove riuscirono a vedere le truppe dei confederati che li salutavano sbracciandosi dalla sponda opposta. La famiglia tornò a Washington l’11 aprile, di buonumore dopo la gita fuori città. Quando Elizabeth andò alla Casa Bianca il giorno successivo, notò che il presidente sembrava incoraggiato dalla prontezza, dalla forza e dall’entusiasmo delle truppe che aveva incontrato, mentre sua moglie appariva più serena e rilassata, nonostante si fosse verificato un fastidioso incidente: al momento di salutare il presidente, una cavallerizza esuberante dai capelli rossi che aveva sposato un principe prussiano e acquisito il titolo di principessa SalmSalm aveva baciato appassionatamente Abraham Lincoln invece di stringergli la mano. Entusiaste, alcune altre dame avevano trovato il coraggio di imitarla, e il presidente era stato quasi aggredito dalle signore che volevano salutarlo con trasporto. La principessa Salm-Salm aveva spiegato ridendo che era stato il generale Sickles a suggerire alle signore di rivolgere al presidente quell’accoglienza sperando di rallegrarlo. Mary Lincoln si era offesa profondamente, ma aveva rifiutato di permettere a quelle donne sciocche di rovinarle la gita. Ciò che aveva sempre desiderato più di tutto era trascorrere del tempo con il marito e i figli, e senza dubbio la breve gita con il presidente e Tad le aveva fatto un gran bene. Mrs Lincoln era tornata a Washington con una nuova idea per aiutare Elizabeth a risolvere il suo problema. Conversando con il personale in un ospedale da campo aveva saputo di una nuova legge che accordava una pensione alle vedove il cui unico figlio era morto in guerra, come Elizabeth. «Tutto ciò che dovete fare è inviare la domanda all’Ufficio Pensioni degli Stati Uniti» le assicurò la first lady. «A mio avviso è il minimo che la nazione possa fare per ringraziarvi del vostro sacrificio». La sarta la ringraziò e non appena le fu possibile si recò nell’apposito ufficio a prendere i formulari. L’impiegato la guardò incuriosito spiegandole le varie firme e autorizzazioni che le servivano, ma era abituata alle occhiate perplesse da parte di uomini bianchi che la vedevano in luoghi dove non si aspettavano di trovare una donna di colore, così lo ignorò. Solo più tardi, dopo aver parlato con diversi uomini cui aveva chiesto di testimoniare in suo favore, capì di essere ancora una volta sospesa in quello strano limbo tra il mondo dei bianchi e quello dei neri, in cui circostanze indipendenti da lei le avrebbero impedito di ottenere la pensione che tanto le serviva. Anche se esistevano alcuni reggimenti di schiavi fuggiaschi, e pareva che un giorno i neri sarebbero stati regolarmente arruolati, George era entrato nell’esercito quasi due anni prima, facendosi passare per bianco. Lui ci era riuscito, ma bastava dare un’occhiata a Elizabeth per rendersi conto che bianca non era. Sarebbe stato difficile spiegare come una donna nera avesse potuto partorire un uomo bianco, ma il problema peggiore era un altro, ovvero che suo figlio, agli occhi della legge, era illegittimo. George era stato concepito in seguito a uno stupro, era il frutto di una relazione che lei non aveva mai desiderato, eppure, a causa dell’assurda moralità che sanciva i rapporti tra razza, matrimonio e la “peculiare istituzione” della schiavitù, la sarta avrebbe patito le conseguenze di quello che era visto come un comportamento sessuale inappropriato. Elizabeth, scoraggiata, temeva che non ci fosse più nulla da fare; proprio quando ormai era in preda allo sconforto, Mary Welch, cliente di vecchia data che aveva conosciuto a Saint Louis, si fece raccontare la sua storia. «Credo di conoscere qualcuno in grado di aiutarvi» le disse premurosa la donna, indignata per il trattamento ingiusto che la sarta si trovava a subire per colpa della burocrazia. «Ci penso io». Qualche giorno dopo Miss Welch presentò Elizabeth al suo amico Owen Lovejoy, membro del Congresso originario dell’Illinois, abolizionista convinto che aveva molta esperienza nello sciogliere i nodi più intricati delle leggi che perpetuavano le ingiustizie razziali. Accettò di buon grado di aiutarla a preparare la domanda, e quando fu costretto a tornare nell’Illinois prima di avere finito, incaricò il fratello Joseph di prendere il suo posto. Un terzo fratello, Elijah, il maggiore, era stato ucciso circa venticinque anni prima mentre cercava di difendere la macchina da stampa del suo giornale abolizionista da una folla inferocita di schiavisti. Entrambi i fratelli sopravvissuti erano presenti quando Owen Lovejoy la convocò in ufficio per spiegarle la soluzione che proponeva al suo dilemma. «Il fatto è che l’esercito dell’Unione pensa che vostro figlio sia bianco» esordì Owen. Aveva un viso intelligente, occhi vivaci e i capelli neri su una fronte volitiva. «Dobbiamo invece dimostrare che George era il figlio mulatto e legittimo vostro e di Mr Alexander Kirkland». Elizabeth avvertì una stretta di apprensione. «Come faremo?» I fratelli si scambiarono un’occhiata, poi fu Joseph Lovejoy a parlare. «Testimonierete che voi e Mr Kirkland eravate sposati». «Ma non lo siamo mai stati» protestò lei debolmente. Il solo pensiero le dava il voltastomaco. «Anche se l’idea non fosse completamente ripugnante ai miei occhi, non potrei mai posare la mano sulla Sacra Bibbia e giurare il falso». I fratelli si scambiarono un’altra occhiata, e la donna capì che avevano previsto quella sua reazione. «Mrs Keckley» riprese Owen Lovejoy con tatto, «abbiamo studiato la faccenda sotto ogni punto di vista, e la nostra opinione è che questo sia l’unico modo per ottenere la pensione». «Voi siete la madre vedova di un soldato ucciso al fronte, giusto?» chiese Joseph Lovejoy. «Certo» replicò Elizabeth disorientata. «E la legge non prevede che le madri vedove che hanno subito questa perdita abbiano diritto alla pensione?» «Sì». «Allora spero che sarete d’accordo con noi nel ritenere ingiusto privarvi di quella pensione solo perché altre leggi di minore importanza vi sono avverse». «Vostro figlio non si è mai finto bianco» proseguì Owen Lovejoy. «Si è messo in fila per arruolarsi e, quando ha firmato sul foglio, chi lo ha arruolato ha desunto che fosse bianco, ed è stato ben felice che avesse deciso di unirsi all’esercito». «Vostro figlio non ha mentito per arruolarsi» aggiunse il fratello, come per rassicurarla. Effettivamente le era di conforto sapere che George non avesse raccontato menzogne. «Per quanto riguarda l’altra difficoltà...» Owen esitò. «Perdonatemi se tocco un argomento che, posso benissimo immaginarlo, vi turba e vi addolora profondamente. Le circostanze del concepimento di vostro figlio non sono colpa vostra. Non è stata una vostra scelta dare a Mr Kirkland un figlio al di fuori dal matrimonio». Non era stata sua scelta dargli un figlio tout court, stava per replicare lei, ma non riuscì a pronunciare quelle parole che sarebbero state interpretate, da gente che non la conosceva bene, come un rifiuto del proprio figlio, l’ammissione di non averlo amato. La verità più importante della sua vita era invece che aveva amato George con tutta se stessa, con fierezza, con la medesima passione di cui si nutriva l’odio per suo padre. «Sarebbe quindi una grave ingiustizia» continuò Owen Lovejoy «far prevalere la lettera della legge su un autentico atto di giustizia. È giusto che riceviate la pensione alla quale vi dà diritto il sacrificio patriottico di vostro figlio». «E se vi negano la pensione» aggiunse suo fratello con un tono di sfida nella voce, «ciò non farà che contribuire alla nostra causa politica». Elizabeth non capiva bene a quale causa alludesse – l’abolizionismo? L’uguaglianza? La causa repubblicana? – ma a lei serviva qualcosa che le tornasse utile subito, non una vittoria politica intangibile che risultasse preziosa negli anni a venire. «Parlate tutti e due come avvocati» replicò con voce incerta. «Non dovete adoperarvi con mille lusinghe, cercando di nascondere il vostro vero scopo. So che volete aiutarmi, quindi vi prego di parlarmi chiaramente. Mi suggerite di mentire per ottenere la pensione, giusto?» «Ebbene...» Joseph Lovejoy esitò. «Sì. Mentire è sbagliato, ma in questo caso una piccola bugia permette che giustizia sia fatta». «Credete che solo mentendo riuscirò a far accettare la mia domanda?» «Ne sono sicuro» dichiarò Owen Lovejoy in un tono che non lasciava adito a dubbi. «Allora lo farò». I fratelli Lovejoy annuirono, soddisfatti di averla persuasa. Si chiese se avessero capito quale delle loro frasi, perfettamente studiate, aveva sortito l’effetto sperato. Owen Lovejoy aveva detto – e la legge lo confermava – che suo figlio aveva permesso alla madre di aspirare alla pensione dando la vita per l’Unione. Erano state quelle parole a convincerla. Non avrebbe gettato via l’ultimo dono che George le aveva fatto solo per obbedire a stupide leggi sulla razza e il matrimonio che non erano state pensate per le esigenze dei neri e non avevano mai aiutato un solo schiavo. Perché quelle leggi dovevano essere applicate al suo caso preciso quando non erano mai intervenute in suo aiuto negli anni lunghi e difficili in cui avrebbero potuto alleviare le sue sofferenze? Era sicura che il Signore l’avrebbe perdonata per le menzogne che si apprestava a dire, in tutta libertà e senza scrupoli. Verso la metà di aprile Elizabeth si presentò al cospetto del giudice di pace William S. Clary e due rispettabili testimoni per prestare la propria testimonianza sotto giuramento. Era vedova e madre di George W.D. Kirkland, soldato semplice del Primo Reggimento Volontari del Missouri, Compagnia D, ucciso il 10 agosto 1861 nella battaglia di Wilson’s Creek. Il padre di George era il suo primo marito, Alexander Kirkland, un uomo bianco morto quando George aveva solo diciotto mesi. Più tardi la famiglia Garland aveva portato con sé la madre e il figlio a Saint Louis, dove Elizabeth aveva sposato James Keckley, ma nel corso degli ultimi tre anni avevano vissuto separati ed Elizabeth non riceveva da lui nessuna forma di aiuto materiale. Aveva acquistato la libertà per sé e per il figlio per milleduecento dollari, a prezzo di grandi fatiche e di lavoro durissimo, e aveva sperato che il figlio, quando avesse percepito uno stipendio, l’avrebbe aiutata a ripagare i debiti che aveva contratto per riscattarsi. Doveva ancora restituire duecento dollari, oltre ad altri cento che doveva versare per gli studi di George. George non lasciava una vedova né figli minori di sedici anni. Elizabeth non si era in nessun modo impegnata, né aveva favorito o collaborato, con la ribellione negli Stati Uniti, e aveva sacrificato volentieri la vita di suo figlio sull’altare del paese. Qualunque residuo di senso di colpa per la bugia svanì quando i due testimoni, Daniel A. Payne, vescovo dell’African Methodist Episcopal Church, e John M. Brown, sacerdote, giurarono in separata sede che la conoscevano da dieci anni e che ogni parola della sua testimonianza corrispondeva al vero. Elizabeth si chiese come mai tutti credessero a quelle parole, visto che non aveva mai negato – e sarebbe stato facile dimostrarlo – di essere arrivata a Washington nel 1860. Ma Elizabeth giurò solennemente, e i documenti furono firmati con tanto di sigilli; nel giro di qualche settimana la sua domanda fu accettata. Da quel giorno in poi, e per il resto della sua esistenza, ricevette una pensione dal governo federale. Se era del tutto inadeguata per compensare la sua perdita – otto dollari al mese, in seguito diventati dodici, per la vita di suo figlio –, spesso quei soldi facevano la differenza tra serenità e preoccupazione, e quindi li accettò con riconoscenza. Il bel tempo primaverile contribuì a sollevare leggermente il morale della città assillata da tanti problemi, ma Elizabeth aveva l’impressione che il presidente Lincoln dimagrisse a vista d’occhio e invecchiasse anzitempo a causa delle preoccupazioni che gli procurava la guerra. L’esercito dell’Unione aveva un bisogno disperato di soldati, tanto che il Congresso era stato costretto ad approvare una legge per il reclutamento di uomini bianchi sposati tra i venti e i trentacinque anni, e di uomini bianchi scapoli fino ai quarantacinque anni. I neri erano esentati perché non erano considerati cittadini, e chiunque potesse permettersi di pagarsi i servizi di un sostituto evitava il servizio militare. L’ingiustizia di un sistema che mandava in guerra i poveri e permetteva ai ricchi di evitarlo pagando creò un clima di profondo risentimento in tutto il Nord. Alla fine di aprile e all’inizio di maggio le forze dell’Unione e degli stati confederati si scontrarono a Chancellorsville, un luogo di passaggio a ovest di Fredericksburg nella contea di Spotsylvania, in Virginia. Anche se i confederati persero il loro tanto esaltato generale Stonewall Jackson, morto sotto il fuoco amico, il generale Lee conquistò una vittoria decisiva in quella che fu la battaglia più sanguinosa della guerra fino a quel momento, con oltre diciassettemila morti per il Nord e quasi tredicimila per il Sud. La drammatica notizia giunse a Washington insieme a migliaia di feriti, trasformando ancora una volta la città in un caotico ospedale da campo, pervaso dal lezzo di morte e marciume; Elizabeth teneva le finestre chiuse giorno e notte, nel futile tentativo di lasciar fuori gli odori e gli orrori del campo di battaglia che quel puzzo nauseabondo evocava. Alcune settimane dopo, a metà maggio, il generale Grant condusse le sue truppe oltre il Big Black River in Mississippi e fino a Vicksburg, ma due attacchi diretti alla città furono respinti, e le forze dell’Unione dovettero risolversi a iniziare un assedio tedioso e demoralizzante. A Mary Lincoln non piaceva che il marito si aggirasse per Washington senza una scorta armata, per via delle numerose lettere contenenti minacce di morte, ma il presidente faceva spesso la spola da solo tra la Casa Bianca e l’ufficio del telegrafo al ministero della Guerra per procurarsi le notizie più recenti dal fronte. Una volta, mentre Elizabeth era con Mrs Lincoln nel salotto privato a provarle un abito, il presidente tornò da una di quelle passeggiate solitarie con passo lento e pesante, e con un’espressione infelice e preoccupata. Come un ragazzino esausto si sdraiò su un divano e si coprì gli occhi con le lunghe mani ossute, l’immagine stessa dello scoramento. La first lady scambiò uno sguardo preoccupato con la sarta e chiese: «Dove siete stato, papà?» «Al ministero della Guerra». La moglie non si lasciò intimidire dal tono brusco. «Ci sono novità?» «Sì, molte, ma nessuna positiva. È tutto buio. L’oscurità regna ovunque». Mrs Lincoln fece un lieve sospiro, ed Elizabeth provò un moto di solidarietà nei confronti del presidente. Cercava di immaginare cosa si provasse a portare un fardello del genere, e non sapeva come un uomo solo potesse riuscirvi. Continuò a lavorare sul corpetto dell’abito, e con la coda dell’occhio vide Mr Lincoln che allungava il braccio e prendeva una Bibbia dal tavolino accanto al sofà, la apriva e la sfogliava distrattamente, finché un brano non attirò la sua attenzione. Si immerse subito nella lettura, e dopo un quarto d’ora di silenzio quasi assoluto la sarta gli lanciò un’occhiata e scoprì che la sua espressione era ben diversa da prima, quasi allegra. La smorfia abbattuta era scomparsa, e al suo posto si vedevano una nuova determinazione e la speranza. Curiosa, Elizabeth si chiese cosa aveva letto per trarne un conforto così immediato. Mormorando una scusa qualsiasi – un puntaspilli che non riusciva a trovare – la sarta passò dietro al divano fingendo di cercare l’oggetto perduto e scoprì che il presidente stava leggendo un passo del Libro di Giobbe. Intenerita, immaginò quasi che Lincoln avesse udito il Signore che gli parlava in tono stentoreo nella confusione della battaglia: «Orsù, cingiti i lombi, come un prode; io ti interrogherò e tu mi risponderai». Lo spettacolo sublime del capo di una nazione tanto importante che cercava consolazione e coraggio nelle Sacre Scritture e trovava entrambi in un momento così buio la commosse, e dovette calmarsi prima di tornare da Mrs Lincoln. Anche la moglie consultava la Bibbia per trarne conforto e consigli, ma dopo la morte di Willie si rifugiava soprattutto nei misteri dello spiritualismo. Consultava i medium e li invitava a tenere delle sedute alla Casa Bianca, sperando di entrare in comunicazione con gli spiriti dei figli morti. Non solo gli spiritualisti più abili riuscivano a mostrarle Willie ed Eddie e a farla comunicare con loro, secondo Mrs Lincoln, ma la avvertivano anche di nuove pericolose offensive che il generale Lee stava programmando e dei tradimenti in atto fra i ministri di suo marito. «Sono stata avvisata che non c’è uno tra loro, a eccezione dell’ufficiale a capo del servizio postale nazionale, che non pugnalerebbe mio marito alle spalle se ne avesse l’occasione» confessò la first lady a Elizabeth il mattino dopo una seduta. Se la sarta credeva che alcuni spiritualisti possedessero indubbiamente facoltà inspiegabili, sapeva bene che anche prima di quei messaggi dall’aldilà Mrs Lincoln pensava che i ministri fossero motivati da avidità e sete di potere piuttosto che da amore per il paese e lealtà nei confronti di suo marito. Riguardo allo spiritualismo, Elizabeth incoraggiava la consorte del presidente a dimostrare un briciolo di sano scetticismo. Imbroglioni senza scrupoli sfruttavano la credulità di vedove o genitori che avevano perso i figli, interpretando lo squillo di un campanello invisibile o colpi misteriosi come messaggi dei cari defunti, frasi in codice di amore eterno e conforto, quando invece erano i medium stessi a produrre quei rumori con aggeggi nascosti sotto il tavolo. L’estate precedente Mrs Lincoln era per l’appunto stata raggirata da un furfante del genere, un affabile gentiluomo inglese che si faceva chiamare Lord Colchester e affermava di essere il figlio illegittimo di un duca britannico. Si era guadagnato una certa reputazione a Washington per le sue presunte capacità medianiche, così Mary Lincoln un giorno lo invitò alla Casa Bianca per una dimostrazione. Qualche tempo dopo certe voci riguardo al presunto gentiluomo alimentarono i sospetti del presidente, che chiese al dottor Joseph Henry, direttore della Smithsonian Institution, di investigare. A sua volta il dottor Henry chiamò in aiuto Noah Brooks, corrispondente del Sacramento Union e il miglior amico del presidente Lincoln tra i giornalisti. Mr Brooks partecipò a una delle sedute di Lord Colchester in una stanza buia nella residenza di un suo seguace, e quando gli spiriti divennero particolarmente loquaci mise una mano sotto il tavolo, ne afferrò una che stava battendo contro un tamburo con un campanello e gridò: «Accendete un fiammifero!» Prima che qualcuno dei partecipanti esterrefatti avesse la prontezza di reagire, il tamburo si abbatté sulla fronte di Mr Brooks. Quando uno dei presenti si decise infine ad accendere una lampada, illuminò una scena che aveva dell’incredibile: Mr Brooks con il viso insanguinato che teneva stretto per un braccio Lord Colchester. Nel parapiglia che seguì l’inglese riuscì a dileguarsi, ma qualche giorno dopo Mrs Lincoln convocò Mr Brooks alla Casa Bianca. Aveva ricevuto un biglietto da Lord Colchester che le chiedeva di intercedere presso il ministero della Guerra e di procurargli un lasciapassare, facendo capire che in caso contrario non avrebbe esitato a ricattarla. Insieme Mrs Lincoln e Mr Brooks organizzarono la venuta del falso medium alla Casa Bianca, promettendogli il lasciapassare, ma al suo arrivo Mr Brooks lo affrontò, dandogli del truffatore e dell’imbroglione, e gli ordinò di andarsene immediatamente da Washington se non voleva ritrovarsi nella prigione del vecchio Campidoglio. Lord Colchester seguì il consiglio e non causò più alcun fastidio alla first lady. Mentre raccontava alla sua sarta tutta la storia, Mrs Lincoln rideva così di gusto che sembrava che fosse stata vittima di uno scherzo innocuo più che dei raggiri di un ciarlatano. Anche se Lord Colchester era stato smascherato, Mrs Lincoln continuava ad avere fiducia negli altri spiritualisti e a credere che i suoi cari figli Willie ed Eddie le apparissero sul serio, non solo nel bel mezzo di una seduta, ma accanto al suo letto di notte, quando la destavano per assicurarle che erano insieme e felici in cielo. Non tutti i messaggi trasmessi a Mrs Lincoln erano portatori di conforto. Talvolta, arrivando alla Casa Bianca, Elizabeth trovava la first lady pallida e scossa, con ombre scure sotto gli occhi. Significava che la notte precedente aveva avuto terribili premonizioni sull’assassinio del marito. Erano solo incubi, cercava di rassicurarla l’amica, certamente angosciosi, ma nulla più che brutti sogni. La moglie del presidente non ne era convinta, e anche Elizabeth doveva ammettere che esisteva un fondamento reale per quelle paure. C’era la guerra. Abraham Lincoln si muoveva liberamente in una città piena di forestieri e secessionisti. Riceveva regolarmente lettere piene di minacce terribili, anche di morte. A volte gli amici erano così preoccupati che dormivano a turno alla Casa Bianca per vegliare su di lui. Da parte sua, anche se talvolta anche lui aveva sogni premonitori o passava notti insonni, il presidente ignorava i pericoli o li sdrammatizzava ridendo, e mal tollerava le guardie che gli facevano da scorta per gli spostamenti più lunghi. Un pomeriggio, mentre Elizabeth cuciva nel salotto dei Lincoln, la first lady interruppe la conversazione vedendo il marito infilarsi soprascarpe e mantella. «Dove andate, papà?» chiese. «Vado al ministero della Guerra, mamma» replicò lui rassegnato alzandosi mentre si sistemava il colletto, «per vedere se ci sono notizie». «Ma, papà, non dovreste andarci da solo. Sapete che siete circondato dai pericoli». «Sono tutte invenzioni» sentenziò lui. «Perché qualcuno dovrebbe volermi fare del male? Non preoccupatevi per me come se fossi un bambino, perché nessuno mi darà fastidio». Tranquillo, o forse semplicemente fatalista, partì per la sua passeggiata solitaria chiudendosi la porta alle spalle. Mary Lincoln non riusciva a provare la stessa, ostinata sicurezza. Sembrava vedere il pericolo nel fruscio di ogni foglia, nel soffio del vento, ed Elizabeth non se la sentiva di darle torto. 9. Giugno-dicembre 1863 Per mesi il presidente aveva rifiutato di ascoltare chi lo esortava a permettere a schiavi appena liberati o nati liberi di arruolarsi per combattere, ma con il passare del tempo, osservò Elizabeth, la sua resistenza andava scemando. Forse l’aumento delle richieste da parte dei repubblicani radicali, le insistenze di personaggi di spicco della comunità nera come Frederick Douglass, e soprattutto il bisogno disperato di nuovi uomini da parte dell’esercito lo avevano indotto ad adottare una prospettiva più pragmatica e libera da pregiudizi. Uno dei portieri della Casa Bianca disse un giorno a Elizabeth che una volta il vicepresidente Hamlin aveva presentato a Lincoln suo figlio e diversi altri ufficiali bianchi che si dicevano disposti a dirigere compagnie di soldati neri. «Il presidente sembrava molto colpito» le confidò il portiere, «e poi ha detto: “Immagino che i tempi siano maturi”». «Se volete sapere il mio parere, i tempi erano “maturi” già mesi fa, e aspettavano solo che il presidente si decidesse» ribatté bruscamente Elizabeth. Non era da lei criticare Lincoln, che ammirava e rispettava, ma su quell’argomento, come sull’emancipazione, non sopportava i suoi temporeggiamenti dannosi e inspiegabili. Ma come sempre si disse che probabilmente aveva le sue buone ragioni per aspettare. Poi, a fine maggio, il ministero della Guerra emanò l’Ordine 143, che istituiva il Bureau of Colored Troops per reclutare e addestrare uomini di colore. A metà giugno, il primo reggimento di soldati di colore vide la luce a Washington e cominciò l’addestramento sull’isola di Analostan, nel fiume Potomac, vicino alla riva della Virginia, a poca distanza da Georgetown. La loro presenza suscitò l’orgoglio della comunità nera di Washington e dei profughi che vivevano ancora nei campi di ex schiavi. Quando Elizabeth andava nei campi a insegnare e a distribuire prodotti di prima necessità, udiva uomini e donne parlarne come dei “nostri soldati”. Erano diventati i figli e fratelli di ogni famiglia di colore. Quando il tempo divenne afoso, in giugno, Mrs Lincoln si trasferì al Nord, come aveva fatto nelle estati precedenti, per sfuggire al caldo e agli altri inconvenienti dell’estate. Lei e Tad trascorsero una settimana dalla sua amica Sally Orne a Filadelfia, per poi tornare a Washington a preparare il trasferimento estivo della famiglia nel rifugio fresco e tranquillo di Soldiers’ Home. Mentre Mrs Lincoln era assente da Washington, Virginia diede alla luce una bella bambina, che lei e Walker chiamarono Alberta Elizabeth. Il parto fu facile, e madre e figlia erano in ottima salute. Elizabeth si sentì fiera e onorata quando i Lewis le chiesero di essere la madrina di Alberta, e accettò con piacere. Era una fortuna insperata che la nascita coincidesse con l’assenza della first lady, perché Elizabeth fu più libera di occuparsi di Virginia dopo il parto e aiutò Walker a prendersi cura degli altri figli più grandi. Non si aspettava di rivedere Mary Lincoln prima della fine dell’estate o dell’inizio dell’autunno, ma il 2 luglio, quando a Washington si sparse la voce che il generale Lee aveva cominciato ad avanzare verso il Potomac, ricevette la terribile notizia che Mrs Lincoln era rimasta gravemente ferita in un incidente di carrozza. La sarta si precipitò subito alla Casa Bianca, dove trovò la consorte del presidente a letto con la testa fasciata in compagnia dell’infermiera Pomroy. «Mrs Lincoln!» esclamò, andandole subito accanto. «Cos’è successo? State bene?» «Oh, Elizabeth, siete stata buona a venire. Sono un po’ acciaccata, ma sto bene». Era pallida e aveva un’aria preoccupata. Aspettò che l’infermiera uscisse dalla stanza prima di aggiungere: «Io e il presidente eravamo a Soldiers’ Home. Lui voleva prendere la carrozza per venire in città, ma all’ultimo momento ha deciso di precedermi a cavallo, mentre io ho preso la carrozza più tardi». «E Tad?» chiese subito Elizabeth preoccupata. «Era con voi?» «No, grazie al cielo. È rimasto là con degli amici». Mrs Lincoln trasse un lungo respiro tremante. «Andava tutto bene, quando, senza preavviso, i cavalli si sono imbizzarriti e la carrozza è andata in mille pezzi. Sono dovuta saltare giù, altrimenti... altrimenti non so cosa sarebbe successo, non voglio neanche pensarci». «Vi siete fatta male nella carrozza o saltando?» «In nessuno dei due modi» rispose la first lady con un sorriso amaro. «Sono semplicemente caduta male. Sono inciampata e ho sbattuto la testa contro un sasso. Ho perso parecchio sangue e confesso che, dopo, mi sono sentita un po’ confusa, ma per fortuna è accaduto quasi davanti a un ospedale militare, pensate un po’, e alcuni soldati si sono precipitati a soccorrermi». «Grazie al cielo erano proprio lì». «Grazie al cielo, davvero». Mrs Lincoln le prese la mano e la fece sedere accanto al letto. «Elizabeth, ho paura. Non è stato un incidente». La sarta fu percorsa da un brivido. «Cosa intendete?» La voce di Mary Lincoln tremò, e la sua mano strinse quella dell’amica. «Quando sono riusciti a calmare i cavalli, hanno scoperto che qualcuno aveva svitato i bulloni che fissavano il sedile della carrozza. Quando il sedile si è staccato, ha spaventato i cavalli. Ecco perché si sono imbizzarriti e hanno cercato di scappare». «Terribile!» esclamò Elizabeth. «Qualcuno avrebbe cercato di farvi del male apposta?» «Non a me, ma al presidente. Doveva esserci lui a bordo della carrozza, ricordate?» «Oh, Signore». La sarta si sentì venire meno dallo spavento. «Avete idea di chi possa essere il responsabile?» Mrs Lincoln scosse il capo. «Mio marito ha contro la popolazione di interi stati. Il colpevole potrebbe essere l’autore di una di quelle lettere ignobili che ha ricevuto. Avremmo dovuto tenere una lista dei nomi. Oppure potrebbe essere una spia venuta dal Sud e mandata da Jefferson Davis in persona». Elizabeth non riusciva a concepire che il senatore Davis potesse essere il mandante dell’attentato, ma l’aveva conosciuto in tempo di pace, non durante la guerra. Poteva essere cambiato. «A questo punto, mio marito deve per forza accettare di aumentare le guardie del corpo». Mary Lincoln si lasciò ricadere contro il cuscino. «Devo insistere, e non potrà far altro che accettare. Potete immaginare come si senta in colpa sapendo che sono rimasta ferita al posto suo». Elizabeth rise suo malgrado. «Allora direi che dovete sfruttare questo vostro vantaggio». Mrs Lincoln le fece eco, ma con una risata più debole che tradiva una leggera nota isterica. «Non ci avevo pensato. Forse dovrei approfittarne anche per confessargli i miei debiti». «Oh, no, quello no. Per lui sarebbe un colpo anche più duro dell’incidente della carrozza». La malata sorrise, troppo stanca per ridere. Chiuse gli occhi ed Elizabeth le tenne la mano finché non si fu addormentata. Il mattino dopo la convalescente stava molto meglio e riprese i preparativi per una celebrazione grandiosa del giorno dell’Indipendenza. Per la prima volta dopo la morte di Willie aveva accettato che fosse una festa in grande stile, con la banda della Marina che doveva esibirsi sul prato della Casa Bianca, una grande tribuna per il pubblico eretta per l’occasione sul Mall, fuochi d’artificio e una sfilata di reggimenti e di dodici delegazioni di Massoni, Odd Fellows e Union League. Lo spettacolo intendeva stimolare il patriottismo e risollevare il morale della gente, ma con i dissapori crescenti legati alle nuove leggi varate dal Congresso sulla coscrizione e la preoccupazione per l’avanzata sicura dell’esercito dei confederati, qualcuno nelle alte sfere dell’amministrazione premeva per annullare la cerimonia. Tutta Washington era in preda a un’agitazione nervosa quando il generale Lee condusse l’esercito al di là del Potomac in Pennsylvania. Cominciò a farsi strada la certezza che uno scontro militare in quello stato fosse imminente, e la paura per Washington indifesa dilagò. Ma quando il segretario personale del presidente le confidò quelle apprensioni, Mrs Lincoln ribadì decisa che secondo suo marito le forze dell’Unione avrebbero arrestato l’avanzata di Lee, e che loro per primi non dovevano perdere l’ottimismo, altrimenti tutta la città si sarebbe lasciata prendere dalla disperazione. La celebrazione si tenne quindi come previsto, anche se la moglie del presidente non vi prese parte. La mattina del 4 luglio, mentre il marito aspettava apprensivo notizie da Vicksburg, dove Grant stava tentando di sferrare un nuovo attacco alla città, e da una cittadina agricola in Pennsylvania chiamata Gettysburg, dove le forze dell’Unione e l’esercito degli stati confederati stavano combattendo, le condizioni della first lady in seguito alla caduta peggiorarono bruscamente. Mentre Elizabeth era fuori con Emma a godersi la giornata di festa, un messaggero andò a cercarla a casa senza trovarla. Solo a metà pomeriggio seppe che c’era bisogno di lei, e corse alla Casa Bianca. Trovò Mrs Lincoln a letto, febbricitante e agitata. Quella mattina l’infermiera Pomroy aveva scoperto che la ferita si era infettata profondamente, ed era stata costretta a riaprirla per far uscire il pus. La piaga si era infiammata, e Mrs Lincoln soffriva parecchio. Elizabeth le restò accanto quel giorno e il successivo, e in certi momenti la febbre si alzò tanto che il presidente mandò un telegramma a Robert ingiungendogli di tornare a casa subito. Lincoln faceva la spola tra la stanza dove giaceva la moglie e l’ufficio del telegrafo, ma la notizia della vittoria dell’Unione a Gettysburg e del successo, probabile ma non ancora confermato, di Grant a Vicksburg lo distrassero solo momentaneamente dal declino della moglie. Elizabeth assistette l’infermiera meglio che poté, ma con sua grande frustrazione non poteva fare molto, oltre a tamponare la fronte della malata con una pezza umida, leggerle qualcosa, assicurarle che sarebbe andato tutto bene e pregare. Nel giro di pochi giorni il successo del generale Grant a Vicksburg fu confermato e sembrò che le sorti della guerra volgessero finalmente a favore dell’Unione, ma Mrs Lincoln non migliorava e Robert non era ancora arrivato. Preoccupato del fatto che nessuno sapesse dove si trovava suo figlio, il presidente telegrafò di nuovo a Robert, esortandolo a tornare a Washington al più presto. Proprio allora a New York – l’ultimo luogo dove Robert era stato visto – esplosero dei tafferugli per via della coscrizione: per diversi giorni squadre di bianchi, quasi tutti immigrati irlandesi, attaccarono gli uffici di leva, razziarono negozi, distrussero botteghe di proprietari neri, bruciarono un orfanotrofio per bambini di colore e aggredirono i neri per le strade, uccidendone brutalmente più di cento. Alla fine la milizia di stato di New York e altre truppe furono mandate a ristabilire l’ordine, ma quell’ondata di morte e distruzione sconvolse il Nord e alimentò la paura che la coscrizione causasse atti di violenza simili in altre città. Due settimane dopo l’incidente di Mrs Lincoln, il presidente sembrava così provato dalla preoccupazione e dalla tensione che Elizabeth prese a temere per la sua salute, oltre che per quella della moglie. Mentre il Nord celebrava le recenti vittorie militari, Abraham Lincoln si concentrava sulle disgrazie: New York era nel caos più totale, il generale Meade si era lasciato scappare Lee, Robert Lincoln aveva fatto perdere le sue tracce e la first lady si stava spegnendo a causa di un incidente che avrebbe dovuto capitare a lui. Infine, alcuni giorni dopo, Robert arrivò a casa, rassicurando il padre. Se il ragazzo aveva fornito una giustificazione per la lunga assenza e il suo silenzio, Elizabeth non la seppe mai. Grazie alle cure amorevoli prodigate dall’infermiera Pomroy, Mrs Lincoln cominciò a migliorare: la febbre si abbassò, la ferita si chiuse. Con grande sollievo di Elizabeth, ogni giorno sembrava restituirle un po’ più di forza, ma il caldo e l’umidità estivi non le permettevano di guarire del tutto. Quando un’epidemia di malaria si diffuse in città, fu deciso che la first lady non era in grado di sopportare il clima di Washington nelle sue condizioni e che avrebbe dovuto trasferirsi al Nord finché non si fosse ristabilita del tutto. Il presidente diede rapidamente le disposizioni necessarie: non appena fosse stata abbastanza in forze, Robert avrebbe scortato la madre e il fratello minore in una casa di cura a Manchester, in Vermont, un luogo situato fra le splendide Green Mountains e famoso per le proprietà curative delle sue acque minerali. A Elizabeth parve un rifugio fresco che favoriva il riposo, ideale per la convalescenza della sua amica. La sarta preparò il bagaglio della first lady e il giorno della partenza si recò alla Casa Bianca per salutarla. «Dovreste venire con me» la esortò Mrs Lincoln come aveva già ripetuto tante volte. «Mi sento molto meglio in vostra compagnia». Elizabeth era tentata di accettare l’invito, ma aveva preso troppo lavoro dalle altre clienti per fare i bagagli e partire senza preavviso. «Vorrei poter venire» rispose, «ma gli impegni che ho preso mi costringono a rimanere». Mrs Lincoln rispose con un sospiro, e di lì a breve la carrozza portò lei e i figli fino al treno che li avrebbe condotti al Nord. Mentre percorreva a piedi il sentiero davanti alla Casa Bianca per tornare a casa, Elizabeth udì un uomo alle sue spalle dire all’amico: «La strega ha fatto prendere un bello spavento al magnate, eh?» La sarta, ferita, si fermò, si fece forza e si voltò ad affrontarli. «Vi prego» esclamò con voce brusca, guardandoli con furia tranquilla, «non usate mai più quel termine odioso in mia presenza per parlare di Mrs Lincoln!» Riconobbe gli uomini che la fissavano stupefatti, a bocca aperta: erano due segretari alle prime armi che lavoravano in due oscuri ufficetti. Non conosceva neanche i loro nomi, ma era sicura che loro sapessero il suo. «Vi prego di scusarci, signora» balbettò il più giovane dei due. Si toccarono frettolosamente il cappello e la superarono veloci, in preda all’imbarazzo. Elizabeth, dopo essersi sfogata, li guardò allontanarsi e la comicità della scena la indusse a soffocare una risatina. Forse nessuna donna di colore li aveva mai trattati a quel modo. Meglio che si comportassero bene, altrimenti avrebbero sentito parlare ancora di lei. A un tratto si rese conto che aveva rimproverato loro il termine “strega” ma non l’altrettanto irrispettoso, sebbene meno perfido, “magnate”, e a quel punto scoppiò a ridere di cuore. La first lady restò lontana da Washington quasi due mesi. In tutto quel periodo Elizabeth lavorò per altre clienti e dedicò il resto del tempo alla Contraband Relief Association, raccogliendo fondi dagli abolizionisti e dai ricchi neri di tutto il Nord, e insegnando il cucito e altre attività domestiche alle donne e ragazze che vivevano nei campi. Prese con sé come apprendiste alcune donne libere che sembravano brave, e che con i loro guadagni poterono permettersi di trovare un alloggio in pensioni pulite e di fuggire dagli accampamenti dove regnava lo squallore, nonostante i giacigli e altre piccole comodità che Elizabeth e gli altri volontari avevano procurato. Le assistenti rifiorirono grazie alla nuova vita, seguite e guidate da Elizabeth ed Emma, che mostrarono loro tutto ciò che una ragazza di colore doveva sapere per muoversi a Washington. Durante l’assenza di Mrs Lincoln, il presidente fu assorbito dalla guerra e dai suoi problemi. Le vittorie dell’Unione a Gettysburg e Vicksburg gli parvero segnare un’inversione di rotta, ma le settimane che seguirono quei trionfi, molto onerosi in termini di vite umane, non furono prive di sconfitte. L’attacco coraggioso, ma rivelatosi sanguinoso e fallimentare, del Cinquantaquattresimo Massachusetts contro la roccaforte dei confederati, Fort Wagner vicino a Charleston, fu particolarmente terribile da sopportare per la comunità di colore, perché quello era uno dei primi reggimenti ufficialmente neri, e grande motivo di orgoglio per gli americani della stessa razza. Il numero di morti durante l’attacco violento fu altissimo, quindi anche gli episodi di eroismo e coraggio lasciarono un sapore amaro in bocca. Elizabeth era fiera che gli uomini della sua razza avessero compiuto un gesto tanto nobile, spingendo altri neri ad arruolarsi, ma piangeva i morti e pregava per le loro mogli e madri. Poco prima che la first lady tornasse nella capitale, Elizabeth ricevette altre tristi notizie dal fronte, stavolta tragiche per i Lincoln e non per l’Unione in generale. Il cognato di Mary Lincoln, il generale confederato Ben Helm, marito della sua amata sorellastra Emilie, era rimasto ucciso nella battaglia di Chickamauga in Georgia. Anni prima, all’inizio della guerra, il presidente aveva offerto al marito della cognata preferita il prestigioso incarico di tesoriere principale dell’esercito dell’Unione, ma Helm aveva rifiutato e si era invece arruolato con i confederati. Dopo Shiloh era stato promosso generale di brigata e aveva capeggiato la famosa Orphan Brigade, l’unità di fanteria più celebre del Kentucky. Ora era morto, e la loro cara sorellina era in lutto, ma i Lincoln non potevano piangere pubblicamente un ribelle. Solo un paio di giorni dopo il ritorno a casa di Mrs Lincoln, si diffuse la voce che il suo fratellastro, il capitano Alexander Todd, era stato ucciso il giorno prima del cognato generale Helm mentre svolgeva per lui le funzioni di aiutante di campo nella battaglia di Baton Rouge. Aleck era solo un bambino quando Mrs Lincoln se n’era andata da casa, ma il ragazzino allegro con i capelli rossi era stato il beniamino di tutti, ed Elizabeth sapeva che la first lady gli era molto affezionata. Quando la sarta fu chiamata di nuovo alla Casa Bianca, uscì subito dalla pensione, ansiosa di rivedere la sua migliore cliente dopo tante settimane di lontananza. Mrs Lincoln la accolse cordialmente, prendendole le mani nelle sue e sorridendo, dichiarandosi felice di rivederla. Elizabeth fu sollevata nel vedere che sembrava essersi rimessa del tutto, ma aveva un’aria triste che, secondo lei, andava imputata ai lutti recenti. Dopo che ebbero parlato per qualche minuto dell’imminente stagione dei balli, la first lady dichiarò all’improvviso: «Elizabeth, ho appena saputo che uno dei miei fratelli è stato ucciso in guerra». La sarta rimase sbalordita dalla freddezza con cui lo disse. «L’ho sentito anch’io, ma non volevo parlarvene per prima per non farvi soffrire». «Non dovete farvi scrupoli». Mrs Lincoln abbozzò un sorriso rassegnato, ma le tremavano le labbra. «È naturale che mi dispiaccia per un mio parente stretto, ma non al punto che temete voi». Elizabeth non sapeva come reagire. «Davvero?» La moglie del presidente intrecciò le mani in grembo e se le osservò. «Aleck ha fatto questa scelta tanto tempo fa. Ha preso una decisione che è andata contro i voleri di mio marito, e quindi anche i miei. Ha combattuto contro di noi e, poiché ha deciso di essere nostro nemico giurato, non vedo perché dovrei piangere la sua morte». «Suppongo che abbiate ragione» replicò Elizabeth pensosa, combattuta tra il sollievo e il rammarico. Era felice che l’amica non fosse vittima della disperazione assoluta che l’aveva colta dopo la morte di Willie, ma sapeva che soffriva per la morte del fratello, ribelle oppure no. Simulare indifferenza era una mossa destinata ai suoi detrattori, alle masse malevole pronte a criticare qualunque traccia, anche impercettibile, della slealtà della first lady. Ma era una messinscena che con lei poteva evitare, ed Elizabeth era molto dispiaciuta che la sua cliente e amica non se la sentisse di essere perfettamente onesta con lei e di lasciarsi consolare come sarebbe stato necessario. Mesi addietro, in primavera, l’acerrima nemica della first lady in società, Miss Kate Chase, si era fidanzata con il ricco ex governatore del Rhode Island e attuale senatore William Sprague IV e il loro matrimonio, previsto per novembre nel salone della splendida dimora dei Chase, era atteso come l’evento sociale più importante della stagione. Alla cerimonia erano stati invitati cinquanta ospiti, inclusi il presidente Lincoln e consorte, i ministri con le mogli e alcuni senatori, membri del Congresso e generali; altri cinquecento ospiti sarebbero arrivati più tardi per il ricevimento. Elizabeth assicurò alla sua cliente che si sarebbe tenuta libera quel pomeriggio per vestirla, ma Mrs Lincoln le disse che non sarebbe stato necessario. «Credo che avrò un terribile mal di testa quel giorno» confidò con noncuranza. «Ma, Mrs Lincoln» protestò la sarta, «non temete di essere criticata se non ci andate? Ci saranno tutte le persone che contano a Washington». «Ho più paura di quello che direbbe la gente se ci andassi» ribatté la first lady. «Sapete che quei Chase, il padre come la figlia, hanno sempre pensato che la Casa Bianca spettasse loro di diritto. Mr Chase ha trascorso gli ultimi tre anni nella funzione prestigiosa che mio marito gli ha attribuito formandosi una cerchia di sostenitori e preparandosi al suo ruolo di candidato alternativo, e sarebbe ben felice di essere designato. Rifiuto assolutamente di favorire la figlia facendo piaceri politici al padre, e di assecondare il padre dimostrando di frequentare in società la figlia. Sono avversari di mio marito, Elizabeth, e quindi anche miei». Elizabeth capiva il punto di vista della first lady, ma aveva comunque un brutto presentimento. Sebbene la moglie del presidente fosse spesso indisposta, nessuno avrebbe creduto al pretesto di un problema di salute se non si fosse presentata al matrimonio, e i suoi critici avrebbero inevitabilmente inventato qualcuna delle loro teorie strampalate che avrebbe finito per metterla in cattiva luce. Mr Lincoln doveva pensarla come lei, perché quando tutti i suoi tentativi per indurre la moglie ad accompagnarlo fallirono, andò al matrimonio da solo e si trattenne al ricevimento per due ore, quasi per compensare l’assenza della first lady. La sarta avrebbe voluto andare alla cerimonia almeno per osservare i vestiti degli ospiti. Diverse dame si presentarono con abiti di sua creazione – Mary Jane Welles in uno splendido abito di moiré rosa antico, ed Elizabeth Blair Lee con uno strepitoso vestito rosso di seta senza spalline, erano ottime ambasciatrici del suo stile – e sarebbe stata fiera e felice di confrontare il proprio operato con quello di altre sarte specializzate in mantua. Come molti abitanti di Washington che non erano stati invitati, anche lei scorse avidamente le descrizioni del matrimonio sui giornali del giorno dopo. Vi si leggeva che la novella Mrs Sprague era splendida in un abito da sposa di velluto bianco con un velo di pizzo, un anello con un solitario da quattromila dollari che le brillava sulla mano elegante. Quando era entrata nel salone, la banda della Marina aveva suonato The Kate Chase March composta per l’occasione da Thomas Mark Clark. Quasi tutti i giornali pubblicavano l’elenco degli ospiti più illustri, primo tra i quali il presidente Lincoln. Alcuni giornalisti fecero notare che Mrs Lincoln non era presente, e solo uno menzionò perfidamente la sua «improvvisa e strana» malattia e aggiunse un falsissimo augurio per una guarigione rapida dal «malessere misterioso e inopportuno». Fu Tad Lincoln invece ad ammalarsi sul serio pochi giorni dopo il matrimonio. I suoi sintomi ricordavano la malattia di cui aveva sofferto nell’inverno del 1862, quella che aveva tolto la vita al fratello, e i genitori provarono un’angoscia crescente vedendolo peggiorare in quel modo tanto familiare. Elizabeth si prese cura di lui come aveva fatto col fratello, e anche l’infermiera Pomroy era sempre reperibile. Il presidente aveva accettato di pronunciare qualche parola all’inaugurazione di un nuovo cimitero nazionale a Gettysburg, ma il giorno prima della partenza la moglie lo implorò di non andare. «Mamma, è mio dovere» Elizabeth lo sentì dire alla consorte, e quando lei scoppiò in lacrime e dichiarò che era migliore come burocrate che come padre, l’espressione dolente e abbattuta nei suoi occhi ferì a tal punto la sarta da indurla a distogliere lo sguardo. Non aveva mai conosciuto un uomo con una simile bontà e nobiltà d’animo, e si chiese perché Mrs Lincoln sembrasse talvolta cieca alle qualità eccellenti del marito. Con il passare del tempo la sarta aveva capito che il presidente era estremamente altruista, e che amava con tutto il cuore la moglie e i figli. Per sé non chiedeva mai nulla se non l’affetto della consorte, ma non sempre veniva accontentato. Quando Mary Lincoln aveva uno di quei suoi momenti di impulsività, diceva e faceva cose che ferivano profondamente il marito. Se lui non l’avesse tanto amata non avrebbe sofferto della sua scarsa sensibilità, invece teneva a lei e all’opinione che aveva di lui. Spesso lo feriva involontariamente, ma dopo, riflettendo con calma, rimpiangeva le proprie parole crudeli. E quello, si disse Elizabeth, ne era proprio il classico esempio. Il giorno dopo la sarta arrivò alla Casa Bianca e trovò Tad a letto, Mrs Lincoln isterica e il presidente che con aria abbattuta si preparava a partire per la stazione. «Tad stava troppo male per fare colazione stamattina» le rivelò la first lady torcendosi le mani e tornando a rivolgersi al marito. «Vi prego, papà, non andate. Mr Everett potrà fare il discorso al posto vostro. Avete detto voi stesso che il vostro intervento ha un’importanza secondaria. Non si accorgeranno della vostra assenza». «Non credo di peccare di presunzione se mi illudo del contrario» ribatté lui, indossando con mosse stanche la giacca e il cappello. La moglie smise di camminare avanti e indietro per ricevere il bacio del marito, ma non appena se ne fu andato scoppiò in lacrime. Elizabeth si precipitò da lei con un fazzoletto, la accompagnò a sedersi sul divano e cercò di calmarla con parole di conforto, ma Mrs Lincoln era ormai in uno stato tale di agitazione che nulla pareva placarla. Alla fine l’amica la persuase a restare seduta tranquilla, le fece preparare una tazza di tè e verso mezzogiorno, l’ora in cui doveva partire il treno presidenziale, si era calmata. Ricordando a Mrs Lincoln che doveva restare serena per non spaventare il figlio, la sarta la accompagnò nella stanza di Tad, che si rizzò subito a sedere e chiese qualcosa da mangiare. Il sollievo trasfigurò Mrs Lincoln: sembrava che dal suo viso si fossero dissipate le nubi, scacciate da un raggio di sole. Mandò subito a dire in cucina di preparare i piatti preferiti del figlio, e quando gli furono portati su un vassoio il bambino mangiò lentamente ma con appetito. Non appena tornò a sdraiarsi la madre e la sarta uscirono dalla stanza affidandolo alle cure dell’infermiera Pomroy. «Mr Lincoln non stava bene stamattina» disse sottovoce la first lady mentre tornavano in salotto. «Spero che non si stanchi troppo durante questo viaggio». Elizabeth annuì, facendo attenzione a mantenere un’espressione neutra. Proprio come aveva previsto, ora che la crisi era passata Mary Lincoln si era pentita delle parole dure che aveva rivolto al marito prima della partenza. «Mr Hay e Mr Nicolay si prenderanno cura del presidente» ricordò la sarta alla first lady. «Viaggiano con lui, no?» «Oh, sì. Sono un bel gruppo». Lo disse con voce carica di sottintesi. «Anche se sono meno del previsto». «Tad stava troppo male per viaggiare» protestò Elizabeth, «e voi dovevate stare qui per prendervi cura di lui». «Oh, ma non stavo parlando di noi, Elizabeth. Qualcun altro, che era stato invitato a partecipare, ha declinato l’invito del presidente». «Chi?» domandò l’amica, stupita. «E perché? Mi sembra che sia un onore viaggiare con il presidente in un’occasione tanto importante». «Pare anche a me, a meno che non si tratti del ministro Chase – non che il suo rifiuto mi stupisca –, del ministro Stanton o del ministro Stevens, che un tempo era un amico fidato». Mrs Lincoln abbassò la voce. «Non credono che mio marito sarà rieletto, e vogliono prendere le distanze da lui in modo che il suo presunto fallimento non intacchi la loro immagine». «Certo che vincerà!» esclamò Elizabeth indignata. «E per quanto riguarda quelle persone, sono scandalizzata dalla loro slealtà dopo tutto quello che ha fatto per loro». «Con qualche rara eccezione – rarissima, anzi – i ministri non sono leali a nessuno se non a se stessi» replicò Mrs Lincoln con aria truce, poi tacque per qualche istante, riflettendo. «Credo che manderò un telegramma a mio marito per annunciargli che Tad sta meglio. Questo lo rasserenerà, ne sono sicura». Elizabeth le diede ragione, contenta che la first lady pensasse ai sentimenti del marito e alle sue difficoltà costanti invece che alle proprie. Tad continuò a migliorare, ma due giorni dopo il presidente tornò da Gettysburg con la febbre, che si trasformò quasi subito in vaioloide, una forma attenuata di vaiolo. Fu messo in quarantena nella Casa Bianca per tre settimane, ma sua moglie confidò a Elizabeth che era piuttosto su di morale. Da quando era presidente, aveva osservato, era sempre assillato da gente che voleva qualcosa da lui. «Che vengano pure i questuanti» scherzava con un filo di voce dal letto dove giaceva. «Ho qualcosa da dare a tutti loro». Durante la prima settimana di ottobre, non molto tempo dopo il ritorno di Mrs Lincoln a Washington, il presidente aveva emesso il Proclama del Ringraziamento. Nonostante la distruzione causata dalla guerra, aveva detto, l’anno 1863 era stato positivo, grazie all’ottimo raccolto, allo sviluppo regolare dell’industria, all’ampliamento dei confini nazionali, all’aumento della popolazione e alla ricchezza dei giacimenti minerari. Anche nel bel mezzo di una guerra civile di una violenza senza precedenti, era stata mantenuta la pace con gli altri paesi, era stato mantenuto l’ordine in tutta la nazione al di fuori delle zone di guerra, ed erano state create, rispettate e obbedite delle leggi. «Mi è parso opportuno» dichiarò il presidente «che quei doni da parte di un Signore misericordioso debbano essere accettati in modo solenne, rispettoso e con estrema gratitudine, con un solo cuore e una sola voce da parte di tutto il popolo americano. Invito quindi i miei concittadini in ogni punto degli Stati Uniti, e anche quelli che si trovano per mare o in paesi stranieri, a considerare l’ultimo giovedì del prossimo novembre come un giorno di ringraziamento e di elogi al nostro magnanimo Padre che vive in cielo». Dopo la pubblicazione del proclama, Mrs Lincoln ed Elizabeth si trovarono d’accordo nel considerarla un’ottima idea, ma quando arrivò il giorno che aveva riservato alla Festa del Ringraziamento il presidente si trovava ancora a letto malato. Elizabeth immaginò che rendesse comunque grazie, per il miglioramento della salute di Tad, per i recenti successi militari che lasciavano intravedere un barlume di speranza quanto alla vittoria dell’Unione, per i consiglieri saggi, e soprattutto, bene ancora più raro, per gli amici leali che davano buoni consigli. Quel giovedì del Ringraziamento Elizabeth partecipò a una cerimonia speciale in chiesa. Tra le molte fortune per le quali ringraziò il Signore c’era il presidente Abraham Lincoln. Non riusciva a immaginare un uomo migliore di lui per guidare la nazione in quegli anni oscuri. Un giorno burrascoso di dicembre poco dopo quella data, Elizabeth si stava recando nel salotto della Casa Bianca dove era solita cucire quando un servitore la prese da parte e la avvertì che Mrs Lincoln aveva visite, e che per tutta la mattina si era sentito piangere, a tratti, attraverso la porta chiusa. Elizabeth lo ringraziò e si preparò mentalmente prima di girare la maniglia. Dentro trovò la first lady seduta sul divano, con le mani strette in quelle di una donna più piccola tutta vestita di crespo nero. Dimostrava vent’anni meno di Mrs Lincoln, e aveva i capelli scuri e il viso dolce, le guance pallide e occhi grandi, tragici, cerchiati di rosso. Le due donne erano immerse nella conversazione, ma sentendo la porta aprirsi tacquero subito e si girarono verso di lei. «Ah, Elizabeth» disse Mary Lincoln alzandosi, lasciando però la mano tra quelle della visitatrice. «Permettetemi di presentarvi la mia cara sorella, Mrs Emilie Helm». «Piacere, Mrs Helm» disse Elizabeth affabile, con un cenno educato del capo, ma la donna era troppo sconvolta per reagire se non stringendo le labbra, un gesto che voleva essere insieme un sorriso e un modo per ricambiare il saluto. La first lady attraversò la stanza, prese il gomito della sarta e la riaccompagnò alla porta. «Mia sorella e sua figlia sono arrivate solo ieri, e abbiamo molte cose da raccontarci. Potreste tornare domani, o meglio ancora il giorno dopo? E per favore...» abbassò la voce fino a ridurla a un bisbiglio. «Ecco, sarebbe bene che non si sapesse in giro che la mia sorellina è qui con noi». Elizabeth acconsentì, vagamente divertita, e tornò a casa. Aveva lavorato molte volte in presenza degli ospiti di Mary Lincoln, ma evidentemente Mrs Helm non era una visitatrice come le altre, essendo la vedova di un generale della Confederazione. La sarta si chiese come avrebbe interpretato la stampa il suo soggiorno alla Casa Bianca. Due giorni dopo Elizabeth riprese a lavorare dalla first lady e in breve ricostruì la storia dell’arrivo di Mrs Helm alla Casa Bianca. La giovane vedova e sua figlia si stavano dirigendo verso la casa della matrigna di Mary Lincoln, nel Kentucky, quando erano state fermate alla frontiera perché la vedova si era rifiutata di giurare fedeltà agli Stati Uniti. Quel gesto avrebbe significato disonorare il ricordo dell’adorato marito, insisteva Mrs Helm, e siccome le guardie di frontiera, spiazzate, non sapevano cosa fare di lei, l’avevano trattenuta a Fort Monroe, sperando che cambiasse idea e prestasse giuramento, in modo da lasciarla ripartire. Vedendo che la donna non cambiava idea, telegrafarono al presidente Lincoln chiedendogli come comportarsi. La sua risposta via telegrafo non si fece attendere: «Mandatemela qui». Entrambi i coniugi Lincoln adoravano la giovane vedova che chiamavano “sorellina”, e traevano conforto dalla sua presenza. Ambedue erano ansiosi di chiederle la sua opinione sulla salute dell’altro; a Mary, Mrs Helm disse che il presidente sembrava in forma, anche se era dimagrito, ma quando Abraham Lincoln le confidò che la moglie aveva i nervi a pezzi, replicò che effettivamente sua sorella le era parsa molto nervosa ed eccitabile, e quel suo insistere sul fatto che vedeva gli spiriti di Willie ed Eddie in fondo al letto di notte era molto preoccupante. Con il passare dei giorni Elizabeth udì il presidente implorare Mrs Helm di prolungare il soggiorno, perché la moglie sembrava stare meglio in sua compagnia. Anche la sarta aveva notato un cambiamento notevole nel suo comportamento dall’arrivo della sorella, ma aveva percepito anche una certa tensione in casa. Per tutta Washington si era diffusa la notizia che i Lincoln ospitavano sotto il proprio tetto una ribelle, la quale non aveva la minima intenzione di ricredersi, e questo aveva alimentato il malumore, il disprezzo e ulteriori commenti sulla lealtà della first lady. Un mattino Tad e sua cugina si misero a litigare su chi fosse il vero presidente, il padre di Tad o Jefferson Davis. Il bisticcio più grave, però, fu quello che si svolse nella Blue Room una sera, e che Mrs Lincoln descrisse a Elizabeth il giorno dopo. Il senatore Ira Harris, padre di un colonnello del reparto munizioni e patrigno di un ufficiale del Dodicesimo Reggimento di Fanteria, e il generale Daniel Sickles, che aveva perso una gamba a Gettysburg, erano andati alla Casa Bianca per incontrare Mrs Helm, ufficialmente per chiedere notizie di amici comuni. La conversazione aveva preso una piega sconcertante quando il senatore Harris, forse per effetto di un eccesso di alcol, aveva cominciato a stuzzicare la vedova elogiando le recenti vittorie dell’Unione a Ovest, dove suo marito era stato ucciso. «Ah, signora» le aveva detto, guardandola fissa. «Se avessi venti figli, combatterebbero tutti contro i ribelli». «E se io avessi venti figli, senatore Harris» aveva risposto lei in lacrime, «si schiererebbero tutti contro i vostri». «A quel punto» raccontò Mary Lincoln a Elizabeth, «il senatore Harris ha guardato me e mi ha chiesto perché Robert non si era arruolato!» «Oh, cielo!» esclamò Elizabeth. «E voi cos’avete risposto?» «Gli ho detto che Robert non è uno scansafatiche e che si sta apprestando a entrare nell’esercito. Ho precisato che, se non l’ha fatto finora, è soprattutto colpa mia: sono stata io a imporgli di restare ancora un po’ all’università, perché un uomo istruito è più idoneo a servire il paese di uno ignorante. Il senatore si è limitato a tossicchiare in modo carico di sottintesi. Avrei voluto fare una battuta più arguta, ma sul momento ero troppo turbata. Robert sa che lo criticano perché non è soldato, e si arruolerebbe subito se glielo permettessi». Mrs Lincoln si torse le mani, accigliata. «Ho paura che uno di questi giorni mio marito mi scavalchi e gli consenta di andare in guerra». «Forse il presidente potrebbe usare la propria influenza per trovargli un posto dove Robert non corra rischi». «Non credo che esista un posto sicuro nell’esercito, oggi. E poi, dopo che il senatore Harris mi ha tormentato con la sua domanda, il generale Sickles è uscito zoppicando per andare a infastidire mio marito a letto». «No!» «Sì! Vi rendete conto dell’impudenza? Il generale è andato a chiedere a mio marito, che giaceva a letto malato, nella sua stanza, come poteva tenersi in casa una ribelle. Mio marito gli ha riservato tutta la cortesia che si deve usare a un veterano mutilato, ma poi gli ha detto, in tono che non ammetteva repliche: “Scusatemi, generale Sickles, ma io e mia moglie siamo abituati a decidere da soli chi ospitare”». «Mrs Helm fa parte della famiglia» ribadì Elizabeth. «Unione o Confederazione, la famiglia viene sempre per prima». «Oh, Elizabeth...» La first lady scosse il capo sconsolata. «Se tutti la pensassero come voi, non ci sarebbe forse nessuna guerra. Potrei riempire pagine e pagine se elencassi tutte le famiglie di mia conoscenza che sono state divise da questa guerra. Comincerei con la mia e andrei avanti fino ad avere il cuore infranto». Verso la fine del mese la tensione in casa Lincoln arrivò a un punto tale che Mrs Helm tornò nel Kentucky. Prima di partire acconsentì a prestare il giuramento di fedeltà, e così il presidente le accordò l’amnistia. Dopo la partenza della sorellina, Mary Lincoln confessò rattristata alla sarta che sarebbe stato bello se fosse potuta restare per il periodo delle vacanze, per aiutarli a ritrovare un po’ di gioia in quelle ricorrenze, ma non era stato possibile. All’avvicinarsi del Natale, però, grazie anche alla guarigione di Mr Lincoln, e lasciatasi alle spalle per un altro anno lo scoglio del compleanno di Willie con i ricordi tristi di tutto ciò che avevano perso, lo spirito natalizio operò la sua magia sulla first lady. Una mattina annunciò che il 1° gennaio avrebbe cessato di vestirsi a lutto, per iniziare bene l’anno nuovo. Entusiasta, Elizabeth cominciò subito a lavorare su un nuovo abito, da indossare per il ricevimento di Capodanno. Che piacere sarebbe stato vestire la sua cliente più in vista con qualcosa di diverso dal crespo e dalla seta nera, dopo tanto tempo! Il vestito sarebbe stato magnifico: un prezioso velluto viola adornato di pizzo valencienne e applicazioni di raso arricciato, con un lungo strascico, e un’acconciatura con una grande piuma bianca. «Porterà fortuna cominciare il nuovo anno con abiti nuovi» dichiarò la sarta mentre le drappeggiava addosso la mussola della fodera per le misure. La first lady sospirò. «La fortuna non sarà sufficiente se vogliamo che mio marito vinca la guerra e conservi la presidenza nell’anno a venire». «Questo è vero» replicò Elizabeth stringendo due pieghe di tessuto tra pollice e indice e fissandole con uno spillo. I Lincoln avrebbero avuto bisogno anche di perseveranza, duro lavoro, fiducia e coraggio. Senza quelle doti, tutta la fortuna del mondo non sarebbe bastata. 10. Gennaio-novembre 1864 Gli ospiti che parteciparono al ricevimento di Capodanno notarono subito che la first lady aveva smesso il lutto, come secondo molti avrebbe già dovuto fare da un pezzo. Elizabeth sapeva che, sebbene soffrisse ancora tanto per la morte di Willie, le esigenze legate all’elezione imminente la costringevano a rinunciare al sollievo che le procurava quel rituale per il bene del futuro politico del marito. La candidatura e la rielezione del presidente Lincoln non erano per niente sicure. La storia e le consuetudini gli erano nemiche: l’ultimo presidente rieletto una seconda volta era stato Andrew Jackson nel 1832, più di trent’anni prima. L’opinione popolare nei confronti di Lincoln oscillava in base all’andamento della guerra: godeva di grande popolarità dopo le vittorie, e crollava nella stima della gente in occasione delle sconfitte. Ora che il successo dell’Unione sembrava concretizzarsi, il dibattito politico aveva cominciato a interessarsi all’integrazione del Sud nell’Unione alla fine del conflitto. Si stavano facendo progetti per la ricostruzione in Tennessee, in Louisiana e in Arkansas, già largamente sotto il controllo dell’esercito federale, ma non tutti condividevano l’approccio di Lincoln. Essendo il presidente in carica, non poteva evitare di essere incolpato per ogni sconfitta militare, e perfino per ogni successo parziale ma non abbastanza rapido. I democratici liquidarono tutto il periodo del mandato presidenziale come un fallimento totale – un giudizio scorretto ma prevedibile, vista la fonte –, ma perfino il suo partito aveva vedute diverse sul bilancio del periodo che Lincoln aveva trascorso alla testa del paese. I repubblicani radicali protestavano sostenendo che fosse troppo tollerante nei confronti dei confederati vinti, e che i suoi progetti per la ricostruzione postbellica mancassero di rigore. Per assicurarsi la rielezione, Lincoln doveva convincere i repubblicani a fare fronte comune con lui, un progetto per niente facile da realizzare. La first lady decise di fare tutto il possibile per aiutarlo. Nei giorni freddi e grigi dell’inizio di gennaio riprese l’abitudine delle visite domenicali, assicurandosi di invitare tutti coloro che avrebbero potuto sostenere suo marito. Il primo ricevimento dell’anno fu organizzato il 9 gennaio, seguito da una serie di balli e cene che diedero inizio alla stagione invernale degli eventi sociali. Mrs Lincoln accettò tutti gli inviti che poté, senza esagerare, e ricevette i suoi ospiti in grande stile; inviò inoltre lettere cortesi e mazzi di fiori colti nella serra della Casa Bianca a personaggi di spicco del governo e dell’imprenditoria. Era inevitabile che i piani della first lady creassero dei dissapori con i ministri del marito, che avevano idee diverse sul calendario sociale del presidente. Il conflitto peggiore, e quello che lasciò più tracce su Mrs Lincoln, fu con John George Nicolay, il segretario particolare del presidente incaricato di organizzare le cene di stato. Ostinatamente decisa a ostacolare tutte le ambizioni del ministro Chase, Mrs Lincoln disse a Mr Nicolay di non invitare lui, la figlia o il cognato a una cena per i membri del governo organizzata per la fine di gennaio. Nicolay si oppose, spiegando alla first lady che non poteva escludere uno dei ministri, non solo perché ciò era contrario alla tradizione, ma perché avrebbe fatto apparire il presidente come un uomo vendicativo e timoroso di un potenziale rivale. Mary Lincoln insistette, ed Elizabeth ebbe l’ingrato privilegio di assistere a più di un litigio tra lei e l’inflessibile segretario che – mai al cospetto della first lady, ma in presenza di altro personale della Casa Bianca – cominciò a chiamarla Sua Maestà Satanica. Quando il presidente venne a sapere del conflitto, vi mise fine bruscamente ordinando a Nicolay di invitare Chase insieme agli Sprague e ingiungendo a sua moglie di lasciar cadere la faccenda. «Vedete anche voi che non ho potere in questa casa di uomini» si lagnò con Elizabeth, sentendosi amareggiata e umiliata. «Tutto quello che faccio è per il bene di mio marito, ma quando non mi scavalcano mi ignorano completamente». Elizabeth cercò di consolarla meglio che poté – anche se pensava che avesse commesso un errore tattico nel tentare di escludere Mr Chase con la sua famiglia – ma Mary Lincoln si tormentò a tal punto per l’accaduto che non dormì per le due notti successive. A suo merito va detto che scrisse a Mr Nicolay un biglietto di scuse, che gli fece pervenire tramite il portiere della Casa Bianca. Se il segretario le rispose, gentilmente o meno, la moglie del presidente non lo disse mai a Elizabeth. Per quanto la first lady rimpiangesse il litigio con Mr Nicolay, rimase piena di antipatia e diffidenza nei confronti del ministro Chase, ed esortò il marito ad appurare se gli fosse leale. «Se pensasse che gli torna utile, vi tradirebbe domani» insistette. «Non sono l’unica ad avervi avvertito». Era vero, perché in molti si erano accorti delle ambizioni politiche di Chase. Per mesi aveva viaggiato in lungo e in largo per il Nord, facendo discorsi e raccogliendo consensi, esprimendo la speranza che il presidente Lincoln venisse rieletto e nascondendo la propria intenzione di candidarsi. Mr Chase godeva delle simpatie degli abolizionisti e dei repubblicani radicali, secondo cui il Proclama di Amnistia e Ricostruzione che il presidente Lincoln aveva emesso nel dicembre precedente era troppo cauto e blando. Perfino a Elizabeth appariva chiaro che il presidente disapprovava quella campagna elettorale sotterranea che faceva Chase, ma sembrava che osservasse le attività del ministro con una tolleranza attenta e tuttavia benevola, aspettando di vedere se le sue scorrettezze diventavano troppo appariscenti. Per sua moglie, il comportamento del ministro era già inaccettabile. «Perché non chiedete le sue dimissioni?» gli domandò durante una discussione particolarmente accesa. La turbava molto che il ministro mostrasse una simile mancanza di rispetto al marito, e non riusciva a capire per quale motivo il presidente tollerava che un rivale continuasse a occupare una posizione influente e ben pagata che gli permetteva di aumentare ogni giorno il proprio potere. «Mandarlo via e riconoscere apertamente che è il mio avversario per la candidatura?» replicò Lincoln. «Non sono pronto a dimostrarmi così poco sicuro dell’appoggio del popolo». La spinosa discussione fu affrontata un’altra volta, mentre Elizabeth stava preparando la first lady per una serata di gala. «Perfino il dottor Henry ritiene che si sia comportato in modo tanto inammissibile che meriterebbe di essere cacciato dal governo» dichiarò la first lady al marito mentre Elizabeth le legava un fiocco di raso in vita. Il dottor Anson Henry era un amico di famiglia di vecchia data originario dell’Illinois, e medico personale, fidatissimo, del presidente. «Ha scoperto che i collaboratori di Mr Chase hanno diffuso delle voci poco gentili sul mio conto, quindi stavolta non potete dire che si tratta di una mia invenzione». «Non vi direi mai una cosa del genere, mamma» le fece notare pacatamente Lincoln. «Forse non lo direste a me, papà, ma agli altri sì, o magari lo pensate» ribatté. «Dovete promettermi di liberarvi del ministro Chase una volta per tutte». «Non posso, e non intendo farlo, mamma». Nessuno degli argomenti della moglie riusciva a far presa su di lui, così alla fine lei levò le braccia in aria in un gesto di stizza e si ritirò all’altro capo della stanza, inviperita. Allontanò la sedia dalla scrivania con uno strattone, si sedette rigida e cominciò a scrivere furiosamente una lettera; visto il suo umore, Elizabeth non si azzardò ad avvicinarsi per vedere chi fosse il destinatario. Dopo un attimo Abraham Lincoln sospirò e si sedette faticosamente sulla sua poltrona. «Ebbene, madame Elizabeth» le chiese con voce arrochita ed esausta. «Mi spazzolate questi capelli ispidi stasera?» «Certo, signor presidente». Elizabeth impugnò spazzola e pettine e gli mise in ordine la capigliatura meglio che poté. Mentre lei si dava da fare Mr Lincoln serbò un silenzio tetro e imbronciato, finché a un certo punto un debole sorriso gli increspò le labbra e disse: «Madame Elizabeth, voi avete vissuto in una fattoria, vero?» «Sì, signor presidente» rispose. «Quando ero bambina, in Virginia». «Allora sapete cos’è un tafano». Elizabeth sorrise. «Purtroppo, signore, conosco bene quelle fastidiose bestiole». «Quando ero bambino, una volta io e mio fratello stavamo arando un campo, lui governava l’aratro e io conducevo il cavallo» ricordò il presidente. «Il cavallo era un pigrone, ma una volta corse fino in fondo al campo tanto velocemente che, pur correndo più rapido che potevo, non riuscivo quasi a tenergli dietro. Quando lo raggiunsi vidi che gli si era posato sopra un tafano enorme, e lo mandai via. Mio fratello mi chiese perché lo avessi fatto. Gli dissi che non volevo che il povero cavallo, già vecchio, fosse morso dall’insetto. «Ma Abe» obiettò mio fratello, «è quello che lo faceva correre!» La sarta rise. «Ora, madame Elizabeth» continuò Mr Lincoln, più allegro di quanto non fosse stato fino a quel momento, «se Mr Chase ha il tafano della presidenza che lo morde, non intendo cacciarlo via, perché forse è quello che fa andare avanti il ministero del Tesoro». Elizabeth rifletté. «A volte un tafano può diventare tanto fastidioso che, se il cavallo agita la coda e torce il collo per morderlo, è così impegnato nel cercare di liberarsi dell’insetto che dimentica di arare». Mr Lincoln prese un’espressione pensosa. «Immagino che, in questo caso, sarebbe giusto ammazzare subito il tafano. Il trucco sta nel capire in quale momento smette di essere un aiuto e comincia a diventare una scocciatura». «Per fortuna siete un esperto di tafani, voi!» esclamò Elizabeth con un briciolo di impudenza, facendo ridere il presidente. All’altro lato della stanza, Mary Lincoln fece un lungo sospiro carico di esasperazione. A mano a mano che l’inverno tetro e fangoso andava avanti, cominciò ad apparire chiaro che i “tafani della presidenza” non erano gli unici insetti nocivi a stimolare il ministero del Tesoro. Per mesi erano circolate a Washington delle voci su irregolarità in campo finanziario e immoralità tra il personale del ministero. Un cittadino indignato scrisse al presidente Lincoln accusando il ministro Chase di speculazione in azioni, oro e cotone. Si diceva che le impiegate venissero ingaggiate per la loro bellezza invece che per le capacità, e diversi signorine affermarono di essersi viste rifiutare un posto di lavoro finché non avevano ceduto agli abbracci appassionati del sovrintendente dell’ufficio preposto alla stampa e al taglio delle banconote. (Quando Elizabeth venne a saperlo, fu sollevata all’idea di non essere stata assunta nel reparto taglio banconote l’anno prima.) Peggio ancora, decine di impiegate giovani e nubili erano incinte, si mormorava. Allarmato, Mr Chase incaricò un investigatore del ministero della Guerra di far luce sulle accuse, e quando il detective trovò effettivamente scandali e situazioni inaccettabili ovunque, una commissione speciale di membri del Congresso iniziò un’indagine formale. Dopo aver udito la deposizione di una serie di testimoni, tra cui due giovani impiegate che giurarono di essere state costrette a incontri intimi con il loro datore di lavoro, la commissione non riuscì a stabilire in modo unanime se le accuse fossero vere o false. Il pubblico preferì credere alla versione più scandalosa e salace degli eventi; quindi, anche se il ministero del Tesoro non era il «bordello più grande della nazione», come sosteneva un detrattore, la sua reputazione era rovinata, così come quella di Mr Chase, proprio nel momento in cui voleva apparire un dirigente responsabile e degno di fiducia. Un uomo più cauto avrebbe forse messo in sordina le proprie ambizioni politiche nei confronti della presidenza, almeno finché lo scandalo successivo non avesse distratto l’opinione pubblica, ma Chase non lo fece, e i suoi alleati più convinti lo spinsero ad andare avanti. I suoi amici nel Congresso organizzarono una commissione per promuovere la candidatura, e Mr Chase incoraggiò in questo senso i sostenitori, pur non partecipando direttamente alle loro attività, talvolta condotte a sua insaputa. In febbraio gli organizzatori della campagna stesero e misero in circolazione due documenti: uno criticava il primo mandato del presidente Lincoln senza parlare del ministro Chase, mentre l’altro divenne famoso come la “circolare Pomeroy”, dal nome del suo autore, il senatore del Kansas Samuel C. Pomeroy, responsabile della campagna elettorale di Chase. La circolare Pomeroy criticava il presidente Lincoln e presentava Chase come «statista di rara abilità e amministratore di prim’ordine», che possedeva «più qualità necessarie a un presidente nei prossimi quattro anni di quelle che si trovano combinate in qualunque altro candidato». Affermava che la rielezione di Lincoln sarebbe stata quasi impossibile, e che per evitare il disastro di una vittoria dei democratici radicali in novembre tutti i repubblicani leali dovevano unirsi e sostenere Chase per assicurarsi che vincesse. Se i sostenitori di Mr Chase avevano sperato di mantenere confidenziale il contenuto dei documenti, peraltro distribuiti in gran numero, ebbero una delusione cocente. La circolare Pomeroy fu trasmessa agli organi di stampa e pubblicata sul National Intelligencer e su altri giornali. I lealisti dell’Unione, che ricevettero copie del documento per posta in buste stampigliate con il timbro dei sostenitori di Chase al Congresso, le trasmisero scandalizzati a Lincoln alla Casa Bianca, spesso con un biglietto che esprimeva il loro disgusto per Chase e la loro incrollabile lealtà nei confronti del presidente. Elizabeth seppe che le voci sull’intrigo avevano messo in grande imbarazzo Mr Chase, e intuì da conversazioni smozzicate nel salone di casa Lincoln che il ministro aveva scritto al presidente dichiarando la propria totale estraneità alla circolare Pomeroy fino a quando non erano stati i giornali a divulgarla. La sarta sapeva anche che, dopo avere ricevuto la lettera contrita di Chase, Lincoln aveva replicato con un breve biglietto di avvenuta ricezione, ripromettendosi di scrivergli una lettera più lunga non appena ne avesse avuto il tempo. La lettera partì circa una settimana dopo, da quanto sapeva Elizabeth, ma la sarta ne ignorava il contenuto e non poteva certo chiederlo. Quasi ogni segreto che conosceva sul funzionamento della Casa Bianca l’aveva appreso per sbaglio, trovandosi per caso presente quando erano state pronunciate frasi importanti. Qualunque cosa il presidente avesse detto a Mr Chase, le conseguenze dello scandalo furono meno tragiche di quello che la first lady aveva sperato, perché egli rimase ministro del Tesoro. «Non so come mio marito sopporti di essere nella stessa stanza con un traditore di tal fatta» borbottò Mrs Lincoln risentita a Elizabeth un giorno, alla fine di febbraio, quando si rese conto che Chase sarebbe rimasto. Questi però cambiò atteggiamento, diventando molto meno presuntuoso, e il 5 marzo annunciò pubblicamente che non si sarebbe candidato alla presidenza da parte repubblicana. «È già qualcosa» commentò Mrs Lincoln, più allegra. L’incidente aveva indotto i sostenitori più ferventi di Lincoln ad appoggiarlo conducendo loro stessi la campagna elettorale negli stati rispettivi, ma anche adesso che Chase era fuori gara il risultato era incerto. Un piccolo gruppo di repubblicani sollecitò il vicepresidente Hannibal Hamlin a presentarsi, ma lui interruppe subito la manovra, affermando di sostenere il presidente. Alcuni repubblicani radicali appoggiavano invece il generale Benjamin Butler, comandante militare unionista di New Orleans, che secondo loro era in grado di unire i democratici favorevoli al conflitto e le ali radicale e moderata del partito repubblicano. Il generale si era guadagnato consensi per la sua intransigente opposizione allo schiavismo e per l’occupazione di Baltimora e New Orleans, ma quando non riuscì a conquistare la desiderata popolarità, rifiutò le avances di quelle fazioni. In febbraio il New York Herald aveva invocato la candidatura di Ulysses S. Grant, ma l’idea sembrò far inorridire il generale, che insistette pubblicamente e con tenacia sul fatto che la rielezione di Lincoln era essenziale per la causa dell’Unione. La presa di posizione fu molto gradita a Mrs Lincoln, che criticava spesso il generale Grant, considerandolo un macellaio che non si curava di quanti soldati finissero uccisi pur di vincere. Elizabeth aveva spesso sentito dire alla first lady che se mai il generale Grant fosse stato eletto presidente degli Stati Uniti, lei avrebbe voluto lasciare il paese e restare all’estero fino al termine del suo mandato. John C. Frémont, che era stato il primo candidato repubblicano alla presidenza nel 1856, agli albori del partito, era molto popolare tra gli abolizionisti come quelli che abbondavano tra la popolazione di origine tedesca di Saint Louis. A differenza del generale Grant, il generale Frémont era dispostissimo a sostituire il proprio superiore. Per anni aveva covato risentimento nei confronti del presidente, che aveva revocato il suo proclama del 1861 con cui liberava gli schiavi dei confederati nello stato del Missouri, e lo aveva poi sollevato dalle sue funzioni di comandante della Divisione Ovest dell’esercito unionista. Frémont sembrava l’unico a non voler seguire l’esempio degli altri potenziali avversari del presidente Lincoln e a non volersi togliere di mezzo. Mrs Lincoln rifiutò di aspettare passivamente che la situazione evolvesse in modo favorevole al marito. Lo sostenne a modo suo, coltivando amicizie con politici e uomini d’affari dalla dubbia moralità ma di grandi mezzi e influenza. Ancora una volta si trovò al centro dei pettegolezzi più feroci perché si circondava di personaggi equivoci. Quando Elizabeth, sempre attenta alle apparenze, suggerì con tatto che i nuovi amici e corrispondenti della first lady non sembravano il genere di gentiluomini che il presidente si sarebbe scelto come amici, Mrs Lincoln replicò: «Ho un obiettivo, Elizabeth. In campo politico è necessario coltivare tutti coloro che rappresentano punti di forza». Scettica, la sarta domandò: «E ritenete che questi signori di New York rappresentino un punto di forza, nonostante le chiacchiere spiacevoli che suscita la vostra amicizia con loro?» «Sono persone influenti, e abbiamo bisogno di influenzare i votanti se vogliamo che mio marito sia rieletto» spiegò la first lady. «Saprò sfruttarli fino all’elezione, e dopo, se restiamo alla Casa Bianca, li lascerò perdere, e farò loro sapere senza mezzi termini che li ho semplicemente usati. Sono uomini privi di principi, e non mi crea problemi fare il doppio gioco almeno per un po’». Elizabeth rimase scandalizzata apprendendo che la sua amica prevedeva di strumentalizzare uomini senza scrupoli, forse anche pericolosi, e di liquidarli quando non ne avesse più avuto bisogno, dicendoglielo chiaro e tondo per schernirli, oltretutto. «Il presidente sa qual è il vostro scopo?» «Certo che no! Non approverebbe mai». «Forse questo dovrebbe indurvi a rinunciare». «Oh, Elizabeth». Mrs Lincoln scosse il capo quasi avesse appena avuto la conferma che la sarta non la capiva, proprio come il marito. «Conto di tenerlo all’oscuro e di raccontargli tutto a cose fatte. È troppo onesto per occuparsi dei propri interessi, quindi trovo di essere in dovere di sostenerlo a modo mio». Come sempre Mrs Lincoln affermava di agire animata dalle migliori intenzioni e sembrava convinta che il suo operato fosse buono e necessario; ancora una volta Elizabeth rimase sgomenta. Avrebbe voluto che la moglie del presidente si comportasse con maggior prudenza. Anche se le piaceva tessere intrighi, non poteva reggere il confronto con quei politici di New York, navigati e scaltri, per i quali il doppio gioco e l’opportunismo in politica erano uno stile di vita. La sarta aveva paura che fossero loro a usare Mrs Lincoln, checché ne dicesse, e temeva che l’alleanza con quei personaggi loschi non sarebbe finita bene. Elizabeth aveva un altro motivo per detestare i viaggi a New York della first lady, che quando era preoccupata o scontenta si consolava spendendo soldi. Se andava al Nord, i giornali si affrettavano a riferire in modo malevolo tutti gli acquisti fatti nelle lussuose boutique di Broadway, riempiendo la carrozza di scialli, boa, mantelle, fazzoletti, parasole, ventagli, cuffie, stivaletti e guanti; se per caso era presente al momento della consegna a casa della merce acquistata, Elizabeth tentava di nascondere il proprio sconcerto, ma un fazzoletto da ottanta dollari la lasciò a bocca aperta, e uno scialle costatone duemila le strappò un’esclamazione scandalizzata. Dopo aver fatto qualche calcolo, non riusciva a capire come facesse Mrs Lincoln a permettersi tutte quelle spese; se i conti erano giusti, le sue spese personali di quella primavera superavano il budget totale per il restauro della Casa Bianca durante il primo anno di presidenza di suo marito. Un membro del personale della Casa Bianca aveva l’ingrato compito di approvare tutte le spese ufficiali della first lady, ma nessuno controllava le spese personali. Forse ritenevano tutti che si sarebbero adeguate alle restrizioni imposte dallo stipendio del marito, ma non era così, purtroppo. Se Mary Lincoln ordinava oggetti di lusso in un elegante negozio di Broadway o di Pennsylvania Avenue, i negozianti erano fin troppo felici di farle credito, ma a un certo punto le fatture sarebbero arrivate e il pagamento della merce sarebbe stato sollecitato. Non appena il sole primaverile asciugò le strade fangose della Virginia rendendole percorribili, gli eserciti si sarebbero rimessi in movimento, e per la prima volta il generale Grant avrebbe fronteggiato il generale Lee. Tutti al Nord capivano che sconfiggere Lee era cruciale per mettere fine alla ribellione, non solo perché costui era un brillante stratega, ma anche perché il suo esercito proteggeva la capitale della Confederazione, Richmond. Il 25 aprile, verso mezzogiorno, Elizabeth, Emma, Virginia e le figlie dei Lewis si unirono alla folla che si accalcava lungo Fourteenth Street per guardare i trentamila soldati del generale Burnside che andavano a dare man forte all’Armata del Potomac. Nei primi mesi di guerra ogni parata di soldati aveva attirato moltissimi spettatori esultanti, ma essendo diventato uno spettacolo ormai comune, quasi nessuno vi faceva più caso. Quella marcia, però, non era come le altre. Questa volta le colonne di uomini includevano sette reggimenti di United States Colored Troops, tre delle quali arruolate nel vicino Maryland, e sembrava che ogni nero di Washington, e non solo, fosse venuto a vederli partire per battersi contro il generale Lee. Elizabeth si sentì invasa dall’orgoglio mentre aspettava, con il suono del piffero e dei tamburi che annunciava l’arrivo imminente delle truppe. Giunsero da New York Avenue, con l’uniforme pulita e in ordine, e imboccarono Fourteenth Street, sfilando davanti alla folla in festa. Virginia si caricò sulle spalle la piccola Alberta mentre le figlie più grandi, Jane e Lucy, si misero in punta di piedi e allungarono il collo per spingere lo sguardo sopra la testa della gente. «Eccoli!» gridò Virginia, indicando con il dito. «Vedete come marciano bene? Li vedete? Quelli sono i nostri soldati, i nostri valorosi soldati neri». Mentre le ragazze, con gli occhi che luccicavano, assicurarono alla madre di averli visti, Elizabeth scrutò i visi scuri, orgogliosi, determinati dei soldati neri e si sentì la gola stretta per l’emozione. Le loro uniformi splendide, la musica entusiasmante, la marcia decisa e regolare, gli spettatori che li acclamavano: in quel momento Elizabeth ebbe l’impressione che non ci fossero limiti a ciò che gli esponenti della sua razza potevano fare negli anni a venire, senza più l’ostacolo imposto dalla schiavitù, e quando la pace avesse ripreso a regnare sul loro paese unito. Era lo spettacolo più sublime cui avesse mai assistito, e pregava perché gli uomini si mostrassero coraggiosi. Sarebbero stati sotto il pubblico scrutinio, ne era certa, e molti avrebbero sperato di vederli perdere. Invece dovevano vincere a ogni costo, e così facendo avrebbero smentito tutti i discorsi falsi e malevoli sul fatto che permettere agli uomini di colore di arruolarsi fosse una follia. I soldati giunsero davanti al Willard’s Hotel, dove il presidente Lincoln e il generale Burnside aspettavano sotto il portico orientale di vedere sfilare gli uomini. Quando i soldati neri passarono davanti al presidente, agitarono in aria i cappelli e inneggiarono al “grande emancipatore”, l’uomo che aveva liberato il loro popolo. Abraham Lincoln si tolse il cappello, fece inchini e cenni del capo, mostrando loro lo stesso rispetto e la stessa cortesia che riservava ai soldati bianchi. La colonna di uomini impiegò più di quattro ore per attraversare Pennsylvania Avenue. Dopo i soldati vennero i carri ambulanza, poi migliaia di capi di bestiame per nutrire le truppe, tutti diretti verso l’altra sponda del fiume, in Virginia. Un nuovo obiettivo, una nuova determinazione riempirono la città, dai soldati in marcia a chi stava a guardare formulando auguri ai militari. Infine i futuri combattenti scomparvero, lasciandosi dietro speranza, paura, impazienza e apprensione. La folla si disperse e gli spettatori tornarono a casa. Ora, lo sapevano tutti, dovevano prepararsi all’inevitabile carneficina. Non dovettero aspettare molto. Mentre gli eserciti dell’Unione e degli stati confederati si affrontavano nei territori selvaggi, i morti e i feriti affluirono a Washington dagli ospedali da campo, proprio come era successo dopo le battaglie di Bull Run, della Campagna Peninsulare, di Antietam e di Gettysburg. I feriti giungevano in vagoni adibiti ad ambulanze, un treno al giorno, ma erano treni lunghi chilometri, che avevano sballottato e scosso per lunghi tragitti, senza cibo e senza nessun’altra forma di conforto, i militari feriti, sporchi, deboli, mutilati, con le ferite non medicate. Una volta arrivati a destinazione, i soldati malati, feriti o agonizzanti, i cadaveri, i prigionieri e gli ufficiali erano sloggiati a grande velocità dalle banchine, stazioni e strade di accesso intasate, per far posto ai nuovi veicoli in arrivo. L’odore nauseabondo dei corpi nell’afa estiva aleggiava, dolciastro e rivoltante, su ogni strada e vicolo, e i cadaveri si ammonticchiavano senza che gli imbalsamatori riuscissero a occuparsene. Un impresario di pompe funebri accumulò tanto di quel ritardo nella preparazione dei cadaveri che fu brevemente trattenuto in stato di arresto e denunciato per disturbo della quiete pubblica. Tutta Washington sembrava essersi trasformata in un unico, enorme ospedale, e nessuno sfuggiva alle disgustose esalazioni di morte. Dai territori selvaggi la battaglia si spostò a Spotsylvania Court House, e da lì al North Anna River, poi a Cold Harbor. Le perdite furono molto numerose in ambo gli schieramenti, in particolare per l’Unione, ma senza che l’uno o l’altro dei nemici riuscisse a prendere il sopravvento. Determinante fu la tattica che il generale Grant adottò ogni volta che falliva nel tentativo di annientare l’esercito avverso: dove i suoi predecessori avevano sempre scelto di ritirarsi, lui spingeva avanti i suoi uomini, una volta dopo l’altra, costringendo il generale Lee a restare sulla difensiva e avvicinandosi sempre più a Richmond. La popolazione del Nord capì che Grant aveva una strategia diversa da quella che avevano visto finora. Nell’ultima grande battaglia di quella campagna, Grant sorprese Lee chiedendo ai tecnici del genio militare di costruire un ponte galleggiante sul James, lungo più di seicento metri, e poi attraversandolo furtivamente e minacciando così Petersburg, il più importante centro di approvvigionamento e deposito ferroviario di tutta la regione, che riforniva anche la capitale confederata di Richmond. Se Grant avesse conquistato Petersburg, anche Richmond sarebbe inevitabilmente caduta. Le truppe dell’Unione iniziarono l’assedio. La frattura all’interno del partito repubblicano si aggravò nel corso della primavera. Alla fine di maggio, la fazione radicale si riunì a Cleveland per scegliere il proprio candidato per le elezioni generali, decisa a raccogliere il sostegno di un numero sufficiente di delegati da vanificare la candidatura di Lincoln. Proponendosi come i rappresentanti del Radical Democracy Party, intendevano scegliere come candidato il generale Frémont, anche se circolava la voce che aspirassero addirittura a Grant, il quale aveva però manifestato il suo assoluto disinteresse per la cosa. Aveva già il suo bel daffare a combattere la guerra, pensò Elizabeth, senza doversi anche occupare delle schermaglie che si succedevano a Washington. Poco dopo la fine della convention, Elizabeth stava vestendo Mrs Lincoln per una serata all’opera con il generale Blair – l’ufficiale in capo del servizio postale nazionale – e sua figlia, quando entrò il presidente con un giornale in mano. «Nicolay mi ha portato l’Herald, così posso leggere tranquillamente le notizie che arrivano da Cleveland» disse alla moglie con un’aria disinvolta ma gli occhi divertiti. Mrs Lincoln fece un’espressione perplessa. «Non avete letto i rapporti all’ufficio del telegrafo, ieri?» «Sì» rispose lui, sdraiandosi sul divano e stendendo le lunghe gambe davanti a sé, «ma Nicolay deve aver pensato che volessi anche il giornale». «Forse sono cambiate le notizie?» chiese la first lady in tono ironico, come a indicare che lo considerava impossibile. «No, le parole sono sempre quelle. Frémont è il loro uomo; o perlomeno, l’uomo delle quattrocento persone che si sono presentate alla convention». «Solo?» chiese Elizabeth d’impulso, senza riuscire a trattenersi. «Solo quattrocento?» Il presidente fece un sorrisetto. «Esatto, madame Elizabeth. Solo quattrocento». Colto da un’improvvisa ispirazione, si rizzò a sedere e prese la Bibbia che si trovava sul tavolino lì accanto. «Questo mi ricorda...» disse, voltando le pagine. «Primo libro di Samuele, capitolo ventidue, versetto due». Trovò il passaggio, si schiarì la voce e cominciò a leggere il testo sacro. «“E tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti si radunarono presso di lui, ed egli divenne loro capo. C’erano con lui circa quattrocento uomini”». Ripose la Bibbia sul tavolino. «Quattrocento, anche qui. Un numero interessante, mi pare». E così Elizabeth scoprì che Mr Lincoln non era molto preoccupato per la concorrenza di Frémont. Qualche giorno dopo, alla convention di Baltimora, i repubblicani leali ad Abraham Lincoln si ribattezzarono National Union Party per differenziarsi dai gentiluomini che si erano riuniti a Cleveland. Speravano anche che il nuovo nome allettasse i War Democrats, con cui volevano creare una coalizione. Come loro, i War Democrats erano a favore della guerra e volevano prendere le distanze dai Peace Democrats, i democratici contro il conflitto, e sostenere un candidato che riflettesse le loro opinioni, ma non potevano certo votare per un repubblicano. Un candidato del National Union Party, invece, poteva essere accettabile. E così i repubblicani e i War Democrats si unirono e nominarono Lincoln come loro candidato. L’unica a opporsi a questa scelta fu una delegazione di ventidue repubblicani radicali del Missouri, che dapprima scelsero come candidato il generale Grant, e poi cambiarono il voto affinché la scelta di Lincoln risultasse unanime. I delegati stabilirono anche la linea politica del partito: elogiarono il presidente per il modo in cui conduceva la guerra e chiesero di continuare il conflitto finché la Confederazione non si fosse arresa senza condizioni, un emendamento costituzionale per abolire la schiavitù, l’assistenza per i veterani dell’Unione disabili e la costruzione di una ferrovia transcontinentale. Il passo successivo fu la scelta di un vicepresidente. Lincoln aveva già espresso il proprio desiderio di non interferire, lasciando la decisione alla convention, e una volta che le discussioni iniziarono mantenne il suo proposito. Il vicepresidente Hannibal Hamlin avrebbe voluto ricandidarsi, ma la situazione era cambiata troppo dall’elezione del 1860, e questa volta la sua candidatura non sollevò grande entusiasmo. Molti delegati pensavano di dover scegliere un War Democrat di uno stato di confine per aumentare il consenso. Dopo qualche discussione scelsero infine Andrew Johnson, governatore militare dell’Unione in Tennessee, War Democrat e unionista meridionale che stravinse alla prima votazione. Più tardi, quello stesso mese, il viceministro del Tesoro diede le dimissioni. Lincoln mise subito in chiaro i criteri per la scelta del successore, ma il ministro Chase ignorò le indicazioni del presidente. Nella controversia che seguì, Chase presentò le proprie dimissioni per principio, come aveva già fatto in molte altre occasioni, ma questa volta il presidente lo stupì accettandole. Elizabeth si aspettava che la first lady fosse entusiasta. Almeno due dei suoi più grandi desideri si erano realizzati: il marito si sarebbe ricandidato all’elezione presidenziale di novembre e Chase non faceva più parte del governo. Le sue preoccupazioni avrebbero dovuto ridursi almeno un po’, e invece Mary Lincoln pareva più agitata e ansiosa che mai. «Cosa pensate dell’elezione?» chiese a Elizabeth un caldo mattino di giugno mentre guardava fuori dalla finestra verso il Potomac. Elizabeth alzò gli occhi dal suo lavoro, posò la stoffa in grembo ma tenne in mano l’ago. «Penso che Mr Lincoln resterà alla Casa Bianca altri quattro anni». Mrs Lincoln distolse lo sguardo dalla finestra con in viso una strana miscela di speranza e apprensione. «Cosa ve lo fa pensare? Io ho imparato a temere la sua sconfitta». «Perché è stato messo alla prova e ha dimostrato di tenere al bene del paese» replicò Elizabeth. «Il popolo del Nord lo considera onesto ed è disposto a fidarsi di lui, almeno fino alla fine della guerra. La gente del Sud ha preso la sua elezione a pretesto per ribellarsi, e per il Nord sostituirlo ora con qualcun altro, dopo anni di guerra sanguinaria, assomiglierebbe troppo a una resa». La first lady sembrava sforzarsi di crederle. «Pensate allora che sarà rieletto?» «Ne sono sicura» rispose con decisione la sarta. «Rappresenta un principio, e per conservare questo principio il popolo leale degli stati leali voterebbe per lui anche se non avesse nessun altro merito». Mrs Lincoln rifletté a lungo sulle sue parole. «La vostra opinione mi pare ragionevole, Elizabeth, e la vostra sicurezza mi restituisce la speranza». La sua espressione si velò nuovamente di preoccupazione, contraddicendo le sue parole. «Se dovesse essere sconfitto, non so cosa sarebbe di noi. Lui non ha idea di cosa rischiamo». Elizabeth la guardò perplessa. «Cosa intendete, Mrs Lincoln?» La first lady esitò, trasse un respiro profondo e disse tutto d’un fiato: «Ho contratto grossi debiti dei quali mio marito non sa nulla, e che non sarà in grado di rimborsare se sarà sconfitto». Elizabeth si sentì morire. Era molto tempo che nutriva qualche sospetto. Si fece forza e pose la domanda che avrebbe forse dovuto rivolgerle mesi prima: «Che debiti sono?» Mrs Lincoln cominciò a camminare avanti e indietro di fronte alla finestra aperta torcendosi le mani. «Devo del denaro soprattutto ai negozianti. Ho un debito di circa ventisettemila dollari, e il creditore più importante è Stewart’s a New York». Elizabeth lasciò cadere l’ago con il filo e si accasciò contro lo schienale della poltrona. Era una somma enorme, superiore allo stipendio annuo del presidente. «Capite bene, Elizabeth, che Mr Lincoln non ha idea di quanto costi il guardaroba di una donna. Vede i miei abiti splendidi ed è contento di pensare che le poche centinaia di dollari che mi elargisce bastino a soddisfare tutti i miei desideri». Smise di camminare e lanciò uno sguardo penetrante all’amica. «Devo vestirmi con tessuti preziosi. La gente studia nel minimo dettaglio ogni mio accessorio. Il fatto che sia cresciuta all’Ovest mi sottopone a uno scrutinio anche maggiore. Per mantenere le apparenze devo avere denaro, più di quello che mio marito può darmi. È troppo onesto per cercare di arricchirsi al di fuori delle sue funzioni, e di conseguenza non avevo e non ho alternative: devo indebitarmi». Scuotendo il capo incredula, Elizabeth cercò di trovare un senso a quei vaneggiamenti. «Vostro marito non ha idea di quanto denaro dobbiate?» «Certo che no!» esclamò. «E non intendo destare i suoi sospetti. Se sapesse quanti soldi devo restituire, impazzirebbe. È così onesto e sincero che gli inganni altrui lo sconvolgono. Non sa nulla dei debiti, e tengo troppo alla sua felicità, per non parlare della mia, per rivelarglieli. Ecco cosa mi turba tanto. Se è rieletto, posso tenerlo all’oscuro delle mie faccende, ma se è sconfitto riceveremo le fatture e scoprirà tutto». Si lasciò sfuggire un singhiozzo isterico, ed Elizabeth si sentì costretta ad assicurarle che Mr Lincoln sarebbe stato eletto senza alcun dubbio. Era anche tentata di avvertirla che la rielezione del marito avrebbe solo posticipato l’inevitabile, ma la first lady era già in uno stato tale di disperazione che la sarta non se la sentì di farla stare peggio rivelandole altre verità dolorose. Mormorò invece parole consolanti e banalità sulla parsimonia, che sapeva benissimo destinate a cadere nell’oblio. L’argomento fu affrontato diverse volte nel corso di quegli afosi giorni d’estate, perché la first lady si faceva prendere dal panico a ogni conto da pagare che arrivava o a ogni evento politico che rischiava di minare la popolarità del presidente. A volte temeva che i nemici del marito scoprissero i dettagli dei suoi debiti e li usassero contro di lui nella campagna elettorale. Quando quella paura la attanagliava, l’agitazione e la paura la paralizzavano. A volte sbandierava una possibile soluzione che a Elizabeth, però, pareva francamente irrealizzabile. «I politici repubblicani devono pagare i miei debiti» dichiarava. «Centinaia di loro si stanno arricchendo moltissimo grazie alla protezione di mio marito, e sarebbe giusto che mi aiutassero a uscire da questa situazione difficile. Glielo chiederò, e quando avrò spiegato i fatti non potranno rifiutarsi di anticiparmi il denaro che mi serve». Elizabeth pensava che non solo potevano rifiutare, ma che con ogni probabilità l’avrebbero fatto, e la first lady avrebbe ottenuto un unico risultato: sarebbe stata di nuovo l’oggetto di pettegolezzi malevoli. La sarta cercò di dissuaderla con molto tatto dal parlare dei suoi debiti con chiunque, a parte suo marito e le sue sorelle, ma non poteva certo costringere la moglie del presidente a darle ascolto su quel punto, sulla pratica della frugalità o su qualunque altro argomento. Ciò che irritava Elizabeth più di ogni altra cosa era che, pur continuando a tormentarsi per i debiti, Mary Lincoln non smetteva di spendere, acquistando scialli, guanti e altri accessori costosi dei quali non aveva alcun bisogno. Il piacere di comprare ninnoli graziosi sembrava aiutarla a dimenticare per un attimo il suo tormento, ma non faceva che peggiorare le cose. Mai Elizabeth aveva conosciuto donna più strana. La prima settimana di luglio il generale Sherman era a un punto morto nelle sue manovre offensive per espugnare Atlanta, e nella Shenandoah Valley il tenente generale confederato Jubal Early arrestò l’avanzata verso sud del maggior generale unionista David Hunter, poi condusse il suo esercito di ribelli a nord, verso il Potomac. Secondo i nordisti si trattava di una delle tante incursioni estive e non vi prestarono attenzione, ma l’Esercito della Valle del generale Early continuò ad avanzare, passando accanto ad Harpers Ferry per attraversare il Potomac a Shepherdstown ed entrando nel Maryland. Le autorità degli stati di New York e Pennsylvania si preoccuparono al punto che chiamarono ventiquattromila membri della milizia a difesa del territorio, ma a Washington la fiducia nel generale Grant era tale che nessuno credeva la città in pericolo. Early prese Hagerstown e poi Frederick, e pretese denaro, vestiti, cibo e altri beni di prima necessità dai cittadini. I soldati ribelli si dispersero nella campagna, dove razziarono bestiame e cavalli e si servirono dai frutteti. Sembrava la dimostrazione che lo scopo era solo un volgare saccheggio, e il ministero della Guerra non si era premurato di smentire. Poi, però, cominciarono a circolare voci preoccupanti sul fatto che il generale Early avesse attraversato il Potomac con quasi ventimila soldati e che stesse marciando su Washington. I giornali stamparono quelle notizie allarmanti, che poi smentirono e pubblicarono di nuovo: il generale Lee aveva mandato a nord Early per minacciare Washington e Baltimora nella speranza di costringere Grant ad allontanare delle truppe da Richmond per difendere le due città. Early aveva intenzione di rapire il presidente Lincoln e tenerlo in ostaggio, costringendo così l’Unione a capitolare. Early progettava di invadere la capitale dell’Unione per convincere i paesi stranieri a riconoscere la legittimità degli stati confederati. Mrs Lincoln si trovava con la sua famiglia a Soldiers’ Home, quindi Elizabeth non poteva avere conferme o smentite di ciò che udiva per la strada. Come chiunque altro, si riduceva a raccogliere le informazioni che circolavano in giro e aspettava. Il 9 luglio il governatore del Maryland e il sindaco di Baltimora dichiararono lo stato d’emergenza e chiamarono i cittadini alle armi. «Non è esagerato affermare che oggi serpeggia una certa agitazione» scrisse il corrispondente del New York Times a Baltimora. Il maggior generale dell’Unione Lew Wallace, comandante degli stati del Middle Department e dell’Ottavo Corpo d’Armata, mosse le sue forze poco nutrite – circa seimilatrecento soldati, quasi tutti “uomini dei cento giorni”, cioè volontari arruolati per un breve periodo – per resistere all’avanzata del generale Early, pur non sapendo se intendesse dirigersi a Baltimora o a Washington. I due eserciti si affrontarono sulle sponde del Monocacy, una cinquantina di chilometri a nordovest della capitale, ma l’esercito di Wallace era in minoranza numerica. Quasi subito la popolazione delle contee di Frederick e Montgomery si mise in viaggio per sfuggire al conflitto e arrivò a Washington su carri carichi di oggetti domestici, con neonati in braccio e il bestiame al seguito. Raccontavano storie terrificanti di eserciti che avanzavano e di fughe precipitose, e presto si evinse che le forze del generale Early si erano spinte fino a Rockville, a soli trenta chilometri di distanza. Il ministero della Guerra aveva evitato di divulgare l’informazione per non scatenare il panico, ma non era più possibile fingere. Early stava arrivando, e la città non era pronta a tenergli testa. Anche se la capitale era circondata da chilometri di trincee e terrapieni, i soldati più esperti erano entrati a far parte dell’Armata del Potomac per la marcia di Grant su Richmond, e quelli che restavano, quasi tutti membri della Guardia Nazionale dell’Ohio, non erano stati addestrati all’uso dell’artiglieria pesante. Ogni cittadino abile fu chiamato a difendere la città. I Pennsylvania Bucktails, che montavano la guardia alla Casa Bianca, lasciarono le postazioni abituali per schierarsi in prima linea. Gli impiegati della fureria imbracciarono le armi e integrarono i ranghi dei difensori della città. Milleottocento uomini dei campi di convalescenza e tremiladuecento ex combattenti disabili furono richiamati in servizio. Quasi mille marinai e meccanici dell’arsenale deposero gli strumenti di lavoro per impugnare le armi. I civili furono reclutati e organizzati in una milizia chiamata Loyal League, e decine di uomini di colore furono ingaggiati per condurre i carri. Il presidente Lincoln era a Fort Stevens quando i difensori della città cominciarono a sparare contro i confederati che avanzavano; in seguito si raccontò che era rimasto su un parapetto, facile bersaglio per i proiettili che gli sfrecciavano accanto, finché un soldato non gli ordinò bruscamente di scendere subito se non voleva farsi colpire alla testa. Rischiando un potenziale disastro come quello di Bull Run tre anni prima, migliaia di civili curiosi – uomini, donne e bambini – corsero al forte per guardare lo spettacolo, e quando i soldati li scacciarono, si arrampicarono su steccati, alberi e colline per vedere meglio. Quando le forze del generale Early arrivarono alle trincee di Fort Stevens e lo stratega cominciò a preparare le truppe per sferrare l’attacco decisivo, iniziarono ad approdare in battello a vapore, nella zona sudoccidentale della città, i rinforzi del Sesto e del Diciannovesimo Corpo ai comandi del maggior generale Horatio G. Wright. Questi veterani, di cui le forze dell’Unione avevano un bisogno estremo, erano poco numerosi, ma Early lo ignorava, perché dopo due giorni di schermaglie, durante le quali arrivarono altre truppe unioniste a dar man forte alle difese, si ritirò prima dell’alba del 13 luglio, in modo tanto discreto e inaspettato che i nordisti non si accorsero della scomparsa dei confederati fino a quando non si fece giorno e la loro assenza non divenne palese. Esultanti, i difensori civili lasciarono le fortificazioni e tornarono alla loro vita normale, ma il presidente Lincoln fu molto contrariato per il fatto che un altro esercito sudista fosse riuscito a scappare. Elizabeth era semplicemente felice e molto sollevata che se ne fossero andati. Agosto, afoso e avvolto in un’umidità soffocante, si avviava al termine con poche buone notizie dai campi di battaglia e ancora meno dalla campagna presidenziale. A fine mese fu organizzata la convention nazionale democratica a Chicago; in quell’occasione fu nominato l’ex comandante in capo dell’esercito dell’Unione, il generale George B. McClellan, caduto in disgrazia presso le forze dell’Unione, con un programma fautore della pace che prevedeva un cessate il fuoco e la ricerca di un accordo con la Confederazione. Ora che Grant pareva incapace di marciare su Richmond e Sherman era in una situazione di stallo vicino ad Atlanta, la guerra sembrava essere giunta a un frustrante punto fermo. Anche Mary Lincoln era scoraggiata. Cominciò a far visita a Elizabeth nelle sue stanze, ufficialmente per parlare di scollature, bordi e strascichi; ma a occupare il suo pensiero era soprattutto l’elezione. «Elizabeth» esordì Mrs Lincoln in tono desolato, «dove pensate che sarò a quest’ora la prossima estate?» «Alla Casa Bianca, naturalmente». «Non credo proprio». Le si riempirono gli occhi di lacrime. «Non ho speranze quanto alla rielezione di mio marito. La propaganda è agguerrita, la gente comincia a essere stanca del conflitto e contro mio marito vengono scagliate le accuse più assurde». «Non importa» replicò Elizabeth decisa. «Il presidente sarà rieletto. Ne sono così sicura che sono perfino tentata di chiedervi un favore». Mrs Lincoln levò le sopracciglia. «Un favore? Se restiamo alla Casa Bianca potrò farvene molti di favori. Di cosa si tratta?» «Vorrei che mi regalaste il guanto destro che il presidente indosserà al primo ricevimento pubblico dopo la seconda investitura». Mrs Lincoln scoppiò a ridere, sorpresa. «Sarà così sporco quando se lo toglierà che mi verrà voglia di prenderlo con le pinze e gettarlo nel fuoco. Non capisco perché vorreste tenerlo». Sorridendo Elizabeth levò il capo, ben decisa a non cedere. «Lo vorrei come prezioso ricordo della seconda investitura dell’uomo che ha fatto tanto per la mia razza. È stato come Geova per il mio popolo: l’ha salvato dalla schiavitù e ha guidato i suoi passi dall’oscurità alla luce. Vorrei conservarlo e trasmetterlo ai posteri». La first lady scosse il capo. «Avete idee strane, Elizabeth» commentò. «Ma va bene, lo avrete, sempre che mio marito sia ancora presidente dopo il 4 marzo prossimo». «Ne sono certa!» esclamò la sarta come aveva già fatto molte volte durante quella lunga e calda estate. Mrs Lincoln si limitò a sorridere, tesa e preoccupata. Qualche giorno dopo, Sherman espugnò Atlanta. La notizia giunse a Lincoln tramite un telegramma il 2 settembre. Il presidente, trionfante, ordinò a ogni arsenale di sparare cento colpi di fucile a salve in onore del generale Sherman e a Petersburg Grant omaggiò il compagno d’armi ordinando a tutte le sue batterie di sparare contemporaneamente contro il nemico, cosa che fecero nel giro di un’ora con grande gioia. Gli abitanti degli stati del Nord erano esultanti. Dopo un’estate deprimente, fatta di stasi, sconfitte e scoramento, ora l’esercito dell’Unione all’improvviso si avvicinava alla vittoria, e lo stesso si poteva dire per il presidente. Da un giorno all’altro era diventato un comandante supremo vittorioso, e nel clima politico mutato il tentativo da parte dei repubblicani radicali di sostituirlo sembrava pericoloso e imprudente. La possibilità che gli elettori repubblicani dividessero i propri voti tra Lincoln e il generale Frémont, permettendo così ai democratici di impossessarsi della presidenza, cominciò a preoccupare i membri dei nuovi partiti National Union e Radical Democracy. In settembre il presidente chiese le dimissioni di Blair, l’ufficiale in capo del servizio postale nazionale, che fra tutti i membri del suo governo era quello più inviso agli occhi della fazione repubblicana radicale. Nel frattempo, anche se nessuno poté dimostrare un legame tra i due eventi, Frémont si ritirò dalla corsa alla presidenza. La distinzione politica tra i due candidati rimasti non poteva essere più chiara: il presidente Lincoln, capo di un esercito vittorioso e salvatore dell’Unione, e il generale McClellan, ex leader militare popolare ma sempre esitante, il cui partito insisteva per intavolare un negoziato di pace nel quale lui stesso non credeva. Nelle settimane che precedettero le elezioni, il ministro della Guerra Edwin Stanton si assicurò che i soldati potessero esprimere il loro voto per corrispondenza, quando le leggi del loro stato lo permettevano, o avessero una licenza per tornare a casa a votare. Il presidente Lincoln stesso scrisse a diversi dei suoi generali per chiedere di concedere una licenza ai soldati originari degli stati in cui i due candidati erano quasi in situazione di parità – Indiana, Pennsylvania, Missouri, New York –, presumendo che i militari dell’Unione avrebbero sostenuto in modo predominante il candidato repubblicano proprio come avevano fatto nelle elezioni amministrative. L’ex ministro Salmon Chase cominciò a elogiare il presidente Lincoln in pubblico e poi a fare propaganda per lui negli stati del Midwest, cruciali per la vittoria. Il suo sostegno fu prezioso anche se opportunistico, dal momento che Chase aveva delle mire sulla posizione, appena resasi vacante, di presidente della Corte Suprema. Sebbene le previsioni apparissero favorevoli al marito, la first lady si impegnò a sua volta per contribuire in tutti i modi alla vittoria. Si fidava ormai ciecamente del gusto e del giudizio di Elizabeth, e le aveva chiesto di accompagnarla a New York per un’ultima spedizione autunnale a fare spese. Quando Mrs Lincoln tornò a Washington per l’elezione, la sarta rimase a New York per fare acquisti, procurarsi preventivi per i tessuti, fare e disdire ordini, pagare conti in sospeso o dilazionare i pagamenti e, in genere, svolgere tutto quello che la first lady le chiedeva di sbrigare, talvolta inviandole diversi telegrammi al giorno. Elizabeth restò a New York tutto il mese di novembre, e quindi trascorse il giorno delle elezioni non a casa sua, nella capitale, come quattro anni prima, ma nella metropoli frenetica e vibrante dove i ricordi di violenti scontri negli uffici di leva evocavano ancora costernazione e dolore, e dove il presidente Lincoln non aveva mai goduto di grande popolarità. Fu lì che Elizabeth apprese la splendida notizia che Mr Lincoln era stato rieletto con un vantaggio schiacciante: aveva ricevuto il cinquantacinque percento dei voti del popolo e ottenuto un margine enorme nel collegio elettorale, con duecentododici voti contro i ventuno del generale McClellan. Da sola nella stanzetta che aveva preso in affitto, Elizabeth esultò, colta da un’improvvisa e profonda nostalgia. Tutte le sue previsioni si erano avverate. Il popolo degli stati lealisti aveva deciso saggiamente che Lincoln doveva restare alla guida del paese. 11. Dicembre 1864 - aprile 1865 «La guerra continua» fu l’esordio del presidente Lincoln nel discorso annuale che rivolse al Congresso in dicembre, ma dopo quell’inizio cupo il tono si fece risolutamente ottimista, molto più che negli interventi analoghi fatti nei tre anni precedenti. L’esercito dell’Unione stava avanzando progressivamente, e i risultati delle elezioni di novembre dimostravano che il popolo nordista era deciso a proseguire con il conflitto fino alla vittoria. Nonostante le gravi perdite, il Nord aveva ancora più uomini e risorse del Sud. Come se si aspettasse che il suo discorso venisse letto anche nella capitale della Confederazione – e probabilmente sarebbe davvero stato pubblicato sui giornali di Richmond nel giro di pochi giorni – il presidente Lincoln osservò che il Sud, ormai in grande difficoltà, avrebbe potuto ottenere la pace nel momento in cui avesse deposto le armi e si fosse sottomesso all’autorità federale. Ma non dovevano aspettarsi alcun compromesso in materia di schiavitù: in effetti il presidente chiedeva alla Camera dei rappresentanti di approvare l’emendamento costituzionale per l’abolizione della schiavitù che il Senato aveva già votato. La fine della schiavitù in tutto il paese era solo una questione di tempo, disse Lincoln, e prima accadeva, meglio era. Qualche giorno dopo, mentre Salmon P. Chase prestava giuramento come presidente della Corte Suprema, giunse notizia nella capitale che il generale Sherman era arrivato all’Atlantico, al termine della sua marcia attraverso la Georgia. Domenica 25 dicembre mandò al presidente un telegramma con auguri natalizi piuttosto insoliti: «Desidero offrirvi, in occasione del Natale, la città di Savannah, con centocinquanta cannoni e molte munizioni, e venticinquemila balle di cotone». Quell’anno gli abitanti di Washington festeggiarono il Natale giubilando, e una settimana dopo accolsero l’anno nuovo con speranze rinnovate. Quasi quattromila cittadini parteciparono al tradizionale ricevimento alla Casa Bianca, riempiendo i saloni fino all’inverosimile tanto che, al momento di andarsene, alcuni degli ospiti più agili uscirono da una finestra del primo piano nell’East Room e si calarono giù lungo una rampa di assi di legno. Per Elizabeth l’ultimo giorno di gennaio fu carico di buoni presagi più di Capodanno, perché in quell’occasione la Camera dei rappresentanti votò l’approvazione del Tredicesimo Emendamento, che aboliva la schiavitù in tutti gli Stati Uniti. Per la prima volta i neri avevano il permesso di entrare nelle zone del Congresso destinate al pubblico, dove assistettero ai discorsi conclusivi e alla votazione in un silenzio assoluto, piangendo ed esultando subito dopo l’esito positivo del voto. Anche se tre quarti degli stati dovevano ancora ratificarlo prima che entrasse in vigore, i residenti neri di Washington festeggiarono, certi che alla schiavitù fosse stato inferto un colpo mortale. Nonostante la guerra ancora in corso, c’erano molti motivi di ottimismo in quei primi mesi del 1865, ma la first lady si ritrovò in preda a un profondo scontento. Dopo la rielezione di Lincoln e un giro di dimissioni e nuove attribuzioni di cariche, Mrs Lincoln operò a sua volta alcuni avvicendamenti tra il personale, cominciando dal licenziamento di Edward McManus, che era stato per molto tempo portiere alla Casa Bianca. Elizabeth non sapeva bene il perché; apparentemente non aveva consegnato dei documenti in tempo o aveva divulgato un segreto che gli era stato confidato dalla moglie del presidente; gli altri domestici non ne sapevano nulla e Mrs Lincoln non voleva rivelarlo. Quando il presidente lo venne a sapere, fece una litigata terribile con la moglie al cospetto di uno dei suoi amici di New York, mettendola profondamente in imbarazzo. Peggio ancora, McManus per vendicarsi raccontò delle sue spese folli, degli atteggiamenti ambigui e degli attacchi di rabbia della first lady a Thurlow Weed, direttore di un giornale newyorchese e organizzatore politico, che Mrs Lincoln disprezzava in particolar modo. Cominciarono a circolare notizie scandalose, che costrinsero la moglie del presidente a scrivere una quantità di lettere per difendersi agli occhi dell’élite di New York e proteggere così la propria reputazione. Mentre Mrs Lincoln si batteva per conservare il proprio status, il marito e il figlio maggiore iniziarono una campagna segreta per conto loro. Dopo essersi laureato ad Harvard nel luglio 1864, Robert aveva chiesto ancora una volta il benestare dei genitori per arruolarsi, e sua madre si era di nuovo opposta strenuamente. Robert, inferocito, aveva dichiarato che, se non poteva vivere come voleva, sarebbe almeno fuggito dalla “serra” di Washington; così era tornato a Cambridge e si era iscritto alla facoltà di diritto di Harvard. Sei mesi dopo, quando ormai l’esercito dell’Unione avanzava nel Sud senza più incontrare ostacoli, il presidente decise di esaudire il più grande desiderio del figlio. Senza consultare sua moglie scrisse al generale Grant e gli chiese di trovare a Robert un posto lontano dalle prime linee, ma non un ruolo prestigioso spettante a un veterano che lo meritava davvero. Il generale rispose per lettera che avrebbe accolto con piacere il ragazzo nella sua «famiglia militare» e così il 17 febbraio Robert Todd Lincoln entrò nell’esercito come capitano e assistente dell’aiutante maggiore al seguito del generale Grant. Mrs Lincoln cercò di dimostrarsi coraggiosa, assicurando alla nazione che era fiera del proprio figlio, ma confessò a Elizabeth che era in ansia e spaventata, anche se, vista la posizione di Robert, suo figlio non avrebbe probabilmente mai assistito neppure a una battaglia. La sera prima del secondo insediamento di Lincoln, una tempesta terribile si abbatté su Washington. Elizabeth si svegliò di soprassalto per il rumore dei tuoni e della grandine sul tetto, si rizzò a sedere sul letto con la trapunta stretta addosso, il cuore che batteva all’impazzata, finché non si calmò abbastanza da tornare a sdraiarsi per cercare di riaddormentarsi. Non si trattava di un cattivo presagio, si disse con fermezza. Era un temporale, ecco tutto, forse solo più violento degli altri in quell’umido inizio di primavera. Il mattino dopo si svegliò e la giornata era grigia. Aveva programmato di assistere alla sfilata con Emma e due delle altre sue assistenti, e poi di raggiungere Virginia e Walker al Campidoglio per vedere il giuramento e il discorso inaugurale di Lincoln, ma la pioggia torrenziale aveva trasformato le strade di Washington in torrenti di fango profondi più di venti centimetri, e lei non aveva nessuna voglia di attraversarli al guado, disputandosi con i molti altri spettatori i pochi fazzoletti di terra asciutta. Sarebbe dovuta uscire più tardi, per andare prima alla Casa Bianca a vestire la first lady per il ricevimento, e poi a una festa con i Lewis e altri amici, ma con un po’ di fortuna per quell’ora le strade sarebbero state più asciutte. «Oh, vieni!» protestò Emma quando bussò alla porta di Elizabeth e lei spiegò, scusandosi, che aveva cambiato idea. «Come puoi rinunciare a venire proprio oggi, quando i neri per la prima volta hanno il permesso di entrare al Campidoglio per l’insediamento di un presidente? Le strade non sono in questo stato dappertutto, e poi c’è pieno di bambini». I ragazzini più intraprendenti erano felici quando le strade erano invase dal fango, perché si portavano in giro delle tavole di legno e si facevano dare qualche spicciolo per trasformarle in passerelle sulle quali le signore potevano camminare senza sporcarsi. «Va’ tu» le disse Elizabeth. «Poi mi racconterai». «Non ti dirò un bel niente» ribatté Emma. «Restare a casa è una tua scelta, e dovrai patirne le conseguenze». «Se mi riferirai il discorso del presidente» continuò Elizabeth, «prometto di descriverti in ogni dettaglio l’abito che Mrs Lincoln indosserà al ballo, e ti spiegherò come ho confezionato lo strascico». Emma esitò, tentata, ma quando si voltò per andarsene alzò il capo e con sussiego si limitò a promettere: «Ci penserò». Il desiderio di imparare una nuova tecnica prevalse, e appena tornò alla pensione nel primo pomeriggio Emma si recò in camera di Elizabeth, con gli occhi che brillavano e piena di entusiasmo. La parata era stata splendida nonostante il fango, con uomini e cavalli che marciavano fieri e bande che suonavano musiche più allegre che mai. Un gruppo di uomini tirava un modello in scala ridotta di cannoniera con tanto di torretta girevole che incantò i presenti sparando a salve mentre scendeva lungo Pennsylvania Avenue. Gli elegantissimi rappresentanti dei pompieri di Washington e Filadelfia, organizzazioni di cittadini e associazioni di tutto il Nord marciavano orgogliosi con bandiere e striscioni. Uno stampatore locale aveva issato un torchio tipografico su un carro, e avanzando stampava e distribuiva volantini agli spettatori. Ma la cosa più bella era che per la prima volta gente di colore aveva preso parte alla parata, un battaglione di soldati neri oltre ai responsabili delle principali associazioni per i diritti civili. Le persone della loro razza erano finalmente incluse nella cerimonia dell’insediamento, parte integrante della celebrazione e della cerimonia, non solo spettatori che osservavano in mezzo alla folla o lavoratori invisibili che preparavano da mangiare e alla fine pulivano. Più tardi, sul terreno fangoso attorno al Campidoglio, Emma e i suoi amici avevano aspettato in mezzo a migliaia di altre persone, sotto un cielo greve di pioggia, che il presidente Lincoln uscisse e prendesse il suo posto sotto il Portico Est, sullo sfondo della cupola appena ultimata. «E a quel punto è uscito con un foglio di carta in mano» disse Emma, ancora commossa dal ricordo. «Non appena la gente l’ha riconosciuto, è esplosa in un grido gioioso di benvenuto, e proprio allora – oh, avresti dovuto vederlo, Elizabeth! –, nel momento in cui ha preso posto, le nubi si sono squarciate ed è apparso il sole; un raggio luminoso l’ha colpito dall’alto, come una benedizione dal cielo». Elizabeth si sporse in avanti, affascinata dal racconto. «E cos’ha detto?» «Non me lo ricordo» rispose la ragazza facendo spallucce. «Lo leggerai domani sul giornale». «Emma!» La giovane rise. «Ti sto solo prendendo in giro, ma te lo meriti. Oh, è stato un discorso magnifico. Breve, ma forse per questo anche migliore, secondo me». La sarta annuì. «La brevità è una sua caratteristica anche nelle conversazioni quotidiane, a meno che non stia raccontando una storia o leggendo ad alta voce uno dei suoi autori preferiti». Non appena ebbe finito la frase la rimpianse amaramente, perché le pareva di essere presuntuosa sottolineando la sua familiarità con il presidente. Se Emma pensava che si desse delle arie, non lo diede a vedere. «È stato un bel discorso, chiaro, triste e caloroso, con tante parole di perdono e di riconciliazione» dichiarò. «Ha parlato della guerra, del fatto che sia stata causata dalla schiavitù e che quattro anni fa tutti, il Nord come il Sud, avessero voluto evitarla, ma l’uno preferiva la guerra alla sopravvivenza della nazione, l’altro accettava la guerra pur di non vederla deperire. Ha anche parlato del Signore, e di quanto sia strano che ognuna delle due fazioni preghi lo stesso Dio e invochi il Suo aiuto contro l’altra». Elizabeth annuì. Ci aveva pensato spesso nei mesi dopo la morte di George. Aveva pregato per suo figlio ogni giorno e ogni notte quando era in guerra e, ovunque si trovasse, anche la madre del ragazzo che aveva ucciso George aveva pregato per il proprio figlio. A un tratto si rese conto che dopo tanti anni di guerra il ribelle che aveva ammazzato suo figlio poteva essere morto a sua volta per colpa di una pallottola, una malattia o un terribile incidente. Un’altra donna avrebbe potuto provare un senso di soddisfazione a quel pensiero, ma Elizabeth sentì solo pena. «Il presidente Lincoln ha suggerito che il Signore ci abbia mandato questa terribile guerra come punizione per avere commesso l’offesa della schiavitù» continuò Emma, «e che la guerra sia un flagello per liberarcene». «Forse» convenne l’amica. «E ha concluso con parole così profonde che me le sono scritte appena ha finito». Emma si tolse un foglietto di carta dalla tasca e lo aprì. «Ha terminato dicendo queste parole, più o meno: “Con cattiveria verso nessuno, con carità per tutti, con la sicurezza di essere nel giusto come Dio ce lo mostra, cerchiamo di finire il lavoro cominciato, di chiudere le ferite della nazione, di prenderci cura di chi ha dovuto combattere, della sua vedova e del suo orfano, di fare tutto ciò che può procurare e coltivare una pace giusta e duratura al nostro interno e con tutti gli altri paesi”». Emma sorrise un po’ imbarazzata, ripiegò il foglietto e se lo rimise in tasca alzando le spalle. «Probabilmente non gli ho reso giustizia. Tutto il discorso sarà sul giornale di domani, e potrai leggerlo per bene». «Sono sicura che ne hai colto lo spirito, se non le singole parole». La sarta si sentì stringere la gola per la commozione e sbatté le palpebre per mandare via le lacrime. «Sono contenta di non aver dovuto aspettare domani per sentire queste parole». Piene di compassione, autentiche, proprio come l’uomo che le aveva pronunciate. «Avresti dovuto esserci anche tu» la rimproverò affettuosamente Emma scuotendo il capo. «Rimpiango di non esserci stata, nonostante il fango e la folla. E ora, Emma» sussurrò con voce da cospiratrice Elizabeth, «vorresti essere l’unica persona a Washington, o meglio degli Stati Uniti – oltre a Mrs Lincoln e a me –, a sapere cosa indosserà al ballo dell’insediamento?» Il viso di Emma si illuminò di gioia mentre la sarta descriveva il raso prezioso, di un bianco candido, lo scialle di pizzo, i drappeggi eleganti e gli splendidi smerli. Emma pendeva dalle sue labbra, come se pensasse di dover poi confezionare lo stesso abito affidandosi alla memoria. Sapeva già come cucire le piegoline verticali sulla parte posteriore del mantua per farla aderire alla perfezione; Elizabeth stessa le aveva insegnato a dare quei punti minuscoli e incrociati che riuscivano a resistere alla pressione del corpo strizzato nel tessuto e a evitare pieghe inopportune causate dalla necessità di lasciare un po’ di agio nella stoffa. Aveva anche mostrato a Emma come praticare punti più lunghi e allentati per le gonne, in modo che le cuciture non rattrappissero il tessuto e non rovinassero la linea dell’abito, e dopo molta pratica la ragazza sapeva farlo alla perfezione. Emma stava diventando molto brava, ma Elizabeth aveva ancora parecchio da insegnarle. Con il suo talento naturale, la mente pronta e le dita agili la giovane avrebbe saputo padroneggiare qualunque tecnica, e con il passare del tempo sarebbe potuta diventare brava quanto la sua insegnante, se non di più. Elizabeth trovava che una studentessa in grado di superarla sarebbe stata un’ottima eredità da lasciare ai posteri, più preziosa, duratura e gratificante di tutti gli abiti meravigliosi che aveva creato per le signore di Washington, perfino di quelli che aveva confezionato per la first lady. Più tardi, quella sera, percorse le strade fangose diretta alla Casa Bianca, dove trovò Mrs Lincoln in uno stato di nervosismo e di agitazione. «Sono sicura di non essere la prima a farvi le congratulazioni in questo giorno solenne» esordì la sarta calorosamente, «ma ve le faccio lo stesso, dal profondo del cuore». «Grazie, Elizabeth» rispose la signora con un sospiro, «ma ora che ce l’abbiamo fatta vorrei quasi che non fosse accaduto. Il povero Mr Lincoln ha l’aria così affranta, esausta. Ho paura che non sia in grado di affrontare i prossimi quattro anni». «Certo che è in grado» rispose la sarta risolutamente. «La campagna elettorale l’ha stancato molto, ma adesso è finita, è arrivata la primavera e le notizie dal fronte non sono mai state tanto buone». «Questo è vero» ammise Mrs Lincoln senza però sembrare rincuorata. «Se almeno questa guerra terribile finisse! Confesso che vivo nell’apprensione che la cerimonia dell’insediamento finisca, perché quando accadrà Robert dovrà tornare in guerra». «Credevo che la sua posizione non comportasse pericoli». «Non marcia con la fanteria, se è ciò che intendete, ma segue il generale Grant, e il generale è al fronte». Le si ruppe la voce per la paura e la preoccupazione, ed Elizabeth provò un impeto di compassione per lei. La guerra sarebbe presto finita, stava per dire, ma si trattenne perché la gente lo ripeteva da tanto di quel tempo che ormai quelle parole erano prive di significato. Ora, però, dopo tante false speranze e delusioni, finalmente la frase conteneva qualche verità. I confederati stavano perdendo terreno in ogni punto del teatro bellico, e le linee delle uniformi blu dell’Unione avanzavano trionfanti. Quasi ogni giorno la sarta poteva guardare fuori dalla finestra e vedere l’artiglieria passare per la strada per andare a sparare colpi a salve in onore di una nuova vittoria. Ciononostante, capiva perché la first lady fosse in preda all’ansia finché il conflitto non fosse terminato e Robert non avesse cessato di correre pericoli. Le parve che la moglie del presidente si stesse chiudendo in se stessa, pensierosa; allora cercò di distrarla chiedendole le sue impressioni sulla cerimonia dell’insediamento. «Il presidente ha tenuto un discorso encomiabile» replicò Mrs Lincoln, rasserenandosi un poco. «Sapete che si è perso tutta la parata?» «No!» «È così, invece. Aveva tanto di quel lavoro da sbrigare che è andato in Campidoglio con il suo calesse prima degli altri, ed è rimasto lì a firmare progetti di legge fino all’ultimo minuto». Fece una risatina, un segnale incoraggiante. «Così tutte le persone lungo la strada che lo acclamavano al passaggio della carrozza, in testa alla parata... ecco, acclamavano solo me. Dubito che lo avrebbero fatto se lo avessero saputo». Elizabeth sorrise. «Sono sicura che molti vi avrebbero festeggiata ugualmente». La first lady fece un altro risolino quasi per schermirsi, ma si vedeva che era compiaciuta. «Oh, Elizabeth, quel piccolo inganno non è stato l’episodio più grave della cerimonia». Fece una pausa a effetto. «Quando il vicepresidente designato è arrivato per il giuramento, era ubriaco». «No!» «Sì, vi dico, e ha tracannato quasi due bicchieri di brandy proprio lì, al Senato». Mrs Lincoln si infervorava a mano a mano che parlava. «Mr Hamlin ha parlato benissimo per introdurre il suo successore, e a quel punto Johnson si è fatto avanti e ha cominciato ad arringare la folla in modo incoerente... terribile. Non avevo mai assistito a un’orazione del genere». «Che orrore» commentò Elizabeth. «Cosa gli è venuto in mente?» «Credo non lo sapesse neppure lui. Era rosso in viso, riusciva a malapena a parlare, e quando il segretario del Senato ha cercato di mettere fine a quell’esibizione vergognosa, il vicepresidente Johnson ha insistito per continuare. Sembrava uno squilibrato». Mrs Lincoln scosse il capo. «Il mio povero marito è arrivato nel bel mezzo di questo disastro ed è rimasto lì a capo chino, a sopportare l’imbarazzo in un silenzio dignitoso, aspettando pazientemente che Johnson finisse e prestasse giuramento». «Non era il presidente a dover essere imbarazzato, ma Johnson» osservò la sarta. «Certo, ma ha comunque rovinato il momento». La first lady strinse le labbra e scrollò il capo. «Che pessimo inizio. Dubito che ci si potrà passare sopra. Nessuno dei presenti se lo scorderà mai». Elizabeth capì dall’espressione accigliata di Mrs Lincoln che neanche lei l’avrebbe mai perdonato. La sarta stava acconciando la signora quando entrò il presidente; gli si avvicinò, tese la mano e gli fece i suoi complimenti più sinceri. «Grazie» disse lui, afferrando cordialmente la sua mano e stringendogliela. «Ebbene, madame Elizabeth, non so se dovrei sentirmi riconoscente oppure no. È un ruolo irto di difficoltà il mio. Non sappiamo cosa ci aspetta, ma Dio è con noi. E io ho fiducia in Dio». Le lasciò andare la mano e attraversò la stanza per sedersi sul divano con espressione solenne. Elizabeth avvertì una compassione profonda per entrambi, la first lady e il presidente. Da ogni parte della nazione divisa arrivavano ottime notizie sui successi dell’esercito dell’Unione, eppure i Lincoln, nell’intimità dei loro appartamenti privati, apparivano stremati, tristi e preoccupati nel giorno che avrebbe dovuto segnare il loro trionfo. Con la discrezione che la contraddistingueva, Elizabeth cercò di distrarli con una conversazione leggera, e quando ebbe finito di vestire Mrs Lincoln le parve che fosse un poco più serena. La first lady prese il braccio del marito e, mentre il presidente la conduceva al piano inferiore dove migliaia di cittadini li stavano aspettando, le disse da sopra la spalla: «Vi darò quel guanto lunedì sera, Elizabeth, quando verrete a vestirmi per il ballo dell’insediamento». La sarta sorrise, felice che se lo fosse ricordata. Mentre i Lincoln accoglievano il pubblico e accettavano con buona grazia le congratulazioni, nascondendo la stanchezza e l’ansia per non sciupare l’occasione per tutti i presenti venuti a felicitarsi con loro, Elizabeth partecipò a un altro incontro, in scala minore ma non per questo meno festoso, con l’élite nera di Washington. Con uno sforzo mise da parte per il momento la sua preoccupazione per i Lincoln, e si unì ad amici e conoscenti nel celebrare la vittoria del presidente, certa che avrebbe compiuto grandi imprese per la nazione e per la popolazione nera durante il secondo mandato. Era presente anche Frederick Douglass, e la sarta, da tempo sua ammiratrice, fu felice di avere l’occasione di parlargli. Questi raccontò al gruppo di persone che lo circondavano di un incidente avvenuto alla Casa Bianca nemmeno due ore prima. Molti neri erano andati a Washington per l’insediamento, e decine di loro avrebbero voluto partecipare al ricevimento, ma non avevano avuto il permesso di entrare. Douglass era rimasto in disparte, preparando già mentalmente una lettera indignata di protesta, quando un membro del Congresso, vedendolo, aveva fatto qualche commento sulla calca e gli aveva chiesto: «Voi entrate, vero?» Mr Douglass aveva risposto che purtroppo non sarebbe stato presente, e il politico aveva esclamato: «Non venite a stringere la mano al presidente! E perché mai?» «Per la migliore ragione del mondo» aveva risposto Douglass, in tono fiero ma ironico. «Sono stati diramati ordini severi per impedire l’ingresso alla gente di colore». Elizabeth non riusciva a credere che il presidente avesse dato un ordine del genere proprio quel giorno, e si chiese quale dei ministri avesse preso tale iniziativa, o se ci fosse stato un malinteso tra la folla e i portieri. Proprio mentre la sarta stava per suggerire a Mr Douglass di tornare alla Casa Bianca e di provare a entrare di nuovo, questi riprese il racconto, spiegando che il membro del Congresso era rimasto molto turbato nello scoprire che il suo interlocutore non era potuto entrare. Aveva allora accompagnato dentro lui stesso il celebre oratore, aveva attraversato la folla fino al presidente, e aveva chiesto il permesso di presentarglielo. Lincoln aveva accettato prontamente, e Mr Douglass si era così ritrovato faccia a faccia con il presidente, che gli aveva stretto la mano dicendo: «Mr Douglass, sono felice di conoscervi. Ammiro da lungo tempo le vostre iniziative e vi stimo molto». Mr Douglass era palesemente fiero dell’accoglienza riservatagli dal presidente, e gli astanti condivisero la sua fierezza, sentendosi felici perché il presidente aveva tributato un tale rispetto e interesse a uno dei loro leader. Elizabeth non era sorpresa, non solo perché aveva visto molte volte il presidente alle prese con gli ospiti e sapeva che era sempre cortese con tutti, ma anche perché lei stessa aveva fatto un favore a un’amica organizzando un incontro tra il presidente e l’ex schiava e abolizionista Sojourner Truth l’ottobre precedente. Non aveva assistito alla loro conversazione, ma più tardi aveva saputo che Sojourner aveva parlato bene del presidente ed era stata onorata e soddisfatta dell’accoglienza. Mr Lincoln non poteva vantare un passato di rapporti perfetti con la comunità di colore, e lei sarebbe stata la prima ad ammetterlo, ma stava imparando, ed Elizabeth era sicura che il suo atteggiamento compassionevole nei confronti del prossimo lo avrebbe portato a una comprensione anche maggiore degli interessi e delle speranze dei neri. Anche se non avrebbe mai esagerato il proprio ruolo spacciandosi per consigliera, Elizabeth amava pensare di aver avuto anche lei un piccolo ruolo nell’aiutare il presidente Lincoln a conoscere meglio i desideri e le paure della sua gente. Sperava di aver usato il rapporto privilegiato con Abraham Lincoln e il tempo che trascorreva alla Casa Bianca per il bene della sua razza, e di continuare a farlo. La folla di persone arrivata nella capitale in occasione del secondo insediamento del presidente si disperse poco dopo le cerimonie, ma la città rimase piena di stranieri, le cui fila si infoltivano ogni giorno che passava. I soldati confederati stavano abbandonando l’esercito del generale Lee; molti andavano a casa, altri attraversavano le linee nemiche e si arrendevano. Alcuni si trascinavano fino a Washington a piedi, con l’uniforme grigia o marrone a brandelli sul corpo gracile, ma quasi tutti arrivavano ogni pomeriggio alle quattro sul “treno dei disertori”, e scendevano sulla banchina a cento o duecento per volta. Giunti nella capitale dell’Unione prestavano giuramento di fedeltà e venivano mandati a lavorare in fattorie, fabbriche o alla frontiera occidentale. Fino al momento di essere assegnati alle loro nuove funzioni avevano il permesso di stazionare in città, facendo conversazione e spartendosi il tabacco con soldati dell’Unione che erano stati loro nemici giurati fino a poco prima; all’inizio le loro uniformi sudiste attiravano sguardi curiosi e diffidenti, ma la gente si abituò presto. In effetti quegli ex ribelli emaciati diventarono tanto numerosi a Washington che almeno un giornalista ventilò l’ipotesi che si trattasse di una sorta di invasione velata: il nemico, insomma, avrebbe ammassato i propri uomini in città in attesa dell’ordine di sferrare l’attacco al cuore dell’Unione dall’interno. La verità era molto più semplice. I soldati confederati stavano morendo di fame, e avevano capito che un esercito che non era più in grado di dare da mangiare ai suoi uomini non era nemmeno capace di tenere testa al nemico. Erano affamati, esausti e stanchi del conflitto, e molti non sopportavano più di continuare quella che chiamavano la “guerra dei ricchi combattuta dai poveri”. E così avevano disertato, sperando di non essere catturati o, se lo fossero stati, di non essere fucilati per il crimine commesso. A parere di Elizabeth non restavano abbastanza soldati nell’esercito sudista per fucilare tutti i disertori. In seguito la sarta si chiese se la nuova iniziativa del governo confederato per aumentare gli arruolamenti non fosse stata la causa di quell’ondata di diserzioni. Poco dopo l’insediamento di Lincoln, i giornali del Nord annunciarono che il Congresso degli stati confederati aveva votato una legge per permettere agli schiavi di arruolarsi nell’esercito dei ribelli e conquistarsi così la libertà. Elizabeth e tutte le persone di colore di sua conoscenza, dagli altri residenti nella pensione ai frequentatori della sua chiesa, agli ex schiavi che assisteva nei campi, si chiedevano come un nero potesse accettare di combattere per proteggere l’istituzione stessa che lo privava della libertà e manteneva lui e la sua famiglia in uno stato di degrado. Erano rimasti scandalizzati scoprendo che solo nove giorni dopo la promulgazione della legge da parte di Jefferson Davis tre compagnie di soldati neri confederati avevano cominciato ad addestrarsi nella piazza del Campidoglio di Richmond. Elizabeth si sentiva profondamente tradita quando pensava a soldati neri con l’uniforme grigia dei ribelli, ma era anche molto dispiaciuta. Certo non capivano cosa stava accadendo nel resto del paese, altrimenti non avrebbero mai compiuto una scelta tanto assurda o, come Virginia la definiva senza tanti giri di parole, un simile patto col diavolo. L’insediamento del presidente portò nuovi arrivati anche nei circoli più esclusivi di frequentatori della Casa Bianca; in effetti tra l’elezione di novembre e l’inizio vero e proprio del secondo mandato del presidente Lincoln diversi suoi ministri diedero le dimissioni e altri furono nominati al loro posto. Il senatore dell’Iowa James F. Harlan assunse le funzioni di ministro dell’Interno, un cambiamento che sembrò risultare congeniale a Robert Lincoln, il quale – forse con meno discrezione del dovuto – corteggiava la figlia di Harlan, Mary. Anche Elizabeth era soddisfatta di quella promozione, perché la moglie di Harlan, una donna dolce e buona, era una delle sue clienti preferite, e la sarta era felice per lei. Il 3 aprile, un lunedì, Mrs Harlan si recò da Elizabeth alla pensione con il materiale per un nuovo abito, una splendida seta a righe bianche e verdi. «Non sono sicura del colore» commentò Mrs Harlan mentre la sarta esaminava la stoffa. «Ho paura che mi renda l’incarnato giallognolo». «Oh, non penso proprio». La sarta la fece avvicinare alla finestra, dove le posò la seta sulle spalle e il petto e fece qualche passo indietro per studiare l’effetto. «Credo che vi doni molto, invece, e che si intoni al vostro colore di occhi e capelli». «Mr Harlan ama vedermi vestita di verde». La cliente dovette alzare la voce per sovrastare un fracasso improvviso proveniente dalla strada, una cacofonia provocata da artiglieri di passaggio. «Ragione di più per vestirvi spesso di quel colore» replicò Elizabeth, trovandosi anche lei a urlare per farsi udire tra fischi e schiamazzi. «Cosa sta succedendo là fuori?» si chiese Mrs Harlan, sbirciando dalla finestra. «Staranno andando a sparare dei colpi a salve per festeggiare una vittoria. Ormai ci siamo abituati» disse Elizabeth. Poi, aggrottando la fronte, aggiunse: «Ammetto però che c’è più baccano del solito». Mrs Harlan sgranò gli occhi. «Devono essere buone notizie, allora». «Di sicuro». Tra loro passò uno sguardo d’intesa, e insieme corsero fuori. «Scusate, signore» chiese Elizabeth a un uomo che fischiettava allegro seguendo l’artiglieria. «Cos’è successo? Che novità ci sono?» «Che novità, dite?» L’uomo fece un grido esultante e gettò in aria il cappello. «Richmond è caduta, ecco cos’è successo!» Quando l’uomo tornò indietro a raccogliere il cappello per unirsi al corteo improvvisato, Elizabeth si lasciò sfuggire un’esclamazione soffocata, la moglie del ministro cacciò un urlo e si presero per mano, girando in cerchio e ridendo. «Devo dirlo alle ragazze!» esclamò la sarta, e corse nel laboratorio dall’altra parte della strada. «Emma, ragazze!» gridò entrando nella stanza dove erano al lavoro le sue assistenti. «Richmond è caduta!» «Abbiamo sentito! Lo sappiamo!» Felice, Emma le gettò le braccia al collo, e solo allora la sarta si accorse che le sue assistenti stavano ridendo e piangendo mentre si abbracciavano. «Avete sentito la parte migliore? Sono stati i soldati neri a prendere la città. I nostri soldati!» Elizabeth aveva il morale alle stelle. Resa muta dalla gioia, si portò le mani al cuore e rise. «Anzi, la cosa migliore non è neanche quella!» esclamò felice un’altra sarta. «Il bello è che ci avete promesso un giorno libero quando Richmond fosse caduta!» Scoppiarono tutte a ridere, Elizabeth compresa, finché non riprese fiato e con un gesto impose il silenzio, scuotendo il capo. «Non posso mandarvi tutte a casa» protestò. «Mrs Harlan sta aspettando dall’altra parte della strada con la seta per un nuovo abito». Un coro di proteste accolse la notizia. «Mrs Harlan non può fare le prove per un nuovo abito proprio ora» obiettò Emma. «Vorrà andare anche lei a festeggiare». Quando le altre sarte diedero man forte alla collega, incitando Elizabeth a provare almeno a parlare con la cliente, la sua risoluzione vacillò. «Aspettate ad andarvene» ingiunse, ma invece di un tono severo le uscì un sorriso. Attraversò la strada di corsa, e trovò Mrs Harlan nel suo salotto, intenta a raccogliere la seta che avevano fatto cadere nell’emozione del momento. «Mrs Harlan!» esclamò Elizabeth, affrettandosi ad aiutarla. «Mi dispiace molto. Dovevo dare la buona notizia alle mie assistenti, che oltretutto la sapevano già. E mi hanno ricordato una promessa che ho fatto loro mesi fa: quando Richmond fosse caduta, avrei concesso loro un giorno libero, anche se mi rendo conto che è un fastidio per lei...» «Assolutamente no» le assicurò con un sorriso la cliente. «Per un’occasione così lieta sono ben contenta di aspettare un giorno o due per il mio vestito. Dovete mantenere la promessa. Date alle vostre ragazze un giorno di vacanza, fate loro questo regalo». Elizabeth la ringraziò e promise di cominciare a prendere le misure per la fodera il giorno dopo. Mrs Harlan accettò e, quando se ne fu andata, la sarta ripose la seta verde e bianca in un luogo sicuro, prese la cuffia e tornò nel laboratorio. «Altre buone notizie...» annunciò, ma non ebbe neppure il tempo di finire la frase. Le ragazze la implorarono di andare con loro, e stavolta Elizabeth accettò. Prendendosi a braccetto si unirono al corteo che si stava già riversando per le strade, con il cuore colmo di gioia, e vedendo la propria felicità riflessa nei visi degli altri passanti, impiegati, bottegai, domestiche e camerieri, tutti con un giorno libero inaspettato. Gli abitanti appesero striscioni e bandierine alle finestre, agli angoli delle strade e nei parchi si formarono bande improvvisate che suonavano marcette e altre musiche allegre. Davanti alle case e agli uffici di vari notabili si raccolsero drappelli di persone che chiedevano un discorso, ma solo quelli dalla voce più stentorea riuscirono a farsi udire nel baccano. Una scarica di ottocento colpi a salve scosse la città, trecento per la caduta di Petersburg, cinquecento per Richmond. Durante il pomeriggio Elizabeth osservò molti ragazzi – e molti uomini che non avevano nemmeno la scusa della giovinezza – festeggiare bevendo quantità smodate di alcolici, e fu scandalizzata e a tratti divertita nel vedere vicini che reputava persone responsabili e moderate nel bere avanzare barcollando lungo la strada, cantando e tessendo gli elogi del presidente Lincoln, del generale Grant e dell’esercito dell’Unione con voce sguaiata. Il giorno dopo avrebbero rimpianto gli eccessi, ma per il momento nulla poteva placare la loro esultanza, o quella di Elizabeth. Il presidente Lincoln era in Virginia dall’ultima settimana di marzo, e si stava intrattenendo con il generale Grant a Petersburg quando Richmond era caduta. Decise che avrebbe ispezionato la capitale sudista catturata il giorno dopo, e quando Mrs Lincoln seppe del progetto gli propose di incontrarlo a City Point, sul fiume James, e di accompagnarlo nella città conquistata. Sarebbe stata la seconda visita della first lady a City Point, il quartier generale di Grant, nel giro di due settimane. Lei e Tad c’erano stati la settimana prima con il presidente e un piccolo gruppo di accompagnatori, ma lei era tornata prima del previsto, e da sola, lasciando Tad con suo padre. Non aveva spiegato perché avesse abbreviato la visita, e sebbene avesse tagliato corto quando Elizabeth le aveva chiesto notizie del viaggio, quel poco che aveva rivelato bastava per dedurre che era stato un disastro. Quando il gruppo si era recato a passare in rassegna le truppe, il presidente era andato avanti a cavallo, accompagnato dal generale Grant e dalle mogli di due ufficiali, ma Mrs Lincoln e Mrs Grant erano state costrette a seguirli a velocità ridotta in un carro ambulanza, rallentato dal fango che ricopriva la strada. Al suo arrivo Mrs Lincoln aveva scoperto che l’ispezione era già iniziata e che la bella moglie del maggior generale Ord cavalcava accanto al presidente al posto d’onore che sarebbe spettato a lei. In preda a una delle sue terribili crisi di gelosia, aveva fatto una scenata alla giovane Mrs Ord, insultato l’attonita Mrs Grant e rimproverato il marito davanti a tutti, chiedendo che licenziasse immediatamente il maggior generale Ord, ordine che il presidente aveva ignorato. Elizabeth non sapeva se Mrs Lincoln fosse tornata a Washington per la vergogna o se fosse stato il marito a cacciarla, ma a quanto pareva la pausa di riflessione e la consapevolezza che l’incidente le aveva impedito di vedere il figlio Robert l’avevano placata. Quando annunciò che intendeva riprovare a vedere Richmond, Elizabeth le chiese se poteva accompagnarla. Anni prima aveva abitato a Petersburg, ed era curiosa di vederla di nuovo, di passeggiare lungo le sue vie come donna libera. Il 5 aprile, alle undici di mattina, Mrs Lincoln, Tad, Elizabeth e il resto del gruppo, che includeva il senatore Charles Sumner, il ministro dell’Interno James Harlan, Mrs Harlan, il cui abito di seta verde e bianca era stato iniziato da Elizabeth in ritardo, Miss Mary Harlan, la signorina corteggiata da Robert Lincoln, e diversi altri signori, partirono da Washington a bordo della nave a vapore Monohasset. Il mattino dopo, arrivati a Fort Monroe, Mrs Lincoln seppe che il presidente era entrato a Richmond due giorni prima. «Siete sicuro di aver voluto dire proprio Richmond?» chiese la first lady all’aiutante di campo mortificato. Elizabeth sapeva che aveva insistito con il marito perché la aspettasse per entrare e visitare insieme la capitale caduta. «Nel suo telegramma diceva che sarebbe andato a Petersburg». Ed era quello che aveva fatto, assicurarono subito a Mrs Lincoln. Solo il mattino successivo era entrato a Richmond, appena un giorno dopo che l’esercito dei confederati era stato sgomberato, mentre le fiamme lambivano ancora le rovine. L’aiutante di campo, apparentemente ignaro del malumore crescente della first lady, continuò a raccontare che alcuni lavoratori neri avevano riconosciuto il presidente da lontano e, mettendolo in grande imbarazzo, avevano gridato: «Gloria, alleluia!» al suo passaggio ed erano caduti in ginocchio per baciargli i piedi. «Vi prego, non inginocchiatevi davanti a me» aveva detto loro il presidente. «Dovete prostrarvi solo davanti a Dio e ringraziarLo per la vostra libertà». Scortato dal generale Godfrey Weitzel, di origini tedesche, Lincoln aveva visitato la Casa Bianca dei confederati e si era seduto alla scrivania di Jefferson Davis. Più tardi lui e il suo accompagnatore erano passati dalla famigerata prigione Libby, dove migliaia di soldati dell’Unione catturati avevano subito fame, malattie e ogni sorta di torture, e della quale era direttore il cognato del presidente, il capitano sudista David Humphreys Todd. «Capisco» replicò seccamente Mary Lincoln quando l’aiutante di campo terminò il resoconto. Si precipitò subito all’ufficio del telegrafo e inviò al marito diversi messaggi urgenti implorandolo di aspettarla e di permettere a lei e al suo gruppo di salire a bordo del battello presidenziale, giacché il loro era estremamente scomodo e lei desiderava ardentemente visitare Richmond in sua compagnia. Dopo alcuni scambi furono presi i necessari accordi, e presto il gruppo della first lady fu a bordo della River Queen del presidente, che risalì il fiume James seguendo una rotta che fino a poco tempo prima era stata preclusa anche alle cannoniere nordiste. Elizabeth trascorse ore sul ponte, appoggiata al parapetto e con il viso rivolto al sole, a godersi il venticello e l’aria fresca e pura. Il fiume scorreva maestoso, e le sponde erano splendide e profumate dei primi fiori della primavera. Più oltre si stendevano i campi, l’immagine stessa della ricchezza in tempo di pace, ma spesso l’illusione di prosperità era infranta da visioni improvvise di accampamenti militari abbandonati e di fortini diroccati, i resti della guerra. Elizabeth non vedeva da anni i campi fertili e le verdi colline della sua regione natia, e da molto desiderava tornarvi. La Virginia le avrebbe ricordato per sempre sua madre e suo padre, le zie, gli zii e i cugini, il figlio George, neonato, tra le sue braccia, i baci affettuosi di sua madre, le ore trascorse in compagnia delle persone che amava di più. L’infanzia era stata difficile per lei, piena di dolore e paura, eppure serbava alcuni ricordi belli di quegli anni. Quando era partita per City Point, una parte di lei nascosta così in profondità da risultarle sconosciuta si era aspettata da quel viaggio una sorta di ricongiungimento con tutto ciò che aveva perduto. Mentre la River Queen la trasportava lungo il fiume, la vera natura delle sue attese le apparve chiara, e avvertì una punta di rimpianto. Forse non sarebbe dovuta andare. Infine la River Queen giunse a Richmond e la first lady con i suoi accompagnatori, pieni di curiosità, entrarono nella città ancora fumante. Elizabeth non l’avrebbe mai ammesso ad alta voce, ma avvertì anche un brivido di apprensione. Le strade erano insolitamente deserte, a eccezione di alcuni abitanti che distoglievano subito lo sguardo mentre li incrociavano a passo veloce, presi della proprie faccende, o di pattuglie occasionali di soldati dell’Unione. Il Parlamento della Virginia dove si era riunito il Congresso dei confederati era in condizioni che tradivano la paura e la fretta degli ultimi istanti: scrivanie rotte, carte sparpagliate, sedie rovesciate come se gli ultimi occupanti fossero fuggiti di corsa. Mentre i suoi compagni procedevano, osservando la desolazione che i membri del Congresso si erano lasciati alle spalle, Elizabeth sollevò le gonne con una mano e si chinò per raccogliere dei fogli. Scorse la prima pagina, e la risata improvvisa che le sfuggì quando si accorse cosa c’era scritto indusse Mrs Lincoln e Mrs Harlan a voltarsi a guardarla, incuriosite. «È una risoluzione» spiegò Elizabeth indicando le carte. «Proibisce a tutti i neri liberi di entrare nello stato della Virginia». Il senatore Sumner scosse il capo sbuffando, ma un altro gentiluomo del gruppo, il marchese de Chambrun, sorrise e disse: «Mia cara signora, credo non dobbiate temere che qualcuno venga ad arrestarvi». «Grazie, signore» replicò lei. «Confesso che l’idea non mi era neanche passata per la testa». «Conserverete quei documenti per ricordo?» si informò la first lady. Spesso canzonava Elizabeth per il suo attaccamento a oggetti che le evocavano ricordi piacevoli. «Penso di no» rispose lei secca, e lasciò cadere i fogli. Passarono in Senato, dove Elizabeth si sedette sulla poltrona del presidente Jefferson Davis e si guardò attorno, immaginando la sala piena di senatori ribelli e pensando alle molte decisioni che il presidente doveva aver preso proprio in quel luogo, e a quanto fossero costate a lui e a tutti loro. Quando si spostò verso lo scranno del vicepresidente per lasciare agli altri l’opportunità di sedere al suo posto, il pensiero le andò a Mrs Davis e ai suoi figli. Li immaginò in fuga o nascosti, diretti a sud nel rifugio non più sicuro della loro casa in Mississippi o sotto il tetto di un amico fidato. Ovunque fossero, Elizabeth sperava che stessero bene. Non avevano colpa, e pregò che non accadesse loro nulla di male. Per quanto riguardava Mr Davis, prima della guerra lei lo aveva apprezzato, considerandolo un gentiluomo, ma aveva fatto le sue scelte e avrebbe dovuto vivere con le conseguenze. Non gli avrebbe mai augurato nulla di male, ma riteneva improbabile che sarebbe uscito indenne dalla guerra. Più tardi il gruppo visitò la dimora presidenziale dei ribelli in K Street, chiamata anch’essa Casa Bianca sebbene fosse di stucco grigio. Le signore di Richmond incaricate di custodirla li osservarono torve mentre ne ispezionavano i tre piani eleganti, ma non poterono certo impedire loro di andare dove volevano. Elizabeth cercò in giro per le stanze i segni della sua ex cliente – un piumino abbandonato nella nursery del secondo piano, un abito che non era stato possibile infilare in una borsa già traboccante – ma non trovò nulla, e quella mancanza le diede una strana sensazione di sconforto. Con uno sforzo mise da parte la tristezza e cercò di farsi contagiare dall’allegra curiosità dei compagni di viaggio. Alla fine riuscirono a tirarla su di morale, e quando tornarono alla River Queen, anche lei avvertì una vampata di trionfo e la speranza che la fine della guerra fosse ormai prossima. Fu un’allegra comitiva quella che si ritrovò la sera seduta attorno al tavolo della cena. Per Elizabeth fu una gioia vestire Mrs Lincoln per un evento al quale partecipava anche lei. Furono fatte le presentazioni e tutti si misero a chiacchierare piacevolmente delle diverse impressioni che Richmond aveva prodotto su di loro, quando un ospite, un giovane capitano appartenente alla commissione sanitaria, si rivolse alla first lady dicendo: «Mrs Lincoln, avreste dovuto vedere il presidente l’altro giorno, quando ha fatto la sua entrata trionfale a Richmond. Tutti lo guardavano. Le signore gli baciavano le mani e lo salutavano agitando il fazzoletto. Ha proprio l’aria di un eroe quando è circondato da belle donne». «Sì, lo immagino» replicò lei gelida. Il sorriso del giovane ufficiale gli si spense sul volto. «Sì, Mrs Lincoln. Un vero eroe». Elizabeth si mise in allarme, ma prima che trovasse un modo educato per cambiare argomento la first lady fissò il giovane freddamente e chiese: «È spesso così? Circondato da belle donne, intendo?» Il capitano arrossì. «No, Mrs Lincoln, voglio dire...» Lanciò uno sguardo disperato attorno al tavolo, ma i suoi amici erano troppo stupiti per andargli in soccorso. «Cosa volete dire, esattamente?» lo esortò in modo brusco la first lady. Elizabeth soffocò un sospiro e resistette alla tentazione di farsi piccola sulla sedia e di fissare il piatto mentre Mrs Lincoln incalzava il povero giovane, che sicuramente non avrebbe mai più dimenticato quella brutta serata a bordo dell’imbarcazione del presidente. Mrs Lincoln fece una scenata prima di esaurire la sua collera, ed Elizabeth si sentì indignata e imbarazzata osservando gli altri ospiti che si scambiavano sguardi d’intesa e fissavano la first lady con aria di compatimento. Non capivano cos’avesse patito in quei giorni, quanto fosse stanca per i viaggi compiuti, altrimenti le avrebbero dimostrato più comprensione. A ogni modo le dispiaceva che la moglie del presidente non sapesse controllarsi, e che toccasse sempre agli altri far buon viso alle sue scenate. Il mattino dopo tutto il gruppo decise di visitare Petersburg, ed Elizabeth fu felice di accompagnarli. A mano a mano che il treno speciale del presidente si avvicinava alla città dove la sarta aveva vissuto come schiava vent’anni prima, il cuore prese a batterle più forte per l’eccitazione e la paura. Non sapeva cos’avrebbe trovato lì, se fosse rimasto qualcosa della vita che aveva conosciuto un tempo, né se desiderava davvero trovare qualche elemento del suo passato. Quando scesero alla stazione Elizabeth si separò dagli altri; mentre loro andavano a visitare fortini, ospedali da campo e a parlare con i generali, lei si avventurò da sola in cerca delle persone che conosceva tanto tempo prima. La città era profondamente familiare ai suoi occhi, ma anche assai mutata. Molte case che un tempo aveva ammirato erano trascurate ed erano state danneggiate dall’artiglieria; alcuni negozi dove si recava per conto delle sue padrone avevano le vetrine sbarrate o nomi diversi sull’insegna o sulla porta. Vide volti familiari tra i passanti, che però la incrociarono senza riconoscerla. Quasi controvoglia scese verso la riva del fiume dove lei e James avevano passeggiato un tempo, chiacchierando e condividendo speranze e sogni (e bugie, nel caso di James). Il cuore le si faceva più pesante a ogni passo, e stava per tornare indietro verso la stazione quando udì una donna dietro di lei chiamarla: «Elizabeth? Lizzie Hobbs?» Con un sussulto Elizabeth si girò e vide un viso che conosceva bene, di vent’anni più vecchio, molto più magro, con dell’argento nei capelli neri e le rughe attorno alla bocca, ma che le era caro come un tempo. «Martha? Sei davvero tu?» La donna annuì con le lacrime agli occhi. «Oh, mia cara amica!» esclamò Elizabeth, correndole incontro per abbracciarla. «Pensavo che non ti avrei mai più visto». «Anch’io». Martha la allontanò da sé per guardarla, e quando sorrise Elizabeth vide che le mancavano gli incisivi inferiori. «Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che ti fossi affrancata e fossi scomparsa al Nord». «Non sono scomparsa» replicò Elizabeth ridendo tra le lacrime, e cercando di nascondere il proprio turbamento. Martha era magra, magrissima, e aveva l’abito liso e rammendato. La sua amica, nata libera, era una bravissima sarta, e aveva lavorato nella merceria di Mrs Miller. Anche se aveva cinque anni più di Elizabeth, erano diventate ottime amiche grazie al fatto che quest’ultima andava spesso in negozio a comprare tessuto, filo, aghi e altri prodotti per le sue padrone. «Vivo a Washington da prima della guerra. Faccio la sarta». «Meraviglioso!» Martha scosse il capo ammirata. «Hai sempre fatto miracoli con la stoffa». «Come sta tuo marito? È poi riuscito a comprare quella terra a nord del fiume cui teneva tanto?» «Purtroppo no». Il sorriso di Martha si spense. «È morto di vaiolo dieci anni fa, ma le mie ragazze stanno bene. La maggiore è sposata e ha due figli. E George come sta?» Elizabeth si conficcò le unghie nel palmo della mano per trattenere il dolore che era improvvisamente montato in lei. «Se n’è andato. È rimasto ucciso in guerra, nella battaglia di Wilson’s Creek in Missouri». «Oh, mio Dio. Era un soldato, allora. Mi dispiace tanto che sia morto». «Anche a me dispiace per te». «Ma devi essere orgogliosa». «Sì» si costrinse a dire Elizabeth. «Molto orgogliosa». Camminarono insieme per un po’, e Martha le fece incontrare diverse amiche comuni che erano rimaste in città. Durante la guerra ognuna di loro aveva sopportato difficoltà e privazioni che Elizabeth non avrebbe neanche potuto immaginare mentre viveva comodamente nella sua bella pensione in Twelfth Street, ma nessuna di loro si lagnò o si attardò più del dovuto sulla propria sofferenza. Ammirarono tutte il suo vestito, che non era neanche il più bello, ma era ben fatto e non rammendato, e si dimostrarono felici, senza neppure una traccia di invidia, per il fatto che avesse fatto carriera. Lei ne fu commossa, e avrebbe tanto voluto aiutarle. Aveva con sé alcuni dollari dell’Unione, che le donne all’inizio rifiutarono, ma poi accettarono con gratitudine quando parlò dei debiti che aveva con loro dai tempi di Petersburg, debiti che non ricordavano perché se li era appena inventati. Congedandosi dalle vecchie amiche, le esortò a scriverle se avessero avuto bisogno di qualunque cosa. Si accomiatò da Martha per ultima e, ricordando la sua abilità con ago e filo, le propose di raggiungerla a Washington se avesse potuto. «Ho troppi vestiti da confezionare e non abbastanza mani» disse. «Potresti guadagnare bene se lavorassi con me». Martha avrebbe tanto voluto accettare, o almeno così sembrava, ma scosse il capo. «Le mie figlie hanno bisogno di me» rispose, «e casa mia è a Richmond. Non posso andarmene». «Ma sarà dura per i neri al Sud dopo la fine della guerra». Martha fece un sorriso tirato. «È sempre stata dura, e ce la siamo sempre cavata». Prima di separarsi, Elizabeth fece promettere a Martha che avrebbe almeno tenuto a mente la sua offerta, poi, con un peso sul cuore, tornò nel luogo dove il gruppo era d’accordo di ritrovarsi. Il triste spettacolo di quel giorno si mescolò con ricordi lontani in modo tanto doloroso che avrebbe voluto salire a bordo del treno e partire subito, ma il presidente desiderava trattenersi ancora un po’. In una visita precedente aveva visto una quercia grande e dalla forma strana che voleva mostrare agli altri, così lo accompagnarono tutti verso la periferia della città, dove la pianta cresceva maestosa e solitaria. Solo dopo averla ammirata – e anche Elizabeth, nella sua malinconia, dovette ammettere che si trattava di un esemplare magnifico – tornarono alla stazione per andarsene da Petersburg. Alla sarta non dispiaceva lasciarsi alle spalle la città, ma come prendendosi gioco del suo desiderio di allontanarsi il treno tornò a City Point a passo d’uomo, per un motivo che Elizabeth non comprese. Il convoglio andava così lento che il presidente Lincoln ebbe il tempo di osservare una tartaruga d’acqua dolce che prendeva il sole accanto alle rotaie. Chiese al conducente di fermare il treno e a uno dei frenatori di portargli la creatura, e lui e Tad ci giocarono per tutto il viaggio fino al fiume James, dove li aspettava l’imbarcazione. Vedere il presidente che ammirava i movimenti lenti e poco aggraziati della tartaruga – e la ridicola somiglianza fra il ritmo del treno e quello dell’animale – rasserenò Elizabeth, che al momento di salire a bordo della River Queen si sentiva meglio, anche se ancora un po’ malinconica. Per una settimana la River Queen restò sul fiume James, spesso ancorata a City Point, offrendo una tregua piacevole a tutti coloro che si trovavano a bordo. Il generale Grant e sua moglie fecero visita agli ospiti del battello diverse volte, così come altri ufficiali e dignitari, e quando il presidente non si assentava per un’escursione restava con gli altri, a suo agio come in mezzo a vecchi amici. Alla vigilia del ritorno a Washington, Mr Lincoln andò a fare un’ultima ispezione delle truppe, e la sera tornò sul vapore esausto più che mai. «Mamma» confidò a sua moglie, «ho stretto tante di quelle mani oggi che mi dolgono le braccia. Vorrei andare a letto subito, se potessi». Mrs Lincoln gli mormorò qualche parola d’incoraggiamento e lo esortò a scusarsi e a ritirarsi, ma il presidente detestava deludere i compagni di viaggio e restò con loro, mentre le luci del crepuscolo si allungarono e le lampade venivano accese. Quando i lumi brillarono, Elizabeth si trovò ad ammirare affascinata la nave che pareva un palazzo galleggiante. A bordo c’era anche una banda militare, e al calare della notte si diffuse un’atmosfera magica. Diversi ufficiali salirono a bordo per accomiatarsi dal presidente, e verso le dieci gli chiesero di tenere un discorso. Con qualche sforzo lui si alzò e disse: «Dovete scusarmi, signore e signori. Sono troppo stanco per parlare stasera. Martedì prossimo terrò un discorso a Washington, e allora saprete tutti cos’ho da dire. Per ora, per salutare i valorosi soldati del nostro grande esercito, chiedo alla banda di suonare Dixie. È sempre stato uno dei miei brani preferiti e, da quando abbiamo conquistato il Sud, abbiamo tutto il diritto di godercelo». Non appena tornò a sedersi i musicisti attaccarono a suonare, e quando le ultime note si spensero gli ascoltatori applaudirono. A Elizabeth il loro atteggiamento parve quasi solenne, come se capissero che il compito fondamentale e ambizioso che li aveva impegnati tanto a lungo era pressoché compiuto, ma che li aspettava l’impresa della ricostruzione dell’Unione. Alle undici si scambiarono gli ultimi addii, quelli che sarebbero rimasti scesero a terra, le luci festive furono staccate e la River Queen fece rotta su Washington. Per tutto il giorno successivo il battello risalì lungo la baia e il Potomac. Per evitare di parlare di ricostruzione con il senatore Sumner, il presidente lesse Macbeth ad alta voce, insistendo sul tormento del re scozzese. Quando l’imbarcazione passò davanti a Mount Vernon, il marchese dichiarò che negli anni a venire la casa del presidente Lincoln nell’Illinois sarebbe stata onorata quanto quella del presidente Washington in Virginia. «Springfield» disse Lincoln con una voce che a Elizabeth sembrò piena di dolce nostalgia. «Come sarò felice di tornare lì fra quattro anni, a godermi pace e tranquillità!» Il battello arrivò nella capitale alle sei di domenica pomeriggio, e i viaggiatori scesero e andarono ciascuno per la propria strada. Non era ancora tramontato il sole, ed Elizabeth tornò a casa a piedi per conto suo, godendosi la solitudine dopo tanto tempo trascorso in compagnia di altri. Il viaggio era stato meraviglioso, istruttivo, ma lei non vedeva l’ora di entrare nella propria stanza e di dormire nel suo letto. Mentre camminava si disse che c’era un’agitazione non comune per una domenica sera, soprattutto considerando che era la domenica delle Palme; erano anche stati accesi dei falò che sembravano guidarla verso il ritorno a casa. «Che sta succedendo?» chiese Elizabeth a un vicino quando imboccò Twelfth Street e lo vide osservare la scena dai gradini della sua abitazione. «Tutto questo è per accogliere il presidente e la first lady di ritorno a casa?» «È una celebrazione» rispose lui «e una veglia. Stiamo aspettando. Ormai non manca molto». La sarta avvertì un brivido di trepidazione e di gioia, e immaginò di sapere già la risposta quando gli chiese: «Non manca molto a cosa?» «Alla fine del conflitto!» le gridò lui di rimando. «Il generale Grant ha tagliato la strada a Lee che si stava ritirando ad Appomattox Court House. I ribelli sono circondati!» 12. Aprile 1865 All’alba Elizabeth si svegliò al suono dei cinquecento colpi a salve che furono esplosi in segno di vittoria e che fecero tremare il letto e le finestre. Attraverso le pareti della pensione udì gli altri residenti rispondere con acclamazioni ancora impastate di sonno, e capì subito che il generale Lee doveva essersi arreso. Si vestì rapidamente e scese all’entrata della pensione, dove Virginia, Walker, Miss Brown, Emma e alcuni altri vicini si stavano radunando per condividere le poche notizie che avevano. «Significa che la guerra è finita?» chiese Elizabeth, ma nessuno poteva dirlo per certo. Nessuno sapeva cosa stesse accadendo in North Carolina tra il generale Sherman e il suo avversario confederato, il generale Johnston. Walker propose di dirigersi all’ufficio del telegrafo per avere notizie ufficiali, ma alla fine dei colpi a salve erano iniziati i tuoni, e cadeva una pioggia torrenziale. Elizabeth e Virginia non avevano nessuna voglia di avventurarsi sotto quell’acquazzone, ma nulla avrebbe trattenuto Walker ed Emma, che scoppiavano di curiosità, e così andarono loro due da soli. Guardando dalle finestre, Elizabeth calcolò che dovevano essere migliaia le persone riversatesi in strada nonostante la pioggia, ridenti ed esultanti, a scambiarsi abbracci. Si sentiva così inebriata che temeva di scoppiare a ridere o di mettersi a cantare, e non appena la pioggia si calmò, lei e Virginia presero con loro le ragazze Lewis e si unirono alla celebrazione. Si formarono cortei improvvisati, in cui i civili presero a braccetto i soldati e cantarono Rally Round the Flag e inneggiarono alle buone notizie seguendo le bande musicali che percorrevano le vie piene di fango. I carri a vapore dei pompieri, adorni di bandiere e banderuole, lanciavano in aria il loro fischio penetrante. Soldati e meccanici andarono a prendere una batteria di sei obici all’arsenale e si misero a sparare a salve. Elizabeth si sentì trascinare dalla folla che si dirigeva verso la Casa Bianca, dove unì la propria voce al coro esultante e grato che cantava The Star-Spangled Banner. La calca vociferava chiedendo un discorso del presidente. Un boato accolse Tad che fece capolino da una finestra, e le grida diventarono ancora più forti quando il ragazzino agitò una bandiera ribelle catturata per far divertire la folla. Poco dopo apparve anche il presidente Lincoln, accolto dalle ovazioni del popolo e da centinaia di cappelli gettati in aria. Quando il baccano si calmò un poco il presidente disse: «Sono molto contento di vedere che è successo qualcosa di tanto bello che non riuscite a contenere la vostra gioia». Elizabeth rise e applaudì con la folla. «Immagino che si stia organizzando una celebrazione più formale» rifletté ad alta voce, «stasera o forse domani». «Non possiamo aspettare!» gridò qualcuno. «Vogliamo festeggiare subito!» urlò un altro, e immediatamente centinaia di altre voci si unirono per manifestare il proprio assenso. «Se ci dev’essere una manifestazione mi toccherà presenziare» protestò il presidente, «e non avrò nulla da dire se mi strappate le parole di bocca adesso». Il pubblico, rapito, rispose con risate e applausi. Mr Lincoln scrutò la folla. «Vedo che avete una banda musicale lì con voi». «Ne abbiamo due o tre» gli rispose qualcuno di rimando. «Propongo di finire questo incontro chiedendo alla banda di suonare un pezzo particolare» decretò il presidente. «Prima, però, vorrei spiegare il perché di questa scelta. Ho sempre considerato Dixie una delle canzoni più belle che conosca. I nostri avversari hanno cercato di appropriarsene, ma ieri ho insistito nel dire che l’abbiamo conquistata noi». Un grido potente della folla gli diede ragione. «Ho sottoposto la questione al procuratore generale, e secondo la sua opinione legale si tratta di un premio che ci siamo conquistati in modo legittimo». Mentre le sue parole venivano accolte da nuove risate e applausi, il presidente levò la mano in un gesto rivolto ai musicisti. «Ora richiedo alla banda di eseguirla». Elizabeth non aveva mai udito un’interpretazione tanto gioiosa di quel pezzo. Subito dopo la banda suonò Yankee Doodle e la folla la accompagnò battendo le mani. Dopo le ultime note Mr Lincoln disse: «E adesso, tre urrà per il generale Grant e tutti i suoi uomini». La folla, Elizabeth tra loro, eseguì subito. «Altri tre urrà per la nostra valorosa Marina». Anche a questo ordine obbedirono immediatamente. Poi, con un piccolo inchino, il presidente scomparve dalla finestra, tra lo scroscio di applausi e acclamazioni degli astanti. Poco dopo si sparse la voce che si doveva andare al ministero della Guerra per chiedere un discorso anche al ministro Stanton, ma Elizabeth, Virginia ed Emma decisero di abbandonare la folla e di portare a casa le ragazzine. Quella sera la sarta rifletté sul discorso improvvisato del presidente alla finestra, e si disse che in tanti anni che lo conosceva, e dopo tante volte in cui avevano chiacchierato insieme mentre lei lavorava alla Casa Bianca, non lo aveva mai sentito fare un discorso pubblico. L’ultima sera a bordo della River Queen, e di nuovo quel giorno alla finestra della Casa Bianca, aveva promesso un discorso formale per il giorno successivo. Forse anche perché rimpiangeva di essersi persa il suo intervento in occasione dell’insediamento, non vedeva l’ora di ascoltare quel discorso, il primo dopo la resa del generale Lee. Il mattino seguente Mrs Lincoln passò da Elizabeth alla pensione per parlarle di un nuovo abito che le sarebbe piaciuto. Mentre stava congedandosi, la sarta le chiese se poteva andare alla Casa Bianca, quella sera, per ascoltare il discorso del presidente. «Certo, Lizzie» rispose la first lady. «Se vi interessano i discorsi politici, siete la benvenuta». «Grazie, Mrs Lincoln». Dopo un attimo di esitazione aggiunse: «Posso abusare ulteriormente della vostra gentilezza e chiedervi di portare un’amica con me?» «Portatela pure» accettò di buon grado la moglie del presidente, aggiungendo poi, quasi se ne fosse dimenticata: «Venite in tempo per vestirmi prima del discorso». «Certo» promise Elizabeth. «Potete contarci». Mrs Lincoln annuì e se ne andò. Qualche istante dopo Elizabeth la guardò dalla finestra uscire dalla pensione e salire a bordo della carrozza che la portò via. La sarta pensò a Virginia e a Emma, e le dispiacque di non avere chiesto alla first lady di portare due amiche. Ormai era tardi per rimediare, e decise di invitare Emma. La sua giovane assistente andava sempre ad ascoltare i discorsi di Lincoln quando poteva, e aveva udito anche il secondo discorso inaugurale, che aveva riferito a Elizabeth con dovizia di particolari. Siccome era una fervente ammiratrice del presidente, sembrava giusto offrirle l’opportunità di ascoltarlo da un luogo tanto privilegiato all’interno della Casa Bianca. Emma, emozionata, accettò subito l’invito, e alle sette di sera entrarono entrambe alla Casa Bianca dall’ingresso principale, come la sarta aveva già fatto tante volte prima di allora. Mentre salivano agli appartamenti della first lady, Elizabeth toccò il braccio della ragazza per segnalarle di procedere senza fare rumore. Quando passarono davanti allo studio del presidente, rallentarono e sbirciarono dalla porta socchiusa. Abraham Lincoln era seduto alla scrivania, riguardava i suoi appunti e borbottava tra sé, con aria pensosa e assente. La sarta si fermò un attimo a guardarlo, sapendo che stava ripassando e perfezionando le parole che presto avrebbe pronunciato non solo davanti alla folla radunata fuori, ma al cospetto del paese intero e anche oltre, perché tutti avrebbero letto il suo intervento sui giornali nei giorni a venire. Quando il presidente parlava, le sue parole facevano il giro del mondo, cosicché ognuna di esse andava scelta con attenzione. Quando giunsero alle stanze della first lady, Emma aspettò fuori mentre Elizabeth con mano esperta vestiva Mrs Lincoln di seta gialla e le acconciava i capelli infilandovi boccioli primaverili. Il presidente apparve proprio mentre la sarta stava dando gli ultimi ritocchi, ed entrambi accettarono che Elizabeth presentasse loro Emma. La sarta nascose un sorriso quando la ragazza strinse loro la mano e scambiò qualche frase educata con entrambi, intimidita da quell’onore inaspettato. Una grande folla si era radunata davanti alla Casa Bianca, e sulle note della banda della Marina si udivano le grida degli spettatori che chiamavano a gran voce il presidente. Quando infine si mostrò alla finestra centrale sopra la porta, la calca ammassata nell’oscurità sottostante esplose in un grido entusiasta. Guardando da un’altra finestra del secondo piano, dove lei ed Emma si trovavano allo stesso titolo delle dame e dei gentiluomini distinti che le attorniavano, Elizabeth trattenne il fiato per lo stupore. Non aveva mai visto una tale quantità di gente: parevano un mare nero e ondeggiante nella notte, e il movimento della folla assomigliava all’andirivieni della marea sulla sponda dell’oceano. I visi nelle prime file erano distinguibili, ma a mano a mano che si spingeva lo sguardo oltre, si vedevano solo sagome vaghe, spettrali. Ad accrescere la bellezza surreale della scena c’era il mormorio delle voci che si levavano fino a loro, simili al clamore lontano di una tempesta sull’oceano o al vento che fischiava attraversando una foresta buia e solitaria. Era una scena grandiosa, impressionante, e quando Lincoln la osservò con occhi penetranti, pieni di sentimento, aspettando che le acclamazioni si placassero, a Elizabeth parve un semidio più che un semplice mortale. Ogni finestra della Casa Bianca era illuminata da centinaia di piccole candele disposte tre a tre su assicelle sottili di legno, ma la luce delle candele non dovette essere reputata sufficiente, perché si udì subito il grido di qualcuno che chiedeva altri lumi. Quando fu portata la lampada, Elizabeth udì Tad gridare: «La tengo io, papà! Lascia che la tenga io!» Mrs Lincoln fece un gesto e disse qualcosa che Elizabeth non capì, ma doveva avere chiesto di esaudire il desiderio del figlio, perché il lume gli fu affidato. «Ci vediamo stasera non all’insegna della tristezza ma della gioia» esordì il presidente, e gli ascoltatori tacquero all’istante. «L’evacuazione di Petersburg e Richmond, la resa del principale esercito di ribelli fanno sperare in una pace giusta e rapida, che non può che suscitare felicità in tutti noi». Sì, pensò Elizabeth, sì, e la compassione, la gratitudine nella voce del presidente le toccarono il cuore tanto da farla sentire trasportata verso l’alto. Emma trasse un respiro tremante, e l’amica capì che anche lei era commossa da quello spettacolo impressionante: padre e figlio insieme, in presenza di migliaia di cittadini liberi, il più vecchio che parlava con eloquenza del destino di una nazione, il più giovane che lo osservava ammirato. Elizabeth non era lontana dal presidente e, dopo che questi ebbe elogiato l’esercito e parlato dell’annoso problema della ricostruzione, la luce del lume di Tad lo colpì in pieno rendendolo perfettamente visibile nella notte. Un pensiero terrificante sfiorò allora la sarta che, avvicinandosi a Emma, sussurrò: «Come sarebbe facile uccidere il presidente in questo momento! Qualcuno nascosto tra la folla potrebbe sparargli e non si scoprirebbe mai il colpevole». Emma annuì atterrita. Elizabeth riuscì a malapena a seguire il resto del discorso, temendo che uno degli uomini malvagi che gli aveva scritto lettere aggressive e minacciose si tenesse in agguato tra le ombre in mezzo alla calca. Solo pochi giorni prima Elizabeth aveva udito Mrs Lincoln chiedere misure di protezione supplementari per il marito, e quasi subito agenti della polizia metropolitana erano stati messi di guardia alla Casa Bianca per sventare eventuali tentativi di incendio, rapimento e altre minacce. Da allora, però, la resa del generale Lee sembrava avere alleviato almeno in parte gli onnipresenti timori della first lady. La sarta, tuttavia, avvertì un terribile presentimento: sapeva che i nemici del presidente non avevano smesso di detestare Lincoln quando Lee era stato sconfitto ad Appomattox. A un tratto Emma la prese per un braccio con un sorriso. Destata dalle sue cupe fantasticherie, Elizabeth cercò di ritrovare il filo del discorso del presidente. «Alcuni sono scontenti che i neri non godano del diritto di voto» disse Lincoln, alludendo alle critiche rivolte alla nuova costituzione dello stato della Louisiana. «Io stesso preferirei concederlo alle menti più elevate o a coloro che hanno servito la nostra causa combattendo». Elizabeth soffocò appena in tempo un’esclamazione di sorpresa. A meno che le orecchie non l’avessero tradita, il presidente aveva appena detto al mondo che approvava la concessione del diritto di voto ai soldati neri dell’Unione e ad altri uomini di colore. «Parla sul serio?» chiese Emma in un sussurro. «Ai nostri uomini sarà permesso votare?» «Penso di sì» rispose l’amica bisbigliando, mentre un brivido di emozione le faceva tremare la voce. Forse quello era solo l’inizio. Forse anche le suffragette sarebbero riuscite nel loro intento. Elizabeth riusciva a immaginare gli ostacoli che cadevano uno dopo l’altro come i libri da uno scaffale troppo carico: dapprima avrebbero ottenuto il diritto di voto i soldati neri, poi gli altri uomini di spicco, quindi tutti i neri, successivamente le donne bianche e infine le donne di colore come lei, Emma e Virginia. Poteva accadere. Qualcuno diceva che la schiavitù non sarebbe mai scomparsa, invece era stata abolita. La gente buona con convinzioni forti poteva cancellare ogni ingiustizia se non si dava per vinta. Pur sentendosi rincuorata, Elizabeth non riusciva a dimenticare che la marcia verso la giustizia era sempre stata lunga e ardua, e che i cambiamenti cui anelava avrebbero potuto prodursi solo dopo la sua morte. Aveva già assistito a tanti eventi notevoli da quando era giunta a Washington. Perché il suffragio universale non poteva essere il prossimo? Quando tornò alla Casa Bianca il sabato successivo Elizabeth aveva ancora la mente piena delle splendide immagini di quella serata; eppure, dopo avere ringraziato Mrs Lincoln per avere permesso a lei e a Emma di essere presenti, qualcosa le suggerì di parlare alla first lady dell’apprensione improvvisa che l’aveva attanagliata quando il presidente si era presentato, illuminato e vulnerabile, davanti alla folla. «Sì, sì, la vita di mio marito è sempre in pericolo» convenne sua moglie con un sospiro. «Ah, nessuno sa cosa significhi vivere con la paura costante che accada una tragedia. Il presidente è stato minacciato tanto spesso che tremo per lui a ogni occasione pubblica. Ho il presentimento che avrà una morte improvvisa e violenta». «Immagino sia naturale che vi preoccupiate» ribatté Elizabeth, ripensando alle lettere terribili che il presidente riceveva quasi ogni giorno. Anche a sua moglie ne arrivavano, ma non quante al marito. La first lady scosse il capo. «Ho detto presentimento. Non parlo di preoccupazioni o paure normali che chiunque proverebbe al mio posto, e che assalirebbero qualsiasi donna con un marito che si è fatto dei nemici. È una sensazione ben più forte». Mrs Lincoln sembrava così certa, così abbattuta, che Elizabeth rimpianse di averla incoraggiata quando aveva consultato gli spiritualisti dopo la morte di Willie. Sicuramente uno di loro le aveva inculcato quelle idee così pessimiste quando era in preda al dolore. Rimase in silenzio troppo a lungo, perché Mrs Lincoln si accigliò e disse: «Conosco quell’espressione. Pensate che sia una stupida ma siete troppo educata per dirlo. Ebbene, e se vi dicessi che mio marito condivide la mia opinione?» «Io... non saprei cosa pensare» rispose Elizabeth sorpresa. «Lui stesso ha avuto diverse premonizioni». Mrs Lincoln strinse le labbra e respirò profondamente, mentre una ruga le si formò tra le sopracciglia. «La prima fu pochi giorni dopo l’elezione del 1860, quando eravamo ancora a Springfield. Cominciava ad avvertire il peso delle nuove responsabilità, e faceva fatica a dormire. Era nel suo ufficio, sdraiato su una chaise longue, quando gli cadde lo sguardo sullo specchio e vide la sua immagine riflessa in due volti, uno molto più pallido dell’altro. Rimase profondamente sconvolto da quell’episodio, e non mi stupisce. Secondo me la visione significava che sarebbe stato eletto due volte ma non sarebbe vissuto fino alla fine del secondo mandato». Scossa, Elizabeth cercò di mostrarsi scettica e chiese: «Siete sicura che il presidente credesse a una visione e non invece a uno scherzo della luce sullo specchio e agli occhi stanchi?» «Se non l’ha detto esplicitamente, è apparso chiaro dal suo comportamento. Ma vi sono stati anche altri episodi. Fa sempre uno strano sogno prima di eventi importanti. Si descrive a bordo di una nave – non riesce a fornire i dettagli, ma sa che è sempre la stessa imbarcazione – che si muove velocemente verso una riva buia e dai contorni imprecisi. Ha fatto questo sogno prima di Antietam, Murfreesboro, Gettysburg e Vicksburg». «Santo cielo». La sarta rabbrividì come se le parole di Mrs Lincoln le avessero gelato il sangue. «Ma se questo sogno è profetico, sembra annunciare una vittoria, non la morte». «Immagino di sì». Gli occhi di Mrs Lincoln si riempirono di lacrime. «Ma non vi ho ancora detto del sogno peggiore. Vorrei che non me l’avesse mai raccontato». «Su, coraggio, Mrs Lincoln». Elizabeth, allarmata, la prese per il gomito e la accompagnò fino al divano per farla sedere. «Forse ne abbiamo parlato troppo a lungo». «No, no. Ho iniziato e ora devo dirvi il resto». La first lady estrasse un fazzoletto, si asciugò gli occhi e tormentò il tessuto bianco attorcigliandoselo in grembo. «Solo pochi giorni fa io e il presidente stavamo parlando con la sua guardia, Mr Lamon, e qualcun altro quando la conversazione si è orientata sulla quantità di sogni presenti nella Bibbia. “Se crediamo nella Bibbia” ha detto mio marito, “dobbiamo accettare il fatto che nei tempi antichi Dio e i Suoi angeli si mostravano agli uomini nel sonno e si manifestavano nei sogni”. Quando gli ho chiesto il motivo di quel commento, ha cominciato col precisare che non credeva ai sogni, e poi mi ha descritto un sogno fatto qualche notte prima e che da allora non cessava di tormentarlo». «Che sogno era?» chiese Elizabeth preoccupata, anche se avrebbe preferito non saperlo. «Ha raccontato che dieci giorni prima si era ritirato nella sua stanza molto tardi perché era rimasto sveglio in attesa di comunicazioni importanti dal fronte. Si era coricato da poco quando era crollato dal sonno e aveva cominciato a sognare. Ha detto che si sentiva avviluppato in un’immobilità di morte, e che udiva singhiozzi sommessi, di tante persone che piangevano. Nel sogno si è alzato dal letto ed è sceso al piano inferiore, dove il silenzio era rotto dagli stessi singhiozzi straziati, ma le persone afflitte erano invisibili. Passando in rassegna una stanza dopo l’altra non vedeva nessuno, ma i lamenti funebri lo seguivano ovunque. Le stanze erano illuminate, e ogni oggetto gli era familiare, ma dov’erano tutte quelle persone che piangevano come se avessero il cuore spezzato? Si sentiva perplesso e allarmato, e si è chiesto quale potesse essere il significato di tutto ciò. Deciso a trovare la spiegazione per quelle circostanze tanto misteriose che lo turbavano, ha continuato a camminare finché non è giunto nell’East Room, dove si è imbattuto in una sorpresa sconvolgente. Davanti a lui c’era un catafalco sul quale era posato un cadavere in abito funebre. I soldati stavano di guardia tutt’attorno e una moltitudine di persone fissava tristemente il morto, con il viso coperto, mentre qualcuno piangeva. “Chi è morto alla Casa Bianca?” ha voluto sapere mio marito rivolgendosi a uno dei soldati. “Il presidente” è stata la risposta. “È stato ucciso da un sicario”. Proprio allora un lamento straziante si è sollevato dai presenti e l’ha svegliato». «Che orrore!» esclamò Elizabeth. Non c’era da stupirsi che il presidente avesse l’aria così provata ed esangue, se visioni tanto macabre lo tormentavano nottetempo. «Mrs Lincoln, non dovete temere che questo incubo si realizzi». La first lady la guardò scettica. «Voi stessa avete detto che sarebbe stato facile per un assassino ucciderlo alla finestra, ieri sera». Quanto rimpiangeva quelle parole! «Ciò che intendo dire è che si tratta di brutti sogni e niente più. Non sono eventi futuri. Sarebbe assurdo che il presidente non avesse incubi, dopo tutte le minacce ricevute; anzi, è prova della sua forza d’animo il fatto che non ne abbia anche di più». Mrs Lincoln sembrava desiderosa di crederle. «Ho ordinato di aumentare il numero delle guardie, ma non so cos’altro...» Si interruppe di colpo quando la porta si aprì ed entrò il presidente. La first lady si ricompose, ma qualcosa nell’espressione di Abraham Lincoln rivelò a Elizabeth che aveva intuito il suo stato d’animo in quel breve istante, prima che lei cercasse di nasconderlo. Le salutò, scrutandole incuriosito per un istante, poi si avvicinò alla finestra e guardò fuori sorridendo. «Madame Elizabeth» esordì voltandosi. «Vi piacciono gli animali?» «Oh, sì, signore» rispose. «Allora venite qui a vedere le mie capre». La sarta incrociò lo sguardo di Mrs Lincoln, che le fece un cenno discreto con la testa e le indicò di obbedire. Quando fu al fianco del presidente, questi le mostrò le capre che scorrazzavano nel prato sotto di loro. «Secondo me sono le capre più buone e brave del mondo» dichiarò, con gli occhi che gli luccicavano di gioia. «Guardate come annusano l’aria limpida, come saltano e giocano al sole. Oh! Avete visto che salto?» esclamò quando uno degli animali fece un balzo sopra dei sassi. «Madame Elizabeth, avete mai visto una capra tanto esuberante?» Lei sorrise. «Non che ricordi, signore». «Guardatela, si aggira nel suo territorio non lasciandosi sfuggire nulla: ha la determinazione di un bounty jumper2» osservò. «Anzi, non rendo giustizia alla capra paragonandola a quegli individui. Preferirei portare le corna e quella pelliccia che abbassarmi al livello di chi saccheggia il Tesoro in nome del patriottismo». Un’ombra gli oscurò il viso. «L’uomo che si arruola per ottenere un compenso e diserta nel momento in cui viene pagato per ricominciare tutto da capo è già abbastanza reprensibile, ma gli uomini che manipolano tutto il meccanismo e che sono dietro ai bounty jumpers, mettendo in piedi una frode colossale, sono anche peggiori. Sono peggio dei vermi che si annidano negli angoli più bui della terra». Prima che Elizabeth potesse replicare che la coscrizione era terminata, e che i bounty jumpers non avrebbero più potuto approfittarne come prima, entrambe le capre alzarono lo sguardo verso la finestra e scossero il capo quasi in un saluto amichevole. «Vedete, madame Elizabeth?» riprese il presidente rasserenandosi. «I miei animali mi riconoscono. Guardate che aria seria. Eccole che ricominciano: come si divertono!» Rise ad alta voce quando gli animali ripresero a saltare, dirigendosi all’altro capo del prato. «Venite, Lizzie» la chiamò imperiosamente Mrs Lincoln. «Se voglio essere pronta per stasera devo finire di vestirmi, e voi dovete smettere di guardare quelle stupide capre». La sarta scambiò uno sguardo d’intesa con il presidente prima di affrettarsi a tornare dalla first lady, che non amava molto gli animali, né capiva la passione del marito per le capre. Elizabeth non gliel’avrebbe mai detto, ma pensava che Mrs Lincoln avrebbe dovuto essere riconoscente per le poche cose che distraevano il presidente dalle sue preoccupazioni. Le capre, i suoi scrittori preferiti, le conversazioni con amici intelligenti, una serata a teatro di tanto in tanto erano occasioni rare che gli accordavano una pausa dalle pressioni continue legate alle sue funzioni. Elizabeth finì di vestirla rapidamente, senza curarsi della sua smorfia indispettita. Le sarebbe passata presto, e la sarta preferiva vederla irritabile piuttosto che ansiosa o concentrata su cupi presagi, nati da una mente in preda a tensione, tristezza e sfinimento. Qualche giorno dopo, la mattina del Venerdì Santo, Elizabeth si recò di buon’ora alla Casa Bianca con il corpetto, la gonna e le maniche di un nuovo abito estivo per Mrs Lincoln, una mussola francese ricamata con maniche ad aletta e un delicato bordo di pizzo attorno alla scollatura. La first lady era già impaziente di trasferirsi a Soldiers’ Home per l’estate, dove sperava che il marito si riposasse e ritrovasse la salute e il vigore. La guerra l’aveva messo a dura prova, e la ricostruzione non sarebbe stata da meno, ma il generale Sherman avanzava nel North Carolina e sembrava che il conflitto sarebbe finito presto. Il peggio era ormai dietro di loro. La sarta imboccò Fifteenth Street mentre un drappello di soldati di colore transitava scortando colonne di truppe ribelli catturate. I passanti non li insultavano ma si limitavano a lanciare loro occhiate di compatimento, o fingevano di non notarli per non aumentarne le sofferenze. Avrebbero potuto coprirli di ingiurie – o anche gettare loro dei mattoni, se avessero avuto un profondo desiderio di vendetta –, ma gli abitanti di Washington sembravano pensarla quasi tutti come Elizabeth: quegli sventurati prigionieri volevano solo tornare a casa, proprio come i padri di famiglia, i figli, i fratelli e i fidanzati nordisti desideravano più di ogni cosa tornare dalle loro famiglie. Con la guerra ormai prossima alla conclusione, e il suo esito ormai certo, tutti volevano semplicemente che finisse senza ulteriori spargimenti di sangue. Quello dei soldati di colore che facevano la guardia a prigionieri confederati bianchi non era più uno spettacolo strano, ma Elizabeth si fermò ugualmente a guardare il passaggio delle colonne di uomini con una traccia di stupore. Com’era cambiata la città negli ultimi quattro anni, e perfino nell’ultima settimana... I festeggiamenti esaltati dei primi giorni dopo la resa del generale Lee si erano trasformati in un atteggiamento più pacato di speranza, gratitudine e pace, nonostante le preoccupazioni onnipresenti su ciò che sarebbe successo poi. Nei cuori di tutti, a eccezione dei più vendicativi e radicali, il recente discorso di Lincoln aveva instillato un senso di perdono e clemenza. Elizabeth ripensò alle vecchie amiche che aveva rivisto a Petersburg la settimana precedente, e a tutte le persone che aveva conosciuto in Virginia, in Missouri e perfino in North Carolina, dove aveva subito tormenti di ogni tipo, e sperava che il progetto del presidente per la ricostruzione fosse clemente con loro. Alla Casa Bianca fu felice di trovare Mrs Lincoln di buonumore. Il capitano Robert Lincoln e il generale Grant erano arrivati quel mattino dalla Virginia, e durante la colazione Robert aveva fatto ai genitori il resoconto di prima mano della resa di Lee ad Appomattox. «Un’occasione storica» osservò la first lady mentre Elizabeth la aiutava a indossare gonna e corpetto. «Ed è appropriato che il figlio del presidente fosse lì ad assistervi». Mrs Lincoln era particolarmente contenta non solo perché Robert era a casa e al sicuro, e perché la notte prima il presidente aveva di nuovo sognato della nave che lo portava verso una riva lontana, un sogno che presagiva, secondo lui, l’imminente vittoria del generale Sherman contro Johnston in North Carolina. «Mio marito mi ha mandato un biglietto stamattina» confidò, «invitandomi a fare una gita questo pomeriggio». Elizabeth dovette sorridere. «Vi ha mandato un biglietto? Non sarebbe stato più rapido chiedervelo a voce, visto che avete fatto colazione insieme?» «Più rapido ma non altrettanto romantico» replicò Mrs Lincoln. «Mi fa tornare in mente i giorni in cui mi corteggiava a Springfield. Ne abbiamo passate tante da allora che è spesso difficile ricordare com’eravamo da giovani innamorati». La sarta sorridendo le sistemò la scollatura dell’abito, infilando due spilli uno dopo l’altro. «Forse una bella giornata insieme vi aiuterà a ricordare». «Abbiamo entrambi bisogno di una giornata piacevole e riposante per altre ragioni, ma temo che non sarà tale per mio marito». «Perché no? Non può godersi un giorno di vacanza il Venerdì Santo?» «Se poteste persuaderlo a farlo, avreste la mia gratitudine eterna. Dalla colazione in poi ha avuto colloqui continui con legislatori e altre persone con richieste varie, e dopo dovrà riunirsi con i suoi ministri. Penso che non lo vedrò fino a questo pomeriggio, e a quel punto dovrò insistere perché faccia un pranzo vero e proprio prima della nostra gita di questo pomeriggio invece di una mela alla scrivania. È sempre più magro e grigio e la gente incolpa me, dicendo che non gli do abbastanza da mangiare». «Dovrebbero incolpare il cuoco della Casa Bianca, non voi» osservò Elizabeth. «Ma anche quello sarebbe ingiusto». Mrs Lincoln si dichiarò completamente d’accordo, ma la sua delusione per il fatto che non avrebbe potuto vedere il marito fino al pomeriggio svanì, perché il presidente entrò nella stanza proprio in quel momento. «Sono stato al ministero della Guerra» annunciò alla moglie dopo averle salutate entrambe. «Ho visto il generale Eckert, gli ho parlato del nostro programma di andare a teatro stasera, e l’ho invitato a venire con noi». Mrs Lincoln sollevò le sopracciglia. «Davvero? Ebbene, immagino che ci sia abbastanza posto nel palco per lui, noi e anche per il generale Grant e signora». Lincoln si lasciò cadere sul divano. «C’è posto, mamma, ma non ce ne sarà bisogno perché il generale Eckert non potrà essere dei nostri». La risata della moglie recava una traccia di esasperazione divertita. «E allora perché parlarne?» «Pensavo desideraste che vi raccontassi ogni dettaglio della mia giornata». Sembrava che il presidente volesse continuare a canzonare la moglie, ma proprio in quel momento entrò Robert con un piccolo ritratto. «Eccolo, padre» annunciò Robert, allungandogli l’oggetto. «Il generale Robert E. Lee, come promesso». «Grazie, figliolo». Il presidente Lincoln posò il ritratto sul tavolo davanti a sé e studiò pensoso il viso del generale. «È un bel volto; appartiene a un uomo nobile, coraggioso». «Mi pare che sia abbastanza somigliante» dichiarò Robert, palesemente soddisfatto di sé. Il presidente annuì compiaciuto e lo guardò da sotto le sopracciglia sollevate. «Ebbene, figlio mio, sei tornato sano e salvo dal fronte. Ora la guerra è finita, e presto vivremo in pace con gli uomini bravi e valorosi che hanno combattuto contro di noi. Sono sicuro che l’epoca dei buoni sentimenti è tornata con la fine della guerra, e che da questo momento vivremo in pace». «Amen» mormorò Elizabeth, a voce tanto bassa che neppure Mrs Lincoln la udì. «Ora ascoltami, Robert» continuò il presidente. «Devi mettere da parte l’uniforme e tornare all’università. Vorrei che studiassi legge per tre anni, e alla fine di quel periodo spero che saremo in grado di capire se hai la stoffa per diventare avvocato oppure no». «Sissignore» rispose solennemente Robert, e suo padre si alzò e gli strinse la mano, più allegro di quanto Elizabeth non l’avesse visto da parecchio tempo. La sarta era contenta di vedere la famiglia godersi un momento di armonia domestica dopo tante preoccupazioni e difficoltà. Fu un momento breve, perché Abraham Lincoln dovette recarsi subito alla riunione con il suo governo, e anche Robert se ne andò, forse per raggiungere il generale Grant. Di nuovo sole, Elizabeth e Mrs Lincoln ripresero le prove dell’abito, e non avevano ancora finito quando arrivò una domestica con un messaggio dal generale Grant e signora, spiegando che avevano deciso di far visita ai loro figli nel New Jersey e non avrebbero potuto andare a teatro con i Lincoln. «Peccato che abbiano annullato all’ultimo momento» dichiarò Mrs Lincoln, gettando la lettera sul tavolo. «Di recente sembra che Mrs Grant colga ogni occasione possibile per evitare di trascorrere del tempo in mia compagnia». Elizabeth non poteva certo biasimare la moglie del generale, visto come l’aveva trattata Mrs Lincoln in carrozza a City Point. «Non potreste invece invitare un’altra coppia?» «Sarebbe uno spreco di carta e inchiostro. Chi sarebbe disponibile così all’ultimo momento?» «Chi non rinuncerebbe volentieri a un altro programma pur di condividere il palco presidenziale con i coniugi Lincoln?» «Il generale Grant e sua moglie, a quanto pare» replicò Mrs Lincoln, ma mentre Elizabeth continuava ad adattarle e puntarle l’abito con gli spilli, ci ripensò. «Immagino che potremmo trovare altri ospiti, e in caso contrario non mi dispiacerebbe tenermi mio marito tutto per me, per cambiare». «Per voi e per qualche altro centinaio di spettatori» le ricordò Elizabeth, e fu contenta di vedere la sua cliente sorridere. In seguito, mentre riponeva le sue cose, la sarta chiese: «Volete che torni più tardi per vestirvi per il teatro?» «Ecco...» Mrs Lincoln esitò. «Penso di no. Non sono sicura che andremo, dopotutto. Sento che mi sta venendo mal di testa, e Mr Lincoln è esausto per i problemi incessanti. Immagino che dovremmo decidere dopo la nostra gita, ma non voglio tenervi impegnata inutilmente». «Se decidete che avete bisogno di me» le ricordò Elizabeth, «sapete che potete sempre mandarmi a chiamare». La moglie del presidente sorrise con gratitudine. «Sì, Elizabeth. Lo so». Elizabeth si svegliò bruscamente nel cuore della notte sentendo bussare forte alla porta della sua stanza. «Mrs Keckley!» la chiamava qualcuno. «Mrs Keckley, si svegli!» Disorientata, la sarta si rizzò a sedere, afferrò alla cieca la vestaglia e la indossò. I colpi e le voci continuarono mentre si alzava e si sbrigava ad andare ad aprire. «Miss Brown?» chiese confusa, scoprendo la sua vicina in corridoio. «Cos’è successo? C’è un incendio?» «No, no, non un incendio, ma notizie terribili, terribili!» Miss Brown si torceva le mani e aveva le guance rigate di lacrime. «Hanno sparato al presidente Lincoln, e tutti i suoi ministri sono stati assassinati!» A Elizabeth venne un colpo al cuore. «Assassinati?» Le immagini degli uomini che aveva visto nel corso degli anni alla Casa Bianca – ridere, accigliarsi, sussurrare con enfasi in un angolo, lavorare con estrema meticolosità con Abraham Lincoln, ridere dei suoi racconti – le attraversarono la mente. Le parve che il sangue le si gelasse nelle vene, e che i polmoni, privati d’aria, si accartocciassero. «Mio Dio, tutti morti? E il presidente Lincoln? È ferito in modo grave?» Miss Brown scosse il capo. «No, grazie al cielo. Non ha ricevuto ferite mortali». «Dio sia lodato. E Mrs Lincoln?» «Illesa. O, almeno, che io sappia». Con il cuore che martellava, Elizabeth ringraziò la vicina e tornò subito in camera a vestirsi. Erano le undici passate ma ormai non aveva più sonno, e non riusciva a sopportare di aspettare pazientemente in attesa di notizie. La stanza la soffocava. Si precipitò fuori, dove le strade erano piene di gente perplessa e spaventata. Le voci si diffondevano velocemente: alcune confermavano il racconto di Miss Brown, altre lo contraddicevano e altre ancora annunciavano notizie sempre più terribili. La sarta si sentì ancora più frustrata e spaventata, finché la preoccupazione non la indusse a tornare dentro, dove svegliò Walker e Virginia e riferì loro che qualcuno aveva sparato al presidente. «Devo andare alla Casa Bianca» dichiarò con la voce rotta. «Non posso restare in questo stato d’incertezza». «Mia cara Elizabeth» esordì Virginia, con il viso sconvolto sotto la cuffia da notte di mussola. «Devi calmarti. Il presidente si starà riprendendo, altrimenti si sarebbero messe a suonare le campane di tutta la città». «Virginia ha ragione» disse Walker, ma anche lui sembrava in ansia. «È stato un brutto colpo. Torna a dormire. Andrai a far visita a Mrs Lincoln domattina presto». «No, no». Elizabeth scosse il capo, con il cuore che le si agitava in petto come un uccellino intrappolato. «Devo andare subito da lei. Anche se il presidente è stato ferito solo leggermente, Mrs Lincoln sarà molto in apprensione e avrà bisogno di me». I Lewis si scambiarono un’occhiata silenziosa, e Walker concesse che Elizabeth dovesse andare, ma non da sola. La sarta camminò avanti e indietro nell’ingresso mentre la coppia si vestiva e raccomandava a Jane di occuparsi delle sorelle più piccole. Le parve di aver aspettato un’eternità, quando finalmente Virginia e Walker la raggiunsero e uscirono tutti e tre. Attraversarono veloci la calca in attesa, la moltitudine di gente confusa e allarmata che si rivolgeva domande a vicenda, ripeteva dicerie e di tanto in tanto scoppiava in singhiozzi disperati. In Lafayette Square oltrepassarono la residenza del ministro Seward e furono molto stupiti vedendola circondata da soldati armati, con le baionette sguainate per tenere alla larga gli intrusi. Accelerando il passo per via del panico che li attanagliava arrivarono infine alla Casa Bianca, e scoprirono che anch’essa era circondata da militari. Ogni ingresso era custodito da una folta schiera di soldati, che non lasciavano passare nessuno. La donna raddrizzò le spalle, si fece forza e si rivolse a una delle guardie con voce ferma. «Sono Mrs Elizabeth Keckley, la sarta personale e amica della first lady. Se sta male, avrà bisogno di me». Il soldato la ignorò, e continuò a ispezionare la folla raccolta davanti alla Casa Bianca stringendo il fucile. La sarta sentì Virginia che le dava un colpetto di gomito, quindi fece un altro respiro e ci riprovò: «Chiedete al portiere chi sono. Vengo alla Casa Bianca diverse volte alla settimana. Lui mi conosce». Il soldato la ignorò di nuovo, ma un altro che si trovava a pochi passi ebbe pietà di lei. «Mi dispiace, signora, ma nessuno ha il permesso di entrare stasera». Elizabeth, in preda alla disperazione, attaccò subito discorso. «Potete chiedere al portiere di dire a Mrs Lincoln che sono qui? So che vi dirà di lasciarmi entrare». La guardia, un ragazzo con i capelli rossi e le lentiggini, poco più vecchio di quanto lo sarebbe stato George, scosse il capo. «Non è qui, e neanche il presidente è stato portato a casa». La prima guardia fece un sibilo e fulminò con gli occhi il soldato con i capelli rossi, che distolse subito lo sguardo da Elizabeth e si mise sull’attenti. Si rifiutarono entrambi di fornire altre informazioni, così il terzetto, con riluttanza e un senso crescente di panico, se ne andò dalla Casa Bianca. Mentre tornavano verso la loro abitazione tra la folla, la sarta si sentiva venir meno per l’ansia e il dolore. Dopo qualche isolato vide passare un uomo anziano con i capelli grigi, e qualcosa nella sua espressione gentile e affranta la spinse a toccargli il braccio e a chiedergli con voce implorante: «Signore, mi sapete dire se il presidente Lincoln è morto?» «Non è morto» rispose quello, «ma sta morendo. Che Dio ci aiuti!» E si avviò con passo pesante e abbattuto. «Non è morto, ma sta morendo» ripeté Virginia con voce tremante. «Allora abbiamo proprio bisogno che Dio ci aiuti!» Alla fine, lungo il tragitto che li portava in Twelfth Street, raccolsero racconti frammentari che permisero loro di ricostruire l’accaduto. Il presidente era mortalmente ferito, e si trovava secondo qualcuno in una casa di fronte al Ford’s Theatre, ma nessuno lo sapeva per certo. Il popolare attore John Wilkes Booth si era introdotto nel palco privato del presidente mentre questi guardava la rappresentazione con Mrs Lincoln e i loro ospiti e gli aveva sparato alla nuca. Si temeva che il presidente non sarebbe sopravvissuto fino al mattino successivo. Elizabeth, Virginia e Walker, distrutti dalla notizia, tornarono a casa. La sarta non riuscì a dormire. Immaginava Mrs Lincoln pazza di dolore, e voleva andare da lei, ma non sapeva dove trovarla, e non ebbe altra scelta che aspettare fino all’indomani. Le ore notturne non le erano mai parse tanto lunghe. Ogni minuto sembrava un’eternità, ed Elizabeth non poteva fare nulla se non camminare avanti e indietro, aspettare e scrutare dalla finestra il cielo verso est in attesa dell’alba, stringendosi le braccia al petto come per combattere un vento gelido. Infine arrivò il mattino, grigio e buio. Alle sette e mezzo la campana di una chiesa lontana cominciò a suonare, seguita da un’altra e un’altra ancora, finché tutte le campane di Washington riecheggiarono dei rintocchi della terribile notizia. Il presidente era morto, si disse Elizabeth senza riuscire a capacitarsene; le sfuggì un singhiozzo e si gettò sul letto, disperata, in lacrime. Si coprì le orecchie con i pugni stretti, ma nulla riusciva a bloccare quel suono lugubre. Restò coricata, esausta e svuotata, fino alle undici, quando una carrozza si fermò davanti alla pensione e un messaggero bussò alla sua porta. «Vengo da parte di Mrs Lincoln» esordì. «Se siete Mrs Keckley, venite subito con me alla Casa Bianca». Elizabeth infilò immediatamente la cuffia e si strinse nello scialle, e dopo qualche istante era seduta nella carrozza che partì a tutta velocità per la Casa Bianca sotto una pioggia fredda e deprimente. A quell’ora di solito si spegnevano le lampade a gas, ma quella mattina le avevano lasciate accese. Le strade erano calme in modo innaturale per un sabato mattina. Le bandiere pendevano tristi a mezz’asta, e qua e là case e botteghe recavano drappeggi di crespo nero. Una sentinella solitaria marciava avanti e indietro davanti a una casa, e lo stesso avveniva davanti a un’altra residenza più distante; dopo un attimo di perplessità, la sarta capì che si trattava delle dimore dei membri del governo. Miss Brown si era sbagliata quando aveva detto a Elizabeth che erano stati uccisi tutti, ma quasi nello stesso momento in cui il presidente Lincoln veniva assassinato il ministro Seward era stato attaccato a casa propria, nel suo letto, dove giaceva, convalescente, dopo un incidente con la carrozza. Se non fosse stato per l’armatura che portava al collo per guarire dalle lesioni subite, probabilmente sarebbe stato accoltellato a morte. Invece era rimasto solo ferito, anche se il peggio non era ancora scongiurato, e nessuno poteva sapere quali attentati contro gli altri ministri fossero stati sventati, abbandonati o soltanto rimandati. La carrozza giunse rapidamente alla Casa Bianca, dove c’erano centinaia di neri, quasi tutti donne e bambini, che piangevano la terribile perdita. A differenza della sera precedente superò con facilità l’ingresso e le guardie, ma oltre la soglia, dentro la casa silenziosa e buia, ebbe l’impressione che le calasse sulle spalle una pesante coltre di angoscia. Facendosi forza si tolse la cuffia e corse di sopra, ma Mrs Lincoln non era in camera sua né in salotto. Poco dopo una domestica con gli occhi cerchiati di rosso la guidò a una stanzetta da letto che era stata preparata per il presidente per l’estate, quando la famiglia trascorreva quasi tutto il tempo a Soldiers’ Home e lui si tratteneva solo occasionalmente a dormire alla residenza presidenziale. «La first lady ha rifiutato di entrare nelle camere da letto abitualmente usate dalla famiglia» le confidò la serva. Elizabeth pensò al fatto che la sua cliente evitava ancora di mettere piede nella stanza dove era stata allestita la camera ardente di suo figlio Willie, e capì che non era assolutamente in grado di trascorrere del tempo nei locali che aveva condiviso col marito. Esitò con le dita sulla maniglia, facendo respiri profondi per allontanare il dolore che rischiava di sommergerla. Quando fu riuscita a dominarsi entrò nella stanza e si ritrovò immersa nell’oscurità. Gli occhi si abituarono al buio e lei vide la sagoma indistinta di una donna che si agitava sul letto, e un’altra seduta su una sedia accanto alla finestra, dove le tende erano state chiuse, lasciando filtrare solo un sottile raggio di sole. Dopo un attimo riconobbe Mrs Mary Jane Welles, la moglie del ministro della Marina e sua cliente. Le fece un cenno di saluto, poi corse al capezzale di Mrs Lincoln e mormorò il suo nome. «Elizabeth?» La voce della first lady era appena udibile. «Siete arrivata, finalmente?» La sarta le prese la mano. «Sì, Mrs Lincoln. Sono qui». La vedova si girò lentamente e lo sguardo addolorato, gli occhi rossi e gonfi, le guance pallide, l’espressione sconvolta, distrutta. «Perché non siete venuta ieri sera, Elizabeth? Vi ho mandato a chiamare». Elizabeth sbatté le palpebre per cacciare via le lacrime. «Ci ho provato, ma...» Lottò per mantenere la voce ferma mentre posava la mano sulla fronte dell’amica, che pareva febbricitante. «Non sono riuscita a trovarvi». «Ho mandato tre messaggeri». «Mi dispiace». Elizabeth si sedette sulla sponda del letto, stringendo la mano dell’amica tra le sue. «Sono venuta. Sono venuta qui, ma non c’eravate». «Non ci hanno portato qui». Parlava con voce distante, incredula. «Hanno trasportato mio marito di fronte al teatro, nella pensione di Mr Peterson. Era troppo alto per il letto, e hanno dovuto coricarlo di traverso». Fu interrotta da un singhiozzo e prese a gemere. «Basta, ora» le disse Elizabeth carezzandole la fronte. «Ssh». Mentre si occupava di lei, Mrs Welles, che aveva l’aria di stare male e si era alzata dal letto dove giaceva, malata, quando Mrs Lincoln l’aveva mandata a chiamare, si congedò discretamente e tornò a casa, affidando la vedova alla sarta. Mary Lincoln era consumata dal dolore, ma l’amica riuscì a calmarla. Dopo che si fu tranquillizzata, le chiese se poteva andare a rendere omaggio alla salma. Quando lei annuì, Elizabeth liberò la mano e lasciò la stanza buia per dirigersi nella camera degli ospiti, dove era stata allestita la camera ardente. Varcando la soglia, con il cuore che martellava e le gambe che tremavano, ripensò improvvisamente al piccolo Willie Lincoln che riposava nella bara proprio dove ora giaceva il corpo del padre. Rivide il presidente che piangeva dinanzi al visetto pallido e adorato del figlio, e pensò alle parole gentili che Abraham Lincoln le aveva rivolto l’ultima volta che l’aveva visto vivo, e a come avesse descritto con generosità e rispetto lo sconfitto generale Lee. Il Mosè del suo popolo era caduto nell’ora del trionfo. La sua morte tragica era ancora più insopportabile perché non era vissuto abbastanza a lungo da godersi la pace che aveva ottenuto con tante battaglie. Diversi membri del governo, alcuni ufficiali dell’esercito e altri dignitari erano raggruppati attorno al corpo del loro capo deceduto; alcuni piangevano senza nascondersi, ma al suo arrivo la lasciarono passare. Lei tolse con un gesto rispettoso il lenzuolo bianco dal viso pallido dell’uomo che aveva tanto ammirato; anzi, non solo ammirato, ma addirittura idolatrato. Il cuore, che le batteva veloce, le si calmò guardando il suo volto; nonostante la violenza che aveva subito scoprì qualcosa di bello, di solenne nella sua espressione: la dolcezza e innocenza dell’infanzia, la maestosa dignità di un intelletto ispirato. Lo osservò a lungo finché non fu costretta a voltargli le spalle con le lacrime agli occhi e la gola stretta dal dolore. Lottando per dominarsi tornò nella stanza di Mrs Lincoln e la trovò di nuovo in uno stato di agitazione estrema, tra pianti, gemiti e convulsioni. Robert era chino su di lei e le mormorava qualche parola, con espressione addolorata e vulnerabile, mentre il piccolo Tad si era rannicchiato ai piedi del letto con il viso stravolto dalla sofferenza. Elizabeth andò subito da lei e le bagnò la fronte di acqua fredda, cercando di placare meglio che poteva la violenta tempesta. Il dolore di Tad non era certo minore di quello della madre, ma gli scoppi di pianto di quest’ultima l’avevano spaventato e ridotto al silenzio. A un tratto le gettò le braccia al collo. «Non piangere, mamma!» la implorò con voce soffocata, premendole il viso sul collo. «Non piangere, o farai piangere anche me! Mi spezzerai il cuore». Mrs Lincoln non poteva sopportare di sentir piangere il figlio più giovane, e con un grande sforzo se lo strinse al cuore e s’impose di calmarsi, ma non riuscì a trattenersi a lungo, e poco dopo esplose in un nuovo pianto, straziante e spaventoso per i presenti. Nei giorni che seguirono l’assassinio del presidente, ogni stanza della Casa Bianca rimase al buio, ogni parola fu pronunciata sottovoce, ogni passo lento e greve. La vedova si rinchiuse nella stanzetta degli ospiti con le tende tirate, a volte in silenzio, altre volte a piangere o a gridare. Non sopportava di vedere il corpo del marito, ma la costruzione di un’alta piattaforma nell’East Room per esporre la bara del presidente disturbò il suo isolamento. «Quando finiranno?» chiese a denti stretti, seduta a letto, dondolando avanti e indietro in preda allo strazio. «Ogni chiodo che conficcano mi sembra un colpo di pistola». Il 17 aprile la bara del presidente fu trasferita sul catafalco ultimato sotto un tendone nero, con specchi e candelieri coperti da crespo nero; le sedie per i visitatori, poste su una piattaforma rialzata, erano state ricoperte di tessuto nero. Regnava un silenzio greve, e un picchetto d’onore composto di due generali e altri dieci ufficiali faceva la guardia giorno e notte. Il giorno successivo quasi venticinquemila persone passarono nell’East Room per rendergli omaggio, e il 19 aprile gli invitati tornarono per il funerale. Mrs Lincoln e Tad non furono in grado di partecipare; Robert presenziò, unico membro della famiglia. Elizabeth avrebbe voluto vedere il presidente un’ultima volta prima dell’inumazione, ma Mrs Lincoln aveva troppo bisogno di lei, così le rimase al fianco. Dopo il funerale una processione accompagnò le spoglie del presidente fino al Campidoglio, dove furono esposte nella rotonda e migliaia di persone poterono sfilare e rendervi omaggio. Venerdì 21 aprile, quasi una settimana dopo la sua morte, un treno funebre di nove carrozze decorato di banderuole, crespo nero e un ritratto di Abraham Lincoln sul cacciapietre della locomotiva partì da Washington per un viaggio di duemilasettecento chilometri verso ovest, diretto a Springfield, portando a bordo trecento passeggeri e le spoglie del presidente e del figlioletto Willie. Il treno manteneva una velocità di crociera tra gli otto e i trenta chilometri all’ora per rispetto nei confronti di chi si era radunato lungo le rotaie per rendere omaggio al presidente, accendendo dei falò di notte. Il convoglio si fermò come previsto in dodici città, dove migliaia di persone andarono a rivolgere l’estremo saluto al loro capo defunto. Per sei settimane Elizabeth rimase alla Casa Bianca insieme alla vedova distrutta dal dolore, dormendo su una chaise longue in camera sua, e cercò di consolarla e confortarla come meglio poteva durante quelle giornate interminabili e tremende, senza mai lasciarla sola. Le migliori amiche di Mrs Lincoln a Washington, Mary Jane Welles ed Elizabeth Blair Lee, di tanto in tanto andavano a trovarla, ma lei non voleva vedere nessun altro. Il nuovo presidente, Andrew Johnson, non cercò di farsi ricevere, e non mandò neppure un biglietto di condoglianze. Si diceva che in quella notte terribile avesse cercato di entrare nella residenza dei Peterson per vedere il presidente sul letto di morte, ma che fosse stato invitato ad andarsene perché la sua presenza non turbasse la first lady. Per quanto quel trattamento avesse potuto offenderlo, secondo Elizabeth, l’unico gesto sensato e dignitoso da fare era accantonare l’offesa per rispetto nei confronti della vedova in lutto. All’inizio la sarta attribuì la sua assenza alle responsabilità di capo dello stato che erano ricadute improvvisamente su di lui, ma a mano a mano che il tempo passava e le sue condoglianze non arrivavano, l’incredulità e l’indignazione si fecero strada in lei. Sperava solo che Mrs Lincoln nel suo dolore non si accorgesse di quell’affronto inspiegabile. La sua cliente non parlava spesso di Booth, l’assassino del marito, ma Elizabeth sapeva che si interrogava su chi potessero essere i suoi eventuali complici. Un messaggero nuovo aveva accompagnato i Lincoln a teatro quella sera infausta, ed era stato di guardia davanti alla porta chiusa del palco durante lo spettacolo, impedendo l’ingresso degli intrusi. Si scoprì successivamente che si era messo a guardare lo spettacolo trascurando di custodire l’entrata per andare a seguire la rappresentazione, lasciando così che l’assassino penetrasse indisturbato nel palco del presidente. Mrs Lincoln era convinta che quell’uomo fosse implicato nella congiura per eliminare il marito. Una sera, Elizabeth era stesa sulla chaise longue accanto al letto di Mrs Lincoln quando una domestica entrò nella stanza, e l’ex first lady le chiese chi fosse di guardia quella notte. «Mr Parker, signora» rispose la cameriera. «Il messaggero nuovo». «Cosa?» esclamò. «L’uomo che ci ha accompagnato a teatro la notte in cui il mio adorato marito è stato ucciso? Per me anche lui è implicato. Mandatemelo qui». Dall’espressione diffidente e dagli occhi sgranati di Mr Parker, apparve chiaro che aveva udito le parole di Mrs Lincoln da dietro la porta, che era stata lasciata socchiusa. «E così siete voi di guardia, stanotte» esordì senza preamboli la signora. «Di guardia alla Casa Bianca dopo aver contribuito alla morte di mio marito!» «Perdonatemi, ma non ho fatto nulla per aiutare a uccidere il presidente» protestò Parker tremante. «Non potrei mai ammazzare qualcuno, men che meno un uomo buono e illustre come il presidente». «Sembrerebbe proprio di sì, invece». «No, no! Non dite una cosa del genere!» la implorò. «Dio sa che sono innocente». «Non vi credo. Perché non eravate sulla porta per bloccare l’assassino quando è entrato nel palco?» «Io... io ho sbagliato, lo ammetto» balbettò, «e me ne sono pentito amaramente, ma non ho aiutato l’assassino del presidente. Non credevo che qualcuno avrebbe provato a uccidere un uomo tanto buono in un luogo pubblico, e questa mia convinzione mi ha reso poco prudente. Ero assorbito dallo spettacolo e non ho visto l’assassino entrare nel palco». «Ma avreste dovuto vederlo, invece!» sbottò Mrs Lincoln. «Non dovevate essere imprudente. Per me sarete sempre colpevole. Tacete!» esclamò, quando lui tentò di ribattere. «Non voglio ascoltare un’altra parola. Adesso andate e fate la guardia per davvero, stavolta». Lo congedò con un gesto imperioso della mano. Mr Parker, pallido e impacciato, si voltò e se ne andò. Non appena si fu richiuso la porta alle spalle, Mrs Lincoln si lasciò ricadere sul cuscino, si coprì il volto con le mani e scoppiò in lacrime. Robert Lincoln era tenero e sollecito con la madre tanto prostrata, ma il suo aspetto provato rivelava che anche lui soffriva molto e che le nuove responsabilità di capofamiglia gli pesavano, anche se di fronte alla madre non mancava mai di mostrarsi forte e sicuro. Sopportò le sue crisi di pianto meglio del fratellino, che aveva già perso un genitore e temeva di perdere anche l’altro di crepacuore. Spesso di notte, quando il povero Tad era svegliato dai singhiozzi della madre, si alzava e andava nella sua stanza per infilarsi nel suo letto. «Non piangere, mamma» diceva, abbracciandola forte. «Non riesco a dormire se piangi! Papà era buono ed è andato in cielo. Là è felice. È con Dio e con mio fratello Willie. Non piangere, mamma, altrimenti piango anch’io». E la madre tentava ancora una volta di controllarsi per amor suo. Elizabeth compativa il bambino. Lui e il padre si adoravano, ma sebbene il presidente avesse avuto un debole per lui, soprattutto dopo la morte di Willie, Tad non era viziato. Pur essendo ancora piccolo, sembrava avere capito che era il figlio di un presidente, e che ciò comportava privilegi e responsabilità. Un mattino presto la sarta passò davanti alla sua stanza mentre la bambinaia lo stava vestendo. «Papà è morto» lo sentì dire alla donna. «Non riesco quasi a credere che non lo vedrò mai più. Adesso devo imparare a prendermi cura di me». La sarta, commossa, si avvicinò alla porta per ascoltare. «Sì, papà è morto» proseguì, triste ma in tono pratico. «E adesso sono semplicemente Tad Lincoln, il piccolo Tad, uguale a tutti gli altri. Non sono più il figlio di un presidente. Non avrò più tanti regali». Sospirò da fare compassione. «Cercherò di fare il bravo e spero che un giorno raggiungerò papà e Willie in cielo». Elizabeth strinse le labbra e si allontanò prima di scoppiare in lacrime. Doveva essere coraggiosa. Il presidente Lincoln avrebbe voluto vederla forte per sostenere sua moglie e i suoi figli. Era l’ultimo favore che poteva fargli, e non intendeva fallire. I figli di Abraham Lincoln capirono dal punto di vista pratico la loro nuova situazione prima della madre, nella quale il dolore aveva annientato ogni altro pensiero. Il presidente Johnson, in un singolare atto di generosità, aveva permesso alla famiglia in lutto di restare alla Casa Bianca mentre lui continuava a vivere, sotto scorta, in una residenza tra Fifteenth Street e H Street, e lavorava in un piccolo ufficio al ministero del Tesoro. Alla fine, però, Mrs Lincoln capì che la sua pazienza non sarebbe durata per sempre, e dovette prepararsi ad andarsene. «Dio mio, Elizabeth!» esclamò un giorno, quando finalmente comprese cosa le restava da fare. «Che cambiamento! Quale altra donna ha dovuto soffrire tanto e affrontare un simile capovolgimento? Ambivo a diventare first lady, e il mio desiderio è stato esaudito. Ora, però, devo scendere dal piedistallo. Il mio povero marito! Se non fosse diventato presidente, forse oggi sarebbe ancora vivo. Ahimè, è tutto finito!» L’amica tentò di confortarla, ma le sue parole suonavano vuote, e lo sapeva. Mrs Lincoln incrociò le braccia e si dondolò avanti e indietro. «Mio Dio, Elizabeth, non posso certo tornare a Springfield! No, mai, almeno finché non sarò avvolta nel lenzuolo funebre per giacere accanto a mio marito, e prego il cielo perché quel giorno arrivi presto! Dovrei voler vivere per i miei figli, ma la vita mi è tanto penosa che preferirei morire». Gemendo si premette i pugni sugli occhi e scoppiò in un pianto isterico. Sebbene la sarta desiderasse disperatamente consolarla, sapeva che non ci sarebbe riuscita, e che nessuna parola le avrebbe dato la pace. Il tempo avrebbe lenito i suoi dolori più di quanto non potesse fare lei, si disse Elizabeth abbattuta, mentre restava accanto a Mrs Lincoln in attesa degli sviluppi. Durante la guerra di secessione i bounty jumpers si arruolavano al posto di un altro in cambio di un compenso, per poi disertare prima di raggiungere il fronte (N.d.T.). 2. 13. Maggio-giugno 1865 Mrs Lincoln non sopportava l’idea di ritornare a Springfield, ma da qualche parte doveva pur andare. Alcuni amici del defunto presidente la esortarono a tornare laggiù, dove aveva ancora una casa, almeno finché non fosse stato risolto il problema dell’eredità del marito. Essendo morto senza lasciare testamento, nonostante i suoi beni fossero destinati a lei e ai figli, non avrebbero ricevuto nulla finché non fossero stati sbrogliati tutti i cavilli legali. La vedova non voleva sentire parlare di Springfield. Si era bruciata troppi ponti alle spalle nella sua città d’origine, ed era stata oggetto di pettegolezzi. Aveva preso le distanze dalle sorelle e sorellastre, perfino dalla sorellina Emilie e dalla fedele Elizabeth Edwards. E soprattutto, come confidò all’amica, non poteva sopportare di rimettere piede nella sua casa, un tempo felice, che dava su Eighth Street e Jackson Street, dove sapeva che sarebbe stata tormentata dai ricordi dei primi anni di matrimonio e del marito e dei figli che aveva perso. Elizabeth capiva, contrariamente a quei signori benintenzionati, che Mrs Lincoln doveva trovare una dimora finanziariamente alla sua portata, visto che i debiti contratti nei negozi preferiti erano saliti a settantamila dollari almeno. La sarta era contenta che il presidente non fosse stato a conoscenza di quei debiti prima di morire, risparmiandosi così la collera e l’imbarazzo inevitabili. Nel frattempo continuavano ad arrivare lettere di condoglianze da ogni angolo del paese e dai capi di stato stranieri. La vedova le leggeva tutte, ripetendo ad alta voce a Elizabeth i passaggi più affettuosi o commoventi, e rispondeva a tutti nei limiti del possibile, con le lacrime che le rigavano il viso. Una lettera in particolare le fu più cara delle altre. Osborne, 29 aprile 1865 Cara signora, anche se sono una sconosciuta per voi, non posso restare in silenzio quando una simile calamità si è abbattuta su di voi e il vostro paese. Debbo quindi esprimere la mia solidarietà più profonda e sincera per le circostanze della vostra attuale tragedia. Nessuno meglio di me, che sono affranta per la perdita del mio adorato marito, la luce della mia vita, il mio sostegno e tutto per me, può capire il vostro dolore, e prego che siate sostenuta da Colui al quale si debbono rivolgere gli sciagurati in cerca di sostegno in quest’ora di afflizione. Rinnovandovi tutta la mia comprensione, cara signora, vi trasmetto la mia amicizia. Vittoria «La regina capisce la mia sofferenza» decretò Mary Lincoln la prima volta che lesse la lettera, e continuò a ripeterlo a ogni lettura successiva. Una volta, infilando il foglio nella busta, aggiunse che la sovrana era stata fortunata, perché nessuno l’aveva cacciata di casa nel momento in cui era rimasta vedova. «Ah, Elizabeth» mormorò con un sorriso triste fra le lacrime. «È ben diverso restare vedova per la first lady degli Stati Uniti d’America e per la regina d’Inghilterra». La sarta era lieta che l’amica avesse trovato conforto nelle parole della regina e, non volendo urtarla, non le fece notare che nessuno l’aveva gettata fuori di casa quando era diventata vedova. Anzi, secondo l’opinione di Elizabeth il presidente Johnson era stato fin troppo paziente, permettendole di restare per mesi e mesi, e rinunciando all’uso della residenza, degli uffici e delle sale da ricevimento della Casa Bianca che gli sarebbero spettati di diritto. Ma da lei, a parte quell’implicita ammissione, il neopresidente non avrebbe avuto altro. La vedova si era accorta benissimo che Mr Johnson non aveva mandato un biglietto di condoglianze né era venuto a farle visita. Robert, che si era accollato la responsabilità di comunicare con il personale del nuovo presidente durante la transizione, protestò indignato per la mancanza di correttezza da parte di Johnson, ma per la madre fu davvero un duro colpo, che la demoralizzò non poco. Se la regina d’Inghilterra trovava il tempo di scrivere una lettera piena di affetto, poteva trovarlo anche il nuovo presidente, che doveva oltretutto quell’incarico proprio alla morte del suo predecessore. Era una vergogna, dichiarò la vedova di Abraham Lincoln, che ci mettesse meno tempo una lettera ad attraversare l’oceano Atlantico che Johnson ad attraversare la strada. Però la Casa Bianca spettava a lui, e sebbene Mrs Lincoln si aggrappasse più a lungo che poteva a ciò che restava della vita precedente, alla fine, pur con riluttanza, decise di trasferirsi a Chicago. Suo marito aveva avuto l’intenzione di recarsi lì dopo la fine del secondo mandato, spiegò Mary Lincoln, e quella città gli era sempre stata propizia. Era a Chicago che era stato prescelto come candidato repubblicano alla presidenza, e quindi il luogo evocava il trionfo, non la disperazione. Sarebbe stata anche relativamente vicina alla tomba del marito a Springfield, dove la vedova immaginava di cercare conforto negli anni a venire. Quasi subito, non appena presa la decisione, Mrs Lincoln chiese a Elizabeth di accompagnarla. Sorpresa, la sarta restò senza parole per un momento, perché non ne aveva nessuna voglia. «Non posso venire a ovest con voi, Mrs Lincoln». «Ma dovete accompagnarmi a Chicago, Elizabeth!» la implorò la vedova. «Non posso stare senza di voi». «Dimenticate forse il mio lavoro?» Anche se ormai cominciava a conoscere il temperamento della sua cliente, la sarta era esterrefatta da quella richiesta. «Non posso mollare tutto. Proprio adesso devo preparare il corredo primaverile per Mrs Douglas, e le ho promesso di ultimarlo in meno di una settimana». Mrs Lincoln liquidò le sue obiezioni con un gesto della mano. «Non importa. Mrs Douglas potrà farselo fare da qualcun altro». Vedendo che Elizabeth non cedeva, cercò un argomento più persuasivo. «Per voi partire potrebbe risultare interessante anche dal punto di vista economico. Ora sono molto povera, ma se il Congresso stanzia dei fondi per me sarete ricompensata». «Non si tratta della ricompensa, ma...» «Non dite un’altra parola, se non volete turbarmi». Mrs Lincoln stava già stringendo la bocca, con occhi lacrimosi e imploranti. «Ho deciso che verrete a Chicago con me, e non potete fare altrimenti». Elizabeth aveva trascorso tanto tempo con la sua cliente, e Mrs Lincoln era diventata così dipendente da lei che capì di non poter rifiutare. Si aggrappò a un’unica speranza: che Mrs Douglas, la graziosa vedova del defunto senatore Stephen A. Douglas dell’Illinois, una delle clienti preferite di Elizabeth, insistesse per farla restare a Washington per completare il suo corredo, come pattuito. Ma quando apprese della richiesta della ex first lady, la dolce Mrs Douglas assicurò a Elizabeth: «Non preoccupatevi per me. Fate tutto ciò che potete per lei... mi fa tanta pena». Mai come quella volta Elizabeth avrebbe voluto imbattersi in una cliente poco comprensiva ed egoista. Rendendosi conto di non avere più scuse, Elizabeth si preparò ad andare a Chicago con Mrs Lincoln e i suoi figli, preparò una borsa da viaggio, spiegò la sua assenza a Virginia e Walker e pagò alcuni mesi di affitto in anticipo, e distribuì i vari ordini di sartoria tra le ragazze. Anche se Emma era stata una fervente ammiratrice di Lincoln e pensava che la vedova meritasse la comprensione e il rispetto della nazione, riteneva che Elizabeth stesse commettendo un terribile errore. «Quando tornerai?» «Non lo so». La sarta si guardò attorno nel laboratorio e posò lo sguardo sulle sue giovani assistenti, il cuore stretto in una morsa di apprensione. Voleva lasciare la parte più importante e difficile del lavoro all’abilissima Emma, ma sebbene la sua aiutante preferita godesse di un’ottima reputazione e avesse assicurato a Elizabeth di soddisfare tutte le richieste delle clienti, la sarta era preoccupata. In sua assenza le clienti più fedeli avrebbero continuato a passare ordini a Emma, confidando che l’assistente avrebbe potuto sbrigare gli incarichi più semplici fino al ritorno della principale per le operazioni particolarmente delicate, o avrebbero scelto invece un’altra sarta, una delle sue concorrenti? «Tornerò non appena Mrs Lincoln non avrà più bisogno di me». Emma fece una smorfia scettica. «In altre parole non intendi più tornare, è così?» «Su, Emma...» «Cosa devo dire alle clienti? Alcune di loro insistono perché sia solo tu a occuparti delle loro creazioni». «Mostra alle signore come lavori. Sono sicura che ti conquisterai la loro fiducia». «Devo pur dire qualcosa» insistette Emma. «Torni tra una settimana? Un mese? Due?» «Di’ alle mie clienti...» Elizabeth esitò. «Di’ loro che tornerò il prima possibile». Emma annuì e si trattenne dal fare altri commenti, ma la sarta sapeva che non era contenta, e che era preoccupata quasi quanto lei per il futuro della loro impresa. Una volta che Mrs Lincoln si fu rassegnata a partire da Washington, si gettò anima e corpo nel fastidioso compito di fare i bagagli, ma prima diede via quasi tutto ciò che aveva un legame con il suo defunto marito, proprio come aveva fatto con le cose di Willie dopo la sua morte. Non poteva sopportare di circondarsi di oggetti che le ricordavano il passato, e quindi, usando Elizabeth come intermediaria, li distribuì a coloro che considerava gli ammiratori più convinti e sinceri di Abraham Lincoln. Il suo fido messaggero, William Slade, ricevette uno dei molti bastoni da passeggio dell’ex presidente e la sua mantella grigia pesante, mentre a sua moglie donò l’abito di seta a strisce bianche e nere che la first lady indossava la notte dell’assassinio. Mrs Lincoln mandò altri bastoni da passeggio agli abolizionisti di colore Frederick Douglass e il reverendo Henry Highland Garnet, pastore dell’esclusiva Presbyterian Church di Fifteenth Street, che Virginia e Walker frequentavano e dove Elizabeth sperava un giorno di essere ammessa, se la sua domanda e il successivo colloquio avessero dato buon esito. Un altro bastone fu fatto pervenire al senatore Sumner, con un biglietto che spiegava che «quel semplice cimelio» era un ringraziamento per la sua «gentilezza incrollabile nei confronti del mio adorato marito e per la grande stima che nutriva nei vostri confronti». Diede gli abiti che il marito indossava al momento dell’assassinio a una delle guardie preferite della Casa Bianca, e l’ultimo cappello che il marito aveva portato al reverendo Gurley, che aveva celebrato i funerali di Abraham Lincoln e del figlio Willie. Le capre che avevano fatto tanto divertire il presidente andarono a Elizabeth Blair Lee, una delle poche amiche che si erano occupate della signora nei giorni tremendi successivi all’attentato. A Elizabeth l’amica donò la cuffia e la mantella che aveva indossato quella sera, macchiate del sangue del presidente, oltre alle soprascarpe, al pettine e alla spazzola che la sarta aveva spesso usato per acconciare colui che era stato alla guida del paese. Erano ricordi preziosi del grand’uomo, ed Elizabeth li accettò con profonda gratitudine. La sua promessa di conservarli sempre suscitò un raro sorriso sulle labbra di Mrs Lincoln. Gli oggetti che non erano stati distribuiti come reliquie e ricordi furono imballati in cinquanta o sessanta scatole e in parecchi bauli. Elizabeth pensava che molte delle cose che l’ex first lady si ostinava a voler portare con sé fossero inutili, ma non si oppose quando vide che la lunga opera di selezione e preparazione dei bagagli occupava a tal punto la sua amica da non lasciarle più molto tempo per lamentarsi. Furono imballate insieme al resto tutte le cuffie che Mrs Lincoln aveva portato con sé da Springfield quattro anni prima, oltre a tutte quelle che aveva acquistato da quando era arrivata a Washington. «Può darsi che un giorno la stoffa mi serva» rispose quando Elizabeth le chiese, con tatto, se voleva proprio tenere anche quelle che non erano più di moda e che non indossava da anni. «È prudente pensare al futuro». Elizabeth, ancora infastidita dalla decisione, presa suo malgrado, di accompagnare Mrs Lincoln, si trattenne dal commentare che avrebbe potuto usare la stessa prudenza e parsimonia anche in passato, invece di applicarla alle cuffie vecchie. Pazienza, si disse. Sapeva di essere stanca e contrariata, e anche lei era in lutto, a modo suo. La ex first lady aveva bisogno di un sostegno affidabile e pieno di buonsenso. Lei o la regina d’Inghilterra erano libere di abbandonarsi al dolore, ma le donne come Elizabeth non potevano permetterselo. Durante il periodo trascorso alla Casa Bianca, Mary Lincoln e i suoi figli avevano ricevuto molti doni da ammiratori e dignitari, e anche quelli furono impacchettati per Chicago. Non portò invece con sé nessun mobile, salvo una toilette che il marito aveva amato particolarmente e che l’amministratore dell’eredità le aveva concesso di tenere per Tad. La vedova la sostituì con un altro mobile dello stesso valore, ma Elizabeth si accorse della scomparsa di altri elementi dell’arredamento, portati via dalla Casa Bianca da domestici e visitatori dopo che il maggiordomo era stato licenziato e non era rimasto più nessuno a sorvegliare. La sarta fu addolorata nel vedere che gli accessori nuovi e costosi, tanto voluti da Mrs Lincoln, venivano sottratti giorno dopo giorno, ma l’ex first lady sembrava troppo affranta per curarsene. Robert si recava spesso nella stanza dove sua madre ed Elizabeth stavano preparando i bagagli, e non si stancava di affermare che tutta quella vecchia roba andava bruciata, o se non altro lasciata dov’era. «Cosa farai con quel vecchio abito, mamma?» chiese accigliato, colpendo uno scatolone con la punta dello stivale mentre lei piegava l’ennesimo capo e lo riponeva. «Non preoccuparti, Robert» replicò lei. «Mi tornerà utile. Tu non le capisci queste cose». «Spero di non doverle mai capire» ribatté lui, indicando con insofferenza le pile di indumenti. «Mi auguro che la vettura destinata a trasportare tutta questa roba a Chicago si incendi, e che tutto il tuo malloppo vada bruciato». Girò sui tacchi e se ne andò a grandi passi. Elizabeth aveva osservato la scena con la coda dell’occhio. Era d’accordo con lui sul fatto che la madre non avrebbe probabilmente mai usato quei vecchi abiti, ma disapprovava quel suo tono arrogante e irrispettoso. «Robert è così impulsivo...» disse Mrs Lincoln come per scusarlo, quasi avesse letto il pensiero della sarta. «Non pensa mai al futuro. Spero che con il passare del tempo maturerà anche lui». «Sono certa che non vi parlerebbe in questo modo se non stesse soffrendo a sua volta». «Sono anni che mi parla così» le ricordò la signora con un sospiro. «Elizabeth, forse un giorno sarò costretta a vendere una parte del mio guardaroba». «Cosa intendete?» «Se il Congresso non prende delle misure a mio favore, gli abiti mi serviranno forse per pagare da mangiare per me e per i miei figli». «Non si arriverà a tanto» cercò di rassicurarla subito la sarta. Non le piaceva pensare che si mercanteggiasse sugli abiti da lei confezionati con tanta cura e passione come se fossero mele al mercato, da vendere in tutta fretta prima che si guastassero. Più tardi, riflettendoci, si disse che forse Robert invece era maturato. Certo era cambiato parecchio nelle settimane trascorse dall’assassinio del padre. Il 14 aprile era un orgoglioso ufficiale dell’Unione, faceva la corte alla graziosa Mary Harlan e intendeva studiare diritto. Ora era il capofamiglia, progettava di abbandonare Washington per trasferirsi a Chicago e, proprio come lei, non sapeva per quanto tempo. Oltre all’inevitabile dolore doveva sentirsi terribilmente deluso, responsabile per l’unico fratello superstite e preoccupato per la madre instabile. Questo non giustificava la sua impertinenza, ma la rendeva più comprensibile e perdonabile. Alla fine tutto, oggetti inutili e preziosi, fu imballato, e arrivò il giorno della partenza. Mentre usciva con Mrs Lincoln dalla Casa Bianca, Elizabeth fu molto colpita dalla differenza enorme rispetto all’uscita di scena del presidente Lincoln, quando la sua bara era stata trasportata fuori dall’ingresso principale in pompa magna. Migliaia di persone si erano raccolte per chinare il capo con reverenza mentre il carro funebre ornato di piume l’aveva condotto fino alla rotonda del Campidoglio circondato dai militari in tutto il loro splendore: battaglioni con le armi rovesciate, il cavallo senza cavaliere con gli stivali rovesciati nelle staffe, bandiere a mezz’asta, le note malinconiche delle marce funebri. La partenza di Mrs Lincoln, invece, avvenne nell’indifferenza più completa, con il cinguettio degli uccelli come unico accompagnamento, e quasi nessuno a dirle addio. Il silenzio era quasi doloroso. Sulla soglia la vedova si fermò per un attimo, trasse un respiro profondo e tremante e prese la mano di Tad tra le sue. «Vieni» lo esortò, con gli occhi fissi davanti a sé. Se ne andò dalla Casa Bianca senza voltarsi indietro, salì a bordo della carrozza, si sistemò mentre il resto dei viaggiatori prendeva posto accanto a lei e non disse nulla mentre si recavano alla stazione da dove sarebbe partito il vagone privato verde che tanto spesso aveva trasportato Mrs Lincoln a New York e ritorno. Di lì a poco il treno partì sbuffando e sferragliando dalla stazione. Finché non furono usciti dalla città ogni sbuffo di vapore parve a Elizabeth un sospiro di sollievo: Washington era felice di veder partire Mrs Lincoln, che non era mai stata all’altezza del loro grande presidente martire e che ora poteva essere dimenticata. Erano un gruppo sparuto: la vedova, Robert e Tad; Elizabeth; il dottor Anson Henry, amico di lunga data della famiglia ed ex medico personale del presidente; Thomas Cross e William Crook, due guardie della Casa Bianca che erano state incaricate di scortare la famiglia Lincoln in Illinois. Poco tempo dopo che il treno fu partito verso ovest, Mrs Lincoln cominciò a lamentare una delle sue tremende emicranie, così il dottor Henry le somministrò il laudano ed Elizabeth le bagnò le tempie con acqua fresca. «Lizzie, siete la mia amica più cara e affezionata» le disse lei con aria intontita, reclinando il capo all’indietro con gli occhi chiusi. «Vi voglio bene, siete la mia migliore amica. Vorrei potervi evitare ogni apprensione per il futuro». «Siete molto gentile, Mrs Lincoln» ribatté Elizabeth, commossa. «Pensiamo a voi, intanto». La signora le afferrò un braccio. «Se il Congresso si occuperà di me non temete, vi aiuterò». La sarta le carezzò il braccio con trasporto, la ringraziò esortandola a riposare. La vedova dormì profondamente quella notte, e il mattino dopo si sentiva abbastanza bene da stare seduta per guardare fuori dal finestrino. Per ore parve assente, intontita, mentre l’amica le sedeva accanto cucendo e tenendola d’occhio. «Cosa state facendo?» chiese a un tratto Mrs Lincoln. «Una trapunta?» «Sì». Elizabeth si posò in grembo l’ago e gli scampoli di tessuto e le allungò una delle porzioni che aveva già completato, sette pezzetti cuciti insieme, un esagono centrale chiaro circondato da sei più scuri. «Ho appena cominciato. Sapete che non sono abituata all’inattività, e confezionare abiti è impossibile con i movimenti del treno». «Che pezzetti piccoli! E che punti minuscoli!» Guardò più da vicino. «Questi tessuti hanno l’aria familiare». «Sono ritagli avanzati dai vostri abiti» rispose Elizabeth. «Sono contenta che li riconosciate. Ciascuno di loro è per me come un vecchio amico, e quando lo sguardo mi cade su uno di essi, ricordo l’abito confezionato con la stessa stoffa, e l’occasione solenne per la quale era stato fatto». «Che bella idea». Mrs Lincoln le restituì i frammenti di stoffa e tornò a guardare fuori dalla finestra. «Un album di ricordi fatto di tessuto. Perfetto». Tacque tanto a lungo che Elizabeth pensò che avesse finito, invece aggiunse in un soffio appena percettibile: «A meno che il ricordo non bruci troppo». Cinquantaquattro ore dopo essere partito da Washington, il treno giunse a Chicago. Nessuno li accolse alla stazione, e del resto Elizabeth non sapeva chi sarebbe potuto andare, anche se fosse stato al corrente del loro arrivo. Mrs Lincoln aveva prenotato delle stanze al Tremont House, un albergo lussuoso all’angolo tra Lake Street e Dearborn. «Mio marito cominciò la sua campagna elettorale per il Senato da quel balcone» dichiarò scendendo dalla carrozza e indicando il luogo con un cenno del mento. «Nel 1860 era il quartier generale del partito repubblicano dell’Illinois durante la convention nazionale dei repubblicani. Pendevano tutti dalle labbra di mio marito, a quei tempi!» Robert lanciò un’occhiata all’edificio imponente, tormentandosi l’orecchio con aria pensosa. «Non è qui che è morto il senatore Douglas?» Sua madre strinse le labbra. «Sì» rispose sbrigativa. «Anche quello». Entrò senza aggiungere una parola, e tutti gli altri la seguirono. Elizabeth rimase interdetta per il lusso della sua stanza. Non aveva mai soggiornato in un luogo tanto elegante, e si sentì morire pensando a quanto costava. Mrs Lincoln si era abituata ai fasti della Casa Bianca, e apparentemente contava di continuare a vivere in quel modo. In veste di accompagnatrice e amica, spettava a lei ricordarle che sarebbe rimasta senza un soldo in poco tempo se non avesse cominciato a rinunciare a quei lussi. Proprio mentre racimolava il coraggio per parlarle, la sua amica le risparmiò quel compito gravoso giungendo da sola alla stessa conclusione. «Qui è tutto tanto elegante e tanto caro» confessò alla sarta con un sospiro profondo. «Non possiamo restare. Non posso aggravare i miei problemi economici». Mandò Robert a cercare una sistemazione meno costosa, e nel giro di una settimana il figlio le propose di trasferirsi all’Hyde Park Hotel, un albergo tranquillo a dieci chilometri dal centro, sulla sponda del lago Michigan, in Fifty-third Street. Il borgo di Hyde Park, con una popolazione di cinquecento anime, era un luogo piacevole e fresco, diventato una popolare località di villeggiatura per gli abitanti agiati di Chicago. Il proprietario dell’hotel, Paul Cornell, avvocato e imprenditore edile di Chicago per il quale un tempo Abraham Lincoln aveva sbrigato delle pratiche legali, disse a Robert che sarebbe stato un grande onore per lui ospitare Mrs Lincoln. E la vedova accettò. Viaggiarono in treno, arrivando a Hyde Park verso le tre del pomeriggio di un sabato. Elizabeth fu colpita dall’aspetto nuovo dell’albergo, che aveva aperto solo l’estate prima e che odorava ancora di legno di pino. L’alloggio era di un livello ben diverso rispetto al Tremont House, le stanze erano confortevoli ma piccole e arredate in modo spartano. La maggior parte del bagaglio di Mrs Lincoln era stato messo in un deposito al loro arrivo, e disfecero quello che aveva con sé. Elizabeth aiutò l’amica a sistemare gli abiti negli armadi, poi diede una mano a Robert a riporre sugli scaffali della sua stanza i libri. Chiacchierarono amabilmente mentre si davano da fare, e quando ebbero finito Robert incrociò le braccia, rimase immobile accanto al camino e fissò lo sguardo su un punto lontano, come se l’entità del cambiamento, il contrasto drammatico tra il passato e il presente gli apparissero reali solo in quel momento. «Allora, Mrs Keckley» chiese infine, «cosa pensa di questa nuova sistemazione?» «È un posto delizioso» rispose Elizabeth, «e penso che vi troverete bene». Lui la studiò per qualche istante con aria interrogativa, come se si fosse aspettato una risposta diversa. «Un posto delizioso, dite. Forse». Si guardò attorno nella stanza piccola ma pulita, e la donna si rese conto che il giovane doveva vederla in modo diverso da lei, considerandola angusta e spoglia. «Siccome a voi non tocca stare qui, potete felicitarvi quanto volete della bellezza del posto. Presumo, invece, che io dovrò subire la situazione, visto che il bene di mia madre dev’essere anteposto al mio. Sinceramente, però, preferirei quasi morire piuttosto che essere costretto a restare tre mesi in questo posto squallido». Se non avesse detto “quasi”, pensò Elizabeth risentita, lo avrebbe accusato di esagerare. Lo osservò mentre si avvicinava alla finestra e studiava il panorama con espressione infastidita e scontenta. Soffocando un sospiro se ne andò, lasciandolo al suo malumore, e si recò da Mrs Lincoln, che era andata a riposare prima di ordinare la cena. La sarta sentiva piangere la vedova da otto settimane, quindi non fu sorpresa trovandola sdraiata sul letto a singhiozzare disperata. Stava tornando silenziosamente sui suoi passi, chiudendosi la porta alle spalle, ma la vedova l’aveva sentita entrare e si girò per vedere chi l’avesse disturbata. «Che posto orribile, Elizabeth!» si lamentò, sollevandosi su un gomito e asciugandosi le lacrime con l’altra mano. «E dire che dovrò rassegnarmi a vivere qui perché non posso permettermi di andare ad abitare altrove. Ah! Che brutto cambiamento per tutti noi». «Non è tanto male» ragionò Elizabeth, sedendosi sulla poltroncina accanto al letto. «Il panorama è bello, la brezza che sale dal lago è fresca». Tese una mano. «Venite a guardare con me». Mrs Lincoln scosse il capo e si lasciò ricadere sui cuscini. «Non potrei sopportarlo. Come faccio a godermi un bel panorama mentre mio marito giace nella tomba e io non so cosa sarà di me e dei miei figli?» La sarta fece un sospiro lieve. «Molto bene. Come desiderate». Si congedò, trovò Tad che giocava in camera sua e lo portò fuori. Il bambino la prese per mano e parlò animatamente mentre si avviavano verso la riva del lago, e una volta lì corse subito vicino all’acqua gridando e ridendo. Insieme passeggiarono lungo la spiaggia, raccogliendo pietre tonde e lisce, ammonticchiando le più belle vicino all’erba per riportarle in camera e gettando invece le altre nel lago, una a una, producendo dei bei tonfi. La domenica mattina giunse serena e tranquilla. Dalla sua finestra Elizabeth osservò lo splendido lago, uno dei tanti bellissimi panorami di cui si godeva dall’hotel. Il vento increspava la vasta superficie azzurra, e i raggi del sole facevano brillare le onde come gioielli. Qua e là una barca a vela scivolava silenziosa sui flutti e scompariva oltre la linea blu dell’orizzonte appena visibile. Si mise a riflettere sul regno dei Cieli, dove un giorno le sarebbe piaciuto essere accolta: i raggi del sole sull’acqua facevano pensare alle corone tempestate di gioie della vita eterna. Non riusciva a concepire che si potesse considerare squallido Hyde Park, quando pulsava di luce e vita a quel modo. Sarebbe stata ben felice di poter restare lì a riposare. Aveva attraversato tante difficoltà e ora era stanca, e sapere di dover aiutare Mrs Lincoln a superare quella prova la rendeva ancora più esausta, e riluttante a uscire dalla sua stanza per affrontare la giornata. Avrebbe quasi preferito incrociare le braccia e lasciarsi cadere in un sonno eterno, per soddisfare infine il profondo desiderio di riposo della sua anima. Robert trascorse la giornata nella sua stanza a leggere, mentre Elizabeth tenne compagnia alla vedova, descrivendole tutti i lati positivi della loro nuova residenza. Le suggerì che forse non aveva avuto modo di osservare i dintorni, tutta presa dal proprio dolore, e che sebbene la situazione attuale fosse ben diversa da quella alla quale si era abituata, bisognava comunque guardare al futuro. Ma Mrs Lincoln rifiutava di fare programmi dopo l’estate, e insisteva nel voler vivere reclusa nei mesi a venire. «Le vecchie facce mi faranno ripensare a scene che preferisco dimenticare» dichiarò, «e le persone nuove non capirebbero nulla del mio dolore, né potrebbero migliorare la mia situazione». La sarta non era d’accordo, ma non riuscì a persuaderla del contrario. Nel corso della notte, però, la vedova dovette riflettere almeno sul futuro di Tad, perché il lunedì mattina, dopo che Robert si fu recato a Chicago per certe faccende da sbrigare, disse a Tad che avrebbe avuto una lezione ogni giorno a cominciare da quel giorno stesso. Tad protestò affermando che non voleva nessuna lezione, ma la madre obiettò che così facendo sarebbe cresciuto ignorante. «Devi fare quello che ti dice la mamma» sottolineò Mrs Lincoln. «Sei grande, ormai, in autunno inizi la scuola. Non vorrai cominciare senza neanche saper leggere». Tad meditò sulle sue parole, forse immaginando l’umiliazione dell’essere l’unico bambino in classe incapace di leggere, quindi balzò in piedi dichiarando che era d’accordo a seguire una lezione e che gli serviva il libro per cominciare subito. Elizabeth rimase a guardare divertita mentre la madre si sedeva in poltrona e il bambino avvicinava la sua seggiolina con il libro sulle ginocchia. Quella scena sarebbe piaciuta molto al defunto presidente, si disse la sarta. Tad era sempre stato accontentato e viziato dai genitori, soprattutto da suo padre. Aveva un difetto di pronuncia e non era mai andato a scuola, così non conosceva bene l’abbecedario. La sarta non era mai riuscita a capire come due genitori che davano tanta importanza al sapere e all’apprendimento potessero aver trascurato fino a quel punto l’educazione del figlio, ed era contenta di vedere che la madre intendeva recuperare il tempo perduto. Era un progetto che Elizabeth approvava perché non avrebbe fatto del bene solo a Tad. Lui doveva imparare a leggere e scrivere, ma sua madre aveva bisogno di un’attività per occupare il tempo e i pensieri. Tad aprì il libro e cominciò a leggere la prima parola. «A, P, E». «Bravo» lo incoraggiò la madre. «Che parola è?» Tad guardò l’immagine sopra la parola. «Vespa». «Niente affatto!» esclamò Mrs Lincoln. «A, P, E non è vespa». «Sì, invece. Vespa! Guarda!» le disse, indicando l’immagine con aria trionfante. «Non è una vespa?» «No, non è una vespa». Tad spalancò la bocca incredulo. «Non è una vespa! Cos’è, allora?» «Un’ape». «Un’ape? Non è un’ape. Non pensi che sappia riconoscere una vespa quando la vedo?» «No, se sostieni che quella sia una vespa». «La riconosco, la vespa» insistette. «Ne ho viste tante in giardino. Le conosco meglio di te, perché ho passato tanto tempo a giocare fuori». «Ascoltami, Tad. Una vespa e un’ape si assomigliano ma non sono identiche». «E allora non dovrebbero assomigliarsi. Guarda, Yib». Era il nomignolo che aveva dato a Elizabeth anni prima, quando il suo difetto di pronuncia gli rendeva impossibile dire il suo vero nome. «È una vespa, no? E A, P, E messe insieme non danno la parola vespa? La mamma non ci capisce nulla». Mentre parlava mise il libro in mano a Elizabeth, tutto serio e impaziente. La sarta non riuscì a trattenersi e scoppiò a ridere. Tad si ritrasse, mortalmente offeso. «Scusami, Tad» boccheggiò, cercando di soffocare quella crisi di ilarità. «Spero che perdonerai la mia scortesia». Lui chinò il capo, scusandola con il sussiego di un piccolo lord, ma tornò all’attacco ripetendo: «Non è una vespa? A, P, E non fanno vespa?» «No, Tad» lo corresse con dolcezza. «Tua madre ha ragione. A, P, E danno ape». «Ne sai quanto mia madre». Indignato, Tad chiuse il libro di scatto. «Non sapete nulla, nessuna delle due». In quel momento tornò Robert da Chicago e Tad gli rivolse subito la stessa domanda. Ci volle un po’, ma alla fine il fratello riuscì a convincerlo del fatto che le due donne sapevano il fatto loro, e che le lettere A, P, E non significavano vespa. Una volta che Tad ebbe accettato questa verità irrefutabile, il resto della lezione procedette senza intoppi. Elizabeth seguì con la coda dell’occhio mentre cuciva la trapunta, mordendosi le labbra per non ridere. Poi si disse che se Tad fosse stato un bambino di colore invece del figlio di un presidente, e un insegnante avesse trovato simili difficoltà nello spiegargli una lezione, sarebbe stato ridicolizzato come somaro, e la sua ostinazione sarebbe stata sbandierata come esempio dell’inferiorità della sua razza. Tad era intelligente, lei lo sapeva bene, ed era sicura che con un’istruzione adeguata e qualche sforzo si sarebbe manifestato anche in lui il genio del padre. Ma Elizabeth conosceva molti bambini neri suoi coetanei che scrivevano e leggevano correttamente, e nonostante ciò il mito dell’inferiorità continuava a regnare. L’ingiustizia di quei pregiudizi faceva male. Se un bambino bianco sembrava poco sveglio, la colpa veniva imputata alla sua mancanza di intelligenza individuale o di istruzione, ma se un bambino nero pareva sciocco tutta la sua razza era bollata come stolta. Alla sarta sembrava che se una razza non si poteva giudicare sulla base di un solo esempio, lo stesso doveva valere per le altre. Thomas Cross e William Crook tornarono a Washington per riprendere le loro funzioni alla Casa Bianca, portandosi con sé le ultime vestigia del rango di Mrs Lincoln. Con il passare dei giorni, dopo avere perso il marito e il prestigio, la vedova fu assillata dal terrore della povertà. Era già stato abbastanza demoralizzante per lei lasciare l’elegante Tremont House perché non poteva permettersi di vivere in quel lusso, ma trovarsi all’improvviso così in basso le fece l’effetto di un vergognoso esilio. All’inizio le conoscenti tentarono di farle visita all’Hyde Park Hotel, ma Mrs Lincoln non poteva sopportare di essere vista in quella condizione di ristrettezze economiche, così rifiutò di incontrare chiunque. «Avevo sperato in un’accoglienza ben diversa quando ho deciso di venire a trasferirmi qui» confidò all’amica. Si era aspettata che l’élite di Chicago l’avrebbe accolta a braccia aperte, coprendola di attenzioni in virtù del suo ruolo di vedova del presidente ucciso. Elizabeth sospettava anche che si fosse aspettata, da parte di un ricco benefattore repubblicano, la proposta di insediarla in una residenza degna del suo rango, accollandosi le spese. Invece non era apparso nessun angelo custode, non era giunta nessuna proposta. Mrs Lincoln continuava a sperare che uno o l’altro dei sostenitori più facoltosi di suo marito o degli amici che si erano arricchiti grazie a lui le venissero in aiuto, e ogni volta le sue speranze si rivelavano vane. Umiliata, la vedova si isolava sempre più, non voleva vedere nessuno e riversava il suo dolore e le sue preoccupazioni in lunghe missive. Il peso dei debiti minacciava di schiacciarla, ma era decisa a ripagare ogni centesimo. Scriveva lunghe richieste di risarcimento rivolte al governo, in virtù del sacrificio compiuto dal marito per la nazione, e chiedendo per sé tutto lo stipendio che avrebbe dovuto guadagnare durante il secondo mandato da presidente. Quando il Congresso non fu sollecito nel versarle un appannaggio, decise di scrivere direttamente ad alcuni degli uomini più influenti che si erano arricchiti in fretta grazie agli incarichi attribuiti loro da Lincoln, nella speranza che ricordando quel debito l’avrebbero aiutata. Sarebbe forse riuscita nel suo intento se i giornali non avessero scritto che Lincoln aveva lasciato un’eredità di settantacinquemila dollari. Naturalmente era ancora tutto bloccato per via dei cavilli legali e in ogni caso sarebbe stato diviso in tre, fra la vedova e i figli, e anche quando Mary Lincoln avesse ereditato non avrebbe potuto usare il capitale per mantenersi, ma solo gli interessi annui. Siccome i giornali omisero questi particolari, nessuno le credette quando cominciò a piangere miseria. Nessuno, neppure gli amici più stretti e i più grandi ammiratori del marito, si degnò di riservarle comprensione e men che meno carità, giacché le sue lamentele sembravano dipingere un ritratto falso della situazione. A peggiorare le cose vi fu il fatto che, quando la famiglia Johnson prese possesso della Casa Bianca, trovò la dimora sottosopra, senza quasi più mobili. Anche se i colpevoli erano stati visitatori senza scrupoli e domestici infedeli, si mormorava che la responsabile fosse Mrs Lincoln, e che il maltolto si trovasse in tutti i bauli e le casse che, si sapeva, aveva portato con sé a Chicago. Mentre la vedova trascorreva giorni tristi a Hyde Park, sentendosi abbandonata e povera, la gente si vedeva propinare una nuova campagna denigratoria su di lei, e beveva qualunque menzogna, anche la più sordida, che sarebbe apparsa improbabile a lettori più accorti. L’idea negativa che il pubblico si era fatto di lei spinse Mrs Lincoln a rifugiarsi nell’autocommiserazione e nella disperazione. Ignorò le insistenze dell’esecutore testamentario del marito – il giudice David Davis, responsabile della campagna elettorale del 1860 e candidato da Lincoln alla Corte Suprema nel 1862 – che le ricordava che avrebbe potuto vivere agiatamente con le sue risorse se si fosse trasferita a Springfield. Implorò invece gli amici di scrivere ai membri del Congresso da parte sua affinché usassero la propria influenza per garantirle l’appannaggio di cui aveva tanto bisogno. Come vedova del presidente riteneva che il suo sacrificio dovesse essere riconosciuto dal governo oltre che dal pubblico, e impedirle di sprofondare nell’indigenza era il minimo. Le lettere continue e instancabili sembravano essere diventate una vera e propria crociata per riabilitare la sua reputazione, per recuperare il prestigio perduto, per ricevere gli onori che riteneva di meritare, e per preservare l’eredità del marito. Lesse i giornali da cima a fondo per restare informata su ciò che si diceva sull’ex presidente, e riempì le sue missive di osservazioni pertinenti su politica e attualità. Qualunque tipo di onore o di emolumento assegnato ad altri rappresentava ai suoi occhi un terribile affronto, perché riteneva che non venissero attribuiti onori sufficienti al presidente assassinato al quale dovevano tutto. Celebrare la memoria del presidente Lincoln divenne la sua grande causa, insieme al desiderio di crescere Tad e di vedere Robert indipendente, realizzato e soddisfatto. Spesso confessava a Elizabeth che non fosse stato per i suoi figli avrebbe preferito togliersi la vita. Mentre Mary Lincoln scriveva una lettera dopo l’altra, anche Elizabeth coltivava le proprie relazioni epistolari, inviando lettere cortesi alle clienti preferite che si informavano sul suo ritorno, oltre a missive più intime a Virginia ed Emma, alle quali confidava le sue preoccupazioni riguardo a Mrs Lincoln e alla propria attività professionale. Virginia si dimostrava comprensiva, invitandola però a tornare a casa il prima possibile, mentre Emma le comunicò senza mezzi termini che in sua assenza le cose stavano andando male. Lei e le altre assistenti avevano terminato gli abiti che Elizabeth aveva iniziato prima della partenza, ma i nuovi ordini erano stati scarsi quando si era sparsa la voce che non sarebbe stata la famosa madame Keckley a realizzare le creazioni. Emma era stata costretta a licenziare metà delle assistenti perché non c’era lavoro per tutte. «Le clienti vogliono sapere quando rientri» scrisse Emma. «Se ti sbrighi, penso che riusciremo a farle tornare e a confezionare loro abiti per la prossima stagione dei balli, ma se resti lontana troppo a lungo troveranno qualcun altro che le vestirà. Non saranno altrettanto graziose, ma devono pur indossare qualcosa». I più cupi timori di Elizabeth si stavano realizzando. Aveva investito ogni cosa nel laboratorio di sartoria – denaro, tempo, fatica – e ora le pareva che tutto si stesse sgretolando. I Lincoln erano insediati nella loro nuova dimora, anche se meno felicemente di come lei avrebbe voluto, e cominciò a chiedersi quanto tempo ancora si sarebbe dovuta trattenere. Il governo aveva accordato alla vedova una piccola somma per ingaggiare Elizabeth come compagna remunerata – trentacinque dollari a settimana per i suoi servizi, cento dollari per le spese di viaggio e di alloggio, cinquanta dollari per gli abiti da lutto –, ma i soldi che perdeva trascurando la propria attività a Washington erano molti di più di quelli che guadagnava a Chicago. Inoltre, pur non volendo certo turbare la sua amica con domande del genere, era certa che non restasse quasi più nulla di quel gruzzoletto. Elizabeth continuava anche a leggere i giornali, sebbene non con la stessa determinazione di Mrs Lincoln, che ogni giorno divorava diversi quotidiani di New York, Washington e Chicago, e trattenne il fiato quando le cadde l’occhio su un articolo su John Wilkes Booth e i suoi complici. La vedova era parsa fin da subito stranamente indifferente alle notizie sulla morte dell’assassino del marito, la ricerca dei congiurati e il loro processo imminente, ma Elizabeth ne lesse ogni parola. Si scoprì anche a cercare sui giornali notizie su Jefferson Davis e sua moglie, che erano fuggiti nel profondo Sud finché non erano stati catturati con i loro pochi accompagnatori un mattino di maggio vicino a Irwinville, in Georgia. I giornali affermavano che quando i fuggitivi avevano udito i soldati dell’Unione avvicinarsi al loro accampamento, Davis aveva indossato un abito della moglie nel tentativo di camuffarsi e si era inoltrato nella foresta. Ma un caporale dotato di spirito di osservazione aveva notato quella donna eccessivamente alta, con indosso stivali da uomo, e aveva intimato l’alt, mentre un altro soldato aveva imbracciato il fucile. Ancora in camicia da notte, la moglie era corsa dal marito e gli aveva gettato le braccia al collo: il soldato, restio a sparare a una donna alle spalle, aveva abbassato l’arma. Elizabeth sapeva che Varina Davis aveva probabilmente salvato la vita del marito, giacché gli ufficiali avevano l’ordine di catturare il presidente della Confederazione vivo o morto. La sarta avrebbe tanto desiderato scrivere una lettera affettuosa a Mrs Davis, che le era sempre stata simpatica nonostante le opinioni divergenti in fatto di schiavitù e secessione, ma non sapeva dove indirizzargliela. Secondo i giornali il marito era imprigionato a Fort Monroe, ma era impossibile scoprire che fine avessero fatto moglie e figli. L’ultima settimana di maggio, Elizabeth lesse che Chicago avrebbe presto ospitato la seconda Great Northwestern Sanitary Fair. Nel corso della guerra, la Commissione sanitaria degli Stati Uniti e le sue varie diramazioni in tutto il Nord avevano raccolto fondi essenziali per la guerra, e i volontari organizzavano numerose manifestazioni per trovare il denaro necessario per l’acquisto di cibo, coperte, bende, uniformi, lenzuola e tutto quanto fosse vitale per i soldati. Anche se il presidente Johnson aveva dichiarato ufficialmente conclusi i combattimenti, l’opera della Commissione sanitaria continuava, perché i bisogni dei soldati, sebbene di natura diversa, non erano meno impellenti. Il ricavato dell’evento di Chicago sarebbe stato devoluto ai veterani ridotti in povertà, ai soldati feriti che non potevano lavorare, e alle vedove e agli orfani dei soldati uccisi in battaglia. Per la prima Sanitary Fair dell’autunno 1863, il presidente Lincoln aveva donato l’originale del Proclama di Emancipazione, che era stato venduto per tremila dollari. Il presidente Johnson o uno dei suoi consiglieri doveva avere deciso che ci si aspettava un gesto simile da parte sua, perché Elizabeth scoprì che il catafalco che aveva sorretto la bara del presidente Lincoln era stato fatto arrivare da Washington. Si sperava che la vendita dei biglietti per vedere la mostra, che avrebbe incluso altri cimeli della guerra, avrebbe permesso di raccogliere una somma importante per una causa meritevole. La sarta, incuriosita, decise di partecipare, ma non riuscì a convincere Mrs Lincoln ad accompagnarla. «Un’uscita vi farebbe bene» la esortò l’amica, «e so che la causa dei soldati dell’Unione vi sta molto a cuore». Mrs Lincoln rabbrividì. «I soldati mi sono effettivamente molto cari, ma neppure per loro accetterò di vedere qualcosa di così intimamente legato alla morte di mio marito». «Il padiglione è talmente vasto che, anche se non vi avvicinate, avrete molte altre cose da vedere». «E cosa direbbe la gente se mi rifiutassi di andare vicino al catafalco di mio marito?» ribatté Mrs Lincoln. «Direbbero che non gli dimostro un rispetto adeguato. Affermerebbero che non piango la sua morte e che il suo ricordo mi lascia indifferente. Tali menzogne riempirebbero i giornali di domani. No, Elizabeth, non desidero essere vista da quelle parti, e anche se portassi un velo pesante mi riconoscerebbero». La sarta era delusa ma la capiva, e decise quindi di andare da sola. Prese il treno diretto a nord, e dopo un breve tragitto verso il centro città scese alla stazione e andò a piedi a Trophy Hall in Michigan Avenue, dove si svolgeva la manifestazione. Pagò il biglietto d’ingresso e cominciò a fare il giro della mostra, leggendo le didascalie e osservando gli oggetti. Scelse un percorso che le permettesse di arrivare al settore dedicato a Lincoln per ultimo, e a ogni passo si sentiva il cuore più pesante. Il catafalco era identico a come lo ricordava nell’East Room, ma sembrava piccolo e fuori luogo in quel padiglione estraneo e pieno di rumore. Il feretro era lungo poco più di due metri, largo settanta centimetri e alto mezzo metro abbondante, coperto di seta nera bordata di bianco, con pesanti fiocchi neri ai quattro angoli, ampi festoni di seta lungo i lati e una lunga frangia tutto attorno. Era coperto da una cupola di vetro cosparsa di stelle, e alla base erano stati disposti ricordi della schiavitù presi dalle piantagioni del Sud durante la guerra: una palla con la catena enormi, un paio di ceppi pesanti, una serie di fruste e altri oggetti che ricordarono in modo così doloroso a Elizabeth la propria giovinezza da costringerla a guardare altrove. Ricordò quanto era rimasta sconvolta Mrs Lincoln durante la costruzione del catafalco nell’East Room, perché ogni colpo di martello su un chiodo le pareva uno sparo di pistola. Come era stata sciocca a proporle di accompagnarla alla fiera! Perché mai una vedova in lutto avrebbe dovuto subire la vista del catafalco sul quale era stata posata la bara del marito? Scuotendo il capo e rimproverandosi silenziosamente, Elizabeth si allontanò da quegli oggetti legati all’ex presidente. Aveva visto quasi tutto ciò che le premeva e stava per andarsene, quando notò un assembramento davanti a un oggetto esposto all’altro capo della sala. Incuriosita si avvicinò e vide una campana di ferro con un cartello che spiegava che era stata presa dalla piantagione di Jefferson Davis in Mississippi; ma non era quell’oggetto ad aver attirato la folla. Stavano invece aspettando tutti di pagare venticinque cent per vedere una figura di cera di Jefferson Davis al momento della cattura in Georgia. Elizabeth non riuscì a resistere. Si mise in fila, pagò il biglietto e quando arrivò il suo turno oltrepassò una tenda con alcuni altri spettatori. Una statua di cera, abbastanza somigliante a Mr Davis, si trovava su un piedistallo, con addosso un abito da uomo e sopra un vestito da donna a fiori. Un indumento stranamente familiare... «Oh, mio Dio!» esclamò Elizabeth. «È uno degli abiti da casa di chintz di Mrs Davis!» Gli altri visitatori del gruppo la guardarono dopo quell’uscita inattesa. «Come avete detto?» si informò un signore mentre tutti gli occhi si giravano verso di lei. Elizabeth, senza lasciare l’abito con lo sguardo, fece un gesto incredulo. «È uno degli abiti di chintz che ho confezionato per Mrs Davis nel gennaio 1861, subito prima che lei e il marito se ne andassero da Washington». Con la coda dell’occhio vide due signore che la guardavano attonite, bisbigliando tra loro. «Sono sarta» spiegò. «Vengo da Washington dove ho un laboratorio di sartoria. Mrs Davis era una delle mie clienti, così come lo era, anzi lo è, Mrs Lincoln». Non sapeva bene perché aveva aggiunto anche quell’ultima precisazione: forse perché il loro sguardo dubbioso la turbava. Si accorse allora degli altri visitatori che sbirciavano da dietro la tenda, attratti dalle sue esclamazioni o desiderosi di vedere cosa ritardasse l’avanzamento della fila. Il primo gentiluomo che le aveva parlato rivelò loro: «Questa donna di colore afferma di avere confezionato l’abito per Mrs Davis». Il pubblico mormorò eccitato, e qualcuno cercò di avanzare mentre altri facevano capolino da dietro la tenda. Elizabeth d’istinto fece un passo indietro. «Davvero?» chiese una donna emozionata. «Potete provarlo?» Altri si unirono al coro per chiederle di dimostrare le sue affermazioni, e la sarta spostò lo sguardo dall’uno all’altro di loro, smarrita, desiderando fuggire. «Come?» disse. «Come posso provarlo?» «Diteci come l’avete confezionato» la esortò una donna anziana. Quello non era un problema. Traendo un respiro profondo per darsi coraggio, Elizabeth si avvicinò alla figura di cera e spiegò che Mrs Davis aveva comprato lei stessa la stoffa, spendendo meno del solito perché la guerra la costringeva a fare delle economie, e aveva chiesto alla sarta di fabbricare velocemente gli abiti perché prevedeva – un’ipotesi che si era rivelata corretta – che suo marito avrebbe deciso di partire da Washington di lì a breve. Le prime frasi le uscirono a fatica, poi cominciò a spiegare come aveva confezionato l’abito, usando una tecnica che era il suo segno di riconoscimento, e quella parte le venne con facilità. Mentre parlava la tenda fu aperta per permettere a più persone di radunarsi attorno a lei. Il pubblico cresceva a vista d’occhio via via che Elizabeth dimostrava meglio che poteva di conoscere di prima mano l’indumento appartenuto a Mrs Davis, perché era stata lei stessa a confezionarlo. Era consapevole che le sue parole non erano una prova – per quello che ne sapevano i suoi ascoltatori, poteva essere una buona attrice o un’eccellente bugiarda – ma la sua sicurezza e le descrizioni precise dei minimi dettagli del vestito sembrarono convincerli che diceva il vero. «Questa donna afferma di avere fatto l’abito indossato da Jeff Davis al momento della cattura!» gridò un uomo voltandosi, facendo cenno agli altri di avvicinarsi. «Non ho mai detto niente del genere!» protestò lei. «Intendo dire che ho effettivamente fatto l’abito per Mrs Davis, ma non so se il marito l’abbia davvero indossato per travestirsi. Mi sembra poco probabile, perché lui ha le spalle troppo larghe e il corpetto gli sarebbe stretto...» Interruppero le sue spiegazioni con grida di protesta, accusandola di volerlo difendere, così cambiò subito discorso, tornando a descrivere l’abito. Nel frattempo qualcuno era andato a cercare la responsabile della fiera, che si era trattenuta lì in mezzo alla folla ad ascoltare come gli altri. Gli spettatori si erano aspettati di trovare reperti interessanti all’esposizione, ma certo non pensavano di assistere a una scena del genere, e non avevano neanche dovuto pagare i venticinque cent dell’ingresso. «Siete pronta a giurarlo?» chiese qualcuno quando ebbe terminato. La folla premeva da dietro e lei cominciava a sentirsi a disagio. Elizabeth accettò, solo perché non sapeva come avrebbe reagito la calca se avesse rifiutato. La responsabile dell’esposizione, Mrs Bradwell, andò a cercare un notaio e nell’attesa la sarta rispose ad alcune domande e ne evitò altre a proposito della famiglia Davis e dei Lincoln. Alla fine Mrs Bradwell fece ritorno con un signore basso, corpulento e con i capelli scuri che estrasse subito carta, penna e i sigilli ufficiali. Lui e Mrs Bradwell le consigliarono cosa scrivere, ma lei cambiò leggermente la formulazione. La sottoscritta Elizabeth Keckley dichiara di essere stata la sarta della moglie di Jefferson Davis e, più di recente, della moglie del presidente Lincoln e di avere accompagnato quest’ultima da Washington a Chicago; dichiara inoltre di avere visto l’effigie di cera di Jefferson Davis esposta al Trophy Hall e di riconoscere l’abito indossato da detto personaggio di cera come un indumento realizzato dalla sottoscritta per la moglie di Jefferson Davis e da lei indossato. Elizabeth Keckley Chicago, 6 giugno 1865 Tre testimoni, inclusa Mrs Bradwell, firmarono il documento dopo di lei, il notaio lo stampigliò e lo sigillò, mostrandolo ai presenti. Esultarono tutti, e in mezzo alla confusione Elizabeth riuscì a defilarsi, agitata e senza fiato, non prima di aver visto Mrs Bradwell che attaccava il documento firmato e autenticato sulla teca. Il giorno dopo rimase sorpresa e addolorata leggendo il resoconto della sua avventura sull’Evening Journal di Chicago. La dichiarazione di Elizabeth era stata riportata per intero, e l’articolo diceva che, dopo la sua conferma circa l’autenticità dell’abito, diecimila visitatori avevano speso un totale di duemilacinquecento dollari in biglietti della lotteria per sperare di vincere l’indumento. «Duemilacinquecento dollari» ripeté ad alta voce Elizabeth, colpita. Decise che il suo breve imbarazzo era andato a buon fine, perché aveva contribuito a raccogliere una bella somma di denaro per una buona causa. Verso la metà di giugno il denaro che era stato versato a Mary Lincoln per pagare i servizi di Elizabeth si esaurì, e la vedova non poté più provvedere al vitto e all’alloggio dell’amica. La implorò di restare ancora un po’, ma la sarta, che aveva nostalgia di casa ed era preoccupata per la sua attività, era segretamente sollevata che quei soldi fossero finiti. Nel frattempo era riuscita a convincere Mrs Lincoln a lasciare di tanto in tanto le sue stanze per prendere un po’ d’aria, e mentre il giorno della partenza si avvicinava passeggiavano insieme in un parco non lontano al quale la vedova Lincoln si era affezionata, oppure sul lungolago, dove tirava un bel venticello fresco. L’ultimo giorno che trascorsero insieme Mrs Lincoln era malinconica e incline al pianto, e siccome Elizabeth sapeva che nulla di ciò che avrebbe potuto dire avrebbe attenuato il suo dispiacere, parlò poco, limitandosi ad ascoltare le lagnanze dell’amica. «Mi sembra quasi di trovarmi in riva al mare» commentò con voce triste Mrs Lincoln guardando il lago. «Quanto è largo, secondo voi?» «Credo più di cento chilometri». «Non c’è da stupirsi allora che non riesca a vedere la sponda opposta». Mrs Lincoln sospirò profondamente, abbattuta. «Le mie amiche pensavano che qui sarei stata più tranquilla che in città, nei mesi estivi, e avevano ragione, ma sarà fin troppo calmo senza di voi, Lizzie». «Se potessi restare, lo farei». Elizabeth era sincera. E non era necessario ferire l’amica aggiungendo di sentirsi sollevata sapendo che sarebbe stato impossibile. «Ditemi, come posso continuare a vivere senza mio marito?» esclamò a un tratto. «È il mio primo pensiero ogni mattino, e quando guardo le onde del lago turbolento sotto le nostre finestre talvolta mi dico che mi piacerebbe inabissarmi». Elizabeth avvertiva un brivido ogni volta che Mrs Lincoln parlava in quel modo, ma ribatté con fermezza: «Pensavate di non poter continuare dopo la morte di Willie, invece ce l’avete fatta. Avete Tad e Robert che vi danno una ragione per vivere, anche se non vi va più di farlo per voi stessa. Dovete pensare ai vostri figli ed essere forte». Mrs Lincoln respirò profondamente e rabbrividì. «Siete l’unica persona a parlarmi in questo modo. Tad si spaventa quando mi faccio prendere dalla disperazione, e Robert perde la pazienza. Siete l’unica amica buona e dolce che mi è rimasta, e non so come farò senza di voi». «Forse avreste più amici se permetteste loro di venirvi a trovare, invece di mandarli via». La vedova restò in silenzio per lunghi istanti. «Immagino che non abbiate torto». Lanciò un’occhiata implorante all’amica. «Promettetemi che se il Congresso mi concede una pensione che mi consenta di pagarvi le spese, verrete con me a rendere visita alla tomba di mio marito il primo anniversario della morte». «Ve l’ho già promesso» le ricordò Elizabeth con un sorriso affettuoso, «ma se vi solleva sentirmelo dire di nuovo, ve lo ripeto. Lo prometto». «E promettete di scrivere». «Sì, ma...» La sarta ebbe un’esitazione. «Confesso di non essere brava in questo». «Lo credete voi, ma non è vero» dichiarò la vedova con una traccia della determinazione di un tempo, «e comunque è lo stesso. Scrivete ogni volta che potete». Elizabeth promise. 14. Giugno 1865 - settembre 1866 A metà giugno Elizabeth tornò a Washington accompagnata dai migliori auguri di Mrs Lincoln per la ripresa della sua attività commerciale. L’ex first lady inoltre assicurò all’amica che la considerava ancora la sua sarta personale, sebbene centinaia di chilometri le separassero. «Conoscete il mio corpo quanto me, ormai» osservò la vedova. «Vi chiederò ancora di confezionarmi degli abiti, quando ne avrò l’occasione e quando potrò permettermelo. Devo insistere perché siate voi l’unica a metterci mano, come avete sempre fatto; non sarò più la first lady, e sono sicura che le vostre assistenti siano bravissime, ma certo non sono in grado di eguagliarvi». «Considererò sempre un grande privilegio occuparmi personalmente dei vostri abiti» le assicurò la sarta. Il viaggio in treno verso est fu lungo e faticoso, ma ogni chilometro la avvicinava a casa. Vedere la porta d’ingresso della pensione di Twelfth Street la riempì di gioia, e quando si avvicinò Virginia e Walker corsero fuori a salutarla, prendendole la borsa da viaggio, abbracciandola e dicendole quanto fossero contenti di rivederla. Dopo che ebbe ripreso possesso della sua stanza, che Virginia aveva gentilmente arieggiato e ripulito in previsione del suo arrivo, accettò l’invito della coppia e si unì a loro per la cena. Quando ebbero finito di mangiare e i bambini si furono alzati da tavola, la piccola Alberta in braccio a Jane e Lucy al seguito, Virginia e Walker interrogarono Elizabeth sul periodo trascorso a Chicago e sui suoi programmi. «Per prima cosa intendo salvare la mia attività di sartoria» disse. «Devo sbrigare alcune faccende alla Casa Bianca per conto di Mrs Lincoln, e naturalmente voglio riprendere il lavoro alla Freedmen and Soldiers’ Relief Association». L’organizzazione caritatevole che aveva fondato per aiutare gli ex schiavi rifugiatisi a Washington aveva cambiato nome nel 1864, per tener conto dei mutamenti intervenuti e dell’emancipazione. «Hai mandato un biglietto da visita alla famiglia del presidente Johnson?» si informò Walker. «O forse coglierai l’opportunità quando passi alla Casa Bianca per sbrigare gli incarichi che ti ha assegnato Mrs Lincoln?» «Non intendo proprio farlo» ribatté Elizabeth. «Non ho nessun desiderio di lavorare per la famiglia del nuovo presidente». «Perché no?» chiese Virginia. «Mrs Lincoln era la tua cliente migliore. Perché non dovresti voler lavorare per la nuova first lady?» «Anzi, per tutte e tre» puntualizzò Walker. «Si dice che Mrs Johnson sia spesso indisposta, e che siano le sue due figlie a svolgere le funzioni di rappresentanza alla Casa Bianca». «È forse questo il problema?» chiese Virginia, sorridendo quasi a mostrare che stentava a crederci. «Troppe first lady da compiacere e troppo lavoro?» «No, non è per questo». Com’era bello ritrovarsi tra amici e lasciarsi canzonare... «Mr Johnson non è mai stato un amico per il presidente Lincoln, e non ha riservato alla vedova Lincoln la benché minima cortesia nel momento della tragedia». «Non devi mica cucire per lui» osservò Walker. «Sua moglie e le sue figlie non hanno fatto nulla di male». Elizabeth esitava. Walker aveva ragione, ma lei non riusciva a vincere la propria riluttanza. Si sarebbe sentita sleale nei confronti di Mrs Lincoln se avesse lavorato per colei che aveva preso il suo posto. Inoltre, se avesse ripreso a fare la sarta alla Casa Bianca, era probabile che incontrasse il presidente Johnson con la stessa frequenza con cui aveva incrociato il presidente Lincoln, mentre non aveva nessuna voglia di trascorrere del tempo con lui. Si concesse un giorno per riposare e riprendersi dal viaggio, poi si recò alla Casa Bianca per occuparsi delle faccende di Mrs Lincoln. Oltrepassò la porta principale con il cuore colmo di ansia, perché ogni immagine, ogni odore le ricordavano intensamente il passato. Dentro, scoprì che i nuovi occupanti avevano già cambiato l’arredamento, e che erano in corso altri lavori di restauro. Nuove tinteggiature da una parte, nuova carta da parati dall’altra. L’imbottitura rovinata o macchiata di certi mobili era stata nascosta sotto fodere di lino. I pavimenti, le porte e i rivestimenti delle pareti di legno erano stati lucidati e ridipinti. Osservando la scena, Elizabeth ricordò gli sforzi fatti da Mary Lincoln per abbellire e rimodernare la residenza; tutto quel lavoro era stato vanificato da personale senza scrupoli e visitatori avidi che si erano portati via dei tesori. Quando la sarta ebbe svolto il proprio compito, cosa che fece il più rapidamente possibile, se ne andò, sperando di avere varcato per l’ultima volta quell’ingresso. Elizabeth aveva promesso a Mrs Douglas che le avrebbe creato il corredo primaverile tanto atteso non appena fosse tornata da Chicago, e così, dopo aver incaricato Emma di portare messaggi alle sue clienti preferite per informarle del suo ritorno al lavoro, passò da Mrs Douglas per avvisarla che contava di mantenere la parola data e mettersi al lavoro. La cliente parve felice di vederla, ma anche sorpresa. «Mrs Keckley!» esclamò. «Siete davvero voi? Non sapevo che avreste fatto ritorno tanto presto. Si diceva che sareste rimasta con Mrs Lincoln tutta l’estate». Elizabeth ammise che avrebbe dovuto trattenersi più a lungo. «La vedova sarebbe stata contenta di tenermi con sé ancora, se avesse potuto». «Se avesse potuto?» le fece eco la donna. «Cosa intendete?» «Solo che si trova in condizioni economiche particolarmente difficili, e che riusciva a malapena a pagare le spese per me ma non a remunerarmi». «Ciò che dite mi sorprende. Credevo che avesse tutto il necessario». «Lo credono in molti, purtroppo» ribatté Elizabeth con aria triste. «Vi assicuro che deve fare economie su tutto». Raccontò degli sforzi vani, da parte dell’ex first lady, per ottenere una pensione dallo stato, e dei ritardi amministrativi che le impedivano ancora di entrare in possesso dell’eredità. Nei giorni e nelle settimane a venire Elizabeth avrebbe raccontato le disgrazie di Mrs Lincoln a conoscenti comuni e clienti comprensive: a Mrs Lee, a Mrs Welles, a chiunque fosse abbastanza disponibile da stare ad ascoltare e da difendere la sua causa presentandola a mariti o amici potenti. Se la verità sulla situazione della vedova Lincoln fosse diventata di pubblico dominio, forse il Congresso si sarebbe sentito costretto a prendere posizione e ad accordarle una pensione. Dopo avere iniziato a lavorare al corredo di Mrs Douglas, Elizabeth radunò le sue assistenti, lucidò la targa e, con suo grande sollievo, diede nuovo impulso alla sua attività, che riprese al ritmo di prima. Quando a Washington si diffuse la notizia del suo ritorno, cominciarono ad arrivare più ordini di quanti la sarta non riuscisse a evaderne. Un giorno di fine giugno, la ragazza incaricata di aprire la porta andò a cercare Elizabeth nella stanza riservata al taglio dei tessuti, dove stava tagliando la stoffa per uno splendido abito di seta rosa. «Mrs Keckley» esordì la sua assistente più giovane, «c’è giù una signora che desidera parlarvi». Interrotta in un momento particolarmente difficile del taglio, la sarta portò a termine l’operazione prima di rispondere. «Chi è?» «Non lo so. Non mi ha detto il nome». Non amava interrompersi a quel punto del lavoro, ma non voleva nemmeno rischiare di offendere una cliente importante. «Il suo viso è familiare? È una cliente abituale?» La ragazza scosse il capo. «No, non l’ho mai vista. Credo che non sia mai venuta. È in una carrozza scoperta, con una serva nera». «Potrebbe essere la moglie di uno dei nuovi ministri di Johnson» ipotizzò Emma. «Andate a vedere, Mrs Keckley» la esortò un’altra aiutante. La loro curiosità aveva stimolato anche la sua, così posò le forbici, tolse i fili che le si erano appiccicati alla gonna e scese. Quando entrò in salotto, una donna alta, bruna, vestita con semplicità si alzò e chiese: «Siete la sarta, Mrs Keckley?» «Sì» replicò lei. «Sono io». «Eravate la sarta di Mrs Lincoln, vero?» «Sì, ho lavorato per lei». La donna sorrise. «Siete molto occupata ora?» Elizabeth allargò le braccia e scoppiò a ridere, indicando il laboratorio dietro di lei, dove il suono prodotto dalle sue assistenti che lavoravano non lasciava adito a dubbi. «Molto». «Potete fare qualcosa per me?» «Dipende da cosa e da quando vi serve». La donna si picchiettò sul mento con l’indice, pensando. «Mi occorrerebbe un vestito ora, e diversi altri fra qualche settimana». Elizabeth ripassò mentalmente gli impegni che si era già assunta. «Posso farvi un vestito ora, ma non di più» rispose con una traccia di dispiacere nella voce. «E non sarà pronto prima di tre settimane». «Andrà bene» dichiarò la donna con voce allegra e sicura di sé. «Sono Mrs Patterson, la figlia del presidente Johnson. Aspetto mia sorella, Mrs Stover, fra tre settimane, e il vestito è per lei. Abbiamo la stessa taglia, quindi vado bene io per le prove». Per un attimo Elizabeth rimpianse di non averle chiesto il nome prima di accettare di lavorare per lei, ma presto giunsero a un accordo soddisfacente per entrambe. Dopo che la sarta le ebbe preso le misure, la nuova cliente le augurò buona giornata, risalì in carrozza e se ne andò. Quando Elizabeth tornò in laboratorio, le sue assistenti erano ansiose di sapere chi fosse la visitatrice. «Era Mrs Patterson» rispose. «La figlia del presidente Johnson». «Cosa?» esclamò una delle ragazze. «La figlia del nostro buon Mosè?3 Intendete lavorare per lei?» Quando Elizabeth parlò, le parve un’ammissione di colpevolezza. «Ho accettato l’ordine». «Temo che Johnson sarà un Mosè molto scadente» decretò Emma accigliata, «e se fosse per me non lavorerei per nessun membro della sua famiglia». Diverse altre assistenti mormorarono il proprio assenso. Fino a quel momento Elizabeth non si era resa conto di quanto poco fosse amato il successore del presidente Lincoln. Che l’ex first lady non lo apprezzasse lo sapeva bene, e tutta Washington pensava che avesse fatto una pessima impressione arrivando ubriaco al proprio insediamento. Ma da quando era diventato presidente, la sarta era rimasta chiusa con la first lady in lutto nelle sue stanze della Casa Bianca oppure a centinaia di chilometri di distanza. Sapeva ben poco delle iniziative che aveva preso o dei discorsi che aveva tenuto nelle ultime settimane, ma chiaramente non era riuscito a conquistarsi le simpatie delle donne che lavoravano per lei. Si chiese se si sarebbe rivelato un capo poco carismatico come Emma lo aveva dipinto, oppure se le sue aiutanti avevano semplicemente dei pregiudizi nei suoi confronti perché non era Lincoln, il “grande emancipatore” che avevano tutte ammirato e rispettato. Quello, si disse con un senso di pietà nei suoi confronti, non era colpa sua, e non andava condannato per tale motivo. In breve tempo finì l’abito per Mrs Patterson – o meglio, per la sorella – e fu felice che venisse apprezzato. Accettò di confezionare altri vestiti per le due sorelle, e durante l’estate scoprì che Mrs Patterson e Mrs Stover erano entrambe gentili, semplici e modeste, che non avevano alcuna pretesa di eleganza. Un giorno, presentandosi alla Casa Bianca, trovò Mrs Patterson al lavoro con la macchina da cucire. Quella novità la stupì perché, sebbene Mrs Lincoln sapesse cucire e avesse posseduto una bella macchina in una robusta custodia di sequoia, placcata d’argento e con intarsi di madreperla e smalto, Elizabeth non l’aveva mai vista usarla, né ricordava di aver sorpreso l’ex first lady con un ago in mano. Ma per quanto le due sorelle fossero gentili e amabili con lei, Elizabeth non si sentì mai a suo agio a lavorare per loro. Vedeva solo di rado Mr Johnson, quindi non era lui il problema, sebbene non riuscisse a dimenticare lo sgarbo che aveva fatto a Mrs Lincoln quando non le aveva fatto le condoglianze dopo la morte del marito. Non riusciva a varcare la soglia della Casa Bianca senza ricordare le ore piacevoli trascorse fra quelle mura, o la calorosa familiarità che il presidente le aveva sempre dimostrato. Le mancava il momento in cui cominciava a progettare con Mrs Lincoln un nuovo abito favoloso, perché le due sorelle non si interessavano alla moda e preferivano vestiti semplici a maniche lunghe, privi di scollatura e con pochi abbellimenti. Le mancava sentirsi chiamare “madame Elizabeth” dal presidente Lincoln, o sentirsi chiedere di domare la sua chioma ribelle prima di scortare la moglie a una serata di gala. Aveva perfino nostalgia delle sue stupide capre ribelli. La Casa Bianca evocava tante di quelle associazioni vivide per lei che a ogni passo, a ogni occasione le tornava in mente il ricordo di un passato migliore del presente. La faceva soffrire trovarsi lì, ora che non c’erano più i coniugi Lincoln. In agosto, Elizabeth aveva appena finito due abiti leggeri di lino, uno per ciascuna delle due sorelle, quando Mrs Patterson le mandò un biglietto chiedendole di andare alla Casa Bianca per confezionare un altro abito più pesante in previsione dell’autunno. In quel momento le venne uno strano impulso: scrisse di rimando un messaggio sbrigativo per comunicare che non lavorava mai fuori dal suo laboratorio. Questo mise fine alle relazioni di lavoro con le figlie del presidente. Emma lanciò a Elizabeth uno sguardo strano quando la sua datrice di lavoro spiegò perché non avrebbero più lavorato per le occupanti della Casa Bianca. «Hai detto loro che non svolgi mai lavori di sartoria fuori dal laboratorio, ma per Mrs Lincoln lo facevi». «Sì, di tanto in tanto, ma la signora non protestava mai quando si trattava di venire qui. Anzi, credo che le piacesse, e perfino che lo preferisse». «Me lo ricordo». Emma la guardò con aria interrogativa. «Ricordo anche di averti sentito ripetere che non amavi che la famiglia del presidente venisse qui da te. Era più consono al loro rango che fossi tu a spostarti». «Ebbene...» Elizabeth fece una pausa, riflettendo, ma non trovò una risposta convincente. «Hai ragione. L’ho detto perché lo pensavo. Anzi, lo penso ancora. Non riesco a spiegare perché ho risposto in quel modo a Mrs Patterson». «Io sì, invece!» esclamò Emma, come se fosse la cosa più ovvia del mondo. «Non vuoi lavorare per loro ma non sapevi come rifiutare». «Devo essere impazzita per fare una cosa del genere» commentò Elizabeth portandosi una mano alla fronte. «Sono clienti gentilissime. Chi mai rifiuta di lavorare per le figlie del presidente?» «La sarta più popolare di Washington, ecco chi». Emma indicò con un gesto il laboratorio in pieno fermento, dove tutte le assistenti stavano cucendo, sedute dritte come la titolare aveva insegnato loro, per evitare dolori alla schiena e al collo. «Non sei pazza né ti sei comportata in modo impertinente. Non hai rifiutato di lavorare per Mrs Patterson; hai accettato, purché il taglio del tessuto e le prove avvenissero qui, e lei ha rifiutato». Elizabeth sospirò. «Immagino che sia un modo di vedere la situazione». «È l’unico modo». Emma le sorrise teneramente e scrollò il capo. «Puoi sceglierti le clienti, Elizabeth, e permetterti di essere schizzinosa». Guardandosi attorno nel laboratorio, si disse che forse era vero. A fine estate l’attività si era sviluppata a tal punto che Elizabeth aprì una seconda bottega. La fitta corrispondenza con Mrs Lincoln rivelava che per lei le cose andavano molto meno bene. Non fece quasi nessuna allusione al processo di giugno e all’esecuzione, in luglio, dei quattro cospiratori condannati all’impiccagione per il ruolo avuto nell’assassinio del marito, mentre si dilungò nel parlare all’amica della morte del dottor Anson Henry, uno dei pochi amici dei tempi di Springfield a non averla abbandonata. «Non dimenticherò mai le sue attenzioni e la sua sollecitudine nell’occuparsi di me nelle settimane seguenti la morte del mio adorato marito» scrisse abbattuta. «Pensare che sia scomparso anche lui mi è quasi insopportabile». Mrs Lincoln vedeva allontanarsi anche la prospettiva di poter esercitare un controllo sul retaggio lasciato dal marito. Aveva vinto una prima battaglia significativa quando, contro il parere dei dignitari dell’Illinois, aveva imposto lei il luogo del memoriale e della tomba dell’ex presidente, ma si stava preparando una nuova prova, contro un avversario che Mary Lincoln non aveva saputo prevedere. L’ex socio del marito a Springfield, l’avvocato William H. Herndon, aveva in mente di scrivere un libro pieno di rivelazioni sulla “vita interiore” del presidente, e si era messo a fare domande ad amici e conoscenti di Abraham Lincoln per ottenere confidenze. La vedova rimase male quando seppe dell’iniziativa di Herndon, ma suo figlio Robert fu profondamente scandalizzato. Un conto era sottoporre a scrutinio un politico, dichiarò, perché esporre la propria vita agli sguardi della gente era il prezzo da pagare quando si desiderava ricoprire una carica pubblica di quella portata. Un’altra cosa era sottoporre moglie e figli a un esame minuzioso e inopportuno, costringerli a vivere “sotto vetro”. Nel frattempo, Mrs Lincoln non aveva subito minimamente il fascino di Hyde Park. «Sono depressa» scrisse a fine luglio. «Resto chiusa nelle mie stanze, dalle quali esco solo per una passeggiata nel parco, ogni tanto, e naturalmente non vedo nessuno, essendo relegata sulle sponde remote del lago Michigan». In agosto lasciò l’Hyde Park Hotel per trasferirsi a Clifton House, un residence rispettabile nel centro di Chicago, tra Wabash Avenue e Monroe Street. Tad fu iscritto a scuola ed era deciso a colmare il ritardo accumulato rispetto ai suoi coetanei, e Robert diventò praticante da Scammon, McCagg & Fuller, un importante studio legale. Qualunque soddisfazione procurata dalla nuova residenza e dai successi dei figli era obnubilata dalla sofferenza che la attanagliava. Abbattuta e sola, Mrs Lincoln era terrorizzata dalla minaccia della povertà e dei debiti, e sembrava che non riuscisse a pensare a nient’altro. I suoi creditori avevano esitato a sollecitarla per i conti in sospeso finché era stata first lady, ma di recente cominciavano a minacciare di denunciarla e di pubblicare sul giornale le liste dei suoi debiti. Scrisse agli amici, agli ex dipendenti della Casa Bianca, ai membri della Camera dei rappresentanti perorando la sua causa e chiedendo loro di usare la propria influenza per aiutarla; Elizabeth immaginava benissimo il tono ora disperato, ora arrogante, ora carezzevole, ora insistente delle sue lettere. Anche se Horace Greeley, direttore del New York Tribune e critico frequente del marito, l’aveva stupita promuovendo una sottoscrizione per raccogliere fondi per «la vedova inconsolabile del defunto presidente e per i suoi figli rimasti orfani di padre», tutti i suoi sforzi parvero vani. Nelle sue lettere, Elizabeth offriva a Mrs Lincoln tutto l’incoraggiamento e il conforto che poteva, ma non bastava mai. Era una vergogna nazionale, pensava indignata, che lo stato non si occupasse in modo adeguato della vedova del presidente Lincoln. Questi aveva dato la vita per il suo paese alla stregua di un soldato, proprio come il suo George, e il minimo che lo stato doveva fare era provvedere al sostentamento della vedova e dei figli, come faceva per i suoi soldati. In autunno una donna – una sconosciuta, pensò Elizabeth – andò a trovarla alla pensione. «Siete sorpresa di vedermi, lo so» esordì la donna allegramente. Non era una cliente, né qualcuno che avesse conosciuto a Washington, eppure il suo viso era familiare. «Arrivo ora da Lynchburg, e quando ho lasciato mia cugina Anne le ho promesso di venire a trovarvi se fossi arrivata a Washington». La donna fece un sorriso radioso, allargando le braccia. «Ed eccomi qui, come promesso». «La cugina Anne?» ripeté Elizabeth smarrita. «Scusatemi, ma...» «Oh, non mi avete riconosciuto» comprese lei. «Sono la moglie del generale Longstreet, ma da ragazza mi conoscevate come Bettie Garland». «Bettie Garland!» esclamò la sarta. Era la cugina del suo ex padrone, Hugh Garland, e andava spesso a trovare la famiglia nella loro casa vicino a Dinwiddie Court House in Virginia. «Siete davvero voi?» La donna annuì raggiante, e si strinsero le mani, felici entrambe per quell’incontro inaspettato. «Sono così contenta di vedervi» disse Elizabeth, offrendo una sedia alla sua ospite e sedendosi pure lei. Dopo essersi affrancata era rimasta in contatto con l’ex padrona e i suoi figli – soprattutto con le figlie femmine, che aveva allevato e alle quali si era molto affezionata –, ma i rapporti si erano interrotti allo scoppio della guerra. La sarta si era chiesta spesso che fine avessero fatto, anche se, quando li nominava preoccupandosi per la loro sorte, gli amici del Nord alzavano gli occhi al cielo, domandandosi come facesse ad avere pensieri gentili per coloro che l’avevano tenuta in catene. Elizabeth, per quanto ci avesse provato, non riusciva a far capire loro che, nonostante le gravi ingiustizie subite, e pur senza perdonarle, provava un affetto profondo e duraturo per alcuni membri delle famiglie che l’avevano tenuta come schiava, anche se non per tutti. «Dove vive ora Miss Anne?» «Ah! Ero sicura che non vi sareste dimenticata dei vecchi amici» disse Mrs Longstreet. «Mia cugina Anne vive a Lynchburg. Tutta la famiglia è in Virginia. Si sono trasferiti lì durante la guerra». Poi la sua allegria si spense. «Fannie è morta. Nannie è diventata una donna e si è sposata con il generale Meem. Hugh Junior è rimasto ucciso in guerra, e ora restano solo Spotswood, Maggie e Nannie». «Fannie è morta?» Fannie era la terza figlia dei Garland ed era stata molto legata alla madre di Elizabeth, che le aveva fatto da bambinaia. «E povero Hugh! Portate notizie tristi oltre che liete». Pensò a Nannie, della quale si era occupata lei personalmente. Aveva condiviso il letto di Elizabeth, ed Elizabeth l’aveva accudita come se fosse stata sua figlia. «Non riesco a crederci. Era solo una bambina l’ultima volta che l’ho vista». «Sì, Nannie è sposata con un gentiluomo. Il generale Meem appartiene a una delle migliori famiglie della Virginia. Ora vivono a Rude’s Hill, dopo Winchester, nella Shenandoah Valley. Desiderano tutti vedervi». «Sarei felice di andare a trovarli» dichiarò Elizabeth. «Miss Bettie, non riesco a credere che siate la moglie del generale Longstreet. Pensate, in questo momento sedete proprio sulla sedia e nella stanza dove è venuta spesso Mrs Lincoln!» «È stato un grosso cambiamento, Lizzie» ammise con un sorriso amaro. «Non si sa mai cosa porti il domani. Dopo aver combattuto tanto a lungo contro gli yankee, oggi mio marito è a Washington a chiedere perdono, e a proporre di vivere in pace con gli Stati Uniti». Elizabeth era molto felice di saperlo. Aveva molte domande sui vecchi amici, e il tempo passò veloce, ma presto la visita di Mrs Longstreet giunse al termine. Prima di andarsene diede a Elizabeth l’indirizzo dei Garland, e l’indomani la sarta scrisse loro, raccontando della sua vita a Washington ed esprimendo la speranza di vederli presto. Quando raccontò a Virginia e a Emma della visita di Mrs Longstreet e delle lettere che aveva spedito a Miss Anne e alle sue figlie, Emma scosse il capo incredula, accigliandosi. «Non capisco perché ti manchino tanto. Io non vorrei vedere mai più i miei padroni, uomini o donne». «Non provo il desiderio di rivedere tutti i miei padroni» le fece notare Elizabeth. «Alcuni di loro non riesco a perdonarli. Ma capisco come ti senti, Emma. La separazione dai tuoi ultimi padroni è stato un momento particolarmente doloroso. Non avrebbero mai dovuto rifiutare di adeguarsi alle ultime volontà della vostra proprietaria, e se li avete trascinati in tribunale la colpa è solo loro. Io me la sono comprata, la libertà. Forse la differenza sta lì». «Spero che non rimarrai delusa, Elizabeth» disse Virginia, prendendo un’aria preoccupata. «Ho paura che la tua vecchia padrona e le sue figlie ti abbiano dimenticata. Sono tutte uguali, troppo egoiste per pensare a te, ora che non sei più la loro schiava». «Forse» concesse la sarta, «ma voglio crederci. In fin dei conti, hanno chiesto a Miss Bettie di prendere mie notizie. Non conoscete bene quanto me la gente del Sud. Pur in un rapporto di padrone e schiava, eravamo legati da affetto sincero». Virginia ed Emma si scambiarono uno sguardo dubbioso, ed Elizabeth sospettava che avrebbero potuto dibattere sull’argomento all’infinito senza che le sue amiche capissero il suo punto di vista. «Hai idee strane, Elizabeth» osservò Emma scuotendo il capo. Di tutte le sue conoscenze, solo Mrs Lincoln sembrava comprendere quell’affetto duraturo. «Ma certo che i Garland non vi hanno dimenticato» scrisse a Elizabeth dopo che la sarta le ebbe raccontato della visita di Mrs Longstreet. «Io non ho mai scordato la mia amata Sally, e quanto si sia occupata di me quando ero piccola. Non intendo parlare male di mia madre affermando che fu Sally a crescermi. Dopo la morte di mia madre, non so cos’avrei fatto senza di lei, perché la nuova moglie di mio padre considerava noi figli acquisiti come un peso, e si occupava esclusivamente della propria prole. No, Elizabeth, non possono avervi dimenticato». Rincuorata, la sarta aspettò ansiosamente una risposta alle sue lettere, e non dovette attendere molto. Si sentì felice ricevendo la prima di molte e lunghe missive che le giunsero da parte di vari membri della famiglia, tutte traboccanti d’affetto. Per mesi si scambiarono lettere, e l’inverno seguente Miss Nannie – ora moglie del generale Meem – le scrisse dicendo che lei e il marito sarebbero stati molto contenti di ospitarla l’estate successiva. «Dovete venire da me, cara Elizabeth» la implorava Nannie. «Muoio dalla voglia di vedervi. Ora viviamo a Rude’s Hill. Ma, Maggie, Spot e Minnie, la figlia di mia sorella Mary, sono con me. Mancate solo voi per chiudere il cerchio. Venite, non accetterò una risposta negativa». Elizabeth fu felice di accettare, e dopo essersi consultata con Emma e aver calcolato lo stato degli ordini nei mesi a venire, rispose a Nannie dicendole che sarebbe andata da loro in agosto. Mrs Lincoln era felice per lei, ma delusa per il fatto che qualcun altro si apprestasse a godere della compagnia dell’amica. Nel corso dell’autunno aveva tentato di vendere alcuni gioielli e vari oggetti preziosi, e di restituirne altri nei negozi dove erano stati acquistati, ma era stato tutto inutile. Poco prima di Natale, il Congresso la informò che non le avrebbe elargito tutto lo stipendio del secondo mandato del defunto marito, come lei aveva chiesto, ma solo il salario di un anno, che dopo le deduzioni ammontava a poco più di ventiduemila dollari, una piccola frazione dei suoi debiti. Più tardi, quell’inverno, il Congresso accordò al presidente Johnson settantacinquemila dollari per arredare la Casa Bianca, e sul World, giornale di New York, apparvero critiche umilianti nei confronti di Mrs Lincoln che, si diceva, si era lasciata dietro una villa svaligiata e una montagna di debiti presso molti negozianti della città. Mr Herndon, intanto, era riuscito ad accumulare lettere, interviste e dichiarazioni da persone che avevano conosciuto il presidente Lincoln – alcune bene, altre quasi per niente – e stava tenendo conferenze basate sul materiale raccolto, che sperava di pubblicare in forma di libro. Confidando ancora di riuscire a intervistare la vedova Lincoln, aveva mandato la sua richiesta a Robert, ma lui e la madre erano rimasti perplessi di fronte alla formulazione: «Intendo renderle completamente giustizia, affinché il mondo comprenda meglio la situazione. Voi mi capite». Mrs Lincoln non capiva nulla, invece, confessò agitata a Elizabeth. «Ha un tono minaccioso che non mi piace per niente. Eppure, forse dovrò risolvermi a parlargli. Se non gli racconto la mia verità, potrebbe inventarsi qualcosa da solo». Ancora peggiori erano stati gli anniversari che evocavano tristi ricordi per la vedova: 4 novembre, primo anniversario di nozze senza suo marito; 13 dicembre, il suo quarantasettesimo compleanno; 21 dicembre, compleanno di Willie; 1° gennaio, che segnava l’inizio di un nuovo anno senza le persone care di cui piangeva la morte; 1° febbraio, data della morte del figlio Eddie; 12 febbraio, compleanno di Abraham Lincoln. Tutte queste ricorrenze dolorose erano solo la preparazione per il giorno peggiore di tutti, quello più straziante: il 15 aprile, data dell’assassinio del marito. Soffrì molto anche il 30 marzo, Venerdì Santo, perché il presidente era stato assassinato proprio la sera del Venerdì Santo. «Sono desolata e non penso che riuscirò a superare questa giornata senza avervi al mio fianco» scrisse a Elizabeth mentre la fine di marzo si avvicinava. Ricordò alla sarta la promessa fatta al momento della partenza da Chicago: se il Congresso le avesse accordato una pensione in quanto vedova, l’amica sarebbe tornata e l’avrebbe accompagnata a Springfield a visitare la tomba del marito per l’anniversario della sua morte. Il denaro non le fu accordato, quindi Elizabeth non poté andare. La vedova fece il pellegrinaggio con Tad, organizzando il viaggio a orari strani e lungo strade secondarie per evitare di imbattersi in vecchi amici. Elizabeth non poté andare in Illinois quella primavera, ma andò in Virginia d’estate. Il 10 agosto, il quarto anniversario della morte di suo figlio George, salì a bordo del treno diretto ad Harpers Ferry, ansiosa di ritrovare la famiglia Garland. Il viaggio non fu privo di inconvenienti. Il treno arrivò ad Harpers Ferry di notte; Elizabeth dormiva quando entrò in stazione, si ritrovò alla fermata successiva e dovette aspettare un altro treno che la riportasse indietro. A quel punto avrebbe dovuto prendere la coincidenza per Winchester, ma l’aveva persa e dovette aspettare un altro giorno. Giunta infine a Winchester, scoprì che l’unico modo per arrivare a Rude’s Hill era prendere una serie di diligenze. Il tragitto iniziò di sera e sarebbe durato tutta notte, ma la sarta era così stanca che faticava a tenere gli occhi aperti. Un giovane gentiluomo a bordo della stessa diligenza disse a Elizabeth che conosceva bene il generale Meem e che le avrebbe indicato il punto dove scendere. Rassicurata, la donna si abbandonò al sonno. «Signora». Qualcuno la stava scuotendo. «Signora, non dovevate scendere a Rude’s Hill?» «Sì». Si rizzò a sedere strofinandosi gli occhi. «Siamo arrivati?» Mentre parlava, le cadde lo sguardo sul giovane che aveva promesso di svegliarla, e scoprì che stava russando piano. «A dire il vero» rispose l’uomo che l’aveva destata, «l’abbiamo passata da un po’». «Passata?» «Sì, dieci chilometri fa. Non avreste dovuto dormire tanto profondamente, signora». «Perché non me l’avete detto prima?» chiese lei risentita. «Ho fretta di arrivare». «Me lo sono dimenticato» rispose lui con un’alzata di spalle. «Ma non c’è problema. Scendete in questo villaggio e troverete un mezzo per tornare indietro». Elizabeth non aveva scelta e dovette fare così. La cittadina, New Market, era in uno stato di triste abbandono, che tradiva la distruzione operata dalla guerra. Dopo essere scesa e avere recuperato la sua borsa da viaggio, trovò un albergo, poco più che una casa, dove poté prendere un caffè e fare mente locale. Quando si informò su come arrivare a Rude’s Hill, il proprietario le disse che la diligenza sarebbe tornata quella sera. «Questa sera?» Si sentì in preda allo sconforto. Era solo l’alba. «Voglio andarmene il prima possibile. Morirò, se mi tocca restare tutto il giorno in questo posto desolato». Non intendeva insultare i residenti del borgo, ma fortunatamente ben pochi di loro erano presenti e poterono sentire. Il proprietario alzò le spalle dicendo di non poter fare nulla per lei, così Elizabeth si preparò a una lunga attesa, profondamente delusa. Era lì da poco, a sorseggiare il caffè ormai quasi freddo, quando il nero dietro il banco le si avvicinò. «Mi dispiace per l’inconveniente, signora». Riuscì a fargli un debole sorriso. «Molto gentile da parte vostra». «Conosco la proprietà del generale Meem. Posso accompagnarvici tra un’ora circa». Elizabeth colse l’occasione al volo. «Davvero? È la migliore notizia che abbia avuto da diversi giorni a questa parte». L’uomo le assicurò che sarebbe stato un piacere, e lei lo ringraziò e lo pregò di partire il prima possibile. Finì il caffè e attese fuori dalla porta dell’hotel che il generoso accompagnatore andasse a prendere il carro. Mentre aspettava, lottando per nascondere l’impazienza, una donna anziana e corpulenta la vide dall’altro lato della strada e si avvicinò arrancando per salutarla. «Non siete Elizabeth?» «Sì, sono io» rispose, stupita che la sconosciuta sapesse il suo nome. «Come pensavo». La donna sorrise, mostrando che le mancavano diversi denti. «Vi aspettano da due settimane, a Rude’s Hill, e non parlano che di voi. Mrs Meem era in città ieri, e diceva che sareste arrivata certamente questa settimana. Saranno felici di vedervi». A quelle notizie Elizabeth si rincuorò. «E io sarò ancora più lieta di vedere loro». «Questo non lo so» ribatté la donna con un riso chioccio. «Hanno tenuto acceso un lume alla finestra davanti per dieci notti, in modo che vedeste facilmente la casa se foste arrivata di notte». «Grazie!» esclamò la sarta, sentendosi molto meglio. «Fa piacere sapere di essere attesi. Mi sono addormentata nella diligenza e non ho visto la luce, e così mi trovo qui invece che a Rude’s Hill, dove dovrei essere». Mentre la donna ridacchiava solidale, l’uomo dell’hotel giunse con il carro. Elizabeth salì a bordo e imboccarono la strada verso la residenza di campagna del generale Meem. «Ecco Rude’s Hill» annunciò l’uomo, indicando con un cenno un’altura verde circondata dagli alberi. La sarta si schermò gli occhi con la mano mentre risalivano lungo il pendio, ansiosa di vedere al più presto le sue vecchie conoscenze. Scorse un ragazzo nel cortile davanti alla residenza, fece un rapido calcolo e capì che doveva essere Spotswood, o Spot, come lo chiamavano tutti. Non lo vedeva da otto anni, ma quando gli fece un cenno lui cacciò un grido di gioia e si avvicinò di corsa. Il suo urlo esultante attirò l’attenzione del resto della famiglia, che si trovava in attesa dinanzi alla finestra o sulla veranda ma che si precipitò subito verso il carro. «È Elizabeth! È Elizabeth!» li udì gridare felici, e ansiosa di riunirsi a loro fece un passo e raggiunse la cima della scaletta. Quando volle saltare, però, il cerchio della sottogonna si impigliò in uno dei pioli e lei rovinò a terra. «Elizabeth!» esclamò qualcuno. Le bruciavano i palmi delle mani e il ginocchio le doleva per il colpo subito, così rimase lì qualche istante, un po’ stordita, assorbendo l’odore della terra fresca della Virginia con un lieve sentore pungente di letame. Spot la raggiunse per primo e la aiutò ad alzarsi, e un attimo dopo la sarta si trovò fra le braccia di Nannie, Maggie e Mrs Garland. Non ebbe quasi il tempo di ringraziare in modo adeguato il suo accompagnatore perché la trascinarono in casa, si occuparono di pulirle le mani e la gonna sporca, e la fecero sedere in poltrona davanti al focolare. Nel frattempo i domestici stavano a guardare allibiti. Nannie, con un’espressione felice, le si aggrappò alla mano come se non volesse più lasciarla andare. «Elizabeth, non siete cambiata neanche un po’» dichiarò baciandola ancora una volta sulla guancia, gli occhi colmi di lacrime di felicità. «Sembrate giovane come quando ve ne siete andata da Saint Louis, anni fa». «Non posso dire lo stesso di voi» replicò Elizabeth ridendo, «perché siete cresciuta parecchio!» Nannie sorrise orgogliosa e fece un cenno a una donna alta e aggraziata. «Elizabeth, questa è Minnie, Minnie Pappan, la figlia di mia sorella Mary. Avete visto com’è diventata grande?» «Minnie!» esclamò Elizabeth tendendo la mano alla donna, che sorrise, gliela strinse e si sedette su uno sgabello. «Non riesco a crederci. Eravate neonata l’ultima volta che vi ho visto. Mi fa sentire vecchia vedere come siete cresciuta. Miss Minnie, voi siete più alta di vostra madre, la vostra cara mamma che ho tenuto tra le braccia quando è morta». La sarta dovette tacere qualche istante per ricomporsi, asciugandosi una lacrima. «Avete fatto colazione, Elizabeth?» chiese Mrs Garland. Quando Elizabeth scosse il capo i figli risposero in coro che bisognava rimediare subito. «Non è necessario che ci andiate tutti» protestò Mrs Garland ridendo, quando Nannie, Maggie e Minnie si precipitarono in cucina. «C’è la cuoca, preparerà lei da mangiare». Ma le tre giovani non le diedero retta. Corsero in cucina e poco dopo tornarono portando un vassoio con una colazione calda per la loro ospite. Mentre Elizabeth mangiava, la cuoca osservava tutto quel pandemonio dalla soglia, allibita. «Non ho mai visto nulla del genere» dichiarò. «Se me ne andassi per due o tre anni, mi riempireste allo stesso modo di baci e abbracci al mio ritorno?» Le Garland la presero in giro ridendo e dicendo che avevano troppo bisogno di lei per permetterle anche solo di provarci. Poco dopo colazione arrivò il marito di Miss Nannie. «Elizabeth, sono molto lieto di conoscervi» la salutò. «Ho l’impressione che siate una vecchia amica, perché mia moglie parla sempre tanto di voi». «Anch’io» intervenne Maggie. Il generale Meem sorrise. «Sì, anche tu, e tua madre. Benvenuta a Rude’s Hill, Elizabeth». Nei giorni seguenti l’ospite apprese che durante la guerra il generale Stonewall Jackson aveva usato Rude’s Hill come quartier generale, e aveva dormito nella stanza che era stata assegnata a Elizabeth come salotto privato. Il generale Jackson incarnava l’ideale sudista di soldato, e gli ammiratori venivano da ogni dove per rendere omaggio al loro eroe caduto e per visitare i luoghi dove aveva vissuto. Elizabeth osservò che quasi ogni visitatore staccava una scheggia dai muri o dalle finestre del suo salotto, che si portava via come reliquia di valore inestimabile. La piantagione dei Garland era bella, ma le cicatrici lasciate dalla guerra erano visibili dappertutto, in casa e nel paesaggio. Il generale Meem aveva cominciato a piantare diverse specie vegetali, e impiegava molti braccianti nei campi e servitori in casa. La sarta scoprì di essere diventata oggetto di grande curiosità nei dintorni. La sua associazione con il presidente Lincoln, l’attaccamento ai Garland, i suoi ex proprietari, la facevano apparire come l’eroina tragica di un romanzo sentimentale. Elizabeth trovava che fosse stupido, ma non si lamentava. Si trovava bene a Rude’s Hill e i Garland la coprivano di attenzioni. Trascorrevano la giornata cucendo insieme o parlando dei vecchi tempi, e ogni giorno facevano gite in carrozza o a cavallo. Elizabeth e Mrs Garland – che per lei sarebbe sempre stata Miss Anne – ebbero molte conversazioni a tu per tu. Per la prima volta Elizabeth osservò bene il viso della sua padrona di un tempo e scoprì lineamenti simili ai suoi. Si chiese se le lunghe occhiate silenziose che le rivolgeva spesso Miss Anne giungessero alla stessa conclusione. Avevano solo otto anni di differenza, erano figlie dello stesso padre ma le loro vite non avrebbero potuto essere più diverse. Una volta, mentre passeggiavano nel nuovo giardino fiorito che Miss Anne aveva appena cominciato a coltivare, Elizabeth le chiese che fine avesse fatto zia Charlotte, l’unica sorella di sua madre. Era stata la cameriera di Mrs Burwell, la madre di Anne. «È morta, Lizzie» rispose Anne dolcemente. «Diversi anni fa». Sospirò e sembrò tornare al passato con lo sguardo. «Una serva, allora, era ben diversa da una serva ai nostri tempi. Vostra zia puliva il pavimento e mungeva le mucche di tanto in tanto, oltre a sottostare agli ordini di mia madre». «Me lo ricordo» disse Elizabeth, avanzando con le mani dietro la schiena. Pensava di conoscere meglio della sua ex padrona le mansioni svolte dalla zia. «Mia madre era severa con gli schiavi, sotto certi punti di vista, però aveva anche il cuore pieno di bontà». Elizabeth rifletté sulle sue parole. «Pare anche a me». «Un giorno punì vostra zia...» «Per quale motivo?» «Non ricordo cosa avesse o non avesse fatto» ammise Miss Anne, «ma mia madre la punì. Poi però, stanca delle sue occhiate meste, le fece due promesse molto generose, a condizione che ritrovasse il buonumore e non le tenesse il broncio». Dentro di sé, Elizabeth si esaltò per la cocciutaggine della zia. «Cosa promise?» «Primo, che Charlotte sarebbe potuta andare a messa la domenica successiva, e secondo che mia madre le avrebbe regalato per quell’occasione il suo abito di seta». «Davvero generosa» osservò Elizabeth. «Mia zia accettò, immagino». «Oh, certo. Mia madre possedeva un solo abito di seta, perché allora quella stoffa era difficile da trovare, eppure lo diede alla sua serva per fare la pace». Miss Anne scoppiò a ridere compiaciuta. «L’idea di vostra madre funzionò?» chiese l’ospite. «Tornarono a essere amiche?» «Oh, sì, l’idea funzionò, e fortunatamente per mia madre. Due settimane dopo fu invitata a passare la giornata a casa di una vicina, ma quando ispezionò il guardaroba scoprì di non avere nulla da mettere». Elizabeth sentì un sorriso che le spuntava sulle labbra. «Davvero?» Miss Anne annuì divertita. «Aveva una sola alternativa: affidarsi alla generosità di vostra zia Charlotte. Quest’ultima fu convocata, le fu spiegato il problema e la serva propose di prestare l’abito di seta alla sua padrona, che fu ben felice di accettare. Mia madre si presentò quindi indossando l’abito di seta che la sua serva aveva messo in chiesa la domenica precedente». Risero insieme dell’episodio, anche se forse non per le stesse ragioni. «Elizabeth...» cominciò Miss Anne ma poi si interruppe, e camminarono per un po’ in silenzio prima di riprendere il discorso. «Per tutta la guerra ho pensato a voi ogni giorno, e desideravo tanto rivedervi. Quando ho saputo che eravate con Mrs Lincoln, tutti mi dicevano che ero sciocca a pensare che vi avrei rivisto, perché quell’ambiente doveva avervi dato alla testa». «E naturalmente avrete creduto a loro» disse Elizabeth in tono leggero, «perché chi non mi ha mai incontrato sa giudicarmi con saggezza». «Certo che no» protestò Miss Anne. «Vi conoscevo bene, e non potevo credere che ci avreste dimenticato. Ho continuato a pensare che un giorno sareste venuta a trovarci». «Come potevo dimenticare le persone con cui sono cresciuta da quando ero neonata?» chiese lei. «I miei amici del Nord mi ripetevano che mi avreste scordato, ma io sostenevo che avessero torto e non ho mai perso le speranze». «L’affetto è troppo forte per essere spazzato via come una ragnatela» sentenziò Miss Anne. «La catena è tanto forte da legarci anche nell’aldilà». A un tratto si arrestò e posò una mano sul braccio della compagna per indurla a fermarsi. «Elizabeth!» esclamò agitata. «Avete qualcosa da rimproverarmi?» La sarta scelse con cura le parole. «Per essere sincera, Miss Anne, una sola cosa: che non mi abbiate permesso di istruirmi come avrei tanto desiderato. Tutto ciò che so, l’ho imparato da adulta». La sua ex padrona strinse le labbra e annuì. «Avete ragione» ammise contrita. «Allora non ragionavo come adesso. Ho sempre rimpianto di non avervi dato un’educazione quando eravate ragazza». Tacque, poi fece un sorriso fiacco. «Ma non ne avete risentito troppo, perché in fondo ve la siete cavata meglio di noi che abbiamo ricevuto un’ottima istruzione». Elizabeth non la contraddisse. Miss Anne era vedova e dipendeva dalla generosità del cognato, mentre lei, pur essendo vedova, era indipendente e autonoma, un’imprenditrice di successo. Aveva vissuto a stretto contatto con i Lincoln, aveva frequentato la Casa Bianca e, a eccezione della morte del figlio, non aveva sofferto per la guerra come i Garland, i Meem e i Pappan. Non avrebbe mai voluto scambiare la sua vita con quella della padrona di un tempo, si disse, nonostante i privilegi e i vantaggi di cui godeva Miss Anne. Era orgogliosa di tutto ciò che era riuscita a fare basandosi sulle sue sole forze, ed era orgogliosa della donna che era diventata. Elizabeth rimase a Rude’s Hill per cinque settimane, e si accomiatò da Miss Anne e dai suoi figli nella speranza, condivisa da tutti, di rivedersi un giorno. 3. Riferimento a un discorso tenuto in Tennessee dal presidente Johnson in cui la folla di neri inneggiava a lui come al nuovo Mosè (N.d.T.). 15. Ottobre 1866 - febbraio 1868 Di ritorno a Washington, Elizabeth aveva molte faccende da sbrigare e parecchia corrispondenza da evadere. Gran parte delle lettere venivano da Mrs Lincoln, che era sola e depressa più che mai. Durante l’estate la vita nella pensione le era venuta a noia a tal punto che aveva speso quasi tutto ciò che restava dello stipendio del 1865 del marito, accordatole dal Congresso, per acquistare una lussuosa dimora di pietra in West Washington Street. Si era insediata in quel quartiere molto in voga vicino a Union Park insieme a Tad, mentre Robert si era trasferito in un appartamento per conto suo, dove era senz’altro più sereno. Dopo lunghe riflessioni aveva infine accettato, pur con molte riserve, di parlare con Mr Herndon, ma quando si erano incontrati a Springfield in settembre aveva cercato, con moine e adulazione, di convincere l’aspirante biografo del marito a non parlare di lei nel suo libro. «Gli ho detto che non era raro alludere all’esistenza di una moglie, nella biografia del marito, menzionando semplicemente il luogo e la data del matrimonio» scrisse a Elizabeth. «Vorrei che non dicesse nulla di me, ma spero che si limiterà a quello. Non so se le mie preghiere l’hanno convinto. Gli sono antipatica fin da quando ci conoscemmo a un ballo in casa del colonnello Robert Allen, poco dopo il mio arrivo a Springfield. Mi chiese di ballare, e mi disse che avevo danzato con la grazia di un serpente. Di un serpente, Elizabeth! Gli risposi, offesa: “Mr Herndon, il paragone con un serpente non è dei più felici, soprattutto riferito a una nuova arrivata” e me ne andai. Credo che da allora ce l’abbia con me, ma siccome era il socio di mio marito capitava spesso che ci vedessimo, e le nostre relazioni erano civili, se non amichevoli. Posso solo contare sull’affetto che lo lega alla memoria del mio congiunto, sperando che non sfoghi il suo risentimento nei miei confronti. Credo che abbia intenzione di dipingere un ritratto lusinghiero di mio marito, e in questo caso è mio dovere di vedova condividere con lui i miei ricordi, che sono più intimi di quelli di chiunque altro». Elizabeth ricevette la lettera troppo tardi per rispondere consigliando di rinunciare all’intervista, ma si consolò dicendo che sarebbe stato probabilmente inutile. Mrs Lincoln avrebbe potuto ignorare i suoi avvertimenti, oppure Herndon avrebbe potuto scrivere ciò che più gli aggradava senza neanche consultarsi con la vedova. La sarta sperava che, qualunque cosa avesse deciso di fare il biografo, le sue iniziative non avrebbero destato l’interesse del pubblico e che nessuno ne avrebbe parlato. Ma rimase delusa. In novembre Herndon tenne un’altra conferenza, diffondendone precedentemente il contenuto tramite volantini. I dettagli furono pubblicati su tutti i giornali. Nella sua relazione il perfido Mr Herndon affermava che Lincoln non aveva mai amato la moglie, ma che spasimava invece per Ann Rutledge, alla quale era stato fidanzato fino alla morte prematura della fanciulla, nel 1835. Dopo di lei, non aveva più provato amore e neppure affetto per un’altra donna. Aveva perfino firmato le lettere a Mary Todd scrivendo: «Il vostro amico Abraham Lincoln», e alla fine l’aveva sposata solo per dovere. Mary Lincoln, quindi, non aveva colpa per i problemi, noti a tutti, del loro matrimonio, giacché il marito non l’aveva mai amata. Quando Elizabeth lesse quelle dichiarazioni scandalose provò grande compassione per la sua amica. Se Herndon aveva avuto l’intenzione di ferire la vedova in lutto, non avrebbe potuto scegliere tattica migliore. Nel primo anniversario della morte del marito, Mrs Lincoln aveva scritto alla sarta: «Era sempre una musica per le mie orecchie, prima e dopo il matrimonio, sentirgli dire che ero l’unica a cui pensava, l’unica a cui voleva bene. Questo mi sarà di consolazione fino alla morte». E ora Mr Herndon le aveva portato via anche quella consolazione. E su che basi discutibili. Forse l’oratore era restato al fianco di Lincoln giorno e notte, anno dopo anno, per poter confermare con certezza che l’unica destinataria del suo amore e del suo affetto era stata Ann Rutledge? Aveva letto ogni lettera scritta da Lincoln a sua moglie, aveva udito ogni parola che lei gli aveva dedicato? Elizabeth non poteva tenere il conto di tutte le frasi dolci e affettuose che aveva sentito dire dal presidente alla moglie nel corso degli anni. Era vero che di tanto in tanto avevano litigato, ma questo accadeva a ogni coppia di sua conoscenza, e per quanto ci fossero stati momenti di irritazione e tensione estrema tra di loro, entrambi avevano sempre avuto fretta di riappacificarsi. Non fu di grande consolazione per la sarta – e di nessuna consolazione per Mrs Lincoln, come apprese nelle sue lettere – che Mr Herndon fosse stato aspramente criticato dopo le sue conferenze. Il pubblico era scandalizzato e indignato per quella violazione di ogni forma di decoro, che toccava dettagli tanto intimi della vita del presidente assassinato, e molti erano certi che quella Miss Rutledge fosse solo frutto della sua immaginazione. Robert Lincoln, furioso, prese tutte le misure necessarie per screditare e mettere a tacere l’aspirante biografo, avvertendolo che l’argomento della famiglia Lincoln era assolutamente da evitare nel suo manoscritto in fase di redazione. Il pastore dei Lincoln dei tempi di Springfield, James Smith, scrisse una replica feroce, indirizzata a Mr Herndon ma pubblicata da molti giornali, incluso il Chicago Tribune, che passò anche per le mani di Mrs Lincoln. Il pastore aveva letto il testo della conferenza di Herndon «con sentimenti di indignazione e insieme di dispiacere, perché venendo da un suo amico intimo ed ex socio intendeva arrecare danni terribili all’immagine di quell’uomo bravo e onesto, ferire profondamente i sentimenti della sua vedova inconsolabile e dei suoi figli orfani, e mettere in pessima luce, agli occhi del pubblico, tutti i componenti della famiglia, vivi e morti, e le relazioni tra loro». Proseguì dichiarando con grande enfasi che nessuno poteva affermare di conoscere il cuore del presidente Lincoln meglio del suo pastore, stimato e rispettato dai familiari, incaricato della salvezza delle loro anime, ottimo conoscitore delle gioie e dei dolori della loro esistenza, prezioso per i suoi consigli e la guida che forniva. «Durante i sette anni in cui abitavamo a Springfield» scrisse «era raro che passassero due settimane senza che trascorressi una serata piacevole in loro compagnia». L’intimità del pastore Smith con la famiglia Lincoln gli dava la certezza che il presidente fosse «assolutamente incapace di privare la sposa che conduceva all’altare di ciò che le spettava, donandole un cuore ormai morto e sepolto nella tomba di un’altra; con tutta la sincerità di cui era capace il suo animo, invece, le diede un cuore traboccante di amore e affetto». Era certo che Abraham Lincoln «fosse nei confronti di sua moglie un marito fedele, amorevole e affettuoso». La vedova Lincoln dovette trarre una certa soddisfazione e sentirsi vendicata quando la guida spirituale del marito confermò l’amore di quest’ultimo nei suoi confronti, ma le illazioni di Herndon le avevano comunque inflitto un colpo durissimo. «Ogni giorno che passa mi convinco che si tratta di un terribile incubo» si disperò per iscritto con Elizabeth. «Nel mio stato confusionale mi capita di pensare che il mio amatissimo marito finirà per tornare dai suoi cari che lo piangono. So che non accadrà mai in questo mondo, e se non fosse per Tad non tarderei a raggiungerlo nell’aldilà». Nelle prime settimane del 1867 le lettere di Mrs Lincoln alludevano spesso al terrore di non potersi più permettere la casa di West Washington Street, di dover cercare un alloggio meno costoso per sé e Tad, affittare la casa e vivere grazie a quella rendita. In marzo scrisse di nuovo, confessando che tale paura era diventata una certezza. Aveva lottato fin troppo a lungo per mantenere le apparenze, ma alla fine aveva dovuto sbarazzarsi di quella maschera perché le sue scarse entrate non le bastavano. «Ho molti effetti personali costosi che non userò più» scrisse. «Tanto vale che li trasformi in denaro, per aumentare le mie rendite e facilitare le nostre condizioni di vita. È umiliante trovarsi in questa situazione, ma siccome mi ci trovo devo destreggiarmi meglio che posso. Ora, Elizabeth» proseguiva, «vorrei chiedervi un favore. Devo assolutamente fare qualcosa per risolvere i miei problemi, e vorrei che mi raggiungeste a New York fra il 30 agosto e il 5 settembre prossimi per aiutarmi a vendere parte del mio guardaroba». La sarta sapeva che le entrate di Mrs Lincoln erano modeste, solo millesettecento dollari all’anno, e che la sua collezione di abiti eleganti, rinchiusa nei bauli fin dal momento del trasloco da Washington, non le era più di alcuna utilità, visto che era quasi certa di non avere più l’occasione di indossarli. Elizabeth decise che, siccome la sua amica aveva fretta, sarebbe stato prudente cercare di venderli con discrezione, e che New York era il posto ideale per portare a termine quel progetto delicato. «Perché te ne fai carico?» chiese Emma quando Elizabeth spiegò il motivo per cui doveva affidarle l’attività sartoriale oppure interromperla del tutto mentre viaggiava per conto di Mary Lincoln. «Hai già fatto tanto per lei, ma non ha saputo trarne nessun vantaggio». «Credo che le faccia piacere sapere di poter contare su di me» ribatté la sarta. «Tutti gli altri l’hanno abbandonata o tradita, a eccezione dei suoi figli. Non bisognerebbe chiedersi perché io l’aiuti tanto, ma perché tanti altri l’aiutino così poco». Mrs Lincoln era la moglie del “grande emancipatore”, il presidente martire che aveva fatto tanto per la loro razza. Come poteva Elizabeth rifiutarsi di fare qualcosa per aiutarla? Il 15 settembre ricevette una lettera da parte della vedova Lincoln con cui le annunciava che sarebbe arrivata a New York la sera del 17. Chiese alla sarta di arrivare prima e di prenotare le stanze per entrambe al St Denis Hotel a nome di Mrs Clarke, uno pseudonimo che aveva usato talvolta quando viaggiava come first lady. Elizabeth, stupita, lesse di nuovo la lettera per essere sicura di non avere capito male. Non aveva mai sentito parlare del St Denis Hotel, il che suggeriva che non si trattava di un alloggio prestigioso e che quindi non sarebbe stato all’altezza delle pretese di Mrs Lincoln. La lasciò perplessa anche la scelta di viaggiare con un nome falso, che l’avrebbe costretta a rinunciare alla fiducia e al rispetto associati al suo ruolo di ex first lady. Soprattutto, sapeva che sarebbe stato difficile, se non impossibile, per lei che era nera, prenotare stanze in un hotel sconosciuto per una persona che non era una cliente abituale. «Cosa le è venuto in mente?» mormorò Elizabeth, scuotendo il capo mentre rileggeva la lettera. Magari avesse potuto chiederglielo! Mrs Lincoln, invece, doveva già essere in viaggio per New York prima di poter ricevere una lettera a Chicago, e un telegramma era escluso, perché avrebbe esposto il delicato problema a tutte le operatrici curiose con cui avesse avuto a che fare. Non sapendo come comportarsi, non le restò che sperare che Mrs Lincoln le facesse sapere di aver cambiato idea. Così Elizabeth restò a Washington, in attesa di una lettera o di un telegramma, con l’ansia che aumentava ogni giorno. Quando, il 18 settembre, il giorno successivo a quello in cui la vedova sarebbe dovuta arrivare, Elizabeth non ricevette notizie, telegrafò subito a “Mrs Clarke” al St Denis Hotel, facendo sapere che sarebbe arrivata al più presto. Prese il primo treno per New York e arrivò in albergo, un edificio a sei piani tra Broadway e East Eleventh Street. Dopo aver suonato all’ingresso riservato alle signore, chiese al ragazzo che venne ad aprire se ci fosse tra i clienti una certa Mrs Clarke. Lui non lo sapeva, andò a informarsi e al ritorno confermò che Mrs Clarke era una dei loro ospiti. «Desiderate vederla?» domandò. «Sì». «Venite per di qua, allora». Fece un gesto in una direzione vaga. «È laggiù, adesso». Esitando, e pensando che forse Mrs Lincoln fosse nella lobby con qualcuno, la sarta gli consegnò uno dei suoi biglietti da visita. «Portatele questo, per favore» chiese, ma proprio in quel momento la vedova apparve nell’ingresso, attratta dal suono della sua voce familiare. «Mia cara Elizabeth, sono così contenta di vedervi!» esclamò attraversando l’atrio e stringendo la mano all’amica. «Ieri sera, quando sono arrivata e ho visto che non c’eravate, ero disperata». La sarta non vedeva Mrs Lincoln da più di due anni, e il suo viso pallido e tirato la lasciò per un istante senza parole. «Vi ho spedito un telegramma» riuscì a balbettare. «Sì, ma l’ho ricevuto solo ora. È arrivato stamattina, ma me l’hanno dato stasera. Venite, andiamo a informarci sulla vostra stanza». Condusse Elizabeth dall’impiegato che, come tutti gli impiegati degli alberghi più moderni, era azzimato, profumato e troppo presuntuoso per essere cortese. Guardò Elizabeth con sufficienza mentre Mrs Lincoln si avvicinava. «Questa è la signora di cui vi ho parlato» esordì. «Voglio per lei una buona stanza». L’impiegato sollevò le sopracciglia. «Non abbiamo stanze per lei, signora». «Ma ha bisogno di una stanza. È mia amica e voglio che abbia una camera accanto alla mia». «Non abbiamo posto per lei al vostro piano» rispose brusco. Elizabeth capì perfettamente cosa intendeva, e lo guardò fisso, serbando un dignitoso silenzio. Non avrebbe chiesto di meglio che andarsene e trovarsi una stanza in un hotel appartenente a un nero più cortese, ma ormai faceva buio e non osava tornare fuori, né poteva lasciare sola Mrs Lincoln. La vedova si accigliò. «Che strano, signore. Vi dico che è mia amica, e sono sicura che non potreste trovare persona più affidabile a cui affittare una stanza». «Amica vostra oppure no, vi ripeto che non abbiamo stanze per lei al vostro stesso piano». Fece una pausa e aggiunse riluttante: «Posso trovarle un posto al quinto piano». «Immagino che sia anche migliore del piano dove si trova la mia stanza» commentò Mrs Lincoln in tono minaccioso. «Ebbene, se lei va al quinto piano, ci andrò anch’io. Ciò che va bene per lei, va bene anche per me». «Benissimo, signora». L’impiegato fece un sospiro e controllò il registro e le chiavi. «Volete stanze adiacenti e vi faccio portare di sopra il bagaglio?» «Sì, e di corsa, anche. Chiedete al ragazzo di accompagnarci. Venite, Elizabeth». Dopo un’ultima occhiata sdegnata, Mrs Lincoln voltò le spalle all’impiegato. Il ragazzo che le aveva aperto la porta all’arrivo fece loro strada su per le scale; salirono e salirono, e la sarta temette che non sarebbero mai arrivati in cima. Quando arrivarono a destinazione, e il fattorino aprì le porte delle loro stanze, la sarta non avrebbe saputo dire chi restò più interdetta. Avevano ricevuto camere piccole, squallide, scarsamente ammobiliate, nella soffitta destinata ai servitori che puzzava di polvere, umido e sudore. Mai in vita sua Elizabeth avrebbe immaginato la vedova di un presidente in un alloggio tanto umile. «Che provocazione!» esclamò Mrs Lincoln, lasciandosi cadere su una sedia e ansimante dopo tutte quelle scale. «Vi assicuro che non ho mai visto gente così poco amabile. Pensate un po’, ci hanno mandato in soffitta. Domani darò loro una bella strigliata». «Dimenticate che non vi conoscono» le ricordò Elizabeth. «Mrs Lincoln sarebbe trattata in modo diverso da Mrs Clarke». «È vero, me l’ero dimenticato. Ebbene, dovrò sopportare i disagi». Prese poi un’aria afflitta. «Perché non siete venuta ieri, Elizabeth? Ero folle di apprensione ieri sera quando sono arrivata e ho scoperto che non eravate qui. Mi sono messa subito a scrivervi chiedendovi di raggiungermi. Stavo davvero male». «Pensavo che forse avreste cambiato idea» ammise la sarta. «Sapevo anche che avrei avuto grossi problemi a prenotare delle stanze per “Mrs Clarke”». «Ebbene, da quello che abbiamo visto finora posso affermare che i vostri timori erano fondati». Poi sussultò. «Ma non avete cenato, Elizabeth. Avrete fame. Me l’ero quasi dimenticato, presa com’ero dalla gioia di ritrovarvi. Dovete andare subito a tavola». La sarta era effettivamente affamata, ma il pensiero di un buon pasto la rianimò. Mrs Lincoln suonò il campanello e, quando apparve un cameriere, gli ordinò di servire la cena alla sua amica. Elizabeth lo seguì da basso, dove la condusse in sala da pranzo e la fece sedere a un tavolo d’angolo. Stava ordinando quando arrivò il maître. «Siete nella sala sbagliata» sbottò burbero. Lei lo guardò senza scomporsi. «È stato il cameriere a farmi accomodare qui». «Non importa. Vi troverò un altro posto per cenare». A Elizabeth brontolava lo stomaco quando si alzò da tavola per seguirlo fuori dalla sala da pranzo. «È molto strano» gli fece notare piccata quando arrivarono nell’atrio «che mi permettiate di sedermi in sala da pranzo solo per chiedermi di andarmene subito dopo». Il maître si fermò e le lanciò uno sguardo da sopra la spalla. «Non siete la domestica di Mrs Clarke?» «Sono con Mrs Clarke» rispose lei, come a sottolineare la differenza. «È uguale». Si voltò e riprese a camminare in corridoio. «I domestici non hanno il permesso di mangiare nella sala da pranzo grande. Ecco, per di qui. Dovete cenare nella sala della servitù». Umiliata e affamata, Elizabeth seguì il maître lungo i corridoi di servizio dell’hotel, sapendo che solo così avrebbe potuto mettere qualcosa sotto i denti. Giunti alla sala riservata alla servitù, il maître girò la maniglia solo per scoprire che la porta era chiusa a chiave. La lasciò in corridoio intanto che andava a informare l’impiegato. Qualche minuto dopo quest’ultimo arrivò di gran carriera, preceduto da una zaffata del suo profumo. «Venite dalla strada o dalla stanza di Mrs Clarke?» «Dalla stanza di Mrs Clarke» rispose lei educatamente, rifiutando di dimostrarsi scortese quanto lui. «L’ora di cena è finita. La sala è chiusa, e Annie è uscita con la chiave». Per un attimo Elizabeth sperò che le proponesse di tornare in sala da pranzo, ma quando non aggiunse altro l’orgoglio le impedì di trattenersi oltre lì in corridoio. «Benissimo» concluse, avviandosi verso la scala. «Dirò a Mrs Clarke che non sono riuscita a cenare». L’uomo si accigliò quando lei iniziò a salire le scale. «Non c’è bisogno di prendersela tanto!» le gridò dietro. «Capisco bene la situazione!» «Non credo proprio» commentò lei sottovoce, arrivando al primo di innumerevoli pianerottoli. «Se capiste davvero bene la situazione» borbottò ansimando «non mettereste la vedova del presidente Lincoln in una stanza tutta sbilenca nella soffitta di questo albergo miserabile». Mormorare tra sé ciò che non poteva ripetergli ad alta voce la fece sentire ancora peggio. Quando infine giunse nella stanza di Mrs Lincoln, aveva la visione offuscata da lacrime di umiliazione e frustrazione. Vedendo la sua aria abbattuta, l’amica si accigliò preoccupata. «Cosa succede, Elizabeth?» «Non sono riuscita a cenare». «Non siete riuscita a cenare? Cosa volete dire?» La sarta si lasciò cadere su una sedia e raccontò tutto quello che era successo da quando il cameriere l’aveva accompagnata giù. «Che insolenza! Che persone prepotenti!» esclamò Mary Lincoln furiosa. Afferrò i braccioli della poltrona e si alzò di scatto. «Non temete, Elizabeth. Avrete la vostra cena. Mettete la cuffia e lo scialle». «Perché?» «Perché?» Mrs Lincoln si aggiustò la cuffia e si mise davanti allo specchio allacciandosi il nastro. «Perché adesso usciamo dall’hotel e andiamo a mangiare in un posto dove sanno comportarsi in modo civile». Stancamente Elizabeth obiettò: «Non vorrete uscire di sera». «Sì, invece. Pensate che vi farò patire la fame, quando possiamo trovare qualcosa da mangiare a ogni angolo di strada?» «Dimenticate una cosa: siete qui come Mrs Clarke, non come Mrs Lincoln. Siete arrivata sola, e la gente comincia già a sospettare che ci sia sotto qualcosa di strano. Se uscite dall’albergo di sera, offrirete loro una nuova prova». «Che sciocchezza. Pensate forse che mi interessi ciò che pensano questi poveri selvaggi? Avanti, vestitevi». «No, Mrs Lincoln» dichiarò con fermezza Elizabeth, anche se il suo stomaco protestava. «Non intendo uscire stanotte, perché capisco bene la vostra situazione, a differenza di voi. Mrs Lincoln non avrebbe motivo di curarsi di ciò che questa gente dice di lei, ma Mrs Clarke vuole restare in incognito, quindi deve essere più prudente». Con qualche difficoltà riuscì infine a convincere Mrs Lincoln a usare maggiore prudenza. Era così spontanea e impulsiva che non si preoccupava mai di come avrebbero potuto essere male interpretate le sue parole e azioni. Elizabeth le augurò la buonanotte e andò in camera sua, e solo quando si fu messa a letto ed ebbe spento la luce le venne in mente che l’amica avrebbe potuto ordinare la cena in camera fingendo che fosse per sé, e la sarta non avrebbe dovuto andare a dormire affamata. Il mattino dopo Mrs Lincoln bussò alla porta dell’amica prima delle sei. «Avanti, Elizabeth, alzatevi!» la chiamò. «So che dovete avere fame. Vestitevi alla svelta e usciamo a fare colazione. Non sono riuscita a dormire, stanotte, pensando al fatto che avete dovuto coricarvi senza cena». Anche lei aveva dormito male in quel letto scomodo e bitorzoluto, con lo stomaco vuoto che protestava. Si vestì in fretta, e di lì a breve uscirono a fare colazione in un locale su Broadway a un isolato di distanza dal St Denis Hotel. Poi si incamminarono per Broadway ed entrarono in Union Square Park, dove si sedettero su una panchina sotto gli alberi dai vivaci colori autunnali, guardarono i bambini che giocavano e discussero del progetto di vendere il guardaroba di Mrs Lincoln. Questa raccontò a Elizabeth che il giorno prima si era recata da un commerciante di diamanti dopo aver visto una pubblicità sull’Herald. «Ho cercato di vendere loro parecchi gioielli» spiegò la vedova del presidente. «Ho detto di chiamarmi Mrs Clarke. Il primo uomo con cui ho parlato è stato gentile, ma non siamo riusciti a metterci d’accordo sul prezzo. Si è chiuso in ufficio per parlare con un altro signore, e proprio mentre ho concluso che stavano confabulando per mandarmi via, è entrato un terzo uomo nel negozio. Ha guardato i miei gioielli – solo dopo ho scoperto che era Mr Keyes, un socio silenzioso dell’azienda – e ha visto il mio nome inciso all’interno di uno degli anelli». «Oh, cielo!» esclamò Elizabeth. «Mi ero dimenticata dell’incisione» confessò Mrs Lincoln. «Quando ho visto che fissava l’anello con tanto interesse gliel’ho strappato di mano e me lo sono messo in tasca». Elizabeth soffocò una risata. «Sono sicura che questo non ha stuzzicato per nulla la sua curiosità». «Non volevo restare lì per vedere la sua reazione. Ho raccolto le mie gioie in fretta e furia, ma a quel punto erano molto più interessati alla mia merce, naturalmente. Ho lasciato il mio biglietto da visita, a nome di Mrs Clarke che alloggia al St Denis Hotel. Devono passare stamattina, e inizieremo a trattare». «Siete sicura?» chiese Elizabeth timorosa. «Ormai devono avere capito che siete la vedova del presidente Lincoln». «O la sua serva ladra». «Non credo». La sarta proseguì: «È saggio affidarsi a una ditta mai sentita, che avete conosciuto solo grazie a un annuncio sul giornale, per una faccenda tanto delicata? Non sarebbe più prudente chiedere consiglio a qualcuno che conoscete, o rivolgervi a un gioielliere con cui avete già avuto occasione di effettuare delle transazioni?» «Più prudente sì, ma impossibile» replicò Mrs Lincoln. «Non potrei chiedere consiglio agli amici o rivolgermi ai gioiellieri preferiti senza espormi. Anche se Mr Keyes ha capito chi sono, il resto della città non deve sospettare. Non potrei sopportare una simile umiliazione». Elizabeth si rassegnò e, dopo essersi godute ancora un po’ il sole e la brezza fresca, tornarono in hotel. Poco dopo il loro arrivo giunse anche Mr Keyes; si chiusero tutti e tre in salotto a discutere e Mrs Lincoln confermò la sua identità. Come Elizabeth sospettava sarebbe successo, l’individuo ne fu entusiasta, e ammirò a lungo scialli, abiti e pizzi raffinati che l’ex first lady gli mostrò. Quando gli spiegò perché era costretta a vendere il suo guardaroba, Mr Keyes si mostrò molto solidale e comprensivo, ed ebbe parole dure nei confronti del governo per la sua ingratitudine. Rimase anche scandalizzato dal pessimo trattamento ricevuto al St Denis, e propose a Mrs Lincoln di trasferirsi immediatamente in un altro hotel. La signora accettò, e mentre si recavano allo Union Place Hotel, Elizabeth suggerì: «Forse all’arrivo dovreste confidarvi con il proprietario e dirgli il vostro vero nome, pur senza metterlo per iscritto nei registri, in modo che vi trattino con il dovuto rispetto». L’amica acconsentì, pur con qualche esitazione, ma quando giunsero in hotel aveva già cambiato idea un’altra volta e si presentò come Mrs Clarke. Anche così, però, furono trattate con maggiore cortesia, forse perché il vero nome di Mrs Lincoln era leggibile su alcuni dei bauli, se si guardava con attenzione, e il personale sapeva chi fosse pur fingendo di ignorarlo. Dopo che ebbero preso possesso delle nuove stanze, nei giorni successivi ricevettero diverse visite da parte di Mr Keyes e Mr Brady, perché c’erano parecchi punti da discutere. Mrs Lincoln aveva intenzione di vendere i suoi oggetti personali e di tornare a Chicago il più rapidamente e discretamente possibile, ma quei signori avevano progetti ben diversi, scoprì Elizabeth costernata. «Affidatevi a noi» dichiarò Mr Brady, «e vi faremo guadagnare almeno centomila dollari nel giro di poche settimane. La gente non permetterà che la vedova di Abraham Lincoln soffra. Verrà in suo aiuto quando saprà che è in difficoltà». Erano esattamente le rassicurazioni che Mrs Lincoln cercava, in termini economici ed emotivi, e così accettò di lavorare con W.H. Brady & Co. Le anticiparono seicento dollari per le spese sostenute a New York, e le assicurarono che il loro progetto, una volta che l’avessero preparato nei dettagli, avrebbe funzionato. Lo Union Place Hotel era confortevole, la sicurezza dei mediatori rincuorante, ma anche così le due donne erano molto timorose di farsi scoprire. Una domenica fecero un giro in carrozza per Central Park ma non ne trassero nessun piacere, perché nonostante il velo pesante che Mrs Lincoln indossava per mascherare la propria identità non poterono aprire i finestrini per paura di essere riconosciute. Evitarono per un pelo lo scontro con un’altra carrozza, e si spaventarono molto non per gli eventuali danni fisici che avrebbero potuto subire, ma perché un incidente avrebbe attratto l’attenzione e il loro sotterfugio sarebbe stato scoperto. A Elizabeth quelle menzogne piacevano sempre meno ogni giorno che passava, ma quando Mr Brady e Mr Keyes presentarono alla vedova Lincoln il loro progetto per la vendita degli oggetti, cominciò a temere che quell’idea fosse un disastro bello e buono. Brady pensava che i repubblicani più eminenti, che dovevano la propria fortuna a Lincoln, sarebbero stati disposti ad anticiparle del denaro pur di evitare che si sapesse in giro delle condizioni disperate in cui versava, che la costringevano a vendere il proprio guardaroba. Per questo chiese a Mrs Lincoln di scrivere delle lettere descrivendo le sue difficoltà economiche, indirizzandole a lui ma retrodatandole, come se le avesse vergate qualche settimana addietro, quando era ancora a Chicago. I mediatori le chiesero di dare a intendere che aveva tenuto da parte lettere compromettenti per diversi politici e uomini d’affari che avevano tratto vantaggio dai contratti stipulati in tempo di guerra. Brady e Keyes avrebbero mostrato le lettere ai signori in questione, sperando di metterli in imbarazzo e di costringerli così a versarle dei soldi. Se il progetto falliva – se la sua richiesta di aiuto, la loro lealtà nei confronti del partito repubblicano, e il proprio istinto di conservazione non fossero bastati a convincerli – Mr Brady avrebbe minacciato di pubblicare le lettere. A Elizabeth pareva un ricatto puro e semplice, e non appena i due uomini se ne andarono esortò l’amica a lasciar perdere. «Non penso che la disonestà e le minacce possano portare qualcosa di buono» dichiarò. «Volevate vendere il vostro guardaroba rapidamente e in tutta discrezione. Ho paura invece che queste lettere non facciano che attirare l’attenzione su di voi». «Sono stata ignorata fin troppo a lungo». Mrs Lincoln si sedette al tavolino ed estrasse penna, inchiostro e carta. «Mr Brady e Mr Keyes sono convinti che debba fare qualcosa per attirare l’attenzione dei gentiluomini che sarebbero le persone più indicate per aiutarmi». «Attirerete la loro attenzione, questo è certo, ma anche l’attenzione di tutti gli altri». Elizabeth non pensava di riuscire a convincerla, ma ci provò comunque, rifiutando di restare in silenzio. «Il peggio di ciò che i giornali hanno scritto su di voi in passato non sarà nulla rispetto al disprezzo e alle critiche che vi attirerete con questa storia». «“Caro signore”» sillabò Mrs Lincoln cominciando la prima lettera, ignorando platealmente i consigli di Elizabeth in un modo che a quest’ultima parve scortese. «“Vi scrivo perché ho letto un annuncio che dice che vendete oggetti di valore dietro versamento di una commissione”. Vedete, Elizabeth, l’inizio è onesto. Non potete criticarmi se seguo i consigli di Mr Brady quando nulla di ciò che scrivo è falso». «La data e il luogo». La sarta le indicò con un cenno il foglio, controllando ormai a stento la propria irritazione. «Chicago, settembre 1867. Cominciate subito con delle menzogne». «Sono piccoli dettagli senza importanza». La sarta soffocò un sospiro e resistette alla tentazione di levare le braccia in un gesto indignato. Sbirciò da sopra la spalla dell’altra donna che descriveva a Mr Brady il bisogno urgente di disfarsi di doni preziosi ricevuti da cari amici. Terminò quella lettera e ne iniziò un’altra, datata 14 settembre, a Chicago. «Mio caro signore» scrisse a Mr Brady. «Vi prego di rivolgervi all’onorevole Abram Wakeman. È in debito con me per aver ottenuto la carica estremamente redditizia che ha conservato per diversi anni, e che gli ha consentito di arricchirsi parecchio. Mi aiuterà nella situazione dolorosa e umiliante in cui mi trovo, prossima alla povertà pura e semplice. So che non avrà esitazioni a ricambiare, in misura minore, i molti favori che io e mio marito gli abbiamo sempre accordato. Mr Wakeman mi ha sollecitato a più riprese perché intercedessi per lui nell’ottenimento di cariche per sé e per altri. Sarà quindi ben felice di aiutarmi acquistando uno o più degli articoli che mi farete la cortesia di mostrargli». Lo sconcerto di Elizabeth aumentava a ogni tratto di penna di Mrs Lincoln. Mr Wakeman era stato membro del Congresso e ufficiale in capo del servizio postale di New York, e il presidente Lincoln lo aveva nominato ispettore del porto di New York, il ruolo più ambito dell’amministrazione, secondo solo a quello di ispettore generale della dogana. Era anche un politico abile e opportunista, ed Elizabeth non credeva che si sarebbe lasciato mettere in imbarazzo né minacciare da un mediatore di diamanti dall’etica discutibile. «Vi prego, pensateci bene» esortò l’amica. «Se insistete nello scrivere queste lettere, esprimetevi almeno in termini diplomatici». «Non preoccupatevi, Elizabeth!» esclamò la donna firmando. «Va bene tutto, pur di sollevare un po’ di polverone. Tanto vale chiamare le cose col loro nome». La sarta sospirò e non aggiunse altro, neppure quando Mrs Lincoln cominciò una nuova lettera scrivendo: «Affermate che i giornalisti vi assillano con domande sui miei oggetti depositati presso di voi, e temete che scoprano la verità dolorosa sul motivo per cui vi ho affidato questi effetti personali e che se ne servano per danneggiare politicamente il partito repubblicano». Lei non avrebbe fatto mai nulla per arrecare danno alla loro causa, scrisse, «sebbene gli uomini per i quali il mio nobile marito si adoperò tanto senza esitazioni mi abbiano privata di ogni mezzo di sostentamento, lasciandomi in condizioni pietose». Le frasi intendevano instillare nel cuore di quei signori la paura delle rivelazioni alla stampa, oltre a suscitare in loro il senso di colpa per le condizioni in cui versava la vedova, ma Elizabeth era sicura che personaggi tanto potenti non si sarebbero abbassati a elargire qualche soldo alla signora per scongiurare lo scandalo. Era più probabile che buttassero fuori dai loro uffici Mr Brady riempiendolo di insulti. La sua amica, però, non le dava ascolto. Le lettere furono scritte e consegnate a Mr Brady e Mr Keyes, che cominciarono subito a mostrarle agli individui indicati da Mrs Lincoln. Poco dopo la vedova si disse che il piano dei due intermediari non prevedeva, in fondo, la vendita del suo guardaroba, e quindi decise di disfarsene in un altro modo. Chiese a Elizabeth di prendere appuntamento con diversi rivenditori di abiti di seconda mano, convocandoli allo Union Place Hotel a nome di Mrs Clarke; ma anche se quelli si presentarono come convenuto e sembravano interessati agli articoli, non riuscirono a mettersi d’accordo sul prezzo. Nonostante questo ostacolo le due non si diedero per vinte: qualche giorno dopo misero un fascio di abiti e scialli in una carrozza e percorsero Seventh Avenue, fermandosi in un negozio dopo l’altro in cerca di acquirenti. Scoprirono quasi subito che i commercianti erano disposti a comprare gli indumenti solo per pochi spiccioli e, sebbene Mrs Lincoln fosse abile a trattare, la sua accortezza e parlantina non le fruttarono nulla. Scoraggiate, tornarono in albergo con tutta la loro roba, decise a non rinunciare. Nel frattempo il loro strano comportamento aveva attirato l’attenzione del personale e degli altri clienti dell’hotel, che lanciavano loro occhiate curiose ogni volta che passavano. I grossi bauli in cui era conservato il guardaroba di Mary Lincoln erano stati lasciati nell’atrio dell’hotel invece di essere portati di sopra, ed erano diventati oggetto di curiosità e di congetture. Prima un reporter, poi un altro notarono la traccia del nome di Mrs Lincoln sul coperchio di uno dei bauli, sebbene le lettere fossero state cancellate. Le due donne si sentirono sempre più a disagio sotto quegli sguardi inquisitori e quella pioggia di bisbigli, finché la vedova non decise finalmente che dovevano andarsene. Presero con loro i bagagli meno ingombranti, fecero consegnare le casse più grandi agli uffici di W.H. Brady & Co. al 609 di Broadway, pagarono il conto e scapparono subito in campagna, dove restarono tre giorni per far perdere le tracce ai giornalisti. Quando tornarono in città, la sarta suggerì alla sua compagna di alloggiare al Metropolitan Hotel, dove era già stata, e di affidarsi alla discrezione del proprietario, che era sempre stato cortese e rispettoso nei suoi confronti. Mrs Lincoln rifiutò. Si stabilirono invece al Brandreth House, dove la vedova del presidente dichiarò di chiamarsi “Mrs Morris”. Elizabeth si era stancata dei nomi falsi e di quella vita clandestina, ma portò pazienza, cercando di convincersi che avrebbe giovato alla sua ex cliente. Con il passare delle settimane, perse le speranze sul buon esito dell’iniziativa, ma non provò nessuna soddisfazione quando, come aveva previsto, Keyes e Brady furono costretti ad ammettere che il loro progetto era fallito. Avevano mostrato le lettere a parecchi repubblicani importanti, ma nessuno di loro aveva reagito nel modo sperato. A eccezione di alcuni abiti, venduti a basso prezzo a rivenditori di seconda mano, il guardaroba di Mrs Lincoln era ancora chiuso nei bauli. I seicento dollari che gli intermediari le avevano anticipato erano stati spesi quasi tutti, e quel periodo trascorso a New York non le aveva fruttato nulla; anzi, con i pettegolezzi che circolavano riguardo alla misteriosa vedova nascosta dal velo che cercava di vendere il proprio guardaroba, sarebbe stato corretto dire che la situazione era peggiorata da quando era partita da Chicago. Nella prima settimana di ottobre, rimasta a corto di denaro e di pazienza, accettò con riluttanza di permettere a Mr Brady di esibire il suo guardaroba nel loro salone da esposizione per venderlo, dando ampio risalto al fatto che appartenesse a lei. «Chi non era interessato ai vestiti di Mrs Clarke sarà ansioso di acquistare gli abiti di Mrs Lincoln» dichiarò Brady, ma Elizabeth non si sentiva tranquilla. Inoltre l’ex first lady accettò che gli intermediari pubblicassero le sue lettere sul World newyorchese, un quotidiano democratico ben contento di coprire di ridicolo i repubblicani. Dopo essersi rassegnata al nuovo progetto, scoraggiata, ansiosa e in preda a una gran nostalgia di Tad, Mrs Lincoln lasciò New York la stessa mattina della pubblicazione delle lettere sul giornale, affidando a Elizabeth il resto dell’operazione. Anche la sarta desiderava tornare a casa e riprendere il lavoro. L’amica le aveva promesso una commissione sulla vendita del guardaroba, ma se non avesse venduto nulla non avrebbe guadagnato nulla. Non poteva permettersi un albergo, così trovò una stanza in affitto in una casa, ridusse le spese al minimo e sperò che esporre gli abiti dell’ex first lady avrebbe suscitato interesse e favorito le vendite. Alla fine, ricevette solo parte di quello che aveva sperato. Le prime avvisaglie del disastro le furono annunciate non dal numero 609 di Broadway o dalla stampa, ma da Mrs Lincoln che le scrisse poche ore dopo essere tornata a Chicago. Sul treno si era trovata in una situazione molto imbarazzante: era seduta dietro due signori che avevano appena letto le lettere sul World e stavano parlando delle sue difficoltà economiche. Più tardi si era recata nel vagone ristorante ed era stata accompagnata a un tavolo dove sedeva nientemeno che il suo amico di Washington, il senatore Charles Sumner, che la riconobbe subito nonostante il velo nero che le celava il viso. La pietà che traspariva dalla sua espressione era tale che capì subito che anche lui stava pensando alle lettere e all’esposizione del suo guardaroba; ne fu così ferita che si inventò un’amica malata che aveva bisogno di lei e abbandonò il tavolo. Più tardi, quando il senatore premuroso le portò una tazza di tè nella sua carrozza, pianse per l’imbarazzo. In una seconda lettera, scritta poche ore dopo la prima, Mrs Lincoln si lamentava: «Vi scrivo stamattina con il cuore a pezzi dopo una notte insonne passata a torturarmi. R è venuto ieri sera e pareva impazzito, ha minacciato quasi di uccidersi, ed era devastato perché le lettere del World sono state pubblicate sul giornale di ieri. Non ho saputo trattenere le lacrime quando l’ho visto tanto abbattuto». Elizabeth impiegò qualche istante per capire il significato di quelle parole, e quando comprese che le lettere false erano state pubblicate anche sui giornali di Chicago fu colta da una specie di vertigine. Avrebbe dovuto aspettarselo: lo scandalo era troppo importante e troppo interessante per restare confinato a New York. «Piango mentre vi scrivo» continuava la missiva. «Prego che la morte mi colga stamattina stessa. Solo il caro Taddie mi impedisce di togliermi la vita». Stava quasi perdendo la ragione, concluse, e chiese a Elizabeth di dire a Brady e Keyes di non far pubblicare più nulla a suo nome. Nelle settimane seguenti giunsero molte altre lettere da Chicago e, sebbene Mrs Lincoln implorasse Elizabeth di scriverle ogni giorno, la sarta trovava a malapena il tempo di occuparsi delle incombenze che le erano state affidate. I visitatori, qualcuno curioso, qualcuno carico di disprezzo, si recarono negli uffici di W.H. Brady & Co. per esaminare abiti ammonticchiati su un tavolo lungo, scialli appesi sullo schienale delle sedie, pellicce, pizzi e gioielli esposti in una vetrina. La pubblicazione delle lettere aveva effettivamente suscitato un certo interesse, ma se molti curiosavano, nessuno comprava. Come commentò sprezzante un giornalista dell’Evening Express, alcuni degli abiti «non sono stati portati molto ma hanno l’aria vissuta; sono strappati sotto le braccia e lungo l’orlo della gonna, la fodera è macchiata e hanno altri difetti». I prezzi esosi scritti sulle etichette, continuava il reporter, erano senz’altro stati suggeriti dai sarti, fin troppo fieri del proprio operato. «La particolarità degli abiti» aggiunse «è che sono quasi tutti molto scollati, caratteristica che alcune signore attribuiscono all’orgoglio provato da Mrs Lincoln per il proprio petto». E gli articoli, su quel giornale e su altri, andarono peggiorando. I giornalisti e i pettegoli cominciarono a parlare della situazione definendola «lo scandalo degli abiti vecchi di Mary Lincoln». I democratici colsero l’occasione per insultare gli avversari affermando che le lettere del World erano la prova che i repubblicani avevano comprato favori dalla Casa Bianca durante il mandato di Lincoln. Per tutta risposta, i giornali repubblicani denunciarono l’operato irruente, indelicato e inopportuno dell’ex first lady e fecero a gara nel rinnegarla. «Sembra che siano stati sguinzagliati i segugi, perché i giornali repubblicani mi stanno facendo a pezzi qui a ovest, in questa ruffiana città di frontiera» scrisse Mrs Lincoln a Elizabeth il 9 ottobre. «Se avessi commesso un omicidio in ogni città di questa benedetta Unione, non sarei stata più calunniata di così. E sapete bene quanto sia innocente; non ho agito animata da cattive intenzioni». Elizabeth, però, non riusciva a considerarla del tutto innocente, perché aveva accettato di scrivere le lettere false. Voleva convincersi che le sue intenzioni fossero buone, ma questa volta non ne fu in grado. Mentre Mrs Lincoln leggeva con apprensione i giornali, cercava di farsi perdonare da Robert e si lagnava del trattamento subito nelle lettere a Elizabeth e ad altre amiche comprensive, la sarta rimase a New York, aiutando gli intermediari come poteva, cercando di evitare che la reputazione della sua amica venisse ulteriormente infangata. Alla fine lo scandalo si trascinò per tanto di quel tempo, furono fatte circolare tante di quelle notizie false che Elizabeth, dietro suggerimento della vedova, concesse interviste all’Herald e all’Evening News, che parevano stare dalla loro parte, per ristabilire la verità. Ma non cambiò nulla. I commenti acidi non fecero che aumentare, il guardaroba, palpeggiato senza ritegno, rimase a impolverarsi al 609 di Broadway, ed Elizabeth era sfinita a forza di darsi da fare. Cominciò a cucire per sbarcare il lunario, ma incarichi saltuari del genere le procuravano compensi irrisori, niente a che vedere con ciò che aveva guadagnato con la propria attività a Washington. Si trasferì in una pensione di Broome Street, la cui proprietaria, Mrs Bell, era cugina di William Slade, ex messaggero del presidente Lincoln. Ma non bastò. Elizabeth restò a New York per tutto l’autunno e l’inverno, cercando di curare gli interessi della sua ex cliente mentre trascurava i propri. Nei momenti di maggiore scoramento si chiedeva a cosa giovasse insistere quando aveva perso quasi ogni speranza di successo. In novembre si sentiva molto depressa e fu sul punto di tornare a Washington, ma Mrs Lincoln le chiese di trattenersi a New York ancora un poco. Forse più tardi, suggerì, quando tutta quella sciagurata vicenda fosse finita, la sarta si sarebbe potuta trasferire da lei a Chicago. «Non sarebbe meglio che veniste a condividere la mia sorte per almeno un anno?» implorava, senza pensare all’esistenza piacevole, produttiva, piena di soddisfazioni che Elizabeth conduceva nella capitale e alla quale desiderava tornare. Il senso del dovere spinse la sarta a restare per aiutare Mrs Lincoln come poteva. Usando i contatti che si era creata attraverso la Contraband Relief Association, scrisse ai leader della comunità nera proponendo che le collezioni di abiti dell’ex first lady fossero esposte nelle chiese nere. L’idea ricevette un’accoglienza calorosa, perché i neri nati liberi e gli schiavi affrancati riconoscevano Abraham Lincoln come loro alleato, ed erano ansiosi di contribuire al benessere della sua famiglia in modo più concreto e determinante di quanto si potesse fare a parole. «Mi avete giudicato bene» rispose in una lettera Frederick Douglass. «Sono disposto a fare il necessario per mettere in una situazione di tranquillità economica la vedova del nostro presidente martire in virtù del suo legame con lui e con il nostro paese». A quello scopo propose di organizzare una serie di conferenze tenute dai migliori oratori del paese, alle quali lui stesso sarebbe stato onorato di partecipare. Il denaro raccolto in questi eventi e le donazioni generose da parte della comunità di colore avrebbero alleviato finalmente le difficoltà economiche di Mrs Lincoln, permettendole di vivere in modo agiato. Sollevata, Elizabeth le scrisse del progetto, felice di avere finalmente buone notizie. Con sua costernazione, però, si sentì rispondere dalla vedova Lincoln che si opponeva all’idea. Per quanto fosse in una situazione disperata, non voleva accettare l’aiuto da parte dei neri. «Non desidero che Mr Douglass o Mr Garnet tengano conferenze per me» decise irrevocabilmente il 2 novembre. Elizabeth, sbalordita e delusa, non ebbe altra scelta: dovette informare Frederick Douglass dei desideri di Mrs Lincoln, e il progetto fu subito abbandonato. Meno di due settimane dopo la vedova cambiò idea, ma il suo rifiuto iniziale aveva sorpreso e contrariato i leader della comunità nera, e la loro disponibilità ad aiutarla si era notevolmente raffreddata. «Scrivetemi, mia cara, la vostra opinione sincera su tutto» la implorò Mrs Lincoln mentre lo scandalo imperversava. «Prego Dio che riusciremo nel nostro intento» scrisse un’altra volta, «anche se, cara Elizabeth, detto tra noi, temo di essere finita tra le mani di persone senza scrupoli». «Ahimè! Ahimè!» si lamentò il giorno successivo. «Che errore terribile è stato tutto ciò!» Mrs Lincoln chiese a Brady e Keyes di restituirle il guardaroba e ordinò a Elizabeth di recuperarlo, ma ogni volta i due intermediari eludevano la sua richiesta. A mano a mano che la vedova si scoraggiava, anche la sarta aveva sempre più difficoltà a mantenere alto il morale. Ai primi di gennaio, in un ultimo, disperato tentativo di raccogliere denaro grazie ai vecchi abiti, Brady e Keyes portarono parte del guardaroba a Providence, con l’intenzione di esporlo a Remington’s Hall, chiedendo la “modica somma” di venticinque centesimi all’ingresso. «La mostra permetterà di guadagnare dei soldi» disse Mr Keyes a Elizabeth, «e siccome il denaro ci serve, questa è l’ultima spiaggia». Presumeva che Mrs Lincoln avrebbe approvato, ed Elizabeth dava per scontato che l’intermediario l’avesse consultata prima di lanciarsi nell’iniziativa, ma avevano entrambi torto. «Perché non avete impedito loro di portare la mia roba a Providence?» volle sapere Mrs Lincoln a giro di posta quando fu informata del progetto, peraltro già in via di realizzazione. «Per l’amor del cielo, parlate con K & B non appena ricevete questa lettera, e fatemi avere indietro la mia roba con il loro conto». Anche se apparvero degli annunci sul Providence Journal per pubblicizzare la mostra, questa non aprì mai, perché i membri del consiglio di contea di Providence rifiutarono di accordare una licenza ai due mediatori. Ma Mrs Lincoln non si rabbonì. Poco dopo la sarta la fece arrabbiare di nuovo senza volere. I bisogni della sua razza, in particolare per quanto riguardava l’educazione, erano sempre al centro dei suoi pensieri, e l’addolorava che l’università di Wilberforce, l’ateneo frequentato da suo figlio, fosse bruciato il giorno dell’assassinio del presidente Lincoln. Anche se era assorbita dall’incarico assegnatole dalla signora, aveva accettato di organizzare una raccolta di fondi per ricostruire l’università. Si era accordata con il reverendo Daniel Payne, uno dei fondatori dell’ateneo che aveva oltretutto testimoniato per farle avere la pensione, per prestare alcune delle reliquie dei Lincoln – il cappello, il mantello, i guanti, la spazzola e il pettine del presidente, oltre alla cuffia e al mantello macchiati di sangue di sua moglie – per una mostra itinerante che avrebbe fatto un giro dell’Europa. Alla notizia di un’altra mostra legata al suo nome, Mrs Lincoln diede in escandescenze. «La lettera con cui mi annunciate che i miei vestiti saranno portati in giro per l’Europa – i vestiti che vi ho dato io – mi ha quasi fatto uscire di senno» rispose subito. «Robert andrebbe fuori di sé se sapesse di una cosa del genere. Se vi resta un briciolo di considerazione per la nostra sanità mentale, vi prego di scrivere al vescovo chiedendo di annullare tutto. Non immaginavo certo che avreste fatto una cosa del genere; non potete immaginare quanto nuocerebbe alla mia situazione già disperata. Che il cielo vi illumini... Per il bene dell’umanità, se non della sottoscritta e dei miei figli, non esponete quegli abiti tristi. Quel pensiero mi ha fatto quasi venire tutti i capelli bianchi». L’aspro rimprovero risultò molto penoso a Elizabeth, che obbedì subito al volere di Mrs Lincoln. Con ormai poche speranze di recuperare una commissione dalla vendita del guardaroba della vedova Lincoln, e sempre più preoccupata per i danni alla sua reputazione arrecati dal suo ruolo pubblico nello “scandalo degli abiti vecchi”, la sarta capì di dover fare qualcosa per sé, senza più affidarsi ad attese poco realistiche. Aveva cominciato a tenere da parte diversi suoi scritti dal giorno d’estate in cui aveva scoperto che la donna cui aveva fatto visitare i campi di schiavi scappati a Washington era Harriet Jacobs, la schiava fuggita dal North Carolina che aveva coraggiosamente pubblicato la propria autobiografia nel 1861, usando uno pseudonimo per sfuggire alla cattura ed evitare di essere restituita al suo padrone violento. Molti altri ex schiavi avevano scritto la storia della propria vita, compreso Frederick Douglass, che lei ammirava molto. Essendo analfabeta, Sojourner Truth aveva dettato le sue memorie a un’amica, e il libro aveva avuto grande successo. Perché Elizabeth non poteva fare lo stesso? Mrs Lincoln e Frederick Douglass, oltre ai Garland, si erano complimentati con lei per come scriveva. Perché non poteva raccontare anche lei la sua storia? Così riprese i propri appunti e cominciò a lavorarvi per trasformarli in un libro di memorie. Intendeva fare in modo che il suo scritto ripercorresse la vita dalla nascita da schiava, attraverso gli anni dolorosi della giovinezza fino alla gioia legata all’ottenimento della libertà. Avrebbe descritto gli anni trascorsi come sarta personale di Mary Lincoln, la frequentazione della Casa Bianca e le sue osservazioni sull’illustre presidente assassinato. Sperava di gettare una luce migliore sulla vedova rivelando i motivi innocenti che l’avevano spinta ad azioni spesso travisate. Infine avrebbe fatto un resoconto particolareggiato del cosiddetto “scandalo degli abiti vecchi” per riabilitare il proprio nome oltre a quello di Mary Lincoln. «Fate tutto ciò che potete, cara Mrs Keckley» l’aveva esortata Mr Douglass mentre progettavano le conferenze, poi andate a monte, per la raccolta di fondi per l’ex first lady. «Nessuno meglio di voi può rimuovere le montagne di pregiudizi nei confronti di quella brava signora». Secondo Elizabeth aveva ragione. Nessuno conosceva Mrs Lincoln quanto lei, e nessuno era in grado di spiegare e giustificare le sue azioni meglio di lei, amica e confidente che capiva le sue buone intenzioni. Poteva ben farlo per la sua amica, e siccome nessun altro si faceva avanti, sarebbe toccato a lei. Lo doveva alla vedova in lutto, ma lo doveva in primo luogo alla memoria del nobile presidente assassinato, che tanto aveva fatto per la sua razza. Decise di provarci per entrambi. 16. Marzo-giugno 1868 All’inizio Elizabeth era troppo imbarazzata per confidare alle conoscenze newyorchesi che stava scrivendo le proprie memorie, sebbene molti amici e clienti nel corso degli anni l’avessero incoraggiata a farlo, giacché aveva avuto fino a quel momento un’esistenza straordinaria. Ma quando le pagine cominciarono ad aumentare, parlò del manoscritto con un amico, poi un altro, e infine la storia giunse alle orecchie di James Redpath, amico di Frederick Douglass, che lavorava nella casa editrice G.W. Carleton & Company. Elizabeth l’aveva già conosciuto ma solo superficialmente. All’epoca in cui viveva a Saint Louis alcuni suoi amici avevano parlato con Redpath, convinto abolizionista, quando era andato in città a intervistare degli schiavi per un libro che stava scrivendo. Si era recato anche spesso alla Casa Bianca per consigliare il presidente Lincoln sulle questioni di Haiti, ma sebbene lei lo avesse visto nella dimora presidenziale, non si erano mai parlati. Avendo però saputo del suo libro di memorie in preparazione, l’editore voleva conoscerla, e amici comuni li presentarono. Lo scozzese dai capelli rossi passò da lei nella pensione di Broome Street, dove Elizabeth sedeva in preda al nervosismo di fronte a lui mentre l’uomo leggeva il primo capitolo del libro, la storia della sua nascita e prima infanzia. Trattenne il fiato in attesa del suo verdetto, finché Redpath non si posò in grembo le pagine scritte a mano e commentò: «L’inizio è promettente». La sarta fece un sospiro di sollievo. «Grazie, signore». «La storia di Little Joe venduto a peso e della sua povera madre che corre dietro al carro che si allontana dalla piantagione...» Mr Redpath scosse il capo con aria grave. «Tragico. Commovente. Immagino che non sappiate se ce l’abbiano mai fatta a ritrovarsi». «Vorrei tanto saperlo» ribatté Elizabeth. «Forse dopo la guerra ritrovarono le tracce l’uno dell’altra, ma Little Joe aveva solo quattro anni quando era stato venduto al negriero di Petersburg. Immagino che sarebbe stato difficile per lui ritrovare le tracce della prima infanzia tra i ricordi ormai sbiaditi». Mr Redpath fece una specie di grugnito e annuì. «Tragico, davvero». Agitò le pagine del manoscritto. «Come procede la storia da questo punto in poi, e dove intendete arrivare?» Spiegò il suo progetto per il libro, e gli occhi dell’editore si illuminarono di interesse quando Elizabeth annunciò che intendeva consacrare una porzione significativa della narrazione agli anni della Casa Bianca e allo “scandalo degli abiti vecchi di Mrs Lincoln”. Intendeva dividere i proventi del libro con l’ex first lady, e rivelare la verità, nel bene e nel male, in modo che il mondo capisse meglio la vedova Lincoln, ingiustamente calunniata da molti. «Ammiro la vostra lealtà» osservò Mr Redpath. «Siate certa che Carleton & Company desidera quanto voi presentare al mondo la verità, nel bene e nel male». Nel giro di qualche giorno Mr Redpath propose a Elizabeth di firmare un accordo con la casa editrice, dicendole che voleva pubblicare il suo libro di memorie il più presto possibile, non oltre la primavera. «Ma sono arrivata solo al punto in cui mi compro la libertà!» protestò Elizabeth, frastornata e combattuta tra la gioia e l’apprensione. L’uomo le assicurò che l’avrebbe aiutata, e così si accordarono per vedersi diverse volte a settimana – anche quotidianamente, all’avvicinarsi della scadenza – per procedere nella stesura del manoscritto. Da quel momento in poi Elizabeth cominciò a occuparsi degli affari di Mrs Lincoln e a mantenersi cucendo di giorno, mentre di notte scriveva nel silenzioso isolamento della sua soffitta. Di sera Mr Redpath passava da lei alla pensione, e nel salotto comune analizzavano il lavoro della notte precedente. Talvolta la necessità e l’urgenza le imponevano di buttare giù di fretta i ricordi invece di scrivere lunghi paragrafi eleganti. In queste occasioni leggeva ad alta voce i suoi appunti, sviluppandoli oralmente quando necessario, mentre Redpath faceva a sua volta delle annotazioni che riportava in ufficio, combinava con le sue e poi sistemava. Elizabeth trascorse il cinquantesimo compleanno lavorando con l’editore al dodicesimo capitolo del libro, che descriveva la partenza di Mrs Lincoln dalla Casa Bianca dopo l’assassinio del marito. Il giorno seguente ricevette una lettera dall’ex first lady, molto abbattuta perché aveva dimenticato il portafoglio, con tutti i soldi del mese, sul tram a cavalli. «È la perdita che merito per essere stata tanto distratta» si lagnò, «ma arriva proprio al momento sbagliato. Problemi e sventure si accumulano; possa la fine arrivare al più presto». Mrs Lincoln aveva ripetuto tante di quelle volte che solo la presenza di Tad le impediva di togliersi la vita che Elizabeth non capì se con “la fine” intendesse la fine dei suoi guai o la fine di tutto. Dopo averle lette e sentite tante volte, lamentele del genere non avrebbero più dovuto turbare Elizabeth, che invece restava sempre sconcertata. Dopo che ogni altro progetto era fallito, Brady e Keyes decisero di mettere all’asta ciò che restava del guardaroba di Mrs Lincoln, cioè quasi tutto. Restia a vendere in quel modo i suoi beni, la vedova insistette perché i due mediatori restituissero ogni cosa a Elizabeth e le facessero avere il conto. Ci misero parecchio tempo, ma alla fine permisero alla sarta di recuperare la merce invenduta e le presentarono un conto di ottocentoventi dollari, in cambio dei loro servizi. Si tennero anche altro denaro, alcune centinaia di dollari, frutto della vendita dell’anello di diamanti di Mrs Lincoln e di alcuni altri oggetti per coprire le spese. Elizabeth imballò subito il tutto e lo spedì a Chicago, e quando l’amica le mandò l’assegno per saldare il conto, lo consegnò di persona a Mr Keyes. Uscendo dal suo ufficio il 4 marzo, ricevuta alla mano, avvertì un’ondata di sollievo, rassegnazione e disgusto. Tutta quella brutta faccenda, che del resto era nata male, si era finalmente conclusa. Purtroppo non solo non aveva procurato a Mrs Lincoln il denaro necessario per il suo sostentamento, ma le era costata centinaia di dollari di commissioni e danni incalcolabili alla sua reputazione. Ma almeno era finita. Sebbene le mancassero casa sua e gli amici di Washington, e fosse ormai diventato urgente tornare ad aprire il proprio laboratorio di sartoria, decise di fermarsi a New York fino al completamento del manoscritto. Siccome non le serviva più vivere dalle parti di W.H. Brady & Co. si trasferì in una stanzetta meno costosa, al quarto piano al numero 14 di Carroll Place, in casa di Amelia Lancaster, parrucchiera delle signore dell’alta società newyorchese. A mano a mano che si avvicinava agli ultimi capitoli del libro, una certa inquietudine spinse Elizabeth a scrivere a Mrs Lincoln per parlarle del progetto. Dopo le conferenze dal contenuto sconvolgente di Mr Herndon, la sarta temeva che la vedova fosse restia, quindi si dilungò nel sottolineare che ogni parola scritta da lei voleva mettere nella miglior luce possibile l’amica. Mary Lincoln fece un unico commento alla confessione della sarta nella sua lettera successiva: «Sembra che chiunque sia passato dalla Casa Bianca durante il mandato del mio adorato marito debba scrivere un libro di memorie. Non posso che auspicare che la mia più cara amica non scriva nulla di sconveniente né divulghi informazioni riservate». Elizabeth aveva sperato in un appoggio più esplicito al suo progetto, ma accettò i commenti della vedova come una tacita autorizzazione a procedere. Non avrebbe potuto comunque abbandonare il progetto; vi aveva investito, insieme a Mr Redpath, troppo tempo e troppa energia. Qualche giorno più tardi la sarta finì di scrivere il resoconto del tentativo disastroso di vendere il guardaroba di Mrs Lincoln, che costituiva l’ultimo capitolo del libro. Dopo che Mr Redpath l’ebbe letto, la elogiò per la sua franchezza e onestà incrollabili nel descrivere quello che doveva essere stato un episodio imbarazzante per lei come per la vedova del presidente. «Incrollabili?» gli fece eco Elizabeth. «Al contrario, ho rischiato spesso di crollare, mentre scrivevo. Devo confessarvi che sono molto perplessa circa l’opportunità di divulgare al pubblico le conversazioni e considerazioni private della signora». Mr Redpath la rassicurò. «Capisco perfettamente. Vi prometto che non sarà pubblicato nulla che rischi di arrecare danno a Mrs Lincoln». Elizabeth fu sollevata. «Ne sono felice». «Avete quasi finito» osservò l’editore, radunando il lavoro di quel giorno e raccogliendolo in una pila ordinata. «Non vedrete l’ora di terminare il manoscritto e di tornare a Washington». «È così» confermò la sarta un po’ perplessa. Per lei, infatti, il manoscritto era finito del tutto. «Cos’altro desiderate che aggiunga?» «Ci sarebbe la prefazione, con cui spiegate il vostro scopo e le vostre qualifiche per scrivere un libro di questo genere». «Oh, sì, certo. Comincerò subito». «Mi è venuta in mente anche un’altra cosa. Le lettere di Mr Douglass e delle signore Garland sono molto utili. Non avete qualche lettera di Mrs Lincoln? Sono sicuro che i vostri lettori le troverebbero affascinanti». Elizabeth avvertì un brivido di eccitazione e paura quando lo sentì parlare dei lettori, come se fossero già un gruppo concreto, numeroso, impaziente di leggerla. «Ne ho molte, ma non le posso includere nel libro, affascinanti o meno che siano. Mrs Lincoln non approverebbe». Mr Redpath alzò le spalle, pensieroso. «Ha permesso che fossero pubblicate diverse lettere sul World». «Sì, e se n’è pentita amaramente, dopo». «Ah». L’editore annuì, riflettendo, e poi suggerì: «Non potreste farmele leggere?» «Siete semplicemente curioso?» «Sono molto curioso, non semplicemente curioso. Leggere le lettere di Mrs Lincoln mi permetterebbe di capire meglio il suo stato d’animo, le sue inclinazioni, e ciò mi sarebbe molto utile durante la revisione del manoscritto. Anche i fatti inclusi nelle lettere mi aiuterebbero a verificare le date e i dettagli che mi avete fornito. E poi c’è la questione della vostra credibilità. Alcuni sciocchi affermeranno che un’ex schiava non potrebbe mai essere l’autrice di un libro tanto bello, né avere avuto un accesso tanto privilegiato alla Casa Bianca. Non sottolineerò mai abbastanza l’importanza della corrispondenza personale nell’attestare l’autenticità di una biografia». «Capisco» disse Elizabeth. Aveva sentito raccontare di altre autobiografie di ex schiavi liquidate, ingiustamente, come opere di fantasia, e conosceva molte persone che, dopo averla conosciuta, affermavano che fosse troppo distinta e abile per essere stata una schiava. Non poteva sopportare che la sua integrità fosse messa in dubbio, ma tali accuse erano probabilmente inevitabili. Se poteva impedirle o almeno ridurne il numero condividendo con il proprio editore le lettere di Mrs Lincoln, avrebbe fatto bene ad agire in questo senso. Salì nella sua stanzetta sotto i tetti e tornò con un pacco di lettere dell’ex first lady, legate con un fiocco nero avanzato dal bordo di una delle sue molte cuffie. Le consegnò a Mr Redpath precisando che si trattava di ricordi preziosi e che voleva recuperarle intatte quando avesse finito di consultarle, e che dovevano aiutarlo nella revisione del manoscritto, ma in nessun caso avrebbero dovuto essere incluse nel libro. L’editore le assicurò che non avrebbe inserito nulla delle lettere di Mrs Lincoln che potesse metterla in imbarazzo, e lasciò Elizabeth alla prefazione. Da sola, in camera sua, tenne la penna sospesa sulla pagina, incapace di cominciare. Fu colpita da un dubbio improvviso: chi era lei per credersi capace di scrivere un libro? Scacciò subito quel pensiero, infastidita dalla propria timidezza. Chi era? Questa era la vera domanda. Il libro l’aveva scritto, quindi la domanda sulla capacità o meno di farlo aveva appena avuto risposta. Ora restava da capire perché l’avesse fatto, e cosa si fosse proposta. «Spesso mi è stato chiesto di raccontare per iscritto la mia vita, giacché chi mi conosce sa che è stata ricca di eventi» scrisse. «Ho finito per cedere alle insistenze dei miei amici, e ho buttato giù in fretta alcuni degli eventi più importanti che hanno fatto di me quella che sono. La mia esistenza tanto avventurosa può parere inventata a un lettore imparziale, ma tutto ciò che ho scritto è vero; ho omesso parecchio, ma non ho ingigantito nulla». Fece una pausa. Ebbe una visione improvvisa: Mrs Lincoln che prendeva in mano il libro, esaminava la copertina e cominciava a sfogliarlo, con aria sempre più accigliata a ogni paragrafo che leggeva. Trasse un sospiro profondo, soffiò fuori piano l’aria e intinse di nuovo la penna nell’inchiostro. «Scrivendo come ho fatto, so che le critiche non mancheranno». Avrebbe potuto stendere una lista accurata dei più accaniti detrattori. «Ma prima di giudicarmi con severità, i critici leggano e valutino con attenzione le mie spiegazioni». I suoi denigratori avrebbero probabilmente rifiutato di farlo, ma chiederlo non costava nulla. Elizabeth si mise poi a riflettere sul tema della schiavitù, sul quale si sarebbe soffermata in termini più personali e profondi all’inizio del libro. Poi ripensò a Mrs Lincoln. «Sarò forse accusata di avere scritto con troppa libertà su alcune questioni, in particolare legate a Mrs Lincoln» riconobbe. «Io non lo credo, o almeno, se l’ho fatto, sono stata animata dalle ragioni più nobili. Mrs Lincoln con il suo stesso comportamento ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico. Ha superato il limite che protegge l’inviolabilità della vita privata e, così facendo, si è esposta alle critiche da parte dell’opinione pubblica». Era giusto esprimersi in quel modo? Il dubbio si insinuò nella sarta, che smise di scrivere. Mary Lincoln non si era candidata e non era stata eletta first lady; quel ruolo le era stato attribuito in virtù delle scelte e azioni di suo marito. Era, bisognava ammetterlo, un ruolo che aveva amato, un titolo al quale aveva aspirato fin dall’infanzia. Aveva adorato l’attenzione della gente, fino a quando quest’attenzione era stata positiva, e aveva certamente apprezzato i vantaggi e i privilegi dell’essere, come lei stessa talvolta si era definita, “Mrs President”. Quindi, decise Elizabeth, era giusto affermare che Mrs Lincoln avesse scelto una vita pubblica. Ciononostante, era stata giudicata con troppa severità. «La gente ignora del tutto la storia segreta delle sue transazioni, limitandosi a giudicarla sulla base di ciò che era apparso in superficie». La scrittrice, indignata, rimproverò alcuni personaggi in vista che erano stati particolarmente duri con lei e certi giornali che avevano usato uno scherno eccessivo nell’esporre le colpe della vedova del presidente, ma poi ci ripensò e cancellò quelle righe. «Mrs Lincoln può essere stata imprudente, ma siccome le sue intenzioni erano buone dovrebbe essere giudicata con più clemenza». Se fosse riuscita a convincere i suoi ipotetici lettori di questo, si sarebbe ritenuta soddisfatta. A un tratto si chiese se Mr Herndon avesse coltivato le stesse speranze quando scriveva il testo delle sue conferenze. Per un istante si sentì profondamente demoralizzata, ma poi ricordò con fermezza a se stessa che le farneticazioni di Herndon non avevano nulla in comune con il suo libro, se non il fatto che riguardavano anch’esse i coniugi Lincoln. Le loro motivazioni – e l’onestà dei loro scritti – non potevano essere più diverse. Eppure continuava a essere preoccupata. Mrs Lincoln sarebbe stata del suo stesso avviso? «Se ho tradito la fiducia di qualcuno in ciò che ho scritto, l’ho fatto solo allo scopo di presentare Mrs Lincoln sotto una luce migliore agli occhi del mondo» scrisse con mano ferma. «Un’indiscrezione di questo tipo, se così la si può definire, è sempre perdonabile». Trasse un respiro profondo e si fece forza; la confessione successiva non era facile. «È in gioco la mia reputazione, oltre a quella di Mrs Lincoln, perché sono stata al suo fianco nei momenti più importanti della sua vita. Sono stata la sua confidente e, se lei è accusata di qualcosa, le stesse critiche vanno rivolte a me, che ho contribuito a tutte le sue iniziative». Per difendersi doveva difendere la signora per la quale si prodigava, e scrivendo tali parole Elizabeth si rese conto che proprio quello l’aveva indotta a scrivere l’autobiografia. Era stata molto ammirata per la sua integrità e dignità, ma le sfortunate vicende legate al 609 di Broadway avevano gettato l’ombra dello scandalo anche sulla sua reputazione fino ad allora irreprensibile. Doveva redimersi, e non poteva farlo se non riscattando al contempo anche la vedova del presidente. Elizabeth finì la prefazione, sperando di avere scritto tutto ciò che desiderava Mr Redpath e che era necessario precisare. I lettori potevano sempre ignorare la sua lunga spiegazione e concludere per conto loro che le sue ragioni non erano oneste, ma almeno lei sapeva la verità. Sapeva anche che nulla di ciò che aveva scritto poteva mettere in cattiva luce Mrs Lincoln più di quanto non lo fosse già, e quindi i segreti che rivelava non potevano essere dannosi. «Non intendo difendere a spada tratta la vedova del nostro compianto presidente» sottolineò. I lettori più diffidenti avrebbero affermato che le sue parole sulle colpe dell’ex first lady non erano sincere perché loro due erano amiche. Doveva convincerli del contrario. «Vorrei che il mondo la giudicasse com’è davvero, libera dalle esagerazioni degli elogi e degli scandali. Il lettore delle pagine che seguono scoprirà che ho scritto su di lei con estrema franchezza, esponendo le sue colpe oltre che riconoscendole le motivazioni oneste che la animavano». Aveva peccato in un senso o nell’altro senza volere? Il dubbio l’aveva tormentata a ogni parola che scriveva. Aveva cercato in ogni modo di essere giusta, e Mr Redpath le aveva assicurato che ci era riuscita. Sperava che il mondo fosse d’accordo, e soprattutto che lo fosse Mrs Lincoln. Il 1° aprile, Mr Redpath le portò una copia dell’American Literary Gazette and Publishers’ Circular, gliel’aprì a una pagina che aveva contrassegnato e le indicò una pubblicità in cima alla colonna sinistra. «Io e Mr Carleton, oltre a tutti gli altri dipendenti della casa editrice, siamo estremamente orgogliosi di avervi come nostra autrice» dichiarò. «Ci aspettiamo che il libro abbia grande successo». Elizabeth distolse lo sguardo dalla pagina per ringraziarlo, ma tornò subito a fissare l’annuncio. G.W. Carleton & Co. pubblicherà ai primi di aprile un libro eccezionale intitolato Dietro le quinte L’autrice è Mrs Elizabeth Keckley, schiava per trent’anni di famiglie sudiste tra le più illustri. Dopo aver acquistato la libertà, durante l’organizzazione della ribellione divenne confidente della moglie di Jefferson Davis, e fu allora che, stando “dietro le quinte”, udì per la prima volta il mormorio di quel mostro, la secessione. Dall’inizio della ribellione fino a oggi è stata la sarta, confidente e tuttofare della vedova di Abraham Lincoln. Ha trascorso molto tempo alla Casa Bianca, a stretto contatto con la famiglia del presidente. Conoscendo intimamente Mrs Lincoln e tutta la sua famiglia, oltre a una varietà di membri illustri della società di Washington, ha molti commenti interessanti da fare su uomini e situazioni della Casa Bianca, del Congresso, di Washington e di New York. Nel libro rivela i retroscena dello sfortunato tentativo di vendere il proprio guardaroba da parte di Mrs Lincoln, che dissiperanno molte impressioni errate nella mente del pubblico e porranno la vedova del presidente in una luce migliore. Il libro è ricco di episodi emozionanti e tragici lungo un arco di tempo di quarant’anni. È scritto con passione e sincerità e, insieme alla sua autrice, coscienziosa e piena di talento, non mancherà di suscitare scalpore a livello mondiale. Tutto ciò che è scritto corrisponde al vero. Volume di 400 pagine. Rilegato in tela. Illustrato con un ritratto dell’autrice. Prezzo: 2 dollari. «Cosa ne dite?» chiese Mr Redpath sorridendo. «Dico che è meraviglioso» rispose lei, con un sorriso incerto. Anche se erano mesi che lavorava alla sua autobiografia, la pubblicità gliel’aveva fatta apparire reale, concreta, tangibile. Domandò con qualche esitazione: «Dice che sono stata una schiava per trent’anni, ma in realtà sono stata in schiavitù trentasette anni, quasi trentotto». «Una differenza insignificante» le assicurò l’editore. «Trenta è cifra tonda, sta meglio. Anche se avete ragione nell’affermare che non è del tutto accurato, suona meglio nella pubblicità». «Certo» convenne Elizabeth, rimpiangendo la sua critica. «Grazie per le parole di encomio nei confronti miei e del libro. Lo fate apparire tanto interessante che, se non l’avessi scritto io, sarei la prima a mettermi in fila per comprarlo». Mr Redpath sorrise. «Ve li meritate i complimenti. Il libro è eccezionale, e la sua autrice ancora di più». Lei rimase allibita quando le prese la mano e se la portò alle labbra. «È stato un onore lavorare con voi, Mrs Keckley. Il privilegio non sarebbe stato maggiore se avessi avuto a che fare con la first lady in persona». «Non diteglielo mai» lo avvertì subito la sarta senza riflettere. Redpath, ridendo, le assicurò che non l’avrebbe fatto. Qualche giorno dopo l’editore si recò di nuovo da lei e le consegnò una copia del libro. Per un attimo Elizabeth lo tenne in mano senza muoversi, incredula. «Impara a leggere e scrivere bene» l’aveva esortata suo padre. Come sarebbe stato orgoglioso di lei, sapendo che era diventata un’autrice. Le mani le tremavano e, mentre Mr Redpath la osservava con un sorriso, aprì la copertina di tela rossa e voltò le prime pagine vuote. Si soffermò sull’incisione che raffigurava l’autrice, e che non le parve molto somigliante. Ma non importava. Poi giunse alla pagina del titolo. Dietro le quinte di Elizabeth Keckley, ex schiava divenuta sarta e amica della moglie di Abraham Lincoln, ovvero trent’anni da schiava e quattro anni alla Casa Bianca. E così Carleton & Company non aveva corretto il numero di anni in cui era stata in schiavitù. Ebbene, si disse, dopotutto che male c’era se la gente la credeva un po’ più giovane? «Come vi sentite a vedere le vostre parole stampate per la prima volta?» le chiese lui. «È magnifico» rispose Elizabeth. Il cuore le batteva tanto veloce che dovette trarre un respiro profondo per calmarlo. Giunse alla prefazione e lesse di nuovo le parole familiari che fino ad allora aveva visto scritte solo nella sua grafia irregolare. Poi un’espressione insolita la colpì, quindi un’altra. Le sue brevi digressioni sulla schiavitù erano state pesantemente rimaneggiate. Il senso generale era rimasto, ma il linguaggio era troppo elaborato per essere di suo gradimento. Avvertendo lo sguardo di Mr Redpath su di lei, ebbe l’accortezza di non lasciar trapelare la sorpresa e la delusione. Lo sapevano tutti che gli editori cambiavano le parole degli autori, si rimproverò. E l’autore di un primo libro aveva bisogno di un intervento anche più cospicuo, soprattutto se proveniva da un editore tanto esperto. Sfogliò attentamente il libro, e tornò felice quando vide che il resto dell’autobiografia non aveva subito cambiamenti altrettanto pesanti. Poi giunse alla fine della narrazione e trovò un’appendice che non si aspettava. La gioia si trasformò in stupore atterrito quando scoprì le lettere di Mrs Lincoln che aveva prestato all’editore per la revisione del manoscritto. Erano state riprodotte quasi parola per parola, con la semplice omissione di qualche frase senza importanza. Ironicamente l’avvertimento di Mrs Lincoln che le aveva chiesto di non divulgare «informazioni riservate» era stato rispettato, visto che quella frase era stata riportata addirittura in stampatello. Ebbe l’impressione che i polmoni le si svuotassero d’aria. «Mr Redpath» riuscì a balbettare con voce strozzata. «Le lettere private di Mrs Lincoln...» «Sì. Abbiamo pensato che contribuissero all’autenticità della vostra opera». «Ma io ve le ho prestate solo perché vi fossero di aiuto nella revisione» protestò Elizabeth sconvolta. «Avevate promesso di non pubblicarle». Mr Redpath si accigliò. «No, Mrs Keckley, no» obiettò, scuotendo il capo. «Abbiamo convenuto di non pubblicare nessuno stralcio delle lettere che avrebbe imbarazzato Mrs Lincoln». Lei gli tese il libro, sfogliando velocemente l’appendice. «Vi assicuro che tutto questo la imbarazzerà!» «Non sono d’accordo» obiettò lui. «Le lettere rivelano il suo pensiero, i motivi alla base delle sue azioni. Avevate sempre detto che, se la gente avesse capito le sue buone intenzioni, sarebbe stata più comprensiva nei confronti delle sue scenate e disavventure. Non capisco quindi come potrebbe essere imbarazzata». Non riusciva a capirlo perché non voleva. Elizabeth, sentendosi male, si accasciò su una sedia con il libro in grembo. Mary Lincoln avrebbe visto la pubblicazione della sua corrispondenza privata come il tradimento peggiore. Non l’avrebbe mai perdonata. «Mrs Keckley, non preoccupatevi». James Redpath era davvero sorpreso della sua reazione, oppure era un ottimo attore. «Queste lettere – anzi, tutto quanto il libro – serviranno perfettamente allo scopo. Indurranno i critici della vedova ad abbandonare i propri pregiudizi e a essere solidali con lei. Siatene certa». Lei strinse le labbra e annuì, sperando che avesse ragione. In ogni caso non serviva a niente discutere con lui. Quello che era fatto, era fatto. Non poteva certo passare da una libreria all’altra, da un chiosco di giornali all’altro, a strappare l’appendice da ogni copia di Dietro le quinte. In realtà la predizione dell’editore si rivelò in certa misura azzeccata, ma non nel modo in cui l’aveva intesa lui. Il 12 aprile una donna per la quale di tanto in tanto svolgeva lavori di cucito, originaria di Boston, l’accolse con il misterioso commento: «Sono contenta di vedere che state bene. Non dovreste curarvi di ciò che dicono a Springfield». Elizabeth sentì il cuore in gola e pensò subito a Mrs Lincoln. «Cosa dicono a Springfield?» L’espressione sorpresa della cliente rivelò che pensava lo sapesse già. All’inizio non glielo volle spiegare, ma dopo molte insistenze raccontò a Elizabeth che era apparso uno stralcio del libro sullo Springfield Daily Republican. Sebbene la sarta fosse sollevata nello scoprire che la donna alludeva a Springfield nel Massachusetts, e non alla residenza della famiglia Lincoln, si dovette comunque fare forza per chiedere alla cliente di portarle l’articolo. Il titolo era Lettura da cucina e da letto, e la critica – se aveva un senso chiamarla critica, giacché il libro doveva ancora essere pubblicato – era peggiore di quanto Elizabeth immaginasse. Una casa editrice di New York dalla dubbia moralità ha annunciato la prossima uscita di un libro intitolato Dietro le quinte di Elizabeth Keckley, che afferma di essere stata la domestica e confidente della moglie di Jeff Davis durante le fasi preparatorie della ribellione, e la sarta della moglie di Lincoln durante la secessione. Può darsi che questo libro sia di buon livello, interessante, istruttivo e dignitoso; ma è molto più probabile che sia un’opera sensazionalistica del tipo peggiore, scritto per ordine del servizio segreto del generale Baker, immorale, falso, scandaloso e indecente. L’idea stessa di servitori che vengono convinti a scrivere libri sui loro datori di lavoro, istruiti su cosa dire fino al rimbambimento da parte di editori senza scrupoli, aiutati nella prosa zoppicante e poco sciolta forse dagli stessi uomini che pubblicano i giornali scandalistici nelle nostre città, è ripugnante a chiunque abbia un minimo di educazione. Speriamo che si riveli un buon libro. Temiamo però che sia pessimo. All’inizio Elizabeth era troppo sbalordita per parlare. «Non dovrebbero leggere il mio libro prima di condannarlo?» riuscì infine a mormorare. «Indecente? La mia autobiografia? Cosa mi avrebbero suggerito di scrivere gli “editori senza scrupoli”? Possibile che credano a tutti quegli orrori?» «Mi dispiace molto» disse la sua cliente, profondamente desolata. «Vorrei non averne parlato». «Non avete nessuna colpa». La sarta inghiottì lacrime di rabbia e lottò per mantenere il controllo. «Siete solo la messaggera di cattive notizie. Non le avete scritte voi, quelle crudeltà». «I giornalisti si rimangeranno tutto dopo avere letto il libro» la consolò l’altra donna. «Per quanto mi riguarda, il tentativo di dissuadermi non ha fatto che aumentare in me la voglia di leggerlo». Elizabeth riuscì a fare un sorriso amaro. «Forse, ma voi mi conoscete». «Pensateci, però» rifletté ad alta voce la donna. «Il Republican potrebbe avervi fatto un favore». «In che senso? Non capisco». «Hanno sollevato curiosità intorno alla vostra storia. Ora tutti vorranno comprare il libro. Lo leggeranno e si faranno un’opinione personale. Vedrete». La sarta sperava che avesse ragione, ma una nube pesante di cattivi presagi sembrava oscurare il sole, gettando un’ombra su quello che doveva essere un giorno radioso e felice. I suoi amici di New York non si lasciarono scoraggiare dalle previsioni pessimiste del giornale, e si sentirono invece immensamente fieri di lei ed emozionati per il libro, tanto che la sua padrona di casa organizzò una festa il giorno della pubblicazione. Emma, i Lewis e altri amici inviarono telegrammi di congratulazioni da Washington. Il loro entusiasmo rincuorò un poco Elizabeth, ma Mrs Lincoln non aveva risposto alla lettera con cui la sarta le aveva confessato la divulgazione pubblica della loro corrispondenza privata, e il silenzio da parte di una scrittrice tanto prolifica non parve di buon auspicio. Il 15 aprile apparve una nuova pubblicità sull’American Literary Gazette and Publishers’ Circular, stavolta con un nuovo titolo destinato a fare colpo che descriveva l’autobiografia come «un cataclisma letterario». Il resto della descrizione era più o meno uguale, anche se quello che Elizabeth aveva da dire «riguardo a persone e situazioni nella Casa Bianca» non era più descritto semplicemente come «interessante», ma «stupefacente». «Oh, no, no, no» mormorò, mettendo da parte il giornale. Il suo libro di memorie, introspettivo e vibrante, era stato trasformato in una pagliacciata. Dietro le quinte scandalizzò la stampa, che fu subito implacabile e feroce nelle critiche. Il Citizen di New York: «Il pubblico americano non si ribella a essere considerato tanto plebeo nei gusti letterari da tollerare le chiacchiere clandestine delle serve nere?» Il National Intelligencer di Washington: «Dove andremo a finire? Quale famiglia con della servitù non rischia di veder distruggere la propria pace e serenità da creature traditrici come la Keckley?» Il New York Times, dopo aver presentato tre colonne di citazioni e aver osservato che Mrs Lincoln era in ristrettezze economiche: «Mrs Keckley, apprendiamo, è anch’essa in difficoltà. Mrs Lincoln non può pagarla, e si mantiene facendo lavoretti di cucito e scrivendo un libro. Avrebbe fatto meglio a limitarsi ad ago e filo. Non possiamo evitare di considerare molte rivelazioni del libro come frutto di un’indiscrezione assoluta. Mrs Lincoln apparentemente si fidava di lei, e quella donna, senza dubbio mal consigliata, ha tradito tale fiducia. Ma ricordiamo che il libro può solo in parte essere considerato suo. Si individua in ogni sua pagina la mano di uno scrittore esperto, che ha conti da saldare e pregiudizi da alimentare. Come testo scandalistico, il libro è un fallimento totale. Mrs Keckley sa ben poco della vita alla Casa Bianca, e arricchisce gli scarsi aneddoti ed episodi con citazioni dai giornali, riflessioni morali e altri espedienti di quel tipo. Il pubblico sarà deluso quando leggerà il libro. Lo troverà meno piccante, meno scandaloso di quanto se lo aspetti, considerando la fonte, mentre dal punto di vista letterario ha ben poca levatura». E lo Springfield Daily Republican sembrò fin troppo felice di confermare che le previsioni catastrofiche sulla qualità del libro si erano dimostrate giuste. «Si potrebbe immaginare che al pubblico siano state propinate informazioni su Mrs Lincoln e sulle sue faccende ad nauseam» scrisse sprezzante il giornalista, «ma lo scandalo è una merce che incontra sempre, e questo libro ne è pieno». Le teorie sulla diffusione del sapere e l’educazione delle masse vanno benissimo, ed entro certi limiti funzionano perfettamente. Non è piacevole, questo è certo, avere una cuoca tanto interessata alla letteratura da portarsi in cucina tutti i vostri libri preferiti, o da insistere per leggere per prima il giornale mentre fa colazione, al mattino; o una serva che preferisce soffermarsi sulle vostre lettere invece di svolgere le sue normali mansioni. Ma tutto ciò è anche sopportabile, armandosi di pazienza, se si pensa ai molti vantaggi che un briciolo di istruzione può portare a Bridget o Dinah. Ma quando Bridget o Dinah si mettono a scrivere libri invece di leggerli, e scelgono per argomento le conversazioni e gli eventi che si verificano nell’intimità della cerchia familiare, suggeriamo, con tutto il rispetto, che si stia esagerando. A un certo punto bisogna dire basta, e sosteniamo che lo si debba dire prima che tutte le serve vengano educate al punto da divulgare per iscritto la storia privata delle famiglie per cui lavorano. Tali accuse ferivano e disgustavano Elizabeth, eppure non riusciva a smettere di leggere, né riusciva a ignorare altre critiche e condanne che minacciavano di seppellirla sotto una valanga di carta e inchiostro. Le recensioni erano sempre cariche di scherno e di condanna, e spesso contraddittorie: Dietro le quinte era scritto male, ma era anche scritto così bene che non poteva scaturire dalla penna di una «serva nera sleale». La sua autobiografia era spazzatura senza valore, eppure le citazioni occupavano diverse colonne dei giornali. A parte il Chicago Tribune, che enfatizzò la presenza nel libro di figure di spicco dell’Illinois, definì alcuni capitoli «interessanti» o «toccanti» e concluse che l’autrice era una donna «di intelligenza superiore al normale», le recensioni erano unanimi nella loro indignazione e nel loro giudizio sprezzante, e sembravano meno interessate a commentare il libro che a mettere alla berlina Elizabeth per averlo scritto. Con suo stupore gli stessi giornali che negli ultimi otto anni si erano scagliati contro Mrs Lincoln ora divennero suoi strenui difensori contro la malvagia «spiona della Casa Bianca» alla quale aveva incautamente dato fiducia. In quel senso, la previsione di Mr Redpath, secondo cui Dietro le quinte avrebbe spinto l’opinione pubblica ad appoggiare Mrs Lincoln, si avverò. Mr Redpath non andava più a trovarla al 14 di Carroll Place, probabilmente perché si erano separati con una certa freddezza dopo la stampa delle lettere dell’ex first lady, ma quando gli attacchi contro di lei e il suo libro divennero insopportabili, Elizabeth gli fece visita in ufficio e gli chiese come doveva comportarsi riguardo a quelle recensioni tremende e ingiuste. «Ignoratele» si limitò a consigliarle. «Non posso» obiettò la sarta. «E non dovrei. Hanno torto. Questi critici non sono in grado di citare esempi concreti di scrittura scadente nel mio libro. Sono solo capaci di affermare che non vale nulla, restando sul vago, e mi attaccano in quanto persona. E continuano a parlare di me come della servitrice nera di Mary Lincoln, come se fossi una cameriera o una sguattera e non una sarta rinomata. Dicono che ho infangato la memoria del presidente Lincoln, un uomo che ammiravo e rispettavo con tutto il cuore. Non posso restare a guardare senza reagire». Vedendo che era decisa, Mr Redpath le suggerì con riluttanza di scrivere una replica, che avrebbe lui stesso trasmesso al direttore del Citizen di New York, uno degli autori più celebri che pubblicava le sue opere presso G.W. Carleton & Company. Immediatamente Elizabeth impugnò la penna per scrivere la propria difesa, chiedendo ai critici di leggere il suo libro, oltre alle pagine e pagine che giornali rispettati di tutto il paese avevano dedicato alla «turpe crociata» contro Mrs Lincoln. Chi di loro, domandò, aveva davvero tradito e offeso l’ex first lady? «È per via della mia pelle nera e della condizione di ex schiava che vengo messa alla gogna?» chiese. «Sono nata schiava, non è colpa mia; e dopo avere comprato onestamente la mia libertà non mi è permesso di esprimere, di tanto in tanto, un’opinione da donna libera?» La risposta unanime del pubblico sembrava essere che no, non poteva. Poco tempo dopo che la sua risposta fu pubblicata sul Citizen, qualcuno le lasciò un pacchettino piatto sulla soglia della pensione, avvolto in carta da pacchi con scritto in stampatello MRS KICKLEY. Curiosa, Elizabeth lo aprì, e scoprì che l’errore che compariva nel cognome non era dovuto al caso. Il dono del suo nemico anonimo era un opuscolo intitolato: Dietro le finte, scritto da una negra al servizio di Mrs Lincoln e Mrs Davis. La presunta autrice, «Betsey Kickley (negra)», aveva firmato con una X, segno che era analfabeta. Con il cuore che batteva forte lo aprì e percorse le prime righe del testo, abbastanza da capire che era una parodia crudele del suo libro. Disgustata lo buttò via, ma non riuscì a cancellare dai suoi pensieri un’immagine che la tormentava: pile e pile di quegli opuscoli che venivano prelevati da chioschi e scaffali di librerie, e lettori di tutto il paese che se li gustavano con feroce soddisfazione. La sua autobiografia, non tardò a scoprire, era diventata ben più difficile da trovare. Le polemiche e l’accusa che fosse un volume «indecente» avevano scoraggiato molti librai dall’ordinarlo, e con il passare del tempo Elizabeth sentì voci, apparentemente affidabili, sul fatto che Robert Lincoln, furioso, avesse chiesto all’editore di ritirare il libro e, quando non vi era riuscito, insieme ai suoi amici aveva comprato tutte le copie che era riuscito a trovare e le aveva bruciate. A Elizabeth pareva di vivere in un incubo. Scrisse lettere appassionate di scusa a Mrs Lincoln, ma non ricevette mai la benché minima risposta. Quando scoprì che Robert Lincoln si trovava in città gli mandò un biglietto implorandolo di riceverla, ma lui rifiutò. I bianchi erano solidali nell’ostilità che mostravano a lei, donna nera che aveva osato giudicare una persona in una posizione sociale tanto più elevata della sua, e perfino chi non provava simpatia per l’ex first lady accusò la sarta di averla tradita e di avere disonorato la memoria di Abraham Lincoln rivelando momenti intimi della loro vita familiare. La comunità nera ce l’aveva con lei perché temeva che i datori di lavoro bianchi, prevedendo la pubblicazione di libri che rivelassero i loro segreti, sarebbero stati restii ad assumere personale di colore. Elizabeth, demoralizzata, piena di indignazione, delusa e imbarazzata continuò ad andare avanti a testa alta, perfino quando diverse delle sarte per le quali aveva lavorato a un tratto smisero di affidarle incarichi. Le entrate diminuirono, e le vendite del libro diventarono per lei più importanti che mai. Quando andò a trovare Redpath per chiedergli come stessero andando, lui la informò che non erano ancora stati venduti abbastanza esemplari per coprire i costi di stampa e distribuzione. Per aumentare le vendite propose di organizzare delle conferenze pubbliche, una a New York e una a Boston, e se queste fossero andate bene avrebbero pensato ad altre città. «Chicago, magari?» suggerì lei, desiderosa di un’opportunità per fare visita a Mrs Lincoln e presentarle le scuse e spiegazioni che meritava. «Vedremo» rispose Mr Redpath affabile. Durante la terza settimana di giugno Elizabeth lesse brani del proprio libro a un pubblico di una trentina di persone in una libreria di Manhattan; un terzo di loro erano buoni amici venuti a sostenerla. Gli altri, capì dalle domande e dai commenti che fecero, potevano essere divisi in tre gruppi: i curiosi, attratti dalle accuse di indecenza e dalle descrizioni scandalose di cui aveva parlato la stampa, e speranzosi di assistere in prima persona a entrambe; gente che disprezzava Mrs Lincoln e che era ben felice di vederla umiliata; e secessionisti irriducibili e altri nemici politici, che volevano trovare conferma dei loro sospetti di tradimenti, indecenza e corruzione nell’amministrazione Lincoln. A fine serata, solo gli amici di Elizabeth andarono a casa soddisfatti. «Mrs Elizabeth Keckley, la spia della Casa Bianca, cerca di aumentare le vendite del suo libro scandaloso leggendone dei brani in pubblico» commentò perfido lo Springfield Daily Republican due giorni dopo. «Ci ha provato a New York due giorni fa, ma è fallita miseramente nell’intento, come ben meritava. Stasera ci riprova a Boston. Legge peggio ancora di come scrive, ed è tutto dire». Sebbene l’annuncio del giornale minacciasse di attrarre ancora una volta uno stuolo di curiosi, il pubblico all’evento di Boston presso Lee & Shepard fu anche meno numeroso di quello presente alla prima lettura, ma composto dello stesso tipo di persone. Elizabeth fu quindi sollevata, più che delusa, quando Mr Redpath la informò che Carleton & Company non intendeva organizzare altre conferenze per lei, sebbene la incoraggiassero a proseguire su quella strada per conto suo, se lo desiderava. E lei non lo desiderava assolutamente. Aveva troppa dignità per lagnarsi dell’ingiustizia della sua situazione. Capiva di essere ormai irrimediabilmente invischiata nello scandalo, e ogni movimento che faceva per uscirne la precipitava sempre più giù. Era impossibile contare il numero di volte in cui aveva osservato Mrs Lincoln dibattersi in situazioni simili. Il suo istinto le aveva suggerito di combattere strenuamente per salvare la propria reputazione mandando decine di lettere per sollecitare un aiuto, evocando il potere legato alla funzione del marito che doveva procurarle, a suo dire, un atteggiamento di deferenza, sfruttare l’influenza che era in grado di esercitare per stabilire alleanze e appianare i contrasti; quando tutto il resto era fallito, fuggiva e lasciava gli amici a raccogliere i cocci al posto suo. Le tattiche di Mrs Lincoln non avevano mai funzionato, per quanto Elizabeth riuscisse a ricordare. Se l’esempio dell’ex first lady doveva esserle di lezione, le aveva mostrato che l’unico modo per risollevarsi da uno scandalo consisteva nel vivere un’esistenza esemplare da quel momento in poi. Ed era proprio ciò che intendeva fare. 17. 1868-1893 Quando le acque si calmarono, Elizabeth tornò discretamente a Washington, dove Virginia, Walker ed Emma l’accolsero con calore, senza accennare al libro o allo scandalo. Riaprì il laboratorio di sartoria, richiamò le assistenti e scrisse alle clienti di un tempo annunciando il proprio ritorno, ma durante la sua lunga assenza molte delle sue aiutanti avevano trovato un’altra datrice di lavoro o si erano messe in proprio. Alcune delle sue clienti preferite le ordinarono degli abiti per la stagione sociale invernale, ma molte non si fecero sentire. Sebbene non lo dicessero, Elizabeth era certa di averle perse per colpa del libro. Scrisse di nuovo a Mrs Lincoln chiedendole perdono, per farle sapere che era tornata a Washington, se mai avesse voluto rispondere. Se l’ex first lady fosse tornata nella capitale, si ripromise di scusarsi profusamente di persona. E le avrebbe fatto un regalo sincero al quale lavorava da tre anni e che non era ancora finito: la trapunta che aveva cominciato sul treno per Chicago, quando aveva accompagnato la vedova affranta al momento di lasciare la Casa Bianca. Composta di ritagli di seta avanzati dagli abiti di Mrs Lincoln, nella trapunta predominavano rosso, blu, oro e bianco, ma apparivano anche altri colori come beige, lavanda e rosa antico. Al centro aveva collocato l’applicazione imbottita di un’aquila calva ad ali spiegate che stringeva una bandiera tra gli artigli, con sotto ricamata la parola Liberty. Attorno all’emblema centrale aveva cucito tre bordi concentrici, il primo di seta dorata ricamata con fiori lungo i lati e con angoli di seta nera. Il secondo era più semplice, con inserti beige in alto e in basso e a strisce bianche e nere lungo i lati. Poi aveva aggiunto dei bordi blu scuro e grigio-blu, con angoli marrone chiaro, decorati di fiori, rametti e altre decorazioni. Aveva progettato di incorniciare il medaglione centrale con esagoni dal motivo floreale, raggruppati sette a sette e separati da rombi dai colori contrastanti, ma quella parte non era ancora finita. E non pensava che si sarebbe fermata lì; sarebbe stato necessario aggiungere un altro bordo concentrico o due, e forse un’altra decorazione, come un bordo smerlato o a frange, ma non aveva ancora deciso. Per un po’ vi lavorò alacremente – meno clienti significava meno abiti, e più ore di inattività da occupare – sperando di completarla in tempo per regalarla a Mrs Lincoln la prossima volta che fosse andata a Washington. Ma anche se la vedova del presidente tornò nella capitale in settembre per il matrimonio del figlio Robert con Mary Harlan, sembrava avere una vera e propria avversione per Washington, perché da quanto Elizabeth ne sapeva non fece altre visite. Era sicura che l’avrebbe saputo, in caso contrario, perché i giornali continuavano a informare il pubblico sui suoi spostamenti, le sue difficoltà finanziarie e i suoi tentativi di convincere il governo ad aumentarle la pensione. Fu dai giornali che seppe che era partita insieme a Tad per l’Europa, che progettavano di percorrere in lungo e in largo. Mrs Lincoln dichiarò di voler partire per migliorare il suo stato di salute, che negli ultimi tempi non era stato eccellente, e per riprendersi dalle delusioni e umiliazioni subite in patria. Alcuni burloni, citando la famigerata autobiografia della sua sarta, ricordarono quanto da lei dichiarato un tempo sul fatto che avrebbe preferito lasciare il paese e assentarsi per tutto il suo mandato se il generale Grant fosse stato eletto presidente degli Stati Uniti. Forse, suggerirono con insolenza, era per quello che progettava un viaggio tanto lungo. Elizabeth, invece, non credette neppure per un attimo che Mrs Lincoln avesse portato all’estero Tad per evitare l’amministrazione di Grant. Senz’altro voleva lasciarsi alle spalle il dolore e i brutti ricordi, uno dei quali, la sarta presumeva, era la brusca fine della loro amicizia. Con una stretta di rimorso e di sofferenza, Elizabeth ripose accuratamente la trapunta piegata nel baule dove conservava i tessuti avanzati dagli abiti di Mrs Lincoln. Non aveva più voglia di lavorarci, senza sapere se o quando avrebbe rivisto l’amica di un tempo. Perfino vivendo in modo estremamente frugale Elizabeth aveva difficoltà a sbarcare il lunario. Il libro che le era costato tanto non le aveva fruttato niente in termini economici, e così trascinò in tribunale, senza clamori, G.W. Carleton & Company per ottenere metà dei guadagni ottenuti grazie all’autobiografia. Non vinse, e quindi non ricevette neanche un centesimo, né le furono mai restituite le lettere di Mary Lincoln. Di tanto in tanto vedeva scritto il nome dell’ex first lady sui giornali e leggeva dei suoi viaggi in Germania, Scozia, Inghilterra, Francia e Italia. Nel 1870, mentre Elizabeth tentava tra mille difficoltà di far decollare di nuovo la propria attività, seppe che il senatore Charles Sumner aveva fatto approvare dal Congresso un provvedimento che garantiva a Mrs Lincoln una pensione annua di tremila dollari, che il presidente Ulysses S. Grant aveva prontamente firmato. Felice, la sarta scrisse subito a Mrs Lincoln una lettera di congratulazioni, esprimendo la sua gioia per quel riconoscimento meritato e perché finalmente era stata fatta giustizia. Non accennò al loro litigio, sperando che i lunghi mesi di lontananza le avessero dato il tempo per riflettere sulle molte occasioni in cui Elizabeth le aveva manifestato lealtà e amicizia, e che decidesse infine di perdonarla. Le mandò le lettere alla residenza di Francoforte sul Meno che appariva come l’ultimo indirizzo riportato dai giornali, ma non le giunse risposta. Poco più tardi, nel maggio 1871, lesse che Mrs Lincoln e Tad avevano lasciato la Germania per recarsi in Inghilterra qualche mese dopo che lei le aveva scritto, e che era poi tornata a Chicago. Si chiese, rattristata, se la sua lettera fosse giunta troppo tardi, e se in quel momento giacesse ancora chiusa, su un tavolo nelle stanze affittate dall’amica in Germania e ormai vuote. Come sarebbe stato tragico, pensò, se quella lettera avesse avuto il potere di provocare il perdono tanto anelato e, per via della mancata consegna alla destinataria, ogni occasione di riappacificazione fosse andata perduta... Eppure, apprendere del ritorno dell’amica negli Stati Uniti alimentò le speranze di Elizabeth, inducendola a riesumare la trapunta abbandonata e a riprendere a lavorarci con impegno. Anche se Mrs Lincoln si trovava a centinaia di chilometri di distanza, da anni non era tanto vicina a lei, e se fosse tornata nella capitale – non era forse probabile che alla fine dovesse venire per qualche occasione ufficiale? – la sarta voleva che la trapunta fosse pronta. Dai giornali seppe, però, non di una prossima visita a Washington di Mrs Lincoln ma, con sgomento, della morte di suo figlio Tad. Pianse leggendo di quella triste notizia. Quando madre e figlio erano giunti via nave in America dall’Inghilterra, affinché il diciottenne Tad potesse proseguire gli studi, i polmoni deboli del ragazzo avevano sofferto parecchio per l’umidità costante e le tempeste. Arrivato a Manhattan gli fu diagnosticato un grave problema respiratorio e fu messo a letto in un hotel, in attesa che recuperasse le forze per proseguire il viaggio in treno fino a Chicago. Alla fine i medici dichiararono che era pronto ad affrontare il tragitto, e dopo quella lunga traversata sulle rotaie che Elizabeth immaginava fin troppo bene, avendola compiuta lei stessa, i due erano giunti a Chicago e si erano stabiliti nella nuova dimora che Robert divideva con moglie e figlia. Poco dopo Mrs Lincoln e Tad si trasferirono a Clifton House, dove la madre poteva accudire meglio il figlio malato. Ma fu tutto inutile. Il 15 luglio, Tad Lincoln morì di idropisia toracica. Elizabeth mandò le proprie condoglianze, ma non si aspettava una risposta che, infatti, non arrivò. Pregò per la vedova e per Robert, ma soprattutto per la sua amica. Non ricordava quante volte, negli anni intercorsi dall’assassinio del presidente Lincoln, la vedova disperata avesse dichiarato che, se non fosse stato per Tad, avrebbe raggiunto volentieri suo marito nella tomba. Per sua stessa ammissione solo Tad e le responsabilità nei suoi confronti l’avevano dissuasa dal togliersi la vita. Per cos’avrebbe vissuto ora? Elizabeth conservò le sue amate stanze nella pensione di Walker Lewis ancora per un po’, ma poi le difficoltà economiche la costrinsero a trasferirsi altrove. Per alcuni anni alloggiò in una stanza presso una famiglia, poi un’altra, ma sempre nella capitale. In seguito la sua cara amica Virginia morì, e lei tornò ad abitare con Walker Lewis per aiutarlo a occuparsi delle figlie più giovani che abitavano ancora a casa: la graziosa Alberta, la sua figlioccia, e la dolce Elizabeth, nata dopo la guerra. Di tanto in tanto cuciva, ma la moda era cambiata, e altre sarte, compresa Emma che ora era sposata e aveva un figlio e una figlia, erano più richieste dall’élite di Washington. Emma, pur essendo diventata famosa, non aveva dimenticato chi l’aveva formata e incoraggiata, e dava spesso lavoro all’amica. Elizabeth era grata dell’aiuto e molto fiera della sua ex assistente più brava. Da quel poco che scrivevano i giornali, i suoi problemi non erano nulla rispetto a quelli di Mrs Lincoln, il cui comportamento instabile era andato peggiorando dopo la morte di Tad. Nel maggio 1875, dopo un processo che fece scalpore e che venne riportato in ogni disgustoso dettaglio dagli organi di stampa, Robert Lincoln fece dichiarare l’infermità mentale della madre e la fece rinchiudere in un ospedale psichiatrico a Batavia, nell’Illinois, una sessantina di chilometri a ovest di Chicago. Impossibilitata ad aiutare o confortare l’amica di un tempo, Elizabeth seguì la storia patetica sui giornali, inorridendo alla notizia che la signora aveva tentato di suicidarsi assumendo una dose eccessiva di laudano il giorno prima dell’annuncio del verdetto. Il tentativo era stato sventato da un farmacista accorto, che l’aveva riconosciuta e aveva sostituito una miscela di zucchero bruciato e acqua alla medicina che lei domandava. Per le settimane successive Elizabeth fu tormentata da visioni di Mrs Lincoln che languiva in un istituto freddo e tetro, privo di calore umano e di comodità. La immaginò lamentarsi senza sosta come quando era morto Willie, urlare e gemere come dopo l’assassinio del marito. Lei era stata la sua più fida compagna in quei giorni bui, ma non era riuscita a offrirle nessun conforto alla morte di Tad, né poteva fare nulla per lei ora. Poi ricordò la trapunta e si mise a lavorarci con grande impegno. Finì i bordi con gli esagoni simili a fiori, aggiunse un’ultima decorazione di seta avorio con quattro aquile orgogliose, una su ogni lato a richiamare l’aquila centrale scura con la bandiera, di seta dorata, imbottita e ricamata con complessi motivi floreali. Quando l’ebbe quasi finita scrisse al dottor Richard J. Patterson a Bellevue Place e chiese se poteva fare visita a Mrs Lincoln. «Le ho fatto un regalo importante, che spero accetterà come simbolo della mia amicizia e del mio affetto imperituri» scrisse. «Spero tanto che questa trapunta, fatta di tessuti che non mancheranno di ricordarle felici epoche passate, le procurerà distrazione, consolazione, bellezza e conforto in questo periodo di isolamento». Si era a tal punto abituata a scrivere in Illinois senza ricevere risposta che fu quasi sorpresa quando il dottor Patterson le rispose nel giro di due settimane. Le offrì i suoi omaggi e disse che era «molto lieto di constatare che la vedova di Abraham Lincoln non era stata dimenticata dagli amici di Washington», ma che si vedeva costretto a sconsigliarla di andare a trovare la paziente, tanto più che si trattava di un viaggio impegnativo, di centinaia di chilometri. Spesso Mrs Lincoln stava troppo male per ricevere visitatori e, anche quando avrebbe potuto farlo, rifiutava di vedere chiunque. Ricordandosi di quando aveva mandato via le molte persone andate a trovarla a Hyde Park, poco dopo essere rimasta vedova, Elizabeth fu delusa ma non sorpresa. Per quanto riguardava il regalo, il dottor Patterson scrisse: «È con estrema ammirazione nei confronti della vostra generosità che vi invito a non inviare la trapunta, che dalla descrizione mi pare un vero capolavoro, finché Mrs Lincoln non sarà in grado di apprezzarla maggiormente. In questo momento detesta qualunque cosa le ricordi il passato. Oggetti, luoghi e anniversari che evocano ricordi piacevoli per una persona sana, per lei sono da bandire. Sono sicuro che, per quanto la trapunta sia splendida, Mrs Lincoln non vi troverebbe conforto alcuno. Vi suggerisco di tenerla in serbo e di donargliela quando starà meglio, e allora sono sicuro che vi ringrazierà». Non sarebbe accaduto, pensò Elizabeth. Mai e poi mai. Non era un sintomo della sua pazzia il fatto che non sopportasse i ricordi del passato. Era sempre stato così. Aveva dato via subito, con impazienza, i giocattoli e i libri di Willie dopo la sua morte. Si era disfatta dei cimeli del presidente Lincoln nelle settimane successive all’assassinio, non solo per esprimere gratitudine e rispetto per i suoi più cari amici, ma per liberarsene e non doverli vedere mai più. La sarta, sbattendo le palpebre per togliere via le lacrime, ripose la trapunta, sapendo che sarebbe stata l’ultima volta. Che sciocca era stata a pensare che la sua amica avrebbe voluto vedere i ritagli di abiti indossati all’apice del suo trionfo come first lady, vestiti dei quali aveva cercato di disfarsi in quello che si era rivelato il peggior scandalo in una vita burrascosa... Che stupida era stata a pensare che Mrs Lincoln avrebbe voluto qualcosa da lei! Di tanto in tanto qualche breve trafiletto dava notizie sulla reclusione della vedova Lincoln. Un giornalista del Chicago Post and Mail che era andato a visitare il sanatorio aveva ricevuto inspiegabilmente il permesso di intrattenersi con la vedova, e quando Elizabeth seppe che l’aveva ricevuto con un abito dimesso e con i capelli ormai completamente bianchi, si sentì morire. Il reporter raccontò che farneticava, e che quando si trovava da sola in camera sua parlava a personaggi immaginari, e la sarta si sentì tanto angosciata da non riuscire a proseguire nella lettura. Temendo che il suo stato fosse destinato a peggiorare irrimediabilmente, fu felice di sapere, poco più di un mese dopo, che era migliorata tanto da essere dimessa per poter fare visita a sua sorella Elizabeth Edwards a Springfield. «È probabile che non torni più al Bellevue Asylum» riferì il corrispondente di Chicago. «Sta molto meglio, dorme e mangia bene, e non mostra alcuna mania; se è definitivamente guarita, solo la vita attiva e il tempo lo dimostreranno». Elizabeth si felicitò della buona notizia, e lo stesso fece quando, nel giugno 1876, i titoli dei giornali riferirono che Mrs Lincoln era stata dichiarata ufficialmente sana di mente. Abitava con la sorella Elizabeth a Springfield, dopo aver appianato, a quanto pareva, i loro dissapori. La debole speranza, coltivata dalla sarta, che l’amica di un tempo decidesse di perdonarla svanì un’altra volta quando seppe che il 1° ottobre era salpata alla volta della Francia e che probabilmente avrebbe trascorso molti anni all’estero. Mary Lincoln non rientrò negli Stati Uniti fino all’autunno del 1880, e lo fece solo perché, a sessantadue anni, era di salute troppo cagionevole per stare da sola. Andò a vivere con sua sorella, ed Elizabeth seppe che non sarebbe mai più tornata a Washington. Il 2 luglio 1881 Robert Lincoln stava attraversando con il neoeletto presidente James Garfield una stazione ferroviaria di Washington quando un uomo, deluso per non essere riuscito a ottenere un lavoro dal presidente, gli sparò due colpi al torace. Garfield sopravvisse, ma sul finire dell’estate fu colto da un’infezione e deperì, soffrendo per ottanta giorni fino alla morte, avvenuta il 19 settembre. Elizabeth, sconvolta e inorridita quanto il resto del paese, non riuscì a dormire pensando a Mrs Lincoln, a come doveva essere angustiata da quel fatto di sangue che evocava certamente l’assassinio del marito. La sarta fu tentata di scriverle di nuovo – per manifestarle la propria comprensione, per assicurarle che aveva ancora almeno un’amica che pensava a lei in quei momenti difficili – ma rimase seduta alla scrivania a fissare il vuoto, incapace di trovare le parole. Alla fine rinunciò senza avere scritto neppure una riga. Lesse altre due notizie sui quotidiani nazionali a proposito dell’ex first lady. La prima volta fu nel novembre di quell’anno, poco dopo che il Congresso aveva accordato alla vedova del presidente Garfield una pensione annua di cinquemila dollari, duemila più di Mrs Lincoln. La campagna di quest’ultima per ottenere un aumento della propria pensione le fruttò nuovi titoli sui giornali. Nel gennaio 1882 il Congresso accettò e, in uno slancio di generosità, le accordò anche gli arretrati e un bonus di quindicimila dollari. Elizabeth esultò per la decisione, felice di sapere che finalmente Mrs Lincoln sarebbe stata libera dalle preoccupazioni economiche che l’avevano assillata per anni. Ma la vedova Lincoln non poté godersi a lungo il trionfo. La volta successiva che Elizabeth scoprì il suo nome sui giornali di Washington fu il giorno dopo la sua morte, a Springfield, il 16 luglio 1882. Non avendo ormai alcuna speranza di riconciliarsi, Elizabeth non aveva più motivo di finire la trapunta, ma mentre la nazione piangeva e celebrava l’ex first lady, lei sentì l’impulso di estrarre la sua creazione ancora incompiuta dal baule. All’inizio pensò di aggiungere una larga striscia di seta nera lungo il bordo esterno, simbolo di lutto, ma poi, proprio mentre si apprestava a tagliare il tessuto, rinunciò. Mrs Lincoln aveva trascorso quasi vent’anni in lutto, e anche se Elizabeth si rendeva conto che era un’idea strana, la sua, non sopportava il pensiero di sottoporre la trapunta allo stesso triste destino. Applicò invece una frangia rossa, che le ricordava l’eleganza e il patriottismo dell’epoca migliore di Mrs Lincoln alla Casa Bianca. Poi, per simboleggiare la scomparsa dell’ex first lady, aggiunse quattro nappe rosse, una in ogni angolo, che le ricordavano le nappe applicate sulla seta nera del catafalco del presidente Lincoln. Fu l’unico simbolo di lutto che usò per la trapunta, anche se sapeva che nessuno guardando la sua creazione l’avrebbe riconosciuto come tale. È finita, pensò quando ebbe dato l’ultimo punto. Aveva lavorato duro fino a quel momento, tenendosi occupata per non avere tempo di pensare, ma rendendosi conto che era davvero finita perse quella facciata di serena rassegnazione e tutto il dolore scaturì da dentro, facendola piangere. Nel 1890, otto anni dopo la morte di Mary Lincoln, che non si curava certo di che fine facessero i cimeli donati a Elizabeth, questa si trovò in tali difficoltà finanziarie che fu costretta a vendere i ricordi del presidente Lincoln, dopo averli conservati e venerati per venticinque anni. Vincendo la propria avversione nei confronti dei mediatori, si affidò a W.H. Lowdermilk & Co. e vendette i suoi tesori a un certo Charles F. Gunther di Chicago, fabbricante di dolciumi e raccoglitore di curiosità. Mr Gunther comprò il mantello macchiato di sangue che Mrs Lincoln indossava la sera dell’assassinio del marito, il guanto destro che il presidente portava durante il primo ricevimento aperto al pubblico del secondo mandato, e tutto il resto. Le uniche cose che Elizabeth conservò furono un paio di orecchini di Mrs Lincoln, i ritagli di tessuto avanzati dai suoi abiti e la trapunta, che le pareva un reperto risalente a quell’epoca, sebbene l’avesse finita molto più tardi. La notizia della vendita giunse fino all’università di Wilberforce a Xenia, nell’Ohio, dove dovette suscitare la curiosità e anche la preoccupazione del vescovo Daniel Payne. Non aveva dimenticato che una volta Elizabeth aveva promesso di donare tutte le sue reliquie dei Lincoln all’università per organizzare una mostra in Europa, per raccogliere fondi e contribuire a ricostruire l’edificio principale dell’ateneo, raso al suolo da un incendio il giorno dell’assassinio del presidente Lincoln. La vedova si era opposta con decisione, inducendo Elizabeth a ritirare l’offerta con grande dispiacere, ma il vescovo aveva capito il suo dilemma e rispettato la decisione. Mrs Keckley doveva essere in una situazione davvero disperata per vendere quegli oggetti a lei tanto cari. La sarta fu piacevolmente sorpresa ricevendo la lettera del vescovo Payne che si informava della sua salute, e lesse con gioia la rievocazione dei ricordi dei tempi passati e la descrizione dei cambiamenti intervenuti all’università da quando vi aveva studiato George, suo figlio. Poi le faceva una proposta che la sconcertò a tal punto da obbligarla a sedersi: le offriva di dirigere il dipartimento di cucito ed economia domestica dell’università. Scrisse subito per ringraziare e declinare. Lei non era una docente, gli precisò. Era vero che aveva imparato a scrivere da piccola, anche se era illegale per lei leggere e scrivere, e aveva tentato per tutta la vita di esaudire il desiderio del padre, che non aveva voluto che restasse analfabeta. Aveva sempre amato leggere, soprattutto la Bibbia, ma non aveva mai avuto un’educazione regolare. Gli studenti dell’università non si aspettavano forse un docente più colto? Assolutamente no, rispose con prontezza il vescovo Payne. Gli studenti del dipartimento di cucito ed economia domestica volevano insegnanti che conoscessero alla perfezione quella disciplina e sapessero trasmetterla ad altri. A Elizabeth quella descrizione calzava a pennello, e la sua esperienza come creatrice di mantua nei circoli più esclusivi di Washington sarebbe stata preziosissima. Il fatto che fosse riuscita ad avere un tale successo senza godere di un’istruzione regolare dimostrava semplicemente la sua forza di carattere, la sua determinazione, perseveranza e il suo amore per il sapere, valori che poteva tramandare ai suoi studenti. Sebbene avesse insegnato il cucito a ex schiave nei campi di neri e a ragazze ambiziose nel proprio laboratorio, non aveva mai tenuto lezione in un’aula. Come sarebbe stato diverso, si disse immaginandosi dinanzi a una classe di studentesse smaniose, mostrare loro con pazienza come creare pieghettature perfette e spiegare la posizione da assumere per evitare dolori al collo e alla schiena. Accettò di visitare l’università, incontrare insegnanti e studenti e saperne di più sul posto che le era stato offerto. Fece il viaggio in treno e fu ricevuta con tanta cordialità da tutti coloro che incontrò sul posto che dopo due giorni all’università di Wilberforce accettò volentieri l’offerta generosa del vescovo Payne. E fu così che, dopo trent’anni passati a Washington, la settantaquattrenne Elizabeth fece i bagagli, disse addio a Walker Lewis, alle sue figlie, a Emma e ai molti amici della Presbyterian Church di Fifteenth Street e si trasferì a ovest, in Ohio. Mai, negli anni piacevoli e gratificanti che seguirono, ebbe occasione di rimpiangere la sua decisione. Elizabeth adorava insegnare e fare lunghe passeggiate in giro per il campus chiacchierando con le sue studentesse allegre, curiose e giovanissime, che erano nate tutte dopo la guerra e non avevano conosciuto un solo giorno di schiavitù. La tecnica sartoriale era cambiata dal periodo in cui i suoi abiti erano in auge, ma si adattò e scoprì che con l’esperienza si padroneggiavano anche le trovate e le mode più bizzarre. Le studentesse sussurravano tra loro aneddoti sul suo conto e poi andavano da lei, intimidite e ammirate, a chiederle com’era il presidente Lincoln e se era vero che sua moglie era pazza. Lei non mancava mai di rispondere elogiando il presidente e anche sua moglie, perché in nessun caso avrebbe permesso a qualcuno di parlare male dell’ex first lady in sua presenza. A volte invitava a casa sua un gruppo di studentesse particolarmente affezionate e promettenti e mostrava loro sete, rasi e altri tessuti preziosi che le erano avanzati dagli abiti di Mrs Lincoln. Di tanto in tanto ricompensava i successi con un pezzetto di quelle stoffe preziose, che la fortunata ragazza poteva usare per confezionare un puntaspilli, un piccolo tesoro della Casa Bianca utile e tutto per lei. Le sue studentesse, così come alcuni docenti, ammirarono la trapunta, e capirono il suo dolore quando seppero che non era mai riuscita a donarla a Mrs Lincoln come avrebbe voluto. Elizabeth trovava strano che nessuna delle sue studentesse fosse al corrente dello scandalo che aveva causato la rottura con la vedova del presidente. Qualcuna di loro sapeva che aveva scritto un’autobiografia, ma nessuna l’aveva letta; ciò non la stupì, visto che Robert Lincoln aveva fatto di tutto per togliere dalla circolazione ogni copia che era riuscito a trovare. Alla fine si disse che, forse, era uscita vincente da quello scandalo. Nel 1893, l’università di Wilberforce prese parte alla World’s Columbian Exposition a Chicago, una celebrazione grandiosa per commemorare il quattrocentesimo anniversario della scoperta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo. Durante i preparativi, le proposte di oggetti da esporre da parte di americani di colore furono sistematicamente rifiutate, ma dopo proteste risentite da parte della comunità nera capeggiata da Frederick Douglass e Ida B. Wells, gli organizzatori cedettero e permisero loro una partecipazione limitata, che includeva disegni e lavori di cucito nel padiglione delle donne. Sapere che molti abili artigiani e scienziati della sua razza erano stati esclusi ingiustamente temperò l’entusiasmo di Elizabeth per l’onore accordato alla Wilberforce, e se fosse stato per lei si sarebbe ritirata dall’esposizione per solidarietà. Ma la decisione non spettava a lei e, come disse a se stessa, le sue studentesse tanto volonterose meritavano di vedere esposta e ammirata la loro opera. Solo prendendo il ruolo che spettava loro in mezzo ai bianchi e presentando le proprie creazioni agli occhi di un pubblico scettico potevano sperare di sconfiggere i pregiudizi. Elizabeth si sentì invadere dai ricordi mentre insieme a diverse studentesse viaggiava in treno alla volta di Chicago. Quando chiuse gli occhi, vide la sua ex cliente e amica come la ricordava in quelle settimane dolorose a Hyde Park, a lamentarsi da sola nella stanza buia, guardando abbattuta la vasta distesa azzurra del lago Michigan. Non aveva mai cessato di sentirsi in lutto, Elizabeth lo sapeva. Non aveva mai rimesso insieme i cocci della sua vita spezzata, trasformandoli in un’esistenza sopportabile, se non felice. Anche se Mrs Lincoln era ormai al di là della sofferenza umana, e si era infine riunita con i figli minori e con l’adorato marito, provò di nuovo un’ondata di compassione per lei. L’esposizione fu splendida. Elizabeth aveva immaginato che assomigliasse alla Great Northwestern Sanitary Fair che aveva visto sempre a Chicago nel giugno 1865, ma la World’s Columbian Exposition era molto più ambiziosa. Vi parteciparono cinquanta nazioni, e quando non erano nel loro stand, Elizabeth e le studentesse si aggiravano tra edifici e padiglioni, ammirando nuove, ingegnose invenzioni, assaggiando cibi esotici e spesso deliziosi, ascoltando musiche venute da paesi lontani, di là dall’oceano. Elizabeth si sentì invasa da una profonda nostalgia mentre aspettava, al sicuro sulla terraferma, le sue studentesse che, incuranti del pericolo, fecero un giro su uno strano apparecchio chiamato ruota panoramica. La vasta zona adibita all’esposizione era così vicina all’ex residenza di Hyde Park di Mrs Lincoln che Elizabeth avrebbe potuto andarci a piedi, se avesse voluto; ma sapeva che non avrebbe provato alcuna consolazione o soddisfazione nel rivisitare quel periodo infelice della sua vita. Preferiva continuare a esplorare l’esposizione, che sembrava rappresentare il futuro con tutte le sue novità, meraviglie e innovazioni, e trascorrere ore piacevoli al padiglione dell’università di Wilberforce, solidamente ancorato nel presente. I loro oggetti esposti erano nell’edificio dedicato agli artigiani e alle materie umanistiche, e nell’angolino che era loro riservato nella grande area espositiva, manichini di legno vestiti con abiti disegnati e creati da Elizabeth e dalle sue studentesse illustravano l’abilità e il senso artistico del loro dipartimento, mentre una vetrina girevole ospitava fotografie e biografie delle ex studentesse ormai laureate. Osservando i passanti che ammiravano i manufatti, e guardando le studentesse che rispondevano con intelligenza, educazione e cortesia alle domande dei visitatori, Elizabeth sentì svanire la tristezza, sostituita da un’ondata di gioia e orgoglio che sembravano farle scoppiare il cuore. Quella era la sua eredità, capì, non il sontuoso guardaroba che aveva creato per Mrs Lincoln o il libro che aveva scritto, pur armata delle migliori intenzioni. Quelle giovani donne, e le apprendiste che aveva formato e consigliato ai tempi di Washington, e le nere fuggite o affrancate cui aveva fornito i rudimenti per prendersi cura di sé e della loro famiglia erano la sua eredità. La loro riuscita, indipendenza e sicurezza erano i doni più autentici che lasciava al mondo. Il suo retaggio più prezioso non si misurava in indumenti o a parole, ma nella saggezza che aveva impartito, nelle esistenze migliorate grazie al suo intervento. 18. 1901 Elizabeth osservò le strade di Washington dal finestrino della carrozza, pensando a quanto la capitale fosse cambiata da quando vi si era stabilita, giovane e ambiziosa, nel 1860. Con la mente la vedeva ancora come un tempo: la cupola del Campidoglio incompiuta, le strade fangose, gli schiavi condotti in catene dal porto alla zona di detenzione. Com’era cambiato il mondo da allora! Com’era cambiata anche lei... Le gite in carrozza a cadenza settimanale erano prescritte dal suo medico, che insisteva perché uscisse per irrobustirsi un po’. Da quando era tornata a Washington, dopo che un leggero ictus l’aveva costretta a dare le dimissioni dall’università di Wilberforce, abitava in una stanza nel seminterrato della Casa per donne e bambini di colore poveri in Fifteenth Street. La divertiva parlare di quel luogo come della sua casa, non solo perché ci abitava, ma anche perché era stata creata in parte grazie alle donazioni della Contraband Relief Association da lei fondata tanti anni prima. Amava la sua stanzetta isolata, piccola e in perfetto ordine, il tavolino con una brocca e un catino in un angolo, una sedia dallo schienale dritto nell’altro, una sedia a dondolo vicino al letto e il vecchio baule che conteneva i suoi indumenti e quanto le restava dei ricordi tanto amati. Sopra il cassettone era appeso un ritratto di Mrs Lincoln e dalla finestra Elizabeth vedeva uomini e donne di colore che andavano e venivano dai corsi all’università di Howard. Nessuno, a eccezione del suo sacerdote e di pochi amici, sapeva che abitasse lì, chi fosse e che vita avesse avuto. E a lei andava bene così. Quando la carrozza si fermò davanti a casa, scese lentamente, con prudenza, accettando con gratitudine l’aiuto del cocchiere. Alta e ben dritta, dimostrando di non avere mai ceduto all’età o alle malattie, varcò la soglia, scambiando saluti educati con gli altri residenti e il personale che incrociò. «Avete una visitatrice nella sala comune» le annunciò una donna, ed Elizabeth percorse il corridoio, curiosa perché non aspettava nessuno, altrimenti sarebbe uscita prima per tornare più presto. Nella sala scoprì con gioia che si trattava della sua figlioccia Alberta, o Mrs Alberta Elizabeth Lewis-Savoy come si chiamava ora, che conosceva da quando era nata. «Mia cara ragazza!» l’accolse felice Elizabeth, abbracciandola e baciandola. Alberta sarebbe sempre stata una ragazza agli occhi di Elizabeth, anche se aveva trentasette anni e dei figli. «A cosa devo questo piacere inatteso? Non ti aspettavo fino a domenica». Alberta sorrise con calore, ma aveva un’espressione cauta, esitante. «Ho trovato un articolo di un certo interesse sul giornale stamattina, e ho pensato che volessi vederlo». Estrasse un ritaglio dalla borsa e lo consegnò all’anziana donna, che lo prese senza aprirlo. «È così appassionante che non sei riuscita ad aspettare pochi giorni?» Alberta fu sul punto di parlare, ma poi scosse il capo, sorrise debolmente e, quasi con aria di scuse, condusse Elizabeth a una sedia. Lei si sedette soffocando un sospiro, e chiedendosi di cosa potesse mai trattarsi stavolta. Avvicinandosi agli occhi l’articolo, lesse il titolo ad alta voce: «Autori neri. Mmm». A un tratto diffidente, alzò lo sguardo su Alberta che le fece cenno di continuare. Autori neri Trecento libri esposti a Buffalo Buffalo, New York. Trecento libri circa scritti da neri americani fanno parte della mostra dei neri alla Pan-American Exposition. La collezione comprende le migliori opere letterarie scritte da autori di colore, ed è unica. L’esame di questi libri fornisce nuovi dati che permettono di giudicare la civiltà nera. A quel punto Elizabeth sospirò e scosse il capo. Tanto vale che siamo subito onesti nel nostro giudizio. È quasi tutto da buttare e non c’è nulla di davvero meritevole. Questo commento la fece ridere. «Continua a leggere» la esortò Alberta, e l’anziana donna obbedì riluttante. Non c’è stato nessun Omero, Shakespeare o Dumas nero, nessun equivalente americano dell’illustre mulatto francese. Molti di questi libri, però, sono migliori di quanto si sospetterebbe, ripensando alle loro origini. Il pregio principale, che li rende degni d’attenzione, non riguarda la loro forma letteraria, ma va cercato nel fatto che si tratta della testimonianza migliore al mondo sull’evoluzione dei neri fornita dai neri stessi. «Secondo te» chiese Elizabeth «quando i nostri amici bianchi scrivono e parlano in questo modo hanno idea di quanto ci insultino?» «Molti di loro no» rispose Alberta. «E se anche lo sapessero, non se ne curerebbero». Elizabeth sospirò e continuò a leggere, imbattendosi nelle recensioni encomiastiche di poesie e lettere di Phillis Wheatley, un opuscolo del reverendo Daniel Crocker e diverse opere erudite. Seguivano elogi per l’opera eccezionale di Frederick Douglass e del professore dell’università di Wilberforce W.E.B. Du Bois; poi Elizabeth trattenne il fiato vedendo il proprio nome nel paragrafo successivo. Come immaginabile, la collezione è ricca di quelle che si possono definire curiosità letterarie. Una di esse, Dietro le quinte di Elizabeth Keckley, «ex schiava ma più di recente sarta e amica della moglie di Abraham Lincoln», era molto in voga all’epoca della pubblicazione (1868) per via delle rivelazioni esclusive. «Molto in voga?» ripeté Elizabeth, non sapendo se sentirsi divertita o allarmata. A quanto pareva il giornalista non aveva svolto bene le sue ricerche, altrimenti avrebbe scelto parole diverse per descrivere il libro. «Credevo che dovessi sapere che il tuo libro è esposto e sembra proprio aver attirato l’attenzione» disse Alberta, profondamente dispiaciuta. Conosceva bene la storia dell’accoglienza riservata al libriccino rosso di memorie di Elizabeth quando era stato pubblicato. Molto in voga, indubbiamente. «Grazie, mia cara!» esclamò Elizabeth prendendole la mano e facendo un sorriso affettuoso. «Ora sono avvertita. Speriamo che la cosa si fermi qui. Fa piacere essere inclusi nell’esposizione, ma il mondo è cambiato, e sospetto che la mia “curiosità letteraria” cadrà presto nel dimenticatoio un’altra volta». Ma si sbagliava. Meno di una settimana dopo ricevette una lettera da un giornalista, Smith D. Fry. Aveva letto dell’esposizione dei neri e, intrigato dalla breve descrizione di Dietro le quinte, desiderava intervistare l’autrice. «Ero solo un ragazzo quando è stato pubblicata la vostra autobiografia» ricordava, «ma mia madre aveva una prima edizione. Aveva la copertina rossa, ricordo, e lei diceva che le descrizioni erano così vivide che le pareva di trovarsi nella stessa stanza con voi e Mrs Lincoln in alcuni dei momenti più importanti, tragici o felici, degli anni della guerra civile». Elizabeth scoprì di essere sensibile alle lusinghe proprio come chiunque altro, perché sebbene fosse stata decisa a rifiutare l’intervista, quel paragrafo le fece cambiare idea. Il dettaglio sulla copertina rossa la convinse che l’uomo descriveva un ricordo autentico, e non un’invenzione buttata lì al solo scopo di conquistarla. Il giornale non aveva fatto menzione del colore della copertina del libro, né era probabile che Mr Fry ne avesse visto una copia di recente. Era anche divertita e compiaciuta per il fatto che avesse precisato che si trattava della prima edizione, come se ce ne fosse stata una seconda. Si concesse comunque un giorno per riflettere prima di rispondere affermativamente. Il mattino del giorno convenuto, si vestì con la consueta cura, con un abito di seta nera e un foulard bianco sulle spalle. Mr Fry la aspettava in salotto al suo arrivo, si salutarono e lei ne apprezzò la puntualità. Aveva una cinquantina d’anni, era robusto con le guance un po’ cascanti e quasi calvo, ma cortese e piacevole; nei suoi occhi si leggeva un’intelligenza acuta e il desiderio di imparare tutto il possibile sull’argomento del suo articolo, anche a costo di dissezionarla. Avrebbe dovuto stare in guardia. Si accomodò in una poltrona imbottita dallo schienale alto, prese un’aria dimessa e aspettò la sua prima domanda. «Mrs Keckley» esordì il giornalista, con carta e matita pronte. «Temo di dover cominciare con una domanda delicata». Lei si preparò al peggio. «Benissimo». «I miei lettori lo vorranno sapere, ma ho paura di chiedervelo». Esitò. «Posso dire che avete ottant’anni?» «Sì» rispose lei, anche se ne aveva ottantatré. Lui annuì e scrisse qualcosa sul suo blocco. «Si dice che siate stata la sarta di Mary Lincoln, ma in realtà eravate molto di più, vero?» «Certo» replicò Elizabeth. «Cucivate per lei e la vestivate per le occasioni importanti, dico bene?» Molto più di quello. «Vestivo Mrs Lincoln per ogni cena di gala» rispose. «Confezionavo tutto ciò che indossava. La pettinavo. La aiutavo a indossare gonne e abiti. Preparavo i bouquet di fiori che portava, controllavo che i guanti stessero bene e restavo con lei ogni sera fino a quando Mr Lincoln non veniva a prenderla. Le mie mani erano le ultime a toccarla prima che prendesse il braccio del marito per andare a incontrare gli ospiti, uomini e donne, in quelle grandi occasioni». «Immagino che abbiate visto spesso il presidente, allora». «Sì». «Vi consideravano parte della famiglia?» Elizabeth rifletté brevemente sul modo in cui Mary Lincoln aveva trattato le donne della sua famiglia. «Non arriverei a tanto. Direi che ero un’amica cara e fidata». «Per Mrs Lincoln?» «Per entrambi, anche se ero molto più in confidenza con la signora». Per un attimo si perse dietro ai suoi pensieri, ma poi tornò a fissare Mr Fry e spiegò: «Il presidente Lincoln era un buon amico per me, ma non seppe mai quanto io fossi e sia tuttora una buona amica per lui». Quando il giornalista la fissò speranzoso, in attesa che proseguisse, lei gli spiegò: «Ero, e sono ancora oggi, amica di Abraham Lincoln, e proteggerò sempre il suo ricordo tenendo la bocca chiusa riguardo le molte cose che purtroppo sospettava o immaginava che accadessero alle sue spalle a livello ufficiale e personale». «Immagino vi sentiate molto leale nei suoi confronti» osservò Fry. «Avviene lo stesso per molte persone di colore, o così mi dicono, perché lui era il “grande emancipatore”». Elizabeth si chiese dove volesse andare a parare. Pensava fosse venuto per discorrere del libro, ma sembrava più interessato al presidente Lincoln. Lei non aveva nulla in contrario. Anzi, preferiva parlare del grande presidente, ma se Mr Fry coltivava la speranza che gli rivelasse qualche pettegolezzo scottante, sarebbe rimasto molto deluso. «Sono nata schiava, ma ho comprato la mia libertà e non devo quindi la mia emancipazione a Lincoln» puntualizzò. «Però gli volevo bene per la sua gentilezza nei miei confronti e per avere compiuto un gesto splendido: concedere la libertà al mio popolo. So cos’è la libertà perché ricordo cosa fosse la schiavitù». Sorrise, e per un attimo si sentì dispiaciuta per il giornalista, che probabilmente aveva figli e forse anche nipoti, ma a lei pareva molto giovane. «Voi che non avete mai sofferto non potete capire pienamente il significato della libertà». «No» ammise lui pensoso. «Immagino di no. Non possiamo». A un tratto provò uno slancio di simpatia per lui, sebbene non riuscisse a fidarsi fino in fondo di un giornalista. «Ero quasi in adorazione di Abraham Lincoln» ammise. «Era dolce e sensibile con me, e mi trattava come tutti i bianchi che venivano alla Casa Bianca. In quello si dimostrò coerente con la sua convinzione che tutti gli esseri umani siano uguali al cospetto di Dio». A differenza del suo successore, pensò Elizabeth ma non lo disse ad alta voce. Mrs Lincoln aveva giudicato correttamente la personalità del presidente Johnson fin dall’inizio, quando si era presentato davanti alla nazione ubriaco. Aveva annullato molte delle riforme fatte da Lincoln, e le sue decisioni avevano creato ostacoli al cammino dei neri verso l’uguaglianza. Molte delle conquiste risalenti al tempo della guerra erano state vanificate sotto la presidenza di Johnson, ma il progresso è inarrestabile, ed Elizabeth non aveva perso la speranza per un futuro migliore per la sua razza. «La pensavate allo stesso modo nei confronti di Mrs Lincoln?» Elizabeth rifletté. «Era molto diversa da suo marito. Lui era un uomo straordinario, il più grande che abbia mai conosciuto. Se dovessi usare lui come pietra di paragone per giudicare Mrs Lincoln o chiunque altro, me inclusa, nessuno sarebbe all’altezza». «Nessuno, avete ragione». Gli occhi di Mr Fry erano fissi sul blocco mentre la matita correva su e giù lungo il foglio. «Non avete mai l’impressione di avere tradito la fiducia che i Lincoln avevano riposto in voi?» «Non ho mai tradito un segreto all’epoca in cui i segreti valevano oro, e l’oro era raro» rispose Elizabeth leggermente infastidita. «Però c’è la faccenda del libro». Allora era al corrente della controversia. «Sì» rispose lei senza scomporsi. «Ho scritto un libro sulla mia vita che includeva anche gli anni alla Casa Bianca. L’ho fatto animata dalle migliori intenzioni ma, come senz’altro già sapete, le cose non sono andate come mi aspettavo». Lui la studiò per qualche istante con la fronte corrugata, poi chiese: «Vi ha dato fastidio, dopo, sapere di avere tratto vantaggio dalla divulgazione dei capricci di Mrs Lincoln?» «Purtroppo, i suoi capricci erano ben noti molto prima che li descrivessi io». A un tratto Elizabeth si sentì estenuata. «Per quanto riguarda i vantaggi, sappiate che non ho mai ricevuto un dollaro per la pubblicazione del libro. Si sono tenuti tutto quanto. Però non lo rimpiango, perché hanno stampato molti particolari che non avrebbero dovuto divulgare, particolari che hanno causato tanto dolore perché non erano veri». Sospirò e distolse lo sguardo, sentendosi prossima al pianto. «Il libro è stato stampato, e il mio nome era sulla pagina del titolo come autrice di tutto ciò che era contenuto tra la prima e l’ultima pagina di copertina». «Invece non lo eravate?» chiese il giornalista, che si permise di incalzarla dopo che era rimasta in silenzio per un po’. «No». Capì dalla sua espressione che voleva un esempio. Oh, come esulta la stampa quando le date abbastanza corda da permetterle di impiccarvi! Ma forse era ingiusta. Quell’uomo non aveva mai scritto una parola critica nei suoi confronti. Era sbagliato considerarlo responsabile per le azioni dei suoi colleghi. «Hanno raccontato la storia di come Mrs Lincoln avesse cercato invano di vendere il suo prezioso guardaroba a New York, ma hanno travisato la verità. Ero con la signora in quel periodo, e ho fatto del mio meglio per aiutarla a disfarsi dei suoi beni più preziosi...» A un tratto la prudenza prevalse in lei, e decise di non raccontare che Mr Redpath si era allontanato dalla sua versione dei fatti. «Ma ormai non serve più a niente raccontare i dettagli di quell’impresa. Ne parlo solo perché li hanno inseriti in un libro che ha fruttato loro del denaro, la pubblicazione del quale non mi ha arricchita ma in compenso mi ha inimicato gente che mi era amica». Si sentì sprofondare in una triste fantasticheria, ma dopo un po’ Mr Fry chiese: «Avete confezionato abiti anche per altre dame celebri, vero?» Elizabeth annuì. «Ho fatto abiti per Mrs Lincoln, e per le signore della famiglia del presidente Andrew Johnson e anche di Grant. E, prima della secessione, anche per la moglie di Jefferson Davis». Ricordò che Mrs Grant e Mrs Davis erano diventate buone amiche dopo la guerra. Allora aveva pensato che, se le mogli del generale unionista Grant e del presidente confederato Davis potevano stringere amicizia, anche lei e Mrs Lincoln avrebbero potuto riconciliarsi. Ma il destino aveva voluto altrimenti. «Dovevate essere molto celebre nel vostro periodo migliore». Lei lo guardò con aria scettica. «Conoscevo gente celebre. Ciò non significa che lo fossi diventata anch’io». «Mrs Keckley, credo siate troppo modesta» protestò lui con un sorriso. «Dovreste essere orgogliosa della vostra fama». Era proprio giovane se non capiva quanto fosse stupido essere orgogliosi di qualcosa di volubile ed effimero come la fama. «Nel mio campo sono stata famosa per molti anni» riconobbe. «Ero orgogliosa; certo, molto orgogliosa. Ma la fama e l’orgoglio non durano, come ho scoperto a mie spese. Non danno da mangiare a una vecchia quando viene dimenticata da tutti o quando i suoi amici sono morti». Tacque di colpo. Non aveva avuto intenzione di intavolare quel discorso penoso, né voleva riprendere il filo, anche se Mr Fry avesse continuato a fissarla con i suoi occhi feriti e speranzosi da cucciolo sotto le sopracciglia aggrottate. «Mi pare di capire che siete in difficoltà» disse infine con franchezza. Traendo un lungo sospiro, Elizabeth annuì. Non voleva la sua pietà. «Quando mi trovo in difficoltà» riprese con uno sforzo, mantenendo la voce calma e pacata, «penso a quello che diceva spesso il presidente Lincoln a sua moglie: “Non preoccupatevi, mamma, perché andrà tutto bene. Dio decide il nostro destino”». La matita di Mr Fry restò sospesa sopra il foglio. «Lo disse davvero? Ci credeva?» Elizabeth annuì. «Molte volte gli ho sentito dire quelle parole, quando gli eserciti dell’Unione subivano perdite disastrose e anche in presenza di difficoltà domestiche». Le sue parole avevano confortato Mrs Lincoln e anche Elizabeth, sebbene non fossero state rivolte a lei. «Sì, il ricordo di quel buon uomo mi aiuta, perché tengo a mente molti dei suoi modi di dire che denotavano fede in Dio e nella Sua bontà». «Fa bene trovare consolazione nei ricordi» convenne con tatto Mr Fry. «Sì» disse lei con aria nostalgica, lo sguardo assente. «L’ho sempre pensato». Chiacchierarono ancora un po’, ed Elizabeth cercò di non far pesare troppo la povertà, o la solitudine per il fatto di essere sopravvissuta a molti dei suoi amici. Quando cominciò a sentirsi stanca Mr Fry se ne accorse e si alzò subito, le strinse la mano, la ringraziò molto e se ne andò. L’anziana donna si chiese, guardandolo allontanarsi, cosa avesse visto il giornalista di ciò che lei aveva voluto celargli. Si domandò se avrebbe inventato dialoghi, sospiri e lunghe occhiate tristi per riempire i vuoti della storia che aveva di certo già creato nella mente prima ancora che lei cominciasse a parlare, vuoti che lei non aveva colmato perché non aveva le tessere necessarie al completamento del racconto. Perché avrebbe dovuto scrivere una vicenda che si attenesse ai fatti, si chiese sarcastica, quando nulla era più facile che inventarsi i fatti per disegnare i contorni di una storia più piccante? Sospirò, alzandosi a fatica, e si avviò da sola verso la propria stanzetta. Presto avrebbe scoperto cosa pensava di lei Mr Fry, e dopo che il suo articolo sarebbe apparso sul giornale era possibile che un nuovo lampo di popolarità illuminasse la sua vita discreta prima di ridursi ancora una volta in cenere. E quando se ne fosse andato, non ci sarebbe stato modo di ravvivarlo. Tale era la natura della fama. Presto sarebbe stata dimenticata di nuovo, se non dai pochi cari amici ancora in vita che contavano per lei. La sua vita si era notevolmente ridotta rispetto a quando si era trovata all’apice del successo e della fama come sarta di Mary Lincoln, ma ora era più vecchia e più saggia, e anche le sue pretese si erano molto ridotte. Era una donna libera in una nazione unita e in pace. Aveva vissuto un’esistenza piena e appassionante. Aveva conosciuto i personaggi più importanti dei suoi tempi, non aveva mai rifiutato il suo aiuto ai più umili e derelitti. Nonostante le delusioni, le perdite e i dolori, non avrebbe voluto vivere un giorno di meno, né, quando fosse arrivato il momento di riunirsi con i molti amici e i cari che se n’erano andati prima di lei, avrebbe chiesto un’ora di più. Era pronta a disfarsi del proprio fardello e a riposare, e forse a trovare in cielo il ricongiungimento e la riconciliazione che le erano sfuggiti sulla terra. Nota dell’autrice Elizabeth Hobbs Keckley visse gli anni che le restavano a Washington, DC, nella Casa per donne e bambini di colore poveri. Dopo una breve malattia, morì nel sonno per un ictus il 26 maggio 1907, all’età di ottantanove anni. Secondo John E. Washington, autore di They Knew Lincoln (Dutton, 1942) fu sepolta nel Columbian Harmony Cemetery «su una bella collina, affacciata a est, sotto un grande olmo» tra «i neri più illustri che avevano amato e servito Lincoln quando era a Washington». La controversia sull’autobiografia di Elizabeth Keckley non si esaurì dopo la sua morte. Nel 1935 David Rankin Barbee, storico della guerra civile e giornalista che si autodefiniva «sudista reazionario», affermò che non solo Elizabeth Keckley non aveva mai scritto Dietro le quinte, ma che una donna con quel nome non era mai esistita. Il libro era un falso, insistette, un’invenzione creata da Jane Swisshelm, «autrice di storie strappalacrime e abolizionista», corrispondente da Washington. Barbee apparentemente non aveva calcolato quanti amici e conoscenti di Elizabeth Keckley fossero ancora vivi, ed è facile immaginare come ci rimase quando questi si fecero avanti per testimoniare che era esistita, eccome. Di fronte a un’opposizione tanto tenace, Barbee ritrattò in parte le sue affermazioni, spiegando che aveva voluto dire che «una persona come Elizabeth Keckley» non poteva avere scritto un libro del genere. «Gli eruditi, dei quali non posso considerarmi parte, si sono interrogati a lungo sulla paternità del libro» affermò sull’Evening Star del 26 novembre 1935. Nonostante i tentativi di Barbee e altri di negare che il libro fosse opera di Elizabeth Keckley e di cancellarla dalla memoria, l’autobiografia, tanto denigrata all’epoca della pubblicazione, è oggi considerata un documento storico importante che offre dettagli fondamentali sulla Casa Bianca all’epoca di Lincoln e sulla vita privata di Abraham e Mary Lincoln. La provenienza dell’eccezionale trapunta attribuita a Elizabeth Keckley è meno certa di quella del libro. Da quanto so mentre scrivo, la prima apparizione documentata della trapunta di Mary Todd Lincoln risale al 1954, quando la proprietaria, la fabbricante di trapunte e scrittrice Ruth Ebright Finley, ne fece menzione in una conferenza. La Finley disse che Elizabeth Keckley aveva fabbricato la trapunta usando ritagli di tessuto avanzati dagli abiti che aveva confezionato per Mary Lincoln, e che ne aveva fatto omaggio alla first lady, la quale l’aveva usata come copriletto alla Casa Bianca e l’aveva presa con sé quando se n’era andata dopo l’assassinio del marito. Alla morte della Finley, nel 1955, la sua collezione di trapunte fu ereditata dal nipote, Bill Dague, che tenne l’oggetto fino al 1967, quando lui e sua moglie la vendettero a un mercatino di oggetti usati tenutosi nella loro fattoria a Sharon, in Ohio. La trapunta fu acquistata da Ross Trump, collezionista e commerciante di oggetti antichi e amico di famiglia dei Finley e dei Dague. Nel 1994, Trump donò la trapunta al Kent State University Museum, dove si trova ancora oggi. Altre testimonianze, però, mettono in dubbio che fosse stata donata a Mary Lincoln da Elizabeth Keckley, o che fosse stata quest’ultima a confezionarla. Non sono riuscita a rintracciare la provenienza del reperto prima che Ruth Ebright Finley ne entrasse in possesso, e così, in assenza di certezze, ho inventato una storia che si armonizzasse con il mio testo. Negli anni Cinquanta, dopo un lungo periodo di abbandono, il Columbian Harmony Cemetery fu venduto a un promotore immobiliare, e i resti di circa trentasettemila persone – inclusa Elizabeth Keckley – furono trasferiti nel nuovo National Harmony Memorial Park Cemetery di Landover, in Maryland. Per trascuratezza o per malasorte, le lapidi non furono trasferite insieme alle spoglie dei defunti, e così i resti di Elizabeth Keckley furono sepolti in una tomba anonima. Per decenni gli storici temettero che il luogo della sua sepoltura sarebbe rimasto ignoto per sempre, ma nel 2009 Richard Smyth, autodefinitosi storico dilettante, stava compiendo ricerche sulle tombe più antiche consultando archivi e registri quando scoprì la zona e il settore in cui era stata sepolta Elizabeth Keckley. Per due anni Smyth lavorò con il National Harmony Memorial Park e diverse altre organizzazioni, incluse Surratt Society, Black Women United for Action, Lincoln Forum, Ford’s Theatre Society, per raccogliere fondi per la costruzione di un memoriale che onorasse il ruolo di Elizabeth Keckley nella storia dei presidenti americani. Il 26 maggio 2010, nel centotreesimo anniversario della morte, fu inaugurata la nuova lapide di bronzo e granito. La lapide reca la seguente scritta: ELIZABETH KECKLEY 1818-1907 EX SCHIAVA, SARTA, CONFIDENTE Nata in schiavitù, Elizabeth Keckley acquistò la libertà grazie alle sue eccezionali doti di sarta. Dopo avere creato la propria attività, lavorò come sarta per Mary Lincoln, diventando sua intima amica e confidente. L’autobiografia di Mrs Keckley, Behind the Scenes [Dietro le quinte], fornisce dettagli intimi sulla vita alla Casa Bianca durante i mandati di Lincoln. Ringraziamenti Un grazie di cuore a Denise Roy, Maria Massie, Liza Cassity, Christine Ball, Brian Tart, Kate Napolitano e l’eccezionale team di Dutton e Plume per l’aiuto fornitomi e il loro contributo a La sarta di Mary Lincoln. Ho un debito di gratitudine anche nei confronti delle persone che mi hanno assistito durante le ricerche e la stesura del romanzo. Geraldine Neidenbach, Heather Neidenbach, Marty Chiaverini e Brian Grover sono stati i miei primi lettori, e i loro commenti e dubbi si sono rivelati preziosissimi durante il lavoro di scrittura. Nic Neidenbach è sempre stato pronto a rispondere alle mie domande angosciose quando la tecnologia mi tradiva, dimostrandomi ancora una volta quanto sia utile avere un esperto di informatica in famiglia. Apprezzo sempre l’aiuto e gli incoraggiamenti di Marlene e Len Chiaverini, e l’entusiasmo di Marlene per questa storia è stato molto confortante per me. Karen Roy e Alyssa Samways hanno compiuto spedizioni in biblioteca per effettuare ricerche per conto mio, e mi hanno inviato copie di documenti storici fondamentali che non sarei riuscita a ottenere da sola; Sara Hume, del Kent State University Museum, non solo mi ha mostrato in privata sede la trapunta di Mary Todd Lincoln con tutte le spiegazioni del caso, ma mi ha anche fornito risposte esaurienti e interessanti alle molte domande che mi sono sorte dopo la visita. Un grazie enorme a voi tutti. Sono molto fortunata a vivere vicino alla Wisconsin Historical Society, dove i bibliotecari, gli altri dipendenti e gli eccellenti archivi sono diventati fondamentali per il mio lavoro. Delle molte fonti consultate, le seguenti si sono rivelate particolarmente preziose e istruttive: Jean H. Baker, Mary Todd Lincoln: A Biography (Norton, New York 1987); Joan E. Cashin, First Lady of the Confederacy: Varina Davis’s Civil War (Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, M A, 2006); Catherine Clinton, Mrs. Lincoln: A Life (HarperCollins, New York 2009); Daniel Mark Epstein, The Lincolns: Portrait of a Marriage (Ballantine Books, New York 2008); Jennifer Fleischner, Mrs. Lincoln and Mrs. Keckly: The Remarkable Story of the Friendship Between a First Lady and a Former Slave (Broadway Books, New York 2003); Ernest B. Furgurson, Freedom Rising: Washington in the Civil War (Knopf, New York 2004); Becky Rutberg, Mary Lincoln’s Dressmaker: Elizabeth Keckley’s Remarkable Rise from Slave to White House Confidante (Walker and Company, New York 1995); Justin G. Turner e Linda Levitt Turner, Mary Todd Lincoln: Her Life and Letters (Knopf, New York 1972); John E. Washington, They Knew Lincoln (Dutton, New York 1942). Naturalmente nessun’opera è stata più importante del libro scritto da Elizabeth Keckley stessa, Behind the Scenes (G.W. Carleton & Company, New York 1868). Anche se mi dispiace per tutti i problemi che la pubblicazione del libro le procurò, sono molto felice che l’autrice ci abbia lasciato una testimonanza tanto ricca e suggestiva della sua vita. Come sempre, e più di tutti, ringrazio mio marito Marty e i miei figli Nicholas e Michael per l’amore, il sostegno e l’incoraggiamento continui. Vi dico ogni giorno quanto vi amo, ma ci sono momenti in cui le parole non bastano, e questo è uno di quelli. Indice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nota dell’autrice Ringraziamenti
Scaricare