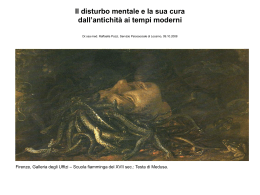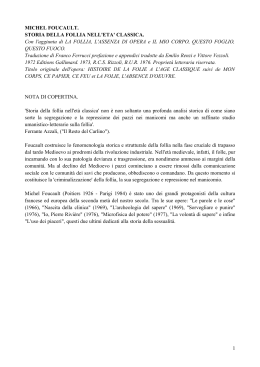Didattica Speciale La formazione è una categoria complessa e problematica perché la questione educativa che si pone è quella della persona, del soggetto che si vuole formare, ma anche del soggetto che si forma, si con-forma, si deforma. La formazione è, altresì, un processo concreto, co-implicato nella prassi umana e che comprende anche azioni ed eventi che incidono sulla crescita ontologica e biopsichica del soggetto. (E’ necessario, dunque,) confrontarsi con il soggetto in formazione considerato nella complessità della sua esistenza, nella sua sostanza di carne e ossa, nella sua problematicità ma anche nella ricchezza del suo essere persona implicata in un contesto in cui può trovarsi il luogo dell’emancipazione o quello, al contrario, della reificazione e del dominio. Questo lavoro comporta, dunque, la chiarificazione di questioni relative all’uomo di cui vogliamo promuovere l’emancipazione, oltre le “stimmate” della disabilità, oltre qualsiasi altra definizione preconcetta di diversità”[1]. [1] V. Burza, La formazione tra marginalità e integrazione. Processi, percorsi, prospettive, Periferia, Cosenza 2002 , p. 150. La problematicità strutturale della formazione, infatti, la si può evincere dall’osservazione che la formazione è il risultato mai compiuto di azioni intenzionali e di eventi che si sottraggono alla volontà del soggetto. Basti riflettere sul fatto che noi siamo il frutto di un incontro-evento tra le persone che ci hanno generato e queste a loro volta sono il frutto dell’incontro-evento tra i loro genitori, in una catena infinita. Ogni storia di formazione inizia grazie ad un evento destinale che è la nascita che ci determina in maniera significativa, evento in quanto noi non godiamo della libertà di scegliere: non scegliamo il dove, non il tempo, non scegliamo la famiglia e il contesto storico-culturale, non le qualità specifiche genetiche e soprattutto non scegliamo di nascere. Se il primo evento destinale a condizionare la nostra storia di formazione è la nascita, l’ultimo evento per eccellenza è la morte o meglio l’idea che l’individuo si fa della morte, il modo che ha di concepirla, di immaginarla. L’evento-morte è per la persona, gravida di significato pedagogico e formativo. A formarci non è la nostra morta, estrema esperienza della nostra vita, ma l’idea che di essa ci facciamo, il modo di concepirla, di pensarla e di dirla. Nessuno sfugge all’idea della morte neanche quando la nega, la ignora, la rimuove. Si può dire che tutti quanti noi siamo formati in qualche modo alla e dalla idea della morte. Odo Marquard in Apologia del caso ha scritto “Il caso che ci coglie nella maniera più carica di destino e più dura, a meno che non lo si consideri come la consolazione del non dovere continuare all’infinito con i nostri volteggi, è la nostra morte. Dalla nascita, per un caso del destino, noi siamo condannati a morte, vale a dire a quella brevità della vita che non ci lascia il tempo di liberarci a nostro piacere di ciò che per caso già siamo”. Jankélévitch in La mort scrive: “La morte dà forma alla vita. In ciò consiste la doppiezza del limite: nel dire insieme si e no, e cioè nel rifiutare affermando e nell’affermare rifiutando, in quanto il termine diventa ciò che determina e il limite risulta parte integrante della forma”. La morte è l’altra faccia della vita. Vero è che nella morte dell’altro si annuncia la nostra morte e porta via una parte di noi, tutta quella parte di noi che gli appartiene. Con lui muore tutto un universo di possibilità. Perciò noi sperimentiamo la morte come perdita in tutto il corso della nostra vita: in un obiettivo mancato, in un desiderio inappagato, in un amore finito o mai cominciato, in una malattia, in un lutto. Ogni perdita rappresenta, in qualche modo, una esperienza di morte. In ciò consiste il nostro “ordinario morire”. Su questo fatto che la morte può dare il via ad un orizzonte di umanizzazione della vita, concorda anche Ernesto de Martino, che mette in luce il significato della morte e dell’elaborazione di questa nei riti e nei lamenti funebri dell’antichità del cristianesimo, come condizione della forza rigenerante della cultura. Di fronte al problema della morte di chi ci è caro, abbiamo tre possibilità: dimenticarli e farli morire in noi, farli rivivere continuando la loro opera, perdere noi stessi morendo con colui che muore. Ma questo è il rischio di chi è disarmato di fronte al dolore e alla disperazione e non riesce a riportare la morte da mero fatto naturale a elemento di cultura, di civiltà, di valore. Alberto Granese definisce “destinazione originaria”[1] della persona quella spinta naturale ma anche quel diritto che appartiene ad ogni essere umano, a divenire “ontologicamente uomo”. La destinazione originaria è ciò che in principio connota la persona, ma è anche e soprattutto propria di ciascuna persona, di quella determinata persona che ha progettato quel determinato mondo ma che un’educazione sbagliata, una patologia, un accidente del destino che per fragilità emotiva non si è trasfigurato in forma, una situazione sociale e culturale “difficile” può portare a non realizzare, ad offuscare il tragitto verso l’obiettivo di quel dispiegamento delle “trame”della persona che ne rendono la forma unica. [1] Cf., A. Granese, Il labirinto e la porta stretta, La Nuova Italia, Firenze 1992. Diventa sempre più urgente, nell’ambito del dibattito pedagogico contemporaneo, interrogarsi su quella dimensione del rischio che va sotto il nome di marginalità intendendo con questo termine quel vasto ambito di esperienze di vita segnato dal disagio, quel contesto esistenziale di forte estraneità rispetto ai processi sociali, culturali e politici delle società organizzate, quegli spazi educativi in cui si riscontrano i conflitti della società, al fine di intervenire con particolari strategie forse diverse dalle tradizionali vie educative, spesso insufficienti a garantire il completo sviluppo delle dimensioni della persona, del suo esistere. Simonetta Ulivieri[1]sostiene che è estremamente difficile dare una definizione teorica degli eventi riguardanti la marginalità, perchè la marginalità si identifica nello sguardo e nei vissuti degli individui che la esprimono portandola con sé. Il dato che rappresenta una sorta di costante tra i numerosi “luoghi” della marginalità risiede, sempre nell’ottica della Ulivieri, in una perversa dialettica tra “centro” e “margine”. [1] Cfr., S. Ulivieri, L’educazione e i marginali. Storia, teorie, luoghi e tipologie dell’emarginazione, La Nuova Italia, Firenze 1999. I criteri di esclusione dei singoli individui, dei gruppi umani di etnie diverse, hanno visto nascere quella violenta dialettica di quanti, riconoscendosi nei valori, negli schemi, negli ideali sociali, si sono collocati al “centro” della vita sociale e culturale, relegando ai “margini” quei vissuti “altri” che proprio perché “altri”, considerati pericolosi, da controllare, da eliminare dalla visibilità sociale. Nel corso della periodizzazione della storia della marginalità e nella elaborazione di un immaginario sulla marginalità molti sono stati i vissuti di persone considerate “depositarie” di un modo di vivere “altro”, non paragonabile ai vissuti delle persone cosiddette “normali”. Si tratta di persone la cui dolorosa esistenza è stata vista e giudicata come eversiva, inquietante, pericolosa, temuta perché ritenuta in grado di generare quella forma di paura ancestrale capace di “consumare” l’identità delle persone “normali” che vivono Leonardo Trisciuzzi[1] ha affermato che là dove ci sono deboli, diversi, handicappati, stranieri, “il centro” mette in moto dei meccanismi di difesa che si traducono nell’emarginazione. Il problema della marginalità è un problema di “evoluzionismo sociale” nel senso che in un mondo ridotto a “giungla”, sopravvive il più forte, il soggetto più adeguato ad affrontare con cinismo le esperienze della vita. [1] Cfr., L. Trisciuzzi, Il centro e il margine. Conformismo educativo e dissenso esistenziale, in S. Ulivieri, L’educazione e i marginali. Storia, teorie, luoghi e tipologie dell’emarginazione. Il termine follia, da un punto di vista etimologico, deriva dal latino follis, un termine che approssimativamente significava: “soffietto, vescica, sacca, pallone, borsa, sacco gonfio d’aria”. Intorno al VI secolo si verifica un cambiamento di senso del termine “follia” che passerà, così, ad indicare la scarsa profondità d’intelletto di una persona, dimensione simile a quella di un pallone pieno d’aria. Infatti cosa è “pieno d’aria”? La persona nella sua totalità? La sua testa, vista nell’antichità come il fulcro delle facoltà intellettive? Ma, soprattutto, perchè “l’aria” dovrebbe essere assimilata ad una dimensione di anormalità? Per comprendere la complessità della dialettica tra significato semantico del termine “follia” e l’“oggetto” di tale significato, ovvero la persona, basta riflettere sul numero estremamente ampio di parole che la cultura occidentale ha elaborato per definire una condizione di follia. La lingua latina impiegava il termine insania per indicare la peculiarità patologica della follia. Oltre a termini come “follia”, “pazzia”, “insania”, la cultura occidentale si è servita anche di termini come “alienazione”, “demenza”, “disordine”, “mania”. Tutto questo porta alla considerazione che il sapere antico e moderno non ha mai saputo o voluto dare una definizione univoca della follia e con essa dei folli . La follia è stata vista nel corso dei secoli, sia come una condizione patologica, inferiore, e sia come una condizione superiore in quanto aperta a dimensioni “altre” dell’esistere, diverse dallo stato di normalità. In numerose comunità primitive, ancora oggi, colui che è reputato “folle”, ben lungi dall’essere visto come un deviato, viene spesso considerato come un individuo mosso da forze particolari. Nell’età antica la follia si vestiva di abiti simili, in quanto veniva assimilata ad uno stato privilegiato; chi era folle era in diretto contatto con la divinità. Il momento di passaggio storico che vede il nascere di un nuovo modo di intendere la follia, si ha tra il XVI e il XVII secolo, quando scrittori e drammaturghi come Cervantes, Shakespeare, Erasmo Da Rotterdam si soffermano su quegli aspetti della natura umana che devono fare i conti con i nuovi equilibri sociali, politici e simbolici di una realtà sociale che non approva più la trasgressione come momento necessario da circoscrivere in un determinato lasso temporale e per questo motivo, ritualizzabile e dominabile. La coscienza occidentale ha definito, in molti casi, la follia in modo non medico o patologico ma, anzi, ne è prevalsa una interpretazione della stessa come una sorta di dimensione alternativa, di protesta ad un mondo individuale e sociale per molti versi insoddisfacente; nell’individuo alienato, l’individuo “normale” sembra riconoscere la persona in qualche modo in grado di vivere fuori dal sistema, lontano dalle sue regole. Una diversa interpretazione della follia che si fa avanti nell’Illuminismo, circoscrive questa dimensione esistenziale dell’uomo all’ambito della patologia e del disturbo. E’ nell’Illuminismo, infatti, che comincia a farsi avanti una sorta di “naturalizzazione” dell’uomo; si cominciarono ad accostare fenomeni reputati come “devianti”, al metodo empirico-analitico. Il sapere illuministico, in tale senso, ricondurrà gli stati di salute e di sofferenza mentale alla dimensione corporea. Sarà la scienza a ridurre la follia a malattia e a creare pratiche di internamento e di esclusione di tutte quelle manifestazioni “altre” della natura umana. Si fa avanti una diversa modalità di intendere la follia, una nuova dimensione che finirà con l’emarginare i folli rinchiudendoli in strutture lontane dalla società. Nella seconda metà del secolo, uno dei padri fondatori della psichiatria moderna, Philippe Pinel, affermerà che l’uomo è un essere materiale e corporeo. Di conseguenza tutte le caratteristiche della vita dipendono dallo stato del suo organismo. Una parte della fama di Pinel è, comunque, legata più che al suo pensiero scientifico, ad un gesto simbolico: liberò i folli dalle catene con le quali erano spesso legati. Per comprendere appieno la rilevanza storica della figura di Pinel, occorre tenere presente che in quel momento storico i malati di mente non erano visti come soggetti bisognosi di cure particolari, quanto dei diversi studiati in rapporto alla loro presunta condizione di pericolosità per sé e per gli altri Gli asili nei quali erano rinchiusi custodivano anche delinquenti, prostitute, alcolizzati. Dopo Pinel, i “folli” non saranno più accostati ai delinquenti e l’intervento correttivo sarà diversificato a seconda del disturbo. Per Pinel la follia è una dimensione dell’esistere caratterizzata dallo “smarrimento”, dalla “perdita” di una equilibrata condotta di vita[1]. L’obiettivo di Pinel era quello di sollecitare nella persona disturbata, la ripresa dell’autocontrollo e del rispetto di sé. [1] Cfr., P. Pinel, La mania (1801), Marsilio, Venezia 1987. L’aspetto interessante, ai fini del nostro discorso, è relativo al fatto che la dimensione della follia, nell’avvincendarsi della storia dell’uomo, è stata percepita sia nel suo aspetto clinico-patologico sia in quello “culturale”, come una condizione di assoluta diversità rispetto all’omologazione del mondo. C’è la follia della lunga storia della psichiatria, che dal XVII sec. si è preoccupata a trattare i pazzi da un punto di vista naturalistico, c’è la follia dei manuali di psicopatologia, delle scuole di pensiero clinico, delle istituzioni totali. Ma accanto a tutto questo c’è quella dimensione della pazzia dei grandi testi letterari e drammaturgici. La follia di Amleto, ad esempio, è una follia che può e deve essere anche “simulata” in quanto deve mirare ad uno scopo, ovvero, “giustificare” la vendetta di Amleto per la morte del padre. Oppure, secondo un’analisi psicanalitica, è una manifestazione della follia che altro non è che una patologia che frantuma la personalità, come la nevrosi o la schizofrenia. La follia, dunque, interpretata tra la clinica e l’arte. La follia nell’arte svolge un ruolo rivelatore di verità troppo a lungo taciute, emblema di moti dell’animo che non riescono, a causa della realtà circostante, a trasfigurarsi in forma. Quando, infatti, i personaggi della letteratura e dell’arte sono folli, lo sono per indicare una verità o per lanciare una richiesta d’aiuto. Certo è che anche questa dimensione culturale della follia è sinonimo di un profondo dolore, di un mal di vivere provocato da una “esistenza ferita” questo lungo interrogarsi sulla dimensione della differenza, letta nei termini ora di follia, ora di devianza, di marginalità, oppure, in estrema sintesi, come manifestazione di “piaga” del corpo e dell’anima, esprime una sorta di resistenza nei confronti dei “diversi”, resistenza che spesso si è tradotta e si traduce tutt’ora nello sforzo di allontanare i diversi dalla vita quotidiana, che altro non è che una sorta di disagio dei cosiddetti normali. E’ come se si scorgesse nel folle l’incarnazione disinibita di desideri pulsanti, ma temuti e censurati, nella coscienza di esseri “normali”; come se si vedesse nel folle una libertà e una potenzialità paventata e agognata[1]. Ma l’orizzonte umano della follia è un orizzonte che si manifesta lontano dall’offrire visioni di libertà. Al contrario, la pazzia è una dimensione chiusa, è prigionia, povertà relazionale, solitudine sociale [1]Cfr., S. Moravia, L’esistenza ferita. Modi d’essere, sofferenze, terapie dell’uomo nell’inquietudine del mondo, Feltrinelli, Milano 1999. A volte il folle, il pazzo è colui che non è riuscito a manifestare tutte le proprie funzioni vitali in quanto non conoscendo se stesso e gli altri, non riesce a portare avanti relazioni profonde col mondo circostante. Altro caso è quando vengono considerati “folli” quegli atteggiamenti che hanno origine nella sofferenza di vivere. In tale senso, pazzo lo si “diventa” a causa della combinazione di diversi fattori individuali, sociali e culturali come, ad esempio, una biografia segnata da vicende dolorose di abbandoni e violenze, una storia di legami sociali o relazionali molto poveri. Nei vari modi di intendere e trattare la follia, Moravia riflette sul fatto che è come se vi fosse sempre stata una sorta di costante, ovvero una continua de-personalizzazione, o de-soggettivizzazione del soggetto che soffre. “Accettata” in una struttura, la persona sofferente viene spesso spogliata del suo essere, della sua essenza di persona. Ma il soggetto della cura non deve essere l’individuo “spogliato” ma, invece, l’individuo compreso come una persona che, varcando la soglia di un luogo preparato ad accoglierla, porta con sé tutto il suo esistere, quello sofferente e bisognoso d’aiuto e quello sano, in quanto tutti i sofferenti conservano zone e funzioni integre. L’oggetto da curare, allora, non deve essere la “sofferenza” ma il “sofferente” pronto ad essere accolto, non accettato, al fine di riuscire ad riattivare le sue potenzialità umane latenti, sopite o bloccate. In tale senso, l’internamento non è altro che un luogo che recide i rapporti del sofferente con l’esternità del mondo. E’ sicuramente vero che il mondo non è di per sé “salvifico”, ma è pur vero che solo il mondo è la dimora dell’uomo, con le sue dimensioni di bene e di male, di doni e abbandoni, di rischi e sconfitte. La persona separato dal mondo è un esule, uno sradicato alla continua ricerca di un senso. E’ in questa prospettiva, dunque, che Moravia intende la negatività della dimensione dell’internamento, in quanto l’istituzione nella quale viene rinchiuso il soggetto che soffre, potrà essere anche migliore del mondo, ma non è il mondo reale, bensì solo un ambiente artificiale: l’istituzione non potrà mai essere lo spazio di una consapevolezza maturativa reale. In questa ottica, si può comprendere come, a partire dagli anni Sessanta, un settore degli studi psicologici e psichiatrici definito “antipsichiatria”, ha enfatizzato in modo totale la provenienza sociale di molte malattie mentali, compresa la follia. Il cosiddetto “folle” risulta essere un potenziale avversario di una ben precisa ideologia, in quanto si manifesta come un ostacolo per lo sviluppo tecnologicoeconomico del Sistema. E’ così che molti studiosi hanno criticato sia le violenze commesse nei manicomi che la validità scientifico-clinica dell’istituzione manicomiale. Il movimento dell’antipsichiatria designa non tanto una scuola unitaria e organica, quanto una vivace e varia attività sia teorica che pratico-politica delineatosi, a partire dagli anni Sessanta, soprattutto in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia e in Italia. Uno dei principi basilari di questo movimento culturale, è stato la rivelazione della negatività dei manicomi. Nei manicomi, infatti, la vita fittizia e “manipolata” dei malati era una vita separata dal resto del mondo, dove tutto scorreva in una dimensione temporale immobilizzata in un eterno presente. Intorno agli anni Sessanta, la denuncia contro le strategie politiche che presiedevano alle strutture manicomiali, è cresciuta in maniera esponenziale giungendo, in molti paesi occidentali, alla realizzazione di radicali riforme dei manicomi, riforme conclusesi come ad esempio in Italia con la legge 180, con la loro soppressione. Parallelamente a questa proposta di denuncia, si sono mosse altre iniziative terapeutiche che, ispirate da principi completamente diversi, hanno affrontato la questione della follia e dei folli. Di rilevante valore è stato il pensiero dello psichiatra Ronald D. Laing che nel 1965 fondò la comunità di Kingsley Hall, una struttura dove vigeva il principio del dialogo, del gioco, del lavoro. Lo psichiatra inglese, pur non negando l’esistenza patologica di alcune malattie mentali, ha comunque evidenziato come un nutrito insieme di disturbi nervosi tragga in realtà la sua origine da difficoltà relazionali, dalla “crisi” di alcune istituzioni come la famiglia e, più in generale, dall’aspetto repressivo che il sistema sociale occidentale porta avanti. Le modalità di vita condotte dai soggetti che soffrono di tali disturbi non possono essere giudicate come insensate o irrazionali in quanto, in realtà, sono manifestazioni esistenziali di reazione ad un patire oppressivo e alienante. Laing descrisse la malattia mentale come una dimensione dell’esperienza esistenziale che, in linea di massima, è perfettamente comprensibile e dotata di senso. Laing, avvicinandosi allo studio della psicosi secondo un approccio non frammentario ma che, anzi, si nutre di notevoli spunti filosofici, esistenziali e politici, rifiuta a priori di considerare il malato come un diverso in quanto, per comprendere gli psicotici, bisogna trarre ispirazione dalla propria psicosi. Per Laing la “schizofrenia” non deve essere intesa come una malattia, ma come una dimensione dell’esperienza umana: “lo schizofrenico è chi ha il cuore spezzato, ed anche i cuori spezzati, come si sa, guariscono, purché si abbia abbastanza cuore da lasciarli guarire”. L’ultimo passo verso la psicosi si verifica quando l’io si scinde completamente dal corpo, che viene percepito come in possesso di altri. Il soggetto schizofrenico vive le stesse fratture del soggetto schizoide: 1) io interiore e io corporeo; 2) il corpo viene avvertito come estraneo all’io; 3) l’io continua ad agire nella fantasia, oppure nei casi più gravi, smette completamente di procedere. Il movimento antipsichiatrico italiano è legato alle opere e all’esperienza di Franco Basaglia. Nel manicomio di Gorizia, che Basaglia dirigerà per molti anni, erano ricoverati all’incirca seicentocinquanta pazienti. L’impatto con le drammatiche condizioni della realtà manicomiale è stato, per lo psichiatra italiano, decisivo. Basaglia inizia, così, ad impegnarsi in una radicale esperienza di trasformazione istituzionale; per la salute dei soggetti internati non dovevano esserci più solo terapie farmacologiche, ma anche e soprattutto bisognava scommettere sul valore dei rapporti umani anche con il personale della ‘comunità terapeutica’
Scaricare