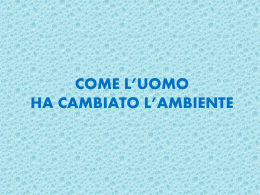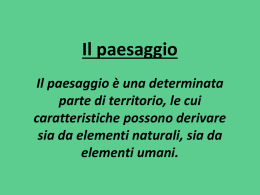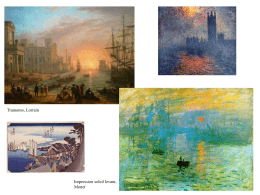Viviana Farina Riflessioni in margine a due mostre sul paesaggio Nature et Idéal. Le paysage à Rome. 1600-1650. Claude Gellée dit Le Lorrain. Le dessinateur face à la nature. Viviana Farina Riflessioni in margine a due mostre sul paesaggio © Viviana Farina 22 luglio 2011 www.ilseicentodivivianafarina.com Grafica e impaginazione Ivano Iannelli Grafica web Renato Caneschi Viviana Farina Riflessioni in margine a due mostre sul paesaggio Nature et Idéal. Le paysage à Rome. 1600-1650 Paris, Grand Palais 9 marzo-6 giugno 2011; Madrid, Museo Nacional del Prado 28 giugno-25 settembre 2011 Catalogo della mostra (Éditions de la RMN-Grand Palais, 2011), pp. 288, euro 42. Claude Gellée dit Le Lorrain. Le dessinateur face à la nature A cura di Carel van Tuyll van Serooskerken e Michiel C. Plomp assistiti da Federica Mancini Paris, Musée du Louvre, 21 aprile-18 luglio 2011; Haarlem, Musée Teyler, 28 settembre 2011-8 gennaio 2012. Catalogo della mostra (Louvre éditions-Somogy éditions d’art, Paris 2011) pp. 312, euro 29. 1. Parigi è stato possibile visitare una mostra che ha spiccato nel fittissimo calendario di eventi che oramai anche gli studiosi faticano a tenere d’occhio. Un’esposizione distintasi, innanzitutto, per il tema prescelto, valutato sia in rapporto alle numerose manifestazioni organizzate per il quattrocentenario della morte di Caravaggio, sia in relazione con la lunga serie di mostre pensate per illustrare, con più o meno coerenza e risultati convincenti, lo sviluppo artistico di un solo maestro. Messa da parte la monografia, si ha avuto il coraggio di affrontare un argomento delicato, più difficile per il gusto e, se vogliamo, meno interessante per il grande pubblico, quale la pittura di paesaggio, un genere pittorico nato quale categoria autonoma a Roma ad apertura del XVII secolo e pienamente affermatosi grazie alla preferenza accordata a questo tipo di decorazione profana, ad affresco e su tela, nei palazzi aristocratici e curiali e all’enorme successo commerciale ripagina scosso presso i collezionisti europei. Accantonando i raggruppamenti tematici, molto amati di recente (finanche nella mostra monografica da ultimo dedicata a Salvator Rosa tra Londra e Fort Worth), e che pure avrebbero potuto proporsi, presentandosi a confronto dipinti del medesimo soggetto eseguiti da mani differenti, si è meritoriamente preferito un criterio di esposizione del fenomeno in ordine cronologico. Stephane Loire e Andrés Úbeda de los Cobos, curatori della pittura Italiana barocca, rispettivamente, presso il Museo del Louvre e il Museo del Prado, sono i commissari generali dell’evento, ma fondamentale è da ritenersi l’apporto di tre studiose italiane, da tempo cimentatesi nell’analisi della pittura di paesaggio, Francesca Cappelletti, Patrizia Cavazzini e Silvia Ginzburg, di cui vanno almeno rapidamente qui ricordati gli importanti studi su Paul Brill, Agostino Tassi e Annibale Carracci. 1 Fin dal titolo – Natura e Ideale – la mostra richiama l’attenzione sul complesso rapporto tra la nuova osservazione dal vero dei fenomeni naturali affermatasi sullo scorcio del Cinquecento – una problematica tangente con l’esplosione dell’arte di Caravaggio – e la riproposizione di questi sulla tela in termini che poterono essere più o meno realistici. “Realistico” è però termine ottocentesco che non si adatta alla nostra percezione della rappresentazione del dato naturale nel XVII secolo. L’abitudine di disegnare en plein air proprio allora prendeva piede, sebbene tali studi grafici venissero poi rielaborati in bottega sulla tela. La natura risulta così sempre messa in posa, abbellita, composita di scelte parti precedentemente selezionate secondo un criterio di epurazione e di perfezionamento del reale che discende dal concetto di Bello affermatosi nel corso del secolo precedente, secondo quanto attesta lo scritto di Giorgio Vasari per eccellenza. E tuttavia, non vi è dubbio che numerosi tra quei primi quadri, seppur raffiguranti scene di paesaggi architettati e abbelliti, furono resi con tinte più vere e con una nuova sensibilità luministica facendo sì che essi venissero percepiti dai contemporanei quali prove di realtà. Nelle sale del Grand Palais più di ottanta dipinti e circa trenta disegni dei maggiori protagonisti di quella importante stagione hanno raccontato il differente e variegato apporto alla nascita del genere. Abbiamo ammirato vedute ideali della campagna romana, raffigurazioni nordiche, in termini nostalgici o non, della grandezza antiquaria della Roma antica, marine, capricci architettonici, o paesaggi che fanno da sfondo a scene mitologiche, storiche o letterarie. Un percorso scandito da cinque sezioni che, nel seguente ordine, hanno esemplificato: 1) le fondanti aperture offerte al pagina tema a Roma da Annibale Carracci e, già in precedenza e con obbiettivi ben diversi, dall’anversese Paul Brill, l’arrivo nella città eterna del geniale tedesco Adam Elsheimer; 2) l’evoluzione del paesaggio bolognese in senso ideale (Domenichino, Francesco Albani, Giovan Battista Viola, Pietro Paolo Bonzi il Gobbo dei Carracci, Giovanni Lanfranco e Sisto Badalocchio); 3) l’evoluzione del paesaggio nordico e la creazione del cosiddetto “paesaggio italianizzante” (Waals, Cornelis van Poelenburgh e Bartholomeus Breenbergh con il naturale inserto di Filippo Napoletano, etc.); 4) i disegni; 5) gli inizi di Nicolas Poussin e di Claude Lorrain sulla scia di Agostino Tassi; 6) il ciclo di paesaggi per il Palacio del Buen Retiro di Filippo IV a Madrid e la piena maturità di Poussin e di Claude. In assoluta evidenza è stato posto il ruolo di Annibale Carracci, testa d’ariete della prima sezione, e dunque della mostra, con l’indimenticabile Paesaggio fluviale della National Gallery di Washington (fig. 18). Un dipinto che Silvia Ginzburg, contro una tradizione di studi che lo vorrebbe uno spontaneo ricordo di un pomeriggio estivo degli anni bolognesi dell’artista fissato sulla tela dal caldo colore veneziano, propone di posticipare dal 1589/1590 al 1599 incirca, mettendone in luce la meditata e rigorosa composizione, frutto dello studio condotto da Annibale a Roma sulle prove paesaggistiche di Raffaello e scuola, e su Polidoro da Caravaggio in particolare, insieme con una rinnovata riflessione sulla tinta di Tiziano ispirata dai Baccanali di Alfonso I d’Este, nel 1598 frattanto confluiti nella raccolta capitolina di Pietro Aldobrandini (cat. n. 1). Circa nello stesso momento del dipinto di Washington, precisamente nell’anno giubilare 1600, Paul Brill firmava e datava la Veduta di Campo vaccino del Museo di 2 Dresda (cat. n. 7). La prevalente componente fantastica, sia compositiva che coloristica, tipica dell’arte del maestro, era all’epoca immensamente apprezzata; inoltre, la tranche de vie della vendita del bestiame inserita tra le rovine segnava gli inizi della grande fortuna di tali scene di genere. Di certo, al passaggio tra un sala e l’altra, il confronto con Annibale risultava perdente in termini di modernità e di anticipazione di motivi naturalistici affermatisi nell’Ottocento, ma non fu questo il punto di osservazione dei contemporanei e degli intendenti d’arte in particolare. Come ricorda anche Francesca Cappelletti in uno dei saggi di catalogo (p. 30), è la celebre Lettera sulla pittura del marchese Vincenzo Giustiniani, mecenate e collezionista di Caravaggio, a restituirci la giusta chiave di lettura: il dipingere un “paese vicino, o lontano”, azione posta dal nobiluomo al settimo grado di difficoltà artistica in una lista che prevede il suo culmine al numero dodici, poteva realizzarsi in due modi ben distinti dal punto di vista tecnico, ma ritenuti del tutto paritari quanto a valenza del risultato: il primo, più sintetico e consono agli italiani, ottenuto con il colore “confuso” o dato a “macchie”, di cui i migliori esponenti risultano Tiziano, Raffaello, Annibale e Guido Reni, il secondo, minuzioso e diligente, tipico dei nordici come Brill, Jan Brueghel e Herri Met de Bles il Civetta. Più in generale, non è stato facile per il visitatore comune, soprattutto ignorante dei cicli ad affresco realizzati da Brill a Roma – dove questo era giunto prima del 1580 per rimanervi sino alla morte nel 1626 –, comprendere all’interno del percorso espositivo l’importanza del contributo offerto dal fiammingo alla nascita del genere paesaggistico nella città eterna, o anche nella vicina Napoli. L’occhio più esperto ne riconosceva invece pagina già il frutto in sala grazie al piccolo gioiello che è il Riposo durante la fuga in Egitto di Giuseppe Cesari del Boston Museum, generalmente datato al secondo soggiorno partenopeo del Cavalier d’Arpino (cat. n. 17), maestro che solo di rado nelle sue tele lasciò ampio spazio alla scena paesaggistica. È varrà dunque il caso di valorizzare in questo specifico contesto il Paesaggio con satiro e ninfa (Giove ed Antiope?) già nella collezione Lodi a Campione d’Italia, ora passato nuovamente all’asta (Sotheby’s Milano 14 giugno 2011, lotto 19; fig. 1), in cui l’ampiezza di respiro e la qualità della veduta sono tali da avere spinto H. Röttgen (Il Cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino. Un grande pittore nello splendore della fama e nell’incostanza della fortuna, Roma 2002, p. 460, n. 238 e p. 186, fig. 99) a ipotizzare, prima, la collaborazione di Tassi, poi, quella di Breenbergh o di van Swanevelt, mentre forse è più semplicemente da cogliervi (dato anche il formato ridotto della tavola) il tentativo del Cesari (probabilmente un po’ prima degli anni Trenta, come vorrebbe lo studioso tedesco) di cimentarsi in proprio sui modelli di Elshemeir e Tassi, dopo la collaborazione intavolata, almeno una volta, con Cornelis van Poelenburgh sui primi anni Venti (cfr. il Paesaggio con Tobiolo e l’angelo del Palazzo Imperiale di Pavlovsk, ivi, p. 187, fig. 100). All’alba del primo decennio, respiro nuovo in termini di spazio, indagine luministica e resa atmosferica aveva dato frattanto all’arte di Paul Brill il tedesco Adam Elsheimer (la significativa Aurora di Braunschweig – cat. n. 12 – la si vede solo ora esposta a Madrid), offrendo spunti di grande importanza per le invenzioni di Carlo Saraceni (cat. nn. 15-16), Orazio Gentileschi (ma il celebre rametto con San Cristoforo di Berlino – cat. n. 18 – è an- 3 1. Giuseppe Cesari, Paesaggio con satiro e ninfa (Giove ed Antiope?), già Campione d’Italia, collezione Lodi (Sotheby’s Milano 14 giugno 2011, lotto 19) ch’esso visibile solo a Madrid), Jacob Pynas (cat. n. 48), Pieter Lastmann (cat. n. 47), del conterraneo Waals e di Filippo Napoletano, questi ultimi quattro artisti tutti illustrati nelle sale successive. Più prolissa la seconda sezione della mostra, dedicata agli allievi di Annibale, dove il solo, imponente, Paesaggio con la fuga in Egitto di Domenichino del Louvre (cat. n. 22) sarebbe stato sufficiente a illustrare il percorso seguito dallo Zampieri ad apertura degli anni Venti, quando egli rielaborava gli schemi compositivi di Annibale in direzione di una maggiore monumentalità, poi presa ad esempio dal maturo Poussin; così come il meno pagina visto Paesaggio durante la fuga in Egitto del Princeton Museum di Francesco Albani (cat. n. 26; artista di cui si sono esposte opere che ne mostravano lo sviluppo dal primo decennio sino al 1640 incirca), spettacolare prova della vicinanza stilistica con il maestro Annibale, avrebbe potuto supplire alla presenza dei più noti tondi della Galleria Borghese (cat. nn. 27-28). Pressappoco a un tempo con queste due ultime opere, verso il 1618, di tutt’altro significato per gli anni a venire fu la svolta impressa al genere pittorico da Guercino, quando l’artista, cogliendo l’attimo, ritraeva con sensibilità di lume discendente dal veneziano 4 Domenico Fetti (coinvolto anch’egli con Roma, ma non rappresentato in mostra) e da Adam Elsheimer delle nude al fiume, acconciandole poi alla storia mitologica. Il bagno di Diana (Rotterdam, Museum Boijmans, cat. n. 31), capolavoro di piccolo formato, nel clima “di calma sospesa” che lo caratterizza (S. Ginzburg), rivelava il debito contratto dal Barbieri con la pittura nordica, attestando, contemporaneamente, la maturazione di una nuova sensibilità di sguardo costituente il filo rosso che unisce le ricerche del pittore di Cento a quelle di Pietro da Cortona. Non sembra che quest’ultimo abbia fatto scuola con i pochi esperimenti condotti sul genere, eppure i minimi Paesaggi su legno della Pinacoteca Capitolina (cat. nn. 50-51), segnatamente quello a tema pastorale, apprezzabili in una sezione più avanzata del percorso espositivo, mostravano appieno come intorno al 1625 Pietro, allora al servizio dei Sacchetti, rappresentasse la prima personalità artistica capace di rielaborare i modelli carracceschi e nordici e la freschezza di tocco di Tiziano in una via di straordinaria modernità, sino al punto da lasciare l’impressione di avere dipinto tali tavolette d’après nature (P. Cavazzini). Nel contesto delle sale parigine, meno innovativo è apparso, viceversa, l’apporto al genere pittorico da parte di Sisto Badalocchio (cat. nn. 32-33), mentre probabili necessità di allestimento hanno fatto sì che si vedesse il Lanfranco del momento del Camerino degli Eremiti di Palazzo Farnese, del 1616-1617 (cat. nn. 34-35), solo nella penultima sala del percorso del primo piano, insieme con opere ben più avanzate nella cronologia, quali quelle di Salvator Rosa e di Diego Velázquez. Sul finale del secondo decennio, Roma vide il parallelo sviluppo di un secondo ed indipenpagina dente filone di ricerca di aerea nordica e italiana, non interessato come quello bolognese al processo di idealizzazione della natura osservata, bensì ad un studio realistico in cui la vera protagonista, secondo la attestata tradizione delle Fiandre, è la luce. Questo l’ambiente ricostruito nella terza sezione della mostra. Non vi è dubbio che un esponente di punta di tale corrente sia l’ancora misterioso pittore tedesco Gottfried Wals, vissuto in Italia tra Napoli, Roma e Genova, di cui abbiamo ammirato l’indimenticabile Strada di campagna con case (Cambridge Museum, cat. n. 37, fig. 2), uno dei più intensi rametti di formato rotondo per cui il maestro divenne celebre. Un’opera che mi sembra potere addirittura precedere il Paesaggio con il riposo durante la fuga in Egitto del Museo di Tokyo, recante sul verso un’iscrizione non autografa, ma da ritenersi affidabile in rapporto all’analisi stilistica, che lo colloca nel 1619 (cfr. A. Repp-Eckert, Nachträge zu Leben und Werk des Goffredo (Gottfried) Wals, in “Wallraf-RichartzJahrburch”, 67, 2006, p. 235). Nel rame di Cambridge, la massa minuziosa degli alberi stagliata sul cielo rivela l’eredità di Brill e di Elsheimer, ma nuovissimi risultano il taglio compositivo e lo sguardo silente e sintetico del pittore, concentratosi non sulla figura umana, che gli interessa appena, ma sull’alternanza tra l’ombra che divora i muri e la luce quasi accecante che bagna il resto della composizione: una lezione fondante per il napoletano Aniello Falcone (fig. 3), che giovanissimo ben dovette conoscere le opere del tedesco allora numerose (sessanta ne elenca il Capaccio nel 1630) nella raccolta partenopea del mercante fiammingo e suo protettore di eccellenza Gaspar Roomer. Vicenda molto delicata da dirimere è il rapporto di dare e avere tra Filippo Napoletano 5 2. Gottfried Wals, Strada di campagna con case, Cambridge, The Fitzwilliam Museum e Wals, figura a sé stante per la peculiare ricerca luminosa, fiaccata a torto dal trinciante e recente giudizio di Marco Chiarini (Teodoro Filippo di Liagnio detto Filippo Napoletano. 1589-1629, vita e opere, Firenze 2007, p. 29, in particolare), che lo ritiene un semplice gregario del di Liagnio, sotto il nome del quale ha preferito spostare una serie di dipinti in precedenza assegnati all’artista tedesco da Marcel Roethlisberger e Luigi Salerno. È il caso eclatante de Le mura di Roma (in prestito permanente alla National Gallery di Londra; cat. pagina n. 38), che si vede ora a Madrid, da catalogare più convincentemente sotto il nome di Wals che sotto quello di Filippo (Chiarini 2007, p. 342, n. 125) e che Patrizia Cavazzini propone, ragionevolmente, di datare sul 1620; come anche quello della più matura veduta con una Casa sulla montagna della Kunsthalle di Brema (cat. n. 39; Chiarini 2007, p. 323, n. 104, la ritiene viceversa del Napoletano), brillante simbiosi tra realismo nordico e serenità lirica in anticipo su Claude Lorrain, allievo di Wals, e sul vedutismo di primo Ottocento. 6 3. Aniello Falcone, Scena di elemosina (L’elemosina di santa Lucia), Napoli, Museo di Capodimonte La mostra francese, incentrata sul ruolo di Roma, ha sfiorato solo tangenzialmente la questione dell’andirivieni con Napoli di numerosi protagonisti di quella fruttuosa stagione storico-artistica, aspetto su cui è forse, dunque, qui utile soffermarsi brevemente per essere poi meglio indagato, tenendo presente che la città vicereale rappresentò, insieme con Roma e Firenze, una delle punte del triangolo in cui questi artisti si mossero. Ricordo intanto che Filippo Napoletano e Gottfried Wals dovettero incontrarsi proprio a Napoli pagina (ne fa cenno già P. Cavazzini in Agostino Tassi (1578-1644). Un paesaggista tra immaginario e realtà, catalogo della mostra a cura di P. Cavazzini, Roma 2008 p. 49), luogo dove il primo si era formato, presumibilmente presso Carlo Sellitto, e il secondo era giunto in data imprecisata (ignota è la cronologia dei suoi spostamenti, dedotta dalla testimonianza postuma del genovese Raffaello Soprani e dalle smilze notizie di Filippo Baldinucci, Pellegrino Antonio Orlandi e Lione Pascoli), di certo inserendosi nella folta colo- 7 nia dei fiamminghi e tedeschi stabilmente residenti in città. Al principio del 1615, quando Filippo si era mosso alla volta di Roma (Chiarini 2007, p. 489), Wals vi era forse anch’egli già giunto. Qui entrambi gravitarono nella bottega di Agostino Tassi, dove il tedesco è documentato alla fine del 1616 (Cavazzini 2008 p. 45), mentre la presenza del Napoletano è deducibile su base stilistica al tempo della decorazione della Camera di San Paolo al Quirinale, saldata al Tassi alla fine del 1617, ad ogni modo entro il giugno di questo ultimo anno quando Filippo partiva per Firenze (ivi, pp. 39-40). Anche in seguito i due maestri ebbero la possibilità di tenersi d’occhio. Tra il 1624 e il 1626, quando si ritiene che il di Liagnio sia rientrato brevemente a Napoli, Wals poteva ancora risiedervi, se era qui tra il 1620 e il 1622, periodo in cui si suole collocare l’alunnato di Claude Lorrain che, secondo Baldinucci, proprio nell’atelier partenopeo di Wals avrebbe appreso la pratica della prospettiva e del paesaggio. E se anche solo di passata, ricordo come queste prime aperture di Napoli alla pittura di architetture – che di fatto segnano l’introduzione in città della cultura di Agostino Tassi e spiegano il successo della produzione di François De Nomé – denotino un favore cittadino per il genere che annuncia, e in qualche modo giustifica, il più tardo e prolungato trasferimento da Roma a Napoli di uno specialista assoluto quale Viviano Codazzi. A Parigi, il mirabile Paesaggio fluviale con viaggiatori di Palazzo Pitti (cat. n. 40) rendeva perfettamente conto di questo intrigante momento dell’arte di Filippo Napoletano, in cui innegabile è il nesso con le ricerche luministiche di Wals, ma anche con le tipologie di Cornelis van Poelenburgh (si confrontino tali figure con le sagome della Veduta di Campo pagina Vaccino del museo del Louvre, iscritta dall’olandese nel 1620, cat. n. 43), ciò che induce a preferire la proposta di datazione di Patrizia Cavazzini sul 1619 a quella sul 1617 sostenuta da Marco Chiarini (2007, p. 246), nonostante sia più probabile il ruolo trainante di Filippo Napoletano sul van Poelenburgh e non viceversa. Quest’ultimo maestro, negli antichi inventari indicato come Cornelio Satiro, originario di Utrecht, la cui presenza a Roma è documentata con continuità da disegni firmati dal 1619 al 1623, dové soggiornare anch’egli a Firenze nel corso del 1618 (Sandrart lo dichiara al seguito del granduca ed amico di Callot), quando non si hanno ulteriori tracce dei suoi movimenti, ossia al momento in cui pure Filippo Napoletano era al servizio di Cosimo II. Stanno ad attestarlo, più dei dipinti entrati ab antiquo nelle collezioni medicee, i ricordi grafici del Bacco di Michelangelo e dei perduti affreschi di Pontormo in San Lorenzo (A. Chong, The Drawings of Cornelis van Poelenburch, “Master Drawings”, 25, 1, 1987, Appendix II e cat. n. 17v). Ed è qui che la Napoli del secondo decennio può fare di nuovo capolino. Cornelis van Poelenburgh è infatti da identificare nel “Cornelio”, “il Fiamingo”, esperto di paesaggio citato, insieme con Ribera, Battistello Caracciolo e l’oramai meno amato Fabrizio Santafede, in alcune lettere che del febbraio al maggio del 1618 Cosimo del Sera, agente mediceo, spediva da Napoli a Firenze ad Andrea Cioli, segretario del granduca Cosimo II (A. Parronchi, Sculture e progetti di Michelagenlo Naccherino, “Prospettiva”, n. , 1980, p. 40), quale artista presente in città, intento ad un paesaggio – non ancora pronto il 1 di maggio – da inviare a Firenze (“e si vorra pigliar il tempo di trovarlo fuor dallegria alla quale egli e spesso sottoposto”), città dove il 8 maestro potrebbe quindi essere giunto nella seconda parte del medesimo 1618. La notizia, che colma innanzitutto la lacuna della biografia italiana di Cornelis, lascia intravedere come Napoli, che il pittore dovette raggiungere poco dopo il suo arrivo a Roma, dove nel 1617 scriveva versi nell’Album amicorum di Wybrand de Geest, offrisse evidentemente più possibilità di lavoro e di successo di quanto sia emerso sinora dagli studi. Non sappiamo quando i paesaggi di “Cornelio Satiro” fossero entrati nella raccolta dell’anversese Gaspar Roomer (Capaccio 1630), residente a Napoli almeno dal 1616 e possessore di ben 459 quadri di tale tema (degli “infiniti paesi, e … bellissimi”, tra cui alcuni di Brill e di Lorrain, riferiva Pietro Andrea Andreini a Leopoldo dei Medici il 4 aprile del 1675; cfr. R, Ruotolo, Mercanti-collezionisti fiamminghi a Napoli. Gaspare Roomer e i Vandeneyden, Ricerche sul ‘600 napoletano, 1982, p. 21, nota 23); né tantomeno è, forse, possibile identificare il dipinto a cui Poelenburgh lavorava a Napoli al principio del 1618 per Cosimo II nel Paesaggio con rovine nella campagna di Palazzo Pitti che si è visto esposto a Parigi (cat. n. 42; fig. 4), uno dei rametti di cui è noto il passaggio nella collezione del cardinale Giovan Carlo e poi di Ferdinando dei Medici. Ma di certo il quadro rende conto dei primi esercizi del maestro (Francesca Cappelletti lo data entro il 1620), intento all’aggiornamento del rovinismo di marca nordica e del modello di Paul Brill in particolare: la nuova monumentale incombenza del prisco edificio, a cui l’occhio dell’artista si accosta da presso, come quello di Filippo Napoletano concentrato nella ripresa di case e mulini, e il vigoroso chiaroscuro ben si legano, infatti, al filone paesaggistico e rovinista sviluppatosi a Napoli, circa dieci dopo, con Aniello Falcone pagina (fig. 5), e di qui dritto sino a Micco Spadaro e a Salvator Rosa (fig. 6), nelle opere dei quali databili al quarto decennio è giusto riconoscere le impronte dei modelli compositivi e figurativi e delle indagini luminose di van Poelenburgh. Meno chiari, invece, i rapporti dei napoletani con Bartholomeus Breenbergh, maestro di Deventer residente a Roma tra il 1619 e il 1629 incirca, in principio collaboratore nell’ancora attiva bottega di Brill e poi membro della Bent insieme con van Poelenburgh. Il Paesaggio con il tempio di Minerva Medica del museo di Würzburg (cat. n. 45), siglato “BB”, ha messo in evidenza come la lezione dell’olandese, a sua volta improntata allo stile fiorentino di Filippo Napoletano, debba essere inclusa tra le fonti di Domenico Gargiulo e Salvator Rosa che dovettero ammirarne la morbidezza atmosferica e il gioco contrastato delle luci e delle ombre proiettate sul monumento. La cronologia del decennio italiano di Breenbergh è abbastanza oscura. Tuttavia sarei tentata di non avanzare il dipinto di Würzburg sino al 1627 circa, una datazione successiva a quella del Paesaggio con Cristo e la Samaritana (collezione Tyssen-Bornemisza, cat. n. 46), segnato 1625 (e distinto da tipi che si rivelano più vicini ai modi di van Laer e Cerquozzi che di Filippo Napoletano), e prossima a quella de La Villa di Mecenate, uno studio firmato e datato nel 1627 (Fondazione Custodia, cat. n. 104) che si è potuto vedere a Parigi nella sala dei disegni, sebbene esso costituisca un ragionevole punto fermo di confronto. È quest’ultimo foglio ad offrire pure l’occasione di ricandidare il nome del Breenbergh per l’Accampamento di zingari tra le rovine della villa di Mecenate un tempo in collezione Gualino a Roma, tela che si ritiene dipendere, come anche il disegno della Fon- 9 4. Cornelis van Poelenburgh, Paesaggio con rovine nella campagna, Firenze, Galleria Palatina dazione Custodia, dal quadro di analogo soggetto di Filippo Napoletano conservato al Museo di Bordeaux, attribuito all’olandese da Giuliano Briganti e da Marcel Roethlisberger, poi conteso a Filippo Napoletano da Luigi Salerno e da Marco Chiarini e di nuovo al Breenbergh da Ludovica Trezzani (La pittura di paesaggio. Il Seicento, a cura di L. Trezzani, Milano 2004, pp. 172 e 174, con bibliografia). Un’opera che, a latere, solleva intanto anch’essa la questione delle tangenze stilistiche tra il pittore nordico e il Gargiulo dello scorcio del quarto decennio. Poco felice è apparsa, invece, la scelta di esporre a Parigi il pur pregiato rame di Digione con la Caduta di Simon Mago di Leonart Bramer (cat. n. 49; pittore per altro ben copagina nosciuto a Napoli grazie ancora a una volta alle scelte à la page di Roomer), opera che, nello specifico, non poteva illustrare il contributo offerto dall’artista di Delft allo sviluppo del genere paesaggistico. Altre osservazioni sono possibili relativamente alla penultima sala del percorso espositivo, accogliente dipinti di Salvator Rosa, i già sopra menzionati di Pietro da Cortona e di Giovanni Lanfranco e, ancora, la Veduta del giardino di Villa Medici di Diego Velázquez (Madrid, Museo del Prado, cat. n. 57), un miracolo di pittura del 1649/1650 che non vedo possibile situare stilisticamente al tempo del primo viaggio italiano del maestro di Siviglia, nonostante l’ipotesi abbia il sostegno autorevole di José Milicua. 10 5. Aniello Falcone, Il tempio di Venere a Baia, Madrid, Biblioteca Nazionale 6. Salvator Rosa, Paesaggio con il castello di Baia, Chicago, The Art Institute Quanto alle opere scelte per illustrare al pubblico la grande innovazione apportata al tema dal napoletano Rosa, celebre pittore di paesaggio dei suoi tempi, si sarebbe preferito vedere esposta qualche primizia degli anni tra Napoli e Roma, piuttosto che la Marina delle Torri e il Ponte rotto di Palazzo Pitti, databili alla seconda parte del periodo fiorentino dell’artista (cat. nn. 55-56), e visti già tre volte in esibizioni tenutesi tra il 2007 e il 2010. Nuovi spunti di riflessione ha, però, offerto il Paesaggio lacustre con armenti e rovine del Museo di Cleveland (cat. n. 54; fig. 7), questo non esposto in Italia dal 1998. Conservato nella galleria di Modena sino al 1868, il dipinto è parte di un gruppo di tre quadri – gli altri due raffiguranti il Paesaggio con Erminia che incide il nome di Tancredi e la Veduta di un golfo tutt’oggi alla Galleria Estense (figg. 8-9) – a cui Salvatore lavorò nel corso del 1640 a Roma per conto di Francesco I d’Este duca di Modena. La serie, come è noto, è stata identificata grazie ad una lettera del 1 settembre di quell’anno, inviata da Roma da Francesco Mantovani, agente granducale, che alla data spediva a Modena (“mando”) quattro “paesi”, due di Rosa (“che si conosceranno benissimo, poiché nell’aria hanno dello sfumato come il primo”), uno di Hermann van Swanevelt ed uno di François Perrier, andatisi ad aggiungere ad altre due tele di Rosa e di van Swanevelt già inviate in una data imprecisata. Il testo del documento, generico circa la cronologia, non rende dunque necessario retrodatare tale prima spedizione sino al 1639 (Rosa era pittore in grado di realizzare ben più di tre tele nel corso di un solo anno), secondo quanto proposto da Anna Colombi Ferretti (in L’arte degli estensi. La pittura del Seicento e del Settecento a Modena e a Reggio, catalogo pagina della mostra, Modena 1986, pp. 266-268) ed accettato nella letteratura successiva. A parere della studiosa, poi, il Paesaggio con Erminia che incide il nome di Tancredi sarebbe la prima opera eseguita da Rosa, in gara nella messa in scena del poema di Tasso con Hermann van Swanevelt, autore di una Erminia tra i pastori anch’essa ancora conservata nelle collezioni estensi (ivi, pp. 264-265, cat. n. 180); la Veduta di un golfo e il Paesaggio lacustre con armenti e rovine costituirebbero, dunque, un’armoniosa coppia in pendant spedita nel settembre del 1640. L’associazione di tali vedute, dove l’acqua rappresenta l’elemento unificante, è, di fatto, di grande suggestione; inoltre, posto il quadro di Cleveland alla sinistra della Veduta di un golfo, si apprezza il contrasto tra il dolce declivio del promontorio dipinto sul confine destro della tela americana e il picco roccioso che apre sul margine sinistro la composizione tutt’oggi conservata a Modena. Ciò nonostante, il medesimo genere di congiunzione/opposizione visiva si scopre anche una volta posizionato il Paesaggio con Erminia che incide il nome di Tancredi – dove pure è uno specchio d’acqua dolce ritratto in secondo piano – alla sinistra della Veduta di un golfo. Di recente Helen Langdon (Salvator Rosa tra mito e magia, catalogo della mostra, Napoli 2008, p. 194, cat. n. 56), pur riportando la tesi della Colombi Ferretti, aveva intanto già sollevato un “leggero dubbio” circa la scelta di isolare il Paesaggio con Erminia che incide il nome di Tancredi, che, viceversa, una volta ricongiunto alla Veduta di un golfo, evidenzierebbe meglio il tentativo di emulazione da parte di Rosa dei contrastati abbinamenti tematici di Claude Lorrain. Sorge, però, pure il sospetto che le tre opere, tutte di identiche misure, fossero tra di loro in qualche modo 12 7. Salvator Rosa, Paesaggio lacustre con armenti e rovine, Cleveland, Museum of Art intercambiabili, senza contare che le due spedite il 1 settembre del 1640 poterono anche non essere concepite in pendant: il Mantovani è specifico solo al riguardo dell’alto gradimento riscosso dal primo dipinto inviato da Salvatore rispetto a quello di van Swanevelt, sino al punto da farne richiedere altri due al napoletano. Non mi sembra, dunque, che le parole della lettera obblighino, come si è accettato sinora, a ritenere l’Erminia la prima delle opere eseguite da Rosa in virtù dell’esistenza dell’Erminia tra i pastori di van Swanevelt: la competizione sul tema tassesco, se pure vi fu, non comporta necessariamente tale conclusione; inoltre, non è dato di sapere pagina se la seconda tela compiuta dal pittore nordico per Francesco I, di cui rimane la descrizione di Mantovani (“contiene certe vaccine rosse ed una donna vestita di turchino”), non fosse stata la prima a giungere a Modena. Nel riconsiderare le tre tele di Rosa, ed ora che mi è stato possibile studiare il paesaggio di Cleveland dal vero, ritengo che sia in esso che vada riconosciuto il quadro di cui il Mantovani elogia lo sfumato: l’omaggio alla luce dalle dolcissime inclinazioni e ai delicati effetti atmosferici di Claude Lorrain non è infatti paragonabile per intensità di risultati né al Paesaggio con Erminia che incide il nome di Tancredi, più vicino nel mood e nei tipi a 13 8. Salvator Rosa, Paesaggio con Erminia che incide il nome di Tancredi, Modena, Galleria Estense van Swanevelt, né alla Veduta di un golfo, che annuncia le grandi marine dipinte per Giovan Carlo dei Medici nel 1641. Seppure solo di qualche mese, la priorità cronologica del Paesaggio lacustre con armenti e rovine è comprovata dall’imprinting ancora napoletano della tela, rivelato dal fresco e sciolto tocco del pennello del maestro, in continua evoluzione stilistica dopo prove pittoriche del genere del Paesaggio con edificio antico, pastore ed armenti del Museo di Chicago (fig. 6), da me argomentato al 1638 incirca, ossia all’ultimo tempo partenopeo di Rosa (V. Farina, Il giovane Salvator Rosa, 1635-1640 circa, Napoli 2010, pp. 88, 90, 92). pagina 2. Nel passaggio dal primo al secondo piano del Grand Palais, la bella idea di decorare l’androne con le riproduzioni fotografiche della Sala dei Palafrenieri di Palazzo Lancellotti a Roma (fig. 10), uno dei laboriosi cantieri a cui Agostino Tassi lavorò a partire dal 1620 incirca, affiancato in alcuni ambienti da Guercino e da Giovanni Lanfranco, permetteva al grande pubblico quanto meno di intuire l’enorme importanza di questo caposcuola, sino a quel momento non rappresentato visivamente nelle sale del percorso. La finta doppia loggia, che al piano inferiore apre la vista a scene di terra e di mare, ben metteva in evidenza il ruolo fondante di Tassi 14 9. Salvator Rosa, Veduta di un golfo, Modena, Galleria Estense – già noto agli studi, ma ancora da puntualizzare – per la nascita della veduta marina di Salvator Rosa e di Domenico Gargiulo. Ed è proprio la parete della Sala dei Palafrenieri a costituire il più interessante repertorio di motivi variamente utilizzati nei cicli ad affresco realizzati a partire dal 1638 da Micco Spadaro nella Certosa di San Martino a Napoli (fig. 11), finanche negli illusivi decori scultorei e architettonici, motivi che a loro volta costringono a chiamare in causa il bergamasco attivo a Napoli Viviano Codazzi, di cui di recente e a ragione si è reclamata la dipendenza culturale dal Tassi (R. Pantanella in La pittura di paesaggio cit., p. 267). Né mi appare anpagina cora messo in giusto rilievo l’apporto dei disegni a penna e inchiostro di Agostino (cat. nn. 106-107; [si guardi soprattutto al Paesaggio costiero con figure esposto contemporaneamente alla monografica sul Lorrain presso il museo del Louvre, fig. 12]) alla determinazione dello stile grafico di Domenico Gargiulo, forse ancor di più che di quello del Rosa (il quale sembra, però, avere riapprezzato la maniera del maestro romano nel corso della sua maturità). Ad apertura della sezione del piano superiore naturale collocazione trovavano, dunque, altre opere di Tassi, quali il Paesaggio con la scena di stregoneria (Baltimore, The Wal- 15 ters Art Gallery, cat. n. 58), tratto dalla celebre Circe di Dosso Dossi, vista dall’artista a Roma in collezione Borghese, e il più tardivo L’arrivo di Cleopatra a Tarso (Paris, Galerie Canesso, cat. n. 59), entrambi utili a spiegare, rispettivamente, l’origine della placida natura boschiva di Claude Lorrain (si metta, ad esempio, a confronto il Paesaggio con pastore del Gelée di Londra, cat. n. 61) e gli albori dell’attività del medesimo pittore francese, che, come è occorso sopra di ricordare, aveva frequentato la bottega di Tassi nel periodo intorno al 1622-1625. Il ratto di Elena di collezione privata inglese, attribuito da tempo al pagina giovane Claude allievo di Agostino (cat. n. 60), lasciava frattanto qualche perplessità circa il responsabile dell’esecuzione. Questi gli inizi della quinta sezione della mostra, da questo momento in poi meno capace di suscitare la curiosità dello specialista, ma di certo utile ai più nell’ambizioso tentativo di raccontare la piena affermazione del genere pittorico all’incirca tra il 1625 e il 1650, a partire dalle straordinarie riletture dei miti bacchici di Tiziano da parte di Nicolas Poussin (cat. nn. 63-65), giunto a Roma nel 1624, alle prove paesaggistiche di Lorrain elaborate sulla metà degli anni Trenta. Punto, 16 10. Agostino Tassi e aiuti, Decori della Sala dei Palafrenieri, Roma, Palazzo Lancellotti 11. Domenico Gargiulo, Paesaggio con santo eremita, Napoli, Certosa di San Martino, Quarto del Priore questo ultimo, idealmente completato dall’esposizione monografica organizzata dal Museo del Louvre in onore del Gellée, aspetto su cui ritornerò dunque più avanti. L’imponente richiesta di quadri di paesaggio da parte degli emissari di Filippo IV di Spagna, per addobbare l’allora sorto complesso del Buen Retiro di Madrid, uno dei grandi eventi del mondo artistico al passaggio tra quarto e quinto decennio del Seicento, sanciva la piena affermazione di tale genere pittorico. Sommi rappresentanti politici del sovrano, coadiuvati da agenti, si incaricarono di coordinare la massiccia commissione di pitpagina ture, provenienti dalle Fiandre e da Roma (dove vennero coinvolti i migliori, nonché emergenti specialisti allora disponibili: Poussin, Lorrain, Dughet, Lemaire, van Swanevelt, Jan Both, Jan Asseljin), in un arco di tempo che potrebbe cadere tra la fine del 1633 – il palazzo veniva inaugurato nel dicembre di quell’anno – e l’estate del 1641. Il tema, trattato da numerosi contributi specialistici seguiti all’oramai celebre studio di apertura di Brown ed Eliott (A Palace for a King. The Buen Retiro and the Court of Philip IV, New-Haven, London, Yale 1980), e già sottoposto all’attenzione del pubblico in occasione della mostra madri- 17 12. Agostino Tassi, Paesaggio costiero con figure, Paris, Musée du Louvre lena specificamente dedicata alla ricostruzione dei decori del Buen Retiro (El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, catalogo della mostra a cura di A. Úbeda de los Cobos, Madrid 2005), è stato ora ripresentato in due delle sale del secondo piano del Grand Palais, occupate da una scelta delle tele originariamente appartenenti al congiunto ed oggi di pertinenza del Museo del Prado di Madrid. Mi si offre così l’occasione di precisare alcuni aspetti di tale intricata vicenda, ripercorsa con ampiezza nei saggi ricostruttivi di Giovanna Capitelli (ivi, pp. 241-261 e schede) ed in quello in catalogo a firma di Andrés Úbeda de los Cobos (Les tableaux de paysage destinés au palais du Buen Retiro de Madrid). pagina Vorrei, innanzitutto, ricordare come vi sia ancora incertezza circa la maggiore o minore responsabilità assunta dai vari alti aristocratici, menzionati nella documentazione superstite, nel coordinamento della commissione, come anche circa i tempi precisi di lavorazione dei quadri. Le poche tracce cartacee disponibili non aiutano molto in questa ultima direzione: sappiamo solo che nel gennaio del 1639 ventiquattro dipinti giunsero da Roma a Madrid e che una seconda e plausibilmente decisiva consegna di diciassette casse di quadri, partiti dalla capitale via Napoli, cadde nel settembre del 1641. Allo stato Andrés Úbeda propone di non scindere la commissione di tali paesaggi dalla richiesta, altrettanto nota, 18 del ciclo di Storie dell’antica Roma destinato al medesimo palazzo a cui, sin dal 1633 e per l’interessamento del viceré di Napoli conte di Monterrey, lavorarono numerosi maestri attivi tra Roma e la capitale vicereale (Lanfranco, Domenichino, Poussin, Romanelli, Camassei, Ribera, Stanzione, Artemisia Gentileschi, Finoglio, Cesare Fracanzano, Falcone, De Lione, Codazzi e Gargiulo e altri). Nella cosiddetta Testamentaría del 1701 (l’unico inventario disponibile, sebbene tardivo, utile per la conoscenza delle collezioni di Filippo IV) vengono elencati dipinti di paesaggio in numero ben superiore a quello delle opere sinora ritracciate, così che l’ipotesi di far risalire l’incarico della serie al 1633 può ritenersi attendibile a patto, però, di scinderla dallo studio dei dipinti superstiti. Nessuno di essi può, infatti, sostenere una cronologia così precoce, tantomeno i quadri di formato orizzontale con santi eremiti generalmente ritenuti parte del primo incarico di ventiquattro tele giunte a Madrid nel gennaio del 1639. L’ipotesi di Úbeda assume dunque di valore se integrata con un dato documentario noto da tempo (M.T. Chaves Montoya, El Buen Retiro y el conde-duque de Olivares, “Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte” (Universidad Autónoma de Madrid), IV, 1992, pp. 217-230), attestante come nel dicembre del 1633 alcune sale del palazzo del Retiro fossero già state decorate con una serie di paesaggi con anacoreti che il conte di Monterrey aveva inviato da Napoli. La sola Giovanni Capitelli (2005, p. 244) ha proposto il collegamento tra la notizia e un gruppo di sedici quadri rintracciabili nella Testamentaría ai numeri 308-323, tutti precisati nel soggetto sacro raffigurato e attribuiti in massa a “Campaño Napolitano”, ossia – ha osservato a ragione la studiosa – a Scipione Compagno, pagina petit maître attivo a Napoli negli anni Trenta del XVII secolo. Rilevo frattanto a margine come la notizia sveli, nuovamente, il ruolo, se non proprio di leadership, ma di sicuro primo piano, ricoperto dalla città vicereale nel processo di sviluppo e affermazione della pittura di paesi nel primo Seicento. Dinnanzi a tale penuria di sicuri punti di riferimento, la cronologia che si è attribuita all’intera prima serie di paesaggi per Filippo IV si è sinora basata, in concreto, su quella assegnabile ai dipinti di Claude Lorrain. Secondo Filippo Baldinucci, biografo dell’artista, proprio in occasione della realizzazione degli otto quadri richiesti dal sovrano spagnolo (oggi se ne conoscono solo sette), Claude avrebbe dato inizio alla compilazione del cosiddetto Liber Veritatis (Londra, The British Museum), un taccuino composto di 195 disegni realizzati a posteriori delle proprie composizioni pittoriche al fine di difenderne la priorità inventiva (su di esso, cfr. principalmente M. Kitson, Claude Lorrain. Liber Veritatis, Londra 1978). Sul retro di cinque di questi fogli (LV 32, 47-50), il pittore ha esplicitato la destinazione al monarca di altrettante opere oggi rintracciabili nelle collezioni del Museo del Prado (inv. nn. 2258, 2252, 2253, 2254, 2255) e non altrimenti databili con certezza. Il Liber Veritatis non riporta, però, date precise sino al 1648, anno iscritto sul LV 117; la cronologia dei fogli che precedono questa ultima carta, inclusi quelli riferibili ai quadri realizzati per Filippo IV, non è dunque fissabile ad annum, ma deducibile in base all’ordine dei disegni, inseriti nel volume in ordine progressivo (con qualche eccezione – Kitson 1978, p. 13), ordine a sua volta stabilito in base alle possibili corrispondenze con tele che Claude ha iscritto e datato. La cronologia assegnata ai disegni ha permesso dunque di fissarne una 19 orientativa per alcuni dipinti e, viceversa, quadri datati hanno suggerito una più precisa scansione dell’ordine dei fogli nel taccuino. Va da sé che nel consultare i testi di Kitson e di Marcel Roethlisberger (Claude Lorrain. The Paintings, 2 voll., New Haven 1961), entrambi costantemente utilizzati quali principali riferimenti bibliografici nella letteratura relativa alla commissione del Buen Retiro, si possano rinvenire numerose divergenze di opinione circa tali questioni cronologiche. Il preambolo è necessario al fine di mettere in luce come attualmente non vi sia alcun elemento concreto che permetta di legare la prima serie di paesaggi italianizzanti per Filippo IV – incluse le tele di Lorrain – al biennio 1635-1636, così come si trova riportato nella bibliografia relativa al Buen Retiro, come in quella specificamente dedicata al Gellée. Le Tentazioni di sant’Antonio (Prado n. 2258; cat. n. 68), uno dei tre quadri di formato orizzontale con santi eremiti del Lorrain che si sogliono ritenere parte della serie di opere consegnate a Madrid nel gennaio del 1639, nonché unico quadro di Claude, a differenza del Paesaggio con santo eremita (già Onofrio; P. 2256) e del Paesaggio con Maria Cervellón (P. 2259), a ritrovarsi schizzato nel Liber Veritatis, non sembrano di fatto potere spettare ad una data precedente al 1638 circa. Nel taccuino, la collocazione del disegno corrispettivo a carta 32 (cat. n. 108) circostanzia tale datazione (già fissata da Michael Kitson), per altro supportata dall’analisi dello stile della tela, una volta verificato che il LV28, che precede l’LV32, è il disegno relativo alla celebre Veduta di un porto con Villa Medici oggi agli Uffizi, che da ultimo sappiamo con certezza essere stata commissionata a Lorrain nella seconda metà del 1637 dal giovane Leopoldo dei Medici con la mediazione dello zio cardipagina nale Carlo (E. Fumagalli in “filosofico umore” e “meravigliosa speditezza”. Pittura napoletana del Seicento dalle collezioni medicee, catalogo della mostra, Firenze 2008, p. 47). È mia idea che l’analisi stilistica non obblighi ad anticipare al 1635-1636 il Paesaggio con santo eremita (già Onofrio) e il Paesaggio con Maria Cervellón (cfr. Capitelli 2005, pp. 250251, mantenendo la datazione di Roethlisberger), tele compagne delle Tentazioni di sant’Antonio che, in tal modo, verrebbero a precedere queste ultime non di poco nei tempi della commissione; né, parallelamente, mi sembra che il punto di stile costringa a tenere in questo medesimo biennio, piuttosto che in quello 1637-1638 (cronologia di fatto rintracciabile nelle singole schede delle opere), i paesaggi di Poussin (P 2304; cat. 67), di Dughet (P. 2305 – cat. 73 – e il Paesaggio con san Giovanni Battista e Cristo di collezione privata londinese), di Lemaire (P. 2316, cat. 74), né tantomeno i vari quadri di formato orizzontale di van Swanevelt e di Jan Both che da ultimo sono stati più genericamente inseriti nel periodo “1634/36-1639” (T. Posada Kubissa, Museo Nacional del Prado. Catálogos de la colección. Pintura holandesa, Madrid 2009, pp. 204-221). Vorrei intanto rilevare a latere, come la partecipazione al progetto da parte di Jan Both cadrebbe meglio nel periodo 16371638, piuttosto che in quello 1634-1636, se si ritrova il pittore iscritto all’Accademia di San Luca – dunque affermatosi in via indipendente a Roma – solo nel 1638, senza tenere in conto che la data di nascita, generalmente posta tra il 1618 e il 1622, rende poco credibile un arretramento della sua autonomia lavorativa a prima dei vent’anni. È così possibile individuare alcuni dati documentari che suggeriscono una datazione per i primi dipinti della serie del Buen Retiro 20 non anteriore al 1637. In questo ultimo anno, Claude Lorrain dedicava al marchese di Castel Rodrigo, ambasciatore del re di Spagna a Roma sin dal 1632 e personaggio chiave per il coordinamento della commissione in cui il Gellée veniva coinvolto, una serie di tredici incisioni realizzate per i festeggiamenti capitolini di Fernando III di Ungheria, allora incoronato “Rey de los Romanos” (e non mi sembra questione di poco conto collegare la notizia anche alla lavorazione delle Storie di Roma antica dipinte dai napoletani Falcone e Andrea de Leone a mio giudizio proprio intorno al 1637). Inoltre, solo nel 1637 il medesimo marchese di Castel Rodrigo vedeva stanziato un ingente finanziamento di seimila scudi annuali per coordinare il progetto dei paesaggi (cfr. Úbeda de los Cobos, p. 72). Se nel gennaio del 1639 venivano consegnati solo ventiquattro quadri di tale tematica, si può dedurre che gli artisti vi si fossero applicati nel corso dell’anno precedente. Nel 1640 tutti gli esperti del genere pittorico erano ancora a lavoro per conto di Filippo IV (è quanto emerge da una lettera riguardante la cessione al sovrano spagnolo dei quadri Ludovisi), tanto da rendere impossibile trovare a Roma chi si rendesse disponibile a dipingere paesaggi per il viceré di Napoli duca di Medina de las Torres, che all’uopo aveva mandato nella città pontificia come suo agente Cosimo Fanzago (Farina 2010, pp. 31, 83). Tornerò in altra occasione sull’episodio, che offre frattanto un’importante traccia documentaria utile a spiegare il rapporto stilistico che mi sembra legare van Swanevelt e Jan Both al napoletano Micco Spadaro, nel 1640 già impegnato nella decorazione paesaggistica della Certosa di San Martino proprio sotto la regia del Fanzago. pagina Una seconda serie di tele, generalmente identificata in alcune opere di formato verticale e nel gruppo dei Paesaggi bucolici oggi di pertinenza del Museo del Prado, giunse poi, come si è detto, a Madrid nel settembre del 1641. In questa seconda tornata si propone ora di includere, secondo la proposta avanzata per prima da Helen Langdon (Salvator Rosa, ed. by H. Langdon with X.F. Salomon and C. Volpi, London 2010, pp. 129-130), una grande Marina di Salvator Rosa (cat. n. 53, esposta solo a Madrid; figg. 13-14), siglata, reduce dal prestito al Museo di Fort Worth, sede americana della mostra monografica intitolata da ultimo al maestro. Per motivi che saranno qui di seguito nuovamente enumerati e meglio argomentati, nel recensire l’evento avevo espresso le mie perplessità a riguardo di tale identificazione (V. Farina, Salvator Rosa. Story of a Myth in Yesterday’s and today’s England, in “Mas Arte”, 66, marzo-abril 2011, p. 18). Due punti in particolare mi spingevano alla diffidenza: il formato dell’opera (170x260 cm), maggiore rispetto alle tele orizzontali rintracciabili nella serie di tele oggi al Prado (mediamente tutte di 155x235 cm), e il soggetto, mancando in essa qualsiasi riferimento eremiticoreligioso, né tantomeno potendo essa rientrare nella categoria dei paesaggi bucolici. Devo alla generosità di Andrés Úbeda l’avere avuto la possibilità di condurre una nuova riflessione dal vivo (giugno 2011) su questo pregevolissimo quadro, non esposto a Parigi e a me noto grazie ad una prima visita nei depositi del Museo del Prado effettuata nel corso del 2009. Non nutro più dubbi circa il fatto che risulti per esso del tutto incongrua la datazione sul 1636-1638 proposta da Caterina Volpi (in Salvator Rosa 2010, p. 136, cat. n. 9), che im- 21 13-14. Salvator Rosa, Marina, Madrid, Museo del Prado (intero e part.) plicherebbe l’allineamento stilistico della tela con le più acerbe prove degli anni napoletani (fig. 6; né il Rosa nel 1638 aveva raggiunto la fama necessaria per essere contattato dagli agenti di Filippo IV), così come mi sembra troppo alta la più ragionevole cronologia, sul 1638-1639, avanzata da Andrés Úbeda. In un primo momento, mi ero persuasa che la Marina del Prado, riproponesse, in formato minore, lo schema messo a punto da Salvatore nelle due enormi Marina del faro e Marina delle Torri, eseguite a Firenze nella seconda metà del 1641 (Fumagalli 2008, pp. 46, 48) ed oggi a Palazzo Pitti. La vicinanza compositiva e tipologica con queste ultime, sostenuta a suo tempo già da Hermann Voss, è incontrovertibile, sebbene ora le marine di Pitti mi appaiano più evolute nel tentativo del maestro di combinare gli schemi di Tassi con le ricerche luministiche di Claude Lorrain. Nella tela di Madrid l’occhio si allarga e si allunga in profondità sulla sinistra, dove le rovine antiche retrostanti il porticato che lambisce l’acqua evocano le fantasticherie dei romanisti e poi di Brill più che l’attenta osservazione dal vero del caposcuola Aniello Falcone. La freschezza di tocco e il chiarore azzurrognolo, rivelati dalla recente pulitura, allineano perfettamente l’opera del Prado con la Veduta di un golfo di Modena del 1640, un affiancamento che permette, inoltre, di sottolinearne la forte sintonia registrabile nelle figure, segnatamente nei natanti, come nel chiarore prescelto per lo sfondo, con l’arte di Hermann van Swanevelt, al pari di Salvatore al tempo impegnato per il duca di Modena. Si potrà argomentare in altra occasione quanto il Rosa abbia appreso o quanto abbia dato al più vecchio collega olandese (sul tema, si veda intanto Susan Russel, Salvator Rosa and Hermann van Swanevelt, in Salvator Rosa e il pagina suo tempo. 1615-1673, a cura di S. EbertSchifferer, H. Langdon, C. Volpi, Roma 2010, pp. 335-356), ma vorrei intanto almeno rilevare come l’ascendente degli azzurri sfumati di van Swanevelt si ritrovi pure nel Paesaggio boscoso con figure di Corsham Court (fig. 15), quadro molto vicino nel punto di stile sia al Paesaggio lacustre con armenti e rovine del museo di Cleveland del 1640 (fig. 7) sia alla Marina del Prado e che, grazie alla nota di pagamento che lo vede saldato nel settembre del 1641 dal fiorentino Filippo Niccolini (Riccardo Spinelli, Mecenatismo mediceo e mecenatismo privato: il caso Niccolini, in Firenze milleseicentoquaranta. Arti, lettere, musica, scienza, a cura di E, Fumagalli, A. Nova, M. Rossi, Venezia 2010, p. 276), offre una solida base di appoggio per meglio circostanziare la cronologia della tela spagnola. Quanto al collegamento di questa’ultima con gli incarichi dei ‘paesi’ per il Buen Retiro, sono possibili nuove osservazioni, innanzitutto relative alla misura che, come ho sopra riferito, mi era sembrata anomala. Andrés Úbeda mi ha suggerito di confrontarla con quella di alcuni dei paesaggi olandesi che rientrarono nella medesima commissione. Scopro così che ai tre tipi di formato generalmente segnalati nella bibliografia (orientativamente: 155x235 cm; 210x 155 cm; 186x185 cm) ve ne è da aggiungere almeno un quarto di 175x278 cm, corrispondente a quello delle due tele orizzontali di Jan Both (La strada di montagna e La strada del Porto, inv. nn. P5442 e P5451; Posada Kubissa 2009, pp. 222-226), che si ritengono parte integrante della seconda tornata dei paesaggi, eseguita tra il 1639 e il 1641. Scopro, ancora, che nonostante i quadri di Both risultino anche lievemente più grandi della Marina di Rosa, lo scarto in centimetri non sembrò importante 23 15. Salvator Rosa, Paesaggio boscoso con figure, Corsham Court, Methuen collection ai redattori della Testamentaría (1981, II, p. 289, n. 154, p. 291, n. 180), che classificano La strada di montagna e la Marina come identici (“tres varas menos quarta de largo y dos varas de alto”). Se non vi è dubbio che questa ultima fu parte della raccolta di Filippo IV – il numero “180” relativo alla classificazione della Testamentaría è rintracciabile segnato in bianco in basso a sinistra –, resta però ancora in evidenza la peculiarità del soggetto, come la presenza di uno stemma dipinto (fig. 16), inserito a metà della fiancata della torre in dirupo posta sul confine destro della scena e sormontante il nome di Filippo IV seguito da una parola monca. Dobbiamo assumere che a Salvatore fu richiesto di esibirsi in una tematica a lui particolarmente congeniale, quale la veduta di mare, e che gli sia stato in qualche modo concesso di distinguersi dalla serie tepagina matica richiesta ai colleghi francesi e olandesi presenti a Roma. Così come, ancora, che andrà individuato il mediatore di tale commissione, difficilmente identificabile nel marchese di Castel Rodrigo, secondo quanto suggerito da Andrés Úbeda, se nessun altro dipinto oggi nelle raccolte del Prado reca le medesime armi gentilizie. Queste sono allo stato, purtroppo, semi illeggibili, sebbene sia possibile ancora distinguere delle sfere in stato larvale, e meglio una corona che sormonta l’intero stemma. In modo affine, nella Veduta di un golfo di Modena (fig. 9) l’emblema di Francesco d’Este è inserito sopra l’arco di accesso all’edificio in rovina sito sul margine destro. Alcun dipinto della serie del Buen Retiro esplicita il nome del monarca ispanico come si trova nella Marina di Rosa, rimanendo così il dubbio, già da me formu- 24 16. Salvator Rosa, Marina, Madrid, Museo del Prado (part.) Prado e la nomina di Giovan Carlo dei Medici a Generalissimo dei mari di Spagna nell’ottobre del 1638, evento che si ritiene essere già alla base della realizzazione delle due enormi marine di Palazzo Pitti (Fumagalli 2008, p. 48). L’ultimo segmento della mostra di Parigi, infine, dava ampio spazio alla piena affermazione dei paesaggi classici e ideali di Nicolas Poussin e di Claude Lorrain, una scelta comprensibile in territorio francese. E tuttavia, la sovrabbondanza di queste figure in termini numerici mortificava in qualche modo il più variegato inquadramento culturale del percorso del primo piano, decisamente più avvincente. Nell’intento di ricostruzione del seguito romano del maturo Poussin, sarebbe piaciuto vedere rappresentato non solo Gaspar Dughet (la cui identificazione nel cosiddetto Maestro G – come Gaspard –, autore di un gruppo di disegni divisi tra varie istituzioni museali, è sostenuta da Silvia Ginzburg – cat. n. 118 – ma contrastata da Stéphane Loire – cat. n. 117), ma anche almeno un foglio di Pietro Testa e del genovese Giovanni Benedetto Castiglione, pur’egli a Roma nei primi anni Trenta attratto da tali orientamenti culturali. Il noto Viaggio pastorale, firmato e datato dal maestro nel 1633 (già New York, collezione privata; fig. 17), distinto da quinte arboree che appaiono da sinistra inclinandosi verso il centro di una scena boschiva immersa in una calda luce estiva, avrebbe ben chiuso il cerchio iniziato con Annibale Carracci: esso appare di fatto una intelligente rilettura del modello messo a punto dal bolognese nel Paesaggio fluviale della Washington National Gallery (fig. 18). lato (Farina 2011), tanto più sostenuto dalla datazione sul 1640/1641 fissata per la tela, che in questa vada identificato un omaggio al sovrano, credibilmente inviato quando Rosa era già giunto a Firenze, dove egli risedette a cominciare dall’estate del 1640 (il 1 di settembre Francesco Mantovani lo attesta già partito da Roma e il primogenito Rosalvo, figlio della fiorentina Lucrezia Paolini, nasceva già nel giugno del 1641). Ulteriori ricerche potrebbero fare luce, ad esempio, sulla possibile relazione della tela con l’ambiente mediceo: lo stemma ben in vista su Il ponte rotto di Pitti, diverso da quello qui preso in esame e caratterizzato da tre sfere e dalla tiara papale, dovrebbe alludere più genericamente ai tre papi di casa Medici (Marco Chiarini). Ciò nonostante, sarebbe interessante potere riuscire a 3. Vengo ora ad alcune osservazioni relastabilire un collegamento tra l’opera del tive alla mostra monografica intitolata a pagina 25 17. Giovanni Benedetto Castiglione, Viaggio pastorale, già New York, collezione privata 18. Annibale Carracci, Paesaggio fluviale, Washington, National Gallery Claude Lorrain dal Museo del Louvre, evento di grande raffinatezza, come spesso accade per le mostre pressoché interamente dedicate all’illustrazione delle arti grafiche, e tuttavia priva di grandi apporti dal punto di vista scientifico, sia per ciò che attiene eventuali nuove proposte attributive sia per possibili precisazioni cronologiche. Un’esposizione destinata al gusto di un pubblico ancora più ristretto di quello possibilmente attratto dall’evento del Grand Palais, ma resa maggiormente favorita nell’affluenza grazie alla sede prescelta, già di per sé meta di numerosi visitatori. È dunque un vero peccato che il più grande museo di Francia abbia perso l’occasione di mettere d’accordo un dipartimento di disegni con uno di pittura. I lunghi tempi di preparazione delle mostre sono noti a tutti, eppure dispiace molto che due dipendenti della stessa istituzione non abbiano tentato di integrare il loro lavoro, e che si sia persa così la grande occasione di restituire maggiore corpo all’immagine di Claude nella Roma del Seicento. L’esibizione del Louvre ha aperto in un tempo successivo a quella del Grand Palais e sarebbe stato bene realizzare dei pannelli didattici che coadiuvassero i profani, come anche gli studiosi, a incrociare le notizie sul pittore ricavabili dalle due distinte sedi espositive. Molto utile, ad esempio, sarebbe risultata la richiesta di prestito da parte del Louvre al British Museum dei quattro fogli tratti dal Liber Veritatis relativi ai grandi paesaggi verticali del Lorrain provenienti dal palazzo del Buen Retiro e frattanto visibili al Grand Palais, dove, a un tempo, l’esposizione del già ricordato LV32 con le Tentazioni di sant’Antonio avrebbe completato la serie. A onor del vero, è l’esistenza medesima di questo importantissimo volume di disegni a espagina sere rimasta in margine al percorso espositivo del Louvre, luogo in cui i pur dettagliati pannelli didattici convogliavano piuttosto l’attenzione sugli altri due tomi di disegni redatti dal Lorrain, i cosiddetti Libro di Tivoli e Libro della Campagna. Contemporaneamente, il celebre Paesaggio con la vista del Castello della Crescenza (Metropolitain Museum, fig. 19), capolavoro della fine degli anni Quaranta che dà corpo alla testimonianza del biografo Joachim Sandrart circa l’esistenza di esercizi pittorici realizzati da Claude en plein air, nonché vero ed unico corrispettivo di tutti i fogli disegnati dal maestro sur le motiv ed esposti nei corridoi del Louvre, avrebbe trovato una sua più consona collocazione in questa ultima sede piuttosto che nel corposo nucleo di opere esposte al secondo piano del Grand Palais. Ciò nonostante, non vi è dubbio che pregevolissima sia risultata la selezione dei circa ottanta disegni prescelti – tutti, se della mano di Lorrain, provenienti dalle collezioni del Louvre e dal Teyler Museum di Haarlem –, integrati da una ventina di dipinti e da alcuni fogli di altri artisti, predecessori o contemporanei (Brill, Tassi, Wals, Poelemburgh, Breenbergh, Poussin, van Swanevelt, rappresentati da un disegno ciascuno), atti a raccontare gli inizi italiani del maestro. Ed è questa prima sezione ad avere brillato per risultato, nella scelta di testimoni grafici attestanti l’allora nata attenzione per la rappresentazione di una natura boschiva e rocciosa inondata dalla luce e dall’ombra, più che l’esposizione di fogli di studio tratti dagli edifici antichi in rovina, tematica, questa ultima, di altrettanto forte interesse per gli artisti stranieri giunti a Roma sin dal Cinquecento. Nella sezione si sono potuti così apprezzare vere primizie, tra cui meri- 27 19. Claude Lorrain, Paesaggio con la vista del Castello della Crescenza, New York, The Metropolitan Museum of Art tano una particolare valorizzazione le Rovine sulla riva di un fiume di Wals (Museo del Louvre; cat. n. 7; fig. 20), identificate da Anne Sutherland Harris (A drawing by Goffredo Wals, “Master Drawings”, 16, 1978, pp. 399-404), allo stato unica prova disegnativa del tedesco giunta sino a noi. Lungo il percorso espositivo Claude è emerso in tutte le sue eccezionali capacità grafiche, nonché maestro di grande inventiva, sia compositiva che tecnica. Un foglio come il Paesaggio boschivo con figura seduta (Haarlem, cat. 22; fig. 21), caratterizzato dall’estesa macchia di bruno ottenuta acquerellando l’inchiostro, pone, ad esempio, la questione della tangenza stilistica non solo con Breenbergh, pagina così come è stato già detto, ma anche, credo, con la grafica di Guercino, nonché con quella di Pietro Testa e di Pier Francesco Mola, tanto per chiamare in causa due nomi di celebri paesaggisti non evocati da nessuna delle due mostre qui analizzate. Così come le innovative, luminose acqueforti del maestro, quali La mandria all’abbeveraggio, databile all’incirca sul 1635 (cat. 25; fig. 22), avrebbe potuto aprire l’interessante capitolo che vede messa a confronto tale personale rilettura dell’Arcadia di Nicolas Poussin con la più vitalistica interpretazione offerta dal Grechetto (fig. 17), anch’essa personalità mai ricordata dai curatori della mostra. Il grande protagonismo del Gelée è risul- 28 20. Gottfried Wals, Rovine sulla riva di un fiume, Paris, Musée du Louvre 21. Claude Lorrain, Paesaggio boschivo con figura seduta, Haarlem, Teyler Museum 22. Claude Lorrain, La mandria all’abbeveraggio, acquaforte tato, di fatto, il più grande limite dell’esposizione del Louvre, un limite messo in evidenza dall’organizzazione medesima delle sale (e del catalogo), in cui forte appare la demarcazione con la prima sezione. Dopo gli iniziali tentativi di rappresentare il contesto in cui l’artista mosse i suoi primi passi, la mostra ha finito, infatti, per soffermarsi esclusivamente sul racconto, in ordine cronologico, del percorso del maestro – in verità, a partire dalla fine degli anni Quaranta, ormai fermo su idee elaborate in precedenza e riproposte e ricombinate in vario modo –, nonché sul processo di elaborazione nel passaggio dal disegno alla pittura. pagina In questo pur encomiabile quadro, sala dopo sala, abbiamo così assistito al giganteggiare della figura di Lorrain e al suo conseguente progressivo isolamento dal variegato e memorabile clima artistico della Roma tra gli anni Quaranta ed almeno i Sessanta del Seicento. Sfumata è così l’occasione di illustrare meglio, anche al pubblico specialistico, il giovanile legame con Sandrart e con Peter van Laer il Bamboccio – una partita che in modo originale si sarebbe dovuta giocare proprio sul tema del disegno –, nonché di articolare meglio il confronto con la stella romana di Nicolas Poussin. 31 pubblicato il 22 luglio 2011 su www.ilseicentodivivianafarina.com © Viviana farina
Scarica