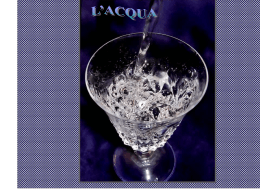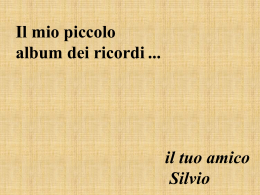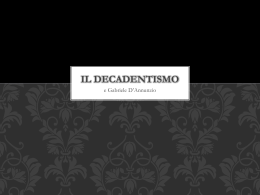"La mia anima visse come diecimila" di Matteo Facondini (IVA), Alberto Montemurro, Giona Pilò, Roberta Silvestri A.S. 2013/2014 classe IVD COLLOQUI FIORENTINI XIII EDIZIONE Stanza del Mascheraio (Introduzione) Si avverte un riverbero strano, opprimente, tra le mura ingrigite dal tempo. Nell'ingresso, nell'anticamera, tutto tace. Fuori c'è vita, colore, la musica sommessa del cinguettio degli uccelli, ma qui regna un silenzio opprimente; l'unica compagnia è quella dei cimeli: ammassati sui tavoli, appesi alle pareti come infinite serie di trofei, confusi tra i raffinati disegni degli arazzi e i fregi un po' pacchiani della tappezzeria. Soffocano, così tanti da impedire allo sguardo di percepire pienamente gli spazi, quasi stessero tentando di nascondere l'immenso vuoto interiore di chi ha abitato queste mura. Ma gli oggetti non bastano, non colmano la voragine scavata da desideri insaziabili, da una cupidigia che prevarica la necessità − per questo, forse, l'impressione che se ne ricava è più di tristezza che di ammirazione. È una dimora ricca, il Vittoriale, una prigione sfarzosa. Non potrebbe essere altrimenti, dato che riflette l'animo di un esteta: se ne percepisce l'impronta, il respiro sulla stoffa pesante delle tende. “Ho fatto di tutto me la mia casa; e l’amo in ogni parte. Se nel mio linguaggio la interrogo, ella mi risponde nel mio linguaggio.”(Libro segreto) Quella di D'Annunzio è stata una vita trascorsa nel vano tentativo di appagare una fame infinita, destinata a rimanere irrisolta, ma comunque presente, come un tarlo annidato nel punto più oscuro dell'animo umano. L'incontro con D'Annunzio non è stato facile. Si tratta di uno scrittore così abile nel raccontare bugie, persino a se stesso, che per il lettore contemporaneo, non avvezzo alle impalcature di belle menzogne, che celano la sostanza dei suoi lavori come un’armatura, avvicinarsi alle sue opere può essere molto difficile. Ci ha colpito proprio questo, di lui: la doppiezza, il continuo nascondersi. D’Annunzio non è mai completamente onesto. Nutre una passione così forte per l’ideale, per la perfezione, che sembra quasi gli riesca difficile affezionarsi a cose terrene, imperfette; si innamora di concetti, di chimere. Cerca di adeguarsi al proprio ordine mentale, si fa eroe di guerra e superuomo, seduttore e artista: la sua tendenza quasi maniacale ad elevarsi al di sopra delle masse è un altro aspetto della sua personalità - (letteraria e non) - che abbiamo trovato particolarmente interessante. 1 Ci siamo chiesti a lungo quale stile adottare nella nostra tesina, e abbiamo scelto, in virtù della splendida soluzione dannunziana, di omaggiarlo con una prosa dai richiami baroccheggianti, - ci sembrava impossibile scindere i contenuti del Vate dalla forma eccezionale in cui sono stati proposti. In fondo lo stesso Oscar Wilde − altro celebre esteta − affermò che "l'imitazione è la più alta forma di ammirazione". Sarà ciò che la sua stessa mano ha disposto, nell’intimità della casa che lo ospitò fino alla fine, a guidarci attraverso quelli che sono i punti nevralgici di una delle personalità più poliedriche della nostra letteratura. Sala delle Reliquie (Superuomo) “Tutti gli idoli adombrano il Dio vivo, tutte le fedi attestan l’uomo eterno”. Icone sacre, effigi pagane, statue di santi benedicenti sporgono dalle mensole e si affollano sulla superficie diafana del tavoli da caffè; una folla, un coacervo di mendichi che si affanna a domandare attenzioni al proprietario da lungo tempo scomparso. La verità, però, è che difficilmente le avrebbero ottenute anche quando D’Annunzio era ancora in vita: non c’è che un Dio, per l’artista, un’entità superiore a cui valga la pena di consacrare la propria esistenza. “Dio è la speranza dell’uomo di essere Dio” [Jean-Paul Sartre] Nel momento in cui l'uomo si scopre solo, depauperato dei punti di riferimento che gli hanno impedito di naufragare in una realtà difforme e priva di prospettive, si aggrappa a se stesso quale fulcro di un salvifico microcosmo. “Io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé e voi volete essere il riflusso in questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo? Che cos'è per l'uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa. E questo appunto ha da essere l'uomo per il superuomo: un ghigno o una dolorosa vergogna.” [Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 1885] Così Nietzsche qualificava l'archètipo dell'Übermensch e per contro dell'uomo comune, dell'essere perfetto capace di elevarsi al di sopra delle masse e del suo ente primitivo, nient'altro che carbone grezzo in confronto alla trasparenza del diamante. È quasi paradigmatico il conformarsi di D'Annunzio ad un simile modello di perfezione estetica e sostanziale, ricercata assiduamente non solo nelle sue opere, ma soprattutto negli atti di una vita che tenta di rendere eroico manifesto, fino al parossismo. Il volo su Vienna, la beffa di Buccari, la presa di Fiume non sono altro che un vano tentativo di raggiungere o, quantomeno, esibire in atto il superomismo. Non soddisfatto di una 2 gloria che ritiene troppo esigua rispetto alla grandezza delle proprie aspirazioni, il Vate si rifugia nel cosmo squisitamente estetico dei suoi mondi illusori − diviene demiurgo di universi e tessitore di trame. I protagonisti dei suoi romanzi, tutte identità fittizie create per nascondere l'io narrante dello scrittore, risentono della fascinazione nietzschiana e si propongono come modelli di perfezione virile. • Tullio Hermil, ne "L'Innocente" cerca di liberarsi dei legami che lo avvincono allo status di uomo comune abbandonando la moglie ma, quando si rende conto di non poterlo fare perché questa è incinta, cade in una profonda crisi emotiva: "Un gran fremito mi agitò; un'illusione fugace si impadronì del mio spirito. Credetti che veramente in quell'istante il mio amore e l'amore di quella donna si trovassero di fronte alti d'una smisurata altezza ideale e scevri di miseria umana, non macchiati di colpa, intatti. Riebbi per pochi attimi la stessa sensazione provata in principio quando il mondo reale m'era parso completamente vanito. Poi, come sempre, il fenomeno inevitabile si compì. Quello stato di coscienza non mi appartenne più, si fece obiettivo, mi diventò estraneo. [...] E, senza poterla rialzare, senza poter più parlare, soffocato da un accesso violento d'ambascia, soffocato dalla forza dello spasimo che contraeva quella povera bocca smorta, abbandonato da qualunque rancore, da qualunque orgoglio, non provando se non la cieca paura della vita, non sentendo nella donna prostrata e in me se non la sofferenza umana, l'eterna miseria umana, il danno delle trasgressioni inevitabili, il peso della nostra carne bruta, l'orrore delle fatalità inscritte nelle radici stesse del nostro essere e inabolibili. Tutta la corporale tristezza del nostro amore, anch'io caddi in ginocchio dinanzi a lei per un bisogno istintivo di prostrarmi, di uguagliarmi anche nell'attitudine alla creatura che soffriva e che mi faceva soffrire. E anch'io ruppi in singhiozzi. E ancora una volta, dopo tanto, rimescolammo le nostre lacrime, ahimè! che erano così cocenti e che non potevano mutare il nostro destino". L'homme fatal (Tullio) in tal caso si vede privato improvvisamente della sua centralità, in favore di una creatura a cui si rivolge con un misto di curiosità e disgusto; a nulla servono carisma e bellezza, neanche lo straordinario eloquio e le qualità di consumato viveur: il vincitore è sempre lui, l'innocente, l'essere inerme che esprime tutta la sua potenza nei gesti deboli di un neonato − in questo, forse, si può scorgere una traccia del pensiero nietzschiano, nella forza di un'entità che, per quanto indifesa, è animata da una tenacia così profonda da surclassare qualsiasi altra vigoria. Anche l’oggetto del suo amore è stato deturpato senza che Tullio possa far nulla per rimediare, perché ormai in Giuliana scorge soltanto "il fatto brutale, il ventre gonfio, l'effetto dell'escrezione 3 d'un altro maschio"; anche il concetto che l'oltreuomo ha di sé è divenuto negativo al punto che il seduttore si paragona allo "stupido eroe sentimentale d'un cattivo romanzo". Il gesto disumano che decide la conclusione del romanzo, poi, non è che un tentativo ignobile di ricondurre la situazione ad uno stato di equilibrio. Ed è proprio qui che il potere di Tullio si rivela inadeguato, inutile: non c'è esultanza, non c'è nessun trionfo eroico dopo l'infanticidio. Al protagonista non resta che rimanere in silenzio davanti all'enormità di un gesto che non può in nessun modo giustificare. Questo diventa pertanto il mero fallimento del superuomo. • Andrea Sperelli, circondato dalla dissoluzione e dallo sfarzo, principe istrionico che incarna la figura dell’eroe decadente, un dandy che va alla ricerca del Piacere sfrenato, perverso e mondano, tipico dei salotti borghesi della Roma del suo tempo. Egli è senza dubbio un alter ego dell’autore; infatti lo stesso D’Annunzio scriveva: “... trovo negli eccessi del piacere la mia più vasta spiritualità”. (Libro segreto) Andrea crea attorno a sé un mondo fondamentalmente ipocrita, artificioso, nel quale deve vivere indossando maschere diverse a seconda dell’occasione. “...nell'arte d'amare egli non aveva ripugnanza ad alcuna finzione, ad alcuna falsità, ad alcuna menzogna. Gran parte della sua forza era nell'ipocrisia.” “L'anima sua, camaleontica, mutabile, fluida, virtuale si trasformava, si difformava, prendeva tutte le forme. Egli passava dall'uno all'altro amore con incredibile leggerezza; vagheggiava nel tempo medesimo diversi amori; tesseva, senza scrupolo, una gran trama d'inganni, di finzioni, di menzogne, d'insidie, per raccogliere il maggior numero di prede. L'abitudine della falsità gli ottundeva la coscienza. Per la continua mancanza della riflessione, egli diveniva a poco a poco impenetrabile a se stesso, rimaneva fuori del suo mistero.” Si fa complice e marionettista di un sistema di ruoli di cui possiede il dominio e non si crede mai realmente perdente, neanche quando viene sconfitto − del resto, come si può annientare qualcuno che non tiene realmente conto degli eventi in sé, del loro rovinare e rimescolarsi, quanto piuttosto dell'effetto artisticamente gradevole che se ne ricava? "Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. [...] Bisogna conservare ad ogni costo intatta la libertà, fin nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: 'Habere, non haberi'»." Possedere, non essere posseduto. L'uomo come autorità, padrone dell'arte − dove l'arte si identifica con la vita stessa, di cui è la massima espressione − ma sopratutto libero, padrone di se stesso. Ed è 4 quasi ironico come questi personaggi, culturalmente ipertrofici, si ritrovino ad essere tutto, meno che liberi: nel loro sogno nebuloso di dominare si fanno schiavi di convenzioni sociali, si invischiano in ragnatele che hanno creato con le loro bugie. Vorrebbero condurre una vita libera, improntata all'arte e alla bellezza, ma tutto quello che ottengono è una patetica imitazione del loro sogno − come un cadavere marcio, ripugnante, divorato dai vermi, ma abilmente ingioiellato. Il lettore che si imbatte in Andrea Sperelli, non trova davanti a sé un oltreuomo, ma un uomo che conduce un'esistenza misera e dissoluta. In questo sta l'errore, la bugia, la profonda contraddizione interna alla sfera emotiva dei protagonisti dannunziani: cercano con così tanto affanno la grandezza che ne vengono respinti, perché il tipo di gloria che sognano è utopica al punto da condurre inevitabilmente alla disillusione. “La passione in tutto … desidero le più lievi cose perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua.” (Di me a me stesso) Scriveva così il Vate durante gli ultimi giorni della sua vita, chiuso nella sua prigione dorata, fulcro di ricordi e speranze indelebili nel tempo. Stanza della Leda (Le Donne) La Leda di gesso si abbandona alla voluttà dell'amore proibito, adagiata sulla mensola di un camino dai decori fastosi. Sul copriletto di seta persiana si rincorrono fiere selvatiche, attraversano il tessuto del tutto privo di grinze; quest'alcova, che fu teatro di chissà quante avventure sregolate, non accoglie il calore di un corpo da troppo tempo − se ne avverte il profumo arido, stantio, di polvere. Furono molte, le donne amate da D'Annunzio: Maria Harduin, Alessandra di Rudinì, La Duse, compagna nell'incantesimo solare, Elvira Natalia Fraternali, la "Rosa Fosca" Luisa Baccara; questi i primi nomi di una lista che non conosceremo mai nella sua interezza. Nei romanzi la figura femminile è affrontata con una passione trascinante, innegabile. Spesso scissa in più figure dalle caratteristiche contrastanti: dualistica, tratteggiata con la grazia fumosa di un uomo che fu prima di tutto un seduttore. Stregano, queste donne forti e mutevoli, come i rivolgimenti della passione amorosa di cui sono foriere; e in alcuni casi sono persino in grado di alterare il corso degli eventi. Anatolia, ne "Le Vergini delle Rocce", rifiuta la perfezione superomistica di Claudio Cantelmo, perché devotissima agli obblighi che la legano alla sua famiglia. "Ah, perché dunque il destino mi costringe a quest'officio così angusto, a questa pena così lenta? Perché mi vieta l'alleanza sublime a cui il mio cuore anela? Io potrei assumere un'anima virile alla zona eccelsa, là dove il valore dell'atto e lo splendore del sogno convergono in un medesimo apice; 5 io potrei estrarre dalle profondità della sua incoscienza le energie occulte, ignorate come i metalli nelle vene della pietra bruta". Si rammarica, dunque, pur consapevole che il fine ultimo di Claudio è utilitaristico: generare un erede intellettualmente superiore. Ad Anatolia, che è solidità e sostegno, sono contrapposte Violante, bellezza infera e mortifera, e Massimilla, che nutre un "bisogno sfrenato di schiavitù" e desidera "appartenere ad un essere alto e più forte" onde dissolversi nella sua volontà. Elena, la seduttrice dalla bellezza velenosa, la femme fatale de "Il Piacere", rappresenta la più grande sconfitta dello Sperelli: se ne innamora, elevandola di fatto ad un ruolo mai occupato prima da nessun'altra donna, e ne viene duramente respinto. Proprio da lei, poi, che rappresenta la lascivia, il desiderio carnale, la rosa decadente dai petali di porpora. D'Annunzio tratteggia la figura di Elena con un'attenzione sconfinata, trasformandola di fatto nel personaggio di spicco del romanzo. "Aveva la voce così insinuante che quasi dava la sensazione d'una carezza carnale; e aveva quello sguardo involontariamente amoroso e voluttuoso che turba tutti gli uomini e ne accende d'improvviso la brama", e questo aspetto del suono, della voce, torna anche più avanti nel romanzo, quando Elena viene ravvisata in Maria : "Egli ancora udiva la voce di lei, l'indimenticabile voce. Ed Elena Muti gli entrò ne' pensieri, si avvicinò all'altra, si confuse con l'altra, evocata da quella voce; e a poco a poco gli volse i pensieri ad immagini di voluttà. Il letto dov'egli riposava e tutte le cose intorno, testimoni e complici delle ebrezze antiche, a poco a poco gli andavano suggerendo immagini di voluttà. Curiosamente, nella sua immaginazione egli cominciò a svestire la senese, ad involgerla del suo desiderio, a darle attitudini di abbandono, a vedersela tra le braccia, a goderla. Il possesso materiale di quella donna così casta e così pura gli parve il più alto, il più nuovo, il più raro godimento a cui potesse egli giungere; e quella stanza gli parve il luogo più degno ad accogliere quel godimento, perché avrebbe reso più acuto il singolar sapore di profanazione e sacrilegio che il segreto atto, secondo lui, doveva avere". Il passo è particolarmente interessante anche per la contrapposizione tra il desiderio carnale, sacrilego, e la cornice in cui esso viene contestualizzato: "La stanza era religiosa, come una cappella. V'erano riunite quasi tutte le stoffe ecclesiastiche da lui possedute e quasi tutti gli arazzi di soggetto sacro". Come sempre in D'Annunzio, si coglie l'aggiunta di dettagli che rendono la composizione più intrigante da un punto di vista sensuale e soprattutto visivo − l'immagine di un amore profano consumato in atmosfera religiosa ha, per lui, un innegabile appeal. Alla figura di Elena fa da contraltare la purezza di Maria, altra donna dal nome parlante. Incarna la purezza e la grazia, la bellezza eterea della dedicataria di versi stilnovisti, e ci viene presentata con indosso una candida pelliccia di ermellino che ne sottolinea ancora di più l'elevazione spirituale. 6 Donna angelo, ma non del tutto aliena ai piaceri carnali, Maria diviene oggetto di un amore sensuale per cui sembra quasi immolare la propria purezza − è lei, con il suo sacrificio, l'unica speranza di salvezza e redenzione per il protagonista dissoluto. Il lettore de "Il Piacere", però, deve guardarsi bene dal considerare l'opera come un romanzo che ha per tema centrale l'amore nei confronti della donna. Il protagonista filtra questo sentimento attraverso la lente di un estetismo che diventa imperativo inscindibile da ogni aspetto della vita quotidiana; l'amore e la passione sono finalizzati alla composizione dell'opera d'arte personale di Sperelli, pennellate necessarie al completamento di un dipinto che ritrae l'Io poetico in tutto il suo narcisismo. D'Annunzio ama l'amore in sé, la sua bellezza ideale e quasi catartica. Il dolore non è semplicemente una sensazione motivata da un volgare stimolo meccanico, non si riduce soltanto a questo: è un'astrazione fine a se stessa, che nella propria sussistenza trova la ragione e lo scopo dell'essere. Quelli che il lettore si trova davanti sono dei veri e propri sentimenti metafisici, nascosti sotto la patina di un intreccio volto ad esaltarli quanto più possibile. Ama l'amore, desidera il desiderio. Ecco perché la sua ingordigia non avrà mai fine: D'Annunzio anela a questi sentimenti con uno slancio che oscilla tra il consapevole e l'inconscio, e se mai dovesse davvero riuscire a superare il desiderio, a saziare la fame che lo rode, la sua arte perderebbe di significato. Stanza della Musica (Wort-Ton-Drama) “Inebriami di musica (…) Non so se abbia più sete di acqua o più sete di musica o più sete di libertà.”(Notturno) Dalla corolla d'ottone di un grammofono, abbandonato nell'angolo più nascosto di una stanza buia, si dipanano le note trionfali del Parsifal. Non è che il preludio, il maestoso avvicendarsi del tema dell'Ultima Cena e della Fede, avviluppati in un susseguirsi dialogato di atmosfere sacrali e lunghe pause intrise di silenzio − quello stesso silenzio che ha una dignità e un valore pari alla musica, perché la glorifica e permette di apprezzarne l'autentica bellezza. Nel canto gracchiante del grammofono irrompono improvvisamente la voce di basso e poi il soprano, come ad aggiungere tensione drammatica e vita densa e carnale alla santità della pura musica, armonia fine a se stessa. Il monologo iniziale di Gurnemanz non ha una semplice funzione narrativo/introduttiva, ma rappresenta il compimento di un'armonia, il principio del miracolo wagneriano: per il compositore tedesco, teso alla ricerca di un infinito artistico che possa colmare la sua infinita fame di bellezza, si può arrivare alla perfezione solo attraverso l’equilibrio di wort, ton e 7 drama (parola, musica e azione scenica). I tre mezzi espressivi, combinati in modo da escludere del tutto arie e recitativi − non si richiede forse una musica infinita per esprimere la completezza priva di limiti dell'arte? − e facendo invece largo uso del leitmotiv, creano un equilibrio simile a quello proprio della tragedia greca. L'orchestra dunque diviene simile al coro, commentatrice viva e tangibile degli eventi. Lo stesso Nietzsche, contemporaneo e amico di Wagner, afferma che l'apice della tragedia greca si raggiunge proprio grazie all'equilibrio tra Apollineo e Dionisiaco, la razionalità come freno alla vividezza dell'impulso orgiastico, e che solo Sofocle fu in grado di fondere e dominare perfettamente questi due elementi. L'arte quindi è figlia di un'armonia dalle molteplici sfaccettature, una composizione poliedrica che spesso implica la giustapposizione di elementi quasi contrastanti. Stelio Effrena, ne “Il Fuoco”, si appropria di questo concetto e lo deforma, piegandolo alla propria visione del mondo. Egli, o quantomeno il superuomo che tanto disperatamente cerca di essere, è forse in grado di riprodurre la stessa infinita perfezione pur privandosi di due mezzi espressivi? Il suo genio si spinge così in là da poter fare a meno di ton e drama, ricostruendo musica e azione con la sola parola? Immaginiamo D'Annunzio come un direttore d'orchestra. In piedi su un palco, le braccia tese nello sforzo di coordinare un brano di incredibile difficoltà; davanti a lui, gli spalti di un anfiteatro sono pronti ad ospitare i flauti, gli oboi, i corni, i timpani, gli archi, le trombe, i clarini, le arpe e i fagotti − forse è proprio il Parsifal l'opera che sta per andare in scena − eppure lo spettatore solitario sa che rimarranno vuoti. Le dita dell'artista non stringono una bacchetta, ma la penna che traccia segni indelebili sulla carta; la sua mente non si perde nelle armonie sconfinate dell'opera wagneriana, ma nell'elaborazione di concetti e costruzioni sintattiche complesse come i significati nascosti dietro ogni parola. C'è una musica, una musica astratta e quasi ascetica, il cui più intimo desiderio "è di non essere udita e neanche intuita, ma se fosse possibile, intesa e contemplata in un al di là dei sensi, e persino dell'anima, in una purità spirituale". (Doctor Faustus di Thomas Mann) Passa attraverso le parole, questa melodia dannunziana, e si infiltra nella mente del lettore in spirali prive di voce − interi periodi si fanno pentagrammi, lettere come note di una composizione che si pone l'obiettivo di realizzare e superare l'impossibile. Non si apre forse con un tema musicale Il Piacere? Il tema dei fiori, degli steli infusi di delicatezza estatica nei loro vasi di cristallo, il tema delle vie di Roma e del tepore che "velato, mollissimo, aureo", pervade il cielo. L'atmosfera rilassata sfuma a poco a poco in un silenzio teso, che colora d'aspettativa l'attesa dell'amante del protagonista: solo quando questa entra in scena − e ci sembra quasi di sentir risuonare il suo leitmotiv, introdotto dallo scoccare dell'orologio della Trinità dei Monti, la musica torna ad esprimersi in tutta la sua potenza. Scorre attraverso le parole, nella loro 8 inesprimibile grazia, nei gesti e nella fraseologia affettata dei personaggi; anche il silenzio, a cui D'Annunzio si affida in quanto elemento ricercatissimo del suo stile, fa da contraltare alla sonorità di prosa e poesia − diventando così una parte integrante, irrinunciabile, del canto silenzioso. I lunghi momenti di quiete quasi liturgica creati da Wagner si rovesciano sulla carta sotto forma di pause verbali, trasfigurati, eppure perfettamente riconoscibili: nella loro bellezza si scorge il riflesso del genio, dell'arte che si piega alla volontà dell'uomo e arriva persino a contraddire se stessa, plasmata in qualcosa di completamente diverso dalla materia originale. È questo, infatti, lo scopo di D'Annunzio: creare armonia distruggendo armonia. Un paradosso, come del resto sono paradosso e contraddizione molti elementi della vita del maestro, diviso tra il delirio di onnipotenza e una natura che non gli permette di assurgere alla vette di perfezione che tanto desidera. Il suo è un esperimento folle, presuntuoso, riuscito solo in parte persino dal suo punto di vista e totale fallimento nell'ottica dei modelli che si propone di emulare: come si può pretendere, infatti, di migliorare un qualcosa che si è distrutto già dalle premesse della creazione? Quello di D'Annunzio è un edificio che si regge sul nulla, privo di fondamenta: coraggioso, certamente, ma molto lontano dalla perfezione assoluta raggiunta dal Parsifal, dalla leggiadra fraseologia musicale del Tristan und Isolde. Per definire il connubio ideale di wort, ton e drama Wagner utilizza il termine gesamtkunstwerk, "opera d'arte totale"; ed è proprio un’ esperienza totalizzante dell’arte che ricerca D’Annunzio. Completa in se stessa, espressione più alta del genio, costituisce quasi un atto eroico che solo pochi sono in grado di compiere. D'Annunzio, come paladino ego-riferito, tenta di portare a termine questa quête dove il Graal rappresenta l'apogeo dell'intelletto artistico, ma fallisce a partire dalle premesse e cade a volte nel facile tranello di un estetismo sterile, barocco. "Il sofisma," dice il padre di Andrea Sperelli ne 'Il Piacere', "è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e a moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse, la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo di intelletto son nascoste inesauribili ricchezze". Ed è così che il wort si spoglia del ruolo di significante e diviene significato, tema e contenuto autentico di prosa e poesia: mai come in D'Annunzio la parola assume un significato preponderante e assoluto, tiranneggia sulla narrazione con la sua bellezza inarrivabile. Mausoleo degli Eroi (Conclusione) La morte lo sorprende il 1° marzo 1938 a causa di un’ emorragia celebrare. Verrà trovato seduto al tavolo della Zambracca, la stanza di servizio che precede il reparto notte della casa. 9 Non fu un epilogo particolarmente glorioso, il suo. Forse avrebbe meritato una morte in duello, o per una qualche ferita in battaglia, forse persino il suicidio. Anche nella sua tomba qualcosa sembra stonare. È immensa, maestosa, ma le linee schiettamente geometriche del complesso e la luce che si riflette, accecante, sulla pietra candida danno un'impressione molto diversa dagli ambienti cupi e sovraffollati della villa. Un mausoleo per un eroe omerico, il sacrario destinato ad ospitare le ceneri di Achille e Patroclo o forse le spoglie di Alessandro, privo della passionalità eccentrica di Gabriele D'Annunzio. La tomba perfetta per ciò che volle essere, non per ciò che fu. “Tutto fu ambito /e tutto fu tentato”; “Nessuna cosa mi fu aliena /nessuna mi sarà /Mai”; “Quel che non fu fatto /io lo sognai; /e tanto era l'ardore /che il sogno eguagliò l'atto. /Laudato sii, potere /del sogno ond'io m'incorono /imperialmente /sopra le mie sorti /e ascendo il trono /della mia speranza” (Maia, Laus Vitae) L’esperienza desiderata da D’Annunzio fu trascendentale, sublime, soprannaturale: segno dell’arte decadente, volta all’evasione dalle regole formali della letteratura. Ed è anche in questo aspetto che si nota il fulcro spirituale dell'autore: nell’acuire il senso di superiorità sulla vicenda umana, affermando che solo l’Arte è ciò che conta nella vita. “Il Verso è tutto” Il modello dannunziano non si esprime solo nelle sue parole, ma anche nei suoi atti quotidiani: quelle stesse parole, scritte o enunciate che siano, furono comunque parte integrante della sua esistenza e ne diventarono il tessuto immanente. Egli pone un domanda che fonda le sue radici nell’insoddisfazione: “Ah, perché non è infinito come il desiderio, il potere umano?” Lui stesso è consapevole dell’ ovvia irresolubilità dell’interrogativo, perciò questa ci sembra più un’ implorazione rivolta ad un’entità superiore, forse colpevole dei patimenti umani. Si dilettò nell’Arte in maniera assoluta, improntando su di essa la sua stessa vita, ma non fu in grado di risolvere il dubbio alla base dell'esperienza totalizzante del Desiderio umano. E mentre camminiamo tra i viali alberati del Vittoriale, la necropoli delle passioni e delle bugie, della sete di vita e della malinconia, non possiamo ignorare la presenza schiacciante del poeta, il suo occhio vigile che sembra emergere dal folto degli alberi come le guglie bianchissime del Mausoleo degli Eroi. “La nostra vita è un'opera magica, che sfugge al riflesso della ragione e tanto più è ricca quanto più se ne allontana, attuata per occulto e spesso contro l'ordine delle leggi apparenti.” 10
Scaricare