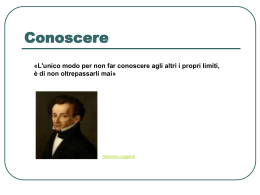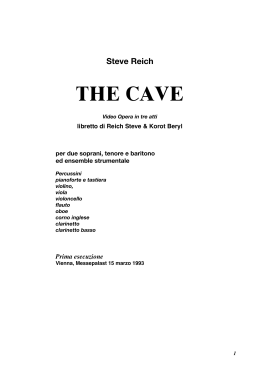Marcello Kalowski – Il silenzio di Abram – Laterza, 2015, Cosenza 28 marzo 2015 ore 15,30 Chiesa San Domenico Ho accettato l’invito del dott. Greco con non poca riluttanza, la mia esperienza professionale non ha consuetudini con simili temi e la delicatezza dell’argomento mi avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza. Ma poiché il rischio è connaturato a qualsiasi attività umana e a volte è salutare non prendersi sul serio (per quanto serio è il dibattito odierno), mi accingo a intraprendere un tracciato che mi porterà non so dove a totale scapito degli astanti e soprattutto del mio conferente. Principio con il rivolgere un ossequio all’Autore, non solo per avere dato ampia dimostrazione di essere un bravo scrittore ma in quanto testimone di una sopravvivenza dolorosa che dà alla Sua gente un credito verso l’umanità. Essa dovrebbe avere più cura nell’educarsi alla tolleranza e alla libertà. Un ossequio all’Uomo, le cui prove di sofferenza dirette e riflesse ne hanno definito l’intima esistenza senza disperdere i toni dolci della vita che tanto bene fanno ai rapporti tra gli uomini. Una dolcezza di parole e sentimenti che da sole ricoprono come un velo un dramma incancellabile e un atto di amore verso i propri cari e il prossimo. L’Autore usa una prosa tacitiana ma profonda e toccante, coinvolgente ma che non alterare la dignità del racconto, una narrazione che espone l’anima del narratore nelle pieghe più intime e inconfessabili senza smarrire il pudore del gesto letterario sano e catartico. A proposito di Abram. Vorrei provare a capovolgere un detto comune, valido anche nel diritto e nella giurisprudenza: la morte non appartiene alla vita, nel senso che la vicenda morte si colloca come fenomeno al di fuori della vita. Ma per Abram e per quanti possono dirsi sopravvissuti allo sterminio, la morte è stata parte della vita, Abram è morto due volte. Abram ha avuto due vite, una prima del ghetto, un’altra dopo. Due vite differenti, come dice l’Autore, senza un ponte, senza un collegamento affettivo, psicologico, direi fisico. Nella lettura ho intravisto due Abram, quelli tra i quali s’è dibattuto nella sua esistenza l’Autore, l’Abram adolescente conosciuto nel e dal racconto, un Abram trasposto con la parola dal ricordo, dalla memoria al figlio, e l’altro del ghetto, dello stadio primordiale di sopravvivenza, un Abram trasfigurato, decomposto e ricomposto nei soli elementi sensoriali dell’esistenza, privato (Vico) di emozioni e ragioni. L’Abram liberato ha provato a rinascere dopo la prima morte, ha tentato il risveglio con le carezze di una famiglia amorevole e comprensiva, di persone che hanno orientato le proprie esistenze al miraggio del risveglio, ma il silenzio ha prevalso. Sebbene si muoia giorno per giorno, o (Montagne) che filosofare è come imparare a morire, Abram ha conosciuto tutta la morte nella prima vita. A proposito dello sterminio. Mi sono chiesto cosa può generare nell’umanità un’azione corale negatrice di se stessa. Parlo di azione “corale” per non riferirla ad una sola vicenda di potere o di patologie personali. Credo si possa riflettere su due termini: obbligatorietà e compassione. Il primo esprime una discendenza logica e razionale fatta di ragionamenti ineluttabili tratti da premesse pre-date; il secondo implica un’immedesimazione, una traslazione emotiva volta alla ricerca di un’identità che accomuna in una sintesi. Ne vengono fuori due raffigurazioni dell’umanità: una prevedibile, l’altra comprensiva; punitiva o misericordiosa, penitente o graziata. Due fondamenti della regola morale: la logica deduzione dalla ragione ovvero la condivisione del dolore umano quale superamento del principio del piacere di freudiana memoria? L’obbligatorietà risponde allo «spirito della geometria», la compassione allo «spirito della finezza» (Pascal). Se le due componenti dell’uomo si congiungono si scopre la sfera esistenziale, quella olistica dell’uomo. Ma è la compassione che fa conoscere quei moti dell’anima che impediscono di negare se stessa e l’umanità. In fondo la dignità è l’in sé del pensiero umano che è anche un dato di natura; è la natura che fa l’uomo essere pensante, dunque, è un dato della scienza della natura che preserva l’uomo dalla negazione della sua dignità. Khen Lampert (filosofo ebreo) nella sua «Teoria della compassione radicale» fa della compassione la trama più solida e profonda della costruzione di un tessuto sociale; la sola obbligatorietà kantiana non rispetta a pieno l’essere umano. Lo sterminio è figlio dell’obbligatorietà, di un’obbligatorietà deprivata di ogni compassione che smarrisce la percezione del dato di natura: l’uomo viene declassato ad homo indegnus. Le difese di Norimberga erano incentrate sull’atto dovuto, sull’adempimento del dovere quale esimente da ogni responsabilità: l’esecutore anche di alto rango non deve pensare ma deve adempiere. Così l’uomo si spoglia della compassione (come cum patior), di quel sentimento che induce all’immedesimazione con l’altro, che elevato a condotta sociale, assume la razionalità di un valore, lo stesso che nutre la solidarietà tra gli uomini. Il valore della compassione mantiene aperta la mente sulla necessità dell’analisi critica, di una razionalità sintattica ma anche semantica. L’Umanità non deve smarrire il senso del limite che è insito nella scommessa di Pascal: perché credere in Dio?, perché se esiste si conquista la vita eterna, diversamente non si ha nessuna perdita!
Scaricare