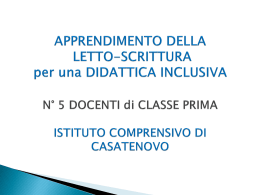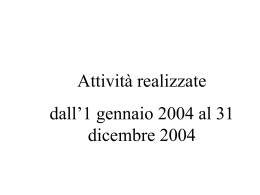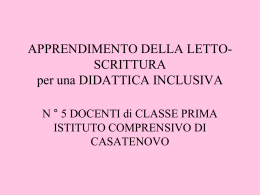T
A
V* O
V
A f*
aReccellcntia della lingua,
7 b
Antichi uelausno la profondità delle
dottrine lo r o .
noa
Antitheti, ò contrarij.
6y b
Antro terzo grado del Theatro «
S ia
Apollo , perche Dio de* Poeti *
i 8f a
A ppofito, o epItheto.
x.4 b
Aquilio giuruconlùlto mandauai luoV ghi delle congetture a Cicerone, co
m e a pIu In gegnofo di lu i.
61 b
Àrea del patto et suoi fignideati..
10 3 a
Arco attribuito ad Amore.
119 b
Argo da cento occhi che lignifica. 9% *9 3 *
Argomento neceflàrio da’ conseguenti
et da gli antecedenti.
m a
A rte, quando fia ueca. %
7a
Arte ha bisogno (li nubuc oflferuationi. 1 o a
Arte d'in gegno.
;
iy8a
Articoli della lingua. v
I27b
Artificio in che modo ci polla giouare
aìrofierta materia.
* 1 j 9*
AruficioeLi feconda natura delle b e l
lezze dell'eloquentia.
7b
Artificio in che modo non fi poffa. unir
con la materia*
\
16 6 z
Artificio di Seruio Sulpìtio . *
Afcoltare , ucrbo.
10 1 b
Ailòntiui (enfi.
88b8^bpob
Augia etfueftalle.
$7 a
Aum enti>fenfo aflontiuo •
jib
A a is c h e c o fa è .
3$ b
T
A• V
O
L' A.
c i o & fua morte.
13 f a
B ABambino
prodotto per artificio di
lambicchi.
IS 7 a
Bailo di conditione , trafiato.
i.j b
Bellezza et Tuoi effetti scoperti d i Dan
te et dal Petrarca.
4;a
Bellezze deH’elcxjuentia,sètte. ,
jb
Bellezze et lor contrari come neder fi
pOslano nelle cose.
i 5a
Benignità e grada in Signoria.
18 1 a
Boccaccio errò nella replica <L’un prò*
>
hemio.
fcJTà
C
A b a l i s t 1 che conoscono et
non credono.
1 483
Caduceo di M trcurio.
11 o à
Cagione efficiente della uoce > qnaIeè.
:r 48 b f f 6
Cagione, sènso aflontiuo •
511 b
Cagioni quattro
44 b
Caldo è cagion della generatione.
9a
Calere Igne folis.
’ 13 b
Calore spirito, o fiato deU*anima«
yz a
Calore et lume che significano- ,
7 J*
Cancrq et sua porta.
..
in a
Candere xftu.
ij.b
Cantare, come fia figurato .44 Icttar^vr '.
T A V O L , A>
ca.
44 b
Capello fatale finto da’ Ppeti. ..
1 09 a
Capo dcU’fiuomo lotto cpjal legno del
cielo fìa. '
13 0 a
Capricorno et sua porta .
1 xx a
Carro ethereo dato da Platone alTaqi, snc.
1x 7 a
Calò qual fi polla chiamare.
. 1 z6 b
Centauri che fignificano.
X3 J a
Onde nati13 X a
Non furon mai nella natura.
14 8 a
Cerbero con tre tette che lignifica 5>o a
Cercar, coirle ila proprio.
. . ijb
ChaoS materia prima.
Da Platone è ftimato gem ma :
dii? a
Chaos da Pitagorici pèrche itueio lot
to nome di Iplendore.
7x a
Chiamare altrui, come figurato dfl Pe
trarca .
44 b
Cibele, et Tuoi lignificati
, 10 0 1
Cicerone a flbmigUa la uiu humana alr
lanaue.
4a
Cicerone dannò ifuoi libri dell'inuentione.
. nN
io a
Cicerone ci ammonilce c’habbiamo riIpetto alla qualità delle persone etc. 1 4 4
Ciel crittallino da alcuni pofto male lo\
pra il firmamento.
83 a
Cìrconlocutioue, o Perifrafi. • 3 o b 3 3 b
Circonlocutionc lodata nella lingua. XX3 a
ClaudioRangone.
17 4
Cogniuon delle colè lupcriori m che
T A V O L A .
modo s'habbia.
6 ti
Colonne di Salomone.
ypa
Comparatione fa il medefimo, che li
fimilitudIne.
' , 71 b
Compofition uililsima quale.
Compofitione in quanti modi può riufeire lodeuole, et biafimeijole.
17 1
CompofitIone è fonte de’ numeri et
delle armonie.
xpà
Compofition dellAlittorc al Duca di
Ferrara.
1 67 z
Compoficioni, che trattan delle noftre
Iciagure.
3 3,a
Concetti poflono da una delle fette bel
lezze dell’eloquentia eller uefliti.
6b
Concetti noftri con quali ordini poflono efier ueftin.
'
a 08 a
Cpncecto è quello >che lententia preflb
Cicerone.
xa
Concetto può eller di cinque forti.
$a
CondItion delle cose et delle perfbne. 1 3 a
Conforto, che uoce Ila, et onde forma
ta.
1,1 b
Congiunti lènza uerbo.
17 b 18 b
Congiunto con uerbo non fi coglie per
locutIone.
x| b
Congregatione,fenloadontino.
pi b
Conieguenti, fènlò adontilio. ;
9x b
Confioerationi d'Hermogene fbpra 11d ee.
z6x
ConfigHo uoce,
34b
CoofiSatione, finoni m o.
1* b
T
A
V
O
L
A:
Consuetudine qual sìa chkpiata dal-,
* TAuttore.
*i b
Vale più che la ragione,
11 b
Conturi , o antitheti.
6x b 6$ b
Contrarij perche s’accordino.
73 a
Conuieneuerbo eouiuoco.
iz b
Conuiuio, grado fecondo nel Thea
tro.
6 %a
Copiosa forma, quale.'
79 b
Coftume de g!I Scrittori antichi.
f 6a
Corpo humano descritto per perifrasi
dal Petrarca.
3S b
CorpodeirhuOmo nonél’huomo, m a
Cornspondenza dal tallone a lombi. 1 1 3 2
Cristallo che sì fa dì neue.
482
'
•
D
*
a n a i con pioggia d'oro *
; 00 a
Delibcratiua forma.
^
81 b
Dehberatiuaforma cai’horaé grande,
et taThor picciola.
8y b
Dentesalbiiv
xyb
Defcrittione e&Rerentedalla perifra
si.
3 6b
Diana perche uada ignuda.
8da
DiletteuOlI sensi.
88bj^b
Dio in quanti modi rrnolge la perfona.
-^
.
442
D io è fonte et principio di tutte le bel
lezze.
47 a
D io è semplicissimo.
.7 1 a
Diuersiùdelle persane et de* luoghi. i i a
D
D isu n ita
T A V O L A.
Ominidi non può efler fofferta da gH
occhi uOlgari'.
ytfb
Dolore ne* uerfi in che modo fi (cord. 3 6 a
Donna , homonimo.
13b
Dottrine profonde de gli antichi, uèlate,
iz o à
etti,
EF ftione.
onde fi figura la locu
H.s>
Elefante più religiofo animai di tutti/ 7 9 ?
Elementati et mifii di che formali {da
D io.
’
84 a
Eletto di Brefcia.
1 6a
Eloquente, fecondo Isocrate.
1 6*
Eloquentia è differente dalle ftcólta fpe
colatiue ; & deue efler misurata co l
senso
8a
Eloquentia in che pofta.
Eloquentia latina quando folle nella fua
maturità.
ìo y a
Eloquentia non deue efler confiderata
nelle parole fole.
i3 'P a
Ha due facce.
241 a
Sue bellezze fon fette.
f bEndimione & sua fauola.
*37*
Enea che getta un boccone a Cerbero,
chefignifica.
90 a
Epimetheo diflribuisce la forza a gli
animali.
1 4-jna
PocoSauio.
14^
T A V O L A .
Epitheti di quantità t et conucneuoli. 1 6 b
Epitheo c'Kanno ujrtu co’i folo pome. 1 7 b
EpI theri da dare a* nopu # et da tor da
ebi.
x8 b
Epitheti di più ucci.
19 b
Epitheto, che colà sia,
14 2
Epitheto temporale.
1 8b
Epitheto fi può trar da fci luoghi.
xj b
Equiuoci et uniuoci.
11 b
Erafindodaconelsimitadonc.
10 3 a
EfppftulacIope.
11 a
E t, pofia in luogo di cioè.
113 b
E p , ò tempo fi dinide in tre parti fìie. 103 b
Età £1 1huorao differente da (e fteflo. 1 p j b
Eternità a gli ferità come può acquiftarfi.
xxf à
K uropa portata dal toro , d*c lignifi
ca.
41*81 a
Ezechiel Frofeta da' Cabahib hauuto
per uilLuio •
, ;
f *. *
F
a c e R 1 certiorem , conuirium,
etc.
n b
F a g g io , parola prefy in diuerfi fignifi^
ca •
\ a
par mftieri, che locimonfia.
xx b
Faua , che lignificano ,
*3 131
Figura tratta da gli aggiunti.
61 a
Da contrari,
,
61 b
. ..P a g fia tti.
, PJ b
T A V O 'L A
Tratta dalla qualità dèi corpo 4
Cì b
Da gli apparenti. alla med.
Figura dell'artificio.
17 1*
Figura topica tirata da luogo neceflàrio.
xi * a
Figura prefa da* confèguenti a imita*
don di Lucretio.
1141
Figure.
43 b
Figure sì geminano a ueftir un fol con
cetto.
4 fb
Figure proprie di Poefia.
83 b
Figure topiche da quai luoghi pollono eller formate.
xiib
Filolofo è aflomigliato al fabro.
18 9 a
fluuij liquente che epitheto sia.
zyb
Forme fono tre fole, fecondo Cicero
ne.
78b
Forme generali d’Hermogene.
8o b
Forme uniuerfali di Cicerone et d‘Her *
; m ogene, in chi conuengano et dilconuengano. _
84 b
Forme fi compongono d’otto cofe • 8 6 b
Forza uoce >che colà Tuoni.
3j b
Fuoco partito in^tre maniere.
9 jz
A v
' c uerità.
99 a
G Gallo
perche faccia humiliare il Leo
b
r a
ne.
94*
Cafparo Contarino fcrilfe di Metafili
ca.
4 -J y a
T F
f
O L A.
€cmmauoc<s.
\
iy b
Gcperation dacheproucpga.
>a
Generation delle cole da quanti princi
pi j dermata ^la’ Pithagor*ci. ^
7 0 a,
Genere a fpetIe, fènfo afloutiuo.
9 rt
Genelì dichiarato nel principio*
6%a
GenItiuo delia medefima uirtù, chele
fofleadieuiuo.
34b
Gerionc uccifo da Hercole che dino
ta .
5>4a
Giudicial genere.
11 a
GiudicIal forma.
81 b
Giudicio, fènfo aflontiuo.
91 b
Giulio Camillo accarezzato da un Leo*
ne.
5>4t
Giunone ricercata d’adulterio cja IfSion e, che cosi focefle.
p oa
Giunon fofpefà finta da Homero. 81 a .9$ a
Giaftitia et Pudore da Giouè mandati a •
glihuomiDf .
14 3 a
Gordio et fuo nodo .
8 ya
Gorgoni quarr^grado del Theatro, i r ò *
Gorgoni da un’oediio folo, che fignificano. ‘ :
in a i la
G o rgo , o figura delrartificio.
1
a
GradI prOposh a gli Scultori et^PittoV
r i.
1312
All'elOquente.
Grane Se loro significate. .
" io o à
Grauifensi.
88b5>tfb
Grtì che significa •
114 a
T
A
vr oc L f
■i'i'
. H
f A v i r e , homonimo delfecon‘ do grado,
J 3 Jy
Hauer memeri che locution fia.
11 b
Hercole purga le sfalle d'Augia.
9 14
Hercole et Anteo che significano. , I X J a
Hercole con la fretta di tre punte, che
dinota.
* 44*
Hercole è 11medefimo che’l Sole.
18
Hercole Duca di Ferrara
1 6j a
Hermogene confiderà otto cose fopra
l'Ideo. _
%64L
Homonimi et finonimi.
- 11 b
Humano ; nome proprio del fecondo
grado.
, 13 b
Huomo per quai mezi polla acconfeutirealrIuOlgimentOa Dio
472
Huomo è un àlbero al contrario.
96a
Huomo ha due maniere d’occhi.
11 o b
Huomo é gran miracolo.
IIU
In che modo fia le più uolte intelo
fidila facralcrittura.
in
Huomo et fuaprudentia.
14XJI
JT
I
.
IIdee d’Hermogene come confideràA c o b e t fu a f c a l a
-tc*
Idee collocate nella mente Angelica.
io £
a
xtfa
71 a
T A * V O L. A.
Imitando un perfetto imitiamo la perfettion di mille
,
12 7 a
Imitatione è porta anclio fuor delle pa
role.
19 1 a
Imitatione infegnata dall’AUttorc . 1 o 3 a
Imitatione quando fi fa . *
. ,4,1 0 9 a
Imitation delle parole, quando fi fa .s z, j 4
Difefacontracolor, che la negano. 2 18 a
Incantagioni, onde nate.
Indefinito a definito, sènio affondilo. £-1 b
Indiriodeiiecofè udii onde ficaua, 1 4 $ 4 «
Indiuidui hanno più colè, che fen d o
no a loro che gli uniuecIàli.
9*
Indnzzo buono , onde può uenire . xp a
Infermità non conoiciute come gouer
nate
1 8 oa
Inferre contumeliam, locutione.
iib
Ingegno del Petrarca nei fuggire alcun
•: 4uobio.
*
j %a
Innabilis unda.
iy b
Intelletti pqfti da Ariftotele .
117 a
Intelletto agente prouato in noi da San
Thomaxo con bello elfompio. 1 18 a
Secondo Simplicio èfuor di noi. 1 1 9 a
Iatention dell'Auttorc nel fuo Thea
tro,
i a vt f i a
IQucntioneonde deriuaper lo più. 1 7 3 1
Ira , et benignità in Signoria.
18 1 a
liberate che diffo dell’eloquente.
rtfa
l&ioae et fua fàuola.
1 33 a
T A V O L A .
LA ntroa .luogo considerato nel Thea i o a
LascIarpaffarc, andare, et simili, che
locutioni siano.
iz b
Leone perche s’humilìa al Gallo.
£4 a
Leone ucciso da Hercole et fuadiduaratione.
13 4 *
Libero arbitrio a che dcue effèr dispo
sto.
f 2>A
Lingua Latina perche è superba delle
me bellezze.
Lingua Latina et suoi siati.
1041
Quando folle in colmo.
3o f a
- Bisogna che sìa imparata da’ libri, 1 0 7 a
Lingua et fuoi mancamenti corno pos
sono esler ristorati.
113*
Lingue pigliarono splendore a poco a
poco .
10 6 x
Locution propria.
x ib
Locutione che importa.
%z b 1 3 b
Locution traslata. **
38 b
In quante parti fi può diuiderc.
39 b
Locution figurata da gli effetti.
f4 b
Locutioni figurare et lor topica, 4 1 b 43 b
Lume et calore che significano di men
te di Plotino. .
77 x
Luna reina delThumiditiL
78 x
Luoghi del Theatro in qua&^oncetti
hanno d’hauer luogo.
11
x
A v o L A.
Luoghi ch’albergano, i concetti, allog
giano ancho le macerie.
3a
Luoghi piem di materie , ma nudi di
lingua.
J a
L u o g o , che colà Cu.
LuogodICiceronepienodimiferigort.
d*a et eli pentimento.
HA
Luogo , fenfo adontino.
91 b .9f
Luogo topico dal limile in Virgilio. X6p *
^
.
M
A g 1 A di Zoroattro era la prima . vi u
cofa, c’hauefle a eflere infegna-,
ta à&è de’ Perii.
*
88 j
Malinconia indotta dal Petrarfca nella
fua donna.
48-a
Mancamenti della lingua perequante
uie poflOno efler rIuorati.
a 13 a
Marco Tullio perche meritò nome di
Principe d’eiOquentia.
9b
Marte perche fintò fopra un Dragone. 9 8>
Matena.da quali parti può eflere infor
mata.
$6 A
Materia prima non è cqefleqtiale con \
l-Attore, et con la nera luce.
' . 73 A
Materia ^ome può efiès copfidgrata.
18^ a l p i 4
Materia che uicne all’eloquente.
1f 4a
Materia prima de’ Poeti.
19 1 a
Materie dell’oratore , et del Poeta da %
che qualificate.
_ „ 1 9 1
Materie
M
T A V O L A.*
Materie quali fi chiamano’.
Mediocre forma quale.
79 k
Mente di Platone.
et.
Mercurio auttor delle malitie.
f<? a ^
Meifcurio con un gallo. . Methodo ha granTorza ne* fogge,ai. 3 4 A
Methodo proprio della Poefo.
.
b
Metonimia.
; ?
^ h
Minotauro che significa-.
A i s \et
Misericordia qualifica J’aceufisriw di
noi flessi.
<
ioa
Mótathon Angelo
*
64^
MIfti et elementari di che furono da
Dio formari.
841
Modelli sensi.
88b^7 b
Modo,sènsoaflonriuo.
,
Mondare.
ìjx ia
Morire, defericto dal Pet*. per p e r i r
si.
Morte.
173 3
n
•
.
,
X J A* ? l f o c lic fig ftfo rv i ’ l t j i r i H
etN Nafrimento.
. •,;J
a
Nascimento delle cofe.
f>a ,73 9
Natura d un’auttorc non può d*
tro eslere imitara.
1 3 I fi
Naue pofla in paragon della uitahuma
n i.
4 + 1*1*
Necessità naturali.
?
Negromanric»onde oa#e.
-,
O
Nephes anima.
* r
,114*
E l’ombra cheJhim otoo V fifoU pO
4 É4 -*v
T A V O L *
d iri.
H 6i
Neflamach anima dia ina.
11 j a
Ncue et giaccio che lignificano prefio
1 11 Petrarca ;
■ * - : : «•, ! t t 9 f 1
N odo di Gordio.
su
8.9 a
N om e , ouando non poflà grcolcriuer
le meaefimo. ‘
' 3 4-b
Nomi appellatila, che fine habbiaoo. i 1 3 vb
Nom i che finivano in A.
11.3 b
Che finivano in E.
. Jfl?4b
Itf b
Che finifcano in O.
Numeri fono effo D io.
77 a
■*-* • ■ .•v'***' ' ?:i ■ , ~t*i !v
o
1
de* fenfi^
OBObliuion
deiranime.
47 b
9
Obliqui perche cofi chiamati v
34 b
Oceano che co fa fia.
7^a
Occhi di Giefu Chrillo
. ;| ,x 8 a
Olimpo che uoce è.
38 b
Operatibni uerfo Finirne noftre, quan- \ "
te fono •
39 a
Operationi fenfibili >et non (allibili. 4 6 1»
Oratione, quando fi dica buona - W . 7 b
Oration Dominicale di quante parale
A9 i
fia.
.
* "Ordina del Theatro.
*^
*
Ordine del T ofone oade tratto 1
^Ordini principali per ueftire ogoiflof ftroconcetto.
n. .
a.afta
^ O ue,uocechefignifiau
. ^ .r llp b
1 t t i
..
T A V O L A *
P
\ l l a d i tre.
I 4 J a
Pan et fua imagine che lignifica. 66 a
Panegirica forma.
8zb
Panegirica in metro.
82 5
Parche che lignificano..
*
67 a
Parola fciolta non può efler traflata. 1 o b
Parole con più fatica fono elette, che
le lentende.
If4*
- Diuifèin due parti.
JfT*
P a r o l e Latine come debbaoo adoperarfi.
Zp 9 *
Part, uoce indetenmna».
is U
Parti che poflono infonnare una mate
ria.
Z6X
Participio fi può uolger neifoo ucrbo.xo b
P
F a sifà e.
;
Innamorata del toro^ cficfignifica. 1 l i f
Tafqua che fienrfica.
43 a
Paflar noia ,lOcution trafiata.
to t
Paflàre e ftar fermo.
4x4,
Tafiione perche fi Renda per la materia.
1 9 5 a
Passioni mafie in diueriè perlone.
z 1 -a
Perdono, uoce.
iiob
Pcrfettione in uno Auttore come Sacquifti.
zi 6a
Perifrafi neramente qual fia.
19 b
Perifrasi, che colà fcu
.
J o b $yi>
fuoiluoghi. .
alLimej.
Ffcrifìrafi è differente dalla delcrittion^.3 6 b
Perifi-afi in quanti xng4 t
«37 ^
¥
A V O L A
Perifrasi posta in una sòia j j o c c . 3 7 b 3 8 b
J'erifrafi cOaie sì conosca dalla Sineccio
che.
37
Peripatetici neganti le Idee >riprouati.
a carte.
78 il
ipèsfona in che sia differente dalia condition di perfona .
1 •
13 %
Perfona et parte.sènfoaflontiuo *
91 b
Tersone et sor qualità.
ry a
PettarcaetfpO artificio- itfa U i i j . a
30 a 33345- a 4$ a 49 x j x
1 7 1 a 1.9 f a
Petrarca trafle la inrtudeHtfffgrire|»oyc* ;i
oche dalie cagiom matenale , et tfffi
dente. 48 b y <^b dalla formale et
finale,
j * lb Lf/bet ftgùc per tuttp
'l'iede significa il uoftj-ó difetto,
1*3*
Pigrat radIeds cpithetb.
1j b
ÌW ugorici a due foli capi riduce uado U t
^Ti^gorici fanno fei principij, n :; y 'jfò it
Pittòn per quali gradi poffono arrraare
alla perfeteion de gli antichi.
tyz a
Alatone ftiniòil Chitos ^gemma.
69 a
Poema, quando fi dica buono A
7a
Poeti perche hanno A pollo per Dio. i $ f a
Poeti di che fi dolgano nelle lor don
ne.
ì?4 ia
Prender moglie che locution sii.
11 b
Tri nei pij deipithagorici.
jo x
. Produzioni fotte da D io.
<T8a
Prometheo legato nel monte Caucafo.
T A V O L A .
fo>.
ny*
Prometheo fctrinio grado del Thea.- / j
tro.
Prometheo et Epimetheo porti adiRri
buir le forze a gli animati »
:. 1 * 1 a
fua fòuiezza.
141* a
Pronomi*
1x 9 b
Proponimento uoce.
33 b
PtoprIj del primo et feconda gradò. 1 1 b
Proprij della PoesTv.
83 b
Proprietà della lingule una naturirddi ‘
le bellezze dell’eloquentia .
7b
è porta ne’ femplici.
alla med» et & b
Proprietà in lommo grado da che pen
da.
n -b
Proteo che. lignifica .
7 8a
Prudentia de gli Vditori, norma de gli
Eloquenti.
x x f*
Pudóre et Giuftida da Giouc mandati a ,
gli huomini _
*^3«*
Purgatorioaflegnatoa Marte*
80a
Purgatorio erouato da Virgilio .
n&a
Pud lènfi.
88 b
b yab
Q
V a l i r a ' delle perfòne *, delle
cofe, de’ tempi, et de* luoghi. 1 f a
Qualità, fènfo>aflOntiuo*.
9X. b
&
A g 1 o n a r e , uerbo #
i o9 b
Ragione che cola fia preflb i Filofi)
fi*
hi 9 *
* *
ni
R
*
T A V a
L A,
^Ramo d’oro di Virgilio.
67 a i * o a
Regola de’ nomi per alfabèto V
14 4 b
Rhetori antichi fabriearotlo il mondo
della lor Rhetorica più utekio attuta
- tellecto , che al fenfo.
■
8a
'Rhetori et loro configlio in qual luogo
del Theatro pofti qall* A uttore. * i n
Richiede, homOnimo, o equiuooo uer
( fco.
n b
Rima, che lignifica nel Petr.
10 1 b
RimpouerautI fensi
8 8 b i>8 b
Riuolgimentoci fa uenir fànti^
41 a
Rofa da Virgilio polla in paragonAelfes
u iu humana;
.v
4a
Ruach anilina ragioneuole.
a1f a
& -.2
•i: . .
■;;i,K es vv ; • •■>., .* \ •
S
A 1 t t A (PHercok di tre p unte >che
dinota.
>• .Ms.n) .14 4 2
Sagito innumerae.
.. i 6 b
Saluto ùCito nel tetto Hebrco . * ^ 1 1 0 a
Satiri che lignificano.
.
i$ .r a
Saturno freddo et (ecco.
1o1 a
, Sauiezza di Prom etheo.
\
14 1 a
Scaladi laeob.
*r?r
v io tfa
Se orza uoce.
^4b
ScrittoriantichietIoracòttumi.
jt f a
Scultori per quali gradi poflono arriua
re alla perretrion de gHantichi. xy-%1
Secreti diurni da noi noa debbono
irfèrriuehuù
rf 8 a
T A V O L A .
Semplici proprij.
LO b
Semplici figurati.
*
I .fb
Sensi fauolofi fon proprij dclM Poefia. 8 3 ^
Senfi, q nature d’efsi, quf2 ^ ;IÌÌap . 8 7 b
• Senfi dilecceuoU.
., , . ,
Jpjib
fettcri.
.............
•” i<> sv
graui.
96 b
modelli.
, T ,
97 b
alteri.
5>7b
n m p r o u e r j i l u , . ..
£ftb
accusànui
,
,
.
^p8 b
Senfo altro non è »che la narurii Hel fog
getto.
8<f b
Sententia preflo Cicerone uol dir con
cetto prefio noi.
X*
Senno Sulpirio et fuo artificio.
1 3a
Settenario numero perfetto .
a
Seuen (enfi.
8 8 b 9f b
Sfinge perche folle polla da gliancichi
alle porte de’ Tem pij.
f7 a
Similitudine, che fiafoogo di locution
figurata,quale è .
69 b
Simiiitudinenon àuanza y ne e auanza* ta dalla cola, a cui s’ailbmiglia. 7 1 b
Sineddoche»
l£ ,b
Sineddoche coinè fi conofoa dalla Peri
frali.
'37*b
Sinonimi et hononimi.
ì 6b
SofTerir onde fia detto.
i i 'b
Soggetto è il primo cercato nella coro-,
v
4>ofitione.
ÌÉ£Ì>
Sognochfcooftc.
1 , \Y.
T /è t ; o U A .
5òlcin Tauro fa uerdeggiare ogni colà. * a
Sole è la più degna cofa, c)i£ sìgosla ue‘ dere in cielo,
iS5?a
Sommeffaformaqu*le*.
78 b
Sospiri amorosi unno nodrimento a^
<
cuore.
i'©3 b
Soflegno nome.
1fb
Specie uiuono sèmpre in D io„
77 a
Species Innumera:.
1 z6b
Spcftabat ad; che locution sia.
23 b
"Spirito dIDiodoue sì fermaslc^
432
Spinto di Chrifto.
10 7 a
sporchezza uien da humidita corrotta. 8 72
Sulle dAugia.
8 72
Statue animate di fpiritp Angelico defcrIttc da Mercurio Trim egifto- 15*2
Stelle fono gli ocelli del mondo.
93 2
Suonarla tromba , cojue figurato da
Ouidio.
44L
A L A R I , che significano .
8 fta
T Talari
fello, grado del Theatro. 1 3 7 2
Tallone corrisponde a’ lombi*
v n^a
Tempi Saturnini et Lunari...
1 o ra
Tem po, fensb aslontiuQ..
91 b
Tempo;o età fi di uidfe in tre parti sue. 1 o 5i,-b
Tempo descritto da gfi anricni con tre
w teste.
iota
cT,erra con che epitheti si nettai
18 b
T?cria. il moue.^ secondo* il- Trimegj^
T A V O L A .
ftO.
1
9 3*
Theatro di Giulio Camillo con quale
mtention fia flato da lui ordinato. . i a
Theatro de11’AitftoIe con chg ordine
sìa flato dIfpofto.
. V->-/
. r
Thomalò Sayl^pproua in noi l’intellet
to agente. . ^ .if
TIberIo Imperatoredilcero^uaalio fai i
ro le cole.
'
<>v i 18 %
Topico et craflatotofieme.
‘a.'i p a
Transìrfc» cioè pattare, come fi fa.
4*?
T ran ce che fi fa dalla parte diuiria et ;
da quella delfttnima.
J 1 a
Trattata lOcijcione ì et fue parti. 3 8Ì> 3 9 b
Trafiatc,fentendofe, et Amplici in fhe "
fiano differenti.
, ’ 40 b
<Traflationc comefipofla fare.
*
Trattatioùe, come fi conofcauia dalla ._
e' pcrifrafi.
£7^
Trafl^cione è più breue della compara
tione.
71 b
Trafiato nome et uerbo, quale.
* 3b
Trattato ; eo^Iie fi conolca daH’hompnimo
; u t»
Trafiaco, et topico infieme.
iì òa
Trifou Gabrieh et fue lodi.
4.9 a
Tn ftezza del Petrarca per la morte della
f
fua Donna.
19 7 a
Triftézze humane.
S ì*
Trouar, come sìa proprio .
ì b
Tuctu alle paro, fenfo all annuo.
guaritati d i Argo w ■
94%
'
i oa b
Vdito come u&heall'imooKJv; ufi. 99 1
Vchicoli dell'anima noftra.
4%
Vello defròró et fuo lignificato mirtico.
ft&b
Verbi.
i$2b
Verbi irregolari*
I37brj$bi4*b
Verbi della feconda congiugauonc .
13 7 b 1 j p b
Verbi d^j^ttìta c o a ^ g a d o n e .
14 0 b
Detta^óiru*.
1416
V e rta cpundofi^Hiami porte eflcntiaL
. j, : delhPecifrafi.
•
;
jy'fc
^ Verbo in che gli attrni et pa&ui fi rifotùono.
14 2 b 1 43 b
Vergogna uoce.
34 b
\V ergo gn a non é ricevuta da A rifliìid r
numero delle uritu.
113 b
Venti' ha forza (opra tutte le cefo.
97 a
,Vcrib di tre parole fole con che artifì
cio fi faccia ; et come''HpSc fotta dal
Petrarc^.
4o a
Vcftimenti del corpo humano aftamen
te considerati.
1oa
Vicinar fi la fora, come potrà figurarti. 43 b
Vina humida epitheto.
17 b
% VirgiliO, quandoabandoaatie la foueciti filosofica.
4a
V
A ccÀ
VdirCjUerbo.
T A V O L A .
Virgilio &. fuo giudicio nel descriuer
la uita humana.
,
i<foa
Virtù attuofa.
13 y a
Vita humana da Virgilio aflomigliata
alla rosa.
\
42
Vita è posta nel fangue,sècondo a l c u n i . b
Vita c una fauola.
iia.b
Vita humana aflbnaighat* alfe roù d*
VirgIUo. itfoa.v
Aflomigliata alla naue dal Petrarca-i 6 1*
Vniuersàii hanno manco cofc, die sal
gano a loro, che gl’indifcidui »
9a
Vniuod & equiuoci.
11 b
Voci accompagnate sènza ucrba
17 b
Voci proprie11 b
Vsò quando sì può uedere.
aa b
Volita che si caua dal Theatro.
fi a
Valiti della lirica deHAutorp 14 7 a
IL F I N E D E L L A T A V O L A
D I L L E COSI NOTABILI.
.fit/
D
I
S
C
O
R
s
a
-
D I M . G I V L I O
C A M
IN_
IL L o
M U T
S v ò
:
fi V A
D e x
*'-T H B A T R 0
A M. T R I P O N G A B R I E L E *
Et ad alcuni altri gcIitiUuioIrmii.
O r s l e X pH rcM .flcm fa
parte compite ere a desse»;
d m di #o/?re Signorie,
n o b ilitim i & d o ttifit
Signori m ia , nel darlo-*,
ro quello affiggi*,eh* d i
mandano dell'Arte, c/si*
tu utile d T h eatro m& \
Ma in quefio mio partire occupato da tante
f t , sa ben certo, ch'io uon potrò f a if f a te a pie*
no a quella affettationiche forfè f i hanno ò w t ,
mesca nettammo . Pur cosoin diuerfe pa rti ti rato da miei m olti a ff a r i, \adombrerò in ffuel
tmgfior modp^ doto potrò U u ia a d ' i o n$gH%
tenere & tengo ; acciai che non pére approsooÀ
J m c o r titm ftm b c q é o jlti qugfiJtponga fHtllo,
A
-
*
Jh f ^
i, * i ,
f|
J* rflaefo n e<tlonmà* 2 a é ta !ig i^ % M M e K
j eda i l
n o fire fa r e re , p s a ^ WbuLjM*- lV jgffw ^ N w *
f a nobiltà c^ewfaesia, che n m y i b&»e*4o «icer queseu^mwaa/ajheo,I»lo ifrglnjjie è k l i \ w t n t e „ Et sesafr ( che Jdrsio? la t^ g U i )
*
non mjfcacerJhetfarea'atKM&LqMabtf# nu ;
d e g n a te fitra p u l, eh ep er sino-a qmjsatfo batte
te* d o t difenderm i da ta n ti morditori-,ch'io per
me non bafio . ] /pensieri» adunque mio eij/rco»
ine io fcrtfii nella eptfttla a Monfignof tetribo )
Intenti* ^ faticarm i ut qu ef a , che eia fin n loco del T /*vl
«UU’autto tro*wo habbia a d r fftr I k f f i t ejuatnevfkc no- *
•e n d fuo s i ^ concetto d i materia y d r b t e , & d * b n g k * .
*tl° ' te fè rc h 'ie fia ntegho tubefa7 Vtp*uàdwio
m w iw E de cweeett*vdiea V d i e n t i fuo tetto f i fh ^ eu U & * f i r t o 9 f * k ^ € k + fin ie n ti* -etrprefièCice- ;
In.
rene v U q u a le fm e jfió è m à t^ enda* m f i ttf # *
fole Mcerne d a
\
ehefmh^toM c^cmtU fio r e n ti* * a eemoé jddi a* oflariiriììiiisCtfnnr • « ai ^ i siVii siiMfcfiilWniiau
fr e g a n e atìegeeù recarne f i
€ F O , sa fym ficaffe fiu a U d o n e K ùuetloCe
accommodato a ia >speculatione; perci*.que fio
arbore nonnafeenatterahntttte ^ fcn en in d a th i
ftlnaueh* & r e m o ti* * 4 lfe n h t *$*gà&paWic^
aUroued» Condotte* • m u . ,
i>.a.^A
' T a /u m « n er dosow u m b ro fie a m m m a fig o s
- A fitdu e u e m e b a t.
•> ■ » ;» r n :G ; V i
X / nella m edefim afigm fcottene pefe t( fe tra r*
4a il dotto arbore ne ^uebuerfo :
A if a r m tttw tif i i? # n b r * 4 o m f id f g g i y v
-
?
*.
-
I
\
' . ■- >s '
D E i wT t H JR * T .
'
IV
, \ T u tto pensesa *
-V ; • . , .
->
accompagnando quella uoct pensesi, c lX 4 « t» *a al dwtosinttm^iso* Et 4 tro u e fa n d a * . *
Casi pensesa in atto humilem s a g g ia «wr£H*
S a f f e »C/ fidcrfewnu mutU rm*n\ ■>.* •
L aqual ombraua-m h d lauru « «ut sa f^ ee „
Impero che uolendo m eftrar i, aur a, lontana dal «
,
hiafitpcm lceio*U A a pexco& pagm +il.s a lg ^ a
rtW i l/enfioro , auar* € ^ < p * fd & w n * k * M ^ * >
che t j U saper , f a f a n d o X 4utsa*siu,**|*
quaet loct* e/ie pvffu u dora albergo a.m onoa/fa k
pc/fimo alloggiar ancor le m aterie. Per la qual
v .-'sa,,.
iofaogut molta, c/ieV fa g g i* figtufcarafprtm **
lattone » quel loca e lic la occuperà , p o trà e /f a A ‘ " _
occupato ancor da m ot erta » concio fia cosa, che
si pua iratfar della/peculati on lungamentet-<%
*’
.
chum'of^mo è 9perche 9 quando il f a g g i o " .•:*,
fich erdfin p iù emente l'arbore, n o n /a m tU esa> >
s ir collocato nel lo to , dome l>aiteremo a ce&oCM
U /ptcuUuotH i ma tra i nona do g li arbor*. E*
él mero , che potendo fi ancor parlardella «a**- •<»’
**
* fa d 4 /àggio & delia f a p a r u o o la r u m m , f a ,
. v7
tr tb b t dm edtfim o Uco^<tikergar non foloM né* - - -l U.
m e d d f tg g to 9 m a la fu a natura : elu ci d e r à ‘ » 'f’ sa*
quofi nmamSUerta . & i n mero, quando fiume
le/Jt parlar del fag g io , come d i materiat f d r f a * 11
he Infogno nducere infum e tutto quello, eh*ì ** * •
i7alo feru ta del faggio , da T heephrafie +
da altri f a t t o r i . Lafciefo di dire la eagum ^
perche^concetta può efjtre d* una <Ucinque matnaniew
m e n : « dico f u m ic a t f f a b i U y b d t c e fe ftm * * 0 *****
tUfibdi ymali cojÀmitaàutfduUt irAarnsi pàrf
* V
V
.
V#
' imifibrt** padi unsepiu vifAik^y ikUHjtbifce
-dSaftotmmntéktm» uchs ehedhge/to wetmt ae
eU#*Uùfi
*wtfc*mf>*gH4t*Ja
tm atttU gb dormenti ptptak*
d*Sr*
htmmaitsfirA .fitm dofiatax tu ,
.foppm a^ dal Immi l & 4 * * à p k fifi* 4 *?fo*g*Ue
' - • • ’fnf'uenseCiAsA .*$V?Ki
•*'**»**
,v,; VrmctfHovohm, aetèrtfo
,
1 ***
d b d e u m /e m i ne’ quah gU eloquenti r f im ty
uoueoAe F/lesasi mofireranm altu^e-befie*<nse;
fi comttfmmdoifumgom fdtrm mottefmì^a ,
fierunfide1k d n de\
* q « w » d o u o g l /n -
■mtratt»ìddU 'fi*ght&ddN*mum* w *a: fi
T*to6f* * X ù $ fiié é * Jlf 4&
in qt4*~
^tuuaettr.AEl nutrir, i lesasi**, ■&< anda ne/
nsenseir inB < *i< »rfi y < l to jft fu n se neimondo h i
UtMl pari d*jl)ÌMMmp*m* **M fcfm dnrabdA :
4?xatfidermd$U Égfifam ; ìdttaeoft ttagbe
Vita ^ daEoh^ ^ o ty. ^ ^ ts^^ T ìp^ l^ ^ I
Virgili ' *w U d& *4** ^
h*t*r*na, si^td
uiTomi- *u&n*#rrt# «flagro*» aWraiW/M ideila roso*.A i*
«u clctrt
i^»nn sa sagfl^
«C
I ^ saMmalimgWfiyn <KÌP »
It 1114
idsu*
iitfinsefet
Aaa «caAM
ine
ami^wniieaJLd^yL^aiil ,iln'l réìih
r
“
y
1"
cta
tawè^mthc^pm Jd fiagd**
,etuniatmne*.
a*< fainsesaaafoodj ^
‘ HHwyii ouwAisuyiàfftdfaloso^awnwflCia «wiad fiuti’
Paul 'Àmpomeprt.asoppAsoMuedoépetetiPe^fiePépja^
lifim a cosai da u t d«re , xneqtr t a l f a tt o * c f a
nel mar tranquillo porta U urie tla te-jd-fr o f f a
re mento:Pnu*f a f f i u u u cm r+ vk t f a f a t i t i
cm rfifiadotU t i f a t f i * Cr f u m o f a ttf r * * * * * j
dJtidetta fa d u a fa e fugk a tifa ifatito at* . s
tateou sap ra hi tinsero franse uihe.Xfi come f a -,
mentre piange l a in e r te >dà i f a * C f a f a
Ma il Petrurna n fa p tije e r fa * r d a à fia x t‘l itsr
dada n au afarf.ìmkfli f a f a s a & é n l * d fy fa m '
s tim a titi* aL eiidomUJe U k iU fif t,. a d o n ti ti
matfirrde&e u f i : he quali non d tm m o g U M é f
q n e fa fi f ir n fa tic a ti, tìr gl# honmafafiem^.
pèntade temone & fin te materiet qu a lefeu a p u fa
U j cete par la n o d e lti adirai menate o partite^*
et i H tam falcqm Jk bona atro *as e smU&hetUt*.
sa «e t^ m u f i fati* tremati tuttiforno contenuti^;
Ha V
lochi fexam* per utentnM f
piena 4 materie rana nuda fu
pentititi** notitinonm lidteèrifatifatiti* i
to ta f a m e q f a t i , i c b t* iw ttm fa x U * o fiù p « ti \
t menti f a nof a nttigteimX c o fu tfa ù fa a rsn éfr ' '
p u t i d e p a rtir, m a m t a t i c c f i t i f f a a H t i t t f a ^ ■.
pae/ne.* 4&t>àlmJmnndmm-*» f a dòm atàti*-i
d e tti cofe p er ù f a t i atti* Infiori*. , 0 u u lta lm fa ^
, fatuità MecaricM pU ltiqfae aleutiAm toubéhy^ «
bòa [cretto. M atior p a r ti note tti-M éM tefadM 1'k
. fornam ento , ch'io ho dato al T k etiroam dper^
fino a quefio g io rn o , m ade quell* f a fa te fw .
darti , fi ai chriftim ufàm o Rie fa u fa d i am*
tarquefio m e a p tn fifa ; ■ ^ f a smarmutgltU,,
cfc’so b otiti a W o m n u titit i d r ip u fip m fim f a r ,
crine*snnyf/oiidl»tw f ^ff^raM(éunp ineinctitici
~
'■ 1 -rV
#
-Lm ■
*•1
f
D I S. ' I N
1
v
M A XT .
r *Rian
A n c a ta nel fejlo d e i naturali può'0
• o f f r e hA
a p p re s s o di me ? doue d ic e , n e lP anime n e
n o v irtù s ir # essere « i t a c e r t a iurta d i alterar le cofe , £ T
l^ fin
5 m o ^ r r ? tr im a nofira è
d ie n ti * portata da alcuna grande off ettian fipro'effe * ,
r * Nfgromi E, A r
^
’S
r
n
;‘*
' 1»
l x
i j L
t L
">neffìmtempo effer
più accom modato , che quando l'animo dettoti §
fia , perche la rra n d t affettion alteri il corpo .
efr quelle cofe , s o p r a lequah egli fi mnoue ; •
L & JK
a c u ì le e o/c inferiori obedifion e, e p e r altra ca
riconofia da D ie . Ma, perche la dim andagli e
m i fate y è d'mtùmo all'arte ; d i lei con noi te r -
- e *co , che pensiero, a n \i preponetene tn me non e,
oom em olti auifano, d# dannar Varte degl'an
tichi A b ita ri per introdurre una marnami* »
bercioche tanto fit* lontano da epieflr-penfiero i
u n to io non ifììmo aUun nùo trouato effer
tono
p i^ io jk tic a di dar per m iei lochi crdm e alla
t J i et enea , che ci hanno lafciato g li antichi i
m olta cura ho bauuto , Cr hauro fem pre, d i
cufiodire & di fa r u edere ogni nummo loro
pregetto c y configli» , n o n qrua fi n u do, ma ce*
me fra sfato trattato d a g li O ratori to da i Poe
t i ; & per quante uie tn diuerfi materie y por
ferm o tenendo i che 1procet to p'I tonfigli o non
u
'& L*
|
DHL
T H E
AiT.
f
sarebbe cefi ben r k tm to dottam m o d ettim pa
rante, sa non fuffecondotto al fenfo fino m qua
modi, ne* quali è fla to meffhiu ufo d a g li fe r iito r i. Laqual fa tica n o n f i lanterne tnoftru.U
virtù d e g li fori t toro >m a ancor de H b c to r fd *
hanno fuputo efftrHarey perche m tanto di chimo
_
„
_
_
In*
o/Jeruata to c unó.
’W S% P 7, 7 %3 r % Z * r 7 ; "m S S S . A t * <>“* " c f e C i O W s u e col trovato mio non intendo di P0 ^”0 ^
fa re ingiuria attorte de gl* antichi ; daUaquat ùchi
riconofco il tutto , e y laquale io metto a federa
in un nwltohon o ra to l^ Q ffe t^ io ^ ^ ^ ^ f iy
" ^ ^ ^ T J W e fo p fT m J io m o /lro . tm per odi e il
trovato pilo e radicatonella virtù de loro prt*
te tti c r configli fJ M a qvefta d ifferentiae tea
noi , d ir g li a n tic ln liM n o te m ^ o tte f^ ^ : 8 c h
J S xS m e T f f lo r o n n ì^ ^ ^ W ^ l u i T i a u ìa f o ^
di mnaeSignori^Tfoo g*a pochi giorni effendi
tu tti no i lufiemc a legger d i que'dtuini libri del
g t^ t^ m r n o a q u e U a p M te T r a f ta d d l Tim eé
espiatone ; doue nella creation del monSTWt*
c U c^ o creo quella p a r tt^ J S m p ^ ^ ^ a ^ r f i
utile a lu i , ei dice queste . o cofi fatte parole ,
g ii Dq m in ori, come a fuoi numflri ; doueni
o w m j m effer m ortale tutto il rim anente, ri
peritene a forn ir qu ef i a fabrica ; & non poten-,
do ciò f in \a tne\o venir da me ; perche farebbe
memoriale tutto quel a che da me filo u t ruffe i
A
UH
t
E T lfS .' E M
uoU m U autU quella
dote tn m e , prendet* *
f h t , & ci) e
*f M lfi
■ -$ £ * < *
-
rae-
Jf
9rmnori Dw nonfiie
fronde P i o , ìó ettirr
^ ^ J e n f e S to T ^
" T
R
^ ^ tu n a r ^ a m ia n I
eaeto
•
.
j
»l graenmond&
B B K
_
.
j
*U*À lWW*W~
##c4saosoe Udlte-f e i* mt*fi\%jifaitljm * iffkM *
f H m i o f i & M * * * -ciirffWM (li-puAof* u tfW
andare n tm f ig k à f i omgfi>4n ^ i e A h & c fijlft
li ordini tocchi d i* fi p r t f c r i t f tf *Qft A f/enilre a l - ,
arte mia--, f i p m r k U x o tÀ * p $ k jfi< r .d ip 9 +
N a ta m e n e * .
»r-r •-.•.>-i *:<m ,
u r* *
*
wgtó»
K m ty-cw ntla lrili>(ofi*ta*tUrtt.tìM:ci4Wit£j*}-:
ì s g r r o s m
pagare rtm p& oche effendi \qy/tu parie d i Jet
I l o q n e n - s u r r a d tlf ià f o f f ii k funtO iChecjiLliiìh) Chi 0M +
4 sa k»K‘>" fi-m ifitra tn \ tìpanche dtfft Cicerone n d tQ rM o -
misura re .‘ CwuToffigiemaurjhui quaxtjm**^ \.\
ta c o ’l sen N e c re d o -, eh i g U antichipenfafferò d i batter ri*
f r e t t o talm ente *1 tutto nelle loro BJoetoricbe,
chrntnr fr fjir o ancor t ima fi de * lefhipfp, Upcn
fieri d t quelli , che haueuano a uenir dapw .
' Ut, perche il proposito mio e tutto di
_
if6 E
Iafètica
T u
F. a r .
*
c-m altfrtojagiores’ It « £ -« »
uenfientHig l indètùdui, tanto fa » * '
w
*
sa if i ti ahi unì v e r fa k , tanto vengono a m e- che fcenJ lr * r f ip i» p « h '.
titano o l i a n t k h i : te r chi fidano nel? d ito . & che quelle
^«i »o, perche pigliooi^fetnui^^^
le Jpetiaftffrm^ ^^^ ^^ntro cllc sa,g®*
. I
. , / «*'
«mawrtto a eli
& l o * n f i ritto e *nivmV
fla to , pertbeTie *tmlìctxttb ftm fre . , sai* norrò &
parlar di Soffiate, o d i Natome, a h fitm ferà p m
commodo l'andare alThuomo , òlqvale è loram
ento , che all'anim ale, o al vivente , a alla fo~
Iran7 a ; imherùche l'am m ale, il vivente,
anc6mMtr£CG}
mo^ g r ere d o f che coso come sa alcuno dim anff ffe q u a lf ifjè ^ c a g jo n T ^ L tg e n e r^ io n ^ fr .
le cof i : le yltlTr/ (l ondeHe il S o tT l/fleT T eT ^
deggu.-j&frmjcc, nonffìia rti*
^
ra dj uo affienato la u<nracagione : la qual e *
* ^ m 7 ^ e A r ^ T ^ S S o n o « puo aunenir a l
trim enti . Ma , perche il caldo rmmflrato da
noi tuo ancor m i pi v freddo uernofar produeer
herbe .f io r i, £T altre cof i , adunque è da dire^
(he il caldo dt qual fi voglia cofa fia cagion del-Caldo et,*
Ii generatione >fe»%a dire il Sole : perche
caldo può far ciò , benché quello del Sol prin u m ,
cipalm ente . C o si diremo di molte compofìtio-‘
>J
ni fa tte buone : imperoche, sa alcun uolefft
aff ermar , che tu tte quelle , che fono buone &
belle , fifiero ta li ; perche fo r te de nse antichi
k haveffi cefi p ro d o tte , <foeffo potrebbe prph*
A
V
i»
D I S .
IH
M A T.
dere ingan no. Et; in nero molte coft ; CTperaenentura le bellifu m é ]
turai confidilo di buoi
tore alcuno nonjecem entiongiam o* . Ma p ur,
se /id i cesse che alcun b u o n o ^ m lrif^ le hauejfe fa tte coft belle f i direbbe fe m p r e lH ^ o perche
fi come quel caldo producent* può effereo del
fuoco , o naturai dell'animale > odi altra cof a ,
non pur del Sole; cofi il buon m drCffio non
' p S s j s m m r , : coir 1 4 ? arte de gl* an tich i,
d v u o ^ tt^ io T ^ jM a n c o r q u e f lv ,che que',che
hanno componuto dapixi chgt'a rte f u o jjèw ata^
ti hanno aggiunto to t. & tc m tT ^ e * ^ e c h e V 'o r
fafia bijognodi num e o jjè w a tio n t. g ra n e *
flètti quelli, che fterrò V a rie , non furono bue*,
m ini fi efa cita ti n e id iro i else potfifer.o meder
.tu tu qmillexofè^che fa u n a » * di. Infogno: d à
quali Jfitmo Cmeroae ,m en tregiouaaetto com*
pofe tltlfié filL i muentume . d annati f a i d a in i
m età matura: nella-fuaUhauea conojomto per,
proutifi come .cm feffa, che Varte d à Sjietorì
nonhaueo com prfiulom tdefim o parte f i quel
le cofe , che tiVeloquenti* perteueuano. M.i
poniamo ,-che il tu tto babbi a a d ejjèr riconufcm
to dall’arte d e g li antichi » io peggio n elT hea^
Irò m io , che quel ne^otio >f i e peri irn e a uejhu il corpò.humano ,.e
^T on tanfiX T effo^ eftire. .Qonciofiacofa, che
f é la la n a , di che pofjano efferfatte le uefìe3e le
-, a a l \ € t fiora richiamata al fuo principio, dui*»
urm alle pecore rptra f i fiutim i 4*1 tonditore
i> E L T H E A T . «1
U freneremo ancor nell'arte del lanificio , b er
nella fila to ria , hor nella tefloria, bor nella ten to r ta , bor nelle mani del follatore, bor di quel
lo ,'che cim a, & fin a m e n te nelle m ani delfo r
te: <y non d i meno nolendo fi alcun uefiire;qual
di quefie a rti f o r a a lui pru commoda? Certo
quella , rhe-gli farà piu m eina,
T beatro mio o lir à , che potrà frenar la lana M
auantt che la troui nette
mani del C im iti ore y o-del farla : & poi la t r i
nerà ancor non p u r nelle mani del farlo ,m a an
cor d 1intorno ail'huomo ne fitto : cofe potrà uedere t preceT tT '^ F f^ c^ ì^ T dT BJretori l a , d e
ue to ordino M ia la AJ e lorica in quel modo „
ch etfii Li infernotto; ( y poi potrà uedere i m edefim ypm m enu alle m a te rie , C r finalmente
d'interna ad effe materie : cioè prim a la uederÀ
applicabile alle materie, & poi applicat a y e g g iam o ben , ctf in un medefimo tum ido di land
fimo alcune parti più accommodate a fa r uefie ,
ebe cattae
pur tu tta * lana : cefi g li altri p r t
te tti de* PJjetori fono accommodati a tra tta r
tufi* le m a m e rt delle m aterie : m a que' mede^
fim t tra tta ti in un modo fono più al propofito d i
qui fia m a te ria , che d i qu ella. E t , quando tu
dico g ià applicata $ io intendo ta lm e n te , che
liberata da certe p erfin e , & d a x e rtt acciden
ti fella di fiik u id o a d tu eriga fife a e ffeciaU fitma
di applicata ad u n o , applicabile a mal
t i . Frendo al prefinte a darut i n d ì t i o com4
per g ratia d i efempto pofiiamo per la u i a d f
JUxter* accufart altrui... hnperoche tu tta qua*
« i \ t f i % * t v r r m * A Tr
sta imprefa conducono fo iìo il Genere giudici** '
l e r & dantto in uno cumulo tu tta quelli Una* ■
d ella qual filo ì mifltù erettati*fanno qual parte
potére accommo'dafè à quella caufa^ehe loro sa '
parerà davanti : m hifìrano dico m fiw n en t*
tanto conrmurH a t u t t i i r f f i c ì t delle accufatiof
m , (he diffìcilmente tr poto perii* faprebbom
farne fie li a ; y , qnonde ancori* fipefiero f a re , O* loro tifw flc bea coffa ; la trattation da-.
Accusare Yvbbe loro «vanno:* . N on farebbe adunque
%ino per
,
» »
.
usa de’ ptti contili odo p a r tite ti G iudtetal genere n d come° of
& nella difte f i ? Et ripigliando
U U i(l ° poi l'accHfatfètie , dtUtderla in q u e lla ,c h e ac*
tu fa noi tnedèfiini, iti ujuetìa, d ie acca f i lo
amico
tftfèRachificvufit tl nimico' f io r td e l
fó to , (yT n qnetia fih e * fa é e u fi n d f i r o ì l e quòH diuitiàm htttfiti tètre tante corrijfinden
t i per la dife fa'. •*' N e pantad-uUuno^inconueheùolc , che f it to d OtndiC idgim oxetoridiica
to c cu/atto n d tm f m e d e fh m fiy U '^ fio flie U * '
ito n e , t y quella dtéàceufa ilHir#tcp\ji*6U del
fo ro ; ìm petiche f i tu tti i VJietori fin fiffà n o j
tr e g e n e ri, 4 D eliberativo , il Dimofhr attuo-,
* 7 Cuni:eralecomprendere 4 tu tto ; ragtoneuel.
m ente * de tttC d p ifo H o il g iu d i a al pofiono usa
f e r r id o tti * f è t ; perche Mare'Antonio *ppr<fio
Cice: iicl fixinM frtldFO frtérépàr'i che non uqg l i a d i r , clx* in vtìf ìf u ttt capt-fi h M ta n o a ri
cever perfine ’( & maffimameute la filone po
n e quefie 'parole':' N dm ftM a n cn u caufam in
nner Mancino ptm tm us, quoti efcunque is,quen\
pater patratttcdtdtdcrit-, trteptui non erutto-*
f) E L T H E A T\
ty
tk s confa n ou a n a fcetvr, &C. ) forfè alcun m i
dannerei. , che nelle diuifìoni predette bobbio
qhafi ricevuto p e rfin e , dividendo l'acetifa tto
ne in qu ella , chef t c riamo di noi medefimi,del
l'amico , o del nemico.. io dico , che al vnk g i v - ^ ^ ^
cheto altro e p e r fin o , altro e conditiondi per-et condìfin a , imperoche fife io
|^
J>eruntnedefvno
fon disTee
sasation t , .CT U o u rex o fi t & non lo vari affé- tcuc‘ •*
7ZF/>erJonet Jà7fim JnT ^ T ? 7 o c Iu TtionJarefpfTfiiJ/irta ^ r i • - •*
N on uorro*f?iTT^?'WcìUre ordinerà in arte il '
^
Ciortdon di Virg ilio , m ettere il nome d i Cori- •
don* ; ma U co n d u io n di C oridone, che s u Prtsto rea
rtneo l<* conditton del ?aflorc, che era
innam orato, conci afta cofa , che ad huomo r i f a
le gp^fohrio d'am ore, ncn jarehbono cotnmuiù
q u e m e ib o d i, che V tr ^ f a vfare^aQ oridonr,,
f i ben feranno co nfidpcat e f i f a r ole di M.%^
co A ntonio i fi p o trà comprendere chior am ente
" fr i quel prenome I S, etp e r q u e fa la ttu o „ Q u £
•xbe.tglt oi e ò n fig h fa r capi delle, condì rioni Mie
p e rfin e , m a non deinome, proprio della per/oria tx e n a o fÌA fiofa, che egli leva via il nome di
Mancino > g y la fii* quello d i {infam o., a cui pp
teff'eavven ireU ca fi, cheavvenne a M ancino*1
Adunque chi potrà ragionevolmente dannare i l '
propofìto mio ; f i egli è fondata nefeonfiglio d i •
Cicerone fitto- la p er f a ut d i
fA jito n io .fi
Non uogl/ogià to feender tanto g in ficffiptpgr •
- Citfii tin d ivid u o , che cofi verrei M firneràener'
* p 4 «-ite m e g lia fa r rie n tr fa r in a r m ^ fi^ o r p e l
i'b& W * *dlqi+4- TJhm onJsa piti f t t o d i fe uatunt alcnna.chc pofi
Id £ ^ JM JjJ& l,É £ £ À f/;e > *"<**# > <2*
nonaufieno pvtefje ancor pm hcar.dt Socrate &
di Fiatone > cerne può predicar fi diurnale ,,o,la
fofianca \ perù olojamente, applicare f im o a lo-. *
ro tuUo quello , eh'e peli'am m ale\ ilqual non
pur è (opra a Socrate < y ,4 Fiatone , v ia ancor
/ opra al L io n e, & a l cttuallo : < y con maggior
pencolo ancor c iò , die pofiiede la fifia itX a , la- ,
qual e più a h a . L eggano ancor g li aduerfaxp
( l'(ec>° )
J eho dice nella mede (ima Ctirtd.
M. Antonio, Q nijìetiam in hs ipfis, ubi de fa -,
l}o a m b ig itu r, ccpsrn uc .cantra Ugts pecunias I \ Decina., argumentaCT crimmuni & defen-*
fi ynts txUtHXtuur oportet Oib genus. , £ r ad ru- .
tu r am nm unfum : quod, Jum pittofus,. d c lu -i. •
A'//ria ; quìul abe;u appetem , deauarrtia: quo d .
■wjidtiu'fus , de iurbuieiuii4)Cy.nndis enubnsety,
rjMod m multai, .arguttur-, de grnerc^tcfimm.,\ -,
Cuntraq- , 4ju* f r o reo dicentur^Mmiua ntcefi-tA
farm d /ctnpore ^atque homiue)y,ailconmu'tieitA
h vw tm syertdn. y generum ,jum m atreuoln tn^
t u r . Jw pirochf polendo aecujar P. Decio di V
quello Airron > che egli era,fopr*umodo.fe d e n d o ,
d<*i<ct da.pxrxfpoda Infun a: x p .u o ia id o lo p c -^
cnfar db quello +che egli aerà, Mgord oddatT,altrui >»
fu cu ltà fMfJegna Tauaratidp^rxdpo^ f&c*>spy«
cefi cim and a M dalcnnepartuolar,m aterie,del- \
le quali U maggior parte haUriam 0 da Pilofiof i ,
tsr. non d a Rhetori *rE t,p e t ritornar alprvpa-. t
/ * « i fapet^ p u r , , che Cicerone m font* lochi t i -
D E L
T - H E A T .v r f.
ammonif i e, che hahbiamo ad h a u crn fietto alle qualità delle perfine ■; delle- cof é d e ' te m p i , delle pera
Cr de /oc/n . O ra io dimando s'egU è w c e s se s a fff,<1^
rio nelle compofitioni d i f a r c iò , c/;e dice Ciee- tem pi, et;
rene j o n o . Se.no, fitnpè il configlia d i tanto ^
c
ìmarno. Se f i , d; ciò non pofiiamo effer periti, «srercca
se non per la o jfimattone: e y a voler c o n f e r v a r e , eyd a ru c la nel Theatro m io , come la p o jfi
usar più com m oda, che nel m o d o , ch'io pren* ,
do ? Et certo aeme par dotta cofa d iletta r d a l
le materie le per fin e g y i tem pi certi: m a fitti
cofa m i atti fi effere il confermar la conditione 3 e>
q u a lità , cl>e dir vogliamo, delle perfine & d t
tem pi v Et prim a , ch'io venga a m aggior d imofiratione;, d ic o , che per etafeuna co fa che
diuengafoggetto dell'eloquente^ da due la ti fi% e\[(l2f
fofjono ved er ic J ie lle ffij c y i loro contrari : et sor rugi
pofta d a .tm iato la cofi da d ir e ,
altro
.
lo fcrittore., imperoche fio fix o m e lóTcofit può re st paini
rnofhare allo fcrttTòfTcdmrnodo,-quàndo ella è nor
• n
- ir
• ’
botte[ta o m drauiglioja , e y 'incommodo, men
tre eìlaTinltonefla o tuie-; cofi lo fcritto re, s'e- f
g li è eccellente, puo-porgere utile alla cofa, O*
danno,-quando egli/ unse poco facondo.. A dun
que , quando UiCofa miniftrera commodo allo
fcrittore, fèanco >effo f aiuterà col commodo*) •
che può da lui ventre f ne diverrà compofitton
doppiamente laudabile , perche fi*ambedue* ,
U tt hanra b e lle fffia , E t ^ quando la cofa por* ;
g è ben delfito commodo alfe, fc ritto rejv m.Tcff#
q u a fi'Va b b o ffi, c y f a d m enir. tuie fip e r non le r
Jàper d are aiuto 3 o -ftr oscurar
l i F . n s e t 1 i ' N n M A fT» ‘
f i contè jeHfbfe d e l fu o ri edo artificiò, a lu i f a
vergogna f if a Mia fa k d a n n à . M a (p a n d a ia à
cofa non fa rà bòne/la , o vero-farà pouer a f f i
lo fcrittvre la m etteradeiU ro del centro dtquefi,
la noflra artificiòfatòM fix lreg ia f e a uederc':
al nostro molto Keutrm do & fÙufire Eletto da
fa e fc iit, & al inolto M a g Si». M Agostana
M uofo; le Sìgiiòrie de qtUili pòtnmno r id ir
ijn e l, che io al preferite pajfo con fìlm tio .} fe U>
Jcrittore adunque la nietttrà dentro del cerebri,
fitta detta rota tira n d o , & a jju m tn d o d a lU
f a conferenti a al centro tu tte quelle co/è, che U
faffanoaggrandire} potrà fenfiadulrbtà fa rla
parer f i ufi tale , quali fonò le g ra n d i ;• Vinse*,
(Ima Yiotidim eno'fcrà'qvclla compofuion^y xho c
non uf in o n fen ttra córrìrtiutò à d iftj/itr ftitte . E t,ben* '
tdtu qua - che \foi r a te i a(eia fje fiifa tt 1f a r e i ’d o f ie n t r a ì
Iror fe ra tale ,
U xofejtfte, cy l* b
a
f ]
perituri \
/o ciò. f i èfftr•mrnseV
dòueffè^ effier. |
chiamato'eloquenti: ; ilfiafif& fafiàafi& drie j
Asa cosa il fio cornhìodò', ononie fitpeffe dar r
di quello, O/e datt'arìifrtióftto foiefjè%i*mre,k>
pier/fifa cotiipififiori bàffità Ma farlaferm io
duif i di fieli o abhdjfòfe artificiofa - ^ u a r if a
Virgtboinvioìte fartidtUrilfud &uooIk*^'ac->
c\h)ì)ìodd{ido te dofé" mtifiiMgtiftr:fiìlé bucoli
ca \f a ilfetrarcn f i tifi iHrihM ie 5 efiine^itllè f ia ti pdrvté ‘Ciurli' 'm n baiìtio hco j perdi*
fafiorfigpà it tàuro àrbore per Laura ejleriorsa p urif a r e , f a ralhàfa il trofico per il mondo,
dfcr ig iirm p e r fitta 1/àntdfyt p e r cagion d ii tv-,
m iliare
'D E L T H E A f i , 17
lArmiUarc lofi tic,. J%tanco Ificrateforfe
ìndi tale inalXare-,r quale adopera Virgiltei;
nella'Georg, inalamelo le ba/Jedfie delle tipi'"
fìttolefinnUudt ni d e ljte r dfi.<^ptfdw,-ètdé%
Combattenti» ..Issineadunque,.modi là.cotn-l ‘ ’ ^
poftùon può rtufen Imdabile>} et tu altrettale£ .
Intifimeuole , ImperocheUudAiile farà, quanfi^Vf^g
do U ni cemtnodQuelle cofe[ara congiùnto qt\[0\e * A
commi)doAsilo Scrittore \ et:ancor pln j tjiùdndò^^^^
V*nc0m?tj<klo d,dlàicfd i farà ahitatq dal comitio?* '
doAettofermerò. xMa Inqfirneuqlcfarh qimùx
dò nella compofiitonj ì uqdcriiìl cornmodp deìlit
(xfiLeJJcreartipqdito ddVincqmrrìodo^ detto S.crilr*
*>&.y et,
quando a m te d ìa
m m m odi \fitr 04tqrdm1o u n iti, Dalle quaP ra.^
uròttinsent4e£cl}.e.jtvtte Ia Jm en ifo n e cAaU d*;
negxiCùfetrouate >:dijputate ^ e t apfet&eeWifòè* '
■A-AftU/ofiuIa im e n tiq n .p u o }{J^e2iicirfia!ttdrt
fàrteAellA. co[*^ma.nfln.m ]s\ìm ^cf^dtè'^
hqtwti e., J h io Q Ìn ,a d o y à r J a ? direm ò per u h ••
^ f y y n o d o U x fifa m in ifir a r ÌJu ó l cìm m o d rià - ^
fin w n fiq p firn cotale Adórna- <
*mentisxej],er tu tta da da,fiqrtè A i l u i . ì[M \fatfa*
rfitéflo.Affeorfo-yperj<ir.xi vedere a poco àfò'c**la ragion .>che m i m one ad aliopar. letrattàtioH*'
-deile altre nonjnptt^^
cdjn^
unenti ma anco rTjvttqfetternqt es?^
"^m f^U rm U itTun dJatfonettcerfeìi erìffiìrP*
^èt.iq&rtj tempi f>perd},e cofi apertahièptejt i*cg-'
goity 4£»mmedi
matcpkj):;nm fidato*-
»* p ; .s* ;i n M a r .
g lfS c r itto r i ^ $t che ho m o ricevuto doloro, tt
più ia p o ic h e f tutto f i f a fo r n ito ,.p (ufo poif i
tutto ritornar*.uii f itta vo lta a..gli. w yuqrfalifrito d /r , d i quello >/franse Mìit/fiu f i
nato, ctsao nfdrl/o aednseososa cApf pripji..redvT
- te r il
f J>J*e , et al maff . et la cagfonfifffiìe^fm«oue^
tra tta -.
re una materiaf che non f i f e H a ta m ai tr a tta
ta , et dalla avaìe io nonbauefii efem pjodi tr a i
lattone , f i t t o la fa rp i vqnjpp,nella p a rte d f i
le n e , q del m fie S c e n d o J a f v a iiatm ^ e t tpu*
tiate moitegpjffimili g i à tra tta i e ^rni d a r e b b e
n u d i [r fitp r rr}ede(trnapn e p te ja ^ p r o p o jla m ^
' t rri*
i * .. ^ " .
'<
ma? nser
?Ìor sane
fede jJ^ìshr/ty
f c ^ritornerò
m o fr a r ^ p e r ji, ’
*raf
nerò a .njg
fineUemamere d i accufatiofii deff£t
S e p c r / h t t f fioJiitendo al. prefe^e^dtgìfiftr/st,
le.loro tra tta tig li interam ente,ma di .accennar -*,
le . Et ittico noti intendo dafar., a o flu e , o ra tio ^
m i, tm u n cortijiofiftoni, p tv ptcciole ; g y nelle .
quali fi può non dimeno, veder quella.medefiina^
diligenti* , che nelle grandi. . Verclipjio^ueduta l* ini agi uè di Ce fa r e f e t i d o la fu a . g r a tin ^
d e f e it naturale compre/a defjMttofin una pie* .
tiolaxornipla j e y poi quella, medefima tira ta
in u n o fiu ti o tanto grandefiche quattro te/te n*
turali h a tq d lc n o bavuta fa tte * .di occupar
tfiiitp h (o >
^ h ^ r i tnm gini .
.•._:
'V%iiig0tdnkmkdimmsdmm^*imsv^uiAsssss^AumAk
defimo d i A curiconfigliò totalprefo i cèrto"nòti1*
trotteremo in KÌ'teior e alcuno, che venga a quri
f l a p art' 'dar mariterà d i accufati one : 4 n \i fM
to q u e l, che dicono, lo mettono si in comune K
d/a tu tteìea ccu fiitk n i ’p o ffa fa ttfa re fi corno
nederho mite.[empio deliri la n a , Aellaqual fi,
foff a f a r m olte maniere d i cofe. : Moì a d m q n ri _
rhimfirattdo nel Theatro nofiro fin loco dedicari .
to fegn at am ente a lt a c w f a r f mede fimo- n if i
modo p r ed e tto , diciamo { cUèincofi fa tto lo cri
daremo A ?O ratore &* a l Poeta ccrtiJiim d'U \.
trattation in m o lteg u ife. E t m e n tr e g lifid u c r .
fari dicono, che la m iu & fa U & confufo. a c ri
cufttion d à RJretori può b a fia n ; io dico db m f & lo prouo cofi, • T u tte le materie ‘C fi còme i r i
difi* in una delle m ie oratsoni L a tin e } neCri
m ani deW O ratore o d e l "Poeta fonò d i necTffif^T.
ta T n e m e x n ^ f i^ t^ ^ ^ r ^ ^ ^ m a t e r ia a la * # }
ha tra le lòrom a/ù pàffar fe n \a : perche lt* m \
de loro f i a t e il muovere alum a dell,
m a conctoJLrcTfTTc!^^
crjia sfa ta infègnata d a g li antichi [fa eto n f i
in confufo, che non p ò p i am e fa p effier li torri*
ammaefhramenti di qual pdfiìohe hdffbiàmriri
qualificar qu e ilr itic n fatìòn rìiiòttàfriu òi ine-. V
defim j C
Eo D I*Se , 1 N
M A ,T .
wo lo tonico o7 m m ico, manifefi'amente appo-,
re la loro a r ti effer g in degn a} che utile a queJìo negotio . Rei* uede V. $. kionftgnor T r i - K
4
u;
f in e a checam mo.to mr volgo . fitipèroch'e, s e
e# m e jirerò Vaccufation x;che -facciamo di noi
|
tntdefim i , non ejjèr tra tta ta d a .ite g li f i m i
|
scrittori con quella papione, con laquale è tr a t
ta ta alcuna dette altre f i etic ; feguirà, che l'ar
te mia poffa g ià dare mdicio della fu a u tilità « ^ j
Dico adunque che tu ttep a c e u fa tio m ifim ifle f- _
^ .A c o .^ g m M H ^ s Z 7 d M A M m £ é ìjm d » m ^ .
»J ! •
anc<ir
,•
H 3 di nos quelle accufatiom , con lequpt pungcm oglì a d ******
tierfitrq, effert accompagnate dalla ir a , o d 'a l
tra c o p p a tù papìdùe v Et la ragióne c,che'neffin a c c u fa sa med(finto per muovere ira i n / t f i
fruì contra di fc^ m d p ia m en te compcipiqne: et\
m edefim am ente, filando accnfiamfilq arnicò\
perche cghhabbia mancato delfuo ufficio , non >,
cerchiamo la f i a i r a , ma laJuA c q m fa fito fii,
& ante quella parte d i papione chianiata ^ f i - »
tim ento , ma mentre ac enfiamo il nimicò fu o th
d el foro ; cerchiami di mouere in lui il tim ore*
la tr ife T ffa > & talhor la d ifiera tio n e. t Et y ,
f e lo accufiamo nel foro , oltre le dette pap io n i■
mossa in lu i, cerchiamo d i muover la indigna
tione & l'ira de*giudici contra di lu it• . Veg-,
gia m o homai per le dettò ragioni, chef i le d e t‘ te qiutttro f ie c it delie acm jqtioni fono q tfd 'ifita te da diuerfe pafiioni , la Uro generale a a # -.
f a ti o n , i fu o i confi fi ammaefiramenti non pua:
d a r .q u c lla in ta y dijìtn tp nttlfià^hp dar pò* >
•r D V
t
H t ' À rT .
• rt
tra Timprefdpnia, f e , per far quali 'tot. mm .... y
toccar la qualità dellefierfirre effere ù tili J ù
*
q n e jlic a fri, uedete Signori m iei, che q u antim * iv
que ir* ambedue le pri me fie c ic delVaccufiitio
ne ; cioè quelladì noi- mede fim i i‘& quella del
l'amico. , che è qua f i , corvè noi mede fim i, f i arri e ^ r ^
uefttìi di e m p a fiò n e : nondim eno, quando acve-?
enfiamo la n u to del non haner fa tto il f i o u f f : Pamico et.
ciò ; mouiamò la coriipafieno in un tc r\o ^ f i
niw*'
pentim ento in lui mède/imo rifa ,q u a n d o accti
fiam o il nimico f i o r i del f o r o , m ettiam o t u tte
le p a fio n ì iti lui fo lo J ' & quando lo accufiavis*
nel foro , meniamo non fila m e n to u n te l e ’p a fi ’
•...
(ioni in luì,m a ancor nè g iu d ic i. A d unque m n
[ tir Ale q ualità dell* / f i f o n e [, nfiaTm cprfaTWe
de lochi fono corion di cof i bèlla d ivertita 7da~
qual non potremo bau ere apparecchiata alle ’i t f a
■qui fargliantichi Oratosi ,ò Toc f i , fenonf id it
f a m f if iT ^ T f io d iìa i^ n U ^ c liid e n tr o de'
particolari. Vuoimi neWanimo S. Èriu h m tì ,
f a mYjtobilifiimo Auogdro, dì non hattere al
' preferifei'hiièi libri dpprefio;perdte meglio’apri
rèi qùcftiftfificr mìei cong li efimpià o.dimeno
nìifijjè conceduto più ditcnvfw, accìocheiopritefii correr con la memoria a ì lochi de f i A s
to ri. M a'V T ^ ttio^ iT T n^ té mi andara 'fi ira*
<orrendo d i qualche accommodato ’efem pfó' .
Eccovi che quel b e lh fim ó ldèò d i Ó'cèr. ne h
Ifilflóla-àddbttduio, dotte acc ufo J efied è fin io
'difittaw iddio•fa u o re'a d • tittM io fi ì 'motio "d i
proptifih
«
»2 D I 5. > i:W U 'M .r .
il i* pentimento^ & d i ce co/i ,.^0 me nunquam
Ckrr. pscfa p u n tc m : g y a liq va n d g jd , quodnon e r a t,
ferie o
r
tx jjh m a tu m : quantum j e Po. Romane
* di pentirle me fe fe llit opinio « O. weaitt calamhofiatnac
•niipo. precipiterà fieneflutem : o turpem, exaffa , de
menta']; aiate , cam ciem . Ego p .conferìptos
ad parricidin/n in d u x i : Ego. Kemp. fe je llt. e‘l •
rim an en te, laqu+d parte per virtù di una pur
gation e si accusa , ct' consense ilf i o peccato;gy
(occando, lochi della compafiione Mienc. ad irti. p e tra r per occulte v ie perdono f ancor che aper
tam ente non lo domandi: & l'efdamatiuo m e
thodo . per tlqual introduce J'accufabone i tie tH molto fu eg li apif i per, cojì duref i l a ogni fiorrm len% a.iftnfi ddi'acfufiitione : t y quante più
f i n te fd a m a tio n i, ta n io fa n più vigilanti i d et
t i sanse. E t , perche V .S . ‘Mense. E n fin e m i
h a commejjò 9 che io voglia non pur n e \L a tin i,
m a ancor nel E. m ojìrar qualche loco i d(co che .
m tp o rr calla memoria al preferite una acca fa - ■
Iton , chc'l Eetr. volge m se medesima X-Uqvala
incomincia pur. dalla cfclamatione cefi].,
Q prfirn o, o h o r a , o ultimo momento ,
O s ì elle congiurate a im pouerirm e.
Mt cofi come nell'efempio d i Cicerone, la esala- m a t rene ua in quel mede fimo ; tn etn ua toccar
fa tto n e , d o t in lui flejjò : coft il Etirare a quafi
incolpando ilg io r n o ,,f/iora , C /c. in quei me*
definii volge t ejclam at ione 3 a quali nafico/km evl e d a la colpa del fv o errore - Et Condune
appre/Jo V irgilio m loco della efilama/ione*
rvejfi tntcrcetsione di dolore r quando d f ie ^
D F L
T H EAT.
»?
' -Fsjeti quid uohii mifcro m ihdfloribus a u fim
'? e rd itu $ ,y liquidi* immifi fantilms apro*. .
XV cjmdi utrfi appare una pura y libera con
fe z io n e y-a ccu fa tio n d d fuo errore, fenda no!
gerla in altrui c'è ri ue'-o ; che il Petrarca *dtrvuc introducendo ri Sonetto p e r la efclamafi ori e , poi che ha rhno/Jo la colpa da fé , y da
ta al tempo , y a d e l i , ritorna ad accujàr pur
fé medefimo ; quando dice ,
'■
O tempo -, o etcì u o h ib d , che fuggendo
In gan n ii ciechi e m iferi m ortali;
O di veloci pia , che vento y serali %
H *r oh e Xpert o uofh’e frodi intendo .
Mae feufo noi <y me s i efio ri premio , y c .
Hora Sign ori , ampif im o campo m i fi para da
van ti , f e tempo fofie di mofirar per quanti m é thodifono introdotte le d ette accufiutoni fiqua-i'
li nonpoffono hauere infegnato i K h e tc rt, per
non effere ficefi tanto al baffo ; y pur' fon ne- '
cefiarij . E t poiché fono conofciuti; danno grate
ccrteTffa a g li Scrittori di non comporre a caf >. Hl fenTfitch'io adduca a ltri efenipi, potete
ben ancor e t edere , che molte altre accujatiom
della maniera della predetta non fono introdotte
per me concitater come le p red e tte , ma per me
quiete y non ejclamanti, come quello pa ir im
pressa il Petrarca
Spmfe amor y d o lo r, cue ir non d eb b i
■ La vita lingua am ata a la m en ta rfi. n '
D otte il me th odo è ta le , che fid a ta m en te m ette
Cerrorem prim i loco; e nel fecóndo tacj*ifati<m ;
deli'errore,: fi come fece>Cice. f e n d e n d o ad Ar-.y
h4
D l S, ì H
M A T
■T#m> ; dicendo ♦ Nasw p rjcr /ex noi w/7«7 iW ebat : qvam f i ut efi prom ulgata , laudare, uoluijjèmus .i a v t , ut erat negligentia , neglige
re ; nocere omnino n&hfo-noìy p o tm ffet.. B se
■miti primum non modo ccjfilivm d tf v it.,f e d
M Ìam ohfu i t c o t t i inqtiftm fitim ns in veflitu
mutando , in popolo rogando \ & c . Benche sa ancor di f a r mentiva d e g li errori, m a in
quella d el ¥ et r. fegu e un a g e n iti confolatione j» ,
pur rivolta in lui mede fim o . Scrivendo nondimeno Qic. a Terentia nel quartodeam o delle
fam igli a r i , dtfirugge nel primo loco la confo!un vite offerta a Im da<T erentia\e accufa fe me .
defimo per fitr m aggiore il fino cordoglioij \ y
pbr muovere m aggiormente ,d ;c e cofi. Quae*
fo n t tv fc r ib ts ìfa to fa £ la putarem ' f errem pav
■lofacilius : fe d omnia fu n t mea culpa cotntnifi
f a x quod ah qs me amari p v ta h a m , qui invi r
dehant. Crc. Co fi D idem e appreffo Virg. uolen*
doft ac enfiar } f i lena nel primo loco tu tte le v ie
d i poter fi confo l a r , quando di ce. • ' (priores
lie ti quid agam ? rurfium ne procos in ifit
Experiar ? gyc.
Ma il Petr. udendo in ogni modo la confolatio
ne f i la riferha d id rie lo nel Spn. d i siopra mo.fir o . iquai configli non poffono effer conferitati3
fienon infume co i detti. E t q velyche hobliam o
detto della prima f e c i e della accufitiione, fut
detto ancora dell'altre: chehor l'intento m io
n o » è di tra tta re di quefia a r te , ma di, fitr.là
probabile appreffo di V Signorie. Et certo,Sip o r i p tlli,c h e « rid o n o , «bt. Q km ia c r £ g !£ fe „
D E L
T H E A T.
t;
flf/fìi p f i v ia di precetti a lti (limi.: molto s'in ^ ^ ! m o 7 f a ^ c f i e f ^ e g g m T t n i m a E.pi. che egli
feriti e a i Attico ^ qùejìe-parole. ' N ttn cn eg ligeriti àm m ea c o g m fce .. D e g lo ria lihrhm ad te
m i f i j f f a / i n eo fio c m fu m i d e f i , 'q u c d jn A c c f a r f t i c f t n t i o 'f f d f a e t i i F oh èam rem ,<juod
bal>eo'voltimeli proheriiforum. e x eo eligere, fo
lco , eviri aliquod firig f am a in fìttiti, fa c i L e quali paròle dfatyà ad in te n d e re fieli? Cic. fi
■jehéfje a p r i f f a *
^ f i e 7 c o ) m c i m m i f ^ f i i .i f a e t o r i ^ Trovo att
e r r a i che'l boccaccio cadde i t i una replicatione ^ oef 9ccf i
r>
■'* r r
1
*’■m ° ne"*
, d un A n e m ie , fi comefece C t:. fo r fè per la m e- re p lica dì
defimo, cazione fimperaci, e d proemio , ch'e»Uvu Fr° nev®
~ ..
%T " « ' i n
•
•
S\.n*»o.
f a n c lh tx . Novella della prim a g io r n a ta 3 e d
mede fim o con quello della prim a novella della
fe fla giornata : ilquale incomincia , Come n f
lucidi feretrifono le s ì eli e ornamento del cielo ,
Cric. O r se le particolàri m aterie delle m edefim e fi e r i e fin o conofciute p erfin o a q u i , tanfo
d m e rfi per quelle poche roso, che babbiame det
to ; quanto più apparrebbono > s e bora io m o J ìr a f i tu tte quelle cof i y che le pofieno fa r d f i
fe re n ti 1 una d a ll al tra 1 Jmperuche ( f i conte
g ià pochi gio rn i io d i f i al m olto M ag, O* d o ttifi. Mori fin i , giovane di ta n ta fper.anxa diquanto f a alcun altro f i o pari a n o jìri g io rn i ,
CXf i come più fia te ho moftro a l molto M agni
fico & g iu d ic iv fi Sig mio te . H iercn im o H o Uno ) ìb non tietrg.cL.le roso coso p e r la tria deità n
.- Idee di H erm ogene : ilquale in eiafcvn a confili ^
C lic '/”
^mSS^ffifSaénU^TptìrjwUi^mcerocheio
* * nonno dalle forme g iù m a terie , ma dalle m a-
. . . » rftf. sU««
«
I
t/5T
la r /1 de* quali habbtamo ragionato, ef
} m a te rie, fanno <he dalorv io p a fii*
a loro pertin en ti. Et l a , dotte H erm ogene con
•fiderà le fo rm e quafi levate dalle m aterie ^cofe
come da loro noi haueftm o d a andare alle m a tir te non infognate da lui y
mmmmmtf&tSLSmifL *
l
pùerca^.
to quante^ cùlthoffiu» uem re M t m t * d a t i t i
>£prine j Q* trono ( fi come nelle orationi mie
i Latine ho d if f u ta to ) non pur otto cofe, come
ferine Hermogene Lina quattordici efler quelle,
:jf lje ^ o f]o n q ^ ù r £ u ^ ^ fic tir qualunque m a (^ t m a - ™ y -fono quell e , l tr o u m * lep d feto n ti
informare
a ff im i, le tue del dir* ^glfargom eiui, l'or»na mate dine ,l e parole-, le loro f ig u r e , i m em b ri, ilq ***-•
g a m i, le com pofitioni, g li efiremi , i numeri.,
y le barmonie : lequai tu tte a fu oi lochi / allo
cate,in eufemia m ateria particolare vengono a
Uberar lo Scrittor della d iffi cult à delle m iftn n
>d* Hermogene : imperoche ancor che nell'Imomo fi ano occhi & p ied i; f i come fono occhi &
- p e d i n eg li anim ali bruti ;, y intelletto , fi co
irne è ancor nell'angelo , y altreutofc fim fo ,
p e r le q u A tin eiafeuno individuo d i cìafcuna
-fp e c tt fottopofia a lt a n im a le, pò f i amo trottar
t meficelate molte, cofe,'che m m o lti dtnerfifoniti
p è b' r n H a t .
a? i
fu tfic o m e ad uno V itto r e v o le n d o dipingerà. >
alcuno individuo , farebbe cofa più facile-di fa*
pere, quanti & quali m em bri babbi ano a d ef i
fere fin uriòlfuomo, mentre lo uuol dipin gere,et
~lrtqualr loehilTaWiano a ri trottar fi del corpo>
s c iita andare mendicitndo la fim ilitu d m t del*
tocchio.da uno anim ai bruto, t t d*un*altro, m etrt
‘bro d*urialtro d i dm erfa \/pecte:: x f f hono tlli- v
mato più c om m o d o ild a r# al m o t^ f a m a te r u T
^ V ed e te adunque Signori , f e la patitone g f
V*fotomattuo methodo faceano* di Jopra tante*
'differente una aceufittion dall'altra ; che cosi*
atterrebbe ■, iVo- piglia/?* fa tica di mofirar. la
'■d f e r e n t i a per tnt te le quattordici parti t c b t
poffimo informare una matertaidellequai ,-bencbefpe/Jbalcune faranno in p iù materie fim ili ;
f i come g li acci)*, il nafio , d'orecchie fim&con*
\
ftm tlt m Molti individui a n im a ti: pur , fi come f [ j
Meglio in ciafcun Individuo farebbe conofciuto; ... A.,
• qua ndo tu tte le p a rti fufferofinfm ne con lu i,
ancor che nthaueffe m olte fim ili a d altrui: cofi
a me p a r , che più commodo ci fa rà il poter ve
der etafeuna particolare m ateria con tu tte quel
le p ari*, chela inform ano, che d i vederci da*
vanti m olti occhi & m olti nafi me/colati nifie*
m e ; iquah a diuerfi d i diucrfe fp e tie apparten
gono ; onero a r te , che infegnaffe cofi fa tto m e *
fcolamento ilaqu a ln o n d im en o fotÀ cpnfirua*
ta nel loco, doue tratterò deltó id e # della ora*
tum* ,f m \a - g u a fia r e f ordm edp H ertm g em ,,
ò
q
i
I
il.
D J S.
I N
M A T.
eh#certam ente è marauigliofo
jLumiuhdbLMtil^tà -n o n delladegl
to condi a m u d ^ l t m u fiì ^ A é e e f i i h a b - :
bi^
qtK e w jid ite delle ragioni mie. E ffa c e /y
s e D io clxio m n f f i t cofiful p a rtire ,
qwnse
ch iam ato, ch'io monti a.xauallo; ch'io p u ^ a
•lungo difenderei i mieipenfieri; de' quali bufit%a parte Vofire Signorie hanno ancor fentito
d a lli lingua m ia ; dalla quale u orrei che v d tfi
J'ero ancora quejh più to fio , che dalla p en n a ..
lm per oche, ne il tempo m i concede, ne la eferc i t a t i o n e ch'io pojfa mofirar loro in quejìi pocìn fig li. tu tto q u e f c b la vorrei,con più purga
t a lingua j clliquefi a. non'farà . Etfnupero^
'ancora clie n o n m fia c v q M ffcr/uerep)^\[uefhi^
^
^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ru e g g o c h c an oor in quefia purifUrna, & ,, uolgar ifhma m a
niera dydurepotrei fa r meglio,* ;q#aWo m i se/sa
/ e conceduto fu u tempo . . Md * quale^ellafi f i a ,
V . Signorie l'hanno f a tj /t efi'er. talc.y eonflringendonn , che in ogni modo io h,abbia a f f id a r
loro alcuna delle ragion m i e. , Vostre Si>. ddurs
ique attenderanno a quel, eh'io n pirei dire> noi»
alle parole ; con Icqualiiodico,. ;£ p , Je fa ra n
no, degne quefle carte de g h occh iy.g y, d e g li
orecchi d i .M o/ifi..3E JvlB ^ i;facciano s preg o ) la m ia scusa r ^ M ic a n f ia fu a S . ch'to nelle
; ' f l r e tte f f e di fi poco t^mpo, py col capo a m jl le,<ofey n o /ilh o potuto far,m egjio, ne rimaner*
m i di fare.ys'ionuleua fa tic a r e a V. Signorie :
m
\
\
D E 'L v T J-T E A T . '
17
OrmTJara1^
altro affare m t chiami a fe , per fa tic a re p a r ti- ;
colarmene e a V . S. m on/i» T rifatte ; g ra n d e or* v rr ifo n '
namento dei nofiro fecola ; 'olla cajhpim a m c n -£ * hrielH,
te dei. quale Apollo col conferii intento delle g f f ntik0*
>1 usa /;a rutto il thè foro delle bellezze della L a -'
im a y della V dlgar lingua affidato: y interi ^
do aprir peranentnra ancora meglio , ch'io n o n i
ho fa tto di fep ra , la m a c in o tengo , im pero
che per unacotal accennata a ha fia n c a , fto p n rò in parte il penfierm io {oprala dim anda 3 che-.
V . S. Wi h a fa tto ; ci ce (opragli f r i t t i del P e~
tr a re a . E t benché ijv e l, ch'io dimofìrero . i>a->
rerq ynottTnfflfSc^^per non cfjere ìla to nella,
conjiderattone -d eli e g e n ti, ne peranentnra m
Poeta : non d im e n o i n o m
quella del m e d i fimo ►
pur nero , wtt r.niso ne ce(fa rio , che n o n p m tfi*
fere a ltrim enti; im Piroche là r im à n délT A ri*
prim a ch'io uenga a '"quello', ctiio pYc*
pongo,darò una fim ilitn d ìn e in una dellequabtordi ci parti tocche, d i fo p ra .: cioè in q uella,
ch'io d ù a m y o m j io ffù ^ ^ ;
d'intorno al Japer preporre, pofponc , y .
terporre le paro le, perche Labbiano propvrtio-
Tornare <U
> Ìo^tl£uM ìM M £fl< y‘e rsa/ltf prò tart/oneV ella
7 trouana anim ata J a
B™/? ,
/
/ /
qm D 'T S ; ' F N
M A T.
♦^nrasersartionenon poteva f a r [enfia Anim a,
coni io t i f i fa tenere in proportion g r a ta aWo*
r tc c h io ju tn je p a r th jclie.P tlfm SM illjr
■aejftto humana^. proponendo, poffonendo , &
interponendo . Lequai parole fubito , che fono
mefje nella loro proporcene, fi truttano jo tto d al
trm gron ontta
p ro ve rem o q u ejìa u n c a n ^ f^ rff^ e T fx fra rc a ,
sarti da fole tre p a ro le. CX dico -chcl Jterfo di
undicifillahe t se dee effer fa tto -da tre parole
fole ; conuien di n e c e fità la , dove /fi adopera
iU in q u e ,il q u a ttro , C r ii d u i, che Im m del
lo parole fia d i cinque fillahe,!altra d i quattro,
la h r a d t due ^perche cinque, quattro & due,
fanno undici * CX- fe per ragion d i A rithm etica
vogliamo trovar quante^prepofiiiom, p o fp o fi
è to n i, C r w terpojìtiom poffano fa r ; troverem o
riho non ne pofilino fa r piti difeù»vJmpero', che.
Versi neleol cinque a va n ti fanno q u efk fi^ & in tlh tq u d L
paròfe f u rnifura meffe il Poeta quelle parole.
n. *
E)con Ero' Soavemente fòfiirandom ouei
**'
0 “S'1 4-che tegono in proportion queflo uerfo.
M anti chif im o fabro Siciliano,
4
E t col quattro avanti fanno medefinutmente
due uarietà 4 . j. i. 0 **4 . u p parimente eoi
due avanti fanno quefle due 1 . f. 4 . qual e quel
nerfo , si c o m e n tg h antichi tefìi i forteto.
c
Arbor uittorw ja triunjale :
■
È r i 4 . 5 %dehjuale al prefenle non m i [occorre
efempio « Ma s e lo lm u efi meco t l libro -, dove
D * V
T H E A T,
j*
feno, fla te g ià per. me ordinate que fle fatich e
( ilqual è a l prefente inm ano d e l mollo Illu/L
S/g. Conte Claudio Hannone ornamento d e lla }
nobiltà di queflo fecola ) farei. vedere a V. 5, '
non folam ente quante, f a t e habbia cantato i l Pe f
trarca in una m edefm a m i fu ra m a quale egh,
o più lofio il fuo buon orecchio, ha cantato ; &
quale m i fu ra (an cor th è dalla necefiità Ari*
thm etica fujjè ricettata j o d a D ante o da altro
antico fu jfe fiata, gm flam entem effa m te flu ra )
il fino buon giudi ciò pi» forfè natu rai-, che arti-;
ficiofo Jrabhut fu g g ito • y - q n e l , che giudico
delV etrarca y 'intendo moflrare un giorno d i
V irgilio ; y forfè altra c o s a - Laqual perche.
farebbe incredibile, paffo al prefente con fi
lenti o * Ut.tanto più, che io non ho parlato qua
fio poco della comparatione, pervoler d ir d i le i
-al prefente : m a per f a r m eglio fe n tire a Vè
-che tu tta l'arte m ia è governata dalla necefiità ,
y dalla baflan \a : y quello. ,, che habbiam*
'dette dall'antippr, po/porre , y s n te r p o r delle >.
parole , per frno^L tanto- num ero, oltre alqual\
non f i può gire^uoglioehe fia detto ancor p e r
la quantità, baftante dalle m aterie p a rtico la ri,
Eccowi perche noi ì)abbiamo parlato delle fp ecie.
delìaccufatione : Lequali finalmente nolendo
noi riducer per tu tte le fatiche a d u i fo li capì :,
cioè, al bene y al m ale: entrar anno nella p a r te .
del male con le loro difefe, dellequali quella che ;
uien nel fo r o , talhor concede inule un modo il
f i t t o : f i come credo faccia Cicerone nella oratio n pro C. RabtrtoFofihumioxon deprecatio-,
£
tifi
3*
D i sv ; $
‘,m A'Tvsa;
n e : T d h o r fid ic è ,h ó n folam tntenon hau er
f d t ó f a h i d ì V fiM T fM d ìo l^ h iifà fa d A lo c ò }7
dò tìeil 'm a lfa fa titi ftyofàèfrcdó’th fa tila Pro
S y tld d ìitd iC e s , fa i* q u e lla prò 9èfiòàXòfft'b*'1*
&■ tA h o rn o n fi n rg d fa eH fa tttiiib n fiafeguià*
t f t ma notrpèri’t i^ f a fix f fó tà ifà U if ttiìW è fa ’^'
nella oratiort pro Cluentio: nella qttal m fifìe g a , '
thè Opiand o n o n fia morto : ttid ben nega che
f a rri»rtò d i uenem m in ifiràtòda CVàerìiiò [ ti r i
fig li a fro ; a i f i j più tofio d a altra infirititsaV*
onerofa r [Celerità d e 'd o m è flk i. -fcstncjuèìlcf
prò Clìhritio hi abitò s n ò rin fa a tiièfa fa u d k ì< i\
m n-fia f f a tb tc tr o tto , m a non é n ftd titr d 'id ixCliientfo t dhXt Càitquelli d ì Ópi.tftìcti. 'iS è f if
Uolèffè riducerè tfa e fìfa à p ì tu tte hoìràtìom di
[enfine, tiretebb e'fottò fate fio capo antior qUèltri
pro Sestio : d o t i n o t i f k ' ^ i effindo'T rib ù -,
n o , egli nonfia tiifu io à rn iA o } f a c o n f a eftdìti'
nel fo r o . Beng li nega s c h i f b i t i i i t i t p f t r
uiolehìta d ia Kep. 'ma'folo aètibftixfiofèffe d m A
m ini fira re il mafaflrato fitto, & difèrifìcrfi d a ll
la fattìvn e C loelia h .t, da lla fa a leg ia era Tlatò
fe r ito . N e farebbe lontana da qttefio capo quel'
la prò Li Vlaccò : doue non nega de* taglion i’
impofh alla c ittà : ma ciò batter fa tto per fo flener 1‘a r m a ta , non per proprio com m òdo. & q u e i, ch'io dico dellè Ò ràtiom fopra 'addotte,
fià detto di tutte fe altre d i C icèrone,& di De-r
mofihene : lefa à lì (ertam ente f i mctterebbonv
f i t t o pochi capii E t cò/ì p e r ii loro ordine fi tro
tterebbe quafi im a necefiltri a b ifid i f ia . per lifqu a l rion potrebbe tin ir c a f o a, noi d a effert'
tra tta to
TTX ' % " ' T
H E A Te
jj
trattato nel foro*, che non hauoffc t r e , quattri*
cinque.,
tallxor dieci a p p o g g i, ta m ii ,tu tti
rmrarebbono un fin ca m a f i uedrebbono tr a tta *
ti per alcune dinerfe u ie , per la diuerfità d e g li
accidcnti.de*quali l’uno al cafo nofiro. fa r ebbi
più ccfnfrmile , cbe Cabro , e pii* conforme ;
ci darebbe quafi di mano d i caminar per quelli
rtieàefime uie si*quella, che la fo rtu n a baneffs
mefjo davanti a snoi-,. Ma cofi fa tta necejfitria/
lraftxri\a accennerò peyauentura meglio pocc d f '
f it to : benché io intenda in tutto quefio mìo dfa^.,
fio r fio, ch'io faccio a l prefente , fulam ente.dar#*
«a
'’^ow^jofuiHerm oj?r7!s?W^
'
loco minifi refi infinite parole da poterlo uososaj
ry* f i per la proprietà, come per,la iranfia*
tione; cofi miniflrerà ancora nelle materie dfa
uerfimente. , Varfaremo, ancora delle humane
triJleXfij : cioè delle xompofitioni , che perten-gonio a ficrmere le nofire male fortune : leqttalj rrattan del
nengoriomedefmàmente fotto il capa del wislesanse^™
- & per dar un pòco d'inditio dell'ordine di cofi cu^u”<*‘
fatte triffe%xe;i!qual non altrimenti di necefifa
tà cadefatto tante dincrfità, <& non piti ;fi co
me caggiono le parole per d'efempio dato : dico
per quel poco, che mi ì rimtifo nella memoria ,
• \i
che uolendo Alcunoferiver della'fisa nudaforti*u ‘
J*
7ia, potrebbe trattar di quella talmente; che efa .. .
-la non pafjajfe in oltra fifa,ne in altrui;fi com4
il Vetraria nel Sonettoì s
’ f i t C f i 'vfi
B
V
ti
t r i i s . v i n* m: a- r ;
T )i dì in dì uo cangiando il w fo erl pelo,et in
- quello. Dice fette anni ha g ià rim iro il cieloé
)A e' quali f>er le medefimeuie firm e del f i o m a
le, dal quale egli non fie r a poter lib era rfi. E t,
perche dalla lu n g h e tti del male hafce il f i o
tnaggior dolore; l'uno y l'Altro Sonetto in
troduce con la lungheTffa del tempo .* E t am*
bidue i principi/ fo n tin ti dim tfericurdia , y
Lt parte fig u ra te di defulm o y d i d tfiera ù o t i e . Mae per più dolente methodo tr a tta i l fu è
male in quel Sonetto;
\
O pafìi fiitrfiyV penfieruagiti y p r o n t i , '■
dotte ttoit cerca col paffuto, m a col prefente d efio r pietà in rutti : y nel Sonetto
Pa ffila natit m i a colma d'o b lio .
Sotto la prtfa allegoria della haue , fem plicem en te tra tta coti rnrferattorte l'infelice f l a t a t
f i o : y il methodo , che da capo al Son .piglia
una gran v ita dal nerbo, che fignìficd muto r
quale ha quello ; che incomincia f i
Mouefi il uecchiarel canuto y bianco /
* ’•*
i.
E / bel configito f i in ambedue i lochi : che Int
uendo a parlare hi uno d'nu pellegrino in v ia g
g io , y nell'altro d i mitre in camino ; quafi di
pin ga l'uno y l'altro moto con v e rb i, non pur
figm fi canti m o to , ma. moto nel tempo prefente,
x o l quàl tempo mefte'qvafi davanti a g li occhi
Methodo il moto : (gA/jMiercut^
ffori«r»vc*
T r n ^ tg m t
(oggetti. m u f c h S l Petrarca volendo aumentare il f i o
stridi, l o f i g ra n d e , o per lagrande fim ilitu d ine della mala fortun a, nella qual fi tr in a ia
D E L
Ti H K A TV
aedi uertw y di notte , effóndo nafcofia.qùeU
la sì ella, che fidigovernare t mannari j o per.
*
comparatione, dell'animato *comefa nel vecchia
retto, y nella. uecchiarella. banche t methodi
fa n o diverfi; y in.tanti altrijpchi imitando è
Latini, ,. ne* quali dim.ofira ciafcvno, animai,
perfaticato chefia , effer.piu felice J i Ivi., y .
per tentare ilfe tr . tutte quelle vie delle tratta
ti oni , chef i poffonoftre., aumento ilfu o male,
ancor per:la felicità * che ne ha: alcuno inani
mato . della quale effo e lontano f i comef i nel
Sonetto*„ .*- v, m
., ;•* .> -, „
.: .
Valle,che deiamenti rniei fe piena: ove dice*
Ben riconofcp inopi fu fateforme, .
N on laffo jn m e, che da sì li età vita
m. Sen.ftnoalbergo d'infinita doglia.. . >, > )i N efilamento poptanto accrefcere d dolor nofirth
per trovarci inferiori ad ogni .maniera di cof i
animata, o inanimata diqucfio mondo,ma an
cor alle cofe del ciclo.; comej\ce iLFttr. in quel,
r
Quando veggio dal del fender? Aurora* v
Vofitamo ancor aumentar da quello, che per. nefi
funa cofaUeta ci pofiiam rallegrare ; che cefi
fece il Petr. nelSonetto ...............
.
Zefiro torna;
,
..
e,altrove. n c per feremxi el....; Et Anco ? au
menta da un loco della mifiricqrdia tocco da .
AriJlotfle : U quale, mentre ditnofirusyno cuhor
efferci Tiato levato qualche compenfo della mfa:
la fortnMyquando mccìmnciana a ven ire:'y^
ì trattate nelSott, / , r..rvi •
^
^
r r r s.
i n
m » a~ t
' T utta la rHia fe r ita tu erd e- c ta d e .
" *
& ! » quello
' !\
T empo era homai ditrxm atpace a 0 tregua,.
fZy nel Sonetto.
Tranquillo p o rto . ;
E t tanto fta detto a l prefinte della diuerfità ,
che può pigliare il mal n f tr o , quando lo uorre*
mo aumentare : pèrche voglio dire un poco d i
quella, per laquatla pofiiamo tr a tta r yquando
la vorremo d im in u ire. E t prima fe vorremo.
Jomeffi di diminuire il dvlorc S alcun dannò bàttuto ; po~.
unionista tremo per una w a confutarci da qticflo , che d i
** Ucrlì‘ q u e l, che par male fo g lia m o qualche commodat
Cime fece ilV e tr . in quel So.«' '*: i
Ì m ì foglio accufitce, & hor m i fe u fo .
egr net Sonetto1
' Ferae Tiella :
nel qual poco f it to
Pur m i confila:
o che ne Intimiamo goduto p e r fin , che-ci è sta tò
lecttj.n elS o n etto .
*
‘:fa" \ \
Q jc tl, che e t odor & d i td v rfiin c e a ,
t y anco pofiiamo diminuire il male, col nonno
ter e lontanarci dal uolcr d e 'fa ti. E t cofi f a lt 4
trattarion troutamo in q u el Sonetto* ■
Rotta e l'alta colonna.
«• Ma se coufèntimento e d i d e/lin o .
C i apre ancor ilV e tr. urtaltra m a > laqual e d i
conjolara con alcunjfirf/o d i dimoftrarci lieti:
xjual e quelldnel Sonettonse
* Cefare poi che*l traditor d'Egitto •
E t fi oppone a quella di f i p r a , che mofiraua ,
lire nejfuna cofa lieta ci potetta confiture.. N e
mancherà anco di diminuire tl cordoglio nor
X
J ìr o , per efjer l'infelicità communi ad altrui ;
fi fogge»
^
«'
D E L
T ,H E A T.;
37
y troveremo di cip gentilifim a trattai igne
nel Sonetto.
v Laffiato bai morte fen\a Sole il mondo :
o per trovar locò accommodato a nof r i tamentv
come dice il Pe/r. nel Sonetto, Solo et pèfofo.
o perche col penflerofiamo con la co/a perduta *
Tj di quefie vie fono molte macchie nel Eetr*
quale quella..
Leuommi il mio penflero:
0*7 * -i r. "Sfornami a mente., ■ • y
\
. Miraesjuel cosoeaffianco mio. cor vago.
. Con quejìo mio debole aifeorfofr itto f r i
7fa libri trafitte, noie, laf i o Va
f r e Signorie, pregando quel
„ , v.
.habbiano ad ai&
: tare in tutte le
parti in
formi :et.anco fe lo troveranno <?& 'm perduta Jferan\a, prego l i ' '
. .
diano per f politura
J
il fuoco* f. ■ •.
L
E
T
T
E
M .
G
I V
C
d
i u
A
L
D
I
A
i
O
M IO ;
J>EZ
[
R
l\iypLGIM E
' h
v
o
m
o
a
d
F.R .C H E g ia p c c h ig io f
ni pajjati jofpinto da un
cotale stim olo ardent f i
mo, iof c r f i a V ofira Isa
/«sire , Signoria quanto t
essa m i detta va ;hor la ,
parte ; che e fa mg d i ra
gtim e , mi f a p ig lia rla penna , & per quella,
chieder loro humtlmente perdono,
tn p ivi e
|Lu sa * csa
- Mae,
rytia/;/ o /K jf'a /ii;m e? !^ ^
?
faccia id d io , cl?*ip\poJ[t fo rn ir quefla lettera
J e n \a pa rtir d a in i.: che certo,non faropicciola
èm prefa. E t accipche otterr&'cio da me medefim o io pojjki prepongo in quefla m o n a m anier a d n n o jlr ^ e fa V fifa ^ u J W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ncndo
‘^ ^ 5 a r i I e o K ^ j ^ ^ t ^ m u d ^ tuutmTndoper
U uojlra v irtù Santo . EtTe ragioni, che t i
m ettere nel m e t y } non folam ente farartno f a - ^
p . E L V H V O M -0 A
1) 10 .
-jf
lesa la verità; ma appareccìneranno, aefifi pàr&
tiranno andati a gltocthi di uojha llluflre Signoria t*ngr.dìiMptme ItmegìdUnf f p d ^
tc ^ te m ^ ffc b e fi^ e n tr a ^ n e ^ ^ m e ^ ^ a ì^
Tate aua gloria nofra .. Non sa, sa mài io le
bobina o detto , ofr itto , rre osoer lq operationi oPfT3rif>,
uerfo le anime no/ire. comtcrTde Mdt one ; a ^*ufrc°
t.u iiV ..... jiii"iTTniiTi^rr tMwwiiivWllii>l.!.B<|iiiiiiM
iiirW»'><»l ' sanimi
producere , u nuocere , che chiamiamo altri- .„tk. 4r,
rnenti cóiMcrItone } y talhor tranfito ; cjristre*
quejlo figue la tenga operationdi Dio , che t ti
fffdxrpeffktoj^. prodllice
affr^fTaiamTdmcntre le manda in ijuefo mon^dTTpQt^jmu! atefffmfne'Le'TrmffTa TuFflaefioche non atte n d a m i motìdo^ maa 1S h &
ultimamente, pòi che fono a lui-non più riugl*
te, ma ritornate, efjo le rende Perfette : &*
"ferdffneTrTicoìfèr (cbeeTafeconda operatià*
n e ) pòfiamo noi divenirfa n tiy d iq u e fo -fld _
ménte con V. S. io voglio tener, fagiana mente \
netti p:n fm p lice , y pura-, y commune d
v tutta Italia lingua, ch'io potrò . Incomincian
do adunque duo ; che, fi cóme fono tre corpi d
noi, chiamati da Vlettone i tre uehicolt dell' ani- '
‘'p ì T j i q u a f t i o * ^ ^ •
X^thahlnamo tre anime : dellequah quella che Anima
c lTm f hf
a a ^ o fe fp t- f; ^ p ii'
ì ftorf/p» Jìtpé- tohr.>co-
~tfm e ^ lflo /y ^ g a P ^ to n ^ n e m ^
T
a
c
o
l o
t ^
ri ore ; da Danni lume, mentreaice, In lumi- mltEVaa?
ine tue mdebimm lumen 3i y 'con D a vid è con* tri,
venuto Pitilogora m quel celebrato precettò ,
•»tm o dél^eo jhìfffmìne. Uqni:mdxàt *ytffift**
/
'■
■i.
.
\
'
•* ••
•
•
K\X T H A A D H L
V
:
i
f» *'
I U V* u s a .
.;.
lume da Arnseo/ele e clnurnato intelletto agent ei.
e^T e quell'muco occhio , per ilqiud- tu tta tre U
foreile chiariate G orgoni, veg g o n o , fecondo i
T he off vi Simbolici ‘ & percb e. I j ^ f ^ ^ d i c e : ,
c h e f e m i et appoggiamo a quefla mente ■$ p e rii
raggio di Dio , che m quello è , tu f fa n o ilifendee tufi^ le co/èfrefen u , pliliale , & che bari*
n^TuPn/rei( Tu/te le i
^TefrTTTFuolnar Paeta la chiama hor [a ie [ira ,
ha r haic ^ i ^ . ^fe^ ffuofm dc/m feiu f^ T be^ per
la m a U e Jua baue/Jc veduto,quelle fui tif o n i j
d ite .
, Standomi uhgìorno filo a la fe n e fr a ,
Onde cofe uedea tante c y fi nove ,
E/ altro ve, f i / g v ,, v
;. .
v Coso colei, pereiIto fon m prigione ,
Stando fi a d un balcone,
,, %
> Che Ju f il a a fuoi dì cofa perfetta r
V / il vero,che altrove h a f g in f a t t i Òdi fe n e fra
m ateriale, come nel principio d i quel Sonetto
Jo hamo feriip r e ni odip la f e n e f r a .
YAa per m aterial jenefi; a non bruirebbe potuto'
ited trle co/e, che haueano a v en ire , come pre*
f cntc /è * ^ n J > ^ U jm n t^ a q H 4 l
ì i s ^ B s Vietino f o n c iS e r y t
rf peccato , ne VenaTrlaTec^^^
tionnle et
animale m uovale : la te rg a , che e tu tta uerjoal mondo,
* rì^domT!^brjmTuen<^^
le ; dotte Stanno tu tte le pacioni ; & non meno
*ajfe hejftt fiche a g lih u o m n n e cómrtitme . D i
qttefta te r ty intefi Chri/ìo,quando dtjfe. T r i
s t o efi anim a mea ufque ad m ortem . perche m
nejfuna
\ D E L L* H V O M O A D I O .
41
rcfjùna delle altre due futi) cader trijìefifia fife
Mira pafsione. T-ffendo adunque i yanimet r
ttonale collocata triu a m en t a ^ c r l a p a rfe d el- v
t'animale, che Mose chiama am m ìiuiueiiìevel— \
la può accompagnar f i , o.con la p r ith d -, 0 con la'-y.
te r f a ; Nenia erimi potejl dnobns dom i ni s f r
uire , Vperche Dio d ifferti X x x . deli Exodo. }
non uulelm me homo & r im e t. non vedrà 3
dice il Signore l'Intorno me ; cioè per la m en te, •
CX irifieme ancor v i ver a ; cioè attenderà al! arti K
mal chiamato anima v iv e n te . Se adunque ella
s'accompagna con l'anim ale, dove regna f appe
tito con le p a fìo n i ; efj'a ditùen peccatrice . md\
f e piglia per compagna la m en te, diventa d x K
bene, qx t utta d ivin a : & cofi la parte d e lta minale abanaonata muore, a ella guai m o r te m uejlraafjcon ditaejì C um C hriflo } & D a v id , *
Ereti ofa in conf i f i n D omini mori fanOornm*
e in st FA lesa Chriflo medefimon quella alluffa
Seguendo adu-n
*
v>' gite t intento mio d ic o , che Plafone nel libro d e
I
Sane//tate , chiaramente cri?nc(ìra, chef i r la RjnnV*
fTtondToperati0n di Diosa che c rivolgimento , mento c
0 conuerfione ; 0 tronfi tv,\ che d ir no fiu m i 0) noi sa, Ventr~
^o^/^n^c^egd^Sgnt^perchese mentre Dio a
rivolge dal m ondo a Ini ^ m ì ^ ^ f l M l f imer^ol
con\m fm m ) ; almeno tn q v c T tn v U o p o fi
efier cw a m a tifa n ti, & t l dettonojìroconfinitiI
|
! - X /mA!crr
0 Signora-diurna, e quella Europa p m a i T d d
4» v K T T E x A D E I J UV.
ehi tote»»Jaqual non tiene il utfo diriffa to a l tèrm ine a
•he ^ssrisaal^na/e il Tauro la p o r ta , cioè al mondo ; ma
tiene il uifo conucrfo al termine , dal quale è
p o r ta ta , cioe a D /o .
^ ^ n o n ^ m e f^ W e ^ ^ p ^ tS n a ^ j^ ^ ^ h a ~X
^ p e ^ c f^ T x m a fe 'fn ttfe fT ^
ittc /d /q u e ffjotrque lle . quando l'anima f i f a
per la conuerfione compagna deliam
ente, f i d i---—
I f r manda so la tnenteV ra a f e ? anim a , e f e Tarn*
k
m a tira d f e la ln e n te , g y tonjeguèntemente
qvetd n u n o raggio r che in lei è, & perche diff i la conuerfione filler ififfamata^arutor t ranfit o i
f i legge* Tranfiuit A braham àdO eum : ( y a n c o fi legge jD eus tranfiuHfitper Mofen, g y ap*
p r e jjo ta lìm . nella C àhiiln fi'erjona c t f p J o f
~tranfiui a d t e , ejy tranfmi Jupcr t e . iq v a lilo tfh danno ad in ten d er, che ejjèndo dallafarte,.
^ d ettd jn en fT , o~di D iòfaT dm krjT m efffd .m ih
dim im tn fo g n o felle dncoridalU p a rtèd e tta m m a (ìa il confentim ento, & l'uno f & l'a f tr f A
perni orlo d i fot]JaggioflfF n ón di fe r m e lffa t
<
•tariffi * ^ onaof ta c<*Ja' dìe Tranfire Meneo da D io d i*
m o\
Thuomo, o daltbuorno a Dio : & Q uiefcere ,
lucro M anere, uicnelLt Dio alfolofino figliuo
l o , » in v e r o , quando lo ffiiritod* D io u ie n e ’
a noi per rivolgerci a lui ; g y , quando noi nel
medeftmo tem po lo confortiamo, ciò fi f a per
t ranfito , c y pei p afi aggio . Venne lo ffirito di
Ifio a M o ft, m a I a/>o,ey non tu rimafe, quan
do ejfo pere offi la p ie tr a . V enne ad Aaron *
DELL*
H.V O M O
A DIO ;
ma {'ubandone nel?adoration del V itello . D?rem o-per anentur a , che dim ofirafjein ifitsa ,,
battendo ej]o mede fimo lafciato f r i t t o ; immun
dus lab ijs ego fum . citerò nel buon Profeta D d m d , leggendo noi n e g lig e r itti fu o i ; fpiritum ,.
fan cium tuum ne auferas a m e * Aggfitngiam° ,jb e P a fg u a fnhebreo f o n a T ra n fito ,- y
ancfiqSeJ/o, che n e ^ ffec e tn fc (f d lè d e )m m an
** '
g ì or dell'agnello., contenne ancor q uèfio , che f i
mangi a fe f i n / a in d u g io ; perche battendo a
fa r tranfito ìo J fin to dx D io , jà b ifo g n o , che
noi lo prendiamo to fo ; & che nel riceverlo note
fìam o negligenti. C o n quefii ivoghi ancor fa•
quello nel Genefi ; dotte f i Ugge , che Adam nei
tn e \o giorno nel giardino vide Dio carninani e ,
f e ben m i ricordo, che qui non ho libri : y non
lo v id e ferm o.. f e r m e ^ ^ M o ^ J i ffio qon
ferm ò -, ne fe r m a , ne ferm erà m aifen onfopra'lD io douc
fiio fighucTo y fecondo il tefitrnomo d i f i l l a ,
qual dice fi Egredietur uirga de radice le jjifi..
y f i o s .d e radice eius afeendet, y req u iefeetfa,
per eum jp iritu s D o m in i. Et d i quello d i d a * ;
u an n i, q u ia m a i fyiritum Dei defendentem
y m a n en ttm fu p er eu m , teflimom um perh i*
b u i , quia hicfilrns D et efi . y D a vid in perf i n d di Dio ver f i i l fig liu o lo , tu es facerdos in
*> ..
x ttr n n m j ne farebbe tn eterno , f i l o f i n t o dò
D io non fo/Jefim pre p er dimorare in lui, per*
'
che dice Paulo , y p l a c u i t in eo omnem plcné*
tinim em inhabitare 1 H abita, du n q u e, y a r i mane nel fole figliuolo tu tta la d im n a pìenc\fi,
•vi r fiafififiducr. da Iut a partirfem giamaU
I
44 L E T T E R A D E £ R IV :
Ttcod fatto fransero sa twlarxQxoLiuto dqjqfa^
blko rfuontco ,jl^ lToinego^
mapercheeptunc to ; non uet!e VodTwTjfre
Signoria, lagnai /tede tutte ! altre belle cof'e ;>
che Virgilio finge, ciré Cria Sibilla. C? Hc/e-f
no danno nfj-on/o ad Enea non legati, mafc id -k
ti ; Cr non dimeno f a , che fa Sileno, Cf Pro
teo non haurebbono rijfojìo, [non ledati ? il-v
qual legamento rifjronde in alcuno rnoaTTfiuei*
utrbt Manere C? Qjtiefctre ; f f d ngp
gato fa col ^crhof^ctfajre^ perche lo ffiritbdfr
D/oliMrrfifana nelU$f!!nla ; arifjflibito, gjjgv
X rfja piena di dittin furore bauea vaticinatog li <
|
tg ^ ria n te f^ ^ T n ^ ^ ^ ^ ^ h ^ b n o to d iD r^
I
J T J a f a m T ^ io le f a preferite , manif'eflero
nella m a n iera , ch'io [intendo , & parimente^
i l legamento . H o parlato per fino a q u ìd e llé
tona erfone ajfai abondantemente, 1 1 perche cl-la f a chiamata tra n fto , & d ì fip r a ancor d o
me Dio la f a , & come pufsiamo divenir fin ti r
E e fa d e d im o f ria
mo in quante maniere Diofaccia la coun erfone
f»!o fnquA l>re^ettet > & Per *ìH/U me\ i p o fiarno noi con■*■'
*i nu>dl rtfe n tir e . Dio rivolge talhor in gnefio mondo là.
Ia * perfètta , fe r ifa lafiiarla mai accompagnar e
allapparte animale: come r in offe la Vergine ma
dre e G iouannì. Riuvige ancor qu elli, che pòirehhono efjèrc s ia ti comparili del?animale ,
con la legge e Col Vaug eìo^ImiAi^mmLAmmAL
f on
>ijj
f a v cf d ìlc n° f di quefio mon~
D E U ’H -V O M O A D I O ..
4 ,-.
‘I p v t u U u v d t M m m m à i m s s
crejcmwi/o,
MAX luu t
>{/, .jQ erauL ddlaX »*.
f f t t r i u . flaa m k i A O c w n r t
gentil maniera di conutrfunge r quando Dio, cr_
rivolge a fe
Il per .
che é da fa p cr.che.c Jd ^ ^ " 5j o 7rfante
rone^^T
.^Irgnj^tr
.ette
cofmficn f i Im %
(fow cn^preffda alcuna 'rieie dei te ]je/!e? V eTT
mmmmmmmmmArn
wmmmmmmmmm mmmMfkrnmmm
rute letam o cm
{s; ionie
^ i ^ u S a ^ f f e ^ ^ ^ u t f f e d ì cefi. C rb e m ix eD a n
W r o fa m e y t e 7?t?r e» a S n S S fl moftfo t e ffe tt? ,^
o^ej^^^^jCt^joTTTps '/^"sj'cl/O:<T;, c'/c ;leg g ia m o -.
.
nfc% jrrj q u a lì/0cDe //^O
Cr^r1^
si del T etrarca. , Oue dice .
,, H c r ti filìm a a piti beata fp e n e ,. .. ..- * «ai
..M iraiufol crei 3 effe tif im lu e in to n tì ,; •.
4. Jmmortal 0> adorno*.., :,<■.*; ’,>* .
-•■•>
,Md delie belleZZe de «U btm o jiL co rpi, & del.*,
jB B jg
^ffSTIx^oxHano m lui,& • a d /h o confcnfm enio. inquella Cannone,
,
•
•v G entil jn ia d o n n a iatteggio
'N el mouer d F u o firi occhi tm dolce lu m e p
., Che m i moflra Ut^ ni a , cìial ci el conduce. etc.^
X y poco f i t t o
- ^
^
. CZneJlo Ua.uiJla y cl} a b e n ,fa r m 'induce
apf
L r T T E R A D K £■ R I V ;
• ' • E t che m i fcorge al gloriofo fin e ;
* f ij^ jìc t foU
m'p llontang ^
y ■ r^^fa^affT efegue.
Io penso , se la sioso ,
Ornic i motor eterno de le s ielle
* D efilo moflr.tr del fu o lavoro in te r r a ,
Sort Valtre opre s i belle ;
■Aprafi la fungion , ouVo san ch/usa.
y benché tn piti altri lochi babbitt detto il m edefnno ; pur p iv chiaramente nella cawrtme,
Quell antico mio dolce empio Signore .
M entre cofi f a dire ad amore
• Aneor ( y quejìo è quel,che tutto a v a n za )
D a uólar fopra'l d e l g li batte a dato ali
V erte cofe m o rta li,
Chefonfcala al Eattcr , chi ben refiima: ■
Che mirando et benfisa, quante, y quali
T.ran uirtutt in quellafua ffe ra n fa ,
■
*.
'D'una in altra femhtauffa
C
"’
Potea leuarft a l'alta cagion prima’.
-;
D/ fim i tariffa adunque in femiàanffd,'ctoè di
ftmthtudine m ftmihtudnie. Poteu(t il Poeta /
ionfentir per il rivolgimento a Dio, perch^oju
quel rtHvlpw erao chjijflm ^ceu^^
sentendo a
Potetti
amrmL .jgr
t/rrell, ffb
.Chiela
' j^ H ^ a u ffj
'ttafdelfAngelo
finalmente per quella a m o rc l^ m ^ D fiòuMa
S ® satirone V
* : rM>m * **
LtifJ'o m e , ch'io non fo iti qual parte pieghit
dim ojira il tra n fito , y la poca fe r m e \fia , che
m lui era d i paffute dalla belteffjfa d e l corpo , a
f
t •
D E L L* H V O M O A ■-D I O .
A?
quella dell'anima : aìU qtial, dove è p iv u e r»
Jpi end or, che nel corpo non p affava tro p p o ^ cr
ucche f i Inficiava abbagliar dalla ù elle/fifa cor
porale . Dice adunque coft.
T u tte le ccfie , di che! mende è adorno, .
\ f a r buone di man dai majìro eterno
Ma me , che coso adentro non di [cerno , '
KhbiigJìa ri hel - che n n fi mofhra intorno.. *
Et y 5*al itero fplendor g ia m a i ritorno y
L'occhio rion ptio sìa r jerm o .
^
Vut la fu a propria colpa & c .
,
r Effondo adunque, o [ingoiar d o n n a , unico rifa
ntiofatmento a Dio , o fola ai mondo , a cui io
cpnjqito , mentre mi rivo lg ete, tanto e del tie
ne di D io , & n d corpo di Voflra ìlluft. Signo
ria , & ’nella fina uittoriofifiima anim a ; perche
non m i pofjo io chiamar Santo ? Certo f a w n
pur fon fin ito , ma fa n ti f i m o . Jdt , f e non è in
me quella fcrm eìffia d i dim orar n ellajbelle^A
fim pre dei?anim a, ancora nel Tetr, non f h .
. B e r uerigo a dimoflrar per guai m e \i .noi pof- Ee? gusS
^ [a m o con] 'entir e . ^ ^ sI/^ svW o^ ocen se^ t/re^ ‘f f j poisf
partendofi dalla fi8$<r*vr S
cQ»*ÌVftti n e : ne può contemplar, (e non ani iene p enfiofo t, D ì o .
. Tre*3/ventarfermamente fino fienjofoffenon p e r•
iln u z o della mainiiconui. D i qtù 7iuvenne,che
j l Tetra. ìiattem fofanTgja la fina d orindeom e r
fa a Dio , in quelnerfo,
v •' seoso ......
, Le Chiome a [À u ra Jparfe * & le iU m c r fit
In dietro veggio; coso afjòmigUandola ad.E *
rop.t , la indm ejh nprepenfofti'.: tome m .-gstd
»
-48
& / Ù S J r 'N
q n tr f e , "• > ; -
M A T.
*•• . .;•■• ***•, ■ • -I 1
Q u a!dolcelffq è ne Jit Tingion-acerba ■V e d erla irfilh co i petifierJhoi htfieme^ - 'v
y in quello ' ■ *• ’
.\
?n. •
L ied fie ri, y fe lic i , cnr bennate herbe, '•
Che Madonna penfàlifio premer J o l e >
fjr in p/u Irllri lochi. Ltt /W uce ancor trioni» *
Malinco + conica nella canyon,
nia Indot-Tacer non pollo,
ta dui re 1tr. nellam que uerfir . ; . >1 *
<>.
.
’
- '
w,
' fiu uòsa. I>Wi bel D iamante quadro, ey m a i riori f i timo
\ V f f i vedetta m ni elfo un foggio altero ;
s * Oue fola Jcdea la bella D onno *>
■■■* **
l>inan<s mtacolonna
■ . \ 11 ^ ** e > * »
* C riJ b tllm H y y im entro ogni p enferò' & c f
laqual donna dentro della to rre t l'anima <U
Madonna Laura dentro del c o rp T ^ y T a u a n tT *
f t haueagià fermato il [angue di calido in fie d
do > y d i httmtdo infecto
la dettafermeX.
rqnefigmficala al mio gindicioper la figu ra del
‘b
hi colonna : come altrove % ■ <• '•*> v. i- v'*^ **•
fq I> W beldtajf'ro era ini una colonna. f*4‘ ■ t •
orniamo manineonici,
aw er di neve non tocca per m oU tannidal Sole:
b iqual tanto m ene cendenfandoftta poco a poco,
che piglia la qualità crijlallérta , che è Incida *
■‘C g ^
l'annua. tanto viene a foco a poco volgeri'dotiJuo caidonei cont rario; y l'humid0 in f i c
ch erà ,
TJ T H E A T ;
47
c b e \j(a , che egli fi-fa lu c ìd o ;& alhor [a n im a , A n ltr^ ,
che m I v i . alberga,
'*<>**>
fp cculaticne. l l p e n l l n l H ^ ^
sa*
gótìtlxyTfffilTT prejè adunque /I Poeta il C riJlalU 3sol per mojìrar,, che. h u m id o d e l (àngue
di Laura., era g ià fi.r ifi retto j.C X per cofi d ir e ,
efic c a to , che, era hqu a ltrim en ti divenuto luci
do , che il Crifi allo fa llo d,i cjìiccataneue : &
a llr.ue difje .
v ..... - i •: . v *
1
G ì m ane donna f i t t e m -u e r de-lauro
■ V id i piti bianca, & p it* fied d a -, che ne sifa
N on pere offa dal Sol m o lti, <px moirianni:
£x cqj't havciulo. pof a la cagione, & la mate
ria , non fi poteva afycttar., fenati cofifatto ef
fètto , cwjfQrjfittilo ^ . Mae Si »nvrq jiu m u u L
molto meglio , che io lafa quefìa parte cofi ,ca
venuta mia., p o che certo fcrm-endo m i è ite m ito n d n ifi.u n m a le fio riX iivzemio-.roflore. V eg>
gio Ulujlre dotmasiteggo haver/mejjófiuòrt tarro
ta robba ( e x della buona come dicedi. molte?
M agnifico SignorìLibanoro, ) chela.uoflttt.incomparabile hum anita fi.d a rìifa c ilm ente a e re
d e re , ch'iofitppia qualche.cofà o feria p otefii
ancor conxdcung e n til pudore ine! ter alcvnaxtye
d e n \ a , che v i f i f e d o ttr in a , nel benigno ani*nio delia g randezza n o flr a , baurei pur feruatd,
quella delle dodici conditioni dell*Am ant e , che
per tiene a l'ornamento per piacer alla. perfinA
a m a ta . deilaqualfece in due lochi:aperta m en
tione d Petr p r im ie r a m e n te ,, quando dtfj'e•
P ercheueggto ( £ r m i jfiitx e f)
\
‘ Gi
^
„v*
• ."-SU~
'• '•
'
'*
fi:
JO
0 I* Si? I N
M € * tf
• Che naturai m ia dote a me non naie ,
■ N e m i f a degno di un sì caro (guardo*
SforXomi d'cjjer tale ,
Quale a Taira/peranna fi conface ,
Et al foco g e n til, orni'io tutt'ardo .
S\tl ben ueloi e & al contrario tardò
Di(pre«iator di quanto!mondò bramii
*• Ter (tllicito siudio pojj'o forme ;
P otrebbe jo rfe allarm e
. s
N e/ benigno gtndtcìo una ta lfa m a ,
pai nella cannone ^
Tacer non po/Jo •
Ke la bella prigione, ond'hor èfc io lta ,
Toco era fla to ancori'alm a g en tile
<■*»
X . 'Al teittpo,cbe dt lei prim a rriaccorfe:
■\
O nde fubito corfi*
:■
Ch'era de Tanno , £r</i m ia et a*e Aprile ♦1
A cogliers i or* in quei prati d'ini omo r ;.%.*!
Sperando aglioccbifnos'pixcer sì adom fo
O ptacefje a D io , che m ofrana orni io a d ornò
de'fiori colti piti ne! celefic,cbe nel terreno g ia r
li n o , potefit piacere alla p/u g en tile j alia piti
diurna madonna del m ondo: m a tutto fi mal
mio è ptfficr in qu efio , che la troppa bontà di V.
ìli a fr e Sigi vorrà mofirare qnefit m iei penfie.*
r i , a perfine altam ente dotate d i ffdpere ; le quali m i leuarnnnb quella a u to rità appre/Jò V .
lllnfi. Sig. ch'io vorrei levata noti fiiffe* D al*
l'altra parte fie r o , fie alcuna delle d odici condìtioTii tu ve nel mrtuofi f im o animo della nof r a
gra n d e f / f i , che ella m i d ifenderà g enti Imense. pur a me pare j che il meglio farebbe a m n
j
j
]
j
I
f
|
1
i
J
|
|
f
|
-W
is-Zi' T ' H E A T .
£ i;m o flù n U jg jfa U tm a ttrif
&
L i Jufitcìoitia mia pieci o la , y iraffa. La hu~
manita nofira adunque fa r à meglio per confi
glio mio di leggerli joLim ente con la dotti l'i
ma , y j ù r t u o f f i i m a Signora G in e v ra , y d i
non g li Inficiar andare.a g iu c c h i y a g li or cechi
d'altrui; perche le donne naturalm ente fin o p m
tompafiionemli. de, g li ìm o m m i.
” ?venutamia poi mi sformerò , . y conti ragionamenti f
y con piu m a furi f ir itti *f i iti fa r e a quellan c hdtfirma , y erudit fiim a Academia d ig e n tu huornnu; alle Signorie de quali fon lanlo inchi
nato,p, y donato, quanto per auenlura creder
non potreltbùUQ.. MA che debbo fare io ai pre
sente ? Dee l'anima mia baffiur le mani a V pfi.
Uhifi. Signoria, y chiuder f/ornai quef i a U tter accia to fiL irg n d .0 pur uecicndvmi ancora
una facciata di carta,ripigliare da alcuna para
te alcun ,ragionamento ? certo V.JJltijfh Si m i
, ch'io uogho fic o ragionar ancora un
poco. Dico , ^che t ornando al tranfito ; liquide T ran£ft©
fi f i .f ijf if a p a r ie i i inna ficom to a q ^ elia de fi
\ V
t
i t
t
w
"
' dìambedue,icjedluhial
ve d;i OjueS
tuquè V'ffdfinicTdica 110, 0 ;c p tvto ffo d eb b i ari..c * h r 'f ***
/Ine, -ffìa parte dndna rapi fia a j e ? animatio»
fr a ,c h e l'anima nofira tiri y faccia M a jfiir e
a fe la parte diurna :non dimeno debbiamo crede
ad un tepe. V t g g U
mo lei
cìuàm ltatèl ì!jèrrv.feStl
fm
efòi
T
ranno in convenevole loco y . d i f a n f a n i cnuffn
etnei tempo, eheia calamita rape f i f o r o M quel
C
j
'
_.
SE
D
I
S.,
I
‘Tnedesimo punto il serro le confette. ne pero
*calamita inette , ;ie si abbuffa al ferro : & f i
■altra materia fuffe in quel loco delferro ; dalla
calamita non farebbe rapita «mmai. Adtm- , que fa bifogno, che cofi come la materia, che
■dee effèr rapita (tafia^famftTf^ffTTJjer^ifpoU bero? e f]u ratto ; cofi ancora il nofero Ubero arl/ttrio
* bitrio dee' •
.
esser Ai- ^ feeX renar dilhofl^ & rattog cheD xgj^dT
fpofto ai m ì chesa ben appreffo Giovanni fi legge : «<?">
Tatto ,
*'*■
Ufo fa di neni et ad patron meum, nifi pater traxerit
n o i,
eum ’ Pe\
mcjhi nrgaito il Uhero
anntrio^t legge non dimeno appreffo al me^
de fimo Gì ouanni. D e d i/ eis potefi at emfilios
'Det fieri .<& thè altro e ,
I
..■cheti libero arbitrio^ ? il qua!ne buonconfait e , Cr ne' maluapi non coniente al rabir, che
fa D /o d i noi ? N e voglio aY preferite parlar "
. w » r ‘Sitrsf’e di V irg ilio , ne della catena
aurea d b lo m e r o , gentilm ente interpretata da
i
D/ojnse2« w ^ ^ S S i£ i5 ^Wf0r cf i pertengano
'^ ^ fin ^ a rfn trT o nostra, perche troppo dim o
rare* Jopr.1 . Tnitto diro aggiungendo alla\
. conuerfione , & al cònfentintento ; cheV JVtrarcamarauigltofamente accompagnò a m b e
due con un modo da pochi perauentura, confile-
Im rtrno rat0 *
»perche io lo avutemi bene aìTmtelhaerl $e\T ^o enti a. deli*alteZyanofir a ; fittole talhora ì l d i a m Poeta , quando vede alcun dubbio tra due
4-uifek». f a r t i , fi*ggjr t tl detto- dubbio con dubbipfa
con fr u tti urte ; a n \ i con confru iiio n e , che
fe i uir puffi ad ambedue le p a r ti. Ecco hauen^ do letto in Theocrito e y in 1 1bullo , ci)e le fiel[e
D
E
L
T
H
E
A
s?"
T. '
fcgueno il cano della notte madre loro ; in quel >
loco dico d i T ib u llo ,
Ludite : iam no x ìstrig if equ éi, cnrrnm j; f i
qm m tttr -
v i/m lafim o fjdera ftdm cborc r si si
& battendo atiCQr letto Virg.ilcfttal quanttm- -,
que altrove conferita a li predetti ; pur in q m - ■
«ersi della Georg, dice che le {ielle menano là
notte; cioè che Ut' notte feguel*.falle
A rm èutaqùe pajeer
-sin.
sa •
Sole recens orta,aut no f i em ducttilm s afìris..
£ y volendo d ir una coso t a l e , la difl'e per 'am~
si
si
p hibologia Cofi. '
N urse t7 c a rte /Iellato in g ir o m en a : :
■■ ...
n el qu a l ve r f i £X n o tte -, Cx carro poflono te r in \
loco d e l prim o-, & d t l q u a rto ’ cafio , parim en te,
confi d e r a n d o ; ebe neJ]una belUTggd può riu p U
(rere a s e j f e n ò n è in p er fo n a ’y n é lU qu a l fie'nè,
lìin ferite d'am ore ; Itq u d ìi' cofi' a jjb ir ià r iflè tè
S fate nella donna fu a , ; i f i<
\
fa
"fi
.•
, VJtogli a morte qu él-fle ti ella n'ha ió lh fa \
Et r f a t i l e tueinfegiìè faci .bel volto ; : fi
s a £X confiderarido 'ancoìrfi .che riefluna perfidine
può cenfehtire aìhh.rdpina, che d i lei fideèffe .
la detta beÙeXzfa f è ancor in lei amor itoti b à
tte,}e le fu e infigne ; lequati non meno m e* >
f tr a e/fer fia te in lu i , che m iei in quel So- ;
n : tto .
V *oso" ; ’ ' ..
A m o r , che-nel perifier mio itiùè & regna:
lu i f i loca, Cx fai p o n ju à , infiggi a "" \
mentre bau ea a d nrìojl r a r iV "fiso ìnndftióM' tm fitv per caffi òri teUe ihfegne 'd'A m o ri f>&
C
iti
fjg* D t
5.
IN " M A T.
non le dir. due m i t e , u fi una acutif i m a Amfifa
bo'ìogia , se io non m'inganno nella terg a perfona del jingoiare de l'imperfetto , laquale è
ulta mede firna conia prim a; perche fi dice io
aelfifibo P °rta u a , & quello portava .
lo g u net rVcrcbe al nifo dlamor portava infogna:- •
&<uarca. - Mosce una pellegrina /I mio cor vano ;
do u e pofa tti fa r la confru ttio n e , m a pelle--g rin a mofje il mitì cor nano, perche io p o rta va »
a l tufo infegna d'a m o r, & fè rcM elfafior tana
tiìfegnad' am o re.• Mae peirtìted o d fig g i o , thè '■
la carta mi-m ancher ebbe yfafà fin E i Yitòrnrari-Ì
do a q u e l, eh'to d i fi* d tfopra ; che tuttoquelVfa
ch'io fxoferitto} de fiderò y che fin interpretato
da V . illusi. S icché io hahbia fa tto fot per'
SJT^juer il qual u e g ^ tS m ^ r&e g l i ST ittiS
ittrcora oriiini) ÌUorpo per piacere; quelli f o li «
uerfi di V trg. potranno fa ti f t r e ^dotky'jprmp.^
& D idone f < y Enea mentre, m nm ùdìadac-*
eia D i g r a tia V. JUuft. $ig. tenga oc- ÌJÌ ^
culte quejle m ie m al colte lettere
x
•Ai '
poi ché ha u rà . degnato leg- . ■
\
g erle una volta9q0*tn
.L'Avt
do non h a w £ vV; ■*'»’>. :
* ’
’* ..ì u iilir W s » * vusa
G' /*
,
Ir
t t . A lta g ra tia della quale
humilmente mi rac
comando
V IL
F IN E
DEL
D IS C O R S O * * »
v ^
A n i .
L
E
T
T
O
R
I
*
.
S s 1 N D O DAI
I S. Mdrchefè del Va
li (lo ( com e io intesi* ,
ia L M u r io )im p o fto a l ;
^eccellentifoirno M %f
». Giulio Cam illo ; che ,
II uolesfè per uia d i ',
lenti: tira dargli alcun sàggio di quel suoi,
tanta maraLìjgliofb T heatro ,d e lq m !c r3
; egli nel !<#,
\ patio !elr^ S j ^ t i n e T T S u e n d o e l i o /
M ucio
,.ck ini-,*
c liia m a t o ld e a , c io è
racla -!a* <rrntr k bricn
;
T ? 3 !tS 3 !u e o p e r e nabbi*am o;Iv m u to : d a i,
M ag. dk 4itce rarifoim o
“r" li!i^ n te m e fìte \(o r itr O . e psu copio
o di quellavài^'co?5T3ie nno,hof pi3T
s e uè cinta .■■D rtlaaiùe C rito i n ico aipec>
tiin io etiac dio-("coìti e da q u e llo , che ...Ha,
o g n i fuo penderò uoko aii’iìriie de’ uirtuofi ) alcune saure opere del m ede fim o , ‘
degnedeila dottrin arn ssap ilcT S ^eliin teli etto eliti ino cb eiio-M, G iulio: legnali
e tru tte e diletto g r a n iS im o in apposte .
ranno* ■ »;• : : u .>v- ;
k,• ; ^
‘
C
nìi
J\.i. **■W.saVl -U'\i-J- *.*.\ki vi/\*A.J**/'faJ\+v
r > tc . ?
1 1 r>
A
t _ t p f \ _ T 1 1 ? ■o -
T
D s u '
e c c e
L i e k j r j . s s .
M. C : V L I O CAM ILLO.’ "
.: V .- O ' À
<• • •
.; :";
r „ » „ m e’ W F ® 8® ^ 1. ? 1 v A ”* ”'
.se gli
’osoosooso osoosooso [ sa^t fin ito ri hanno firn
fx ri i. o i) '« £s. v S rt^ i osoiosooso •. lire l>huti! o .in co(Unric
¥ U U ‘“ ‘
; i
t
p
!
^
f
V.^, -T
*
l
i
b
^ M
o
s
*itatfpttiillW
W
mfi
o
o
s
o
S
»
^-i<;>4?,
.i ,ii fni rt lsaeew ejr< ?Ayr»f u/
* j & i P :j oi-to\ of cnìrf u ti tirniy die»
ito cne non j nino j n lei i ,
fc iw n d a co turo , '. q u a li f come niCCChriJio } ^
*(rann o ofcccTn e~da udire ;Y/oe che da fi) io fo n fa'
^ae^osoisa1iseIsacre>I7^'fan it fin iim ijie r i. E t %
IrosoosorÀ,
i l bit posoowo1 /offerire i r.a?gì. delia dim n itfa
m
Tir rio se confermMcon lo e(empio i'u<Miof i , tlff-E niuinl
. .
> ? »»
r
#
r '-1 r-
^ f^ ffaifcfixb^ gh orcin
ti non '*l1*alcJ cena orio <ia. monte yjopra utpHilc egli
jnio nfcr-ancur (>cr h m e \o dea*Angelo battona parlalo
t\
/y
/
s /
d.r rii ocf('w Dio j non fx.tena i'jjcr oudrJafo aa{ pòìtytt^iil.«t .
•ehiuol-pvìo fife ense /I itifò col neh) non Jin tfeludei:a .
£*f s • | K /^li Apoflult ancora ucdnto d i n fio tra n s fr
D R' L . T K E A T....- f f tirato-:, ch etava f i partite daitegrejfe
de!f Immanità , aita qua fi fiorià d etti d ivin ità:.
m n (ufficienti a riguardarlo pèr ut debotififfa
raderono. Yx fieli*àpQcalipfi fi legge . T ifigm fi carni mittens pér'Angehtbi f.iumferuo f m .
loanni. Dotte c da notare, che ancora a Gio
vanni i con tatto \ che egli fojfe fervo f i o ; : i m .
aperv ‘'intendimento fino , jenon per fiigtufca
tioni y per uifìoni. Et fieramente y f i corno
nella mondana militi a fono adoperatele ucci
de C apitani,
le infogno, per.
conducere y mdHifiuLfiifcfimatc fchiere con- x
tra i nimici ; non in altra maniera, nella m iliti a,
dmtna hahbi&nojtòfipcr la noce, le parole del
Signore 7le, angeliche trombe'
vocilit Profeti , & ^cjnredtCMori^
'
...
'ilò.c.:
(] {se~
7fTlnw
nutm T *dà afifiunfierc 3
, rh t ‘
,
TrÌfinc<rijìo dice - che
J
-pienf ii Dio
glifòprauie)
non [en fia ragione g li antichi in f u le porte d i
y
qualunque tempio tenevano o d ip in ta , o fieoi,s
p ita una sphinga 3 con quella im a fin e dim os b a n d o , cf-è delie cofifidiT)w non f i dee } (enàn
con enigm i f a r publicam ente parole. ìlclieTriìé porte
m oli è''mani ere a e fia to ancora infognalo da oso
Dio : che parola di Chrifio è y c h e f m a rg a n tp ix> w£r*
non fi debbiano g itta te a porci, y che a con» .
non vogliamo, d a rle cofe [a n te ,„ f j f i •;a n do.fi '
ihApofiòU. faci d fffc .loro « \ o h i i à a tn m ..
C
oso
9
'<0
f3 .
L A
I D E A
'
éo/Je m i f i eri a regni a v io ru m , -exteris in para--,
fo lti , u t ni dentes non v id cani , O audientes
non in te llig a n t. Et nel quarto d i T fl r a D io
f i n i andò di Mose fa tto Jaiir /'opra tl m o n te ,
dice . E t detinui ermi apud m e diebus m u h is ,
c y narravi ei m irabilia m ulta tem porum ,
fucreta , c r fi netti . c y d i x i . hdc in fidlàm.,
fa c ie s , c> bac ab/condes. Iil D avid a D io
piirlandò , dica , Reuela ocvlos meos , c-T cv/t..*
Jklera/w m irabilia tu a . don e d ijjcnon di do
ver p alefar e , ma R iam ente d i conftderar le.
alte m ar auto Ite , 'E 'o f appartermhTo' le d o fé"
dittine al /opracele f}e moiul C",
s
tm n i ste t/,
non "poi n(fodlMm
e
Jnigva,'ln c ff^ a mg y tn g c y ^ a ìh t
1
■j
j
!
1
ejmnfffa__pgr jin n h tu a n il, rt Jsne "Tic per '/ o ~
mejjfo dWie coso uiftfnfTJlvy a n io alle in vifib d i :
uon ite e recito , ancor, che Dii- ci aej/e q u a lche gratia d i afe end ere a lte r a i cielo , Cy d t
f fecrrt! vedere i /v o i fecrcli ;
esiti luinó le a t di rivelare ; perei oche quelli riucfafhio , .
*■- lecita filili
Mimarlte chi noi doppio error fi m e n e a com m ettere.
fieno r i u r d i / ó p n r ^ ^
0
Tare ti co/Vq.veyia "TTopryTT^r^ s
4<7vello il fu y e tto filìtb n « u e d jjjd a jn fi^ c lf f
ìqva!: live inconvenienti liuUndcT/aggtr Q fo iuvini y f riffe le fu e nifìoni fe r ifa 'cercare in
altra fu i f a dici» ararle i f £ t i ò i n e l l c c ^ ^
et ferviam o delie i mag m i.. come d ifignificatr fa
-Ci di quelle co/e, che non fi debbon profanare>
r-&t >quanto a DioJìa caro^ che le cofejvejiano
.
,
|
!
j
D E L
T
EI E
A T.
tenute nella r m e r e n fa de loro velam i, e /fi itte*
defimo ne f a fe d e , chiamando Molo f i d a i rr;i'‘^ trc^
n ifr o f i o . E t c liC u é a u fì^ J fic h ie l uien chiar .pt ()fm "
maro p ro p hcta w lla n o 5 per hauer Ala guifaofano p
d'urihuomo di siila, /coperto tu tto quelle , siseiiT^Cabasi
e'r/r baueua veduto
N e tacerò io , che r m e - iti,
de fimi. C ahahfh tenzono , che -Maerid Jorelia
di Mofi f i j f i a S la 'l'ebbra oppreffit, per hauer
revelate le cofi fic re te della, durifa ta : C xche
per lo m edefm o delitto Ammonio, mori fife d i
Jlorca & m i fera m o r t e E/l /Anso bafanducs
d i haverrifetto d A Ia riv
nel ctt*A (i hablvano da tener ie cojc ja n tc , paif o n i òCol nome 'del Signor e a ragionar d et no*
ftr b T h t t t m z ■■
^
. ’>
ff
- Salomone-al nono de Vroverhu ^ dice la fa*
f
Jn ei^a h a u .fp 'f edificato cafa^risr ì)offeriti fonda. '.
ta j o j^ tjk te c o lo n n e .. Q u efe,co lo n n efig rity Colonne ^
sicanti Sìnb ih fiim a e te rn ità D o b b ia m o d a in tender che f i ano leJ e tte S a ffriroth del /opracele
fi e mondo \ che (nnrfleletje n iJ u r p
xca d d celefle f fidelFinfericre , nelle q u a li fono
compre fed e Idee' eh tu tte le c o fi, a lcelcfie, f a
^ ll'in fir r iò r M p p a r ^
f i o n d i due .
fio numero cofa alcuna non poetiam o im agina-.
" **
r e j Q vedo fettennario è m m ieropjtrfettoì perS etrena*
cioche contiene l'uno & ?altro fe llo , per effer1,0
s
,. q ,
.
? V ,
to ptxm +
fa tto di p a r i, csi a i d ijfim . onde volendo dir t o .
Virgilio perfettam ente beati>dijfi,terque.qvar
p a r U n À o d M U tfa r e q ito n M ^ ^ o ^ ^ fa ln dH C ^fi
in c d ljn n fiàTiomandarc* -^Elementa v a tu r& w x
.
ۥ
yi
>
èò
£ A \f f) E X , O
•‘.‘. f t m à h à ru n t? Et-Tììrtaiklro ri'fpondea -scM
jwo^ifnTSe111/ T et,
iter bum
“f f r v m jy 'n tv ita n n in u v m , ad etM exem plar
Ircj/Tnse
cu t is ; li itali b u fi: (ernfa
tnin
l- g7sa3U/ j { uh iu e
J cxù< firawdTtate ptenfistm ustàta* Q 'iffx cv tn ,
J binius fin te n t
deimeps fabricavit pnbernat tares Arsiti circulis
j^nuYuium (ènfif/itèm contblecfìm lvr. E t n d
Vero Intuendo la d ivin ità ejfucate fu o ri qucfle
f i t t e m i fa r e , segno e che nello cibifio.della (ha
divinità, filino ancor im fdlettam ente contenute*
frèìréiòiftb'ncnto d a t quod tum habet ; Q o e ffé fc lo tiiìc Efiva le chiama fe m tn e , quando.di
ci* $ èffièri fh u lM eì ’ttppreJyeiiderimt. (ibi v im m
itim in , V.t chiaviate fim ìn é , c/yeTittold^ ftoso’sa
U r\\,d oè ‘ ftrodnsee ; Ma sa consa itt'ce pX/o'?
‘Porsan orimid verbo'u irtu th funt . .Et altrove
Vnftm iìiotrmibits, c y omnia in uno Et a G o llo fe n fi. E fi irrtago D ei intnfthtlis, p r im ig e n i
tùs omnis creatura , quentam i n i f f i condita
fu n t uniuerfli in c&hs & in te rr a , u ifd n h k ^ O r itiv iftb ilja fiu e T h ro n /. (use dominationes„
ssaie pjfdmdJmmdlfa fiUe t’ofclhitei^orm uaper ÌP~
he non p o fi
‘Ì'Ìtn.
a ^ intj ;
£j>*
J ta m o ffo u a r ^agforTpTv capace che quella.di
D io . H or f ig li antichi Oratori volendo collot a r d i giorno ni giorno le- parsa de/le orationi,
nsee havevano a recitare, le affidavano a luoghi
C aduchi , come cofi'caduche; ragione è, che vo
le n d o noi raccomandare.cpermlmeme g l i . e m r
3
*
D K L ‘ T; H E* Ar‘T.
^
n i d i tu tte le cofe s . ebe.pcffono effer . m f i t } 4 is n tm tia n
oratione con "li eterni di- eifa oratione ; troni a- dà'awno
ò
•
•. ^re j*rl ruo
r?;o ir loro luoghi eternò»- L'alta, adunque fatica. f \ u m Q
nof r a c s fa ta di trovare, ordine in ove f é fette,
rnifure ■, cap
T e n g a jtm p r e il fenfo fife f i la to , O" lei memi,
ria per coffa. Mae confid crand o che fe noi ef i m i
m ettere altrui da va n ti qttefie al tifiim e m ifu-re,
y filo n ia n e didia.nof r a cogm tjqnej c b e f o L u ^
9
farebbe un m etter mano a cof a troppo malagevole ; Pertanto in luogo d i
em ette. Rifilerem o i fette p ia n e ti, le cui n a tu re \
ancor d a u o a p trrto fH^^
•• ma j r
talm ente le tiferem o , che non ce le p ro p o n ia m o
come term in i ) f m r de quali non babbiamo a d
u fi ire 3
wli.i-L.___jiTiiìi irr
fc fa a p r te y r ^
j ^
e
f
sr -r-nwii si i
e
n
f
a
iirr-“"n
suesa
V ts À -%
^tetrparfanao , rTtormitoSSa t rne/;te quei prin
cipi) , donde quelli hanno hauttlo la loro virtù . m
Q u r fia a ita & incomparabile collocatione vtilsta*
s a non fJ.-m ente officio di co n fin ta tc a le o ffìd a ^ ^ e fi eaaa
te cofe 3parole 3 y arte., che a m a jy fid u a ad f i f 1}kVu"
€</in no/iraInforno
trin a re
|
fo n ti d i q f ! e l i a T n S - e ^ o ^ T T n ^ S u ffòri'Stelle
■
'^In.pm tinaram eU i ^ v m e r m y j i M
•' J/ A
I D' E A
sito. Serro/ fvfsimo in un gran b u f o , osi ha nefiim o defi deno di ben vederlo tu tto , in quello
sta n d o y aldeftdcrio m jìro non ( otrernmo fe d isfare : perete che la infra ini orno m orendo , da
v oi non fe ne potrebbe u e d er, fenon una picco
la par te , impedendoci le piante cir conni ente il
neder delle lontane : m a fe. ideino a quello n i
f i f e una erta , la jtta l ci conducefle Jopra uri al
to colle , del bofio u fe n d o , dal? erta cominciaremmo a veder in g ra n parte la forma di q u e lla
poi Jóprd tl colle ajcefi, ta tto intero il potrem
mo raffigurare
J t'c o fe \fa fr T o r fiy tfn e T ^
u ff*
T u tu rto ri: <QJ ut alto w g tu guardando, di quc~
j ì e poi remo haute più Certa cagnit u n te . D i
qnefio modo di intender pah che g li antichi'
CìMant Jchlsèrittùri g e n tili, n o n n e j offeroal tu tto digiti« i lutino n i . di che S\afstato ’Ytrio allega H omero , che'
j^^oso C /n rli/ce V /s/c a f e f i in alta parie confdcrare i»
ti nn flViir cofium i de g li h a b ita n ti, r.t ArI/si/^ /c a la- fa ’
refe insse. p f rrj t t >cf}e fe noi fa fim o Jopra : a e h , f i
CÌ0
I
I
0
u u de He potrebbe dà noi conofcer e l'EccltJse del Sole £X
superiori u li(!a la m a perle loro ca g io n i, fetida volere a
quelle a fe n d e re d a g li effe tti. E t Cicerone nel
fo ttio del minore Scipione f a , else di- cielo l'a
volo f i o a lui dim e f r a f i coje te rre n e .
fila , non dubbiamo S ta r contenti d i f i r m ^ Q
D E, L T H H: A T.
€y
o d . cieli ; anzi, col petifiero ci d ebbiamo iqf i x a ^
a quella osooso-oso >afloso£ sarpslosogfo
n o ffr c T y ^ 'o n e a U n a n n e da rito rn a re r. ove
a e r e .1*Aua q u ^ p e m o m n a o ^ ’ia/no prejon
I
ffuoftpenjar di- dover per nofira,uirth poter p e r -
i
j
|
v e n ire : x iia que fio modo et farebbe detto da]
Dio quello y che jli rifp ojio a M oso nella /ita pre-^
fin ito n e .-
!
;
|
j
e jje tu delie.cofe., m a n o iiTe c a fo n i di Quelle.^
v T " " r / / s a " exr.y/e^sivl
s?d., che ri faccia degni di-. quellaj/ratja,,laq.ua ;
i
I
I
|
(
j
j
j
j
*
. .
lequaeulo jm ficq u -e.a d ei, eìiafio/fi aliatilefimo Musa , spofiraiulofiti le. molte, fif eqnarati,fa
glie ; ilche ftràquAnd o.noi farem.offattixtiàU
che annichilati y f i noi, H rffn u lfaprcffaf
roendo-, potremo con. L\&pfilgjp d fie ^ .y ^
. ìa m non m it o ego , feci sanse in
Q r efjóiulo il preceder n o f ì r o f f f ragionevole ^
|
;*' ; ! ....
v
come tn oprato babbi timo r - ^ d S S j i j i ^ L J ì É t g ^
le cefi ba/Jt- j . y j j i j n x n d e r j f i ^
x- •
c a c o a T n fn o »
Te t rottone più p e rfe tto /n e più dittino ,c h c per
uno altro fettennarip applicato a ctafiuna delle
dette colonne, o ucro a ciafctmo.cip .detti pia
neti y che a ir fia uogliam o. Dicono adunque *
..., ,,
j^ S ii& S lL i k jdmàdut.
‘f i 0
'■ ' J J
che M osof i t t e volt c p u f f per l efe tte Saphfrotfa
fe n fia p otergiam ai pajfitr la R ifit . , £ i dicono■
1 } terminQ »- a f f a l e IffteifettT !? ^ ^
*
*4
£ À . 1 f> E A
rnrmo può effer Iettato. E t benché .Mnse piante
alla detta R in a , hauejfe d irim p etto la fàccia
della coronastiperior e ,e t quella della Cihochmà,
JLpojToh) vjr qneflo auuetnie \ percioche . N etno nouit jìliftm , riifi p a te r , ncque patrem '
fili* n o u it, n ifi filius, & cu
à ircitfiliitf re-■
de!are . FA offèndo Alosa arrivato alla, 'ùhjà x
.^VfUratliAnellaqnale è u n officio di Angelo , detto M itra -'
Augrlij. f> 0//. cioè princeps ftc ìc rtm i ; con.quello heb.be
i fu o t ragionamenti,. Effondo egli adunque sa-*
hìo fe lle itoli e fo tte fin te x che fim o quarantanone, numero 'dèlia rem tfio n e ; ai qual num erò
Ancor G ie fiC h r ifo noi fd ?cìjc*afÌend cfim o f a
cendo orai ione al.pr:
imperciochc là crai io^
,
n e , che D vnt/nical chiamiamo. ; fecondo t l ì e Oratfon
•
fi'
aomfnica
sosoo Jcr/tto da Matteo ? e a> quara.nlanvite
ir c di parole ; s ombra d i queste sa/ite im itando noi »
parole. Jhdbiamti dato
0 fìtlài-J , 0 m ^ L
s
^ ^ ^ J y ^ ^ r ^ p ^ T g f ^ u r J T r a m e T r f ^ d ir if
Ordine con ta l fa c ilità ^ che facciam o « l^ h id je ffa o n id
de) Thea- /U / ty i mesa-iamo
tinsejj^ggsaVo d ir vogliamo in 'Theatro d ifiin T fè p e rjette ja liie . 'E r, perche g li antichi fis e a {fa erano talm ente ordinati x eh e J o p r a T g r a ^
mio fie tia c u lo piti vicini f 'edm ano i più honora
ti: pei di innuo in mano f u ! citano ne g ra d i a f e n
d e n tr q u elli, che erano d i rumor d ig n ità , taf*
mente»
D E L
T T7 F A T.
tf
meni exhene' fu prem i g ra d i fideuano g lia r te f i ci >
entno
se per /it uicimtii dello [betiri
m i o , come ancora perche dalfuti-.: ....... . r i f f a
ci non finsero - / ; oso:
creatici) del m om lofitrenio fe d e r ^ fir r n ififr a ^ J u m T !m e g p ^ ^ flje r e sia le p e n a d ifficfitim .
d ivin a avanti alle altre cefi creai c . Voi collo
cheremo d i grado ih grado quelle , che appfeffh
fin o fig tii t e , talm ente , che n e l fà tim o ■
i^nrw
ì air j•fuf-pcr:or
■\u ertati; tu ite
nell
uh
imo g<rrado
berìore.;fideranno
lf.t.,nWn-T..
,i,
— h
•cen^ n ori
OZÌL
cfo-3
perTagto,
falcione at i lo ta , 'uriti per ragion di
tìTtemjw , *’
effindo 'cji*cUe,come tTltjmedaf^ W ^ m f jì^ i ^
r i trovate. '. N èl primo g ra d o adunque fi uedrari"
% T ÌW te p a rtid ij? im ili, perei oche ckfc®
_
...savie efier dipinto m parig ra d o con g l i A t r i , cedi?'
à i conuifiio detta, latitudine.He ?Ji E n t i, che d
drriagjnc della d iv in ità ..
f fa ti o fa por- <•
fa di eivrloson pianeta faranno co n fa v a te U rittt
cole appartenenti, coft dilanisi ara nei {oprare
UMBtUTrrrtrir-t.k.- * if .
, ...........
f artenzono ad ci f i pian eta T cfa A I F p n tn n a è "
Poeti intorno a qu-ehofi come tùreriio
^Son^^^^au^ta^i'afi tratteràdel fifa
<rr-
l
a
ID E
a.
mcmlo C<>Oracelefrc Marcut C fjfia b rie l.
D el celeste la Luna , la opa cità, ij^ jra n *
A tìl iVM mfrf inffsanse^i1
0*
ritt, /e site ttifcgne & il num ero delle D ia n e .
Sotto At porta dt Mercurio nel fino mondo
/opracele/}e farà le/od^C r Michael a
K elcelesee/l suo p ianerà .
Nelle fattole Mercurio mejfiag « itr d e «li D e i, et
■ suoi ttrnefi.
Sesto /ii porla di Venere nel fopracelefe IT od ,
Nt%jtcì), IT o n ici.
*
. r N el cele(le Venere pianeta
Nelle fiutole Venere Dea, Cupidi ne, fm g .r n e - .
scasi numero delle Veneri e y de Qupidtnfa
i\
(
, f ^ T l ^ ^ S T i r o u è r c r p o ffip m è T netto J ?
a v ;* cena i v i? , defauaT e ^ r l ^ m ^ S S t t S m h dnfocom lo « ra d o .
jwwMwwwmaBWii
."uwiwpfcni/pi n»jiu.
Sorto la quarta porta aattm ù e*p n itu rra m en tt •
troveremo la la titu d in e , o &cplnxmo d ir la la r -i'he'Z'Z a d e «li E nti ^
sopra la cut J o m m ità im aginerem o u n Ptmtor ^
ct«e ci
'
f m Xa ^ fa tfo n e fT ^ T o n T cì^ fo n ^ f't}
H?^R et fua
9? a d re y li^ n lJ ^ m ta n ìi Ia incarnatione p o h y ^
ìai.ipmr,
<y lo Spirito fa n te .
«
««Appressa ut f i uedraTtriàìniagjtìit d iV jtn , ilqttH
07'tecon
pelle fle lL{opratelef
u
tfh; ^ V e perei oche con la
fin la
figrhficdil
t^ h n o n o o m T J fe f
n le gam be caprignp.
'con le corna d'oro, e b ei» fu g u a rd a n o , C r con;
f inferi ore: Sullo q u e fa fig u ra a faranno fig g i-
D E ..L
^ficati i tre t
T H £ . A .■T .
Nel ttr\c luogo fitto la porta.medefmaciap* prefinteranno le Pareli
Wsa/AI fansenae , dcTjmncifn^y
fetto,y delfine. Et qvejht tfieffx imagnejofc
^ " T ó f ^ l ^ f ^ J k h e r a tintorno ejj'er cagione, ciép
alcuna cof a .
■,
.,
: Et fitto iTalari [ignificiterà dar cagione*
a o ro T ilctnale è quello, de (qual ferm e Virgilio^. .
che f m f f a queilo non jk p u o andar a .uedsre i f
tfgno,dell'inferno , T tc /n e
ì
S
s
s
kpc/starmfmarinare* c ù fic i f i ere ittumina* ,
B'q^siae^espit ìmagn^fiottoJedGorgom'figni-* ;
fiehemtmtMttto agt/M* delqmle .parleremo- %
a if
i n
o
,.. r ni moso- i - ^
T^JwÀ&h f&rtjt di Màrtfifit tratterà nel mondai
) .. ..
I f if m f f f f b ttQ é m d d h * & " & w a t t *
t ..^ N
e! sei
y
.oso
invetri £ ? nelle favo!*/
* Mdrse-ipii* ± y f w > i a r r u f f i , . -.., ; .
S otto Upartadt-Gionenel mottaòfiopracelejlefa
C b a f i d 'T y 'E ^
.vi,
•n-Nctc$leftfQù&c Pianeta*
. „,, -, .,£, ;
, 4..<NeÌle favole Dame Dio & lefile ìnftgne *
Sotto SttiM7K>lraueremo.m['fopraceleJieBim oso
Zaphchiel* -,.
.
Nel ec/osoe Saturno Vianet a . . . . . . . . ■_
... Heilc fauok Saturno T M .y l e f i f infigntji'
/t'
w
‘Y L A
I D T. X.V' '
T.t con qtiefli^/'aggetti viene ad ejfer conciufo i t
friimo grado del Thèatro * .
I L
CO N
s e c
V
,
;
I X J O., .
DN.D
o
j
grado dei
1 / f i J !$%&*>>»*« diTm a!}M/aimai>ine,^ r
\
sari* «W
'*
H*™*™ > [Oceano fa re.u n
conuno a rutti i fa v i Dei ;
m fe n o T A tifA m o Poeta fece tai flint-ione, 5R
. to rn ^m a q u a le con la g r a tta di D io .n a n e dire-,
yro d attlo '^o alcuna cofa . D ue fo n o fia te l cò^ ^ t t t o n L .
- saoso ^ che laxa ha fatte', I p ^ fa n tr tiA e lL i e llen xa d d la
J d rid m in ttd , %x l'A rra ih fu o ri a L a prodat
tTnuuurnLroficfjrc prokutrm * felina princìpio».
t y ( per dir cofi ) confaflànùale , t» eoefid iti ti
fa' y CX e te r/ia , è.quella del tterhe, dellaquabcof i dice lM er ernia. Epe , qui ceteris generatio- .
etrm tribuo , sieri lis ero ? Be Òio v a n n i hot en
fi o dir che f i f e coeterna , flesse * . i;? sisisiesseg
E t per dichiarar c h r i S i o T T p f i ^ ^ ,
ci pio j, Aggi tin fi. J L t |n ^ h tw t eraf-ei^ud petyy*
A pprefjì); perfarefantender
che ego in p a tr e , £ x patcr. jritti e c fìffv g g linfe*
E / Deus era; u e rh u m . fiLa produitien ai ju gf i
nett e coefjhitiàle ;
tn a fm jjw ^ ^
***
ta altram ente Chaos, cy.
^■iiiifimwMnfii MmiÌìm
^X dA Poeti
li fòt co.; ' D dlàquafa D io poi- tr a fitti ci d o * U
%
!> -E
LT II.'E -X T. rft
térrd , g r tu tte le cofe. E t i perche.
Vintoti» ■
.
,
„
' .
f--»1-** 'rimò u
J imeo crede quejta m ater/a prim a ejjere sta ta ciuc* y
g e m ni a
u
in p r in a p M c r e a m tD
cr ed effe Dio h a u e rfa tte due m aterie f i u m i del.
iwvWMidi
--"f
r
ciao , <y p A y ji^ q c jla J ^ r ^ ^ E t qu t c .ben t a
Xuot<trc, cl)e (e Vane f im o ad intender in quefio
' faj]aggio M/oso cofi j t w f licerneajc-,r cio cch e
■Dio nell'un giorno crea/jc il\Qietòrj&. là 'T x m i,
-per ciclo form ato & per' T erra, f i r m a ta nsepd/l
fu g g ia m o , inutilm ente ri pigli crebbe f o t , che
-il fecondo g io r n o , Juwefiè fiu to il tfa tc h iì^ c h e
jQ
iV Jfrrn Sm t^E
, ’ro , come dicono g*}i
li in te r p re ti. EUtt in u tilm en te
•haurebbeancot me fio il t e r ' g io r n o , ne! q ual
fece -apparir la te r r a . Ma f i come f i - uno f i
tiolefie ite]}ir d i lana > battendo d a v a n ti una c!da rate lì
•m afia di.lana non lavorata.; potrebbe d ir chc
equelia fojjè la firn beretta ,U i Tua ca p p a , & le
f u e ca l\e ; cofi dijfe M ofe , che Dio creo il cielo
»*&>la terra , intendendo d i avella m àfia donde
. quellif i bau citano a form are. E tK a im o n d o L v
T U
J i o , rende tejlimonio nel libro f n a f e ^ ^ b i a m H
tim Z juQjefbàfnjcnic; f r i t t o mentir*eglber a riten u to
in Inghilterra ; che Dio creò una m ateria f r i , ama, poi U d in i f e w tre. p a rli y & c h e d el fip r
dxlla pin eccellente fece g li a n g e li, g ? Tariime
, znojhre, delTaltre .i ci e h ,
della : erìgi q u ffio
mondo inferiore.
'Mono
do i
g fto A ir
jfer-»
\
t A
T"D F. A
^ r u t t i c n è , come ha in cofiurne di fir iu e r A tifié»
tele ; pereioche oh eP i vocaboli di!piacciono à
Mercurio T rifm cg ifio , tmt'fccondo ìa fenterifiii
eh lu i , delia dimoi! rat torte , CX de! nafiondim ento . D ice Mercurio nel Eiwii&ùuitil :< I I.
C tip. Sed appellationes quadam j'alfit hom i n e t
tu rb a n ti m g u c m in i penerai io m in cre.it io e lìf
/e d latentis expheatto futa , ntujue m uta/io
j
rnors ,■f i a occultai w p o litisi gnu m b.cc ig itu r
ita Jc Ita b ea n t, im m ortali a em ina. E t per d ir i
-—
fitefio fifa getto quello , che a! preferite ci oc.. corre della ? etteratiotre deliri cofe ; fanno t PiCenerino ,
. . **
1 -s-A
delle cose tha?orici m u connumeratron ri/jet principitela
«Ir t incita "'quali vogliono che tu tte lè cofe preti erigano; £X
xuT* ciosoc? questo chiamano C antone, e x nuefio è ta le .
principi;. Sci y L u x , L u m e n y Splendor, C alar, G enera<tio . E t per Sole itttefere Dio padre ; per la lu
ce ilfigliuolo ; per lo lum e fa m ente angelica., q
il m onde intelhgdnlc ; per lo fJnendoYe l'anim a
del mondo , o dichi.irne il Chaos*, ser per lo ca
lore lo fin rito de! m o n d o , o'fia il fiato- del? ani
m a : £ x cofi fa r .t ii G anione.
Sol, L u x , Lum en, Splendor, C ai or, G enerati
Deus pa- Deus f i - Mens art- A n im a Spiritus
te r
Uns
•?elica ’ m undrm nndi
Mundus in Chìttos Hiatus anima
telìw
Ò b iU i '
f t in qttefid loro ditti fifone è da notar , che coft i
Tithit^oric/j come Plotino, trattando delle Idee
n B L
T c H E A T.
fjT
im & s ll k o collocare quelle in D w , p n effer fe m plicifiim o: y per ciò quelle collocarono n tlh f
■
m ente angelica. . Uguale lore ri fie n o / a foticre èio , effóndo quello, il /opracele/e dico, m ede/Im am ente /em p iicifim o ,ch e anche il Soie tje m
f lic e , y m o ltip h a fin o i f m ì raggi , y i f u - i
effetti... , .E t Di anifi q di ce,che atte or che l'anim a
f u i fem plice , inoliij?lia J m o l e f v e operatèdnT, "
'fT c o m e ancor ci fi dim offra per qu e l. lucpc d i,
T e tra rc a ,
À nim a ; che ditterfe cofe tante
V edi,odi,et leggi,et f e r i n i , y parli,et pen/Z
E t noi fip p ia m o pur che in Dio fono le idee, d i
cendo G iovanni . Q ned fin ! uni e f i , in ip ff ut - ,
ta e r a t.. N on e da paffnr con fileni io la cagio
ne , perche (otto il .nome dello (p la n i or e interi- £jw ot (t,ip
deflero il Chao f . E ' adunque da fa p e r e , effe rstha^or;
Órpffeo ferine Tl.Chaos efler mito a n tiq u i f i m e fi f / f i
fiofifaincre ridi grembo ; tignale le rivolge ’a ìla.-o M m r
m ente r neilaqu(ile f ono im prcfjc le id e e , y d cff'f
quelle In fo r m a . concepara o Per la ìcFhelleZfia
ulcneadlK qiilffd r ffle n ’lore f Ma per torri. y*t
alla m ateria della generatione, credano i E it h a
m a occulto y ciìe ddfiuelle vrcon.a la d etta
anim a anelando lo partorì fca nel or enfilo d etta "
"Tv '----- ==' :r-—*----- ---------- -—*-*-------- r ; —rr*
natura , y coli lo con<nun"e col moto , y
---congiunto iu eterna comfuviTint con m a ^^io r a lfe llo /o ffa p o r i (jvnirenu.de fotte alla d im e n p o n e ; Jte. per tutto ciò lo fharfefina in cerai cir
cuito a fedo raccoglie. Er quanto offa più ftA ìf-
* rt
T)
fo n d e , tanto p iu a r c o n fo rd e , & Manda atrafi.
■fitòfi '-con- erigine m ioua un tim f: continuaia
f i n t o di Jet fjurani e . Q uefia. opcnicm hanno
tenuto quelli <xc<dld}r id i fim i i >iemali non in i efero C ìirijlo , ma
Nafr’mrn pur della dimojìrali< ite, & del nafcimento deldelle
e cose è , che.ejfudo la m ateria •.prima in ogm
cwfc.
■ r ie , & riduccndofi y o /rm andofi inficmelle
•rosa d i diuer fa nalura;come e l'acqua & la te r
ra y effe m ai non fi congumgereùbou o in im a
■unione ; fedo f i n t o di Chrillù m injoprauem fìe;
e t in quelle entrando non -le concàiajje a d c fjd ita r (uoriffjerne occulto delleherbe <y d e 'ji ari.,
- J i t natila ehmclìratio?i li fa per lo tn*rc{ ,im m ,. <^ f i ò M i c i tn ^ c r ìn y , lagna/ por n/futiiylnviclof:,;
w éfo fcem rjìì d ^
*A'/.TV¥ m »
f i fati) 'refi asey idue .. Tit coji jè c w *
0
4
7
. . , il d d ld fn in u y . deTTfaijnmrfffo ; immortalisa
'** li emmet . Ma quejìét è lachmsrde* verfi, iquali J
*“
l nonlfoglùmio ptààtcartraccioche mrfii trrophet* I
nino . in conferrnation ddU.<q?tdi cofa die?*'.
Titolo . Stuntits Chvifìi ,. Spiritile ttiutficmsP
Et altrotte dice la frittura Ego cccimn dy
terram impleo. Ugo nia , tieni a s & nifa
El se queflo ffnrito non JopramnifJe a jm fa
C«*i tr.nu cenediamone; i contrarie mtù non fi <tccordereh*
4
■tanto hauendo di fipra propojlo il Gaifione dt
•Ti/haforici, quello riduceremo a tre capi , O
nogliamo dire a tre primipii in qvefìo modo*
Set#
D E L
-""T H ‘E A T .
>71
Sol, L u x , Lum en, Splender, Color, Con cratio.
•
<A r tife x
Deus
•
j
E x e m p la r VKestrc . • * . n
Y eròum - d M ateria prim ari *
•C he il primori [ attor-di tu lte le -c y fi, et il fe condo (da nera luce,et fighienria.di Dio-fln cui-fino
le Idee d i t t i t e l e
fa ìia ie ìfa r fe d o J id rfi
io tiiHifìcdn-ie:.-- E th td w rZ ji s ia maieria-, nella \
quale d imprimono le driverf e fo rm e d ella dime.- J
Jtrilli otte; U guale coloro-ehitm am venerai i v i e*
che ideile in G onjequeizfia^ &
f i i x c m e i g r i i t - _____
Cipro i ■>■
:•«. .
;
E t per pMkchidra dimofirationefCDc la M ateria
prim a non fu i coejjanttale, ci p ta c r d ip rou-ccri#, r rima*»o
perTo firm a pio del "ftm ecfidi
f i xonunmt . V n itsy duo ,t r e s . - Y m s .fi.g m - r A t t o r e
fc M .U ,
ì ìu o -Im x ,
tn s .b H m m
g e > uhi c p m r tm i . E t ^ fe M jp o fh c Q m r iu s la horitt adu-erfk. uaTetiulme.*■■ ■ B tfim cp kfd l^n B n T
d e ta m ateria p r im a ,U flu d fr n p re-(a lie ra peri*
le m fa à n m i
. ^ J ^ e j J e n J o , m n c cordpji tinti a ie fiM
& e ìn fir T
triti biadanti m ìg h a ia d'a tim ^fy per ta n te rnuìdtiont t'J a c r e lìe r , c h ftia d a l eter io rana o ,
c h e f f n t f t , £ x quando non putrii più,ne ftg m - . *
rii il triudicio im i uerfide* ... n- *,•» . . . . . .
*’
hxi m ateria prim a a eram ente A i chiamo noi ef i
\\
Jeracqueru, farToeìkllUj*{e;->ttkvntanente, cifi
/j
.. eftii-fMJc'ifanriòfadòqmelU;^■cpme.jàFJópm-
.,
,„. Vi,;.>*>-., -
7
habhìamo detto della materia} comune al cielo*
‘ D
Toso’ .TfIJL A
L 'D 'E - A *
y alla tm d (U q u a ld rtfc ,efler inane y unenti,
eia ed* agni fir m a fe f i d i eh perappofìtion la jv à
natura d i c e n d o 1 FI fid r itm YJoin ferebatur
L ’acqua , super a q u a s,-benché il i.ejìo H fhreo/n o m in e # *
fecondo
Et. -b\xrsenoxomlindex<fi «-^vErfo. a alcuni » fu
'J
'------innanzi al qua fia t, anlcquam codum y terra» dEt Heine<lrio et alr* feIjU w m & p ro d u U io m d i dentro4' che è dei
lod'cfcrnpiarvi tu tte te coso ; r agione era -, a ie
ancoriapròdMUiorkd^ jtto riftfie a c q u a -: perciò
che omnia per nerbim i f e c t t . Et-a nello. fv e e d
tu tto con fin a li » . E t benché, diCiL^lacqtai efiere
à ia ia favo rita dallo fi/trito d b Eloithyche de >figinficare in alcun modo calore: nondimeno ì ’h i*
in o r r id i ti off/i. m ha (, come ancor pruonafiìo-^
ìfm fir ix Z ù r e ^ iU a lQ ir f m f i a.WitL
rrtorcji .onde eoli pròva m, cwfo rwn e/Jtr a ltr o ’
che lurne v y calor himndo <y i m m o r cali do.*T
J enfia hujual unione non, f i potrebbe f t r gene
rai ione . E t qui èvia notar f xhéd$ k b a ? jw ià
nel loro Gamonc , dopo il.calore mettono In g e
nerai ione ferifia-precedente hum ore * qu a /ila *
fciandolo per intefo Jotto il nome del calore. }p ercioche fono m feparabili. Laqual verità fdul-^~~
m ente conofceremo nel'/ o p ra celef e . . ìm peroené
quantunq u e dicinom o la Chochmfi. acquea , y
la B ina ig n e a .: nondimeno Fsàia volendo d ir ,
che nel fi f i molo di Dio era ogni cofa d ifle^ -Cihaui t etim àotinnns pane, u n a , &> u it ellefin*
f i y l'intelletto e dello fi) trito ) & aqua fa p i en
fia, fa hita ris potau/t illum-» E t a ltr o v e . Egre
d ie tu r uirga de radice ì effe ,. y f o s de ra d i e t
3
D %>T* T H B A' T.
75 .
tin safcendet, ; xq u ie fiet fit-pcrcum fp iritn s D omini \ Spn ttu s-ja p ien tu & .in tel!e£ U s, oso,
se/ido pur la fa p i enfia-della C b c c lm h , & f m - t alletto della. L in it. E f altrove ancor p fa ia
Donec abluerit fo r des filio ru m Sion m f p m t u \
ir u iid j, & in fp ir i tu- ardoris. D o m è d.i m>ta~ t
re , che ejfendo il g iu d i rio d e l(g iin o lo , perche ?
c m n e M tà w n d e d it m ihi, pater ,»/<& e ffe n d i
Vardor dello Spirito Santo , f y ejfendo U m ifu-y
ra del figlinolo l'acqua ^ tifo n io quel, nerba,
abluere, dim ofira, c/;e l'hum or c o tti ardore in -\
fi erti e fi ano co ngiunti. E t non ejjendo u e m tcfi
A tr a per fona a la v a r , che Cirrifio ; egli è qu-efa
lo . che ha fa tto quefiu Uu amento d' tannar mesi
s colato con calore . Si clicf e ben Moso òffe,che.,.
lo Spirito di E lo infauoriua le acque non pariti^
d ic o fe f e parate , m a d i cofe u nite & inffar.rt»:
\
'T f i l f r f r a quello fi accorda Vtotfaìo.nel libro de.
^
cedo: ilquaì tiene n tutta a ltra cofa ejfér- m.ct-cio-,
|
Tonfimi le alle nofire qualità in alcun modo , f c Lvime <%
■non »calar
unito con humore y& lim e •* ^E t diceS&fa*'?}*:
11 t ...................................
ebe il tnm c j t ha m luogo n inteaipcn^qy & x \o di mm
v u o i, cbe'icalor la fi f a f a l'efficacia della tr ita ixt di
f a f f j l hum or fisa il-m o to si & il n u trim ento, d i f ° *
guelut. N e g ai ni fi /e n te altram ente il c a lo ? /
che c qu-afi un fattore £ x nutrim ento y
crea
tione et h igore. N e tu fi [ en te A tra m en te l'Jm m ore, che c qnafi uno aum ento, am plificàìionefi
& f a t t e a g ilità , quali talhor fe n tìa m o appref
fe a n o i. 'Adunque il calor d e t Cielo non puri:
dee effiet eh tornato cauiofom a ancor hrmudo f i
3
■cioè liquidò r flu id o f a p l e , lubricò T y p itic c -— —
ir ^ —
*
sa*
•' t
A : J D È 'A." .
tlóle , esa ‘d ta tto del!a natura jo d u e : d i f i a l
tatto della natura , perei oche quello dell3intorno
non può arri tiare , csa di (fi della n a tu r a , per
«nae eotal fim ih tu d in e al no f i o tatto , csa a n o seri rio p e t t i . E t altrove a ffe r m a ti mede fim o
autore , il detto calore c 'rh u m o r cclefle- ejjer
ritolto diuerfo h i genere dal Hofirò , csa ancor
fin c h e l Ciilor naturale hi un inno d ell a n i or d i
una fornace, csa che la t epide f i n del Sole (bilie
lio fìre fia m m e . Adunque f i come l humor cele/le non d ifilla per bagnare ; cofi il calor celef i e
non [calda per con]lim are. E t cofi fatto hum o
re e alrntp tanto dal n o fio hum ore aereo d if
ferente quanto è differente Phumore dell'aere
noflro da quello deiiacqua . csa io Aggiungo a l
la fia tile opemon di Plotino , che quella di fi creafia , che cjfo f a dal caler csa lum i or cele/le a
quello di quefio mondo , fi dee intender , che
^
fi a ancor dal fu prue eie(le aìcelefìe, Mae tornati
©reano, ; .
J 1
.J
.
<hr cofa do noi al m u n ito , che I Oceano f a ci g li Det >■
& •
jthchtam oT Oc e.ano n on efj'er altro , che l'acqua.
della fa pi enfia, che f u ancora aitanti- alla m a teVia prim a \ che è la pr rena pr od hi tiene > y
D ei Coniatati non ejjer altro che le idee n ejji
~!*mo e jè m fla r couffirantt in un mede (imo [prritoT pVrciochetfUto q u ello ,che è m p i o , è cjfo
"D d . Santo A f f i n o , ora» fautor delle Idee f i
fo p ra quel luogo d i Gioitami!-. Q u o d f a t i im i
oso y in ipfiy u tta e r a t, adduce il detto d i Saiomone: J te I )/o h a u m a fa tte tu tte le cofi: in nitL
mero j in p u f) , O r n i m i tura ; Csa concinne,che
-ijawac
f i come noi tu quefìo m oni(Vnumerando pefan-.
3
7
.
-—'W
M
IM
hu,
3
D E L
t H E a T.
77
d o , y m i fu ra n d o , non diamo co num erat i, p e ^
fa ti , y m i furat i , i n u m e n , i pe f i , O ' te n n ?
ju r e , nitt ce li confermiamo': cofiD io cifia.ueder
tn quejio mondo tu tte [e cofe ben num erate, pe
sate , Cr m fibrate ; tari t num eri , r p e f , y le §
m i fa re ha a cinto c h e ffin o fu o r d i quelle. E t' I
effondo tu tte Te
,<he fonò o Dio o coja. prò - |
clutta di f u o r i , y file tti n u m e n , p e fi, y rtrisare vtoit efjend o p ro d o tti, come g li a ltri num e- j
r a t i , pefatr, y rnifnrati yfig w ta cl?ef i ano e]~ m
f i Dio . O r d i qtajTi num eri p e fi, y rni/iire.*
ne fa mentior.e i l (crii tur a ,c h e neW Enangdi^
fi legge . jCapdìt c n s / l/ ss ne( h i num erati
E t ncifApocatipfi f i fia im ention dei?Angelo ceri
le bilance, y d f i m a ltr o , elicm i fura con v.nn,
canna. E ttn E-faia fi i egge . Ego fir n ip ficere
fn m primns y n o m fsim n s, m auvs m ea funda,a it a v lo s, y dextera m enfia ef!.c<xh±, fi? ) m .
&Airm, c.m hd.ìt calos .
Sono ad/ut-pie fi Idee forme y effm blarl delf i
co/e ejjènitali /iella eterna m ente in quella efijìc titt/U T c o r R m ^ clJeJèfiòJefatte i filtro : ori
ne tu tte l e cofe creale i im n o ? o f f r e , y p o rta come da ftgjlii pqrija tla re riapre f i io n e . E t
tempre nei toro efiere con Dio per fencranc
E t la loro eternici j a che tu tte le f e c i e rimati*
g ano etern e, ancorché g li india nini Jfan c TqE
atubi y m ortali . Aclunente quantunque gPiti
dim dui fi tr a fila tin e , y corrompano onero fi
nafumdemo ; nondimeno'le f peci e y .le eterne»
, .
„ ; .. . . . .
' •
. Jl
— •....——- Specie ma
uiee.ni Dio unte fem pre unto n o . Et p e r qmjjLo nono fcm
Giovanni di f i e . Q uodfacttm uefi, in ip jd u ih i ?xt in Di/4f
D
ifi
'7 $
L A
T D Z A
•pvris . cioè y tu tto quello , ct;e e , csa OV nói
tw »? i amo di fa tto in quefioyo nel cel ejle'm ond a,
erat v ita nel utrbo y ne tulle dir n in o , ma die
de la m ede [ima appellati on del nerbo , che e
iu ta : csa e tinche ben da con'Taerar q u el prete
r ito ”E R A T , che fi contrapone a quello E S T
’pparente. Per legnai : ragioni p v fi amo ben
*'oritr* *J donfulcrare iito rto y che hanno / Veri parca n ey /fa n d o le idee , f y dicendo g li um uerjali prece
dere a poflcriort, non a priori y Csa ciò : percicche la dtu ina japienfict un diniOflranao l oro
s Tombra Csa i paìim talhor di f e ; m a l u fo n a fcoiuìcndo. O ra a d u n n u e fo tto Ut p o ru T d e l
tom i ittio appari enente a qualunque pian età d a
remo g li elementi (em p iicifim i , o nero cofe p iù
m ente o alt intelletto, o credute per autorità
che fottopojh al fe n fo . *
So tto la porta del cottundo Lunare faranno co
perte due ima» i n i , quella A i Eroico , c y quelv la di N ettuno col T r id e n te .
>
.
viv.>
Trote* , V rqteo di più forme con faceta hum ana fig n ifi-
9
cu*"
^ m ateria prim a , che fu la feconda produc
itene . E f ri atujera thè dentro ai (uo canone
fu r a m i noiurne ordinalo per lag In d c u e fi
se ra della m ateria prim a , y del ( Jnios che dire
m e lia m o -, csa della (ita. natura capace A i tu tte
le form e per fàccefioue . D i e ffi fo rm a ,y della
p n n a tio n e, Csa d i cofa n a tu ra le. «. , ~ -.sa
N e ttu n o prom etterà, che nel filo uolumc. fi tra t
terà deli'elemento d elPacgua ptt ri fim o et fr m
p lm f i m o . Si da alla L u n a per efjer ia & u n a
delle fium i d i t a .
D
E
L
T H E
A
T.
Q tiefta m ede fim a f i t t o l'antrofignifìcherà l'oc
gnatico , cnr j t m a n im a li.
Sotto i T alari, t entare-il <rnao.o, paffar l'acqua^
la v a r con acqua-, bagnar , berefiprvTraro *
E t fitto Prometheo.art i Copra ta c q u e ,te m e ac
quedotti-, fo n ta n e artificiate ; p o n ti, A rfia~
ria,arte n ava le,& l'arte-riei notare et peflave.
Sotto iicoaiiiuia di-Mercurio fa r à m a im a g ine di Elefante ; ilqiiA e-perei oche e detto da
- Scrittori efiere il pi y religiof i anim ai d i tu tti osooso**.
i brutif u egli a m o , che nei volum e nel fiso cari, fio r i ani*
none -fi b a r ila a tr a tta r della origine de nsesasasaoso
Dei- fa to lofi , delia Uro deità > r<r de'loro n o r m .& perciò che d a fci calare delle fiutole xcn~
'- n e quella openion, qua.fio (aggetto a M crenwrio-s'appartiene, come a patron della h m m *
& del fattoi c<rgta r e , g u fila me ciefim a figgfttt
' f o tt o f r o m ctrico Jìgaflicherà religi etrt iter f i
■fili. Dei favolo fi .
Sotto il continuo di Venere fa r à u n a f i e r a c m
dieci circoli, C? il decimo fa r à aureo ,
ca
rico d i ([tritelli d a per tu tto , il cui u d - x
4fa r à nt {ag g etto di campi E li f i , <& defittivif o u d de beavi, o X ld fir ita tr im e jìo m e n a e ^ csi
pe rv e n ire , fecondo la openi<'n de Platonici
& di alcuni poeti. Tìt in audio (i t ratterà arri
cor dei P aradifi tc rre jìre . Ut fitto V cneresa-'
locano per la d iletta r ione e t va g h ezza di quei
lu o g h i.
D el c o m izio del Sole Imi ibi amo parlate nel [ r ituo -grado. Or-fi come in quei luo g o , dotte
perii*ordinario deueua effer Apollo n i fu loca~
’ D
esse- *
Eo
t A I D E A
to ri convitilo I coft in quefìo luogo ordinario
■del convivio fitta collocato Apollo : y fiotto Li
'porta fu a nel mondo Jopracelefi'e f i tra tterà
d i T ip h e r e t, y di K aphact
.Nel ede fi e fi tratterà di efio S o le , della Luce,
del lum e , dello fide u d o re , y raggi .
Nelle (tiutdej di Apollo Dio .et fim i appartenenti.
Sol/o ii convinto di- M arte faranno due im agini,
un V ulcano, y una bocca T artarea aperta ,
y divorante a n im e , qual nelle p ittu re Eiaininghe fi jn o i v e d e re .
'Vulcano lignificherà fiotto qnefia porta il fiacco
f a n pii ex
Sotto l'antro? etherg ,j l fuoco d e m en ta le, Tiri- '
tendio ttn iiìerja l e , iTfuoco nufiro , Tincendio
'fXFriCtttdWyfdfiitlay fi lima,carbone, et cenere.
Sotto t T a l art f i grufi chera batter fuoco, pigliar
lo ntll'ejca , accenderlo , m etter i n c e n d i o y
efiingtiere.
•
Sfitte E rane t ìleo contenerli tiUte ÌL àrti f i ó r i li,
che fi fi inno con j n o co.
■*
L a bocca Tartarea coprirà un volum e y dotte f i
. tra tte rà difiintam ente del Purgatorio , y de
purgatura luoghi , fecondo la opvnion d e jg fi
j i r .t t o r t , che ne hanno Infoiato f r i t t o , i lip id i
...purgatorio diamo a M u tr ie , pereioché Ancora
, tl fuoco tnifto e m ar h a i e , y v o n ■■differente
dal?infernale, che appartiene a Saturno oso'-■non in quanto la p e n a , che le anim e pattfeo110 nel m arnale , e temporale ; ma quella del
l'inferno y Saturnina è etern a , contieni ente
- alla ta rd ità d i S a tu rn o .
!
1
D E L
T H E A. T .
Sr
Q uefta me de fim a bocca contenera ancor m e i
luogo , che e.chiamato Lim bo con tu tte quelle
anime y che Hanno con qualche fp e ra n fia d i
fa llite , ,
,
Sotto il comfnùo di Gioue faranno duc im a g in i,
una fa r à Gì anon fu (fé fa y £sa TahraLuropa..
Giunca Jufyefa p ig lia m o la ITom.ero , ì l q u a l e f f i f i f n g e Gioue tener quella fufjxefkpcr u n a caie- ^ i i o w .e ’l
na y csa Giunone ha u erea ciafcun piede u n ?o.
coni rapefu . Gioite è il rettore d i tu tto l'acre,}
• Giunone e. l'acre ; il contrapefi d c ip tu folle-:
nat o piede è l'acqua ; Csa quello del più- b a ffi è
la te r r a . Q u ejta im agine adunque in quefitr
luogo lignificherà Taerefe»:plice . Mae f i t t o
l'altro come nera i quattro elementi in gene
rale , csa’ appreffo l'aere in- particulare c o n te
fiic p a r ti, rj'Jd o i appari m e n ti,fi. come f i d i . rii in quei luogo .
•. - •••. >;/
E t fo lto i Talari panificherà reffirarey fifg ir a
re y tifare l'aperto cielo r
....
■
E t f i t t o Prometheo panificherà qualunque ar
te , che per beneficio dell'aere f i facci a ,c o m e
ÌTnohni da uento .
TTSTropa rapita dal T ero, csa per lo mare porta-Emor* r<$
ta y riguardando non la. parte.,
è,portata , ma quella, onde ella fi è partita ; è dinocl ,
l'anima portata dal corpo per l o pelago di f i e
fio mondo , Jaqual fi rivolge pure aVioy ter* - . , ' ‘
* ra f ip r a c e k fie : esa quefia coprirà un m lu m e
A ppartenete al Parodi fo aero e t C hrfidano, e t
a tutte l'am ine b e a ta g d fcpardte * ctq u efio è .
•
a Ciane p ejjer planetoi d i vera religione*
P
'V "
k
„•
•-'
-
n
- ' L A
T D' E A ! H
f i t quegla fiotto Prometheo lignificherà coirner Jivne , conjcntimento , ar.m cinU tione, fa n til>t CT Religio n e .
Sotto tl continuo di Saturno faranno due im a . gnu , di Ciòcie una , come ella e dejo'itta d à
Lucretio ingim i andata d i to r r i, y tira ta da
~71ue Leoni legali al carro di lei, lagnale ligni
ficando la u r r à , a no; in quefio loco ,figrufi
ci/era la terra Jcmplue & u irg/nea.
Q jiejìa medefirna (otto l'antro contenerli la, ter
ra y le fu e p a r ti, & q u a lità , come fi d ir à
nel luogo fino: y fa rà ancor quejìa /otto i Tct-■
U ri y f a t o Vrom ctlìco.
■
Jialtra nflagme di (aheie p itterà un vom ito d i
JiioCo : . y f it to tjuejld farà il volume del?inj e r n o , y de nomi delle (he m a g io n i,y le an i■ m e dannate Et la cagton,perche diamo I'in
gem o a Saturno,e detto nel cernii aio di Marte»
V
A
N
T
K
O.
Tersa? grado bau era per
I T O W il
. ,* v \sa. ^
L- '
^vyìjM j f ó & l era;cuna nelle. Jum porte u t - ’ ^
pinto uno Antro, ilquaffcroi
}m
W
■
m
i:'i)lilrnntn^ ^ ì'tro Eterne cico^y a b ili n e n ia da quel/a* "
che Eìaton deforme nella JudT
A rato K" - 1eP’ Marnerò adunque finge fip r a il porta ci*
irò t(j floJtn cd uno Antro , nel quale alcune Nimphe te fyui'ì roT~*Jono il^e Purf!tirec> & finge a p i , che e f i o n o , y
'no d‘i u - Uornano a fabricare i loro meli: lequali tejìit# ta '
r e , y *f ù r i e amenti. Jìgnificande le cofe m tjfc
3.
-
9
D E L
T H E A T.
f
£ ? elementare , vogliam o, che qualunque d à . Ili
fe ti e antri fecondo Li natura del f i o pianetti (Il
h abita a confermare i m i (li e x elementari a !nt l j f
appartenenti i E t per batter guai che in fo r m a "
non dette ro s a mif i e & d em en ta te , dico ; che
fecondo la diftinlion mefih da Mo/e, poiché E le
v i l’un giorno creò la .m ateri a prim a per fare
il Ciclo à r i a terra, perche no n fi. contienitia. a l
ia m ateria tu tto Vinfiuffo d efopracele f i rujcclit ; il fecondo giorno form ò la. K a c l n a c io è la
m a/fa de*c i d i , & non il form am ento fecondai
che detto babbi amo a ncora. percio che efiu è
folam ente lo tta v a f i e r a ] £ x m ife la detta m uf
f a d t f l e f a f a l l inondo fnpracdejle,csi l'in ferio
re , a jh ic che d iuideffetacque da fopracelefl»
t v fedii i che non bagnano , dalle acgtte d i q u eJìo mondo y che.bagnano, delle quali fiopracelef i acque è f r i t t o . Benedicite aqua. omnes ,
que fu per c<xlos fu n t d o m in o. E u in tcrp o fltt
adunque la detta m affx celejle, & dijìefa y a ccicche non pi ouefie maggior U n f u fio delle ac
que Juperìori, che alla capacita detta m a teria
f i cm u ein jje. E t intorno a quefe-.acque è d a
, ,;
notare , che Gregorio N a xa rifiem si inganna , Errar £5..
3
intendendo per quelle il cielo crijlalitilo fa ìlw à j.lfì *j?
nanam ente j sia to finto da alc u m j o p ra li siri- et istallino
tiia;cnc.ntii : ma non ìninno ne rani e n n e fondar Ioncrt te
, ,, ,•
, „ °
i .
m ento ne tìena ja c r a } ve detta profana j<.nttu~ .
ra • N el te r \o giorno dice M usa, che ìlio i n
com andò, che fi congregaffero le acque , che
/ c-no fitto il ci eia in un luogo., cioè tu tte U .uir- ,
t è g erm inative infuni? 5 p a p p a r effe fio r i £&
D
oso
.
$4
L A T O
K
A
ftr r a a r id a , a fin che per le dette g erm inatine
v irtù raccolte efia dmeni/]e feconda : ìlchejdlt'o
dtjfe • . Producat terra h eri»am v ire n te m ,
b g n u m ( se dir fi potefje ) fe m in ife n tm . N el
quarto giorno furono fiu ti i L u m in a r i, & col
locati nella mafia de c ic li. La L u n a nella pri
m a >Csa tl Sole aect/ae q u a rtiifì’CYa , per Ugnali f i
csa
lutmjjc -nse/ e s e " ' ^
i voi
le co/c, che batte ano g ià ricettitiv fo rm a da quel
le , che ancor inforniate non erano . N el ciumJ o gtomb-fntrla della Communica finn della u ita :
in ru ttig li am m ali : Perei oche tmol ? chele ac
c j h c , irio o le germ inai ine iu rta producano tu tte
(fib rfirfita (te «li ammali- cofi agitai!ci, conte
tonai d i , csa te rr e f ri qui a baffo , ae difiere n \a
di quelli d tla fu . N e l jljìo giorno produfih
l'interno , csa nel Jktirno riposò . adunque dopo
la m ai erta prim a n&n uepp tanto, che D io creai~fc nuova m ateria , usa della pYtmn f ormo tu tte *
co(e , legnali____
neiy.chiamiamo
m ille , •csa e.V*
-----«littef et sa
-S=S«fc=S*i
eienienta- m eniate. E t lequali habm am o a trovar nel te r .
sa dt *,,r, To' «rado delle feti e colonne (otto la porta d elfotfero
—usa.
t>io som tu' ittisro ; eccetto IT) uomo , uqtTale ejjem o
tf- JTparatament e J o n u a tt, & f a tto fugior di tu t. i ti m u f t ì , cfachl'ricntitl t , vogliamo che babbi a
jm prono f a r li cularcy come poi f i uedfra, :
* Sotto la porta adunque dell'Antro Lunare ,tr o r
ucremo cinque in u u fin i, N e ttu n o , D a p h n e,
D ia n a , a cut Mercurio porge la u e fia , le sfalle
ihA u« ia , csa G m non fr a le nubi
N e f i bah?
tua a niarattufiiare alcuno che N e ttu n o , tìq u a *le era fo llo il comimio , f i babbi a arraedet f o t -
n *• L
T •H E A T.
Se
. toT A ntro , fiotto i T a la r i, £ x f i t t o Prometheo;
ilche atterrà a n c o r ò altre im agini et in que fio
CX in altri pianeti pcrciochc anche llo m c rd
dice : che V lesse banca nodulo Hercole , £ r f i a
g li Dei in cielo 3 £ x n ell'infim o : fiche f e aliti"
n o n fi disdice, m en fi dee disdire a noi iquali
per non. aggravar la memoria d i diuerfe im a
g in i ni cole mede fi m e , facciamo che fi ria eg-s
g a la mede firn a f i gura f i t t o diuerfe porte. P ro t.eofig m fichcra fo rm a g ià fip r a u e n v ta , fig g e r
to y e x cofa na tu ra ie.
..
N ettu n o adungu efiato il com m io fi u n ific a le * ,
feto tento dell'acqua ìn n p lia h ’imo . m a fiìtta l% n
irò lo lignificherà già mi [io : per cieche in qUcfio mondo non ?/<??fa n n o alcuno eleménto fi f u - f i
~Toy che.mifio non jia ; fi come lungamente* ha
pronatoXX tenuto A n a x a g p ra . Sotto la ifìiag in e adunque di gucjru N ettano fa r à contehv.-,
to il volum e , dotte faranno ordinate difiirttam ente per tagli l ’acqtta in g e n e re , & fiacqux^
in fa cete : £ x l'acqua in genere fi d ividerà ne!
[no tu tto e x nelle fu e parti, il tu tto è , co m ed ire acqua jo laniente ; le Jue p a r li, come goccia. .
V i faranno ancor le qualità delle acque , EX de . q u a n tità , L e q u a lità , come dolce <fx fa i fa ,
3
3
3
£X le dotò Ticinii £x correnti, £x gli altri ac
cidenti . Et oltre a ciò i le tti, le ripe, £x a ltri
appartenenti , £ x ancor g li animali aquatici ,
& fatto quefio N e ttu n o , non u i f i impaccia
a n c o r\h u om oyp ereio che e fa l'ultim o creato de
g li a n im a ti.
.
_*
“* "
oso1;sr? c r i
ihCfe/"
Moffiqnandq troveremo Nettunofitto iTdiari osoo
L A I D E A
perei oche quello fipalificano. Li oc cr aliane , che
può far l'Intorno intorno a cnifi un a co/a creata
a v a n ti a lui n a tu ra lm en te, &■' fu o ri di arte ;
uo fi/am o che egli hai di ut nel fico Canone ope
rai ioni h u m a n e , y r al tir ah intorno alle ac
que , cornee detto ancor nelcomiittio .
ì \ t folto Vromei beo ci dim ojirerale arti fu p ra le
acque .
Daphne che fi trafimnta in Lauro fa r à Sìmbolo
dei Iwfcfmto . Va qu ì fi contener a ci o , che g ta m ai ! hcophrafio, cjr altri (erri, tori hdn fe n tto
de plantis co*fir n c o n fig g e n ti, che. fin o le om~.
hre.
........
M a fiotto i T a la ri Daphne lignificherà le ope
raiioni naturali intorno .al.legname , come pie-,
g a r e , portare . E t finto, Ex.ometheo contener f a
i g ia r d in i>et tu tte le arti intorno al lagnarne.
D aphne neram ente,cioè il h.ofichiuo , e h e n J a to ; .
alla Lu/w , cu c a D iana Dcq II e'ficfihi;,p era ,
che è re fin a {come l>affiamo.detto, / delle la tin i.
d ita y filil a ìcquali ninna pianta crefcerèhùe *.
T (U n d c \\irqjlio n e i quarto della C èurgica.
O ceanuni}; pai ri- rem w ,n ) mphas j; forerei. „
C cnt u , q u x Siluas; a i f i qn&fiin m u ia f a x ah
D iana , a in i Mercurio porge la ueJ}a, e l a j e r - \
'fia im agi ne . Si legge f ia le favole Greche, ch e .
ver- t:<: grado Cliotte D iana andareigrtinfa, ejfin- t
+ìie linda do ciln cada n o i g ì : p ia cque,O r comniije a M er
ignuda.
curio , che le f a i effe una u e j ì a } \t per molte*
che egli g lie n e fa c e f i : ,. non ne J n m ai alcuna
che le fi potefje accommodare. L a q u a ìfin ito n e
a da jftnìjQlo fig g fiicM n e la m tita tio nc^ r f i sa,
D K' L ' T 'H ■: A T .
S?
i i t f f >ecie : cioè Ia generatione , /ae eorruttione,:
1augum ento, ia d im in u ito n e, T a lt oratione, Id
rtmt at ione fecondo il luogo, d y i t moto con tu tte _
le fie c ie recitata da A riflo teìe, csa d ip in te per
li fa 01t a g li.
Quefila im agine f it to Vafiphe fig n ifch erà fa
m ntation delTlntomo : o fecondo la optinone , v
fecondo la trasfiguraticn del corpo.
E t f i t t o i T alari lignificherà tnviouf)rc c Trutta?
cofa j ricever , d ip o rre, o p e ra tio n fitta topo o
f u fato . M a fiotto Troni etheo conteneva i m e f i >
Csa ie loro+ arti. L e stalle-di Augia cefi chia
m ate fono da G reci, pera oche Augia fu un K e f J
n c cliifim o di pofj'efieni csa di c a m p i, m a là.le.
g ra n de ah cn danit a di defilé che t enr iia ^ u g a m
fife fi ilj<io Pacfi di letam e, che corruppe la fe r
tilità de c a m p i. Adunque fit t o qu efia im à ? ìne daremo un volum e e che coir,premi età le fj>ór
eh e f f e delle cofi del mondo , le m u ffe , i fi aci
d u m i ; le rii !fà , le im perfettiim i y e y ■ 'T -fim ili non pi a c cu d ì.
Q n e fta m c d efi m a im agine fiotto Tafiphc conten e ra te f i or ci) e f f e del corpo h u m a n o , csa f* o i
eferem enti, come q u a li delle orecchie, del n a ”f i (delle ungin e , deg li occhi, il fu d o re , lo firnt o , il v o m ito , i l m e fìru o , T u r in a . cyc
M a e fatto * 7 alari lig n ificherà le fporche opera
tig li , fr u tta r , macchiar , &C*
L t (vaepe Stalle fi- danno alla L u n a , perei oche
non m h a f i e r c h e f f a , fenèn d a h u m id d à cora
■.r o tta .
•' • ,
\C im orrfra le n u b i, G i m o n f ig f itf c d T d m j^ ''1
n
'
L
A
T
D
F
A.
q u e f i a c o p e r ta d ì n u b i c i d a r a f i g n i f i c a t ì o n d i et)
(e n a jc o p .e in n a t u r a , e t d i q u e l l e c h e d a P e r i p a
t e t i c i f i n o c h i a m a te S i b i l l e ,n / a c h e n o n f o n o a n
cor fa pn t e
.
fig m fe b e r a a n c o r tempo hrieue. E t queflc co
f i (i danno alla L una f i farcJfaJìc.non habbiamo
pianeta. , che in p i ù b r i t u e t e m p o ci f i nafcoiida_
“"(fifafi a /m acine fottoV afiphc lignificherà l ’a Jcondim ento, che può f a r Interno d i f i .
E /
.1
M a fitto i
cofito A
Y a la r i d in o te r à h u o m o n a f io n d e r
tr a p erf i n a
.
.
.
S o t t o M e r c u r i o f a r a n n o f i i t m a g r m f a i n e tto d e l
1 oro
,
r h A lo n i!
n o m i p i ic a h )
f i n ta d i n u b i.
,
l a \ Jt r a m a t e , i l n o d o G o r d i a
i l m e d e f im o c f jd ic a to ,
s
I
G iù n o n
[ n e l l o d e l l ’o r o q u a n t u n q u e n e lla
» i t f l t c a p ìli lo fi: f i n a b a i f i i a j ig i n f i
a l t o d o l i o ? ' e b e t i S ig n o r -D io f o g l i a :d o n a r e a g e
ch i d e fu n i e l e t t i ,
s a
c h e h a h b ia - g r a n J / g i r f -
c a t i o i i p e r c o ji ' J a tto r a p t o l a c o n g r e g a t fo n
fi»
H e r o /,
la n a n e p r im a
,
&
de
ri p e r d im e n to
" f i i l j c f e c e ù f > n d e l ca l f a t o n e l f i u m e f i f o n i m o it
tf l
d o f i n f a i u n i t o . o n d e p e r a n c u tu r a è t r a tt o l'o r
d in e d e
d i /.o r o f iW o y l a q u a le e r a
la fin f in a fif ilff iih " c
l u fi f i n i v ìf lf a l o u e f j e a l n o n e tto E r c u c i l e d a
u c a o t h e e n o n fo ffe
T
ir a n n o
. }
P e rsa
N o n d im e n o t i
r a n d o n o i d a l l a a l t d f i f i a d e ! (n o m i ( i n io q u e l l a
m o r a p e l l e , a lla b a jjc f ig u d e l n v fir o b if ig n o
e lla c i f o r n i r à p e r i m a g i n e d i
tu tti g li
c h e »'a p p a r t e n g o n o a l g fid flr c iò t i
to ic u ìu n ito
>
o g g e tti
,
o del
c o n te g r a n e Q " l e g g e r o " a fie r o
W o lle , d u r o , te n e r o , &
, |
,
f i utih : in te n d e f i n o n
dimeno
’
9
D E L
T H E A T.
t
dimeno di quelle cofe che fon fu o r dell'Intorno^
Quefra m elefim a im agine fatto Fafipbe fig n i* ■
ficherà le cofe m edefime dei corpo bim ano*
E t fiotto i T alari lignificherà ? operati un /e n fia
arte di f a r , d u r o , m olle, afpro .
E t qncjìa im agine con ta l f i g ru fi catione si da'a
M eretir io : perei oche le m ani* che principale ,
m ente fanno quefii g iu d ic i), fono dt G emini «
che è cofia d i Mercuri o \
G li A to m i ci fìgruficheramio tutta l a cpMniiù,
!
d jfir e ta nelle cofe"
~ tj
E lS o ito Pafipbc lignificheranno il m ede fimo W
gli h ù fim n :-,J come alcuno .
Maefiotto i T a la ri lignificheranno q u a n tità a tfc re ta fa tta del?intorno f a i fia arte : come la
re in p e fifij una colà co ntinua, dafjoluere* y
fy a rg e re .
^
E t per efjer quefio fh g g e tto del?Ar itim i etica, h?
q itale c f a enfia d i M ercurio ,, d lu i f i dà q u ef i a imagine .
L a Piramide fig n ifica qu a n tità continua neUtTJ
cofe.
^
.•
•
Sotto Tafiphe n e g li m o m m i, come g ra n d e,pie* '■
d o lo , m c fia n o .
Sotto i T a la ri fig n ifica operatione {en fia a r te ; •
conir alzare ,cd)hafijare ym g rof]àre}afjotigfiqrè, ■- ,
Le quali due qu a n tità effondo lam a della A ri-» •
tirai e lic a , y l'altra
r fiq n fi '
ze appartenenti a d Eiercole tirante la /d e tta
di tre Inmtc ? faranno fiotto- quella im agine '
compre/e fiotto Prom etheo . •
■ ■T ^ d o
Il Nodo Gordiano implicato fi* porto a d A f e / f i Mi° ‘
o
t
.v
.56
L A J O sa A
fiuulro da cfplicare,ct egli im patto te io tagliò.
. • .Sotto qnefìo fi contenerti q u a n tità continua
im plicata , come un filo , od una f i f a a ,
E t fiotto i Talari lignificherà ' ;'<tncar delle
cofi.
I l nodo mede fimo efigli cado dinoterà cofa conti
nua efjd/cata .
l:.t fiato : Talari efjdicationedi.cofe intricate„
G m non fin ta <h nubi è tra tta dalla la u d a , che
tjjciu.lv ella H a ta da ìfivne ricercata di .adul
terio , di apprefiufo un corpo, d i n u b i, cheti
. lei f i <tfimag lu m a tesa con quella egli fi.giac
que. O r per quefìa b effa f a tta a c o iu id i quel
la cofa fin ta fio tto qiTcfla fi« u ra ja ra n m .co n
tenute le co apparenti ,, m a ruoti a tre. . ni
Sotto T a fp h e dinoterà natura f i rm U trice., ssa.
a f iu ta , (sa fra u d o le n ta .
t
.
T t fitto l'T a la rifin g ere & ing/fìfnare.
4,
E tq u r fì a im agine diamo a Mefcarso per efifa:
egli l'autor delle m a h tie ..
• ,
..
Sotto l'antro di Venere fin o cin q u td m a g m i #J
Gerbera , una fanciulla , che porta in capo un,
v a f i di o d o ri, 17ercole purgante le stalle d i
A u g ia , N arci/Jo <sa Tantalo fiotto d fiaffoé
Cerbero è s lato dipinto con tre tefiìe a jt «nifi corCerbero
«O» txMfile tre uecej'ùìk na!MraìT'\ Cui. fina iì tea n p ia refi.
Ce ■rhr sisai.7bere., C / n dcrirarc : Lequali percioche iynpe
fcnific*.
d i (cono molto lim o n io dalla fpeculatiUrne,finire»
V irò j Ito g h e Enea per configlwdetiti. Sibiliti ho—la id o pai fa r alla cent e m p ia ione delle cofc alle,
«I y t . a un box cene , -osa d i fiutato puff a A lic h c
I g n i fica , clic quauiy.iujue. n o fiM ta tn Q a ■lo...
fé
~7
m
D V, L
T J-J E A T .
«n
disfare a que fle tr e nece f i n i i , con poco babbi'ti
mo loro a [odisfare , fe uogUanu} batter tempo
di coi ti ehi filare %
Gufar a imagine adunque fitto ! antro Confir
aera cofi appartenenti allafam e, alUjetc, et al
fanno. V it turigli efieucraggi, et cefi, che fanno
n/ducono . E t a Venere da (tifala figura per
la dilettationc .
Sorto Wtfìphe fignìfueherafam e:;fite, & *finm 3
g r configgenti.
Sotto i T alari m angiar ; bere }<& dorm ire, £y>
confi?Urenti operationi naturali.
Pfifafonc Tromethea ftgmfi cheta la cucina f i
■ ctìttttieideticiofi, £x ledelitie accommodat*
al dormire y come i fnon i, £ y i canti.
L a fim à u lU portante in capo d uafe d i odori y
quale fi* trottata in 1Som a,ueif antro lignifiche
rà tu tti g li odori * E t per effere il u fa o 'd J T e l
n e re , a fie fji d a .
;
'
Sotto i Talari- fig n ifica ie nófire operazioni in
torno a gir odori f i r n d i a r ie , come odorare-'
&* portare odori A M a f i t t o Prometheo contie
ne le arti portin-nti ad odori -, & a profum ieri
HerCoìe purgant e le sfatte d'A ugia e in d o tto e*
frircioche le fattole dicono , che quel Re uedenà
do fi' opprefjo dalle m olte im m o n d izie, chiamo*- :
Hercole a levarle u ia . Ef q u i fig n ifich erd fa- '
cosa nette per n a tu r a .
Sotto Eaftpbe lignificherà te n e tte /ffie del corte
Im m a n e .
Sotto t T a la ri il n etta r fin T a o rte .
'.-'fi,
E tfin * Xrwetberhagnp &• harhm e , • \ -. . ">•
9*
LA
J D E A-
TJ que f i a fig u n t n Venere f i conviene per ia 11d gjififiga > Ù " delicatcTfifia .
„ N 'a r c ijju
Jio
fi p j u t n i o n d F a c q u a t r . n f t o r i a d i q u e
m ando
fiy j i g r u f t c x
la m o r ta i b d le 'fiff a
e m t ie n ili n eh i Ir o tu tr la v u o le
3fa
a f i e n d e r a l (o p r a c e le f i e T i f e r e t % a ò tte
'Tl a t o n i c o l a d o n e r e b b e c e r c a r e .
U
di
'
ip p ic i
E t tu tti noi
a n c o r a , p e r e i o d te q u i v i è J e r n i a y &
le .
, la
Inf o g n o
im m o r ta
O r fo tto q t t tj ì a im a g in e b a tte r e m o la b e l -
l e f i x a y C b e c i a p p a r / f e e tu
x o je n a tu r a li y
q v e fio m o n d o n e lf a J
d e f in ìe r a b ili.
.•
Qitefifa f i g u r a f i o t t o È a f i p h e fi g i n f i d i e r a l a b e l *
Icfifia hum ana egr fin ti c o n flu e n tiy fifi>rh;
’f i j h V'tgbefizgt, Deìettatione, D / J c g n o 3 A m o r e *
■
n Spcfanfigt 3innamorarfi y ejjer amato,.
Sotto i T a la ri fi grafici) era fa r beilo 3 fa rd n n d tn o ra re , (Iiy defiderare3fiirJ]>erare,t& c .
J:t fatto Vromeiheo contenera farte.de hjciy<y
d e b e lle tti .
fi
,
Tantalo fla to il fia(fio fignifica cofe uacillairii0o
tr e m a n ti, q che >latino m pendente .
■ ,
Sotto Vafiphc dinoterà natura tim id a jfitfg c fd ,
,
d u b b to f ia 3 g r rii a r d i t i g l i a r f i »
T ri f i t t o t
a l a r i f a r t e t t i c r , s a r t r e m a r 3f a r d l i
T
b i f a r 3f a r v a c i l l a r 3 f a r m a r a v i g l i a r e } & c . \
Sotto FAntro dei Sole fono cinque im agini. A r
no f i l o , hi V accaguardata da.Argo,3x G erione ucci fi da l '-.erede , u n Gallo.g? u n L corte.
fY .i A polline 3che file tta Gimione .
<k |
A
f
f
r " o f i f i I n c ito d i o c c h i l i g n i f i c a t u t t o q u e f i o
j]
t n e h , ZJ~ g o c c h i
II
;
e tà
/7
crff'O j u ì u i
ir T J T e 3. c o n I c q u a U c o ji j a v v r f i c c
le c c j e
in fc - I
'
s
D
F L
' T
H
£
A
T.
9;
ri ori a u-mire alla a p p a r e n ti della generatione
d i 'hiitano j ccmelo s tm .p fio Ie jn e o n a , d o - sa
iiando a loro la nita d i quello fj/irito , che è n el
le fu e rote dei qual cofi parla E fid a ne/ .
E t jpiritu s erat in rotiti. Questo come che tcn pa lim ita tu tit «li elementi : nondimeno più
fanorijcc il fuoco , che Teiere, s a piti 'Caere che
Tacqua 3 O" (n n ta c q u e che la terra « M a fe
auejla te r r a , che è m en fa v o rita y p e rla n itti
Csafecondità che le dona q uè fio JJnrito, g e rm i
na tutto d i tante varietà di cofe ; che debbono
f f j k r i f a k m entl a 1* Clii- fecondità a noi in - Tfr~ ’ ff7
e fum ivifee ancora la terra * Mercurio Òondo
nel Pima/idro d ic e , la terra per ni un modo e/- M ercurio
JCrc hnm oldJefiìu i cjfere agitata da m olti m o- j f ' 'n{sa5
it i m enti : nondimeno in comparatione de g li m uoutaltri Elem enti esser qua fi fila b ile. E t a g g iu n ge , che non è da creder, che ella, lagnale c n u
trice di tu tte le cof é , (sa che concepì ice s a p a r\\
turi (ce y manciù di motiimento; perciochè e irn’ pojfiilnfcofà , che fe rin a m ovim ento pofjapar
turire, E/ fi come le fiielle fono «li occhi ai guè'
fo rn en d o ; coli Therbe s a g ii a rb o ri, che m ol
to pcr la loro pan!;!a riceuonv del detto v ii ale
[invito , tono a «ni fa di p e li, s a d i
f i o corpo Tesar 'm e ta lli, c a le picare fÈ,
J a d i offa fi" N on è ad annue martini'^1
jìygpljg r T fim b olici hanno {cu ra to il ytiond®
lètto i i p n u jo td a iArgo /, art» 7occhi: perciò- •:
ch eti mondo u n te . Q iiej}I"m a « h u : afiu n q tttT
tu tto ' in ' m i n erfalè »
e y n i j'j/eciv la riiaffa cc ifr e , s a iW rp i alejTir--
<>4
LA
i n
v A
L a Vacca guardata ila Argo, ancor che fignificor po/Ja la terra, nondimeno a noiJigntjicbeni
tu tti i ut[finii C ' tu tti i colori.
O rio n e G ertone, a cut i l ercole tronca le tre te fìe , fi
ne 111w ÒLtm fi ut l i t r i n a tuo , Ut confifieni a , C r l'occaIsetiolr , tS; ■;
s i si
chr dino-sa de! tempo appartenente al Soie . E tq u c jia
** '
im agi ne figni fi (.bera a noi non fidam ente Le età
del mondo , ma ancor le quattro s fapponi, le
gnati fifriiiw per Tac ceffo eyrecef/o del S v te y t
parim ente/!giorno O 1la notte con le fue parti,
tj
fitto Pafipbe lignificherà l'eia deìl'hm m o.
Sotto i T alari operationi n a tu ra ti interi}/) a m i
v\ '
-nuti,rii bore,all'anno, alla e tà , Csi aUvroiofio .
x
E t fiotto Prometheo gli anni a rtific ia li, m in u ti,
horc, horologii > f y ifin im e n ti d i tempo.
fj J c a l l o fa lfaeone^ N on Colamento Li mio apre
qucjia" fi gm fi catione-, ma. la m b lko Platonico
ancora , csi L ucreno d icono , che Q uantunque
■cmemine qitc/ci anim ati fiano Solari; nondim e
no il Orilo porta n e g liv cc U iaicitn grado eccely '* ” ~ "N e;;/c cicì Sole f n d fitut! e r; guardando il Leon e *
Caso mi u c f i burrai fin 'a f i n . Et Vili’airi ore di quejto T h eo tro attenne , che ritrcuaiidofi cidi q Eari gì ne
G iu lio Ca ‘
._ - .
_
m ille, est t i n g o , d e tto ji [ o r nel f i , concinoti/ gentuhu-o-
n ri L e o h u m iliò ,
•da gejaienne tinOfi'e rig tiferàantr- ^
un giardino, un Leone ufeiio (ti prigionia.
y u ime in quellafiala; oso a fui da dietro accofJan '
el f i con le branche io prede Jen fiti n ocuTricrJd*
per le c'ufd e , s y con la lingua, io ''àndatia icc- "*
emulo . VA a queVfoccafnefiTo d y i i iju e l fiato
ejjoìuiofi egli rm olto, e x vanendo quello a nim ai
u a iu to , effondo tu tti g li a l t r i , chi q u a & chi
s a p rae
D E L
4*
^
T H T :A
n$
la f u g g iti, il Leone a i iti fih u m ili and * qua fi
ni atto di dom andar m ercede. llche non è da.
d:re , che aventfije. p e ra ltro , fin a n c h e quelle
animate ifiorgejjc in iu i-effir malto. *
Solare . Q vefia- imiigine-atUmjue contenera i
ecccilenxtt delle co]è naturnlfiper clonip arati e n fi
"Sotto EaftpheJtgji/ftcheradaòccdleifia deiChmT
me , lajitperi '.rila,* i a d ig n ita -, l'a u to rità , y dominio tu enfia degna d'honore. •
Sotto-i.T alari fig m fic h e m fir fit peri ore3ddr. d i»
.
- . «. «.?
g n i t à , y g r a d o ...
Mae figPJ.0 ì'rcnictheo.contenerli i Principati
i n f r u , iqualt m iti da fieriiter ;fin o con preceè*
( i Siati regolati ; cofi p f i ero ben fo r n a ti.
Apollo ., che fa e tta G nutone ira le nula, è im a girne oppofhi alia Cuunon .nafiòfìa fra le.nubi y
che è delia L u n a . Le bea che Homero, induca
quefia ./a itila ; non e .perdo-da creder , che m *
.
g lia tta ro d u c irg iie rre fia g li D t i f i come deceri1
na Socrate nel M esm ie, lini finn tifica cefi m atd~ j
/
• -V
E t f i t t o Tafiphe fig n ifica th ito tn o m a n ìfifia rfi,
' .
y ventre a iu c e . :
Sotto?antro di M a rte :fin o q u a ttro im a g in i,
,Vulcano, una firn eia Ila. i cui-capelli- $7anno leM atiuer fidici e h . O ne fcc p i , ci>e combat tonò f i .
y Marre (òpra un Dracene*.■ .
... .
. ,
Videano parta talm ente fioco L t fignificatione
is L ■ v o c e che non ha m eju er à i dichiantùione, Fuoco ?+
Sìt.pm !;e ilfo c e .tp M X < > m - tr tm a n ie r K c m .
dopa- a fit chela p m /ò tid p a m -fita U c m a p u n g maro
tolUoikO M o^elldLm tet-iiì& wxm fitQ * a n co ra ti^*
L A I D E A
J.afnit esser chiamato a e re . L a onde Cicerone
d e N a tu ra D eorum f f f X fL g lu X , quia confiat
e x ahifs. m/s t«m ìnisgrati ucm nr hoc *iuog; ueri bum dicaturg; Min Alber latine , q uam J tc P
tu r aer. Et benché per quefìo iiiogo alcun/ T a c i
Compagrere!‘boro con l'a ere, che ua fiotto l \ n tro di Clone ; nondimeno ri se u ard and ani ai all/t
fitta natura fi innea . che •• gpr.n-t fupgtiuurr.il *
fuoco , m oliamo che f a più tifilo d el (reco , che „
dell'aire . Lj tanto p m cne Cicerone dice nei
"ni e ie fi tuo a j 4 . A rder co d i, qui- ai b e r , nel d c lum nom inatur. E t a g 7. T ew tts acjpniuceircgT t
Csa /equabili calore finfjn-fhs Ai b e r .
fruirà il f uoco Eli m e n ta le , s a nel terfig-i frego
(ara collocato iìfn§C0 no [Irò . E t pcrciou/e qu«
f a mingine t anche nel conni tu o , s a fo tta a l- ^
tre porte e/t- quelle babbi-amo nel convivio detto
piti ampiamente ; qui ci hajìera di tornar a d i
re,che Vulcano in quefìo luogo fig nifieberà Ve
rbere fi! ( uveo cì n nvt are coni incendio num eri A
Te, et appreffo il fuocoìujFrccon i 'inccìidio'fiarTt™*
cui are J a facellaja fià n im a g l canzone, & la ce
nere. E t quefia im aginc co’ contenuti da lei ne
può convenire ad altro p ia n e ta , chea M a rtez
perciocbc folo M arte c caldo c (ecco, f i cim e c
il fu o c o , la done il Sole c caldo , s a bnm ido ,
L a L ancndtit co capelli le v a ti nerfo*l cielo cofi e
fin ta da n o i, perei oche PIut-omo fecondo Vinto- \
,
ii£ è arbore rivolto y che l'arbore ha le radici
\J
a!!*tu «ni , s a inverno le ha alt,in sù . Q p g c r y ^ /
fiiA & iy o n iridJ u oJcguace uopUonof che nu-an-
D V. t
T *H E A T .
le [ a b b ia a d j n tg jd e r d i caprili ne d i fi
. d e/ corpo .3 • ma dell an im a y U g u a le per- m e ta *
0
a c f ^ £ ,
>
,.
flèti ti al corpo,. E t perche f e im o
. f i cfjnmcfjè ignudo al?aere notturno,più m a n if e
Jìcrebbom i capelli g y U barba ti centrati o Ira-
■
fi -a ' M w e.dalxjelc.i .che alèrti parte d e f corpo ; pro
si c
gliene, che fi ernie ? aroore-pfole r a d ìc iffe d irti
1
. a Je ìufimvoFnuHfìTifio
|f
|j
I
faritfa C/ TcapcIUileuufrojm omG interiere t irriti
''fv fiM id
;
fijìp fi1à cjopracelejìì ca n a fffa o n d ^
I
c che fi legge nell/
C a ntica. G c n u tim f u n f ì x ca n n itb u ,, in tc n |
. dendo.de ffim a e d e fa r ifìe n i ; U gual feiu em ^t.
|s a sp òrta fi «nifi cam nefio)cqnfA?a anim a fi/le p ie - |
? ■-7 n£l del f opracelefie a lg o re . E t nel /alm o fi leg |
g c della r agi.utofi IZ iT J ,Aaron in ,q m ffa me.
4 defimo jhitirnen to „ A d unque que f i a im agine
coprirai! volitine appartenente al n ig o r , a ie
fffja fianer c o fu n a u f i o mondo ,0 * lignifiche
r à cof a uigorofà.o fo rte., o nerite urie é E t to '
ncniiÒpriniTmriT)Tcj ìffic % o g o 3 "corri?avella ,
dellaqtfale da Cani d i Dario f a cencitifò, che
Liba <:effeforbii (opra tta te le altre cofe .
oso tutte
Sotto l'afiphe quefiri im agine lignificherà, nari* C° k *
tura u igorof t , f o r te , e y vera c e .
E t f i t t o i T ala ri dar vigore, ofo r \a , o opera* ,
intorno al nero j ,
_
. . ....
E / è. da notar , che la GaJmrà c tterità , £ ? c h i
per quella tùa f i dichiara..
7
te fir ic o r d ia & ìN m ^
' " .fe:
'* X A
T D H A
. 'flitia ■& p d x o fo d a t* f u n t ,
G
t duc Jèrpentì condat tenti c i , rapprefintane
quella ftu td a , che fi legge.di Mercurio , che f*
incontro in due fe rp i, che combàttetti:-'r ' f o t . tto la quale imagine- collocheremo la dtfcdr- .
d a n * a ja d ifferen za ,et la dinerfità-dcVe. cosa*
E t fa tto Tajiphe lignificherà tale t-rnttqjm
tura contentio f a
•’sa
f . t / otto / 1 'alari con! end ere *
E t fo tte Prometheo Parte m ilitare, s a U g u cr* .,
i
rae terrestre et marituma et le loro pertinenze.* '
M a rte fo p ra J I Dragone è. finto d a m i con qvjffi f 7 j
/ f aeragione »: D el/o habbiam ói pianeti r flin s r
/e loro n a tu re sa- in fh d h -dalle corrifo n d e n ti
^
, ~%api>hott)fopracele(U-* , E t perche la G abura ,
che d a t i aftajj'o «a-tActrte ysaae tper fo p r a fia n fa ^ l $.tijj
una angelica firttlligenfia.. chiamata, Zamae!*, sa, \
clic figntficasteUno di Dio-, Pcrdoche. per m efio
j
d iq u e fla Dio cafu«AÌl mondo.;
perci oclnsd
|
Gabal tfii JiconoTaicHtiiélligenXfethmcr
d t D ragone,, noideponiam o M a ri ta-rc avallo::
)
s a »t qucjla im a «m e daremo un volum e conte;
nenie cofé nocive s a uelenofc n a tu ra li
n
-FIfo tt o Vaft.phe {ignifi eh era natura noci sta, erte
j
sale s s a utndtcturice . ,
vi v
E t fotto-t T alari, nuocere,incrudelire m e n d ica r!
fi im pedire.
ÌP antro di Giove crmtenrrd cinque.Im aginir.
Gnu non j o ffe f i . I due Fori della Lira. Il C a
duceo , a cui ptou-C: Poro in g re m b o , s a le ite
G ra n e.
.
fàitniin f t ffc fa v. nel com m i* di Giove.ancora),
r
i «
i
oso
^
à
gu
n t
r
'Y 'H n r %
kó
(Uve fignifica l'aere /em p iite ; Y.t qu i fig fif iciterà quattro elementi, in unì» etf a t e . coso? *
re in par ti e d are , tlq u d e effóndo di n ifi m irti.. .
r e g io n i, nella piti b a ffi ^collocheremo rugiada ?
brina , m a ttin a , lu c e,fred d e > fresco , caltta-ef
nebbia, nella feconda* n u b i, -Henriguomffarrt*
fì\fhìm ènbipiotH ggut\ffagm tcla y 'n e ù e * toc&à
rer^at
atra co m ete, fuochi.coìr ettii* y f e l
. ...
le cadenti in appaterif#* •
- - •' • *
Qgtefia fivrlv ancor f i t t o i T a ta ri e fiottò T r o tti^
tbeo* conte è detto nel conuiuio * ' ' • '
J s s a l 'jgijleUci Lira, h M ia m o f a t t i pr:
li tu fin a con quefta ragie n e , che la natura h a m W p fa tto g li orecchi a g li anim ali > t i r pr/A* V dlto e®
cipalmetite alThucmo con vie r ito r te , coso oso- !u *hu©* *
commodate a ricever -l'aere fercpflò *da atcùn m<>%
fio tto y im pera oche e j f i f coni irrcc.a g r u fi di:ac -, **osov '
q u a p w yo [fid a p ietra : E r la m t i v r & f f t me*- «
^
merlo g h tiene ap parecchi ato luogo f a t i m ente
contort o , ijucflo acre bàttuto , y entrato nèlk
Vorecchia dell’ anim ale per cuci g quell'aere - d f
d entro-y Uguale chiamano connaturale, coso il
connaturale battuto , batte alcuni nervi didòn*
tra t per h q uah Ihmimale ode . ■Ahrc&qne yU
antichi fabricatori della L ira , per ccmm odirà
di toccare t nervi di quiedaffecero quelli d i fi o *
iq ,j)U i Tori ad im ita tion delle orecchie p ria - ■
cipafmerite d etFhuomo » D i el?e quefia im agine
hauera i l volum e continente tu tte Le cefi ::di*
hi li & ogniEìrepito, y fiutino naturale . Q -m
f l a im agine f i t t o t i alari' lignificherà -ja r flr e d
pito «- i t i s i d f f a r t k w piiU i Q m k * che a è d i*
M
{ mìo.
,
fa' fi
À
•T D FI- A
f f ó Vtànètd Per effir egli patron del?aere ,fe B f o i quale m n fi può fa r fm no-,
i l Caduceo è la verga di Mercurio , laquale egli
pofe (come dicono le fa v o le ) fr a i due Jèrgenti,
che egli trono a combattere ', fecondo che fi è
detto in M arte, <y efri con perpetua unione in
forno a quella jim tn c h ta r c n o . E t quefìa in?ag n e c i d inota'd cofi u n ifo rm i, medefime 9 nort
■ d ifferen ti ,& * e q u iv a len ti.
Sotto l’a/iphe contenera natwrdamici)cuoiè,in*
■ clinata alla a tra fa m ig lia r e , £ ? atta Wepuh*
E t l'otto f T a la ri a rm a t/a , o conferà ai ione osotsiw
■ citata.'
v
'
"*~f
_ Sotto ?r&metheo fila eìttìi & h i c w a fa m ig lia • siti? flacpm U èd fw fii.in padre di fa m ig lia ^ s/si
V
g li noli >V$* fim i*
r t 'Dduae con fa pioggia fo r o , rtntcr clic f og l i à ìS S r r tfa n rfle rip fin rlìw / 'quellifi effo, che rifarlo deffa
T ó ro , E x g li ho rti arile be ffe rid ic a noi g ò f f a
g iti lichen? intona fo r tu n a , pienoosod, & aboli
ti ari fan delie cosa , che ofanì pienituiim e, £? o p ri,
co]a buona nicue da alt o .
Sotto Pafiphe dinoterà buona fm ttm a , f e l i cita ,
' n o b ilita , ricchezza J f i n i t a , g lo r ia , otteni
m e n to d i d i fid e rio .
Sotto i Talari operatione intorno alla buona f ir
Grafie Se rmui >& *i!k eofe d ette d i [o p ra ,
t.xr isimfi Le tre G rafie erano da g li antichi talm ente d iioeto,
p in tT ^TnefnhqTerièua' flm fo naficof l o , <jr que
fin ffa n i fi c a n a ti beneficiò ilei fi.ani e . che non
d W e ffrr piti efato da co ìv i, che lo da . E t G ii-
fi* Cl/rifilo dice „ Ctfmjticits elcetftcfinititi : noli
’
- D E ti. T ”E f i % T .
sor
tuba canere ante te . Eta ltro v e
scusa '
f r a tua , quid f a a g t d extera t u a .. • V a ltra ih
m o firm a tutta , O 'fignific'adlrece.M tordelbt*n e f c i ò a cui f i apparti.epe dame f r a ? e il n ifi y
ciò c palefitr la g r a tin ricevu ta . , .La. te rr à
parte neafcom le > s a .parte ne.mofiray& f i g g i - ■
fic a il.beneficio comperfitò.,gnojìra>:de il rlcegu n to , sa. e d an d o i l d a to . O r qu efila imagi?.
in quejlo lignificherà .c o fiu tiifa y . <. s a , v. . Sotto W ifph en a tu ra b en efica .
;
S c tto l.T a la r i, dar fin ta rJ m iefi ciò, et.aiuto.
?antro di.Sa turno coprirà f i t t e im agini. Ci b e y
^ U ^ r fè 'ca p t, di Lupo ,c it Peone, s a 'eh .Cane*
L *arca del patto Proteo leg a te, V n p a jfe rs a —
l d ar io . P andora. E t una fanciulla , a cui è
capelli levali n erfo ì ciclo fia n o tagliati-.
. *• •
* "*
. 1
1
Ciòete babbi amo haunta nel conim io±s a s i ? » / ’v£&t
fic a In t e r n i , c y p o r J c z c Q r o ìk t.tH n iìè .fit^ fic tifi^ ff^ fa
le. citta da lei fo fie n u te .. •. Q ù e f i a f i .ù r a t a J a X ^ ^ - f
due Leoni nel cJh'o; per cicche come iLL eonec .
.
i;
fin e , dam im i _s a debile.didietro ^ o ih l So h rS
\ f
onde i Leoni hanno cota l natura.., e fiii-p o fi^ p d ^
fe lla parte d a v a n ti, che m quella d ì dietro..*D d
etnefia s'i.detto aiic!i.e(nel im m u to ,
•
ne T alari y s a in Trom ethec.m n u t m i reriifittoce ; pcrciochcfignifchcrà puram ente la T e r r a i
L t fit t o l'antre dinoterà la terra fin g e n era le ,
con tu tte le fite.fi> ecieirm a fia Tp}d<h
sa ..
capitolo y c h efia fe fie rfa rm n ,g m e rih u .s, co n m
creta
arcuT fiT cd fìgm fcfihrh Terra hab f i - : ,
t a t a , s a 'm n J ìa ln ta ta j piana f i y y i c n t u o f a i \
L a jn a m r conta?era
'
,.sa
È
td
_
W tfl
, _x
tittimaktorrejhtè^ t*> « ae*Ufo,,
* " v i\ * c
cotti tn e rh fiitto i T a la tù ie e p i*
r o tim i ,. ae//< p u e s a r Chuomo .naiurabttente^ tt+*
H pNOi/dlxuwa^.fmr ch e m n oónfcrmnQ i nse*t
di > /quali portano U fie .operativi# appreff^ fi»
come g li a ltri m em bri >v . *.» xsx » . Aiy$vi
I n f è t t e . Fevtnetbeo cotti eaeraM ^ G fom etrù »
G tq g fia p lù t& fm tfflA p fa
k p f r ù dA iep ^imperchchc
s
*
.‘
* E t e r n o m>
' -e * « r
y in tf ik lk fiip a r lm
U ri della a g n c p U jra *
q m fia /MKteoso
#^o?f
L il p iù im m o b ile, effond a la tcrr d T tita l natur f i ;
f e jS ^ Q d T r jf iy e jf flh . LJP&&fefie y d iX ù fa ja
dS^eone , y J h C m ^ f i u o ta li ,fi Scrive M u s n i
c ru ki^ cJ ie .gU a m ic h i uolmdo «figurare
T em po
d e s c ritto
H
fi*t**eu'
dipingevano le tr e p r td e tte te fte fa jf tg u eliacUL ->
M lìZ à n th m fi*
~"
.
.
f lp r e U o ttia te R ^ . . f o r t u a * .e f t
p r e f ittila m ettono cefi (a tt# te tr o r c T quale*
m etterebbe s a u n se a d a o s o M o n e i* ^ sa aj'opraflej»
saw Eie quella
w
\
fa ' oso:
U t ferciod>e&guifa d i C^ngaduL uoreil bem*. j
p àfotvroxi prom ette Cetnprtjdljnegtiafaijiidtnk I
ytc/p
ù n a g im cxo^&^e^
tpie^uuefia
eflaìm
&qrkiìfa
^ tkH
ftiptre
T * te m ppkk /j
?
Saturnini a. e y j l à r o a p p a rp é n e n tiy p m io é ì.^
«*•
tu tti quei te m p i , osoe non f i com prenden^pek
uktnanTfay o lontananza d e l ufiyofoiU rSafaVtYnpì Ss
tu m in i+ a fonoLunarfa Saturnini tom e q u e l l e t ^ J ^ j ’/ 4
tre '3 thè lì4 > b *^ o ò ttifa <[4AUmLLdfLmani^ - T
fefianotm lo
I
j p . il g io r n i ,■.
tm a u u ; ttg U a n n i sv> L a k n tm a n \A a d u n q u e
d i quefiò pianeta fdcheiqMtfJìitxe. ptedettktem M
^ JV o s o is a tìo n n s e # * » ^
fin m 'p e r M
paffuti , per lo fr e je u ity è& 'per lo futuro x - t,.
fooso [ a ^ a d f l U L y - k
fit9 k ^ 9 d \
,sa
aeEc«ll«< 4it7e^m « ^«6*
M e t& fty p o rg tfit uefkt*%&
L 4 m « ( e s iiu a e < iw a e g in e A i/lff i^ ^ s a ^ ^ n s e ^ o s o s a ^
i
phc fignificheràlhudm » tffirfottopofton hem k* f a <&&;*»
fo& àw ir.- t. u .i. * v5.< y u ù ;* > .« •^càu as-.n ìiH ^ v fb '
'* ’Ì jo s o
E i s e t t o i T alari u n te le operati ohi dintorno nse*
^
t$mpo*tonconofeiuro'p*rbntananiTa,■e ukfc *
nan%a d tù to li fin e fe r eorfi'lunare ,< tom e ho*'
dugi& e jf a r i^ H g ia re , dar term ine to r im it» ^
v*
# e re in oltro tempo. V arca del patto quantun- g tc i d e l
q u e n e l s u o u l te mifterio fig n ifiìf» i tre Mondi/ P a t t o , ac
c h e ìtabbiamo d a ti a P itti, percfache e r a f a lm e n ^ td
tò f a n a , che un cubito & frte% p la m i fu rava f i .
per lun go, tom e per largo ; & eia fetin cubito
coflandodi f i t p a lm i; figh e,che notte palm i f o / L 4
sap*r b*njpH i y n o i H f f r Penderf i fa ilq u fl/w * ^ ,
E
M ffo fa f
’
;
•? ' r*-- ' .rigfXgl
144
r
a "
jwTo hMbùdaftgmflcàre
d
' e c im a e r a ^ w a t a p o s o o s o a o p e r o s a s
Ai
f i f ia
d o r o , floso
la p r im
osoyw/e / i c i t
a ,e t
U ft c o f^ d iiq fio p e , ( fid a t e r ^ a fir im
e -
'ma {capotta ,. Q r q fifia fc o p c rta 3 fi., come bah*
' hiantone mifiefircuelait,/figwficwa qnefto
mondo m jewrf efioftq 4 piovoso4 #eqti,acd
a * a fieadi,Cratyttclem utatittij. Laoso.corida figmfc.tua il ceUJfi mendo y y fe r tal
'kagianetakfintfyi u# ^àndtiafiroaHreo
tr Licerne ,fignifoam iifitfi pianti «poi hte
usua una ' Lucerna, separata sen. nse (qL tw i per
Ut#, lagutdeancora fignifiefit* A $» k vetfZT
* tfufiorfirifiu
osownse n ^ k
t$ *
tr e n in i vuoso * * t ^ a l e
ro so -
ra diu/na
h
siufffanoso
Li remiflfitkde peccali M ftgnificare esapetsa.;
•- n
sionse i
e
n
t
u
f
i
oso.
jopracelple,. Ify clfiangiitfi fifa rted i m ctyt
cìÓMWàJMU Jaaflafi
fM fm c fa te y X a f
r rn ,
certj^ai^-r^r^Sw^
^
dir me**
X y ? ffib & b } y » m w * ì
y .
r^
y
D £ L tjH iA T ,
danno fmguUre a cicli' f E tffi scunsei tte mondi t
f o c e mentione Giovanni y quando difle *. ,I p >
m u n d o e r d / , s a m u n iu tfierip fq m fiiffus ejfi}
s a mundus eum non cognovit : c h e dicendoj / t M o n < #
mundo e r a t, intefedel [opracetejle, C-Eq u a n ^ ^
dp dific , E s mundus' p e w p jw n fatfus e s t e n s e '
g w fi còdice tejlc f f E i i n d r i e i . E i mundus eurhnon tognouìt,porto de^raondo infofore » A rs a ti
'* * « * c/><? p et s a
\c o m e hdfibidrno detto j s isee m onse/V ;;nseosoosoe«.
Ho per hauer tioi g ià affidati olla (guardia J t
T a rili fign ificationi di. qdellt f . dogliamo \
<
f tld hdbbtn a coprire il ridurne appartenente a l ‘
k o g b V s a d f U t i t U f u e f f f f e r e i ^ . E / qu ejl<f
t i f ar di bon tr ragionevolmente ordinato
v
tiochtconieiteniio Tarca tu tti gre i ti{onds , ($>
cm fegventemente luogo a tu tte le
c t à è ' f Afcd per contenere tu f t^ k ijofe f i ntffrhqj *
tà cotiferudììon del luogo con tu tte le [u è d iff i^
r e n \e ; éofibaueiulo ellaad effer d a ta adunp^ *.
de fe tte p ia n eti, no p può del a ltru i c o n v e n iri -
■
*
Q *£
Jla Jotto fJTnlaft jtgw jich età t n to p tm e m ,
può fitr thuom o intorno a i lu o g o co m eco ìlo ca rf
e f f e q u à e y là .
■
-, iì
Proteo /egaefa 4 d ifferen za del T rotina [ciòtto ^
tbc cn ilco n u iu io L u n a te , s a q u ilev R o ca p ff
da nai per quello *, ib e appreffo f id i r # . E t b e n y
’ ^
A * •
^
t f n r ^ s s a /
Y
- r
y ' /S
F
i
t* ¥
r t A
VD "E A > l
g a tu ra , chi fd Arosoeo ds P roteoper conftglio d i
C e r e o e s u a m a d r e a p p re s s e *li H o w e r o
fc'
%
det
Y in rtlio { è legatura s t r ig a - f j q u i h a b e t a u - ’
r e s a u d iT ^ f a u d ia t, perctoche appartiene al
fe c re to , del quale habbiaPto parlato d i fip ra • *
Mae la lcpatHrj n atu rale , & della quale f i t t o *
quefla figu ra intendiamo » i tale , quale dire*
tno \ La lb irito d i chrrfìo è m ello ( conte haeh- *
u
s tia m o an cordcttoaeì conunno y^ ffj^ ÌL A ìiS S S sL
j ^ e j ^ n ^ O*putte le i
quSffr'JtJcrm T quà g ^ r o W i^ n a tC ffie r b r flgX f io r i. \
o s o s e v e s i n w rìh ou af]'t , le cofi tu tte perireb* *
Im ito .P J q V e ftd è pédàuertMra quella città f a x
G iovanni ùidè ntWApoealipfi fin ta dtfcendente
fie n a di G h ie . E t pef quefto D a u id canta il'
cantico nuovo / vedendo tante cofi riti o v a te . '
H e E foia dice i Creabo ccctnmrtoymn , C 5* f e j^ ?
ram nouarn. E t nelTApocal. ancora e s a r t t f ó V g
^C eaU <U g r cf nona* faciu om nia. • E t q u e fid r la fia la d k I
#
<
I d c o h , p e r Uquale d ife n d o n o , C r osoiosoososas*
W« /?><n(/, c h e k A t n d tr e e tl u m lr V ^ S ^ '
S M T u J jssm é ^
p J k J fe m M L v f w ^ & a d f y t s à m M m d k
I T T s ìa di quefla ri nettai ione nolendo farm ene
rione il P e tr. ( come colui ', "thè m n 'paffàua i /
cesaste inondo ) ftc e -qvtl Sonetto' ? ilqual <co*
trància. '
' ■ Q uando il pianeta,che diflìngue V hore,(dof
r i Ad aIbergarcol Tauro f i ritorna dove- d if f c
-* C a d e W r t n ila [infiam m ate coma) -ri ri<$\
*
*
^
DEL
T H È A T. 107
Che uefìe il mondo di nouel colore .*
ttten a dare a cieli quefta operatione d i tornar 4 .
f a r bello il mondo , non intendendo che Vanimg del mondopiena di u iu tf conte fj/irito » d ie
e C Ìm jl o, portata d a ls flfig lu d a l concavo d t l y
la Luna con m c g g w r a b c ^ S » ^ y feco n d ità' .
fiiando T l Sitte co m
pra d i n o i, j
chequandoT ptù^
Jlion3 che vuoi fa r la natura volendo far la prò*H uttion delle herbe, de’f io r i, y delle altre co-'
fe dem entate - Esifo si non interuem ff 'e epmei ,
bon m ai fia t* tnfiemc fiotto la form a d i quefta
o d i quella h erb a , d i quello o d i quel fio r e . T 4 ^
te è adun ale la tem peranza del dittino (P ìn to .
che à c e jr d ^ n c o fa ffftiftf o rdeaSn ti i
Hi è quello iene 7$c"etl Vropl!STT^^ocaS!SS^
y terram impleoé y altrove dice la fr ittu r a i
pieni, fu n t codi y terra gloria tua - Q v efto ,
,(d p m tk ^ lL w ta J t S X m l b ^ y ti
ùdm on dofi come dicono $fF Igienici ) c »onfo~ Ai
fto
y
la hum ana f i agilità A E t che quello nera*
le eofc. haù
W
U
S M
m
W
f
btam o dal l>ab o. A u erten tetefa ctem tu a tn , i
| i ìrtalu àtu r*, y o m m a in puluer em reu erte* th r . E t Èm itteJpiritum t v u m y r e rio v a ih fa "titm tc r r a ix ió d u m m tf io ^ m q n e
£
T,
_
q f t, K J l ai d r a
tV u m , \noffra quejìp effere (tertio d i t t o , s a
non dell'anima del m ondo. E ta nolo lo d n a m a
(
S o f P a ^ ^ ^ tn f o m q u e la materia p r im a , cioè
Trofeo fieno d i questo spirita vivifica n te, alla
m ijlion delle herbe, & de'fiori > s a d eg l/ a ltri
MiJÌT, fia naturalmente tanto legata dentro da
term ini di quefio fiore, o di quella herba, per
fin che fi vengano a diffoluere. f a t a v i l da no-x
tare un ufe/co
. Idi
l MercitnseTWfi
IIIIIWBBBMWMIBWIHMIBIIIIWIB .......... ^
O au ie Q uid d e alto de fc e n d it.
duo. G
■
b
T ifT féT ffi
Pl^fianT yitam , l; o £ _ —
^ --_____
sar/Vo sapraeuewettte alla ni/f i ione1’, ehetiorrfbbe far U n a tu ròì mefcoUndofi
con q u e l l t ^ i t j ^ f i b o m T fa tr ^ J c ^ i Ò ^ T o ^
j;7fJa& faXnera .v j j j f r f e i j ^ saTi T
anim ai orefice, lo nutrifte s a vivifica»
adunque legato in qualità
Sta
•Imd.tàUbm . adp‘mfar‘,.jf cfp- 4 ,
N pn mori tu r in mundo quicqtiam , fe d cotnpofuaCotporea di/Iòluunturidiilòlutio tnors non
s ! L M m Ù m l x é h £ 3 > v 4 m ; /é " 5 !L
éH tentjfijy,n o » * t t a ,a u * f » n t .
. . - V ' ..
T e r quanto tenifo a d v ^ r l a ' i n v o n d t m f i
Sfa infieme,, per tónto rim an U g a ja , s a f e N
i l i a t a , s a rifiretta quella parte J ifb ro tco colf
itiItf jp ir if o in f l^ if f
■ jf
»■.,, j . •
- ,>f*
1
D E L
T ; H -E , A T .
gine hahbia a confiruar fo t/o d i f i effe im m *
W yfe r m a te , o fe r m e .
.
r
n
Sotto Pafipbc fg m fìc b erà natura ofìinatafa?
im m u ta b ile ,.
- v
••,
E t f i t t o i Talari, fa r coft d c m a k n m o b tle , coìr
me fo r m a r e , arrefìare.
,, • *.vsi>: rr, , i
E t quefla, imagine a S a tu rn o u ie n d a tq p e r la
fu a tardità*
, ,
u.-ns..*
U paffeffoìh a rio fffa i per f i fin Z a a ltrc t d jch fo
* ratione m oflrahaueùja m d e n m tff4 fiU % -£
dandyna l X
.
:
v
Sotto IMfiplfcfegnifcbeYà ih itu ra filita ria * &
huomo-filo , faxabandonato.
M a f it to i T alari fig m fc h e ta andar f ilo rf h tt
f il o j abandonare far lafciar perfina o luogo,
o cofa/thandonata,
v.... si.......
at natura tpalmconica , t
.. v, si-,
W ay^oT aneW M roJigufca afflittiòn d i cp.fi • :x
^
M tto V ffipbe f f f h t t m deWhMomo^jfar
, fu e m 4 e fo rtu n e , w fik c itd * tgnpfalta, p < $ f t
^ in fa m ità
nott ottener
v •
i
o
m
i
i
...
L a imagme fllf capelli ta g lia ti alla fancifffit.*
fanali vedemmo in Marte diflefi ver f o l i ciefi^
*#*»»*■*
porterà tu tte le cofi oppofite, cioè deboli • .^ J j^ o e d ha
c/o babbiamo fa tts fe n x a a u to rità . im bercio-osoftneo^
,osoe AUefie appreffa E
a
Pir e della d e a e r a ta m o rte , il
iCftriqfi taglia il
Ntsa uon fu da Mirtot a%gttt*tQ ,.fin o jt
i
*mo?d*
dependa^
pìuo" S a i
w*
A
I D E A
p efa , N e Xù d p A Pt>reffo V irgilio può fin ir d i m i •
r ir e , fc r n n fia p o i, che Iris ni c u la ta da Giùno/le , le h a u d ia to il capello > Et il confali*
Sanjone .
- *»
**(fyefla fmagine fiotto Vqftphe figm ficbera de- *
h/lttd dell Intorno , ThuteheTfifaynaUtra f a fia,
X7 b u g ia rd a . ,
vi
■ « a. .
Mdsctfe i T d o r i Significherà d eb ilita r ffo n a ,*
tju ie dilatatore, che n e tte fio tìeb reo quello ;
c tic tradotto per/im agine , ì d etto C e le m , coso
duella , d i i detto ftm ilitudin ey i fc ritto D e m u t.
L eguali parole d el Z o a r •d i R ubi Sim con, «che
ju o n a illum inator ( cioè d a to rd i luce ) fono inte r pretate in quefta fimfio , che Celem fegnifichi
( p e r d ir C ofiftaftam pa o u e r la forma angelicar
éì'O em ut unpaf t ì gra d a do n a ó . perctocheuupri
•
DEL
T II É a ’T.
ifV‘ 1
le che Dio non fidam ente tir affé l'anima nofir# \
a lU ecceken fàd e”d i Àri?eU, Wif'^WggFteaef^antivedendo T A n - ’
s a dalTamor proprio, parfo contra il voler della
dtm na Maeestae. Mae Mersitr/q Trifale? fio neh
fuo Vim andrò p ren d ila imagine sa laeftq iilitv - .
per una cofa ifleJJ'a, s a il tutto per lo g r a * '
4 o divino , dicendo cosi a A l pater omnium in± '
telleflv s , uitae s a siu/gdr ex f i em , h o m jn ^ J t^
x ea u fi, atcjvc ei tanqvam ffj&
'uo congratulatus e j l , -pulcher enim erat *jpd4 ;
jr is f k fu i ferebat im aginem . Deus etimi re u erae p ro p rfa ^ ^ m T ^ m n u m ^ c lc fla tu s , operae
eius ornm'ae usui concefiit humano . E/ il medefim o nello j^sisap/o pI _ _ _ _ _ ____ ___
nomo c
eulum
gran mira
HMIiPpi eifilhom
. j.jo,
.|e animai adorandunfaatqibono. -. ratulum : iioc emrn in naturam D e/ tra m iL qt&a colo.
t e^ u T efrm fiA em ortum eflè'tognòfta$ifaj
t
i
S
t
n
T
u
a
i
* diti'
riuy pa rttsa itftnttat
W i j tonnfu^. A U W $crìtiqt*
O a b a lfii hànno lafciato fir itto la fim ilitu d ittéf
appartenerli alla operatione ; quafi uolendo dn$
ffb to h a v e r fattoThuornoafined i operari
" ^ t con 'qifijfa
ta id o u e f a m ention, le opere b u o n d ì d fifiu c * ò
ciam o, n o r fd jé r m ftr e , m a c fflS io if& h o i e fL
-Ifr-r» - —---- v -i.
'.
V
/e r folam ente g li fin im e n ti. La onde alcuni
W k t m p l d ^ i cìnamano quefte oper**, operé ;
'ifterne*
D f jh f raear~*
ìS:h*K»
fJ
ìtS
t l i
|D
E A
r
regionari^ LqfiafTm n acceperis ? Et e da no»
U r , che le più delle fia te quando U fe rittu ra i
fia m em ion dèWhuomoX intende foLm e n ti d d V igterfote, tltbe faràrtùrienle fi tritona tteUàf*.
Mojeintitolalo \oh * cM A & _. s lS lle d *
il} carnibus ueftijìi m e , òfiibus & toeruis com tt*
.........
che m odo . . .
J :r .
«t
na i,ncsv>
W e. per legnali p a r o le , coso, per quel pro
le. Pltt tioìpom é, in e, ùTchtaranffnTead intendere >altro
I esce)- r huomo interiore daWefìeriore. In qùefiafi
• * Q p e n to W e W ^ e ^ o c r a t^ itf iù ^ ^ b Alci b ia d iidppfejjb F iatóne, c^/^ulaendo dèlia natura d e j
Ijfa W Q .: tpercioche fic o m e la u e jlg , osoeper* .
g ^ -o s o ' d j f o s o .
m o non c ® {f u s a usa*4 4 1
s g ù s& T
V e r la q n a lc o f a f o m
d#'
rh u om o. enser confederate le parole d i M òli nel Gcnefi',
Adam fit c
*
' -J
"
- «■ . c ■; . A
*o di trin JaCiamus bommem ad timtgrnem y f i m i l i t u ulrgiiule. dinem nofiram : lequali non fumano finoriV hfl
E tch e utro f ia fa lq ìiith t'ó ^ tt^
fifggttinfe , Hondum e ta t hotnó ; q u i operarè± \
m
tttr iti te rr a .
' v * .V
f
Fra adunque a v a n ti n elfp ra ceU fie fa tto fh u p - 1
I
wfo h tierio re\ cl/e Dio g li formaffè il corpo d i
i n g o ffifiÉ e poteffe operar in quello mondo , »
&*j]erje (fru m en to Ielle opere a u u ife T Et per
ciò Mosa/dfrgfunseTsaF^^^
de lituo te r r a , Ugual limo non fignifica fango *
( Gtime m o l t ì ^
coso (per dir
Coso ) U capo d i latte della terra fcTie era V irgi
nale ' i fiercsce7?e m>h~7jàueud“ancor co n tra tti
vm cctdaj fi conte contraflc la fa m ig lia d i A dagi "
"
’dopa
0
li
D E L
T H E A T.
dopo il peccata d i lu i. L a qual tcrra u irg in a ^
le era chiamata A dept4 sbendò Adam, l resse.
m m e ^ N e q u e fio . tacerò^ chòChrifiofper fio-* _
defitte- oda. g u f i d ia fllunset.se àpprffento £ cn .
pWgfoòFf i f W t ò i e h u jn ^ ex o ip ck ic ò rp p cop+l
cesse ; cioè in corpo fa tta di terra Virginale,
difan ^tu xpurifiimo
.«
K q ù e fie x e fiji aggiunga!, [poi c b tft parlar
' \ ^ d a m - f i a n f o xeutraii , ch'egli quan ti t l JieccatoiottT n tù *
ara in due mad* nelThgrto delle deh tic fomTSJfayr i n a
/Messesi, che MofenojxdjfJe g ia m a i ■ N efprl*^
mo piado adunque era nel?horto fjp ra c elcfien o .
prffent^afoen tcfa^
f i D io g o d eì\v
a
do f i tu tti * beati jn f lu fii • m a come bejwc pec* ‘ r ^- * '*
crio pofif u cacciato del detto horto fo p i
*
n fflfftrM e ttfC s
t^ J ifi& M
^ a tia J d P r e ttc ip e f o :fJ k 3 f a L
r C ^4 Z\rA\cfofle neJhfug fam ig lia ? m a p ecca n * \
g r a tip f o t f i potrebbe dire., ehif o
fo jji ca{Qt(0orifaI!fi7ffuf N ese m arautèjrabfoffa
no jW T JoW iW d'qòfoaqu filo n e in campo, eh* ,
/tyjr/o del quale fin cacciato A dam ; f offe t i f o ,
t [em o cito quefiafu openio}
tp }r ir (ia d i O rn a te . : o r p i JJ Hicroiiimo fS .
jegu ]tatore. V a ltr o m o d o f i f i r e f i e A d a m J
* f ecw 4 °
osoo> PM p f e f e t , fax d/chiamai9 fate
lioso
1
1 n*
G;‘
LA
I D E
A.
m a n ti il peccato era n à ia terra m rgtnal dì qué
fio m ondo, Et mentre dimorò m quella fcn%4
maculare il corpo Jùo di peccato, era in Paradifo T errefiro. Et fa tto il peccato , la terra
tontrafje m acchia, s a cofi venne ad ejjer cac
ciato del Paradifo Avvenne adunque al mondo
fiuto.per Adam quel , che potrebbe avvenire ad
un Baron di Cesane, ilqvale fe peceo ffe, tu tta
la fu a fam iglia verrebbe a contragger macchia, .
ancor che ella non bauejje peccato , s a tu tti li^ _
guarderebbono con occhio, to rto . Peccando?
Adunque Adam ; peccarono tu tti g li elem enti
per contratt tondi macchia . D i che in loro non
e/fendo ptula.prim a v irg in ità , f i può dire, eh#
per quefta cagione Adam f ia detto ejjèrc fla to
cacciato dal terrejhre Paradifo :
Muoi* ***M zfcgHtndo il prQpofetanpJlrocda fapere, ch i
* jf in noi fono tre a n im e , lequaU tutte tr tq q a n *
^ ttm qu e godano d i quejlo nom+ipmunc animo
nondimeno cia/tuna ha ancor ilfiio nome parti fa
colare. Impercioche la più buffa f s a ùicinaq
e t conipagtia del corpo noflro i thiam ataKefr^
jK m : s a e questa M iramente d e tta da Mose tin i
Kephei fnauiuens . E/ que(ìa}percioche in lei capen d r
anima. nnwwwif"' «g
i,
■
i
tu tte le no(tre pajs m u f f e babbi amo noi comu
n i con le b efiie, Et d i quefia parla Cliriflo B
quando dice . ’ T riftis efi anim a mea ufque a d
m ortem . E t a ltr o v e , qu i non habuerit odio
anim am fu a m , perdei e a m . a /qual non affnrando la lin g u a , ne Greca , n e L a tin a , non f i
può rapprejètitare nelle tra d u zio n i la fu a fig n i
fieotione , come ( per cagione d i efempio ).itp -
a
\
DEL
t H E A T ,
ì if
^ !t% ù Im o . Lauda anima mea dominmn;qvan ci
tuiuiueja ferittor. dello Spirito Santo habbia pa
sto tl vocabolo d i N ephei, ci fanno u fa reil
nume. Et fu ben ragione,che il Trop/yeta ufaf
f é il vocabolo Nesnset : udendo lodar Dio cori
la lingua coso con a ltri membri thè formano la
noce, coso fono govern ati da'la N epbe* , cÌk è
p m u ic im a
lUcarnt. V a n im a
,
/ 4 rationale , e chiam ata col n >me dello ff /r ito
\S ^ ^ io e tfu a c ì) . La ler;ta o ìletta ' N e ffim a f £*d^r>euole.
^ btraxulo , da D tuid y d a Eithagora Iv- t t essi«neh
*nhiwda**
da Agostino portion fuperiore , da Platone- Ulna*
^
V
a
S
i
b
:
^
come la N ephes ha il Diavolo , che le m iitiftra
il dimorilo p e r te n ta to re , roso la N effamah hau
D io , che le miniftra Vangelo . La poverella dH*
m e Z ^ d a a m e fa t^ T fp d r tfe ìh m o la ia JB kJjU ff
sier divina permifiion s'inchina a far unìon con
«BMMMmt
- a Y**-’« ' t -osola N efhes , laN cpIies f im ijc e c o n U carne, O f f
la carne eoi dimoni 0 , coso U tutto f a tr o n fiti'
C+r trffm utatione in dianolo f per lagnai copti^
M pe^Ó i ifio i tfg o è le g i uos duofiegm ,
unùs eriuobisdiabolus efl r- Mae fe p e r la g r a » ,
*«t 3» Ghxtfto f d ^ S ir tr iiw n può venire un tan*\
to beneficio ) la anim a d i me/fo fi d i fiacca qua*'
f i per lo taglio del coltello della parola di Ghri**
fio dalla N ephes mal perfuafa, .cosofi ninfee cori*
y la H effamah ; la xHcf1qvgaljt che ètH ttadiu ìnn^' |
J>ajja tfaU natura dell'angelo, C £ J * n fe g ttc r i^ j
temente f i trafm uta in D io . > E erquefìo G b ri-. a
lo aìducendo quel teflo d i Malachia ; • f a * *
•;*<*m itto angelum v ie uni j uuol * chef i intenda •
«.
\
!
;
■
\
f
né
LA
I D E A
)'
d i Giovanni Battìfia tra/m utato in AngehjfiZ*hM
lA pronidenZj divina,ab fintio s a antfrJxcula;
J io fa tto mentioq del coltello del verbo d i C b ri
fio , tlq u d feh> cól Jvo taglio d ivide Tamimi
bafja dalTamma rationale, laquale bàbbiqm*
ie tto h^ver tl uotnedelLfpirito. La onde PaoA
lo d ijje . Vmus e/t ferm o D e i, s a efficax 3 sa!
penetranti or onwi gladio ancipiti pertingens:
vfque ad diuiftonem anim a 3x y J p ir itv t. E t'
afin che monofeiamo le tre anime ciafcuna con
nome diuerfi nelle parole di Musa fip r a tn c th f
'
nel Genefi ; e da notare, che quando d ifie , f a oam us hominem, int efedeli'ànim a rationale
N E t quando dtfj'e, pofvit eum in anim am viven- 1
te tti, intefe della N ephes, m a dicendo ,f la u it
in nare, tiu s ffirraculum v i t a , figni fico la N usa
fa tr .a h . Nonpoffio f a r ch'io non m etta f ip r a
que (li pajfaggila openion dello fcrittore d elZ o~:
f e r un certofirn v id e ro , ouero
anima e ombra nofira > 1 iqual non ft partè m ài d a je p n :
- t '■ ■ r .. '
y
, ■
i ì r £ \ M é M m , td e re n .n M o m e n t' la . . .
torno à rpaancor d i giorno da quelli^ dquàU D io b r i
jcpoluh aperti allocchi. Et perciocbe il detto fc ritto r '
dimoro auberemo per quaranta anni con f e tte
com pagni, s a ccn un figliuolo per cagìon di il
lum inar la Scrittura /a n ta ; d ic e , che un g io r
no ut de ad uno de fiuoif a n ti, s a cari compagni
difiaccata la Nephes talm en te, che g li faceva
d i dietro ombra al capo. Et che d i qui s*àvide,
che qnefio era il nuntio della vicina morte d i
colui : ma con molti digiuni, s a orationi otten
ne da Dio che la detta Staccata Nephcs da capo
,
D H L
T H E A T.
là c o fy ju o f i ricongiunfe : s a coso unito refié
per f in a lfin della im prefit, U qual luogo da m t
ueduto m i f a penfhre , che V irgilio toccandola,
uiqina morte di Marcellof f f i o feruito d i quello* a
EI che o da H chrei, o da C a ld e i C a b a lic i, hau §
v tè M tb s * td . i k ó s & r - r - T * * *
Appreffo dice il detto (crittor d c lZ o a r,che q u e- v \
t
(k M Ó è fiè fr < fè n te M ftm f a » 3 l t J u m f a
tfondeffBmbnmfa* M a che la Pausarsi non ed* fa
f r a , fejjon t i f e t t i m giornoÀstpoffa
s a che per eia Dio comanda, che il fanciullo f u
ajiprefintato a ln i
alla circoncfiont l o t t a i
ito d i , cioè un giorno d a p o ì, che Tanima ratio*
naie ha fo t t a f entrata. E t quantunque laeNense
fam ah non,entri , fenon al tri«elimo «torno,non
samum*
gjaa^MMiiQuojwBiip^ai.iui. » ....
fi bavere ad afpettarlonto a f a r la arcan a fiofa
ne ; affO qudm n debbono interu cmr» fe n p a fd *
ape:effeU N ejfam ah pffendo diurna non può
p e c o re . E t in quefio p o ff aggio cofi confente
Elotino intendendo della terZ a anima a lta ,q u a
iìgjVi.sa’gV.-."Tal 1
do dice. , In a n im a non cadit peccatum , ncque
j"
ptsntt t .(fla b e n voluto il bello ingegno d i A r i- ,
Jlotele prender fatica intorno ad una a ltra tr i-,
p lic ità , che è nell’huomo interiore, ma in qu ella,
' ‘v
non pon e, fenon quefio, ter^ a a lta . impercio*»■•;
che dtfjjutando dottifiim am ente d i tre m tellet- Intrllfttf
ti m j l r i , chiama l'u n o jo ^ jd e
chiamato da noflrt Latini, s a da uoljràrt ìiuréZlt»
L offro} f i fa tto , in bfa$pre,fhe e i intellettoprfa A
hauergiaapprefo , s a pensee
it*
L
I D I A
A
etere. U /eroso intelletto a g en te.
per u ijtu delqualc noi intendiamo .
trufr» cofafi° paffo San Tornalo volendo provar Pintclletfcelso ef; $o agente eff'er in noi, f e ben m i ricorda, d à /V*
prmSsin Ò H ' 0
dtlhtpottnXttn<jflr«HÌfÌM
noU'intel raggio d iju o co , che dentro a noi riffonf i ^ lletto a"e-[occhio, ìlquale noi affai foUente fregandoci a b
Cun de gli occhi col ditó ueggiamo internamente
m fifntUtndme d i fiam m a in r o ta . p e r la qual y i
rota fiam m eggiante ffefifi tfa te auui<%<fadff>
'■
nói fu e g ltn ù , aprendo gliocchl ttetta ofcura not»
te per picciohfìimo ff a tio ueggiamor, far d ifferì
marno delle cofi nella c am era, laqual rotà poi
debilitando fi a poco a poco perde il v ig o re .Ad#
f y e f t come nell umeo occhio babbi amo il poter
Uedere, il uedere \ & la ro ta che c ifa u e d e rc \
1 1 cofi e in not non follm ente lin telletto , che può■
fi . *-- .. j
. >femm mmm. a*, marnwmm» *k msmmOm
l
i
S
6&
"■
c/ta , Che d ir la uogliam o)j*r*tffoànt*ndcr \
1 1 ' w J t l'intelletto p r a tic o , wae a n co ri intelletto m
1 1 u re n te , cioè quello, che f a cheM ondiam o . L a
T J b J o t o t a l i fu o c o , d i che h M a m o d e tto , > s a g £ f
d ifre m t*
occhi d i Tiberio effere fla ta f i grande
• t U c o f ' ^ ùtrtuofàjche per g ra n peTfpfaldifceriCèua neU
* 'U fu à camera la notte tu t te le cof i
h a ondò
fe g u ita 3 che altri ChaptU-, ts f A tr i m en o . E t
’À rifto u u
ce , che quando con àifficult'a a ffifim o gftocchi
né g li occhi A t t u i , quel lume da pp n fica tio n
.
dijùuprófjnrenc ip t.• ^ onffeTScuni a n tia n h a n kò if iia td f ir itto fagli òcchi d i lefu Chriff&effife T ìa ti tofi fatti*. 'M fisito p tició Uòltndo Wr4
D E L
T: H E A T .
tisi
m j x \ r , cosof o n a r e in ogni
UllettoÌQente efler di fu ori, dice che egli nonM . fuor di
tróm ente e fu o ri d i noi,che è ancora il Solefu o r ^ fik c o n .
ftiè p u r i*
>
te Sole v eg g a . Adunque f i come neWoccino nofir o fim d X tl poter Medere , >coso ittKor
hor il
c e d e r e , m a il fa r v e d e r e , che appartiene al SoU:y o ad altpo fù o w c w ig r è difu o ri dell occhia;
icoft quantunqu e ne/ nojho huomointeriore f u i
potere in fefa ere ,.Qice Fi,ntellettopo(ìihde » f
p)0 1 m f , y inten lere ancorj>Tattico innondi»
mfinp rntiellettp agente, che e ti raggio divino>
r is
i?
I
r
i a
f t
*
r i?
.,
.
*;
J é
spentone q i Stm fU ho par che più fia approvata
d a U q ftfittu rq , mafiìmamcnte p e r g u ttlu o g o
1n te lle é ìu m iili & q y i t f f i y a m
te in uia , q u a gradieris... Se adunque Dio *e t
il dati rey è ancor quello,che lo fo ttraggo P a tettf
po * p per fe m p r e . D i che temendo D a vid d iff e - ;, )i t Jpiritym fané} uri tuum ne; auferas a
ffie , fifa altrove della perpetua, fottrattionefic
. f i r m o . ReUnqupntur dptnus v i f r a d e fe rta .
^ -
Il
rii
/
dfutno t fuor (U n o t . y m f o te f ia ssefe
|Iquale intelletto i philofopfn in o r a n ti 4* ^ ^ ^ *
iio il chiamarm pxogipm À perlaquale dicono
ofc [
'
r . r i n
i n
..
i ppfia presso
cedfqu (Jto i n n U ^ a g i n t e ]
p i o non piace d a r k , cola che
non è diflerente nelfientro: d
i
no
LA
I D EA
fc ritto nel Salmo + H o m o eum in honefoeffét,
non intellexit, comparatus ese tumenti» tnftpien
tib u s , O* fim ilis fa flu s efl illis. Conifitéflo
luogo s'accorda quello ofcurfiim o paJJ'agrio d el
S
.
W
o
, si
^
, o s o Ì T
tifato nel N umerus hom tm s , nutnerùs b e jh à , nutnHUs
Licu 1C" (tu*im bejlia. fexcen ti fexagin ta s e x . percioche
i / numero che airiua a mille, per la g iu n ta detto
intelletto agente c il numero delthum io illumi-* ^
n a to . Et percio nella Cantica uolenfio f l ò f i d e f o
rar bene a chi fi parte, fi dice nel T eseo yicu,xo.
Mille ti Ili Sulomòth. Vichefigmftcà . io li deero noti folamente la figura humana, ma an*h il raggio cimino .■ Ver laqùal cesse, q u a t t i
do io fa lu te r b if mìo Eccellentisa. Vré fi ape m
luogo d i d argli il buon d ì , io *fi dirò. Mille fi
l i . Ma m i r i fid a i in altro tempo il dici) tara
re d i quejìt n u m eri. A qunseae spentone p a r ,
che fi conformi ancor Virgilio difitiuendo il fuo
S
jT d *
b a è v f* M srM I
ffTx^iio^Jgffatbero] 0 non bajlando ?humana uolout4 |
adiiauerlù^ n u ffra , effeJ ta co fa d ì f u o v , 0
|
if
J is e w
|
dono d iq u ejlo intelletto. Mae tempo e homai , *
W e S m a n i o W n f f l r e im agini : fiche f a - *.
,
' . •ismmkvmm r
J
rem o,Je prim a h avremo detto una cofa non pu
re appartenente a Theolooici (imboli, che ho d a
. **
■
s w
>
rm.
' -t i
dare a quejta p o r ta , m aartu ttele tm a g m td n
uciauo1 ììlt0 ^ ,catro
top "ofon A p p r e s o g li antichi adunque era in co/lum e,
di ti celle che quei philofophi medefimi, iquali infeena«fottrinc
' * * * t m £ e e K t 1
. J <*
Iota.
Udito,0 mcjtrauano le profatui* dottrine a,ca-
s
^
I> E. Tv ; T H E, -V T.
«I
1 é & f f l.lìosoVoli, poi che le havenano c h ia r ii ente
dM anjffm , Le coprivano di firn ole, a fin che co~r
MM
flmutowy^upipypatiai.«mum* • . • c
-e fi fify c coperte le tene]]ero najcoje : s a coso non
fojferq prophanate. \
lV*
emwuI* :
llqm d cùflume aggiurfe iufìno al tempoJ ] V j r n
j^ flio ^ k n a lm i(tto d o tlfo s m o fiffs ^ ir ito quel •
fi.
usa nome induce Sileno cantitre, cioè ni(w ifijìa re
p \c h ta rattieni e t principi] d tlm o n d o a cjrrom ij^
[
.s a ae N aftlio cioè a Vapro y s a aed esco Virg tU o f
j
poi che Quelli ha c a n ta ti, entra in fattole; co ■
l
sa*jU
Tirana a lettori ignoranti dei
■d^tto coffume. Ad imitatione adunque d i cofi_
grandi PhtlofQphi,poi che io ho chiaramente ri- QMÈk
w la to Ujecreto delle tre anime » s a de tre tn f .
r-. ■■* '
a a l,M r ,%
u sar* *
j f j f o , Era le favole greche adunque fi legge d i + f i ^
« ' & & ^ é i* ch,y ‘ele^ q ^ U lt t ‘a
} i Co,ionl
f a loro fiati enano un folo occpio co m u ta b ilefa duuii’oce»
loro» p ercm h e l'ima ali'altra il poteva prejìaree,
e/ quella,che {‘batteva,tanto vedeva,quoto quel ftchino .
lae cjie non lo bavetta. N el qualfim bologiace tu t j
ro il m ijlerto della v erità aperta di [opra; s a cj J
si fa intender il raggio divino effer di fu o ri, s a |
'«.«»
d e n t r o ù,no,
., O r
« a g » * crtm ra /
/u lto l ordine del quarto «rado,contenendo fot- .
.
r
■*
.*?,
.
"■‘1
to le toso appartenenti allbuorno interiore Jeep» |
■do la naturagli ciafctm pianeta . Et per ttem te l
a l particola? delle porte , Sotto U Gorgoni della
L u pa fa r à U tm agin^ della T a ^ a di Sfitccoffr* 1
qu ale è f ia lf f a ^ r o s a il Lposoe. h i fic o w k
- * *
F
u»
*
L A
I D E. A r y /
«he dtcono i Platonici , le andine che uej/ffina
quejìo m o n d o , fe n d o n o per, la p o r r ù e l Can
cro, coso nct ritorno offendono per quella del C aFort* di {tricorno. Et la porta d i Cancro è d etta port# de
huomini per f e n d e r ta n im e ne corpi m ortacorno . l i , Coso quella di Capricorno è d etta porta d i g l i
D e i , per tornar elle in fu nila dtuim tà , fecondo
}a n a tu ra dell'anim ale, che e fegno d i quella
<
Et e il Cancro cafa della L u n a , dellaquale U Ut }
te 11/gelida e G a b n e l. Et p t r d ife n d e r egli pi*T£y
volte m andata d a V io ? U fcriCfur)?*£'drfina
huomo , dicendo . Ecce u ir.G q b rte l., E t per
tornare a* Ploton* et ^dicono che k ariime i # d i fe n d e n d o baono d e ilo tr iQ a d i Basco ,£osos?d#
m t.
an em èca n u m teje cofe d i la s ù f esas?/^goso4chi
m en o , fecondò , chefiqfcuna p i# y m e m tic
bee . fingeremo adunqucun Z q ògoin m ad,g< ,
d ie m ila fina più alta et ptvjuifib/l p # rte fiu g g g a i ì Cancro coso d Leone ^ y la taX*& in m e \°
con una vergine inchinata a b tr n e . a Et quefia
im agine conferuera fo tta volume pertinente al
la humana oblivione ( quale , che efl'a fifia ) ce
fiuot configuentt neccflarij, come da ig n o ra tila
y la r o \e % £ a . E t quefia im agine olla Luna
f i appartiene, per efler ( come habbiamo detto)
la cafa di lei il Cancro^ intendendo quefia fa n
ciulla per Vanima tn commune d t tu tto quello,
d?e delle tre habbiamo d e tto .
Sotto le Gorgoni d i Mercurio fa rà la imagine
ali una fa c ella accef a , laquale intendendo n o i,
\
che f a quella, che accefe Prometheo in cielo con
Coluto di ? allude,vogliamo chcfigmficbi lo sij-
—-v
_ V
D E L
T H E À T . Ì tj
pepn& fogè l'intelletto p o f i l i l e , o p a f tb i lc ,é f
la docilità,di cui tl uerbo c im parare. D I q u efla ficella parleremo a pieno nel fettim o grado$
doue di Prometheo tra tterem o ,
Sotto le Gorgoni d i Vewere fard coperta la im a
gin e di Euridice punta nel piede dal ferpe : 0 Virde #*
percioche il p rèd e ,
in particolare il calca-gnifica
**
gno o il talone a che dire il ùogliamo , ftgm fica*m # #
oso
ru n a delle potenze <
quale fi dim derà in libera & m n lib era . E*
contencra cjuefln ancor la N ephes. 0 a firn
' che non rifu gga della meritoria,habbtamo a f a ..
per , th è g li Anatomi c i dicono, dal t alene a i
lombi e/Jère una ta l corrifpondenfa d i alcuni ConsfpS#
n e r u i, lagnai f a , che le fc n ttu re alcuna uéUu uUant*t*
ptglino ?un per l'altro. D i che Ohrifto uolen- lombi.
do d i r , che t noflrt a f f e tt i, 0 la n i f r a uolon.’t à falc/Je cafltgàta 0 monda, desse. Smf lu w Lt ueflrt p r x a n ftì, 0 anche lauo i piedi nel fu*
partir e,et uè g li affetti a gli-A pofioli. Allaqual
lavatione non aulendo confentire Pietro,gli di f i
fe . N ili lanero te, non habebis partem mecnm.
E t nel Geneft èfcritto. Et mfidiaberis calcaneo
eius . AppreJJ'oJì legge n cllefa vo le G reche,
Achille fanciullo p efjere falato immerfò nelle de
que fiigte,efler divenuto in tu tte le p a rti m u td ngrgjìfk i fiduo che ne i piedi, per eq u a li fu tefiuto 90 doue [acque non toccarono ; fiche f i - f uor che
gm fica y che tanto huomo iti tu tte le p a rti potè- nr> P,rdi *
« u efjere c o fta n te^ u r che non foffe tocco
t* 4
%* >•
^
- t A I D E A
;
N e fiivfat mifiero lafine a n d a n fi d r a ^ N
•f tire f i nello dell'oro perde Vano de cal^Ci nelfin
m e unico al mondo ferina u e n to . De* piedi d i
A ntheo ripigli tin tila fin c a della terra q u a ltw e p e c o tta la to cca va , rie pariarem* al luogo
J'uo. ! • '
*
■ ,•/.. •
Sotto le Gorgoni Solari copriraifi la im agine ^
. d o t Ramo d'oro-, & quefia à fig itific h e x $ J fa ^
teUetto a g e n te , la Nejjamah L'anima in generi
i
\
r a te , l'anima rationale, lof p i r i t o ^ y la u ita /r0*.
Sotto le Gorgoni ut M arte fo r a la ntlSgirrtriai
Una fanciulla con un piede fia L fo , coso con la ue
f ia f o n t a : Q uefia fignifìchera la deliberal'enne‘j onerò fropofìto f ir tfto , coso nato Jabito,a
dtffereiC fadi qtielLi deliberatione, che è una co
f a tfieff 'a col configito, lagnale è G iornale. E t
•/
te j f e r e f i ì n t a & fcalljba/Jtti è iute f i per la d ichiarattone de*lombi f & . d e l .piede di infine
fe n ic o . Et.quefia figu ra c i ejprefje V irgili4 rieUa fu b tta & fe rm a deliberatione d i morire 1 *
th è frce'D tdo dicendo de l e i , che ella era
V nutrie x u t a pedèm uinclis, in uefìe recincta*
Eèdàiu ih a b b u tm o noi prefi quefia im agm e + i?
B ettole Gòrgóni G io v ia li, f a r a d a im agi v e d i
una G ru > òhe vola v e r f i il cielo p orlando nei
b exConti C aduceo, y lafitamiofi cader da pie»
d i uria p h a retra ', dfihtcp*aìe-lefaette ufcendv
cadetto-nd'in/du per?aere ffargendofi., quale
hò iò vèd u io nel riuerfi*d i una antica meda*
ntro fignl nsenV'AF Ì llu G ru fignifica l'animo vigilante ,
* ca *1'1' fiqudiegta H.inco d ìi mando, coso defuoiinganm
laute, ■:.» h i ; p e r boiler tranqm ttita vola u e?{ó,il C ui?
V
D E 't T ti ÈVA1T.
115
p o r t a n d i Caduceo in bo cca , cioè la pace 0 *
la tran q à ftitk d i lui. Et dae piedidecade la phot*
retra con le fa e tte , che figoificaiw le cure d iqnefìo mondo . A questae imagine Jiconfintut*
quel uerfo del Salmo. Q u is d a b itffiib i pennas?
jic u t columba ? 0 uolabo, 0 requ iejcam . ‘U à
-, che tradujjè il Petr. in uh fit o Sonetto defide-*.
rando pur la le della Colomba daripofarfi ? 0 X
\ leuarfidt terra. Q u efia g en tile in w g h g ifi-cor*
S fo rn e rà la dqttione >d G tn d tc jo .g y d .twftgfio*.
Et f o c a quejta irnagmt^ a G w /to # per- ejjètv
Pianeta q u ie to , benigno > 0 x d i m n t e <cotn*f,
pofia.
si.-»
i. » oso
Sotto le Gorgoni d i Saturno fa rà la im agine*
di Hercole > ilq u a lk tia Antheo fopra il p etto %
Hercole è Vhuvmno ([ itito , Antheo è-il coppo #
petto d i Hercole è la fe d ia della fa p im z f l,e f d e f
la p r u d e n z a . <fluejhydv*(a$w .dÌ£& È 4 plo ^
fanno continualotta >i0 d n c e ff4 4 g u erra ,p e rA .
tm b tjt r n ^ M s g ^ à s m m m à U ì L
- rito * O 'sa J fw to s w itM r ifo fiaxne^ jiepMaJo.
fp m to efferutncitorffdko haitagUa ì fonarle-*
ua tanto a ltoda lU tepra il&rpeifa c h e oso pi ed fa
cioè congli\afj'£ttù.i nohpofjà ripigliar le f o r \ t
dalla m adre, et ttintòrio tent*a falcetto, che lu e *
r id a . dove d 14e cofe priueipalmente hubbiamo-ft, .
nei ueroy f à i corpo nafirof o muore della m orte
A t^ l, a p t t , ^ »!>y p w f a c J l . i r j t u d e ll, q a r l ì
uno in C h rtjìo. .Della qual ritorte cofi parla
Paolo * -Mormi ejh$ y 0 tirtajw flra ab/condita
*
J
t A ID E A
tftc u m Chrijlo in D * > ,sa D avid »
con/petlu Domini mors fatU iorum
Salmo 6 1 . (i le g g e , la carne rivolgere il defiderio fuo a Dio al pari, dello f p ir ito . Siù u it in i #
usanza me<t, quam m ultipliciter tib i.caro, mea.
E t Paola a lte r c o a Ehtlippenft.
D eni reformaturus oso corpus hum ilitatis .u e strae, configurando ipfum corpori claritatis (u£„ f
•
E t Chrifio nella f i nuli tudi ne della morte del
^
g r a tto ., Noso granum fiu m e tu i cadent in terp fa T
' ra mortuum f u e r i t , ipfum foXfornnhtmt*: f i
autem mortuum f u e r it, m ultum f u tiu m a ff e r t . Et sa ben faro, conftd erat a la no(ira in
terpretatione , f i trouerà , che habbiamo ancor
WOnifeft
la trqfm u tation e, laquale è Luna
delle due cofe da npi propofie. Et a e gen til*
m ente tocco il Eetr, quando d iffe. "
\
apa
»
v Vulusao ni ctel cònja terrena fuma •
: ; J.
I
Q u efla trffm u ta tio m ancora affai fi m anifefla
«orgonl nelle tre cieche forpile , lequqfohauemloJòcchio,
«U uii’ocdentro lorp , m a d if u o r i , s a preftandofi
denotilo lòuna all’a ltr a , coi^eM^Mo f t conformano in-,
fie m c ,& diuengono una cofa ifieffa, come Nusa
fam ah tira ta dalT Angelo , eh» tira la Jguach ,,
s a Ouellae lae N ephes. Et cofif i fa la tra fru itapioneJffmtufilc { H l i q u e f a imagine per sa-f
g u f a r e s a ten a cità nella flr e tte fff j, ,c h e f a
H erco le, C ^fidleuationdaterra in altocoprfa
f a u n uolume , i ^ l
faranno is fijm e m n ^
le cofe a quefie p a rti appartenenti, copte l e m prefium i >*he l ’anim a p o rta d q le id o .^ la m e^
m o ria ,la fiien Z a ,la qpemone f l'intelletto p ra t-
I
|
i 1
(
*
}
;
oso
O R
L
r H E A T.
li?
, il f é nfam ento, lagna*;
p in e , c u s a contemplatione. Et a Saturno ft
conuiene quefta im agine prim a : percioche f a
mede fuma mi fura nel fopracelefte della Bina ,
cioè dellhntelletto, è comune a Saturno . Et poi
per efler co(a ferm a., una altra imagme fo ra
ancor f i t t o quella p o r ta , y ciò è una fanciulla
[m
ascendente per lo Capricorno. E t quefia fig n t*
% fichera la afcefa delle anim e iti ciclo . E t queim a g tn s jd a ta a Saturno > per eflère il Co*
flicornocajadTliéi g
B A S I P H E.
P latonici le anime
■■■u . .
Carro
nostre lafufo bau ere un uebtcu^ttìxwm
lo igneo,o nero etbeteo, berciooso? ? 0 ***
~v >e» *
f JC
Alatone
che altram ente non bau rebbo^ U'anlmc#
no mouimento ; percioche cofa.
non fi m noue, J e n o n ^ r ^ l Q ) del corP? *
th e c comprobato n e g li angeli da D a vid ,q u a n
do d ic e . Q u i fa c it Angelos fuos f l i r t i u s , coso
mmijbrosfuos ; fla m m a m ignis nel urentem E t
aggiungono iR ia to n iciP che quando a ciafcuna
delle d ette anime è apparecchiato nel ventre m a
ttipoM M eìnculo terreno ^fe b en ? anima t c b jg .
n e lfattili f i mo uehiculo ig n eo , f i uolefje CQfU-g •
te r col corpo, cioè uehiculo te r r e n i, non potrei?*
h e , percioche ta n ta fo ttu tta * con trofia jgrqll o o N o
i
M
Z
i
'
coj Meni re
ch g neC e LU éM St^ E w ii> & f o n altro*
Coso che per tanto fu n d en d o p U tlìC iclp in G * *
j ?
m
? ; e a
r t) E x
_
«X — ,
Ìo , sa di ffsradi eUrnenMjnffiera aidwient9\XH*tHHtvMgkV/Jàwkfc
q u if if il Uelfi* cnio a e re o g iln v a h e n e n d ^ d a indura & ■ £ $ /»
usa? usanè riilic-UmfmUttMtfi : Qioso* (f o n o »
tie n e A iiùjfaV'tyitltoridfffiov dove dice, y d fo le
«i Ottime peccaticia parfanfyfiJk.qKaftQ.fvrlip, an
•». <*rnsee ellef a i t t m n w b .itylo f im o b b e y x c ,
* per tu lt r eie THIi sano lilie x c jl^ 0 g c o a s a per
r utgato- snl capitoti nonno a foofin purgatori* fio ul ta n - .
r i o *r™* ieWi?/*s svino)chi’fkU’MMO u fù ctd ó jyn o libere
trin aate
im e o , pfièlffuoLeal
e l quate al beato
g ilioj '.V" ssaa r.r.trin
te nel
nel (>w(\
pnfAÌgneo^
beato
tf/ceg^oitosi^
a fin
Jjfc che nonfojje pApbatiM ajfuicoperta nellafiheo
m
rarità
1
.....
S S - ^ x f i a q u d l f o o n d o À ^ l ^ l é f ì cade m a t i d ì t à
c f i^ /c d ^ e lc e r p o . Ee n w nseps^^ l^sar csunse^cqpusa
AVi* *t *■S S S y fa tanto fo itiU P i a n t o
k \^ W
dnaV acca fiuta-, che figmfya, il fiaUifiprppritty
reo , eoV qndU usjutta a m gd n ttg jm rit.
:ctpifceet 'partorite* un mojiro chiamato $ i %#>-*
ram o ; delqujle al fuo luogo pal leremo , Q£ae'
rt ;;Aoidnfe uolanu tonleuctUicofe, a x f j x f i n jtp .
rtea >-usa non fili'(inumo*intcriore
& tie, M m pm fam teriort folaw
k
m a a tinti *, che e coperto am or dallo, ejtenore,
yjmmmm '
appiMjji
m entir a par titolari del corpo Jecon
1 i
i
r
" ì '" ?
oo la natura tu ci alcun pianeta , legnau
b r a pitr titolari^ e yfo g g e ite alla n a tu ra fe l con
.
tienenolpianeta faranno Jitu pH fo lto la u ltim a
*
< r.“ *.««&*
3 vr ..-. ..*JflSgMtaMV
v, *
m a ffW T
'
*
f
_
D EX rT H
E AT.
«f
tortaginè, c h f k r k m f l i m M f o
ò ~v 4
Sott* i^Pafiphe d eU a^ bih iafarxn ofw rm agw i.
V nae 'f anciulla fe n d è n te •per sa i iCaencro oj e E t
quéfìa ftg m fta I m ir n a fie n d e tà ia i cielo y lae et#,
traetaesud nel corpo) la dim ora d i quella nel cor
po a u a n tiilm fc iin tn tr Y & d nafeimentoco'ioro
apparten en ti. Didw* y a t m Mercurio' porge
la nef i a , 'fm n ficam utatron Satnm o o d i fig u ra
d i corpo'1/' 1
r>
*;lsay •*.* sm a Le Staed*d!Ar£M fig n if^ rttio b 'fio re h e zK à d e l
'T
.i
corpo\ - 0 i j m i efctemcnlié - v-n» binrvv.-i i ;? i
•
G tunon fi'4 le ndn /ìgftifica afiondim entodi per
fin a f " s
\ ‘ 4'' •
; sa. •
Vrometheb apprefjtì m i.m on te, Uguale f i m ette
in dito uno quello d im a catena atta cca ta . a l de t
to monlè . ‘ Et è d a ff ie te ^ che nelle aortiche fà ?
f
noie f i le g g e ^ ^ T ^ firU ' fmto"» che. Hromètbea Prome.»
/ere ìlei-fuoco G rotte l olego^oaondanmkad .esser1 heo ,If£?
,
• J
si ,
•to nel nro
legato con una catena al tnonte Gaucajo., pii» tt Cauca*
ini jjò dada fu a piet à lodibero se £ìf egltgrcrto^0 •
d ifobeneficioj> reje u m ^ ietl^ d ella catena,&
u n p o fo d ifa f fò d è Ì ,G ^ ^ ;0 ^ m o 0 l^ d tr Q
feìegò'n d-m dìtò w 'Ó ijd éW c'o n o ' essere a d nn m
tem po'nataìa inuentioivddio.anello , 0 tl proti
tterbto d i b a w n fa filegata aeldito . mQ u e fia im a Anello
trine
la, OwwM
gratitudine
obligatione
, ° ncJc
C
> ,confermerà
. ,
Wì* rn.w,aKla
a.acw
u.uOl>
0 il dcbtto90 j i m i U . 0 s}appartiene alla L u
na per [apparente beneficio, che tu tto d ìr k e u e A
dal Sole p iù che alcun*A tro pianeta *• 'sii v ; *
V ii T auro f i l o , tlqugle ha a contenere (fico m e
tn ogni altra Pafiphe) alcuni mem bri delfo rp o
fum ano . E t di quelli alcuni c fir a o r d m a r q ,^
E
T
i) 0 '
L A I D E A
a ^
alcuni ordin an j. Eflraordinaci) chiamo fppp»
CEp# dtU ioche efìendo tuttsy l ^ po JeWhuom o Yeconda.
S fo tr o °
Astro logt consegnalo all'ariete che è uno de*
l’Ariete .sagjw del Zodiaco,ragioneuolmente u a tu tto fa t
to d T auro della Tq/ìphe d ip a r te ,p e r . efler Va
riété la fu a ca fa . N ondim eno leniamo fu o ri
d el detto capo i capelli, la barba,coso tu /ti i peli
del corpo, cosoanche il ceruello. E tg li conftgnia
mo per la loro hum idttà o per la attra ttio n d i
oso duella, a membri efèraordtnanj dellj^ L u tia ,la - *
*
quale per membri ordinari) ha tl p etto ,et le pop
pe ; percioche tu tta la parte del petto è fecondo
—
gl* Aflrologi del Cancro, che ècafa della Luna,
Sotto la Fafiphe d i Mercurio fono im a g in i. .
liv e llo delVoro, ilqual contiene lagraue%?&*
Coso le g g e r e ^ jt del corpohum ano, la a fp r e \\a y
la m ollitie, cosola foUdeufti di quello.
G li A tom i fignifìcheranno quan tità difereta ne
g li huofm m , come alcuno ,
L a Piramide fign ifi cheta q uan tità continua ne
g li huomtm , come grande, picciolo, d im e ^ a ria S ta tu ra . Giunon cinta d i n u b i, fim ulatore
Coso difìm ulatore,afiu ta eoso inganneuol natura.
Ifltone legato ad una ruota fignifica fecondo la
o penion di Lucretio le m ortaii c u re. E t a q u e J la imagme farà dato in gu a rd ia la natura nc*
goctofa t fa tico f a , coso i n d u s t r i o s a . . >
V» T oro . Quefio haura per membri eftraordinari) la lingua con le fue p a r ti,& confeguen-,
u >
4 parlar ordinato per
li fu oi capi ben. diflm tf ic o fatantomarauiglio^^
f i , quanto f i u e d r tp c r li tagli ddfuQMQluj^e.^
D E L
T ‘ H E* A T .
131
'
I membri ordinari)farannodi due m aniere,per,
hauer Mercurio due cafi , cioè G emini & V er
gine . E t per conto di Gemini baurà g li homer i , le braccia, & le m ani per V ergine hauerd.
Sotto Vafiplye d i Venere fa r ano f i t t e im agini.
Cerbero fignifi cheta fa m e , f i t e , cosofonno .
Hefcole purgame le Stalle d i A ugia, contenerà
le nettcX/fe del corpo.
N arcifo contenerci belleZfaa, uagheTffd,leggia
dria, a m o ^ J iffg n o , innam orarli, defiderarfi
/peran na cosos. coso baurà due ca ten e.
A accoconl'hajìain mano uejlita d th c d e r# , f i g m f citerà lui non uolere com battere, m a darfi
buon te m p o . E t per tanto bauerà uolume per
tinente alTotio, coso alla tranquillità dell'animo,
dinotando natura allegra, fillcCQ(euole, coso’
che attenda a darfi buon te m p o . V n Minotau-:
r o . Q uefto è il parto di Fafipbe fecondo i Foe
ti , congiunta col T oro. E t qui è da notare,che:*
la [fftìlc g iq Jim bo lica M n jen zg im iflerio h a r
introdutto non pure il M inotauro, m a i Centau _
r i , coso i S a tiri, coso i E a u n f iy f im ili, c h e f or-Satiri 9c
tono la figu ra humana infino al b ilico , eoso d a l* 1™* f 1}*
... . .
a*.
-fliì&mx*
m ass li fot
bilico in g iù la portano di befiia : percioche g l i - t ì , che di
fiuòmihi , che fono uitiofi «foso d ie non fon obar- DOt*>° •
hanno foìam ente la figura hum ana, m a nel r
manente fono da efler comparati alle befiie* Seri
upT laton nel Tim eo 4 la parte irafeibile nofira
efler da dare al cuore, cosoche la concupifctbìle è
f i t t o la cartilagine chiamata diaphragma ; fo t-,
to laquale fono fatte le pafiiom : y
F
quefia d f i
V
.
' I n l f - r ' h ' E -A
.
* tfdféfU .tfi noi da M h m /d é fìv n . E th A u e n d o X ^
9toi qu tfh t fù rie piubajfkcom unc con U bcjhe.;
f i l e <omp t a cèktn)o}diHentrino befite. Cotig r a n
ragione adunque g li antichi hanno Jiìtio lìm o * ,
m óìrasjorm ato'm bffita daqueUa parte in g iù . "
A ìk th ifié à f o f t a imagine daremo natura in* % >
d itta ta al uttio,quantunque non lo efercitaff'e ,
qu a l fu quello d i Se cr. ite por la confefiion di lui
1
mede fimo . Et questo dico , percioche tl tutto
dii
ffercttato fi trattava ne Talars i
e*.
^
T àn talo fitto tif a fio dinoterà natura tim ida,et
f itf f e ja ,
dubbio f a , <jr m aritutgliofa.
V ii Torà per ^Membri eflraordmarq banera il
ìiafo 0 la Uirft* odoratiua, percioche Venere
ancora ha g li odori ; 0 haura ancora leguaneie , le labbra i 0 la bocca per l a i or be'UZflfa,.
Per m ombri 'orilmartj’ ha» ria per litu ro tl col
lo , la g o la, [inghiottire, à i im orare , 0 per l a
libra haura t i parte d id ie tro che è la groppa* .
Sotto la Eafiphe del Sole faratinneinque imagoiti ; Gerionc ucctj'o da H ere.le lignificherà Ve*,
t à dell*Intorno.
,
I l Gatto col Leone ftgnificberh eccellenza,fttpen o rità ,d e g m tà , autorità, dominio dell'huomo
in cofe di honore .
j
L e Parche fignificheratmv Ì huomo efjer cagion
d i alcuna cufit .
\
.v*i- .vysfcto
L a V acca g u a rd a ta da Argo hauera i colori del
corpo hum ano.
Apollo ,che ferifce Giunti fra le nubilig n ifich erà
ha m am fefiation dell'huomo, et il utaire a luce .
Va
Tauro
per mcwfprt
efiraqrdm qrq hauark
j
D E L; T H % A T .
JJJ
g li occhi con le loro ópcratipni,xome fin g i}{tifa
ra re , ib i edere, coso per m em bri orfimarij/oaug^ *
la fichima, coso t fo n d u ,p e r x jfir quellasiel Epa*
we-, che eoafàdel Sole <
sa
Sorto Maerte faranno f i imagini oso.,-oso .s a ,
ìfito n e , cJjem ol M ra c c /a rla G iu n o n fittiti d i j,fi0ne ^
«uhi : che fi legge nelle a n tk b e fa v o le , che Sfila slU
nefu si superbo d i natura. y coso si arrogante, Coso
>
f i prefivntvofo, che f i n w batterea G ip u r a fu n
•
rifletto , vpn fidamente si Avide ad amar G iur
itene r m a ancora de fuoi abbracciem enti Lt r icl/tefi. D i che ella [degnata, per Schernirlo fin
fe una G tum n di N ubi; con laquale \ f i ione f i
g ia c q u e , coso di quella giacitura ne nacquero i
& » • * " '•
:
■ Cfntaur!
Q uefia tmagine adunque, baurà f it to di f i nella onde lu d
a f e fio volume due catene, l'una appartenente
alla pr efu n t ione di Ifilone , y l'altra allo [de
gno di Giunone. La prima baurà per attedi no,
tura orgoglio [a ,fu p e rb a , c a n ta tr ic e , prefonw
tuo f a , arrogante, coso firnUi . Et l'altra natura
fdegnofa, y fchernitrice, y bejfatrice.
;\
Due fir p i combattenti fig w fi ehoranno natura
tonten tiofa.
;
\ n a fanciulla co' capelli levati uerfi il Cielo con
tenera natura f o r te , uigorofa , Cosovera ce.
Marte fopra il draconc lignificherà^ natura noci
u à . V r i intorno fic a ia capo * cioè f e n y iilc e r ?•**
nello, ilquale è il letto dell*intelletto. E t per
quefia tmagine ci faràJìgnificata natura fu ria *
V » T àuro, Q
uejlonon
b r u ttim m b r a
jy
»
.
..
u - y
'n *
i,A
I D E *
dittarle * m a per ordinarie per Tariete haurà la.
te f ia , s a per lo Scorpione .haurà le parte g e n i
ta li con le loro operationi.
Sotto la Vafiphe di Glene faranno f e i imagini
#
Il Leone ucci io da H ercole . Alla dichiaration
I c o n e ’»C . .
■
. r
i r
i
, '
tifo da d iq u e jla J avola ci sa bijogno intendere, che
ricrede q kei ln0,r0 della S crittu ra . J/raeel si me audte& Ina di« f :
o
J
V
7
chiara ciò W > non adorabis
ntcl u t ^ i t m
®c •
/e De/" rtretti, r/sa intender, che pofiiaino f a r
duegrau/Jinni peccati, l'uno di non adorar Dio
vero s a sa lo , ta ltr o d i commetter maggiore
id olatria , che non fa c e v a Tantua firnplicita •
Ìrnperciocìte quella adorava Dei fu o ri d i fc ,m J f
i pus d i noi adoriamo g li D e i . che ci facciamo
dentro
percioche de capi facraii ne mo
na/ieri, m olti h m m f d io dentro di fe uno idolo
della loro cotti m e v \g » s a cajhtà . t f //o/i sala ,
m ente esi/ lae adorano, ma uarr abbono per quel-,
l i da g l i a ltri efi'ere adorati 9 sa,cosi hanno d i- »
riÀ ffato dentro della lo r fa n ta fa g m a Oeae V sa
J ìa ,C y i più letterati hanno diriZ fato una Talluflejaqual non folamente efii adorano,ma uor
re biotto ancor che foffe da tu tti stim a ta s a odo
rata. I P reticipi d e g li ejjercitt hanno diriòfa^a .
nel cuore la D eità d i M arte.'N e folam ete efii la
reputano, s a adorano, m a uorrehbono che tu t
ti a quella 4 me Innafferò. Et per dir brteu e,tut
ù habbt amo deutro un fe r o s a fuperbo Leone t
che figm fica la nufira maLuagia, s a indom ita
am bitione » Et e il recente D io , che ci babbia
mo dentro Se adunque il noflro fin rito d iv e r
rà u r iile r to le fo tttfitm o a ucciderà quefio Lg<j-
•
j
D E L
T H F- A T .
ij ;
ne : il quale ucci/o , ne feguirà la hum ilita, nel
la qual fola pofiiamo piacere a Dio divenendo
pargoli , 0 poneri di f i i r i t o . Q uefia im agi
ne adunque fotto la Eaftphè d i G iou e, ci ligni
ficherà natura humile, uergognofa, 0 inclina
ta alla bontà , 0 a tu tte quelle cofe, che fe ben
da Thilofcphi nonfurio chiamate uirtàfon o non
dimeno difiofitione a quella, come b a llia m o
detto della uergognà.
Maef itto i T afari Significherà efercitatione d i
ta l bontà , o buona d ifio fitio n e.
Il Minotauro uccif i da Tbefio nel Labirinto ,
daràfignifi catione d i inclinatione alla uirtu .
Md fotto i Talari lignificherà qualunque delle
uirtu nelle fue attionrche altramente non Jàreb v jrtd 1C#
bono uirtày che molti fanno la diffinitione della tuof*.
uirtu ferin a hauerla. Et quefia da Cicerone è
uirtu chiamata attuo f a , 0 \ . d a Virgilio ar
dente , 0 cofi dal P etr. Et nel nero fe il Mino
tauro uiuo figtiifica uitio ; morto dee fig n ificare u ir tu .
Il Caduceo lignificherà natura am icheuole, 0
inchinata alla cura fa m ig li a r e , 0 alla Repulsi
D anae lignifica buona fortuna, felicità , fianità, .
ricchezza,nobiltà, 0 ottenimento di dtfiderio.
L e g ra tie figntficano natura benific a .
V n T auro ha per memoria efiraordinarie g l i ^ %
orecchi, 0 le loro operationi, udire, 0 afcoltg r e , 0 anche la pa fiio n e, come la firdeZjg* »
ordinarie per lo Sagittario le cofee , per li E efri
i piedi , 0 loro operationi.
Sotto U Vafiphe d i Saturno fotto fe tte imagini*
* iìftt
'oso .
«
,
f
n f*„
Ki
oso
LA
l D E A
’
1 tre capi ,del Lupai, de! L eone, & delCdrieflenificano Intorno cjjcr fothp'ofio altZ ln p ó ff'X
Froteo legalo , fignifica, natura òflfyaiti \ t irti
m utabile ?
**•' ‘
' *
^
■ Il pafjer foli tari o fignifica natura fo lti a t t a , o
huomo foto o abanduttato.
" Faudora m a ltifii l fortuna, infelicità,ignobiliia,povertà,in fam ia,in ferm ità, non ottener déJ td c rio .
L a fanciulla co*capelli t agli atfafinot era debilita dell*huomo , ShvuhriQfix, y m e n zo g n a .
Endtmione addormentatoJopra un mónte, Coso
bafdato da D ia n a ^ S d eg g ea p freffo I C a b fifa
t o l t a l o s i; *
la m orte ilei b afa o non cipofiìa' mo f ^ r id i nera unione co* cclejh , né con Dio «
Questo d ic o , percioche fia il >numero de* pi#
m o r ti, nelle quali entra ariclr quella,chedtieìn
m o d i Anteo , è quefia del bafcio , della quale
Salomone cofi fia m enti oli net p tk ta p io della
C a n tic a . O fculctur me ofculo oris fu i- Ahqual
J'cnfio per altre parole è più apertam ente d etta
da Pnolo, quando d ic e . Cupio difjoliti,coso essa
curn C h rifio , ilqttal de fiderio non è effireffio d a
Salomone nella fig iuficatione del uerbo, come
da Paolo , ma f i nel modo dt f d o ta tiu o . E t il
. V etr. lo
nell*indeclinabile, quando dijje.
**
O felice quét 'dì ; che d a l t e r r e n a r r i
Carcere ufieiulo, lafict rotta Coso f i o r ì A ? *,
Q n'tffc nu agràue,ct f i ale,et mortai
JEl da ftlunghe tenebre m i p a r ta ,
‘ * -4SfrvVdando tanto f u nel bel (ereno,
t
t Ch'io uegga il m io Signore,et la m ia donna.
rntfic
D E L
T H E A T .
fy;
Adunque il corpo effondo quello \ che ci fieriJc-
c
,
-,
r- - W f f a i m
d i qttfUo f i qsr^hbe a Juaeftu b fffff.fiX lc b t ì
T h eM g t fw ib o liii HoUndy aprire b a w iv iffc ià tv ueuffpr‘f iHolg.felpe Órana ( l a q i f f f t e n e n d d ^ ^ ^
il
d] tu tte sa w f f w sofrdcnse^i ^ ’^ j ^ & U t a , *
lei p affando tu tti g li tnflnfit fi. periort, e uie aria
CyltiOgppMeyte. f i n t e l e effe fu p erio rijh d ìi-'
no saito Ù if^ % e g ]ù e /}q irigam oratafii t n d i i
ta ja j u , ■dejtileroja di po terlo uafciare mentre
M & Ì* ^^dìyPffXnU dt fo p ra un m p r i e ^ h q ì
twJduJy addormentato può nelbafciarlo fa tia r
m o r t a l e , m o r t e \ s a ti f o i g h Anelli a lei a p i
fiflCfenenti, f o r n ì apom pdptn tébre] V n T ifi
rsi.. Questo per mgmbr$ efiyaprdinarie h a u rà
ifiplf canuti f s a sa .f/espe i Y% fpér ordinarie '
per c m tpjÀ ffa p ftfo rp Q k ginocchia , O 'p c t
V /
I
T :A L A R L
■ : • • ' * - * ' •• •• •
• ’i
T heatrri
j&ri ha fip r a la porta d i qualunque p ia
® neta i Talari^ s a a ltri w u r w m e »
\ ti che Mercurio fi m ette quando v a
ad ttfèqmr la volontà d e* De t , fi come fauoleg'L
g h w o i TfèCti. L a onde ci fuegharanngda pne*
aMtfttfe,
^
/
ld&
IL A
IO E A
r
ritorta a ritrovar f it to cofi fa tte porte tu tte U
operationi, che può fa r Chuomo d'inforno a
g ra d i fottopojli naturalm ente 0 fa o r d'ogni
arte.
fiotto i T alari della Luna forano fette im agini.
L a fanciullafcefa dal Cqncro lignificherà la
cim are , che lena t fig liu o li, 0 l*ufficio d e lle uarh .
Nettuno dinoterà il guado , paffar l'acqua d a
mar con acqua, bagnar y b e re , f ir u \y a r e .
Xjaphne operationi naturali infoi no a l i g n a
vi e . D ia n a , a cui Mercurio porge la u e fia ,K
muover, o m utar cofa, riceuer, d ip o rre, ope
rat ion fa tta to fio , o fubilo .
(re»v
Le fialLc d'A ugia,bruttar, f i orcare ,o macchia
G iunonfia le n u b i, afeonder p e rfin a , o cofa.
Prometheo con l*anello, operatione intorno al
la gratitudin e , o o b l i g a t i o n e si •
■ si
Sotto i T a la ri d i Mercurio faran n o fe tte im agi*
I t i.
■> .
:si; . "Va"' v *
I/ uello dell'oro dinoterà aggrauare,alleggerii
r t , indurare, intenerire finafiare, lafciare.
A
(sii Atomi (ignificheranno m in u zza re , dtfcqn• ■
tinuare,fiargere, dijfoluere.
v>
la i Viram ide,atZjire,abbaffitre.
Il nodo Gordiano me f il i atto fign ificheràim plicare,intricare,annodare*
Il nodo Gordiano efih e a to , fiie g a r e , àiffiduere , di fin e a r e .
Gmnou finta d i nubi dim o flra , ufàre (im ulaito n e , e difinnulaitone, ufim ia , o inganno .
I f im i legato A U Rolae fig n fica dare, o riceuer e
D E L
T H E A T.
ij>
nego ciò,fornir e, tn u efig u re, u ig tla n Z a , indù*
Jìria,diligenza fierfeueranTfa,fatica.
si
Sotto V en ere faranno fe tte im a g in i.
«
Cerbero figmfica m angiare,bere,dorm ire.
Hercole purgatitele s ì Ale d i Augia, p u rg a rti
0 n e tta re . .
■
Hàrcifo fa r bello, fa r inam or are, f a r de fiderà
re , f a r fp e ra re .
L a fanciulla col uafo d 'o d o ri, profumare *
Racco con PI?ufi a uefiita d ‘f e d e r a , dar fi buon
tem po,giubilare, ridere >far r id ere , confolare?
fa r allegrare.
Tantalo f i t t o il (affi, f a r vacillare, f a r trem ef
te,far du b ita re, fa r te m e re .
?
i l M inotauro, operat ion d i uitij.
Sotto il Sole faranno cinque tm a g in i. <
L a catena d \r o lignificherà andare a l Sole,pi
g l lare il Sole , Tlendereal Sole.
. >vii
G ettone uccif i dinoterà operationi intorno d
m in u ti, A rb o re / A la n n o , alle fine p a r ti,
A le tà n atu ralm en te .
si li
I l Gallo col leone, fa r fuperiorejjonorare, dar*
luogo . Le parche, da r cagione , tncom m aar f
menare a fine.
»•
f
Apollo, che fa e tta G iunone, fignifica m ani•
fifta re p e rfin a , o cafie.
Sotto i T alari di Marte forano cinq; im agini »
Vulcano dinoterà b a tter foco , pigliarlo nel**
1 efcayaccluderlo.,m etter e incendio,eflingnerlo •
\f i ione fchernito da Giunone hàurà due C o tete. l'una conte nera Vinfuperbirfit, 0 f a r i n ruperbire, prefumere 0 f a r prefintuofo, uau*
taet 'V L A
I D E ' A? ’4
ta rfi coso fa r u u n ta re, arrogarfi, y f tr d r r o -■>
g a n te , y ? altra batter a /degno , beffa re, coso*.
tfcberm re.
Lafanciulla co*capelli d m ì f f a t i al <;tela,dar no
g ore ,o fo rte zza yu u trapper are intorno a lite r ò .
D ueJerpentt com battenti contendere.
•:>
;M arte (opra ti D racone, nuocere , incrudeli
r e , vendicar f i , im pedirò.
. i *;
, >.5
Sotto i T a la ri di Gicue faranno fe tte im a g in i.
• Giunone fttfpefa lignificherà re[j>irare,fufjura
rr,ufare l'aperto cielo,
■ ...sisasa
>
\ I due Bori della Lira ,f a r S tre p ito .
k
I l Leene Mcs/foAa H erco/e, eforcitar la hum i
lita , bontà yfq n p lifiità, coso uergogna..
. .v
I l M motamp uccifàdaThefeo, efercitare uirtk.
I l C a d u cei, ejercitar a m c itia o conuerfatione...
D anae cper ottoni et confi(#Uon d i buona fo r
tu n a.
... * .oso n
v ... sa. ...
{Le ^ratie dar e.fa vo re, benefic$oh9y aiutoY ■
Sotto i T alart dcSaturno f a ta l o fe tttjn u tg tn i*
Cibele dinoterà operatu # fu or f i arte intornoé d làterra.
- A
I tre capi d i anim ai jn d u g ia rfi f a r indugiare*
dar term ino, ri mettere in alcun tempo .
X ’arca del patto , locare , coso collocare •
Vroteo legato ,f a r cofii immobile v i
»
Jl pafjer foU tario,andar falò, Slarfolo^ uban
do nare t y / > ,
t . ^ ^tosow.
i ■■
F and ora dar tr ib o la tim i. .
L a fanciulla co*-capelli ta g lia ti, debilitare ccfa,
a m e n ti.
. „•
^
*
f
|
D E L
T H
t A T.
, 4,
P R O M E T H E O .
)
’Ì
st intenda la cagion, per laqual uogham o> che
egli ci fin Ufimbolo delle artjfa, f a bifògno interider quello, che 'due
Ssim
'M
JA
f iatone
D u e egli adun que, che effendo uenuto i l tempo fatai della creatione de gli anim a Antmo.lt
{ b e o , 0 ad Epimetheo , che difirtbuiffero a e ia thco Stfilin o le conneneuolt for% e. Et Epimetheo prègo Prometheo, che a lui DfciaJJe fa r cofi f a tta
<* diftrt
difiributione , 0 che eg li folam ente f i s i effe à
M
porui m e n te C o n ie n ti Prometheo, 0 E pi m e- gli anima
>
più deboli diede nel .c ita . alcuni artrio , 0 a
cpuellt, che m ancali ano di a r m e , trouò alcuna
cofa accommodata alia loro fillute. E t di quelli^ ~
che erano chtufi in picciol corpo, parte ne fece
Iettar p e r l'aere dalle p iu m e , & parte ferpirc
per la terra. Et quelli, eh e erano di am pia g ra n .
desioso, v olle , che ejfa g r a n d e z z a desse lesse'
14 »
L A
I D E A
fo r fa f>er la loro falu te. Et poi che Socrate ha
molto vagato intorno alla varietà de gH anim a«hro p o * b r u ti, dice che Epimetheo poco (auto confo€ • b u io .m ò tu tte le doti nelle bejìte / 0 non averti d i
ia fa a r parte di tanta l a r g h e r à da donare alVhumana f]>etie. Refiava adunque la foetie hu
maria uota 0 priua d'cgni d o te . Mae Prohietheo vedendo Li mala dtfiributivn fa tta da Epi
metheo , 0 g ià ut curarf i al giorno fa ta le , nel
qual focena bijognofnr ufcir in luce g li anim a
li , non trouando altra via da poter alla hum ana falute prouedere, nafcofornente col fuoco f o
rò [a r tifi ciòfa fa p ien \a di V ulcan et d iM tn er•« p lm a ua • percioche nonf i potata f a r , che alcuno fe n 4 1 P io n e z i fu o c o , cioè fetid a acutefa^a di ingegno , la
€° •
potejfeneconfeguir neufare. Q u efiaadu n qàe "
tnife Prometheo n eg fi huomini \ laqual appar- *
tiene fofamente al m uore, m a fa ctuilc manca
v a , laquale era bene apprejjo Gioue Mae non
f u lecito a Prometheo afiender tanto a lto , percioche rhorribtl cufiodie, che fatavano intorno
allaroccadi Giove y ne lo foauentavario . Per
Ét uom v
fir to aduli qtte lhuomo fu lv f a ? li anim ati
,4 cat UVf j esse partecipe della divina fo rte ; sahhe cagnitifa id c r ifiD e 1d a p rincipio, per la q u a l cogni
tione divenne u fig io fo , 0 a loro dedicò a lta ri
0 s ta tu e . D ifimfe con arte articolarmente la
uoce in p a ro le, edificò cafe, fece uefiimenttflet
t i , 0 raccvlfe nutrimenti della te r r a . Mae pur
gli huomini ffurfornente uagauano dal princì
pio , percioche non ancora erano edificatele cit
t a 3 donde aueniua, ih eglih u om m i effendo p tu
D E L
T H E A T.
Hi
deboli dellefere, erano da quelle per tutto dif i pati , lyne era trouata lafatuità appartegenti *
all'apparecchio del uiuere ym a da combattere
contra lefere non haueuano il modo : percioche
la ciuil facultà, della qual la militia riè una
parte, non erafia loro. Pur per poterfi gli hue
mini dalle fere difendere, fi congregarono coso
e U ficarono le città. Mae oime, che cofi congre
gati non fi poteuano l'un l’altro comportare, coso
tra loro fi facevano di mille oltraggi, percioche
della ciuilfatuità non erano partecipi. la onde
sformati ad uficir delle città , tornarono a diuentr p ufiara delle fere. Al finGìoue moffo a pie
ta della fiumana infelicità , mandò Mercurio.,
chepprtaflè qgh huominiiljuìofe. cosolagitif i t t a , a fin che queste due cofe ornajfero CosofeAia d.rcl£
gafjero talmente le cittàxhegli Intorniaifi con- l( «muda
citìaffero con be/uuolen\a. Mercurio Intuendo huornuil.
tìa portar queftì due ornamenti, interrogò il Va
dre>sa hauea da diflnbmr quefti due doni nella
maniera , che erano Sfate dtfiribuite le arti ,
delle qucdi l'uno ne haueua luna, coso l'altro Val
tra,o fie pur le bpueffe da dai-e a tutti egualmen
te . A tutti rifbtìfe Gioue, percioche tutti oli
gli buomim ne debbono efler partecipi, che al
tramente le citta cunferuar non fi potrebbono ;
chejTuene nrimódridfò un c^fìffM ÌW iM ttii »
ta potèfi e (odisfare AM O Iti m medici et a molti
nondimeno.di pudore y di
giufhtta ornato fia molti, che ne pudor negiufiitta non hau efièro, non fi potrebbe confervare.
Apprejjfo Gioue commife yclte da fuaparte fa -
**4
L À
I D E A
"
ffffe una legge, che qual fi trouaff'e nudo d ip o *
4
«dorè s a d ig m f ltlia , faffé carne pefie^ella cit
t a con efìremo fupphcio to lto dal numero de*'usa
aett * Mae noi Migliamo x che il neflro Promethe#
non finam ente contenga tu tte le a rti nobili c f
ig n o b ili, s a che d a in i fu rin o d tfin b u ite , m a
•*
ancor la civile s a la m ilitarpunita*per n o n U - "
***»* 33* * * *'*'
»
*1
• mWm*"#** »
J
naer il I heatro a pi a alto grado .
,.
<
Sotto il Prometheo della Luna faranno cinque
*
im a g in i.
V
.
D ia n a , ae cui Mercurio porge fa nef a , contener
t à t m e fi, s a le lor p a r ti.
'' , N ettuno ci dura le a rttfu p ra le acque ,■ com4
acque d a tti fo n ta n e or te fi ciate,ponti,porti, Ary
saetta, arte navale s a del pescare .
Daphne contener a 1 g ia rd in i, s a l’aerte intorno
a l legname
,H im en eo fignifichera n o ffie & parentadi *
D iana con l'arco dinoterà la cacciagione.
Sotto il Prometheo di Mercurio faranno fi»
im a g in i.
r
- Vn Elephante. Si come quefla imagine f ttt»
il C onvivio figtufc.i fauolo/à Dcita; cofi qui d i
noterà fauolufa religione, r i t i , s a cerimonie
HercoTe co* f i o i a pparten en ti.
con la f«i- H erco/e, che tira una f le tta con tre punte , è
punte1,tre nobilifiim a tmagtne d i tu tte le fetente p erti»he hgns' nenti alle cofi cele (li a quefio m ondo, s a ad'A*
^c* *
biffò . perciocbe i Theologi fiimbolici vogliono
che H ercole fignifchi I'humano fp ir ito , tlqnale
ì | fom e fa e tta di tre punte poffa penetrar "fon
I Tuna i fic r e ti selesse, con l'altra quelli di quejfo
\
mondo
'
i
D E L
T H E A T.
14 1
m ónda, 0 con la te r\a (futili d e li A b iffo .\d u n
que contener à un volume molto ben difi tnto,nel
qual f i udiranno ordinate fe n \a eccettione tutte:
le fcieiC fo, con tu tti g li anelli appartenenti al
le, loro particolari catene. Et finalmente la, e/o-»
q u e n \ i come ricetto 0 ornamento d i tu tte : la
doqu-en\a. dico appartenente alla oratione fciol.,
ta fon tutte le fine jp e c ie , percioche tl poema
foL\te osoEL ajulrà albi im agi ne d i Apollo f i a le
Musa, 0 f itto quefio Hercole ancora fa r a com«*.
prefa U libreria L'Ariv celtfie con Mercurio Per esser Iris m e /l
Jaggiera di Giunone 0 Mercurio de D ei. Q u e
fia tmagine bau era tl volume delle amh affatene
del uuncio p r iv a to , 0 del mandato f it to m a
no. Et il privato eontenera i pertinenti alle lef*
ter e , chef i nundano, 0 che fi ricevono.
Tre Palladi una edificante c ittà , l'altra che tefir
f a te la figu rata, la ter\a ,cb e faccia una statua*
d e li edificar habbiamo "Virgilio. Ealias quas
condidit a rces, ipfa co la t. Della tela fig u ra t4
ne tefiifìca il congrejjo con Arachne. E t che
ellafoffe statuaria di E laflica/l ci pofiiamo per
fu ader dalle coft dette di f i p r a . Et dalla fa v o
la d i Socrate d i fip r a da noi r e c ita ta , quando
dice che i Dei firm arono tu tti g li animali fien\a
nominare alcuno in particolare : Q uefia/m a^
g ì ne adunque confervera uolume appartenente
aldtfcgno 3alÌarchitettura, alla p ittu ra ta li a pror
/pettina,alla plafiica,et A Lifia t varia, et a tu ffi
i loro appartenenti, Et la d ifi im i on farà ta le ne
tagli, d ie fa r à appai'ire putiattigliofo l'ordini*
a
%
»4 »
L A
I n E A
Mercurio ^Mercurio con un Gallo,ftgnificherà la m e tta $*Uo
turA * & f kot a pparten en ti. *nefo otifc il Lari»
Ì$nv feV habbta tr a tto . Ma a me bafia il tcflimonto fuo nelle fue allegorie ; nelle quali e* dice
Vanti cinta hauere ufato coJifa tto [im boloper la
m ercatu ra, aggiungendo non fa , che ragione
della garrulità di Mercurio rapprefentante quel
Vi de m ercatan ti.
Vrometheo con la fa c tlla , come è ancor in fu la
porta,rapprefentera a rti et irrtefci ingenerale.
N e cto paia n u o u o , che ancora Ariftotele nella
fu a Priora dice efler lecito per difetto dt voca
boli da r ta l’bora alla facete il nome del g en e re .
'• • Sotto V enerefaranno fe tte im agini.
- Cerbero contiene la cucina, et appartenenti
Conviti t y a l dormire folenne I n u m i, che fa n la fe ta cotenerà il G'mecio, cS
Va u e fta ria , con g li antecedenti,et conseguenti*
Antecedenti,come filare,t efler eJarton a, tin to*
f i a . Confeguenti uefltrfifaogli#rfi,refietcireV
y la guardaroba *
•>
k H ercole purgante le Halle d ’A ugìa,contenerà
bagni y ba rb erie.
L a fanciulla col uafo d'odori fignifichera la
f e r fu m e r u .
II Minotauro q u i è arte u itiofit, ruffianefino ;
bordello, y arte m cretrk ia .'
• *
Racco con Vbafta coperta di hedera,m u f ic a ,y
i r t i d i g iu o c h i.
Narciso conteneva Parte de b elletti.
(n i\
Sotto il Frometheo del Sole fiorano fe tte im agi
<Gerion uccifa da H ercole contenerti m inuti >
b o r e , anno, horologio,
» ^
n EX
T H R A T.
147
J / Gallo col Leone conte nera il principato, s a
a
suoi appartenenti.
La SibiGu col tripode fiunificherà la diuinati#
n tj& J e f i e ffiecie, C r ia prophetia.
*
Apollo jra le ninfe dinoterà la Poef a .
Apollo , che uccide il Serpente, cioè i ueleni
dell« tufi i m ita , haurà tu tta la rned teina •
Apollo p ijlore ci darà l’arte pajlorale >
X ri Intorno a cauallo con un logoro in mano con*,
t citerà la caccia dello /p a ru iere & del falcone
efercittj n obili. Et benché appreffo g li antichil
non foffiro in co/lume : nondimeno potendofi
iper pcrplexiouem accommodare a m olti modi
di p ari.re , s a acci oche u olendoft d ifflu ere le
ìiouelle deljioccaccioJjuchi non manchino.hab»
iia m dato quest i tuo«o . E t qui dirò quattro
parole della utilità della m ia fa tica : osoepropo-Vtf lira
nciulomt lo stato d i quefia età, s a della nofira
religione , Ih>cercato d i accommodare molte co* l ’Autore*
se al nojlro cofiu m e Kcome per efempio. Q u a *
tnnque Cicerone non habbia m a i parlato d i
CJmfio 3 ne dello Spirito Santo, confidarandoau
il btfogno noflro del p a rla re , s a dello fcriuer
delle perfine diurne f it to la imagine della U t fa
ludm e d e g li e n ti, ho apparecchiato gra n felu a
tra tta d a g li Jcritti di Cicerone, con la qual C i*
Ceroni,inamente fi potrà uejlire il nome del fig li
nolo s a dello Spirito Santo . Et quello del f i*
gltuolo ha due filu e fip a ra te l’una per u ef i ir e d
fitto fanti f im o n om e, come nerbo s a fapienX **
l'altra come uerbo incarnato , cioè Chrtfto s a
Cbrifiocruafi/Jo p e r n o * . Q u efia dico., per*
«
%
V
r4 «
L A T D E A
Cabalisti rioche m olti d à Cabahfii Hehret hanno cohoclic cono sauro Ia fiifie n \a 0 il uerbo , m a nypi hanno
r ó credo „ creduto quella efferft in ca rn a ta, 0 \)auer per
no.
noi p a tito , ' JIche vedendo Paolo due un fo t tifa
paf]aggio . Non per fapientiam nerbi, ne crux
C jjriftì euaeuetur . D i che fe ejjo gelofifiimo
Paolo hauejje hauuto a Jcriuer lo Euangelio d i
G io v a n n i, hauerebbe perauentura d e tto . 1«
principio erat C hrijìus, 0 Chrijlus erat apud
fte u m , 0 Deus erat Chrtfins: benché Giouan
ni diede il rimedio , quando d ifje . Et verbum
caro fa ffu m cfl
Sotto Marte faranno fette im a g in i,
- \Vulcano « darà fa rti fabrili di fuoco .
V n Centauro , benché nella natura delle cofe
non fu tbnonfiano mai Siati i Centauri, pur leggendefi,
Ratinai del cl;e quandof i cominciarono a domarei cavalli ,ù
lì «ofe • coloro , che di lontano m iravano , pareva , che ’
Ce mimi
^ ...
il cauJlo 0 cavalcatore f i f e una cofa ifieffatt
Sotto quefia intagtne copriremo le arti ahàual
b , 0 alfuo beneficio appartenenti. Et fi da a
Ma rte , per effer il cavallo animai Martiale. *
Duefer penti combattenti conteneranno forte
m ilitare, 0 la guerra terrefire 0 navale
Due gio ca to ri d i Cesta conteneranno tu tti$
giuochi M artiali.
Rhadamanto g iudicante le anime, bavera il
foro criminale dtfiinto.
'• Le furie infernali per effere efecutrici delle pe
ne , conteneranno il bangeliato , cattura, car
eer e , tortura , fu p pi u fi .
- M afia fiorile at o da Aprilo ci darà il maaeltol
D E L
T H E A T.
149
- Sotto il Frometheo di Gioue faranno^ cinque
imagiqi.
Giuno\\fofpefit contenerci artifici f a tti per be
neficio.d i a c r e , come molini da u en to .
Europa[opra il Toro fignifica la conuerfione ,
iltpnjbitimentpjafont# afa anwcfnlatitine,et
la religione.
Lafaheradm oteraPA flrologia * -i
Sotto il Frometheo di Saturno faranno cinque
jpia g in i
,*4
Cihe/e conteneva la G eometria,Geograpbia ,
Cofimographia, Coso A gricoltu ra.
Vii fanciullo (opra lattinola del? Alfabeto ci da
t'ala Gram matica.*.
L a pelle di Marfia conferuerà Parti et in to m e
A CUOI > Cosopelli .
. *}, ;• -a
, V/m ferula conte n e ra ? uccettagionito nottuen i uccelli.
?
. Vn Afino, per ejfer anim ai Saturnino,, et n a te
, d ìe fattibefign ificiterà vetture,facffjì}) i*sassatno,et fe r u ta quello condannati. , A -
-
^
■?
■ ■: :
‘
'
'
*
'
V
Vvo4} **>,' v‘ :•* A
: :^:tse ., ~
:• i l
i ' ."usa*' ‘* •--'■se
y * ¥ .se •••-,■'"•■
> »'. ^ 4yy*'**
' t *:>seses* se?
rrf*
y
•» ' ■
: sese * "sese.se *>;* ^
.
;H r
■ " '■
i*■:;■,•
? - : .s -' -?. z €p -$s ;*- »■:
' 1
'■ '•■■'*:,
a. I s e 'ó .s e :
■ '
,
y
■■■**>,
,
,,: m
*U
■
"
::> • . - . , .>.; _
'
'- s e
s e '
se*se?se;se:
’s e s e is e s e
.se -7
‘
/s e
sese!se*fese
-•
T 'l 5' T ; - ;
V-E STI
d ’a l r i s s ì m a
mente, ne
mai in
human co
cotto caduti pensieri de’
. luoghi della iocucio nc
dei D i v i n G I VL' io '
C u m u l o ; Perche
la gloria a lui. domita ;
Altri per se Thalam ente
non usurpasse ; F r a nCESCO
P
a
t
r
i
i
i
o
dona ai mondo j s i v |
Et ai molto, per Virtù,
.
. ... i
ri ■
& per fangu e il IufoeCo n te S'
e X
t o.X i
da Collalco, Abbate di
Nemcfa dedica seri Per
petuo.
r
.
y
L A T O P T C A sa
OV ERO. D E L L A '
E L O
DI
A
C V T I O N E ,
Msa 'G I V L L O
M .I
L
L
O
vV - ,
D e lm in io .
! O N o m o ke, n c n m g ù ; te,
* bette\\e dell' eloquerùffo, ma
...q u e l l e e l i appari
j; lamente a llafin a della lin-
Ig u a ,
f i che f i pofforto co
gliere con la Jofìantia di
j quella, fe ben riguardo ae,
ciò, clje'i celefie lume fa * fifo lte tenebre degna
rnofirarci t non fino più che fette . Hnel vero 4
quefìo Jettenario numero giunti gli antichi, conobbeo ejfer agli ultimi termini dell'eloquentiae
pei verniti •„ Li quali tanto meno giudicarono ne*
le lor comfnfitjoni douerfi tentar di poffare,quan- ■
to à rari dà mortali è auttenUio y che w ejh fette
donigli habbia l'eterno Motore per (frettai gratiafelicemente conceduto # * 4
;
’ -oso*’
*
l A T O V ! C A D I M.
L a prima parte adunque della Selva è lo ap
parecchio y che ci debbiamo fare à i [empiici , sa
fc tolte vo ci , che h or proprie , borir affate y hor f i
gurate efferpotranno ,
* '“se” •*
*" L a feconda d i nucraccompagnate fe n \a nerbo.
La tcr^a delle locutioni proprie.
L a quarta de g li E pitheti,
t
L a quinta delle VeTifaff .
:'
Lafefla delle locutioni traffale,
vse
La feitima di quelle , chefono figurate «
Jlrhe offendo cofi \ non m i par che fe non g iu d i
cioftm cnte f i opéraffe , quando Cofi fa tti apparec
chi infi emc confu f i , CXfe r ii a difìintlon e f i collo •
caffero . Mae cor» quello mede fim o partito , s a na
tu rai o rd in e , che di [opra m effram m o. [Impero che,dovendo fi com pare alla regola delle forme del
dire , off eria te d a g li antichi . delle q u a li alcuna
dim anda parole solamente proprie ; alcimd tYaffat i >g fig u r a te . alcuna mifie ; altra in un modo 9
altra in uri altro ; come è poffibilc, che la compofittone sotto alle dette norme,felicemente futeerdense, sa la copia d i tutte in ttofra gode fin non
f offe ? : Et anco d i quelle Tordine dtfiintifiimo ?
Maranigliosa cofa è , che q u a fi ciascun d e g li hitm ani concetti p ofja effere dalle dette fette qttafi
ueffe uefiito , Le quali fe faranno feparatamento
ordinate f tenendo noi• d rifg a ta la mente , men
tre comporremo > alla ferm a propofld , a nofiro
arbitrio potremo , hor con quefla , bor’ con quella
l i nof r i concetti %d i conueneuo! h a lito adornare ;
E t et e piaciuto y q u e fe fette rit cheTffe in cofi fatto
ordine à iffio n e, Il qu al chi ben Ytssguarda/ro-
<
•
l
fa
l
s|
;!
■
|
I
'
Gl y L I O C A M I L L O .
7
nera in duedature p a ri ito , , cioè nella, proprietà
detta lin g u a , y n e t t a r t i f i c i o , Che è ; n q u e lla
parte , doue g li auto ri. hanno pofio del fu o inge
gno , oltre alla lin g u a . All'im ita ti on de* q u a li.
noi potremo far il m edefim o. Coticiofiaco fa,che le
tre prim e colonne., & anco la quarta et daranno
tutta la proprietà . L a q u a le pofia m afiìm am enlt
nc'femplici , & per g l i [em piici ne g li fig u en ii ,■
Ferri oche efii,due grandifiim e utilità ciporger an
no . L'.una ds darci tanti [in o rim i, quanti bavera
la lin gu a ymentre si:
affretti componendo d i
morar alquanto [opra un foggetto . FI per ta l co
fa * quello più uolte ripigliare . L'altra d i darci
tante uoci, quante vorremo» N el rimanete d etta itre colonne,doue è l'artificio, per f a r ad im ìlatìon
de g l i antichi d i cofi f a tt e , y epitheti, y perifia
f i , Coso locutioni trafilate, y figurate . N e m i ri.
m marrbfii dire , quefia f ila Strada e ff drquella y che
r i può condurre per mc 7o del fettfiiario ordine
alla u era E loquentia. E t che p iù b a llia m o in
V esenm o noi. componendo, che d i aggiugnere à
quel fogn o, à chegiunfiro g li antichi ? li qu ali
per confefiion d i M . Tullio y à tanta eccellentia
non farehhono a r r iu a ti, ferula la ejferritation d i
opponere quafi contendendo le. bellcXge detta loro
lin g u a , à quella detta G reca. Che per cofi f a tti
* paragoni veder potevano y quanto à quelli y .che
im itar uoleuano, f i fa c e va n o v ic in i y y quanto
di p erven irci loro mancava .D a lla qual effircitation è nato ,c h e la lingua Latina ne uà [u p erb a
di tuttriquette lellc/fge ; che le f i èp o tu to trapor
ta r e . L à qual usa udendo noi come dobbiam o ;
S
L A T O P I C A DI M;.
p è r là ottima tenere y neramente in nefjun A tra
parte trottar lapo/siamo , d ie nell'ordine f ilo pre
detto . Che battendo noi ordinati g lk a jH o ri di
p ia lingue y e volendo noi in una di quelle com
porr e, defiderofi d i fornirci delle hel/eosoe d i u ri ul
tra y al modo di'Rom ani , a m e tiir à , che di . fette
colonne y quattro fem pre ci potranno yfe dal g iu d i
ciò accompagnati faremo , grandi fiim a copia tm m fi rare , Che Ltfilando quella d à /em piici fciolti,
quelli d à /em piici accompagnatife n \a nerbo , 0
quella delle locutioni proprie a quel tempo , n d
qual vorremo in quella medefima lin gua efjerc iia rc i, qvafificuro potrem o, componendo in a l
tra lingua, alla colonna de g li E pitheti (c h eh en
potremo d è g lt Epitheti in altra lin gua 3 non che
nella propria feruirci) à quella delle p e rifia fi, à
quella delle locutioni trfila te y 0 à quella delle
figurate commetterci 0 Verche in quefie offendo
p t v dell'artificio dell'autore che della proprietà
della lingua , a una im itation quafi feco conten
dendo fenici binfimo d i furto ypotremo in u n a l- f
tra lingua g ra n m araviglia operare. Ev nera
mente per quefia fola via fifirio fu ggir il gran v i
tto di comporre con furto , 0 non per altra v ia .
imperoche fe noi riguarderemo al g iu d i t io yche ha
tenuto M. Tullio nelle fue vende mie, fa tte n te a m
p i d i Plauto y 0 di Terentio y della proprietà del
la lingua ttjata da loro foiam entefi e je r u tto . La
q u a l è pofìa netti fim p lici T'obrij, 0 nette pro
p rie’locutioni , m a di fitto ingegno h a fatto 0 le
perifiafi y 0 le tr affate > 0 le figurate locutio
ni „ Nella qual p a r te , come fuar 0 con fino
anifi-
*) I VL I O C A M I L L O .
.9
artificio f i t t a , merita imm ortai ’lode . Veden
dolo adunque noi cofi d fin ta m e n te ordinate y
fe vorremo ufiir la proprietà, dclii quale non paf
fiamo meritar altra lo d e , che d i fa p e ria , b a c e
remo luoghi certi dove andar, à p ren d erla. Hi fe
vorremmo motivar del nofiro ingegno, potremo
aixhora ueggendo le colonne del! orli f id o fe a d
tm itation d i quelle fa r delle nofire , fe. comporre
mo in quella lingua ^ Mae fidi» vii altra , lode an
cora grande fa rà d i non .meli er altro artificio, che
d i farle $1arco fi bene in quell'àltrM ingna r coni e
fece Tautor nella fua
Et cofi dìmofiraremo quafi
una contention delle lin g u e . Sia adunque cofi à
bafiarifia rtfpofìo à coloro, che porta/fero opinio
ne , che cofi fo ttìi difi ini ioni niente fa c e jf ero atta
compofitione : quafi che foffe lecito vdae un con
f u fo tumulo di lingua , quelle parole & quel
le locutioni p o ter prendere, ad efprimere i n a fr i
concetti , che prim a ci uenijjèro alle titani* Et non
f i auuegono Marco T ullio sol per f i aver à Jaoi
\ luoghi tifata quella parte d i lin g u a , che g iu d iciòf i mente., dove a , „ a m r .m erita lo il gnome di
Principe d i eloquentia . Che ben,altri ancora al
fuo tempo hanno ttfitto .jqiuìle. medefirn e parole
nelle loro com pofitioni, m a non. forfè cofi al fu o
luogo. ìl che quando,non fojfe tanto>nece(fariojion
havrebbe nel fuo dìuin oratore dato in precetto>
quefìeparole. .N o u m tprim um ujm gnaturam ge
nera verborum fim plicivm > s a copulatorum de
inde q m t modii qnidque dicatur ^ J à c .f rnaràm g l i alcuno y perche non cofi lifim p lic i vogliamo in
p ia , c o lo n n e p a r titty c o m tle lo m io n f che nel ve*
' ‘ A %y.
io
L A T O P I C A D I M. To {(fendo le cofi[empiici, propri) t r a f a ti, <&fig u
ra ti come le locutioni, potrebbe forfè ad alcuno
dover fi feparare non altri meliti in partite col onne l i [empiici che le locnttoni, llche quando b a
vette fondamento di ragione ^ guafio farebbe il
nofiro numero Settenario. Mae se ben riguardaremo , neffuita pinola sciolta può e f f r tra/lata per
se che la trafi aliene nella sóla lefiura f i conosce
Et pronuntiata qualunque noce y efi'a fignifica
quello, eh e propriamente è usata di f i gru fi care .
Adunque non occorrendo quello atti semplici \ che
atte locutioni attui erte , una soia colonna , mentre
Vofficio d i 'Epitheto , o di pei-ifi-afi non fa ra n n o ,
li potrà hafiare. Et se noi d i sopra hahhiamo det
to l'apparecchio dette [empiici noci douerfi far d i
proprie , di tra.date , & d i figurate , non f u per
che effe , mentre sono sciolte , hahbiano ta l v a
rietà y m a perche no(ira intentione è, d i non ejfer
p iù audaci dette trafiate , o figurate d i quello f u
rono g li a n tic h i. I l perche m p h a rm ben.segnarle
ancor per ttefic d i quelli concetti, che d i Cofi tic- ■
p ir li furono cofi g li antichi, nella colonna de' sem
plici , m a con particolar nota segnata sopra à
ciascuno »
j
DELL!' SEMPLICI
•
P R O P R I t.
Vrim o g r a d o S e c o n d o grado .
^ Ver se
rpVerhom om m i.
il V er confuetudine »
A Ver Suonimi*
Semplici propri) d el prim a grader [&#$ tu tti
u
G l V L I O C A MI L L O.
quelli y chefignifica no mia cofhfila %o per la pro
pria nirtuie y o per la prefit della confa et udì ne .
Semplici del fecondo grado fono tu tti quellis a
che con un^ f il a uocefignficano più cofi: d iu e r fif
fim \a virtù d i trafi adone .
Sono adunque alcune uoci talmente Proprie
come quefia, comPafiionighe q tta fifi dimofìrano
nate con la cofi f i g r ifi cala x Imperaci? e tal mena
te la detta noce e(prime il compatire, coso qua.fi il
compatir il dolore, che fi p ig lia d a l mifiero , che
in noi la m u o ve, che pare infieme con quella efifer H ata prodotta. Et il fcmmo grado d i p ro
prietà prende dal non lignificar a ltra cofa fu o ri
del predetto affetto humano» Ma non tu tti firn
d i ta l d ig n ità . ìmperoche alcuni fin o propri» ^
non moflrando in v irtù ragion alcuna della fina
proprietà, come trovar y cercar ,*Coso f im ili. Et
quefia proprietà , benchéfia per fé , p ur s non ap
petir tanto inienfa come la precedente. A Unni a l
tri per lungo ufo fono diven u ti propri}» Che nel i*c
ro chi ben riguarda , fono form ati da' tra f la ti, co
me conforto y cheforfè mene da quefia p a r tic o la ,
con , Cosoforfè . i l perche dimofira U confilatìont
tffer detta per fortificar i l d e b ile , coso enfiato ani mo » Et fo fferir, da fah , coso fero , che è del
corpo y Et pur f i è tradotto, dal corpo allanim o »
Che per l'animo Solamente la confaetndine T u
fa . Et la confuetudine chiamo quella de g li] au
tori , come quella del publko parlare * T u tte
quelle uoci ad u n q u e, che ci verranno cTavanù i d i
che alcuna almeno delle due ccnfitetudmi th a b hia in cofiume r f ig n aremo cerne proprie.Et f i ceA
V
Il*
L A; T O P I C A
D I M.
me il [arto venutogli chinanti il panno per fa rci
uefla /n o n dee prender fatica di Confiderai\ , da
quali pecore foffe tomlata la lana y d i che il panno
f u fatto , ne da e v i .n eco m e f la to : tifafidamen
te conftderar quello, che pivuicino è all'arte fu a :
Cofi noi battendo gli autori davanti y delle e vi p a
role vogliamo empir le colonne., nort dobbiamo ,
per mio twuifo , a i tender col penftero a quelli co
tanto lontani principii . Affai p(u naie la confuetudnic, che la ragione. Ma d i f endere, 0 a v v ic i narfì quanto p iù f i può al cofiume^ Saranno ad un?
que da noi tenuti proprij del primo, grado tu tti
quelli y 0 f im ili, compafi'tone , afflitta^ perfetta- y
conforto, meflieri, difereto, tiputaryf i f f a r e rp e r
che non piti di una cefi figntficanQ .« M a h p ty p r ijd e l fecondo grado y fino..di. proprietà molto
d iu e rfa , ìmpeto che fignificqndo fiin cfife y non
pofjono parer nati-cor» alcuno particolare jlp e rch e
da g l i a ntich i fimo Siate d iv i fe alcune p arole, m .
b o n iu n im i,0 fi noni mi Et homonitni fin o quelli v
che apprejfo i Sdofofi equivoci,0 fin o n im quel
l i yche u m u ic i. F.t hanno chiamato bomonimi
tu tti quelli femplici y che convengono nella v o
ce; m a fono dinerfi nella figni/ìcatione , copie que
fia voce . Richiede , che hot fignifica d ecen tia ,
hor dim andare . E t quefia Conviene , che hor
opportunitàyhor venir infterne denota) Et f i non im i
f in o quelli, che nella fighifcatione co vengono; ma
nella voce fono d ifferen ti, come conforto , c o n f
la ti one , 0 f im i l i . N onofià adunque che una
ifleffa cofa poffa ha ver piti nomi Si come non offa
che uno nome non poffa fm u trp iv fig n ific a ù o n u
CI V LIO CAMILLO.
IJ
Et nondimeno nell'uno coso nell'altro può h au er tuo
g o la proprietà .
\lp e rc h e faranno propri) del f e
condo g ra d o tu tti quelli , coso fim ili . liu m a n o ^ h c
hor lignifica differente da beffi a i faétie , b o r be
n igno , non p er v i r t ù d i tr a f a t t o n e , wae p e r esser
hom onim o . Coso, d o n n a , c/;e alcuna vo lta f i r i
ce v e a d iffe ren tia d i fanciulla tali)or à d iffe re n
tia d i etade f y tali) or in honore . Et qu efia v o
ce . E la v e re , s e /o n ell'in fililo . hnpérocbe o ltre
che lignifica quello che'lfino nerbo , fig n ifica ancor
la facoltà . F inalm ente dalie predette pa.rolc com
p ren d er f i prio y ch e qu elli del p rim o g r a d o fc ìo ltd -m ente p ro n u n cia ti, m an fi filano la loro Significa
ti one , p e r esser p a r tic o la r i.
Mae qu elli del f e
condo g ra d o , per h auer la f ig n if ca tio n e 'm o lti-
p i t i e , » >»p tfi'cnò cefi m a n if e fd r è ( f i non p e r le
coso, ae sui s*à g g i ungono .fi fif
” * ‘ ssesasa. '
„
'
^
r
DELLI
T R A S tA T C ^ ''
'
• ’ a , ,o > ; ■ sa * Primae maniera dà animat o ad animato fi '
l
D a a n im alo a d a n im ato ».
3
a.
y
D a animato a<fi:nanimdto fifi;
Dae inanimato ad animato.,
ri ^
D f vicina parte nel medefimo individu o ».
Trafialo ì que! nomef o verbo tradotto dal p r ò t p rìo luogo a quello t dove onero manca tlproprio
onero il trafilatoli m iglior del proprio..
sari
A lii dichiaralien della predata deferiti ione esa
d a fip e re y che cofi nehrafiato fi cerca Vornato r ’
come nel proprio la chtarcfiga fi E t cofi come non/
. poffom ejfer cliiamAfaproprie^quellfr
'
\
T4
L A T O P I C A D I M.
fono ofcuret C r che nella prim a uifìa non f ortifica
no là cofa , cofi ornamento non apportano quelle.,
che duramente fin o traportate , Come quella a pp rejfi Dante . D a ta vagina delle membra fue.Vo
lendo fignificar Thumana pelle . Che nel vero il
Tetrarca chiamandola fc o r fa , fi perd ie f i hauea à
mofìrar murato in Lauro , & f i per e ffr da Plato
ne definito Thuomo per uri arbore n crollo , è p iù
honefia , s a più piacevole . Appreffo , f i come è
detto, nefjunq trafilato per fe pronuntiato tiene hit
tu di trafilato ,ma d i proprio. Cosi quefio. noce (cor
Z a . Etf i l o nella te fìm a della compofitione dèmoJlrano effcr tr a /là li. Nondimeno m i per la itoflra
imprefa , f i come femplici , s a trafiati y /em piici
tonfcrueremo per poterci cofi di toro fe ru ire , co
me g li autori fatto hanno . FA la trapazionefipuò fare ad uno d etti cinque fi/detti m o d i. Ioso
/èm pio d e l prim o . S*io di c e fi y chralc nrihuomo
correndo y u o le ffe . perche da uno animato ad al
tro farebbe tradotto . Effimpfa del fecondo . Le r i
tte off renar li toro fium i , perche è tradotta dalsre-; 1
»0 f che e inanimato , atti f u m i parimente inani
m ati. E ff empio del te r f o . R id e r i f i o r i . Fffempio
del quarto . V agina dette membra . Q u in ta m a
niera è quella che f e tif a pari irfit da uno medefimo
individuo traduciamo quello , che è a i uno m em
bro a d u ri altro y come il parlare , o’I tacer à g li oc
c h i * Conofcerafii adun que il trafilato dalVhomorumo in quella , che non come Thomonirrto tien fo fpefiy chi ta fco ìta per ta fita n a n a fignificatione *
C h e pronunciata (ric h ie d e re J llw o rn o non pu ò
fip e r e p i t t a f u * doppia fig n ifi catione B in q u a li
G l VETO CAMILLO.
If
e g li f i f i a al bora preso f i n \ a alcun'altra parte de!
l'or attorie. Et benché ancora il tra flato p e r f ig m fe a r prim a il proprio pa r effe ad alcuno f a r il
m ede fimo nondim eno f i ben confideraremo, non
porge cofi fatti? dùbbio.. Imperni;? di prefinte li
gnifica il fuo proprio . Il p erch e, quando dico r
fiflegno , onero, alloggiamento , f i rapprefnta
/àbito il proprio loro , che è l'uno d i fiffener cofit
cadente, l'altro di^lìeuiar p e fi. Ma nella te fin?a
tali;or vengono come trafilati f nonim i a lign ificar
confilaticn e. ìlche attuienegton filam en to quan
do (nuoce è tradotta àfignificar meglio r che'I prò
prip , quale farebbono le dette voci y Sofcgno , s a
alloggiamento per confaiaiione y perche affai pius
Toffìcio dimofirano , che'l proprio non farebbe r
Mae ancora mentre fi conduce al luogo , la cuti?
manca il proprio • Si come quella noce 3gem m a r
à fignificar q u e lli , che per non batter vocabolo ,
per traflatione , occhi d i v ite ancor chiamiamo m
Saranno adunque trafiatitu tti q u e fii, s a 'fim ili
accender d 'a m o re . alti f i m o dt n o biltà , baffo d i
conditione y che fin o propri] d ì cofi corporee. , ,
D .E L L J Z f S E X P L I C I
. V l G V R A T T ,
^SINEDDOCHE,
T
V n o p er m o lti.
z
Earte per il tutto r o per i l contrario *
5.
Genereper Ufgme f opn iicontrarfo
1 6 t A T O T I C A D I M.
Sineddoche c quella figu ra,che (enfi n attribuir
nome d i una parte , per darla, ad uri altra y p itie
ana parte per u ri altra*
'
M E T O N I M I A .
•
I
x
3
Vinuentor per il trouato , Òper il contrario.
il pojfeffore per il pof]editto fi per il contrarie,
II continente per il contenuto, o p e r tl con
trario .
4
Cagione per effetto ,o per contrario «
5' A ila cagtone accidente dell'effetto i
MeromWae è quella figura , che da il nome d i
uno de* fuoi correiattui all'altro f ponendo l'uno
per l'altro .
/ * Sono alcun*altri [empiici, li quali non trafilati,
.nM p/u toscofigu rali meritano di efj'tr chiam ati :
non perche la trajlatione non fia figura*,, m a, per
d i e quefii d i fig u ra fa n anfano % Et questi fono,
a l creder m iot governati dalle due figure [opra d iuifie Sineddoche', & M etonimia, lequali fin o fi oso
vicine , che a fa tica f i Infilano talhor conofiere .
Et quantunque la differenti a loro non fia molto al
propifito necejfaria , p u r diremo effer t a l i , che
la Sineddoche. non u fi un nome per uri A tro , come
f a la Metonimia : a n zi non f i parte qua fi da f i me
deftm a. lmperoche fi pone uno per inciti , Come
R.ornano, per li R o m a n i. Et la parte per il tutto,
come il tetto per la c a la , e’l genere per la fiiecie,,
come i l ferro per la fix td a ,n o n f a .partenza dal
[oggetto „ Ma laM etonom ia rùetfc uno nome par
m i A tra «.
C om t
G I V LIO CAMILLO.
17
Come Vinventore per il trovato , qua! è Cere
re per il g r a n o .
z E t t l pofjcffor per ilp o jje d u to , quale e V u l*
. can ofer tl fu oco,
‘^
3
E t il continente per n i contenuto , . qual c il
Cielo ,p e r alcun Dio .
4
Et la cagione per L’effetto. qual e lo Tirale per
I n fe rita .
.
..
* 5* Et lo effetto p er la cagione .q u a le l'orma p e r
il piede .
.
6
FA talbor attribuifc e alla cagione l’accidente
dell effetto , come pallida morte .
Mae in quefìi figu rati fono affili più licenliofi li
Voeti , che g li O ratori. Et tanto fia detto delli
[em piici Jc tolti ; li quali fono con gran diligenti &
da eff'cr c o lti, 0 g o v e r n a ti. Imperoche la doro
colonna fola ci dark la copiofit felua de’[m o m m i ;
onde la Eloquentia ha la propria origine r ,
.
I
.
■ •
CON Gl VNTI
V E
*-Vi*- .toh*. fj": "V. . ?
S-£Nssa:si;sa
IL B O.
•
D o v e p iù uoci proprie f i congi ungono à aefih
alcun concetto.
■
/
.
... < v t
Dove la feconda 0 terZa noce f a genitivo de*
term inante .
.v
Dette la feconda 0 terZa noce f a t onero abla
tiv o notante non cagione efficiente^ m a qualita
te [e v iro infinitivo di mede firn a viri vie ,
Le noci accompagnate fenici verbo fono qvefie
chef i f a uno, ouer quando convengono p ia proprif
/e m p iic i à u ifiira li s j 'concetto. Quei ditelo pii*
I*
L A T O P I C A D I M.
fiofla u liv if i umfcorn f i r i [ a verbo . Detti quali al
c vn o fia g en itiu o determinante alcuna precedente
gen erai natura . Bencheapprefló latini in luogo
d i cotal genitivo ssanse volteJi troverà anjfor ilg<~
ron dto. Onero quando alcuno d i congiunti j'ojft
a b la tiv o , ouero infinitiuo-figmficanti alcuna qua
li t o t e .
Non piceiola felua fa rà quella de'congiunti fe n
%a verbo . L iq u a li, per quanto io v eg g io , hanno
l i tre luoghi fi* inof r a t i . V uno cioè , mentre p iù
uoci proprie u t fio no fo t amente un fin fo , q uale f it
t e l i e q v eflo . Per tutto il mondo ». Imperoche non
fidam ente fi potrebbe uefiir con quefle belle Verifia fi ; Q u a te r r a , qua fo t patet u trvn q; recur
rens Afp ic it O cceanu m . Quanto il Sol g ir a , (oso
fim ilt : ma con a ve f i e fa m ig lia ti fiim e » Per c trines
terras t legnali b e n d e non facciano perifrasi , p u r
^
fon da efler confervute , f i non fossa p eraltro f per
ja p e r in quanti modi l'autore la b b ia una fle)fa co
fia d e tto . Et volendo conferuare y tn tteffuna delfa ltre colonne poflono hauer luogo . Il fecondo, *
quando la ho co determinante alcun precedente g e
nerale , fi trova in g e n itiv o , ouero in gerondto :
Come q u e fle . Lum ina f ò li s , Ignìs fo lti , uires
fiulmtnti * ( For^ae di proponimento , g r a v e r à d i
p enfiero , y f i m i li ; pur che fumo fo li, chetici con
g iu n to habbiano una cota lfo r\a .e v irtù rifiutan
te dalli componenti . Che fie e /fio s i rifo lu ejf ? tn
luogo , quella fip e r d e f le . Et d i quefli lungamen
te m i hanno tenuto confufo q u elli, che rnficme ag
g iu n ti parevano poter circonfcriuer alcun tutto y
cernefa r c iio n o q u e fli. Sòlum codi, [o h m m a tis •
GIVLIO
CAMILLO.
!.f
Impcroche.per ambedue le dette ucci intendendo*
f i il cielo & il mare y quafi m i conducetta a cre
dere y che foffero Eerifra fi del ciclo s a del mare >
Che quella medeftma v irtù m i pareva batte/fero
cotali g e n iti ni , che hanno ne' d etti luoghi quelli
a l l e t t i v i . Solum cccle/le . Suolo marino appref»
f i a D an te. Mae meglio confederando y parrai nets
efièr cofi . ìmper oche la Vertfia.fi neramente c quefi
la , ove non c la propria noce.Ma in luogo d i quel
la uri altra y o p i t i , cire onscriventi la uirtu^ deliri
propria. Che nefjùno può se medefimo circonscri~
uerey se tanto non degenera da se , che fa rlo posksa \ Come auuiene a g li adiettiuiy li quali troppot
f i lontanano da effir f i fila n d a . Et però y qnan* t
tunque di lei sentano , la po/fono aiutar à circonscrivere, non come q u elli, in cuifia tu tta v ia a l- ,
cuna p a r te , a r if i più tofio alcun segno d i lei . E t
cofi l i a d iettiu i pojfono circonscriuer la sofidati a
d i quelle cose , le quali ef ii d e i tutto figrtifica uafa
n o , mentre erano sofiantm i. Si come le prede t-,
t e • Sohtm calefie y s a suolo marine . Et cotale
lontanane* da tutta la sofiantia } ma»ifefta il po
terli aggiungere a p i té altre cose, corney celefili
flette , cclefit D ei Tm arini p e sc i, m arini l i t i . L i
quali congiunti in tiero non circonscriuono il cielo«
Mae quando dico per ri g e n itiv o y Solum c e d i, dal
detto genitivo tutta la sofiantia del cielo e fig n ific a ta .. N e altre f a y se non che dichiara di cui fihf
il detto suolo . Et g ià detto habbùvno , che nes
suna uoce figmficante alcuna tutta sofiantia d i co
s a , può r- .ir à fa r pcrifiafi d i quella, sduo fot*
f i nelle cose d iv in e , come in quefiìe m c t ♦ Curae
lb
rL A T O P I C A D I M.
'
D e i , bottitai D e i . Che per avventura eirconfcriuotto la rnaefl.t diurna per quel fon dam en ti}.
Q uicquid est tn Deo , oso ipse D eu s. Adunque li
g e n tim i sopra addotti y lum ina Jolis , igtvs s v its y
uircs fu lm in is yfo r\ct dt proponimento , g ra n éfid i penfiero , determinando solamente di cui fia
quel lume y quel fuoco , quelle fo r^ c , quel propo pim en to, quellagraqeXgga y sono da ijjer locate
per uoci congiunte sotto le lonuenettoU ch ia vi. Et
in cotal numero m i auuiso yflano ancor q u efli .
x Secreta nemorum y latebra flu o ru m , lustra fera
s a r n n i. Imperoche con qualunque de'.predetti n e .
congiunti fi può fignificar quelli luoghi y che sono
ripofli nelle selve . Mae J da sapere, ct/e se lae «ose ;
che ua innanzi al genitiuo J offe participio, potendo fi ogni participio volger nel suo nerbo, potrà fa r
congiunto con ucrbo y cioè locutione, Come queflo,
Vaf i amento di noia : imperoche p q jja r nota, sareb
he lottition traflata. Il perche cofi f a t t i , a nofìro
arbitrio f i potranno collocare, y come congiunti
con verbo.M a in (juefio modo come f i traudito nel
l'autore ; in quello per torcimento . Ut quello che
fi dice in queflo luogo del participio yfia tntefio in
e v i tig li altri luoghi di quefia imprefit , Il terzo
luogo e quello , doue la feconda voce de congiunti
« in ahlatsuo fignificante alcuna qualità di cofit.
Q u a le sarebbe in qnefio conni un to. Sauvs inge
nio . Ma se fofje ablativo figiuficantc ca gion e]fi
d en te , come quefli micans auro y alta sublimibus
columnis , sarebbe dt Epitheto fa tto d ip iu uoci
Coso come Epitheio al suo determinato luogo f i s c - t
andrebbe . Oltre à c iò , del numero dt cofi fa tti
;
SOPRAM 1 L SON.
il
congiuntif ir e lb oiìo quelli, dove alcuno infinitius
fignificaffè la medefim a qualitate Come, dignus
a m a r tn d tg n u s U d ì . ìmperoche yfin- abbuine
ancor f i yotrtb b o n o con la m eaefi 'ma f i grufi ca
tione ritrovare 9 Come dignus a m o re , in d ig u m
U fio ne .
y
T
z
3
D E L L A
L O C V T r O N
P R O P R I A ,
Ver l'ufo de' co n g iu n ti,
Per alcuna particola della cofirut tiene *
Sententiofa .
Lecutionpropria è propriamente quella manie
ra di congiunti con uerbo, che per lungo u fi f i f o
no ufatt afignificar alcuna cofa p a rtic o la ri, non
per gram m atical r egola , Òper altra r agione .
• Locution propria da riponer mede/imamente
per locutione y b e n d e mollo di ver f a tara quella:
cowpofittone de semplici propri) , o come 'preprq
aiu tati da alcuna minuta particola , dalli quali
effd non fipotrebbe le uar f i n \ d di/Ir ut tiene di al
cun bel modo d i d fre .
Veramente appreffigl'an tich i qnefio nome le
citi ione altro non suona , che modo di-parlare, E t
modo dì parlar non suona altro , che uno non so
che di p iù d iq u e llo , che f i ha dalla cofiruttione
gram m aticale A l perche se ben trotteremo d e g li ac
comp agnati che per le gram m aticali regole.fi f a n
no , colali non segnar ano per accompagnati, co
me lodar alcuno , riputar alcuno , dar ad alcuno
qualche cosa. Jmpdroche p er se la gram m atica!
21
E A T O P I C A D I M.
tegola fit cofi fa tte compagnie . F r a noi affai id
ra mettergli nella selua de*semplici ; ma mentre
ci fi pareranno d'atlanti alcuni proprij della prim a
maniera, cioè d i quelli, che lungamente*};anno iti
cofi ume d t accompagnar/t per lignificar alcuna co
s a , com e, prender moglie , per maritar fi * ìm peroche tu luogo di prendere, altro verbo non batte
rebbe forfè luo«o . Cofi facere certiorem , che in
luogo d t faceta non f i potrebbe dir reddere , Cefi
facere cornettium , inferre contumeliam ; Che tu
inferre convtttum , nefacere contumeliam f i trova
tu Cicerone , Cofi facere uiam , d ie appreffo noi
f i d ic e , s a anco fa r luogo . in formn.a tutu quel
li , che per lunga usanza f i sogliono accompagna
re per u ili chefiano, come hauer m i (iteri ,f a r m i
fiteri,o Insogna, sono locutioni propriamente pro
prie . lm per oche qu efie, lasciar andare , lasciar
pafiare , lasciar cantare, andar allhorto, andar
alla p i a l l a , non sono da segnar per locutioni f
quantunque congiunti propri'j le fa ccia n o , Impe
ro clic quefio nome , locutione , come ho detto , im
porta una certa cosa i\t p iù , che cofr u tti on gra n jm aticale.llqual più f i coglie dall'uso \<y Tuso non
f ì può u ed ere mentrè ad infinite cose le co(ir unio
n i fi po/fono applicare , ma a d alcune particolari,
Quelle locutioni ancora propri e fi ricetteranno,
benché fi ano più dimeffic , le quali non fi potrebhono dtfirugger sem a perdimento di alcuna fo r
m a , ò di particola , ò dall'altra parte quantun
que fofjè fia ta fa tta daWtfìefjo autore nella cvfirut
sio n e . Come metterfi in qualche operatione , ri
pittar alcuno da m o lto , penfar ad alcuna cofa. L e
G I V L I O CAMILLO.
'-%$
quali nel «ero saf i corrompefièro, non f i cogliereb
be alcuna u irtu te . Che à me par 3 nejjùno con
giunto con nerbo doUcrfi coglier per locutione, doue appar fltam cnle la pura forZa grammaticale *
come quello , Calere igne fo lis. Candere afìu fo~
H s. Imperoche locutione come è detto , non t ai-,
tro che uno modo di parlare t-che nop dalle g ra m
mati cal regole. ne da altra ra g io n e, ma dalla cc&
Juetudìne prim a del publico parlaret roso poi eia g l i
autori è nata . Ouero locutione ancora.fi può chia
mare quella -, che so fifeparaffe ne ì fu o i [em piici f,
f i diflruggcrebbe una cofi di p ia , che acquiferi d a
alcuna propofittione.
Per laqval cofa f i comprende , non effer locu
tio» quefìa . Calere igne fu lis . Venne quel v e r
bo , calere y in quefìa compofitione p ig lia quelli
• enfi , che la gram m ati col regola cife d e , Si come
quel?abìat ino per la cagìon efficiente . Dalla qual
cofirutti cn gram m aticale , fe pur il componitor
» d u b it a le y posto che fi defj'e à cercar come [e m p ii-,
ce nella prima colonna y.nondimeno rim andandojl
per il numero all'autore y dal qual lo c o lf , fi p o - r
irebbe in quello confermare» Proponiamo adunane
quefle due coftrunioni d i mede/:mo nerbo . Spc- .
Hans Vencidas un das, coso faeclabat ad Io. Dico
che non la prim a y ma la feconda cof r u tti o r e hot
da efj'er colto pre locutionpropria . Per quella p rò - '
pofttone . a d . Impero (.beffala quella f a modo d i ’
parlar fuori d i quello , chele regole gram m atica ti'
tn fognar ci potè fiero . T a l e è quefia „
Interea medios Iuno defpexit in a g ro s. S is t
dunque generai regola, che. tutte le pure cofintU
14
LA
t o p ì
:
a
di
m,
ù o n gram m aticali'à noi daranno fe lu a d a coglier
fedamente le [empiici , Ma dove niente [a ra d i pii»
d i quello , che le gram m atte al regole* comandano,
douerafsi coglier fe r ie emione .
r
E per la fen t enfiofa bafii quefio effempio .
Non a cafo è u n ta te , a n \i è bell'arte. Et quef i a a differenza deli'jultre cofi si Jegnera.
DELL’EPlTHETO .
V p ith e to .
(fiPerpetuo.
| Tem porale.
j Dulia proprietà .
\ Dal V'. luogo della M ctonim ia .
j Dalla differentia.
Dall'Amplificati otte,
Dalla dim inuitone,
L Dalla tra filite n e .
Vpiihcto e quell'ad iettino, che f i può a g iu g n ercad un determinato , s a impermutabile fo fìa n tiho . O come quitto , (he fert prc li f i conviene ,
o come quello , ehc in aLtin tempo li si può t onileture A l qual altramente .appofitofi chiam ato, Vi:t
libero a V ocìi, clic a g li O ra to ri.
Per la dichiarata un della data deffinitione e da
[spere , che fono alcuni y tth e tt , /i q u a li per effer
f la t i una fd u o lta attribuiti ad alcnna co fit, non
m i par che f i habbiano a coglier per e p ith e ti, m a
p e r adiettiui nella colonna de' fem piici , quale è
quello eli C uidio * ffic erat inflabilis tellus , l m -
pèrocbc per epitheti f i deotto leuar quelli , che, e
jcrttpre poflono , in alcun tempo ad alcuna pa rtìcolar cofa convenire . non quelli che già furono
.
■*
•> °
7
con ale u n a to fa , 0 più non fo n o ,n t farranao.M d
quello nel rimanente, del predetto tu r fio . I nnabihs
in u la . Potcudo/Ì dir acqua noti rtauivabile, 0
•
*
^
acqua , che per esser pencolo f i n n le i, non fi p of
fa notare ,e da ripcner per epitheto. I l perche mol
to fono da fljcr confiderai qufadi ,che g ià una f a
t a f poterono attribuire . Et aual'è quello. Vivrà
radices,nella trasformai ione di Dafne. Oste Ji leg
g e . Pei modo tarn u e lo x , p igra radi d b u> hor re.
Perche per dar / intitheto alla voce piede, diede
il irto di pigra alle radi ci,nelle qual/ fingiam o una
fila volta cj] orfi m u ta li g li hum ant piedi. Ma U
colonna de* firn pi ici confi r itera tu tti li cofi fa tti »
Y.t f i non come e p n h e ti. che ju o officio non è, a l
meno come adieiiiui . Il perche e da sap ere, che
talhor efio che ha fim b h in \a d i epitheto, è n i ca%g io n di ju g g ir la proprietà di epit.beto . T alhcr
la uoce, à cui efio f i accompagna . Et come fui m
cagione efio m edefimo, g ià bh abbiamo detto effer
mentre faapplica, non come perpetuo , ò coninncuole in alcun tempoti Benché per una volta fi l a f i
f i/jè conu-enuto.Laqu.il non potendo forfè p iù a v
venire, nano farebbe tl noflro batterlo colto . Mae
bora moficartmo , come in cagione può ej]cria no
ce, a cui l'epitheto f i può aggiuguere . Et e qnan
do ef i a è indeterm inata 0 non fognata a lig n ifi
car cofa alcuna particolare,come quella a Ohi dio*
N e pars fin e era trahatur. C he qn ef i a noce P a r s ,
effonde indeterm inata , 0 g e n era le , a fig n ifìca r
2f,
L A T O P I C A DI M.
(o n f n f im e n te q u a lu n q u e m em b ro h u m a n o
p u ò p o r t a r p e r e p i t h e t o q u e llo a l l c t t i n o
,
non
fy n c e ra .
,
T a l e è f o r f è q u e f ì o . S p e c te s in n u m e r e . C h e 0 * 1 %
u o ce d i c u i è C a d i e tti ho
in c e r ta
coso
d a Ie tta r n è d a
M a
, coso e s e o
in d e te r m in a ta
in q u e fle
q u tjlo y
u o c i.
,
flg n tf lc a n d o c o f i
mifa
cred er n o n e jje r
d a c o fi f a tto e p ith e to
no
S a g itta
.
in n u m e r e : a lm e n o
o ff e n d o i l f o f f a n i i n o d e t e r m i n a t o y J ì p u ò c o g i t e r
q u e fia p a r o la y i n n u m e r e
,
p e r e p ith e to .
Laqnal
v l t r a + u i . i d e t t a r a g i o n e m o lto f i c o n t i te n e a lle f i e t
te
,
le q u a li in n u m e r o fi p o r ta n o
.
£ f
in n e ro f o
,
ch e h e m h e
n o a l c u n i e p i t h e t i d i c o fi j a t t a u t r t n
f i g n i f i c h i n o q u a n t i t a t e , c h e p a r u ^ c e m o lto g e n e
r a l e y p u r a g g i u n t i a d a l c u n i n o m i yd i m o f f r a n o
co
h a u e r g r a n d e c o n ite n e u o l e Z g a
d e tto y in n u m e r a
.
E
*Q
jfa l
sa
è ri p r c
t q u e f l i f t g n i f c a n ti lu n g h e ^
\ a f u n g h e p o m p e j o n g u s o y iIo . i m p e r o c h e l e p o m
p e f i c o m e d e ' t r i o n f a n t i ^ g l i o r d in i d i m o lti ca
m i n a n t i f i a t i n o m o l lo d i b e l l c f g a , q u a n d o à l u n
g a J ir o c e d o n o .
Appresso
e d a f i p e r e y ch e t u t t i q u e l
l i e p ith e ti y c h e f ig u r a ta m e n te h a n n o m u ta to lu o
g o a te i c o g lie r f a r a n n o d a re fi itti i r l i a q u e lla c o f i
d i c u i n e r a m e n te f o n o .
S i c o m e q u e llo i n q u e f ì o
u c r f o d i O u i d i o . C r u r a n e c o b la to p r o f a n i u e l o c i d
c e r u o .C h e i n o g n i m o d o ,
sa a lle
non
a n o i p u ò b a fh ir a ff a i d r
c i fo u erre b h o n o
. E t
cru re
f
o ff ero d a t e ,
f i p é r e y c h e p e r c o fi f a t t a f i g u r a p e p i a m o f a r d e lle
m ed e fm e %
E
t g l i e f f è m p i d i t a l i f e tic h e f i a n o i n
f i n i t i , p u r q u e fli c o n d u rre m o in m e z jt.
7
I«< ;
p a t r i s b l a n d i s h a r e m c e r a ree l a c e r t i s y p r ò
h ia n d i p a tr is .
V i n c e r e a r u n d i n ib u s [ e r u a n t i-a I h
m m a te n ta i y p r o lu m in a f e m a n i l i .
M a in a tte -
G I V L I O C A M ILLO.
17.
fio fecondo,per non h au er fofa n tin o f ermo,O 1fin
mutilili le , // coglierà come pu.ro participio . Per-,
che intendendo d i Argo , ilq n a l fa tal in d i ni.da*,
che per non f j e r im perm utabile,di lui pcranenlti
ra non potremo ferii irci.Cofi fa t t i ancora fono cu e
Jh.T irriJicam capiti* comufsit terj; qnaterj; C e
sarie/// . intendendo d i Gioue : Benché per la d i
g n ità di Ci cne jnoi particolar luogo babbi amo da
to a fnoi caprili. Et à quelli tale epitheto . Mae
qudlo, ora indignantia folliti, prò ora in d ig n a n
t i <, non e da dare per .proprio epitheto a G io u e.
li perche attero c da poncrìo ver temporale,delquà
le topo parleremo,onero ai concetto della in d ig n a
none. Ut e da confsacrare gite alcuni epitheti p ri
m a che firm ino da efjer colti cpnhciifhanno v i r
tù coi foto n o m e, a cui .fono a g g iu n ti., s a nerbo
hor f f a n t i ao, hor allcttino d i f a r locutione ,q u a lc è quefin m C he per uol.er d ireb b e, era ottimo a r.
ci ero}«ItJJr, nof i rani fo yiita m effe, certam . JEs sol.,
jijte ttiin giulcndi d ire,ch efi sfogò con parole,d ,fJe , ora rudi «nauti a f l i n t . Ma Jh fi aggi tignejfe
altro nome (ofianpiuo., nonoperar ebbe , come. „
$ ignare agros iovgos lim ite, bnpercche a n c o r,fi«mire *vrrosyfarebbe concetto di m i fu r a r U c o n f
ai . Ma levando a tti predetti lo epitheto , fi- leva
rebbe anco la natura dei primo concetto , la q u a l
nuoua fignificatione, fe ben f i g uarderà , pren
derebbe . Et lo epitheto da f i principali luoghi
Jvpra nella d i n i f o n m o fr a ti y per mio anifo f i p u ò
trarre .
I
D alla proprietà del nom e, à citi è aggiunto,
come ., dentes a lb i} uina hurrada , J lu u ij IiB tj
1«
L A T O P I C A D I M.
q u e n te t.
l
D al luogo detta meton im ia t fin efiu s trifiis,
pallida mors. Et in quefìi due modi altrim enti t
chiamato epitheto perpetuo , perche Sèmpre à cotali nomi to ta li epitheti per proprietate f i con
vengono .
rf
|
Dalla differentia, come d itta pla cid a, cioè à
j
differentia d i q u elli, quando dicono , aie la
irata •
Dalla Amplificatione , come parole fan te.
J
Dalla dim inuitone , come animus nvnutus ,
j
per animo picciolo.
Dalla trafi ottone, come netti f u d a ti effempi,
j
dififa placida , onero irata , tmperocbe l'ira e la
,p iaceuoleTfoa fono trafiate dall'animo atti detti .
t
Et in tutti quefìi altri quattro modi può chiama
j*
, re epitheto temporale : perche e mutabile, 0 non ^ !
perpetuo,di quelli nomi a cui s aggiunge . Mae di
sa
quefìi tem p o ra li, quelli che potranno uefìir con(
cetto, non faranno da efferfogn ati, la dotte ti per,
j
p etu i f i fognano'. Et per g ra tta d i ej] empio di uè
f i i r d> epitheti quefia uoce, rem ?, dice che que
lli 0 cofi fa tti le faranno perpetui ,g ra u is, den
sa y pendens . ma quando io trvuasfi di q u e fìi,
madens p lu v ia . 0 fumili, per effer epithett tem
p o rali , non più fono d i quella uoce terra , ma d i
quefia determ inata T erra bagnata,la quale deter
j
m inata,può tutte l'altre uè f i e d ella lingua ricevef
r e . Il perche tutti quelli epitheti , che potranno
uefìir nuovo concetto , che di neccfolta f il i tem
porali faranno da coglier dirimpetto alla nuova
chiave, come c il predetto , 0 quefio , opera perj
j
fi
Gl V Lì Q CAMILLO.
.
dieta, che Latino f t dice, labor in ita s . Vera oche
fitto la mede/ima chiave, non fo llm en te potremo
trovar il predetto Epitheto , ma alla f i a colonna,
quefìa loditi on am ora > perder fa tica , cosof i n Hi.
w a quclh epitheti tem porali, che ci parra non p o
ter rtiratili compagnia di locutione afflai farà col
locar f it to g li propri) con quefto K , che fignifica
m i a perio, come , monte a/pro ’ monte 'dilettato
le , ecco che cjaffano d i quefli non i perpetuo,
tempera? . Goff Donna betta y Donna laida . £#
esse nel mero non potendo batter in compagnia lo
cutioni , che potè [fieno «esser il mede fimo per non
f a r concettoyf i contenteranno d i eff er, come è dei»
to fig n a li con la infognata diff erentia fiotto li lem
fe r a li. Et perche ancora fin o epitheti c h e f pofj'on
dar à nomi > coso ep.i
:■, che da quelli f i •' yjórtp
fray sset m e parrebbe, che tu tti quelli ychefi tr a g
gono , fiano da riporre nella c oh ama de*[empiteti
C omt q uèfio n o m e . Amore yf ù ò hauer per epi
theto nobile ,alto y rosofim ili tem porali. H da lui
f i può trar quefia epichetv y am orojo, da dar per
cofi dire alle fia m m e . Io direi- che anelli, nobiley
roso a lto , fifiero da legnar per epitim i fittoi. m a ,
amorofi,pot che fa rà dato per epitl>eto alle fiam me
(oso ad altra coft convenevole, [off e collocata alla
prim a colonna del concetto d'amore , come firn plice , non altrimenti t che.nobile , coso alto fra li
debil i loro [empiici y fatto il fuo officio. Impera
che confideraii cofi-traiti dal nome, non f i r n epi
theti almeno fitei. £' uri altra maniera di' epithe
t i , che di p iù uoci f i f a , la quale trilhor d'u ri tfi of
f a cofa con la peti fra f i , d i etti d fu o luogo parie»
ir /
30
L A T O P I C A D I M.
remoy d o t quando circojcriue talmente alcu na co
f i , che può efjèr iute fa ; talhor le dette p iti paro
le lignificano alcuna qualità della cofa . E t m i e f ìo fecondo modo (s confer nera ancor nella feconda
colonna d eg li cpitl)(tiy com ey om bra apta p a fto ribu», h.creutia mora ru b etis. Alcuna uoltafi fa
di più n o c i, per aggiugner la cagion efficiente.co
m cocuh mie ante* igne. Et quelli epitheti che fin o
di più noci a differentia di quelli {h e fono d i una
f o la y vegliam o fognar con quefia pariicclar nota
di più da aggiugner itgl'epith eti , che quelli che
fin o di una uocefin\a altro fig n e f i cogliono3 ma
quelli di p iù cofe.
D
E L L A
V E R I
F A
A S L
1
D a lia v e n e r a tio n e
z
Dalle a f e , che opera f o ha operato, o suol
operare.
Dalle cofe y che pofoie.de y ha poffednto.
D alli ornamenti.
D a' configgenti.
D a cofe u itin e .
D a* firn ili.
3
4
y
6
7
,
o
Verif a fi è circonio cut ione che in luogo del drit
to nome,pone uiialtrofaofoioso di p iù u e<
vrnpa
g n a to à con uerhoyoferina uerbo,onde e coturnato
ancor Anto noma]ia .
Quefia è connumerata tra le ornatifoime fig u
re y 0 pero molto poetica ; tir può appre/fo orato
ri haucr p iti d i tre l voghi Cioè mentre itogli am o
\
GI VLIO CAMILLO.
31
coprire Li dishoneflàfe quelle cofe, cheJcircbbom
molcjle a g h (tutori, bquelle , che detrebbenegra
usseV 4i> da e n ti. Mae il Seccaci o-, che f u fa?fio
Vuota Dìpwija , non fi ha guardato di s f a r fuori
delle dette tre leg g i infiggiate ci- da- Hermogene .
Kt a noi e piaci utò per due cagio collocarla ju b ilo
dopo l'eprtheto.Yrimaperche effet taihor èpofia in
una noce , taihor in ptu . In una u>oce3co ih e.T idide , Veline , l ’em pio, il p a rric id a , V e n e re , 0
amor , 0 fuoco, per l'a m ica . h t p iù n o c i, come,
i l Vaf i or che a Golia ruppe la f o n te . Ver D a u n L
L 'a u ra , perche qual'hor apprtjjo la circonlocuiia
n e jip o n e ancor il circonfcntio, fem ore la arcunlocutione per autorità d i Q u in ti li a n o ,h a da efier
chiam ata epitheto . Mae noi , o f f a , ò non f a pe
f i 0 il cìrconf ritto,hauendo rifa etto a te m p i, che
» di lei ci vorremo f r u i r e , fa r a da noi fognata, cotnc perif a f i . • Appreseci c da Japerc, c h e la acrif i f a di più- parole,alcune volte in d ù de'nerbo , a l•. cuna uolta non uc lo include . Onde O in d io nel
prim o,ufim dola intorno al nom e divino otto uoltc
le f i fece fin /fa verbo . M undi fa b ric a to r, opi
f e x r e r u m , moderans curiti a , re x fa p eru m , re
di or faperum , cecief e nu m en . Qui cvelefiia f i e
ptra tea e t , q u i unga fu lm in a m itili. N elli quali
due ultim i luogln ti nerbo è in c h iu fiycome un? de
g li /noi com ponenti. Mae ne f i u n i m aniera ut de .
locutioni che fegueno , pefi ano esser f n \ a uerl/o
neramente. Et !ss u d a ti luoghi puflon darci a ia ,
y d a conofcerla , coso da fir m a rla . Effemino del.
prim o come fem plice . T iti d e , m a come compof o , f ig li noi ds M aia , d d fecondo, fabricator del
B iit’j
mondo,del /eroso, colui che m arna il fu lm ine, del
quarto,colui che regge il mondo {lei quinto tubar
infigne cor u f i s radi/s ,p rr i l Sole . D a congnm
U . A qua liberi or , per il mare . D Ale vicin a li,
Regna N abatta per COriente . Si può ja r ancor
p e n jra fi, qualbor dal nome che vogliam o circonferì vere yformar erno uno ad iettino, aggiungendo
un Jo fa n tin o ; che g li f i convenga „ Come fe c e
O v idio t che circonfcriucndo il cielo ,fece un a d die/f/uo, celeste, 0 aggi un f i quefio nome Solum;
onde d tjfc . Astrae tenei/t caie/le folum. Et D ante
parimente a quefia regola circonfcriucndo lim a
re , desse, marmo jnolo .
A ggiungono però , che non tu tti li g e n itiv i do
pò alcun fcjhntiuo , opera p e r if afi ,fie non quan
do col fiffantiuo precedente, po/fono fign ificar tu i
to il circonjcritto , 0 non parte, i l perche quefìi
d i O vidio , ignis filis , lum ina f i l i s , non presseno efier p e r if a fi del Sede. Perche quantunque
que/ìi g e n itiv i fiano del Sole , It fo jìa n tiu i non
dimeno non importano f i non una parte del Sole,
l'uno cioè il calore, l'altro lo Jjdendore . Et f i
alcuno dicefje , poiché non pojjono efjere perijrafì
del Sole, (inno almeno pertjrafi d i quelle.parti del
Sole , l'una cioè del calore, l'altra dello fjdendore;
perche tanto è a dir ignis f i l i s , quanto igr.is fo~
la r is , se coft dir f i pote/Jè . Ht tanto lumen f i l a ,
quanto lum en fila re . A quefio rtjpondcrei, che
<t fa r perifi-afy il fofiamino che vogliam o circoJcnvere , ò fi dee levare , ò almeno degenerar da
fic diucrtendo , ò adiettiuo , ògenitivo fo co /a f i n u le. .Mattel prim o fGiumente detti fivdeiti luo
ghi *
O
s
C I V L I O C A . M M . t O . .3 3
f f i i f t mention dì fe. hi un trafiatogn quella uoce,
ndl'altro remane Jaldo, s a intero, i n f i t t i
la noce lum en , E t perche del jitole non può eff e?
dubbio y cfa' per alcun modo non ptto effere, u e r
giam o del prim o per efferfi imitato in u v trattalo 9
perche con quella r aprone y che quel t r a fa i a fo
tum fece p a ifia fi in qrtebi congiunti , ccciefie f o
tum , par che lo faccia ancor t u quefie , ig n is f»
l i s . Et f i come .. io adiettiuo , celefie^uolgend o fiin genitivo , non manca-di f a r per fra. fi , d i
cendo Cefi, jc iu m cfai y per effo cielo. C ofi aue-*
fri compianti :gm< f i l i s . parche fa r debbiano. Io
non fip r e i dir altro al prette»:e r fe m a che non'
tni par benfatto , che conducili amo le p enfia fi ad
facttna u ih a d e f E t fe f i l a dotim i » tener peri fr a
fi quella y che deferine un tutto y come fa tte lo ,.il
% Soie y il mondo y u n bucino, cyfim s'l cofe . non a!
cune lor particelle , con quejie conditioni n ondi
meno , che difiruggendo toro cioè, fe p arando li
, f empita , non veggi,amo , che f i d ifiru g g d cofa ,
che ne «li/'em piici trovar non f i p o j j a Quest*
congiunti fòr\a. di proponimento, d i configli o, s a
ci vergogna , poi che faranno parti tam entc collo
cati per li f im p lic ì farci i l luogo loro nella p eriJrafi di., aajcatto loro concetto Z: s a che pcfivno fa r
altre, che perifrafi y non offendo locution: ? Si UHat ebbe per auentura alcun argomento cofi con
ira » Effe non hanno la. diffinitione de perifrafi i
adunque-altra cofa, fono-, imperaci)e la.pcrifiafi
è q u e i, k che pene uno nom e per stri altro «. m a in
eia/cuna d i quefie. rim anendo il proprio-, n o m e ,
m w tfaropom nitniQ a c h i è quanto, deliberai ione,
\
,
•5
'V-
34
L A T O P I C A DI M.
per >jjer fko fin o n n n o \0 configito 0 uergog»*
m ente circo fendendo , concluderebbe facilm ente
qttejle non cjj'er perifiafi . In nero quefio argo
mento ha ta n ta sa roso, a n zi ta n ta Jltybianzjt d i
ventate , che non e cofi d a J]}rc\gjtre,perche da
ra lume a molti luoghi di quefia beila trnprefa.lo
nel nero r:jpondera y che sa 7nome rim ate nel j'uo
vigore y coso non può arco ferì nere fe me defimo .
O nde udendo circo feriti ere y ja Infogno levar lu i y
0 porre u ri altro y ò piti nel juo luogo. Ma q uan
do efio degenera da sa in ali un modo y aiìhor può
ejj cr parte etreoferiuente di fe f i e fio . Si cam ene
g li eficmpi y ch'io diedi nella deferititene del cie
lo , fa tta da D indio , quando d ifi e . Cadeste saium . K/ in quella del mare fa tta da D antey mun
ir e d i f i e. marmo (nolo yche f i come quello adie n i
no > ndcjìe y degenera da quefio nom e , cieloy che
per efjer (ojranttuo , 0 retto eajo, è nel m aggior
Jho u/gore y che efier pofja ; 0 marino degenera
da mare {Zo fi tutti li g e n itu i enfi macai» detta u ir
tute del lor retto, onde ragionevolmente f o n chia
m ati obliqui. Et nel nero fin cofi fatte maniere di
parlare fil g e n iti ho h a quella medefi ma uirtu ycht
se adì etti ho fo fi e . C cm iofia cofa che quando g li
autori diconotuis éogitationis, « /s anim i r t quel*
lo Sicf i oy che fe dacefiero per Ice adìettiuo y uis C o
g ita t tua y 0 uis a n im a li>, cioè efia p o ten za , che
chiamiamo cogitatione,0 animo ".parimente q u el
la fio fio è forza dì proponimento , fo r za d i config lio > /eroso di vergogna y.che fe la g e n tile z z a
del parlar hauefic comportato dir fo rza propofiti
vai,] orza, configli eli ina, saroso vergognati uà. x che
'v
G T V L T O C A M. f L !. O .
;>■
^ f n p o f i t o , cffi configlio , cffi vergogna f esa
m alte altro (bona fo rza g lie apprejfo L a tin i, v is.
La qual bora per quell a uirtntegh e tr a ila cefi ,
f i pone, hoty per io sformo. Ver la qual cof i (e
noi ricetteremo forza nella prim a figrùficatione ,
cioè per quella u ir tu t e , che è nella deliberat/n*i~ ,
f i come fi dice un arimi a , per quella virtù che
t nell'ani ina , a'ilhera ciafe un a delle dette para 5
fa rà perifiafi . I niper oche uno de' .congiunti g u f i
sformo, fignifica una cofit, che non èjernpre nel
la deliberatione . N e m i par effer ben fa tto d ir ,
che ella fia circolocutione di q a efio concetto■d e
terminato , deliberatione fo rm a ta , ò ■sformata ,
percioche p iù in falli (ni regola debbiarne ha nere ,
che una circolocutione non pofia.cficr p iù che di
uno circo fr itto determinato. Et nondimeno cofi
% tire ofcriuerebbe no t> fv i am eni e ladebber airone ,
ma quefio d e te rm in a n te fo r m a , che effer non
p u ò . Vercht allhora, forfia f i pur fino n i mo d i
.sfo ri* g Et quel genitiuo , deliberatione , per fe
nulla può; f e non che dim ofira, d i cui fia cofi fai
fo sforeo a A ggiungo fe alla perifiafi fi appone
nerbo , che non fia ejfential parte a u ffa p er uè*
jh r infieme urialtro concetto , taihor coiai com
pagnia d i congiunti diuierie locution trafiata, (oso
taihor figurata,coso ri verbo fi chiama parte ef i en
lidi della p e rifia fi, qualhora levando quello , f i
leu affé uu membro della intelligenza della perif a f i . come che sio noief i circofcriuere Scipione ,
di c e f i , colui y che rrin ò C a rla g m e sa Mae p a r te
non effettiiale , sosoperò conducente alla perifiafi riMciuTr u ti concetto d i n o f i dii lei t'ytptattdp il nei*
&
$6
L A T O P I C A D I M.
ho foffe ta le y che per levarlo v ia y non fi leuajje
membro di lei, quale e ni emetta locutione del Pe
tr i r. ujc/r del terreno carcere y che quefio con
giunto tutto uefie quefio concetto, m orir, 0 den
tro.» i e una peri fra fi dell'httrnano corpo. Ne p e
to fa locutione figurata y ma trafiata y per quel
uerbo tif a r , che conviene al carcere t al qual da
Vintone e afjomigliato Vhutfntm c. rpo . !/ luogo
Juo e da inanimato ad animato . Ma quella ch'ai
none fece. Inficiar rotta 0 fpa/fà quefia frale,0
graut , 0 mortai gonna . ebeti locutioi fig u ra
ta . dentro d: cui c mede fi inamente nryi perifiafi
dell' bum ano corpo Et è tratta d a l luogo deli'ef
fetto . H' differentia ancora fra la pertfrafì y 0
la defcrittione. Che la perifiafi non folam tute r imouc da fe il circofcritto y ilqn al farebbe m anife
Jhfitrtto ; ma r quello da alcuno detti fa dati Ino- r
gin circojcruue. [it cofi lo vuole dar ad intendere:
Ma la defer attorie f i ritiene tl defcritlo .. Et quel
lo fi come non iutefa dichiara t aprendo alcune*
proprtetadk della natura . I m per oche, fi? off e al
cuno, che non. fapeffe, che cofinfoffe [A q u ila , 0
d i to g lie la uolefii dare ad in ten d ere /A q u ila e f
fer uriuccello d ’oc dito pofjente a riguardar li rag
g ì del Sole , 0 unghie rapacifa m e , di cotanta
g ra n d e7
g it y
0 di ta f cofi urne*. In quefia dichia
rottone non è rime fio il defcritlo,atifo necefia ti d mente è mchtufo . Cofi fe io noiefot deferì iter un
giardino, uno viaggio , netta prim a parte del ra
gionamento haurtbbe luogo hi cofa r a r ifj in q u a
dunque parte Potrebbe batterla qual io uolefii de
ficit u u e * E t quefia d tfin tsic M , per. la. f ita hm~
C I V L I O C A M isse L O .
17
ghe 7
g g s a n atu ra, sT confi rideranno con le fine
materie s a macchie „uobliamo nondimeno delle
defir itùoni trar molte p enfia fi defi effe per appairocchiar m aggior copia a nofiri bifigrn da quelle
cioè,dalle quali fa r j l potrà acconciamente _ An
corae perche come è (letto y Ut perifi-afi può u em r
in tre m ode, cioè: in più ucci con nerbo g n p i# ito
ci fen\a nerbo, s a in una f i la,noi pigliaremo tre
dijjerentic da fig lia re , che a qu-efia generai no
ta iìi peri jrafi G aggi ugneremo per Li p rim a que'
f i a t per la. fecen :a l, per la t e r f i oh epa e. SV
che fi vedranno cofi- fig lia te . C + ]
0 *
Et fe faranno perifiaft difleffe , cofi ^ 4. 0 use
T.t perche a ba fh n g a fi e parlato d i quelle periir a
fighe fino, di più noci con nerbo fioferina verbo.pi a
cernì che babbi amo alquanto di ragionamento in
torno a quella , che èpofta in una foia ucce. Dico
adunque , che molta, ccnfideràtivnc è da. bavere!
in cofi fitte .per la u i ci n itale che è tra l e i , men
tre t in una noce , s a ira la Sineddoche ^ Et la
tra/lattone, s a la perifrafipoffom p e n e una uc
ce per u r i altra _ N on per timo cioè quello scense*
Tuna & l'altra . Che f i quello ifieffo fofjetogion
faceva Infogno, che g li antichi b ave[feroritrova
to per fign ffcarie , p ia n o m i.. Sia adunqu e p e r
fen n a regola tenuto y c h e f con (fiere le Sineddo
che , s a la trapalione v ia dal ,: perifrafi d i ury%
ucce, aperto fegna f a r à xf i io. vece figm jlca. alcu
na porte per un rutto , ò per contrario, b altra cofap r im a .. Irnper& cbe quantunque s'intenda appreff
fio i Poeti il cielo per quefia voce- A x is --opera pe?w
quefia j, O lgm pm * tm d im e m n e ffk m dà I m £
3*
L A T O P I C A D ! M,
,
p e r/fra /i. M a la prim a e Sineddoche; perche per '
u n a parte del Ciclo e [igni fi cato n' tutto . Concio
fia c o ft che Ax is e quella parte del ciclo g ì te è Setdentri a n a le . Ella feconda è tra jla tio w . perche
cotal fiocc , Q lym po, è 'siala, traportata da u r ia llu ftm o monte di cofi fa tto nome , al cielo . Mae la
per fr a fi di inni uvee r ha m aggior ecc ottenga che
alcuna delle predette figure . Imperoche la fu ti
/in g o ia r noce, fempre pone per m aggior enfiaf i ,
f i i i \ a aiuto nè d i Sineddoche , ne d t trafi ottone.',
formando quella da alcuna operatione, ò dal luo
go , ò da alcuna perfino. per utrtu della denom i
natione . qual è quefia, tonante, per Ciotte, d a l
la operatione . Et La io n ia , C am bia r y O rtig ià dal luogo . Mae non e cofi di q u efia noce E e he . perche quefia noce Fche , e {m om m o., non
p erifia fi di Diana , non altrimenti che quefia Faeho , d i Apollo , da nome di perfitta farebbe, come
ciipefio, S a tu r n ia , per G iu n o n e , Imperoche cofi
» denom inata da Saturno „
.
I O C V T I O N 1' R A S L A T A.
F ura.
A lleg o ric a .
Sententicfiu
Location trapala e quella doue alcuno fi p i te d t
congiunti fono trafiati .
L a trafilata ferina riguardo,fard da coglier per
conofier il g iud trio del?a ut ore . I rnperoche nello
trafiate, coso nelle figurate,ejfu può p ia m e n te mo
s t r a r del Juo artificio aperto . y le trafilate fa ra n
no com e atte fi e . Seguir laude , fig u tr hiafimo ,
fig g i ir pencolo, frenar cornpafiione in alcuno, ac
ccndcrji d'amore , pervenir a. notitia concepir
m m :i
w refiigeriv rportar cjguicne ,. p o r -
G JV L IO C A M I U O .
3:9
piacere : Et in acro di fr u iti i componi m orti
detta Location trafilata quantunque g li [em piici li
fitto luogo fofiero ripojìi ficco y nondimeno
rii
[irebbe d ifi rutta la indù f r i a dell*autore Ja q u a i ci
nofiin Infogni non potrebbe efjere apparecchiata;
che.la tur ni della trapati otte non fi può trovar nel.
le noci Jliolte , m a nella tefìura di quello . Et nel
aero facendoci inef}ieri dii■quefio concetto, chi la
terra bagnnùi f i fa acconcia à produrre , quandoil Soletti percuote ; rionci foitenirebbe alcun bel
modo trafilato prefo da Poeta . ma et Jocctrrcreb
bero fo llm e n te Le proprietà. Apprefo è dafiàpe
re y che la locution trafittila fi pu ò d ia /der tn tra
filata p u r a ,0 trafata allegoricay0 trafilata fenr
tentiofa . . Et per la tra fa ta pura p u f i -io affai hoc
f a r h fi- dati e f empi r ma per l'allegorica filano
quepiyCj] er giunto al. m eoso g i orno yuol enclo c h e f
intenda efifiergiunto.ai m t\o d ella v ita ..E tq u a li
fono quelli nella Sef i ina d i Dante . A l poco, g ì or
noy0 idgran cerchio d'ombra . Scn giunte [af
f i , 0 al bianchir de colli-. L i quali trafilatifigm .
ficario, lui ejfergiunto alla v e c c h i . Et uniruerfidmente quefte allegorico comprendono futi»
li prouerbij, Emimmi y 0 compoflùom cofi fatte
lequali per difin gu erdalle pure cofi fognar emo
O . ht li tuo chi dtll'una , 0 l ’altra fono tu tù
quelli y onde fi puleua tra n s il femplice trafilato ...
Mae della- fientcniioja fini q u e fa .la morte èfin d ’?&
mi prigton ofeura, a g li a n im i g en tili _ Er im ittertalmente tu tte quelle coftru-ttiomycl)e hanno là
enfi efeogitati r che fanno Informa d i grdm-tate..
sa
K t altra differentiAx traile ftntm tiofie t r a f a u f
40
U
T O P I C A D I / M.
s a l e finten tio fe proprie , che netti loro fem p lu *
com ponim enti : m a nella v ir tù fono rnedefipie.Et
pero vengono a fa r Jenfi di un a rnedefìma form a.
E t vogliam o quando ben avanza/]erode coflrutt io» di'uno concetto , che fa n o confer nate in uno
d t questi luoghi , per m ento della loro d ig n ità .E t
p er batterle tempre p ronte, s a ac ci oche fi poffari#
conofier dall'alt r e , vogliam o , che le tra/late / I n
tenti afe (t.ino con quefio particòlarfogno notate ,
— . N e rrn rimarrò di dire, la locution trattata
batter g r a n v irtù , nel dtp/ngejr le co e d a v a n ti r
lidie m aggiorm ente fa la figurata che fógne» Ma
la pittura y che fógne dalia tra fla ti t>ne,uien fo la mente dalla c o fiyomie ti tra/lato cTlatio pre/o, che
per correre alla mente no/ha la cofa , onde è sia la
ir .u f t rita la noce , ci f a quafi veder/ìnule quella,
à cui è trapor tata,qual è quefio. di. V ergili o S -t p a
iris A ncbifjtgrem /o compiei h tu r offa.Cofi wntato.
d a l Petrarca pariando^ alla-terra y otte era fen o li aM adonna Laura» C h 'a b ra d i quella,cuì ved o m i
tolto.Ecco clic,per udir, noi quella noce abbracciar,
corremo-con l'a n im o a quell'atto, fignificato u era m ete da qitefia noce,abbracciar. Et cofi et par qua.
f i veder un non (o che d a v a n ti per ejjer d a to , co
m e atto d'huorno ; alla terra i»fenfila le. Mae la leCVti.Qti fig u r a ta , quello che mette q u a fi nel Cof i et
lo de* ItUori, ìto n fa je non per la v irtù del luogo,
onde eff Ocf i muove-., i l perche Virgilio hauendo k
fa r tirar il mede fimo, concetto,eh e è di je p e ltr , cosa.
d ijfe .O n era n ti m embra f i ptdcre-.$ rendendo la fise
g u m d a l luogo detti configgenti %m ijÌA in alcun,
m a vk c m quella de «li a p p a m ifo
CI V L I O
CAMILLO.
.4?
+
T O P I C A D E L L E - F i G V ?v A I E "> i • sa:..-.,' ....
L O C V T l - o ' N ' X»
9
("‘Materiale,
“
i
n
f
e
r
UFinaie.
i
i s s a
, ■
Da g lì ìnfirumenti detta c a r i on efficiente,
D a g l i e ffe tti.
D a g li antecedenti,
Dae/lt configuriti)..
_
[P r e c e d e n ti,
*
D a g li a ggi unti f a Accompagnati.
, L sehuenlL
D atti contrari * '
• Daense a tti .
Dalla q u a lità Cosom a n tiÙ del cerbr*
D a g li apparen ti„
Daellae f i m i Illudine
Dalla comparatione.
Locati on figurata e quel modo artificio fa db
parlare , c/?e tratto dalla u irtà dì alcun lu o g o , u
topico , o fig u ra tiv o , hor in preprie , .W irr rrtffiate parole talmente cl ipprefenta quafi la fig u
ra , ò tm agine che dir vogliam o dèlia cofa , fintila
fpefjèuolte nominar q u e lla , che più topo ci pouf
d i v e d e r la , che d i leggerla y q d i ud irla .
G ut pervenuti a quella parte d i lingua , do u t
p iù dclTartifirio,quaji con di fogno a pittu ra J ì ino
fir il y0 Ltqu.dc gl» autori- cvn /dentio hanno pa f
futo,dtuina nel uera, 0 m afinna cagfin della d ilettatione, che da g li ornati fiy fiti antichi f i preti
de ; e prim a da fupere , che ne parole proprie, nè
tra/late partorì/cono la e fje n tia d i quefia locutio
ne , di che bora babbi amo ragionamento , m a fa
lò i! luogo onde esse: fi trahe . N e puffo negar che
la trajhti ion non h abbia g ran m agi/ter io nei dar
le colori , qua n d o f i ricette per ornamento . Mae
in nero tutto il difegno uiert Jolamcnte dal luogo,
E t il luogo non è altro , che il fonte, onde la effets
iia della locution può hauer origine. Si come luò
g o chiamano g li Oratori quefia fe d e , ovepofii l s
u ir tu dell'argomento , & onde ejjo argomentar fi
può . N e fi potrebbono trovar quefle locutioni f i
g u r a te y fi come ne anco g ii a r g o m e n t i f i p rim a
voti f i conojcefjero U lu o g h i, non altrim enti , che
trouar non fi potrebbe gì ani ai la penice ni Ita lia ,
quantunq u e fugacem ente per tuli i U m onti, o f d
tue di quella f i cere affé . perche il fino luogo non è
in quefia regione . L a cagnition de1luoghi a d un
quCy cofi per tra fia t ion chiam ati d a 'lu o g h i m ate
riali y porge tu tta la inuentione di cofi fa tte bel■lefge . Et fin g a qu dìa cofi farebbe pofihbilelro.uar [ g u fa d i locutione come la Tirila d i Saturno
nel cerchio della L u n a , quando bene alcuno p o
te re col Corpo la f u andare Ut fin o al credei mio
a lc u n i luoghi to p ic i, commu ni à g li a rg o m en ti,
0 à quefi efig u re gam e le cagioni, g li effetti, g li
antecedenti, li configgentiyg li a g g iu n ti, li cvn-
"W
c i V LIO CAMILLO,
„43
trari , toso i n alcun /nodo li fim ilit roso '< compara
ti . imperoche quefli che f i prendono da g li ijhtfi
m e n ti, dargli a iti, dalla q u a lità , toso q u a n tità
del corpo , d a g li apparenti , non fo n o topici, wae
s(T cefi d ir e , f ig u r a tiv i. Ben sano ta li, che p iù
m a n i/; ' uente mettono davanti à g li occhi le f i
gure , le quali da loro f i form ano, che non fanno
perauentura li topici.N e fin o quefle fig u re q u e l
le,che fig u r e , di /c ru e n te fim o , fi come ci infiegua H erm ogene, una mede fi m a cofa c o n ti ine
tti o d i,tir i cpn quelle aie, per b a tia li f i indriZfi ti
noJc fim e tìfie ■» E t le fig u re d: parole quelley che
per la fola.!ero cofiru/tione, epllocatione , f i m o fìrano citali, m a def i ru tta cofi finita collocatione, '
f i d ijìm gge ancora la fig u ra . Ma quefie chiamiti»mo locai ioni fig u r a te (n o n perche in d rifig i no a l* cuna finte& zg, operche f i m ettano in tale•, o ta
le fig u ra di cofim itie n e , che rivo lta la cefiruttio
rie in p iù maniere quella medefima fi rim a ne pan
iti Perche rapprefen tatto d a v a n ti la fig u r a elesse
cofit , f i che ti p a r dt vederla . Il perche fo rfè con
m ag gior ragione.merìtano.quefl e il nome d i figa*
ra , che le predette d u e . Et fopra tutto t da con
fi derare,eh e le trafiate uoci, o le proprie non f i n $
quelle , che danno ejjcntial siato a quelle figure ?
ma come g ià detto hahbiam o, fidam ente il luogo ^
E t per g r a tia di efj empio poniamo, che alcun m.~
g iia figurar quefio concetto,uietnarfi ìn fe ra . D ir
co che potrà gentilm ente per mio auifio tirar la f i
gura dal luogo ile g l i antecedenti , uefiendo ta l
concetto, ò. con quefie parole proprie , poter pa
rer à quelli, che heibiia.no Marocco d i p i affo, veder
44
L A T O P I C A DT M.
ritappreffo il Sole f i con oneste trafiate, Il Sol g i r i
bagnar nell'Oc e ctn l'aurato carro. Et accioche m e
glio cotaì virtù He' luogh i s*intervia , ipcom inda
rno da. quello’delie cagioni, che fono quattrognau
rial*, efficiente, firmiate, s a finale . LtquaU fono
m ciaf cuna cofa , Si come nel T eatro la eagion
jm ateriale (tea forno le p ie tr e , & altra materia d i
che fitto fu l'efficiente Tar cìnteti o , la form a che
ense ha di T eatro , non d i chiefa o di to rrefa f i
nale , che a fine d i recitar & rapprcfintar cofe à
cUUtt o del popolo fu fatio.
D alla cagion materiale cofi figurar f i potrà Io
Cupone. Ecco il Tetr.proponenti <f i di voler adirrmar con fig u ra quefio concetto , cantare, li uennt
pon fato poter f a r ci b adoperando l'artificio intor. no alla cagion materiale del canto , che e g li / p i
r iti , cioè il fia to ,il quale tiralo da naturai fofpiro * j
«die p a rti fupreme , come, in/egna Cic. nel fecondò
della natura delti Dei , g h ifru m en ti che lu i fo
no , in molte maniere d i noci lo difim guono, s a
informano come in parole ha/fe,in g r id o , in can
to ♦ diffe dunque. Et i vaghi f r i n i i in un fofpir*
accoglie, con le
m a n i. Et altrove udendo
d ir chiam ar a ltr u i, Hijfe » Quando muovo if o fpir a chiam ar uos. Et il detta concetto ricorda
m i M .T ullio nel prim o delTOrtitor haiter cofi u efiito . Excitare a o cem . Tari «indicio fi» quello
1
d i G nidio , che intuendo a uefiir quefio concetto,
fo n a rla tromba y dtff'e » Buccina qua medio con*.
x ip it ubi aera pomo * Et fe ben ccnfideraremo ,
nè a l Petrarca parve che't concetto del cantar, nè
\
cui O vidio q ne! del fon ar fiffè a bafianza fig u ra -
e
sue
\
G I V L ! O C A M I L L O.
4C
T fa /J filo luogo della cagio* mater ride , per fi*
g u ir il luogo degli a g g iu n ti fig g e n ti, l'uno d k m
d o . Et i v aghi figirti in u n fojjnro a cco g lie,C m
le fue man# , e poi in ucce g h [ d o g lie , C hiara
[ c a n e , angelica , 0 diurna . L 'altro . Buccine?
qux medii? (' incip it ubi aera ponto , L rttora ucce
repici . Ne può effer luogo d à confegnenù , r-tè
de g l i a g g iu n ti, perche non fegue di n ecefìità ,
che da poi il concetto , ò fiato , u aere , la voce , e
il fitono fi f in ta .che dapoi cofi fa tta f per d i r e f i )
com ettione , l'h m m o f i potrebbe form are . Per
laqual c e fi tl Petrarca con ale un. stu d io u i in te rpofie quelle particole ( 0 poi ) d im o fira n ti l’ordi
ne y non la nccefiitd. Et Q u i dio quella particola,
u b i , di me d fir n a importati fa.*. Pofi'iamo a d u n
que per g li effempi dati d w ee o fo u c c
Putta
che t albera le fig u re mentre una fila c impotente Y
f i gem inano a u f i ire u n fiolo concetto, che à io*
etitivn d'altra maniera non è cono f i o , E t in esser ro perla, fina tirata della. cagicn m ateriale, no#
'era del tutto meffo d a va n ti li concetto del cantar e/
e del fonare, m a acce-mpagnata.quella d e g li a g
g iu n ti f i g g e n t i, ci f a veder il jofipiro ,cf?e prece
' de tl canto , che fogne fi come prefinti [ f i m o ,,
V altra è,che ornatifot me fin o quelle fig u r e , che
da due ò da più mefcoletti luoghi in fu m e rutficnv,
nè p e r i i due m e focolai i lu o g h i di fip ra interni#
quello della cagion m ateriale, 0 quello degli a g
g iu n ti, che nei u n o non fin o m e/colati,a/flds i - n ifi. Et come ho detto , la divi/ione è chiara n d
[ effempi o del Petrarca m quelle p a r ti cole}
po i
0 nell'e/fornpi9 d i O si ^ in quella sisse mfessesi
0
A
4 * 1 L A T O P I C A D I M.
che pu r fign fic a ordine . Mae per cjnello de g i i
aggiun ti seguenti , s a della cagion formale a pet
ta Ha quelli a d ic iliu i, chiara, foane, angelica , e
d iv in a . ma d i qucfia , s a forfè più- a m a ti confidorando al fuo luog-o diremo . Mae e dae confiderare per la coprititon della cagion materiale f che
le materie non fidamente fi chiamano quelle , d i
che alcuna cofa fi fi,co m e le pietre , di-che fu fot.
Io il te a tr o , ma ancora quelle , intorno adequali,
o fopra le q u a li iterfa alcuna nofira operatione,
ìmperoche dalloperatioti del percoter è cagion ma
teriale il corpo,/òpra cui fifa la pere u f i ove. Ne'
f i conofcerelle operatio?? di per t a f ione , fe non
foffè corpo,(òpra cui f i fac effe, clic fòla cotal m a
teria fa fènftbilc la detta operatione, nè il pugno,
ouer il ferro con cui f i pere offe, è da eff'er chiama
io material cagione , ma ifir umento d ell anima , ^
che fi m cjj e rifar tal percuf?ionc,pcr m e fo di ta l
ifir umento . Et in queft a /ch i era di materia, sa
prae le quali ver fa /’operatione , po/fono cader ein- T,
cor lo materie m itili «ih ili , lequali henche v era
m ente non fia n c materie, pur fono come materie.
Appreffo è da Japcrc che d e g li effetti,ouer opera
tioni prodotte da animali , alcune refiano [enfih i
li dapoi che fono fa tte , come il theatro, lo ferine
r e , alcune non refiano , come il parlare,il tocca
re,il caminare, s a fim ili : p e ra oche non fono n i/'tirili , fe non ni quel /olo tempo che f i operano . >
Ver haqual cofa'iquelle che fi rimangono , hanno
per cagion materiale quella fopra laqual Operan
do fi aerfa : s a d i quefie che rimangono dapoi il
fatto, tu tte feri f a cccetrione hanno la cagion ma-
•y m
C I V L I O r. A ‘M I L L O ,
ieri aie fuori di noi ; perche altrimenti non n m tif
rcbbono fin fib ili, si come il T eatro , ifoual ha la
niat crìa. nelle p ietre . 'Ma d i quelle , che f o r
l'operatici!?, mancane di effer f in fi b i l i , alarne
hanno la cagion materiale ir» noi, come il parlare
o'I cantare, benché di fuori, p rirv amento la n ceua . Imperoche fe bene il fa to , che m aterial
cagion e del p a r la r e fin tia m o in n o i, pur d al
l'acre g h e di fuori e, lo riceviamo. 'Aleum l'han
no fim pre d i f u o r i. Come il caminare. Impèro che la v ia , o altra cofa ,fopra laqual fi camina, t
del tutto fu ori d i n o i. Alcune la pcjj'ono hauer
dentro,toso di fuori di noi, come il «edere, il tocca
re . Vereh e coso altrui rosonoi mede fim i pofìi amo ?
y u e d e r e ,y toccare. Si potrebbe am o nelle ope
rativi! che refianodopo il fa tte , trottar d i quelle
che haurebbono accompagnate materie , cioè non ]
folamcnte quella , di che alcuna cofk.fi: f a y md
quella y fib ra etti fi f a , come lo fcrìuere. \mpe*
Troche quella operation dello feriti ere lafeia il /un
effetto ndT inchiofìro , come in matèria di .che fu
f i t t o , coso lo lafcia nella c a r ta , come in m ateri
fipra cui fu fìn to . Facendo adunque hi fógno a l
la inuenticn delle fig u r e , che daff-i cagion mate
n a ie tirar vogliamo , ce nof a r prim a la detta ca
gione , io direi per regola generale, che di tutte
le operationi de' [enfi, fiano material cagioni quel
H , che altrim enti s i chiamano obietti de' f in fi ;
perche d'intorno li q u e lli, come d'intorno a mate
ria verfimo l'operai ioni de* Jenfit, V ari mente .di •
tutte quelle óperationi che dopo il fa tto non ref a - ,
no j direi ejfcr cagion materia lei quel corpo, f i -
4%
La t o p i c a
d i m.
I
f r a il qual (t fecero osi fanno, che nel vero effe f i \
m ofrano fenfihtU /opra effe corporali. E t Jopra
che altra materici uerfii quefia operation del cam inar, che s opra il luogo per i l q tta lé f i camina ? ?
cofi neWoperativn del notare, entrando l ’acre, come luogo o corpo , per ilqual f i vede fènfibdmente iter/.ir cotal operatione del ualare, d irei Ter»
(fi cr la ragion ma ter hit e, non Tali, non le penne. i
bnpcrochc Tal i s a p a n ie fono g it tfinim enti per
7iK \« d t quali fi vola-, non altrimenti, che ìi pie
d i, per U quali f i ramina s a il calamo,per ilqual
f i f ir tue, s a ihpianella , per cui f i fabrica . Mae
d t buon f i udiri o fa r à , nel figu rar delle m a terief
f a per cogl ter talhor fidam ente q (ielle parti che Pof
fono non meno unof i far u a g h efx a ., che la figu ra
della cofa . E t f i ben cetfiderian/o le cofi del Te
trarca-, trotteremo della i agion materiale di citte- *
fila operatictt det caminare, batter tolto fila m en ti I
le p a r ti, che fi mofhrano belle,tniperot he ueggendo i
il luogo,ottcr la terra ejjer la materia Jopra c u tf b f
cam m a, non nominò terra, ma herbe s a fiori ,p e r
m aggior v a g h e z z a , la dotte diffe.
G ta ti m ai io d'honefio foco ardente
M etter i p $ f i a Therbe s a le viole.
Dalla cagion efficiente truffe la uirth della fig a
va poeticamente, il Tetrarca netti fu d a ti off en.pt,
attribuendo quello, che e di- Laura , all'amore.
3ni pero che la nera cagion efficiente della u-oco è |
Vattimo dt colui,che la pronuncia. Erafidunquc
Tanima d i Laura camion efficiente del fuo canto, *
fi. corneali fjù ritt ouer il fiuto erano la materiale.
Ma perche e jf i, volendo dimofhar Laura tutte le j
co/è
l
GTVLIO CAMILLO.
ttffc p e r ar g r a tto fin te n te , fin g e ch'am ore, p ri
ma eh'ej]a incornineiafijè à cantare, inchinajf e g li
occhi di lei p er fa r c i veder che L a u r a con a le n a i
vergogna in c o m in c ia f ety m a vergogna che. molto,
ora,imeneo *ggikgnfj]é al fu o canto. Am or d u n
que j u quello che inchino g li occhi . A m ore con
le (ue m ani jciolfe g li (p iriti , cioè il fiato alle f u
prone p a r ti. remore fin a lm e n te g ii jciolfe in dol
ci fiu ta uoce. ]lquA. tim ore nondimeno fi» esse L a»
rapicna d‘Amore 0 d 'a g n i g ra tm . V c r ie q u a i
parole fi può comprènder f(fervi inficine f i luogo
de g li aggiunti precedenti, 0 de g l i A tti.ìm p e rio (i)vfiti necofsiili ncn e che prim a che uno canti,
u n iu m g li occhi d/ v erg o g n a . M a il prtrarcci
puijandu quello , che in L a n a s oleica proceder
prima che cani affo , iti accompagna per mettere e^ la qua (i d inaliti a g li occhi. Mae in quel Son.Spìr
10 felice , (he (i doli (m e n te , ire volto una dopo
l'altra fig u ro dall a nera ragion efficiente , che 1 1$
*f(trt!o anim ale , onero anim a . dicendo » «
Spirto felice che f i dolcemente ,
Volger quegli occhi più chiari che'l Sole >
E t form a tu i J o ff tri e le parole ,
X ine y che ancor m i fonai» nella m e n te ,
C ia ti v id i io d'Lonefìo fuoco ardente ,
Metter i piè f a l'herhe e le viole .
ìmpcrochc non filarne u t c d a llo (fin tò anim ale
11 volger d e g li occhi , ma il fo rm a r delle parole t
0 U ni011cr d e 'p ied i . Et Oiridio quello attribuì
Ala tromba poeti cameni e , ih e era d i T r ito n e ,
imperò che la tromba ncn ha ur ebbe fintatot f i la
ragion efficiente del f ie n o , non hauefje ciò epeC
ri
.
?o
LA T O P I C A D I Ms
' \
rato .. Et per h delti ej] e m p i fi può accogliere
,
non volendo dir altro concetto che. cani are , lo fi
g u ra da tutte le dette cagioni , egr v i confuma
quattro uxrji .
’
t
Dae gli ifr u m e n ti della cagion efficiente ferm o
bellifilm a figura altrove , quando volendo nefiir
il mede/imo concetto , cantar over parlare , drjfe.
O n d e le perle , s» d i et frange & a jfrrn a .
Dolci parole , b o n e/le, (oso pellegrine, coso quefio
concetto t lam entar Cofi us altro lu o g o . P E r l s
e roso u c rm ifiie ove l'accolto Dolor fir m a v a a r
dentino ci coso belle, imperoche > quantunque li
denti ch ia m a ti dal Petrarca perle , (oso le labbra , 1
Toso, soso appreffo la lìn g u a , di f i inguailo cosofa c
ciano efjcr tale coso tale la voce , nondim eno l'ani
m a nojìra per cotali ifin im e n ti , m » a ltrim en ti
opera tosoform a la voce , (he ji faccia il fabbro al- #
cvn (ho effetto per L'incudine i l martello, che fo
no ju o t infìrum enti . Oiule «e/ primo eJ)empio la
cagion efficiente diede f fecondo il. fitto Copione
ad A m ore, Fi nel fecondo ali accolto dolor , co
m e Poeta y offendo in ambedue ti luoghi ucramen
ee l'anim a o m ente , che t/ir vogliamo d i Laura :
(oso l'uno toso l'altro c m tfio della cagion fo r m a le ,^ .
roso sanse ancora della fin a le . -M a d 'ifru m e n to
del f i o no tifato nel f u dato ejfernpto d'O unhc
pone luogo , onde fig u ri quei concetto, fonare „
Percioche, quantunque dipinga cofi q u e fiifr u
m ento , C a V A buccina fu m i tu r illi. Tortilis i n
la tu m , qua turbine crefcit ab im o , nondimeno è /
partìcolar d e fin ito n e della tro m b a , roso niente fa
a nefiir quefio concetto, fin irn e. Apprtjfo è da
ctv
i
L ro c
a m
r
i
L o.
?t
fusai, lerar , che Gnidio -r"*' dipinger Tatto dei fo
n a r , imagiruindo quello cnc precedeva al fàune ,
trafifofigura dal luogo d e g l» aggiunti precedenti,
come fece ih Tetrarca nell’inchinar de g li-o cch i,
quando dijfe » C ava Lucerna fo m itu r d i i . Per
che volendo fo n a r, noti t di neccfolta prender .a
tromba prim a , che potrebbe efferporta alia bocca
da un'altro . puo Set* ciò ave ni r s a perauenturu
attiene fipeffe volte , mae non e neceffariooso , che
foia luogo da g li antecedenti-, F w ancora dal luogo
de g li fr u m e n ti della cagion efficiente quella fi
Tura d'OuidtVji bc uolenno air la terra pro.dur da
se , diffe . Kaforoj; in ta f la nec nlits , S au na hom n tb u s. Et è in alcun modo ntejcoiaio il ì uog*
de’ centrari j .
Dalla cagion formale pretteancov mode d i ue*
*> f i ir il m edefm o concetto , cantare , /*« q u a l q u a n
tunque non fiafem piici' ,m a nv.fia con la m ateria
le >s a forfè am ara con U fin.de , pur chiaram en""te fi può veder Lt fu a fig u ra in quelli adiettiui f
chiara fid a n e , a n g elica , d ivin a . L t ne g li a l- ‘
tri efifonip i a r d e n t i uoci s a helse . E t , Docci
parole benefiche pellegrine » p ero che f i come di
ciamo U cagion m aterial d i u n u-afo d'argento oso
for Taro ente , s a la form ale quella firma, che ha
di uaf 'o, non di sta tu a , perche fitto à mille fo r
me può f ig g i acer U m ateria deli'argento -, Cofi la
cagion med ertale delie parolee o de! canto è
to ,h i efficiente c Lt m e n te , g ii
amenti , la lift?
gaia, li denti, le labbra ; la form ate e quella fo rm a
che la ucce , o il f a t o ha prejo di- parole a lte , c
buffe , o dt canto , c di g r id o «. Che tu tte q ite jh
1%
l A T O P I C A D T M.
sono form e chi f a t o , o della uoce che d ir v o g lia *
tn o ja q u a l non e fim p re fo lto la fo rm a del canto,
nè fem jtre fitto la fo rm a di parole buffe , o di g r i
di . Adunque dando allo fifo lto sed o d i L aura
fo r m a eh uoce chiara y fia u e angelica t d iu r n a ,
non f i quanto p iù g e n til fo rm a dar le po teva , ne
come m eglio fa rla a *lettori fe n fìb ili. Cofi O indio
nei f u dato efj'empio della ;tromba accompagnò il
luogo della cagion f ormale , dicci: i . Lìttorà ho
ce replet-, fu b 'vtroj; iacentia Vhecbo . Che delle
predette form e della noce , da a q u efia- della troni
ha di Tritone , la g ra n d i fiim a , amplificata non
altrim enti dal circuito del mondo , di quello che
V irg ilio amplifica la g r a n d é z z a del Ciclopc dal
la capacita della fi) cionca , quando d iffe; i acuiti;
per a ntrum im m en fu m . K t tu tta qu ella a m p lific a !io n e è pofia nel luogo de* configuenti , ìm p e
rb che f i la noce della trom ba empie li liti d i tu tto
si mondo , consegue eh neccfiitaghe j"offe g ra n d ifi
fir n a . FI fc il Liclopo f i di fì efe per la grandi fii~*y
m a fa elenca , dando iu rta a quella particola, pery
d i lignificar tu tte le p a rti delia f g clone a , c o n fi
g g e di necefiitdyCÌ) eff of o f f e ancora g ra n d i fiim o ,
M a dclli configuenti al fu o luogo diremo .
Dalla cagion fin a le truffe parim ente m efiolata
fig u r a il Petrarca intorno al predetto concetto ,
cantare , nell'ej]empio dato d i fopra . Imperoche
m ia d i due potendo effer la cagion fin a le del canto
c t o t , ouer la dilettai io n e . onero il rapirci al defideric della celefie armonia ,d i cu i quefia del moti
*
do è picciola im agi ne,dal? una (oso dall'altra occul
j
tAm ente fiece fig u r a g li ef e ben confidcrìam* quel
* C i v i l e CAMILLO.
fZ
le parole , chiara , f'oaue y toccano la dilettiliien
che dalia uoce prendeva . Et in quell a ltre , • ca
role , angelica . d iv in a , dimostrano aeeiai
r/i
'Lanra osoe? r h ita im a g i ne non filamenti? della ce
le/le, ma di quella onde la cd e f i e d e r iv a , alla
qual ceicfie harm onia , conviene in fin e del Son.
quel nome , d ie elette Sirena , im itando Viatorie ,
il q u a l quefio nome d i Sirena attribuìfcc a quel
((incetto , che da volger ciafiuno o d o procede.
Et fi gin fica cantar tt D io , over laudar D io . Es
quefia battendo nel quarto u n f i cofi strettam ente
involta , li piacque nel fecondo quadernario di c»
Sento f a r del m io cor dolce rapina ,
hechefia m ifiò del lungo della cagione & effet
t i che un d o k tfiim c canto , q ua fi d i necefìitn . H
** cagione di ta l rapina, ma p i» pure è quello .• D a
qual angelo m uffe 0 da q u a l fpera . Q u e l celef i 3
cantar. Et quella che ha ilfin e la diU ita tio n .fi
la , gentilm ente fig u ro altrove , la doue , p o i che
alla ucce di Laura a ttrib u ì quefio nome d i aura
(Affi , L aqual era pofi ente, Cantando d'acquetar
gis sdegni 0 l*i r e , D>fe r m a r la ttmpeflofit m en
te . Dotte jo rfe è la predetta m i fi ione del luogo „
delle cagioni 0 effetti * Riabbiamo adunque n e ditto , come il Petrarca mefcola li luoghi , 0
feguentem ente le fig u r e . Ma G nidio nel fonar lei
tromba dì- Tritone,più d iv i fo m e n ti p o fi la cagicn
finale , f i che fa di uerfo concetto d a l fonare , d i
cendo co fi. E t iufjos cecinit in fia la recejfius>
F.t ni vero quelle u efìi d à concetti faranno artifi
cio/, im ente fig u ra te } dette p m luoghi m ifU fa r to
€
fa
<T4
L A T O P I C A D I M.
*
tiranno le fue b ellezze , f i che qua fi Tord ito ri del
la uejìt ucnga da un luogo, coso l° Slame da u ri
altro ,
non dimeno di to lti quefit f i fàccia una
fola tela . llche ne g li argomenti ha Tanta fo r \a ,
che fa fbeffo vacillar Tanverfirio , f i come quello
che t onero per I'implicatione de lu o g h i, non s a
pendo a quell’argomento rifponaer , rejìa confa/o,
curro f i pur rifa onde ad uno , non ha però fcioltQ
il tutto per rimaner il uigor dell'altro . •
•
V a g li effetti-fifigurerà locutione, quando fu*
fa la indù f in a ja ra pofìa in quella cojAtche t pro
dotta dalla cagione . Et per g ra tia d'effimpio 1t m
gact da d ire, esser prim avera, noi ne! vero uctin
do operar alcuna figu ra del luogo da g li effetti ,
potremo alla cagione che produce ? herbe coso h fio
r i, f a r f ig u r i quelli. Volendo adunque ufiur luogo
da g li■effetti, f i Infogno che tutto t artificio appo *
ia n e g li effetti ,fe non ci pìacefje m éfcolaril luo
g o delle cagioni con quello d e g li effetti. Come f i ?
ce il Petr. nel Sonetto. Quando'! pianeta che*
difiingue l'hore, doue diffi: che la uritiì, che cade
dell'infiammate corna del Tauro , tiefie il mondo
di nouel colore , Coso le r u te , (oso i colli di fioretti
adorna . Alle quali trattate mente, cedono quelle,
come proprie ,a n \i forfè p i» gentilm ente pingono ,
la doue attribuendo la uìrtit del Sole à gli occhi di
A.aura dr/fe,che facea fiorir co'begji occhi le carri
pagn e.N e f i può dare puro luogo dalle cagioniym
d e g li eff etti , perche l'uno fi conofct per l'altro *
Ben f i potrà chiam ar v dalle cagioni ,o d a g li effet
ti , d o u e più basterà me fio Tautor d eli'anifimo ,
I lp e r chela dotte dice . E x f i corm d t lor belleg-
coso
f
^ C IV LT O C AMI L LO , rf
il cielo Spi tific a quel d ì , parendoci a noi Per
tal parole; quafi valerlo fjùendvre p iù che la ca
rie» di quello , diremo efjerd a g l i effetti , cefi
quello . ìfc ie l d ì vaghe , s a lucide jà w fìe , S'ac
cende intorno e'n m fla f i rallegra , D %
ejjer fa tto f i
rea da f i begli o cch i. .Per loaual ef]empio ancoraf i può conofier meglio quello che /òpra d n eu a m o , cioè u n concetto figuratopoter h a m r a d un
ir atto p iù c iu m verbo , s a una coffru tti gite f u o r i
della regola deli altre lo c u tio n iP e r c i oche in tui
t ili predetti uerfi non intende il Petrarca ve f i f i
più dt quefio concetto . C ti occhi illum inar tu t
to ti mondo per la v irtù attribuita ter dal Sole .
L t in alèrv luogo fri a m e n to di■m e fia fila co fin k
tien e ,
• Et d
E occh ifito i f i l t a n far giorno .
-*
L i luoghi de g li antecedenti s a co n fig g en ti
Comien che fiant- fo n d a ti f u la necefiita non altri
finenti che le cagione & g li effetti. Et perche h a n - .
no gran fem bianZa , non fo llm e n te con le cagioni
s a e ffe tti, ma con g A a ggina; ' , unì cofa fiita d i
aprir uia alla dtf l i n t iva <ù .q u e lli. D ebbiam o
adunque f i p t r , che q u alunque volta alcuna na
tura è pofia im m ediatam ente alia pred a ti te n d i
alcuna cofa, quella f i p uò chiam ar cagion e ffe ien
te . FJ quello che na fee dallo eff etto , f i come il
Sole levato t cagione ne cefi aria del giorno . t l g i o ?
ho è ne c efiarfi fie n o del Sol levato.. Ma f i ben
alcuna cofa precede/fi di necefiilà ad un'altra per
natura , oper tempo , f i r i f a operar produzione »
la cofa precedente n on f i può chiam ar cagione di
a m ila , ma più, lofio antecedente. £ t guelfa , che
C* »
»
(4
fri
LA r c r i c A D I M.
^
ne fogne al detto antecedente , ha m eritato nome
eh confoguente , E ' i l vero , che queJU luoghi eh
antecedenti
confo'guenti,hanno fi difoefo i Im
perio , mentre fono adoperati g li Er fo m e n ti ,
che pojjono anchor effer cagione
ososi^i non
che altri ìm g h i fa r diuem ar da g li antecedenti
configli u n ti. Et ciò au vien e perche acquifr a
no il nome hor dalla natura delle cofe , che nella
loro forma neram etice antecedenti y
ccxfognen
ti fono , hor dalia p u ra fo rm a dell argomentare ,
p o f h t u t t a i n c o n d i t i o n e . l ì p e r c h e cofi f a t t i I v o
0
0
7
0
0
■v
f i n d i a n te c e d e n ti 0
e o n f e g u e n t i , fe c o n d o l a f o t
m a d e l l ’a r g o m e n t a r e , J o n o
t o n d i (to n a le .
:
fompre
f o n d a ti n e lla
co m e , fe e g li e h u o m o ; è a n im a le .
S e C h iijìta n o è
,
e g l i è le v a i o d a l j a e r o f o n ì e
,
la
q u a l f o r m a h a fio r fio, d i f a r i n q u a n t o f o r m a d i ,
u u n ir le c a g i o n i , 0
/u g n a r ti, 0
g l i e f f e tti a n te c e d e n ti, 0
f a n é tl S ol U n a to , 0
con
r
i l g io r n o in
( f i e n i p t o ; d ic o , c h e q u a n t u n q u e t l S o ! I e r n i a f a '
c a g i o n e f f i c i e n t e d e l g i o r n o , e 'l g i o r n o n e r o
fo
d e l S o l te tta to > n o n d im e n o
f o r m a c o n d i t j o r n ile
, se
l o i lo c a t i i n
'e u n to t i l
S o le
o so r* -*
q u e fia
, e g io r n o ,
I l S o l c h e è c a g i o n d i v e n t a a n t e c e d e n t e , e'I g i o r n o
(h e è e ffe tto d iv e n ta c o r ife ? v e n ie
E t tu tta q u e
.
f i a f o r m a d i a r g o m e n t o co fi , f e l e v a t o è i l S o le f i
g i o r n o , a p p r e jjo D i a l e t t i c i , 0
R
et b o r i c i f a r e b b e
d e t t a e f f e r d a I l u o g o d e ’ conseguenti, p e r c h e i l c o n
f e g u e n t e f i c o n c lu d e , 0
d a lla c o n d u fic n e f i p r e n
d e i l n o m e , fi c o m e a n c o ra q u e fio
r ito , h a g ia c iu to co n h u o m o
.
.
Se h a p a r to - ^
Che q u a n t u n q u e
p e r c a g i o n d i t e m p o , l'b a t t e r g i a c i u t o c o n
tta
m n a r ifiì a ll'b a tte r p a r to r ito
*,
Interno
n o n d im e n o d i
venta
G IV L IO
CAMILLO,
roso
ucn\a configuenie , non perche U ragion del t n n
pò ciò dimandi y m a la forma deli'argomentar*
per quella particola condii tonale, che f e lo rd in e f i
m lg e jft n ^ n c (irebbe la necefiita , soso inftem e il
poter argomentar per condit tonale . Il perche
n e g li argom enti non f i feru ti ? ordine fim p r e n i
della natura , m del tem po, fi che le cofi: che fo n *
prim e , fum o nel primo luogo, coso le foglienti d o
po i , a n \i le turbano j beffo . • Ma poi che q u i/li
luoghi hanno acqm fiate ti nome di ante cenemi
configuenti non fila m e n to Per riguardo dilla f i r
coso
m a del?argomentare , m a ancora per ri*i*anlv
della natura delle coffe , che nella fir m a dell*argo
mentare entrano y noi la fediremo alla fiie id fi
? argomentare cefi fa tto nome y aflhor che riguar
da la fo rm a d eliargomentare. Et p ig lia r emo Jop ia m e n te quello, in q u a n to riguarda la na tu ra del
ie cofi , che neramente procedono y fig u o ito .
Saranno adunque per cagion tutte quclu nature
*che im m ediatam ente producono alcuniej]
; coso
per cf]etti le cofi im m ediatam ente prodotte y *
tutte l'altre che in altro modo procedono per
recedenti y (oso che fig u o n o per configuenti » E t
a cricche meglio dim enda aeriam o a g l i efJempU
Proponiamoci d i fig u ra r quefio- concetto fi or fi not
te , dico che, f i uogliatno fig u r a r dal Luogo della
cagione efficiente , potremo dire , l'ombra della
terra far negro i l nofiro Cielo . Retici) efio . m i fio.
con i'ejfeito . M a fe più» ri piacer li de g li. antece
denti, pendendo che alici venuta, della notte proce
de y che la regio# "m entale,per effere più lontane?
0
d a l Sole, carnuta#, il fix io r arfi ^potrem o cofi ffi-i**
C
-r\
I
LA T O P I C A DI M.
come il Petrarca . E imbrunir le contfade
d%
Oriente . Il qual imbrunir m vero r quantun
que.
preceda la notte J, non e tper tutto ciò 9
, cagion
J
i
r/tr
e1*
e fflu e n te della n otte Tm a f i l o l'om bra della te rr a .
G ia c q u e ancor a l. Petrarca f a r d e l m edrfim o lu o
g o ile g li an teceden ti qu efia f i g u r a .
Q u a liìo r
fain u la , Per p a rtir fi d a n o i [e te rn a lu ce . I m p e roche,penur che la venuta della notte d i n cce fù ta
*
precede d partir del Sole , ne p erò i l p a r tir d e i
)
Sole f a la n o tte .
Se ben la fua p a r te n z a e in ca
g io n e , che l'om bra de Ila terra (opra fi volga , 0
f i p u r è cagione y non e cagione ne im m e d ia ta , ne
producen te . Et f i come tl nocchier lontanato d a l-
j
la n a u e non è f a to ra g io n effsciente della fo m m er
f o n delia nane im m ed ia ta m en te r m a li u c n tt,
0 l'oruiu ybenché fifoffe Sfato prefinte , non f i
farebbe per aucntura fimrnerjà ; Cofi i l partir del
Sole non è immediata cagione diprodur la notte „
Rene he fe m ai dall*itemij berrò ttoflro non f i par! t f i
f i y m ai notte non et coprirebbe . A l m e d efm o *
■concetto diede fig u r a dai luogo de g li anteceden
ti , quando diffc , il Sol tafciarfi Spagna dietro
alle fine [palle > E Granata , e Marocco , e le cola»
n e , che necefjarsament e al venir delia rtotte, p re
cede che i! Sol Infera dopo fe li p red e tti luoghi-. il
mede fimo concetto figuri# da c o n fig g e n ti, quando
d ifje . M A poi chel ciel accenti e le fu e U tile. Et*
p o i quando to veggio fia m m e g g ia rle Tl elle, per
che 0 partito il Sole CX venuta U n o tte, d in e ce/stta fo g n e che le Siede fi pofiono m o fira re . Mae
}
quel lungo d i V irg ilio y Ij-iffefiere omnes m edi) y
J fu ti tt m<j; dedere, fo r fè i dock cagioni 0 cfj <t:i a
C I V I IO C A MI LL O.
T5*
perche coloro à Audio f t partirono per far (haifa .
Che se baite fiere [aito partenza, ferina t,vem'icne
tU Ufiiar ti luogoJ patiofv , farebbe dfa configge?}
ti , perchefigue di necefiità y che alla partenza di
molti- il luogo da loro prima occupatofi s i moflrifb utiofo . Neper tutto ciò la partenza, di ancia ha
prodotto y come cagion efficiente anello f i a t fa ,
pere/!or mancata cotal a tieni ione.. Mae il Sofa.
quando fi parte da noi y non ha qne.fia intentio?!
di partirfi perfar. notte , ma per volger per la firn
rotonda sa infinita Arrida , benché il Petrarca »
come Poeta . effe in quel luogo , Come ri Sol noi
ge rinfiam m ate rote , per dar luogo alla notte *
Que/lae Virg ilia n a anco ra. V ef i aura, a th irea.
Volendo dir unterò , e fo rm a ta da configliente „
perche consegue necejfariam ente t che f i alcuno
utue y fipajca d'acre y ne però l'aere è cagion chi
*** egli fia unto . Et in n u tfla dei Petrarca in fila r in
terra la f i o g l i a , che altrove d tjfi y abbandonar il
* corpo in terra , u d en d o d ir , .m orire. E dal m edefimo luogo necejfarioy m a altrove per contrario,
volendo d ir na fette fo r m ò fig u ra d a g li ,v • «Itn
ti c o fi.
A pie de colli\ ove la bella nef ia ,
Prese de le te. r ?.j m embra pria; »
Perche al nafcerài necefiita precede l'baver
prefi) corpo. M a lfa configgenti ma r nviglio fa
me»t et n due modi fig u rò il medefimo concetti) d i
mifiere , la deve dtjjc .
Che g iù discesa a provar c a ld o e g ie fa * s
E del mortiti fentiron g li occhi f i o i ,
S.t m ti n o .quejh ani eced w ti s a t co n se g u a li I
er>' ' t A
* T O P I C A DJ - Mv '■
tufferò- la f in v a di argornentarm-per
' éricbmUàtnHilvypùtYcbhmo m a u tenerfi necefictrix
m en ti n e i firn natu rai ord/ne *• Et anco uofierlo,
cvm è-fife? ombra della terra i k noi uolta r è not-.
ti'
ferto n tra ritn \ f e notte è y . l'ombra della
te rr a è rim ira- <i>neù^fEt f i nato è. r fin te caldo e
g ititi
fifè fin te v d l d o y greto-c nato : B cucire
tn alcuno m n fi w w ie rtk e b h e w Come, fe nato e,
ha pre o il corpo . o’MAsa proso h a il corpo , non f i
potrebbe argomentando.d i re che, di molto prim a
f i prende il corpo >dosowdto-.che s i riafce. El ianto
d e g li antecedenti y configgenti detto f ia . . -.
« G li aggiun ti cofi detii'dii Cicerone.^ perche f i
aggiungono'aktt né qunlitk- aue-.cofi #ym n come
ueceffàriamentc \ o jc m p rc ,a m m o n ti ,\m#,fpef]e
■'mite . Non fono aduna n e g l i a g g litn ti da. alcuna
, iteceftita g o v ern a ti<, ma da riguardo d ittin o di
tre capi t il perche f i come il tempo è tripartito , *"
cofi g li aggiunti tripdrtiù fiom H m per oche.p.one
ro poffòno preceder per temp&ad akun<txof#%r co- w
m e l ’amore à g li abbracci am enti.y onero, poffom
effer con effh coffa ad tm tempo , • come lo Strepito
d e 'p ie d i col cam inare, oner poffom fig u ire ^ o m c
la p a llid e zza ad a icm o errar commeffo y N èy c n 7
fa ragione hahbiamo prefi h dire r che po/fono
preceder A che po/fon effer con la coffa ^ coso - che ' la
poffono f ig u ir e , non che precedano , non che f ia ' vto con offa coffa; non che non la fognano., perche
' m n fin o ne ceffitnj come g ii antecedenti y confirgu en ti * Mae fono ben pofsibili che fio effe, ito Ite •
4 anuengono perche JeiiXa h'iuer amato f i p n ò a b U ro.citare y y colui che non ha, abbracciato p m
; G l VLE O C A M ' ì n O ;
tfrarmtre, 0 c amittar f i peri fc n \a fa r strepito* "Et
fafar strepito f i può fi:n \a caminare *•. Vj Impatti*
dirfipuofenzci batter commcjfoserrore y
.commet t er amor fi p trioj'enza. im paliidire, Utuali Ivo -*
ghi n e g li argomenti tanto wagijo.no ad a iu ta r le
cori ettur e , che Gaio A q u ilio dotti fim o G iu re-
0
Confitto tu tti q u e lli, che à lu i-n elle c o n g ie ttu rd i
canfi per Jòccorfo rieri nano , à C terrene y „cert:e
più ingegno fio ,
p iu éfjterlo d i In i fafolm m .tn " dare : D t quanto adunque g li aggiunti-,fimo.pii»
deboli’ de g l i antecedènti
je e n fin te n tita n ti?
m aggior arie chieggono rila lor divieni ione per'
fa rli probabili, i- Imperò che le cofe fie q u r it m a n i
f e flati: ente,
d i nocefitta Arila natura precedono
fin o m effe à tu tti in rnegod-. Ma quelle che n o n
je m p re , m a tàlhorapof]òtto<o p r e c e d e r o e!fer coli?
U cofi. , o quelle fig li ire , conviene ohe fila lo dall*ingegno penfate . Per la q u a l cofa no:i m enu
nelle figurate locutioni, che ne g l i argom enti 7 d i
ffe r ì le m aggior ingegno ,
iitvetrtione negi, a g
g i u n t i , che n e g li antecedenti
configis enti,£ ?
ntrilc cagioni
esse/fi ,• £ ' adunque tratta d a g li
•aggiunti qnefh ifig u ra ; bagnar con g ì occhi l'Iter*
l à , eyl p e tto , c l'u n o -,0 l 'a l t r o m l m d o d ir p i a 'gnere. Viro;, nell'undecime .. . . .
Spargitur 0 tellus lachgm ìs. , ffiargttniur 0 ’
arma -,
M a da’ configgenti q u e fia , bagnar gfioc eh sa et
bau er g i i occhi bum id i , o mollisporche d i necefri
ta piangendo , f i hanno g li occhi b a g n a ti,m a .m rt
rii- n tee f i n a fi bagna piangendo i'hetbd, c i petto-T
0
r0
0
0
0
0
-E l m n d i& tw -ito n e d ifficile, ■àa.'trmfcet- q u a n to
41 L A T O P TC A D I M,
p iù dipinga quefìa d a g li aggiunti,che q u e l& d i
con figgen ti. M.i per dar effempio in tutte tre lt
m aniere ,fta quefio de g li a g g iu n ti precedenti ,
«itre di quello d i fopra addotto » Et pallida mor
te futura . FA quanto è fu o r della firnilitudini
quello del Petr. c’ha f r i t t o m a r in i, che à parlar
com in ci. N e g l i occhi s a nella f onte le parol e .
Yfiernpio d e g li aggiunti accompagnati, Vanterq;
«culai , tclumq; teterniti . lìt appreffo il Pe
trarca .
E la conta a Vorecchia Lauta g i à te fa . Perche
f i potrebbe tirar Turco f e u \q aggirarft in coft fa t
ta maniera , nondimeno e luogo m/fio con quel
lo de g li a t t i , Ma quello di V irg . è firpplice ag
giu n to accompagnato , Mih ifitg id u s horror,m tm
bra q u a ti t, C eliduaj; toitfornndtne fan guis . Et
quello . F. T trepida matres preffert ad ubera
0 itos » Che necejjario non e fetnpre trem ar men
tre f i ha paura , nè fempre è nece/Jario alle donne,
tneutre temono , premer al petto U fig liu o li. Che
se Turni s a l ’altro fo ffe m ctff ario y ri primo far,eb
be d a l luogo delle cagioni s a effetti , il fecondo
ile’ coufeguenti . Effempio d e g li a g g iu n ti (eguen
t i è , che m ietuto d ir V irg. poterfi n eg li olmi in
fe r ir la quercia diffe. Glande i n f fie s fregere
fu b k lm is , perche potrebbe esser infera à la quer
e la mlTohno , Lt doue porci entrar non potèf i ero »
m a quella è da confiq v en ti. Ornmq; incanuit
albo fio re p t r i . Perche fe inferito è il pero neWor
mo , s a che habbta à produrre , d i necefitta amm éne ,che Tomo i m biancbifca d e g h a ltru i fr u tti
D a liix o tu ra rd [igoto ancora gentilmente f a r -
G l V LIO C àM ILLO.
43
m ar figura , benché molte locutioni , flte figure
non fono , f i form ino , quali fono quelle ± non me
L ttct. «olendo d i r y m'è noto , Ef »
-se' }' ■
Ncc acjjjuc crudelibus occubat u m b ris. Ve..
tendo dir non ejjer morto » Ma S f ig u r a te locu
tioni l/abbiam o detto effer solamente quelle, che
figu ran o, s a rapprefinlano talmente la cofa t che
et para vederla dam anti. Ev dunque g en tili f i im a
figura prefa dal luogo de* contrari quella d e l Pe/,
che venutogli da dir quefio concetto y Laura p a rttrfi da l u i , d iffe. •*-' ■
Deh perche tacque r s a allargo la mano . Im
p eri che d t fopra banca d e tto . parergli che Vpen
sarg li baueff 'e mojìro effer flato prefo per mano
da L au ra cofi \ ?er man m i prefe y e diffe pn que
jla fje ra » Ut che f i ben f i confiderà, com esi ta ^ ier t contrario d el d ire r cofi a lla rg a rla mano è
centrano dett'ha-uer prefi per m ano . Ma tan to
piùfig u ra allargar ta mano , cljc tacere , quanto
p iù si par ueder la cofa d in a n zi . Ma Tthul/o noi*
volendo uefiir concettosi p a rten za corporale , m a
della parteiiZa di uita quando diffe *
Et teneam rnoftens-defictente m an» y non potè
ufar li contrari] cofim anifefir . Imperoche tener r
& deficere non- fono u tr i contrari] , ma tenere s a relinquere, che à dire partenza corporale haurebBono battuto lu o g o . \lperche volendo d ir mori
re in prefin \ctd i D e lia , che e preferita d i v ita , .
mefio inluogo Jirtlenquere , deficere , fondando t
in un luogo > c to i n e l luogo de* configuentifim pz rothe al morir di necefina , ponfiguegtonfoLtmem
tc il mancar detta d e h ilita u mano x m a d i tu tti
*4
T O PICA
g‘ l i altri mem bri ..E t cofi con doppia fig u ra R f a
tieder uno che muore in cofi fa tto atto fotti. fori è
libero perciò dal luogo de g l i a t t i . Si jpuo beti
talhor tacer uno de' contrari , s a talbqjr noripuò
tacerlo y m afupponerh tn nafeofa dottrina^ q u a -
•(_.se._se se
h $ quello fo k '
oso*
V irtù ch'intorno i fio r apri e rinoue$
D a le tenere piante fu e pa r ch'cfia *
Ch'altroue è cofi detto ...
_se.se
' se se
JU'herbeUe verdi e i fio r d i coke, mille f i
fi
Sparfi fitto q u e lf elee antiqua e negra f
f
, Prega» p u r e fo ffo lp i* g l* p ro n ta e ttftjtf;*
\lq u a l coysetto^fhe ì d i camino? p t r f i t y t y
b grbe, in lode file' piedi in ditte ifi luos/sa dmfofatnent* è uejìtto . Ma nel p iù con fig u ra tra tta dàt.
luogo d t contrari; de* quali l'uno ha fidam ente ta
M uto ma nella dojtrttta nafeofo. Imperochc Colo*- ^
nulla comanda che le tenere herbe ftan qfihU ate
dell'Immane piante , si come quelle ^ Icquqli-pìu
«he d'altro anim ale h fònonem ichò fo u fo etra n a ^
adunque up lfi d a l contrario lodar te, p ia n te di
B a u ? * , accioche in tutte le p a rti del corpo moftra fle , che effaau an\a{Je la forte humana . Ma
pfa nero c o tti contrario non è manif i fio , f i per
effer taciuto , come per ejfer d i ripofia dottrina .
Ef?fintile qutllo ycbe volendo-dn Veffer morta. x
dijjtparlando della rhorte *
1\t*bar novellamente in ogni urna r
r Entrò f i le i che riera data in forte *
se
E t l i contrari fono uitiTy e m o r te .. Ma lette d i
nom inar v i t a , s a fila m en te dim eflra effet entra
ófK.cuAdim orar f i o / U u jta x ò o lp f ik - u tn e . Ir»-
«•
G I V L ! O CA M I L L O .
però che nel [angue , cJ)e è tulle vene, fecondo a l
euti* ElioJofi, e porta la ni Li . lit coso laesaù tutfio f i quefio contrario tu Ila d o ttrin a . Maeso altra
bellezza im e f o la t a con le dette figure netti d a ti
effem pt, non è al prefinte luogo di moflrarc.Ren. che fe ben f i g u a rd a in quello: Et allargò la mane
t luogo mifio con quello d e g li atti , 0 g i à babbi a
tuo detto quelle figure effer d iv in e tuon altram en
te che g li argomenti fo rti f i n i i , L a doue p iù lue
gin infiem eft te/Jono.Ma hor parliam o de' luogh i
[empiici folam en te, liquati f i ben faranno conof i u t i , fa c d cofa farla da cortofeer g li m ifii. Sona
ben alcuni altri co n tra ri, liquali g i à col Greco
vocabolo f in chiam ati antitbett nella parte de g l i
ornam enti. C o m e ,
Pace non truouo , e non ho da fa r guerra. M *
* * di quefii non parliamo alprefinte , f i non di.quel
luogo detto da contrari .o n d e ancora li fo rti or*
• menti f i traggono .
'
*
D a g li a tti d i qualunque animale f i figliòrto
talmente fig u ra r le locution i, che efii a m m a li
auàfi al coffetto ci f i moftrano . E/ in uero come
riabbiamo detto, benché quefìi luoghi,che hor ad
aprir incominciamo, non filano topici,come q u el*
li f i fip r a , onde an co ra g li argomenti f i muouo*
no , nondimeno fin o luoghi d i tal m aniera , che
talborpiù uifibili da loro efeono le figu re,ch e dal
li T o p ic i. l/che non fa r à drfficil da conofiere, f i
confideraremo , che à V irg ilio effendo venuto dà
d ir quefio concetto, non effer lunghi firp i in Ita
lia ,fi diede a figurarlo da g li atti,cioe dalli cor~
perai m ovim enti f che f a il firp e Amperochc mo~
€6
L A T O P I C A D I M.
%
mtnd.fi , fi lungo f i fife , farebbe grandi li g i r i .
d i fi e adunque . Neq, tanto Squammeus iu fpirarn traéìu (c colhgrt a n g u is. Et non fila m en ti
d a g li a ttt nat urobliente perpetui, ma dalli tem pova/if i poj]m o ueder qua/ì unte figure t qual t
j;
quefia di Virgilio nelfe rm a r fi a cavallo col tirar
della b rig lia , adducili amens fubfifht habenis.
E t quello di volger li c a v a lli. 5ed fla ter habenis
f l e t i it equos. Et quello del Petrarca Q ual N infa
on fon ti, in felue m ai qual D e a , Chiome d'oro f i
fin o alTaura fc io lfi, che uolendo uefìir blamente
quefio concetto, Laura hauer p iù belli capelli d o g i i altra , muffe la figu ra dal luogo d e g li a ttic h e
figh ono fa r le donnet quando più va g h i mofrem o
b lo r capelli, coso altrove dal contrario atto figurò
i l medefimo concetto . N i d ’or .capelli in bionda
treccia attorfe , Si bella. Ete da confiderar in %*
quefio non altrimenti che in tu tti g li altri luoghi
f i topici come q u e fli, che fig u ra tiv i chiam iam o, r
che taihor le f ig u re tf i come avvien e ancor alle
locutioni d*altra maniera , uefiono lontano concet
to d a l fuono delle parole : taihor quel medefimo
che f i coglie dalle parole : le due figure del P etrar
c a g ià date fono in effimpio : p e n n e la intention
del Petrarca non era d i voler uefiir quefio puro
concetto, Laura fiioglìer U capelli a l’aura t a a t
torcerli in bionda treccia , f i che il concetto fu o
fossa dentro di ta l parole : Mae che L. hauea belli
c apelli. La bclleZfrt de’ quali non li p a rta poter
con maggior uagheTf^a mofirare, che per virtù d i
quefio luogo d e g li a t t i . V efie ben il concetto fe
conda il fu on delle parole quello . Eratto i capei
a
GIVLIO CAMILLO.
67
eTuro A Vaura J p a rfi. Ch'ut mille dolci nodi g li
avvolge a y perche non trotto c'babbi* concetto fu o
rt d i quello che è legato nel fu un deste parole
tali fono^gli effempt d i V irg ilio a d d o tti. Ma
qual'Apelle,qual P olicieto potrebbe pennelleggiar
f i uifibilc Vandar et un vecchio., come fece il Prtrarca , Mouefi il vecchiarei ì non ci pa r v e d e r
thè egli fin d i immobile fa tto \mobileper fig u ri il
-si '
* Indi trahendo poi l'antico fianco,
v C h i notilo vede tale leggendo quefio uerfò 9
che non li p a ia veder lu i rtirarfi le ancheJlanche
dalla vecchiezza una'per volta ? E tà qual lettori
non par vede te a m in a r la uecch ia, quando'legge
que' ver fi ?
.si „est si *'•v ■«
Vergendo f i in lontan paefi fola
*
*+ . L a fianca Vecchiarellapellegrina:. «
Raddoppia i p a f ii, e p i ù , e p iù s a ffretta.
•
O levar quelpafior la f e r a , che tutto'l dì era
fia to diftefo ? qvando legge q uelli.
Dn'osoaense in p ie d i , e con l'ufitta v e r g a .
E t q v a l lettor c f i cieco , effe Uggendo que'ver
f i d i V irg ilio , non u eggia g li a tti, non f i n t a i
colpi de'fabbri ? si
- si
.
IIli inter fe f i m ulta in brachia tollunt In nu
merum) uerfiintj; tenaci fòrcipe m a ffa m . C olui
adunque che b a g li occhi e r g i* orecchi ne' predei
ti «ersi, potrà prometterli d i poter operar d i cofi
fatte belleZz* y quando f i m etterà filo ad i m ita r
la g ra n maeflra natura nette cagioni, n eg li effet
ti , n e g li antecedenti . Et cofi in ciafiu nde g li
altri luogh i , l i q u a li
non co itim a g g fir firm jr d i
%e t
L A T O P I C A D I M.
%
defui eri o , che con virtù di ingegno ci habbiamo
peram niura d a ti a d a p rire. N e ben fo quanto
ciu fio atte beate anime di quegli antichi , fe di U
f u ci veggono , che noi fiam o s ia ti t o fffd ifa r u t
dere li fa n ti lor fecreti , che prim a netta p iù ripo -Jìap a rte d i quefìt luoghi fi Piavano rin ch iu fi.
s Dalla qu a lita del corpo f i tirano molte mantfe
Jìe figu re , quatte quella d i V irg ilio .
V irgin ei uolucrum uultvs ,fa ed i f i im a u entris
P roiuutesy u n ca f m a n u s, s a pallida femper
O ra f a m e . Hi q u e lla .
Squallentem b a rb a m , s a concretos fa n g vin e
crin es.
Cofi dalla q u a lità , benché rade udite a vien e,
(Ih non fi mefcoU con la q u a lità .S i come appreffo
V ir g ilio .
M onfirurti horrendum , inform e , in g en s , c u i
lumen adem ptum . '
T rune a manti p tn u s regtV;sa ùefiigta f ir m a t,
Et infieme ut e il luogo de' confegucnti , hel
qual è tutta fondata la grandeZ^a s a Vamplifica
tione del Ciclopo . ìmperoche s'egli haueva un
pino per h afion e, confegue di necefiita che foffe
g ra n d e, tale è quel luogo . la c u itj; p e f antrum
im m enfum . v
\
D a g li apparenti f i muovono molte volte le f i
g u re , s a fono t a l i , che quando ancora g li appa
r a v i f offero altrim enti quanto in f e , nondimeno,
perche cofi alla nof r a utfìa appaiono ; molto vo
gliono nel dipinger dette cofe . Q u a l è quella
del Pef.
Ss ratto ufeiva il Sol cinto d i ra g g i •
\
CTVLIO CAMILLO.
69
N e la figura f i mofira cofi fa tta per la fola
virtù della tradat ione , posta in quella p a ro la ,
cinto . perche parer a noi tl Sole, come circondato
uèf it ta li r a g g ila molti modi f i potrebbe dire.
Et fe. ben f i diceffeper traflatione, non f i potendo
altrim enti , U concetto nondimeno è d i dir quello,
che ci appare ueder nel Sole . Dt che talmente
Ouidio fi mofira in v a g h ito , che in un luogo fece
quefia fig u ra . .
»...
: ,V
A t genitor ericum caput omne micante
Depofuit radios.
Et in urialtro quefia .
Impofuitq; coma radios, dal contrario .
L a fim ilu u d iu e , mentre è luogo d i figu rata
locutione fi quella, che fi fr o l rifare quando la cof i foffe tanto flerile , che non potcjfc da alcun al»
^ tro delti predetti luoghi defiderata belleTja p a r
torire . Propofloci adunque alcun concetto, coso
# fatto con la mente dtfeorfo per tu tti li predetti
luoghitnè ueggendo onde coglier fi po/fa modo di
figu rare , ottimo rifugio fa rà la fim ilitu d in e , 9
a comparatione.Et quantunque dellefirm i ilu d i n i
alcune fiano breuigom e quelle che un filo concet
to uefono , q u a l e quell j d i V irgilio 1 8 4 . T o rrentis aqux, T el turbinis atri More fu r e n t. A l
cune lunghe , che in più parole f i difiendono^ua
le è quella . Q uatis apes affate nova per floret
exercet fih file labor Cosoc. Nondimeno ambedue
nafeono da un medefimo luo^o é II perche, fe ben
noftra intentione non è a Jegnar alla uotia più pa
role di quelle v (he po/fono uefiir un filo concetto,
nondimeno quefle fim tlitu d m i m n altrim enti che
toso
70
L A T O P I C A D I M.
%
ta ltre figure per la loro dignità batteranno eccet
ti one perche il luogo aeramele non e p iù di uno ne
fa p iù d i uno effetto , f i ben f autore con molte pa
role lo jft'g a fje . E/ fig n o che dfò uerofia, e, che
f i pofjono tutte quelle molte parole ri fù n g e r fo la mente à tante t che da un f ilo uerbo potrebbono
effer governate . Ecco adunque Virgilio nel p r i
mo ejfimpio y hauendo à uefiir quefio concetto 9
f a r grande occifione, che altr intente f i dice, me
nar grein Strage , non f u contento di quefia uefia,
C a d etto , Vtenera per campos, m a perm etterci
quafi davanti à g li occhi il furor d i Enea^nell'uc
cider quefio s a q uello. N e parendoli da alcuno
de* luoghi fu m o fira ti ,p e r tirar fig u ra che ciò
operajfè , tutto fi riuolfi allaJim ilitudine,che d i
cendo tale effer il ftiror di Enea neltuccider, qua
le e quello del torrente, o del tùrbine , opera che*»
mettendoci noi d in a n zi à g li occhi quello, che tul
tu d ì ueggiamo del torrente , s a del torbine , c f
, m ettiam o parim ente quello che non vedemmo g i à
m a i . I/ perchexquellc firm litu d iw batteranno
g r a n f o r i a d i dipingerci la cofa, le quali faranno
m an ififitfiim e. che cofi dalla cofa conofiwta 9 ue
n i amo a conofcer quella che non vedemmo g i à m a i t s a s e talhor Virgilit) prendefim ihtudine da
cofa, che non fu uedutagiam a i , lo f a poche uol
t e , s a / n ta li cofi che l'animo no[Irò almeno fe
Thabbìa imaginato, f i come volendo dim ofirarci,
di qual bellezza s a d i qual habito , s a d i q u a l
arm e ornato foffe E nea, aiutando alla c a ccia ,
tra tte cofi la firmittudme da Apollo . Q u a tis%ubi
hibernam , L yciam , x a n th ij; fluenUt D eferti, ac
„ G ! V L I O C À Mi L L O .
71
D cium maternam innifit Apodo 0 c . Et volendo*
ci parimente m oJlrarU helleosoaedi D id o n e , ci
meffè cofi avanti Diana . Q u a li in Eurotx ripis
ave per tuga C ìn th i, Exercet D iana C horos. E'
m i nero coftfimigliando Enea 0 D idone à cofa
diurna ypoflo che le divine nonfiano à noflri oc
chi maniftfle,pur la imaginatione fa tta c i d i Apoi
lo 0 di D iana y celo f a v e d e re . Et quello che è
più lafiiato alla confidetottone , che al fenfo f a
parer la cofa d i maefia m aggiore, cofi il Petrarca
volendo uefìir quefto concetto, Laura caminar con
granita, prefi la fim i li Untine dal cam inar d i uno
A ngelo. Et cofilafciò nellt mente nofira m ag
g ior riveren za di quitta , che'l puro fenfo h avreb
be d a altra cofa manife fi a p o r to , dicendo .
Mouer i piè fra I’herbe e le v io le ,
^
Non coni: donna , ma ccm A n g el fittole • Mae l'Oratore f a pur contento d i trarre le fu e
J ìm tln u d tm da u f i tutte m a n ij'cfe. Ma è molto
da confoderar fottiim n/te in quefia p a r te , che .
talhor i Poeti pieni d i dittino f i n i t o sfaran no la
proprietà di una c o fa , che fa i ebbefom ilitudm e,
per far probabile alcun'altra, se/toso ìpofhrar ale»
nafim ilitudine ; 0 per g r a d a i'ejfem p io . L'cru
ditif im o Petrarca u u l n tfiir quefio concetta $
che ciò che u td e , non è altro , che la fina donna ;
0 perche uedea quefia cofa poco probabile uolfe
aiutarla non con la firn Hit o d i ne del Sole , ma con
la u irtu , che e netta fim ilitu d in e . I mperoche f i militudinc manif i f a farebbe fia ta f e haueff'e tor
to; Si come alcun che ha fifftm e n te riguardato nel
Sole, riuoltofi in altraparte , non, u t de altro cht
iS m
èri.
ì L n S E C O 'N 'D O .I f
K St
<k&
W
È
È
È
TOM O D E L L ’O P E R E s a
^
oso
D I M A J IV .L L O
.
,' D E L M l N r O ,
^
'C A M I L L O
'
ÒJOE'.
'
N V O s s e A M ÌN T E
I> rA T O
'
•
/
T N, L V C E.
.
L:.vN
I N V I N E G r A. A P P R E SS O C A B R I E L
G I O L I TX> D H’ , F E R R À. R I. /
M
D L X X 1 1 1 U.
'
. ■ -oso
~
E/p o fìtio n e fo s a n iì-p rim o et fe c o n d o
S o n e tto del PctsaIcaoso sa oso - /oso
'
.
T i p ica ffitiàrojctell ’É lo c tfti One ,.
La G r a m n u u q g i S . - ososa
.
à 't
7i
L a t o p i c a d i m.
Sole , ma la virtù della firm i studine è , dir dt non
veder altro , che il Jua So le. , Perche f f l f g l o f a ver attribuìto il nome del $ole a L* fi.con^ rtndf
quefìa effer virtù prefa da fim i Ut udin^nonfim ila u d in e , lmpcrorbe a voler f a r fim ih tu d in c ,
no» douea levar uia il nome d t L .s a in fuo luogo
poner Sole y che cofi è p iù toflo trafi ottone prefa
da do tu f i ma fim iU tudine, D / q u i f i mosce Q u in
t d i ano à d ìreg h e la traslauone era p iù breve del
la comparatione . Et Li comparatione f a il medefimo ihe la fim iln u din e ,se non che la fim ili t udì
ne non dimojlra auawgire , nc effer a u a m a ta dal
la c o jh y a cut f i fa la JinnUludine , fi come la com
paratione » quatte .
Et lei p iù prefta affai che fia m m a o venti .
IL
FINE DELLA
TOPICA
dt M. G ridio Camillo ;
AL
M O L T O
ILLLVSTRE
S.
C O N T E
D A
C O L
SER TO R IO
L A
/ v l i o Ca
m i l l o prese
il cognome di
‘TDelminto ,
Dehniniocittà antichifama di
Dalmatia, c h e fu patria del —
*>a d r e . Et nacque f come io
credo al mondo , per eccitare
ielle menti di tutti gli
'e marauiglie , in qualunque
> D
74
opra
, obuona, orea che et fi
metteffe. Hebbe un genio con
ardor inefhmabile. uolto uerjò
l'Eloquenza. Jìquale non ca
pendoper la grandezza fu a ,
tic
gliflrettifimiterminidi
precetti, dei macjìri di 7\etonca , udendone,
in
gufa , che la difìcfe per
gli ampifim i luoghi del Tbea
no di tutto il mondo. Et au
uenga che ufcendo egli primie
ro in cofi gran campo , uoleffe
hauereper forra tuttigli an
tichi
"Rotori:egli nondimeno
infinite cofe invento con la for
za del
fuoaltfim o intelletto .
Fra lequaliela Topica mara*
I
.
'
-
.
' v f
1 uiglio/àdella Elocutione. La
,
!
!
i
[
|
'
:
'
quale io ho
fiatto uni ,
àfine che ellanon ifinarrifca
nell’ingordigia di molti , che
cercano con
loplef tro
’
uati di lui illufirarf i
m i. Et ancorché quefio dificor
fio chefitg u e , e la
,
fahcfiofinoM di cjue' due So> netti,fileno
digran lun
to alla eccellentiadella T
ca ; nondimenoperche ellefino
fue, ffi potrebbono infiuftamente ornare-altrui,
pure fino utili a gli
dell'Eloquenza, ho uoluto dar
Je al mondo, {fi dedicarle con
la Topica d Vo i , fi come à
D o so -
genttl'huomo,
Udall'an
tichifw a nobiltà del sangue ,
recando la aera nobiltà dell'a
nimo ,
f f l’amoredella
f f del giùfio , e’I
dèi
teccelleràia, hauein predio
ff) lef atiche di
di
vino , f f la carità mia uerfo
loro .
r
P atritio,
DI'SCORSO DI
M ..GIVLIO
C
A ' M I L L O
SO P R A
M
O G
H E Rsa
E N
E,
i l come Varchitetto , non
f con fana mente f i co ndureb
he k fabrica* alcuno edifi
cio con le pietre , 0 altri
I [em piici f e prim a nella men
j te non baueff'e con b e lli, 0
dotti pcnfiert fa tta una men
tal fabbrica : ad im itat ioti d i c u i , d i fu ori efferatajfe le m ani. Coso d i niuno configlio è da g iu d i
tare quello conipcmitw
f i dà fi
'mettere iiifieme lè~pàfòte,T f ^ a ltr i ornam enti t
fon\a regger lo siile , fecondo alcuna forma, p ri'ma còttocatafi nella mente . Sia adunque tenuto
'quefio per fermo ,neffuno poter meritare il nomi,
di eloquente , fe prima, non f i ha cofiituito in a n i}
alcuni m odelli, quali baueuano g li A n tic h i, 0
-------------_
D
iij
y 8
D I S C O R S O
* '
sa la tmagine loro nelle fenfibili opere non fiaprà
rnojlrar di fu ori. Et quantunque M, Tullio tre
fole form e nel fu o Oratore , a g u ìfa di tre modelli
apparecchi, nondimeno p iù fu u ra m i p ir e la uta
d i D tonifio , (oso di Hermogene . JLiquali fo rfè
confilerando ciafcuna delle dette fo r m e , ,cl)e un iuerfali fono , effer compojìa d i più particolari fior»
tue : f i come i h umano corpo . che confideiato tu t
to, benché habbia nel tutto q uelli grande Coso uni»
uerjal fo r m a , per la quale e difìinto dal cane coso
dal b u e , nondimeno quefia f i/ m a è di più fo rm e
particolari cofìiluita : f i come del capo, delle brac
eia , cosom a n i, cosogambe , cosop ie d i, lequali p a r
ti ciafcuna ha fuo particolare fórm a . Et tutte in
fa m e fanno la uniuerfàle ; S i diedero à fitlfa ftele
trattare delle dette p a rtic o la ri. Dice adunque
; Cicerone effer tre fio)e fo r m e lla fommefJaf la me»,
diocre, cosolagrande .
sa
r; oso;; Lv
;.
L a fomm effa è quella, che quantunque firfh u»
m ite , e nondimeno da effer governata d a prude#
ti ; percioche effa ben con la h a f ftifa fina moflxa
poter f i facilmente imitare: ma farffe volte in g a n
na colu i, che ne fa p r o v a . imperoche q uan tun
que Cic. dica , poiché confefjata ha la f u a dif a
tu ità , fc alcuno cade da le i non poter c a d e r , fe
non da baffo luogo , pur a me pare , quanto effa t
p iù baff à , tanto tfptggi'-r pericolo effer d i d iv e n
tar u tle. Et gra n cofi è tenerfi fila m e n ti un p o
co le v a to , la onde fc alcuno f i abbaffaffe , non me
citerebbe p iù nome d i fom m efjo, ma di vile. Q u e
f ia adunque dee ufare molte cosojfe ff e fen ten tie,
ma ta li, che'l loro lume no» molto, rifjd eu d d . Le
r
SOPRA HERMOG.
7*
parole fecondo la confuetviine , s a l e tra flttio n i'
niente dure ; ma d i quelle che nel commuti p arla
re fi riceuerebbono ; molto dee effer afiuta , roaest
che taf} ufia fu a , p iù fittile che magnifica f i a j e
parole fue non deouo effer g u a rd a te da (amorfi d i
vocaboli, ne per tutto ciò da ingrata negligenti»*;
ma da qu elli che diligentemente è compofia. Sciol
ta ancora dice Cicerone dei tutto da n u m e ri. Ma
per mio auifo non dee effer intefo cofi fem p h eetncmt yf crei oche ancora detti numeri fono ( s i co
nte al luogo fuo diremo) che non muffirono ornato)
s a pvr con dtligentia , che non appai e , fono te f i
fitti.
La mediocre forma t alquanto più robufla, s a
pitn & r jQA non p tr tutto ciò ta n to , quanto l'am pHfiima , che fig u irà fa appreffo. H a qvefia le
y ferventi e più d e tta te , s a tu tti g l i ornamenti-, s a .
lu m i dell* Eloquentia le fi conuengono ^ E t benché
con l t Ira fia t to n i, s a altre bellefge f i parta a l
quanto dal commune ufo y in quanto èlle cofi non
fi parlarebbono , pur non f i dee partire dalla in tclligentia commune.. Da quefta ancora Cicerone
dice y cadendo alcuno , non poter cader da luogo
molto a lto . Et uero dice >perche ha fiotto à fe la N
form a fommeffa , cht farebbe fu g g ire il pericolo
diuentaruile y nondimeno d iffid i cofa è tcn erfl,
nel m e \o si „> 4 diuentare alcuno de g li eflrem i,
non dico fen\a participor la natura ile g l i e jlr tm i , che impofiibilc fa reb b e.
'
La terza form a è ia magnifica , la. copiofa , la
g r a v e , la ornata , s a s i come la fommeffa e ite*
esneta a prona re > C /la mediocre à dilettare
D
tese
lo
D I S C O R S O
coso lae /eroso à piegare , Cr muovere g l i anim i .
N eper tutto cioè da intender il luogo d i Cicerone
fi, che quefia fola habbia uirtu di muovere g li ani
m i: percioche Hermogéne ha opinione, che la
fim phcisfim ajornu fi 4 acconcia à piegare g li a n i
m i talhora . s i come à miferie ordì a . Et noi mo
streremo altre form e pot^r altre p a fiio n i, fecondo
la loro natura , trattare . Mae Cicerone per mio
auifo , intese nel p iù .
f i Purità*
C h ia r e lla
Ù £«iterali
form e
d i H er
m oge
ne.
L ucidezza»
S e v e r ità .____
GrandcZ$a. \ Vehemen%a sa
BelleZ^à •'
/ Asareosoae, ’
Splendore v
V ig o re .
yrtpific\jì si
Prosoeosoae,
Costume.
V e r iià .
Simplicità ,
D olcezza .
A crim onia.
M anfuetudm e.
LAggraeuaewrnto
.
Delle quali tutte forme dice H erm ogene far fi
I'oratione C ivile Dem ojìhenica, cioè quella che
del tutto ha vfato Demojlhene ; laqual nondimeno
um ucrfautà divide m tre forme p rin cip ili ; nella
D elibera-
,
SOPRA HERMOG
8l
D elilerati&a 9 G iu d tcia le, s a Va» efo n ica . L à
D eliberatim i, dice abondar di tutte quelle form e t
che fanno g r o n d e r à , s a g r a v ita , che e s s a
appare ; altrimenti non p e rfid e re b b e , s a m ediocr emente del cofiurne benché alcuna particola}
deltberattua potrà hauer btfognodt co fiu m e, per
la perfo n a , d i cuif i haurà I'oratione : la quale ci
afiringerà a partirci dalla propria d ig n ità , s a d i
scender d forma pitt m orale. Et nel nero le persa
ne , de lejquali fi p a rla , in parte fanno s a picciala , s a grande l'or al io n e .
La Gindiciate dico effer d i contraria natura a.
la deliberativa , fatuo fe non fo ffed i cofepubhche .
s a g r a n d i , utetne alla deliberatione . Q ue f i a.
adunque intanto è contraria alla d e lib e ra tiv a , in
quafTTo infogno , eh*abondi. di cofiume } ilqual / i .
^faccia per martfuet udine s a fe m fiic ità , m a neffj^
1ita parte dee hauer dell'aggrauanien'o, ò, d'aìa*iu forma ta le , o pochifinno ben ricevela g ran <■**•
delffa fiu ta per JrtpesteAu dalli fe n fi, e non.dalle
parole , ne dalle cofe che f i fanno intorno à quella%
tie dal methodo del fenfo ,faluo cheleggerifs im a
mente, quando.pur fi fa c effe. La qual g r a n d e z
z a non è però ricevuta , fecondo le fu e altre m a
niere , fatuo fe in alcun luogo non ricette la uehemenfid , in quanto a l fenfo . Et in qualche luogo
alcuna volta ancora, fecondo la parola con te, f i
gure t chef i fatmo intorno ad effa, ma nel rim a
nente ufa a ltre parti c iv ili % fi come la dehberatiu a .
La Panegirica netti fermom riceve tutte le fot*
me che fimno la g ra n d e zza , fatuo V afprefga, s a
D
V
*2.
D I S C O R S O
Li uebem enZa, riceve ancora la ja n p l ig ù , f i l m
la dotte li conuien Iettar [oratione alla fo u erità ,
0 fo la dvhefoza ha in nejjun luogo opportunità,
ha in quefia, riceve ancorala b ellef i f a g y la g r a
v ita , fecondo i t m ethodo, la quale non è apparen-,
te del tutto : ma altra g ra vità per niente . Eccetto
la dove vogliamo di/nofirar per quefia alcuna per
fona t che babbia o riti on Panegirica appreffo noi
P r e sied a ha poco luogo in quefia form a, la q u a
le e qu.ifì tutta pofia in narraliane . Lj Panegiri
ci nffonfì h i u(ano ancora l'a fp re\ze : cW * u themenZy occupano non poco luogo : fi come anco
tutte le fie tie di g r a v ita , 0 alcune oratiom di
Platone nel Gorgia fono d i g r a v ita , che appare
0 non è . Ricette ancora quefia fo rm a Panegi
rica tutte le forme per la im ita tio n e. . Vfàrffrnffmente tutte le cofe può t e , che ufa la giudictale 0
deliberativa : m acon una certa, correttione . Et ■
per dire alcuna cofa p a r tic o la r e q u e f ia fola può i
ufare tu tte le form e fe paratamente, l ’usta dall'al
tra , f i n 7a mefoolamento. Mae quando diuieue il
P am girtco qu*fì più ciutle , come fe gli Atheniefi
0 Lacedemoni f o f f ero in quefiione , dopo le cofe
d i M edia , dal precedere ; abonderà più del file n ^ dorè , 0 de la f i verit à , che la D eliberativa ,
P A N E G I R I C A IN M E T R O .
Q u efia che è Poefia, ufi» tutte le cofe della
oratione Panegirica : ma poco o niente di quelle
dilla g iu d tcta lt 0 deliberat tu a . Poefia è im i
tatione di tutte le cofe : 0 quefia molto uerfa nel-,
la delettatione, 0 nella grandeZya , f i come dice
Hertwogene ne la form a d i fe m p lic ità , oltre al
,
S O P R A I TER M O C .
I3
parlare del tutto : coso ha li ver fi cou f f ri , coso cqtjoJctuti dall'odio. P roprtj fono alla Porfia t a t t i l i
finfi fiu o lg fi, come di Saturno , de' T ite m i, dè'
Giganti j y C ent a ri r y Sirene , e T r ito n i, e'
Leflngom , Ciclopo f coso Pcrfieo . D ir cofe che ec
cedano la natura dell huomo , m a mofiruofiimcnte
fi come f a tte , coso degne di credenza* carile che
Achille fall affé ta n to, coso che A ia ce, ouer H etta
ri fucihnente(gettafa'e tanta pietra : coso che efr i fo fi
fero f i g r a n d i. D ir che cofe inanimate ferva n o ,
d g h \d d tj, con alcuno fenfa ,come che d ìfu a p ro
pria uolorua f i aperfero le porte del Cielo , C /td
terra d i folto mandaua à quefli herbe coso fiori „
Dir uniuerfalmentc mofiruojamente le cofe im pofi
filili coso incredibili. Ev anco cofa femplice coso pi*
Z nte Poetica , sottilmente narrar le cofe p a rtimente y come , che foptno cade, n e l* polvere t
• /na nell' hifioria ciò renderebbe b affeffia \ eccetto\
a doue uogliamo femplicemeute firtuor la Storta;
perche fino fem pii ci coso p arim ente dilette noli le
cofe particolarmente d e tte .
Il Methodo proprio de la P oefia.,oltre a g li aU
tri Methodi nel?orat ione pa n eg irica y è uno , cioè
il non parer d ir da fe Si ef i quelle c o fi, che d i
cono , m a inuocar le m u fe , & Apollo , 0 altri D ei
Cosofarà che la oratione p a ia propria d t q u e lli. I l
qual Methodo è f i proprio della Poef in , che nefa u
na oratione la può ufare, fe non la Panegerica y
ma non ferina correttione . Le parole y quali usò K
H omero , coso H esiodo, le figure proprie d i Poefia
non fono , come li fieufi a coso alcun methodo cosop a
role: percioche ha quelle m edfam e s a /# la Pane0'
*4
D I S C O R S O
£irtcae oratione , Yt in quanto a U imitatione , fe
condo chiedono It forme d e' parlari .
Poi che hahhiamo dato a)faggio 0 delle tre
uniuerfali forme di Cicerone , 0 delle tx% di H er
mogene , hora cJ.conduceremo a breuemente mofirare , in quanto infieme con vengono , 0 in quan
to di[convengono : 0 quali h abbiamo a feguire .
V ico adunque y che f e noi pareggeremo la forma
fomm ejja ; mediocre , e grande alla forma delibe
rativa , g iu d i cia le , e Panegirica : la fola Pane
g iric a del tutto converrà con la temperata . Alche
f i può fim iniente provare per effo Marco Tullio
nell'Orat. oue d ic e .
Fuit ornandus in Manilia lege Pompeius.T erti
perata oratione ornandi copiam per (et u ti fum us.
Che nefJuno fi può ornare , nè laudare , si non $ol
demo/iratiuo 0 Panegirico genere. Et vera
mente quella aratione in quella p irte ^ doue orna ,
pornpeo è tutta Panegirica . Et del temperamene
tosare d i [opra fogno Hermogene t quando di fife
la Panegirica tifar alcune forme con correzion e.
Mae come contraporremo noi le due altre forme di
Cicerone a le due reflanti d i H ermogene? certo
non veggio
Tmperoche ne la fo m m cjfa , ne la
grande fimo , si come giacciono deforme dal loro
autore , da aff'omigliare ad alcuna d i quell'altre
d u e . Che fe hen Voratione di Cicerone effaminaremo, dotte effo confefia ne l'orationehauerle trat
tate , troueremo in parte la fommejfa effer quella
che la g iu d tcia le . 0 in parte la grande deliberatiu a , 0 parimente ne la grande in parte effer la
g iu d ic ia le . Il perei# è d a conchiudere { h e le per-
sT ’-sa
^
SOPRA
H E R M O 0.
'
,
ti
fin e y Coso k caufi n o b ili, coso ignobili fanno rice
ver , cosolafiiar di fuori le form e, che pofi'ono fa r
fammifaion y grandeZ fa , «e sempre effer gra n
de , ne pjfctola la deliberativa , ò la g u id i et a le, ,
ma taihor g r a n d e , taihor p ic c io la . Wt/e fusa
adunque , coso ncceffaria fava d i fottilmente inlett
dere*iutte quelle particolari forme , le quali noti
folamente conflituifcono le tre predette uniuerfah :
ma ancora , per la loro preferiti a ò lontananza,
quelle, cosohumili cosograndi fanno divenire . Et
prima m i p ia c e , che nel grani? ambito f i conof ia no le tre u n iu erfali, Cosoptu tosoo quelle tenute da
Hermogene , che da Cicerone , per effer più vici
ne à ia cognitione. Viacemi, dico, che queste sia
no prima conofciute, che le particolari J e q u a lig ià
ùedmente fi offeriranno, fàpenclo noi y che tali
f a y i d i , cotal uniuerfide c o fi tuifi ano y y fempre
\ la uniuerfileè p iù propinqua a la cognitione,
che li fuot particolari. Et nel «ero p>u facilmcjn~\
te dal tutto à le parti,che da le parti al tutto ua U'
nofira cognitione al primo a ffe tto .
Hor volendo noi trattare de le particolari fo r
me fottilmente ypiglicremo quefia p iù fa c il u i a ,
che fapremo conofiere. , Et quantunque quella d i
Hermogene f a y uera y d iv in a , eoso perciò da
I tenere , nondimeno non ef if a c i le , che alcuno per
! lei poteffe fenZ # g ra n fatica hauer quefia nobilif i
\fama fcicn \af Ben aflàifarà. à d a rci à vedere p r i
ma le fette gen era li fo r m e , cioè la chiareZga & c*
Et poi come la chiareZ^a fi d iv id e in pu rità y Ite
à i e Z z a , EVla grandeZgU tn fiu e rità , affireZgay
nehanenz* , falendorer u ig a rt ^ y in a fjo n tiu a m
U
D IS C O R S O
Et il coftume in fom plicità , dolce7
gga , acrimo
nia , manfuetudine , s a aggravamento ; le quali
in tutto tra le generali s a particolori fono 1 7 fo r
me . Il perche Thu omo faprà fubito , dolendo ali cuna oratione , o parte d'oratione effer grande v»
’ morale , di quali form e ella ffa fa tta »0 f i poffa
\ fa r e per quefia u n a . Ma perche ciafcuna forma
■f i compone di otto cofe , le q u a li con venute infieme la cojlituifcono, cioè , di fenfo , d i m ethodofii
parole t d i figu re , d i m e m b r i, di compofittone ,
di firm a m e n ti, s a d/ n u m e ri, f i come l'offa, la
farnese la p elle, il colore , s a uuae coiai q u a n tita te , s a qu alitate, fanno uno braccio d i ta l form a,
che t particolare de Lt cotale forma, deT.huirum cor
po . A ine pare d ì pigliare p e r g u id a ti sanse, s a
per certo indici9 d t la form a . I l che potrà fim p rt
darci a vedere la natura de la f o r m a i m p e r o - »
che chi èf i roselo , c/jfleggendo alcuna compofilionr non cerchi prim a d'in ten d eru ljo g g etto ? JBsi'
sanilo adunque iljo g g etto primo cercato ne la Corti
pofitione , pann i fa c il uia douerft per noi apparec
chi are %fe daremo à conofcer tutte le nature de*
fenfi , che po/fono venire ne la compofittone , per
e i oche altro non fa r à fenfo , che la natura del fo ggetto . Et p e rg ra n d i e/fepipi fiano propofii quffii
uerfi di V irgilio per conofcer in che form a compof i i fu ron o.
T ytire tu patule & c ,
JN e l n e ro conofiiuto il foggetto effer ta le , ’ che
un pafìore dimofira , come otiofo un fuo eguale
d im erifottoH » fa g g io , cofi potrà coglierla natu
ragli quefio finfogffer^pura . Tmperocl^ragio-r
,
SOPRA HHRMOG.
$7
nand «fi d i p a f o r i , & di un arbore , 0 d i otio *
0 di fin iti cofe , il ragionar cofi fatto è puro 0
fcntpltcc 0 baffo, fiche cottofciuto, g ià fi* in d iti»
Laforma aquel fenfo effer quella di p u n ta te . Mae
[c alcuno uoleffe fotto'tl nome d i quell'arbore, o Lt
ulta fiumana ,o Augufio ; 0 per Tytiro alcuneccellente huomo , potrebbe coglier , che trattan■
dosi di cofe g r a n d i, 0 d i Intorniaigrandifiim i 9
la natura di quel fenfo effer feuera , 0 feguentemente la fu a fo r m a . Q uefie ragioni adunque
m ’hanno condotto à perfitaderm i, che la cognition
de le forme fia neceffario prim a intendere la n d -i
tura 0 la quantità de U fe n f t. Liquak come che
fi poffono condurre ad alcun facile 0 chiaro ordi
ne , fono nondimeno talmente fparfi p e rle forme
ordinate da Hermogene , che à pena f i poffono cojf if ofccrc \ pur raccolti da tutte le fo r m e , ritrovo
effer non p iù di noue ftnfi,o nature d i fènfi,che d ir
vogliamo , 0 fono li fot to feritti.
1
2
3
4
5
6
7
S
P A
R X.
A Soso O N T 1 V I . *‘
D I L E T T A V O LI.
S E V E oso, I .
G R A V I .
;
M O D E S T I .
A L T E R I.
RIM PROVERANTI.
> A C C V S A T I V I.
5
Et quefìi fenft quantunque fidam ente j.f ie n e f i*
cofikuffcoiM nondimeno 1 7 . fo r m i + peràoff*#
88
DI SO O R S O ,
#
.
foli lt fanfi p u ri entrano alla fa ttu ra di 7 . fir m e
fattofirttt.e . L i dilettevoli à quelli d id o lc e Z z * *
li feueri à la f i ver ita , li g r a n i alla grauità , li
modef i a la manfuet u d in e, g li alteri cdtyfllendor e , ti rimproueranli all'acrimonia t g li accufittiui
à ia uehtmeriZq , y a l'a fp reT fa , O" a l vigore
fi-come appare tn quefia f ig u r a .
P V R ! .
p P u rità .
f L u cideZ ^a. ' y ; W
\ Sem plicità.
T B elle^ vi.
PrefieZ za .
A crim o n ia , .
v
L V e r ità .
hffontiui
irififioAn
v
\
f $ D ile tte m ii
ì
7
5
6
4
D o lc e z z a ouer d e-. 7
le tta tio n t •
I I Scueri
Seuerità .
G rani
G ra u ità
l)M o d e fli
M a n ju e tu d in e .
c?
a lte r i(ti
Splendore
$ l\im pronera Jdggrauam ento
O y ic c u fa tim ^ p r e z z a , tiebe»
rnen^a ,
.
Et su antutique li fo li [enfi p u ri ent tin o à la
tornpofitiQho de le dette 7 . form e , nondimeno fono
d e fe rti are m loro 4 . g r a d i, imperoche, fecondo la
va rietà
*
S O P R A H E R M O G.
$9
varietà d à g r a d i, vengano .1 la fattura Aeriforme*
J l fenfo puro e t a f ] unti uo, fono come uniuerfitli
à g li altrt 7 .fottopufii fin fi ■ Imper ochesi/?i f i pofii
fono trotfhr f i parafi d a la 11 a u ra d i c ta fc m io detti
predetti , m i tiefftmo d i quelli fi lafeiera trottar
fon\a la natu ra dell» detti due , petcioche con#
mai f i trouarà fenfo feti ero ; ò dilctteuole che puro
paffon ino non fia <* Et nel uerotqu:llo diletteti oli
0feuero , che niente aj]unterà ili f u o r i, per far*
f i probabile ,fa ra dilettevole , ò federo puro , ma
quello che a]fum erà, fitrà d ile tte u o r i, ò fcucYi
affontiuo . Et apprcfjò ,fe noi pareggeremo il pu*
r0 attiaffontiuo , naturalm ente il. puro anderà
i)ktn\i altaffon tìu o , 4 guifia d i uniuerfale feto >
Imperoche l'affontiuo ( intendiamo del feparato )
y-qn può effer, fe non puro , m a ben puro , può
J effer forila ttaffontiuo . il perche al fenfo p u ropa
^ reggeremo Ut lana npn tinta , 0 à' I'affontiuo il
panno mdefìmamente non tinto , à tutti) g l i altri
fette foitopofìi fenfi pareggeremo li panni colora*
ti 0 tinta . V eggiam o chiaramente , che f i co*
me la lana , 0 anepra tl panno , che tinti non
fumo ,fono come uniuerfitli 4 tutti li panni tin ti,
0 la lanalparimente non tin ta , come uniuerfale
al panno ùnto , cofi il fenfo p u r o 0 fiaffontiuo fo
no uniuerfidt à g l i a ltri; 0 nondimeno ancora il
fenfo puro e uniuerfitle all’affontiuò. E/ due coudittoni dee hauere ilfenfo , fe puro dee effere. La
prima , d i non effer tinto del colore d i alcuno de
l i 7 . fottopofiif enfi, ma d i contener perfonehumi
l i , ò cofe bafife. L a feconda di non^Jfium ftfji fiu0
p ro b a b ilità ,g en ere, ò indefinito , ò jd tr a cofa •
90
DISCORSO
•
VT
D e le quali due conditione , /a feconda f i ricerche*
t a per T ifjo n tiu o . I mperoche fe la p rim a anco
ra f i ricercaffe , non farebbe ajfonttuo , ma una
ifìeffa cofa col puro . L > sensi a lu n q u P p u r i, •
fernplici che dir vogliam o, niente hanno di perfid
io , o dì profondo yper effer di tu tti g li altri p iù
d im f i . fjp e rò all'intelligenza d i tutti accortisnodati , quale e quello appreffo Cicerone ne le
\ errine,Lampjacum efi oppidum H ette/ponti In
die es sae, il perche a le n a rra tim i s a deferiti ioni
fono molti accom m odati.
Li fenft affontiui fono cofi d e tti, perei oche no»
offendo chiari per fi mede fim i a g u fi* de li puri ,
f i anno come al centro d i alcuna circonferentia 4
f e tutte quelle effe d'intorno tra h e n d o , come p e r ii
. fie e , che lucidi s a m anififli render li f o ff quo .« \
Z t poffo'no a ffa m tr fa n u ri altro
luogo ui
mette d o po la p fin a , ancor
cosa p par
te . s a do
p >li cofi.
'gu tt t ut
fi U luog h i topie» *
f f Genere a ff e tie .
Confufo a diflinto . <
Indefinito à definito .
C cn gregation e.
T utto a le p a rti .
Luogo .
\ T ernpo .
/ Terfin a op a r te .
Modo,
Cagione .
Aumenti per differ etic .
Q u a lità .
Auenim enti .
Conseguenti.
X^Gmdicio d e'g iu d ica ti,
La quale
se si nlrtr
terd
#*•
n a tici s a
non s im terpone —
ra fa r à
una rr\(t*
ficTai figu
ra de U
b e tte lg a .
sef'
v -v
-
- ' g
,,
v „
S O P R À ' H E RMOG*
GENERE
Jl
A SPETIE.
VucciSer Thuomo, usar crudeltade , però*che uccider è fpette a la crudeltà, ch'altri misfat
ti fitto à fe contiene . Virgilio . i l . Voi o clitrif fima mundi Lumina ,Ubente calo qua ducitis
annum, Lther sa alma Geres .
Jndesa 4' definito \
in moltt cofe io fin o in feriore, mae in due m ag
giom iente,
Congregatione . Virg*, 17.
T usi adeo 1juem m o x , qua ftnt h a b ita r a Da# •
rum C oncilia, incertum e fl\
l
Tei rende cagione della fu a incertitudinefon»
nagandò tu tti li particolari i
nse ■v l 'se v"
'
T utto h le p a r ti .
,j K
. Se alcuno diccffe il Palagio, i l giardino', i l f i n
m e , e tutto ilfito fono tig u a rd e u o li• > i
L uogo, tem po, per f i n a , cofa d i perfetta, s a
m odo. Eefr. f f *
r 1
Chiare f i t f c h e , e dolci acque,
Veggiamo che p rim a che egli renda qaet ner
bo } date udienza , tu tti li fenfi che fono ih quefia
flan \a , cioe tutte quelle cofeche ad udirlo chid*
ma rurouando poco pure cioè manifefle , fece a f
fiatine . Et chthakrebbe in tefi d i che acque f i
uokjfe parlare t fe non hatteffe affonta la perfine
di Laura ? L aquale nondim eno, non t filo appor
ta luce , ma ancora dignitate : ne folamente eofi
mofira parlare'dell'acque d i Sorga , mae in un co
lai modo ui ajf ume il luogo s a il tempo,-benché il
9\
D I S C O R S O
'
"
tempo più sintenda: percioche f i l o l'f i a t e ne ta c
que et figliam o bagnare « Cofi quando affume tl
rafno , ori ella [appoggiò , dificnue un particolar
luogo ; coso quatidà aggiunge herba y * f i o r , coso
affume per/otta & parte dt per f i n a , coso Cofit che
e parte d i perf i n a , come la gonna . Et modo y .
quando d ite hauét coperto col fie r o fieno V herla:
Coso anco dicendo .O r iA m o r co begli occhi , defiriue il m o d o , col quale effa lo g u a r d a v a .
’
Cagione Pet. 3 .
Per far una leggiadra f i a ven detta •
A umenti per diff. 6 7 . w ■•v QuOndo'l voler . E t 6 8. Le Stelle rii cielo. Et 113
V u ltim o la ffo d ifm iei giorni . ri ’ ^,v ^ ■/ 0 « .
Q u a lità ’. V irgilio
'
* ■'
Ego hanc uitulam riifl forte r e c u f it [B is nenU
a d y c . Et 11. E afiorvm M ufam y c . m a quattri
do cotali affontiom f i fanno diètro", non in a u ri
ne'interfiecando , ma qvafi nafcondetiàole; albe
ra, fanno g ra n fim ln an ti'di p u rità ficàme Cicero.
in V errem 1 0 3 Rubri cum deliciasffùrts , v‘V ir *
g ilio Eormofir n y c . Delicias d o m in ii Et*l<f. '■
T" M e me a paupertas uitx traducat in e r ti.' \ ‘
t V u m m tv sa fiid u o 1 . i.c o s o c s
*-.
*; ■
A u m en ti, . f e u • v t i o a 4V s a r i : ’
. I farei fu o r del %iogo.*
fi
C onfiggenti. Pei. risasi"/
* D i quei fioff>ir a n d 10 nudriua il co re.
..
G iudicto Pel. .
$ , One s i * d b i per prova intenda am o re .
*
Ks V i r g i l .
ri Veri* i</ ) quod multo tutefatthere m a tto <osof.
• S O P R A 'H E R M O G.
91
Del numero dellepafiioni che poffono effer p ro m n
d a te con le detti due fenft p u ri, 0 a ffm tiffijb m
c in q u e . 'Pmwo m itigatione y facondo mifijrjcordia , ter^h tim o re, quarto tr tjle ig a , quinto de
a e r a li otte,
SENSjl
A ~-4 ■■vs.
■
'
D IL E T TE V O L I.
Li Jiletteuoli fen fr, olirà che fiano hor p u r i \
perche non affumono ,hor. a ffo n d iti , pere/?e af
f i mono ,
. * i
Dei prim o grado fitto tu tti li fattolo fi,m a quefìi
perchtneWoration O z i le partorifeono baff&foa ,
Oemofihene cafhgo con le cofe proprie della pre-,
f i e \ \ d %tagliando quelli per ifpedirft lofio d a lorosi
Et e da notare ohe per mio a u ifo, per. una* d i A qc
cagioni faranno dilettevoli : onero , perche d e t
teranno lubilo il lettore d i loro natura , come ap*
pare in quefìi g r a d i da ti da H erm og. onero p e ra
che conterranno cofe , che dilettano colui fo n -cui
poffono cadere . Si come è ia pafitone d i diletta
ti one , 0 fin tili. ìlche f i può da le loro tratta
tiani facilmente comprendere . L'éffempio adutt*
pie di quefio primo:, grado darà il bel Sileno d i
V irg il,
‘ *voso
Del fecondo grado ; fono tutte le narrationi
vicine a {e fau ole, 0 d i quefìi fia am pltfiim o
effempio la Can\one delle trasformationi preffoL
Fetrarca.
' '•■*i .
D el terzo grado fono tu tti quellr fauolofi, m a \
addotti in confirmatione di alcuna cofifaome v e
t i , quale è quello di C k e r ,in Verr.. 1 0 ,3 . Zryphi *
9Af
D I S C O R S O
J a m accipimus in fabu{is ea cupiditate g re. Et
j»el medeftmo volume 1 x 3 . di Cerere. E t Fe*
tir are a .
Che m eraviglia fanno à chi Va/coltri.
D el quarto g ra d o fono tu tti quelli che porgono
diletto ad alcuno de f e n f i . Come ,
Stiamo Amor à veder la gloria nof r a Benché diventi alquanto jet*cretto p er quella
UocC y.Glona.y s a altri jì g m f canti le doti di L.tu
ra . ln fom m d quefìi ancora deferiuono le bellez
ze di perfine , s a di luoghi s d i piante , sa di corfr
d t fium i ; quefh ancora dicendo alcuna cofa , che
altrim enti haurelbc del lafciuo , vanno fila m en te
perfino a la pie digerita . \ t r g i l . Speluncam D i
do . E/ ofctda libavit nata . Et Petr. 8, Con lei
Jofs'io . Et 5 y . Vien da begli occhi .
. De. quinto grado fin o quelli che danno dettia
mo , Per. l i t i , f o n , s a p O . V oi pojfedett s a i.
X irg. 1 o .
la rtij; novttm terra Tlupeant] lucefcere So
le rà .
Et i o .
Ifle canit ypulfà referunt a d fid e rà ualles. E t . ^
I m ito pTocejdit uefper olyrnpo .
D el fefio grado quelli che Agli iddi] 0 cofi d i
vine , s a fiparate da hu/nani corpi , humane paffio n i attrtbui/cono • come è Ofctda hbau tt n a ta .
£ l Petr. f o .
V na do/ma più bella affai che! Sole .
D e l fitti ni 0 grado fin o tutti quelli che conten
gon o cofi non vio le n ti, c ome o tto , ripofi
Pe
trarca 4 9 .
Q u i nn flo filo e come amor m ’m a iù t .
, S O P R A H E R M O G.
9f
D e t ottavo grado fono tu tti quelli, cht etnie»
gotto ricordati otte d i le cofe paffute , che»fo n o fio*,
tc gioconde , f i l che male feguito non f a , perche
coft farebhono d i mifericordia , Petrarca •
Amor che meco al buon tempo ti. T h tu i. A n f i
di cofe, che 0 gioconde fu rono , la lor ricorda• .
none è gioconda P «tr<. j f . D a bei ram i f i endea ,
Dolce ne la meritòria, Sono ancora di quefio g r a
do quelli, che quantunque fieno fiati noiofi , n t c
nondimeno fieguito bene . Petrarca l $ 9 ,
Dolci du rézze*
i >
D A minerò detti pafiiorù \ che coii dilettevoli
fin fi f i poffono dire j fon o quefìi 6 »dilettatione 7*
d e sid e rio . 8 amore 0 am icttia, 9 a e /ie g re o s o t.lO '
emuUUonc . lis i cortefia si ■ • v c.dae esse
' . ? si rii ... .. si n
»
-si» -«ri'4
SENSI
$ E V E R Tesse si
D el primo grado fono tu tti q u e l l i c h e dicono
d i l ddtj , in guanto Iddi) , f in \a attribuirli cofa , I
' 0 pascione humana , qualffappréfJoliriPlatone. l a - . ‘
dio e u no, infinito, mcomprenfibile , m a quefìi
fono tanto feuerfachenonfi poffononUiàmar civili*
Del fecondo grado fono quelli, fhe effaminando
la natura de* tempi pde'fùlm ini , f i n \ a affegnaa
cagione , che fuggendo di dir le loro cagio ih f 0
filo di loro parlando, meritano nome d i fin fi f i - .
neri O v i l i quali nelfir/lo di V irgilio . Principi»
Cali* m 0 c , Et nel Sileno .
Naentq; canebat * u ti magnum per inane co a
tt a Semma 0 c m
Finalmente tutte le cofi de*c ie li, di clem enti »
Casosi pertinenti ad Afir elogia >o à ia Meteora y
j
lì
96
D I S C O I S O < ^
>
fono d i quefio fecondo g r a d o .
*iv
,
/o s o Del ter\o grado fono tutti q u e lli, che parlane
di* cofe d iu in e , ma .poste- ne g li h n o m ittb j- come
dell anim a , e ì a lcim a u irtn morale, j-Upodi quefio
grado fono tuttiglt-uniuerfa'ti d i cofe, mentre in
loro dimoriamo , cioè tutte le thè f i , li tffenrpr fo
no in f in iti, che •accommodati al particolare, d i nengono a ffc n tiu i.
.
v i ,v
osoDel quarto grado fono tu tti q u elli, che parla:•
n o d i cofe ..eccellentemente operate , s a f i uvular
mente una per una , come de la pugna d i M arath on a. Cofi parlando di grandi
degni Jino
m ini .
t
n
• . . . a n i ■v:
•V.., • . v '
M .A,
- . u ». •«; .
SE
,.
N S I
C R A S
f ì v , ....
t \
L i fenfi g ra n i fono tu tti differenti da li feueri.
Che li feueri d tfu a natura, feueri fono-, ma U g ra
ui non fatebbono d a fe g r a tti, feda efaog/tatione
no/ira-non li faceffe grani.» Ma perche fi fàppia di
quali fenfi g ra n i nor in ten d ia m o , »utile fava fa r
qnejla ditti(ione d i quattro maniere di g r a n ita » *
•r*
Ese
Ev
Et appare »
No» appare.
G r a n ita . *
• *vaer
zt-r* N o n e
Ma appare*
A
* N < w r e - |r > ( N e appare.
ir.
-uo*
• “'ri
L i fenfi adunque che m g lio n fa r gr/tuicà , che
f a 3 s a c°fi effer a p p a ia , noti cleono escer u o lg a r
ne d i moltf yinaparadof?iy cioè f u o » della com . oso
• .
.
• *
• S O P R A H EAM OC.
97,
mune opinione , Et profondi coso v io le n ti, Coso del
tutto *fcogitati. C o m e.
*
‘ ; ¥., * oso
Vn he/ morir tutta lae vita honora «
HI
.Sua utm nra ha c i a f un dal dì che nafce ,
<Et m o lti, a/nse ittiii quelli J e n fi y che [c o g ita tamente fin o tr a tta ti per li luoghi to p ic i, fon o d i
quefia maniera . t Et quefli fila m en ti fono ueri ,
Cosopropri) [enfi g r a v i .
■C L\ .-j
,S a N S I
M O D E S T .I r
Del prim o grado quando alcuno diminuif ie fe
medefimo del g ì tifo a Studio come quello .
. Ncn par ch't me r ia u e g g ia .
Quanto m ia laude è ingiurioflt à u o i. . . . . . .
Oel fecondo quando alcuno connumera f i nel
munero dri molti *
> .
Del tc?Z° quandbtilcuno dà alt'auuerfario d i
uoUnta alcuna co/a di p i ù . E*l d ir. che fe [fi in li
veniamo in giu dicio , y fu o ri d i agni nofirn cre
denza ; rii d ir di non hauer m ai accufato , ,C i ce t.
w V c r r .j f .t 4 * .- -
S E N S
• ’
-
U
te T
L E l i .
A1
L i [enfi alteri deono effer confidentemente det
ti f o n alcuna alterigia per li fa tti g ì orto]am ente
operati . Sum pius Aenaes . Onero perche a g l i
uditori fia dt le n tia u d irli , i l , A n d a titi. 15.
S p era n e • 14. I m p r u d e n z a ^ , v "
-
pS
D I S C O R S O
SENSI
R IMPR OV KR A N T L
\
/
.. ;
Q u e fìi contengono la -commemorai i one d i he
m ficio per cagione de la ingratitudine di alcuno,
cioè per hauer ricevuto indegno contracambio,
quali fono quelli del Petrarca .
Q u el antico mio dólce empio Signore, Doue
- Amor connumera li beneficij fa tti all'ingrato Pe
trarca > i y . Indignatione 1 6 . Ira ,
SENSI
ACC V SATIVI.
*
Q ticfii poffono accufar perfine di tre maniere
# superior/, o p a r i, o inferiori . Et fono differenti
dalli rimproveranti yperche quefìi riprendono in
g r a ti, connumerando beneficij: 0 imputando da
loro indegno contracambio hauer r ice v u to , ma
g l i accufittiui riprendono cofe degne d i riprenfo
tte, fenfaa communi beneficij{qu ali fin o in gran
p a rte ne la C a n i}
L'Italia m ia } One accufa
li principi dT talta . Et ancora in , Q u el antico
m io dolce , dove accufa Amore . Finalmente tut
ti quelli , che riprendono fen ^ a connumera tione
ne' beneficij fin o tali. 1 7 . I n v id ia . 18. Spreoso
oso . 1 5>. F u g a . 1 0 . O dio si 1 1 .V ergogna, z i
V ìfco rtefia .
-V . \
4
•
IE
FINE PEL DISCORSO
Ai M. G iu lio C am illo.
ESP O S I T I O N E
DI M. Gl V L I O
Camillo DeJm inio,
SOPTfA' L 'GPT^IMO,
& fecondo Sonetto del
T e tr a r c a .
O i , ch'afcoltate in rim i
Jparfe i l /ugno
D i q u ei fofyiriyond'io nudrtua il core.
Iti s u 7 mio primo g io u en il
errore ,
Quand'era in parte a ltr'buom da q u e l, ch'io fin o ;
Del uario f l i l e , in ch'io piango e ragion* y •
F ra le ua ne ffieranZj » e'l pan dolore^ . . _
O ue f t a , c h ip e t prona jttie n d d A fró re ,
SperotrouOrpietà ,n o n che perdono.
Mae ben ueggi'hor , sc come al popol tu tto
E
f
}
se
ino
ESPOSITIONE
'
F (tuoia fu i gran tempo , onde fin en te
D i tne medefimo meco m i u orgoglio ;
E del mio waeneggi.tr uergogn.t e l flu tto ,
EV pentirfi , eV conoscer chiaramente t
Che , quanto più ce a l mondo , e hreue sogno ,
,
V o i , .Q u efia uoce pofìa nel no catino , sa/i-
i
^it esser appoggiata a nerbo ha ten u o fa tic a ti mol
ti, i/ qu a li a g ra n torto ft fono ruar a v ig lia ti ,che'l
Petrarca non g l i Labbia dato u e r b o ji come diede
atte ! i S.
O uoi che fifa irate a m iglior n o tti,
Ch' afiottate d'aniQr , od ite in rime ,
P regate non m i f a p iù cruda m o r te .
Doue quella noce V o i riposa sapra quel ner
bo y Pregate . Q uufi che tiitùi li libri L attai non
f a n pieni d i quefia m aniera d i ttoca!iut , iquali
g li autori f ig l tono mettere fa effe uoltc a v a n ti,
per apparecchiar fi attentione , qu a l è quella prefio
a V irg ilio . T ityre tu patuU . OMoclibec Dctis
noìm y y c . y nulle altre y apprefio i{ medefimo
Petrarca alle j S .
V oi,cui fortuna ha pò fio in mano il'fieno . Doue
n oli mette per altro il detto uocatiuo 3 f i non per
fa r attenti i Prencipi alTinterrogatione che f ig u e .
Che fan qui tante pellegrineJj>adc? y c .
I/ perche dico , che* il prefinte pronome y nel
cafi uocaliuo , sfa fifa efi da ucrbo , ne per altro e
pofio y fé ìionper mettere attentione nella mente
de' lettori ; che dim anda quando .
Otte fia chi per proua intenda d tn o re , y c .
Si come dicefi'e * O uoi che leggete i diuolgd*
.
|
i
!
!
S 0 P R A* L T. S O N .
xor
ùerfi miei, fo tti in età giouenetta , pur chefia tra
n o i, cln per proua intenda amore > fpcro trottarpit ta non pur perdono del uario siile : ntlqual io
piango 0 ragiono , f i a l e uane fperanze e'I uan
dòlore. Et tutto quel che èpoflo tra il detto uo(àtino Voi > 0 quelle p a ro le , " '•
Oue fra chi per proua intenda amore ; è pofió
^ per virtù del Methodo d'interpofìtione > che d/man
da la forma di 'rnptpoRn ; che è tu tta volùbile. u
Voi tl> a fediate in rime Jparfe il fu o n o , D i
queijofpiri. Tutte quefreparole faum^^pàippccaiv 9 cioè circonfcrittione di auditori o d i lettori ,
onero di auditori volontari de* m iei publicati uer- v
f i : dijfe le dette p a r o le , ricohfcriuenti nondime
no quelli. Si come Ale 1 1 8 ,
' * .sa
*
Ch'afcoltate (Tornor odite in r h h è . J 'v oso ' !
C io è , che fete o lettori d i cofe amoro/è,o cotnà '
ponitort di quelle t Afeoltate j quefio nerbò f i - ' gntfica porgere Vorecchie , coti altetìuone à d u ìtL a
cuna cofa. Ma udire ha fign fikatioh e d i r/saetW? ~
cofa che fentir fi pojJà ; 0 udir fi può fin ita a f o t
ta r e , cioè ferina porre l'orecchio ad alcun fuono sa
f i come f può cogliere per quel luogo ; alle 1 6 6 ,
Quando udì d ir in un fiuon tri fio è baffo '. T/i
qual udire non pofe per Acuii precedente de fide-,
rio di raccoglier quelle noci , ittioso' fu à cafo . Et
affollare ancora fi potrebbe fienai udire'. ìm peroche 0 uno c'haueffe gravato l'udito 0 uno
lontano da cofa ( per cofi dire) audibile ,potrebbono afeàitare t cioè concedere g l i orecchi ad alcu
na cofa , in quanto p er loro f i poi effe , m a per ìu t '*
te ciò l'uno potrebbe m a l udire , 0 l'altro per-
ioi
ESPOSITIONE
duentura niente, lequalifignificationi f in o a ba
fian ca f itte notte dal mede/imo Poeta alle 9 $ .
I pur a/colto è noti odo novella ,
Adunque l'aftoltarefignificando , Tiare atten
to con l'orecchio ad alcuna cofa , inchiude defide•
rto di quella . Il perche è molto accommodato ner
bo à dimofirar la Tlimagietta q u a le erano le com
pofitioni del Tetrar capii» apertamente dim ofirau ,
alle 1 3 6 . Et defuoi detti confer uè *
Si fanno con diletto in alcun luogo .
Suono, accomodata uoceall'afiottare, perciòche nonfi H a con g l i orecchi ad alcuna cofa fella
n o n h a jv o n o . R im e per f a r differenza tali) or i;
da u erfi, che per latini poemi in ten d i. Vfa que- '
(la uoce R im a , volendo per quella fignificare la
Voefia T ofeana , la qual ua tutta fornita d i rime, \
cioè d i rithm i concordanti.ilperche diffe alle 4 4
Che non curò g ì am ai rim e ne u e r fi,
« j
C io è , ne fuoi T ofeani} ne latin i poem i, Sparf e , diuolgate. Sospiri ondiio nodriua il coreg u t
te quefie parole, con la precedente Suono 3fanno
Verif a fi dell'am orofa compofìttone , Imperaci»
non effóndo altro la compofitione d'innamorati
P e o fi, che uno sfogamento , f i come esco medefim o manifefta alle 9 .
Perche cantando il d u o lfi d ifa cerb a .
x
E t alle 1 4 .
E t perche un poco nel parlar m i sfogo.
E t alle 3 6 .
Dirò perche i fiof f ir parlando han tregua
i
• S i come f i legge appreffo Propertio ,
Dicere quo pereas f i f e in amore in v a i,
% S O P R A* L 1
. SON.
ioj
De/cr i ve il detto sfocamento , con cagione coso
effetto d a flo fo fi. ìmperciò y che altro è l'amoroso sfogamento che i fofairi ? Et che altro effet
tofannogli a m o ro fififjjiri, che nudrimento a l
cuore ? Percioche effendo nel cuor di qualunque
animale, posto il calor n a tu ra le, la natura ha
proueduto di tenerlo in egual temperamento Con
raltre q u a lità , per me^o del polm on e, .coso delle
narici : perlequali habhiamo percofl umg conti
nuamente di,pigliar tanto a ere, quanto f a me f i e r i alla refrigerat ion del cu o re . Et quando f a
mo f in i f a ricevere poco aeie , i d e tti flrom enti
f i faticano : ma quando il detto calore è ere/cinto
per alcuno acciden te, com e, per corfa , per fe b
bre, per Tamorofe fiam m e ; ò per altro acciden
te fla n a tu ra f i d a fa tica riintrodurre p iù a e r t
alla refrigeratione del cuore, ilche non può fare
fcn \a fo p ìr iS e adunque i fifa ir i fin o m e r in i a ll'mtrodutlio ne dell'aere refrigerati v a , fip u ò d ir e
$ fofpiri tenere nodrito , cioèuiuo il cuore per ta l
sfogamento, del chef i ricordò ancora alle 4 jsa
E m i f a di fifa ir tanto corte/e,
Q uanto bifigno a disfogare il core •
Et quella voce Onde^ bene'habbia molte frignò
f i cationi, pur in quefio luogo fignifica,per liq u a
li . Et coso uuol dire y che per m efo d e 'fifa iri no*
d riu a , coso refiìgeraua il cuore infiam m ato. IH
s u l , à quefie uoci aggiunto te m p o , ò <^àfignifi
ca perfettione d i effro tempo , ò d i effa e tà . Impe
ro che c ia f un tempo y ò età oso divide in tre pa r
ti fu e , nel fuo' .Oriente., nella fu q c0n fif eriga y
ouero perfettione, cheuerfa nel me%o toso nel firn
vi
E
***Ì
104
E SPOSITI ONE
occhiente \ cioè nel ftto fine . Et qu.mdo f i legge
nel Decani. Ale i j 8. in fiel uejfiro , Et alle 188.
in su a;tef i hora . Et Alò 9 8 . to su Thora della
compieta . Et Ale 9
9» t i f o la completar. No'n s'm
tende nel principio , o nella v ic in ità dell*bora del
uefiro , 0 dellacom pieta , hè anco nella fine y ma
apunto nétta confif i en\a dell'bora. C ofi il Vetrari ‘
ca dicendo. • ‘
’ • ■' U esse
• * si “S
In jrim tiftim tfg io v e n iT crro Y e , ‘ si ’* 1
*
N Wf intende né v e l li f ridia ; ne nel?ultima
parte ) friànella corlfifienteAclln fina àddolefcenyi,
1 m pèrócbe, se come nétte co fifv é la tin e fachiama
te fienilijdtm ofira nel libro 1 8 . nella epifiolà a la
p ó fe rita faeffofu prefio d à Tarn or d iM . L .‘nell'età
r ie g ltn n n i f i n i i z . 0 m efiti. Et TaddólefcenXà,
fiepftd à to p in io n d i D ànte fafi d ìfien d ép èf finirà
g ita n ti
laqual è fig b ita f ordalia g ioventù ,
che abbraccia anni t ó . GioUcnìle errore. N on
h a noce la lingua volgarefa da potere fignifi càrie
TaddùlefienZa . Il perche la Vote d ig io ven tù Tè
commune 3 ma per dimofirare , ch'egli era in
quell'età , che i Latini chiamano àddolefientia y
piena d'errore p e r ii forno mentale , che profonda
mente che la tiene occupata , fece fe g v ite quella
voce. E rróre, ch'effóndo due strade d a teneresi
quella della uirtu , & quella deliappetito , il g ì 0»
Umetto à cut fono chiufigli occhi mentali y entra
in quelloffielTappetito
11perche d ijf e , alle 1 3 j
si Madonna il manco piede
' Giovinetto pofi io nel cofi v i regno. E t Ale l o j
* A n \i mi sforma amore si
v ., -* V' Che La sfradad'honorev"^ *
V1 • •
^ .m
M ai
%
SOPRA’LlxSONV
i of
Mai non lascia seguir chi troppo tl crede .
Et benché non dica nel g io v a n i [unno , 0 ;>elI
l'etdfotm achiofa; nondimeno dicendo G ioitem i
errore, y [e ia per iute f i , c h e li fojfrro g ra tta ti d a l*
giouenil f ilin o g li occhi m entali . Ma nel prim o
capo del T rtonf o d'am ore, alle 145’. dtrnoflrand#
t
reta, nella quale conobbe am o re, diffe •
•
a
lu i sia l'herbe g ì a di pianger fo c o , *y
•
n se
Vinto dal fanno utdi m a g ra n lu c e f a y :
Dotte po/e l'herbe per l'appetito , si còme a l fu o
luogo dichiareremo , s a i l sanno p er la cagione
del predetto errore „ N e dimorerei tanto fip r a
quefio fanno Je molto non facej/e per quefio Sonet
to , quantunque nominato n o trih a b b ia . lmpcroT
ì
che quelle noci . Ma hen ueg'gio h o r , s a l'ultim a
del Sonetto, Sogno , p a tt engono molto al satino],
che ci bifogna intendere fitto quella uvee Errore ,
fi come al fuo luogo f i dirà . Q uando era in pai*
/
t e , rimuove meglio U colpa da A gg etta n d o la nel
l'età gioue nile ; nella qu.de 1'buomo c altro d a
quello che trovo poi nella matura epa , non fo la mente fecondo la fifta n tia m ateriale, la quale d i
continuofi ua cangiando fitto la medefima f o r ttia , corwe moflra Arifiotele ne li {noi v r e lic m i ’
ma ancora f i muta t fecondo l'opinione , come d i
ce Platone. D a quefie ragioni f i mojj'e Porfirio rie
i predicabili fuo i a d ir e , che Socrate vecchio è a l
no da Socrate fanciullo, volendo dire Td?e c ia f cu
rili uomo (incor da sa m ede/mio è differerite^ fico do
1
l'età . Imperoche uaxangiando l'openioni, f i co
me cangia l'efo se M ^ iffa e tr a rc q , confederando
I
che nell'anim a, che è la f i r ma (perccfiS r& ì) jtffo
io *
ES PO S IT T O N E
sem iale , ne la form a corporale ft cangiano m a i,
modero U detto di Porfirio con quella uoce . I N
parte t cioè none in tutto . Se adunque l'anima
del Petrarca ha mutata opinione nelTetà rpatura,
non uorrebhe che'l binfinto ci>e li f i poteua dare ,
m entre tra nell'etàgeonemie, li s i d ia neWeta f a
m a , coso diff erente dalla p r im a , fecondo l'opinio
ne ; la qual mutation d'opinione mofira ancora
nel Sonetto alle i i z .
v
Come ua't mondo ; bor mi diletta e piace
Quel che più m i dt fin acque . Et $alcuno uolesse che'l Petrarca f i contradicat imperoche pare
che nonf i mutaffè d'opinione, ne d i cofiumi per
quel Sonetto alte f i .
D icefitte anni ha g ià rivolto il cielo ,
Voi eh'in prima a r fi, e gia m a i non m i fp en f i cosoc.
Doue nel fecondo quaternario d ic e ,
Vero c'I prouerbio ch'altri cangia il pelo «
A» Z j che'l v ezzo . .Parimentealle 1 9 .
D i dì in dì uo cangiando i l . v i f i t'Ipelo :
N e però smorzo i dolci im e f ia ti ham i ;
S i potrebbe rifaondere» che'l Petrarca in m olti
luoghi delle fue compofìttovi dimofira , in alcuni
pun ti dell'età che tendeva alla m atura, esserli v e
nuto deliberatione di rimanerfi dall'amoreyma ciò
giu d ica r di non poter ottener d a f i tf i prim a non
ueniua alla vecchiezza, Imperoche nelle fu e ope- .
re L a tin e , fa fed e in età molto giovane efferli u t
nuta alcuna canute^ 4 , nel libro ottavo delle ro
se f e n il i, nella prim a epifiola. i l perche diffe al»
i* 3*
'
4
S O P R. A' L L S O N ,
107
Se bianche non fon prim a ambe le tem pie y
C l/d poco . à poco p a r , che'l tempo m ifih i ,
Securo non fa r ò . Mae alle 45*. àimoflra effert
liberato p erci oche del tutto la canute\Za l'haueud
coperto , chiamandola neve y e'l fu o capo , a l p i »
dicendo .
G/d fu per Talpi neua ri ognintorno, coso aesserntaeffere fu egli a to , coso che'l giorno san ici naud
' • Et egiae pressa il g io rn o, ond'io fon d e flo ,
Dael qual giorno f i g u e , il ucderfi y come dire
mo d'appreffo [o p ra i uerfo . Mae he« ueggio hor •
adunque fottilm ente f i co m iene guardar le cofe
del Petrarca . D el uario S iile . E' opinione d i
Platone nel Simpofio fuo , che Tamar fia qualità f
mifla di dolcezza coso d i amaritudine , Il che toc
co ancora C atullo, quando diffe .
Er dulcem'curis mifcet am aritiem .
Coso il Petraercae .
-,
N el cor pie riamar iflim a dolceZzj* Et alle iy 4
E/ quaTè'l mel temprato con T acenti .
Adunque fe g u e , che ae/icor le compofiuoni fu e
fieno u a rie , coso che taihor pianga y taihor in pa r
te co n fla to , quantunque non r id a , almeno hah
biagran triegua con g li affanni, che poff a ragio
nare , il che non ò d i piangente y ma di alquanto
fedato. Imperoche il piangere nafce dall'amaritu
dine \ il ragionare dalla dolcezza .M a pur non
fu m ai del tutto pu ra dolceZgib eh* non potè g ì un
g e r a l rifo y ne à ia g iu b iìa tio n e . Et b a ia f i a t o tl
Petrarca due cagioni di coiai m iflioe d i dolcezza
Cosodi amaritudine > molto m m sasteJ'unaalle 9 1
£
yj
Io8
ESPOSITTONE
,
C antai ,b o r piango , s a non m e n d i dolcezza,
D el pianger prendo che del canto pre/i ,
Ch*a la cagion , non a Teffetto in te ff,
Soit'o i m iti fe n fi vaghi p p r d*àlteZrgs. *
Tmperocbc prova là mifìtòn detta dolcezza,per
la qual cantava; s a dell'amaritu dine ;per Li qual
p ian geva , dalla cagion del feto amore , eh*erano
g li occhi di L a u r a . Et d a g li effetti della dettg
cagione , eh*erano i tormenti anioroft, perche ri
guardando la cagione , p e rla fetia dolcelfgg cniìtA
v a . E t battendo riguardo lt g li effetti \ che fono
g l i affanni a m o r e f, ejfo p ià n g eva , s a p o p Can
ta re , per compor lieto : il quid in quefio luogo per
m aggior eflimatione t chiamò ragionare. L'altra
cagione , nel feguente Sonetto pofe pur alle 9 1 .
‘ 1 pianse t hor canto, che'! celeffe lume
Q v t l vivo Sole a g l i occhi m ic i non c tla .
P erciodie là d o lc e zz a \ s a Tam aritudine dinio
fera pigliare da u n medefìmo fo n teg io è da Laura
bora benigna , bora turbatase E t nei u e r o ja dol
c e lz a poteva ricevere il cuor del Tetrarca,»)entri
vedeva cortefe il volto d i Laura uerfe dt lu i. Et
cofi componeva cofe , che tenevano d i ta l qualità,
E t a m a ritu d in e g u fta u a , quando Laura per sde
g n i f i faceva avara del fuo volto . Onero mentre
lo mo fr a n a turbato . Et cofi ì Uerfi fu o i fentivano di pianto . i l perche diffe?atte 3 y . O nde dì e
nette f i r in u e r fa .
i l grati defio per isfogar il petto ,
Che ferma tìen dal variato affetto *
Imperoche il petto del Tetrarca va ria va le qua
litri di dolceZgàt s a di 'amdritiidinc da gl* occhi
S O P U A ’L r. S O N .
IO;?
di L au ra. E ta lle jiq .
Oue è la fronte che con piccia.I cenno y
V o lg e a l mio cor in qucffi parte c tn q u i 1.: si
Ma cì)$ diremo più■per m aggior rln /nseaetnsev to
quella noce Ragiono y cheposo in luogo ai rido .
o canto ? Certamente quantihi pie il Vetra.u:
talli orfif r a condotto a concederfi il rifa .come A Je6% .
, fa" \esse
In roso , in pianto yf i a paura., effiem ey .
Nlt ruota f i ch'ogni mio flato injqrfa ; :
■Nondimeno alle 7 6 fece quel Sonetto . • psa
Se 7 dolce sguardo di coflei m'a nei de ;
N el qual ra fferm a , ne anco per il lieto n ifi d i
Laura p iglia r perfetta letitia , ha vendo riguardo
per molle prove a la *nobilita fu a 0 saquello che
poco tempo durerà in tale s fa to . Adunque f r e
mo fodisfatti al prefente d'intendere , perche il
Vetrarca non ha voluto in quefia m iflioped i dol
ce 0 di amaro , dar il fito contrario, a l uerbo p ia n
go , che farebbe fla to Rido , 0 perche anco non
ba ttolato dir canto , ma Ragiono faefjend* verbo
acconcio a lignificare tanto d'A leggiam ene . da la
pena,che fc ben batteva cagione di ridere o d i can
ta r e , affettando toflo.il contrario per la mobile
natura di Laura, almeno.hauena-tanto d irifto ro ,
che polena nelle compofitioni fu e dar .inditio d i
non piangere. Imperoche ragionar/offono yfenZ a impedimento di pianto 0 d i lagrim e quelli ,
che fono rim a fi d i pianger/;, f e ben xnqlto non s'allegraffero . Tra le vane ffie ta n Z j , queste noci
acconciamente rifpondono à quel uerbo , R agio
ne* Et quelle cioè jL 'In aii'dolore ? a P ia n g o .
uo
E SPOSITI ON E
Perche coso nanamente fperaua ragionando', p e r
vederla alquanto cortefe uerfo d i l u i , y nana
mentef i doleva , uedendola sdegnata , conciofia
rosa che , coso ?nno y l'altro hanea à du rar poco.
Il perche alle \ 6 6 .
Q u efli f a r teco m iei in g eg n i, e m iei arti , H or
benigne accogliente , (oso bora sdegni ; T r ii f a i ,
che rihai cantato in molte p a r ti. Oite , quefi#
noce non altramente che appreffo L a t i n i, taihor
fignifica luogo , e taihor tempo y y in quefio luo
g o fignifica q u a n d o , Si come nel Decani. I 4 f .
O ne dar non uoleffero la Donna,a nceuere la h a t
taglia t'afactt.iffero . C h i per prona intenda amo
re j cioè, chi conojcd per J p e n e n \a a m o re , T ro
fia r p ie tà , cotal modo di parlar usò il Bocc.
n tlT tpifola a Vino . Trottar m i f r i cordia . N on
(he , non latamente , ih e allrouc dice , non pur ;
V tritino , quefio taihor pcrdonan\a (oso re m i filo
ne citi,una il Boccaccio , coso benché perdono non
jp c tt, i propriamente y f i non a g iu d ic i, che p u n ir
piffuno ; nondim eno in quefio luogo è pofio per
nuu biafim o . Imperoche quelli ancora , r i quali
non scappamene il punire y l'ajjoltiere y poffono
nel?animo fu o rim ettere, cioè, non li parere di
biafim ar alcuna c o f i . Mae ben veggio , i Vlatonu
ci hanno detto Tbuom o, hauere due maniere d i
o c c h i , m entali y corporali . Et quando i corpo
rali fono molto aperti a loro mah; alili o ra i m e n
tali tf]ère addorm entati : ilche attiene al?huomo
m ila g to u en e età . Et m e n tre i corporati diven g o
no debili per la vecchie^saae, all1hora i mentati d t
f i arfi d a l f i u n o .il perche il Tetrarca diffe alle i o
S O P R A ' L I. S O N .
ili
Et C/O seppi to d o p o i.
Lunga fiag io n d i tenebre u eflito .
intendendo per l'ignoranza della giouentù ,
che è a ggifa di una tenebro/a notte alle giouenet
te m en ti, Et parlando à g io v a n i alle 1 7 9 ,
Mae io u'annuntio che uoi fete o ffejì,
> D i un g r a u e , e mortifero lethargo ,
* A lquale è un foimolcnto morbo f i , che per lui,
- “Asai infermi addorm entati uanno a morte. Q uefio'
~~ \h ia m ò Paolo Apoflolo mortem peccati. Et DaewH*
Clamabo ad te per d ie tn y y non e x a u d ie s, y
nof i e yfed non ad in fo ien ti am m ih i. coso altrove^
Mane exaudies uocem meam ; dotte O rigine , y
Gieronimo dicono . Marte id efi S la tin i, tene
bra fugere ceperint y e x a u d ts, no;> quaew fin em
meum . Imperò Iddio yfrio ito che Thuomo fi sve
glia dalia notte del p ecca to , Tefftudfce y tlqual
tempo dello svegliamento è , come Aurora e m a t
tino tra la notte paffata del peccato, coso il giorno
della g ra tia . Per laqual cofi d iff? il Petr. alle 45*.
G ià f u per Talpi neua d'ogw intorno,
Et e g ià prefifo il g io rn o , ond'iofon d eflo.
Et a lle i $ 7 .
'
' /
Subito ael/W come aecquae ilfuoco a m o rZ d 9
D 'un lungo e g ra ve fonno m i rifueglio .
Etale.
66
V uggir d ifp o fg ti inuefeati ram i f
Tosco ch'incominciai d i veder lu m e .
^
Et in quello luo^o usa fidamente quefie vo ci,
Veggio hory cioè ueggjo in quefia età uecchia con
g li occhi della meni equello che p e r ii paffato fo n -
nononhopotutovedere• rm
jlrmfxU
a■
»11
ES P O T I T I O N E
,
che precede al vedere , cioè lo svegliamento, ma
accompagna ambedue alle 1 1 3 .
Hor comincio svegliarmi e seggio ch'ella.
: Et nella medefima , nel Sonetto f 'egucnfx accorri
pagna il vedere con la cagione, cheg l i vietava il
vedere, dicendo.
Hor veggio , sa ferito ,
*
Che per haucrfalvte hebbi tormento •
E/ al primo terzetto .
Mal cieco amor y e la mia fonia mente .
^
Mi tnua inanZj , sa chiama cieco amore, per
che fa ciechi, Cr privi di luce gli innamorati. Al
popol tuttofavola fui gran tempo : T otto da Horatio fcrìvcndo ad Pedium nel libro ultimo oda.
x j . Heu me per veibvrn (natn pud et tanti mali )
fabula fui : conviviorum sa panitet. Dove Horatio alla vergogna, accompagna il pentimento .
Mail Vcty. prima ch'adduca il pentimento , ripi
glia la vergogna predetta . Et la rafferma"[opra
una fi uterina di Paolo Apostolo, chefuona\de juoi
piccati coglier per frutto la vergogna . Favola
fu i , pofe quefìa vocefi come Horatiopcr mormo
rativiie , la quale uorremo in quefio interpretare
lontitno dalla fignificatione che ha alle 98.
La mia favola breve c già compita
Voue la fiotteremo per Lt brevità di quefla vi
ta , che non alti munti e vana , che una fattola ,
xfn è cofa uanifiima per ejftr tutta finta. On
de , per la qual cosa . Sovente , /pesco volte , sa
c uoce provenzale . Imperoche dicono Soven . Di
raii rnL.defimo ni eco mi . Cinque concinnitàgenesesVili dt eratAni f m a me ? wo
MaV irgli.
S O P R A ’ L I. S O N.
in
V irgil. fu contento di- tre , con le dette lettere .
i
]ncipe Mcenali os tm eu m m Bae tib i nerfùs
Et a ltr o v e .
si
v
t Fbyti i da m ltte m \h i, m t u s , oso natali*, To/d.
E' il v e r o ) chela te r fa che fece U V etr. e n d
fine della uoce ma comun q; pofia fi a mette dei' c&firna harmonia . Mi vergogno. N o n u itole
4 j j k n f l o t . nelTEth fu a rìceucre la vergogna n e ln v
* mero delle uirtu . Iwperoche Tbtiomo non dee fa r
* cofa, p erla quale babbi a è vergogu arfi, nondi
meno dice f a r bene alli fa n c iu lli, 0 a le donne
p erla lorop o ca ferm efya . il perche diffe il Boc
caccio nella Riammetta Ale 18 , V ergogna fa n tifiim a , dur f i imo freno Ale vaghe menti... Al
perche il Petr, mette quefia fu a vergogna fra f e ,
0 n o n p A e f è , ne d t error commefffa' nell'età ma
tura , ma nellagiouenile. Et del m io v a n e g g ia r,
quefia particola * E t , e pofta ifhofit inamente . E t
ha virtù d i dichiarare le cofe precedenti, non A irimenti checiò è , cofi alle 4 9 .
*
-..si
Et dall'un lato il S o l, io dall'altro era .
«
lmperoche d ic h ia r a , quali fofjero quelli d u t
amanti detti nel primo uerfo . Colt in quefio luo
go parendogli h a ver detto confu [amenee uergognarfi f eco A prefrnte, delle mormoratiom fatte
g ià di lui S e gu ita n d o Horatio , ripiglia il m edefim o fenfo , con ia f e n te n \ji, come ho detto dell'Apofìolo, 0 con la virtù di quefia particola va
dichiarando la mamera delia vergogna fu a , ac
compagnandole le cagioni. Ma è da faperc che il
Pelr. m quefio.luogo, fecondo il cofiume d à Poetsa
volge l'ordine delle cofi. Qonciofiacofa, che Timo-
114
ES P O S I T I O N E
ma prima conofre, poi fi pente £r pentendofi,si-,
rod i f i fi vergogna . Coll alle 7 8 .
(guand'to caddi nell'acqua, coso ella [p a r v e .
Ma prima faarut, cb'ejjo cade/fi nell'or.qua del
pianto.Q uanto piace al mondo non dtffe a me.
imperoche il Petrarca ha mutato l'opinione,fi co
me ha mutato l'etitfna il mondo non la mutar l o
per la grande ignoranza , in cb'è fip o lto , le
nerbo nel tempo prefente . Perche fempre è a d un
jj
m o d o . E un Irreu e fogno . Q uefia uoce e p re- V
j
fa dal jonno , che debbiamo intendere per tutto il
Sonetto é Si come (opra dicemmo . Et perche fo
g n o è quella u a n ità , che ci par uedere p e r il fori
no . Ouero intende i fu orpenfìeri, che f i f a b r i
ca nanamente nell'etàgiouemle cosofinnacbiofa i»
torno alle cofi d ’am ore, ouero intende della belle^
Za d i Lau ra y chelo faceua\ vaneggiare > laqual
per effer ben caduco , & poco du ra b ile, I'huomo
non d eaferm a rf in lei.quantunque il mondo pien
r i errori fa cci altrim enti, ma il Savio auedutofi 3
dann a quello che g ià tanto p reZ ^ a va . i l perche
(die 4 6 .
T al pa r g ra n m eraviglia y e poi fi Jp reZ jta .
E t dalla poca durabilità della eccellente belle/,'
diffc alle 9 9 .
Mae che ? uicn ta rd o , cosofu b ito v a v ia •
Ma perche die effe vlen tardo , diremo al fuo
luogo ..
0, . . . . . .
.
.
'I
IL
F I N E D E L L A E S P O SJT IO N E
[opra il primo fonetlo del P etrarca.
EXPOSITIONE
j D I M. GI VLI O
-A CamilloDelrninio.
SOPTf A' L S E C O N
DO
SONETTO
del Petrarca. ,.
E v. fa r .una leggiadra f u a
v e n d e tta ,
E pun ir in un d ì ben m ilk
é fe fe .
Celatamente A m or Varco
riprefe,
Corrihuom , c/?’d nuoce?
luogo e tempo a ffe tta .
E ra la m ia uirtute a l cor r i f r e t t a ,
P e r f o r i m e n e g l i occhifue difefe :
Q uando l.colpo mortai.la g iù difeefe %
Otte fole afiu n ta rfi ogni fa etta • A
P ero turbata nelprimiero affatto
~
116
H S]P O S I T[I O N E
Noi; heble tanto , ne uigor , we fa o tio ,
Che potejje al bifogno prender Tarme ;
O vero al poggio fatuo fo , (osoael/o
Rjtrarmi accortamente da los?ratio « c
Dal qual hoggi vorrebbe, e nonpuò aitarme .
Q u e f a è m i altra maniera d i f in far f i . Et sa
/ tenuta al Petrarca f i ben fa tta , c h e , q u a n tu n -\
que'quefio Sonetto fu/Je de'prim i che jòrfe egli
ftc é fje m ai , y ultimo il precedente ; nondimeno
tn lauto conviene con quello. che poflo tp rim o iti
ordine che non battendo in quello y che ua avanti,
dato al cafo quel peccato, che da fe r im u o v e , ma
f i l o alla im p ru d en tia, y a l l a necefiità y in q u e flifisfo rZ i* volgerlo al cafo . Imperoche tutto
quello fi può chiamar cafo che attenuto è fuori d el
penfiimento noflro . Et è tino de*tre membri del
la purgatione ; ma non e fi femplice che liberar f i
pò))a dalla im prudentia. La quale cofi come d i
fopra t venne a d un irfi con la necefiità ; cofi in
quefio Sonetto non può liberarf dal cafo . Im p e
roche doue è il cafo , e ancora TJnimana impru
d e n ti,t. Et fc fa fcufii dalcafo , cosoinfieme dalTim
prudentia , come certamente f a , fe ben f i confide
rà il Sonetto nel quale fi sforma dt dimofirare , che
Amore per coglierlo cosopor vendicarli afaettò luo
g o coso tempo ; certamente quefia parte d i feufa
Jara da ordinarla fiotto il perdono, fi come fine f v o m
Appreffo è da confiderare , che'l Petrarca, {e noi
li vorremo conceder cognitione di artificio, m eralùgliofament e adorna la feufa p refi dal detto ca>fe »\4dar cdrico a l Signor fito amore da due
S O P R A ’ t T I. S O M ,
JJ7
p a r li, an \t da tr e , ma diremo che due . Perche
la feconda nafce da la p rim a, la pr/ntae fa r a per
che Astore uolendofi vendicar della dureZgg del
Pet nella quale hauea f f untato molte fu etti a f f e t
tando luogo s a tempo J ì vendicò da nobilifiimo S i
Wore sfacendone ven d etta convenevole k l u i .
jtìm p ero ch c non lo fece cader in amor d i alcuna v i
le ancilla. , come haurebbe potuto fare se a n js di
; * mille donne eccellenti riflejje u n a . Et cofi fece
leggiadra ven d etta . L a feconda parte nafce da
quefla, che fe Amore si vendicò cofi leggiadram cn
te facendo cader il Petrarca nell'amor di una f i ec
cellente donna , l'amor fuo , diuien p iù efivfabtlc.
il qual modo tenne ne la Canyon de i verdi pann i , s a in alcun altro luogo . Imitando forfè V ir g .
nel quarto de l'Eneida , dove Dtdone prim a che
Jcopra l'amore concetto di Enea a la fe rella , nar
ra le doti di Enea , accioche da quelle p ig i i efeu fatione.y quando aprirà il fuo amore , s a p e r m e
glio Jcufarfe ffen \a molto accufar Amore 3
ag«iun
g c uri altra parte; che nafce da la feconda s a c que
fid che Amore come ojfefefi vendicò„ Et nondime
no di mille offefe una fola vendetta fece , ma f i f a
ti fece a d ir che Amor f i u tn d ica ffe, ma aggiunfe
il modo della vendetta >dicendo celatam ente, m a
quantunque il vendicar fi d'agnato non fra laudevolc ■ pur rapò medicato coiai m o d o , ha vendo
detto la vendetta effere fia la leggiadra . Et tutto
il fecondo quaternario, s a primo T erzetto è fe lamcnte per difhiarar m eglio, come celatamente
Amor fi ftiffe vendicato » Poiché c o p d k ricreder
f he apertamente AmQTt n o tti' haurebbe ferito , s a
tl 8
E SP O S 1T IO N E
se ferir non lo poteva apertamente , adunque a l
cuna virtute era in lui da fcherm irfe. Et poiché
v irtù era dimofìra perche Albera non f i potè di lei
f r u i r e . V ultim o T e ffetto e , che ricor r t adobicttivile
PERDONO.
Valla pru den za tifiem e.
A . Colatamente riprefe Parco , non per vendicarfi vilmente, ma
c V a lca fo 0
B Per uen d k a rfì leggiadram ente,
Dir quefie f e g u e ,
che caduto in ae
nior lo dettole f i a
efcufitbile ,
C. Amor non effer d a
dannare, perche of
f e fio f i vendicò , 0
d i mille ojfefe con
g e n tile .
una
D.
D ichiaratiòne, o narratione della v en d etta .
A. Mette due •*L a cagion finale ava n ti ; imperoclie 9
battendo à d ir e , che Amore* ripren
d e re cehaamente l'arco sprem ette à che f i
ne ,0 pone.due f in i. V p rim o , •
t
Per fa r una leggiadra fu a v e n d e tta ,
G A I fecondo f i n e , FA
'esse ;Vi
Per punir in un d i ben mille offefi •
A. Cdatam ente A m or l'arco riprefe.
Comparatione.
D„ D ic h ia r a tile 9ove confitma il prim o q u a te r-
*
S O P R A ’L I L 5 ON.
iij
narìo . Imperoche mofira colai fiopraprendimento la utrlù rijlrctta al cere efferfi smarri
ta , cosowoti hauer potuto adoperar le sue
forzfi.
X l t im am ente ricorre nel? u ltim e terzetto a d u n a
q b ìe ttio n e , doue d im oflra y che ne a n e o ji p o
r i a iu ta r con la rag io n e
,
L’aereo.
.
v
A ttrib u ìfe e a d A m o r l ’a rc o , fecóndo
i l eofiume de g l i a n tic h i P o e ti , m a d i p iti fin g e
e li A m o r con l'arco fiu ffe S ialo n e g l i occhi d i
L a u r a cofi alle
67.
I u idi amor ch’i begli occhi uoìgea ,
Soaue fi eliogrialtra uiflaofcura
-v Dae indi in qua m ’incominciò apparere.
j:
....
E tfe r a ^ D o tm a che con g l i occhi\fuoi arsa
Et con Varco à cui fiol p e r fiegno p ia cq u i Fe U
pia ga é i l medefimo f a n e l Sonetto alle 61 .
Sem iuccio, il u i d i , e Varco che tendea
E t alle
74.
; *
Amor m ’ha pofìo come fiegno a Tirale .
Ripresa, quefio u e rb o fe g n a che ancor altre uoi
teprefo V h au ea .
v
"sa % "
G o m ’h u o m r ottim a firrìilitu d in e . E t accom
pagnò L u o g o C r tempo giudiciof'am ente , perche
l’ u no fienza l ’altro eff er non pu ò accomm odato
Erae la
m ia u ir tu te .
Questo q u atern ario
.
h a ta l
mente tenute fa tic a te le m e n ti de’ lettori , che a n
. im
, che se
- sa
cora n on rip o fa n p ìn alcuno appagam ento
peroche pa re del tutto, co ntrario a quello
gue in quella p a r ce che d ic e .
Xethponon m ip a r e a d a f i n r i p a r o .
'
• • "
* '
-* W > -
~
■H O
ES'POSITIONE
Contra colpi d'amor però ria n d a i #
• «
Secar fe rin a ./'off etto . E poco fitto .
T roiiarn m i am or del tutto di fir m a to , •
F f aperta la n i a tur g li occhi al core fa'1
* Se a d u n q u e dice efjere sìato colto da Amore ,
perche non li parca tempo da fa r riparo, il perche
Am ore lo trono tutto di-formata : come può di) in
qucfto . C 'haucua r (fr e tta la u irtu al core, • v
Q uando tl colpo mortai la g i n difiefe ?
M a*non ci daremo quella m aggior cura che pò
tremo , f e non di dire a punto la mente del Fefrar
ca , a lm tn di dire cofa nerifirn’le 0 n on tirata
per captili y metteremo adunque in m e\o due ef}>ojitio n t, acci oche di loro una almeno pojfa effer r i
c evu ta . L a prim a fa r a, che talhor quefio verbo
Jcffantino . Io fo n , tu f r i , quello è , fogni fica ritrovar fi , nella quale fignifi catione , 0 nel m edefim o tempo preterito imperfetto la pofi alfe 8 6 ,
i A lfa / tre dì creata era alm a in parte . ■ . *
Che fognifica yf i trono creata, m a in quefio
luogo ha quefia particola di tempo reddittua ,
q u a n d o , hi che infieme hanno tal relatione che
0 il trouarfi 0 il quando fa btfogno , che fia n o
urte fi itt uno medefimo infilante , come fe due correjjtro ad tino tempo , per g iu n g e r incapo d'una
pfrigga , e l ’uno f i f e g ià pervenuto quando l'a l
tro era nei m e\o . il umeitorepotrebbe dire . To
era n i capo della p ia n g a , quando tu g im g e fii al
m e \o , onero tu eri in rne\o dellapiafaga, quando
iogrunfi al capo di quella . Eccovi, co m e, quan
do 0 era , riguardano uno medefimo in fta n te>~
tiq v a lc relation di tempo , in m olti modi dicono i
•
oso O P R A ’ L I L
S ON.
i n
L a t i n i , m a d i r ò u n o ., d o v e la p r im a p a r te m e d e f i m a r n a n e è n e l t e m p o p r e t e r i t o i m p e r f e tt o &
V ir g ilio
.
V ix
C o n f f e f lu S t e n l a
e
t u m V eT a d a b a n t lo c ti
bant
.
s a
v u ln u s , h x c fe c u m
%
.
P erch e
.
J fU m a s f itlis a re
ru e
D o v e 3 C m n y f u p p le d i g i t ,
p a r la r d i G iu n o n e
q u e jìa (jp o fitio n e
« c rh o ,s a
q u a fi in u n o
T r o ia n i
r itr o v a r f i d e '
,
,
c o n le to /e c h e
tro p p o
s a il
s a il
in fa n te fu
d i r im p e tto a S ic ilia
d o b b ia m o a d u n q u e d ir e p e r
t h è i l P e tr a r c a n o n p r e n d i m io
p i ù g u a r d i a d i j e , J i c o m e a l t r e v o l t e f ic e a
«l si
di
C u ti I n n o a te r n u m f e r ii an s [u h p o ffa re
ItiV r e l a t i o n e a u i x c o l f u o
feg u o n o
e
te llu r is in a l -
, s a la ti
d i fe m e d e /im o , q u e lla v i r t ù c h e
J o h u a e j f c n a la g u a r d ia f u a ,
si e ra
g ià
p a r t i t a ; itn p e
r o c h e e ffe n d i! h g i o r n i f a n t i , i l P e t r a r c a
tu tti i
p f n f ic r i, con l i q u a li g i à f i g u a r d a v a d a a m o r e ,
h .it t e a r i u o l t i k l a p a f i i o n d i C h r i f l o c h e f i c e l e b r a
uà a li'h o r A f ì l q u a l r iv o lg im e n to d i p e n f ic r i, ch e
g i à J o le ita n o f a b r i c a r l a c o n fi a r i f a
,
e ffó n d o a l -
t r o u e c h e a l d e b i t o lu o g o y A m o r e c o lfe
s a
t e m p o a f a r l e fu e u e n d e t t e
.
M a
s a
lu o g o
a u e d u to f i t t ir
d i i l P e t r . d e li i n g a n n o , r i f l r i n f e l a a l l a r g a t a v i r t ù
d e lla c o n f a t i l a
f in ita a l core
,
a l c o r e , m a e ffa a llh o ra e ra r i
c i o è a l l h o r a u i f i tr o ttò r i f l r e t t a
.
Q uando il colpo mortai la g iù difeefe.
Perche s a chi difendeva , s a chi offendeva ad
un tempo al luogo da difender , s a da offender sa
ritrovarono. Ma q u ella , che douea difender f i
trovò f i sm arritagli e nonfeppe porger aiuto . Il
perche f i fu o l dire y ch'huom a jf 'alito è m e \o
perduto, ne pa ia nuovo q u e fo m odo, che a n
cora in urialtro Jenti mento usò i l Petrarca
F
n i
ESPOSITIONE
uno alquanto fim ilealle a 8 .
I die ea f ia mio c o r , perchepaventi ?
Mae non fu prim a dentro tl penfter giunto ,
d i i rag g i , ori io m i Struggo , eran p r efin ti.
Doue e una belli relatione. Ma non d i quefia
f a sa-
IL
F I N E D E L L A E S P O S I T IO N E
sopra il fecondo fornito del Vetrarcaf
GRAMMATICA
D i M. G I V L I O
Cam illo D c lm in io .
y a l y n cu E x ome appellativo , levando
ne aldini propri) , che nel
numero del meno term i
nano in f . Si come G io uanni prende del detto nu
mero per fine una di que
fle tre h o c ah che fcg u o n o , c io è. A , E , coso
O . Li q u ali seguendo pofiiamo dirittamente a f .
fermare effer mede/imamente tre le declinationi
de' r u m i,
D E L L !
NOMI
IN
A.
T u/fl lt- nomi della prim a declinatione , k
cui darete per fin e A. mentre faranno dell'or d i*
ne dei ma fichio , nel numero del più fnifcono in f ,
m t mentre feran no di f e m in a , in E, ef]empio del
r
‘1
114 G R A M M A T . D I M. primo . Il Poeta t lt P o e ti, delfecondo , la D ea,
le D e e .
D
E L L I
N O M I
I
NT
E.
L i nomi o fofian tiu i o a d iettiui chef i fiegio ,
che in e fin', fieno nel/iugulare numero , in i cade
ranno nel fino plurale . Et del fofiantiuo ni f i a e f
[empio la o p in io n e, le opinioni, la corte, le corti.
De lo adicitiuo , il felice Dio , s a la felice D e a .
Li felici D e i , sa le solici Dee . Ma rivolgendoli
alle cofe L atine , dovete fitp ere, che chi dtcefjt il
uiolenu lupo , come diciamo il leggente Intorno,
ingannato dal medefimo fuono , errar ebbe fenica
dubbio alcu n o. Conciofiacofa che o g n i uoltaghe
nel Latino parlare fi troua noce che ferve al m aJchio, s a alla fem in a, il medefimo auerrà in que
f i a lingua ancora , come f i uede manPfeflamente
in quefle uoci fe lic e , debile , capace , s a altri f i
m ili , che ne l'ima , s a ne l'altra, lin g u a , hanno
folo una defintnZa; ma comedi L a tin i haueranno
per qualunque fejfò una noce, partita s a d ip in ta ;
cofi l'hauera il Mitigare. Dirafei adunque i l vio
lento lup o , s a la violenta m ia fortuna , che fe fi
diceJJ'e il uiolento lupo , oltre che dal -berfaglio La
tin o ci d ij copi am o , la detta terminatione fi con
fonderebbe col plurale feminino ,ilch e non dee po
ter efiere per alcun p a tto . Et [otto quefio ordine
vengono tutti li nomi della te rfa declinatione La
tina , s a fecondo che alcuni anfano , tu tte le ter-,
m inationi di que f a lingua f i traggono dalli a lla
tifa La i m i ,fi-come il patte y nelfingolare^ ts a li
• G IV LIO CAMILLO,
iz q
patri nel p lu ra le , rimanendo dal ablati uo Latino
Pu tribu s, l'ultima fillaha bus .
*D E L L I
n o m m n o
.
^ N e h ' v l t x m a - terminatione d/ O ,
non hanno luogo i nomi d ife m in a >da que Jio uno
in fu o ri, cioè Manio Percioche o tu tti fin o o m a
leoline , o neutri L a tin i, 0 per fu g g ir ogni con
fusione, che ut potcff'e inleruenìre, non fa rà fu o
ri di propofttc il fa r d i loro treJ ih ie re , alla prim a
concedendo tre p lu r a li, alla feconda due 0 Jucw
cefiinamene e uno alla te rfa , 0 u ltim a , Rt pi"
gliando la prim a d ic o , che qualunque d i queste
tre vocali , 01, E** 0 A . li puole effer fin e y
detti quali il prim o a lti natura d i mafehio fa r i
tratto , il fecondo fen te d i f e m in a , i l terzo , 0
ultimo ffn c u tro d im o fìra ; u e r o f che dalla f i m i na fi pig lia per u ia d i prefitto L'articolo . I/ muro,
lì m u r i, le mure, le m u ra ,il membro fati m em bri,
le membre, le membra , il ginocchio, li ginocchi*
le ginocchie , le ginocchia y l'offo, li osasse offe ,
le offa, il corno , li co rn i, le cerne ; le corna. La
feconda , che appreffo feg u ita nel plurale feem afi
delti terminatione in E , della quale fono quefìi.*
Il dito , li d iti , l e d ita , 0 non le dite, lo Ttrìdo ,
li Tirid i , le T lrid a , 0 non l e f l r i d e , ile afelio,li'
ca p etti, le cafiella y0 non le . x a f i e l i e In quefio
ordine sieffo entrano alcuni a ltri ancora , ile a m - ’
p o , li cam pi y le ram par a , i l lato , li la ti ,,é?.le
la to r a , li ram i *0le ramora y H peccati y 0 Ìe
peccata . Appreffo d i D a n te i m a bene, fa rà > di
F
fa
I iK
G R A M M A T . D i M.
questi corali non tifare fe non il plurale i n i L ’u t
t i ma nel fopradelto ordine ter^o , suole effer d i
due m ani tre in quefio modo, percioche o ueramen
le il plurale ha naturale toso proprio , ò nero per
commutatione. E quando diciam o li cam pi,li oc
chi coso fim ili , cotah p lu r a li, finotnaturali , p frciochegia rie detto il plurale in I , tenere la natu
ra del mafehio : rna quando f i dice li fasfi Jt p ra
ti , cotah fino per comm utatione, che cofi come li ,
plurali di quefie tre noci rifa , oso quadrello , d i
ventano neutri fuori della natura loro , percioche
hanno in cofiume i c h ia riJ iritlo ri, oso illu firifii
dire , le rifa »le quadretta , oso non a ltrim en ti,
cofi li f a s f i, li p r a ti, fono mafcolini ferina hàuer
riguardo al fuo primo p e d a l e d a cui ef i d ife n
dono , oso fin o ra m i '. Occupano adunque q v e f e (juattro u o c i, in f id e , Vuno oso /assero , o per- y
dir meglio commutarla in quefia g u ifaS x quefia ■
ultim a fchiera , ri f i , quadretta , fasfi aprati . Eì
in cotalguifit fanno lu o g o .
‘
H acci etiandio uri altra compagnia d i n o m i,
l i q u a li, percioche Iranno il loro [ingoiare biforca
t o , oso bora in E , oso bora in A , finifeono , m e
de firn amente hanno il plurale , alquale. fe l'ima
d i due definentie conforme , oso correffondente ,
come la a la , oso la ale , la arma , oso la arme , la
fio n d a , oso la fi-onde , la loda , oso la lode . Et
appreffo d i D ante il lo d o . N e perciò è da dire
( per quanto io m i creda) che la v a rie ta te del ter
minare m i (ingoiare, babbi a fo rza di uariar la fi
gnificatione, fe non in quefia unica voce hifogno,
la quale mentre dentro h i term ini di quefia. defi-
%
G IV L I O € A M IL L O .
11 7
venti a J't ritiene , non ha bifogno d i mutar altri menti il fuo figntficato , ne altro importa, che ne
ce f i tate y dove quando f i dice b:fogna , quel vale ,
che u olginfelinamente chiamano t plebei faccen
da f s a che meglio f i pu o ti dimandare il fatto, sa
più l egguviram ente.
D E G L I
ARTICOLI*
Il nome mafehio defederà fempre ìnanxj b atter
nel fingolare numero un d i quefei I L , 0 L O .
L i quali nella fignificatione convengono , ma nel
la collocatione fono differenti : percioche IL .u n 0
le effer e regolatamente auanti a noce, che dalla
confo nante cominci yfoto che doppia non f a : m a
L O , ttuno di due luoghi b r a m a , onero d'efferprt
posto a noce incominciante da vocale 9onero da
noce incyritfhian te.dagem inata confonante yp er
te m p ra l'afprefza che rifultarebbe dalla incul
catione d i tre confinanti . Onde appreffo di que/?/ che rettamente parlano , r itro v a n te le p iù u ol
te lo Jìratio Et non ilJlratio , lo f f irito fa y 'non
il[p ir ito . Q uefio medefimo articolo L O . Suo
le ancora precedere molteparole incomincianti da
M . 0 da P . il perchefi trova fir itto , per lo mon
d o , s a per lo petto . Et in a r i\i ad N . fp e ff ?an
cora y per lo noftro cielo . Et appreffo d i D ante
in n a n zi a G.lo giorno f e ria n d a va .B o ccia r 11
a P. ha ufato lo la g o Et ca. 1 6y Per lo dilette
vole giardino . Et per lo bel giardino, Etcae. i 65*
Per lo quale, D I E L , non parliam o percioche
effi non c articolo fe m p lk e . m a compofio di E-,
F tese*
Ìi8
G R À M M A T . DI Me '
coni tuitione copulativa . E t d i I L . Articolo
fcrnplice . Et per cotale fi fittole tifa re. Onde non
farebbe da dire y E L Sig. D a ta r io e gioitane .
M a , I L Papa ,e'l Sig. Datario fono jfto u e n i.
Si hene . Ouero è campofio di E' /cr'saae per fona
del turbo fofiantiuo , oso del detto I L. L i b a
li ambedui compofii dal Vetr. fin o u f a li. dout
d ic e .
E del mio vaneggiar vergogna è 'ifiu tto ,
E* l pentirfi e'I conofcer.
Danno li/o p r a d e tti articoli I L . Et I /O .
per loro plut'àli.quefle quattro n o c i. I. E . L I .
G L I . Benché io mi creda il fecondo, effere nato
per la mutatione oso affinitadc di I. Et E. come
appare in quefia uoce difio , oso defio oso all'u lti
mo ni $*aggiunge G .q u a fìper im itatione G reca,
li quali ogni noli a y d ie dopo L. fig u ita ì .p e r G .
li pronunciano . N e t » quello che al fif&ficato ap
p a rtiate t fia loro alcuna diffenfione folamente
collocandoji, f i prende d iff e re n z a . Percioche li
due p rim i y confupimente inariZj a f if ia n tiu i, oso
/tdiettiui f i collocano >ma / due figlien ti più pro
priamente inanz) à fif ia n tiu i. Et l'ultimo in a n \ i a fifia n tiu i che da vocali incominciano . O n
de g li a n im i, oso non li animi diciamo >percioche
talmente dicendo , fuono troppo languido oso mal
pieno neh i ufi irebbe .
N e fòlio pero fiempre le dette particole da chia
mare artico li, percioche feruono alle uolte per se
g n i relativi oso per p ro n o m i. Segni relatini f a
ranno quando Significando alcuna cofit, come d i
p in ta dal?altre, fu o r d'alcuno uniuerftle come
s’ale uno
rV L IO CAMILLO.
119
[alcuno di ceff'c >non 'hauer vedu toU ti Theatro
[huomo ;gran differentia farebbe quefia yfcnz<t
dubbio >pertiochc nell'ultima parte ,f i dìm ofira
ri a alct^ìo huomo particolare , ove la prim a à tut
tìg li huomini[accom m oda. E tfe 7 m io g iu d icio
non erra.La dotte il Bocc. nel prologo del Occam,
dtjfe * Fra quali [alcun m ai nhehbe . Non bau*
r ebbe potuto dire f u i quali y percioche banca d i
fip ra confitfiimcnteparlalo , 0 non d'alcrm p a r% ticolarc : ma ben quel luogo mal fi legge . De li
accidenti d i Martellilo da N eiphile raccontati y
fenati modo ri fero le Donne . Et mafiimamente
tra giovani Filoftrato . n e g li antichi tefii yfi'a i
giovani f i légge . Et dirittamente r cff'endofi d i
Jopra conojciuto il loro difìinto 0 particolare nu
mero y come net detto prologo , oue f i dice . Eeco
intrare netta Chiesa tre g io v a n i y non haueniìo an
coni di loj^qfittto più mentione . E tanto fio, d e t
to , mentre retationc (ignif catto, quando fono prò
nomi y benchc datti plurali fo li f i traggono y a lIhora non in an \i à 1 nomi y ma inan zi a i v erb iy
0 doppo quelli pongono 0 conofionfi
artico
li y 0 pronomi fin o dalla fo la collo catione y nella
quale f i term ineranno in l . faranno pronomi ma
[colini yfc in E , fem in ini, come io li d ifitjn luó
go d i di f i a i v i . Et io le di f i , onero disfile per
quello che f i direbbe , dijfe a le i..
fi
D E L T I
,fi
P R O N O M I .
Q v i s t i cinque p ro n o m i, l u i , l e i , loro
c u i , altru i > non m ai nel dritto eafi>,pofii co uer*
V
y
T} o
G R A M M A T . D I M.
hi fi trottano , fatuo che li due prim i , che tali)or
col fo fa n tin o verbo i'accompagnano , fi come a p presse il (Vtr. s a ciò che non è lei ». One m anijefianu nte erra , chipcnfii di poterai interporre que
f a particola i t i . Veni oche la medefima fiu ìten\d
e nell'opre Latine del Poeta , con quefie p a ro le .
Et quidquid illa non efi . V ero è , che per rtiro uarft t detti due pronomi cofi r a r e fo Ite nel primo
risse, non configliare alcuno a dover fi porre in co
fi f itto modo . Diremo adunque per regola g e n e
rale,lì detti cinque prenomi efiere in enfi obliqui.
Et in qualunque coso fi pongono E t cui non
pure m ftngoUre , ma in plurale ancora
ma
quando i prim i pigliano quefla fillaba% C O . per
augmento in pri net pioteranno pronomi communi
Ììt tu tti li c a fi, d icen d o, colui se colei, coloro a g
giunge nifi ancora , che7 primo d'altrui è a t r i .
La qual voce yparim ente e commutryyd plurale ,
dico apprefio , che (piando fi ufiera quejh in fingo-'
lare , non /èra bifogno aggiungerli fo f i am in o no
me alcuno . A ltri Jo che ri bara più d i me doglia ,
Mae quando fi mutajfe I , In O , allhora diremo
altro huomo. La medefima maniera di fu g g ire il
fofiantiuo tengono . Q ue f i t ,s a q u e lli, ambiane
pronomi nel jingoiare . Qwosoi m'ha fatto men .
Sono ancora jrrGnomt s a communi a tu tti li c a fi.
Esco j Esse, Pilo , PAla. Q«esc/ a ltri pren om i,
M i , T / , M e ) T e , S i , S e . Non/c’iiosoJdifjeren% afi trovano mfieme collocati « Tercioche mentre
f ir ifjt m e lo fi trovano pofinnariZj al verbo , p i
g lia n o la terminatione in 1 , Come, M I mosfi y
s a quella fera . Mae mentre tra loro * cosa «jaeul*
. y y
, G l V L I O C A M I L L O . 131
posti a l verbo , una 0 p iù partici l:re u i $’interpoli
g o n o , non p iù godono di termina) e in L . ma m
E . Me non batteJU tu m a i . Verissima cofii t \
che taihor ancora , cusi immediatamente p e p i
inanZJ al uerbo , contro la detta regola Joglicno
terminare in E , quando alcuno di loro mene ,
ouero nella fig u ra , che rimo vendo una parte, po
ne l ’altra , 0 pone lu n a oso rimuoue l'altra.Effcm
p io. Rallegro ci afe una , me empie d i in u id ia l'at
' to dolce e fr a n o . Ouero nella fig u ra di congre
gation e, per la copulaùua particola , ma fi che
tutte le parti copulate vadano d i p a r i f i come in
quel luogo fi le g g e . Giudica tu , che me conofici
e lu i . D ico che vadano di pari t fe non in tutto,
almeno in parte , come là . Et me f a f i p tr tem
po venir meno , quando non uanno di p a ri .mani
* fefìamente tnu terafiiin I , la defineiifa . D i che
~ y p n uo ffiiiaUndo oso forfè altrui . Q uin ci paffan
do a (m fid e ra r, che terminatione hanno doppo
il uerbo , dico che in due modipoffono effer collo
cati ,f in z a meZo d’altre uoci ,o congiunti, 0 d i'/g iu n ti . Se congiunti faranno f f i che folto ta c " cento del uerbo f i pronunciano, term inar anno in
I : C om efem m i,diffem i.Q u efia regola non uale
quantunque volta i uerbo , con cui fon compofii
cade in alcuna d i quefle due liq u id e , L , 0 R ,
percioche allhora, Tuna oso l’aiira terminatione f i
piglia , com e. Earm i , Ea r m e , V arrai, Parme,
V aim i V alm e, C a lm i oso Calme: Ma f i di [giun
ti immediatamente f i collocano ,Ji che colfu o ac
cento , oso non con quel del uerbo fiano p ro fe riti,
. . cllhora in E , fin ira n n o } C om e, lo [e n ti me tiit¥
yj
1
7
,1 C R A M M A T . D I M . to ve n ir meno . 1« E , finiranno fem pre ancora
dopo It' propofitivn i
0
in to rn itio n i d i dolore . di
te , d i m e , d i fe , pe»* m e , p er Le, per [e,con le in
ter ie tti uni laffo me , m i/ero m e .
D E L L I
V E R B I .
«
«
Sipotrebbero» fare per attentura foto d u e cong iu n g a tio n i di ucrbri, che fi,de fiero à conojccre
dalla rerTa perfètta (ingoiare dell indicali no fon
q u e fia regola , che mentre il nerbo rncfhera b a
vere ta detta per fon a in A , ter m inante , come io
amo , tu i im t, quello ama . Si dica ejfcrc della
prim a : Mae quando finirà m E , come e, io le * ,
g o , tu leggi , quello le g g e , io odo , tu odi %quello
ode . Si dica tjfer della feconda . Et quefia opi
nio n e già alcun tempo ho portato , auifandom ipo
ter buffar il detto numero , di due congfijyationse...*
ch'ogni modo vede a che [io bau ef i voluto'feguire p/u inan-\i ordinando la terza 0 la q u a rta ,in
che c la m a g g io r d i d ifen d ere li verbi communi
con quelli della prim a 0 della feconda : ben m i
parea neceffario di fare alcune eccettioni d i pre
teriti perfetti dell'indi catino y fecondo la varietà
di m olti in fin it i , li q u a li ancora in eccettioni an
dati una . S i come per g ra tia di efftmpio y la doue
f i uedea le uoct dello in fin ito andare in ir e jn ip a
rena effer bifogno di. dire che la terga per fona del
preterito perfetto andava in I , ouero in Io . Co
rrie , g r a d ite , g r a d i, morire * m o r i, m o rto . Voi
dim orando con p iù [incera confiderai/ove fio ra
ciò , 0 neggend? , che quantunque ode 0 leg-
^
4
i
'
|
ì
GfVLIO CAMILLO.
135
g e cadano in una medefima uocale u tili toso.?
per fona dell'indicativo , h a m o nondimeno ,c w; //:<’
pr ef i n t i , e nell'infiniti u i la detta d if f e r e n ti , r/tl
fon mojjo a credere , aetnse ad aff ermare', che non
dilegua quattro congiurati uni- fa re f i debbiano:
percioche cofi cotali eccetrioni f i letterebbono td a /ido à ciafeuna congiugatione , quello che le f i con
uiene, Ne ci turbi lo firnith udine di detti fw tg io n
*
tini j che ne anco li L a tin i, benché uedeffiro il
foggiontino della quarta c/fere in molti fim tle a
quella della terf i , d i ordinare la terza diuifamen
te dallfaquarta ff rimafero . Direi adunque che
la p r im a , feconda , ter f a , s a q uarta co n g u g a
llone di nerbi ff corniceranno dalli infiniti u t IJir v ci oche t infiniti no in un di quefii quattro n u d i
può fin ire in Are , come am are, in Ere : ma in
'
due modi
con l'accento fu I'antepenultima, ce
1^6ere y fr ttu c re , 0 fu la penultima come te
nere y uolere. Etfinalm ente in ire y come u d ire,
fe n iir e , perire. L'infinito in A r e , fa r à fig li*
che'l nerbo fia della prim a; quello in Ere, con i'ac
' cento fu T antepenultima , della feconda'quello in
Ere x conTaccento fu la penultima-, delia te r fa %
quello in Ire della quarta . Solo adunque l’infini
ti no ci darà à conofcere la congiugatione del ner
bo . E t con la term inatione della te r f a perfona
[ingoiare dell'indieatiuo, la.ccnfid'erationc d i cui
non fera però in tutto una ♦percioche quantunque
non fa rà atta à m ofrare la congiugatione, ferri,
almeno di tale utrlitate , che quante uolte li nerbò
in tal perfona conuemranno d i terminare. e
mrcinm aticoriLparimcnu ia tutte. U ttaci d d jo g g
.
fi
IJ4
G R A M M A T. -D I M.
giu n tin o . Segue adunque la prim a in quefio
modo .
Jo amo , tu a m i , quello a m a , noi amiamo .
FJ quefia ucce benchc fia del fuggiontiuo , pur an
co nel? indi catino su fa , Et la propria uoce, che
farebbe y amerno , non c ricevuta oso è da confìtte rare per u n i iterfide regola , che f i come la feconda
[ingoiaregode d i term inare in quefia uocale I ,
cofi la feconda plurale in E . Et ciò auiene in tut
t i l i te m p i. lo amano. , tu am am , quello am atta,
noi am avam o , noi arnauate , quelli amavano ,
A me pare che l'ufo d'hoggi habbia ottenuto, che
la p rim a ih quefio preterito inperfetto termini in
O , oso 4
iccfi amavo , oso usasi ollr.t di quefio d i
porre la feconda del [ingoiare in luogo della fecon
da del plurale , cioè atnaui > nolendo fìgtiificare ,
a m a v a te . Io per me g iu d ic a r ti ottimamente fa i
to il fegitire in ciò g li antichi y mas/nha^ente si
Vetr. oso il Bocc . i l preterito perfetto ha ùÒci di
ire m aniere , percioche cltra quefia y io am ai y tu
am a(ìt quello arnoe, oso amò . noi amammoyquef ia fincopata è , da* buoni autori riceuuta, non
l ’intera ama fim o , uoi amafie , quelli amarono ,
non amoro y come alcuni dicono . Si di flende a n
cora ni due a ltri modi y cioè coi prefente v oso col
preterito di quefio uerbo ho y aggiungendovi quefio propvio participio amato . imperoche si tro va ,
io ho *nnato y oso io kebbi a m a to , oso quefio ulti
m o è molto in ufo ferina quefia uoce ypoi che cofi
D an te . Po i ch’e i , pò fato alquanto il corpo la ff
- Ne fa bifogno altrim enti p er ogni per fona decli
nare quefle due m a n iere , percioche chi faprà de >
.
^G IV LIO CAMILLO.
137
clinare ilprefen tey'lp reterito di quefio verbo ho , ‘
aggiungendovi fempre il participio amato , per
fe medefimo f i fapr'à nell'ima
nell'aura regge
re . fai nel uero in quefìi due verbi fin o ,
esse,
tutti li p reteriti.
p iù che perfetti d'altri nerbif i rifolvono. Et coso] come in quefio uerbo fono
quelli de'p a ffiv i , coso in quefio ho quelli d e g li at
tiv i m Segue il preterito p iù , che perfetto d a d i
fe n d e re : m a chi fip r a declinare il preterito im
perfetto dell'indicatiuo d i quefio uerbo ho * Cofi
io haneua , tu Jhineui quello hau e va . Et a g g iu n
gendovi per ogni per fin a quefio participio amato,
lo d ifen d erà g en tilifiim a m en te . io amerò , tu
amerai, quello amerà noi amaremo y uoi am aret e , quelli ameranno .
im perativo , L o Im p e ra tiv o ffe ffi volte c o n te
fu e noci f i co n fig lia ,
effhrta ama t u , a m i quel
fio , am iam o n o i, am ate v o i , amino onero am e•no g fte lli, am erai tu , am erà quello , ameremo
n o i, amerete u o i , ameranno quelli,
D efideratino. N el defideraiìnó fono da pro
nunciare tutte le voci con affetto d i defideriogran
1esse ama f i io y onero facejfè iddio , ch'io am afii 9
amaffe . Ma quefia feconda è de' ?cetì,a m a ff i tu,amaffe quello 0 amafii: Mae quefia feconda
e Poeticae, am afii mo n o i, ama/le u o i, amaffero >
onero ama fim o quelli,
quefic noci,ha commu
ni con quelli d el Soggiuntivo y hauefii amato , esse
onero faceffe Iddio ch'io hattejf »am ato, che tu h a
. uefii amato , che quello haueffe amatoyhe noi ha
ve film o amato, che voi havefle amato t con l'altre
0
0
0
9
0
0
0
fecondo t i r e g o ti dJmofhatct d i {opra d i’ave f i &
13S
G R A M M A T. D I M.
verbo , ho . Ami io , am i tu , aewi quello , onero
rime , am iam o noi , amiate u o i, amino , ouero
ameno quelli : m.i quantunque le uoci di quefio
fu tu ro f i ano communi con quelle del p r e fitte del
Joggiontiuo, nondimeno a tutte quelle del foggion
tino nel fingoiare y è lecito potere confufamcnte
terminare in Ir oso E, che a quefia del futuro don
è fim pre lecito . Soggiontiuo ch'io a m i, 0 ame ,
che tu am i y o ame y che quello am i y o ame , che
noi am iam o , che uoi am iate y che quelli amino o
ameno y e ragione è y che nella terTa plurale f i
troui I , attero F y percioche qualunque dt- loro nel
la terZji [ingoiare f i tr o u .i, tl preterito imperfetto
ha di due maniere uoci da pregare: il perche eiafcuìu iper fe difenderemo; fe io amafsi ,o amafj'e:
m a quefia feconda è Poeticat fe tu a m a fiije quel
10 am a)] e oso amcifiiym a quefia feconda è poeticay
fe noi ama]timo o amaffemo , fe uoi-mmafie , fe
quelli- am iff ero . so amarci y o ameria y urgimerejhy quello am eriay o amerebbe, noi amcremmoy
uni amerefie , quelli atneriano y oso amarebbono
11 perche s i comprende , che ameria è commune
alla prim a e t e r \ a . 1
Ichepotrebbe auenire anco
r i ad ama f ] e ypercioche talhora appreffo i Poeti
nella prim a perfona m E , fi ritro va y non a ltr i
menti che nella terZa : mentre y o p t i ch'io habbiet
amato , con I'altre uoci y con la regola fu data .
S'to ìfatte f i amato e baueffe: ma quefia feconda è
pi elica y p u r conia detta regola • Et perche in
due modi , quefio p iù che perfetto, preterito fipuò
p ie g a re , aggiun ga/} quefio. Io b a im i oso hauri a
amato %tu baurejk amato 7
quello hauerebbe am a
to oso
» G I V L I O C A M I L L O.
137
io 0 hauer i a , noi haueremmo amato , uoi haue
repe amalo , quelli bauercbbono , 0 Innieriano
amato mentre 0 poi ch'io ha uro amato - Infiniti
vo artiere , bavere amato , per dover am are.
»
VERBI
IRREGOLARI.
I V c r i i irregolari della prim a cangiugati-one
% predetta fono q u e fìi. D O , S T O , F O , liquali quantunque habbiano Vinfinito in Are , co
me d a r e 3Tiare fo n te , non hanno per tutto ciò il
preterito perfetto dell'indi catino in A I , come
a m a i, che D O , ha diedi , fio , p e tti foo feci *
Et talli ora nella terza feo . Appreffo e da fapere y
che ne anco hanno le voci di foggientiuo , come
quelli della prim a congiugatione : ma quelli della
feconda y 0/e r c o n f ig u e n z a dell'altre * D efqttol
-f ig g i offi tuo a l fu o luogo f i darà regola. Et li dot
ati trm ie rb i, D O , ST O, FO, convengono con Poy
Vo , So j Ho , in due cofe , cioè nel foggiontiuo
predetto , 0 nel portar doppio lo N , non fo la mente nella terza perfino, plurale del fu tu r o , fi
che fan n o tu tti g l i altri d i qualunque congiuga
tione ancora : m a quelle della ter'Za plurale p re
ferite dell*indicati uoy perche f i dice 3
quelli dannr 9
fanno , fanno yponno , vanno , hanno , fanno ,
Ì E L L A
S E C O N D A
confa ugatione,
I n d i c a t i v o . Io veg g io y tu uedì 9
quello u ede, noi- ueggiam o , 0 uedemo y
0 que-
fj l
CPv A M M A L D I M; *; V
/tif ili'v e r b i delti feconda hanno taihor. apprtffo
Foetì ottenuta quefia voce propria . c o m e . V N
fo t conforto , oso bellae morte hauemo . Voi ucdev te , q u d ti veggono . .Et regola generale è* che la
te rlfi plurale perfona ddV indie attuo .p ig li nella
firm a i! on f t a le lettere della prim a fmgotirefael
medefimo modo : quantunque I'altre perfine d i
m e \o vari affero ; come io efeo y tu efe tin e llo efie,
noi u f i amo y uoi ufi i t e , quelli efeono . ìo odo y
tu o d i, quello o d e , m i odiam o, uoi udite y quelli
qdono . lo u i d i , tu uedefii y quello uide, noi itedemo y uoi nedefie quelli videro y a g g ju n g a f an
cora, quelli a ltri due modi per quefio uerbo rifo luttore , oso per ilparticipio ;f i come fu. detto nella
prim a congiugatione. Io ho v e d u to , oso hehbi
ved u to , io netterò y tu netterai, quello n e tte rà ,
noi netteremo uoi netterete , quelli netteranno .
Im perat• ucttì tn , veg g a quello , j t effigia tgo noi.fm
ùeg g late uoi y veggano quelli , netterai iùTpjtettem
rà quello y netteremo n o i, netterete Hoè \ netterà#,
no quelli, Defitteratiuo. nettef i i o , euetteffe
poèticam en te, uedefii t u , uedeffé y
nettef i
quello y mttefiimo noi , uedefie uoi y àetteffero oso
uedefiino quelli y hauefi'io v ed u to , hauesfi tu v e
duto yhauefJ'e quello veduto , hauesfimo noi- ucttu
to , bauefie. uoi veduto ,haueJfero quelli veduto .
Soggiornino : ch'io n e g g ta , o v e g g a , che tu v e g
g i , o u e g g ie , o v e g g a , o n e g g jà , che quello u eg
g ià o uegga > nel qual prefente f i ite de ,ch e il ter
minare in a y è à tutte tre le perfine commune ;
m a netta feconda è proprio l , oso E , che noi v e g
etiamo , che noi ueggtate, che quelli neggiano , o
•GIYL 10 C A M I L L O .
135?
ti e rg an o . Se io uedcsfiy o urne fife Poeticamente,
fe tu uedesfi , f e quel uedejfe > o uedésfi poeticamente . Se noi uede.fimo , / c voi uedefiefe quel
li uedejfiro. A« g ì unga fi ancora que fi a feconda
guijCt dt p ie g a re , io vedérti y o uefleria , o uede-rehlc, noi Mederemmo y noi uederefie , quelli ve
deri ano o uedereboono, mentre io li abbia gu bah
hi y quello babbid veduto y mentre noThabbicirnof
% noi h.tbbiate , quelli babbuino veduto , s'io ba.fa'
uesfi, o hauéffe veduto,s a coft i l rimanente fecun
do la form a della p r im a . I ufiriniuo : vedere , ha '
uer veduto y per dover u edere
.
VERBI
IR R E G O L A R E
'• V e r b i irregolari in que f i a feconda congiura* ,
tione non sapidi affegnare, perche cia fcm ó q u a fi/
alcune ha proprie nel preterito fierfettódeìT im licaf
km /far nel foggio n tiu o , che «edere, nel preterito
perfetto f i u n ii: nel foggiontiuo v e g g i a , potere
nel preterito p o te i, s a nel foggiontiuo p o jfi: uo* '
lere nel preterito volli e uolfi : nel foggiontiuo v o
glia ; tenere nel preterito tenni : nel foggion tiu o '
tenga e tegna , Sapere, nel preterito feppi : nel
foggiontiuo fappia : tacere y & giacere : nel prete- ■
rito tacquise e g ia c q u i, nel foggiontiuo taccia %
& g ia c c ia , s a solere non ha preterito : m a ita
fua uecefi/itole ufare fficbbi in cofiurne : n e lfo g - *
gìontiuo foglia *
•
;
' cogntugatione .
> , '•» V»
,.
v e •
lo ferivo y tu furi iti, quello fe rin e f n o i ferin i a
pio y uoifcriuete %(inetti ferì»eoo , o f e r i v a t e io
ferine v a oferine . tu feri n e v i , quello feri u e o a ,
mifcrittCM am o,uoifcriu(uateyqudltfcriu eu anoy
uoi Jcriuejìe 3quelli f a i fiero Yo feri/ferio ) o fari f i
fono : to hauena ferino , io ferm erò, tu ferm erai,
quelli fermeranno . Imperativo, ferini tn y ferina
quello, fermiamo n o i fcriuete uoi,fermano quel
li yfermerai tu r Depilerai tuo , fcriu efri io , O*
fcriuejfe Poeticamente Jeriuefi tu y ferine fio quel
lo y oJcriuefse Poeticamente, ferine fiero o ferine f i
fono q u elli, hauefi'io f r ì t t o , t u g y quello batie/f*
Jeritto , hauefììmo noi', hauefìe uqj- ) haue/foro
quelli fcritto , ferina i o , feritii J n , feritifojuello
ferivano quelli * S ogg:enfino, ehVa sirtnesse e//?
?/t fe rin i yfc r in a , ferine , che quello ferina , che
quelli fe riva n o , perche alta g ù tfa d e g li altri ha
due maniere da variare Jo piegano p rim a tnxn a,
p o i nell'altra . S /o fcriucff'e y oferi uefit f a prim a
y è poetica , se tu ferm e f i , fe quelìò feri nef i , o
fcrinefi'e, fe noi ferine f i m o , oferine/]ernofe quel
lìferiueffero , io fcriu e re i, 0 fc riu e ria , t/i-fcriuer e f i , quello ferm erebbe, quelli feri neriano y o
fcriuerebbono * Il rimanente f i d ife n d e al modo
detti precedenti. I nfhitino fe r i nere, hauer fc r iti o >per dou er feri nere .
,
a
,
,
G IV
LI O CAMALLO.
141
V E R SI I R R E G O L A R I ;
N & anco in quef i a faprei bène spegnare ner
b i irregolari, battendo quafi , ciafiun preterito
perfetto proprio s a li fo g g i ont i ni regolai r . Ler
cio che f r i nere fa nel preterito feri si i , s a nel Sog
giontino ferina y le fii? legga yp o fi 3ponga , ren~
' d e i, renda . '
" se
Q V
A R T A
•T I
C O N
O N
G I V G AE.
Io fin to , tu fe r iti, quello ferite, io feriti i t a ,
io fenti-j, in f e n tif li, quello f e r iti, <?fendo,quellifin lìro n o , ofen tiro, iohau eu afentito, iofinttrò„
Im perativo , fin ti t u , fin ta quello.Optatiito fin -,
tifin o ^ofintefie poeticamente f in tif ii quello
%ppeticfirncntey c fentefi'e ,fin tifiirrio ,ó fenteffemo
n o r,fin te f i ero, 0 fenteffouo quelli,hauefii io f i n
tilo , fin ta ' io , fin ta tu , fin ta quello. Soggiorni*
uo ch'io fin ta , che tu fin ta y macpùefli uerbifac
d o y ho , voglio s a poffe, hanno ancorà in quefla .
feconda perfona , che tu facci ", babbi > t/ogli e posi
f i . S'io fe n tifii , ofintiffe poeticamente , f i tu
fintifii- ,fe quello fentijfe > s a poeticamente , f i n
tif ii . Cofi il rimanente a lla g u ifa de 1
precedenti.
Infittitine fe n tire .
,
‘oso’se •• oso'
V E A BsosoRR E G O L À Roso* ■ ‘-"oso
RA g i . o. N farebbe che t u t t i i n e rb i detta
I 4i
G R \ M M A T . D I M.
r
quarta ypenite hanno Tinfinito in Ire, fa ce fiero
il preterito in I , ouero m io y come fentire, jè n tiy
e fieniio . Nondimeno fon quefli che cofi non fan
no , venire » che f a uenne y d ir e , che fa difiè y
aprire eia j'a aperfi o apriti e f i fioggiontìui delti
quali fono tu ttiyfin ta y mora , oda ; perciochf O ,
in V , non muta fe non nel? in fini ttuo . Vd/re , e
participio udito , dica , apra yp era : ittic h e yfe
condo il mio g iu d ici o quello infinitivo dire non fia,
proprio : maJmcopato da d icere.
D E L
V E R B O
I N
g li a ttiv i f i n film ilo .
C H E
I n d i c a t i v o ho f a g g i o , oso apprtffo
D a n te , habho , hai y quello haue } ouero ha , noi
hauemo ouero habbiamo , lo hau ea , o h a u eu a,
quello haueua y o hauea . Io h e b b i. E t if>preffio
ii Ferrar, io havex : ma apprejfo Dante perfinco^fC
pa del primo bei ; quelli hebbero , o hchbono . lo
haueua hauuto y cofi in fc medefimof i rifotite. Io
bavero , uoi haucreie , oso harete perfincopa.lm
peratiuo babbi t u , Defideratiuo , hauesfi ioy hauej]ero yò hauefiono quelli y hauefit io hauuto, i n
se medefimo f i rtfilue ybabbi a io yb a b b i tu. bab
bea quello , habbiamo , ouero habbino quelli y e
b a g g ia n o . .Soggiornino ch'io hagg*ay o babbi a y
che tu haggi babbi e , oso babbi a y quello h a b b ia ,
o h a g g ia , che noi habbiamo y o haggiamo y che
uot babbiate y o (raggiate, che quelli babbiarto ,
babbi n o , o baggiano Meglio è da dividere nclJ t due m aniere con la g n i fa d i difendere quefio
14$
€ IV LIO C A M I L L O .
preferito , (i comefi è fatto ne' precedenti p u n ta ti
mente . I nfmitiuo bau ere & h a u er, come chef i g lif i caricelicosoae , -hauer hauuto si -
«‘ ‘V E R B Q L N C H E L I P A S S I •
•
-W se rifrittone .<
■■lo fin o fou f e t i quello ce {onero è , loerae ,
fio fui"y q w lio fu e y n o i fum m o , lo e r a Tlato in sa
medefimo f i rifoltte ; yvfero ) 0 farò' 0c.im p era t,fiu fia . Defìderatiuo fofit io , ofoffe poeticamen
te:y foffe quelli* y ò fofltpoeticam ente f o f imo noi,.,
fofjcro, 0 fofl'enoicpttèllp ff i f i Tiratoio , fra 10 , / s
t u , s e a e quello .
Saggiammo ch'io f a y che tu s e / f
sieUuseae.*TE' pur ynsep. questo, d à . dividere nella
predetta mani-era fu ti talmente ; -hifin iti ho 'effere*
*effereTiaio *„isis 1* .,
W !/ A
Di V
E
G«>•*■. •
A
r
[.
s i
-
TI i g -otti r h u c qua , iflie c o fli, ifiuc cof i n y
Ulte li y llu c -la y q u iv i y u b io U e , quo dotteyn b t- ■
cunq; OJHtnqy, quocunq?douunq; , h/ne quinci ,
f i me. cofi u n i , tl/ie q u in d i, inde indi , «nde oitde , donde , aliunde altronde , thi i v i , alibi 'a liroue.
■4. '
'
Q uefia particola . N E ha fignificatione d i *■
aduerhio locale, mentre f i accompagna'con nerbo
frignificante moto,: c o m e , ne porto, m a e dubbio, ■f i fignifica de luogo y ouero ad locum : mae sa se •
accompagna con verbi nonfignificanti moto allho ■
ra ha inchìufr E x y chefigiufica m a te ria , 0 db
>.44
G R A M MA T . D I M. -
quella cofa y dt che Jì ha parlato y come s'to d i • c e jìt, piglia quefia cofa y oso nc f a amilo che ii
p,,ICC f a
Q u e s t a pitrt i cola C I . talhora , olir a che f i g a i fic a quefio pronome n o i, fignifica ancora que.fio adtierhto locale , q u i , ciac, h ic, 1/ per eh*, m a i
tre cofi fignifica gioii f i può accompagnare con qui
t t i , ma con q u i, ne et turbi y che f i troni taihor
terminare in quefia vocale e. cofi C E . percioche
in cotal vocale termina , mentre tra il nerbo oso
essasi interpone alcuna cofa , fi come fiele aucnir e alti pronomi, dalli quali al fitto luogo habbiamo
Q u e fia particola V T. olirà che fig n ifica quef i c pronome uoiy taihor ticn fìg n i fi catione d i que
fio aduerbio locale J V i . il perche è da notare
leggendo y che o quefio, o quello fignifica ; ne m a i., j
abonda come s'auijano alcuni .
,
i
^
R E G O 'L A
E T
per Alfabetto .
M O D o
A v. Si muta in O . audio e d o , aurum o r o ,
aura ora , lauro alloro, laudo lodo , gaudeo godo.
Et rimanendo lo A . netti p reteriti di Audio , e fa
u d :>udiuayfi rirnuoue lo V.Et reftalo A.aufiulto
afiolta yf i rim uove totalmente la A . arcua rena y
a pagliapu glia , arcigni ra g n i. h i compofii onef i
cangia in E. amico y nemico . Et in V . falfit y
uff alfa , . V? I . h abeo prohibifico. Si pone in
luogo
!
• j
;
i
j1
j
'
'
*•
k
' G ì V L IO C A M I L L O.
14?
luogo dt E , g io v a n e , gjcuene A , t» O yf u i f a n
j
fodi sfare .
........
B.
in V .fa b u la fattola, ib i iu ir cabaRo cavallo
habebam hau ena y tabula tavola , aihi awe B , tti
luogo di I grem io grembo . B, totalmente fe*r i m o n ef obfeuro ofcuro , objeruamìo ojferuando «
■
abfeondo afeondo y V>, fi duplica B , dubium dub\ , ^ bto , deheo , debbio , ribbia , fib b ia , fabricatore ,
abbietto , abbarbaglia , crebbe i perebbe t nebbia ,
oggetto dicemmo ancora da abbietto.
j
\
r
y
n
>
se
i
C
‘C . ni luogo di G , fa tig o cafeigOyfatico cafeico.
0 . si duplica giacies giaccio y faccia , placeo piac
cio , cofe i verbi, che terminano in ceo , s a m rio,
netti fu tu r i d e g li optativi , s a netti foggion ùui in
\
tutte leperfone yC numeri raddoppiando il.C tfaC
se fr 4 , taccia f fa cei ta c e i, nelprefente filam en to
• ^ sg d d fe p ia nella prim a perfona jacio, faccio y tace*.
taccio , saggiu n g e a q u a , acqua , eimene fan fio
fanto .
D
D >fi rivolta in duéKG G„ cado c a r d o , video
neggic yfideo fig g io y hodie hopgi ,si dupplica ,
fieddo f cadde , preterito D ,fip o n c in luogo di T ,,
latro ladro y madre , nudriuo y l i d i , tm p cra d o ri,
ctade , honefea.de t grado yfo d i fe r e . D . in luogv
d i R. raro rado , radeu ole
in luogo d i N .
rendo reddo.. D quando è inpropofetione con A ,
s i muftì nella-iettera con che fe accompagna , acciò
timoni{co t appago y a rrivo •. T u tte le R E , s a '
V E yittcotvppfnione f i mutano i n i , ri iterf i , r i * '
Q
T4 S
G U A M M A X D T M.
( t w , r motto > d ifìm g g o , dimando y nondimeno f i
raccomandò , refìo , racqiiìf! o y raddoppia jraffron
ta , rappelhc, rasserena. , raffigu ro, raccoglie,
racconto, rallegro y refiauro , e refioro , d efinito y
refiu to d o m a n d o oso demando , oso adunando t
trono s ragiona v
;
'•
sa
-
E
•-
;•
- •. •*,
H .st muta in T. meus mio H , m olte volte t nel
futuro dell o tta tivo oso fioggiontiuo f i trotta l yper
£ , E per l. Petr.
- ssevosaoso
T u che da.noi Signor mio \ti ficompagne y Sa
pone in luogo de 1y firfir degna y a n g ela , filu a ,
legno , wmri , vendetta ; vergo y le g o , facc^/se-,
tr o , nemico . Et t« luogo d/ S. scompagne come
detto habbiamo , oso s id e , osoesedri* Dante ,.. ,
;
Guarda com'entri y come tu ti f i d e . S i , r infoue hattre , Capre , werlrò copre* potrefli, cede»,
fia , oso chiefa y m luogo ,d i A confacrabo, confa-:
arerò, senza sa ri^ a * - -v
oso-v* ri- v
: . ■:* C ve •saisser' sa\.
.
G . non può Sfare in mexjy k due N , p o n e fifer
M .fom no fo g n o , ow/tt o^ n i, ponefi per Q s s e g u ir e k seq u o r, d in a n zi a L. f i interpone G . L i
g l i : oleum y aglio folco fo g lio . Diciamo ancora
scoglio vp ig lio , g ig lio , artiglia ,- f ig lio , esnseo ,
sveglio , efiiglio ; ove nonf i profienfie l y benché f i
scrina : doue f i duplica trono I fo to ,S a p p i che ne
g l i antichi libri non s'interpone I , rnae fi ferine y
configio yofiglo E , in-egljy come quegli,occhi v
hense occlri, finse >;capelli p iù fi'eqm ntem enteq
m a per f o r \a della rim a trovo difiefo eapegli, mi»
g tio r a , oso cofi'miti nomi che- ra ddu pticam L L*
\C I V L I O C A M I L L O .
147
non f ìp o n e , quelli y ribelle colli y trafittila f i chip
plica G . posto in meoso a due noeA i ràggio , ieg».
g l / uia^po ggc.nondtm cì.ojl dice privilegio y in-:
dugio y refugio y ligio , agrada y aguagi fa'G. f i
pone in- luogo dt C. precor prego -, lacrima lagri
ma acro agra , craffii graffa ; Si rimane cognoJco conofeo {regina r e in d i D itta n ti ad I f i pone G .
ìo cm g io co frugum g io g o , No/oso nclli. ltb ri an
tichi lofean i, in ne.fa'
dittione f ip o n i tifa n fgrìn,
cipio m a f i legge o g g i.
:
H
“ ■
A g g tw g e m o H , non per fare p iù graffa la
pronuncia y ma p i ufonante,fa tig a y faughe ychej\perche hard- fomite suono d i G ,it i interpone Hsa
e riefd tig h # , cofi vaghe, p rieg h i, occhi, bianchiy
quefio. accade in E , con E, 0.1, e fim iim ente ne g l i fu tu ri d e g li o p ta tiv i,
fe g g io n titi, di
che , preghi sacci- ne , (sir cosofanno m .esse, q u e lli,
•nse l s f i n i t i terminano in Are ., se hanno G , <?ue~
rsaii , corte o , secchi, secche , arifchi arri fin e y i n .
luogo d i L yponefi G io ia m o chiamo, c tir o ih ia
ro * Si ufa in m olti nomi\t 0 verb i „ E t perche,
•non fi p u ò dare regola alcuna;; noi ne porremo pd
recebi frequentati nei V olgare y ho triompho y t i
berini!} 0 , htimore , fian ch i y T he soro y porchi y
homero sifia n ch i, hora y herha Icthe , honora ,
Alh ora occhio 3
humano Y
0 a ltr i. sassi , .
0
0
In luogo di In, aessai «-olle si pone E y per osoV
vocali amicifiirne yxom e V , 0 O , come.è detto
in 51H , d r de , in compofitione intro y 0 entro
moke uoltr fi pone J, a va n ti a l E }0 lo accampa*
y0
G
f
14$
G R A M M A T . D I M. , o
f na cielo lieto piede f i rimoue qneta ,f p ir to , Spè
gna , I U ffa «na dice it Petrarca . fa4«giunge con
G , s a D , ignudo , iddio ,
K
^
K .n o n dn fa , benché K a r o lo , s a K cd e ito bah
b iam o , s a K a le n d o , s a K.alumnie .
.
L
L. si m uta in T , placeo p iaccio , p lu s p iù * Ssa
du plica H annibale per la r im a , m eltefi p e r K ,
utneno veleno , f i ri/ucue , qu elli q u e i fa
*
M
M . f i pone m a n z i a ? , e G . E t quefle lettere
fingono N , cosi am an o in tem po f i pone per N ,d a
nutrì danno dom in a , dorm a.M , f i m u ta iti Vanum e
rare n o vera r e S 'a g g iù g e C ap ito liu m C apidoglio .
N*
■\ 1 0
N . entra i» luogo dt 0 . occida an cid a s 'a g g iu »
g e , afe ondo n a fo n d o \ f du plica nelle te r f e p e r Jone fa n n o y UiWno .
O
O . s a V , Lamio tanta affin ità , che l'u v a , s a
Valtra commodamctitefi pone , ubidire , molto ,
fioko. g r e . In luogo d i E., de nere douere , in lueg o di A , f id i sfaref i legge in profa .
•
P
P si c a n g ia in V , opra cura , Jòpra [àura , in
T yfcripto f r i t t e . si dupplica , doppio , tro p p o y
tta p a fio ,p e r cvmpofitiane di p a jju s L atin o .
Q
* Q . in G, fè q u ir e , fe g u ire ffi m u ta laqueus lac
ciò , c torco d a torqueo dice D a n te , R a g g iu n g e
■ella q u e l l i .
'
R .ttf
„
f
? G I V L I Ò C A M I L LO.
;
.
R '
14*
....
R . in N jferno fitm ? : ri/D ferire fid ire v in
I , moia mora yf i lena propria propia J i duplica f
trarre s p o r t e .
s
•
S .s 'a g g im g e sfamilo y sm o rte, osoriri?.
T
T./Twufae in G y ratione ra g io n e , tn D , [bit
ta faada , in luogo di S , fp a rja [ f a r la , oso wj lu#
*» 'Io di C » noIT/e ?Io/le,
V
VA» E , come c detto in O yfolgore , in T r o t
titi uolio yf i rim ouefaceva fa c z t - ?interpone in
nanzi a d O y huomo y lu o g o .
X .
. /
x . s i c a n g ia in uno S , effe fio, e ffe tto , in'due t
d ix t dif a .
.
* '
Y --sasasa'T ofcani m a i nàn Vusano t oso fochi altri >che
^Mièbrar lingua scrivono .
>
Z
Li moderni dà nofaro tempo Jq dupplicano fir n p r e , quando non g l i è altra confinante mnanZ* ,
ma foppia ciafcuno che in altri libri antichi f i tro
v a in meZo di uveali f o la ..
IL F I N E
D E L L A G R A M M A T IC *
d i M . G iu lio Qarmìlo *
•.
s
a
v
»?
1 O intefo del fecondo d a u ‘ no , che V . S. hae sat/o in
' I quefio anno . Ilabe rm ha
f ì 1J
.
; j aggiunto tanto dolore,quan
%l lo potea capere nello afflitto
! petto p e r la morte del SigJ?,
Il Antoni otto , pur che bab
b i a potuto trovar luogo per effer occupato il tutto.
N e vorrei g i n , che la Signoria del Magnifico P a
dre, o V. S. cadefjè in quelle d iffer a iim i , che w
tendo e f f r it le uoflre amar il udì iti- f i vicine „ che
non volete ricever alcun conforto . ìmperoche fòri
*certo, che , oltra che non piacete al S ig .D io ,p e r
non v i voler conformar col voler di S. M. tv tb a te
co fo fb iri, s a con le lagrim e vofire iltranqu illo
Tìato delle ben locate a n im e. Era bù i ragione
che! caro fratello d i V» S. non contentandofi d i g o
d e r filo la cclefic helkZgjt } damamiaffé dfai $*g.
esse' esse
.
\
w d el tuito una dolce cornò
gh
E r n on
i .aO
esseia de' Jesser»r .m
hi nolendo p riva r del Sig. Padre per effer troppo
acconcio à f ì t t i nofiri , uoleffh appreffo d i fa la
nobilifom a madre y ha fatto e g li'per aventur a ce
f i g ra n torto , fe ha coft g ia lla m e n te partito cor%
v o i? Appreffo yprego per quella fine era am i ci
ti a faeh e f i a n o i, che non fola mente V ) S. f i ri
m anga da cotanti p ia n ti, m a uogl-.i anc«r perfvadere al Magnifico P adre, che da loro c e f i ,
*> cofico n fem a tt non fidamente v o i a v o i m ede fim i y
ma uoi li li Hofiri cari fiim i am ici ; da li quali la.
ulta hof r a è forfè ; (■de fiderata > che non irid a te
a credere . Ringratto V. S* del dono, che mi m an
dò de' buonif i m i puf ci y ilqnale venne in tempo
molto accommodato a blfogni n o firi. lo L uni, &
M artedìfarà a ? ortogru aro per andar à V mogia
con una bella compagnia y 0 cofi ci potremo tenefa
ramento abbracciare. H o intefo che'hnofiro cesse
^ bene M. ?re Michele ha fatto a equi fio d i un benfa
f id o per il nepote : m a vuoi effer tenuto ficrcto si.
molto m i p ia c e .
■ . ,
.esse esseesse
D / San Vito adipe, x. v 11 I . d i O tto b re.
Ai
D/ x . 3c V i
.
V. S. degnerà/aiutare lo , Eccellente comparire
mio maejìro d i Scola y 0 Ìi Magnifici Signori
F ratin i) infierne cong ii a ltri Magnifici , 0
lorofigeniHhnommi am ici communi „
G iulie Carmtto esse ' 4.
AL S. BERNARDINO
.
F R A
T
I N A .
'§ìs£kbs>
? haueua i
anim o di m andar a V . S.
qualche mellone : m a per
1* t
fri
osorr w al perito in cotaL mer
l ^ j j cantia : dotte la fo r tu n a ha
qmfiper/,no a quefio giorno di f e g u ir il mio defìi urto f i n rimafo , pur al (in ho fia t
lo buon tmimo in mandarne h V. S. (ette : g ra n
miracolo fera ; f i tu tti [.ranno r e i , t taccia a q u e l
la (• cfjmdvne.al$ttn buono ) di goderne per amor
rmo col mólto Magnìfico M. Gioitami i Verone f i :
oso f i per iK'fha buona ventura tu tti buoni f i ben,
che V . S. non fo /ìerra , che li nòhilifiimi Rifegati i y
rii ualorofi N egro non ne a fa g g in o % A D io In
ficio V . S. con tu tta la firn gentile , e lieta, compa
g n ia ,oso f opra liu ti col Signor Q u in to * .Di V i negl a a l i x x n i . d ì Luglio *
M . D
x x i x .
'
D u i C apitani Spagnuoli fir n in JLontay dotte
f i apparecchia efircito di dicefette m ila fa n ti per
andar [opra F iorentini. In qa.efio Autunno/? u t -
v . '...
.
V
oso?
drà in Tsa7laosoesarev e7 Ai». Chrìfliancftmo , s a
forse il g r a n T iranno f cioè i l T u rco, per alcune
lettere y che ho ucauto in mani-molto degne ; D /o
regga ut combattuta natte'di qttefìa no/ha Qbri*
fh a m Kepuhlica .
• • ^ oso
>
lp ro d ig i] di Cremona f in o p ie n i d i r k à j n é
la cofi d t skagufi è / * 3o s o :
dì
v.
. '
s .''"
,y
‘o s o o s o | s a p :%
*
fa ~ osoosooso
Bxen Servitorir .oso oso '-oso v‘
• ' Giulio C t im iìf i
* ?4
fiX ì
•
‘«Alt
AL S. BHE.NAR.0IHO '
.
F
R
A
_
T
I
N - A ;
.
■
.
m andala
ìit^ '“V ri^ V P ^ p il
cJV.
l ^ k l x M ^ k i ,er^ ni:t eTtb'i<>f i » cadu* osoosorf^ tof l° tof i ° r b o u à t a
'/**/*• ^
/e antiche T ra fi
- | o s o ^ s r / o s o ?nationi , perche son ut
erino ri tH m sta r, sa fon te ,
fium e .,D a la pre
surae d i Rot?M in quìi m i fimo morti tón ti cimici ca
r i , che eia f i r n ài loro , &*per la dolce,rortgitm
iion dell'amicitic! , s a ,oer m eriti > hnurchboa tic •
luto mille occhi n d c a p e mio con mille ahonrinniififim i fiim fo a n z j m a n d i lagrime , patientia et con
mten battere ; am aram ente. (Frego V . $ . degni
tifo dar hi mdnfia lettera ri f M if it m e mani : p er
ti fe molto tr i importa , sa /sa/termi scusalo fe 'Cado
pero tanto „
A V iòla /ciò V . S. s a quella del g en tili fiim o
N e g ri y s a Ile li Signon Bffig a tth rtia dove la fd o
éo il Signor Q g jn to dt San Vito 5*
^ ,
N o n mando p iù la le tte ra , che disaprd raccé*
fnadaua : perche U ho h d r izz a ta -per n i a delta
T affettà.
oso
. . sa
&
Di
Tse Sse oso
Serti. Giulio G am itte.
-
A
'"B5 '
C
B
F 'G '.’
efirn, eccello <3,
S
che è Temo.
T tetti fino
ÌN
VINTI Gl A" A P P R E S S O
G A B R I E L G I O L I T O
DB* F JÉ R à A R I.
+ & & X A
L O G Q
’r i i ^ E T L ’ O P E R E
D I M. G I V L I ' Ò
C A M I L L O
C O T t T E H F T E
*
D # -«
v
I T L Q r i ^ S T l
O E V M
i
Iseo us o
t
.
i
-
-
in liuttxh<kl fuo-.
Theatro.
Lettm del riu
m q X D io .
utóleir
Trattato delle materie. 7
v v T rattato cfcll'Imicatione e - % V
D ue orationi.
v
saSsa,
R u n e , et lettere diuerfè.
L a T o p ic a , ouero deirO ocudone.
^
D ifeorfo (opra lìd ee d’H erm ogene.
La gram m atica.
«
Efpoiltìpne (Opra’I primo et fecondo S o n e tti„
del Petrarca «
‘ '*’►
AL M A G N A N I ^
ET NO BILISSIM A
S I C
N O .R
Sr
DI V A L VAS O Ne.
T H O H A ^ O PORCA C ^ R L
*0? E R H D E
gran
oi
CAM ILLO , g ra n *
de d'ingegno ,d'éÌ0:
qeu& di dot
trini
i effendo ripiene dlalftgfai .
cettt non mai pia per quanto.ppffk- esse. esse
congetturare caduti in men#
mana\ debbono da
mr i m .
te effer prestate
perche io fiatem o a ffarle m agari?
tonor ) che
qt
,
,
aPI
*
"C
C A M IL L O
IL
JD ^ L M IN L O ;
C ATAVO d ò
d e
Ll e q V a l i
*’ha nella (èguente facciata • nuouamente
^ .
ra m p a te , et ricorrette <Ja
e
f H' Ò M A SO Psa R C A OC H 1
c o tt i LA ÌT A V Ò L A^JP E t LE
^c^Jfc^wbisi,
e t con
le posjiisc i* margine.
:C o fiY A ÌriL E G l4 , f •
> n ;,
*
*
<rs
IN
;
VIN E G IA ?»eR Es
50
« sa E I U E E ,
GIOLITO*BE’ F E RRARI
M.
D,
L X
V I
I I.
l e le g g i,
n
'ffpft
indd'ètte
tolte
altffvófó
ì come [epolte il)rtneyi$ de*
ygreuoli a
T a lper alcun mero fi può mai
" - . . ..ili; - ........-ni]'-';—ir-*::"'.....
t. fi uenire in cognition di
.„.nofo Theatro .che
da 1
quello
dì*
*
*
*
■
■
’
■samn»**. si*. ;
uino. Auttor^fitmafi del
fubucato .co}/ s a v u t p ; u . S.Jlmo to
<sl3l | ^ v q ^ e i ^ ifa
par
te a/
mondo;fi pegl'auttori
(jenprfffocosar, àÈ' fiffkde, che,
tbabhiano; come pct Vfoor/cffefid
porta alla
grande & #
memoriadi
teiletto .
ftjwirwftU, « e
J i»
& di procuri.^,,
c h e le ^ e u ic n it
ioa. dt tui jfierò'
iffiofat dare in 1
ciualùnaue uq“
• - • .y y * * .-
«pp^'
» » |r -
■
''', 4#» ' *
alRaifeVoeticp,
:,
&</ue#olo fo
lettere i & \
to m o
p e r -p a r e / e
colar,
ii
sa
di. yfsfdame perfe d iti
ch’altfptu
uolte .
io .
F rialtro rifpettoMppreJforifaiù..s
duce a-giudicar U.S.
j
cui ftano prefejitate quefte fcfffafa[t . «f;
on sa d
ueder, quanto ellanidla'bel-f
legga
fingolarità de'
fcriuendo in uerfo, e in
•
«h i 4 '
pen
fir, ad’elocutione di
O i v t i o C a m i l l o * in Mia*
.” do
che' nònminor lode acquifla per
_
top bottarato sforgo
gua
,&
di quel,che le fe né debbia per tanttfE
Mitre
qualità; degni di Gentilhuo»
mo,& di
CauaUiero,u vs< *
nokilifimo
ualorojìfiimo.
^
C9tycflò io, quando freffe
^
1
me,particolare atnmirator dpi# -Iae
molte uirtu, entro in cofi fifata con.
fideratione ; di non fopcr rettas&ritp ]
nN
d i f m è e r e qva/ f c
h
...........................
‘
i
( t e ti# ! # .
J
-
• « vrp*-
e
uirtuofamente; <jr Cavatore• fcamenteaCuna
éfrl'al
li
è nondimenouncofi fatto colmo,
che bafta a ogni animo ben compofio,
|
ejw nelle morali difcipline effercitato.
'
•vlbseto quali V . S . con tanto
,
inuagbita di quegli ornamenti, che •
illuftranoi poffejfori
per fuo
diporto trattenendo/i >che.ne' ragio
namentifamiliari è lodata cerne Cai
tilhmno di belle
lette
feorfi graniti ammirata, contefcien
tiato. X bi legge le poefie, & quei
I
componimenti, eh'alcuna
fer 1
dar qualche ricreatione a g li jpiriti
in altre uirtuofe operatimi affaticar
ti,
eper istigare
te tto , elegantemente di/pone vRiota
V. S . per molkcelebre
; din
le attribuifee tutte rftteUelodi^che
( per molte e infinite che fiano )
fuo
fummo ualorfempre f i r n poche- r i
I o , quanto am e( febene & dipoco gufto, & d t i n f e r m o giudicion
tere) fon refiat» molto-pieno di mai
fe ,
r Miglia, quando fri?altre pie uittuofepitiche, ho letto , mercè della
S ua pngolar cortepa,cheme n'ha ri
putato degno,la tradottion ch’ella per
gran parte ha pitto della Thebaide
dt Statio. 'Nella qual pitica , quan
to i uirtuop & litterati pano per
darne gloria a V.
S.lopimino, i quali homo letto il poema di
quelC^tuttore, duro,
/ufo, & lepiù uolte , come
bile a effere intefo : in che nondime
no piglianiop V. S. uagbeiga di
piegarlo con eloquenza c r con faci*lità , è dalei cop dolcemente trapor
tato in quefia lingua, che Statio ne
refierà con bonefio, ma non ingrata
roffbrc,
uedendoppiùlodato 'per la
tradottion d iv . S. che per l’arte pia.
Chi entra dall'altra parte in confiderar la nobiltà fua
,/ap che n
nobilifìima & amenifiima patria del
Friuli, ella è non pur nato
JnSJtna Signore,o( come quiuifi
dice) Capellonadellafua patria Val...
*
-uafone nobilifiima, & giocondifi ima
fcuanto altra che
' tanto più in lei
rigla
uirtu , quanto è pofla in più alto
fpiendordi nobiltà. Degli
Otuallerefchi non occorre fare alcu
na mentione ; perche quefio è
pryfiimo & commuffìfiima
quellafelicifiima Troutncia;
le par,ehe fotamente regni in quefia
p a rte , cb'è
d'effernero C
deualore • Tacerò ftmil
. jmfWeta aortefia & la magnanimità
d i u . S. la quale, »3$ nonfiuede
mai fattarieffercor&
cofi in quefia uirtu par, che
mente;fi nodrifea : & làfcerò di rac
contar moto altre fue
lifiime xiriu&yyofifiime, per non
offender kmodèfitafua. La pre
gherò falò, chefi cornea me fempre
è fiata cortefe della fua gratia/in
honorarmi, & liberalmente leni
ficarmi : co/i uogltadt prefente ac
cettar dame uolentiert quefio dono i.
accioche
accioehenel legger
di n i ysa
riconofcain
gran parte s eccellentide'
fin*
golarifiimi
concetti;&
nel ricordar
fi tal uolta, ch'ioglie le ho dedica
te , fappia
daniunoeffer più amata,
ne riuerita & tie bacio la mano)
Il Sabato Santa
jl X
le
M
£> I J f u ì .
.
no CAMiito,
;
K
6 6 .
T
A V O L A
DELLE COSE
PIV N O T A B I L I
C Q
.
M T>
K S
S S
N
E
f
tomi dell'opere di M .Siulio Casi
milio :
doueè,a,fignjfi- ,
ca il primot & dpue,b)lfecon»r
do
Tom
—
_
»#* ■• ' '
moie; t(V^)to.*' r s b
[ AccuOttioÀtsilMKiie '-•*
diuifiiiteù&QfaA
gli antichi.
MI
Iccufàtionc fi itol_
#
à iiMIoi flessi. i#A
Accusation de* Rethòridtójtó&Ie &
confufirnon ci
'*&CW - * W
Accufàtiui (end.
*%8 b
o
Achille fatato fuor che nc’ ffedt, che '•*
lignifica .
113 a
.Acqua innanzi al ciclo & alla tetra.
74*
juUm fiato d ilata uùgiaaslts/ si U t *
T
A
V
O
L
A
.
In che modo fofle nfell’horto delle
delttie. *
' 115 *
AdOklccnza fino a quanti anni fi Ren
da.
I04b
Aduerbi*
*43 k
Aggiunti lOno tripartiti.
tfo b
Aggiunti,p ueri, o fiati*
21 f A
Aggiunti finti.
2162
Aeoftino A biofo.
Ì62
Allegiamentonome» ,
, tf b
Alteri (enfi.
f c p :b $ 7 b
Altifsimo di nobiltà, traflato.
1f b
Amore, che epitheti pofla hauere •
29 b
Amore c qualità mifla di dolcezza, &
d'amaritudine.
1 07 b
Amore é un dolce amaro «
x 1 99 2
AmOrofo epitheto a che conuengi « ; .29 b
Anello onde nato.
4
129 2
Anfibologia nel Petrarca*; osooso-oso***
Anitpanoftra, & fuoi uehtcoli. , osoflt
Anima prima conte chiamata. ‘ oso | * *
A n in M W Ù ^ a l< f., i
se
% 40%
Anima qua^dod accominc^fata atta %e se
c u U t ìo d e .
osov
'se oso 4 * *
Animale >uiuente, & (bflanzaa
pa
Animali de loro creatione.
j 41 a
.Anime noftre hanno uirtù d’alterar le
* cofè.
62
AnjtDc tre in noi
^14^
Anime de loro obliuione.
..'in i
Anteo & Hercole che flgnificano « .. 12 f ±
* D I M. G I V L I O
C
A
M I
P B U E
U
llo
■ ii,T
L
L
O,
*
M A T E R I'E .
il l u s tr is s im o
eccellentissimo
s.
il si?. Dan H ercole Duca di Ferrara.
iiì»
. ■
WS***
;
j E i o hautfit penfito,chi
I le parole d i questo poien*
j npim o R e , infiammate
da l difiderio del Reuefen
! d i f i . 'Cardinal d ì Lo¥&
I w , h ave/jet o *per J h jo S
__
1 q ui hauuto a tirare i l
v ia g g io , che to bramo fare per Jtaha ; bauerei
peraueritura prim a h i f i tato l\ilthz\d>uoflra con
qualche debito fegno del?ófferuan\a m ia : im
peroche, io m i fa rei taihor dato afarle rìuerenZa con alcuno p enfi ero f r i t t o dintorno a quitti
fim i/ n o b ilitim i, ne quali il ualoruofiro tra g li
a ltri Fyerìcipi del mondo ha loco laudabile. Mia,
per nero d ir e , parendomi da molti me fi in qu a
d i giorno in giorno effer per entrare in camino,
D
ELLK
M A T E R I E .
rji
perche m i era cofi continuamente promeffò : la
m i daua ancora a creder, che di giorno in g io r
no la lingua m ia hauejjè a fa r quel? o f f ciò, che
la penna piglia al pre/en te. O r a , ancor ch*io
f ia slato per lo adietro più atto 4 conofiere il
buqn volere uerfo d i me, 0 t i p o ten za d iq v e fiu gran difiim o R e , che diff>ofition d'iddio ,
il qual mena le cofi a fin e da noi non conofciu«
to. : e auvenuto , che io m i fta fiihtlmente ranedato del lungo tem p o, che firfa a fa r mio.debir
to f i ne è con le ptomeff'e reali andato ; 0 pe?
f irne notabil ammendaào intendo con fim p h ei
0 neglette p a r o le ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ i^ a ^ oso
ta to id f Eccellentia twflra dedicato la g r a n d e ,# ,
flifficiti , 0 da a ltru i non tra tta ta itnprefa cfoL
le m aterie fife f it to lo fh le cleì?eloquentepojt. /
fono v en ire . ìlq u a ttr a tta to , benché potejfe •'
effer p iù , che ùtile a ciafcvn, che uotiffe d a i
(u lto il de fiderio alla laude della eloquenza r
nondimeno perche io l'ho ombreggiato fo t comò
ilgentiltfim io M. Domenico A n ia m to ha ned#
ipf nfile confvfiomdella continua peregrinatio*
n f d i quefia co rte, dotte non può effer largo i l
tem po, ne il loco; prego t i infinita uofira p ietà
Commetta * che per fino m iJ'arà lecito potergli
dar l'ultim a m ano, fia conferitalo nelle slret~
teZge d e lti lealtà di alcuno fv o fe d e le . Dico
ancorché pia t ofìo [ho
Commini parlare d'Ita lia , che nella lingua L a *
sPfae fip c rch em i e A l'anim o, quando a Dio
piacerà « d i vicinar\p ancoya alt i int^Uigtifa ci...
d i qveli'alta Donna > cbe io per t i molte 0 raert
« MB B i WWmv i Www:
*
, ....
- •
G
uq
ti
Iji
T R A T T A T O
*•v irtù fue fonmiamente honoro ; fi ancor, perche
•io m i penfo di apprcu.W fW fiitdette dette ma
terie con illuminati efempi del Pe tjfp c r farle
•più fentire . Adunque l’Eccellenza nostra per
da fu a incomparabile i)umanità nette bore del
Silaggi or otto , mentre farri coti g l Vluflrìfiimi
fu ot fr a te lli, Monfig. di Melano , e'I S if. V>on
Yrancefco , tu tta rivo lta a g li honefii ragionam en ti delle belle lettere , degnerà per una fola
volta a ir tr la via per g li orecchi a que f i a miri
'im perfetta fa tica ; ne per tu tto c ij preg o , chi
g li apra per la telitene del dittino M. C elio, no
-anco per quella dello erti di iJJimo M. AleffinfMiro Guefinó,o del dottifinno m edito Brafauola,
f erciócbe qtiefie carte d i vergogna arreffarebbo
fio; ma più lofio per la uoce di M. Agojìm Ma
sco , 6per quella del nobitt M. Nicolo Bendide/,
du e g ió v a n i d i g ra n d rfiim a ffera n \a ,e y di co
f e nove defiderofi. 1fthè fe fa r le p ia cira , como
detta fu a utrtù f ie r o ; iò le p ro m etto f e b e !el&
trotterà aperta Ventrata a m aggior Cofedlla ve
rtuta m ia ; la qual non può ejjer lun ge, quando
'ancor quefio alt tftimo R e , e 7 Cardinate ili* f r i f i. menafj'ero un poco più in lungo il co mia*
t o , che io fo l per due me fi non ho potuto ancora
otten ere. Ma per non perder più tem po; cofi
fa tfo fa rà delle materie il principio * '
- * seTwtM la elo qu cnigtjjpcr mio avifò f t pofla
ch*tn tqficófe prmcip 7
fit \ in m aterie , in artificio,
s a in p a ro le. Et quantunque ne Cicerone, rio
'labro a u to re , che io veduto babbi a , ha bfciatri
f i r i t t a pvn taltn .n te cofifatta opet:ione ; nondi
meno U *
'D E L L E MATERIE.
15J
meno io oso da più luoghi di C icerone, oso dal*
Tifteffa fa o u a , tefl imorio d i ogni verità , b *
colto , quuttfo ho propojìo • Et accioehe le pr>■*
mierc dite fieno primieramente ne i libri de
O ratore riconoferite., oso appresola ter^ae; •
da consederas, che neffuno eloquente fi darebbe
a lti compofittone > prima non f i par affé da
va n ti a lui alcuna m ateria degna della fina fa r
fisa : ilqvale fe veramente faffe eloquente : nare
f i fatisferebbe delti m ateria ignuda, che o la na
tu r a , o 7 cafo » o vero alcuna delle arti lodata a
v tle g ti haveffe meffo davanti : a r ifi p o i, che 9
dalla n a tu ra , o dal ca fo , o da alcuna dette arti
degna o noti degnagli fa ffe arnminijìrat a alcu
na cofa, che ruet'taf)e l'inchiojhro , o la pennaa
esse ancor prenderebbe c u ra , che dal fu o inger
gno fibaueffe a meuere alcun benefìcio fopra t i
cofa a lv i venuta : ilqual beneficio ancor, che
posse venire da p i# ali re cofe da dir nel tra tta to
dell'artifìcio ; pur perche t i maggior parte del*
t i nwciuionp ff h a dalli fa n ti T o p ic i, onde an- inuentto*
Cor nafeonogli argomenti; da quelli diremo,clic
egli b a b b ia ti maggior p a rte della fu a maggio*
foat\
ra n \J , oso anco dal nome dettiartificio . Q u e - Topici.
fio alunijue > ma fedamente quando i fo n ti T o
pici, come m t\a u i dell i ( i t a g r a n d e v e n g o r
no , e tratto non altrim enti che t i m ateria . »
dalla n atu ra, o dal cafo, o da alcuna delle a r ti *
p r e d e tte , ma non da quella medefima natura ,
m da quel medefimo cafo, ne d a quelti medcfema arte , daUaijual t i m ateria tr a tta .fosse.»
fdquale artifìcio non m eno, che alla m & e rti
G
y
se
r*4
T R A T T A T O
Cicerone ha dato nome hor d i m a te r ia , hor d i
cofa yf i come manife fia ta ente appare t e i fecon
do de O ra to re .
A d probandum aut erti duplex ef i oratori fu lie é ia materia : una rerum earum, q«ae non exco
g ita n tu r ab oratore, fe d in re propofita ratione
traP la n tu r, rtta b u U g eftjm o o ia p a P fa , s a f e lujua ; qud non ab oratore partuntur , fe d a d
oratorem a caufa atque a rets deferuntur : a lt
ter a e fl, qua tota in d /fiu ta tio u e , s a in argu
mentatione oratoris collocata efi . Ita in fu p eriore genere de traPìandis argum entis, in hoc
datem etiam de inueniendis cogitandum e f i.
E f (i come Cicerone diede nel predetto luogo a d
ambedue il nome di m ateria ; cofi nel te r f o de
O ra to re , alla m ateria diede il nome d i cofa J ■
Apparatu riob/s efi opus, & rebus exqkifìtis
umhqtte cotteti t s , nccerfitis, s a comportatis ,u t
(ibi Cesar faciendum ejì ad annum , ut, ego i ti .
a d d ita te labcraur, quod quotidianis s a u ern d L ,
culis fatisfacete m e poffe huic populo non pula*
barn. E t per m o fira r, che apprcjfo la m ateria,
s a appreffo lo artificio,che è quafifeconda'm a
teria , ueniua ancor la parola ; dggiun fe. Ver.
bcrum eligendorum, s a collocandorum , s a
concludendorum facilis efi uel r a tio , uel fitte,
r a t ione ipfa exercitatio. Ma quelle due p a ro le,
facilis r a tio , muovono dubbio: im per oche n e
é in e
k
g
, ne ragione d ic e , altrove efi'er nelle pa
g ei le pa- r o le . N on fa cilita , pttche pur nel te r fo ha la laefenten* f C
ia
t0
f critte qaefie parolev Aliquanto me ma*
tie.
ùòr io Herbis^ quam ta fenlentijs eligendis la b e t
DELLE
MATERIE,
tu
0 cura torquet, ucrcntem ne fi putido ohfole-,
tw r fu erit orati o , non d i gnu expeflattone 0
filetuio fufafe m d e a tu r . N e anco ragione due,
cjjere nelle parole nel libro de claris oratoribus *
Solum quidem ( inquit ille ) 0 quafi funda-%
tnentum oratoris jiides elocutionem emendatfirrf, 0 latinant : cuius penes quos laus adhuc
fu erit, non fu it rationis, aut feientia ,f e d qua-,
f bona confuetudm is. 0 chiarita la locutionct.
fnolo 0 fo n d a m en to c o m e nel terzo dell'Ora ~
to r e . V erum hoc quafi filu m quoddam atqu&,
fundamentum ejl uerborum ufus et copia bono
rum . Mae f come nelle due materie mofire da.
Cicerone, T una uiene all'oratore ,0 l'altra na
f ie dall'artifìcio deli oratore.; cofi nelle parole s>ue farti
una p‘ir te , nella quale non è la ragione, ma lae
?are
confi et mime tenuta f o g l i autori d'altra,perche,
nafte dall'arte dell'oratore ; regolata dalla ra
g jo n c . per laqual cofa alle predette parole f i g
g ili nfe q u tf le . Scd quid ipfe /d ificet orator
0 in quo a d im g a t artem , id effe a nobis q u a rcndutn atq; explicandum u id e tu r, Et in quel,
de claris Oratoribus dijfi , Cesar autem ratio
nem adhiben? confuetudinem uttiofarn 0 cor
ruptam , pura 0 incorrupta confuetudine emen
d o t . Nondimeno percioche in quefio tr a tta to
io non intendo parlar fenon della m ateria ; r i - . - ■ :
Cernerò le altre due parti a due altre fatiche, chi
a qttefiafe a uefira Eccellenti a piacerà , feguiran n o. GoqC a iu ta adunque d'iddio d ijfu ta rerr.o della nìaterta fila , di quella dico , che non
(p a r to r ita dai?eloquente >,WA ujene 4 Jui pe^
G
y)
*
T R A T T A T Ó
chiedergli ancor quel beneficio , che effe dar le
può con ?artificio J u o '.y fc taihor mejcolero ce
f i pertinenti all'artificio ; non far& fer tra tta r
in quefia parte d'effe artificio ma per fa r la m a
teria più pale(é é II perche Jàpendo io primie ro
per quefio erto oso d iffid i monte non fig lia to d a
f in tin o alcuno, mofirerò la m a te ria , che mene
al? eloquente, non uenire fin o n dalle tre parti
dette di /opra : cioè, o dalla pura natura , o dal
cafo, o da alcuna delle a rti honorate, o manual i , non a ltra m e n te , che taihor anco?artificio,
poi faro veder quando la m ateria non è p a llo
nata ,-oso quando p iglia una o più pu f do n i , oso
come la pafìkn e taihor divenga m a te ria . appresse come la pofiiatno trovar ne g li a u to ri ,
quando ancor da molte qualità nafeofia oso co
perta fu f i è , oso ancor quando può e fiere chiama
ta a più capi. ìlche f it to diremo doue ella è ,e t,
per cofi dire ,/o h ta r ia oso dotte accompagnata,
oso quello che è il più, del numero delle m aterie,
oso configù atterri ente pache la m ateri a dee te
nere il primo luogo , Tartificio il fecondo J a p a
rola il te r ^ o . all'ultimo brevemente per Tautorità di Cicerone fi darà la e ia tien e delle m ate-
che* use **C ' ^ ripigliando la prima delle propofle nel
ne «ll’elo primo loco ; d ico, che la m a te ria , laqmtl può
giunte,
mintflrdr all'eloquente là natura , farebbe qualutujue Cofa di quelle , che nel fi «grande grernl o Vennero pctta creatione del maulo:come t c u
h fig u iti dal tempo oso da l loco, g li elementi J e
p ietre, le piante, i bruti im perfetti, i bruti per
f e tti, thuem o m t m r e oso esteriore. S er iw lh
D E L L È M A T t R I E.
do adunque lo eloquente di alcuna delle predet
te nel modo, che Dio s a la natura l'hauejfef a t ta ,c r no.^ancor Tari e f i potrebbe d ir cofifiu ta
m a teria, ejjer m im jlrata all'eloquente della n<t
tu ra , ma JealTeloquente piffero apportate cofe
pertinenti a d alcuna confa ciuile , o ad alcune
rei per alcuno homicidio of u r to , percioche d e t
te cofe non furono fa tte da D io n e dalla natura
fu a mnujìra,m a figlio no venire dal cafo;ragiqneudmente f i d ireb b e, che dal capigli fuffhro
mejje davanti s a dt quefio f ilo r\iernbro fece d i
fopra mentione O c . in quelle parole. Qjtx.not*
ah oratore p a n u n tu r, f e d ad oratorem a caufk
dtq\ a rets deferuntur . Ne l i dubbiamo Ufci.tr
confondere dalla vicinità : imperoche m e n tre ,
per g ratia diefèm pio , l'altrui morte cade f i t t o
10 s h l dello fr ittu r e ; eff'o dee confiderarefe ella
è naturale o violenta : che f i n atu raifujjè,qu al
f u quella di Anchift appreffo V irgili oda duurpb
he nconofeer dalla natura : ma J e fu jfi violen
ta , qualfu quella di D aphfi,di, M/seno, dt Estria lo , di N i f i , s a d im o iti altri : dovrebbe d ir
hauerla hauuut dal cafi . ne pofiiamo noi dire
11 mede furia del n ficim cn to, il qual e nel nera
non può e jje r, fenon n atu rale, (fual venne alla'
penna di Virgilio , mentre era per corriporre
nf>
Tegfaga > che fcnjje a ? olitone. è il vero , che prodotre»
ancor v iv e una perfona n o b d film a , d e tt fiim a , Fer
s a di fu n t f ilm i cofiu m i o rn a ta ; lacquai benfhe j>icch i.
vergogno farnent e , pur confejfa hauer per a r ti
ficio di lambicchi s a d: altri ifiromenti accorti-*
.mudati a d o p e r a g li p i* amn prgdftUjt M j frdrth-
%
ifS
si T R A T T A T O
bino : ilq u d l, come prim a uenne alla luce 3
fu
abandonato dalla u it a . ilcbe fe c o fi fi*ffe, 0
che uno eloquente fcriuerne uoleffe; Ifoarebbe a
riconofcere ilnafcimcnto dall'arte di colui, a c u i
no n mancano te (limoni ; iquali arditam ente a f
ferm ano hauer ueduto , quanto ho detto.A dun
que, quando io disci alcune cofe poter effer por
te alCeloquente dall'arte,non inten dala io ali to
ra dell'arte fu a mede f m a , pertinente d o t Alo
eloquente ; ma d i alcuna arte o d'ingegno.o d i
A tte d'hir m an o . Et le a rti d'ingegno , che poffono appdr
gegno. rtcchiar materia all'clloqu ente, fono tu tte le (f e
culai tue [a c u ita , 0 tutte le a r ti nobili :
quelle di mano fono non pur le a rti mecaniche ,
m a i loro eff etti. Il perche diciamo tA effer non
pur Varchitettura; ma il g ià fa tto edificio ,0 la
naue ; 0 quando Vhilone architetto parlò a g l i
Jkthenief dell'armamentario ; l'arte fu a alhor
g li f u materia . O r q u a n tu n q u e [intento m io
non f a d i tra tta r al p r e fitte dell'artificio, ch^
ila in cofiurne lo eloquente dare alla m aterni \
nondimeno per fa r meglio uedere in che fia egli
differente dalla m ateria , poi che efeono da i
medefìmt p rin c ip e , ma non in un tempo m edefim o,n e nel medefimo modo; non fa r a perauentu r a inutile di farne alcuna parola : che cofi
/ pero deflar nel uirtuofo petto d i uojlra Eccelle/*
t t a , quello ardente de fiderio , che m erita la d ig n ita del detto artificio , per efier unico f r u
m ento de lti elo q u e n za , perche effo folo può
a p rir largam ente tu tte le uie Ala in ven tio n e,
A la dtffofitioìH ? 0 A la tr a tta tiv i# . V iw
D E L L E M A T E R I E . ’ I;9
adunque, che per li tre mede fim i principii Vari Artificio
tifi ciò può alcuna volta porger benefìcio alVofiffifi possa*
fe r ta m a u ri a , per liquafi effaf t ojferfe all'elo- recar beai
quente: cioè per quel d e lti n a tu ra , per quel d e l ^ ffr
cafo, & per quel d i alcuna delle a r t i , Mae la materia.
differenZa è , chele materie efeon fu o ri delti
de tti tre prim ipij fem pre ferina meZo alcuno ,
f e prima noirfifiero s ia te tra tta te da altrui.M a .
Cartificio , quando efee dal?uno d e i p red e tti
principij tifar non p u ò , fenon per meZjp d i a lp
cuno de i fo n ti topici : d tfii quando efee dall'u
no de i detti tre principij : perche può ancor alfa
tram ente venire al commodo della m ateria, mct>
ftm pre ha bifogno d i alcun m e\o . Sia propoflo,
nel ertela , che alcun voglia fcriuere d e lti fin g i»
lità della humana uita;certofe ben riguardaremo * t i materia è talmente n a tu ra ti, che da a ti
tro principio uenir non può , che dalla natura *
imperoche le cofe, che vengono a lti fattu rorfieti
Vhuomo, fono naturali , oso non poffono per la
miflion de i contrari Sfar lungo tempo infiemet e
tra loro ancor quefia notatili differenza ,ch e la
materia è talmete defiinata all'ima delle tre pre
dette radici,che in altro tróco t i medefima no po
irebbe efiere inferta g ia m a i.. ma Vartifi ciò d'in
torno ad una iflefia m ateria può taU?or et f o rti
osofa r f r u tto , fecondo il noftro arbitrio fopra i l
tronco di due oso anco d i tre . L e mie parole
fu on an o, che t i m ateria deWhumana c a d u c i t a f . j
etalm en tedefiin ata non pure alla n a tu ra ; m a
alla natura fu a ; che altro principio 3che q u e l '
della fu a pròpria n atu ra j t y p l a pfiirthbe a U '
1
^
^
f
i
l'eloquente minijìrare: 0 nel medefimo principio farebbe Inficiata d e fu n ta , fn qflra, esse tr a tta ta dal Fhdofipho & d a l/ti e d k o , /quali dalle
cagioni non lontanano gU a ffe tti g ia m a i . ma
Veloquent e , che vuol ancor porger dilettai ione,
* a lti a pa filone , A .pidonarebbe più tofio (a
p b tlofip b ica , f iu c r a , 0 fitttir a g k n e s/te(fe
m ite lontana dalla intelligenza d tg ii afe?luti
t i , o d e i lettori ; che il loco , ilquale g li potcjfit,
aprir la uia a muouer g li anim i de i p red etti *„
O r , perche una ifiefia materia può effer tr a tta
t a dall’artificio dell’o ra to re, «sir d el P u tta ; v e
dremo con quale artificio l’haura tr a tta ta ,g ià -.
fcun di loro , de’ quali l'uno ama ancor più t i .
dilettai ur neche l’altro . Ma fia uofira JLcceil.
prego alla lettione di quefia parto non meno u i- v
ct#d con l'animo , che congli orecchi • Virgili*.
Virgilio altifinno Poeta, poi che fade l'humma c/ujuctri
ì« o * ^iUt l
a
mtut(K uf f n k* > dafoqual
natura proprta quantunqueconofiejjè proceder
tessei caducità ; conobbe nondimeno fe nel poema
l'hauejfe nello Plato fuo raccolta: che effo poema
non haurebbe ritenuto ne dignità,ne dilettatio*
ne aie anco miferatione : ilperche tutto fi rikolf t Ali fin ti topici, dalli quAi non pur gli argo
menti , pia quifi tuttelemuenttOHi di tutti gH.
artifici per irrigar la eloquenza derivano ; _ 0
giunto a quei, (he chiamiamo a S i m i l i *
^ x ^ cU n à ^ fi £Ql p iffero per tu tte le altre cofe dAla na
nule Hswurae prodotte, per veder,poi che la offerta ma*
tocU v ir /tTW era troppo fin o ra ,fi pvfejfi trovar « f a 4
th è bella [u f f t n v ijìa , quid è la v ita nojlra,m *
in bruti
D E L LE M A T E R I E ,
iti
tn hreue caduca, dellaqual ferine mio , chtleg*
;
geffe, potesse fubito cogliere ta l ejfer la u na
bum ana. fai entità adunque a lui la ro ft per t i
mente ; giudicò che?artificio , che porgeva il
loco a S I M I L I , farebbe alla propofia cofa
molto accommodate : per v irtù del quale fece
quefia diurna eleg ia, laqxal benché h a h b ta ti
^
tnfcrittion d i Kofa ; nondimeno veramente t i
^ y d tw n 4
dfrfmi0K ìella humana caducità * nella
) quale elegia p e rla fin titiu d ìn e della r o fi f i con
duce con maravigliofio artificio a m etterci da»
v an ti tipenfiero la brevità della v ita nofira ,
ancor che bella par effe, come la r o fa ; im perothè facendo co*uerfi Jvoi a poco a poco languir
la r o f t; fittegli a la mente a m aggior cofa, oso
^
tacitamente le propone la nostra caducità, d e lti * qualenòn f a aperta m entione, fenon n e 'd u t
u ltim i nerfi.
(bes.
■Collige virgo rofits,dum flos novus et nova pi»
Et memor ejìo auum ftc properare tuum .
T u tto adunque Vartificio fu nel?abandonar t i
propofia m ateria fu la naturai ra d ice , poiché
troppo fieuera la uedea, oso dal poema lontana.
N e pur artificio fu l'abandonarla ; ma nel tr a t-.v
tarrie una fom igltan.e/opra uri altra radice pur
n atu rale, per meZo deliaco della fim ilttudine,
tanto piena di d ile tta ta n e oso di m iferationt ;
che ben fi v e d e , che ella è più al p o em a , eh* <
alla oratione accom odata,oso tanto piena d i dò
feg n i della nofira fi-agilità ; che fen Z a fa rn e
mentione la dipingono. Ev il vero, che ncriuntUnrrto de f a tti d i Enea ritiene nella trattation*%
f e r fim ilitudm e ancor la cofi afiirnigliatA, in iferocbe «compagna col fio r languente ancorati
giovan e ucctfo , cofi :
Q u alem virgineo demijj'um pollice fflorem ,
5eu moliti m o lti, seu languentis Iryacinthifo/it•
C ut
fulgor adirne gite dum fu a forma r c te f
N o/i tam m ater alit tellus,urie s<f mnufirat^
e oso il T etra rca .
Comefior colto Lingue,
A rv*
.
L ieta f i d ip a rtio , non chefic u ra .
I l qual Vetrar. imitando perauentura uno CQtdn
le a a enfiamento x che io mofirerò d i Cicerone *
abandono parimente la feuera m ateria della ca
ducità della hnmana v ita fopra la fina r a d ift
pa tta > s a tu tto fi diede a fa rla fentire altrove«
piife c e , some V irgipoj, riquale fe abandonò la
m ateria nella fu a propria fo r m a la dove ella
nacque ; tra ttò nondimeno la fu a fim ilìtudinet
fo p ra un'altra c o f i, che uenitia parimente d a lArtificio la natura: ariZj il Tetr. lafciando la d etta m a «lei Penar ie ri a al fuo loco naturale, la fa veder phé pienti
d i com pafiione, non in altra cofi d ì natura con
finale ; m a nella fim ilriudine dilla natit , che è
effetto pertinente ad arte ignobile. E t in vera
J e ia rofa appar bella tra le cofe n a tu ra li, £ r f &
m ette pietà per il f i o Cubito languire ; che d ir e * .
SJmìlltu - njQ della n a v e , che uien dall'arte ? Quaef ia ue*
Emùe con ramente folcando rim are tranquillo a piena ueìa ulta hu L t, mentre l'aere e fercno diletta tanto,quanto.
f*una‘
a ltra cofa dilettevole ; & anco fe fubito fitffe
affali ta da lfu ro r de u e n ti,{y percoJJ'a in a lcu m fc o g lw v tanto muove in noi maggior dolore^
j
EfEttE MATERIE.'
K
[ri,% quanto nella belleZffia, nel corfo, oso nella rot»
! j • tura fua, ci m ette davanti uri altra cofa ancord%
|
cioè la utta humana a le ifim iti . V edete attrito
que d Petrarca
i
Indi per alto m ar u id i una naue
Con ti f a r t i di f a t a , oso d'or t i u e la ,
*
T u tta d'attoria oso d'bebeno conttfta ;
*<
ÌL'l mar tra nquillo oso Paura era fea u e %
?’
,f e nulla nube il u e la t
% 4 Ella carca d i ricca merce honefia .
'
■' Boi repente tem pefia
lV
? O rientai turbo f i l'aere oso Vondei
f
Che la naue pere offe a d uno fe o g tio .
’
:
' O chegràue cordoglio :
B revi bora oppreffe ; oso pocofanti* afe onde .
L'aUeericcheZffie a nuli*altre feconde f
1v.
I
E t tu tte le H a n fe della d etta carinone, eh (f in *
)
fe it forn fabricate fo p ra la natura, fu ori che è/ut
\
f ia H a rifa , laqttdlc ha prefa la fim ilitù d in è
della cofa pertinente a d a r te . apprefjó tu tto fa * ‘-rtò trattate per artificio fa fitn ilitu d in e , fen z/l
f a r aperto motto] della vicina caducità della fifa
d o n n a » fu ori che l'ultima a d imitatiorie f o r f t
ì
d i V irg ilio , nella quale abandona la fiim h tu d i n e , oso leva tu tto il velame . E t perche no#
t
vengo hora a quefia intprefa, come interprete ;
j
lafciero la fignifi catione dt m o lti cofe meffe n el,
la propofia S tin g a , oso sol dirò che'l percotcr .
*
nello /(coglio, da fegno , che t i morte della fua
J
fo rm a doue a effere v io le n ta , oso nel m è\o del
6
.corfo'della v ita fina. . T anto ho detto fol per f a r
fe d e , che'l Fetr. prefe tifin n litu d in e ctitiandué
I
..^ 4
-T R A T T A- T ‘O
da quc( picciolo accennarne)ito perauei(turayehe
diede Cicérone nella m orte di Lucio Graffo, lu i - .to tolto dalla nanale
O fallacem hominum
jpern frag/lemq; fo rtu n a m , 0 inanes nofiras
contentiones, qua in medio /p a tio fip e frangun
tu r 0 corruunt, esse ante m ipfo cvrfu obruun
t u r , quam portum confpicere potuerint a E t
cofi come Virgilio per t entar tu tte le vie neWun
decimo meffe ancora;cn ti fim/jtutincrucip or 0
il color dell’ucciso giovane ; cofi il Vetrate a. in
una Sefin a non pur m ette la fim tlriudine della
pauet ma aiicor la trita nojìra a fìm ig ra ta cofe.
Chi èferm a to di menar fu a uria
I
Su per f onde fa lla ci, 0 per li f o g l i ■' »
Scettro da morte con un piceiol legno \
si
N on può molto lontano effer dal fine » . . •
;+\ <4
f ’ Pero farebbe da rrirarft in porto * ■
M entre a l governo ancor crede la v e ti •
-\
Et con quefia Sejliua uìen quel Sonetto *
Vaffa la itane m ia colma d'iddìo « •: ^
I*
i & a ltri fu oi d e tti, iquab bem h o ilE etr: babbi*
foatto fe n tir piactuolnpvr per l*accennamene d i
..Cice. pufìi.uno giudicar, ehe. ancor alla oratione
. potrchbono effere accommodati : ,perche ta n to
Jeutono della g r a n ita , quanto quella d elti rofù
; « delfior fentono della d o lc e zza , più del poema
amica ; m a maggior g ra v ita porta ancor quelSulpnio ‘ bar tifi ciò diS eru io Sulpriio dintorno, pur a lfon u endo [h u m a n a fra g ilità , quell'artificio, dico, che,firnir
m otttr ^ abandonar. t i m a te ria , che tien d> vicino ,
grande or/piega le riccheZfae fue fip r a città 0 tafielh*,
tifccio.
sensi effetti delTarte edificatori* per w Z ?
D T L L E M A T E R I F.
% i i quelli lochi topici a M A I O R I , san Mia
[ • NORI , Ex Afi a rediens cum ab Aegina Megaram uerfits navigarem, corpi egomet regiones
circumcirca profpti ere. poft me erat Aegma,an
te Megara,dextra Piraeeus, finifr a Corinthus :
quae oppida quodam temporeflor entifiima fuerunt^nunc proftrata sa diruta ante oculos ta!* cent cxviegometmccum /ic cogitare , He?»
MmoHìomuuculumignamur, fi quts noflrum in\< terijt, aut occifus efl, quorum uria breuior effe '
debet: cum uno loco tot opptdum cadauera prò- '
iellaiaceant ? Visne tu te Serui cohibere, sa*’
meminiffe hominem tc effe natum* ITabbiamo:
detto dell'artificio,che può effer tratto dalla na
tura, sa da alcuna delle arti per mefo di alcun '
y r t < i fonti topici: sa anco non è traiafeiato quel,
| che fuol uemr dal cafo , fe fiamo flati bene dt- *
| tenti : ìmpei'oche fe la morte uiolenta, fi come •
| /opra difri, e dal cafo, sa che nel?efempio del- *
I
r
Li nati e pere offa nello fcoglio fia sla ta moflra J *
feg u t che riabbiamo ancor tacitamente fa tisfa t- 1
to aUafo : ne cofa incontteneuole è , che un# '
ifleffò artificio fia prodotto da alcuna delle a r tif
C rd a l cafoinfiem e, f i come ne anco, chetino'
argomento nafea da più lochi ad un tem p o . s a
m vero, fe quefio fu fiè il luogo da tra tta r l'arti
ficio ; darei m olti efempi non pur del cafo ; m a
ì
dt cose aticor più nobili pertinenti a lui: Per laI 1 qual cofa il tu tto riferuarem oal fu o trattato V
J
Jalno che per fa r ben conofcer la materia ; dire-1
mo ancor quefio, che quantunque I'a r tif ciò non'
p a fim p re louat\(iM lk rimfta*, ''daboafó f o dii*
166.
T R A T T A T O
Artifìcio alcunaddle a rti diuerfe da quelle, dalle quali
luche mo \
.
n
-v • ' j »
do non fintene la m ateria alla p en n a , per m e\o.ctoe de
possa unUJqptj tQpiùyiouditncno in qualunque ancora a ti
a. nU tKf* mù(£ l'artificio f i parte dal?eloquente al Le- .
tu fido detta m ateria, non fi può unir cerulei Jett
\ \ il triezp di qualche cofa ancor lontana da i
f u l t i topteii ilche non f a t i m a te ria , laqual
Jcpipre mene all'eloquente fenga alcun m e \d ~
no , m a q u a l, o la natura, o 'L a jo fó a ìtu ri a r ?^
9
te Tha p ro d o tta . E t , per nero d ir e , per qual
artificio fu meT^ vennero fiotto lo Sili di F ia tò -■
ne oso di Arifiotile molte m aterie pertinenti alti'
n a tu r a , che per lo adietro non furori tra tta te
.g ì amai * per qual rne^o d i arti fi (.io L\ confa prò
bilio n e , pro Sex.Ro/'cio, pro Q uin tio, oso altre^
f in tili, che dal cafo procedefiè r o , fir a c a m a n dar uno a lti eloquentia d i C icerone? per qual
finalm ente rilego di R i retorica l'armamentario,
effe uenne dall'arte d i Fìntone, tlqual f u a m o r
eloquente f i diede ancor ad efferati Athene m a»
/e r i a , ddLiqnal Fintine bauefie a g li Athertiefi.
eloquentemente a p a rtire ? oso essi che delle d e l
t$ m aterie jc rifie ro , o parlarono, n e fir fièro,o
partirono , f e r i \ a tifc u rle da p a r te , oso fenzfi
rnofirar di p a rtir d i altra cofa,benché con fim ile : anZj » mentre fopra t i penna ofopra t i lin »
g u a t i rie eve t to n o , perm eZ ? d i alcuna d e lti
p a fo o n i, o di alcun m ethodo, o d i altra Cufa »
che al fuo tico direm o , ? artificio aggi unfero-.
poti ebbono bene i c a m p i ,y altre cofe per t inen*
t i a lt agricoltura, quando vennero f it to lo Sh l
di Virgilio,hauer portato art effe loro alcun me
•
/
D ’K t t H
Zg
*
|
•
;
M itF .K IE .
i'«y
c io è a l c u n c o m m o d o d i e l o q u e n z a , p e r c h e
fu r o n p r im a t r a tt a t i e lo q u e n te m e n te d a
c o m e a lc u n i d ic o n o
I
do , s a
5
m e n te d a
N
ta v td r o
Ne
.
,
H
e f iò -
m o lto f i u a m p i a -
f a r e i o /o d i u e n i r t
i‘ •
t a n t o a u a n t i , f e n o n p u r p e r l e o f f e r u a ti o n i d a g l i
%
a p p r o u a t i a u t o r i t r a t t a t e ; m a p e r q u e l l 'u f o , c h e
io tA l h o r lo r o a g g i u n g o , n o n h a u e j ì t t r o u a t o f a r
(t
, ch e n o n è c a d u t a d a lla rn é
f i n
o r i a a e l l 'E c c e U e n ti a v o f l r a q u e l l a c o m p o f u i o n e
,
a n c o r c h e m a l p o l i t a , c h e io f e c i p o co
i
ch e e /fa fu le u a ta a lla S ig n o r ia d t F e r r a r a .
;
m a te r ia a d u n q u e ch e f u ,
DON H EKCOIH
RIA
L i M ’a u t o r
V e n v 't A d i
NELLA
TN
P s u a t*
AI
Ai
J
SIGNO
D jl F E R R A R A ancor che d a l CO.fi
i fuf/e jé > r ta ta , p o te a n ondim eno v e n i r e
a
me
o n w tf m a g t a n elJu o u n iu erfile d a alcun nobi
le am ico , o non tr a tta ta .f e g i à t r a t t a t a } io m i
p o te v a a quelle p a r ti d el p rim iero artificio com
m e tte r , che m i f u f i r o p a ru te con u en eu oli. E*
m i farebbono bene f i a t e , come ben fu ron o, me..
Z a n e a l l a i n d i g n a t i o n e d i q u e ll! a r t i f e i o , c lie d a
m e p o t e v a n e u tr e
che c i v e n g o n o
: s a
p e r c h e t u t t e le m a te r ie B
d a v a n t i d a e f fe r t r a t t a t e d a n o i ,
v e n g o n o co n le c ir c o n fia n tie d i p e r f i n e , d t lu o
ghi
,
di te m p i,
q u e l l a , c h e io
a
s a
d i
co fe f i m i l i , n o n p o t e u d
l a u d e d i u o j ì r a E c c e l le n t i a , m i
p r o p o f , u e n i r a l t r a m e n t e : t m p e r c i o c h e e f fe A d #
la f u a u n tu e r fil q u c jla ,
C
N
o
r
I A
V
e n
v
t a
I N
S i a
; fc g u e ch e d o v e n d o la a p p lic a r e io
a l l a p a r t i c o l a r e d i u o j ì r a E c c e l l e n z a ; iof u f i t e
n u t o a m e t t e r l e d ' i n t o r n o q u e f l e c ir c o f i a i i f e ,
Don
h er c o l i /
f e r r
a k
a
:. pcY
1
T R A T T A T O
le q u .d i la m ateria particolare fuffe questa
V I'N V T A
MELLA
DI
D O N
SIGNORIA
HERCOLE
DI
-
F I R RA-
R A . Or che do m a fa r to ? d om a prim iera *fnsntc., come f e c i , ueder fe n eg li ordini m iei
frouaua alcuno artificio ridotto all'uniuerfiale *
ilq u a lm i poteffe m fibrate tl camino A la t?attaticn e di quefia m ateria p a r tic o la r e 0 (è h a
nefii trouato pii* di u n o, qualm ente iftrouaifaT'
mio officio era di correr fubito alla particolar
mm ateria , 0 confidi r a t ben le circofianfe fu e,
tira r dall'alte'Zfaa, quell'artificio umuerfale *
th è più fuffe i i aio accommodato al nome della
perfona , del loco, 0 delle a ltre circof i a n f e ,
0 unirlo talmente con quelle , 0 'quelle
h i : che dell'mime)J'al artificio, 0 deliri p i* a *
colar m ateria haueffe a riufii e un corpo f il o
pieno di corrif i ondofae : perche io m i ricorda
v a hauer letto in Gal. nel libretto de opttma eie
Oione , fcritto a Thrafibulu, le particolari caj
g io n i , o le in fe rm ità , che d ir vogliam o, 0
1/indKdn n jn
communita , tu quanto communita, d a deiie cofe re inditio delle cofe utili : perche ueramente co-
ralle***1 f i comt nonf i ^ t e ^a r ^ o d ie r n a apprefi nella
gioiti par fu a e. m m u n ita , in quanto com m uiu ù,A la inUc viari. j ; rm it4 tlf un particolare , Ce in quelle non con
fient ono tutte le circofla n g e dell'inferm o, nel
numero delle quali uengono q u efle, la cagione,
fi loco patiente , t e t à , / cfila m i, le g ra n d e zze,
0 p ic c io le \fe d e g li acciden ti, la n a tu ra , le
f fagian i, 0 le ragioni ; cofi non debbiamo ap
plicai e un artificio f i t t o w u u e r file , in q va n tf
a
J
15 E t m '* {% T E R I T .
;
M v e r f a lc , ad alcuna particola* m a te ria , oso
prim a non veggi a m o , f c confa arc<flanze*li
quello cfloconjàr fi pp/Ja,, E ta c cfi che l'alt*
/p ir iti d eli)Eoe òlientig-mfinCg diabbia commi*
d ite di confiderare almeno uno ritagli aftffìgL
miei ; io le
v.
' ;
eh* io allaflarticolarditi Moria della fu defaJtetjp
ne applicai » _ > * •,& )& & & & ■: UosoV.f"*V '
fa'
■ m r c g m im o ^ h iq u e fio cerchio fa¥*gQ*£<Ì*:
*
dal qual f i partono ,
d i a lin ee, delle q u a lp leje tte ^ a lla -fa rteifo l? * ■ habbiano dallafirnfti*a fittie ‘Hi fito o ppofieji, - v ^ ^
che ciafcuna frapponga all'altra nel m ejefim a
"se:
filo corri/condente *
,
v
^
^ j f 11 p r # o artificio uniuerjde è ffe la peifona,
c^ ììam (orrem o 'lo d a re, 1
)aHYà b e l l e f j a , o a l/
Ira dignità m a norkarte;noi potremo p e n i fo n
te topico*# Simili 'aJ]'omigliarldàUa,fiu folla cofa g lie ueggianto nel cielo:poi per uirt/i de lochi
•ah Antecedentibus ; #. Cottfeguentibus , s a db
A dm nchs potremo fare andare auanti,o configuire, o potremo ancor ftn Z jx n ecefità aggiun
gere alla perfonaquelli a o cid ffft n o ta b ili, che
Mia più bella tif a # che uegjgi0no nel cielo, o
nella fu a uenuta, o'nella prefenxa > o nella fu a
apparente benignità precedono, confeguono, o
aggiugnerfi po/Juno, sa gli oppofii pigleranno
tu tte le Cofe contrarie. Ma quale è la più bella, ^ ^ ^ ,
& la più degna cofa che nel cielo pofiiam oue- ja piu de->
dere i certo il Sole. Che co/à ua ava n ti il So- g na cofa,
le ? le tenebre, lequali appreffo feguono la fita Jjs^posoa
p a r tita . che cofa confeguelauenuta, s a la pre- uedere.
"sasa‘ V
fi*'- H' dmkj*' '* "4
[-
V.vsa
^
^ v !^ *
-c
sa
*
‘’ * *
A; T T A
A
^Vv•
T o
f im a f ita ? Io fpUndor* » </;< cofa f i può aggi»»
g tg r c J C o n g iu g n e r e intendo quelle cofe rfh e
non fono fempre necejjartc, m a aggiugnere fi
pofjotto, cotpc,ifiyny cii*llafv(i (tenutafi leva
no , corrianeor uriapparénffia dt fecolo aureo ,
m afim iam ente nella p rim a u era .
•
sa..
f t
i' f
11 C O N D O
'
->
ARTIFICIO.
. Se /4perfona haneffe alcuna arte; fi potrei- .
fono aggiugntre alla trattatami gli iddtjdeUa 1
sua arre, osomofirar, che altifua venuta
ancor il Dfa del?arte fua ucnato
\
f i a , oso eh’offendo prefetti£
effofia ancor prefetti
t i il detto I d d io . coso
.?-, \
■“
sa '-«fc.
sa Usa -
thè partita iplóptàna pnfatkt^A
.^‘
partito 0 lontano H Dio d d » i;:
rari*
•••sa- •>
S A
.-'rfc.V
;sasa*<*
- A 'e.
’+À
. 1 : " ' *-
m
sa-
\vsaN
g &
v ri
sasaAsasar*' sa sa - , - v
; r*;sa “
•
. ' ^ 2 5
.3* salì **
‘* 4 sasa?
essent.' 17»
T a A t T A ro
■ . Vesse
r t / I primo artificio adm iquf ,0 anco tific o ^ - '
do fervono * tr e maniere divenute, f i l a ljr g a n - *
te prefenZj ? ad altre tante partite , esse nse à lttre tante {on taifanZ j, esse alla benignità, che la
perfino, degna può mofirare confa fua prefen»
f a , esse anco Ala ira 0 Alo sdegno . L a p r i
m a a/unque delle venute e quella 9
-c h e f ac clamo
con la v ita in quefio mondo: 0j,pse(la jh ìa m ìa ^
Wfffdmjfo pio altramente nafeimento : & ha per feguocr
laprefirfaa con la uffa : perche dapoi,che la per , |
f in a è nata > è fa tta prefente a n o i, cl# . f i come i
esse
il nafeimento era nel moto sa cofi la prefetfaa è
4'
' .Dello sla to » Q uefie due tratto V irgli io nel n a . ,
v *- ‘ foiwt^losi del fanciullo . celebrato tirila egloga fc ritta a tfollione t p & la v ir tù d e lìa c o a S iL o so .
M i l i ^ fig lia n d o la f im f itu d in e d e ly ^ T f o - ^ ^ a
.v
•#
m e cagione, esse le téfefifie cppfiguenq , 0 f i v
V
H v ‘ etggti/ngo/ia A la te n u ta F r a t t i prefen%à d el „ /
Sole’sfacendoci Vederi u n /g r a n Jpetie npn pur
della p rim a v era ;.p ià della aurea c t à .l a q u f i
'•lesse'
t * £ eH f ^ v g a ; io pofi fotto/friH efofi*
" jb A/le predette d u e , g ran f i ornamento àggiunfity
ÌlV ct%velU C anX one , *
K
k
TacerStoUpoffo. esse
esseesse .
*
fo l d ì^ th e ^ fie i nàcque eran le stelle *
.
eCfo P T fifito ty fix w filic i e ffe fti.
..
esse
esse*
L u t w uer PAtrjt con amor copuerfe : esse esse
Venere à i padre conbetiignì a ffetti
Tfneapyle parti] ignorili 0 belle ,
E t le luci empie 0 felle
Q u a fi in tutto del d e l eran d i (perfi :
■•wssa;
■-? :. V V .'
sa «*■-.
* sa- &*
-i-.
, .-' sa v.t®
^ * , D 'E L L E sM A T'E R I E. i ; j > , ^
i l i Sol m ai pit* bel giorno non ap&fe ; &
sa * y
V a r ia , oso la serra [a lleg ra v a > oso Vacqttt^.,
' T r ito mar hauean pace, oso per li f u m i • fsai
»
Et dalla medefima fim ilitudine, et dalli mew
defimi configuenti, oso aggiunti poco f it to ce
lebro la preferita dopo il najcimento con quefli
u e rf.
s a " ■■
vN ysas • •'/•Et bor carpone, bor con trem ante paffé' '1
safenrgno, acqva^ terra ',* f i f a ~
Verde f i c e a , chiara y fóau ez l'berbit
• Coti le palme & e ò i piè fi efia y fip e tb * f* > . >*V
Et fiorir co* hense ocelli le Campagne sa
sai
- Et acquetar i venti oso le tempefie
' *■"iv ssse
Con uoci ancor non prefle
•
Di l/N jA » , che dal la tte fi {com pagne ,
<
sa
Clnafrmo/ìraiulo al mondo fiordo osociecon .
Q uanto lume de! d e l f i f e g ià f ic o . sa
Alle predette d u e , cioe alla venuta c m t i u i t H l
' >>
laquale è il na [cim ento, & alla prefenga c o n ti
sa* ‘'
ì v ita dopo il nafiimento ,fegueno d u e , che loro
f i oppongono : cioè la p artita con la u it à , chea; *•
t i morte, oso la lontananza conia v i t a , daqufalMcrttt.
mófiriamo effer , mentre f r i (d a m o d i alcuna -i sa.
a n im a , die f i f e g ià incielò sa le q u a lin o n al
tramente , che le precedenti con Taiutò 'detta f i mthtudtne del Sole oso de g lia ltri f in ti topici
& rifaleridono > oso con fia u e mormorio corryno. V eggiamo netta morte di D a pi m ie t d i Ce
sare Virgilio hauer e ufàto quefio vocabolo é x tinfìus ; coso come cutfiutidi loro [uffe Statò in
v ita un Sòie al moftdo l
-sa " sa '*
E xtinflum nimpha ctjidefìfunrié ÙaphnirJ
Fehatt; •' sa -
.
H
'm i
Mae m ar aviglio fa è l'eflmtfi nella fin e d e l p r im i
della G corgicagperchedmQflraghe'l S o le & U jft
negg en d o jp en to jl f o t terreno, fi m ette/fi f i t t a
il capo u n te lo firrMgiJtiQ^ ffp trflk due Sol* fi
veggono ffien ti .
..
^ .
....... :
ìlle etiam ex t infilo m iferatusCajare Rofnam*,
t Cum caput obfcura nitidum fcrruginepexit,
ìm pióq; aternam tiniqerunt fecula n o li erri.
llq u a l fenfo fe i\ Tetrarca noqyapprcfnfo fon
quella f o r \ a , che havrebbe potuto nel prim o
quaternario del ter\o Sonetto; hebbe riguardo
alla d ebilità ietta prefa m ateria noti p o ten ti
f if le n e t f i g ra ve p tfo nelprincipio , 4 cui i l ri
manente noti poteva co rrijpondeff • ,
Z r a d m ^ ,,f lS 4 M
*' f f
J T e r U p te à d c lf io f a t£ o t* ir p i .
g
M a per t n f i ' g m ^ S e ì f o c a nella n f i f i ì p i
U t pione tr o tip ff ^ ^ r f ia p n o n e lS ù le , che non
fece VirgiZsaaw^
MoptuoScipio-
m S fili € ttU r e c io ti . ne perptÌjrQ tf#ti {tffitpjg
f« non il modo, d i a c t o m m o ^ l i ^ ^ t p i / i d f r r
l e ; percioche Cicerone vio to fifa ttep a ro le
Ja p artita d tf f vrnpeo da I ta lia , ma diffe d eg ù
d i t . laqual m utatione da indicio , che la p a rtita c o flle m ta # g y l a p a rty # d i alcun U o g iliè l
P ig ft
w m m m * s m J Q
‘m M f f *
i
.Occhimi^pfiforat9 hiUofiroSede. etfahroue
JP tfio f orato, Infi
solfori
C he mai f lu id e , e i p ìv baiocchif f enti . s e .
f é *!?
gM iidcgH eu ^ '
"u
h j s w K f$ *§
•
& •• se*
oso
s
.
DELLE MATERIE.
175
VE’/ mondo rimaner ferina il f i o S ole.
0
Lume de g li occhi miei non è più m eco.
Loco prefj'o DittmT, Derelinquit me uirtus
mea,et lumen oculorum meorum esse ip fim non
9 ejl mecum. esse nel fonetto
^
Spirto fe lic e , che fi dolcemente )
’
f
Co£rae dolcezza collocò nel fine il cader del Sole.
, ^
N e l tu o partir Partì del mondo amore •
'r
Et cortejìa, c'faol caddedal cielo.
'
/
Mae che eforipio dar emù m i per la lontanane
esseS
£ae Con la u ìta , ferfad che partiamo dal Sole ? ?
I/ \
alcuno certo , che dtmojìrerà l'anima della pera
!
fin a am ata nella lontananza fu a file n d c r { 6
(K
I
me Sole in c ie lo .
‘
esse
*
-^ O cch ijffei ofcurato à i uofho Sole fa
esse
r -’
y y j f f f A i t o al cielo, esse iutsplendo.
Q u e lli, che /u delseco? n ojh ohqnorèfa^ i»
H ora e del n e l, che tu tto orna & nfiffixhfZ
!
Diremo mede/imamente, c h é ti venuta indai
t o , cui fi oppone la lontananza, da locog e r it iti
mente dimorano nella fm ilitu d in e del Sole, esse
nell apparir esse nello f i o r i r , ilche rtranifejìamen(e fi può comprender per la venuta d i V e*
nere appreffo Lucretio. ' ***
b
\
!
n
T e Dea,fe fu giu n t u e n ti, te ntihila cocli ;
Àduentuq; tuo t ibifuauidadala tellus
Subm ittit f u r e s , tib i rident aquor a p o n ti* i
Vacatumj; nitet difufum lumme corium.
esse
Lequai tu tte fom enti e fono prefe d a g li ef
fe tti , chef a nella primauera il Sole, cofi V irgi
lio imitando T heocritó.
Aret ageruitio m o rtem , fitit aeris herba 9 *
m
T R A t
T A^T Q f f f
1
Lioer pampineas inunht collibus umbras ,
ThylUflis adventu m jlr a nemus omne virebit,
ìu pp iter oso lato de fc erniet plurimus im b r i,
*
u
*i.;Et perché il? etra rea per l d ueputa et per t i
p a r tita , per t i prefeu\a oso per Iflontan ariZ j
fa c tjjè Molte belle efercitaitòni, non fi partendo
d a l Sole, come quelle iti t r i i fo n a ti t v n dqpo
Coltro M i n a t i , de quali il primo è .
’* ‘
#
Q uando fa ll proprio fi teJ iriryo u e.
' j
^
-i 'Anebor che con qualche uelo, perciqche per
f d r e il te r z o , nel quale f a mentione anchordel
f
S\de celefie ,fèce Ucttiè precedenti i nondtmenè.
*
quidlosóìdiu rn o : ; * > £ ; . .
‘
iU\ \
Se'l Sollevar fi [g u a rd o ; fi .
i
‘
Sentorilfitfiydpparir [ch e m * in n o n d a i
AS e tr a m m ^ ffM p ).
Tarm iitH d& 'qU aadàfi volge a ltro v e,
. L a fidando téì/ebròfo. 'i onde f i mone
r 'f
fa R o n w o lto d ifiM le /fa q u è J h fi- che pertiene
étti pa rtita con ti a tta
'V ergendo a colli ofcura.notte mtot/to f ' f V - O nde p reiidifli al ciel l'ultimo u o h ,
^ ^
xlU douegli occhi tuoi folean f i irgiorno . v*\sa;
w Della qual p a rtita lasciò nobile efiercitationi,
^firgjfio ne p er fi 7che nonno avanti o lii tnofiri
d i fo p rii, p # r ìrttftandu T heocrito, ne quali untbqf. ta lp iè fe iiQ f celebrataci con# ne p red é tti '
v y$* V . ,sasa'V V
fistdnt y ìkkipeel oso effatn fa hirfiuta, (m a.
r S trata tacent pofiim fida quaq\fiub arbore pò»
O m n ia nunc rident : a t fiformofius A le x # ' ^
M o n titi# his abeat 9
videas osoflu m ina f ic u .
..Cfcefcettfl « ■'■ ■ : . . T , -, v aMa
«a
*
^
■
!
D E L I E M A T E A I? a i7
7
r0
t Mae facefalo ritorno a g h f w t t f o t f JPaesraerc^ 5
dico chefra g li altri. Ivcftj, douescsraelsaede//ae
ugnata esse d e lfip a rtita
•
p u g g e ael wos&v apparir? fo g o f ifi
E tneluaftw partir ternano f i f o n e +. fa f tif a
h a quello c m a rw g !to fQ h # té p /t^ e n Z j/t^ *
Faeoeaew dubbiar fe mortai d on n eo ditta
.jy
Fosse, che*/c/elrajfpremuta intorno +
..a>
Et ancho quello, che g li fa dolce compagnia#^
non porge minor m araiugha.
. . . . . . . '•
U ctel di faglie esse lucide fanttte
<
.. »
.—fa'faaccerffe intorno, e Vi u ijla ft rallegra
Ttejfòffatto feren d a fi begli occhi. .
Et p erla lontananza ,o ltr a q uel/h àhdhbì*^
mo moflro di Virgilio ne uerfi A ret agejr * «off
fio no da JfireZfagar quelli del Tetrarca , che non^
fi partono dal Sole .
, - . si si. sai
Raero un fìlentio , un fotitario horrori ffafai\
D'ombroftt ferita jn a i tanto fftipiacqu e*,.si ... c.t
Se non che del mio Sol troppofip e rd t» \
E t per tratta rfo elia ip n tp n a n X * d i a ltru i)
non folamente pofiam o àim ojlrar l*incommo
do , ih e ne fe g u e a l loco, nelqual ftam o nonni*
anchor il commodo,che riceue il loco lontano 4* r
noiydoue la perfona fossa* comefece
f* ‘
Caen^ope oltra q u e ll'a ìp t^ p . esse,, ,.
L a i deìue il cielo è pia fereno & .U *tp & s is ii
• Mi riuedrai fopra un rufcfa c m e n p e ^ Y
EX in quel Sonetto e b e jo tin c a l
V
~
"
-V -
—
'
sa
179
-
ari
TRATTATO
b a t t e t t e inariZj rèi tuo corfo non f e n a
M *M
N e Stanchezza nc fanno ; oso p r i a cherepdi
S u o dritto al m a r , fiffo u fi mofira atten d i
xV herba più u ertie , oso P a r t a più f r e n a ,
T r i è quel nofiro nino & dolce Sole ^
. ^ sa
' C b'adorax'jtfiota titu a r iu à m a n ta .
- Etjper quefia medefima r i a trovò' tdtrouè il.
Tetrarca modo tlt m u ta rla m araviglia d i una
in altra cofa , m o lto notabile:imperoehe f i Come:
V irgilioha fa tto afcenderpaph m in cielo per.
il loco a cm/èquentihutp oso a b o d iu n é lis * f a
N cheeffofi m ararigh a delti eofr i tila fu y co fi il
Tetrarca per li m cdrfim iluoghifinge /chequelli
4d i la fu prendono ruararigli a d i uede^uentre a
lóro anim a fa b e lla . oso Ì M e r f i.d i'V ita to / 0^
5 u e sit‘:
^
- W
j ;
gCandidus infuetum m iratu rlim en olytnpi .j
Sub pedtbùfq: uidet n u b e s ,y ftd e ra D aplm à.
-* E t quefli del Tetrarca., *a>Vt
'Gli angeli e le tti oso Camme b e a ti « a «J&v ... s.*.s
C ittadine d el Cielo il .priptogiorno f
- Che M adonna pasco , lefuro intorno
v.»
Piene d i m araviglia , y .d ipictade *
Che luceri quefiOf oso qualnuoua beliate
Dice antro, t i r , perx'habito f i adorne
sa, >\
D a l w o m lO ie r ra w te a q u e fio a lto foggiarne 1
«Nonfa lk m a iin .tu tta q u efta /eta tea a-qA ,>sa
I . Ma p e tc h e n o n u e n g ^ io at .móftrar liom ai
■per le altrui compofitiotù, che dadi m ed d fm i
fo n ti pqffaanchorjeerir a cq u a alle.piante, che
pertengonoada uenutain.Signoria p & altifua+ppvfia 9y a n c lr ia lk jr x fe ii 7
& in b ig m r ia x ^
V
aÀ.
"a.
A"
DELLE MATERIE.
179
# à quello, che le f i oppone ? nel vero io uengo a l
prefinte s a d ic o , che quantunque il Tetrarca
face/fi quella bella Can\one
■
Spirto gentil*, ' ■
a Cala K enxp-m enttt
fu eletto Tribuno d e l l a plebe , tlqual m agiflrai 0
tn que tem pi era fupremo in R o m a ; nondimeno
pefcheconjùma tu tta la Cannone in efortat fa
tte , che è m ateria diuerfa d a quella che p erticò
ne a l celebrar la creatum &'un. Principe » iltrA ,
che il principato è p erp etu i, d i m agi fira to tem
porale 1 ella non a può porgere alcuno aiuto nel,
nofiro tm e n te . m a conftderata ben la egloga di,
V irgilio a Vollione trono, clic in quella non f i «.
Irniente feda il nafeimento delfanciullo, m a an
f i j o r U p g n i r i a , che atti)or le»eua Toilione, in
e fìn fté tfi,
;...oso
T edu ce fi qua manent feeleris uefligianofhr}9
Irrita perpetua filu e n t form idine terras « 1
Appreffo io trouo , che egli celebra la Signo
ria , nella quale h a u ta a venire & fanciullo, la #
qual celebration nafce n e l più -da g li effettiprecedenti, chefarebbe il Sóle in una mar a n igito fa prim avera ,J a q u a l f i haueffe a cangiare
in ficaio aureo: { y a u e r fi f i n quefi* AriZggtù a l
fanciullo» ...
.
ì ,
.oso. ,
• H inc ubiiam fir m a ta u tru m te fecerit *ta$i
. C ed etetip fi.m a riu c£ lo rynecnauticapinus
; M u ta b itm erces, omms fe r e to m n ia telbts**. >
& reliqua*
. oso. oso.-oso ' j U. h Vi?? ’
M a che Airgmo della p r e fim za in S ig n o ria ?
f io e d t g li’effètti 9 chenafcottoda colut^chtlien
jjfo g e n ttlm e n ti da S ig a o r ia f saaelw? dkern»
•Ih.
r-t,
a
T r
a t
o
s i i
Anchor della p a rtita d ‘alcuna Signoria ? c K v ,1 i
delti lontaiuvtXji da quella t benché quejle due
*’ «
ultim e per tengono n o n a q u elli, che nafcono
Vrtrtcipì ; ma tt quelli , che nelle Republidie en
trano ne m agifirati esse poi nefeono. pur che di
remo , non trinando fi ne Poeti alcuna tr a tta
ta n e ? io per me direi quel,che dice Galeno del
predetto libretto de optirna electione: che e jjh i*
vdb'alcuna in ferm ità , le cui cagioni noto f i cononon cono f iom » f o
ti0afiretti i medici a trajportarfi al f i-
fruite fou m iti,reg o la n d o nelht lqr mente per lafim ilitu*
teda fimi dine deK
g lt accidenti : 0 ci da quefip efem pio.
le.
potiam o che alcuno fia m o rd a ti da.quelVàmma
tiam oroos per il qual m ordim en e f a cadutp
iteltiw ferm ità delfiuffo d elfm ig iieiq u u & lo m ii^
X
fuffe nota la cagione al medico . p e r la q ft/tM l
mor ditto fofìeneffe il detto f i uff) ;doUrebbe por
g e r quelli rim edi, che fi danno a i flufii del fa n g ite per dtu/fione. per cofifa tta cagione ip ie d i0
4di Gnido f i donano a curar quelli r che p a ti
nano ne polmoni ,tra jp o rta n d o f a l fintile ;cofi
diremo n o i , iquali pòi che bob/riamo nel g ra n
cerchio, che gorgo il chiamiamo, tan ta acqua ,
ehem inifita Chumtdo per tante maniere d i uen u te , d i p refen \e, di p a r tite , di lontaitiffae ;
anchor ehenon trouiamo quella che particolarmente v ic m per bagnare i l campò detta pa rtita ,
C T delti lontananza pertinente alta Signoria ;
nondimeno f i uogliamo dir anchor, che g li op^ *poftinoticipojjanom ofirare Ionia di tr a tta r la
predettam ateriaK iA ir A m en potremo ? c h eli
fum ili, cioè le preferì^*? l e .p a rtite > 0 d e lo n -
^
nan\e pertinenti o alla ni t a , onero a l luogo
et pojjòno a l beneficio delle al.indom ite im pre
c a r i m odelli. Apriamo apriamo le. p o r te , le quali tengo» ehtufi t r /u i, che uedremo l'acqua
pernejjima parte poterci numeare » Rosojf che
dichiarilo alcuna cofa della benignità, s a dell!r it, che può mofirare il.Trinctpe nella Signoriaf.
ma che f a bifogno che in quelli io j/ie tta m olte p ,nigni >
parole.? V editano fila m e n ti D a v id .;, liquefi ta, e ira in
volgendo il parlare a D ia , che ha la SignoriaSl^n° 1^
del tutto,dice sa p e r U b e n ig m tà g y lo sdegno, i.
Ottima e xpefla u t a te , u t cUs.ilUs cibum in tetri
pore, dante te illi colUgent, apericnte te m a m m tuagi omnia implebuntur bonitate, averte
(te autefi. te factem turbabun tur, auferes j f ' r i
tum io ru m , s a defeient., s a in puluerern reuerteutur . E m itte jp iritu m tuum , s a creabun-.
tu r , s a renouabis faciem te r r a .
quot lochi
tu tti pojjòn nenire dalla fim ilitudm e del.Sole, et
da i configuenti s a aggiunti pertinenti a l forpmo Sole; che e O io , lequaifintentie im ito il Te
trarcam m olti lochi ^et mafiimamente m quefii
J
u erfi .
• cosooso.
• . 'r
A pena hebb'io quefie parole d itte y .
v Che m di lampeggiar quel dolce r i f i , fo
. 0 1 un Sol fu g ì# d i mie uirtuti a ff litte . - .*
Era adunque ta benignità della fu a P orina a
g u f a del Sole , che folleua i fio ri laguida,s a coso
bàttuti dalThumìdo della m tt e t f i fiiafcìaua ue
der firen a . e d i nuom V abbatca^ m en tre f im o
firaua turbata .» d p e r ^ y ^ f le Mfip.ouc yt i osof- »c o m A & o r.h invita# -
T jo r ride fio r piange, h a tem e>bor iaj]ecur 4
jjp ^ f
E 7 volto , else lei sagwe, ove ella il mena ,
*
Si turba y rafferm a,
; I epnsesanse pcrtefigonoa d o , thè f a r poteva ^
la ftMXXopna p erla Sigj«osse,c//e haueua in lu i.
i
ewa hew pofa<w p fin ti r , nsee junse i rtui a chio ,
ho d a to ti gu fa r, per fin o ,a ffat* rtncbcr che fin
d t f e r e n t i materie ? pafcono d a un fai gorgo ^per
•• j
la fola fim ilip id tn e. ilqual gorgo è fi tnjeccabile , che a t p p i je n z a mancar m a i può baflare .
E t f a t i lo s ia detto m n g ia d i p u d
s<yjff*ficij,
thèpotrebbe™ ejjèrgdopfrati nella Jra tta tien * . r {
\ delle deUe eu4U nc y m a de} prim o prqpofio ,
bor^dafeqfawM nse^plod i quell'artificio , aesitfu "
s a # feconifcA ico eh* Virgilio a rila quinta g g fo A y ^
ga. celebrando ìa deificatiopM J>qphi*tra le a U
tr e lapdt m e ffe ^ é fa *
che D aphni
p a rtì con la u p a d a q u ejfti/p p tfa ^ p M ro p p ait*
ehora i D d delle a r ti di l J t t p h n i , p a ì .y f i p g l io y Baie,»
v -,;sa
T y d e e u s otpne taisfaopquam te fa ta td e r u fo
Jpfà Palet agros ,.atqy ipfe reliq u it Apollo. {; sa
Eaedicendo Apollo oso Fole effer p a r titi dfap. ,
campì \ mofhrache D aphm era p e rù 0
*pcn;pur
v rifa te * , d a jp ftp o n ea lp fa fler* h rpaanchor in "
■quellajebe p tr p fe p fd T & e t a ^ m U sE ftro u a . ,.
fN p l i u o ^ À j r ^ r $ l d e b m ^
tiakriV. ;
, EA Cort*fiu^. A> .% ;
S'saMeS- ^ a f t e y n e a # # w o s o u o rtfa a fajfero Iddi) ».
fy ? e * t# fip 1
*tifaQ ~ ìtiln fecero a u a n tiil E e-i.
./Tdsrca y ? f a u t t o y X j m t l io, y w o l t a prim a
■T
^
fsae \
oso \
k
^
£
\
D E L L E M a T E M E . it j
flùido partita la fila donna dotta città per d iti t
dare Ala uilbt, 0 Venere esse Amore effe te ti# fa
de fintamente andati in uitta e
‘ ;
Rura tencnt Cornine m e am uilh qu e puellam a
Terreus efi eheu quifquis in m b e m a n e ti * Ipfii V entts latós ìàm nim critigrauit i n a g r ò if s i
V erbàque aratoris rufttca d ifà t A m or si ' - ‘
Et cofi da ornamentò alloco [Aqudl atjffo ho Donna nel modo'* ch'io drfii foci fipra 1/auerr
fatto il Vctrarca nel fonetto si Gli-angeli Aetti cF J
[amine beate » Ma che dirà drVirgilio ? arfifòchedirò di Theocrito si da cui prefi il maraui- gl*ofo artificio Virgilio ? $tr*peroche cangiando J
fp f /unente^, tl 'riùmt di Daphtii * nel nome dò
Gatto,, 0'AcunaAtra cofitta * cofi rapprefinio i dtuimuerfidi T beòCrito..
Qua nemorataut qtti ttos filtUthabuere fiteti e>
N aiadef, indigno cum Gallus amore periret £ : ■
Namricf, Tdrnafiac/biséHgdituirtrnèqyTindii '
Ylla moramfecere+ncque.Aonia Aganippe^ •
Non Atramente adunque, thè fedff Mufifùj%
fero Dee, dice che erano far ti te.da Varnafo,%dal Lindo si lòchifacrià effcMufi^ Ma perche
finge la laropartita dàtutti queluocì» diurni ?
certofa bifognoche in tendiamouno .anteceden- i
teyciòc che Gattograndifiimo Toetà f i ne eràsi;
partito dalli medefimi lochifofpinto dalla doglia
prefa per Lycan,.che già riabbiamo dettò effer ’
gentilif i mio artificio iidirjielle'partite di Acùno >chefi dUctti di alcunajtrte foi Qei àncbonf J
di queirarte eJJarnepartiti si 0.[oppoftto f i dessesi
rebbi itektJtemtti* & } t r U f a r t m d i ^ à ^ À
t«4
'T R a T T A T O
qu e lochi fiacri, fifiee intènder che Gallo pct upatQ clal dolore non dami più operata p o em i.
s a non è. mijior jii confegunite /a n z i l'aggiun
to topico-del predetto antecedente : imperoche
dicendo, chele Musa non filafciauano trottare
in peffun de lochi a loro fiacri ifigne.* a n \t a g
giunger ut f i può la prona . percioche i Poeti*,
t quali volendo com porre, hanno in cojhm c d i
chieder aiuto dalle Muse, non lefapeano trovar
in alcun de lochi pertinenti a to ro , mentre,
in andavano la g r a ti a loro. Cofi T/bullo volen
do mofirar che Apollo p er effer innamorato, erg
infanto adjfltra cofa , che a g l i oracoli ^ prova
ta l occupatione d a g li aggiunti topici. perei och^
aputti+fihc kauepfanffyfggno del fuo reffonfo ,
f i ne ritornavano a cafafenza hauerlo L utato ,
tlche dava sogno cfo Apollo era lontano dalli lo c iiifito i.
s e v oso
; oso ,
Sape duces trepidis petiero oracula r e b u s ^
Venir s a è templis irrita turba domum . \ .
• E t fo co fiotto
’o s o (tlw ?
'Ùetos u b i nunc Vhccbe tua efi?ubi delphica P j
• V cm pe A m or in parua te tubet effe cafa . ■ .
v Eidetiche non fi trouafje n e g li autori alcuno.
ejèmpio per le prefen \e & per le lontananze ;
unico rtmed iofarebbe, jcontesof r a d i fr i , il t r a - .
f l i r t a r fi alfintile y ìA&doucuo io ? fi£bi m i ha
condotto a ragionar/djqHefii dite :artifici tanto,
Intuendone mafiimamente ios in altre mie f a tioso
che altre u o ltt non poco detto ? mi ha condotto
non pur la materM uniuerfale V E N V T a IN
S IG N O R ÌA ) Iftquale èjtp p lica b ilcA tu tto fa
efalt adoni
f
*
D E L L E MA T E R I E .
iSjf
y cfaitatim i de Principi, esse d i altri nelle Signojfa r ie y ma anchor quella particolar, VENVTae.
D i D O N HERCOLE N ELLA S IG N O R I*
D I FERRARA ; accioche tt offra Eccellenti»
uegga il configlio, ch'io prefi nella elettion d el- ,
la rtific io . EtheQjJje fiano pju altri artificij*
iq w li d ' iriforno Ala materia predetta uenit
« poffono ; nondimeno io di tu tti elefii quelli due,,
che fon dentro del predetto g o rg o , come p ìu jti* u
tini, esse per cofi di ce,più applicabili . g y fe ben
V* detti due predetti a me pia cque m aggiormente
IL il p rim o, che'l fecondo ; non è per tutto ciò d a
^ dire y ebe il fecondo non li abbia cofa feco , ciré
co la detta particolar materia non fi poteffe con
fa r e , imperoche fe effo non porge altra tnuend '
t
tion e, che Caccompagnar con la uem ita del Si. >.
gnor nella Signoria g l Iddìj dell'arte, d 'in to rm ^
atlaqualfi diletta il Signore; certo uofira Ec c e tix
lentia nonfolam ente per effer principe, esse per .•>
tener principato, che è la più bella arte, che f l i t !
fi poffa * ha il Sol per Dio di quella ; m a anchor <
per dilettar f i , cornefa d i poefia. perche non pf* >
re i principi ; m a anchor i P o e ti, in quanto i :
Fuetifano f i l a r i , hanno Apolline, cioè il Sole Poeti,eoe
per Dìo della t ir a rti» A ggìugm am o, che hauendo anchor t i m ilitia nette m a n i, quando le Apollo j>
piacerà, non le è lontano M a rte, ebe è Dio d* *Pro Dsi>.
quella. £ t inuero fe la compofition »ch*iofe c i [fa
foffeTlata lunga; Laurei anchor introdotto m \
Acuna parte il fecondo artificio, ma non m i
tendo Stender in maggior circolo di quello , che fa
ttu daua t i legge di quattordici uerfi* elefiiàl ^
t* t
;
t
r a t
t a t o
xa
primo : oso le circoftanZj ne furon cagione, neh: «
numero delle quali uengcno qu efle, D O N
H E R C O L E , F E R R A R A . E t perche
* P oetifernpre, mentre parlano di.alcuna c ittà ,
fi fervono anchor del nqme de i fiu m i, o de m oli
t i v ic in i, fai che f ufièro di alcuno nome ; io a g - .
giu n fi per circoflanZji della d etta m a te ria il
P ò , fium e nobilifiim o, ilqtiale bauefie a rip rcfientar i popoli/oggetti alFalteffifiauoflra. Coti
fiderando adunque io le det te circofian\e tu tte ,
tnfieme; conobbi la marauigliofa corrifa o n d e» - ♦'!
Z a tr a loro . imperoche tu tte nfiem e um u em - J i
vano nel Sole, oso nelTlro . oso ìncommaando
Vfevrole i dai nome d i uoflra Excellentia x udiamo iq uél ,
Jnc^chc 1 d ie dice Macrobio. S e in e c Hercules àfubflat%\
S o ie .
t i * Solis alienus nsev quippe Herculi ea Sohs oso
p a te fia s, qua humano generi uirtutem ad fim i*,
U ntdm tm proflat Deorum . Nec-exesei/wei A l-.
dim ena apud Thebas Baotias natum folum ^
u ri primum Herculem nuncupatum, tirnne poso
* multos atque pofiremos die hac appellatione d i
gnatu s efl , honoratufque hoc nomine* qu i n i
m ia fo rtitu d in e m eruit D ei nomen uirtutem r e
g e n titi, y reliqua. E t poco fiotto . E k t e u e r A
H e ro d e m Solem effe nel e x nomine o la ret.H ee
cules enim qu id aliud e fl, nifi h e ra s.,. id oso ae».
r is c le o s ì qua porrò aha Aeris g lo ria e fl, nifi.
Solis, illuminatio ? cuius recefiu profunditate
fairitus occulitur tenebrarum G ì a adunque habbiam o d e l nome d i uoflraE ccHlentia per a u to rità di Macrobio la fign ificatene dei Sole» ilqufl. Sole non e nel detto nom e?
/
*
'
D E LLE M A TE R IE .
1*7
come Dio di alcun'arte ; m a come uojbra Eccelse
lentta fu ffe , f i come e , il Sole m edefim o. E t
perche il Sole e p ia n e ta , che ha dominio /o p ra \
l'oro. ;grande c onfaceuoleZffahanno infieme.etI l'oro non fotornente trouarem o nelle corna d a te
j
da Virgilio al P o \m a anchoYnel fecolo r che uà
Jbré Eccellentia f a uenirein Ferrara dtuerfo dal
nome d t l e i , cioè dal f e r r o . difri l'oro trovar f i
|
nelle corna, cioè vede /ponderici P o , in quelita
f
miche auree, lequai percojjc rial Sole t oro ra p -\
\
prefentano.pcrche anchor Virgilio lafciò fc ritto ,.
V
E t gem ina auratus taurino comua uultu
^ E ridanus.
T rouafi fo ro anchora in quella primavera, .
• che può fa re A nafeente S o l e m a tale, che hab
ita cangiata d e l tu tto la qualità nel fecolo au
reo . non lontana ria quefio propofito V irgili».
in que uerfi a Telitene nel nafcimento del f a n - ,
ÙtdlO»
X
i
u modo nafeenti puero , quo ferrea primum^
‘t)efenet '9
a t toto fu rg e t gens aurea mundo *
|
-C afta fiw e L ucrna, tuus Jam regnat Apollo . ^
|
; fiL t dicendo xhe Apollo regna \ alce regnar H <
‘
Sole a u tor d t quella e t à , che i l nome prende,
dall'oro : & f i come Virgilio dijfe la fe rre a e tà
hauer a m ancare, s a a Jacceder Tastrea^cofi toso,
a fu a im itation e, benché occulta, dico che tu tta
b ip o rte F errea, che.in Ferrara è , fixartgierà
per il fuo nuovo Sole in o r o .
TEriforhito or o ri ferro tu o rito m a +.. .
V ien e un'altra arcoftanfet : imperoch# f a
y
-come a Ferrara configmuaper ttrcofianfog^iL
188
T R A T T A T O
■j
eoi 'cofi al Po consegue per circofian^a tl cigno\ » |
arriut or delle acquef u e . esse al marquigliofo Sole^tjj ■
consegne la marauigliufà primavera , anZjil
iflarautgliofofecolo aureo negri ultimi verfi,
>Al sin de lefue tacite parole
\ Ogniriua fio ri, cantò ogni cigno ,
W 'o r fi fe il fecol, laria esse 1acqua chiara, <■
t
i Et per dar ìnditio , esse che quefio finse Vrin- - *
riputo , nonfignoria , o magiflrato a tempo, nel
primo terzetto e quellauoce , ognlwr.
, O domator de m ofln , ojol qui Soie * '
I'
V otide, eli io uolgo ag li honor tuoi benigno,
jf
Rt[guarda , et co*tuoi fguardi Qgnbor rifrin a ta . : ~ . v v
- N on effóndo adunque neffùna delle circofin n
%e predette arte pertinente allagrandezza na
f t a ; non poteua uenir cofi comodatamele alit
tir trattatigli e il fecondo a rtificio ch e piglia i
Dei delle a r t i , come il primo , che tutto dimora
tirilafimilitudjn e del Sole, esse nelli fuoi eff etti,
anchor che effo habbta il Sol per Dio dèi princi
pato esse della poefia. Mae maggior honore ho
da to a uoflra EcceII facendoui, come ho d etto ,
il Sole ifieffo ; che fe to hauefii accompagnato il
Seli come Dio dell'altif i ima arte uojlra, anzi
di duey in que uvrfi dii fi/fa ti dal Vo a Ferrara.
: In forbito oro il ferro tuo ritorna ,
(Starne diceffè ; àn buotit i rei cqfium i ,
Et gli Itonor/pentì in piti r accefi lu m i,
Eoi che'l Sol nono in te regna esse foggiorna a .
Ó demator le moflri t o fui qui Sole. a
‘t Mae ii aglio hormaidar fine a quefia parte di
^
D E L L E MATERIE,
ih
S c a r tif ic ìo . perche fe io uolefii dir folam ente tuffar
éè ta quella, che appartiene al Sonetto dicato all'al
té \À J nofira interamente; baurei troppo da fa
re . ma ne f a detto tanto per accenderli bellifii»
mo fa ir itj f i o aWintelbgenZa d i cofe non vicine
alla mente di t u t t i . Or col diuin fauore ritorna
retno allarmai eri.1, The affai vagato habbiam o, Materia
*
k
^
ripigliandola nello fla to uniuerfale. oso dico fe* en™ confi
coìuIo la propofia, la materia, poter effer confi- deraw.
derata ofinffia pafiione, o con pafiione .fen Z a
pafiione la confid'ereremo, mentre f i prefinterà
tale al?eloquenti, qpale.il philof>p!m porger là
può , ìlqtial la m inifìra fem pre ignu da, oso pri
uad* ogni pafiione. perche filo Veloquente, poi
che l'ha p re fa , le può a 'giugnere alcuna delle
pafiioni ; qualfarebbe iollegreZffia, la trifleffij
Z a , il defiderio, la fa era n Z a , la differa t io ne «
«oso le altre dottam ente tra tta te da Ariflotele
nel fecondo ad Tbeodeflen. V ergiam o ben che
il phdofipho volendo tra tta r d i m o rte , femffi**,
tem ente apporterà la dtffinition dellam orte f i
ign u da; che dentro d i lei non mofira cofa fora*?
f ie r a , perche nella diffinition non deono entrar
cofe Straniere. oso è il philófipho ftm ile al f abro;fao lo .
facitor della f a a d a , ilqual ben f a r la fa,m a non
t i fa ufare, oso folamente m ette netta fa ad a tu t
to quello, chef i conuiene alla fu fla n Z a , oso alta
figur^dellafaada; m a l'orator è quel perito fo l
lato,eh efa tta fu a t i fj>ada,efje t i aggiugne quel
l'artificio d i fu o r i, che alla fpada è conueneuoly,
oso accommodato. y f i come il faldato fecondò
le diuerfi maniere d ig iu o d n , può accommoda?
I to
T R A T T A T O
r
1
Jiverfeguife di artifici alla Jfiada, che
giajj'e ; cofi è nel poter d etl eloquente d i accont- ^ |
rnodar ( l f a amo hor g li a ltri artifici) alla ma
teria diuerfie pafiioni. s a per darne efcmpio ;
eleggiamo che V irgilio trattando in Una ifieffa
egloga indue luochi della morte d i Daphni 9 nel
primo fa ( per d ir cofi)qualificata la d e tta m o r- ‘
t« con la tr i f i e f f a in que ver f i .
.. *•«
E x tin flu m nympha crudeli fim ere Daphnim ■
F lebant.
>*va sv.
N e l fecondo la fa pafiionata d t
jj
mentre dice D a pim i efferg ià incielo, s a de/oso /
rate . : • • • • ■ ■ •
^ - V • ■> ■ ;•$**« *i.;• u
-Candidus infuetum m ira tu r lim en olympi: 11> Z i poco Cotto.
. lp fi U titia uoces a d fid e rà /affane
»
Intanfii m on tes, ipfit iam carm inaru pes, : -ì
Jpfa fim ant arbufia • Deus Deus /Ile Menale a i
■■+ Loco d i Lucretio . ■ '
(m i.
j& k tttd u m efi,Deus il/e f a i t , Deus inclyte Meni
' Parim ente f i ved rà la m ateria p a rtk iL tr >
tr a tta i nella efidtationc di uojìra E ccellen- ■
I W , fi ved rà dico qualificata d i letitia s a d i d i
h tta tio n e anchora. perche ne il P o havrebbe
detfa quell* parole fe n Z a dar fegno d i letitia,n e
eutrto fecolo può venir f e n f a dilettatione * m a
perche Tumverfid m ateria fu tra tta ta a va n ti
fhe ; segue chefvjje tra tta ta con pafrione l s a co
f ic h e U d e tta pajìione jv jje g ià rmcbiujà nel
detto a rtificio , anchercbe per m e \o d elli d etta
pajrione io lo accommodafii alla parttcolar m a te ;
c è a % N e la p a fiio tte fo U vieti percommodori*
Iì
«,
DE LLE M A T E R I E ,
r?»
\fo ù o ri a lti tra tta i ione d elti m a te ria , m a più a l-,
\0t tre cofe da d i r , quando prenderemo * tra tta r
pienamente d ell artificio, k q u a i tu tte cofe lena- '
t
•
\
f
f
no I eloquenza a quellaU /Z ffo > nfika qual tu tti ■
f am m aran oM arito rn a n d o -A la maternydfoa,,
che potendo e ffa? fonte riabbiamo v e d u ti, verìfo
nelfr mani dell"eloquente .opafiionata, o non p a f
fionata ; in due modi [eloquente la può efferuà * # ,u ttà *
r e i min, p a fio tta ta , quando la pigli offe, e dalla in duc
(
p vra n a tvra ,o d A c a f o , o da alcuna delle a rti: r^ oq u a!
j
i
|
[
1 nr&tquab uienè il plnlofopho , che t i porge per te può ef
oso/ae pura diffinitione ,sa egli non uolejfe efferatichora eloquente .esse quando d ico , o dalla na~,
tu r a , o d a lc a fo , o d a a le v n a dellea rti ; interiJ
do t A m en te, che o per non effer H ata per la d ie
tro mai tr a tta ta , o per non piacerci tr a tta tio n c , fe Vautor non fuffè degno ; e ltifià tin ta »
*•
im da ogni p a fìo n e . m a t i m ateria\farebbe osa
feruata con pafiione, quando fvffècolta dall'ofi.
feruatoregià tra tta ta in alcun provato a u t o r i
$ 4 come potremo aggiugner del nojìro artificia "
•
a quelle m a terie , cric lo hauefferogia prefo d'Ati
trui ? dico> che fornendo noi in u n 'A tra l/n*., oso' "oso
g u a , buferebbe p e ra u en tvr* tA h o r fila m en to
"
ucjhrle delta t e r i / parte ,< h e è pofla nella pa-,
fa.
roti yfo t i m ateria fuffè breve , 0 fo non cifitffa
se alFanimo di mofirarci più che tr a d u tto r i^
- ,v
Ne piccioti laude farebbe il notar
c~--.
la
pari uAor nella elettion delle foleparole J a q iia l*
per openion d i Cesare o dell*eLoquen/a origine^
ma volendo, nella mede firna lingua tra tta r fo
g ta t r m m m t p & f i a a u t w t i d a f o i fo c in g #
tt ò t
T R A T T A T O
JldHZfi delle particolar m a te rie , che atte ;tof?re 4
m ani uerraimo , et potranno fa r d ifferen ti. oso I
•cofi moflr eremo im itar l'antico nella uniuerfiil
\m a te r ia , nel f io artificio uniuerfale accommod a tò • nondimeno esse a r tif ciò alle circoftànZj
della particolar m a te ria , oso le ctrcojiariZe del
ia particolar materia a lt artificio , nel f i a t acf
con miodamento potremo nfojìrar la nofira u i r - ^
tu. il che ja me per m io g iu d icio fa r fi poffà,Apet
tornente th o nwfìro nel Sonetto alla g lo ria del»
Imitatio <FEccellenza uojìra dicalo, : ne paffero qu i Fin* ]
gonne fai ritolti, /q u a li non fenfano/he la im i - /
fuor'delle ta tio n ifta pofìa fin o n nelle p a ro le , quasi che
parole. u
n
0j n q U<f l a lingua non poteffe im itar Demoflhene o Cicerone t Homero , o Virgilio ; oso si
Concedesse che g li d o tti autori poteffero effer
im ita ti in lingua lontana da quella, nella qualefirifjero ; certo m i t potrebboU dire che netta
uproprietà della lingua medefimo poteffe effer in.
te f a la d etta im ita tio n e, ma nel fido artificio,
th è f i uolge intorno alle m a terie , oso d'intorno
alle fig u re delle p a ro le. Ma facendo ritorno afa
la m ateria paffienata ; d ic o , che può prender
taihor u n a , oso taihor più d'uno puffio n e. m a
acci oche ella fia meglio intefii; dico cheg li a n tri
chtTheologifynbolicichiam arono m ateria p rìIWateria àna quella ,* che può foggiacerea molte fig u re n t
prima de* a m o lti a cciden ti, oso Finte fiero Cottola fauòla
eti'
di Proteo, ilq u a lfi cangiavafiotto molte oso ua
rie fig u r e , rimanenàd finiprc quel medefimo
nettarne defima fiu fia n /a , o materia che d ir uot
g ii a m o , q u a l c e t e , c h tf in \a cangiarfe m ed»
.
^
I
f in a f it to diuerfe figu re foco fu ctefiinam eiltt
Y
p é l]# * s a mofir a r m ila f ig v r a 4 w f im p % m ì?
.cavallo 9 m a n etta fu fia n ^ t* enelfafitaterradfa
1
I
j
L
-D E L X * M V T Z M E.
cepatl cangiam ento } laqual fem ptpfarébbffi?
m e d e s im a . ^Jla m ateria aàunqueAel T ro ttò # *
. $ della te ta p o i éflimigUarùno
v m l (ratear lV sa q iia e ^ < ^ sa /a f^ r it# W 4ect^v
Infletta m ateria M U l r o t t o # ofide!J4xe* 4
ffW
' • -* '
a ft/a » t< f c f f^ ^ fc e » » * * p a c h « .
jrj$Pfi come,al fi** luogo v e J r é m ìfij^ ,< f? e ella difand*
| K. sia quello^ che per tu t ta , o per la jr i^ g
U t dell* m ateria fi dtfienda * E' il v e ttà b e A m t •roso oso
‘^
pofiiamo nel Trotto, ornila cera mofirar più d i
oso “. * ; j
una figu ra per volta, ma fuaefiiuam enteo t v t oso
/e o m olte. ma auten che dette pafiiotùrtaU/or
vna fo la, s a talhor p iu a d un tempofifimatiT&fy „•
t
defima materia f i pouin#,fiol che le d ette pa fif/r
m haLbiano dependenza, o confegHenZaJaqaat*
de p e n d e n ti, f a che più p ffiion i in una. q n jfi
|
fola si rivolgano, s a quafi a v a fo la faccia Hi1 mofirino per nondarflndàio faim posfibiktkX rt "
j
f
li in vero J ù r m o ^ d ^ e fa tfio m ^ e iifo ^ i^ fic a *
'* *oso. ' -fgg
wo ilfin e tto e li io f if a (netta efaltationdelTEc*
celientia v o fir a , delle quali benché Luna fia oso
* >/ ;
titi^ Taltradilettationefiparatanjent#tratt]M fi
*?
da Afìftotele ; nondimeno perche iitjfatjtia p u p f f ^
Rnser s o n o ti d t cofi che dilettino , ^ p v s f i a %&$'*>• fo/fo
prender ddettatione , f e # o n ’acxt &i fi f
^ ^
ciamentt am beduefitto quafi
paren ta d i pu sfio tp feh H rJ /fyem ^
,se>oso sc; *. • oso':"
’•
'■.' ~ k 1 '
'>*V'
• as .
pp4^A#àrjo a più
c o , c b eiltu tty ^ o ffitm o c o n o fc e tm l{a g g e tto ?
.
riteprffe l\ F itr jtìc a . Q hì può d ir r , J ; e lapteT .
if a tn p donna* t i m edffw je p a rti fue d e mede fi
me.cofe W & o s o lodeuolin anfu fière a lu im a ^
^
#*ta della,
i e t t a d o p w Kcome in jn a r te , ma.fo tta d m erfe.
p O fiio n it^ C l* più d i t i .<*no% ci partendo dalla* **]
u ita di lei j la mede fim o donna oso le coso ^c/ie*.
a lei confegUMiUto d x /r fon tr a tta te con Ufridet
fattone Jhór con trifleZjia i d ie fono . contrarie
p a fìto m :c o t(lq 4 ik u a tio n e 9 m entre f i g l i ma ,
\
tte fje ^ lf fa y a u à dopatiti Arata oso orgogliofai
t t i u a m ^ t f k ^ d ^ f a l m c n t a nel S o n etto .
Ifarbor g e n til, ch efo riia m a i m olt'atmi. f >
»
jpientre i ties rami nonim'bebbero aa d eg n o r »a
J t o f t r faceua il mio f i b i k i ^ t g m ^ A ^ V à k
A la fu a ombra» oso crefierne g tìe ff a tm * ^ a *
Tfachefecuro m e d i ta li in g a n n i,
* -.* > ?
d e c e d i s o lc e fe fai etato legna ;
sa
XfeP^fl ipetfterm tcqrim tigno t
*v{ saA .,:
^ ^ tjfp ffò a fc m p r e de'2or prifti d à r ih i+ ^ if ó f i
fm fid m o firo ^
P o e t i fi
date <
d otgon O,
donne
n o c o rte si r $ h a p f fie g fi.a m a n ^ fip M fignorta, effer d i-?
d a piinci ' U{0u te (f» d d i ferrite dèce, ancor Tibullo .
.
g r a te «i ft ^em perueùklucar blandos offers m ihi uultùs,
ne
S
'
i
e tn * [ * o m f f u y afaeram or a i
4 El t l
pmt LE MATERIE.
ì#
Et ilVetrarca nel primo d e lirio fo d e lfK m o re/
i*
Manfr.etòfanciullo esse fiero ueglio .s i ^
J
Cioè manfueto nel cominciamento , m a poi
I crudele» esse cofi come in quefio loco piglia, la
I fanciullezza p e rii principio ,* esse lau ecch ieZ /a
per il fin e; cofi nellax a tif o n ti Benyriittcdea^ |
paffitr mio t empo homo*, a ffom igtti mio le Tifato
fa*mmgioni dell'amo•AlaéumatM età r ip ig tia l& p fimauera per il detto p rin C tp io ifà jb fo p er$ èf 2
$ '' '
c iu lle w # esse piglia il uerno p é f iì f i n i c o m p r e '
|
so per la vecchiezza . Vs fi.:
si
s si
\
Felice agnello a la penof a m andra >’/ v s i' •>
i
■
^ M i giacqui un tem p o , hor a l'efìremofarrtmefa ‘
E t fortuna 0 amor p u r } come fo le ;
s is i
•
Cofi rofc 0 utole
s i ' s i-s i ;
I la primavera, e‘l uer/to l;ae nette esseghiaccio?
E t intende per le ro fe, esse per le uiolerqtfClti fa
* henigìùtà che la fva donna le m oflrdudfiàVtofa
m in a am ento, deh e metta medefimo, cannóni
|
desse nella precedente slan^a*
*‘ ^ '
Gli «cJitfoaui fond'to foglio hauer v ita jr si
D e /e diurne tir a lte helleZj# s
F u m i in fu 'l cominciar tanto cu vttfi. *
Ma per la neve $ esse p e r ii ghiaccio, che fono
^
g li effetti del verno,vuol che in tediam ogli ejfet f |lf fignia
I
ti dell'amor fu i f i ne,che fono essefdegni et ir e ,e t ft^ano ^
i
orgogli, iquA i g li fecero rivolger ip e n f i e r tu tt^ txx%
f
ad un fegno{he parlan fem pre de lor trifti dati±
ni : nella qual fentenza venne in quel r ceffo
le
Mai nonno piv cantar /c o m ' io foleua v s i v s i \
Èthenche habbia poco fo p ra ufata quella p a \
rola ,f(m p r e ,m e n tr e à d i/fe ?C he p a th ttfcrrU
1
i
fatiti
siT R A T T A fT \0v
prò d à h r t n f i i (Unni ; j & nel principio d elti
dijficilifiÌMa<a»zpH fo rilep a ro lc^ M a i non no '
pia cantar, non dimeno p c rfin jh c lifH a d p n n J
m jj'e, pur daàmedene in p iv M d ,c h e t i m utaf i o » delle dette f asfiorìfi faceva j perche f i leg
g e nella feconda Cannone d i -,g f i occhi 9 ; ,
T o rto rniface il v e lo ,
LwXoso-il: s ii
E t t i m a n ich e f i jfrffo s'fX ra tu rJ a
v
«a
FraeVm iofim m o diletto ,
-,,i s _ .
H t ^ / i occhi faonde d ì e notte f i r i u f t j k r v ..
I l g ra n defio p o rù fo g a rrifiu ti* * ^ ^
,,
Che fo rm a tìen d a l ÌM riatoaffit#o^r , ,. , , j
Mafcmflopigliava varie pasfiwificcenjo ti r
UMUtèt^aJfieuo » che gli mofif*v*ja fua
•! itim fo ^ ^ a fio 'tM ò o r *k>fir*ffck tafo f a t t i l e * *
itf o a tifp e fle r ìk e e r a ancor in d u b fiio fip erch e
dtffe in quel Sonétto*
X W
Q u efia hutnitfera> un cor d i l & f & v j ’Q rfa ,
C he*» vifia humana., e n fo rm a d'angclueite ,
in rifo , e'n pianto
fa
M i rota fi i eh'ogni m io
§ 1, .
E t nel prima terzetto ih l m tdcfim o ,
l
♦ » N en può più la v ir tù fia g ile & fia n c a * . .
a f f a n t e varietati, homo»/ofoÒ^»^». ,‘ (bÀae#?cae.
j
\
\
^ L < ^ e V ^ » / w » r a A r d e > a ^ / s i i d c c i a e ^ fnsea,e>m -
^ p A le o p tÀ iM a r ie tfa fit aperù sjfoaym $n ttine
*¥ofi n e lf/c o n d o d é tiU o r te ^ . 4
ggivgnfi*dovi t i
I iagfa rìriirh a n 4 H n lrì^ d fo m to * g { s%y(,
^' T m d if m ltif ia te k a d ip in f o ^ : f a ,
6, :
i l tto tiom o^ dilam órvtrdeva ilc o r e ,
»■ M a u o g lia e in m eragion g ia m a in o ti ninfe,
Foioso u in s e I/' u n s e d a l d o lo ra i : ^
. oso.
j
f
DELLE MATERIE.
197
D rtZ^cii in te g li occhi alhor foauem ente * »v
J
Salvando la tua v i t a , e‘l noflrohonore.: seffyfc
1« Et/efru pai fi oh troppo pojfentc pfat* . -*> se • a
IJfi
Et la fronte s a la uoce a-/a iu ta rti 'Wloso ^ 3i«se-‘*-*6,
f*
Moifi hor timorofa sa hor dolente, roso
t
Questi sur teeo m & fngegniy& ym Utftrti fi
Hor benigne accoglienzea-sa horaufdegtii
T u'l sai y c h e n lf tè c a n M a in m o k c ^ r tijg
t
C//t uidt g li occhiiuoicaU lor^ 0 ^ s ^ f e 4
D i lagrime ; c4 ’i* disse * q v e fii èxórfo is e ^ se
A morte ne» tm ta n d o y i veggio* fo g n iti u»
*
w Alhor prouidi ditone fio fo c c o rjo t . *
, 4 jy
? 1 Tal/tor ti v id i tali Jproni a l fianco* ; r i i
C tii disfi, qui conuien più duro morfo •
.*■
j
Coso caldo , verm iglio , f r e d d e , s a bntneo . se
Hor triste, hor lieto infin qui t'ho condotte.
Salvo, o/uCio m i rallegro, benché Tfancó% )&.N ondimeno la tn fie zz * » ch e d T c tfa rc a fre Tri ftew»
sa per la morte della fu a donna y f u M ^ m t o d<jla
maggior s a nell'animo s a nello Tiile d iq v tf la , te della
che iaffliggeva nella v ita della, dettaidou& a i s ua non#
mentre ella f i m efirovo.turbata ; in quanto ejfafi* *
trifleXxa non f i poteva p tv cangiarci» U titia , fi
tome la fua donnadi m orta ivjuiua n o n f i p o te
v a cangiare. A d vn qvrqvan tw tqve. il Tetrar
ca m uria della fu a donna per g li Orgogli, s a
per le altre {piacevoli turbationi d i lei. haueffe
compojlo dintorno a materie qualificato ^ do
lore: pur tu ut Mulof i eJJ'asfrosoe up.Ue.dijttgogUfa
f a in hum ile, ancor essa mut d u a le am ateti e ,
che tr a tta v a , dt a ffa n n o ia le ù tia g a n cc y ch e
1
co» la prefa le titia ijf'ifem pm . tit*jKffifafifa&ìl
» 4
4
^
«9*8
: T K Ac- T T Ai T O
j
tim or M ricader nella trifieZ za p rim ie ra , c u e - j
ro maggior 0 più cocente d e ftd e ria /h e la f y e - \ r
ranZa g li accendeua » de quali eia fu m o non r
g l i lafiiaua d o ttin o , d ei tu tto «pùeto. oso- del L
r ite n to tim or fe e e quel S m e tti * ’ "sansa* y
1
x Se*/ dolce [guardo d i cc/lei n fa n d d é -, • '
I
^
E t t i foaui paratine acmtt&M p*** sa-v~ *
]
E t s*àjftor [oprarne y la jf r fif o r te
*»•sa- ' * * 1
Sol quando p a r la , ouer quando /òrride »
I
Lofio effe f i a , fe forfè ella d m u f t
*
I
O per mia colpa,o per m aluagia fo rte \ - ■
G li o c d n f i» k d a m e r c if f ì: th a f im r te '
. ^
J f c e r à ^ ^ m i M ; > , < N w w / correlato"* % *
“
n a to . . J
T t m i n / l coCdmebil per u a t u r a / ^ ' »sa ysa■ O m tjo fo b e )y ,c lìu n a m o r o fo lla ta i? V ì iJ
5 I f l c o r di donna ficchitem pùritu ra 7 4 ^ ^
H a « to ss e * , c o i»* l d le ù tid tiu m u & ì l tim o r
d is to r n a r e nella p rim a tnfleZ*&S*<m/iend<3L
r < f o 7 d f u a donna, dimorerebbe breue tem pò bc*
jfig n a u e r[o J i luiàlqual convfcimento g li daua
epgiott d i non poter, fife* del tu tto .contenta.
JLefia ^clZioi faccia, ueder y (qualmente '■anco \il
fafiderfo/#crficiktodulU jporatiZflfJifcèm -aua
w t t o J t i t k gtifoteriieogtidellabenigputà della
f u # dùnaprpfojm urebbcper s fiir iM m fa g lia *
p U e m p a jn t a m p in i fifa m en d u r a
; p a ttg e lic a fig u r a i l d o lc e rifo ,
n». .
E t Taria de ib e l uifo „ . . s a i i V i a ^ ^ r ' ’ .
*•■
*t e d e ginocchi leggiadrèpnenùffiura» * * t ^
. , k.
sa - C fo sa "
DELLE Ma
t e r ie
,
i ??
Che fanno meco homat queflt f o jf ir i} *
^C hejufcean di dolore,
><
. E tm o jk g u a n d ifo re
'< w .
~
La mta. an gofoofaxy difinctata a ita ?
S'auien che'l m ito in quella parte g ir i
Per ac q u e ta rti cere,
; *.«♦#..
; se* - »
• fa r m i ueder Amore .
. ^se
• Mantener m i T ^ j a n > fjyd a rm itiù td « :
. N e però trovo ancor guerra
N e tranquilla.ogni fia to del c w W i& p >W%.
• Che più m'arde il difió+'fa 34V sevsoso*
'\ ;
. .Quanto'più la jp e ra n fa m 'afiicvra.
iv a
^ • * D irein on pur per le dette cagioni} m a ancor\
per effer amor un dolce amaro per tefiimonio Amore c
dt Tintone, il Poeta non hauer in v ita della fu a
donna hauuta letitia piena : m a troppo f ip r a
quefia parte dim o ra rti. Adunque pergiugriér
al fine del propoftom ioj dico che la tr ijk Z f fa ,
che egli hebbe detta morte dellaffua Dorina , f u
tale ; che quella*, che f e n tìn e lla u itd d ik ic d u fa ta dalle cofe p red e tte , cra/m olt« inferióre :
conciofiacofa, che;la tr ifìé fffd , nella v ita della
Donna hauea fempre dappreffir per compagnia
la le n tia , qual è l a f i f u f f e u n a la] tr tfk Z g a ;
nella qual cadde per la morte d i le i, non potete-.
do volger fi in principio alcuno di- allcgte%$dT
non haueua nell*amaritudine alcuna pari . per
Lt qual cofa nella Carinone, Che dehh'io f o t' ,
che m i configli Amore ?» Son d a effere confiderat e quelle parole. O g N- i y s a V -0 li T A :
Poscia, ch'ogni m ia gioia* ùù&W'yX se &
Ter lo fuo dip a rtir in pianto è v o lta ,, oso* oso
I
ih j
i o j v g f i / w o f i r a w t t/fifo jp o tm zf.tn ,a lc u n tem pofiiraddolcir e.
io )
/ae.rp ld VlcUmcéLf / e r . tin ta tijf o u e ja f conti^ n d fo tp n fo saosotososa.
J n y p fo tlie
t & f d o d i l e n t i a 0 f v b j t o appreffo del dótto g r a
4 o d i la titi* inattiarifiim a tfffie%rfa: perciotl)^ *
f o t in qvefionumdo non dimoriamo m itt m une
J $ 0o y l f tirare* v^AccmfaqvdU.parfo^QQHi,
$ 3 $ , tradere , c / j e p e r s i a m o r i e d tlf a f o v a f o ti^
*» Àùti^pfoafii%flerqrfak r?tai'* fodlciin coni & j j B f f l nm nfad^cfie poto, fip r a d if i i, ; ,U
tJ w rijo èn fii* fa < » fo -a p a u rq 0 'J p e u e '-■fa *
H i r o t d f i 4d f ^ n ì t ^ ^ 0ato m fir.fa
*
4 II perct/e A tr o i# /fa r la mori e lnse/ò sari/;#
in qvelti beìla6& dvppM&efiina.
/. .»*■-*»? Vi
JM/anb en ig n a firtvn a &%
1
I c h ia r ig to r p i, esse le tranqutllen o ttif - h ) \,
f a E i f i a v t fùflnri , e*l dolce Thle , ... X s i f s i
[X J ie f ii e a rifonar in u erfi, e Vi r t m e i a t & t e * ^
-
»Ì?'
-
t^lfffaàotzpne , fy ergine
" sosor^t,
g^
....
.
.
...
* .T r ib e b e fignific* ferm ezza a
ha in doglia
la» j i w f j r
vivendo in f im a # il ten n i)
Vergine faele eterra , esseposto
|
D E Ì L E "M A T E A I E.
osofci
^ Et a ltro v e , dove dice non f o p tr fin m utar
H & fi, d a a veder la detta fitrh e Z fA ; ^ r 'osooso
Pianse y & cantai : non fo più m utar ué\rfo(
: Ma d ì & notte il dttvl ne Valmk accolta .'oso"
Per la Ungtià r y p C 'rp io c ch tsfg X o g y nèrfol
Mae affai viig a ttrh M iq tn o fo lp e r m o /lratfcbe
Quantunque iljfo c ta bqbbta u e fltìo d fd ù ld r %
4
^ tf le f f a m a t t r i * w i f ò $ ^
no il dolóre & l a
ferirti dopo la rhótit
f# w afgtoH ?’-frtq to ff*
, • partedel/aemorreipwdoteMiltcf» d d lffi
V " *m jlez& i, dct dolore, sa della W i ^ ®
t • e*i- ftricordiadiflintamentem*
*-v
**
fogn ati da 'hrifiotele
' K:f ^
n d fecondo ad \ "oso/;.*f oso
'» Tbeódt*}; *>
-
,
'
E- /<%> vse
•oso ;.
■s a-, • - se-
osooso*- r% y
w
•oso •!'•*>>
l .
" ■ yp[
S parsa d’or rdreno f i ambedue corna
Con la f o n te di T oro il Re de*fiumi ,
A la c itt# uulgendò tglauchi lum i-,
La quale ilferro d e ltu d n o m e adorna»
I n forbito oro il ferro tuo ritorna ,
Vari* e dicejfe, e’nbu om i rei Cofivin i ,
E t g lib o n g rfp en tf ip f i n taccefi lum i »
f*oi theT Soi noup m ie regna oso fo g g i orna..
O domàtor de* n io fifi, o Sòl qui Sole y *'* .
V o itd e , ch’io uoljgo a tuoi cenni benigno,
Riguardarci co i tuoi fa g g i orna et rifchiarà*
A l fin de t i fu e ta cite p a r o le 'g v
f ‘f*
f
O gni r iv a f io r ì, cantò ogni cigno a \ ' u ■' '
’ D * o r f t f e il fiecol » V a ria , oso l’acqua chiara*
D I M. G ì V.L.X1
,—
C Jtmtyi I C ” L
O
DEt l
I TAT I OH I
IfftliiìsMiliPisa^riìiìrjirir T-rifmmipiainmni
)
M
a n c
A
il
p r i n c i p i o
t •■
*
<<
M a che diro di te Erasmo, huomo di ta n ta
f
' y *'--m ■*■««m mm ■
Jctentta , oso d i tanta uirtu ?.. che per un tuo
slibretto , ini fi ó la f o ìl Ci cerò n ta n o , meffó n e l
p u b l i c o f W ^ ^ f l m t W i W n e f i dilettano,
ti uorrehbon lcitar d el numero non p u tid e g l i
doqueti;m a di g iu d icio fù E o rtip m a d ife fa c o n
ufin,cbe tu t i apparecchi, sa perauetura ta lo p c
nio della im itation porti, qual ne tuoifc r itti f a i
al mondo fen tire : o f i g li huomìni u orran , che
fia tenuto per cofa d a donerà ciò,che tu forfè per
ifchergo fcriuejli. Io per me so certo,che nel c ic t
toni ano tuo piti tojìo hai efercitato le dinine'for
Re del tuo ingegnoiche detto apertamente il u t
ro parer tuo.Volgi o [iugulare ingegno; uolgi lo
'
ftilo tuo> et tu medefimo sij contentò d ir iri con
trario di quello,che fir itto hàrijl come pefi,ch e'l
contrario fin ti, tefièJJ'o uinci; che neffuim uinccr
- " ^ i potrA il^ p r p è fa jh e o b ìig a tìo n tih a u e r a U
l
rf
T l'A T T A T O
flluquenz*, quando tu medefimo fc b e k h & fm o
fo so qua tu f f o pifoi nuoter 'Cprt^X ivfa g n to rjta ;
U irigJlXerai,quanto inneor con hèifleffà le potrai
fo lo u a rfila trien téfik
nett'anté k U $ lo q tten & ìutta, lagrim oJfit U fi gitradaiùuiH , ls a uuotójfer tua, f i tome
fenipre fi*: effe peH a tua ptetJpJ&prega, s a per ^
el'm rnctuo per f i f ie r i nutrim enti , che beuejh
d u i petto fuóa s a per g li oìfitamenti, rl/effk per
t e ha acqurflato, s a tu per d e i, nonio voler efiri
fe r ingiuriòfo ne i t f i u f a r d i non fapere , o d i
noti poter fo td ltr a m è d ft ; c h ia m e Jilq u a l fo n ^
un minimo ; s a venuto riuouoconfideratQr d el
le fu e bdleZjfa étiràto dtd zelo >ch'io porto atta
u e rità / sah/M hnar tuo , da H cuor d i fin u e r
alquante p'ctcùley lequat ( Tic non m'inganno )
i l uero in alcun modo adom breranno. • Q uefie
ancor, che non potrairgiugnerc afa a lte\\it d c ltin gegn o tuo ; prego uogU ójfèr contento > d ie
come tue uadan per le m a m d i c o lo r< r,< b eù
h ia fm a n o , perff» che U h tre tue d à fiù darga-,
s a più eloquente v e n a , nel conffetto d e l man»
do usciranno. Poffòf enfiare adunque che quan
do tu vorrà* ripigliar la ueraperfima tu*;dirai 3
lin gu a s a molta jqcgliò d* m e , che la lingua L atina, fi
latina h»cottv tiffie k M treeffe dtlrqondo, h a h a m to il
f
a
o
L
c
u
*
M , Me-& f i éemeettiiifi pUòHegar thfal Sòlnofababbia
«oncjttc * * 8 ® ^ v irtù & > p iù aperta bellc^/fia 4
g io rn o , che quando'leua 3
o quando cade : cofi
■ci-conmaLper ferino to n er, che tu tte le cofe ,
' e h i,a d q fér c m to à fin o y
DELLA i m i t a t i o n e .
f
I
f
J
tendono a l loro colino » oso finalm ente codone^
fia n più perfette nel colm a, che nel comirttià?
mento »jo nella declinatione,., £ i effe/fa J ìa p q
la lin gn xL a tm a u n d M .q to ficj^ .a m Q .a firettj
a confefjìr* che s a uo^npgsia^osryuar, t i f a *
erfittUne \ non fa b if ig n o ^ fife c e ti pom ym »
ax/nnse ^ / ^ . u a e i q u a e f a q
u
d
e
,
qual era:ncltifxij fiftx . ^ g a g lia r d a
E t cond ì fiacofa,.ritosa o so e f^ to o s o s ^ s c s s e ^ ,
-ri/* cr*dfiruonm o\dcpbH Q d e ^ ù ^ a % i t é ,r i
■4
M
Lfugm
■quelfgtmfeCQlQdcbbMm,cornepefato/enere^è £
J color,che andarenm oU iarm i Auanti,o.ugnnero fosse in
/
d o p o , come fanciullo non bene attéffifii al p a r- colmo ♦
dare, o com&j+eccbi g ià balbettanti^ È* */,uero,
che quelli y d m ù p n t furono, auMifi,gfadap 9
Ì»
■più [accoflarone A quei , ;<fo(
h diafitor
Fiacque a Cicer. d itifc ia r c fo itto ^ . thè t i ciò«quentiaiattnasasse r i fio-tempo gsaitfl* allasud
m atu rità: oso quelcplm o, (òpra ilq u d e non p o r
ie n a ella più andare,-di n e c e fa a je m inacciava
d iu tc im la
?
fir ifa o n e ltitin g H a ud i e # p f i d fio ocgafo cifri
naudynertLoroitért han fa tto feufa M p o n potere
fcNuerc a» quel pcrfetto JdttHo ; percioche t i
In ig u a d lo ro te m p rerà g ià cadu ta ; oso no0 ri
♦weno <wolti f i tro va # d rfi perduto guflo ; che
più ta f ti piace «tir ra p p refin ta re. in fa m e non
p u r la bom ba; m a t i rib a m ln ta lin g u a ; che,
quella laqnalnella j u a p iu fo rte eri, parole p ie
ne d i m aturità , .oso-di configli*, oso d i belle*»
tif a v a ,
V < m w ^ d ^ m n e lf a u r f o f ic p lf a
*
■v
*$*?■
'*t r i a T m a T o
]
Gtcerot lal$ngua Lati m a t u r i l i eccellen ti &
m j
jo m m u a y u ie p o te . Alpercbe tu tte le altre
%
‘ ' Q t jW ctd en ti esse feguenti hebbero deWimper»
I
L lnpie 'Jfettds »E t ficrytegUo d ir , la lingua d i tempo in
i
aw& jfacendpfi pii» bella* f i che per fin *
«lorea pod#*uenne a l n tt/o cerchio feto ctafcuna fucceco a
oso*
co po' dente età usò la lingua della puczd& ats^epalr
cuna co n ettio n c. Ver tiquJTcoflt fi può com- xT~ \
prendere , come fiano m al configliati color ,
che d i tu tti g li autori uoglion levar la lingua
confufam ente. percioche potrebbono appunto
pigliar quelle parole >che dalla p e rfe tti e tà f u r o n , conte vecchie alando n a te ; o qu elle, che f.
declinando*!? lìngua , da radice g ià priua d i oso
littori tdgor fe nZ* molta bellezza fottonacque»
oso r o . Ter fin ch ejl genitifccolo fu nello fla to f v o t
la lingua era come uria 'ghirlanda te jjv ta d a
l e Ihfu m a uergine : nella quale ghirlanda erano
alcuni f i o r i , che fem p reff. mantennero y a ltri
per la lor debolezza non poteron u m e tt ai pari
con i pin f o r t i . I l perche la uerginexan giudi*
riffa m ano andò buon tempo *fecondo U b i fi*
gn o , levando i la n g u id i, esse in lor loco ripa*
nendo dàfirefichi ,Jen zaguaflai g li M i n i d e lti
g h ir la n d a , M a poco dopo la morte di Cicero*
negmort la uergine, che hauea ju g o tiern o ia
ghirlanda : p e a d Attori è d a to fa re s l m edefi
n to , perche anco da radice è del tu tto fecco il
prato launo , nel qual piti non nafcom i fiori >
d i che la rinfiefcata ghirlanda tutto di p ia
meZgiofa fi ned ea . FA f e vogliamo godere d i
y u r i f i o r i , poi che n<$p.poflono enser piu^col*^ ^
i
D E L L A I M i r r A T I O N E . io ?
tk nel f rato , conu t en , thè ci rivolgiam o
Ala ghirlanda , la qual r im a f e , m a tteria ).
nervine) ,X e mtc parole fuonaiio , clx la Un- Lingua
latma con
guae latm a non fi parla p iù ,c o m e la m o jtra^rinsesre
popolare, o la g a llic a , 0 « g ià ferm ata ne'di- »
hri : essejwtc h e n o n fia m o n a tip ilei, fe la v o - o s o 1 >>
pAiMuim»J.Aiae la togliamo da i l iuri , dove fi è fc r n w a yhon d c o d a q u el Q che
ci danno a veder , che un'altra .gbirtindtuper,
loro/peror fi pojft foatta d i f i o rifm za fo a u ttk ^
falfa im itatrice detta prim a ; n d tiq u a l n e lu c d
d i parole, ite helleZg* d'ordine, ne g en tile zza .
J di tejlura f i uede ; ma da quei folam en te, da i
/> quali tanto ornamento posfiamo b a v ere . E /a
fendp. adunque i libri difettiti in m e d io c ri/u o
v i , 0 perfetti , 0deelu n a ti, fecondo la mer .
diu crità, bon tà , perfettione , 0 diìhinario*
ne de fecali ; 0 ejfeiulo noi aft retti d i coglier^
t i linguario» dalle bocche de g li huomim , m a
da i I è r i ; perche nop^ pii* foste da i p e r fe tti^
ohe da i m ehbuom & E t perche, f e io ,c h e fono
Stianterò * pojfo i / d a l perfetto fecola leupr
**
qu a/i il trìto id e b b A ifo tiù tr u i lingua mefcQ~
t i r uoeaboUfa o mofo d i p a r t i r , che non piac
quero a l g r a n f i imo gm dicio di q u e lli, che nel
più felice fecola in quella lingua parlarono
fcriflero, 0 giudicarfeppero-, fi come q u elli,
d?e col la tte bevuta Chaiteano, esse che dottisfi*
m i infieme nel Senato 3
ncl fo ro * nel popolo con
gra u ifìm o giudicio.la tra ita r otto* caftigarajio*
tttujlrarono i N e voglio , p e r f o t to- ciò , che noi
p i a n t o uforno tilo r p f le tte parole \ c h e d t/J k *
•fa»// ; ilnseo
« » * ’*
firtnI tnfify fà b ìn tirn è uiiit'h e n ia l i d k % £ i i
thefopfirasasse per Artificio * m i per lin g p a d é
r ii approdati a n im i effe usar Td ruejtefimai
f i rnn ci desse itiU ò f d i ira fo rn i a r ti ta lm en te
ssonf/A
alita.a/ A 7^aiiì^«l
ef ‘ i
:n
fàSffii ; che noi n offjtfaiam o nella òperqfiia n conpfcer qual f ip r m q u e ftd f o m q u e lU fia tt*
k '
d e l/wele sita uirtùm ettefie L a n zffic o p ie tu t ti
- ^ ? il «tele ueniffe dalla uirtu ^défTape * fffa t i X ?
apparecchia , oso chi dm a fi] mele f f / j f f f f p m
Ordin i f io r i. E l!accioche io fia meglio w f f l o ^ w f r W
p rfricip ali fù tili ordini po/fono ejjcr della lingua accorto/
acromo- X. ..
J
rC
.» ■ ” • .*-Z
d a ti a n e - r t t i i f a a ucjhr a a fc m noftro concetto, i l f r p a
n o u r o 2 ' 11 fc*0 >1° ^ rafiato > & quello , a cui per fino 4
concerto. fa h ó fo rfe fic r non effere fia to cefi bene uitefo j
4-r
>
"s ne confantio, non. Scaduti nome , osoche fot
tn tu tta Firnpijtfffffiyffàlfrófmi chiamiate y oso
chiameremo f e i h p r i ^ p f a o j ^ jefa/cun i^diV :
q u a tf t i élofaealtaù fecondo la natura della
m a tè r ia \ ueftitd f i v e d e . imperoche fono a ti
cune m a te r ie , che della pura proprietà ft con».
dentano f altre vogliono effer dette da Trajla t ì ,
p w
•' -T
' se :«i - ; ■
: s e T> E L L A I M r T A T I P N E . .209
/ p e r & e j o i * q u èlo c^ h a u ereù • fo ^ m a g g io rfo r fa , onero ; p tic firie 'a p p o rta . rebbc ornamento * a ltre jfoglìonó per locnttotà
de lettori /pigliando U fk tfo re bór dalla pròJ rieÙ ,fio r dotta tràfilationfi.; E t benché: quefio
terZy ordine fia te m e n te delMpèfà}.chefenZjp
M w ig lia ^ pòffk nett'animo del
lettor mettere :
olméti
loco f e lo f à c e m ì m t U ( c o r i \ f i ^ f i 0 ^ ^ ^ i , B
che g li f i cornuti/e, quale equèfìo jjijfia rifra ^ „
faa del Ciclo , in luògo d f jp i r a r ; appreffo Ci%
t corone. M a per mio awfo p mentre uferemb
§ f a Proprietà, o U tra fla tio n efre q u e n ta ta fuo»
** f i del modo Topico; più ragionevolmente pò»
. tremo d i r , che habbiitmo ufato il medefimo -,
cjie usò fautore ; t/;ae d i r , che habbiamo im ita
to lui'3gonciofiacofi j -che la im itatione è m cnijm ìtutfo*
tre/facciam o eton quello ifieffo;tnaurk fin tile
l / ] 1**
^ d p e r g b e fe c o n d o il crederjmio, la in u ta titftt* .
ejfotta del modellò f i ; chele parole o proprie f v . ' S t g f
trafilate, che/fonq^ in ufo. d i fai ,Jojt libere < E* ^ . - ^ 1
[e, p u r talbor rè fla to chitupato '%pfiore il d ir
1
M c lm e à p fim o \fu préfaìa im itatione netta fu a
largìjifìim a figntficatìone. Volendo adunque
v
adoperar le parole latine ; ciò non pofiiamo fa r ,
j*
fenon pigliando quelle m ed ffm è., che g li autó-tlne co»
r id e tte hanno, o fenZ jt bfaffjrio, o 'con p r if ib Q w ìd o
còlo dibiqfim o : fenT/a binfimo , nfyntre 3 eosopetfufi.
m e io difii uferemo li; p ro p rie, p le trafilate',
v
legnai fono fia te da più autori tifate in q u d
modo > s a roso Vufo: le ha f i t t e divenir 7 fam e
( ;H®
T A T Q
f?èprie ; jj)e anco* Cicerone esse Vfr£t/to t e l i t i
ieuarono d a g li/a ttfo r ifc b é andarono a v a n ti
• al oao. I
oso
„t u
*
|
fp fic ta ì comefoteiM nopm fgoprjarrientrhom i |
f A m o tè } cf*!ìÀÌhùrè ^ .^ q h a n d o ' puqe
!
ùdeun di loródiffef i r d o t , ‘q uantunque f i a t y / r
fiat<r\ nondimeno hoh 'fu cofi dettò da alcun ,
me s u o tr o v a to , ct / e m o l ^
iiojidijjerq * ìlperche pepiamo ajicor noi fe n fo
fo fp e tto d i ladroneccio u f ir e , esse ufandofopoh
pepiam o d i r , che im itia m o , ma che n o i dicìa- j n e A medefimo ;\fela ftg n ìfica tio n della im i»
ba tto n e , f i rivolgeffe adTautore , non alle p a ro -?
tip <Md quando fitflintQ a rd iti d i ufar t r a f l a t i oso
.efielffpel fo l autor fa tto haveffe confuo a rt f i - ^
cìeff'o quel modo T opico folam ente dà lu i d è i to : giudico y*bt¥potremn}o cadere in peritolo
d i effer chiam ati ofafurpatori fao la d r i, fenato
fapefiinto quelli' ti/ctifofmarenelld compofltio»
- mf l ra#>fi co™ i* jl?
|||
io " iè f a jr a s p M M . L t per p a rta i d ^ ìti^ ìp ic iif a f a tti
M ' «e
il traflato f t v e d e , f i dirò&lndfcer , nd*
f i i i non -m a tterò hiaftmo volendo fertuer L a»
tin o * che non un filo ; m a tu tti i Latini c e fi
hafino Lanuto in cojlum edi d ir e , oncia prò... „ prie fa Laura Jocaff Ma s e io dicefli u fa r v e
paefi d e lti luùf [ f a conièidjffe' Lucretio ; per
mio apifo port& ei fittkÒ ^
e ffe rn o ta to *
' %m afiim am ente fàceiMo efi nella lingua m edefim a \: che perauentura ih un'altra farei da
laudare per coHtcntìon , ch'io potrei moflrar di
f & t . M a la g ra n la u d e , ch'io poffo meritare
D E L L A I M I T A T I O N E . , . xix
in quefio t e r Z o ord ine , t o p i c q ^ f i p o s l a ^ / l l p
fcoperto P a r ti fic i o d i In c r e tio
*cgmquel
m ede~
fim o poffofa b ric a r p f f a lt r a f ig u t a / u m d i ffiin p r
b.elle%£d , f e n i f i ru b a re *} p e rc b jt/fo n g fc m ta
ta r te d i 'Lu cretio ^ f i f e f i f i i i e u a r X a f i g m a M l
loco de xo n fe g u e iU i y pptro J o v d f i m edefim o
e<ru;dé,Éttalitar di 0)0$
per dar afiaggìo di quefia arte,fidùfafirm*
niene a luce ; dico:, chefia quei medefimi lochi figure t»
pefjòno effer formate le figure , Ghe
\ chiamiamo , da qual gli armamenti. ENil Wa.Tormatej
J j r.o, che ialhprfarà un Igeo.} che faràfin tifiia/ef2 qu' 1
Vargomepto, fiffiebolifittna la figura* osop^neu?, che
contràrio fora,un'altro ,dal quale fe tireremyZ]i AXZ+*
targomento ;farà dt p
k c i p
l a
*.
meremola figura, faràgagliarda,fi come fio?
. *> * ■antopeifictrifa \ .. ' ^
-i-i*
f ^-e dtwgànoda-fo
,
cohfeguènìi a &4ajfiifiqtece.denti ,/onp uigOr\
refi[ f i / q#ei che nascono dagli aggiunti, fono,
priui dtgfàn for^a ; oso per gratia di efempio y.
quefio, argomento è nepe/Jàrio da i confeguenti
oso d a g li antecedenti, fe il Sole è leuaso^nsee^”^
fi# giorno » perche cade nella -ponfideration «osarli» da*c6
fita 0 fi\efiefa o fifipl cagipndel g i o r n o i .£g^ ng,}
da apatiti iCtitfitffilfiSole ffftbfifigifcpo} quelantcccdcii
mm^o adunque t antecedente ; oso quefio confa?1*
.
tir
T R A T T A T Ò *
unente d f necefiita. m a quefio tirato da g li
aggiun ti nou ha m cesfita , f i f a Strepito co i
piedi ; adunque camina Vperche anco r fedendo
posfiamo menar ì p ied i in mòdo » che facciamo
ftr e p ito . Ter /quali esempi fi uccie fargom en
to , che porta necesfità, effer più fo r te ; s a
quello', che
la porta
sa,nsej*
d im ejto , f i come io d is fi, ia n o r la fig u ra , che
fitrà fia ta tra tta da loco, d ie non hauerà fteceffità ; elee dal loco de g li a g g iu n ti, tlqual
nrinifira cofe, che d i necesfità non fimo , m a
qggiu g rierfi poffoìio ; batterà più gagliarde^Z a , che quell/., che fa rà muffa da loco neceffà- /1
' t ì o ì y p /fipnpio *daremo intorno a t fiJpirò
tk^ ^ ^ d ^ f id u t^ U fo d ir ò Jfofi/irare ; pigli ero U
‘f iro jrih j ' i y àuefie parole àccom pagnatediranno tl m eièftm o fn ta haueranno traJÌÀtione
quafi pura , matidar fp fp iri, g e tta r f if p ir i :
ina f e io d ic e s f if w m h k tf a w
pira rira.ce neceffarto, cioè da canfeguentt itmperòchè
r a d a suo d i necesfità confegue alfioff/rar, che l'aere, chè
KrioV 'ìdOttanti alla bocca di coltri, che fojpira^fid
pm effiò* rotto dal fi/piro. Nondimeno fé
trottare i'bofchi ycffghaurebhe m agjtrgae nectffario ,clte al
Jofpfrar hrèmmo le cvfe oppofie, fi noti fufferó
pi ulto deboli sa utcirie • Ma per mio auifo , il
'Poetam qùefia naturaiphitofiflria del figuràir^m
DELLA IM IT A T IO N E
ilj
topicamente dee effer molto fiu io neltA>ando»
nar le cofe, che fuj]ero troppo foprd la u e n tfa ,
qual farebbe quella ,f a r trem ar le f io n d i, esse
maggi arment e ìquella f e l i e i fijfq r i crollilo i
bofihi : parimente fo e fia , Vjlefigura tlla g rfc
m a r , p o r ta r g li occhi m o lli, o hauer g li occhi
t i m i d i , nafte daìconfeguenti nèceffanj : im • »ap&V tìA ititi j
fch en o n fi faccia»
“fi
...
petto ; quefia figurahaueru uigore : & p o n d imeno non nafeerebbé da confeguentì necejjarif*
ma da g li a g g iu n ti: perche può ben pianger
n alcuno ferina bagnare il petto o lije r b a . adun*
que quefiafigura am plifica, esse quella folamen
te può dire il uero . Ecco Virgilio volendo ite»
(lir [in ferir di fig u ra T epica ; non p u r f f f f e j t
loco neceffqrio de confeguentiJfa'afioco afi»
preffi quello d e g l i aggiunti 'dffitòeroclieuo»
lendo d ir , che nell'orno pptouafffer in ferito ti
pero : rigttardo^a q u e l, w f f io te iid cdnfefiuì-'
f e . Penso
pero
inferito neìTorno , s e 'tiaùèuajffÙiuer ; fa ceva
bifigno
*
chefieffoTorno diuefoeri4bianco p e r i fio ri del
p ero. Mahauendo a d ir e , che nell'orno p ote
va eJJ'er in feritala quercia; miro non al ne»
affario , ma Al'aggiunto . D ijfe adun que,
chei porci fpejfio urtino d f i / i g e r le gJiirtA o
fotto g l i olmi : gjP nondimeno nonjeguefot n e i '
fefiita quello [ d i T à i c h *percipaie pgirfabl)/
J fc .
'■
'
T A T o . ..
>
ma‘
i fe r r i* E tfe T ;
ritornare A la fig u r a d i Lucretio, la q u a l (g li
fóce d e l nfosojr
4* i cwfegfaent i r
f h rrTie?s
-ff
r
o£wsa
nisaf
trìUept/0
H ènfrijefcà riè f f ^ f o e t ^ u f t ^ a d i n u i f i i o t } '
f r a io f i tro fo rm a re un afif/tfigura dal mede»
finto loco, Jen^a u fu r p a r tflfifa . siosoem v/W , • ,
f o to còiifiderando, che a l nafeer del fanciullo
fo g n iti, c h 'e g li/ che nel neutre detta madre
nOn era aueZgp fifont ir 4
fettoni** caldo conti
nuamente piacevole, esse poi nato incoftuncia
\
figura
presa
’« he/la figura j C
c o n s e g u lo s o
, „uadt , IJanseoosoesseoso sa w riuvlgesfi acquei
l________a
i a im ita qu&
* on d!
, che uari'ndavanti a l nafeeryjforytcrri
ucntio. y f i a u r a /a g li àniecedenti ; lochi wcfjfixrq :
cotoief e , feguitàrido ì Èlatohfoi, f o d i c e f i * co
lu i difeefo dalle
ò d ^ p in $ file {ie lo
p e fle Jphere , esse defitto delle tencHe membra,
o d'hrimanita rnojharfi al mondo : o f e la m a
teria lo .comfortafle jfiacesfi alcun g en ttlc ac
cennarnento per la ùta delti mifitefi T heoltfgia
fi^ jfa fio ta d i Vafipbe congiunta col [Fauno ;
chefocorn fjktfibrQ folfofim filicff/ìrihifoplria
d
o
t
i
ì
■
non p ù r tifla ifi
à fio rn im i lochi
d eì thioTÈhedtrq \dfirioJfoprò il CQngÌHpgjinen-
•s*'/*
D E L L A I M I T A T I ONE V f
m a .il dtfcender deflam m a nel forpo» E tslri^
noi effe formare Una ff «nxa pur d i jw fó m e n to -.
da g li aggiunti ;
c o fe ,.c h e p o te ffè ro fe n \a n e k sfu a fe g u ìrg /^ # ^ •■
le è q u e fla , incomincia ìra d q p rfr g liò f a h p ff^ ^
u *'1
cofe del mondo , o g U 'idi
mortale. FA ancora da /c o n fid a r e ,clie> de f* ° u€ri •
k m /f fo n ó fie r ifif fc n m ff ifiig j? .
R aggiunti akunfifonó
neri fono tu tti quelli se de* q u a lifin o /q u e fio ^
loto habhiamo d a to g li efem pì, ì/y /q u a li fiojffa
no effere all'oratore y & .al Poeta corrim ani*,
quantunque Vorator g li,a d o p e r i tem p era ta - .
mente ; i fin ti fono del Poeta fo llm e n te , quali,
/ f i n o quelli , è ie finge V irgilio fcriuendo a
Pollione , che al nafeer del fanciullo le culle:
metteff 'ero if i o r i, s a renouato il fecolo haneffe.
a ritornare au reo. Iquali aggiunti fiq p . fon#,
d a ti f i l a fim ilitudine, f u la cagione, s a f a
l'effetto . s a cosi non fin o a g g iu n ti.pu ri} iqi-ri K
per oche asfim igliandoil nafeer del fa n c iu llo ^
nafeer del Sole nella prim auèra ; quelle coji , vse
che poteano confegjùre/àl S o llev a to , aggiunfe #
il fanciul n a to . I / penhe'aiw ìene, che ficcartipagnate al Sole alcune di loro poteffèro in alcun
modo effere neceffàrit: ma accompagnate a l
nafeer del fanciullo ,fiano non fidam ente ag
giunte ; ma aggiunte fin ta m e n te . D isfi effer
fin d a ti anco J'u la cagione, s a f u l'effetto tir # se.
peroche il Sole è cagion ch ela te r r a m a p d if
fiori, che egli confittio n e accommodautlle culle} .
s a i fio ri fo n o , come affetti • D a l m ovim entos e
%v##incor folar^
'm iti
Jifo,
■
fojfong nrntr^TfectìM M ferro nriFiro , fa n a le
off etto f a r g iU ^ fr ifa tm f a t^ a g g iu n /è alna*
/ c t t d * ì f i f a i t i t t e y i b f a t i è-come unSolm effo*
fono, epicàr hellifiìm i ,
O S * * ; ^ ffin d eù fo n ò fa fim c^ m p a g n a ti f is c h e Fwto
d t d t d b o f r o o e d r ^ f a é i fonop/uelli n é ? A rgo
nautica d t G 0 u M f a u t i l poeta m tin d 9 figu r a r la prim a rtauigation deCgh Argonauti ; fC iì
f i a q u e l, che fintam ente fip o teu a aggiugnere
a quella : ilpcrcbt dtfjè, th è tin im p h e d el mare
m e jfa o f a r i ilenpo piene d i m a ra vig lia , veg
g e n te fi g ra n m a c h m a nel r e g tte tir o : oso poi
Jubìt+tagmugneiUKor. q u efio, che gli occhi d i a
tnotoella nane htbhero g r a tta ^
ty f a y p p M ì & f è N f o o d i gu ardar t i Dee m arili# : * d fa ffa ? p * rd > ? n o n feg u ed i ngeesfità,
éhe a i una f a r i a navigatione t i .Nere/de m et
ta n o li capof a r del m a r e , oso chegliocchi mor
t a l i potejfèro g o d e r della: utf t a n i t i . D ee; oso
/•una oso l'altra figura n a fte fa g lfia g g iH n ti :
Et [p tr c h tm n e certo ttflim o n iò , che Cofif a tte
Dee veram ente pano : diciamo d e tti aggiunti
)mit*tió ri f a f i n t i : E t f e in alcun modo la p a tta tio n
arile panse fu o tro va r nelle-parole, 5 certo far a in quefie
™Xt ^ fd e W o r d m e topico » nel quale potremo im ita r
la!* * €f 1‘autor-nell'artificio fidam en te. oso per poterlo
bette m o to r i debbiamo f a t f a f a f a t e fig u re
tenere a v a n ti fernet g u à f t a r l e ^ y
ri-
ehiamarti a loro fimpiici ftJn bfi facendo ci
potremo fanpre renderfimili
in talcun
^ s ia p e r g r a gentil modofa t i divenir
tia di e/empio r
V* 1
tonìia
iati
D E L L A I M I T A T I Q N E . -ZZI
fonali non li pi/tessero hauer , f e i iò n m g li edir.
fu i antichi ne' quali l'arte de m a tto n i ferm ata,
fi fùjje ; s a uenga in de fiderio ad u fr architette
de inferi tempi d i fa re un hello edificio d im a t
toni fecondo d difegho , che biweffè fih rfia to ,
nella mente, celtio farebbe affretto d i a b b a tter
fa terra alcuno edili et o antico ^ £& con quelle
pietre cotte f a r illtm o rp . & fi* foffìatrflupetto
nobile ; non dourebbegia leuare i. peZ jg d i
ro. s a della fabrica anticaper m et tergjuelU stel
la fu a , che farebbono conofciuti per non fuai;
ma ridur tutto il muro a quel cumulo d i pietre,
doue l una fuJ]e dall'altra d i v i fa , f i comefurono
mentre il primo fabricator in opera le m ejfe .,
e il nero, cìie, quando uemffe alle cornici, alle
colonne , o ad a ltra figura d i m arm ore, che
fi/]e in alcun nicchio ; efio la donerebbe confe&r
uar cofi in te r a ,o per farne alcuna, fim ile a d
e/empio di quella , o per fa rla in alcun, p ru dente.modo diuentar , come f u a . Et benché, le
parole tu tte , che debbiamo coglier d a g li auto
ri , non debbiamo,ordinar di felpate per Jempiise,
c i , che alcune aiicor delle proprie, non che del
le trafilate uanno accompagnate , s a cofi deono
effer confiruate s a usate; nondimeno tu tte que
J lc , che non fin o da effer disgiunte, fono , come
fuffer. ridotte a i loro principi], mentre: uamto
fecondo l'ufo de g li autori con fa loro compa
gnie . O Chrifiianife. o feltcifeimo. Re E rance fico, queffi fono i thefori, s a le ricchezze della
eloquentia che'lferuo di tua Maeflà Giulio G a m ^ iu lio t i apparecchia, quefte.fen le uie
mu
/
:•*«#
fTR A T T
legnali afeend er di alla im m o rta lità . per qtiefle
non folam ente m ll'im prefa L a tin a f A ir potrai
a tan ta a ltcZ $ a, che g li Atri Re del mondo
perderanno la uijla , / e tiuorranno in f a t u a r ».
d a r e ; majincQrle M ufi'trancefche. potranno
p er quefìi ornamenti andare al pari delle Ro-c
m a n e , esse delle. G reche. Vtuae
gra n d eZ ^ a tua » che fe AcuCta cofa mancava <t
i m olti ornamenti dell1a lt iftimo ingegno tuo ;
lagra n fa b r ic a , che to g li apparecchio^ certaContra utente g ite la apporterà* Ma per f a r ritorno
MmUatio4
9 c^ e
w h a tio n negano confiderino
oso ne.
per Dto a q u a m a brutteZzanengonol* fc r itti fa \
A# dalla lor torta openion nafeono, esse aelld \
gran dtfcordia ; che /rae /ero e ; esse ancor a que- ,
ssa >che per le loro campofittovi di qui ad Acun
tempo no» potranno effer ri conofciuti., conte
huomini di Acun fecola, m a, come Scrittori
hiZarrt , 0 di fuo capo non babbiano voluto
convenir con la openton de prudentii»e<w la
ragion , ne con la-natura , ne Con l'arte .
he pur fe leggono i perfetti , troveranno fr itta
daQicer. nelfecondo delfuo Oratore, che tut
ti i buoni fecoli quelli eccellenti f r itto ti, che
hanno Lanuti , tutti fempre fon convenuti in
imitare un perfetto» Ne far ebbe ne i loro fcrit
ti confaceuoUZ&a di Stilo,,fenon battefiero tutt i qu elli, che infum e di opemons'accordarono,
im itato una * llperche mentre fono le tti i loro ,
libri ; dalla form a uniuerfal, nellaquA s'accor
daranno, poffono effer g iu dica ti y qu A i fuffero■d'un Jecoloj esse guai JFm'Atro *
,
\
D E L L A IM IT A r i
E . %t9
i fcritti d t q u efli, che fenZa-uorma fe riu o n o \
faranno meffi tnfteme ; duqtà a pochi' anni non
f i potrà dar g iu d tr io , che in un medefimo fic o io fi f i ano trovati ,n e che in d t u e r j i . l n un
mede]imo no : perche ne anco qtiefti hanno al
cuno tn d riZ j(o , alqual tu tù mirino , anX j nel;
tihr-difco*àe u ia d a buoni fono tr a lo r d i f io r
à i : oso p a r , cheXtafcuno habbia g iu ra to d i\
fa re al peggio che può « Non potranno' ancora»
effer g iu ricati per ifcrittori d i dtuerfi fecola fi
perche non f i potrà trouar feQplo, a lq u a lfe r
fin n litoidine dt openione potej]ero effere a ffim igh a l i , conciofia cofa, che nef]un di lor fi vuoi
/ dedicare a lin gua, che f i poteff'è riferire ad un
fecolo. Ev il v e r o , che s i potrebbe portar fo r fiK
fferanX a ,s e fu jfeu era la openion d el ritornò*^
noflro in quefio mondo; che quando effi ri ter*'
naf]'eru,efft forila poteff'ero rteom feer , fò la me*
mort a di f i cieca openione, oso sa cofi dura offri*
trattone non fù jfi ancor p a rtita d a loro ; E /V
che più dirò ? effi, quantunque, non fian n a tisa
nella lingua Latina ; ardifiono m trodur notr
dico figure to p u h e , non dico lodeuoli trafilati t
ma ttuoua proprietà d i vocaboli : perche Cice
rone , o altri di quelfecolo, oso d i quella lingua
furono off d i fa r cofi, oso di perfuader che cofi safaccjje, mentre ejfa lingua era in ufo, oso ancor
fi andava facendo . N on riderefii uoi G a lli,
f i io flraniero uolejfe aggiugner vocaboli a lla
nofira lingua ? certo fi : *oso pur uenendo'io * no*, oso hauendo ad ha b ita t con u o i ; potrei1
<pprender la lingua uoflra * m a non f o t f a .
*110
T /R A T T A T O
aggi ugnarle f i fedelmente uocaboli, come f a
rebbe un d i n o i. Et f e uoi fitrefie le r if a ,
mentre io tfolefii effer cofi audace nella uofira
lingua y che tu tta via fiorifce- nella bocca s a
nelle mani del gran R e , s a d i tan ti a l t r i , che
Vaumentano ; più riderebbe Ce fa re s a Cicero»
d i Va ;fe veder poteffèro quefli nunut tqqQrfa
M inor e n o r certo farebboncjuefii, fe im itaffero un Vhnio , o un men buono ; perche potrebbono J p e r a r , che fuff'ero da alcun fecolo fla ti
Contra intefi yCome fig li quel fecolo fia tifo fie r o , Et
•
usar poro Perc^€
m i f i oppongono dicendo che ne a
le , non O s a r e A ne a Cicerone è uenuto detto tu tto •
rnigUorT I uèlo >chef i potrebbe dire : il perche afferm a- ^
Scrittoi! . no cche fe ci vogliamo f ir ingere ani uno d i quef i i perfetti}fa r a hifogno, che lafctamo di d ir
tu tto quello y che non e uenuto detto a ll autore ,
s a cofi diueniamo po u en , s a non accommoda
t i a dire il tu tto ; A quefii A ffon do , c h e p e r
i
f i n , che io poffb hauer oro Tnon voglio n e a r 1
g e n to , ne ferro : ne- perche m alcun locom i pò*
|
*' teffe mancar l'oro; io lo uoglio abandonar%
’
uedendo y che Vargento o'I ferro mi.poteffe effer
copiofo per tu tto . M a quando haurò meffo in
t
opera tutto l o r o , s a che alcuna parte dell'ope
ra m ia dimanda]]e alcuna giu n ta ; io m i vo l
gerò all*argento , m a a l ferro non m a i. . Il
perche è da fiipere , che nella g ra n fabrica del
1
Theatro mio f in per lochi & imagini diffiofh
tu tti quei luoghi y che poff'on baffare a tener
collocati, s a tniniftrar tu tti g li humani con
cetti , tuttofa c o fe jc h e fin o in tu tto i l m o n d o ^ * m
j
D E L L A I M I T A T I ONE.
f
mi
non pur quelle, chef i appartengono allefidenti e
t u tte , esse atte a rti nobili, esse m edianiche. So
b en , che quefiem ie parole partoriranno m a vaniglia, esse faranno g li bitumini increduli »
perfui che l'effetto non venga A fenfo: pur pre
go q u e i, che quefia parte leggeranno ; itogliauó effer contenti d'uri efem pto, ch'io fo r ò fan*
•
rt>chiaro, che ben potrà dar tndicio d i M enta V
Auertifian prego ; prim a.,{he. fiiffèro\ tro va to
I
le uent idue lettere f a i nostro A phabetofoè'aU
\
cun f i fitffe ofi erto di dar uentidui ca ra tteri fa
conti quali po teff èro effer n o ta titu tti i penfier
n o firi, co quali tutte le cofe, delle quai par
tiamo poteffèro effere ferrite : non farebbe fia to
beffato? esse pur veggi amo ,ch e quefie poche
I
le tte re , che fon ne l'Aphabeto , fono baflan ti a
e jf n m ere tl tu tto , E t la p r o n a , che e tu tto
dì nelle m ani di c J o r , che. fenuonv > n c fiim a tufefia f e d e . Appreffo, fe dapoi Aie f i trono»
v o m ì libri g ià f r i t t i ,
Jmarrito ìln u m e *
ro delle lettere dell'Aphabeto , esse che alcuno
noleffe prom etter d i condurle tu tte fu or de i lib ri
a certo esse picchi numeroffarebbe egti uccellate
da q u e lli, che meriterebbòito maggiore uccellav
m en to . iquati ueggerulo t libri pieni d i lettere
f i darebbono a credere ; che tu tte fuff'cro d iv e r
t i > 0 che fcriuenào non fifaceffe ffeffò ritorno
atte mede fin te . So ben io , che m i b tjfd n a fa p refin te , prim a che non v e g g a n o a lim ù d ìe
parole, tutti. quelli a orecchie<fo e qt+alieue»
nutoquefio trovato mio.; esse purè+uero,. A p r — preffo, prim a ,.che fuffero f la ti v e d u ti/p r /d iK
iij
funse
itti
.1 Y R* A T T A T O
tom en ti d ‘ A Tiftctele ycln haurebbe m a i creda*
to , che a dieci principtj tu tte le cofe, che fa n é
m ciclo , in terra , s a nellabiffìs , f i potefiino
ridu rre? s a p urfoiio in lu ce, s a tutto d ì sa
veggono , leggono, s a f i conofce, che fono hafia titi fo li d ie c i. -Adunque p a rrà # quefli m iei
calunniatori tanto d a nucuo , seio mi ofjenfio
d a r tu tti i concetti humanig, & tu tte le cofe*,
delle q u a i/ i può parlar m tanto numero , eh*
ia fia n te fia ? i quai quantunque afe end ano
per loro fo p r a il numero di diecimila: pur di toto n e f i n più di trecento quarantatre G over
natori , s a d i quefli G overnatori qtiarontano-»
# e G a p tta m , s a d e'G a fìta n i fe tte s o la m e n te ^
Principi . Taccio de'm aggiori fecreti ripofii
v e im a g g io t numero acconci a fa r quelle m ara
vig lie , c h el roljor s a la nwdefiia. al prefente
s coprir non m i U fi to n o . Adunque p o i, cito
noi habbiamo tan ti lochi con ta n te im o g io i}
th è pojjòno m iniftrar non foU frtnfe materie S
eruditioni piene r s a artifictj con nuovi modi
condotti a l fenfi : nta an corale parole, s a tu fit
t e le d ette cofe d i flin t e a i loro o rd in i, che posa
f in o effer bafianti a tu tti gh humani concetti :
fia to mio configito d i fa r d i per f i t t i f i m i a u
tori fi minuta Anatomia i che tutti que?lochi\
thè bau potuto ejjer fatti ricchi dalla lingua do*
mbolifiimifcrittori, non fonofiati contaminati
della lingua de' non perfetti : imperoche, fi co
me ho detto > dove ho hauuto modo di mette
te imopera foro; non ho voluto ne targento ,
« a i l f e r r o , ne il piom bo .
Ma > perche alcun um
D E L L A Isii I T A T I O N E.
Leo non era fia to adoperato da que feltri auto
ri ; acetiche noi bauefiimo tu tti i concetti no*
f ir i » che partiffer.o, ym o n fu fiero -m u to li : m i
f in dato a f e r r i m i defiargento **oso per d ir
apertam ente, upa d iir e m e m i p a r , che habita ad effer offerti# a in xofi fa tt i mancamenti •
Ut prima è che noi più tofig.,potendo, debbia-Tre irledj
m.o levar tl.u o ca b ff, che
ne -perfetti
autori da alcuno Scrittorea iozjùcjno, chea) desia un
dalla propria licentia vnofira ; beitche nel p tiP 1* *
qut uocaboji, che non fonofia ti ufati da Cefa
re ,.da Cicerone osoda fin tili : » fono, hocabati
pertinenti a qualche arte : oso gli.autori della
arti j come della M edicinadel?Agricolturay
delti Mùtria, oso delle a /ir e , di tutte le, loro
Jpoglie i lochi miei adorneranno. Quefia adun
que difotrifare a i mancamenti è t i primaria*
f a feconda è tenuta ancor da Ciceróne, ososse
fa r i buoni : dimetter il Greco r i loco di quello+
che donerebbe effer Latino. baterZ au rigi** circonfoa
manca
^
/diro effere la a re onlgcutio n e, tiqu alancor. sitacutsonc
fa accQmmodatajtd ejprtmere tu tte quelle effe
che per non effere fia te in ufo appreffo g li an* la Ungua «
fichi ; non hanno ne anco hauuto vocabolo : cosa
me la bom barda, t i f ia f f a , C / q u e l, che nella
commune lingua d'Italia chiamiamo Capiton
di fu oco , oso fin tili. O circonlocutione aureo
foc^orfo in cofi f a tt i m ancam enti. tu f r i una d i
quelle rie , che di tanto impaccio liberar ci
p u o i, O rdì, poveri fa rci parer rie fili » tu queU
t i f i l a , per cui ancor nelle-cofe, che* o perche
jton caddero r i propffttou, o perche non f a * #
K iiij
A
,« 4
> T sR
T T A T Oi V
dalla n a tu r a tile co fe, 0 dottar te ancor m efi
f e m luce ; non f u m i m a i dette d a i L a tin i, ci
puoi fa r p a r e r .L a tin i. Q uelle tre Mie ittlunq i# ha» fornito di badanti parole tu tti i nostri
• concetti : iquali f i n g iu n ti a quel numero , che
a d ir tu tte le c o fi, che per lin g u a , o per cala|
rno , f i poffono effrim ere, fattsfannò . lrnpèroche, f i come ,f e mane afferò altalfabel o queJì e lettere f . R. effo farebbe manco : conciofia
cofa che quantunque per [a ltre lettere potejjète \fffife fe r itti qu tfti nomi D io , A ngelo, esse
tu ttig ti'a ltr i, d o v e n o n hauefjèro loco F. IL
M lid im ty o fe ' I b i fogno fuffe d i fc r iu ere Fritti- .
tefcorfffit;[alphabeto darebbe chiaro fogno d i ^
W m fljer perfetto ; Cofi mofirerebbe im perfett ì c t o *JMl# 4
trfifnÌQ, quando f i poteffe trovar
esse penfjvr{oticeìto 9it ovi loco non u ifu jfe * a llaquale.bM ianto.riccam ento proueduto * Et
fie o m e apprefe t i lettere d e tt alphabeto > ma
non ancor ffe rc ita te , fcriuerefiimo con afiuno
indugioquefieparole Francefeo R e , esse pochi
iorni dopo fetida peufarui fu dal calamo f u tto fip r a fa carta piouerthbono per /’habito
f a t t o i cofi im parato l'ordqie d a i lochi m ie i,
f e r a le un giorno Panimo neh ancora efercitato
■p tw rtu n -p u c h e tto , m a p ei per l'ufo in picch i
u m p * a sq u tftim V /a e o so /^ v /^ ^ ^ e^ u r w 4
quella <#mpofifJo» a f f a t i nobilita contiguità
f
per la im itazion e, patxd. m eritar laude : Ma
perjiolgcre a buon catnino q u e i, che ubandonato l'hanno fo t per fu g g ir la imitatione d i ali m p e r f e t t o , ricordam i, hauer letto in u n iiy
brelto
f
r
DELLA IMITATIONE.
M*
I r etto di D tonifio Altcarnaffeo fcfiito ( come
crejo) a Kuffó Melisio , che colui non potrà Burnita »
mai fierare eternità'a g li feri tri suot sei/qua/^oso oso".!
non bauerh haunto riguardo a tre maniere* di me duoac
fecali, a paJJ'att , a prefènti t & a futuri » A <l u
^‘
paffuti , perche debbiamo méttere'davanti I I
jnti perfetto dey paffàti ficoli r sa la clettipn
d'un cofifatto , satonfo dite Cicerone idee effere fatta con lunga confìderatioHé i &cò)tbfto#
conjiglio . A prefenti 'ancora' debbiamo hfàfcr
riguardo, a quelli dico, che nel nòjlro fecolo f i
pareffe effer dotati di prnd etnia sa di giudi (io : impercioche con essaloro ci debbiamo con
figliare , fvl che prtni fu fiero di ogni pàfilone ,
sa pieni dt buon dtfeorfo ; sa ueder (èia compofitto» noftrafta uicina a quella perfotaidèa
dell'eloquentia, che es?i nella mentedìdueff&tò
collocata. ’ llperche M. Tullfa nel!\Orator fho Lapmdee
dice, chefempre la prudentia degliaudatorifù
quella, che diede norma alCelocjuentia^dial- norma.a-,
tra i . Et per nero dire ; quando Cicerone bd-ffo
uea ad orare, a quanta perfettion di configito
credete uoi lo condttceffè tl faper, che da u n C e fare, da un Pompeo, danti Bruto douea effer
afeoltato * Konpenfate u oi, che egli meiteffe
tutte le forze del fuo ingegnò per piacere d'
quelli huomini, die perauentura nella ntedefima eloquentia il primo loco tenevano, o d u iano al primo uoleuatio ? Afuturi fecòh deb
biamo ancor riguardare, penfarido% tutte quel
le cofe, che poteffèro di/piacere a tutti‘ quelli,
che dopo noi verranno y ì> irh aletm^ e/oefièreK “d
tiS
*
- W & y c * T * X 'T ^ Ó
khpofiibib d ù fitp trc '! tónfi fio i o , thè ciò d i
tu tto non pofiianró sapere; m a ben dico Velie a
ito pofiianieprbuedere : imperoche f e bau eremo
htohatfrheiKil fetfeHoé’untteo- in tu tto quel ,
e h t i m a # f i p u o f f y f id e r à non potremo noi
efjèreifMfmiati feemeabiafirnudel perfètto autdre'in p ta to . B e r tifa tili ragioni d i Ùionifio /
neh fe come conjèguiraudb pfrpetM tà g l i f i r i t
ti di coloro , che da quefio propofito d'im itare
un perf ètto fim o lontani : percioche a uejjùno
d f ìa r e fic id ic o l p en fiti 'fi uolgtmo . d p a fla ti,
che dap a ffà tt n offù itn obitir o s o certo.■ fiprépongono^, d fa n a le efler fintili uoglianó ; anco
a b g fa d k ti d [ f r e f in ti non fo t tornei tono :
tq u a r itu tti, fa l che la d o lcezza della eloquen*
ttó g u fa to In ditiatm in qu efio almeno conuengoiUi, che più pofjom hauer veduto mtllè » che
’
.
•'■* •
y
,
fi
unfilo . HI, conti credete Hot, che'l perfetto
.
- . i i . .
.
*
■
.
autor, dìe et debbiamo proporre*, fi à giunto ‘
mt i'*C' alla perfettione ? Certo delfuòmnm tiapofio fe non la natura, oso quel poco di bèn e >chi da#n feti affettar fi può , oso la fatica dette
ttfeofferuau, oso gentilmente infieme teflit te
fatta compofittine. Adunque le cofe ; che per
4kdè0td$t#e# fùvono ojferuate , erano di alevu iìfa q u d di buono , che venne a cafo detosoeWMt#A4 ehrhMégitt»
rie in m io
uu t o te ,c o
elicti e n e a v a n ti j - ch eta n ti bei modi d e tti a
fa * fùffero ofl'eruati ; fi trovarono tutti in un
filo'* M a dapoi q u e lli, che fi diletta ro n o d èi-'
Dartifirio , andarono di fecolo in fecolo offer* ■Mando : fi che trorimdsfito in mille tuffi/, antif a
V
D E L L A I M I T A T I O N E . 'x%7
mille bellezze d i [ferfe in modo,y che per<u<en+tura ttna fola in cia/cunfulaineute fia m o lte .tea
nebre rijflendea;,quella età fiuaknente u e n n ey
nella quale. coni*aiuto d i coloro, che, ojferufilo
boaeano , f i poterono veder infinite? ojjèruatio m ,
ni t .0oè infinite perfeti ioni infiemdfoeqfafrs 4
&\
alcun perfetto ingegno, fu rqn norme ;t<dbwbfa.
te.perfettion i,
prim a e rm o difperfein m ola
ti autori, fu r o ìiv e f o te m te riluCere m a n f W
lo . .Adunque colui;> clic .im ita un p e rfe tto iChs Imf*
im ita tip e r fe tti a# dimiUtraunatcLÌn uno : esse oso muoso
tatrto m eglio, quanto.in quell*uno effa p e r f e tta perseti
tfatte, app ar continuata, n m m una fola partdjfaf^ oso
delfa compofitio n compofia ; ' fi.cotne in ale un dfa
qtfa[primi autori veder fi p o te a . Debbiamo
p w fa r* che non im itando n ofialcu n pp+ i
f e t t o , nta no i m td e fim ; in noi medefimi, norrpQjJa faJère fenon quel poco d i bello , cjieM na*.
%
tura.elcafo può dare a d & tu n , Etri» q u e fia ? ' si,, f i
buona openion ci dee -confermar la nobHffimfe ;‘
arje dtl.djfegno « fo tto Iqqualxade la T tttù r fa
*
esse la Scoltura imperoche neffm a d i q u e fity
g in ffe rìfa fu a fo m m itk 9perche alcm V àttor e,o *
Scultore del fido fu o ingegno fieónten taffè , #
perche uolcndo lafciare alcuna opera perfetta f -v
ej]o piglia/Je la fim itit udì ne. folam ente dt alcu~y
ita particolar perfona : perche i cieli noii d te d e ^
ro mai a d alcuno individuo tu tte le perfettionk •
a n d i tigiu dteio d i.Z e u fifu > d i più uergrni cAt
glier le parti più bellea. esse quelle accompagnò
alla belleZs .
4* ehe egli fibau eu a fo rm a to n e lla .
m e n te , p r fe ttìfìim a d ifig n a tr ic e 'J i quei f ù f a
:U8
T-R A T T A T O
crett, a quali ne la n a tu ra , ne l'arte può per
ven ire. N e dal gn idi ciò d i 7
. enfi debbiamo
noi dtuenir prefonttiòfe nel levar d a m ù tile
parti più belle oso come fece Cicerone, o alcuno
altro pétfetto : perche quejìa fittica in tu tte le
generationidello fid o cff'o di hauer cela adom
brata p r o m e tti, cl>e Zeuft non fece fe non in
quella, che una bellifiim a giovane rapprefen*
tar p o tea . E t al prefente io non intendo , che
i dati ejfempi f i fe n d a n o fopra tu tte le p a rti
dell'eloquentia, ma filam en to fopra le p a ro le .
Debbiamo ancor penfar, che C iceron, fi per
effer nato nella lingua L a tin a , s a perhauer
fatto fiorir la fua e t à , laquale ancor per m olti
altri ingegni fio riv a ; come per hauer letto con
grdnde elezione g li a u to ri, che erano an dati
a u a n ti, s a per hauer conuerfato fim p re con
buomiiu pieni deficienti a , di buona Lingua ,
s a digiudicio , ad alcuno de*quali batteva an
cor fa tica d t fa ti sfare; che egli habbia faputo
con maggior prudentia coglier le bclleZj(e della
lingua L a tin a , s a leuar via le parole troppo
popolarej'che, o comiche, o d u r e , o g ià a m i
chette ; che non farebbe uno di noi non nato in
quella lin g u a , non dt tanto giu dici o , non tifo
con hvomtni d i tanto fenno : Et f i li Scultori
s a Pittori del prefente fecolo haueffero non pur
l'imagine di Z e u ft, nella quale fi vedeva quel,
che conueniua ad una giovane; ma tu tte le perfe ttio n i de' ftmulacri, da quali poteffèro coglier
tilt te quelle p a r ti, le qual conueniffèro a fin
ger non pur l'huomo, m a tu tti g li a ltri anim a-
D E L L A r MI T A T I O N E . - n*
li yf i come 1
)abbiamo noi tutte, le parole accom
modate y come mollifiim a cera a cader fiotto
qualunque figlilo d i tre m anieri d i d ir divina
mente tra tta ta da Cicerone s a d a c ia f curial
tro perfetto ; farebbono di quella fatiga lib e r i,
della qual fiamo noi . E t fe quefli m edefiifi
Scultori s a Vittori , mentre voglio» fa re una
'figura ; più lofio, fi contentano d i pigliar la
im itation da una sta tu a antica fiu ta rla alcun
grande artefice, che da m olti individu i f i t t i
dalla n atu ra , ne qttaì ìe belleZj,e non fono uni
te , s a non è poco , quando m ciafcu\i fe n e r ise
troni una : percioche nella fig u ra antica del pe
n to artefice fi neggongia tu tte le belle cofe uni
te ; perche debbiamo noi potendo levar la im i
tation da un perfetto in tutto q u e l, che l'huomo far può , 0 di noftro capo ho ter ritornar si
que pnucipu , ne quali ha f i t t a g ià la fatica
quel perfetto autore ; 0 levar ancor le parole di
coloro , che nell'imperfetto fecolo JcrijJèro ? 0
follm en te rapprefentar quella picciola b ellez
z a , che la particolar m fìra natura hauejfkbaunta dal Qielo ? Certo ni tanto error non può
cader ,so non co liti, che non ha g iu d i ciò d i bel
le z z a , ne d i b o n tà , s a piglia confufxmente
ogni cofa per bella s a buon a. Q u e f i a tale cofi,
come non vuole il g iv a te io de' p r e je n ti, ne d e*
paffuti ; cofi ancor poco penfa a quelli 3
che f e gu iran n o, iquah fa r Mino forfè più fafiidiofi nel
voler fi contentar;, che non fono i preferiti, N e
tanto ho d e tto , perche io m i tenga eloquente :
rmperoche, che può d i fe promettere urilmorm
1JO
TRA T T A T 0 *i7
di fi piceiulo ingegno, com'io, oso occupato tan
t i anni interno a quefia iniprefa perdi/occupare
altrui ? oso per fa r ijpartniar tu tta quella età ,
f a fvghvno ffendef'gli* huomini, mlVacqutfio
delle dotte lingue > acetiche le peffano collocar,
m i uefiir le jclentie , che ancora ignudo fo n o ,
oso principalmente le sacre f r i t t u r e ? E t pet
nero d ir e , io ten g o, oso certeffon dt faper. meno '
d i ciafciino, che dt lettere fi d iletti : ma ben
pofiò p ro m ettere # mio I le , che di quel poco 9
ch'io fo Kiti poco tempo fif a r à partecipe, osofe r u irajfm e, coniio , oso ta Uo tn egli o x quanto e
dotato d i pi# alto ingegno, He. al prefente feri
uo per infognam i, w a per dire il parem m o : i t i
qual fe ut parrà , che g io v a r ut poj]ài.ue;ren-r
dereti hfinqre a Qio». f a q v a le ogiu ben, proce
de : f e anco la tro v a te ti, uang. * *pigliate . il *ni#
buo# upler 3oso atta f a n debilita fea ccia u i ba
tter tompaffiont* Q r e fa a b f f tw f f i& h w x d ir
M iffraJofiqiitaO 0» d'ufi perfetto fatoF i fffri t o ,
wuM, oso/a openione di quelli osoor, pana, f/ja
t i pegany ; imperoche nenpoffon metter-pare*.,
tiftifrim e del fatto equabili > ne del f ut tabelle,
K/ psffa e in quefio nego rio d ell im ita r cofigr f i .
vanno im plicando, bor dicendo effer cofaim»
pofiibile y bar non.effer fa tica d a prendere,ma»
ehr da tu tti . f i dee pigliar q u e l , che ferijmetto
davan ti,, oso alcune altre v a n ita . nette qua* ,
confondono le parti detta eloquentia : Le quai
cofe mi fan ne credere , che fim o fia te d a lare,
mujlvppdiam ente d e tte , perche non hanno uo-
tuja philofophar intomo a quefio fa to » ne cor*.
DELTI A I M I T A T I O N E .
iji
Citi diligentemente qual cofane g li a ltr u i ferito
ti im itar nonf i possa, s a perche : & d i quelle,
t.
che pofri amo im ita r , tji/ael/ fi deuno d a un fifa
s a perfetto aut. r ricercare, s a quali da più
ancor di diuerfi fe c a li, s a d/ diuerfe lingue ri
cercar, & im itar f i potrehbono. I Iperchei#
non come a r d ito , o perche io m i fiim i E fficien
te ; ma come defidefofe, che quefla u erità fi tra
uaffe, con l'aiuto d'iddio m i darò fa tic a d i
a p rir, fecondo l'auifo m io , quali & quante
f i ano le pttrti della eloquentia , s a d i quefle
ijual fia quella, di cui folam ente l'effetto , s a '
non la cagione im itar pofri a m o , s a perche, s a * 1
quali s a quante fìano quelle, che ci pofri,imo
nell'altrui fcrittrp ro p o rre, & com e. Et per
incominciar , dico q u e l, eh'un'altra fiata iti
cfuefia oratione d ifri, che io ;to/t creda, che l^ u n o a u ^
natura dall'autore pofja effer im ita ta g ia m a i, torc non
ma folamente que' configli, che da lei procedo«
rio . s a per gra tia di efempio , un nuovo òrchi- rc i mitneae
re/to non potrà mai rapprefentar la natura '
d'Hn an tico, chehautffe fa tto utt tempio a d '
H ercole , o a Diana f i , che quella ifteffa potefje
’*
effer giudicata ; ma quel config lio , che l'antico
hehbe di fa r al tempio d'hi ercole le colonne ra.bufie , a quel di Diana le fiottili, s a d i volger '
la porta del tempio , o uerfo il fiu m e, perche
fujfe rivolta al 0io , che l'antichità credeaftiffe
nel fiume ; o uerfo la fira d a „ perche stinse ac
commodata alle falnatiom de' nia n d a n ti. E t
in nero quefii configli Jono di tanta tur tri, per
che [ d i dannò la T ir affa', s a i o iridrià/fp a - f y tf f
1
4’
t
x ; V jt * r r u t t a t o
*'
t t ilfenfi ; li qu ali. poteffèro effer tr a tta ti dalla
m~ eloquentia ; che di loro in loco della natura a
òajìa n \a contentarci po [riam o. Ma perche i
tonfigli dSnuiar l'eloquenza a quel camino, nel
qual era al più felice fecó lo , fono fla ti ta n ti loti
ton i dalla cognttiori d i q u e fli, che hannof i f r a
na opinione nétta, compofttione della lin g u a ,
quanto eff 'a lingua è fia ta lontana da loro ; tiri
sferrerò con alcuno ejèmpio di f a r quelli non
p u ru ia n i all'intelletto; ma ancora al fe n fo .
Hit non ui poffo dar l'efempio , ch'egli non fia
f i grande ; che abbracci il tu tto . Et effendo d iut/o in fe tte p a r ti; U fejìa folam ente fitra ac
commodata a q u el, ch'io pro m etto. Foniamo,
che la nobili[rima arte del difegno fuffè per ef
fere infegnatada i più periti Scultori, s a Pittori ta lm en te, che nejfuna parte d e ll op era ,
che uoliffero comporre haueffedifetto alcun» ,
a n zj comprendeffè tuffo q u e l, che poteffè mai
. .
f a r un Scultore, o un Pittore nell'opera dellef i
g u re . Siate contenti eccellenti Scultori s a Pis
tori d i porgere un poco torecchio ad uno, chetile
* ” 1'
saolptr, ne dipinger f a : s a l e ui p a r r à , che nel
ila d 'tU f'k marauigliofa arte uofhra fappia difporre i uo
fi«» a gli feri fecreti a perfetto numero (fopra tlqu al non
tu Vittori fi fu 0 afcendeie3et fo tte tlqual fe n d e r nò f i dee;
acciochr potrete pigliar indicio , che io meglio jape f r i , o
fino Ini*' Potefi* f e r c
t0m quella (acuità >nc g li ordini del
t.ruU> otri laqualho collocato Audio g ià tanti anni. C erto,
/ rtu? ilVe Per
’ è ie io mi cred a, dourejìe fa r fe tte
tHianti- g ra d i principali, per tquah falendo potrefle
t W.
g tu gn ere pi r virtù della im ita i ione alla eccelle-
DELLA I M I T A T I O N E ,
ijr
fia de g li aniiilu u o fìri. Adunque nel prim e c.xiAo pii
grado deurefie hau ere ordinati ta n ti lo ch i, c7; e » ° ,
potè fiero alloggiar non filam en to l'Intorno ; m a . ■
tu tti g li altri a n im a li, che fitto il difegno e t effer o cadere, acci oche c o lu i, che uoleffe pi
gliar le norme d i difegnar alcuno^ fapeffe an
dar Va, dove a man faina tro va rlo poteffe ,
N e l fecondo, p e r d io a tv f i , dovrebbe effer c<d- $ « •» ufo
locata la differenza di e fu n ii m ali p er il fc jjo :
perche altra confideration f i dee hauer volendo
difegnar un mafchiq.., altra volendo fingere
una firn in a . N el terzo la differentia per (*e f o ttt9#
to , perche altrimentt.fi finge u ri huomo m afclm
essefanciullo t altrim enti un giovane, altrim en
ti un ueccìno. E t perche la in fe r m ità , o la
~
fh vtch czza, la f i n i t à , o la robufteTfga b a tti#
g ran fomigtidnxa con l'età ; tu tte potrebbono in
quefio te r fo ordine capere. N e l quarto Aeti- quarte.
rebbono effer po fiig h o f f ci de g l i anim ali : per
cioche altrim enti farebbe,da efierfinto u r i huo
mo religio f i , altramente un f o td a to , quello Info
mi l e , quefio altero cofi in altra uiuflcìtxti»
cava 'lo m dòm ito, in altra uno aueZyp alla gucr
r a , altrim enti un dato alle uit fa tich e: N el
quinto farebbon da effer richiamati non p u r g U ^ ^ tQ *
f o r t i cameni i d i tu tti g li anim A i , le f a tt e z z e
per fino a i n eru i, esse le magreZyS uicine a
quelle , esse poi le quan tità * esse le q u A ita delle
carn i, che in quelle entrar pvtefiero per da r co
gnitione d i poter fa r di cofi fa tte note o empiute
d i carne, esse per la pittura potrebbono effere ag
giu n ti i colori, esse le loro nujìure, esse anco l*#~
-
' ; * ::
* 1 4 A (T O T * T T X T O
‘
.f°4
t quelfi, oso, finalm ente i lum i y ? om bre,
t y appreffo tu tte le effe-,- che. poteffero andar
fg p ra t i carne. ig n u d a , che olii Scultori , oso
f i t t o t i fonocomtounù) cioè tu tti g it h a b iti, oso
S ito ,
.t *
g li ornam enti»,f a * , g irim m a lx fffietta n e
imperQchf Ig p k g h cd e panni vogliono effer ne
$ lùqghi noti dettafigura» m a ilu o g h i d o u ejò m
i riletti detcorpo apparenti , / ó m e l e fp a llè , i l
p e tto , le ginocchia , i bracci r deano effer n e tti
d ì pieghe , acciof a q u e ltip a rte del carpo , f a
J p u n ta , f i vegga d a r la fu a fir m a a lp a n n o ,
E t poche pieghe deo,ne x ffe r . dat e intorno a lti
figura pern o# cadere in confitfume > Joso f l u f a
p u r i f a deonoxffeTm ojhratt, vogliono porge»
%e gi namcnto, y effer in buon luogo \ N e lfe *
fa + d e o n o eflh&tadinate tu t te le , pofitioni 3o
f a r iP W tid e ty e ìp o » éb< dtiu ogham o x quefio
farebbe peraue tàuro. f a t i yuelquaL V artefri
ce .potrebbe m o f i r m p m ^ f a i n filtro h / l i t i
f a , t e b e f a H p 4< m iìn fiv k » A ffk fia # v p f a
osoni ; im p e rch é riafiuna. con u n * pieciòla a t i
ter#ion epotrebbe effer dittif a in molte ; nondintenó p J tfa farebhonole principali: oso, pur „
<m4#do:m c o r f i t t e l e principali jtoleffe ordinar
le f a t o d ir isai uercebbon fe n \a dubbio* nume».
t $ , che haUer\bbjexert 9f i n e . Q uefio ordine
adunque t#ofirerzrm w n fo la m p M tq u a n tep o fi
t f i r ip < /p t f a r m corpohumanoi o d i altro o titi
f tia le x w a t i f a fu ra d ic tifcu n a : percioche r t i
p jglia u d o .tittig lito rd in i d i f i p r a , m i m ede fi. mo corpo m afihio, g io ita n e, [U d a te , .uefiito r,
potrà effer c e f tifa Q tm w k e p p fitim h g n m efln
D ELLA IM IT A TI O N E.
tre haurà cpmpofte le membra in unor, darà urta
riùfura da un lato in un m odo, che in u ri a lita la .
vari arebbe per cagion di qualche firm o , chef r if
f e fatto da alcuna contranione , o d i qualche
aumento prodotto da alcuna cof a , che fa c effe
ftender quella parte. N el f e t tim o , fen Z a il
qual tu tti g li altri farebbon u n n i, haurebbe tuo*
go ilgiudicio d i elegger più toflo d i fin g er ih
quel nicchio u n im m o , che un L e o n e , p iù to'fio un m afdrio, che una fe m in a , firn tofio.un
g ì ouane robufio , cheyun fitncitfllo tenero > p i ù ,
tosto un faldato, che un reltgiofo, più toflo rii*
ueflito j che uno ignudo , s a più toflo quefio
r]
huomo m afclnogiovane, fa ld a to , s a uefitto ,
in talpofitione , che hauefiè il deftro p ie d e , che
•- se.
è il più f o r te , auan ti; che'l finifiro in a tto d i
Andante , non d i u n , che fi ripòfi , bat/endori*
guardo alla natura dell?animale ,
d e i luogo,
alla H icìnità, s a alla lo n ta n a n ti V -Ef ft.p er i
f i t t e ordini u ip a r che uno Scultor i o V ittore,
poteffe u en irt alla tm itaticn d i ciafeund figurtè
f o t te d a iperfettifim tb antichi uoflri ; k iu ia lé
f ic u r i, cheper ilmedefimo fettennario numerò
d ig r a d i, quando fuffe ripieno d i tu tte quelle
e ffe , che degno d 1
imitatione alcun eloquente
antico fa cejjeto , a quella ifiejfa eccellenza, che
giuufe CMitica, potrebbe co lu i, che imitaffeintilcunm odo perven ire.. E t il prim o gra d o
che hauef]e a curnfpondereal unsero yilquale < loqumtc >
A i t e t tig li anim ali ornato, farebbe con rin flp t? ^ J n u S lf
t ifimto tir dine d i te tte le m a te rie , f s a che' pò^TimiU a»
ìe/Jèro effer
■eloquente se
-
il*
T R A T T A T O
b d le Z fia farebbe fa vedere una dopo [ a lt r a tu t
te Popeniout di Art fio te le , di, fia to n e & d e g li
a ltri vhìlofopbi pei* fi» d e \.n o fir i C jm fiian i
T beologi, esse appreffatuttele/rifiorì*, -, che a
k ofifa tta piatejja appatfenejjèro,. JNe coftfa tte
m aterie dotierebbono, fi come al fuo luogo ho
-•m ojìro %effer fenda t i f i# p a f i w i ,n p ferizan
luoghi , da iquali le dette p fasi ani tira r f i p o p
fo n o . J« quefiofinalm ente tu tte non pur le, li
b e ra li a rti ; m a aticor le altre esse degne 0 m è»
d e v ie deurebbopo tu tte le lor pompe f in tg a r e .
Il fecondo gradonqfiro da effer adeguato a l uo«ondo,*’€mf ! S p 3e-*
d e g li animati deurebbe m ofirar
ci iefajferentte detti trattatiotu per il uerfo esse
per le profe : perche im a medefima m ot cria può
ejjer tra ttfa à à a l Poetae, esse dall'Oratore ; m a
altrim enti d m fa i? # esse a ltrim enti daWaUrò,
Teno.
4/osoC 0 g rafa tifa x éb l# afeender o lite ta ,p e r
lo f i fa r e , delle materie :>ètnperpché, fi come n t
iu o firi anim ali confiderai* Ifoaw fifaltìQ ytfic1\paf a [em plicita , la giouan eZ Ja tu tta dilette*
Vóti r la u irttifa g r a n e , la tiecchteZya fe u e ra ;
{j*\ de quoti alcuni fono fcm ptici, a lc u n id ititt\èfa tfa [a tiu fo g rtffa * t if a i feu ert per fin o .d
Quarto, numero,
f a d i fiìptdfi } l squarto
Vsi
y '
tw q u p Q p fm p h C it# (jpfalettfaionc J & g r f a
‘ u if it, esse fe tk ritd jja u erfoffa tjo ; nondimeno,
fi come nel uofiro f i faurehbe ueder, a f a a fe m piletta in un fanciullo, A tra infirihu^mo ro^o,
altrq fo rX fftn * » f o lf a r if a ^ fff a n p fa K p tir ta
DELLA I MITATIONE
137
a preZ jo ; cofi il nofho ordine ci m ette auanti
altrim enti la fem plicità d u n a materia , che
parla d'un fanciullo, altrim enti d i quella , che
tratta d'tm pafto re, 0 d ‘un ruflico : altrim enti
la gran ita di quella m a te ria , che tra tta dell'anima : altrim enti quella che parla dettitelo., de
*lt elem enti, 0 della Rep. ancor che tu tte quelle'
cangiano f it to la firn p ittila , & ejueflefitto la
g ra n ita
II quinto grado comprende le locu
tioni proprie, traflate , topiche. E l le p r o p r ie * ^ 1** *
fin o qu elle, che a gutfa idi carne deono effer
meffe a 1 lochi, che la natura dimanda peli . .
corpo dell'eloquentia. ilqual f i r i \ a le parole*
m a g ia apparecchiato a riceuer quelle non altri
menti 3che la m ateria g ià f a tt a tiicina alla
eloquentia, s a che g ià foff 'e dal!artificio aci\
concia s a d iffo fi.t, s a laqual fi come un corpo
organi\atti y ma fic o defideraffe la carne, è ie'
e
u f i ( A , s a tu tte le fu e parti n o te r ie m p ile ,
s a fie fio ancor noleffè mofirar non U carn ài *
ma i uejlim ent i ,. s a quefli fin o i traflati : de
quali traffati quelli , che f i n f i à d o p e ra tila tu t
t ig li autori; che non fanno Mifia d i effer trofia: /
t i , fitto la pernia d ì tu tti i buoni corfero,a g u i f
f a di quella parte de ueffim enti, che affètta be<s
ne a i pieni del corpo, s a paiono effer n a ti con
eff 'o lo ro , oue ferina v a g h e zza di fa ld e fiu n if cono co i nleui : ma doue per le p a r ti, che
fcaggiono, non può andar cofi fa tto affetta-,
m ento, han luogo le fa ld é defle p a r o le c io è l *
trajU to deflartificio dffFautarffolo. 'Eb+tper.*
che il Móflro fiffo gradò htfègnjfita.qtM nfofofi^
Sefto.
tj8
T R A T T A T O
. *Hrc poteffèro effer collocate in un corpo ; il noflr o , che gl* corriffonde, parimente potrebbe
dim ojìrare in quante pofitiom fia fla to colloca
to il fenfo d+ma materia dal perfetto antico con
le nitfure fu e : percioche un medefimo fenfo
d?una ifteffa materia è Tlato pojìo hora in pofìtion d iru ta , hor a in obliqu a, hor in quella,
che porta am m iratione, hor in quella 3
che d i
manda . Le quai p o fitio m , benché molte fila
no , pur hanno il numero f in ito . Il fettim o
m io , s a ultimo g r a d o , per tlqual posfiamo f i a
nalm ente giungere a quello, che fi può : s a a lqual ajcefo posfiamo d ir d i hauer nel tutto im i
ta to , e il dar giudicio della e ltttio n e , ilqual
dee correr per tu t ti g li a ltri f e i ordini : conciofìacofa, che hauuto riguardo a J n fife r in e , s a
alla fa cu ità >nellaqual f i ferine , s a alla cofa,
d i che fi fcriue per il giudicio d i colui , che Mor
remo tnu tare ; potremo faper pigliar più toflo
delle m aterie q u ella , che m iniftretà Fiatone;
che q u e lli, che d a rà A nflotele : più tojìo quel
la , che fa r à tr a tta ta da Bafilio, o da ChrtfoJlomo ; che quella d i Thomaf 'o, o dt Scotto : s a '
, più toflo la graue ; che la Jèuera : s a più toflo
la grane della m ateria deAanima ; che la graue ■
della Repub. più toflo la locution propria ; che
la tr a /la ta : ptu.toflo U f o fittoneam m irativa ;
che la d ir itta . L t tanto d i quefli fe tte gradi
voglio hauer d e tto , aeaoehe io u i habbia fola m ente aperto quanti s a quali a l parer mio fila
no qu e lli, per tqualyalla im itatione afeender
posfiamo
N o n e adunque la eloquentia da e fi
n ELL A I MI T AT I ONE. »J9
,
fer folamenl e confidcrata nelle p a ro le, f i come noquen*
ne anche uri edificio nelle pietre fole . Et non*1* non
a ltrim en ti, che le pietre fa n fenfibìle quel tnodello , che prima fla v a occulto nella mente del- nelle pare
l'architetto ; cofi le parole firn fentir la f o r m a i ^olc *
dell'eloquentia, laqual p rim a je n \a cadere fiot
tò l'altrui fenfo, nettammo dell'eloquente f l a
va ripofi a : esse di intono, fi come quel mede fi
mo modello potrebbe effer fa tto fenfibìle da pie
tre coite , da marmo b i a n c o , o d a porfido i coso ».
in un medefimo modello dteiotfuentia può effer
uefi no di parale G alliche, R im a n e , Greche ir,
AdiuvjHe è da confìderare , che p r im a , che%;
modello venga Ala cognition del fenfo per m e \ o delle parole, fia dattm telletto alla im ita tio »
di Acun perfetto ben fo rm a to , introdotto yessesi
dt/pofio. Percioche non A tn m e n ti r che malti*
edifici fi ueggon fabricaù dim a rm in o b ilifiim ib
fen\a difegno alcuno ; cofi ho uedutofi/efiò m o ti,
te compofitioni di belhsfime parole fenzazdeum,
na form a laudabile : esse pcrxontrario m olti bfó '
modelli d'tndigmsftmè pietre f a tt i* ;Rricordarmi
g ià in Bologna , che uno eccellente aitàtomifla
chiufe un corpo humano in una coffa tu tta per
tugiala , esse poi la effofe ad un corrente d'un
fiu m e,ilqu al per que' pertugi nello {fa tto di po
chi giorni confumò esse portò uta tu tta la carne
di quel corpo, che poi d i fe tnofiraua m araui- >
gito fi fecreti della n atu ran e g li oifi f o li, -essesa.
nerui rim a f i . Cofi fiu to corpo daHe offa. fifteto*.
nuto io affo miglio A modello della eloquente**
d A ti m ateria x esse d A Aifegno fitiffa tttm tù y ,*
-i4o
T R A T T A T O
Et cofi, come quel corpo potrebbe effere fia to
ripiego di carne d v n g ì ottone, o d 'un vecchio ;
cofi ti modello della eloquentia può effer ueflito
di parole, che nel buon fecolo fiorirono , o che
g ià nel caduto languide erano . FI cofi come
all'occhio di/piacerebbe ueder, che'l capo d'tin
ta l corpo fu ffeuefitto di carne & d i pelle ìli
gio ita n e, ma il collo d i canoe oso d i pelle di uecchio tu tta piena d i rughe; oso più ancor f ir n
una parte fu(fe di carne, oso di pelle d i mafchio
* tu tta ta r iti » in un*altra d i fem ina tu tta m olle,
oso maggiormente fe haueffe il braccio d i carne
pertinente al?huomo, oso il petto d i quella, che
f i richiede al B ue, onerò a l Leone, oso jw/isusa
f c tu tta equabile, y qttal dotterebbe effer netti
fu a più fiorita età ; cofi farebbe ingrato atto»
ròcchio, oso attintelletto l'u d ire , oso l'intende
re Una ora tio n , che non haueffe tu tte le parti
Ucfiiie d'una lin g u a , oso non juffe tu tta a f i
medefima conforme , oso che non poteffe effer
richiam ata ad un fecolo. Et quando fa r à r i
chiam ata a quello, nel quale ella p iù , che in
dUro haueffe mofiro il ua lo r, il u ig o r, oso la
bclleX$a fu a ; tanto più fa rà degna d i laude:
oso quanto meno in lei f i v ed rà lingua di altra
generatione;tunto meno di/piacerà . Et nel ne
ro, fe la fauola d i Pelope fufje htfioria ; credo ,
che firà n a cofa farebbe fia ta ueder la /palla
fu a d i a v o rio , oso il re fio del corpo altrim enti
ta l uifta farebbe p e ra u e n tu r a ,y più /piacevo
le un Satiro,un C entauro, un Mofiro. Per t i quai ragioni >fi conclude nella p erfetta compo* fition
DELLA IM ITATIONE.
^4«
fitio n tre cofi principaltfiime effer da o/Jèrutte,
l'età perfetpa a quello ,(h e ,è quafi fifio >
sc e c ie . L a eloquentia adunque ha due fitc o k y
lu n a , che riguarda il modello ; l'altra, le paro
le , s a ilmodetto fialLi fu a parte ò a molte cofe,
come i configit, te m a terie, 'le "phfitoni, i e uie
tda introfiur fa/natetie , i tr f iU a tig lik j jo n ti,
*g li argom enti. fifet le parole , oltre, che uanne
in tré pòrti d iu if t, Tirano alcunefigu re d i oollo*
catione i mem bri 0e le g a tu re , la lesturdl, lV preiriaà à nu m eri ,
Vharmonia: lequai tu t
te cofe con tdeune altre,che di d ir m i rifervo per
f in o , che alla RegiafiAaeJìa piacerà, s a no» f o
no di mmor p e f i, che quelle ,c h e te ho narrate,
« quelle, che nel corf i del*crai ione prefinte ho
propofio dt narrare, ti daran mano, f ie r o $■£*? ■
gnere in alcun modo a quella fim m ifà ^ d fffo
qual potremo guardar in g iù tu tti coloro fcìgf
j m \ a la im itatiòn d'un perfetto y alla compofi1ione uengcn ? . D « o lm i, che non m i f ia le a tp
dimo firare dt tu tte le d e tte x o fi la fa c ilita s a ,
la p r e f ie \\a . m a per fino d Qui v i b a ff i hauer
tntefo, che io h ablia l'arme cinta} con la q u a ije
m ifu jjè lecito con piacer del R e , s a che la leg
ge di Chrìfio me lo perm ette/fi ; m i potrei d i
fender contra q u e i, che a torto m i uanno lace
rando. Q u e f i a arme, Erafino m io,m d i f if a m ia
et della tua mente, laqual f i ben,che dalli f r i t t i
tuoi d ifiord a quado nó m i fa rà uie tato m etter
la a mano no g ià per o ff edere a ltru i, ma,perche
io nonm i laffioffendere ; f i e r oc attira g li altrui
morfi mofirar colfauor d i t u t t i i buoni ignu daa
.sa
I L
F I N
Ese'
L
*4*
O R A T I ON P R I M A
D I M. G I V L I O ,,
C A M
/ l
I L
KE
P E R IL
L
O,
-
C H E J S1*I .A '
VESCO V O
M t A V I
C 1 No.
a
, ; > .,
A 0 i v i N A preferir
tia d im ftr a M a e ftk y l f f
quale col fuo. fp le n d q rè, .
r afferam ancora t i t q i e —
bre di quefio aere I hasse s
ttalm ente, riguardando
t i io,mandato nelle m o ti
m io , Miilt desuo/ raggi, v
cheto d i gentili)uomo f o r e f iie r e p r iu o .di ognj
luce d i cpnfolatione, a lti fo la loro g u id a , d a ■
tu tti o non conof i u t o , o abandonato, f i n uenur$o a mifericordiofi p ied i j ù o i : dandptyi a crer
d e r , che non ejfendo R e in terra , il quale rapprefinti p/u Iddio nella apparenza, quando Ip
p oSesfimo u ed e re , cheuojlra M a eftà , non fq t
ancor Re, che nelle opre lo babbi a p iu a rdpprcp
f in ta r e , D ico a lù fftn p B ,e,}a n ta e f a e j a h i ^ .
v- v
ri
i
1
-•»
*
f
D J
F R A N C I >A.
m a r ita , la manfuettifane, 0 la clemeqUa nel}
• unsero dittino a ffe tto , che ritenuta fa debita jposo
uercntia, han pofio fin e a q u tl tim o re , cbeit$g
me fim pre perfino et.qui èfiato d ila fiiffim i C<t*r
dere 4* clejneutisfimt .picfa f a i , ^ ^ t o nel.
cader mio è infante cedute quel ù ì t m e f o e perv
saio « qui ini ha tenuto, in d ijf a r te . Mae v o g lia .
idd io, che we/ caedere del forpo 0 f a i
mik.»'troiài Iettata nel cuoxe fa uojfira
qu ella cpmpafiiotte , (aequae/ s e lf sdì p e sa re se-,
mile ae D ie \r0 anco troni t f a f f cranio. Icuatain me,qual fogltino hauer uerfi D io tu /ti q u e l-.
l i , che con tutta ilcuoren e lo f ita miferi cord/a..
f i commettono , Offfiche.» f i co p u la d iv in a m i- >
fericordta ha Fiancato tu tti i,calami cessegli iti*
chiofirt de p r o fe ti, cosi quella d i upflrq ^aenseoso,
habbia ad empire tu tti i f i g l i d?Qr/fcnfif
titri H fio r ic i, e P oeti. Nessun
f tw e fi grande, o grandi s f a ? JjWs n fjfiqfofirrL
\ a di lin gu a, o p enna,. la ^ /f a é jta pòjfe»te+ ^
no/i dico ad tlluflrare, ma d/si penae aedowhraesi
re le infinite lode A e llW te ^ #
meno uoflra benignità m i perdoni. . Nnseunae,
nseriae puo bavere acquiferi0 0 a^quifiara g io r t
m a i, che a qu efia, che. fi le/ropotvcfp n elp re«...
fin te g io rn o , habbia a poter fi ptireggìare. so '
henc, o Re incomparabile nejfuno Re d a l prin* f
cipio del m ondo, nejfuno lm per a d or e nejfuyi# ^
Duca d i efcrcito battere fa tto g e fli più notabili ^
n^pju maraviglio f i , nè in maggior? numero^^ ^
nc più disfim ili, nè con m aggi oret p r e f a X f / ^
ch<utfìra
.M lhjs-tfiffUSUiUffW M Sfi.
244
’O 'R A T * t . À s R f e
rnifericordia;
fa k propongo ; farà 'm o lto
m aggiore, s a durerà maggiormentè : impèro-'
che g li ìJ iflo riù , che fartuono, pojjono fem pre
de gli altrui fo tti fecòdq il loro piacere dtm inui
«rt»;facendogli", o « ca p ita rti; onere d i efere ito ,
d alla fortuna com m uni, m a netta gloria della
m i fe ri cotdta , che io le propongo priori potrà,
ba u tte nojhra Maefià compagno alcuno :tu ttr i
fa r à f u a , non hauerà parte in q u ella , ne capi
ta n o , ne èferctto, ne quella Mali* agi a fortuna,,
laquale, perchè dubitava > che t e tti iu ofiri bù
tteri , tu tte le uofiro vitto rie ghane/foro ad effe-'
r e YicQriofciuteda&a fola uojìra m r tù , s a non
d a lei ì& àri riife c e fig r a n d e ingiuria inàptótiia m o fo h iffim o R e ; che le infinite uéflrelotii
‘r firiM fa o d + M ftrt g loriofifim i fo tti,fia n o fid é t'
anent* dglrJtM trfrattom dn date^
quando faranno i é ì e g « ‘ascoltate, rioripotraiipaffipr ferinafte p ttfip a tm o p to rtrd ri dìeferL
e k r,j'u o n id i troriibt^e^YandtiurH ^fon^M keo g r i d i ,, s a lam enti do g lifo p érttik ; f o t# i; s a
'Uccifi dal mfiro*alfa v a lo re . Lequai cofe, an»
-cor è ie fo n o ornate d i g lo ria , pure ddladH*mar '
na ten erezza fono lontane i m a quando f i l * g - <gfrà detta mtferteordid d i vofhtd h U e fta , s a
onasfimamenté d i qutfta^ che io demanderò r
d ritti q u e lli,d r e i udiranno y® leggerann o, f i
òndurraHnó tr ié tia d à m a rr ) & adorar r ia al- 4
J t£ f f a Uofirriy ancorici re non la haueffiro conofe m ta g ia m a i . Aggiungiamo poi, (he la gloria
delle arme non. fi partirà da quefio mondo y m a
quella d d U in if é ìfa r d iv .ù m a t^ r k eterna an* *
I
D i
E Rr A* N C .1 A. . W
cord m C ielo, per laquale potrà nofira Maefiù
tfiere fim de a Dio ; che per. quella delle arrqi
mi rendo h ormai certo a lti f i m o R e , che la
Mae/là uoftra habbia g ià comprejo dalla noce
oso dallo f in ito mio %eoe quella regge * la ifi effa
uoce C / lo medefimo fiir ito del Predicatore F ai
fiumano ; a chi effendio d a acerba prigione, g ià
' per più d'uno.awfp uiefato il, potere venire a i
piediJiioi, vengo i o , cjie H nicoefion fitittofiafellog li fin o \ a n X j uiene effo m edefirnoin un#
altro cqrpo, poi chealfttoin fi duro c/rcere è ri
tenuto , dal qual t i f i l a nofira d c m e n tia l*
può liberare. & in nero anicinandofi uofir#
Maefià conia am pifi(m a g ra n d effifa fina a O ri
per le infinite altre fue v ir tù ; fisiche ritenga
t i m ifiricordi* » che non t i Morrebbe. ufiire dà
f in o i neffuno grado le mancherà per aggiungere a quella divina parte , attaquale f il o a n ta n ?
. t o R e , che t il prinio del mopdo
glorio f a
mente pervenire. Ne.dimando, q u e f ta f a f y icordia Sire.* che d a d a g iu fiitia d t'v o firtg iu d i»
. ci potrebbe ancorafinalmente, ven irti m a quella
fo la ,c h e nel clementifiimo petto dell'alteZjta
nofira vorrei deflare, dellaquale per neffun mo
. do ifv o i giudici fuffero partecipi , ella dee certo
efiere talmente d i uofir a M aefia., che altra por
fona non ne fia per hauer parte alcuna , ,.Nom
voglia Sire il fap tenti fiim o giudicio no (h o ri*
conofcer la divina v irtù della m ifericordia.d a l
Configlio d e fu cK g iu d ieij p erch en ei nero ella
non fa r ebbe m ifiric o rd ia .,m a p iu to fio d e b k a
ragione j
la rtconofi* f i l o d a l t i f i a i n f i f a
. - i i t ' ‘O l i i ' T i I r A i RE
H a clem en tia. & / e p l t r vuole degna? d i r ito ' n o fc e ttid a perfetta ; quella la dee certo ricottoosoere d a l fia t el mio ( l i q u i d i , fehon fuffe S la to
de cuf a t o , fenofffhjjè S ta to imprigionato , sa
l'aio» fu ffifla to lungamente Hejla prigione a f
flitto ; uoflra MaeftànòH havrebbe cagione al
pre fente d i ufare t i più eccellente v ir tù d i tu tti
fé a lt r e R i t b r d i f t uoftra Metesed, che il pecca
l o del primo huomo, fu cagione d i miiouer la
<!tntfertcordta d t Dio , che altrim enti non ia b a
e re b b e fa tta conofeere y oso d i m andar il j ù o f i y jiu o tii n te rta a'prender* t i humana carnè :
^deUa q kalm iferiòordiaùfata cofi, come hauef*fe obligatione al peccato hum ano, non fo ld fm en teeo l frrttìofo fangue del figliuolo la t i f o
'* t/ 4
nnutfò iìttaU peccatorefece compagno dei
s ta c e l e f le h é e d k ^ N ìtn è Sire s ì d te r à fr itiìi* f e , sì Sbranò; ìfto r itM z la quefio H enrìftèr
^riari cb eyo u fa ffid -fite^ fu n ife f dtco m orifs
*im ritifero ,u n peccatore r vfd tiritiferico rd h i,
"per effer v irtù troppo eccellente j troppo d tu iA na y ft trova iti pochi. V arrà adunque uofita
* M a e s t a a ’mondo un te a , e n t n t r e nel numero de*
^trt&tii > o de* pochi f Vorrà ella p iu to jìo affo'm igliorfi all'hudnto y e /;e è imperfetto ; onerer à
'D io fcbe'c joprn tu tte te perfettroni p erfettifiiKmo ? 'V a tr k p iu toflo uoftra M aeft^éfèqtrit f i Kcondo ilie jììm o n io tt un mortale ; che non può
*feufittft di non effete peccatore, oso petauentura calunniatore, o per malvagia n a tu ra , o per
^errore , ouero per m ettere in efecutione il cìtnftg lio d i Qiefie Chrijìo nero D ìo , oso Intorno, tilt-
p
/
D I
F R A » G t ‘A .
ta n o d a ogni macchia , d a ogni livore ? Noto
tà ella, che dimandato da Pietro,, f i f i t te uoltf
haueffe a perdonare a l peccatore , g li rijfofekNon t i t i dico fepties), fid 'fip tu a g ie s f ip ii es :
lafciando fcritto in altro loco : N o ti m ortem
peccatoris , fe d ut convertatur esse uinat ? Pojm amo adunque : che il f i atei mio habbia pec
cato , che ( certo io non lo ho m aiconofciutoper
ta le , quale g li aecufittori lo dannano} nonni*
g o , che io non [h abbia conofiu to , per huomo?
che jfe fje fiate per cagione d i r ifiu ta r e ha prò?
poflo delti cofe >tiqu ali e(fo ueramente non pie*
ne ancor che fujjèrà Siate altrim enti 'interpre
tate . Foniamo dico ciò da una p a rte , esse lae
feuera giuflitia d a ll'a ltra , e la mifericordia : a
qual fi dee il clementifiimo mjó R / ap p o g g ia rp
f a t t o alla parte più Jicura d i p a c e te a V io : esse
f e ben la fa s ta feritturafajfpeJJ'o m & tfone delia
g iu flitia ; ella non * però interpretata d a fq p im
Ji.per quellafeuera g iu flitia # laq u a leA elflp m
i Principi u farecontrogli ofim ati delinquent*#
in manifefiifiim i errori, esse non in quelli , che
fono poJU in dubbiofe p arole, interpretate d à
accufator ignorante , & da chi non intende la
lingua Italiana,nella quale filo può hauer parla
to tlfia te l mio , perche t i g iu flitia il più delle
uolte è prefa da prudenti per t i b o n tà , come f a
chi meglio intende t i ferittu ra d i m e . P otrà
dir V . M aeflà di non poter mancare della pa
rola fu a * Certo ,C h rifiia n ifi.R e, quando an
che t i Maejlà uofira mancajfe della m in a ccia
uoi parola fu a 3ancor p iù J ì afim nfoiarebbeyt,
L
titj
si*
. -.. ..se
■ •
-
»4*
’
d G jM lffl
* :B $ > h d r i m
'^ V
- 's e
AjI.- R.Jt r
r i
tW iW é te x *
*£pfri>f» 4jr:£tH.C0J‘*} ai? Iddi», tndnao lana
’t t o f t i a ì
Aeflra im a : cip g tu n fea p iu t}im a ta la ,p o te n i t a m i0 1( f y m i w m e n o fiorflQfit id d io t a l *nenie H/aerusafeiw* c b tM V o è tb b o ttH ta , s a
f i popolo f i o l i e v / i i f i e r f i ^ J A a c f tm m dir,e,
th è ancor f effiif SJjr, nffrfenqn p ^ ù f i a f i c ^
fio legninocele f i t t e , s a non fe c cia i l bene f i se
còitdo Jepromeffè; egli nondimeno èfem pre fere
fià , s a immutabile : s a tu tta la m utabilità,
procede fi# m ortali y i quali m u ta n d a fid i m al
v a g i f i b u o n i, ifo$feeLlono p fie jjc r e p un iti :
C p d b fó ó fe 'fifi$nd<fi. in m a lv a g i, non m e rise
cheti fa fafjnfa Ihtébio
.f f ic a to j f y f h e j à V. Maejlà h a ifia g iu r a s se
non è te minacciato d i fa rlo pittu re. J-eco tl po
ìe ro fitti e h n io , che per la. noce rtiia chiede f i
io /h a M tJericordia.
L **' *
.1
i
jtic Ì n )ìÈ iw jfe iiimuacciurliruina,
■ ffr fifr i' (& ,n ? M n e n o .
p tc v v o r i,
m M tcóffiperitjat dar fo rò ,ilp rp m jfo flà g e lfri? M a g g io r^ o fi^ fo Si re * fe m ie lecito Atre;
lche il Signop nofiro nonJta ojfirtiataJa promcfi^
y it f a tt a con giuram ento al f i o caro popolo di'
j j r a e l , mentre che era in Ciitttutta : io non d i' co in cofi appartenenti a minaccio , m a a lene»
f i f a iq m v f o d ijf e prejfi D avid Trofica , Si
òblfivs fie r o fu i llferu filem ,, ohlitticmi, detur
ji^ t^ A m e a ù & c f o a l *ÌM fcm £iito.Juettejjèt
efiq fifer di quefiò , f i to m i feordero d i te g ià *
f i p f p . iqrufA cin, f ia mondata in oblivione la
»
;
, 1
i
V or/A d d /tfijilt ilnserA
’
MaefiàI
!
!
,
ni
fra *r;,t-u .
Maefik fa r punire un g e n tilh u o m o -ftfiiw trfy
Ithcui ragioni nonfono flnse
. de da uofira Maefià quella mifericorfiia, oso
quale egli finalmente cotifetuir a f o v e to * esse
fe noi crediam o, che'per g r /tp e c c à to r e , rfy*
egli T h ttofn ffe, Aie hauendo' aim a fo a to p e radono a Dio , g i f f i a d d l t fuad^iferie ofoia a fo
braceiato; chièdendo
ypJìra Ma e ftà , «orsa ella loirtrtiarftfoa quelle#
che fatto ha tifo ? Deh mffericordiofo Re ,
Deh Clementifiimo Monarca d à Qhriflìani re
gn i , non voglia il perfettifiimo giudicio ftpfita
fare ad altrui. queUoin terra , che per f e n f o
vorrebbe in cielo. Ma fia lecito d ir e , che dopo
i molti acquijlati trionfi, dopo le molte hono
rate Corone, dopo che la tefia d i uofira M àefia batterà tocco i l Cielo , esse li piedi tpèr fitto
[altro H e mi/fe r io: mentre la de(Irafuagover
nerà l'O rien te, esse la fm ifira reggerà [O c c i
dente: mentre la fchicna fv a fifo p p o g g ie ra r e d
mente n ett Aquilone 3esse che la faccia J ù a p la therà lo Aufiro : Dopo dico un lungo rivolgi
m ento de fe c o li, quando ejfa mede/ima fi fa r à
fa tta defiderofa > per fu e rc h ia vecchiezza d i
dèporte tl corporeo v e lo , esse d i falire in cielo ,
cerco ancor che la maggior parte d t uofira Mae
f i a farà tu tta p e rfe tti f ii m a , tu tta purifiim a ,
tu tta divina ; puro ut è una certa parte x la q u /t
le non per fu o difetto , ma per effer compagna]'
della carne > porterà nella /ita feu<fiit\qu 4lcl&
nuvole to y qualche turbido diito n fo che.
'
.mando io a V à k a e f ià , f e .q u e l t i J u j t y a r i e j ^
' r . . ; > s ,* - •r
•
;
k i t «t:
‘ \>
w défìèetfira pruioftffiffjbr rasseritia tk fik l Soft d aliam fe r i cÓr'diJtdi i ) i o , o da quella detta
fu a fe n tr a giu flttta . e fe quefio defidererk per
tit(p e r c h e uu olfili ad a ltr u i, quello che per f i
f i effa non f i eleggerebbe ? Ma V me m ifero, a
Tne infelice, dotte ferfratello, </«al dura p ig io
n e m i tie n e , p e re ti non riti puoi tu al pref e r titi
aiutare ? T uf i a t etto hai potuto molte fia te con
le tue predicai ioni intenerire uerfo Dio la du
r e z z a d i m o i t i . oso lo con la tua <lunse mede fim a uoce , non pofjò muouere a pietà il più pietosa Re del mondo ? T u f i a t etto con le tu e c ra ti m i hai ffeffe fia te p re g a tò D io a d a r perdono
A (peccatori t oso io non pofjò piegare quefio
gran d i fiim o R e , che tanto fe g li affò m ig lia , a
riten erti nella miferie ordia f u a ? Ecco fi-ateii o , ùedi , / e ueder puoi da me lontano incarce
rato , et»ufo in tiifte tenebre -, pofio in tanto pe
vicolo ; u e d ìd ic o , f i puri [ l o ultimo ' ufficio,
che uerfo dt te pud fd re lo unico fratello tuo :
uient m quefio ultimo punto almen conio f i tri
to tuo , ilqu alefu fem pre meco congiunto , uiew i, oso a piedt dello a lti f im o Re Francesco in
quefia tua ultim ahora abbracciam i, Stringi
m i , d i te r iem p im i, m a primieramente f a r t uerentiA A piedi f u r i , oso con loro lam entati .
A rdtfci fratello d i aprii* quelle tue fuppltcbevo
lt braccia a q u e f it tiv i gru p ie d i, p e r i a u ta tu a ,
per r honor mio , sanse per quello di tu tta t i fa *m iglia no fira , quelle Sue /braccia dico ardtfci
fupphcbeuolmente a p r ire , ti quali tu tante uolsteh aijterjò id d io ^ p e r la J a lu te d e lR e C h r i-
;
i
{
(
,
D I
F R A N C I ^
*yt
fiu m i f im o ap erte. Lafjofi tuffo rt# , p e r f a ,
per tanti tuoi offtctj uerfodi m ef'O tello. n o li,
puffi ren derti, fin o n lagrime ? L a f f me , c h e .
in luogo d d tuo tanto minacciato corpo, ho»)
posse d a r ti, fe»on quefio corpo '. Q uefiq corpo *
f ateli*.) quefio f ip e r d e r a i, li tuo bafierà per
opibtdui x quefia lingua fpotrai anporp ufare ^
quante (i piacerà J n r g li eterni ì)onori del R e
Francef i o , esselrfa ra i conofiere,thè ancor dopo
la crudel morte che ti e procacciata,nejfuno fé ;
potrà leuare lo f i ir ito ,)tefJùnoti potrà le v a r e ..
quefia lingua nejfuno quefia uoce, laquale /...
a te esse a me commune;et dedicata alle im m orta .
li lode del Qbrifiiarufiirno Re Vrancefio : uieni*
f a te llo , uteni j piangiamo, in fa m e, /tieni co/t ...
lof iir ito tu o , c/;e io lo raccoglieròy 0 f a r a im e,[
co.una tfiejjà cofa, in un medefimo c o r oso
p ò , a perpetuo J eru ttio deljnoJlr%\ o s o .
Re ; p o i, che i malig n ii 0 ^?. sioso :
d e li, g li f ii e ta ti auer vv oso . oso f
fa rtjn o n pojfa,.... .. ..
iw p a tir ,
. ..
ette
xorpi. M a, rim e, che qui
màco da fonereine
lagrime, esse
dolo
ne impedito*
■
''V'osooso..oso;
E
's i
sa)--n
■v.
»
„ tV
d a
D i ~ M . C I V l i o *•"••• *
•*•»...
) *... •
i
ri : sj Ei-- -
,
C A M I
O.
: i,*i ,,
É
l.t
..1fVv.:
« a e I s J lE
.A* v ^ jfiM :V 1
•• v'
* ' ' '• l >
A C H S s k Iddio clementifll
y f a q u e l notabile-defiderió i f a pcbbegia Socrat e, ha
ueffe hor effetto ìtf me per un
pgco : itnperóclieriè ttffarei coj h etto d t trovare parole in quefio mio debito
ringrattam ento d'intorno al mifericordiofo oso
im m ortale beneficio, che V . Maestà benigna
m ente ha d ig ita to fa rm i f ne F alteZza itof r a al
prefinte uerfo una coiai fua marauigltofit hu«v a n ita , chinata prenderebbe fa tica dt afcoltare cofe* lequ ali dtg iu g n erea tanto rfceuuto be
ne baftanti eflere no# potranno. f o r ia te /d tf i
fim o R e , tì cui petto f u chiam ato^èm piÒ di Sa*
:
.
1 • • . * •i r t
'
t
1 l
'
pien ti a , haueua grande d eliderlo , che le hu mane m enti fujjera JenéJtrate talmente , che
per loro , come per fenejlra tutto Fattimo del-
ér
D I F R A N C I A. t s i
Tbimn.o potejjc effer, uedutfa Q fe qunseo fu/sa
liberalis fono
trebbono al pre/ente u ed éreìa d iu rim iptdgine.
d i fe m edijtm a federgtel pfo.alto luogo d e fla trima m ia , in quella Maefta & rii quel pie tofo
atto n u i quale d m a g g ip r m fa b ìfig m la b a v e
^ duta , f m \4hauerfeneg muovere m jirjgìam aj,<
' s a li m ede/imi sechi suo; ft- potrebbono vedere,
davanti la fe d e li mia cofianz#. trasformata in
un facro altare ,, fopra ilquale ancor d o p p ila
morte m ia collpctóeflat& i{donofattom i, lega-,
to fo rte nel me%$ fa n u n ^ f o d i una indifj'olubile catena di obligatione, tdqual con l*altro ca
po tie n e , r y terrà m perpetuo circondato il
collo de fl!marno mio intcriore. Potrebbono a n m g li TJtefii .occhi veder d'ottanti alla detta,
im agine tu tti i miei arden ti fin ffi'jffltffg ifin d é fg a t sa* alla m i f i r i c o r d i a i m ^ f ^ ^ in
perpetuo dedicati lucer, come faefiftnfidffiqua
/ae.
r
f
,
che ftono J p w ti dalla in feìJ à éik tm ffd d riZ a
delle lagrime m ie . che p iù d irò ^ 'rMóJhimi la
v ia dej ringratfere. ta ìflefft g r a n d é z ià d d he& ficìo , & .m # lfln io ftri Tfinórédri qrrel beni
g n o R e , (he il ben f i ciò-hafatioV O A r s o te
le j o di a lti fiim o ingegnò philofopho, o unico
trovatore d e g li fecret» di n a tu ra, come véra la
feiafit f r i t t a quella fin ie n tia , nella qvtil tu
tieni (o liti, che ha f it to )l beueppò f/tm a r m ag
g ì ormente il beneficiato 'di Q uel* che-il benefi
ciato am arefiùpU f erfiùfil è ie fa tto Jmbbia il
Osi; A T *4 L A l R £ T
^
f a f ì f a l'alt u f im o R c J ìM fa m ofiratom agg io r amore uerfo d i m e à d jq u p f cheta poterà,
volendo efftre gra to 4 fu » Maiefià * portare ?
certo pfcrrfoo/à difa^ratitffm o^ puro è natu ra
t i ? Imperochè xfe eeafim afte/ìce am a Iope•tafaafificpriiefa H padr{ff a teneramente am a
tl fig liu o lo , c/ie *fu # fa ttu r a , effóndati henefi- h
cip opera , essefa ttu r a , non di colui ,, chela ri
c en e, ma di colui, che t i f a ; seg u e , che la reai
m i feri cordia battendo a me fa tto , nella refiituctone del fra te i mio $ un tanto beneficio ; effa
ancora.ami il detto beneficio, come opera /ita, ■
m p effóndo U benefichi collocato in m ecch e roso
tetfu tofiho. f e g c f a ancor a m i enfi#'tp m .fi
luogp jd o u e h a pesco il beneficio , che e la ditti*
fa .ip p o tr e t fua f a ^ f o f a n a r e , H o n e ificn io ,,
di
am?re# ma fe ben U uolapta.vufifo* fan atur#, non p u tte # perche [o p e r a iw n fm fa, Adunfoe,,:
f e L'aywre è dalla parte d i uofira M qefin m ago,
j u j r e > effondo l'opera fitta , come potrò t o , non
potendo bavere egual e jfe ttn m e , hauer parole,
f a À ricevuto beneficio poffono effer? e g u a k ì .
ì l per f a prego esse riprego ,an fa fu p p lico , fo fa k
non poffò ne potrò tro va r p a ra te , lequafta: pie
no render t i d e b ito grapte * f a rm tforicarfafo
uofira M p fiq u a g U a w hf a n p n m g h a f u t fo
s c o dar la M o t t e f a f a a m à , esse d buon defidertom ioiMf a a fa g r f a l e n a del. beneficio esse
del m ofbrato.am ortfuo. llu ofiroben efictpfli*
esse ttù sforzo f a p w e n tr f ^ 'C a n f a
:*t#M ttfftiarniforiiffttfa >fa
itnwgeHf-
H T
6 l " F R ’A ' N C l X
fa
Tt
tiX £ * fono td tt y che tu tti coloro, c h in é rie*• \
nono, non altrim enti rim origano to n jù fi, che
quelli, iquali dopo lù iig ti tenebre diueuì/Jero
jm p o fe n tid ific e u & ti abotidanlìfiiMà liète d e l '
Sole, che loro foprauènijj'e . E nel iu e rò ,fe q u e
(li fufjero tanto dddU deltaÙ fjla, che no# potefi
fero netta lucè a ffìfirfi y ifome' potrèbbono dcUa '
11
^
[
1
I
j
■
ssetd luminof a v irtù tener ragionamento ? * H o f
rae chiamo in teftimonio uoieccelfo, uoi a lti f i l
mo R e , per la *v ir tù del quale il nomelòranceferia tante uolte pojjèHuto vittoria Cori laude ,
'oso non con fra k d e; per il cui'glorio fo ualore
spesse uolte, la nobilita Frane efe ha portato' té
palm e, oso leg h ivi and e d i lauro : p e rla q u a le
hanno gem uto g li inimici , ne ui ha m ai hauu
to luògo la fortuna-, fenon quando per fa lfi m o- *
d i copèrtamente fe rie è u e m ta a m etter còntré
le uofbre lodi il fuo velen o . Chiamo dieduoftra
Maeftk in te (lim onio, fe quelle poche d i g r o t i t i ■
cheto render t i pofjò ; potranno effeò jM uififififi
nitla, ae/ld incompie nfibilefùd coffefìà córrijpbu
denti : & fe inferiori fermino , te r tarane ór 1
nelle parole [che t i cofa ràppr efin ta r debbono, •
mancheranno ; Ma qual pronteZ fa d'ingegno,
quàl fiunte d i eloquenti*, qual la tita , qual dii- '
rea maniera di dire , potrebbe chiuder in f e la
buona m ifm co n li.i ufeita dal uirtuofifiimo p e tto d ì Ubfira Mac fin , oso non più tofio effer chiù- fa da lei ? Spande Stire, fp a n d e U jpàciofi oso sa.
smniettfo lago d elti d im e n ila uójlra ità lm e m /"
fopra leriu e fu e ; che tu ttede risco p erte, oso af
fo *
fi
e/stf
;
R Bs
:Jjfkwìi
•• M* j t o ®
/N ^ l
.y-^vr,-J-TT,-/'(TV-, dV
ytfajkltercà artfilm in e dì
'óheffjtéfiffih'à tirfatargiàwf&jtfrffittalingua /Starni-
virtù ad
.■ ?
M"yHmjira uirrn
wt
é rite v k fb f i fè flitw tó
d esee^ rt^ i^ ij
fornello > ,& meJdfoàtellò f tf ià e r à tf im ó ì a c f
i éh ó U v ita ., ~ad a m bitivi ? f r ia r e e
tu tta
la fatrH gliltuoJtr<t còHfacqua d d td g ò 'f io ha
U v a ta q u f i U ì i f f i c f i i à ^
fa J é h b ttfii nome ntfirò rtm afa . E nel vero f e
X
'
■v.
oso •
'ManseiV
o /^ ^ a ij^ u n s e p n 'd ^ l^
u n u m p ò d a ìk
dtrtefèfontà dettafttzX a Vhffràl Starnò kdurijf r ttìif ip e r t o c } / # l
Jdlfatnffertcordia u a fijfifa rià é d È ìpfetfìféLfiri
dem ènte d i m e : de uè fq ró fd h d a ìò i f feria »
'fiàvefii potuta ottener i l / a tetto? in Italia ? tra
.m iti? ogni atira cofa haurei fa tto S ir e , quairinquetfm lontana regione, qualunque più d i
f e tta la u rei habitato que fio a u a ri\o d t uita , f e
n iu efh a u efii potuto f e i/f d la vita,m ia , cioè
f i n \ a i l foauisfiipdfoytiéliti sper?>inselMuerfe m pre davanti a g l i etichi è ri Jefilfte IjàtfaebÙé te
nuto bagnate le m ìe la g fim t ccndefue.. Q u a »
d o adunque verrà quel tem p o , che lo im m orta
le beneficio d i uojìra Mdesia habbia ne g li a n ithi nof r i a m a rn e ? Q uando potrà m ai cadere
tanta
D- t a l l u . & £ . / , A !' i ; r ';
(# ria in gratitu d in e# fa g e n ty j? a }titr ifa a y c l^
U u f f ra liberalitàf f
Jìrj cuori ? . A lb o re s jre
>fi* .
poi la memori# m quefio mondo dita n to b en e f i cio » f a h n f f r a f a m g ljf tf tto m
disfi in queflo m<mdo i p c r f a n e lF f a o infiem /
con le anime noftre porterem o/colpito (gfitoqu#
o fa tto » n el/n o d o , c h f a A if f td i f o p r a ^ f a
i i# quefio- m ondi n o n /n a n fa r ^ /f in o n c o ff
M
il w f a p
fy a ic m 'd tf a & g M ii & M % h
fi.fadi& iicfto fe c fip ^ a g li o p e c c lfifii.q u ^ n # ^
« V
Feffetto della u f # a ..m ffen cordia , esse durerà
lungaptenle . D epfiercke M » fo n io p e m f f b e f f
< x jw a m o k > fa
f a m i fa filo
m o r i/a Sin ? • ;
terra d im # b t* ty k \
^ u o ld iu m p fife fa
tatedfacjcàfi(ff f a q f a i
u o ifiiripiffm p Re sa /uogR, d*infense m e rita te
fem pre ifo fa s fin ffo fa r ijii q u if io r i ? che tu tta
di cogliono le d o tto (N in fe netta fo m m ità del
Varnafo. O P d ia d e fittiti sfima D ea empif r e
go Fintelletto m io , y fallo capace tanto fie li/
altre infinite uirtu dsque/lo R e , q u a n to e jà tt#
d elti fifq m ife ric o rd ri^ acciof a io p o ffq con
Faiuto tuo honorage/ncpfq con quelle lo f i l l i
I L A l U ff
'feeft atem i i uofiri calam ibagnati ne dottis funi
'èmjnoftrt, che temprare [o tite nelle acque C af h ilte , quando le uoftre fatiche g li afciugano.
O fottedttm aefirs d i Corrieri diffionete hcmai
per le p afte i più uelvcA, i p m correnti ca va lli,
khe p o te te , apparecchiatemi non follm en te ap
preffo alh pungentufim i fpvoni cocenti fla g e lli,
perche più toflo il corf i fortificano m a jhrocur*oso *
u jfe p o s fib ile t i d i aggiungere a ciaf(uno esse pium e esse a liprefh sfim e, acciò non folamente
corra > m a noli uerfo I ta lia , & per tu tta quoti
Sfaolando con la tromba de la uoce m ia d in o ti
g in tie le m e n tisfim a , la C lm fiiam sfim a, t i d i
u tia mifericord/a del cl m e n tis fimo , d d c b r i *
fiù m h p m o esse dittino R eFtancefca /u te n d i,
a tte n d i ; f a t i vango bora , bora [fo n buona
U c in ttid tlrm fo /m tm o R e monterò , b o ra , bo
ti# partirò * .tijfa r ifp r im a d ite ancora alcune
paròle) poiché torneggio itim io humanis fimo
R e cotrtanta hu m ari t i rtfcohanri», Che*don**
titio * che p r e fitte fiirò io aytefiraM rttftàSirc,
p e rta n to beneficioi prim a +(he d i qui m i Iteti*?
n o» le diffii a ccia; prego , che to ridoni a uofira
pòrtef i a t i donato mio f ia t elio * N on puffo Sire,
lafaare m aggior pegno appreffo.uofira Maffla,
nel p a rtir m io s che il. proprio fierielio.ùi M a ,
perche p a r ta forfè# th è ridonando io t i ifleffo
ricevuto dotto i .fia ptrHimoflrare f ohe quello ,
f a t u i « carisfimo , m i fu tin poca S tim a ,d ico
per le?ofe an date a v a n ti, quefio penfteronon
poter? cadere in uofira Maefia : esseittico d ido,
tin ch e fi dona m A c m m o d o tfia i t medefimo*#
b * • T R ‘a
C I A. o
"non d p ir ò conlem cde/lm ecanditionitr alm pto
rocf)e U clementia u o jlra rn i ' donò >un f i’Otel
' m io s a io doIto,un fuo fó r w to re lia c i emen
tia uojìra m i donburtfratei m U tutto afflitto?,
s a io I / dono u n fuo f è m to r e , là fu a mercé
tu tto beto ; Inclem entia uojìra- m i dono ri»
fratei mio itt carcere, s a io le dopo un*feruùor
osoWse per la mfierieordÌA di quella in lib e r ta .. la
clementia uofiram idoriò w tfra te l m io ginduogo tetiebrofa, & i o le dottò unferuitcnjuv, per.
la pietà d i qu itU In chiariiftm alucese La cte*
m enti# uojìra mirlorio tlfi-a telm io inunlU o^
g o , che hauendvùnome M erci} chiamava tac$
2
tornente quella m e r ìè ;c h è m ifu dottata : s a i #
le dono un fu o feruitóte tn luogo, dou è la C hriShanifiitàa Reina v M u e fio m rifim ^dtuim fi±
g liu o ti, s a figliuole g douèjbrfoJanti Frincipf,
ta n ti Signori ;4
umridiqttéfioJLegno, dove fonh
ta n te Ittufrisfim èM adam pornam ento d i que*
fio Jecolo ; iquali t u t U foriofe dell sfimi alberghi
d i M ercè. A pcite& frU e& tkfim a R ein a , apri
*e aprite dwinisfimiàfigtiUoli y sa flg /tu o /e d i
quefio graridisfimo R e ,■ A prite a p n te lUnJhififim i frtn eipii aprite ancora Uoifinalmente chià
risfim e Madame i thefion della tioflra mercè ;
s a meco infiem e, perche i ofido non ardifio g ià
m a i, che troppo g ra n cofa ho ottenuto , meco
infieme pregate la reai b o n tà , che rueua U no~
no dono , s a orni della prim iera g ra tia colui,
che ha confcruato: cofi 3a lti f i me Re uojìra Ma i
f i a ,a me ancor maggiormente adorna il.fino bé
uefiàoypercheaggwngendowfiailacQnfem& ifa
,
k
. . . O Ks A T.y I li AL* RE
ttd?
*to t ancora I ornamento #ejfo d iu errà rn h o mag
\ g m t s Cofi renderà le fo r z e del mio rin g ra ta
mento motto m in ori, z:£equak*perche conofco
.d e b ili, non m i fa rfo to lto faltnen fo e fio , che
{quante uolte vedrò con g li occhi del torpo”, o
f a ll a mónte il /ra tei & fa : quante m ite vedrò t i
■aita fu a a me conferuata > esse.lae mia a lu i, lesquali cofe certo perpetuamente v e d r ò , toni*
.volte uedrò lo i u m o r tale esse di uni bene
fìc io d i Hojh# Maefia ... Laqual
- . . * piaccia A Signor Qio difejr*
x. :
• ososi*
-
[fa ^ u n ^ m è ù te fo m .
f>* x x . . .
,ù 4t t y { u L ' ìr
■-
U
.o s o ^ ,
rososi-.',
- >n .
I
_
p a t t i dettafua iiu im fa & . ^ _ si
■, v. i . s i s i
• « s i-
•
m io m b id m fia te tfim
--
v si.
, s is ir v /"
•« si
,
vi , li-. GXZ
•■ t!G« «v\ » .
; 2 , « <s i V •••' s i5<
*
• V-si'- “ •V- ’■
*t-v. -vi «
-<'v
•; . .*• •
■ ' s i v s i s i ■ ■''/•'
V- •
M v" . \
- >yytH .v .
W * ■>vsi. ;
a
s;t. s ••' :^ •A -‘Hit-si ,
-VjV {>'; ■
•
usisi-rii-- si.
Visisi- •' s i- s is i
-
sin -
•• ••'. . •>:
•
i V si
>*
R
I ;M '- B I X
* •
, ,
;
i> r ò n
I
'i ■"
: C ^ M i L L Q u ,;sa'
A f o s c a notte g ià
con ta li t e ff
V a e r e abbracciaua, c't
triio’partire amaro :
.Q fa n d & d e htrnìa L
-•*»*$> * A ilu ifo chfafa
I file u & v a itic i tu tte Ifftc l
accef a a ^
l ì ‘*
P area iiceffc loro^ ò lu cia p p refè'Q \ s v-.v-V^!
Imparate arder dctfplendtm pi# tarò: ;>
Che i D ei la terrà d'altro lume ornaro i i l
Menare la m ia beltà qua g iù d tfc e fa *
P 01 volta a me con folgori cocenti , .
A
SenZjt tem prar de la lor g r à n v irtu te
i
Con lagrime pietofa pur un poco 5
. I : si"
V attene > disse, in pa:e ; oso mille ardenti. T
Fiamme mi mando a l cor ; mille f e t t a t ,k
I>t»qi^ansesassep4;^<osrsa^ueosojfo^^ y‘
-
oso!*
.E lf i
^
t^ em ertjf^ »«ra^
herb&fyifti t
F regar carifoddgop(yt# 0lgktffererio i ' £
ili/ /a rugiada pàra d tflb o tto r ìo f lr i. M i
& bella d e l i b t l k ì é u r g h t ^ e i - j à r - y <
^
fi
"*v-
H
Ih?- «ceda perì
jDnwfioso
li
V W /w r g a a m k l
tìMtet* f r é é tp if o ilta
b ^ e n tr e tl eelefiehétm orì^acquà foat<t ?>v. tf
à tftm * r a c c e g li^ ^ fe x
k i&jf
*
nÉTle * —t«1* rf.ifn enaii er ' *i T
...
W Pideat*
É ^ 4& & n É * & ' A
V a lm b fà tò
; V itd n fa ie & ik e è & fir it^
&
e è f a
d
A
à
#
i ;f
V etchfabrtèritìtl p t f v r i m t u pivg rtiV * $
Hri* 5
' m. g ì y
c
;
A
N * maiugcì fkJolce
>
m i l i o.
^
u&
':3*rQ
sa-
•IT**.* -
S’nsei d4«jdsaa<f^?uroso W g f a - if a Ì ± j. ‘ * ' ' -V
vMenlre4ue’ faì^tpìmoli
.Salutano dfiofa y /eerdeXpr/sei
N e fi saduesaouoiuscsseDle>. .v,*
fq e
p?i nse. Ds[ / V^A
Q u d ls a r A ^
4 Bagnando m r h à f a w t t
w
rgi ■:
€ ome quetye
Q H fn d o fa fa
Che cìjargano attorfo rfè w m rfa a fa i h
N e posse f a f t 'd l p w d f r w w i t f a
C j^ ljfapfa# 4 >^ M 0 ia ardirsorregge i
*
*
*►"••
.
•
O reaenosran p # lr e d c k f f f e ;^ ^
JRrgnonM ggiorfaèfi 0 fam 0 ^
a,eda
'mm/mf0àri[m
c ’ o«ae«
Crejcer
T^ftgiaii CQìifrdle Jpotidf/iltt
'P
#%. A*
M rT fflJ w w g M f& ik jv fa - :
a i is
v>
' j
À gf*.
« v * m jc, -« -r '»
•
T adrfr, phe turbi U d e h ^ f s ^ / f a * !
/
C orriate piace \ t l torbido f w V m à f h ir e
Sparger /o p ra i r e a tù attitfctiiofiri, ■ ■*
Sgombri quella p ie tà , chàtécotien i v
I p a n f l a t q del ciel del tuffo p ie tii^
y"
S o n d i p fo d in en cto }tìù À < d fa tim firi ; A
E t [À q u ile boti tempriti o r d u k r à fir i > ’
■ V er tingerli n e[ cor de nofiri fieni.
C ru d ei, ra p a ci, 0 affam at( augelli
**
L ungi Sta dal bel Rrgno tl kofiro nolo %
E in A fic a deferta iu é firih o n o ti. \ ' '
A n g elifo rtitn b en fo riu tih o fieU fi
' *">
^ È f ù f 0 fàncta gua rd a te ikfittolo 9
a fiutilo ,
p a M tA o ittr ig U M e ti si
*
-
fsiosoososiososi
R
ugìadoftlokS^À kÙ élntv'A • o <*
C elefiiliu m ò r >
p o ti* canne da not tante ptègiótc f
[
*ÉÀùoi doni de [a lp i alti esse d iv in i ; r
JfL^ br tr a g lio fcu rt e i lucidi c6 n fin f ‘ ’
p e la n otte esse del di (cosa jbaeièe)’ / k
o s o f n d u e la b é a d o k jf iim tr f f é e f
;
^ ^ Ù fiÙ fo fffa fu o firi d b e rjfltife W m im .
.
’*
'
«tèsaIfotèctd ' m i t f i ^ ^ i ^ ^ d r d o r i
' * T r a jf e /ltiià bene i esse f& esset dolce uano ?
J l fo g n ò irtiv; Ì Ù iu a L y coso e n A , il fogno
N enfino* p iù dolci 1
0 p a tio f ie r r o r fifo
X if ty f if a f a f o 'l u e r f i r U d ^ i M ^
r $ i f '/*•
'
M. G T V L I O C A M I L L O .
t* s
R Cile g li a ltri Jiiperbi altero augello,
\ E t tu nuntio del giorno ; poi che'l cielo
Levato u b a d a g lio c b i tlfofco velo ;
Che tanto piacque a l ferpe empio et rubello:
T emprate i duri ro jln ; s a quefio s a quello '
Q uafifiagofo folgorante telo ,
Spinto da un puro s a honorato Z e lo ,
G li franga ild o ìfo fuo fijuamefo s a fretto
C hor me i par riu ed tr nel lito MeroV ibrar la lingua s a arrotare i d en ti ;
Per darci d'ogni error debite /a lm e .
S i uedrem poi Tlatue d'argento, s a d'oro •
D rizza rv i a l'aura; s a con lev g ia d n accenti
Cantar le g io n e altiere , m u n te , s a alrnc ♦
0 fifa d i m araw glie s a d'honor piene g oso-Che f i jle n e fie g ià carne & figura
P e l m aggior cauallier ; che mai natura
E e centra Spagna s a l1[Africane arene ;
A nxt d g r a n d ì de t^ p rem i , sa de le p ettt
V fcite ignude de la tom ba o/cura ;
Sol per opporui a quelle di mifrura ;
»■
Che;1/ piu nobile Jjùrto in uita tie n e .
1 / gran R e 3
che'l Erane efi o almo paefre » *
Regge benigno ; e 7 nome da lui prende ,
D a l fommo è par a uoi fino a le piante *
M a yfe'lualor ,fie l'animo corte fe
i
D t duo Principi in u itti ancor contende;
Men è fiorofia il buon Sir uojlro ctA nglate #
M
il*
R I M E D I
F
/unirne ardenti dt D ia , Angeli f a n t i ,
Che la g u a rd ia di Francia in fo r te battete;
E t con g li a la ti jfo r ti uniti fe te ,
C h 'aigra» R e portan la corona auanti ;
G . t i m i filili ttojlri aiuti ta n ti
H a n lefo la f i t t i l e , s a ampia rete:
O nde prefa al trionfo homai tra ia te
L a Fortuna d i CARLO, e i/u o ig ra n va n ti.
N ùnica d i u ir tv cieca sfacciata.
Q u a n ti languon per. t e , q u a n tifin m orti,
Q u a n te im pudiche, e » dolorofi lu tti *
T e Dea diremo a C A R L O m aritata
Cagion d i tante in g iu rie , s a ta n ti to rti :
. L e g rid o » dietro g li elementi tu tti*
O ech i, chefulm inate fiamme s a f r a l i ,
Ho r che uolete più dal petto mio ?
Mofir e l mio cor , s a unsero il mto de/io ,
4
2
agion deluofiro b e n , & d e i miei m idi *
G ia feorgo in uoi con l'a v o te f o , s a Vali
E t con l'ardente fa ce il picciol Dio ;
Et par che m i minacci flato rio :
M a prima (oim e) non ui mofir afte ta li.
Z t fen o n che Cangelicheparole
Prometton pace a chi l'afiolta s a ode ,
M i .rimarrei d'entrar in tanto affan n o.
M a chi le utriù uoftre uniche s a fole :
Chi la b e lle z z a , s a I'altre uoflre lode
Farebbe conte a i fiecol, che verranno ?
M. G I V L I O C A M I L L O ,
usy
D / ben mille m ature e bionde fyich e
Cerere o rn a ta , s a di fe pieno il como 9"■
. D icea in un f acro a Giove alto f aggiorno
T ra le folenni pompe udendo Pfiche} *
S ante parole del coltel nemiche ,
Che fopra i hia n d ri aita rfa te ogni g io m *
Q u e l, che fojlien il mio candor d'intorno,
P ajjar ne Vhumqn Dio con fo r ze amiche :
A l fècreto honorato* uoftro J'uono i
O gni dolce filentio riaccompagni : '~ si
C h'in felue afeonda il più ripofto horrore •
T aciti i peccator g rid ili perdono;
N e au gel, ne N infa preffo a noi fi lagni ;
Et prego a me perpetuo t o n i honore.
O echi, che uergognar fa te le f e t t e ,
Q ualh orferite lor con m aggior la m p i
Serenando d el d e l g l i aperti campì , 4*I
Et moflrandogli cofe affai più belle ;
C ome d 'A d n a Veterne alte facelle
Giugnete cim e ? perche co chiari va m p i
Non cofi a luoghi men lontani s a am pi ;
O ri e l gran m ar men rotto da procelle ?
C he a me uedrefte qui del mio languire
Far tefiimon d i Tlieti il buon conforte
A le radici del g ra n Pireneo.
O echi, che ne Vamaro mio partire
Io uidi a fe iu tti, s a uaghi d i m ia m orte:
Cofi uedefie hor noi me un lieto O rfeo .
M
ij
i* 8
R I M E D I
/ verde Egitto per la «egra arena,
Ma più per q u e i, che la d o m a r d'ingegno ,
Finseg ià d*amicitia dolce fegno
L a nof r a form a et ogni fe d e piena ;
H or d i fedel'am or, di lunga pense
A la pianta del più felice legno
Finta non i o , ma nera nota uegno
.]Legato di ferm ifiim a ca ten a .
6 oso la Ninfa tu a non tenga f f e n ti
l fochi /noi con quelli di Fetonte
N e l più fuperbo fia te , c'babbia il T tòro.
6 o/i t la tra ti miei con g r a ti accenti
'Muouan tuoi r a m i, s a le du rezze conte
H onorato yg e n tile , alto Q intbro *
I
A ure le g g ia d re, benché mille ardenti
Fiamme d'A m o r , s a mille fu e fatiche
D etto babbi armo i le gran memorie antiche
H auer s offerto, s a wnlle o ffri torm enti ;
V incavi la pietà de ig ra n lam enti ,
Che fa Cupido fu le riite Apriche ;
V non fon F a u n i, ne le N infe amiche ,
Et eglie ferina V ali, e i fuochi h a ffe n ti ;
D am eta al uojlro fuon f it to un Laureto
D o rm e , ne fentir puo'l fanciul dal fiume
G ridar ; ch'un Capro lo fif fm g e a fonde •
A vre ferm ate y o Aure in aer queto
I l m ou er dolce de le uofhre piume ;
E fi rim anga il fo w to entro le fio n d o .
F
M. <31 V L I O C A M I L L O .
269
acendoffeccbio a la mia L 1 d i A un rio;
Chefogge queto fc n \a muouer onde
Al fauor di novelle ombrofe f onde ,
Dt quanto moffra a me benigno sa pio ;
P area Vacque correfjcr con dìfio
D'effer dipinte alhor tu tte feconde
Verso il fembiante honor d i quelle /fro n d e ,
Come il lucido corre al negro mio 3
M a toflo foor de Va beata parte
L a / h u a n la figura tn fle s a fo le
Fatta più bella da un foaue rtfo .
C oso a ruscelli fm p lic i comparte :
Et a g li occhi m iei f o lli, quando vuole 3
Gli Jchermi fa o i 3 e ì fu o fugace r i f i •
V dite r i v i , 0 date a l corfio fe n o i
. -I
O ferina onda eifen va da piano s a lento i
N el ftccian trem olar pietra, b e rla , 0 vento3
Se ffrecchi effer vo le te , 0 cari almeno ;
L I D I A il lume del uifo almo s a f r e n o
N el crejfro d'un di uoi vedendo ffrettio ;
E t fe tid a i bei color, presa Jfrauento
Non cofifoff'e o im e, uenuto meno .
G ridaua al cielo , e a i negri hofcbi infieme
incolpando il foo foco , s a la m ia cura
Con uoce t a l , d i ancor le valli ingom bra.
B en puoi veder cru del, s'Amor m i preme , se
Che per te m*è caduta ogni figura.;
E t d i me non fon p iù , clie parte#s a om bra.
M tij
17 ®
R I M E D I
parfo d'or l'arenofe ambe due corna
Con la f o n t e di Toro il Re d e 'fu m i
A la città volgendo iglau ch i lum i ;
Laqual il ferro del f i o nome adorna ;
I n forbito oro il ferro tuo ritorna
Parue diceff'e, è n buoni i rei coftumi ,
Et g li honorffentì in tan ti accefi lumi ;
Po/ che*/ Sol nuovo in te regna et fo g g i orna,
O domator de*rnojhi 3
o fin qui S ole,
M onde y ch'io volgo a cenni tu o i, benigno
R i/guarda; et co tuoi[g u a rd i ogrihor rifcì)iti
A lfin de le fu e tacite parole
(r d .
O gni riva fiorì , cantò ogni Cigno ,
D'orf i fe 'l f ic o l, l'aria y e l’acqua chiara.
S
f
oi che r .ilta fallite d*ognigente ,
Sangue s a fu dur piovendole dal uolto ,
N e l u e l/la m p o f i, che la D o m a fcio tto
D a l crin le porfe me/la s a riverente ;
Q jta fife m p h e e dgnel puro innocentev
Fra mille morft d'affrri lupijnuolto ,
Come poteu benignamente volto ,
A lei diffe con g li occhi s a con la m en tei
A ruma fola moffa a miei m a rto ri,
Dopo volger de luflri tornerai
Col ver ne prim i accenti, in ch'io rijùono :
A lì)or in carne feoffe d ’atri errori
L a m o rte , ch'io fofiegno, fe n d e r a i ;
E t io la dottorò dal fommo Throno •
M. G I V L I O C A M I L L O .
171
S
e’l «ero, ond'ba principio il nome uofir0
Donna fopra Fllluflri alte L a tin e ,
Tofje con quelle lodi pellegrine ,
Che date al mie non ben purgato inchioflrt\
S arei ( lasse) il'bcnor al fecol nofbro :
TJ tra le Ninfe federei d iv in e ,
else fon più care a Yebo oso più vicine
N el fiorito , frondosa, oso fiacro bofeo •
B en n o i, uoi fo ia con Fece e lfi mente
A le cagion pacando in ogni cofa ,
Leuate a la natura * fuoi fe c r e ti.
E t fian do Apollo, oso le lue Musa intente
A l nofìro dotto f ti l ,giagloriofit
A uangatc t filo so fi, e t Poeti •
T u } chefecondo FaltaRoma honora;
Sol coglier puoi per quefle rim e ombrofe
Le più fiefebe m o le , oso dtlettofe
N a te ad un parto con la bel?Aurora.
A te il bel T ebrole fue fro n d e infiora ;
Et per l a f onte tua purpuree rofe
S'apron, d‘ornarla quafi uergognofe ;
Che ghirlanda maggior [a f fe tta ancora *
A te i candidi pomi , a t e pendenti
Metto» dolce roffore : e l delfereno
P tu affai f i mofira , e i prati affiti più m olli •
C ofi cantò da un [affo in dolci accenti
D i fu ror pieno il gra n paflor Sileno :■
E t G i B £ R T 0 fonar G ib b r t o tio ttL
M iti)
17*
R I M E
D I
L E G A la benda negro
A la tua trifla f o n te
Musa che!gran D e l f i n morte accampa
Sorg i fquallula s a egra
(gn i.
D a l conturbato fonte :
Et vefli il mulo tuo d'opre di ragni :
E i f a tti eccelfi s a magni
D el Gar%on fèmpre in vitto
Stati le funebri pompe :
E t quella , che interrompe
V o lte glorie col termine preferitto ,
E i trofei mofir a faampie scoglie carchi •
D ou'eri Marte fero ;
Q uando fo li il tuo Sole
Dando ftvp o r al d e l del nono lume ?
N o n t'havea g ià L'Fhbero ;
N o n C A R L O , chef i duole
D e l vano ardir fu i rapido sa g r a ti fiume*
Q u a l aria a le tue piume
Sconfolato Cupido
C ede a d i nebbia piena ?
Certa il piatito s a la pena
N on u affliggeva in Paso, non in Gnido: t
Ma in luoghi o ffri s a feluaggi
TTra prU n, C ip re fli, s a fu lm in a ti Faggi .
nco a ulcan del petto
In loco arido s a itermo
, L a v a v a il duol le ferruginee la n e .
Lo feudo al g iovinetto
Fatto tene a, che fc!termo
Sarta Jol contra d tu tte l ’armi Yliffane : w
A
V
V
M-
, . Hi
M. C I V L I O C A M I L L O .
E id e le [quadre infane
E t dt C A r L o tra loro
T o rta la fu ga im prefia:
La m ttoria prortiejja
St uede tu tta n elfa b ril lavoro ;
*7
\
E'l gran Kc co fuoi fig li
*
Coronati d i Lauro , y aurei g ig li»
V er quefio (diffe) ii cafo » ■■
. t.
Fer quefio fiudo*auenne
\ ,
A d Etna d ia n z i , mentre fUtto accefe}
Che'l licor dal g ra n uafo ;
Che'l pesa non fofien n e,
Rido ruCo nel temprar Vinfufo arnefei
O nde k u k in paefe
D al liquido torrente .
D i metallo èfom m erfo.
E t fe F ebo per uerfo
Spenfe il lu m e , eh’ufiia d a l fu o O riente \
Anco Cefar m orio,
Q uando Etna a i fochi tante parte aprio %
M e n tregli Etnei Ciclopi
Eaticauan l*in cu d e,
Tremo t i te r r a , e i monti dier mugito 9
E t g li u n i, y g l i altri E thiopi,
E t ciò che’l d e l rinchiude,
V id e rfia i rotti Àbifii il g ra n Codio*
M a , percheg ià ogni lito
Branu.ua l'alma luce ,
Si tìnfe il Sol d'ofeuro ; .
E , come inuido e duro ,
V cdfeF alto y gloriofo D u ce;
T em en do , non cof in i
M j
174
R I M E D I
Il mondo difcopnrfe pria di lu i,
Q j(ì qui Nvife sorelle
D e la m ia mufa m ejìd
"Venite hor moli* dal corrente uetTQ :
Spegnete le facelle ;
E t con purpurea cefia . .
N embi di fior uerfate fu ife r e tr o ,
, come per ? adietro ,
D a le man uojlre fiocchi
Nette nel m ort o uifo ;
, che'l Faradì fo ,
tu tto 'l hel fi chiufc co* begli cechi.
M a a te Efculapio ad orno
i facro pria Vaugcl nuntio del giorno »
$ d o g li il uel fofeo fconfolata D iva ;
Che'l Delfin ttuouo H E N 1U C s)
G ià col Sol g ir a , esse g irerà fuo amico*
Et
Ecco
Et
E
I h
V
1 N E.
R
I
M
E
D
I
M
.
G I V L I O
C A M I L L O . /
a g g i v n t e
di
n v o v o
V A s i inccnfo odorato
al raggio efituo :
Q u a fi ili fio r fioa v ita v e f it ta :
D i piume faAurd>quando
è ben g r a d ita ,
Lungo il più c rfa llin o , et
verde rivo :
Q jta fi folfiam m eg g ia n te unico s a «tuo ?
Q u afi arco in nube dolce colorita :
Q u a fi Aurora dal vecchio fuo p a rtita :
Q uafi feren faognicontrariofchiuo :
Q jia fi d i perle pieno s a di rubini
Gran uafo d'or3quafi a l g a rrir inai fem pre
Fiume in vitato faamorojo augello :
Q jta fi fa ld e d i neve da d iv in i
Ostri difiinte con celefti tem pre
D 'E m ilia c ln o m e 3e ie u ir tu titlb e lle .
C / a n m eraviglia l)ehì/io T ofcana Musa ,
Q uando [ u d ì tr d i bei fio riti colli
1 D ei chiamar con g li occhi tu tti molli ,
O rnandoti A m a r m i, oso Arethusa ;
A cui tenendo ogni altra Ninfa e fclufit,
Lafciafii prender d ì uicini crolli
Q iie ‘ vaghi ponti', ch’io g ià indorilo volli
V ' pende'ancor la canna mia delu fa.
L unge era Emilia : oso uòi Emilia voi
D a l Re da'fiu m i , oso dal T efin felice
D im andavano i p i n i , e i prati to feh i.
D imandauan pur uoi co g r id i fuoi
1Mi r t i , le G in efire, oso le Mirice ,
E*imparavano Emilia i laur*, e i bofehi.
L o fc tolto dir de la purgata uena,
Che con l'ut il taihor tempra Fhonefio :
O fa 'l giudice ir a to , allegro, o mefio :
O lo d a , o danna fem pre ad onda piena ;
N on dee da r a chi afeo Ita indugio, o pena
N e f a r fentir alcun fenfo m olefio,
A n ? / chiaro fide adente , oso manifefio ,
Come è il bel f o l , che t i bell'alba m en a .
. M a la M usa, che al fu o diuin poeta
Lo Siti im penna, e infiamma le do ttrin e ,
Lo lena accefo al d e l con altri uan ni,
O nd'è calor di cofa ogni hor fecreta
Sotto ah di parole pellegrine,
Jilflro u a n d jg en til, nobtl G iovanni.
C o* purpurei corfier la bianca A uror a.
Seren m'addujfe , esse fortun ato il giorno
Ch'io ni conobbi d’ogni laude ad o rn e,
Ond'è la mente rugiadofa an cora .
C r e f e par uoi il picei ol Rheno ogni bora :
E t fem pre eterni f i or g li empiono il corno
De le u ir tu , chefanno in uot foggiorno
E t del boffitio che Bologna honora :
O pici.,'eh 1
e' G nidotti al d e l le v a te ,
Stando, nel bel contento uoflro hu m ili
De t i citta ne la ripofia parte ,
D el unsero nome i bei fogli f lie g a te ,
E t lo f lir to y eh'in uot tanto g e n tile ,
Sojlenga veder tin te le fu e c a rte .
C ofm o, ch'ornate il nobil fecol nojlró *
V o i, che'lgran Re nel culto dir facondo
Lega fi e conflu p o r d i tutto'l mondo ,
Rendendo luce al dolce fi'ate uoflro ;
h e u a te , prego , a l bel fecretom oflro
i l c o r , che a uoi ncjfuna cofa afeondo.
E t p o i, che'l d e l u i e tu tta qui fecondo »
E afetate hor A d r ia , esse chi fi uefìe d'oflro»
C h'effo M ercurio, Feho , esse la foretto.
Stringerete nel lor ricco legame
"Prima, ch’io auanTy l'Alpi al p a rtir prefls
C ofim i ftabenign/t ogni altra f l e t t i :
E t miniflri al m ioutuer lungo sìa m e
E ta rd i chiuda tl giorno m io fm ejh j^
A l'alto uojlro s a più che humano ingegno.
D ebbio le lo d i, s a g l / imm ortali honori ,
Cerron divino, s a l’arte y c i grati odori ,
Che fu i d el g ra n fecreto date il pegno :
N novo impero m ofirate , s a nuovo Regno ,
Che le corone d'or , e i vincitori
Lauri vince con tu iti ig ra n thefori ,
S i d ’ogni pregio , s a d'ogni Ti ima è degno •
P er noi g ià \fin to come l'alma f iolta
D a virtù a m ica, s a p er amicoJJnrt»
Faccia a l purgato corpo fuo ritorn o;
£ t poi che.a lei ogni im m onditia è to lta a
Come f i fiacri a la g ra n D ea del m irto +
V oifate voi d i tanta notte g io r n o .
P oi che lejfe lafon nel cuoio aurato
In lettre d 'o r , qual era il più perfetto ,
E t di tem prate q u a lità foggetto ;
O nde potrebbe l'buomo ejjer beato ;
E t com’egli egualmente dem entato
Poteva p o t, per magiftn'o e le tto ,
O gni incarco la jc ta r, ogni diffetto ,
E t l’alma ripigliar in puro f i a t o ,
X* alma , che con Mercurio nel ritegno
Per Cibele , O rio n , Bacco, A rifìeo
A ffetta r dee il ritorno a la magione
V id e g iù fcritto , s a rihebbe doglia, c [degno,
Cotanto ben non f i riferba a un reo ;
M a a l buon C e rro n F i lo ffio M e rc h io n c .
S fin to , c'1
) a il foco ne la ierraclnufo
G li a rg en ta ti, osofulfurei f l i r t i al cielo „
Con g li hum ìdi ita p o r , col dolce g ie ti
Che'l Sol attraffe 9leganfila fufo•
E t m entr e l'ombra Feho tien efclnfo,
S'aggrauan tanto nel notturno uelo ,
Che pria che torni il grande honor d i Dolo f
Si fla rg o n fopra t uaghifio r quagiufo .
P crchc t i pi oggih d 'o r , in che fu G ioue,
E t la te r r a , oso t i u ite , e'I mele ancora
H an g li m ed cfim ifu rti fempre am ichi •
G ia bell'aere ha picuuto, oso più non pioue ,
G ià parte a uoi t i rugiadofa Aurora ,
Care A p i, ufcitc homai a i lochi A p rich i.
L* a rm e , c'hor a l bel fianco almo terrem
R endo n del fol la luce sbigottita ,
E i tnobil più u e t i t i , c'hor p a rtita
V an t i fatica a Fonde del Tirrheno ;
S cn le cagion da f ir m i uenir m en o,
N o tig li altrui niorfi, non t i tela ordita
V e la coppia m alvagia al m al fi u n ita ,
V'ifituro infamia, infamia al piecroi Rheno:
M a noi flirto dinin ,fla g e l d'erro ri,
V tetra (aera a natura oso a le flette ,
F atta dì Febo a ita r , oso del fu o fluolo :
L of l d arm ate d ’ire oso d i fu rori ,
E t folnii nate le due lingue felle
Si 3 cbelJùon vada a l'uno, c al'altré poti.
iScr
T crche li numerofi ahi concenti,
Che non capir nel fin del tbofeo m e tro ,
M entre io rifpofì a quei del ditun Pietro ,
Trowo nel tutto ejjer da noi prouentt :
V erran de gli a ltri a nofìra lode in te n ti,
Qpiai dal bel crijlallin liquido uetro
N o n fajjofo , non turbido , non tetro .
V / dan le Mnfc per dolci a lim e n ti.
D ho , o g e n til, o mio honorato Varco ,
Che noi varcando già di colle , in culle
V i condujje ad Apollo una del choro :
t eiferbati fo lg lt f r a l i esse l'arco
D'bumor celejle ut fe tutto m olle,
Et diè ti cetra a uoi diede Pallor9 .
E
D o v n a , che col p a t t T uttio andate a paro
D el nome , esse del bel dir facondo esse raro
V a u re a , jè lic e , esse predo fa v e n a ,
Che forge del di uni candido petto
Con nuouo mormorio
Fra refe , esse perle uri aura dolce mena ,
Rifior d i dafeun nobil intelletto
Stanco d'alto defio ,
O di N infa celejle unico rio
Tramai per tuo fin rar l'aere mio chiaro?
D a ti
«.
D a le due luci uofire, an%jde!cielo
Vn angelico , altero , s a caldo nembo
D i fj>/rittlli ardenti
Piove foaue s a non l ’offendegiclo i
C ia f un porta nel fuo beato grem bo
Perdoni s a pentim enti
O m ejfaggier cortef i , a ititi, lucenti,
C h ifm t a me del fuo theforo avaro ?
Q jtn l è vago il fetftier dt latte p u ro ,
C he jegna il etc ì, poi c’ha d f r a t t o i lum i
N e la notte più bella :
T al pietà n o m a al maggior uofro^ofeuro
P ien di R e a li, accefi s a unti a cu m i,
Tra lu n a e Valtra Jìella ,
O ti ir t u , che’i rmo corfempre rappella
M i terraifem pre in quefio fla to amaro ?
G tVl Pelfin i o terren lieto contende
Col cicl ottauo d t beUeZgfo eterne ,
E’l nudo Autunno p a r , che tutto f u tr n t,
T an te a lui pompe l ’alma Fiora tende :
V n giovanetto fo l le f e lle accende,
O vunque g i r a , s a le fm a rrite e’interne ,
Soffringe s a quafi al mondo alte lucerne , i
Perche non s’efea dal cam ino, a p p en d e.
T ai volgete ig ra n d i a n n i, s a li m aggiori
D i f f e r o a i f i t f i , s a a l rotar d?Apollo
L e parche d i fa ta i confentim ento .
G ta verrà il tempo ; offrirà a i gra n d i honori
O del arbor dtm n caro rampollo
Nuovo d i Gioue s a grande ocaefcim ento
ìS i
D I V E R B I
D E I V E R B I SE M P L I C I>M E N T R E
uefiono tutto il co cetto,coni e fa la locutione.
fiV rim o grado.
|
Troprij
nerbi \
mentre uefiono f
il filo determ i
nato .
*.
pP er f i
\ Per con•
f fuetudi O le .
^.Secondo g rado.
Troprij del primo grado fono tu tti quelli,che
figiufidano una coft f il a e per la propria v irtù ,
o per la prefa dalla confu et u d in e.
Troprij del fecondo grado fono tu tti quelli ,
(he con una fola uoce (ignificano piti cofi dìuerf i f i n \ a v irtù d i Trafiatione.
|
|
S o n o adunque alcune uoci talm ente prò
p r ie , come quefia , comp a filone , che quaft fi
dimofirano ejjcrc con la cofii fignificata nate :
\ imperaebe talm ente efprime il com patire, esse
quaft il computer dolore, che fi piglia dal m ifero , che in noi lo muove : che pare tnfieme con
quello effere fia ta p ro d o tta . E t il fo m m o g ra
do di proprietà prende d a l non figmficare altra
cofa lontana del predetto affetto hu m ano. M a
non tu tti fono di ta l d ig n ità , imperoche alcuni
, non moflrando in uifia ragione
rhe non* alcuna della fu a p ro p rietà , come trottare, cerappare.
care y essef i n u li. E/ quefia proprietà , benché
I
fia per f i , pur non appare tanto in ten fa , come
$ E M P I I C I ,
tSj
la precedente . Aleum altri per lungo ufo fo
no divenuti proprij : che nel uero , chi ben ri
guarda , fono formati da T r a tta ti, come con*7.
i r e
1
n
■ 1
p a r d o Oli
sorto , cheforfè mene da quefia particola con 3 dc u;ene „
oso da forte; perche dim ofra la con flation e esc.
sere data per fortificare il debile , oso cascante
a n im o. Et fu/ferire da fu b , oso/e r o , che e dei
corpo , oso pur f i è tradotto dal corpo all'animo:
che per l'animo f diamente la confyetudine I'ti
f i . FA la^p/fluej#M #e chtanio cofi quella de
g li A u ttc n , come quella del publico p a r tire m T u tte quelle uoci adunque, che et verranno d a
uanti t a l i , che alcuna almeno delle due confuetudn .i ha '/ita in cofiurne, feguiremo Curne pro
p r ie . Et fi come il furto venutogli donanti il
panno per fa r la uefia , non dee prendere fatica
d i conftderare da quali pecore fojfe to n d u ta ti
la n a , di che il panno fu f a t t o , ne da c u i, n t
come f ila to , ma fidam en te, conftderar quello ,
ch'c più utcìno all'arte f u a , tlcofi noi hauend0 %
7 * ...........7 .......... * ' "
11
j m p i r U colonne ^ n fe b b ìm n ^ p W m iÓ a u if
fio) /ycen a erco7 pernierò a quelli cotanto lo n ta J r . .
. 1
J . .
.
r
j,
'•
ni principq , cbg affai p iù uale laconfuetudjne^
effe la ragione, ma difendere oso anicin o r d f
guanto p iy J d jo fiu fa Z d a r a n n o adunque d d |
noi tenuti proprtj del primo grado tu tti quelli,
C r (im i li ; conipafiione, a ffitto , per fo n a , con- drì'pfrLo
forto , me f i e r i , difereto , riputare , /'offerire, gwdo.
perche non più d i una cofa fign ificano. Mai
proprij del fecondogrado fono d i proprietà mol
to rim e fifa ; imperochefignificando più co fi,n n i
**4
DE* V E R B I
fojjono effer nati con alcuna particolare. Per
che d a g li antichi fono sta te diuife alcune paro
le , m H omonimi s a Sinonim i, s a H omonimi
fono q u elli, che da Eilofof Latini E quivoci, s a
tfom oni - Sinonimi quelli che Vniuoct fono ch ia m a ti. E t
xnLofcqui hanno detto leiomonimi tu tti quelli fim p lici,
tto ei *
che conucngono nella voce, ma fono diuerfì nel
la. ftgnificatione, com e, richieder, che hor l i
gnifica conuenirfì, hor dim an dare, s a quefia
cotiuenirc, che hor fignifica decentia, hor op
p ortu n ità , hor uenìre m fiem e. Et Sinonimi
muniticeli ***&* q**lli, che ne la ftgnìficatione convengono,
m a ne la voce fono d iffere n ti, come conforto ,
confolatione , s a finn l i . N on ofla adunque
che u n a tfte ffa a fa pojjà hauer più n o m i, fi co
m e non ofìa 3che un nome non poffa hauer più
c
f ig m f cationi, s a nondimeno nell'uno, s a f a l
tro , può hauer luogo la proprietà ; perche f e ranno propri] del fecondógrado tu tti quefli s a
f i n tili. H umano che hor fignifica differente
d a b e fiia l f f e c ie , hor benigno, non per v irtù
d i trafla tio n e , m a per effer H omonimo : coft,
don n a, che alcvna v o lta 'fi riceve per dt ffe r e n -,
tia di fa n ciu lla , talhora a differentia di età s a
talhor in honore ; Et quefla vo ce, hau er, fola
n t l'in finito, imperoche oltre chefignifichi quel
lo , ch'è il fuo verb o , fignifìca ancora la fa cu tt à . Finalmente dalldpredette parole compren
d e r efi p u ò , che quefli del primo grado f io tta *
m ente pronontiati fvbito mamfeftano la loro f i
g n tfi catione per effere particolare, m a quelli
d e l fecondo g ra d o per hauer la [ignificatione
\
S E M P L I C I .
m ultiplice, non la poffono cofi m anififiare „ s a
non per le cofi a c ri [aggiungono y
f Prim a m aniera K
Setoli#.
D a anim ato a d
anim ato.
Da inanimato ad ,
inanimato!.
! Q ju trta.
|
‘Q u in ta •
D a inanimato ite!
animato *
D a uicino nel me»,
defimo tndim duo. .
Trafiato è quel n o m e, o uerbo tradotto d a l
proprio luogo a. quello, dotte il trafiato è miglio,
re del propr/o , ouero dove manca il proprio .
A L L A dichiaratione della predetta diferit
tione e da fiip ere , che coft nel trafiato f i cerca Ornato ^
l'ornato, come nel proprio la chtareZ ya. E t in c^e £
cofi come non poffono efjere chiamate proprie chieggo *
quelle uoci che fino ofeure, esse che ne la prim a no *
■
utfia non figm ficano la cofa, cofi ornamento
noti apportano quelle che duramente fono tra p
portate , come quella in D a n te , de t i uagina
I
iS<?
D E* V E R B I
delle membra f u e , «olendo figm ficare [hum a
na pelle, che il Tetrarchachiamandola fcorZa,
nel nero e pia honefia esse più piaceuole, s i per
chefi haueua a moflrare mutato in lauro : esse
f ? per effere da Platone deficritto l*Intorno per
un'albero riu o lto . Appreffo nifjùno trafilato
per fe pronuntiato tiene uirtu di trafilato , mae
d i proprio ; che pronuntiando vagina fen \a al
t r o , fid a ro[fignifica il fino proprio ; cofi que
f ia uoce fc o r\a ; esse solo nella teffura della compcrfitiune dimofirano effer trafilati. N ondime
no noi per l'imprefa nofiìra « olendo fegnire piu
Caltrui che'l nofiìro ardire come fiempiici, esse
trafilati fernplici conferueremo per poterci cofi
d i loro feruire come gli A u ttu ri f itto hanno.
Traitotlo*
la trafilaticne fiipuò fare ad uno de* cin»ie a qiian qUe fu d e tti m o d i. EJ'empio del primo, s'ìq d ipuosare* coso* » che A c uno huomo corre trio m la ffe , per
che da uno animato ad altro farebbe tr a d o tta .
Esempio del fecondo, le riue off renare i loro
f i u m i, perche è tradotta dal fieno che è inani
m ato , a i fiu m i parim ente in a n im a ti. Pfem
pio dal terZ o, rider i f io r i. Ffempio del quar
to uagina delle membra . Q u in ta maniera è
quella, che fienZa partirci da mio medefimo in
dividuo , traduciamo quello, che e d i uno m em
bro ad u r ia ltr o , come il parlare, o'I tacere a
T r tih to
occhi. Conofcerafìi adunque il trafilato
ionie jj co dall'Homonimo in quefio , che non come l'I lo nostra dui.- mommo tien fofbefo chi Vafcolta per la fua uaH hoinoNi
c
r
■
f
^
ria fighi fi catione, che pronontiato, richiedere,
l'huQiìio non può faper per la doppia fu a fig n ifi-
S E M P L I C I .
iS j
catione, in quale egli fi fi a allhora prefo ,f e n Za alcuna altra parte d efloration e. E t benché
ancora il traflato per fignificar prim a il pro
prio , par effe ad alcuno fa r e il medefimo , non
dimeno fe ben confo!ereremo non porgerà cofi
flato dubbio, imperoche d i prefente fignifica il
fuo proprio. Perche quando io dico J'ofìegno,
euero alleggi a m e n ti, fi rapprefenta fuhito il
proprio loro, che è l'uno d i fi/ten ere cofa caden
te 3
faaltro d i alleviar p e f , m J nella tefìura ta l
hor vengono come traflati Sinonimi a [igni ficare c o n fla ti une ; Il che avviene non folam ente
quando la voce è tradotta a fignificare meglio
ehfai proprio, qualifirebbon le d ette uoctfofiegno , & alleggiam ento, per c o n fla tio n e , per
che affai più L’ufficio dinwfìrano che7 proprio
non fa re b b e , ma ancora mentre che fi conduce
al luogo l à , dove manca il proprio , f i come
q u efla noce gem m a afignificare quelli, che per
bavere vocabolo per traflatione occhi di v ite
ancor chiamiamo , fa ra n n o . adunque traflati
tu tti q u e fli, s a ftmiU ; accendere faam o re, a lùfiimo di n o b iltà , baffo d i conditione, che f i
no proprìj d i cofe corporee.
D e ifem phei figurati.
~V no per m olti.
Delta f in e tdoche.
Parse per il tu tto , o per con
trario .
Genere per la ffrecie > o per
g -c o n tr a r io .
s incedo*
Sinecdoche è quella fig u ra , che f e n f a a ttri
buire nome d i una p a r te , per darlo a d u n a a l
tra , pone una parte per un a l t r a .
Metonìa
M etonim ia « quella fig u r a , che da il nome d i
m ia.
uno de'fuoi correlativi all'altro, ponendo l'uno
p e r l'altro»
"'U tm entore p e rii tro u a to ,
o per contrario,
llpoffeffor per ilpojfeduto ,
o per contrario.
Me t o n i
m i a .
< I/ continente per il contenti* t o , o per contrario ,
Cagion per effetto , o per
contrario\
Alla cagione accidente de
~l'effetto,
.
1
S o n o alcuni a ltr i fim plici, iquali non
trafi a l i , ma più tofio fig u ra ti meritano d i effer
ch ia m a ti, non perche la traflatione non fia f i
g u r a , m a perche epuefii d i figura iau an \an o :
E t quefli fono , al creder mio , gouernati dalle
due figu re fopradtuifi Sinecdoche oso M etonim i a , lequali fiotto fi uicine, che a fa tica taihor
fi Lifeiano conofiere. E t quantunque la diffe
r e n z a loro non fa m o l to al propofito neccjjar t a , pure cUremo effer ta le , che la Sinecdoche
S E M P L I C I .
iti
non ufo un nome per uno altro , come f o la M#»
tonim ia , arife nou f i parte quafi da fe medesi
m a ; imperoche fi pone uno per m o lti, come i l
Romano.per li Romani; la parte p e r ii tu tto ;
come il tetto per la cafa ; fai genere per la fo e
d e , come il ferro per la fo a d a , non fi parte dal
fo g g e tto . M a la Metonim ta riceue uno nome Metonle
per uri altro , cornei*inventore p e r ii tro va to ,™
quale e Cerere peri il g r a n o , fai pojjeffiore per il
pojjèduto quale è Vulcano Per il fuoco , e l con
tin en te per il contenuto , quale è il cielo per al
cuno Dio , s a la cagione per l'effetto, quale a
lo Tirale per la ferii a , e l'eff etto per la cagio
ne , quale c t'orma per il piede y s a t alhora da
alla cagione l1accidente deli*eff e tto , come p a lli
da m o rte .
~T)a la pro p rietà .
D al quarto tuoco le iU
Metonimia,
Luoghi degli
E pith eti é
< Dalla differenda.
Dalla amplificatione »
Dalla Diminuitone »
"Dalla traflatione *. •
E P l T H K T O e quello , che f i Aggiunge *
ad uno altro nome , . onde altrim enti appofito è
N
19«
D E* V E R B I
Epitheto, chiam ato, più Ubero a Poeti che a g li O r a to r i.
o»*de fi D a s e i principali luogh i , per mio auifo , fi può
può trai> tr a n e \ Qepith eto. Dalla proprietà del nome a
cui è aggiunto , com e, Dentes a lb i, n/wae Aienuda e Fluutj liquentes. D al quinto luogo del
ta metonim ia , Seneflus trijìis , pallida mors :
esse in quejìi due modi è chiamato altrim enti
epitheto pei'petuo, perchefempre a cotali nomi
to ta li epitheti per proprietà fi convengono .
Dalla d ijje r e n \a , com e, d illa placida , cioè
a differenza d i q u elli, quando dicono, d illa
ir a ta . Dall!am plificatione, come, parole fa n
te . D a lli dim in uitone, com e, animus minu
tus , per animo picciolo . Dalla trafiationc ,
come ne sii d e tti efem pi, d ifla p la c id a , ouero
i r a t a , imperoche Vira esse piaceuolelfifa fono
trafilati dall'animo ; esse in tu tti qnefih quattro
m odi f i può cbtam tre epitheto tem porale, per
che è m utabile esse non perpetuo di quelli nomi
a cui s'aggiunge. Q ualunque u d ta adunque
fi troverà alcuno a d ie ttiu o , prefio al fuo nome,
effere tra tto da uno de Jopra mofirati luogh i,
potrà effer tolto per epitheto. Et perche fièno
e p ith e ti, che fi poffono dare a n o m i, esse epithe
ti che da quelli fi poffono trarre , a me parreb
be , che tu tti quelli che fi traggono , filano da
riporre nella colonna de fim p lu i, come quefio
nome , Amore , può bavere per epitheto , nobi
le , alto , 0 filmili temporali : esse da lui fi può
trarre quejlo epitheto amorofo, da dare , per •
d ir c o fi, Ale fia m m e . Io direi che q u elli, no
bile 0 a lto , fufi]ero da fegnarc per epitheti
S E M P L I C I .
191
suol : Mae amorofo poi che fa r à dato per epi
theto alle fiam m e, o ad altra cofa conueneuole,
fof]e collocato nell a prima colonna del concetto
di am ore, come fìm g lc e , non altrim enti che,
nobile osoalto , tra a debiti loro fim plici fa tto
tlf io ufficio . E' una altra maniera d i epithett che di più noci f i f a ; oso perche è ima tfieffia
cofa con l a ? en fi a f t, nel fiegutnte tra tta to di
Inifi fa r à ragionarrtento,
D a lageneratione •
D a le cofi che opera, ha
operato , ofetol operare,
Della B erifra ji, V.
Da le cotte che pofifide, e li A
poffeduto
*
<.
\ Da gli ornam enti,
^ D a g l t configuenti.
D a cofi m a n e .
Tcrìfi-afi è circunlocutione, che in luoco del Perifrasa' 9
diritto nome pone un a ltr o , of o lo , o di più uo* fa* C°**
et accompagnato, onde è chiamata ancor A ntonoma f i a .
Q y E S T À e connumerata tra le ornatiffime fig u r e , oso però è molto p o etica , ne
*UO
appo g li O ratori hauere più dt tre luoghi ;
mentre uogltamo coprire le cofe disbonefic , elPcrifiafa^
N
tj
19*
DE* V E R B I
quitte che farehbono molefie a g li a u d ito r i, •
quelle che dar ebbono g r a v e z z a a' D icen ti, Mae
¥ ~ s l Boccaccio , che f u Jfrefio Poetae in p ro fa , non
in prosa, fi haguardato d i ufi ir fu o ri delle dette tre leg
g i infognateci da H erm ogene. Et a noi è p ia
ciuto per due ragioni collocarla [a b ito dopo i e pitheto , prima perche effa talhor e pofla in una
v o c e , talhor in più : in una noce come, T itid e ,
V elide, l'impio, il P arricida, Venere , o Amo
re , o fuoco per Tam ica, in più u o c i, come ;
Il T a f or c ita Golia ruppe la f o n te , per D a u id, ,
ttgltra perche qu alhor a prefju la circunlocntion efi pone ancora il circunfiritto ,fem p re la cirCfreonJo*cunlocutioneper autorità d t Q u in tiliano e d a
quando*ce0er ^ c im a ta epitheto : Ma n o i, o f ia , o non
da effer fia appoflo il circunf r itto , hauendo rifoetto d
epìthcco temt}* >che di lei ci vorremo fir n tre , fe r à da
noi fegnata come p erifia fi. Appreffo e da f a pere , che la perifiafi di più parole alcuna uolta
end nude uerbo, alcuna uolta non ue lo inchin
ile , C W e Ouidto nel primo ufandula intorno
a l nome divino otto v o lte , le fe t la fece fe r ifa
nerbo , Mundi fabricator , opifex reru m , mo
derans e u n d a , R exfuperum , K edurfiiperum ,
cale f i e numen , Q u i cclefha fccptra tenet ,
Q u i uaga fu lm ina m it t i t . netti quali due u lti
m i luoghi d nerbo e inchiufio , come un de’f uoi
com ponenti. Ma ni ff una maniera delle locu
tioni , che feguono , poff 'ono effer ferifet uerbo
n eram en te, s a li fu detti luoghi poffono darci
m a , s a da conofcerla , s a da form arla • Ef a n
pio del primo , com e[em piice, T itid e , ma co-
S E M P L I C I.
19}
me compofio figliuolo di Ma ia . D el fecon di
fabricator del mondo . Del te r\o colui che man
da h folm ini : del quarto colui che regge il mon
d o . De! quinto lubar infigne corujcis radqs
per il fo le . Da confeguenti , aqua Uberior , •
per il m a re. Dalie vicinità Regna K abathaa
per ÌO r ie n te . Et e differenza tra la perifiafi,
esse la d e fin ttio n e , fhe la perifiafi non fo la mente rimoue da fe il circonfcrilto, ilavale fa
rebbe manifijhfitmo , ma quello da alcuno del
ti sii detti luoghi circutifcriuc , esse cofi i t vuole
dare ad intendere. Ma la deferìttione fi ritie
ne tl d e fin ito , esse quello fi come non mtefio d i
chiara , aprendo alcune proprietà della fu a na
tura . Jmptroche fe alcuno non fapeffe che fo ff e l'Aquila y esse che io glic'l uolefii dare ad in
tendere , rA qu ila efjere uno uccello dio echio
pofjente a riguardarci raggi d e l fo le y & d i
unghie rapacifitm e, di cotanta grand, e ^ g a ,
esse di cotal c0fium e ; in quefia dichiarai ione •
non è rimoffo il deferitto anZy necejfariamente
ui è inchiufo;cofi s'io uolefii defcriucre un g ia r
dino , un u iaggio , nella prim a parte del ragio
namento hmrebbe luogo la cofa, a r i\t in qua
lunque parte potrebbe hauer e , laquale 10 h o - .
lefit deferiuere : esse queste deferittioni per la
fua lun ghezza esse natura f i conferueranno con
le m aterie.
X
iìf
fV r o p ria ,
g ? e r C ufo de*
[c o n g iu n ti .
Da g li antecedenti.
r Da
configuenti.
j D a g li fr u m e n ti
Laorp orali.
. Tropriamente
Locutione propria è quella maniera de* conpropria”*
ftmp l k i , che per lungo ufo fi fono ufati
««a*iata ; ad accompagnare per alcuna figmficatione par
* *gura- tito la re .
Locutione p ro p ria , fa rà quella , x h e fa r à
compofia di uoci p ro p rie, o come propriet , lequali per alcuna inchiufa particola della cofirut
none non fi potrebbono feparare fienai dtflrus
tione dt quella.
. L ocution trafilata è quella, doue alcuno, o
più de* congiunti fono t r e f o l i .
Locutione figu rata è quella, per laquale noi
uggiiamo quafi m ofirarela figu ra , oso la im a
g in e della cofa.
V E R A M E N T E appo g li antichi quefio
I ocu^ 0 ^tiome locutione altro non fu o n a , che modo d i
ite , che fi parlare , oso modo di parla re, non fuona altro %
guifixa. (j/e un nQn j 0cf}e
à i q u d lo , che fi ha da t i
S E M P L I C I .
i 9s
cofiruttione gram m aticale. Ter ehe fe ben tro
tteremo degli accompagfhiti, che per g ra m m a tic A i regole fi fanno , cotali non fegniremo per
accom pagnati, come 3lodare alcuno , riputar
alcuno fidare ad alcuno qualche cofa ; Im peroche per fe la gram m aticA regola f a cofi fa tte
compagnie. Er a noi affai fa r à m ettergli nella
felua de fim plici, ma mentre ci fi pareranno
avanti alcuni propri] della prima maniera, cioè
di quelli che lungamente hanno in coflume d i
accompagnarfi per fignificare alcuna cofa 3co
me prender moglie , per m aritar f i , imperoche
in luogo di prendere 3
A tro uerbo non baureb
be lungo , cofi facere certiorem 3che in luogo d i
jacere non f i porrebbe reddere, cofi facere con
fitti u m , in fin e contumeliam, che ne inferre
c o m itiu m , ne facere contumeliam fi trutta in
Cicerone , cofi facere u ia m , che da noi fi dice ,
esse anco f a r luogo. In fim m a tu tti quelli che
per lunga ufa tif a fogltono accompagnarfi , per
tùli ebef i ano come 3hauer mefliert ,f a r m efìier i , o Infogno, fono locutioni propriamente pro
prie . imperoche quefìejafeiar andare, lafciar
paffare , lafciar cantare, andare all*horto , an*
dare alla p i a f g # , non fono da fegnare per I o c h
fiorii quantunque congiunti proprij le facciano.
Im perni): quefio nome locutione, corsi ho d e t
to, importa una certa cofa d i più che ccjhruttion
gram m aticale, ilqual più fi coglie dall'ufo 3esse
l'usa non f i può uedere, mentre ad infinite cofe
le coffr ut t ioni fi poffòno appicare 3m a ad al
cune particolari. Quelle ancora locutionip r o N
iiij •
.
oso
DE* V E R B I
prie fi ricetteranno lienche fi ano più rim effe, le- J
quali hon fi potrebbono difiruggerc fcn\a per- '
dimento d i alcuna fo r m a , o d i particola> o d i
a ltra p a r te , quantunque [offe Sfata fa tta dal ’
iflefj'o auttore nella coflruttione, conte m etter fi
in qualche operationi, riputare alcuno da m ol- 1
to , pensare ad alcuna cof a , penftre in alcuna
cofa , lequali uel uero f e fi corrompe/fero, non
f i coglierebbe alcuna uirtù : in fontina tu tte •
quelle fi deano cogliere, che per li congiunti'
fanno uno in telletto, che fe alcuno de g li con
g iu n ti fi diuidejj'e, non fi f n tir e b b e .
/ “•oso
L a T rafiata fe n y t riguardo fera da coglie? '
re per conofcere il Giudicio del A u tto re, im perocht nelle tr a fla te , s a nellefig u ra te , effo può
folam ente mofirare del fuo artificio a perto, s a
s a le trafiate feranno comequcfie , (egu ire lai* '
d e , fèguire biafimo , feguir pericolo, tro va r
compadrone in alcuno, accenderfi d i Amore
pervenire a n o titia , concipere amore , porget ‘
refrigerio, portar opinione sporger piacere.
La fig u ra ta cofi chiamaremo a d iffere n za
della tr a fia ta , imperocbe quafi depinge, s a s i £«ra la cofa y onde di quanto la trafiata moue
il fenfo più che la propria 3tanto più la fig u ra
ta l o f t , che la pro p ria .
E T benché JpcJJe uolte la trafilata venga a l
la fa ttu ra della figurata, nondimeno quefiaper
le altre giunte la accrefce in b e lle zz a . E tjù o l
erari atu° * ^
ptu da cinque predetti luocbiform are, del
onde li cu h quali i quattro prim i fono topici , onde i belli
s a sottili argomenti fi oratoritj come] poetici f i
traggo n o .
SF.M F L I
C 1.
fa
Vfempio del p r im o .
Buccina,qux medio concepìt ubraera poni «fi
E t quale è quella diurna del P etrarca.
'*
E i vaghi f l i r t i in un fofliro accoglie. ■ *
P erri oche precede alfuono oso 'al con to , che Tae
re oso lo flir to fia accolto prima , Efirn pio de*
conseguenti è , che volendo O vidio m cflrarci
d a v a n ti a g li occhi dopo il diluvio im a r i oso i
f u m i difcrefciuti penfando che i fiu m i non f i
pojjono chiamare difcrefciuti, fe alle loro ripe,
non fono ritornati p perche a l dijcrefcere corife-*
gue il rimanere dentro dalle proprie rive, dijje.
la m m are littus h a b e t, plenos capit Alveus
am nes.
r'
Flumina f uhfidunt , colles exire videntur [
Surgit hum us, crefcunt loca decrefcentibus
u n d is.
Lequah tu tte fin o tra tte da i luoghi de i coni
feg u e n ti. Dalle cagioni mafiimamente effciek
t i , hauendo a dire che la terra produceua d a
f i t togliendo le cagioni che con artificio fi f a n
produ rre, d iffc .
R afiroj; in ta tta nec ullis ;
Saucia uomeribus per fe dabat omnia teflus.
D e g li effetti è che hauendo detto il Tetrarca
Laura accogliere i uaghi f li r ti in un fo fliro ,
soggiunse quello che nel fciogherli feguiua co
me effetto , cioè uoce ch iara, f ia u e , angelica ,
divina ; oso differenza è tra configuenti oso esa pùferéth
L .
-
•
r
r
ir
1 r
* » 1 « o n fc
/ e t t i , che i con/eguenti non fono fi ejfenttalt, gUemi se
come g li e ffe tti, perche ta li, oso non ta li poffo-%# effetti,
nofig u ir e , onde g li effetti fin o come necejjàrù.
N
y
D e g li ifru m e n ti corporali, mentre g li k u tto r i prendono per luoghi effe parti del corpo, la
qual uirtu nel nero molto p u ò , nel f a r qua fi da
g l i occhi uedere le cofe .
C om e,
Mone/i il V ccchierel canuto esse bianco,
ìn d i trahendo poi l'antico fa tic o .
In fom m a d rizza ta la mente ad effa n a tu ra ,
quella nelle fig u ra te locutioni ci fiera ottim a,
rnacfira.
f
h M. M A R C A N T O N I O
*
L
A
M
I
N
I
O.
O t e 5 s ’ i o M. M arcantonio
mio per lettere dimofirarui la bel»
lefjtyy e*l valore del libro , liqua
te hauete in defiderio di conufi ere:
che prenderei ferm a fp e r a n \a per me^o uoflro
tti ufiire della m i f e r ia , in che, per non abban
donar lu i., caduto m i truouo.. Et in uero fiele
pr.efenti parole d el Magnifico M Aleffand.ro
M anzuolt compagno di tan ta fa tic a , nonni
hanno potuto di lui fa r pigliare alcuno affig
g i o : fi come dal nobilifin io M. Filippo O bermairo ho intefo ; come le lontane m ie potranno
m ai ? Ben fio io , che effeiuto dalla prefienz<t.
uofira diuifa , l ’opra è come impofiibile per
adombramento , che fi faccia di. le i, p o te rti
m ettere in n a n zi della fina diurnita la form a
g ra n d e, esse dell'ordine l'u tilità m aggiore. Che
f e acutifinrn è de g li A tr i fienfi il uedere , co n .
f i n ddcttvfi) conofiamt»to f i ■appw A on p ti co-A
*99
f e , che tanim o per g li occhi raccoglie, m entre
ancora da g li occhi com m endate, & dentro
m an dategli fo n o . Pur per fe g u irc , in quan
to p o trò , il unsero piacere, m i di [porrò a diflen
derni in que fi a carta ciò , che in eJJ'o libro non
m i è concefio al prefente
Sono h ornai ; se ni
v a per ut memoria; più a n n i, che con grande
d ilig e n za incominciai ad offeruareli {empii
ci , s a copulati fila tin i , come volgari ne g l i
fpatiofi campi de più lodati antichi fc ritto ri s a
quelli fecondo Vordine dell*Alfabeto mettere in *
ftem e : ma di cofi fa tta fatica non ho ricevuto
maggior p rofitto , che! conofcere con quanti s a
quali nomi fi per pro p rietà , f i ancora per tr a f a tto n e uetbi s'accompagnino. ìlche per g ra
tia di efempto fi potrà comprender per quefifa
due volgari lo cution i, pofie nella lettera . A«
A bbatter fi in alcuno, onero ad alcuno. A bbai*
ter e alcuna cofa'in terra ; che dalle la tin e, f r i
nendo bora in v o lg a re , nonmouerò parola •
D i/o ; che quantunque le predette fiano ancora
feguite da tu tte t a l t r e , in che quefio uerbo Ab»,
battere ha luogo o tran fi ti v a , o intranfitiucU
mente ; nondimeno ciafcuna battendo fignifica
tione diu erfit, s a in nefifuna altra cofa infieme
fim igliandofi, che nel verbo capo della locutio
ne , par euam i ta l ordine non potere efiere pre
f io a miniflrare la lin g u a , fe non a co lu i, che.
a quello d i continuo fofie in tcfo. P ercioche sa,,
ad alcuno nuovo nelle dette lingue fa r à hifogno
d i aprire con favella , o con f rittura uno de'
d e tti [enfi , i n quale lettere dell?Alfabeto faprà
'
p i a i tr o v a r e con q u a n te
oso
t i c h i l'b a b b ia n o u e fiito (
A .
ch e a q u e lla d e l ,
B ;
q u a li p a r o le g l i a n
C om e
ou ero C
p t u a lla l e t t e r a
.
/ a p ra r ip a -
F arf i ? la q u a l f a c i l i t a d t t r o v a r e v o le n d o f i c o n
f e t t a r e d a n o i 3f a c e v a b i f o g n o d i p o r r e d a v a n t i
i t il a m e n t e a lc u n o g r a n d e l a v o r o d i p a r t i b e n d i
J h n t e ; a c c io c h e
p e r la fu a g r a n d e Z Z f1 u
o so
i
t e f f e r o c a p e r e le f i l m i g l i a i f \ e d i t u t t e le c o f e ,
p e r la d ifiin tio n e f e n Z a e rro re
,
oso f e
p°~
oso
n \ a lu n
g o p e n fu m e n to e f jc r a f e n i p r e p a r a te d o n a n t i ,
p ie n e d i t u t t i q u e ' m o d i d i p a rla re d i ch e g l i
'a n t i c h i f e r i r t i f i v e g g o n o o r n a t i
.*
E v
il vero ,
c h e d a u n a p a r te h a u e u a m o la m a n ie r a in a lc u p o e d i f i c i o d a C ic e r o n e p r i n c i p a l m e n t e t e n u t a
j
D a lT a ltr a q u e lla d i M e tr o d o r o n e d o d ic i f e g n i
d e l C ie lo
>
,
d o u e tr e c e n to f e fja n ta lu o g h i f e c o n d o
i l n u m ero d e g r a d i g l i eran o fa m ig lia n f iim i
M a
u eg g en d o n e Tuna poca d ig n ità
m o lta d tffic u ltà
,
&
,
«
n e l'a ltr a
a m b e d u e fo r f è p iù a l t i
r e c i t a t i o n e , ch e a lla c o m p o f itto n e a c c o n c te ,
r i-
v o l g e m m o t u t t o ' l p e n f i e r o a lla m e r a u i g l i o f a f a
b r i c a d e l c o r p o b u m a tr o
.
' A u u if i tn d o f e q u e f i a è
S la t a c h ia m a ta p ic c io l m o n d o , p e r h a u e r e in f i
p a r t i , c h e co n t u t t e le co fe d e l m o n d o f i c o n fa c tio n o
,
p o te r f i a q u a lu n q u e d i q u e lle a c c o m m o
d a r e fe c o n d o la
m ondo
lig n ific a n ti
f u a n a tu r a
a lc u n a co fa d e l
c o n fe g u e n te m e n te le p a r o le q u e lla
, o so
.
E t co m e ch e p e r la g r a n d e u ic m i-
t a d e lle p a r ti p a r r à f o r f è a u o i a d o m b r a r f i i l lu
m e d e lla d ifitn tio n e
,
n o n d i m e n o f e u e d e f l e co
m e n e l lib r o f o n o c o llo c a te , p a r e b b e u i , n o n f e n
Z [ g r a n m e r a v i g l i a , J e p a r a ta m e n te v e d e r e in
*ò t
ordine da non ufcire m ai d i mente tante arcl?e \
o conjèrue , che dire vogliam o, da riporre cia
scuna cofa , esse cia/cun modo d i d ir e , che nel
mondo f a . E t che le parti del corpo come luo
ghi nceuere f i poffono , ci infegna Galeno ; i lquale nell'opera chefe c e , delle pafiioni, che alle
membra dell'huomo poffono auucnirc , dice > le
parti del corpo humano da tu tti g l i antichi effere Siate chiamate luoghi. Laquale im p re ft p r i
m a che ci porga la u tilità p r e d e tta , ci conduce
fecondo il fixnto detto d i Apollini alla cognitione
d i noi Sì e fii. Et veramente nonf i che pruden
tia habbtano g li h m m tm di cercare dottrina d i
tu tte le cofifu o ri che d i fe me definii, conciofla
cofa che quefia donerebbe efferc la prim a . H or
quale opra u f i m ai fuori delle m ani detteterno
m a fro più divina d clt huomo? certo n in n a .
Et ciòJicuraniente poffo dire nonfolam ente per
hauer con alcuna. diltgenZji corfio più uoltc il
diurno T im eo , in che Vtifone è tutto d'intorno
alfyum ano c a po con grande m eraviglia occu
pato r le opere di Galeno fopra ciò , Arifiotele ,
Cornelio Ceffo , Marco Tullio nel fecondo
della natura de i D e si Plinto,, L .U tantio, esse
m olti a ltr i, che fopra tale fabrica con d ivin i
p en feri fono d im o ra ti. MA per effermi ancora
d a uno Eccellente Anotomif a hornai in due cor
p i humani di membro in membro il divino m agiflero mofirato : ne fidam ente ci t paruto toso
uerfi conftderare ignudo di fu ori > esse dentro
quefio corpo, m a a certi tem pi conti cneucli a
g u f a del Vertnrmo d i Ero [erti? essedl O m di#
h o t fptto m o ,h o r fiotto uri altro uefeimento. ,
che cofi tu tti li paefi del mondo per l ’ordine della
cofinografia per noi meraviglio]àm ente fono d i
fettiti o tu tti g li o ffici, & le conditioni dt tu tte
le perfin e; fiche cofa non può ejjer im aginata
in cielo , in aere , in te rra , m acqua , s a in
abtjfo y cl?e nel. nofiro libro non po/Ja hauer (nè
g o p e r f e , s a per quella parte di lingua accon
cia a renderla ni anif i f i a . JVJae prim a ch’io prò
ceda più avanti m i darò a d allegare le due lo»
cationi da noi fo p ra in ejempio a d d o tte . Dico
adunque che g li nervi d e tti o p tic i, p e rii loro
inconlramento pcfiono essere accommodato luo
go della p rim a , s a efe n d o da g li antichi d a to
alla u o la , che e nella cani t arietta mano tu tte le
v io le n ze, onde è da alcuni a M arte fuppofia ,
cotale luogo fin z a alcuno errore potrà riceuere
la fe c o n d a . N e quefii nofert luoghi fono ta li
che per impofittone nofira qnefia o quella cofa
habbtano a lign ificare, quali erano quelli d i
Cicerone, che cofi forfè a noi J'artbbono menda
ci , s a talhora d i loro la memoria ci potrebbe
fu g g ire ; m a o per loro natura mofir ano la f i gm ficattone , com egh occhi il vedere , g l i orec
chi lo afeoltare, la lingua il p a rla re, t piedi il
cammare , benché talhora cotale natura habbia hi fogno di essere a p e rta , come quella delT ambi hco ; dquale perche nafeiuto l’huomo cefi
f a dall’ufficio, che haueua di porgerli il nodrim e n to , m lui capirano per locati tu tti g li ceffam enti , s a ripofamentt dall"opere. Et il fin ifiroR en e no» effondo d irim p etto d defero,
m a collocato dalla natura alquanta più baffi -,
per dar luogo alla m ilf a , pigli era per luca*
t i tutte le cefiion i. Cofi a quella parte delle pop
p e d e t ta da Greci M ivo: ouero t oue il /a n g u e .
J ì conti erte in L u te , fono da dare tu lle le tra*i
sform atiom , o per a u to r ità , come alla infim a
parte de g li orecchi e dato da uoi il rendere
alcuno ricordevole ; oso anco il chiamare alcu
no in giudicio ; percioche per quefio y & p c t
quello fecondo l'outtorità d i P'linio foleua effev .
re anticamente cotal parte ficoffa , E t perfaruùpiù noto quefio thè fo r o , fra alcuno chefi prò fo n
g a voler elegantifiimdniente feriuere alla fu a
ofim ata Donna , lui comprendere da ch iarifil
m ifo g n i, che effa lo babbi a in poca 7
1
im a , oso
mafiimamente da quello, che egli m ai non ha
potuto rammollire in parte la dureffifa fina,
Q uefio fu ggetto tiene tre principali Jenfi, liquali qualunque, leggermente nella n o fira fi-brica in trodotto,■fa p ra di fila to com e, oso tri
q u a tti modi poter d ir e . Ver ci oche effóndo p ri
m a am m aeflrato, che per li fig n i detti? umano
volto fi può pigliare iuditio delle fecrete pafiio- ;
ni dell'animo ; egli al luogo de Ino Ito troverà ap
parecchiati tu tti ifim plici oso copulati, per Uquah tali furono, d e tti da g li a n tic h i. E t cofi
potrà a fu a /celta occupare quella parte, che g li
parrà più acconcia. Appreffo fe dtfiorrera con.
la memoria tutto il corpo humano, troverà p r e f
fio il luogo dett angine quel cerchio f i t t o uefiito.
tfilhor di nero,da Greci chiamato
et efen d o
app o lo r o j C t m t d
w jr g n frb Ì Q ,m c tM f a -
-
riamo non Stimare alcuno un nero d'un ghia,
cofi fa tto luogo g lt m in iftrerà , hauer e , o tene
re alcuno a u d e , esse a ltriftm ili ne Vuna esse [ a l
tra lingua fegucntemente haurà imprcffa la
opinione d e g li antichi: chefe la natura hau eff e fatto [offa fe n \a midolla , quelle in tanto in
durir ebbono , che del tutto infiangibtli fa re b hono : perche neceffariamente f i tnchtude chi
tan ta durezza mtenerifca ; d\l luogo della m i
dolla trotterà come potere il te r \o fe n \a orna
tam ente dire Ma fe in vece di quefto , f e n \a
j rammollire [a ltru i du rezza , lìducffe voluto
prendere a dire; non hauer potuto rendere m an
Jueta la fie r e z z a fu a , conuerrebbe che egli f i
conduceffe non al luogo della m idolla, rna a
quello della palma della m a n o , che con quella sa
fiogliono molte fiere domefi icare menandola per
il dof i o . Tot et e homai frateRo canfiimo hauer
in pM'te comprefo con quanta fa c ilità , esse con
quanta b e lle z z a p erle membra dell'humano
corpo noi apparecchiamo [u n a esse [a ltra lin
g u a . cofi potefii dim ofirarvi con qual ordine
[a g ric o ltu ra , la cofmografia, esse [a ltre f acui
tà ; percioche in quefia medefima fabrica po
trò in brevi fiim o tempo , esse con poca fa tica ,
non folamente le p a ro le, m a ancho le cofe infie
me allogare ; esse cosa rendere una imagine d i
quel vincolo della JàpienZa , esse eloquenza d a
Socrate a g ran torto difciolto, onde la filando
bora d d irv i un'altro mio penfiero d'intorno a
quefia op era , qualunque. udendo comporre ,
esse haucndofidamente udito da me lefg n ifica »
rioni
J
^
,4
fio ri de*lu&gfyi, che fono cento fo p ra quel d i
Metrodoro , fui ch'io babbi a un poco a i tem po
d t notare lo Alfabeto , s a d i ciò empire quefia
fabrica , potrà a fuo piacere trovare in ciafcvn# \
due fe lu c , una di cofe, L'altra d ì p aroU ,
A M. A G O S T I N O
ASBIOSO*
O ri canuto lettere da uno g e n til»
Èj
8 Intorno sa cafìellano d i F riuli,rie»’
H g E l B co s a figliuolo al fuo padre f o h t
dquale per ejfere fla to a ltre v o lt# .
fiotto la no/ha d ija p lm a , mentre leggeva laicap
s a per ejfcrmi com padre, & parte de P a n im i
m ia , perciò che il rimanente fi et e noi ; m i pre»
g a flrettam ente che io g li tro vi cafa più vici»
n a , ch'io pOjJlt, a avella in che albergo ; alle»
grondo fi meco di c itilo che ha ottenuto dal pa
dre di poter venire , onde andandomi p e r la
memoria le pa ro le, che mi dicefte di uoler cafa \
d a g e r u o t, hommi o u ifa to , che farebbe ben *‘
fa tto vin te le due parti deipari ma m ia . cioè ds
riporle amendue f it to un medefimo setto ; ac
cio che venendo io talhora a vedere P u r a , non
la troui dalPaltra d tu ifa . fe voi mi am ate 3d i/pon etevi ad incominciare am ar cofhti : perche
m aggior piacere fare non m i p o tr e te , che effer
contento di batterlo caro nella v a fr a compa
gnia , in qualunque modo in Bologna alberga
to v i tro verete. ilgiotutne g e n til incorno , olert
che m obo la uofira buona natura m i rappre-'
f e n ta , è tutto gentile in fittevi e canti , s a ne! *
comporre noti f ilo la m uflca, ma latino esse uolg a re , sol che non [offe nella u ia , tnche tutto il
mondo ua cieco : in fumma è tale che degno lo
ripu tai di batterlo per uno diflu ta to r e nel nofiro Platonico T en%onero a Dio . D i Bologna ,
alle x J 11 L d i Agofto.
M. D . X XL
A
M. P I E T R O
ARETINO;
K IL infinite pruoue ha conofetu
lo Molto Magnifico.fiaitlloyildno efjere il nofiro contraffar co*
d eh ; quando, àgriffa di nim ici congiurati, a l contrario delle
nofire v o g h e g ira n o . Che non ho fa tto io per
tener fermamente uolta la m ia navicella contra
alle f i r \ e delle tempeflafe o n d e, che contra fe m pre nettatele fin o ? esse nondimeno vìnto fin co»
f r e t t o a d a ffetta r la bonaccia, veduta g ià d a l
la ffe ra n za m ia d i vicino : essefcnon , che io m i
riparo in un tranquillo fieno per racconciate le firn,
te tu tte , e s s e per rifanar 4’un poco d i feb re i
verrei cofi bagnato esse m al tra tta to dalla fortu
na , al ditti» Coffetto di V .S . laqual quanto io .
am i esse ojferui, ungiam o le. fa r à palefe quella
m a n o , che con la fu a compagnia fi flende uerfi
la dolcifìim a, esse [ietofifiim a natura fua : pre
g a n d o ti a tenerm i nella fua buona g r a tta , esse.
nella defidcrata racconciliatìone con tunico M
T itiano .percioche ho più de fiderio d i f a r v e •
dere a l mondo , ch'io intendo dare alla Fortu
n a ogni volta , ch'io le po/fi effere fnperiore,per
S E M P L I C I .
j op
battermi vietato il poter fa re il debito m io g tiìt
non ho dt viver lungamente. . p e l l e t t o .4,
A L S. A N T O N I O
C O N T I
D I
ALT A NO
DB*
$ A L V A R O L O ,
ginocchio : prego adunque V. S, s a quella d d
Signor Cornelio Frangipan da Castello : a l i quali in quejìa mut infirm ita v o g lio , che quejfia fia commune : che non habbiano a m a le , f e
d a l mio ritorno in Italia non hanno m a i rice»
fiuto mie lettere yimperoche s a le g ra v e zze d elfi
le imprefie, s a Li mala diffrofition del corpo mi;
fono s ia te fem pre d'impedimento , s a poi (p er
ueìo dire ) debilifiime giudico quelle am i/là T
clic hanno bifogno dt effer puntellate dalla fo r za ,
delle le tte re . Pompeo m i ha prima fc r k to 3s a
poi detto conia lingua delle difiefe, che V . S« h a %
fa tto per me .♦io la ringratio ben del fv o buonoanim o, s a della imprefa prefaper Thcnor mio v
Ma , s a g /i aver f ir n , s a V. S. conofcendo la
maniera de*miei Tivdi , quali ejsifi fo n o .:,a m ?
bedue le parti vanamente s a contram e , s a in.
mio favore argomentano, V . S. adunque con.
più piacevole animo Cappotti la m alignità d i,
q u elli, che m i vorrebbono lacerare ; che li lor&
fnorfi ne anseranno n a n i, oso quando m i parta dì f a r loro romper li d e n ti, non m i mancatto
d i quelli, che ad un cenno lo faranno. Ma rin
gratto D i o , che non m i ha dato fi vendicai tua
tin tu ra , prego ancora V .S .c h e , tjuawib m i
frouerocon lei non entri in quefli ragionamen
t i . ClyriJ}o dia k ro la diritta mente., oso a V .
5 . tutto quello che defidtrano * D i Bologna
esili. X X d i Sett. del x x x I L '
A L
M E D E S I M O .
I ! N d o io r ifo n d e r a V . S.
fa pertinente al cavallo d i M.
ìd ic l nofiro Braceie tto , ho ìn te , che egli è 7
iato mandato g ià a .
F errara : i l perche V S. è libera d i quefia
amorevole p e fo . Io fero tofio a P a d o tta , oso co
f i con la venuta m ia fatisfarò a l de fiderio m io :
ilquale non è m inor di quel d i V. S. d i vederci, .
oso teneramente abbracciarci avanti al p a rtir
nofiro„ Ìlqu al g ià e vicino yfe Dio non ci man
da m aggior impedimento . R ingratio V S.
d el fu o buon animo d'intorno a l fa tto d i Me.
Georgio t Ìlqual inuero, non hauerei m ai collota to appreffo a ltr u i, fe prima i o non bauefli
intefo il piacer fuo . Con quefio tifeio V . S.
con molte m ie , .oso humili raccom andationi.
D i Vitretta atti 19. dt Cenaro . I y j j.
A L S. B E R N A R D I N O JF RAT INoso
} A c v e A ho intefo alcune eia * j c e , che fono Siate f c r itte , esse a t I taccate a P; laseri ; lequalt erane se^ _ j g r ifi catrici d i uiolativn detta no\ sera arniona . Deh Signore M. Bernardino,poi
che non è pofithile a m etter fieno a lesfien a te
lingue, che h M td m o noi a fa r .a ltr o , che a do
lerci della loro mala n a tu ra , esse a d attender a
conferuar inuiolahile l'amor nofiro ? lo non peri
fio ad A tro , che a poter un giorno m vfirar a V .
5. quanto io l'a m i, esse o ffe rti. Mi fcriue an
cor Pompjlio di alcune altre cofe r ib A d e , esse
tace quella, che Cuca m i ha detto . Io ogni mo
.do debberò prima ch'io uada più a u a n ìL tl uiag
g io m io , di fa r ritorno alla p a triay esse mofirar
ad alcuno, che a torto m i f a ingiuria!-. Tn que
fio meZo V . S. f iia fana # esse doso? ricordevole
c o y g li Mag. fu c tfra te lli, esse a m ic i. E r degni
- a nuo nome fa lu ta r la g en tile fua, Sig.V io. E t
il mio Mag. Signore Q u in to . D i cui g ià A q u a n tig io rrijo b e l l i una amorevole letterina;
esse ne rw gratio , che le piaccia ricordar fi d i m e .
Cesare piglierà la corona di ferro il d ì della C a tedra di San Pietro , (Er otti. 14, riceverà quel
la d 'oro, essefera il giorno detta fu a n a tiv ità 9
essegiorno della vittoria contra Francia. V uoi
m i , che V. S. non f i tro vi a tanta fefia . c h i
quanhmque Bologna fia piena d i C o r ti, esse d ì
P rin cipi, nondimeno tv haurei lan u to una ca-
mera per V . 5. alUquale m i raccomando, s a a
Maestro A d ria n o. D i Bologna adì . iti. di. Feh. '
«j-jo. Degvii ancor salutarlo Eccellente M ac(h o mio C om padre.
<
Se in quefio m e\o tieni(fi alle morii d i V . 5.
im buon s a bel cavallo , d i g ra tia lo fo g li, s a ^
tenga appreffo di fe per fino alla venuta A i T hef i o , che ferri vici/ u .
lo b o acconcio P empiito p e r Camerero d el
Cardenal di Ravenna S. D ot tifi imo , s a ricc h tftm o .
J O l T O I d a f re Signora, s a Si I gnor a m ia offertiand t f i m a . Per
j bauermi atti giorni paff'ati già due
fiate fo c a to un medefimo p ie d e , et
■per ta l cagione fla to molto male ; io non ho po
tuto fe r i uer a m /fra lllujhe Signoria, laqital
fo la con ttetto loJfrirìto am o , s a honoro :,aif:or
chefom pre Lt imagine di leifia d a g li occhi del
l'animo mio v e d u ta . m a perche con gra n comp afiu n eta lh o r l>o conofciuto perfona; che più
m offra d'am ar con la lingua, o con la ferittura;
che neramente non fa col cuore, s a io temendo,
f e t o d m o r a f i molto nel fa r pale fi le p a fio n i
m ie a V . S. cì/io n o n fu fi ricevuto dal fuo g iu
ritelo per tale ; le terrò chiufe nel petto : perch'io
uogbo più toflo languir nel mìo Jecreto ; che dar
tm minimo [affretto d ifltlio n e a quella lllu fìriffom a 3s a divina D onna, laquale io ho colloca»
p s
*
#
fa
to n e lla c im a d e lla m /a m e n t e .
A d u n q u e p o i''
ch e è p ia c iu to a ch i l'h a p o tu to f a r e , d i f a r l'a
!
n im o m io ( o g g e tto a u o fir a lllu fir e S ig n o r ia ;p o r
t e r ò l e r a d i c a # l tr o n c o
r o fo ,
o so
V
i
^
V . s . o so
\a n e i f i o f r ,
che
ro
non
, o so t
r a m i d e l m io a m o
{ o lc if iim o p e fo d e n tr o d e l c u o r e ,
o so f r u t t i ,
oso
a l m o n d o I n f i le r ò u e d e r
ch e n e v e r r a n n o .
E t
per *
v o r r e i , ch e o g n i le g g ie r b r in a p e r la lo »
<i
d e b i l e l / # p o te f f c o f f e m e r i p a r ti d e l d e tto fi]
i
a lb e r o
; io
i
h ta a
p e r p e tu o h o n o r e d e lla i m m o r ta i g l o r i a
j è m p r e u o p e iìfa n d o a lla lo r o d u r a b i- .
d e ll'a lt e f fia . u o f ir a ,
.
in e te rn o te (lim o n io
o so
d e lle a r d e n ù f iim e f i a m m e m i e , n a te d a l p i ù b e l
10 y
oso
d a l p iù g e n t i l f u o c o , ch e m a i a cc e n d e ffe
11 p i ù a m o r o f o f i g l i u o l o d i
Ve n e r c .
M a p r im a »
V
c h ’i o l a f c i v e d e r e a u o f i r a l l l u f i r e S ig n o r i a a l c u
n e d e l l e m i e c o m p o f i t i o n i d ' i n t o r n o a g l i h o ti o r y
f
fu o i
;
.
ho d e lib e r a to d i m a n d a r a v a n ti tif if x f à * fi
n i e n t i d i q u e l l e : a c c io c h e o g n ’h o r c h e l e u e r r a n * *
n o l e t t e d e l l e f a t i c ìie m i e i n l a u d e f u d [ f i t r o v i
p iù a p p a r e c c h ia ta a d i n t e n d e r l e : ch e in v e r o
o g n i p o e m a a t l 'h o r è p i ù c a r o a c h i i o l e g g e
;
m e n tr e f i h ro u a h a u e r a jfa g g ia to d e l f iig g e tto
;
E t
p e r i n c o m in c ia r d i t o , c h e v e d e n d o i o , c h e
q u a n t u n q u e m o l t i fi. f i a n o i m p a c c i a t i p e r f i n o a
q u i d i lo d a r il n o m e
d i
L
v
c
r e
t i
A ;
non
d im e n o a n c o r n o n h o tr o u a to f c r i t t o r , ch e f i f a p
p i a p a r t i r d a l l a a litif io n e f i u t a a l l a R o m à n a f
ch e co l f e r r o a p r ì il fu o
p e tto .
T
e n fio
,
d ifd e g n o fé
oso
u tt i c o rro n o * a d a f itm ig lia r c ta fc im a
ch e h a b b ia il d e tto
n ó m e , a q u e lla
q u e l g r a t io f o n o m e f u jjè T i e r i l e ,
oso
:
,
c o fi c o m e f
non f i m g '
*-
oso*
Ai multe lette cofe. La/cianJo io adunque d i
f r efo tte di raccertar quelle lo d i, che fono fi prò
prie di uofira Signoria zebe A tra non u b a par
t e , esse lafciando la nobilita , esse-jfteste altre do
t i del corpo , d e tt anim o, & della f o t u n a , lefjtèàlifoglio talhor te/Jrr'col f i o d à ìfiieì uerftQ
esse*lequ ah fono in ogni modo f u e , àftSPFfoatiA o ella tcnefjè altro nome ; vengo pur ad effo nom e per m o fra r quel che fu o ri delti f o r i t i fù o i
ho fofp/ntc in luce . So che uofira Signoria fa
chel\fu o prettofo nome m i primo fuono fu o f i grafica guadagno preffo a g li orecchi de latini.
È t Platone in quel dialogo intitolato H ip par co
diftu ta n d o molto del guadagno y & d i co lu i,
(h e del guadagno è bratnofo , poi thè tre definìtio m del guadagno diedefecondo la openione d i
alcuni apparenti fi lofofi ; mefje in luce la fu a ,
effe è u e r a . Delle quali la prim a falsar era d i
alcuni antichi d ic e n ti, che coluifoffe d ifid ero f
d i guadagno,U quale haneffe nettammo d i gua
dagnar in cofa non degne di Si im a : L a filan da
a r a , che il bramo fo d i guadagno fu fi e colui, ilq u a l per le tifiti tubile appetito tu tte le cofe, an
àcer le m in u te, esse t i l t marauigito fornente bra
m a f ] e , esse in quelle medefime cercaffe il g n a Augno : La terZ ji difintttone diede per la ope
nione dà quelli, che tenevano efjer honorata cof a , in q u itti cofe cercar guadagno nelle quali
g i t I)uomini cThonor non fareblono ardiri d i f a r
g u a d a g n o . Dalle d ette tre definitioni, non
m olto d iffere n ti, nostra lllufire Signorìa comf r e t t i er può in quanto errore erano foe* Fil o f f i
a m ic h i#
%
s
j
Jj
,
j
Jj
1
[
j
1
............................................
anticir i , ìqualì ntofii fila m e n ti da quefio ne»
me guadagn o, f i davano a creder, che fojfe
cofa m alvagia & non honoreuole. i l perche
Fiatone iiuluce Socrate, dannante le predette
fa ìfifim e ^ e fn o n i: dar que f i a nera definitio
ne } c!)e'lguadagno fu fife ogni pojjcfiione di he
^ifcTfrfmwdi s lim a , laqual alcun pojj'a acqui•
IL
[
\
r
*
* lar o con nejfuna fu a fise fa ,.c con tale Jpefit,
cIk g li rendefj'e.fru ito maggior della Jpefit.
A du n qu e, unico fojlegno de g li /p ir iti m iei ,
£*** Potfte dalle predette effe conofcer, che!
uoflro honoreuolifiimo nom e, nelqual Pinchi»de il guadagno, tiene nel Jùo hit riti ficco cofa aro
ticlrifiim a, s a piena di laude per teftm onio. d i
Socrate, s a d i Plafone : i quali fi lontanano dal
m lg o de Filofio/anti, cheV nome del guadagno
tiene a v i l e . F enfo, che uojìra nobilifirna S ignoria ancor nella uera definitiori di Fiatone
troui nella nifia alcun fojpctto di m a le , per
quelle parole ferina fpefa : ma certo, f e l t r a ria/fio della per egri) uiti cn con quefia Corte mi
desse alcuno (patio da refi?ir or ; io fa r et veder
a uojìra lllujbre Signoria la d etta definitione
effer hcncfiifitma, s a tanto uera; quant o io fon
Juo uero f e r u ito r e c h e nefjùna cofa in que fio
mondo è più uera » Et f e pur uojìra Signoria
hauejfe alcuna ombra dt j'ofpetto ; io la prego
per ta fua n o b iltà , per la Jua grandeZg^i, per
le fue incomparabili v ir t ù , degiù fivrfi m etter
tlattanti Puipparco di Fiatone, s a conofiere col
fuo c a n d id ifim o , s a al ti fim o giudicio qutild
u cn ta , ch’io d i fidero le f ia p alefc. s a tanto
a
ri
3*4
#
.
fa
dico per paffar ad altra m a te r ia , ancor che il
:
Tetrarca da alcuna non fi lontana)]e quando
1
disse, Et danno fiogua d a g n o , oso a tti dann o.
m a io m irife rb o a aprire fe c o n d o il pcttfiero
m io, al mio v e n ir , la interpretation ì/fel detto
uerfo , oso di altri filmili, aiiXì. d e g lu titi fa i fi ^
d i Vintone : atti quali c o lu i, che gitrgm rfpuo
affai in quefia tu ta conoficer del detto honoreu»
le gu ad a g n o. del qual uogfio , che per me ta n
to fia detto al prefente : per die /fiero tofio con
la prefentia fa r piane molte cofe, d'intorno le
gnali per cofi brieui le tte re , oso piene d i quel
r ifle tto , che m i fi contitene 7 ne pojfo, ne deb
bo , Varò adunque punto qui alla lignificati ori
del gu adagn o, ben pregando la incomparabi
le uoftra cortefia , che del guadagno , che m i
par hauer fa tto detta infinita Immanità di uo
f ir a 1
Uufire Signoria, degni confermarmi ■ogni
C\ l
parte in te g r a . che cofi come neffuna. altra Don
ua Riamai più potrà dir , ch'io per lei fif lir i ;
cofi cuor non f i troui tra g li huom ini, fìiò ià
che'l mìo,che vantare neramente fi poffa di ha
uer guadagnato dal uoffro q u e l, ch'io penfo d i
hauer acqui/iato non per miei m eriti; ma per la
g e n tile z za del nobilifim o animo di u offra Si
gnoria , molto più lllufire oso (filendente ; che
*-raggi fiolari non fo n o . H or pajfitndo ad al*,
tra maniera di fa r partorir al pieno nome d i
nofira lllufire Signoria cofe, che per auentura
fiatino anco naffcoje ; d ico , che nell'antica prò»,
fietica Theologia erano fe tte modi d i theologi%are : de' quali l'uno era citiam ato S i r . y-v.t
ilqual
Y _
■ l l S"/
il qual f i fa ceva per m utatione a i lettere da le
co: per laqual (i levavano fenfi a lti f i m i ,
E t per darne a fa g g io all'alteZya -dei f u - ^
bltrm àngegno uojìro ; dalla prim a
[[parola del G encfi,iaqual da
\
gli interpreti è detta.
I N P R IN C I
r "
PIO,Che
'
'
• nel
ososi
# L e b r a ic a u fo tà fi B E ». e s J t , f i t t o * *'
intelletti f a l d a t i dallo s a i* ** *
' rito Santo fiu a te per tratta
fm u ta tio n d L lettere»
i
1
y $ tù k M
fr itte
•> A
é
;
i ;
marfimgUofi 'firn*.*
le n tìe . 4
■■■&&&*#***<•’
|
'
oso. oso, !'
.. t
oso.
¥
si
_
/
si
i
;
i
r»
,
&
si
3
fi
oso
4 .,,
> J l7
mutando 'ii P in f» il che è molto ufate appre/Jò
gli H e b r e i. Adunque d a quelle fole lettereyehe
fono la prim^Lparola delta Bibita ,-che appreffo
g li F lebr/fe Berefit , interpretata in principiot
.
t effettate per S tr u f quefie fenterCfe , il
P À lf a r t s
N É L F . t G L I V O L . O , :JPJLIN
C I P I 0 , ; E r' ÌPÌ rtl E ’HOl C R £ A T Ó ,
C A P; O , • V t * f* r O C n o so E T ,1;I,
f A N D A M E N T O ,
H VO M O > CON
1> E, n G IL. A N D Sì
PATTO
BVOK-O »
O S ignora lltufire / 0 luce de g l i occhi dell’ani»
mo mio i non ùede uofira lìltifire Signoria > ì
miracoli che .f a r può tu n a delle fe tte maniere
della Theologiaantica ? non vede quante fin »
tenti e poffpnojpcr rinolgimcntcnto di lei t e r /
effer leuate da una fola parola ? ne ciò creda:uà
Tira Signoria effer trovato humano ; m a d ittioso
no., im per oche D auid in fp irito conobbe, wr
perfona del figliuolo di D io r che nella parola
cm Tbro della fa n ta fferittu ra fi faceam ention
dt effo f ig lim i d i D io, f i come di fopra babbi a
mo ueduto 9il perclre dtffè , I N C A P I T A
&
c
L i b r i
r i jp t y "M e s t
D s
mjr#
Ma perche mio propofito non è di aprir è
dutini mi fie ri ; tanto uoglio hauer
detto per fa r fin tir e a uofira
Vlufire Signoria 3
che; , se
per la medefi»
? ' f f
m a v ia
:•
. .
•
dot
fi ^
u o s o fi^
diurno fuo nome ho levato
Jottofcrittefiententie.
oso
I
-oso
V,
O niJ'se"
T)att'intentione dette quali lettere d'el nenie d i
L v c x E T I A , fr come appar per la d etta
dimufiraij/one , pojjono efj'er levate tu tte quefle
( I n t e n t i L a c A R A , r. 7 c b , C R E A ,
R A R
CERTA,
R J T., E ,
AITA,
C 7R A ,
A R T E,
i RATA
- c i L A C E R A , - V a lte z z a dunque uofira
V s e riguarderà u n d fn u m c n [òpraferittìalle lei
tfte dei [no nome ; cono[cera effer nero quel
ch'io dicQ:ne nego che multe altre co fe per auen
tura m n putejjcro dalle mede fin e lettere effer
■ colte : ma per fino a qui non mi ho fermio nel
le cotKpufiùoni mie fe non d t quejie : Lequati
compofitioni quando aereranno a g li occhi, oue
ro a g li orecchi d i uofira lllufire Signoria none
le .faranno molto lontane dedi'intélletto yf in ta r
do far mentione dt Guadagno , di Gara. d.i Ksz
ce , di C re a , d i R a ra , d i C e r ta , d i A ita , d i
Cura , d i A tra , dt R e te ,. dt A rte *, m a non ticiddio pero , che ne cura atra ,.ne le ultime
parole che fono, Irata ci lacera, babbi ano m ai
luogo ne in Va. 5. ne in m e y ne nettiferriti m iei.
H a g ià potuto ned. e re , oso concficer la nobiltà
del?ingegno uofiro , che ftn zA fa r attnjioncy f
oso accennam elo alla Romana L u cretia, il no r
me fino può partorir molte cofe , ìequali m i fo
no oso faranno m ateria nelle compufitioni m ie,
dette quali-al prefente io non mando*, alcuna*? .
[perandò di efjerne io medefimo in Imcue Vapr
portatore. Ne a V.. S. paia tanto uno un là v ia ,
ch'io tengo : imperoche ancor appreffu i Greci'
L itofono f u molto lodato del fafieficon lttùd&
;
-s i
oso s e - ' s i * s i* o s o * •
Ai chi piaceva à lui, f r u i r fi dette le tte re del n i
mie : .esse per g /a tia di efem pi ordirò d i q u el mo *
do che usò in m i er lodar la m ogli edf-Tolotneo^
chehauea nome ccpatvoni c h e f nona c fa a tio n d i
si-oso
piente, efio col helloforteto fio lrafir\ìtandole
le tte re in quefio modo la fece d m e n fa o r /ff d a f
A* Cignone * ■
.
:
- s i
£
CT
. Mi*%
dar -, i l .‘.Tip- ' CC
t
s i s i
Y
*
*1
!
o s o s io s o ’
é
"'H-oso*
si .-.L.-rv >jta* *-f*i ,/f
'
«<•
CT-' ■
■/• • :
' * si*
oso'"'
sVv.-
■•fcìWv .• \ v vsi> ;•
<’> <
ik; *, . .,,^ -, ‘V.i.• £? A?; V, 4l» i C f c A
?***’.
ir.si L ochiam o adunque u p a r ti# , d i una parola
facendo d u e , leq u d h fig m fo rn o M ivlà d i Ginn on e. Et benché quefia uia. d ì Ucofione f ia
bella ? nondimeno quella dellantica hcjjratcrt.
theologiae marauigliofa: esse tanto m aggfcrA
m e n te , quanto è comprobata; d a g li oracoli de*
P ro fe ti, Ma perche m i uo io dintorno a f i p n
fon de cofe auoghendo ? certo lllufire Signora
per dar cibo: contieneuole Ala profondità del uo
Siro A tifiim o ingegno : a l qual m i duol d i non
poter giungere# perche fo r e re i,s 'io g iu g n e fifi
Ai m e rita r ancor più caro Imco nel cuor fuo**Y ìtfruche più d/ro to ? Viro certo quefio >mol
•t 'o lUufire-Signoray esse unico fjìe g n o della men
l e inut; cherfondo io giunto a quefio luogo ; m i
f u p orta ta una lettera d i uofira Signoria-: la
A io h e lé c agrande miracolo# che fcrium »
*,
\
,
#
■\
doto A lei y in quel mede finto tempo r k e ti'f ò ;
delle fu e hum anfiim e lettere.: t i gnali mi*.min
no dato maggiore f l i n t o alia compof tio n ic h e
non hanno tfagto ,tutte le p redette inventioni [ l
Deh perche fleffe ttohe non fon io tn f la to , an
Zi fottecitato dalle dolcifiim e, oso. co rte/fiim e
lettele d ì uoftra Signoria? perche la corte/è
bontà fua tal!>or conia fa p ie n tifin ta fu a m n r
^ e , oso con l i delicatifiim a fu a mano non m o Lira di tener memoria del perpetuo f im o suo?
Ma facendo ritorno a quella , che bora Ito d e t
to , oso ritta grm i cortejìa, che in quella m i rne^
Thra \dico ch'io ricetto coti fatto il cuore la libe
rale offerta, che Vofira Iflufre S ign oria, ha
degnato fa r m i , oso è ben ragione f i 'Camma
mia ha dato eterno albergo alla im agine., oso
atta maggior parte di V. S. che V . S. alberghi
con la cajà fu a , & fe m e d e f m a oso coiài, che
la tiene caramente dentro d i l u i . ben prego V «
.1ttufi. 5* che non mofiri quefia le tte ra # p e rfi% d y fo t perch'io l'ho fa tta certo di- cuore, oso
fe n za cerimonie > Io non u fo con perfine ama*
te ,.oso cito t r i ttmtnOf, parole di' oficane, ne :»
alcuna maniera eìaganti Tchea mc~bafia <&
firm e r fim pheem ente, oso in quei medefim o
m otto, clTio p a rlo , in fin im a To attendo pìif~
àUè cofe ctiio tfógtto d ir e , cito atte parole orna -
ir
a e fucile com pefit i otri [ c h e fioro per effer u e d u T
te d a g li occhi d id a tti , osoche defiaèrano au*T
'rar lungamente lìdie m a n i, oso nella m em oria,
d e 'L e tto ri* Frego ancor sioso rifrego Immiti
sen.
\toiente V . ìthtfì. S. degni darm i rifoofla fulrito
. chehaucrà letta quefìa lettera ; la qual, nfpofa.
certo nn dara cagione d i venir toflo alla divina
prejentta fu a , laqual prego il futJSor Dio lun'g a m e n u confer ut s a fana > s a di r-’je ricorde
v o le > s a la qual giorno Cflnottc è. dauantjgilla
unente m ia . Supplico arfgor, che vegga uolett<ticrSebafilano mio fcd el fe r u ito r , col qual no
.Tira JllufIre Signoria può parlar UberamenJjfèf
s a a lm dar la nfoojìa : laqual io piti defilerò,
.che altra più felice cofa, che in qtteflo mondo
tn i potejfe au en ire. A Dio lllufìre , un ica, s a
sol degna d ’ogni honore : alla cortefe Immanità
téli cui tu tto bumile s a riverente m i raccoman
d o . D i Rouano in F ra n cia .olli V .d i MaegM. D„ X X X V ,
- Tdlumilm ente f ila to la di ulna S ig n o ra fiflneura fa a compagna E farà U fu a to un cd*
ual mio dall’apportat or d i quejìa per fin o alla
ven uta m i a , lo raccomando . D a poi fc r itta ,
penfo mandar que f a lettera per un dolcif i m o
amico che uà per le poftem
•I %>
V ì
N
E
* VA' R e
Tutti fono
D E F G H I
,
i, eccetto 0
eflrn
S
chej Terno, .,
Scarica