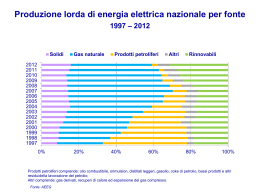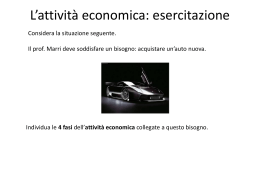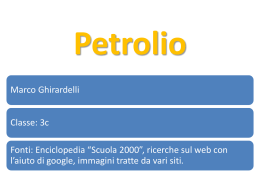Domenica l’attualità Quel che resta dei vecchi bar La di DOMENICA 26 LUGLIO 2009 SIEGMUND GINZBERG cultura Repubblica Gli eterni ragazzi del Club Salgari ERNESTO FERRERO e MASSIMO NOVELLI Il Secolo del petrolio Centocinquant’anni fa a Titusville, Pennsylvania FOTO ©SEBASTIAO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO fu aperto il primo pozzo del carburante che ha mosso il Novecento VITTORIO ZUCCONI T TITUSVILLE (Pennsylvania) utto quello che resta del fiotto che allagò la Terra è un’ampollina di liquido scuro, esposta ai fedeli dietro una vetrina, come la reliquia di un santo. «Petrolio», mi addita senza toccare l’ampolla la signora Zolli, direttrice e sacerdotessa di questo tempio-museo costruito fra le quiete colline della Pennsylvania, accanto a un bosco di larici e di cervi, esattamente sopra il terreno dal quale, il 27 agosto del 1859, un avventuriero che si faceva chiamare «colonnello» fece sgorgare il greggio dalla terra perforata. E lanciò, senza neppure rendersene conto, quella rivoluzione e quella industria che oggi muovono il pianeta Terra e che lo stanno asfissiando. Se nell’Inghilterra del carbone e del vapore cominciò la rivoluzione industriale, fu da qui, dalla terra che un tempo apparteneva alle sei nazioni degli Irochesi che raccoglievano col cucchiaino il «succo delle rocce» in superficie per usarlo come medicinale, che si avviò quella carovana di barili, oleodotti, petroliere, raffinerie, stazioni di servizio, catene di montaggio e armi che raggiungono sei miliardi di esseri umani, poveri o ricchi, ovunque un sacchetto di plastica arrivi. (segue nelle pagine successive) MAURIZIO RICCI spettacoli L’ Eduardo e Peppino oltre la lite ossessione del mondo per il petrolio non è irragionevole. Al contrario, è assolutamente ragionevole: niente contiene così tanto in così poco. Un solo litro di benzina vale 9 kilowattore di energia, il 30 per cento in più di un litro (per dire) di bioetanolo. Non c’è da stupirsene: quel litro di benzina è figlio di 25 tonnellate di antiche piante, lasciate a cuocere nel sottosuolo per decine di milioni di anni, fino a diventare petrolio. L’uomo, per ora, non è in grado di replicare un simile concentrato di energia, prontamente usabile e trasportabile. Peraltro, ci vorranno oltre quarant’anni, dalla prima trivellazione del colonnello Drake, perché il mondo si renda conto della portata rivoluzionaria di quella scoperta. Alla fine dell’Ottocento, il petrolio, oltre che per le ultime lampade pre-Edison, veniva usato sempre più per le prime automobili, ma in concorrenza con un ventaglio di altri carburanti. All’Expo di Parigi del 1900, Rudolf Diesel esibì, con orgoglio, il primo motore, appunto, diesel. Che funzionava, però, a noccioline: il carburante era olio di arachidi. In quel momento, in tutti gli Stati Uniti, c’erano complessivamente quindicimila automobili. (segue nelle pagine successive) LUIGI DE FILIPPO, RODOLFO DI GIAMMARCO e ALESSANDRA ROTA i sapori Cucina creola, tentazione agrodolce LICIA GRANELLO e ANTONIO SKÁRMETA le tendenze I robot di casa docili e inquietanti PINO CORRIAS e JAIME D’ALESSANDRO l’incontro Dennis Hopper, ribelle di successo ARIANNA FINOS Repubblica Nazionale 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Secolo del petrolio DOMENICA 26 LUGLIO 2009 Era il 27 agosto 1859 quando la rudimentale trivella di Edwin Drake, un avventuriero che si faceva chiamare “colonnello”, fece sgorgare in Pennsylvania un fiotto del carburante che avrebbe cambiato la Storia Siamo tornati in quel paese sperduto tra i monti Appalachiani per vedere cosa resta della “rivoluzione nera” che, dopo centocinquant’anni, sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva Titusville, la città-fantasma che inventò l’oro nero VITTORIO ZUCCONI (segue dalla copertina) ppure luogo meno trionfale, meno pomposo, più timido, con la scontrosità della Pennsylvania che Michael Cimino raccontò nel suo Cacciatore, potrebbe essere immaginato di questa languida cittadina di seimilaquattrocento abitanti, molti dei quali studenti in un campus della Università di Pittsburgh. Un villaggio qualsiasi, nel «grande ovunque americano», che sta nascosto tra le infinite valli degli antichissimi monti Appalachiani, la spina di roccia logorata dalle ere geologiche fra l’Alabama e Terranova. Ironicamente, per il Paese che inventò l’industria del petrolio, nessuna autostrada lo raggiunge, nessun viandante lo attraversa se non smarrisce la strada, e rari turisti transitano avanti e indietro lungo una Main Street rimasta intrappolata nel tempo, dove non ti sorprenderebbe vedere Superman bambino sulla Ford Modello T del padre. Soltanto perché io sono l’unico passeggero, e visibilmente adulto, sul finto tranvaino turistico che offre per cinque dollari il giro della città, la guida mi addita, con pudore, un palazzetto di mattoni rossi a tre piani che negli anni della “corsa al petrolio” era il più vivace e frequentato bordello della contea. E oggi ospita, per pura coincidenza, un negozio di abiti da sposa che quelle povere ragazze di fine Ottocento costrette ad amplessi fetidi con i trapanatori del petrolio avrebbero sognato invano. Tutto quello che rimane del fiotto che sgorgò dal campo dove ora sorge il museo è appena abbastanza greggio per alimentare la riproduzione (autentica, come si dice qui) della prima trivella del finto colonnello Edwin Drake, un secolo e mezzo fa, e per mostrare ai visitatori delle scuole come funziona l’estrazione del petrolio che non c’è più. Se Titusville, battezzata con il nome del fondatore, non è diventata una città fantasma come le città minerarie del Colorado, del Klondike, della California quando le vene aurifere si esaurirono, è per il campus universitario e per la presenza di una fabbrica di plastica, alimentata con il petrolio importato dall’Arabia Saudita. Due motel a una stellina, l’immancabile grande magazzino di ciarpame made in Cina, il Wal Mart, quattro saloon e una dozzina di ristoranti alla svelta sono tutto quello che rimane di una scoperta che avrebbe prodotto, centocinquanta anni più tardi, una ricchezza mondiale da milletrecento miliardi di dollari annui per le nazioni produttrici di petrolio. E che qui, nella terra spompata, è un ricordo. Il petrolio greggio, per chi non lo avesse mai visto da vicino, è una cosa che fa schifo, come è ovvio che sia un distillato di putrefazioni organiche millenarie. Ma qui non si avverte più nell’aria quell’odore di corruzione sulfurea che mi rimase per sempre nelle narici dai giorni della Prima guerra del Golfo, quando Saddam Hussein nel febbraio del 1991 allagò il Kuwait per la rabbia di averlo perduto. Sono ormai solo i nomi dei paesi e dei luoghi che si attraversano nel labirinto degli Appalachiani per raggiungere Titusville da Pittsburgh che ricordano che cosa esplose qui, nomi come Oil City, Pithole (il buco del pozzo, oggi villaggio fantasma) e Oil Creek, il torrente del petrolio, nel quale ancora affiorano striature luminescenti di greggio. Alla metà del- l’Ottocento, quando arrivò il “colonnello” Drake, che si era attribuito il grado fasullo, il fetore di petrolio era pungente. Furono quell’odore, la tradizione dei nativi che lo scucchiaiavano dalle pozzanghere e il traffico dei pochi barilotti usati per accendere i lumi a petrolio ad attirare il “colonnello” e a spingerlo a chiedere i diritti di esplorazione al proprietario dei terreni, che neppure immaginava di essere seduto sopra il futuro del mondo. Drake arrivò a Titusville quando il paese era un grumo di casette di legno attorno a un “trading post”, un emporio per il commercio con gli indiani della vicina valle dell’Ohio, con una borsa di pelle, un cambio di mutandoni, duemila dollari in contanti ottenuti da finanziatori di Wall Street e lo spazzolino da denti con le setoline logore che la badessa del tempio, la signora Zolli, figlia di generazioni di immigrati italiani piovuti sulla Pennsylvania, mi mostra compiaciuta. Ai geologi, come agli abitanti originali degli Appalachiani, la presenza di FOTO ©SEBASTIAO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO FOTO ©SEBASTIAO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO FOTO ©SEBASTIAO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO E petrolio nel sottosuolo era evidente, e la nafta, da esso derivata, era conosciuta all’umanità da secoli, probabilmente parte della inestinguibile miscela infernale che le navi di Bisanzio lanciavano sulle flotte nemiche, il fuoco greco. Ma quando, dopo ripetuti fori nella terra, e debiti per rifinanziare la ricerca, il primo “gusher”, il primo fiotto uscì dal praticello fangoso, la sua intuizione non fu la materia oleosa succhiata ai sedimenti lasciati dall’oceano tiepido che aveva inondato questa valle per milioni di anni. Fu nella visione della domanda insaziabile che il mondo avrebbe sviluppato per quella schifezza maleolente e fino ad allora quasi inutile, perché il petrolio in quel 1859 era una soluzione alla ricerca di un problema. Un carburante senza un motore. Mancavano ancora diciassette anni alla messa a punto del primo motore a quattro tempi e a combustione interna, creato da Daimler, Otto e Maybach nella lontanissima Germania. E decenni alla scoperta della superiorità del motore diesel sulle caldaie a carbone per le navi da battaglia, insaziabili divoratrici di nafta. Ma qualcun altro, anche meglio del finto colonnello, aveva capito quale inimmaginabile ricchezza la sua trivella in Pennsylvania aveva stappato. Il suo nome era John D. Rockefeller, piccolo commerciante di Cleveland, che dieci anni dopo la scoperta del giacimento nel cuore dei monti della Pennsylvania già si era impadronito del controllo dell’ottanta per cento di tutte le raffinerie della regione, necessarie per trasformare il brodo nero in carburanti, con la sua Standard Oil. La reazione a catena che avrebbe travolto l’intero pianeta era partita. In tre anni, le catapecchie di Titusville sarebbero cresciute per ospitare quindicimila persone, il doppio di oggi, diecimila nella vicina Pithole, ventimila a Oil City, con tralicci fitti come oggi i larici e i pioppi che hanno misericordiosamente ricoperto e risanato la terra trasformata in fango dalle ruote dei carri e dagli zoccoli dei cavalli Repubblica Nazionale DOMENICA 26 LUGLIO 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 SEBASTIÃO SALGADO Le foto di queste pagine e della copertina sono state scattate da Sebastião Salgado in Kuwait dopo la fine della Prima guerra del Golfo: i pozzi petroliferi continuano a bruciare e i pompieri giunti da tutto il mondo cercano di estinguere gli incendi Sole, atomo, idrogeno Cosa c’è dopo Big Oil MAURIZIO RICCI (segue dalla copertina) utto cambia, solo pochi mesi dopo: il 10 gennaio 1901, l’ex capitano della marina austriaca Anthony Lucas, esperto di miniere di sale, trova il petrolio sotto la collina di Spindletop, nel Texas orientale. Spindletop non è il primo pozzo. Ma è il primo megapozzo. Fino ad allora, i giacimenti producevano, in media, fra i 300 e i 1000 barili al giorno. Spindletop ne sputa 110mila al giorno. Una eruzione immane: il più grosso problema per Lucas fu capire come contenere quel getto che stava inondando ettari e ettari di terreno. Era la dimostrazione che il petrolio era una fonte d’energia abbondante e facilmente disponibile. Presto, la rivoluzione sarebbe diventata mondiale. Nel 1908, l’Anglo Persian Oil Company (poi Bp) trova in Iran alle pendici dei monti Zagros, un giacimento con riserve per un miliardo e mezzo di barili, cambiando, di colpo, la storia del Medio Oriente. Ma la rivoluzione ancora non è compiuta: gli ingegneri devono aggiustare il giovane motore a scoppio per poter utilizzare la benzina invece di un altro (e più costoso) distillato del petrolio, il kerosene. Solo nel 1919, chiusa la Prima guerra mondiale, nelle 667mila auto in circolazione negli Usa il numero di quelle a benzina supererà quelle a kerosene. E bisognerà aspettare la fine della Seconda guerra mondiale perché il petrolio invada il mondo. A questo punto, infatti, i passaggi chiave, nel romanzo dell’oro nero, sono due. Il primo avviene nei deserti dell’Arabia saudita, dove la Standard Oil (poi insieme alla Texaco) trova un oceano di petrolio. È vicino alla superficie, vicino al mare. Estrarlo costa pochi spiccioli: due dollari a barile. L’energia a prezzi stracciati diventa il volano di un imponente sviluppo economico, che le auto sempre più grandi e potenti simboleggiano ai quattro angoli del mondo industrializzato. Attenzione, però: l’equazione petrolio uguale auto è sbagliata. Solo il 50 per cento dell’oro nero viene bruciato nei trasporti. Guardate questa lista: microchip, telefoni, detersivi per lavapiatti, piatti infrangibili, sci, lenti a contatto, anestetici, carte di credito, ombrelli, dentifrici, valvole cardiache, paracadute e si potrebbe continuare a lungo. Sono tutti derivati del petrolio. Il secondo passaggio chiave è l’invenzione della plastica. Non ci muoviamo solo con il petrolio. Ci nuotiamo dentro: il petrolio è tutto intorno a noi (nel caso delle valvole cardiache, anche dentro). Farne a meno sarà doloroso e difficile. Ce ne siamo resi conto, una prima volta, negli anni Settanta, quando l’embargo dell’Opec (i paesi produttori) lo rese scarso e costoso. E, ancora di più, negli ultimi anni, con il prezzo del barile in ascesa, apparentemente, irrefrenabile. Cosa è successo? Di fatto nessuno nega che sia finita l’era del petrolio facile, abbondante e poco caro. Ma sul perché esistono due interpretazioni. La prima è politica. Il petrolio c’è, e in quantità adeguate, peccato che sia nei posti sbagliati. Nel 1954, con un colpo di Stato, la Bp riuscì a rovesciare la nazionalizzazione del petrolio iraniano, ma, negli anni Ottanta, quando a nazionalizzare furono i sauditi e poi tutti i paesi del Golfo Persico, le multinazionali si ritirarono in buon ordine. Oggi, il grosso del petrolio rimasto nel sottosuolo è di proprietà di compagnie nazionali che, dicono i sostenitori di questa tesi, non investono nella ricerca di nuovi pozzi e hanno di fatto interesse a tenersi stretta, finché dura, questa fonte di ricchezza. La seconda interpretazione è geologica. Qui, la data cruciale non è il 1980 e la nazionalizzazione del petrolio saudita, ma dieci anni prima, nel 1971, quando la produzione americana di petrolio ha raggiunto il suo picco e ha iniziato inesorabilmente a scendere, trasformando gli Usa nei maggiori importatori di petrolio al mondo. Lo stesso processo, dicono questi geologi, è destinato a ripetersi via via in tutto il mondo. Il petrolio diventerà sempre di meno, sempre più difficile e costoso (sotto la banchisa artica, in fondo all’oceano) da estrarre. Da due anni a questa parte è lo schieramento dei geologi che guadagna consensi. Gli organismi internazionali rivedono al ribasso le stime sulla disponibilità di petrolio nei prossimi decenni. Gli uomini delle multinazionali sono anche più bruschi: Cristophe de Margerie, boss della Total, uno dei grandi di Big Oil, ha detto recentemente che «il mondo non riuscirà mai a produrre più di 89 milioni di barili al giorno». Oggi, siamo già a 85 milioni. E poi? La rivoluzione del colonnello Drake e del capitano Lucas l’abbiamo bruciata in centocinquant’anni. Nessuno sa se il futuro sarà il sole, l’atomo o l’idrogeno. L’era del dopo-petrolio si apre con molte domande e poche risposte. FOTO ©SEBASTIAO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO T Un villaggio qualsiasi, nel “grande ovunque americano” Ironicamente, nessuna autostrada raggiunge il paese che lanciò l’industria del petrolio, nessun viandante lo attraversa se non sbaglia strada che trasportavano le botti. Pozzi e trivelle spuntarono a caso, senza regole o norme di sicurezza, come i cercatori d’oro con i pentolini nel Klondike, talmente vicini e fitti da scatenare incendi ed esplosioni che in un solo giorno avrebbero incenerito ottanta persone, cremate e raccolte in una fossa comune senza croci o nomi. Sgorgarono marche di lubrificanti e carburanti destinate a stamparsi sulle pareti di ogni garage, Quaker Oil, dalla setta di quaccheri che qui erano emigrati, Pennzoil, Kendall, Sunoco, e la più celebre, la Exxon, partorita dalla Standard Oil dei Rockefeller, a sua volta figlia della Pennsylvania Rock Oil Company. Titusville era diventata la città del fango, dove era più faticoso estrarre i carri dalla terra collosa che estrarre il petrolio. Una vampata che, come quella che consumò la vita di ottanta uomini, cominciò a spegnersi nei primi anni del Ventesimo secolo, quando un oceano incomparabilmente più vasto e facile da estrarre fu scoperto sotto la prateria del Texas. Il regno di Titu- sville, i suoi sontuosi bordelli e saloon, le fonderie che erano spuntate nelle valli vergini degli altri fiumi vicini, il Monogahela, il fiume della luna, l’Ohio, l’Allegheny, conobbero una seconda, fuligginosa primavera nella Seconda guerra mondiale, quando si dissanguarono per alimentare la mobilitazione bellica. Mentre Detroit era l’arsenale della democrazia, Titusville e la sua regione fornivano il carburante per far funzionare le macchine da guerra. Oggi il “jurassic park” della rivoluzione nera sta esausto, come se il parto di quella mostruosità l’avesse sfiancato. I sedicimila pozzi ancora attivi in queste valli producono 4.027 barili al giorno, appena un cucchiaio di “olio di roccia” rispetto agli otto milioni di barili pompati — ogni giorno — soltanto dai deserti d’Arabia. Resta, sotto l’occhio affettuoso della signora Zolli, la reliquia di un santo che li ha sedotti e abbandonati. Il tranvaino per turisti che non ci sono funziona a batterie elettriche, per non inquinare la città fossile di un combustibile fossile. Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA l’attualità Trasformazioni DOMENICA 26 LUGLIO 2009 Questa settimana anche la Turchia ha detto addio al fumo nei suoi caffè. Il paese del narghilè aderisce così al divieto che in gran parte del mondo occidentale ha mutato l’aspetto dei locali pubblici. Con i bistrot francesi in via di estinzione e i pub inglesi in crisi profonda, nell’era di Facebook cambia definitivamente un altro spazio dedicato allo “stare insieme” Quel che resta del vecchio bar SIEGMUND GINZBERG «D i quanti editti imperiali, di quante dispute di teologi e lotte sanguinose è stato cagione questo “nemico del sonno e della fecondità”, come lo chiamavano gli ulema austeri; questo “genio dei sogni e sorgente dell’immaginazione”, come lo chiamavano gli ulema di manica larga, ch’è ora, dopo l’amore e il tabacco, il conforto più dolce… Ora si beve il caffè sulla cima della torre di Galata e della torre del Seraschiere, il caffè in tutti i vaporini, il caffè nei cimiteri, nelle botteghe dei barbieri, nei bagni, nei bazar». Così Edmondo De Amicis nel suo resoconto ottocentesco di viaggio Costantinopoli. L’autore di Cuore era impressionato dalle «file di botteghe basse ed oscure, dove si vende il tabacco “la quarta colonna della tenda della voluttà” dopo il caffè, l’oppio ed il vino, o “il quarto sofà dei godimenti”, anch’esso, come il caffè, fulminato un tempo da editti di sultani e da sentenze di muftì, e cagione di torbidi e di supplizi, che lo resero più saporito». Per pagine e pagine quasi non parla d’altro: «Tutta la strada è occupata dai tabaccai. Il tabacco è messo in mostra sopra assicciuole, a piramidi e a mucchi rotondi, ognuno sormontato da un limone. Sono piramidi di latakié d’Antiochia, di tabacco del Serraglio biondo e sottilissimo che par seta della più fina, di tabacco da sigarette e da cibuk, di tutte le gradazioni di sapore e di forza, da quel che fuma il facchino gigantesco di Galata a quello che concilia il sonno alle odalische annoiate nei chioschi dei giardini imperiali. Il tombeki, tabacco fortissimo, che darebbe al capo anche a un vecchio fumatore, se il fumo non giungesse alla bocca purificato dall’acqua del narghilè, è chiuso in boccie di vetro come un medicinale. I tabaccai son quasi tutti greci od armeni cerimoniosi, che affettano un certo fare signorile; gli avventori tengono crocchio; vi si fermano degli impiegati del ministero degli esteri e del Seraschierato; alle volte vi dà una capa- tina qualche pezzo grosso; vi si spolitica, si va a raccogliervi la notizia e a raccontarvi il fattarello; è un piccolo bazar appartato e aristocratico, che invita al riposo, e fa sentire, anche a passarvi soltanto, la voluttà della chiacchiera e del fumo». Ad Apollinaire, che faceva il soldato nella Istanbul occupata, i caffè gli ricordavano quelli della sua Parigi. Mentre per l’americano Curtis erano come i saloon di Chicago, con la sola differenza che vi si serviva raki anziché whisky. Per secoli ai viaggiatori la Turchia, anzi l’Oriente più in generale apparivano come immensi barcaffè e tabaccheria insieme. «Ci sono luoghi in cui la storia è inevitabile come un incidente automobilistico — luoghi in cui la geografia provoca la storia, la voluttà del caffè si accompagna a quella del fumo. Uno è Istanbul, alias Costantinopoli, alias Bisanzio», si potrebbe dire parafrasando il Nobel Iosif Brodskij. Tutto torna, prima o poi, come sempre. Anche gli editti e le dispute più o meno teologiche. Non so quanto i turchi rimpiangeranno la sigaretta, il “puro” o il narghilè al caffè. Penso che se ne faranno una ragione. E forse con meno drammi di quanto ci immaginiamo. Anche perché il divieto arriva con mano pesante: 5.600 Yeni Turk Lira, 2.600 euro di multa per ristoranti e locali che non applichino il divieto, 69 lire, 32 euro per, come dire, gli “utilizzatori finali”, ben cinquemila sbirri e delatori, agenti speciali formati dal Ministero della sanità, per controllare l’applicazione delle nuove norme. “Farsi occidentali” ha un prezzo. Specie se si è meno europei e meno americani di quanto si dovrebbe su altre cose più di sostanza. Si comincia sempre da dove si può. Atatürk aveva cominciato abolendo con estrema severità il fez, il velo, tonache e turbanti dei religiosi in pubblico. Nei miei ricordi d’infanzia le sue fattezze sono associate più alla bottiglia di rakimarca Klup, dove era ritratto in impeccabile smoking, e ai pacchetti di sigarette, che al resto. Ma è evidente che Georges Simenon Quei locali erano frequentati solo dagli habitué o da gente come me cui piaceva una cucina popolare, non ricercata. Il menù era scritto su una lavagnetta e comprendeva un solo piatto, oltre alle sardine e al sedano bianco da “UN BANC AU SOLEIL” il percorso della modernità democratica è stato molto più lento e complicato. C’è in tutto questo qualcosa di già visto e già sentito. Quando l’anno scorso passò definitivamente in Francia la proibizione del fumo in tutti i luoghi pubblici, la stampa del resto del mondo era sgomenta. Come, niente più fumo al Cafè de Flore o ai Deux Magots o alla Brasserie Lipp che sono passate ai libri di storia — e alle guide turistiche — grazie alla frequentazione di fumatori accaniti come Jean-Paul Satrte e Simone de Beauvoir? Si lamentò la fine di una cultura, si derise il fatto che la Bibliotheque Nationale arrivasse al punto di falsificare i ritratti in cui Sartre o Malraux comparivano con la gauloise in bocca. Da noi ci sono norme analoghe, si erano accesi per un momento gli animi, ma ora è come se non ci fossimo mai accorti del cambiamento. In America praticamente non si vede più fu- mare, non solo in pubblico ma anche nelle case, da molti anni. Esattamente come non si vede più bere alcol, grazie all’ipocrisia, credo ereditata dal protezionismo, per cui la bottiglia in pubblico viene nascosta dai sacchetti di carta. Se ti invitano a cena, neanche a pensarci, a meno di assentarsi furtivamente, come un tossicomane, all’aria aperta. Ricordo ancora gli sguardi di odio e sospetto assassino che suscitai una volta che mi ero messo in fila in posta: avevo gli abiti ancora impregnati di toscano. Mi feci l’idea che il disprezzo pubblico nei confronti di Clinton per aver dissacrato l’Oval office nella faccenda Lewinsky si fondasse sulla voce che aveva tirato fuori il famigerato sigaro cubano, sia pure per farne un uso improprio, ancor più che sul resto. Paese che vai usi che trovi, ma su una cosa non ci piove: se non sta bene fumare (o derubare l’erario, o mentire, o andare a puttane), deve valere per tutti, e più ancora per chi sta più in alto. Eppure, non credo affatto che i nuovi divieti turchi si debbano catalogare nel faldone del “molto rumore per nulla”. Ho anzi l’impressione che tocchino un argomento più profondo e universale, il senso di perdita, la nostalgia di qualcosa che faceva parte del nostro modo di vivere, che in qualche modo, talvolta anche inconsciamente, permane nella nostra memoria collettiva, e di cui continueremo a sentire la mancanza. Qualcosa che abbiamo vissuto — vale per i più anziani — o che magari abbiamo solo letto nei romanzi o visto al cinema. Non mi riferisco alla sigaretta, che a questo punto può anche essere considerata un dettaglio, anzi un pretesto, come lo era la madeleine inzuppata nella tazza di tè di Proust. Intendo un certo modo di stare insieme. Ci sono modi di stare insieme che hanno dato il sapore ad intere epoche, e che ci sono scivolati tra le dita talvolta senza che nemmeno ce ne accorgessimo. I pub in Inghilterra non erano solo un luogo per farsi una birra, fornicare con le servette, erano nati con la libertà di stampa, erano il luogo dove si discuteva, si facevano affari, e si leggevano i giornali. Ho letto l’altro giorno in un gu- Repubblica Nazionale DOMENICA 26 LUGLIO 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 Orhan Pamuk Dopo aver bevuto un bicchiere di birra e vodka in uno di quei locali dove la televisione copre il rumore della folla, avrei fumato una sigaretta come tutti e quindi, sentendo di attirare l’attenzione per il fatto di essere un giovane curioso e solo (e con la faccia da bambino) in mezzo a tutta quella ressa di uomini con i baffi, sarei uscito per entrare nel buio della notte da “ISTANBUL” Nick Hornby È un pub enorme, con soffitti alti che il fumo di sigaretta ti si raccoglie sopra la testa come la nuvoletta dei fumetti Non lo tengono bene, ci sono un sacco di spifferi, i sedili perdono l’imbottitura, il personale è scorbutico, la clientela è terrificante da “ALTA FEDELTÀ” stoso servizio del New York Times che stanno scomparendo, negli ultimi anni hanno chiuso al ritmo di tre al giorno, metà dei villaggi inglesi non ne hanno più nemmeno uno. Nella Turchia di fine impero ottomano, checché ne dicessero i viaggiatori in cerca di folklore orientale, i caffè erano spesso “saloni di lettura”, kiraathane. Il sultano Murad IV nel 1633 (così come di tanto in tanto i suoi successori) li avevano fatti chiudere non certo per ragioni teologiche, ma perché vi si discuteva di politica. Lo zar Michele di R u s s i a proibì il fumo, sotto pena di fustigazione, taglio del naso, deportazione in Siberia e persino morte, non certo perché ce l’avesse col tabacco, ma perché incoraggiavano “crimini” ben più pericolosi per lo Stato. Il secolo dei Lumi e la Rivoluzione francese erano maturati tra il fumo del Procope e degli altri caffè parigini. La grande cultura europea del Novecento sarebbe inconcepibile senza i caffè di Berlino, Vienna, Praga e Budapest. Non ci sarebbe Simenon, non ci sarebbe Maigret, non ci sarebbe la Francia che resiste al nazismo senza le sale fumose della Rive gauche, che gli ufficiali igienisti delle Ss evitavano come la peste. Ma ho letto che in Francia nell’ultimo mezzo secolo bar e bistrot da 200mila che erano sono scesi a poco più di 38mila. Colpa anche, dice qualcuno, dell’invasione di “le sandwich”. Hitler, notoriamente, non fumava e denunciava il tabacco come «punizione dell’Uomo rosso nei confronti dell’Uomo bianco, giusta vendetta per averlo avvelenato con l’alcol». Fidel Castro ha smesso di fumare sigari dal 1986, ma non per questo Cuba è diventata democratica. Il fatto è semplicemente che non si sta più insieme come lo si faceva una volta. Nelle campagne cinesi di trent’anni fa avevo fatto ancora in tempo a vedere le ultime case da tè dei villaggi, dove i contadini si recavano all’alba, per fare quattro chiacchiere e magari una partita a mahjong prima di recarsi nei campi. Il fumo delle candele si mischiava a quello del tabacco, all’umidità del fiato e del sudore. A Pechino le Serge Latouche in libreria Mondializzazione e decrescita L’alternativa africana prefazione di M. Giannini e V. D’Amico www.edizionidedalo.it case da tè sono tornate a migliaia, ma non è la stessa cosa. Mia madre amava sedersi ai tavolini del Biffi in Galleria a Milano per «vedere la gente». Non sono nemmeno sicuro che ci sia ancora, e comunque non c’è più niente e nessuno da “vedere”. Quando arrivammo a Milano da Istanbul negli anni Cinquanta scoprimmo un fenomeno unico e irripetibile: le serate al bar di quartiere, tutti a vedere Lascia o raddoppia?. Ora la televisione la si guarda in casa, in atroce solitudine. Sì, certo, si chatta al computer e c’è Facebook, ma ho l’impressione che sia un modo per stare ancora più soli, non un modo per “stare insieme”. In Italia abbiamo ancora qualcosa di meraviglioso, di cui non ho trovato l’eguale in nessuna altra parte al mondo, nemmeno dopo il boom degli Starbucks: un bar a quasi ogni angolo. Non so se si fanno ancora le discussioni interminabili al bar sulla partita. Non vorrei che fossero state del tutto soppiantate da quelle che si sentono fare in tv, come avviene per la politica ai talkshow. Il vecchio biliardino sarà stato stupido, e certo rumoroso, ma consentiva di “stare insieme” più dell’andare su e giù per il corso o della gimcana coi motorini. Per anni, quando ero più giovane, passavo le mie estati alle Feste dell’Unità, è lì che incontravo le ragazze, altro che i festini. Nessuno le ha proibite, ma è un dato di fatto che non ci sono più, o comunque non sono quelle di una volta. Il fumo è il dito, temo che sia caduta la luna, e non ho idea di come sarà quella nuova. Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 26 LUGLIO 2009 CULTURA* C’è chi ne ristampa i libri, chi gli dedica sale nei musei, chi colleziona carte autografe e cimeli e chi, come Ernesto Ferrero, addirittura abita nella sua ultima casa, a Torino. I fedelissimi dell’autore che inventò il romanzo italiano d’avventura sono tanti. Tutti pronti a celebrarlo nel 2011, per il centenario della morte. Intanto, è in preparazione un dizionario che ne raccoglierà personaggi, temi e luoghi MASSIMO NOVELLI S TORINO i definiscono salgarofili piuttosto che salgariani. Sono una pattuglia composita di donne e uomini sparsi per l’Italia che dell’inventore del romanzo nostrano d’avventura sanno davvero tutto, ne collezionano edizioni preziose, carte autografe e cimeli, ne tengono vivo il ricordo in convegni, mostre, pubblicazioni. C’è chi, come Giovanna e Franca Viglongo, da anni stampa e ristampa i suoi libri. Chi gli ha dedicato una sala nel Museo della scuola e del libro per l’infanzia, come ha fatto Pompeo Vagliani a Torino, a Palazzo Barolo. E chi, da Roberto Antonetto a Ernesto Ferrero, a Silvino Gonzato, a Felice Pozzo e a Vittorio Sarti, scrive di lui, ovviamente di capitan Emilio Salgari, con una fedeltà pari a quella di Yanez per Sandokan. Ognuno di loro ha cominciato in netto anticipo a preparare la celebrazione del centenario della morte dello scrittore veronese, che si suicidò sulla collina di Torino il 25 aprile 1911, oppresso dal carico impressionante di lavoro, dalla miseria, dagli editori che lo pagavano poco o niente, dalla malattia mentale della moglie Ida. Tra questi c’è Ernesto Ferrero, narratore, saggista e direttore della Fiera del libro di Torino, che sta scrivendo un romanzo sugli ultimi sei mesi di vita del nostro “Tusitala”, Colui Eterni ragazzi uniti dal sogno di Sandokan che racconta, come gli abitanti di Samoa avevano chiamato Robert Louis Stevenson. È un’idea nata in un contesto e in uno scenario perfetti. Il letterato abita nella stessa casa che fu l’estrema dimora di Salgari, in corso Casale 205, a due passi dal Po. Il destino e i suoi giochi, uniti ai richiami misteriosi, fantasmatici, di un coinquilino segreto hanno avuto la loro brava parte nell’indurlo a cimentarsi con la tragica fine del creatore del Corsaro Nero, di TremalNaik, dei Pirati della Malesia, dei Naviganti della Meloria. Ma l’impresa veramente degna del Capitano, lussureggiante e sconfinata quanto il delta gangetico delle Sunderbunds ne I misteri della Jungla Nera, ha deciso di compierla Vittorio Sarti, lombardo di Casalbuttano (Cremona), bancario in pensione che vive fra Milano e Parma, già autore di una pregevole bibliografia salgariana. Insieme a Silvino Gonzato, giornalista e scrittore veronese, qui in veste di coordinatore, e all’editore Sergio Pignatone, sta componendo la bibbia delle bibbie in questa materia: si tratta del dizionario enciclopedico dei personaggi (oltre millequattrocento), della flora e della fauna, dei luoghi geografici, che s’affollano nelle decine di romanzi di Salgari. ‘‘ Una voce robusta, con una specie di vibrazione metallica, s’alzò dal mare ed echeggiò fra le tenebre, lanciando queste parole minacciose: “Uomini del canotto! Alt, o vi mando a picco!” da “IL CORSARO NERO” Un’opera eccessiva, che sarà terminata nel corso del 2010, per un narratore che dell’eccesso fantastico era il maestro. Soprattutto una summa, spiegano Sarti e Gonzato, che ha uno scopo preciso: «Vogliamo dimostrare che Salgari non descriveva a casaccio o inventando di sana pianta la natura, le popolazioni, gli usi e i costumi, gli animali dell’India, del Borneo, della Cina, dei Mari del Sud, dell’Africa, delle Americhe. Si documentava scrupolosamente, invece, consultando resoconti di viaggi, enciclopedie, atlanti, giornali e riviste». Sarti, dopo avere elencato i personaggi dei libri, ha compilato una lista di tutti i popoli, le tribù, i reami, i luoghi, le montagne, i fiumi, i mari, gli animali, le piante e i fiori citati nei romanzi e nei racconti. Tanto per dire: da «Abad, voce indo-iranica che significa luogo abitato» a «Fico delle pagode, grandissimo albero delle Indie Orientali», passando per «Sindhia, nome di un regno dell’Indostan» e per «Sandakan, porto dell’isola di Borneo». E chiudendo, perché no, con «Valez-de-Gomera, città d’Affrica (sic) nel regno di Fez», che ispirò verosimilmente il nome di Yanez de Gomera. In seguito è andato a cercarne i riscontri nelle enciclopedie e nei compendi scientifici, di viaggi e di esplora- zioni dell’epoca, fra Ottocento e primo Novecento, avendo la conferma di ciò che sapeva: «Salgari non ha mai mentito o inventato. Si era semplicemente attenuto a quanto aveva letto». Vittorio Sarti lavora a un tavolino che sembra quello di Salgari, quel piccolo tavolo nella casa di Torino su cui vergava febbrilmente e senza sosta migliaia di pagine. Non è casuale, naturalmente. Nulla, tra i salgarofili, è ispirato dal caso. Li lega un destino: quello di essere riusciti a restare ragazzi, di sapere ancora appassionarsi per un romanziere che era la quintessenza dell’avventura e della fantasia. Repubblica Nazionale DOMENICA 26 LUGLIO 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 Il timido scrittore della porta accanto che viaggiava seduto in biblioteca ERNESTO FERRERO e ne stupivano tutti: il celebre scrittore che la regina Margherita aveva fatto nominare cavaliere, l’uomo che forniva sogni agli italiani viveva modestamente in due stanze di un caseggiato popolare, in un borgo sul fiume detto della Madonna del Pilone, ai piedi della collina di Superga. Una campagna d’acque placide non ancora toccata dall’espansione edilizia, rigata di canali, fitta di mulini, botteghe artigiane, osterie che si chiamavano “Posta”, “Stella d’oro”, “Sebastopoli”. Ci potevi trovare fabbri, operai, cavatori di ghiaia, ortolani, mugnai, cavallari, soldati. Bevevano freisa e barbere gagliarde, cantavano fino a notte fonda. Gente allegra, quando non aveva il vino triste e litigava per donne. Quando passeggiava sull’argine S Emilio Salgari poteva vedere la Mole dell’Antonelli svettare oltre il ponte intitolato alla Regina, ma la città restava sideralmente lontana, per lui, almeno quanto i padiglioni di cartapesta che stavano allestendo al Valentino per l’Esposizione Universale, magniloquente tempio della Modernità e del Progresso. A Torino andava soltanto per le ricerche in biblioteca, poi affidate a una serie di schede ordinatissime, o per vendere a un amico libraio di piazza Vittorio le copie d’autore che gli editori gli dovevano per ogni novità pubblicata. Era una sorta di esilio volontario, un’affermazione di estraneità, d’indipendenza. Con una venatura polemica per quanti lo lasciavano lì a consumare la grama esistenza di cottimista della penna, quattro libri l’anno per contratto, nemmeno il tempo di rivedere quel che aveva appena scritto. Il cavaliere scriveva direttamente in bella: buona la prima. O più semplicemente gli piaceva vivere in mezzo a quella vegetazione di tigli e platani che svettavano su canne e robinie, su erbe selvagge e sfacciate che nes- COPERTINE il dizionario Amok Si chiama così, presso alcuni popoli malesi, il furore cagionato dall’abuso dell’oppio e manifestantesi per lo più con la mania di voler uccidere o ferire Chiunque porti armi ha diritto di uccidere gli invasi dall’amok Arak Voce araba (rak) dell’acquavite. Gli Indiani danno questo nome a tutto ciò che sa di forte. In Europa si chiama così quel liquore che nell’India si fabbrica con una mistura di riso, di zucchero di canna, e di noce di cocco Labuan Isola e colonia della corona britannica, nel Mar della Cina, presso la costa nord-est di Borneo, davanti alla foce del fiume Brunei, ceduta (1846) da un sultano agli inglesi Bassa, fertile, paludosa in parte. Cave di carbon fossile rinomate Sandakan Porto dell’isola di Borneo, capoluogo del Borneo settentrionale britannico, sul Mare di Sulu, a 1670 chilometri da Singapore, con circa 5000 abitanti Sindhia Nome d’un regno dell’Indostan, che i maratti avevano invaso contro la volontà degli inglesi. Essendosi questi ultimi opposti colla forza, vinsero i primi e resero lo Stato all’antico sovrano Le voci che pubblichiamo sono un’anticipazione dal dizionario salgariano curato da Vittorio Sarti e Silvino Gonzato che uscirà nel 2010 dall’editore Sergio Pignatone In queste pagine, una serie di copertine storiche dei libri di Salgari Sotto, una lettera dello scrittore A sinistra, una sua foto suno contrastava e che potevano evocare i viluppi vegetali tante volte descritti nei romanzi. Uomo di statura modesta, per sembrare un po’ più alto si faceva mettere alle scarpe tacchi spessi tre dita. Davano alla sua andatura qualcosa di esitante, quasi non fosse sicuro del terreno dove poggiava i piedi. Faccia rotonda, radi capelli brizzolati e inariditi, sarmenti secchi pronti per il camino; baffoni a spazzola gialli di nicotina; occhi grigi, già velati come da una cataratta. Lamentava spesso d’aver consumato gli occhi sulle carte. Atticciato, piuttosto robusto, diceva d’essere stato buon nuotatore, ginnasta e schermidore, temperamento di compagnone che amava esibire la propria destrezza. Dell’agilità di un tempo gli restava una sorta di solidità contadina. Nelle rare immagini rimaste affiora un’espressione di stanchezza stupita, quasi offesa, incredula. Usciva in passeggiata intabarrato in un soprabito color giallino chiuso fino al collo, anche d’agosto. Il miglior modo per avvicinarlo era chiamarlo rispettosamente «capitano». Avrebbe voluto navigare mari lontani, si accontentava di canali impigriti dall’estate, mulini cigolanti, lavanderie. Le sole vele che poteva vedere erano le lenzuola che le lavandaie mettevano ad asciugare oltre il ponte di Sassi, in plotoni ordinati. La famiglia Salgari si compone della moglie Ida, che lui ama chiamare Aida, di nervi fragili anche lei, e quattro ragazzi. La primogenita Fatima ha una bella voce. Ogni settimana va tre o quattro volte in città a prendere lezioni di canto. Si è già esibita con successo al “Circolo dei meridionali”, dove ha cantato arie dell’Aida e del Trovatore. Talvolta il cavaliere si mette al pianoforte perché vuole accompagnarla e strimpella come un matto. Suona piuttosto male. Fatima deve smettere di cantare, aspetta che lui finisca le sue sarabande. Gli altri tre figli sono maschi ribelli e irrequieti come gatti randagi. Aida ci diventa matta. Casa Salgari è un teatrino permanente. Il cavaliere ama ritrarre dal vero, per questo avvolge Aida e i ragazzi di stoffe a suo dire esotiche, fusciacche, pennacchi e turbanti. Anche i vicini vengono coinvolti nelle recite improvvisate, possono diventare un visir orientale, un principe pellerossa, un guerriero thug. Il cortile echeggia di urli guerreschi, ruggiti, barriti imitati alla meglio. Il cavaliere si è portato dietro vari cani, diciassette gatti, una scimmia, uno scoiattolo, un pappagallo, un’oca che di nome fa Sempronia e quando si innervosisce diventa aggressiva. Per tirare avanti, per rimediare al calo dell’ispirazione e all’angoscia delle consegne, il cavaliere si tiene su con il marsala, e fuma troppo. Le molte sigarette di Yanez sono le sue. Vive segregato nella prima stanza, che fa da salotto, pranzo e studio. In un angolo, vicino alla finestra che dà sul corso, dove arranca il trenino per Chivasso, ha sistemato un tavolino traballante, ingombro di carte geografiche disegnate da lui stesso, giornali illustrati, fotografie ingiallite. Scrive con un calamo che s’è tagliato lui su misura, e poi ci ha legato un pennino con un po’ di refe. Fabbrica di persona anche gli inchiostri con certe bacche che crescono in abbondanza. Sui ripiani delle mensole giacciono impolverate statuette di divinità indiane, collane di conchiglie, cristalli di minerali, pistole ad acciarino, pipe, bussole. Appesi alle pareti fucili, archibugi, un arco con la sua freccia, uno scudo in cuoio, due fiocine, reti, canne da pesca, foglie di palma ingiallite. Ogni tanto arrivano in visita delle scolaresche, anche se i suoi romanzi a molti educatori non piacciono e anzi, appena possono ne denunciano gli eccessi come un segno di tempi cambiati che non promettono niente di buono: troppa violenza, troppo sangue. Libri che possono far male alle giovani menti, creare degli esagitati, dei sovversivi. Salgari è l’anti-De Amicis. Il suo è un mondo di folli impegnati a farsi la guerra, inseguirsi, massacrarsi, vendicarsi di qualcosa. Ogni intreccio rimanda a un pregresso di tradimenti e offese da punire, che non è nemmeno il caso di stare a spiegare in dettaglio, perché è il tradimento che governa il mondo. Ma chi ha tradito e offeso lui? Anche lui vive per vendicarsi di qualcosa, per avere quello che la vita gli ha negato. Ecco perché i suoi personaggi non possono aver pace: perché la pace è un bene voluttuario che Emilio Salgari non si è mai potuto concedere. Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 26 LUGLIO 2009 SPETTACOLI Hanno dato vita alla più celebre dinastia del teatro italiano del Novecento, ancora ricordata grazie alle versioni televisive delle loro commedie riversate in dvd. Ma per decenni i due grandi attori ruppero i rapporti. A trent’anni dalla loro riconciliazione, Luigi, figlio d’arte del minore dei due, va in tournée con “La fortuna con la effe maiuscola”, una pièce dello zio E racconta quel diverbio durante le prove, nella Napoli della guerra... INSIEME Eduardo e Peppino De Filippo in una rara foto degli anni Trenta col campione di boxe Primo Carnera In alto a sinistra, i due con la sorella Titina in una caricatura di Onorato LUIGI DE FILIPPO u una bella lite, accesa, mio padre si ribellò in maniera non solo violenta, ma, se vogliamo, anche ironica. Stavano provando al teatro Diana di Napoli, era il 1944. L’atmosfera era già tesa da un po’ di tempo, due galli in un pollaio non ci possono stare. Peppino voleva fare una cosa, Eduardo un’altra. Quella mattina Eduardo notò un atteggiamento svogliato da parte di mio padre alle prove e lo rimproverò davanti agli altri attori. Mio padre si risentì parecchio di quello che gli sembrò un gesto dittatoriale e si rivolse a Eduardo facendo il saluto romano e gridandogli in faccia: «Duce… duce… duce…». Gli astanti dovettero intervenire per separarli. Anni e anni dopo, quando mio padre si ammalò, avvisai Eduardo. Un po’ si fece pregare, ma poi riuscii ad accompagnarlo in clinica; li lasciai da soli. Avevano tante cose da dirsi e poco tempo. Devo ammettere che come famiglia siamo stati molto uniti in scena, ma una volta chiuso il sipario, ognuno faceva la sua vita. Ho continuato a vedere Eduardo anche dopo il litigio. Andavo spesso nella villetta di via Nomentana a Roma e sono stato il primo ascoltatore di Filumena Marturano. Una mattina, a Napoli, mi fece sedere e cominciò a leggere, interpretando da solo tutti i personaggi. Quella commedia in origine aveva un altro titolo, Filumena Maisto, ma il cognome della protagonista corrispondeva a quello di una nota famiglia napoletana che si risentì mol- F intervenivano le forze per aiutare i cittadini ad andare al ricovero. Questa Unione era formata da gerarchetti fascisti, gente anziana che non poteva andare al fronte, mezzi rimbambiti. Eduardo capì al volo la battuta improvvisata e rilanciò: «Ma come? Tu sei cretino». «Appunto mi hanno preso all’Unpa». La cosa venne riferita al federale di Roma, che decise di mandare una squadraccia per dargli una lezione. Fu lo stesso Mussolini a salvarli decretando: «Lasciateli perdere, sono la mia valvola di sicurezza». I De Filippo da una certa area politica non sono mai stati amati. Eduardo è stato molto vicino al Pci e rammento la sua commozione ai funerali di Berlinguer; mi ricordo anche che Togliatti portava la figlia al Teatro delle Arti a Roma e andavano a salutare mio padre, che allora lo gestiva. La Dc invece ha sempre osteggiato Eduardo, per esempio impedendogli di aprire la sua scuola di recitazione. Non hanno mai censurato le sue commedie in tv perché sarebbe stato come “tagliare” un monumento nazionale, ma queste sue simpatie di sinistra gli sono costate care. Peppino De Filippo ha girato cento Mio padre rifiutò l’offerta della Titanus: film di serie B ne aveva girati tanti, Erano accaniti antifascisti e non perdevano occasione per sfottere il regime, anche davanti al pubblico tissimo di vedersi rappresentata da una prostituta. Così Maisto diventò Marturano. Mia zia Titina ha interpretato moltissime volte quella parte e un giorno, nel camerino del teatro romano Eliseo, un gruppo di signore entrò per complimentarsi, ma soprattutto per chiederle di svelare il nome del padre dei tre ragazzi Marturano. Titina, come se confidasse un segreto, rispose: «Lo so ma non ve lo posso dire, mio fratello Eduardo farebbe una tragedia!». La famiglia De Filippo si trasferì nella capitale nel ‘42, due anni prima della celebre rottura. A Roma c’erano i grandi palcoscenici, Cinecittà, la radio e, soprattutto, non c’erano i bombardamenti. I De Filippo erano accaniti antifascisti e non perdevano occasione per sfottere il regime. Mi viene in mente un episodio che riguarda La fortuna con la effe maiuscola. Durante una replica serale al Quirino, eravamo in pieno conflitto, Peppino cambiò il copione: «Finalmente ho trovato un lavoro. Mi sono iscritto all’Unpa», proferì, rivolto a Eduardo, con lui in scena. Ora, l’Unpa era l’Unione nazionale protezione antiaerea: quando squillava la sirena ma insieme a Totò era un’altra faccenda I fratelli De Filippo “Eduardo, Peppino e quella lite coi fiocchi” film, ha scritto una cinquantina di commedie, con lui ho conosciuto tantissima gente. Fellini, per esempio. Scherzava sempre e, come me, aveva il problema della perdita dei capelli. Un giorno sul set di Boccaccio ‘70 mi fermò per dirmi: «Luigi, ho trovato che cosa impedisce la caduta dei capelli… il pavimento». La televisione è stato un mezzo di comunicazione che i due fratelli De Filippo, in maniera diversa, hanno saputo usare: ero a casa di Eduardo quando arrivò una telefonata della Rai. Mio zio, finita la conversazione, ce la raccontò: «Pronto, qui è la televisione…», «Piacere, adesso le passo subito il frigorifero». Peppino accettò di condurre Scala Reale negli anni Sessanta ma gli ascolti non erano soddisfacenti. Allora gli venne in mente il personaggio di un cuoco che si esprimeva per strafalcioni e che aveva usato in teatro. Pappagone diventò più di una maschera, la gente parlava come lui («ecque qua...»). La Titanus gli offrì di fare una serie di film con Pappagone, ma lui rifiutò. Di B-movie, come si direbbe adesso, ne aveva girati tanti; ma insieme a Totò, era un’altra faccenda». (testo raccolto da Alessandra Rota) Repubblica Nazionale DOMENICA 26 LUGLIO 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 Va in scena la riappacificazione I DVD Ogni venerdì in edicola con Repubblica e L’espresso le commedie in tv di Eduardo a 7,90 euro in più ALESSANDRA ROTA La fortuna con la effe maiuscola la commedia che sancisce idealmente la riconciliazione tra i due fratelli De Filippo, Eduardo e Peppino. Dall’abbraccio sul letto di morte sono passati trent’anni, era il 1980, e Luigi De Filippo, figlio di Peppino, di fatto l’artefice della sofferta riappacificazione, mette in scena il testo dello zio (scritto insieme al giornalista Armando Curcio) e debutta il 29 luglio al Festival di Borgio Verezzi (Savona). Sarà però nei cartelloni dei maggiori teatri italiani nel 2010 per- È ché, oltre al trentennale della pace dei De Filippo, sono anche i sessant’anni di carriera di Luigi. «Adesso posso confessarlo», dice l’attore (come gli illustri parenti anche prolifico autore), «sono stato sempre in mezzo a persone che mi ripetevano “tuo zio, tuo padre... divisi”. In realtà mi sono sempre meravigliato che, considerati i caratteri, avessero lavorato insieme per quattordici anni. Il loro sodalizio ha indubbiamente segnato pagine bellissime nella storia del teatro. Ma a distanza di tanto tempo devo ammettere che il fatto che si siano separati ha decretato la loro diversa fortuna: mio padre ha potuto recitare i grandi del teatro europeo; mio zio ha trasformato Napoli nel palcoscenico dell’umanità». CARTOLINE In alto una cartolina di Peppino in tournée a Praga (1965), che si firma col nome del suo personaggio A destra i tre De Filippo con Luigi Pirandello La scommessa di intrecciare i repertori di una “famiglia difficile” RODOLFO DI GIAMMARCO zzeccatissimo, il titolo d’un volume biografico di Peppino De Fi- grado il legame di sangue e il sodalizio, nei primi anni Quaranta Peppilippo, Una famiglia difficile, che nel 1975 esplose come una bom- no arrivò a comunicare per lettera a Eduardo, ed è storia patria quello che ba urticante nel terreno già minato (e laconico) dei rapporti tra accadde nella rottura con plateale litigio nel ‘44 al Teatro Diana di Nal’autore e il fratello Eduardo. Fu proprio una famiglia difficile, quella che poli. Come apprendiamo soprattutto dal libro-sfogo di Peppino — che originò dal ceppo di Eduardo Scarpetta, sfacciato e sfaccettato artista rivela una scrittura umorale, fatalmente soggettiva, con ereditario sedell’Otto-Novecento che non volle riconoscere la paternità di Eduar- quel nei due volumi sempre di famiglia, un po’ più pacati, Oje vita, Oje do, Peppino e Titina, destinati a fregiarsi del solo cognome della ma- vita mia!... e De Filippo & De Filippo scritti dal figlio Luigi, vena cui corridre Luisa De Filippo. Se il sangue non mentì affatto, e se il palcosceni- sponde una speculare riluttanza autobiografica di Eduardo e del figlio co conobbe il miracolo di tutti e tre splendidamente uniti per tredici Luca — la spaccatura irritò soprattutto Eduardo, che dopo il divorzio, anni, dal 1931 al 1944, in quel fenomeno irripetibile che fu la Com- giudicato da lui un tradimento, trovò da più teatri sbarrate le porte, tanpagnia del Teatro Umoristico, è vero pure che le difficoltà dovettero ta era la delusione di non vedere più assieme due artisti così unici. Ma davvero c’erano strade ormai diverse, per loro. E avendo ben pregià un po’ segnare una diseguale gavetta in cui Eduardo ebbe la fortuna di fare più apprendistato ufficiale con lo zio Vincenzo Scar- sente il carattere di fondo “cattivo” di entrambi, sarà stato carico di senpetta. Poi il fare ditta assieme creò, sì, una bella coesione e una so quel silenzio comune mentre s’affacciarono fuggevolmente da un tercomplementarietà tra i due De Filippo maschi, dove lo humour razzo (di Eduardo) a Posillipo, o il gioco del teatro mentre consolavano prosciugato e scarnito di Eduardo soprannominato “sic sic” (di qui, Thea Prandi, moglie di Eduardo, prossima a morire, o la disputa all’inSik Sik l’artefice magico...) si sposava bene con la comicità più tornita e domani della scomparsa di Titina. Non furono Coppi e Bartali, furono gagliarda di Peppino. Senonché apparve progressivamente difficile molto di più. E fa bene Luigi a reintrecciare i repertori, come quando già un’intesa sulla linea drammaturgica, e qui Eduardo affermò (contrat- cinque anni fa recitò Non ti pago! di Eduardo. Questo ceppo è un patritualmente) una sorta di primato che il fratello accettava con riserva. Mal- monio difficile ma indivisibile. A ALLA RIBALTA Foto di scena di Peppino e Eduardo nel 1931 (in alto) e nel 1960 (qui sopra) Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 26 LUGLIO 2009 i sapori Non ammette alcuna rigidità la gastronomia del Caribe Creola di nome e di fatto si abbandona a una ricombinazione continua di ingredienti e colori. La parola d’ordine Contaminazioni è “mescolare” e i soli tratti comuni sono l’abolizione del confine tra dolce e salato e la predilezione per il piccante itinerari Architetto e produttore di uno strepitoso rum a Barbados, Larry Warren è proprietario della storica residenza St. Nicolas Abby, con distilleria e ristorante, dove vengono serviti piatti della cucina tradizionale bajan Giamaica Santo Domingo Curaçao La terra del reggae e del jerk salsa a base di pollo o maiale piccante e speziata è un paradiso di materie prime e gastronomia, “bagnate” da birra, caffè e rum Un’isola sola per due nazioni: Repubblica Dominicana e Haiti Il risultato è un mix di ricette indigene, africane e spagnole, dal sancocho (zuppa-stufato) alla bandera (riso, fagioli e carne) Famosa per il suo liquore a base di scorza di laraha, un agrume locale, l’isola “del cuore”, gioiellino delle Antille Olandesi, vanta una cucina variegata e speziata DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE STRAWBERRY HILL New Castle Road Irish Town (Kingston) Tel. (+876) 944-8400 Camera doppia da 120 euro, colazione inclusa HOSTAL NICOLAS DE OVANDO Calle Las Damas Cuidad Colonial, Santo Domingo Tel. (+809) 685-9955 Camera doppia da 115 euro, colazione inclusa LODGE KURA HULANDA Playa Kalki 1 Westpunt Tel. (+5999) 839-3600 Camera doppia da 100 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE NORMA’S ON THE TERRACE 26 Hope Road, Kingston Tel. (+876) 968-5488 Chiuso domenica, menù da 40 euro EL MESÓN DE LA CAVA Mirador del Sur 1 Santo Domingo Tel. (+809) 533-2818 Menù da 35 euro DE GOUVERNEUR Rouvilleweg 9 Otrabanda, Willemstad Tel. (+5999) 462-5999 menù da 30 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE OLD TAVERN COFFEE ESTATE Blue Mountains National Park Kingston Tel. (+876) 924-2785 LA CUCHARA DE MADERA Freddy Prestol Castillo 86 Santo Domingo Tel. (+809) 566-2420 FLOATING MARKET Caprileskade corner Handelskade Punda LICIA GRANELLO venne il tempo della cucina del sole. Estate, vacanze, temperature bollenti, momento ideale per sperimentare quello che la quotidianità lavorativa reprime: una late dinner, perniciosissima cena pre-sonno al chiringuito vicino a casa o sulla spiaggia, un aperitivo lungo, un paio di appetitosi cartocci take away comprati nel negozio di gastronomia etnica appena aperto. Per i più fortunati, la scoperta di una cucina senza regole eccitante e golosa, conosciuta direttamente in loco, tra le foci del Mississippi e il triangolo dell’America Latina. Perché la cucina creola ha confini così lassi e ingredienti così variegati che ognuno può infilarci dentro il proprio piccolo contributo alimentare o impossessarsi di una nuova, inattesa variante. Dici creolo, e pensi alla bellezza impossibile di certi bimbi: capelli ricci, biondissimi, occhi come due bottoni di carbone, E Caraibi sole la cucina del Mille ricette senza regole ardenti in un viso colore dell’ambra. Oppure, stessa pelle mielata, ma capelli corvini e sguardo di smeraldo. La cucina dei Caraibi, intrisa di sole e di energia vitale, è trascrizione fedelissima di quella ricombinazione genetica che fa dei creoli il popolo diffuso più bello del pianeta. Come per gli umani, anche le ricette creole sono orfane di una specifica terra d’origine, che in qualche modo ne limiterebbe il respiro gourmand, per riuscire invece come miscellanee magnifiche di ingredienti e tradizioni sovrapposte nei secoli grazie a dominazioni e liberazioni, tra storie di migranti e di accoglienze. L’unico vero guaio è classificarla. Perché da Cuba al New Mexico, dal Perù a Barbados, dal Salvador al Belize, ogni piatto rappresenta un unicum, per come è stato riletto e interpretato, figlio spurio di chissà quante ricette originarie, arrivate da Africa, Giappone, Inghilterra, Indonesia, Francia e cento altri paesi. Certo, qualche minimo comun denominatore esiste: il sapore piccante, l’abolizione del confine tra dolce e salato, un debole dichiarato per agrodolce e spezie, l’accorpamento mattocchio di materie prime che usate in solitudine metterebbero tristezza. Dalla cucina degli schiavi a quella dei latifondisti, l’arte di trasformare l’insipida banana verde negli irresistibili tostones (chips), il pesce crudo nel succulento ceviche (marinatura in lime e peperoncino), l’avocado in una salsa mirabolante chiamata guacamole, ha ispirato i cuochi di tutto il mondo. In contemporanea, l’aver provato da vicino i gusti variopinti della cucina creola ha fatto sì che lentamente ma inesorabilmente si allargasse a dismisura la curiosità verso alimenti di creola provenienza: papaia, avocado, guaiava, christophine, boniato, maracuja, yuca, ma anche tequila, rum, cachassa... Se dal Caribe volete risalire la geografia della cucina creola, fermatevi a Senigallia tra il 14 e il 23 di agosto, luogo e tempo del “Jamboree Summer Festival”, appuntamento con la musica e la cultura degli anni Cinquanta made in Usa. Troverete le prelibatezze della cucina cajun, servite a ritmo di gospel. L’APPUNTAMENTO Da non perdere la diciannovesima edizione di Latinoamericando Expo, nell’area del forum di Assago, Milano, fino al 17 agosto, sotto la direzione artistica di Franca De Gasperi In programma, le “Latin American Show Cooking Classes”, lezioni di cucina tenute da Vittorio Castellani, in arte chef Kumalè Conch Chowder Accra mori Cinnamon fried bananas Stuffed Jack Nasi goreng Christophine farcie Pregiata la zuppa delle Bahamas con i grandi molluschi dalla conchiglia rosata. Cottura in brodo a base di cipolle, sedano, carote, pepe, patate e pomodoro Di derivazione africana, popolari a Porto Rico e in buona parte dei Caraibi, le crocchette di merluzzo,calde e fragranti, che accompagnano l’aperitivo La ricetta delle banane verdi fritte attraversa tutta l’America latina A Grenada, le rondelle di platanos vengono saltate nel burro e addolcite con zucchero e cannella A St Vincent il jack, versione caraibica del pesce sugherello, viene marinato in lime e sale, poi farcito con pastella aromatizzata alle erbe, infine impanato e fritto nella margarina È la ricetta indonesiana del Suriname con il riso bollito e poi fritto Dentro: gamberi, carne, cipolla, uova, pesce fermentato, semi di coriandolo e cumino La chayote, metà pera e metà zucchina, è il contorno di pesci e carni bianche nelle Antille francesi, soprattutto nella versione ripiena di besciamella e gratinata al Groviera Repubblica Nazionale DOMENICA 26 LUGLIO 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 Kassav Flying fish melts Peas and rice Ajiaco In Guadalupe, le crêpes hanno per ingrediente base la manioca, da cui si ricava l’impasto. Cottura sulle piastre bollenti, cocco o cioccolato e bacche di vaniglia per farcire Alle Barbados, i testicoli del pesce volante sono una prelibatezza: marinati in acqua di mare e lime, si mescolano a una crema di formaggio con farina, latte, pepe e prezzemolo A Trinidad come a Tobago, il riso e piselli parte da tocchetti di maiale essiccato, cotti nel latte di cocco. Aggiungere un soffritto di cipolla, pepe, pomodori, erba cipollina A Cuba è il piattosimbolo di una cucina povera ma gustosa Prende il nome dal peperone con cui si prepara un minestrone di verdure e carne (pollo, maiale) Quei piatti croce e delizia di noi poeti tutti obesi a cominciare da Neruda ANTONIO SKÁRMETA acconta Neruda nel suo bacchico libro Abbiamo assaggiato l’Ungheria che il poeta spagnolo Rafael Alberti gli disse che questa era l’epoca dei poeti grassi, degli aedi di buon appetito come Paul Éluard, e che era finito il tempo dei poeti pallidi ed emaciati, con la lira denutrita che sospirava sublimemente. In America Latina queste parole sembrano trovare conferma. Molti dei nostri poeti sono autentici tori di muscolo, grasso e passione. Il più vorace forse è Pablo de Rocka, il cui libro più emblematico appropriatamente si intitola Epopeya de las bebidas y comidas de Chile (Epopea delle bevute e mangiate del Cile). Molti hanno interpretato come un semplice scherzo quella scena del mio romanzo Il postino di Neruda in cui il vate cerca di convincere il suo messaggero che vuole esser poeta a desistere dal suo intento: «In Cile sono tutti poeti. È più originale che continui a fare il postino. Almeno cammini molto e non ingrassi. In Cile noi poeti siamo tutti obesi». Non era uno scherzo, miei cari lettori. È un dramma. Lo dico per esperienza personale e lo certifica la mia bilancia. Anni fa la rivista per la quale scrivevo mi mandò a Isla Negra per intervistare Neruda e io, sapendo della sua fervente ghiottoneria, gli proposi maliziosamente questa domanda: «Quale piatto chiederebbe nella sua Ultima Cena?». Il vate lasciò cadere le palpebre e mi rispose: «Per quella malinconica occasione mi piacerebbero delle ceche (le anguille neonate) al pil-pil (salsa a base di olio e aglio)». Da buon drogato di chili in più e cucina criolla cerco di posticipare la mia ultima cena mangiando almeno una volta alla settimana un’invenzione peruviana che vale un sole, o che vale un Perù, come si diceva in secoli passati. Il mio top one è il tiradito assortito di salmone, ombrina e polipo, un piatto che consiste di filetti crudi di queste delizie del mare, tagliati sottilissimi e che acquisiscono una dinamica nuova grazie a una preparazione che fa emergere i loro sapori più segreti. Il condimento è criollo che più criollo non si può, perché ha come base l’ají amarillo, quella varietà di peperoncino giallo che è la nostra seconda ricchezza dopo l’oro che si sono portati via gli spagnoli. I “cerotti” di polipo e pesce si lasciano a mollo per una ventina di minuti nel complicato condimento dove cuociono. Il composto include una tazza di succo di limone, un rocoto (peperoncino rosso del Perù) a rondelle, un ají amarillo, una cucchiaiata di coriandolo tritato, un cucchiaino di aglio schiacciato, sale e un pizzico di pepe. Il polipo, che ha una consistenza più dura, deve soccombere nella stessa salsa, ma prima di tuffarcelo dentro è meglio pulirlo, sfilettarlo e poi metterlo in uno scolapasta, quindi bagnarlo con acqua bollente, lasciare che si raffreddi e solo a quel punto tuffarlo nel recipiente insieme al salmone e all’ombrina, dando vita alla santissima trinità. L’opera d’arte si conclude poi con una grande foglia di lattuga accompagnata da enormi chicchi di pannocchia tenera, che con la loro pacata dolcezza smorzano l’effetto un po’ acido dell’insieme. Qualche fetta tostata di pane col burro è imprescindibile per raccogliere il condimento restante, poiché la tentazione di inzuppare il pane nel piatto è poco diplomatica ma irresistibile. E se il commensale vuole completare la delizia, e en passant dare il suo contributo all’amicizia tra Cile e Perù — oggi ai ferri corti all’Aja per qualche miglio nautico di oceano — intrattenga il palato fra un boccone e l’altro con un cilenissimo Chardonnay Marqués de Casa Concha. Traduzione di Fabio Galimberti (Dall’ultimo romanzo di Antonio Skármeta, “Il ballo della vittoria” (Einaudi), il regista Fernando Trueba ha tratto un film che uscirà in Europa a dicembre) R Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze Invasioni DOMENICA 26 LUGLIO 2009 Assemblano pezzi di automobili, falciano il prato, cucinano o intrattengono i bambini. Sempre più i nostri sostituti tecnologici alleggeriscono il lavoro e riempiono la quotidianità Se in Italia la loro diffusione è in crescita, il Giappone resta il paese in cui la fantascienza diventa realtà E dove automi simili all’uomo corrono e combattono JAIME D’ALESSANDRO Q uelli utili non ci somigliano. Quando infatti hanno forma umana o animale i robot sembrano essere destinati al solo trastullo o al massimo a far notizia. Eppure c’è chi sostiene che le attuali otto milioni di macchine automatiche capaci di operazioni complesse, diventeranno nel giro di due anni più di diciotto milioni. La previsione, fantasiosa, è dell’International Federation of Robotics, ente non-profit con sede a Francoforte. Che nel suo ultimo rapporto dice implicitamente una cosa interessante: fra loro quelle capaci di cambiare sul serio la nostra esistenza facendo i robota, termine usato per la prima volta nel 1920 dallo scrittore ceco Karel Capek per definire i lavori pesanti, sono sempre prive di gambe, braccia o occhi. Non a caso i più promettenti, commercialmente, sono i robot aspirapolvere e i tagliaerba come il Roomba dell’iRobot o l’Automower dell’Husqvarna, che di umano e di animale hanno davvero poco. Nel 2007 erano tre milioni e trecentomila, per un modesto giro d’affari di circa un miliardo di euro, ma in costante crescita. Tanto che potrebbero raggiungere a breve quota quattro milioni e mezzo. Li si lascia in soggiorno o in giardino e loro puliscono e falciano entrando in azione all’ora prestabi- CHEF Nato nel 1978 come semplice frullatore, oggi il Bimby della Vorwerk grattugia, trita, impasta, cuoce Solo in Italia, abita in un milione e mezzo di cucine Le macchine domestiche che ci cambiano la vita lita. A differenza di quelli usati in campo militare, dispositivi telecomandati in genere, questi hanno sensori per interagire con l’ambiente circostante evitando gli ostacoli e agendo lì dove si è accumulata della sporcizia o dove l’erba è cresciuta troppo. Quando poi le batterie sono al limite sanno ritrovare la strada verso la base di ricarica. La loro precisione, più che l’intelligenza vera e propria, sta aumentando di generazione in generazione. Così come sono aumentate nel tempo le funzioni del Bimby, capace ormai di cuocere e elaborare il cibo in maniera raffinata. E pensare che era nato come semplice frullatore nel 1978, mentre oggi si ritrova a essere fra i robot domestici più diffusi al mondo. Solo in Italia ne hanno venduti poco meno di un milione e mezzo di pezzi. Anche quelli che non si vedono mai perché impiegati nelle fabbriche stanno lasciando un segno nella nostra società. Un milione di unità in tutto, concentrate essenzialmente nel settore automobilistico (che poi qualcuno, come la tedesca Kuka, è riuscito perfino a riciclare in giostra da parco divertimento). Qui Giappone e Italia sono davanti a tutti gli altri con, rispettivamente, 2.100 e 1.700 automi ogni diecimila operai. A Tokyo e dintorni però, a differenza dell’Europa, il culto della robotica è di massa. Il Giappone è uno dei pochi paesi dove il mito fantascientifico dell’automa simil umano non è mai tramontato, malgrado la crisi stia mettendo a dura prova l’intero settore. Prendete ad esempio Asimo, acronimo di Advanced step in innovative mobility. È il robot della Honda da un milione di dollari a esemplare che dal 2005 fa bella mostra di sé al National Museum of Emerging Science and Innovation di Odaiba, isola artificiale nella baia di Tokyo. Fuori dai laboratori di ricerca, rappresenta l’unico punto d’arrivo tangibile della costosa evoluzione dei robot antropomorfi: un breve show a uso e consumo delle scolaresche dove il clou dello spettacolo è una corsetta a piccoli passi frettolosi. Il suo erede? L’aspirante modella Hrp-4c, presentata il 16 marzo. Per ora sembra capace di camminare in maniera rigida, dire quattro parole e abbozzare un sorriso, e, se mai entrerà in produzione, costerà oltre tre milioni di dollari. I robot dedicati al trastullo hanno avuto invece sorti alterne. Dopo l’exploit dei primi anni Ottanta, con prodotti stile Omnibot o Topo che tentavano di emulare R2-D2 di Guerre Stellari, dal 1998 si sta assistendo a una nuova ondata di automi giocattolo. Merito del Furby, esserino tutto pelo e occhioni che muoveva orecchie, bocca e palpebre, venduto in oltre quaranta milioni di pezzi. Capace di parlare, ottocento le frasi in memoria, era alla continua ricerca di attenzioni come il Tamagotchi. Ecco perché la Sony nel 1999 lanciò in pompa magna il suo cane Aibo, per poi mandarlo in pensione nel 2006. E lo stesso si può dire di Pleo, il dinosauro inventato recentemente da Caleb Chung, uno dei padri di Furby. Forma di vita artificiale, intelligente e sensibile alle carezze, che però è riuscita solo a mandare in bancarotta la Ugobe che lo produceva. Vanno meglio i robot giocattolo programmabili costruiti in una certa varietà fra Giappone, Corea del Sud e Hong Kong. Il capostipite è il Mindstorm della Lego, 1998, seguito da robot abbastanza sofisticati come il Manoi, il Robonova-1, il Bioloid, il G-dog o il RoboSapien. Ma sono prodotti di nicchia pensati per appassionati di robotica e per tutti coloro che seguono il Robo One, torneo internazionale cominciato nel 2002 a Tokyo dove gli automi in gara se le danno di santa ragione. Inutili pure loro, ma almeno divertono il pubblico come a un incontro di wrestling. CASALINGO Roomba di iRobot è l’aspirapolvere automatico con sistema di navigazione intelligente. Grazie ai suoi sensori, evita gli ostacoli e, terminato il lavoro, torna a ricaricarsi ‘‘ Philip K. Dick Eppure, quel suo fuoco interiore, così oscuro e profondo, si era dileguato, la sua forza vitale era svanita, come aveva già visto in tanti altri androidi da “MA GLI ANDROIDI SOGNANO PECORE ELETTRICHE?” ATLETICO Corre, cammina, conosce sei mosse di kung fu, balla e raccoglie oggetti Robosapien, l’androide prodotto da WowWee BAGNINO Pulisce il fondo, le pareti e il livello dell’acqua della piscina Dolphin Dynamic Plus. Dotato di telecomando, aiuta a prevenire l’accumulo di alghe e batteri Repubblica Nazionale DOMENICA 26 LUGLIO 2009 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 GIARDINIERE Si prende cura del prato fino a superfici di tremila metri quadrati Automower 230 Acx, il tosaerbe prodotto dalla svedese Husqvarna Androidi troppo umani nell’era Blade Runner MULTIFORME Può assumere diverse forme e scopi Bioloid di Robotis Il suo kit comprende un software per programmarne i movimenti PINO CORRIAS a le macchine e i robot che ci circondano hanno un piano? Tecnologie amabilmente ci assediano. Ronzano intorno a noi su rotte di innocua vita quotidiana e ce la cambiano: guidano, cucinano, puliscono, riparano, comunicano, proteggono, giocano con noi. È possibile che sebbene fabbricati in polimeri e matematica binaria, percepiscano il sonno della ragione che li sta generando? Che addirittura lo assecondino? Incorporano perfezioni di prossimità umana che aumentano di serie in serie, di progetto in progetto. Aspirano, insieme con la polvere e le imperfezioni, i nostri desideri. Può essere che infine li realizzino per realizzare i loro? Fate mente locale: le macchine progettano altre macchine, le costruiscono, le riparano, faticano senza fatica, non conoscono la noia, e per il momento ci salvano la vita persino in sala operatoria. Chi può davvero dire che non arriverà il giorno in cui è la vita che ci ruberanno, o almeno il cuore? Non è del tutto secondario che sia il sesso la loro prossima frontiera che (dicono) sarà valicata a velocità crescente. Con crescente verosimiglianza a mimare l’umano, a sostituirlo, perfezionandolo con gli abbracci, il respiro, la temperatura. E che renderà plausibile agli umani — secondo David Levy, scienziato britannico, sessantadue anni, esperto di intelligenza artificiale — avere «relazioni sentimentali a lungo termine», con robot maschili e femminili entro il 2050. Scrisse negli anni Sessanta Phlip K. Dick, il più visionario tra i cartografi del nostro presente: «Nell’universo esistono cose gelide e crudeli a cui ho dato il nome di macchine. Il loro comportamento mi spaventa». Per una volta la sua preveggenza si è manifestata con un certo ritardo. Impedendogli di accorgersi che il futuro aveva già cominciato ad accadere: l’universo era precipitato sulla Terra da quando il primo robot aveva lasciato la sua impronta sulla sabbia, tra noi. Da allora le macchine e i robot si sono moltiplicati. Sempre coltivando la specializzazione più pervasiva, anche se occultata dall’utilità delle differenti funzioni: la fedeltà artificiale. Che ha il potere di rassicurarci come un mantra. O di gettarci nel panico quando si interrompe — per guasto tecnico, per disfunzione del destino o di un fusibile — lasciandoci intravedere il buio che ci separa dal funzionamento di tutte le cose artificiali che portano luce e senso, vantaggi e dominio, calore e nutrimento, dentro le piccole superfici della nostra fragilità umana. In un tempo non molto lontano l’uomo comune conosceva gli ingranaggi di quasi tutto quello che maneggiava: dagli utensili, alle stagioni. Il resto del mondo ignoto apparteneva al capriccio degli dei: i fulmini, i sogni, la malattia. Oggi quasi nulla di quello che assembla le nostre vite contiene equazioni risolvibili o bulloni che possiamo riconoscere o manici che siamo in grado di afferrare. Misteriosi meccanismi regolano tutto quello che ci accade nel tempo quotidiano. Maneggiamo energia, cibo, immagini, velocità, comunicazioni, temperature, mestieri, burocrazie, sapendo nulla, o quasi nulla, del flusso che ce le rende disponibili, tranne il pensiero magico che si autoavvera e che, un giorno alla volta, ci assoggetta. I robot e le macchine abitano questa misteriosa distanza tra noi e le funzioni animate dei loro involucri, le luci che le mettono in moto, i chip che le governano. Riempiono il vuoto che ci separa dalla materia. Nell’input di un telecomando, rendono istantaneo l’atto di volontà. Incorporano le nostre intenzioni e docilmente le trasformano nelle loro. Ma se provano qualcosa, cosa provano le macchine nei nostri confronti? La loro è solo indifferenza o è attesa? È un caso che milioni di motori a idrocarburi, ogni giorno, ci facciano viaggiare e insieme ci avvelenino? I molti vantaggi della velocità con cui attraversiamo lo spazio non sono la trappola che accelera il nostro costante sterminio? Ammettiamo pure che tutto vada letto come proiezione del nostro sofisticato istinto all’autodistruzione. Che l’imperturbabilità delle macchine che tanto ci inquieta non sia altro che lo specchio della nostra. Ma prima o poi — crescendo la loro perfezione in ragione proporzionale alla nostra dipendenza — ci toccherà ridefinire cosa è umano e cosa è artificiale. E non è detto che saremo solo noi a chiedercelo, proprio come accade ai replicanti di Blade Runner che hanno acquisito, oltre a tutti i saperi cibernetici, anche la consapevolezza umana della morte e dunque il senso della vita. A meno di non svegliarci, un giorno, dal sogno che ci sta sognando chissà da quale dimensione. E aprendo gli occhi ci riveli (con massimo spavento dei sensori) che siamo noi stessi macchine programmate per crederci umani. M UMANOIDE Mindstorm della Lego, il robot costruibile e programmabile nato nel 1998, ha inaugurato la serie di giocattoli hi-tech del terzo millennio SPAZZAGRONDAIE Si pilota con un telecomando Looj di iRobot Con la sua pala che ruota a 500 giri al minuto, pulisce le grondaie, spazzando via foglie e rami Robot casa di FIDO DIGITALE Gioca e simula la crescita da cucciolo ad adulto Aibo, il cane digitale messo in commercio dalla Sony nel 1999 Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 26 LUGLIO 2009 l’incontro Ribelli di successo Ha cominciato con James Dean e, come lui, ha rischiato di bruciarsi Ha infilato duecento ruoli nonostante l’ostilità delle major. È stato il simbolo della controcultura sull’onda del trionfo di “Easy Rider” e si è dovuto accomodare in comparsate nei B-movie “Pensavo di non arrivare ai trent’anni - dice adesso - e ne ho settantatré. Ogni giorno ringrazio Dio perché sono vivo e ho una famiglia splendida” Dennis Hopper ennis è un genio. Non sono sicura in cosa e neanche lui, credo, lo sappia. Certo, non nella recitazione. Ma è un genio». Chissà se l’eterna malinconia negli occhi dolenti da cristo in croce di Dennis Hopper, quello sguardo che l’ha reso un cattivo perfetto in troppi film d’autore, di lussuosa cassetta, perfino in alcuni horror di bassa lega, ma soprattutto l’ha destinato alla memoria come il compagno di viaggio di Peter Fonda in Easy Rider, sono causati dall’ingrata missione di dover essere un genio, come suggeriva nell’involontariamente crudele giudizio l’attrice e amica Joanne Woodward, oggi vedova Newman. Minuto e quieto, lontano anni luce dagli psicopatici incarnati sullo schermo, Hopper socchiude gli occhi e si gode il sole seduto sulla terrazza del Residence Gray d’Albion che affaccia sulla Croisette di Cannes. «Pensavo di non arrivare ai trent’anni, ne ho settantatré. Ogni giorno ringrazio Dio perché sono vivo e sano e ho una famiglia splendida», sorride. Anche la sua carriera, duecento ruoli tra cinema e tv, è splendida e tuttora attiva: nel 2008 ha girato sei film, tra cui Palermo Shooting di Wenders e la serie Crash per il canale Usa Starz, recentemente programmata in Italia sul canale Cult di Sky. «Sento che la mia avventura d’artista è tutt’altro che conclusa, sento di aver ancora molto da dire, da dimostrare». Il fuoco arde ancora, ma è ormai una sorta di fiamma perpetua, calda e gentile, non più quell’incendio che ha ri- va sparlato dell’autoritario Wayne. Ma il ribelle senza causa viveva immerso in tutt’altra cultura. Per lui il Metodo era la nuova religione e la “memoria emozionale” lo strumento per aprire le porte di ogni arte, non solo la recitazione. «Ero un ragazzino che veniva da Dodger City, Kansas profondo, avevo un unico approccio per tutti i campi dell’arte moderna». Parigi ha da poco celebrato alla Cinématéque il suo eclettico talento con la sontuosa mostra Dennis Hopper e la nuova Hollywood: non solo film ma anche quadri, scultura, scatti e le immagini del suo tesoro da collezionista. Ha sempre avuto il fiuto per gli artisti e oggi vive in una casa lussuosa a Venice Beach, la Los Angeles freak, disegnata da Frank Gehry. «Comprai i primi quadri di Andy Warhol, uno lo pagai 76 dollari. Presi un Roy Lichtestein per 1.100 dollari, lo cedetti in uno dei divorzi e oggi ne vale 17.500. Amo Julian Schabel e considero un onore aver girato con lui Basquiat». «Solo la musica non mi è mai appartenuta fino in fondo — confessa — anche se con Easy Rider, ed è una delle cose di cui vado più Nel film tratto da Kerouac c’era l’affresco di una provincia americana perbenista, ipocrita e violenta E l’energia di una generazione on the road FOTO CORBIS «D CANNES schiato di rendere cenere la sua vita. La prima scintilla arrivò a diciotto anni, sul set di un film che si chiamava Gioventù bruciata, insieme all’incontro con James Dean. «Lui sì, era un genio — spiega Hopper —. Io venivo da esperienze di recitazione shakespeariana in cui ogni battuta, ogni gesto erano precostruiti. Ma questo giovane uomo non recitava, lui era: non mostrare che apri uno sportello, aprilo e basta, mi diceva». Si ritrovarono insieme l’anno dopo per Il gigante, l’ultimo, incompiuto film del giovane Dean. «È stato un grande dolore la sua morte e ugualmente grande è stata la rabbia verso chi parlava di suicidio. Nessuno aveva tanta voglia di vivere quanto lui. Ricordo le lacrime di Liz Taylor quando riprendemmo a girare. Dovette abbandonare la scena decine di volte. Scoppiava a piangere, non ce la faceva. Non eravamo amici, James e io, non andavamo a bere insieme. Aveva cinque anni più di me, era maturo, io un ragazzino. Ma mi dava consigli, guardava i giornalieri e mi diceva come andavo. E quando iniziò a interpretare il personaggio che invecchiava, mi chiese di guardare i suoi girati». Dean, la cui vicinanza avrebbe cambiato Hopper per sempre, «non era una promessa del cinema, era una certezza. Film come Lassù qualcuno mi ama e Nick mano freddasarebbero stati suoi». E invece andarono a Paul Newman, che si vide aprire le porte di una luminosa carriera. «Già, ma se lo meritava. Eravamo amici da quando avevo diciotto anni, ho trascorso cento fine settimana a casa a sua e di Jeanne Woodward quando vivevano ancora in California. È stato l’uomo più buono e altruista che abbia mai conosciuto». Dennis Lee Hopper era inquieto, invece. La fiammella di Stanislavskij, accesa da Dean, ardeva forte nel cuore del giovane attore sotto contratto con la Warner. Ma l’improvvisazione era poco gradita da registi dirigisti come Henry Hathaway. All’ennesima lite, Hopper smise di lavorare con le major. Se ne andò per cinque anni a New York, a studiare il metodo con Lee Strasberg. I grandi contrasti con pezzi di potere hollywoodiano garantirono a Hopper anni di serie televisive, come Ai confini della realtà, e B-movie. Fu richiamato dallo stesso Hathaway nel ‘65, sul set de I quattro figli di Katie Elder e poi su quello de Il Grinta dove, leggenda vuole, fu inseguito, pistola in pugno, da John Wayne al grido: «Dove si nasconde Pinko Hopper? Gli devo parlare». Hopper, rifugiatosi nel camper di un collega, era colpevole di essere amico di un esponente delle Pantere Nere che ave- fiero, per la prima volta al posto di un commento orchestrale ho cucito la colonna sonora con le hit di artisti come Steppenwolf, Jimi Hendrix, The Byrds. Costò poco. Allora bastava andare a cercare gli artisti e chiedere il permesso. Il risultato è stato una sorta di capsula sonora di quegli anni». Ma Easy Rider, girato esattamente cinquant’anni fa, è stato molto di più. «L’affresco di una provincia americana perbenista, ipocrita e violenta, l’energia di una generazione on the road». Ricorda Hopper: «Per la prima volta al cinema mostravamo personaggi che facevano uso di marijuana senza, necessariamente, essere criminali». Divenne il manifesto perfetto della controcultura del tempo, sancì l’affermazione del cinema indipendente, la dimostrazione di un successo possibile fuori dalle major. Hopper l’ha scritto e diretto, oltre che interpretato. Ne è orgoglioso. Non parla volentieri di Peter Fonda, con il quale ci sono state spiacevoli questioni economiche legate ai diritti, mentre s’illumina al nome di Jack Nicholson: «Un amico generoso e presente, il professionista più disponibile mai incontrato». Sì, Jack Nicholson. Diventò l’interprete naturale, filologico di quegli anni spostati, generosi. Aveva scritto lui Il serpente di fuoco, due anni prima di Easy, nel cast c’erano Fonda e Hopper. Il titolo inglese, The Trip, raccontava il viaggio nel lsd di un regista televisivo in crisi interpretato da Fonda. Nicholson sostiene che all’epoca le case farmaceutiche incoraggiavano la sperimentazione senza mettere in guardia dagli effetti devastanti delle droghe psichedeliche: «Era davvero un modo per aprirsi alla creatività, solo che poi spalancava le porte dell’inferno. Prendevamo lsd per cercare Dio e nella realtà ci ritrovavamo a bussare alla porta di uno spacciatore». Grazie allo straordinario successo di Easy Rider il nuovo regista della controcultura americana poté finalmente realizzare Fuga da Hollywood, storia di un film girato nelle Ande, in un villaggio d’indiani peruviani. Era il ‘71. Fu premiato alla Mostra di Venezia, ma disconosciuto dalla casa di produzione. «Mi chiesero di rimontarlo, rifiutai, mi dissero che non sarebbe mai uscito. Magari non sono diventato un genio, ma non è stata solo colpa mia». Dopo quel disastro nessuno gli avrebbe più prodotto niente. Il fondo, in quegli anni, lo raggiunse in New Mexico, dove si era trasferito e dove voleva girare un altro film: una notte, dopo un mix di alcol e coca, la polizia lo trovò nudo che correva tra i boschi. Lo misero su un aereo per Los Angeles dal quale, ride mentre lo rac- conta, cercò di fuggire aprendo l’uscita di sicurezza. Fu internato in un ospedale psichiatrico e gli fu somministrato un farmaco che gli provocava gli stessi effetti del parkinson. «Tremavo, non riuscivo a parlare. Non pensavo per me ci fosse la possibilità di una nuova vita, e invece il miracolo avvenne». Nel 1986 Dennis Hopper smise con alcol e droga, e smise di maltrattare le sue donne. Qualche anno dopo avrebbe incontrato Victoria, la quinta moglie, trent’anni più giovane, che gli ha regalato una vita serena. Il controverso Hopper oggi ha ritrovato equilibrio e speranza politica: agli anni della ribellione erano seguiti quelli da conservatore, a sostegno di Reagan e di entrambi i Bush. È stato Barack Obama a riconciliarlo con la tradizione familiare democratica. Ma sulla sua difficile recitazione, dibattito ancora aperto quando il protagonista viaggia verso i settantaquattro anni, c’è tutta una letteratura a supporto. Marlon Brando sul set di Apocalypse Nowchiese di non dividere scene con lui, non sopportava le sue ubbie improvvisative. Lo stesso Francis Ford Coppola rischiò l’esaurimento nelle centinaia di strampalati ciak personalizzati: «Ne puoi fare uno, soltanto uno, come dico io?». Poi, lo richiamò in Rusty il selvaggio. Fu lì che il giovane Sean Penn fu folgorato dall’Hopper’s Method. «Arrivai una notte perché nel cast c’era mio fratello, Chris Penn. Hopper girava la scena in cui diceva al figlio, Matt Dillon, della madre. La battuta era: “No, tua madre non era pazza, solo pensava in modo differente dagli altri”. Invece al ciak partì: “Tua madre non era pazza, vedeva zoccoli di bufalo sul dorso di elefanti e arcobaleni venire su dal culo di un’anatra, ma non era pazza”. Capii che quello che avevo imparato fino allora sulla recitazione era da buttare». ‘‘ ARIANNA FINOS Repubblica Nazionale
Scarica