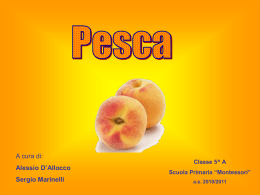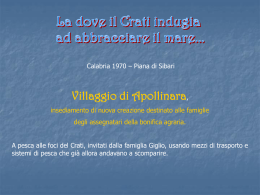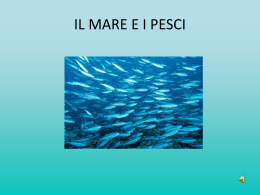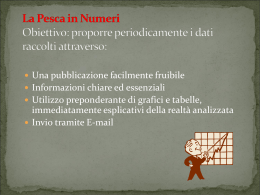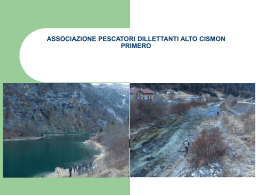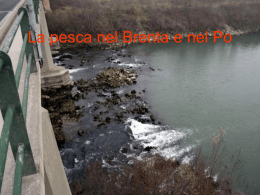La pesca professionale nell’AMP Portofino In Liguria la piccola pesca artigianale, un’attività praticata sottocosta con piccole imbarcazioni, occupa un posto di rilievo nell’economia di molti borghi costieri e assolve un ruolo sociale e culturale di primaria importanza. Poche AMP in Italia possiedono un patrimonio di cultura marinaresca come l’AMP di Portofino e l’Ente Gestore è chiamato a studiare e tutelare tale risorsa. Scopo principale di un’Area Marina Protetta (AMP) sarà quindi salvaguardare le sue risorse naturali e tutelare le tradizioni locali, quando queste si svolgano in armonia con le esigenze di una corretta conservazione. La pesca professionale e dilettantesca sono, evidentemente, attività di grande impatto sull’ambiente naturale e sulla struttura delle comunità marine: basti pensare ai danni che provoca la pesca a strascico, giustamente proibita in tutte le AMP italiane. In questo senso il problema all’interno delle AMP non c’è, visto l’esistenza del divieto di praticare questo tipo di pesca. La pesca all’interno delle AMP resta, comunque, un problema gestionale tra i più importanti e difficili, ma negli ultimi anni i pescatori professionisti, sopratutto gli operatori della piccola pesca costiera, hanno saputo modificare il loro rapporto con il mare ed oggi possono diventare i protagonisti nella gestione della fascia costiera e nell’uso consapevole dell’ambiente in cui operano. Infatti, la loro capacità d’utilizzare metodi ed attrezzi selettivi, di differenziare le specie bersaglio a seconda della stagione, d’accettare alcune restrizioni in termini di periodi o aree di pesca, dimostra la disponibilità del pescatore ad operare in sintonia con le regole di protezione dell’ambiente. E’ un processo molto lento e difficile, ma che sta dando i suoi primi frutti in alcune AMP italiane (Cattaneo-Vietti & Tunesi, 2007). La principale sfida che l’AMP di Portofino ha raccolto al momento della sua istituzione è conservare la straordinaria biodiversità dei suoi fondali, evitando che l’uso delle risorse biologiche e paesaggistiche e le attività di pesca provochino danni alle comunità che si vogliono proteggere, ma al tempo stesso studiare e valorizzare le tradizioni legate al mare che si sono sviluppate sul suo territorio in centinaia di anni (Cattaneo & Bava, 2009). In questo contesto la realtà esistente nelle marinerie locali dei tre Comuni facenti parti dell’Area Marina, in particolare quella di Camogli, ben si inserisce nelle attività da valorizzare all’interno del territorio, in quanto rappresenta ormai da anni un borgo marinaresco molto attivo per la piccola pesca. La particolarità in questo senso sta nel fatto che Camogli rappresenta una perla all’interno di quella che è la realtà delle marinerie del Mediterraneo, un mare già di per sé particolarmente ricco e con caratteristiche che hanno favorito il diffondersi di specie bersaglio nettamente diverse e che pertanto impongono obbligatoriamente l’uso di attrezzi diversi: l’attività di pesca in tutto il comprensorio ha radici molto antiche e i pescatori raccontano che negli anni si sono succeduti cicli biologi nettamente differenti l’uno dall’altro che hanno visto l’alternarsi di una specie piuttosto che un’altra, nonché la comparsa di specie “nuove” a seguito di fenomeni quali ad esempio la meridionalizzazione del Mediterraneo. Più specificatamente la pesca professionale nell’AMP Portofino è un’attività artigianale che, essendo praticata con metodi invariati da centinaia di anni è radicata nella tradizione dei Golfi Tigullio e Paradiso. Nell’AMP Portofino la pesca professionale è riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data del 4 agosto 2008. Nella zona di riserva integrale la pesca è vietata. Gli attrezzi consentiti sono reti da posta fissa (in Zona B disposte perpendicolarmente alla linea di costa), palangari aventi un numero massimo di duecento ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, (in Zona B calati a profondità non inferiore a 40 m o 50 m a seconda dei siti, in Zona C ad una distanza minima di 50 m dalla costa), reti a circuizione e fonti luminose; nelle Zone B e C è inoltre consentita l’attività professionale per la pesca al rossetto (Aphia minuta), previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i modi e i tempi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza e che abbiano già svolto tale attività prima del 31 dicembre 2004. Censimento dei pescatori che operano in AMP Per conoscere e caratterizzare l’attività di pesca professionale in AMP è stato effettuato un censimento delle imbarcazioni e dei pescatori attivi. Tale campionamento è stato condotto grazie alla collaborazione dei responsabili delle cooperative che, sottoposti ad interviste, non hanno esitato a comunicarci i dati anagrafici dei soci, le targhe delle imbarcazioni e le tecniche adottate da ciascun pescatore. Riportiamo di seguito la scheda utilizzata per raccogliere i dati durante le interviste. Figura 86: scheda per la raccolta dati dei pescatori professionisti Il primo dato ad emergere è che in AMP operano 57 pescatori distribuiti tra le marinerie di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure come illustra la figura 87. Figura 87: numero dei pescatori professionisti divisi per marineria di appartenenza Nella quasi totalità dei casi i pescatori sono riuniti in cooperative: a Camogli sono presenti la “Cooperativa pescatori di Camogli” (27 iscritti), la cooperativa Castel Dragone” (5 iscritti) e la “Cooperativa San Fortunato” (3 iscritti); a Portofino la “Cooperativa pescatori di Portofino” (6 iscritti), a Santa Margherita Ligure la cooperativa di servizio “La Calata” (11 iscritti). Gli attrezzi utilizzati dai membri della “Cooperativa pescatori di Camogli” sono le reti da posta fissa (tremaglio, incastellata, imbrocco in monofilo di nylon, palamitara), sciabica per rossetto, lampara, reti a circuizione, palangari e tonnarella; quest’ultimo attrezzo è concesso esclusivamente alla cooperativa in questione nel tratto di mare che va dalla casa del Generale al Mulino da Drin circa. Come gli iscritti alla “Cooperativa pescatori di Camogli”, i soci delle cooperative “Castel Dragone” e “San Fortunato” espletano la propria attività tramite reti da posta, palangari, reti a circuizione, lampara e sciabica per rossetti inoltre hanno la concessione per utilizzare la mugginara nella zona di Porto Pidocchio; la cooperativa Castel Dragone svolge anche attività di pescaturismo. I membri della “Cooperativa pescatori Portofino”, fatta esclusione per tonnarella e mugginara, adottano gli stessi attrezzi dei colleghi camogliesi, mentre i pescatori sammargheritesi della cooperativa “La Calata” utilizzano esclusivamente reti da posta e palangari anche se talvolta praticano la pesca del polpo per mezzo di apposita polpiera. L’imbarcazione più diffusa per l’attività di pesca professionale risulta il tipico gozzo ligure, in legno o vetroresina, con motore entrobordo. L’età media dei pescatori è pari a 54,4 anni, la marineria più “giovane” risulta essere quella di Portofino con un’età media pari a 43,8 anni, la più “anziana” è Santa Margherita con i suoi 66,3 anni di età media, mentre l’età media degli operatori di Camogli è 53 anni. In questo senso ultimamente ci si chiede sempre più spesso se gli operatori della piccola pesca rappresentino ormai una “specie in via d’estinzione”, in quanto ciò che emerge dai rilevamenti effettuati nell’AMP Portofino è facilmente riscontrabile anche in altre AMP italiane le cui marinerie da anni basano la propria economia sulla piccola pesca (quali ad esempio Porto Cesareo in Puglia e Tavolara in Sardegna): tra il 50 e l’80% dei pescatori, l’età maggiormente riscontrabile si aggira tra i 50 e i 70 anni, mentre solamente un valore percentuale compreso tra il 10 e il 40 dei figli dei pescatori è intenzionato a continuare l’attività del padre. Già a livello nazionale l’attività del pescatore professionale ha incontrato negli ultimi anni diversi ostacoli quali ad esempio il forte aumento dei costi (come per esempio quello per il carburante), quello dei punti vendita (che ha favorito gli intermediari che compongono le filiere commerciali a discapito dei pescatori stessi), nonché le misure adottate a livello comunitario che hanno ridotto di molto il numero degli addetti e delle imbarcazioni negli ultimi anni. Se, infine, si fa riferimento alle AMP, a queste misure si sono aggiunti altri fattori quali la sottrazione di determinate aree di pesca (le zone A). Nonostante questo però, da un altro punto di vista, le AMP possono rappresentare un’occasione per invertire questo “trend” in declino del pescatore locale, attraverso, per esempio, misure di conservazione della diversità culturale delle comunità locali, pescatori compresi; incentivi per promuovere attività economicamente ed ecologicamente sostenibili (come ad esempio il pesca turismo, la commercializzazione del pesce povero nonché di prodotti alimentari tradizionali conservati), integrando così il reddito derivante dalla pesca, attività dura e non prevedibile per definizione perché strettamente legata a cicli biologici e condizioni ambientali in continua evoluzione. Come si intuisce dalla figura 88, il 56% dei pescatori è residente in uno dei tre comuni bagnati dall’AMP che quasi sempre coincide con il comune in cui ha sede la cooperativa di appartenenza. Figura 88: studio sulla residenza dei pescatori professionisti divisi per marineria di appartenenza Come evidenziato nella tabella 6 gli attrezzi più diffusi sono le reti da posta fissa (tremagli, incastellata, imbrocco a monofilo di nylon, palamitara, aragostara, imbrocco a treccia) seguite da palamiti e reti a circuizione. Nei grafici è mostrata la situazione per ogni marineria. Tabella 6: Percentuale operatori che utilizzano un determinato attrezzo ATTREZZI Totale generale in % reti da posta fissa 50,8 Palangari 24,6 Polpiera 3,3 sciabica per rossetti o bianchetti Lampara 21,3 19,6 Tonnarella 18 Mugginara 6,6 Figura 89: numero di pescatori di Camogli che utilizzano un determinato attrezzo Figura 90: numero di pescatori di Portofino che utilizzano un determinato attrezzo Figura 91: numero di pescatori di Santa Margherita Ligure che utilizzano un determinato attrezzo E’ evidente che la marineria che registra la maggior diversificazione negli attrezzi è quella di Camogli, ad indicare ancora una volta il perdurare, in questa località, di antiche radici e tradizioni pescherecce. Monitoraggio reti da posta fissa e palangari Conoscere quanto sono utilizzate le reti da posta risulta essere molto importante poiché alcune tipologie di esse, tremagli in primis, oltre a creare un indubbio impatto sulle popolazioni ittiche, possono arrecare, se male posizionate, danni significativi ai fondali; infatti, grazie ai colloqui con gli operatori del settore, abbiamo appreso che un tramaglio, seppur calato correttamente, raccoglie anche esemplari di specie strettamente bentoniche come crostacei ed echinodermi. A tale proposito, in Sartor et al. (2008) sono stati riportati alcuni studi effettuati su tipologie di pesca che utilizzano differenti reti da posta lungo le coste italiane, nelle quali sono state osservate, fra le catture, elevate percentuali di specie non commerciabili, unitamente allo scarto di specie commerciali costituito per lo più da esemplari danneggiati durante le operazioni di pesca e da organismi di piccola taglia (anche se in misura minore). Tale situazione è comune a molte realtà italiane della piccola pesca mediterranea e una recente Comunicazione Europea riporta che, in questo bacino, gli scarti della pesca con i tramagli variano dal 15 al 35 % della cattura totale e quelli della pesca con reti a imbrocco si aggirano intorno al 10 %. Figura 92: stella marina in tramaglio (Foto V. Cappanera) L’esigenza di diminuire l’impatto delle reti da posta e aumentarne la selettività è manifestata anche dai pescatori, in quanto la presenza di catture indesiderate spesso allunga notevolmente i tempi di lavoro per la pulizia delle reti, determinando così un precoce danneggiamento delle attrezzature, aumentando i costi e riducendo le giornate utili di pesca. Per preservare i popolamenti sessili di fondo duro presenti nella Zona B dell’AMP, il regolamento di esecuzione ed organizzazione impone che in tale zona le reti da posta fissa siano calate perpendicolarmente alla costa cosicché la porzione di attrezzo a contatto con il coralligeno sia minima. Dal mese di giugno dell’anno corrente è in corso una campagna di monitoraggio da gommone degli attrezzi da posta fissa volta a quantificare lo sforzo di pesca e ad individuare i siti preferiti dai pescatori. Per questo studio è stata adottata la suddivisione della riserva in 18 settori definita in passato attraverso punti cospicui della costa per monitorare la nautica da diporto (figura 93). Figura 93: suddivisione in settori dell’AMP Portofino Come si deduce dal grafico di figura 94, i siti nelle zone C sono preferiti a quelli nelle zone B, con una forte concentrazione elevata nel tratto di mare delimitato da Olivetta e Punta del Faro di Portofino. I pescatori non calano spesso in Zona B poiché tale zona è contraddistinta da fondali rocciosi nei quali è facile danneggiare l’attrezzo che per essere riparato richiederebbe una spesa maggiore dell’eventuale guadagno ottenuto dal pescare in riserva generale. Figura 94: numero di attrezzi da posta fissa censiti nei diversi settori dell’AMP La figura 95 evidenzia l’assiduità dei singoli pescatori, qui identificati dalla targa della propria imbarcazione, nel calare attrezzi da posta fissa. Figura 95: numero di attrezzi da posta fissa censiti per ogni singolo pescatore delle tre marinerie dell’AMP Dalla figura 95 è facile apprendere che, nonostante costituiscano la marineria meno numerosa, i pescatori portofinesi sono coloro che utilizzano maggiormente gli attrezzi da posta fissa in AMP. Riportiamo qui di seguito la carta dell’AMP con i siti di cala per gli attrezzi da posta fissa. Figura 96: disposizione degli attrezzi da posta fissa nei diversi settori dell’AMP Dalla cartina risulta evidente che le zone di maggior concentrazione degli attrezzi sono, come già accennato, le due zone C e la zona Est del Fronte Sud: tali zone dovrebbero essere tenute particolarmente sotto controllo, in particolare il Fronte Sud (soprattutto palamiti) dove si ha competizione elevata con un’altra attività di fruizione, la subacquea. Questa è un’altra attività che ha raggiunto negli ultimi anni numeri significativi a Portofino e spesso, durante le uscite in mare, gli operatori si sono trovati a dover prendere atto dell’estrema vicinanza di alcuni attrezzi da pesca alle boe adibite a tale attività subacquea. Per cercare di armonizzare i rapporti fra le due attività, il nuovo Regolamento ha previsto che gli attrezzi da posta siano recuperati nelle prime ore del mattino e siano riposizionati solo dopo il tramonto, in particolare laddove sono presenti siti d’immersione. In questo senso l’attività di sensibilizzazione andrebbe sicuramente incrementata, ma, spesso, anche colti sul fatto, i pescatori locali sembrano non comprendere l’importanza di certe regole che indipendentemente dal regolamento dell’AMP costituiscono per lo più una regola di buona condotta e di maggiore sicurezza. Quando si parla di pesca professionale non si può che fare almeno un accenno a tonnare, tonnarelle, bestinare e mugginare, sistemi trappola che hanno fatto la storia della pesca mediterranea, ma soffrono oggi di una lunga, inevitabile crisi: fanno eccezione, appunto, la Tonnarella e la Mugginara di Camogli che, pur tra quotidiani problemi, continuano il loro antico mestiere (Cattaneo & Bava, 2009). Pertanto l’area marina, nell’ottica di una gestione delle risorse e delle attività di fruizione che la caratterizzano, da alcuni anni sta continuando a monitorare le catture che vengono effettuate stagionalmente da questi due secolari sistemi di pesca. Per quanto riguarda però la mugginara, quest’anno non è stato possibile recuperare i dati circa le catture. La Tonnarella La Tonnarella di Punta Chiappa esiste da sempre: documenti storici datano la sua attività fin dai primi del XVII secolo, ma non si può escludere che sia ancora più antica, coeva di una rete posta in mare tra Santa Margherita Ligure e Portofino e di cui si ha notizia fin dal XIV secolo (Cattaneo & Bava, 2009). A differenza di quella che è una tonnara tradizionale, quale ad esempio quella carlofortina, la tonnara di Camogli, pur mantenendo l’antica denominazione, di fatto non pesca più tonni ma pesci di passo, sfruttando il vortice di correnti che si viene a delineare nel Golfo Paradiso per l’incontro di una corrente Levantina (da Est a Ovest) ed una Ponentina che, oltre Punta Chiappa determinano un gyre in senso orario che lambisce la costa (tale andamento è illustrato in figura 97). Figura 97: rappresentazione schematica dell’andamento delle correnti superficiali intorno al Promontorio di Portofino (P. Povero, Università di Genova, dati non pubblicati). Sia a levante che a ponente del Promontorio si formano due controcorrenti che influenzano notevolmente l’andamento della pesca nell’area. Diversamente in figura 98 è riportata una rappresentazione in 3D dello sbarramento costa-largo che caratterizza la tonnara. Figura 98: schema tridimensionale della tonnarella (Torre, 2005) Questa tradizionale rete è calata in mare da ormai centinaia d’anni da aprile a settembre a circa 400 metri da Punta Chiappa, nelle acque sottostanti la millenaria chiesa di San Nicolò di Capodimonte. E’ fissata a terra a Sca’ di Rocco, uno scoglio da cui parte la rete d’arresto, il pedale (talvolta chiamata pesale a Camogli), che perpendicolarmente va dalla costa al largo. Il suo scopo è chiudere il passaggio ai pesci sotto costa e guidarli verso una prima camera grande o di raccolta. Da qui i pesci entrano nella lea, la camera della morte. Figura 99: Sca’ di Rocco (foto C. Umili) La posizione della tonnarella di Camogli non è casuale, ma il risultato di attente e, si potrebbe dire, centenarie osservazioni. In primis è necessario calare la rete e sopratutto il corpo che si appoggia sul fondale in un punto in cui non ci siano rocce o ferrature che potrebbero strappare la rete o impedirne il recupero. In una zona ricca di scogli affioranti dal fondo detritico, l’ubicazione non è facile e solo un’antica esperienza permette ogni anno di calare la lea senza danni (Martini, 198586). In questo contesto i riferimenti a terra sono risultati negli anni particolarmente importanti soprattutto nella ricerca degli idonei siti di cala e, in tal caso, nella fase di messa a mare della tonnarella stessa: i punti cospicui sono stati significativi soprattutto negli anni in cui non vi era ancora un sistema di riferimento quale il GPS; basti pensare che il posizionamento della barca da pesca che viene lasciata tutta la stagione nello specchio d’acqua sotto S.Nicolò, l’Andrea II, viene effettuato grazie alla ricerca di un buco in uno scoglio nei pressi del ristorante di Porto Pidocchio. In figura 99 è raffigurato un momento della messa a mare. Figura 100: messa a mare della rete in aprile (Foto V. Cappanera) La rete della tonnara è tessuta in fibra vegetale: il cocco. La sua manifattura e quella delle cime d’ormeggio e di levata (branchelle) avvengono sia a Camogli che a San Fruttuoso,dove si utilizza un sistema realizzato su un modello seicentesco. Qui si intrecciano le cime e i lunghi cavi di fibra di cocco che servono per legare i vari spezzoni della rete e sollevare il sacco durante la leva (Cattaneo & Bava, 2009). Fino agli anni ’70 tutto il comprensorio del monte era coinvolto nella manifattura della rete, non solo S. Fruttuoso e Camogli, ma anche il “vivo” approdo di Porto Pidocchio, cui spettava il compito di preparare i cavi d’acciaio e le ancore per il fissaggio sul fondo della rete; ancora oggi sono visibili i segni di questa attività: lo scoglio in prossimità del Ristorante Spadin, mostra infatti ancora macchie causate dalla presenza di catrame in quanto i cavi d’acciaio, utilizzati per issare le ancore venivano avvolti dalle cime e successivamente “incatramati” in forno con la pece al fine di creare maggior tenuta durante le operazioni di carico del materiale. In quegli anni, un tipico prodotto della comunità di S. Fruttuoso era la lisca (Ampelodesmos mauritanicus), una pianta dalle cui foglie si ricavava una corda particolarmente resistente utilizzata un po’ in tutta la Liguria; tale pianta (detta taglia mani per le sue particolari proprietà) era stata utilizzata per un certo periodo per “far su” la rete della tonnara. Dopo sperimentazioni che hanno visto l’utilizzo di materiali differenti (quali ad esempio la canapa o il nylon), la fibra di cocco è risultata la più idonea all’uso; pare infatti che questa fibra sia determinante per lo stabilirsi sulla rete stessa di complessi popolamenti animali e vegetali che costituiscono un fouling “attrattivo” per specie ittiche costiere (Boero e Carli, 1997). Tale fibra, a fine stagione, viene abbandonata sul fondo e non recuperata in quanto completamente biodegradabile. L’ultima parte della rete, la lea (camera della morte) è invece in nylon e pertanto non subisce lo stesso fenomeno. Questa parte terminale viene ogni anno tinta a caldo sul molo di Camogli con un colorante chimico, al fine di renderla invisibile ai pesci più scaltri che potrebbero deviare ancora il loro percorso anche se già entrati nella camera di raccolta (figura 100); anticamente le vasche di rame dove avveniva il procedimento di tintura della rete erano le così dette “puieua”. . Figura 101: tintura a caldo della lea attraverso un colorante chimico (foto S. Bava) Le barche che caratterizzano la tonnarella sono tre: quella ormeggiata al centro del corpo si chiama poltrona, utilizzata per salpare la rete, mentre quella che va avanti e indietro dal porticciolo di Camogli per portare l’equipaggio ed il pescato, è l’asino. La rete viene salpata tre volte al giorno, all’alba, il mattino e nel tardo pomeriggio ed il pesce viene avvistato grazie ad uno specchio (batiscopio) in mano al capoguardia che si trova sulla vedetta, una piccola lancetta a remi. Ciò che avviene durante la levata è illustrato in figura 102. Figura 102: schema dello spostamento delle barche durante la levata (Torre, 2005) Le levate sono solitamente tre, ma con l’avanzare della stagione possono diminuire a causa della mancanza di pesce. Le stagioni 2007-2008 Durante le stagioni 2007-2008, l’equipaggio è stato normalmente costituito da sei persone con turno settimanale e cambio effettuato il venerdì. Le “regole” vengono dettate da un Capobarca che, negli ultimo due anni, essendo rimasto l’unico, effettua il doppio turno. La prima levata, l’albetta, prevede una partenza dal porto di Camogli alle 3.30 circa di notte mediante l’asino ormeggiato in banchina e viene effettuata sempre, in quanto il fatto che avvenga in notturna non permette di verificare la presenza o meno del pesce con lo specchio. Durante questa levata vengono catturati per lo più pesci di piccole dimensioni che devono essere catturati prima che il sole illumini del tutto la rete, dal momento che le maglie iniziali della tonnarella sono abbastanza grandi e gli stessi pesciolini riescono facilmente ad entrare e uscire (i pescatori raccontano infatti che le notti di luna piena non sono molto proficui per la pesca); differentemente la presenza di fitoplancton bioluminescente si pensa aumenti la sensazione di sbarramento avvertita dagli stessi e pertanto è particolarmente apprezzata dai pescatori stessi. Figura 103: la chiusura della lea all’albetta (foto V. Cappanera) Figura 104: pesci (soprattutto Trachurus spp.) di piccola taglia nella lea (foto V. Cappanera) Questa levata è la più breve proprio perché viene effettuata senza guardare con il batiscopio; il rientro in terra avviene intorno alle 6 quando viene effettuata una breve sosta per rifocillarsi e ripartire appena dopo le 7 iniziando a tirare la rete intorno alle 9.30, a seconda della presenza del pesce. In figura 105 è raffigurato un momento della levata del mattino. Figura 105: la levata del mattino (foto V. Cappanera) Nel pomeriggio la partenza dal porto avviene intorno alle 16.30, con rientro previsto tra le 18.30 e le 19, in relazione alla maggiore o minore quantità di pesce, fortemente influenzata dalle correnti e a discrezione quindi del capobarca di turno. La durata delle operazioni di levata è strettamente correlata anche alla quantità di pesce che può rimanere “immagliato” nella rete e che determina quindi un appesantimento della stessa. Accade per esempio che spesso, nella prima parte della stagione di pesca, ovvero nei mesi di maggio e giugno, numerosi esemplari di pesce luna (Mola mola), invadano nel vero senso della parola la camera della morte e restino intrappolati nella rete appesantendola molto e creando così non pochi problemi all’equipaggio di turno. Infatti è ormai noto che i pesci luna, seppur numerosi nelle acque del Golfo Paradiso, quando restano intrappolati nella rete della Tonnarella, vengono immediatamente liberati in mare in quanto non hanno sul mercato un valore commerciale. In figura 106 è illustrato un momento in cui le operazioni di levata si interrompono per liberare in mare i pesci immagliati. Figura 106: liberazione di un esemplare di pesce luna (Mola mola) immagliato nella rete (foto V. Cappanera) Le numerose “catture accidentali” di Mola mola che vengono comunque liberati rappresentano quindi un problema per chi gestisce la tonnara, sia in termini di tempo, sia in termini economici. Per quanto riguarda più propriamente le catture di queste due stagioni di pesca, occorre sottolineare in primis che, come già precedentemente accennato, la tonnarella pesca pesce di passo e le sue specie bersaglio sono quindi soprattutto ricciole, boniti, palamite, tonnelle, sugarelli, boghe chiamati a Camogli con nomi volgari propri di questo borgo marinaresco. Nella tabella 7 è riportato pertanto un “dizionario” camogliese in cui ciascuna specie è identificata con il suo termine in italiano, scientifico e locale. Tabella 7: Dizionario camogliese - italiano della tonnara dialetto camogliese Agn nome comune aguglia nome scientifico Belone belone ancia, gianchetto da galla (j.*) acciuga Engraulis encrasicolus Büdego rana pescatrice Lophius budegassa Buga boga Boops boops Cavalla lanzardo Scomber colias Dëntexo dentice Dentex dentex Êuggiâ occhiata Oblada melanura gianchetto da fndo, lunarino bianchetto di fondo Crystallogobius linearis gianchetto da galla bianchetto (j. di sardina) Sardinia pilchardus Giânello rana pescatrice Lophius piscatorius Laxerto sgombro Scomber scombrus leccia, lecciotta (j.*) ricciola Seriola dumerili Luasso spigola, branzino Dicentrarchus labrax lüssu de mà luccio di mare, barracuda Sphyraena spp. mangia pece lampreda Petromyzon marinus Menoa menola Spicara maena Mêua pesce luna Mola mola Museu cefalo, muggine Mugil sp., Liza aurata Oâ orata Sparus aurata Oca corvina Sciaena umbra Pämïa palamita Sarda sarda Papagallo lampuga Coryphaena hippurus pescio spâ pesce spada Xiphias gladius Roscetto rossetto Aphia minuta Rundine pesce volante Exocoetidae Sagâo sarago maggiore Diplodus sargus salacca, laccia Salbuga sardenha, sardenn-a cheppia cheppia di grossa taglia alaccia Alosa sp. Alosa sp. Sardinella aurita sardenha, sardenn-a, paase (j.*) sardina Sardina pilchardus Sarpa salpa Sarpa salpa Sarpa sulla, pinzüa sarago pizzuto Diplodus puntazzo Scatausella Serraiola costardella leccia Scomberesox saurus Lichia amia Strmbo tombarello, biso Auxis rochei Su sugarello Trachurus mediterraneus su verde sugarello Trachurus trachurus Tanüa tanuta Spondyliosoma cantharus testa nêigra sarago fasciato Diplodus vulgaris Tonnella Tnno tonnetto tonno Euthynnus alletteratus Thunnus thynnus Zeru zero Spicara smaris pesci cartilaginei - selaci ferrassa, ciuccio ferrassa, ciuccio Gattopardo trigone Trigone violetto gattopardo Dasyatis pastinaca Pteroplatytrygon violacea Scyliorhinus stellaris Gattûsso gattuccio Scyliorhinus canicula Manta manta o diavolo di mare Mobula mobular Meanto makò Isurus oxyrhinchus Meanto smeriglio Lamna nasus meanto tnno Squalo bianco, pesce cane Carcharodon carcharias Nissêua Nissêua pescio elefante palombo liscio palombo stellato squalo elefante Mustelus mustelus Mustelus asterias Cetorhinus maximus pescio martelo, pescio scrssua pescio ratto squalo martello squalo volpe Sphyrna zygaena, Sphyrna mokarran Alopias vulpinus Razza spinosa razza Raja sp. Tremulina torpedine Torpedo sp. Verdn verdesca Prionace glauca tartarughe Tartarüga Tartarüga boe main ca-adiün Drafin Drafin Drafin tartaruga comune tartaruga liuto mammiferi marini foca monaca, bue marino globicefalo delfino comune stenella striata tursiope Caretta caretta Dermochelys coriacea Monachus monachus Globicephala melas Delphinus delphis Stenella coeruleoalba Tursiops truncatus j.*: giovanile I dati e le successive elaborazioni circa le catture effettuate in tonnara sia nel 2007, sia nel 2008, sono stati desunti dai Registri commerciali della Cooperativa pescatori di Camogli. Catture stagione 2007: La prima levata del 2007 è stata effettuata l’8 Aprile, mentre l’ultima il 17 Agosto. In questo senso tra le catture alcune specie sono risultate meno numerose del solito, soprattutto in riferimento che la stagione è finita molto presto; le specie in questione potrebbero essere boniti e lampughe, di solito numerose in settembre. In figura 107 è rappresentato quindi l’andamento del pescato durante l’intera stagione 2007 espresso in tonnellate: risulta evidente come le catture più numerose si sono avute nei mesi primaverili (maggio e giugno), come abitualmente accade ogni stagione di pesca. Figura 107: Catture mensili in tonnara nella stagione 2007 espresse in tonnellate (t) Per quanto riguarda invece le singole specie, in figura 108 sono riportate tutte quelle catturate durante la stagione. In tal senso la stagionalità risulta importante per comprendere l’andamento delle risorse da pesca durante l’anno: a Camogli si dice infatti “se a maggio non si giara, non pesca la tonnara”. Figura 108: catture totali per specie relativo alla stagione 2007 espresso in tonnellate (t) Le catture totali nell’anno si aggirano intorno alle 40 t: la stagione è stata particolarmente avversa dal punto di vista delle condizioni meteo-marine, sebbene alcune specie prediligano condizioni di tempo piuttosto instabile. Le specie sono riportate con il nome volgare con il quale vengono chiamate a Camogli: da esse sono state eliminate le catture di totani e calamari perché in esigua quantità, le altre sono state riportate nella totalità. Per le specie maggiormente significative, ovvero le specie target più catturate, sono stati elaborati alcuni andamenti nel corso della stagione che mettono in evidenza il periodo prediletto per la loro cattura. A quanto risulta nel 2007 le specie più pescate sono le palamite ed il loro andamento è mostrato in figura 109: Figura 109: andamento delle catture di palamite (Sarda sarda) espresso in tonnellate (t) per il 2007 Nel 2007 la palamita è risultata la specie maggiormente catturata, soprattutto nei mesi primaverili, poi la quantità delle catture diminuisce raggiungendo valori minimi nei mesi di luglio e agosto. A tal proposito occorre sottolineare che le catture di palamite sono molto apprezzate dai pescatori della tonnara, in quanto il mercato sta cominciando a conoscere anche pesci considerati di scarso interesse commerciale quali la palamita che, di sicuro, non sono qualitativamente inferiori a quelli considerati di maggior pregio. Il periodo primaverile è inoltre quello in cui la carne di questo pesce risulta essere molto più grassa, in quanto in fase riproduttiva, e spesso le femmine si ritrovano ad essere piene di uova (come accade anche per gli altri pesci). Tra le specie che invece non mancano mai in tonnara, vi sono i sugarelli (Trachurus spp.), il cui andamento è riportato invece in figura 110. Figura 110: andamento delle catture di sugarelli (Trachurus sp) espresso in tonnellate (t) per il 2007 Da alcuni anni i sugarelli (Trachurus sp), o suri a Camogli, sono tra le specie target in tonnara. Si tratta di specie catturate prevalentemente nel periodo primaverile: nel 2007 tali catture sono state leggermente anticipate (di solito prediligono il mese di maggio) e, solitamente, vengono seguiti da altri pesci quali ricciole (Seriola dumerilii) e boniti (Auxis rochei). Se si osservano infatti i grafici di queste due specie (riportate in figura 111 e 112), è facile notare come il loro andamento sia praticamente identico. La differenza nel periodo di cattura pare sia legata alla dieta delle diverse specie che determina un maggior o minor avvicinamento alla costa, unitamente al forte legame con il periodo riproduttivo. Questo fatto è evidente soprattutto nelle ricciole che sono una specie particolarmente scaltra ma che, nel periodo della fregola, si lascia facilmente catturare. Figura 111: andamento delle catture di bonitti (Auxis rochei) espresso in tonnellate (t) per il 2007 Figura 112: andamento delle catture di leccie (Seriola dumerilii) espresso in tonnellate (t) per il 2007 Leggermente diverso risulta invece l’andamento delle catture di cavalle (Scomber colias) illustrato in figura 113: Figura 113: andamento delle catture di cavalle (Scomber colias) espresso in tonnellate (t) per il 2007 Spesso capita che, per il suo scarso valore commerciale, i pescatori siano costretti a rigettare in mare numerose cassette di questo pesce. Le catture presentano un picco nei mesi primaverili (il massimo valore risulta sempre in maggio); è una specie non troppo apprezzata dal mercato e pertanto, non sempre ben voluta dai pescatori, ma da anni quasi sempre presente tra le catture della tonnara e quindi in fase di rivalutazione da parte del consumatore Catture stagione 2008: La prima levata del 2008 è stata effettuata il 19 Aprile, mentre l’ultima il 6 Settembre. Nonostante la rete sia rimasta in mare fino a questa data, il 2008 è risultato un anno ancor meno proficuo in termini di catture rispetto al 2007, in quanto le catture totali nella stagione si aggirano intorno a poco meno di 30 tonnellate. Figura 114: Esemplare di cavalla salaiato dalla lea (foto C. Umili) Chi si occupa della gestione della tonnarella sostiene infatti che ormai da alcuni anni le catture siano scese parecchio e spesso risulta difficile, per gli operatori del settore, riuscire a far tornare i bilanci di un’attività che, seppur tradizionale, sembra da certi punti di vista destinata a perdersi. In figura 115 è rappresentato quindi l’andamento del pescato durante l’intera stagione 2008 espresso in tonnellate: anche quest’anno le catture più sostanziose si sono avute nel mese di maggio. Figura 115: Catture mensili in tonnara nella stagione 2008 espresse in tonnellate (t) Per ciò che riguarda invece ogni singola specie, le catture sono riportate in Figura 116. Figura 116: catture totali per specie relativo alla stagione 2008 espresso in tonnellate (t) Le specie target per il 2008 risultano essere le stesse del 2007, tenendo però conto del fatto che le più catturate sono risultate essere le cavalle, seguite da sugarelli, boniti, leccie e, in ultime, palamite. Nei grafici seguenti sono riportati come nel 2008, gli andamenti relativi a ciascuna di queste specie, a partire dagli sugarelli (figura 117): Figura 117: andamento delle catture di sugarelli (Trachurus spp) espresso in tonnellate (t) per il 2008 Nel 2008 il massimo assoluto si verifica nel mese di aprile da quando poi le catture scendono fino a raggiungere dei valori minimi a fine giugno. Figura 118: andamento delle catture di palamite (Sarda sarda) espresso in tonnellate (t) per il 2008 Le palamite risultano avere, differentemente dagli sugarelli un andamento che segue una gaussiana, dall’inizio della stagione cresce, ha un picco massimo nel mese di maggio e poi raggiunge i minimi valori nei mesi successivi. Figura 119: andamento delle catture di leccie (Seriola dumerilii) espresso in tonnellate (t) per il 2008 Negli ultimi anni le ricciole risultano tra le catture maggiormente apprezzate in tonnara anche se spesso, come già precedentemente accennato, si tratta di pesci particolarmente scaltri che solo nella stagione della fregola risultano più facilmente catturabili. Il mese di settembre, che mostra valori piuttosto bassi (anche perché la rete è rimasta in acqua davvero pochi giorni), è solitamente quello caratterizzato dalle ricciole più piccole, chiamate “pesci limone” a Camogli. Le catture di riccole sono numerose nello stesso periodo in cui si ritrovano quelle di boniti il cui andamento è mostrato in figura 120. Figura 120: andamento delle catture di boniti (Auxis rochei) espresso in tonnellate (t) per il 2008 Le catture di boniti hanno anch’esse un valore massimo in corrispondenza di maggio ma diminuiscono in modo più graduale rispetto alle stesse ricciole. In questo senso le abitudini alimentari sono differenti, infatti le ricciole predano maggiormente piccoli invertebrati e altri pesci più piccoli, mentre i boniti sono ghiotti soprattutto di alici e piccole sardine. Per quanto invece riguarda le cavalle, anch’esse presentano il valore massimo nel mese di maggio e poi scendono, presentando valori minimi intorno a luglio, a differenza del 2007 in cui invece si sono registrate ancora alcune catture (figura 121). Figura 121: andamento delle catture di cavalle (Scomber colias) espresso in tonnellate (t) per il 2008 La pesca speciale del rossetto Nel contesto della pesca professionale all’interno dell’AMP Portofino, ben si inserisce la pesca speciale al rossetto (Aphia minuta). Questo tipo di pesca viene effettuata con la sciabica, il cui nome proviene dall’arabo e dà quindi un’idea del luogo di utilizzo nei secoli di questo attrezzo (Ferretti et al., 2002). Le pesche speciali che vengono effettuate in Liguria sono tre: rossetto (Aphia minuta), bianchetto (stadio giovanile di Sardina pilchardus) e cicerello (Gymnammodites ciciarelus). Queste pesche sono praticate lungo la costa ligure in modo diverso, ovvero vi sono alcune zone che prediligono una pesca piuttosto che l’altra, dal momento che le tre specie si localizzano spesso in ambienti differenti e soprattutto sono strettamente legate all’interesse commerciale locale. In questo senso l’attrezzo (sciabica) utilizzato presenterà caratteristiche differenti in relazione anche alla geomorfologia del fondale sul quale si vuole effettuare la cala. In generale la pesca con la sciabica è andata progressivamente diminuendo, sia per la diminuzione della forza lavoro, che di aree costiere destinate alla pesca (Orsi Relini, 1984). L’Unione Europea avrebbe dovuto abolire la pesca con la sciabica da gennaio 2002 (Reg. CE 1626 del 27/06/1994) a causa dell’alto numero di catture accessorie al di sotto della taglia minima. Questo principalmente perché l’UE considera la stessa al pari delle reti a strascico nella regolamentazione dell’uso e delle caratteristiche costruttive. Infatti viene inserita tra gli “attrezzi trainati”, definendo: 1) "attrezzi trainati": qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe di cui fanno parte: ii) "sciabiche da natante": reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio; iii) "sciabiche da spiaggia": reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva. In questo contesto però la sciabica a maglia fine in uso nelle marinerie liguri, in particolare quella per la cattura del rossetto, non è paragonabile a quella utilizzata nei Mari del Nord da imbarcazioni di imponenti dimensioni (le sciabiche “danesi”), ma viene utilizzata da barche di piccole dimensioni, il cui equipaggio è solitamente costituito da due persone e il recupero della rete viene fatto tramite un piccolo verricello o direttamente a braccia quando la barca è del tutto ferma. Il disegno di una tipica sciabica utilizzata in Liguria è riportato in figura 122. Questo attrezzo, a seconda della specie bersaglio (rossetto, bianchetto o cicerello), può presentare piccole differenze di armamento nella proporzione tra il peso e la spinta dei piombi e dei galleggianti: per esempio nel caso di cicerello e rossetto l’assetto della barca sarà completamente neutro, mentre nel caso del bianchetto, l’assetto è leggermente positivo. Figura 122: sciabica utilizzata in Liguria per le pesche speciali Ciò vale per tutte le marinerie della Liguria, tradizionalmente legate alla piccola pesca artigianale, chi per la pesca del rossetto, chi per quella del cicerello o bianchetto. Successivamente l’UE ha chiesto ai vari paesi europei la definizione di piani di gestione locali, di cui si sono fatte carico le singole Regioni. In particolare le Regioni stesse si propongono di offrire un appropriato strumento di gestione diretto a conservare e tutelare nel tempo queste specie ittiche marine e, nel contempo, mantenere un’antica tecnica di pesca attuata con un attrezzo che fa parte della storia e della cultura delle comunità locali di pescatori. Con questo piano saranno date limitazioni circa lo svolgimento dell’attività di pesca (periodo, numero di barche coinvolte, dimensioni degli attrezzi e catture accessorie). Successivamente è previsto anche l’avvio di un monitoraggio che consenta di verificare catture, effettive zone di pesca e numero delle cale effettuate. I piani dovranno essere redatti entro maggio 2010, una bozza è invece in attesa di essere presentata entro novembre 2009. Ciascuna regione lo proporrà autonomamente e, in questo senso, la Regione Liguria, è stata una delle prime a presentarlo. In questo contesto l’AMP Portofino da anni segue la pesca professionale che si svolge al suo interno e più propriamente la pesca speciale al rossetto. La pesca del rossetto nell’AMP Portofino Come già precedentemente accennato, nel Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP Portofino di luglio 2008 tale attività di pesca è già propriamente gestita (consentita nelle zone B e C con modi e tempi definiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza e che abbiano già svolto tale attività prima del 31 dicembre 2004. Il rossetto (Aphia minuta) è tra le specie appartenenti alla famiglia dei Gobiidae e, per le loro caratteristiche di adattabilità all’ambiente, nonché per la loro peculiare strategia riproduttiva, hanno un’ampia distribuzione geografica. Lungo le coste italiane, sono rappresentati da una quarantina di specie che si riuniscono in banchi, comprendenti un numero molto elevato di individui, che di solito si rinvengono negli strati più superficiali e su batimetrie intorno ai 40-60 metri di profondità, anche se possono migrare a profondità maggiori. Mentre la maggior parte dei gobidi ha larve planctoniche, che trascorrono un breve periodo della loro vita nella colonna d’acqua e successivamente passano ad una vita epibentonica, A.minuta trascorre l’intero ciclo vitale nella colonna d’acqua come pesce planctofago (Collet,1878; Tamura e Honma, 1969; Miller, 1979; Iglesias et al., 1997; La Mesa, 1999). Il breve ciclo di vita di questa specie, associato alla veloce maturazione gonadica, fa si che gli esemplari adulti conservino caratteristiche larvali (Brunelli e Atella, 1914). A. minuta è un organismo gregario che vive in banchi seguendo le correnti che trasportano le grandi masse di plancton; è un pesce molto attivo e predatore (come suggeriscono la sua morfologia, il tipo di dentizione ed il suo comportamento), in continua ricerca di alimento vivo. A. minuta vive in prossimità della costa, spesso in corrispondenza degli estuari dei fiumi, predilige i fondali sabbioso-fangosi e le praterie di zoosteracee e si può rinvenire nella colonna d’acqua, dalla superficie fino a circa 80 m di profondità (FAO, 1987); è una specie eurialina in quanto tollera ampie variazioni di salinità. In particolare, sembra che i bassi valori di sali disciolti siano favorevoli per il processo riproduttivo. Reagisce prontamente agli stimoli ambientali e, in caso di pericolo, tende a nascondersi in prossimità del fondale variando la tonalità del corpo per mimetizzarsi; Cole (1954) ha indicato con il termine “semelpare” le specie che manifestano un solo evento riproduttivo a stagione e “iteropare” le specie in cui l’evento riproduttivo si verifica in più di una occasione in una stessa stagione. In particolare, recentemente, il concetto di semelparità è stato sostituto con quello di iteroparità prolungata, per cui per ogni stagione riproduttiva questo pesce può effettuare due deposizioni (Caputo et. al., 2000). In relazione alla particolare morfologia del Promontorio di Portofino questa specie vive a contatto con il fondo aggregandosi solo quando raggiunge taglie massime e questo fenomeno è comunque soggetto a variazioni di anno in anno. Il periodo di pesca consentito è compreso tra novembre e marzo, con la possibilità di ottenere una proroga dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaf) fino a circa metà di aprile, nel caso in cui le condizioni meteo marine siano state avverse durante l’inverno. In base a ciò che è stato precedentemente evidenziato, entro maggio 2010 verranno presentati dalla Regione Liguria i Piani di Gestione per le pesche speciali. In attesa però dei suddetti piani, per la stagione 2009-2010 tali pesche verranno ancora consentite in deroga dal Ministero. In base a dati della Regione Liguria riportati all’interno dei piani di gestione in via di presentazione, la flotta ligure che utilizza la sciabica da natante nel 2009, è costituita da 96 imbarcazioni ed il 60% delle autorizzazioni si concentra nel Compartimento Marittimo di Genova. Le autorizzazioni concesse alla pesca tradizionale del rossetto nello stesso Compartimento risultano 56 nel 2009 e, nella sola marineria dell’AMP Portofino sono 11. Ciò ad indicare il forte nucleo rappresentato dai pescatori della piccola di Camogli. Occorre sottolineare che, non tutte le licenze concesse sono utilizzate, ma spesso vengono comunque rinnovate per evitare di perdere la possibilità di uscire in mare: infatti se una licenza viene tolta, difficilmente verrà di nuovo concessa. In particolare la situazione delle barche autorizzate nell’AMP Portofino è illustrata nelle tabelle 8-9: Tabella 8: barche autorizzate per le pesche speciali e relativo numero di licenze nell’AMP Portofino Stagione di pesca autunno-inverno 2008-2009 Camogli Portofino S.Margherita Ligure Numero imbarcazioni piccola pesca 26 5 11 Numero licenze pesca rossetto 11 1 0 Le barche adibite alla pesca del rossetto in AMP e, in generale in tutta la Liguria, sono di piccole dimensioni. Di seguito si riportano i nomi delle unità navali adibite alla pesca del bianchetto e rossetto nella stagione di pesca 2008-2009 con le relative caratteristiche (tabella 9): Tabella 9: barche autorizzate per le pesche speciali nell’AMP Portofino NOMI Carla II Paolo Ippofior Giola Selemar Mami Fabrizio Gabry Pagan Lepanto Albatross caratteristiche barche attive in AMP STAZZA (tsl) POTENZA (hp) 2,81 130 2,91 21,76 2,18 114,5 2,32 82 2,9 80 1,68 25 1,61 35 2,91 65 1,61 35 SIGLA 3GE1044 3GE912 3GE1017 3GE1049 3GE1013 3GE937 3GE1021 3GE0995 3GE1021 15GE669 15GE667 Le barche rappresentate in tabella e riconoscibili perché contraddistinte dalla sigla 3GE appartengono al Comune di Camogli, ad eccezione delle ultime due che appartengono invece a Portofino. E’ evidente quindi che le uniche due marinerie attive sono quella di Camogli e Portofino. Camogli, in particolare, rappresentando da anni un borgo marinaresco legato alle tradizioni della pesca, si è mantenuta una realtà molto viva ed oggi, da sola, rappresenta un parte consistente dello sbarcato annuale non solo su Genova ma in tutta la Liguria. Grazie al rapporto di collaborazione e di fiducia, che negli anni è stato costruito tra Ente Gestore e alcuni operatori del settore pesca, è stato possibile recuperare i dati riguardanti le dichiarazioni effettuate a fine statistico dalla Cooperativa Pescatori di Camogli alle Capitanerie di Porto dal 2001 al 2009. Ciò ha permesso di iniziare a fare alcune prime valutazioni circa lo sfruttamento della risorsa e, soprattutto, verificare gli eventuali cambiamenti nello stato della stessa a seguito dell’istituzione dell’Area Marina Protetta. Stagione 2001-2002 La prima stagione che si va a prendere in considerazione è quella 2001-2002: le barche attive dovrebbero essere 6 ma, di fatto, quelle davvero operative sono circa due o tre. Di seguito, nelle figure 123, 124, 125, si riportano alcuni grafici relativi all’andamento stagionale rispettivamente dei giorni positivi di pesca, delle catture totali espresse in kg e delle CPUE (catture per unità di sforzo). In particolare i giorni di uscita sono riportati nella totalità considerando la somma delle uscite di tutte le barche attive (299 giornate) così come le catture. I mesi in cui vengono effettuate il maggior numero di uscite risultano gennaio e dicembre, analogamente alle catture totali. Figura 123: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2001-2002 Le catture hanno un picco in corrispondenza di gennaio e poi scendono fino a raggiungere valori minimi a marzo. In generale i kg totali sbarcati sono stati 1617,6. Figura 124: catture totali per la stagione 2001-2002 espresse in kg Figura 125: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2001-2002 Le CPUE espresse come kg/giorno/barca presentano un valore massimo in corrispondenza di dicembre rispecchiando i massimi quantitativi catturati ed un valore stagionale pari ai 5,4 kg. Per quanto riguarda più specificatamente le catture effettuate per ogni barca presa in considerazione, di seguito si riporta l’andamento nel corso della stagione di ciascuna barca attiva nella marineria di Camogli. Occorre sottolineare che le catture dichiarate dalle Cooperative spesso non sono quelle reali di ogni singola barca: il totale (comunque attendibile) di solito viene “spalmato” su ognuna di esse a fine mese (al momento in cui vengono inviati i dati sugli sbarcati alle CP). Figura 126: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2001-2002 Le catture giornaliere riferite a ciascuna barca mostrano una conferma di quanto si era detto per il totale realizzato nei vari mesi. Le barche più attive risultano Giola, Ippofior e Selemar. Stagione 2002-2003 Per quanto riguarda la stagione 2002-2003, le barche operative risultano 5: i giorni di attività totali intesi come uscite positive per tutte le barche sono 153, con valori massimi rispettivamente in febbraio, gennaio e dicembre (leggermente spostati in avanti nella stagione rispetto al 2001-2002) e valori minimi in novembre. Figura 127: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2002-2003 Figura 128: catture totali per la stagione 2002-2003 espresse in kg Per quanto riguarda le catture, i kg totali catturati nel corso dell’anno risultano circa 808,65, con i valori più elevati in gennaio e febbraio. In questo caso però l’andamento delle catture durante la stagione sembra essere molto diverso rispetto a quello che si delinea nella stagione precedente in cui le catture dopo dicembre cominciano a scendere a picco; in questa stagione sia l’incremento che porta a valori massimi, sia la discesa, dopo febbraio, risulta più graduale. In generale i quantitativi pescati sono in numero di gran lunga inferiore rispetto alla stagione precedente così come i giorni di attività (sono circa la metà). Ciò è probabilmente è dovuto al fatto che la stagione di pesca 2002-2003 (precedente alla grande estate 2003 caratteristica per la sua anomalia termica che aveva causato morie di organismi bentonici in tutto il Promontorio di Portofino) era stata caratterizzata da un inverno con condizioni meteo non particolarmente favorevoli alle uscite in mare. Figura 129: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2002-2003 Per quanto riguarda invece le catture per unità di sforzo (CPUE), esse presentano un valore massimo in corrispondenza del mese di gennaio; il valore stagionale si aggira intorno ai 5,82 kg/giorno/barca, molto vicino al valore riscontrato per la scorsa stagione, nonostante l’andamento durante la stessa sia differente. Di seguito si riporta il grafico relativo alle CPUE per ogni singola barca autorizzata alla pesca speciale in AMP. Figura 130: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2002-2003 Anche in questa stagione l’andamento del grafico rispecchia il totale annuale; le barche più attive risultano essere Giola (in media tra i 20 e i 25 kg nei mesi di gennaio e febbraio) e Carla II (in media quasi 15 kg negli stessi mesi). Stagione 2003-2004: La stagione 2003-2004 risulta essere particolarmente attiva, delle tre esaminate quella con il maggior numero di uscite positive (pari a 336). In questo caso però l’andamento risulta nettamente diverso rispetto a quello delle stagioni 20012002 e 2002-2003: a novembre in fatti si registra il numero più elevato di uscite, con una diminuzione graduale per tutto il resto della stagione ed un valore minimo a gennaio. Figura 131: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2003-2004 Le catture totali effettuate si aggirano intorno ai 1106,5 in tutta la stagione, con valori massimi a novembre e minimi a gennaio, a rispecchiare l’andamento delle uscite stagionali (figura 132). Figura 132: catture totali per la stagione 2003-2004 espresse in kg Le catture per unità di sforzo presentano un valore massimo invece in dicembre, con un valore totale che si discosta però parecchio da quello degli altri due anni (3,29 kg/giorno/barca). Figura 133: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2003-2004 I valori massimi stagionali risultano molto più bassi dei precedenti ed anche il trend caratteristico della stagione di pesca è nettamente differente, con valori più o meno costanti nell’arco di tutta la stagione. Figura 134: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2003-2004 Questa stagione mostra un andamento più regolare anche per ciò che riguarda le catture effettuate da parte di ciascuna barca: in questa stagione le più attive risultano due, Fabrizio e Ippofior rispettivamente con catture che variano mensilmente dai 12 ai 20 kg circa. Stagione 2004-2005: in questa stagione il totale di uscite positive risulta essere pari a 151: il valore più elevato si riscontra a dicembre, mentre i due minimi si hanno in corrispondenza di marzo e novembre rispettivamente. Il trend, indicando un numero piuttosto simile nelle uscite, indica che durante tutta la stagione le condizioni meteo si sono mostrate abbastanza favorevoli alle uscite. Figura 135: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2004-2005 Per ciò che riguarda le catture totali effettuate, esse si aggirano intorno a 575,65 kg: la stagione mostra un massimo in corrispondenza di novembre, con una graduale diminuzione fino ad arrivare a marzo quando si registrano i valori minimi; il trend risulta per certi versi quindi analogo a quello della stagione 2003-2004. kg tot 160 140 120 100 80 60 40 20 0 NOV DIC GENN FEB MAR Figura 136: catture totali per la stagione 2004-2005 espresse in kg Figura 137: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2004-2005 Le CPUE mostrano un andamento ancora a sé stante rispetto a quello delle trascorse stagioni: il valore stagionale è pari a 3,81 kg/giorno/barca, leggermente in diminuzione rispetto agli altri anni, con, ovviamente, un valore massimo in novembre (la stagione sembra pertanto anticipata). Per quanto riguarda ogni singola barca, il grafico relativo alla stagione 2004-2005 è mostrato in figura 138. Figura 138: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2004-2005 Le barche che effettuano il maggior numero di catture sono essenzialmente due (catture tra 12 a poco più di 23 kg circa). Stagione 2005-2006 La stagione 2005-2006 presenta un totale di 377 giorni di uscite positive (7 barche attive): dal valore minimo che si riscontra a novembre, con il procedere della stagione i giorni vanno aumentando ed il numero massimo si registra a febbraio, con un andamento analogo a quello che si verifica per la stagione 2002-2003. Figura 139: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2005-2006 Le catture totali effettuate dalle 7 barche partono da un valore minimo in novembre ed hanno un incremento fino a febbraio, mese nel quale raggiungono un valore massimo per poi scendere a marzo, andando a rispecchiare all’incirca l’andamento del numero di uscite positive (figura 140). I quantitativi totali nell’anno si aggirano sui 1227,2 kg. Figura 140: catture totali per la stagione 2005-2006 espresse in kg Le catture per unità di sforzo presentano un trend analogo a quello delle catture totali effettuate nei vari mesi. Figura 141: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2005-2006 Il trend è anche molto simile a quello della stagione 2002-2003, ad eccezione del fatto che quest’ultima risulta leggermente spostata in avanti come sforzo di pesca. Il valore annuale che risulta è 3,25 kg/giorno/barca. Figura 142: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2005-2006 In questa stagione l’andamento delle catture per ciascuna barca è analogo e il picco viene registrato in febbraio (con un massimo di kg pari a circa 22-23) per le barche Giola e Fabrizio. Stagione 2006-2007 La stagione 2006-2007 presenta un andamento a zig-zag per quanto riguarda i giorni di pesca effettuati, con numeri più bassi registrati a novembre e gennaio; il numero totale di uscite effettuate nella stagione è pari a 370. I valori più elevati, a differenza degli altri anni si hanno a dicembre e febbraio. Figura 143: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2006-2007 Anche i kg totali pescati durante la stagione (pari a 1164 kg) presentano un andamento analogo a quello delle uscite effettuate con due massimi (dicembre e febbraio) ed il valore minimo stagionale riscontrato a novembre. Figura 144: catture totali per la stagione 2006-2007 espresse in kg Anche le CPUE presentano un andamento non lineare ma a zig-zag, con due valori minimi in corrispondenza di novembre e marzo, mentre lo sforzo di pesca più elevato si ha a dicembre. Figura 145: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2006-2007 Il valore che si calcola delle CPUE nell’anno è pari a 3,14 kg/giorno/barca. Figura 146: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2006-2007 Anche in questo caso si registra un andamento a zig-zag, con le barche Fabrizio e Giola che effettuano le catture più elevate (i due picchi a dicembre e febbraio mostrano valori pari a 18 e 20 kg massimo di catture). Stagione 2007-2008 Per quanto riguarda la stagione 2007-2008, i dati riportati rappresentano delle stime stagionali calcolate sulla base di alcune interviste effettuate e di cui alcuni dati riportati nel precedente rapporto di “Valutazione dell’impatto antropico nell’AMP Portofino” (2007). In particolare nel 2008 le Cooperative di pesca non erano obbligate a fornire alle Capitanerie di Porto i dati relativi agli sbarcati, pertanto i dati relativi al 2008 non sono risultati disponibili allo stesso modo di quelli delle altre stagioni e sono stati calcolati come stime. I giorni positivi di pesca presentano un andamento a zig-zag con un valore minimo a novembre e due picchi massimi in corrispondenza rispettivamente di dicembre e febbraio. I giorni totali nell’anno risultano essere 146, con un numero di barche attive pari a 5. Figura 147: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2007-2008 (dati stimati) L’andamento delle catture durante la stagione presenta anch’esso un valore minimo a novembre con due picchi stagionali a dicembre e febbraio. Le catture totali nell’anno risultano essere circa 900,96 kg, sempre tenendo conto che si tratta di stime (figura 148). Figura 148: catture totali per la stagione 2007-2008 espresse in kg (dati stimati) Figura 149: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2007-2008 (da dati stimati) Le catture per unità di sforzo (CPUE) presentano un trend analogo a quello delle stagioni 20052006 e 2002-2003. Il valore minimo si registra in novembre e aumenta poco alla volta fino a raggiungere un massimo in febbraio, per poi scendere a marzo; le stime rivelano che nell’anno il valore totale delle catture per unità di sforzo si aggira intorno a 6,17 kg/giorno/barca. Figura 150: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2007-2008 In questa stagione due barche (Ippofior e Selemar) mostrano un andamento analogo. Si possono vedere due picchi stagionali, di cui il più elevato a febbraio è caratteristico della barca Fabrizio (circa 20 kg nel mese di febbraio). Stagione 2008-2009 Per quanto riguarda il 2008-2009, le informazioni disponibili riguardano solamente la seconda parte della stagione, per le stesse motivazioni per cui i dati relativi alla seconda parte della stagione 2007-2008 sono stati stimati sulla base di alcune interviste. Nel 2009 applicare una stima ai primi mesi di cattura sembra non permettere di calcolare dati attendibili, pertanto per il 2009 si riportano esclusivamente i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. In figura 151 si riportano i dati relativi al numero delle uscite positive effettuate nell’arco del trimestre 2009, il cui numero totale è risultato pari a 61. Figura 151: giorni totali di attività per le barche della marineria di Camogli nella stagione 2008-2009 In questo caso il numero massimo di uscite si registra a marzo, valore che non sembra coincidere con quelli delle precedenti stagioni: è probabile che, considerando un solo trimestre, non si possano considerare del tutto significative tali informazioni in nostro possesso. Per ciò che riguarda le catture effettuate, il numero di kg totali in tre mesi risulta pari a 370,7 kg. kg 250 200 150 100 50 0 GENN FEB MAR Figura 152: catture totali per la stagione 2008-2009 espresse in kg Per quanto riguarda l’andamento nel corso della stagione, il valore più elevato, come per il numero di uscite si registra a marzo. Figura 153: CPUE (kg/giorno/barca) relativo alla stagione 2008-2009 Le CPUE presentano un valore annuale pari a 6,07 kg/giorno/barca; tale valore può essere considerato attendibile in quanto calcolato proporzionalmente in base ai giorni nel periodo considerato. Figura 154: catture per unità di sforzo relative alla stagione 2008-2009 In questa stagione si sono presi in considerazione esclusivamente tre mesi, visto che si avevano a disposizione i dati relativi alle catture; il picco massimo si registra a febbraio con valori pari a circa 16 kg. Considerando in modo più ampio la serie storica di dati che va dalla stagione 2001-2002 e quella 2007-2008, l’andamento delle CPUE che si delinea nel tempo è il seguente: Figura 155: serie storica delle CPUE per la marineria di Camogli dal 2001 al 2008 In questo caso non sono stati riportati i dati relativi alla stagione 2009 in quanto non completi. Considerando i valori medi annuali dalla stagione 2001-2002 a quella 2007-2008, emerge un valore medio nell’arco di sette anni pari a 4,24 kg/giorno/barca, un valore abbastanza alto, e che sembra aumentare nel corso degli anni. Tabella 10: valori medi e deviazione standard per la serie storica di dati dal 2001 al 2008 GG TOT KG TOT KG/GIORNO/BARCA media 152 631,58 4,64 dev.st 83 244,19 1,59 In ogni caso di sicuro il grafico che permette di fare maggiori considerazioni circa la tendenza nel tempo è quello a dispersione; in particolare se si vuole considerare anche la stagione 2009, occore prendere in considerazione solamente il secondo semestre di attività. In tal caso, l’andamento che ne risulta è illustrato in figura 156: Figura 156: serie storica delle CPUE per la marineria di Camogli dal 2001 al 2009 (trend annuale del 2°semestre) Dal grafico pare evidente che lo stock di rossetto (Aphia minuta) le cui catture avvengono nelle acque dell’AMP e in zone ad essa limitrofe, risulta stabile se non in crescita, ad indicare una buona gestione della risorsa da parte dei pescatori che operano in collaborazione con l’AMP. Purtroppo non sono disponibili dati completi relativamente alle annate precedenti l’istituzione dell’AMP Portofino, cosa che non ci permette di effettuare dei reffronti adeguati. Gli unici dati a disposizione sono quelli ricavabili dallo studio effettuato da Relini et al. 1998 relativi alle stagioni dal 93/94 al 97/98. In esso i dati di CPUE variano da 263 g per la stagione 96-97 a 3,614 kg per la stagione 97-98. Il confronto porterebbe a dire che la risorsa è non sovrasfruttata e, addirittura, dopo la nascita dell’AMP Portofino, sia in incremento. I fondali del Monte di Portofino non sono caratterizzati solamente dalla presenza del rossetto Aphia minuta ma anche da un’altra specie di Gobide pelagico, Crystallogobius linearis, pescata esclusivamente in questa zona e che, per questo viene chiamato “rossetto chiaro o bianchetto di fondo di Camogli”, in dialetto “lunarino”. Pare che questa specie venga catturata soprattutto nella seconda parte della stagione, da gennaio in poi, quando cambiano anche i siti di cala preferenziali dei pescatori. Infatti nella prima parte della stessa, di solito fino a Natale, le zone di pesca preferite sono poco lontane dall’Area Marina, davanti a Camogli, ma si concentrano soprattutto nello specchio acqueo tra Recco e Sori, mentre col proseguire della stagione, si spostano a levante entrando stabilmente nel territorio dell’AMP. Più precisamente si tratta della Zona C di ponente e di alcuni siti di cala localizzati lungo il Fronte Sud del Promontorio in Zona B. Crystallogobius linearis è una specie segnalata nelle acque liguri, per la prima volta, da Orsi L. e Fanciulli (1977), pur essendo una specie solitamente pescata dai pescatori locali come è stato ampiamente dimostrato. La biologia di questa specia risulta essere ancora poco conosciuta e, per questo, durante la stagione 2009-2010, l’Ente gestore dell’Area Marina Protetta di Portofino ha programmato un monitoraggio delle catture ed un approfondimento sulle caratteristiche biologiche delle specie sia di Aphia minuta che di Crystallogobius linearis, per allinearsi alle esigenze della Comunità europea riguardo ai Piani di Gestione della pesca di queste due risorse e cercare di approfondire maggiormente le conoscenze sul “bianchetto cristallino”. La pesca sportiva nell’AMP Portofino La pesca sportiva rappresenta un significativo fenomeno sociale che coinvolge circa due milioni di cittadini italiani. È un’attività diffusa che, anche se praticata con moderazione, ha un indubbio impatto economico ed ambientale; dal punto di vista economico, solo in Italia, si stima che i consumi legati alla pesca ricreativa (attrezzature, esche, imbarcazioni, carburante, eventuali pernottamenti in hotel, ecc.) ammontino a svariati milioni di euro; in Europa, fonti di settore, stimano in 8-10 miliardi di euro il giro d’affari che ruota attorno al mondo della pesca sportiva o dilettantistica. Si tratta di un’attività in continua crescita sia quantitativa sia qualitativa; se un tempo era solo un passatempo per anziani, negli ultimi decenni invece si è assistito ad un incremento vertiginoso del numero dei pescatori sportivi; infatti, oltre che tra i pensionati, tale pratica si è diffusa come hobby un po’ tra tutte le età. La presenza sul mercato di molte aziende produttrici di attrezzature dedicate ai pescasportivi ha provocato una naturale concorrenza che si combatte con continue evoluzioni tecnologiche. Il frutto di queste sistematiche migliorie è la produzione di attrezzi molto più efficaci di un tempo. (Campodonico, 2009) Nell’ambito dei programmi di gestione di un’AMP l’attività di pesca sportiva rappresenta una delle problematiche ancora irrisolte, in quanto risulta difficile entrare dentro una realtà complessa come quella del pescatore sportivo che ha spesso paura di trovarsi limitato nella propria attività. In senso lato, tale pratica risulta di difficile collocazione fra le attività consentite in una Area marina protetta, perché non conforme allo spirito di conservazione, educazione ambientale e sensibilizzazione che è uno dei principali obiettivi dell’istituzione di una AMP e costituiscono uno dei capisaldi della sua “mission”. Nonostante questo risulta socialmente scorretto pensare di ostacolare un’attività che, ovunque, da sempre, è radicata nelle comunità locali; cionondimeno è fondamentale approfondirne la conoscenza al fine di gestirla, mediante specifica regolamentazione, e renderla così il più possibile compatibile con l’ambiente e le altre attività di fruizione del territorio. Una corretta gestione può determinare in tal senso sostanziali modifiche sui periodi, le aree di cattura e gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva. Tali regole poi, dovranno essere integrate da un’efficace attività di controllo e sorveglianza senza la quale l’istituzione di un’AMP verrebbe vanificata. Nell’AMP Portofino la pesca sportiva è permessa ai residenti sia in Zona B sia in Zona C e, ai non residenti, esclusivamente in Zona C. La pesca a traina, con i palangari e con i nattelli è regolamentata da 120 autorizzazioni rilasciate dall’Ente Gestore delle quali 80 sono nominali, riservate a singoli pescatori residenti, e 40 ai circoli di pesca sportiva. I circoli di pesca sportiva autorizzati e facenti parte dei comuni dell’AMP, sono l’Associazione Pesca Sportiva "Il Porticciolo" di Camogli (30 autorizzazioni), l’Associazione “Pescatori Dilettanti Sammargheritesi” (3 autorizzazioni), la Lega Navale di Santa Margherita Ligure (2 autorizzazioni) e l’Associazione Pesca Sportiva “Amici del Mare Portofino” (5 autorizzazioni). Un’autorizzazione rilasciata al circolo sportivo comprende 20 uscite di pesca. Per le altre tecniche di pesca consentite dal Regolamento non vi è un numero prestabilito di autorizzati né tra i residenti né tra i non residenti ma, per questi ultimi, l’ottenimento del permesso è subordinato al pagamento al Consorzio di Gestione di 110 euro per la pesca da riva o 220 euro per la pesca da natante. Per quanto riguarda i non residenti, l’andamento del rilascio delle autorizzazioni è stato complessivamente costante nel tempo. A partire dal 2003, anno successivo all’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione e di Organizzazione dell’AMP, fino al 2009, le autorizzazioni per non residenti rilasciate sono state: 21 per il 2003, 57 per il 2004, 53 per il 2005, 63 per il 2006, 78 per il 2007, 49 per il 2008 e 62 per il 2009 (grafico qui sotto). Andamento numero autorizzazioni rilasciate a non residenti per pescasportiva in zona C amp Portofino I pescatori sportivi autorizzati a operare nell’AMP sono tenuti a riportare annualmente in appositi libretti, la cui compilazione subordina direttamente il mantenimento dell’autorizzazione, la data, le ore e le zone di pesca, il tipo di pesca effettuato, la classificazione del pescato e il peso/taglia. Da analisi condotte in passato è emerso che spesso i libretti risultano essere compilati in modo frettoloso e parziale, alcuni riconsegnati addirittura vuoti. Questo accade in particolare con i residenti che spesso lo compilano a fine anno al solo scopo di ottenere l’autorizzazione. Oltre alla compilazione dei libretti, il pescatore autorizzato che utilizza i palamiti è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa, rilasciata dal Soggetto Gestore, il galleggiante dell’attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera dalle autorità competenti. Prima di descrivere le attività di monitoraggio si definiscono brevemente le principali tecniche di pesca utilizzate ed i relativi impatti sull’ecosistema. Tecniche, attrezzi da pesca utilizzati e relativo potenziale impatto ambientale da essi causato. La prima tecnica presa in considerazione è la pesca a bolentino, una delle tecniche più tradizionali del comprensorio. Da natante fermo è calata in acqua una lenza (detta “madre”) che termina con un piombo; alla madre sono collegati da due a quattro spezzoni di monofilo (detti “braccioli”) dotati di amo; se le specie bersaglio vivono a contatto con il fondo i braccioli sono collegati alla lenza in prossimità del piombo, se invece si vuole insidiare specie strettamente nectoniche la distanza tra braccioli e il peso sarà maggiore. La lenza può essere avvolta sul tradizionale “sughero” oppure sulla bobina di un mulinello inserito su una canna da pesca; in questo caso la tecnica può essere denominata “canna da natante”. L’impatto sulla fauna ittica da parte di questa tecnica non può essere definito perché in base alla scelta del sito di pesca e dell’esca cambiano le specie che possono essere insidiate: con lo stesso attrezzo è possibile catturare specie abbondanti come occhiate (Oblada melanura) con un prelievo a carico di specie molto comuni e di facile reclutamento, oppure specie carismatiche, e più determinanti per la conservazione dell’equilibrio dell’ecosistema, come cernie brune (Epinephelus marginatus) o grossi dentici (Dentex dentex) il cui prelievo può non essere più considerato trascurabile soprattutto se la cattura di tali specie viene reiterata nel tempo. Come ogni lenza calata sul fondo anche la pesca a bolentino crea un impatto di tipo meccanico sul fondale con la possibilità di compromettere a seconda dei siti, i popolamenti sessili di fondo duro tipici del coralligeno o, seppure in misura molto minore, le piante di Posidonia oceanica. Tale impatto non avviene soltanto durante l’attività di pesca ma, se la lenza fosse persa per incoccio o altri imprevisti, creerebbe un effetto pendolo assai dannoso per gorgonie e altri organismi o colonie di forma arborescente (Bavestrello et al. 1997) (figura 157). Figura 157: impatto da parte di lenze perse sui popolamenti sessili di fondo duro tipici del coralligeno (foto L. Torti) Un’altra pesca praticata nell’AMP è la traina. Come si può intuire dalla sua denominazione questa tecnica consiste nel trainare una o più lenze per mezzo del movimento di una barca. Le esche adatte alla traina possono essere artificiali (imitazione di prede in difficoltà) o naturali vive o morte (pesci o cefalopodi). Le esche naturali sono più “catturanti” ma, spesso a causa della difficoltà nel reperirle, sono sostituite dalle artificiali. A seconda della profondità in cui è trainata la lenza si parla di traina di fondo o di superficie; inoltre, in base alla distanza da costa, si distinguono la traina costiera, la media traina e la traina d’altura. Per ognuna delle tipologie appena citate variano esche, attrezzature, imbarcazioni e soprattutto specie target. Nelle acque dell’AMP è praticata la traina costiera di fondo e di superficie. Pescando a galla le specie bersaglio sono pesci da “passo” come sugarelli (Trachurus trachurus), lampughe (Coryphaena hippurus), palamite (Sarda sarda), tombarelli (Auxis rochej), cavalle (Scomber colias), sgombri (Scomber scombrus) e pesci serra (Pomatomus saltatrix) o pesci sempre presenti in zona come occhiate (Oblada melanura) e spigole (Dicentrarchus labrax). Nella traina di fondo sono catturabili soprattutto specie stanziali come dentici (Dentex dentex) e cernie (Epinephelus marginatus, Mycteroperca rubra, Polyprion americanus), anche se non mancano catture di pesci pelagici come ricciole (Seriola dumerili) che talvolta si avvicinano alla costa. Solitamente per la traina di superficie sono impiegate esche artificiali mentre pescando vicino al fondo si usano esche naturali come seppie (vive o morte) o aguglie vive. Rispetto al bolentino questa tecnica in una AMP risulta, in generale, più dannosa all’ecosistema e, proprio per questo motivo, le autorizzazioni che ne permettono l’utilizzo sono solo 120. Come già accennato la traina di fondo ha come target predatori come dentici e cernie il cui prelievo eccessivo contribuirebbe a creare uno squilibrio nell’ecosistema (effetto top-down). Questo tipo di pesca, per trainare l’esca sul fondo, si serve di zavorre molto pesanti (da 500 grammi a 5 chilogrammi a seconda dell’attrezzatura e dell’imbarcazione) che, transitando in prossimità del fondale, possono arrecare un ingente impatto meccanico sulle biocenosi del coralligeno; tale danno è creato anche in caso di incoccio di queste zavorre il cui conseguente abbandono sui fondali crea un indubbio impatto visivo per il turista subacqueo. Dedicandosi a pesci di passo o comunque a pesci abbastanza abbondanti in AMP la traina di superficie non crea problemi significativi. Figura 158: piombo per la traina di fondo reperito nel sito d’immersione “Punta Torretta” (foto P.Campodonico) Un’altra tecnica tradizionale utilizzata dai dilettanti è la pesca con i palamiti (o palangari). Il palamito è un attrezzo costituito da una lunga e robusta lenza (trave o madre) con numerosi braccioli più sottili, ognuno dei quali porta un amo. Il palamito può essere fisso se ancorato al fondo o derivante se libero di seguire le correnti. Si tratta di un metodo di pesca molto selettivo perché a seconda delle esche adottate e dei siti di cala è facile indirizzarsi sulle specie target: ad esempio innescando un palamito con castagnole vive ci si indirizza esclusivamente sul dentice. In AMP sia i pescatori sportivi che i professionisti utilizzano esclusivamente i palangari fissi. Gli impatti generati da questi attrezzi sono da annoverarsi tra quelli di entità considerevole: avendo a disposizione 100 ami il pescatore sportivo ha, potenzialmente, la possibilità di catturare molti esemplari. Questa pesca, se praticata eccessivamente, può comportare seri danni ad un ecosistema protetto sia per il gran numero di esemplari potenzialmente catturabili sia perché spesso le specie bersaglio sono predatrici. La maggior parte dei fondali dell’AMP è rocciosa, ciò rende assai probabile l’incoccio e la perdita dei palangari o di parte di essi. Proprio per questo motivo solo un numero esiguo di pescatori professionisti utilizza costantemente questi attrezzi. L’impatto provocato da porzioni di palamiti abbandonati sul fondo è duplice: in primo luogo anche in questo caso vale la pericolosità dell’effetto pendolo per gorgonie e altri esseri viventi dalla forma arborescente; inoltre anche se meno importante dal punto di vista ecologico, laddove queste lenze non creassero danni di tipo meccanico, sicuramente arrecherebbero un impatto visivo agli occhi del subacqueo. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione tutela il coralligeno dall’impatto dei palangari in quanto impone che siano calati a profondità in cui tale biocenosi non è presente: tuttavia non potendo sorvegliare continuamente l’area costantemente per 24 ore le irregolarità possono essere sempre presenti. Per quanto riguarda le tecniche praticate da riva il rockfishing è quella che causa più problemi all’ambiente: si tratta di una pesca a fondo praticata dalla falesia. Nel rockfishing tramite una robusta canna dotata di mulinello si lancia una lenza terminante con un piombo montato in modo da essere abbandonato sul fondale in caso di incoccio. Questa pratica di pesca è consentita solamente nelle zone C, ma abbiamo constatato che alcuni pescatori contravvengono al regolamento scegliendo siti anche in zona B. Figura 159: Rockfishing illecito in zona B - Casa del Sindaco (foto P. Campodonico) Tramite questa tecnica si catturano orate (Sparus aurata), saraghi (Diplodus spp.), scorfani (Scorpaena spp.), dentici (Dentex dentex), mostelle (Phycis phycis) e cernie (Epinephelus marginatus). Il rockfishing è vietato in zona B proprio per tutelare le specie appena elencate e soprattutto gli organismi che costituiscono il coralligeno che, come già spiegato, sono sensibili all’impatto meccanico generato da lenze. Da riva è praticata anche la pesca con il galleggiante. Le lenze che il pescatore confeziona per questa tecnica sono assai diverse a seconda delle condizioni meteo-marine, del sito, e delle specie bersaglio. Il principio generale è che un galleggiante posto sulla lenza, oltre a funzionare da avvisatore di abboccata, determina a quale profondità è presentata l’esca, scegliendo così su quali specie indirizzarsi. I principali danni creati da questa tecnica, pur nella sua relatività determinata dal numero limitato delle catture, sono sugli stock poiché la maggior parte delle catture è composta da esemplari giovanili. Lo spinning è un metodo di pesca praticato sia da costa che da imbarcazione. Attraverso una canna con mulinello si lancia una lenza terminante con esca artificiale il cui recupero simula il movimento di un pesciolino in difficoltà attirando un predatore se presente in zona. Questa pratica non crea impatti sugli habitat e sui popolamenti sessili ma essendo volta ai predatori, come per altre tecniche può generare degli squilibri nella rete trofica. Il vertical jigging è una tecnica di pesca sportiva praticata da natante fermo (possibilmente ancorato) nella quale viene calata un’esca artificiale sul fondo e salpata sino in superficie o quasi. Si pratica con canne specifiche per questa tecnica montate con un mulinello a bobina fissa; le esche artificiali impiegate sono concepite ad hoc per questa pratica di pesca. Il vertical jigging essendo una pesca importata dal Giappone non appartiene alla tradizione ligure; ciò nonostante stiamo assistendo ad una rapida diffusione di questa pratica poiché è molto efficace per la cattura di grossi esemplari. Come altre pratiche di pesca anche il vertical jigging impatta sia stock ittici che sui popolamenti del coralligeno poiché è indirizzato esclusivamente su specie predatrici come cernie, ricciole e dentici; inoltre, essendo necessario portare continuamente sul fondo esche artificiali di massa anche superiore ai 200 grammi, è indubbio il danno meccanico che si va a creare su esseri viventi dalla forma arborescente. A proposito di impatti sull’ecosistema non si può non menzionare quello generato con l’introduzione di esche naturali nell’ambiente. Spesso si tratta di policheti provenienti da zone tropicali che, per giungere ancora vivi nei carnieri dei pescatori sportivi, devono essere dotati di grandi capacità di resistenza a variazioni climatiche e ambientali. Abitualmente accade che il pescatore sportivo al termine di una battuta di pesca getti in mare le esche inutilizzate spinto talvolta dal proposito di salvare loro la vita; queste azioni hanno però la conseguenza di introdurre nell’ecosistema organismi alloctoni o, più comunemente chiamati “alieni”, molto resistenti e capaci probabilmente di scalzare dalle proprie nicchie i policheti autoctoni. Monitoraggio dell’attività di pesca sportiva Per approfondire le conoscenze sulle dimensioni e sulle caratteristiche del fenomeno pesca sportiva nell’AMP Portofino, dal mese di giugno è in corso un’attività di monitoraggio svolta congiuntamente con gli Organi di Vigilanza. Il campionamento avviene sia in giorni feriali che in giorni festivi in orari che possono variare tra le ore 6 e le 23. Tramite uscite in mare si riesce a monitorare sia i pescatori da riva che quelli da natante. Attraverso brevi colloqui con i censiti e osservandone le attrezzature si procede con la loro identificazione, si accerta che agiscano secondo la normativa vigente, si definisce quali siano le tecniche utilizzate e si indaga sulle catture. I dati raccolti sono ulteriormente analizzati ed elaborati al fine di conoscere lo sforzo di pesca, i siti più frequentati, tecniche ed esche più utilizzate, e il numero dei pescatori attivi nell’AMP. I dati inseriti in questo lavoro sono relativi al periodo giugno-settembre 2009: i mesi estivi sono quelli in cui la presenza dei pescatori sportivi in mare è maggiore, quindi, anche se siamo obbligati a definirli come parziali, crediamo che tali dati non si allontanino di molto dalla situazione reale. Si riporta di seguito il modello di scheda utilizzato per la raccolta dati: Figura 160: Scheda utilizzata durante la raccolta dati sulla pesca sportiva Per ogni pescatore si annota l’ora, il sito in cui è stato censito (utilizzando i settori già adottati nel monitoraggio della nautica da diporto) e la tecnica di pesca che sta praticando. Quando è possibile si procede con una breve intervista per ottenere dati sulla residenza ed eventuale numero di autorizzazione del pescatore, sulle esche utilizzate e sulle catture. Attraverso questi dati otteniamo informazioni sui pescatori come la provenienza, i siti e gli orari di pesca preferiti, se sono a conoscenza del regolamento e, quindi, agiscono di conseguenza oppure no; inoltre possiamo studiare la diffusione delle tecniche di pesca ed delle esche. Per quanto riguarda i dati sulle catture esse si basano sulle dichiarazioni dei pescatori e non su perquisizioni o controlli da parte degli Organi di Vigilanza. Il numero delle giornate di campionamento è stato pari a 14, durante le quali è accaduto di compiere delle repliche, ossia di censire lo stesso pescatore in più giorni; per questo motivo il numero totale dei colloqui è di poco superiore al numero dei pescatori incontrati. Durante i 14 giorni di monitoraggio sono state condotte 66 interviste e sono stati avvistati (ma non avvicinati per impossibilità logistiche) 11 pescatori, per un totale di 77 campioni. Considerando che in ogni giorno l’attività di monitoraggio veniva condotta per un massimo di 4 ore, possiamo stimare che le effettive battute di pesca verificatesi in queste 14 giornate si avvicinino al triplo del valore dai noi riscontrato (considerando 12 ore utili in una giornata) ossia 231; mediando tale valore possiamo stimare che, nel periodo estivo, il numero medio giornaliero di pescatori sportivi in AMP sia di 16,5 unità. Le informazioni ricavate hanno permesso di verificare la provenienza di ciascun pescatore sportivo come illustrato in figura 161. 21% 21% 23% 23% 14% 14% SML SML Portofino Portofino Camogli Camogli non residenti non residenti 42% 42% Figura 161: residenza dei pescatori sportivi che operano in AMP Dal grafico in figura 161 si apprende che il 77% dei pescatori censiti è residente in AMP; il restante 23% è rappresentato soprattutto da abitanti di comuni limitrofi come Rapallo, Chiavari, Recco, Genova. Questo ci rivela che i turisti in villeggiatura nel Tigullio o nel Golfo Paradiso, che si dedicano alla pesca sportiva in AMP, sono solo una piccolissima parte. Possiamo quindi affermare che il grafico in figura 161 possa essere valido per tutti i mesi dell’anno. La distribuzione dei pescatori sportivi, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, non è proporzionale al numero di abitanti dei singoli comuni. Camogli, infatti, che ha circa la metà degli abitanti di Santa Margherita Ligure, conta un numero di pescasportivi pari al doppio di quella della cittadina del Tigullio. Di estrema rilevanza sarà l’informazione circa gli attrezzi utilizzati in relazione alla marineria di appartenenza (Tabella 11). Tabella 11: residenza e tecniche di pesca adottate dai pescatori sportivi in AMP (le caselle evidenziate indicano tecniche non consentite) SML Portofino Camogli non residenti non censiti TOTALE traina 4 3 7 4 2 20 palamito 0 0 1 0 0 1 canna natante 2 3 2 6 0 13 bolentino 2 3 12 1 0 18 nattelli 0 0 3 0 0 3 vertical jigging 2 0 0 1 0 3 cefalopodi 1 0 2 1 0 4 rockfishing 0 0 1 1 2 4 spinning 1 0 0 1 1 3 galleggiante 2 0 0 0 6 8 14 9 28 15 11 77 TOTALE 10% 10% 4% 4% 27% 27% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 1% 1% 4% 4% 17% 17% 23% 23% traina traina palamito palamito canna natante canna natante bolentino bolentino nattelli nattelli vertical jigging vertical jigging cefalopodi cefalopodi rockfishing rockfishing spinning spinning galleggiante galleggiante Figura 162: Tecniche di pesca adottate nell’AMP Portofino Come si intuisce dal grafico in figura 162 e dai dati di tabella 11 i pescatori sportivi, principalmente, si dedicano alla traina e alla pesca a fondo dalla barca (bolentino o canna da natante). Non possiamo affermare che il suddetto grafico rispecchi una situazione valida per tutto l’anno poiché anche la pesca sportiva, come quella professionale, ha una sua stagionalità. Ne è un esempio la pesca con i palangari: dal campionamento risulta essere praticata solo dall’1% dei pescatori sportivi. Tale dato sottostima la situazione reale poiché, da colloqui informali con operatori del settore, abbiamo appreso che tale pratica è abbastanza diffusa. Abbiamo ipotizzato che, avere campionato un solo palangaro nelle 14 giornate di monitoraggio, possa essere dovuto al fatto che nel periodo estivo, a causa dell’accentuata presenza in AMP di natanti e imbarcazioni da diporto, il rischio di danneggiare un attrezzo sia molto più elevato che nelle altre stagioni (ovviamente in giornate con condizioni meteo-marine non particolarmente avverse). Come si deduce da figura 163 e figura 164, la pesca sportiva in AMP è praticata soprattutto da natante. 19% 19% riva riva natante natante 81% 81% Figura 163: distribuzione delle tecniche di pesca sportiva da riva e da natante 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% SML SML Portofino Portofino Camogli Camogli non non residenti residenti galleggiante galleggiante spinning spinning rockfishing rockfishing cefalopodi cefalopodi verticaljigging jigging vertical nattelli nattelli bolentino bolentino cannanatante natante canna palamito palamito traina traina Figura 164: analisi delle tecniche adottate in AMP dai pescatori sportivi in relazione alla loro residenza Il primo dato che emerge dal grafico in figura 164 è che, avendo praticato la traina, più del 20% dei pescatori non residenti censiti ha agito contro il regolamento. A proposito delle tecniche adottate emerge che a Portofino sono praticate pressoché in uguale misura solo traina, bolentino e canna da natante; a Camogli circa il 40% dei campionati si dedica al bolentino, poco più del 20% alla traina. Anche se rappresentati da una bassa percentuale, solo a Camogli sono presenti pescatori che usano i nattelli. La traina è praticata da circa il 25% dei pescatori sanmargheritesi; canna da natante, bolentino, vertical jigging, pesca ai cefalopodi, spinning e pesca a galleggiante sono diffuse più o meno in uguale misura. Il fatto che questi dati siano relativi solo ai mesi estivi è evidente quando si analizzano le tecniche adottate dai pescatori non residenti. Come già detto per chi non abita in uno dei comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino o Camogli l’autorizzazione per la pesca sportiva da riva è rilasciata dopo il pagamento di una cifra pari a 110 euro. Essendo state rilasciate per l’anno 2009 quarantatre autorizzazioni da riva, è palese che, avendo campionato due soli pescatori da riva, si è sottostimato la reale situazione. Un campionamento compiuto nell’arco di un anno intero potrà rivelare una situazione più vicina a quella reale. Per quanto riguarda i siti preferiti per la pesca sportiva la situazione è quella illustrata in figura 165. 41% 41% 59% 59% Zona B Zona B Zone C Zone C Figura 165: Studio sulla distribuzione dei pescatori sportivi nelle zone B e C Esiste una leggera propensione a pescare maggiormente in zona B dove l’effetto riserva e fattori di natura geomorfologica aumentano la possibilità di catturare specie target. Tale dato non è confortante agli occhi dell’Ente Gestore, poiché, il fatto che la maggior parte delle attività di pesca sportiva sia svolta in una zona di riserva generale, è indubbiamente in forte contrasto con gli obiettivi di conservazione della biodiversità ed di educazione ambientale propri dell’AMP. Intervenire con norme più restrittive sulla pesca in zona B agevolerebbe il raggiungimento degli obiettivi espressi nel Decreto Istitutivo L’adeguamento dei comportamenti e delle attività di pesca sportiva ad una esigenza di maggiore tutela potrebbe essere conseguita attraverso forme di coinvolgimento delle associazioni di categoria ad un “tavolo tecnico” attraverso il quale definire vincoli ed opportunità in modo aperto e, di conseguenza, condiviso. Azioni congiunte potrebbero portare a definire nuove situazioni ed opportunità che valorizzerebbero ulteriormente l’effetto riserva e il conseguente effetto “spill over” a tutto vantaggio anche delle attività ludiche espresse dal pescatore sportivo. In questa analisi, riteniamo opportuno e foriero di informazioni anche l’approfondimento del tema della pesca svolta in modo illecito, al fine di comprendere cosa spinge a praticarla in AMP e quanto possano essere accresciute le attività di sorveglianza (figura 166). 19% 19% in regola in regola non in regola non in regola 81% 81% Figura 166: studio sulla regolarità delle attività di pesca sportiva in AMP 18% 18% senza autorizzazione senza autorizzazione sito interdetto alla pesca sito interdetto alla pesca attrezzi non consentiti attrezzi non consentiti 18% 18% 64% 64% Figura 167: studio sulle diverse tipologie di pesca contro il regolamento La situazione delineata da figura 166 e figura 167 è, nel complesso, confortante poiché risulta che solo il 19% dei pescatori sportivi agisce contro il regolamento. L’attività “illegale” più frequente risulta essere la pesca senza autorizzazione. Il 18% dei pescatori non in regola utilizza ami di misura vietata dal regolamento (<18mm di lunghezza) e, altrettanti individui sono stati sorpresi a pescare in zona B con tecniche non ammesse in tali siti. Uno studio ulteriore è stato eseguito sulle tecniche del bolentino e della traina in particolare sulle esche utilizzate; per quanto riguarda il primo caso l’obiettivo è quello di studiare l’efficacia delle diverse esche ma per addurre affermazioni in tal senso è necessario disporre di molti più dati di quelli attualmente in nostro possesso. Per questo motivo, attualmente ci limitiamo esclusivamente a descrivere le scelte dei pescatori (figura 168 per il bolentino). 4% 4% 11% 11% 7% 7% 15% 15% 26% 26% 22% 22% sarda sarda acciuga acciuga altri pesci morti altri pesci morti cefalopodi cefalopodi mazzancolla mazzancolla 15% 15% pesce vivo pesce vivo gamberetto gamberetto Figura 168: Studio sulle esche utilizzate per la pesca a bolentino Per quanto riguarda la traina, invece, abbiamo provato a capire quali sono le esche utilizzate, poiché, se da un lato si vuole fermare la pratica devastante del vertical jigging, dall’altro vietare l’uso di esche artificiali andrebbe a penalizzare coloro che praticano la traina di superficie che nulla impatta sui fondali e sugli abitanti stanziali degli stessi. Lo studio condotto ha pertanto lo scopo di comprendere quanti trainisti sarebbero penalizzati con il divieto degli artificiali. 8% 8% naturali vive naturali vive naturali morte naturali morte artificiali artificiali 23% 23% 69% 69% Figura 169: Percentuale delle esche utilizzate per la pesca a traina Come ben evidenziato dal grafico in figura 169 la maggioranza dei trainisti utilizza esche artificiali. Il rischio che, in caso di divieto, questi pescatori cambino abitudini adottando esche naturali e, di conseguenza, dedicandosi alla traina di fondo è moderato: infatti gestire e reperire un’esca naturale, soprattutto se viva, risulta molto più difficoltoso e, quindi, non molti pescatori ne sarebbero invogliati. Vietare l’utilizzo di esche finte potrebbe essere molto efficace per la tutela delle specie target del vertical jigging ma, nel contempo, andrebbe a creare una situazione di malcontento per i pescatori sportivi che si dedicano alla traina di superficie e allo spinning in AMP. Infine è stata condotta un’indagine sulle catture compiute dai pescatori censiti. Essendo stato condotto da personale scientifico e non di “controllo”, lo studio è basato sulle risposte date dai pescatori sportivi durante le interviste. Potrebbe essere verosimile che le dichiarazioni sugli esemplari catturati si discostino anche in misura considerevole dalla situazione reale. Dal momento che, per altro, molti intervistati ci hanno permesso di visionare le loro catture, abbiamo comunque deciso di riportare qui di seguito il grafico che riassume quanto emerso dal monitoraggio. 8% 8% 23% 23% 27% 27% solo bycatch solo bycatch target target nulla nulla 42% 42% non censiti non censiti Figura 170: studio sulle dichiarazioni dei pescatori in proposito alle proprie catture Il grafico in figura 170 mostra che più della metà degli individui intervistati non è riuscita a catturare nulla. L’effetto riserva sui popolamenti ittici ci risulta essere significativo, per cui è francamente difficile pensare che un pescatore mediamente competente non riesca a pescare neppure un pesce! Inoltre, se si pensa che l’età media del pescatore sportivo è piuttosto alta, l’esperienza in merito dovrà sicuramente essere proporzionale all’età. Un dato confortante per i futuri monitoraggi però è che il 27% dei pescatori ha collaborato di buon grado non esitando a mostrare gli esemplari catturati appartenenti alle specie target, come illustrato in figura 171. Figura 171: esemplare di mostella (Phycis phycis) catturato nei pressi di Punta Faro con la tecnica della canna da bolentino (foto V. Cappanera) Figura 172: esemplare di Dentex dentex catturato con la tecnica della pesca a traina da kayak (kayak fishing) (foto P. Campodonico) È su questa classe di pescatori sportivi “facilmente intervistabili” che si dovrà far leva per rompere quel muro di diffidenza e di omertà che tuttora è ben eretto all’interno della categoria dei pescatori sportivi. Come già affermato, la strada da percorrere sarà quella dell’apertura di un “tavolo tecnico” con le Associazioni di categoria, con gli Enti Istituzionali più importanti (Regione Liguria e Provincia di Genova) con l’Università degli studi di Genova, con le altre AMP liguri, per studiare assieme le problematiche, le opportunità e le soluzioni per una proficua coesistenza fra l’ambiente e l’appassionato. IL MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE: lo studio sulla distribuzione di Caulerpa racemosa nell’Area Marina Protetta di Portofino Caulerpa racemosa è un’alga della famiglia delle Caulerpacee, appartiene alla classe Cloroficee ed è monotipica in quanto accoglie il solo genere Caulerpa. È ampliamente distribuita nei mari tropicali e subtropicali (Taylor, 1960) e definita specie lessepsiana migrante, cioè introdotta nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez (Aleem, 1948, 1992), dove ha colonizzato diverse aree del bacino meridionale e orientale (Piazzi et al., 1997). Essa si è rapidamente espansa lungo le coste nord-occidentali (Modena et al., 2000), come specie altamente invasiva, e le conoscenze dell’effetto della sua diffusione sui popolamenti zoobentonici in Mediterraneo sono ancora molto scarsi. Questa specie invasiva è, come molte altre, definita “aliena”. Il problema al riguardo è scaturito soprattutto negli ultimi anni, a seguito delle sempre più vaste problematiche determinate dal riscaldamento globale e dei relativi discorsi aperti. A volte anche frutto di un eccessivo allarme diffuso, facendo riferimento alla famosa ”alga assassina”, Caulerpa taxifolia, la cui comparsa aveva fatto acquisire alla biologia marina un posto nell’”effimero dei mezzi di comunicazione di massa”. In particolare, se si considerano sia le varie precedenti invasioni, sia le trasformazioni del paesaggio da esse causate in tempi storici, l’episodio Caulerpa ne esce per lo meno ridimensionato, tenendo conto anche del fatto che il Mediterraneo è stato ed è crocevia storico di popoli e culture, fatto talmente noto da rientrare di diritto tra i dogmi scolastici e i luoghi comuni di cultura liceale. Inoltre la varietà dei sistemi costieri del Mediterraneo, l’antichità della presenza umana e dell’uso degli ambienti mediterranei, rinviano ad un’immagine della natura sicuramente ben diversa dall’attuale, non soltanto per la comparsa di qualche gruppo di specie legata all’inquinamento. È verosimile, infatti, che l’arrivo e l’insediamento di alcune specie alloctone abbia giocato un ruolo compensativo alla scomparsa di forme indigene. In questo senso non si tratta solamente di specie rare: il volgare mitilo è infatti l’esempio di una probabile migrazione che ha profondamente cambiato l’assetto bionomico del Mediterraneo centrale. Boudouresque e Verlaque (2000) avevano redatto una lista delle macrofite “introdotte”, definendo nove di queste come invasive. D’altra parte non è solo il Mediterraneo ad essere caratterizzato da invasioni di specie estranee, ma si tratta di un fenomeno generale, facilitato dall’incremento dei traffici marittimi e dai cambiamenti nella qualità delle acque costiere. Più specificatamente le invasioni di specie alloctone di origine antropica sono spesso dovute a movimenti di grandi navi (attraverso grossi volumi di acque di zavorra e degli ancoraggi), ma anche a fenomeni legati all’acquacoltura, mediante i quali si sono verificati nel tempo modifiche importanti (Occhipinti-Ambrogi e Savini 2003). A questo si aggiungono altri fenomeni legati alla pesca, quali lo strascico e l’abbandono di reti sul fondo unitamente al movimento delle correnti che possono in qualche modo favorirne la dispersione (Klein & Verlaque, 2008). In questo senso svolgono un ruolo importante nell’ospitare e concentrare le popolazioni delle forme larvali e, quindi, nella selezione ed acclimatazione delle forme adulte, i cui discendenti si liberano i mare aperto con probabilità di sopravvivenza maggiori, i terminali petroliferi e le aree semichiuse portuali, oltre alle lagune costiere. In molti casi sono i danni alle economie locali e alle strutture industriali a rivelare l’invasione a posteriori, quando questa non è più rimediabile (Riggio S., 1995). Pertanto risulta ormai fondamentale tenere altamente sotto controllo gli ambienti, riuscendo a cogliere i segnali che lo stesso ci dà e adottando in tempo, dov’è possibile, le misure necessarie a limitare tali modifiche che, in determinate circostanze, potrebbero essere irreversibili. Il gruppo sistematico delle Caulerpe comprende circa settanta specie, 6 delle quali segnalate nel Mediterraneo (Meinesz e Hesse, 1991). Le prime segnalazioni dell’avanzata di Caulerpa taxifolia mostravano attacchi dell’alga soprattutto su ambienti instabili degradati, su sabbioni grossolani privi o quasi di insediamenti; è possibile infatti dimostrare una certa affinità con l’attiniario Alicia mirabilis, nonché diversi attacchi ai posidonieti, anche se su mattes già in sofferenza (Riggio S., 2000). Analogamente a taxifolia, Caulerpa racemosa, ha subito una diffusione a macchia di leopardo. La prima segnalazione di Caulerpa racemosa nel Mediterraneo è avvenuta in Tunisia nel 1926. Per quanto riguarda le coste italiane è apparsa per la prima volta nel 1993 in Sicilia (Alongi et al., 1993), nel 1994 sulle coste livornesi (Piazzi et al., 1994), in Sardegna (Di Martino e Giaccone, 1995) ed in Liguria (Bussotti et al., 1996). Jousson et al. (1998) ne rilevarono la presenza vicino a Marsiglia. Per ciò che riguarda più specificatamente il Mar Ligure, Modena et al. (2000), segnalarono la distribuzione dell’alga, il substrato preferenziale e la morfologia dei talli in una località a ovest di Genova (Varazze) e in altre tre situate in zone limitrofe situate a est della città: Sturla, Quinto e Nervi. Nell’Area Marina Protetta Portofino, definita sito a miglior stato ecologico in Liguria (Mangialajo et al., 2007), sulla base dell’utilizzo di un indice (Carlit) ricavato da presenza e abbondanza di alcune specie significative, Caulerpa racemosa è stata avvistata per la prima volta nel 2007 (Mangialajo com. pers.) in due siti del Fronte Sud: Altare e Punta Chiappa Levante. Successivamente diverse sono state le segnalazioni da parte dei subacquei locali che ogni giorno si trovano in stretto contato con i fondali del Promontorio e hanno pertanto buona percezione dei suoi fondali. In questo senso, vista l’importanza di una tale invasione, soprattutto in correlazione ai cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni a seguito di fenomeni di riscaldamento globale, l’Ente Gestore ha deciso di attuare una prima indagine circa la distribuzione della suddetta alga, al fine di poter avere un’idea di base dalla quale poter partire e prevedere futuri ampliamenti della sua distribuzione. Nell’Area Marina Protetta di Portofino non sono presenti studi antecedenti su tale alga. Studi condotti alla fine degli anni ’50 segnalavano la presenza di Caulerpa prolifera nel Golfo del Tigullio (Tortonese, 1962), ma niente su C. racemosa. Caratteristiche biologiche: Caulerpa racemosa presenta un unico tallo uni-assiale diviso in parti (assi) chiamati stoloni da cui si dipartono rizoidi e fronde erette (filloidi) che consentono l’ancoraggio al substrato e l’assimilazione di sostanze, nude o con rami caratterizzati da vescicole di forma sferica (figura 173, Klein & Verlaque, 2008). Figura 173: descrizione struttura tallo Caulerpa racemosa (Klein & Verlaque, 2008). Quest’alga ha riproduzione sia sessuale sia asessuale, anche se in Mediterraneo non è mai stata osservata alcuna produzione di gameti da parte di entrambi i sessi. La riproduzione asessuale è, tra le due, quella considerata maggiormente importante e può verificarsi in due modi: attraverso crescita vegetativa e attraverso frammentazione e riattecchimento (Ceccherelli et al., 2001). Anche un piccolo frammento è in grado di attecchire e creare una nuova colonia; è quindi facile favorirne l’espansione trasportandola inavvertitamente per esempio con reti ed ancore (attività quali pesca e nautica, molto presenti a Portofino). Una volta insediata, pare che la popolazione di Caulerpa si mantenga piuttosto stabile, senza decrementi, anche se un piccolo collasso era stato osservato nel Sud-Est della Francia e in Turchia (dopo le segnalazioni del 1998), probabilmente dovuto alla concomitanza di diverse condizioni non favorevoli, come le estreme temperature, le abrasioni nel sedimento o l’elevato idrodinamismo. Allo stesso modo alcune zone francesi ampliamente colonizzate da Caulerpa sono rimaste tali per diversi anni e non si sa ancora se questo sia dovuto a condizioni non favorevoli nelle zone limitrofe, alla mancanza di dispersione o ad altri fattori (Klein & Verlaque, 2008). Il suo sviluppo è condizionato dalla luce, dal substrato su cui s’insedia, dalla temperatura dell’acqua e dall’idrodinamismo. Luce. È stato evidenziato che Caulerpa mostra un elevata tolleranza a basse condizioni di luce, ovvero si parla infatti di una “foto acclimatazione” che inizia quando aumenta la profondità e durante il ciclo stagionale. Quando aumenta la profondità aumenterà anche l’efficienza foto-sintetica per mantenere costante il numero dei centri di reazione. Substrato. È stata rilevata su ciottoli, roccia, matte morta di Posidonia oceanica, sabbia, detrito e coralligeno Profondità. Da 0 a 70 m con un elevata abbondanza tra 0 e 30 m. Temperatura. È stata rilevata in condizioni di temperatura pari a 8°C (Croazia) e 28°C nel bacino est del Mediterraneo (Cipro, Libia, Turchia). Idrodinamismo. Gli effetti dei movimenti dell’acqua non sono ancora chiari. Alcune specie sono state rilevate in zone riparate così come in zone esposte; tuttavia sembra poter essere danneggiata da sabbia pulita, mentre relativamente resistente alla sepoltura di sedimenti. Si evidenzia quindi una dinamica stagionale che prevede il massimo di accrescimento vegetativo in settembre – ottobre ed il suo minimo sviluppo tra marzo e aprile (Piazzi et al.,1997). Essa ha la capacità di colonizzare una grande varietà di substrati sia coerenti che incoerenti. Inoltre, il particolare meccanismo di metabolismo facoltativo eterotrofo, ne ha favorito l’insediamento su substrati anche degradati (Cossu e Gazale, 1996). Monitoraggio su campo L’indagine nell’AMP Portofino è stata effettuata nei mesi di settembre e ottobre (massimo stato di accrescimento) 2009, ad opera di due operatori subacquei in immersione autonoma con A.R.A. Figura. 174-175: foto dei due operatori durante i campionamenti di Caulerpa racemosa (foto V. Cappanera, S. Venturini). In fase di monitoraggio sono stati considerati 9 siti d’immersione distribuiti in modo omogeneo nella zona B per un totale di 10 immersioni (Fig. 176); tali siti rappresentano la metà di tutti i siti d’immersione di Zona B, dal momento che alcuni si trovano così vicino uno all’altro da sconsigliare ulteriori osservazioni. Le due Zone C dell’Area Marina saranno monitorate successivamente. Per ogni immersione gli operatori effettuavano il giro completo del sito, da levante verso ponente (stesso percorso consigliato ai subacquei ricreativi), rilevando la distribuzione di Caulerpa racemosa alle varie profondità. Figura 176: siti AMP Portofino dove sono stati effettuati i campionamenti C. racemosa Per ciascuna immersione gli operatori hanno rilevato i seguenti parametri: x sito d’immersione e data di campionamento; x descrizione del substrato insediato; x limiti batimetrici di rilevamento; x aspetto (continuo o a chiazze); x stima percentuale di copertura, rilevata con maggior dettaglio nei siti Altare e Punta Chiappa levante; x descrizione del prato rispetto all’altezza dei filloidi ed alla coperture degli stoloni. Nei due siti d’immersione Punta Chiappa levante e Altare sono state effettuate specifiche procedure per il rilevamento delle percentuali di copertura. Il livello di ricoprimento è stato rilevato direttamente tramite osservazioni in mare e attraverso elaborazioni fotografiche; l’operatore durante l’immersione effettuava foto (ogni 5 m circa, partendo dalla profondità di 30 m e risalendo) con l’utilizzo di una riga di 30 cm per eseguire, in seguito, un’elaborazione fotografica tramite quadrati di lato 30cm x 30cm (vedi Figura 177). Per semplificare la stima di copertura, sono stati scelti tre range di ricoprimento percentuale: x 0 - 30%; x 30% -60%; x 60% -100%. Figura 177: esempio elaborazione fotografica (quadrato lato 30cm x 30cm), Altare (foto S.Venturini) Punta Chiappa Levante In questo sito d’immersione, come per quello dell’Altare, sono state effettuate osservazioni e campionamenti maggiormente dettagliati; questo perché, come già accennato precedentemente, i due siti erano stati segnalati nel 2007 per la presenza diffusa di Caulerpa racemosa. Essa è stata monitorata dai 7 m ad oltre 30 m di profondità (limite inferiore stimato: 40 m). A partire dai 30 metri, e per ogni 5 m, sono stati effettuati monitoraggi per il rilevamento della percentuale di copertura, ottenendo le seguenti elaborazioni: Figura 178: Punta Chiappa levante, 30m fondale sabbioso (foto S. Venturini) Già a partire da 30 m è stata monitorata una copertura di Caulerpa racemosa che rientra nel range 30% - 60%. È stato osservato come l’alga sia presente a profondità anche superiori. Qui abbiamo la predominanza di un substrato sabbioso con poca pendenza, condizioni rilevatesi ottimali per la proliferazione di quest’alga. Intorno ai 25 m è stata monitorata la presenza di una piccola prateria di Posidonia oceanica. Figura.179: Punta Chiappa levante (25 m): fondale sabbioso misto roccia con Caulerpa racemosa in presenza di Posidonia oceanica.(foto S. Venturini) E’stato rilevato come Caulerpa racemosa, anche in presenza di Posidonia oceanica, assuma una percentuale di ricoprimento compresa tra il 30% e il 60%. Come si può notare in Figura 179 Caulerpa riesce molto bene ad insediarsi su Posidonia, però l’alga non sembra prediligere tale substrato, in quanto la prateria si presenta in buono stato di salute. Infatti, in un lavoro di Ceccherelli e Piazzi (1999) in cui si è cercato di valutare l’effetto dell’orientamento dei margini di Posidonia oceanica e della densità dei fasci sull’alga introdotta Caulerpa, è stato messo in evidenza come l’accrescimento degli stoloni di Caulerpa ai margini delle praterie sia influenzato significativamente dalla densità dei fasci: sono infatti le praterie in cattivo stato di salute e quindi con minore densità dei fasci (10 %), che possono subire maggiormente l’invasione della stessa; quelle a densità più elevata (50%), pare abbiano i margini più vulnerabili all’invasione rivolti verso costa. L’accrescimento dell’alga deve essere comunque tenuto sotto stretto controllo dal momento che ne sono stati registrati valori piuttosto elevati e, da singoli frammenti insediati al margine delle chiazze di Posidonia oceanica, si possono rapidamente sviluppare reti di stoloni in grado di ricoprire il substrato quasi totalmente in soli 4 mesi di tempo, indipendentemente dalle condizioni della fanerogama. Figura 180 - 181: Punta Chiappa levante, 25m fondale sabbioso (visione dall’alto e visione laterale, foto S. Venturini) In questo caso l’elaborazione fotografica per la valutazione della percentuale di copertura di Caulerpa non risulta efficace; questo perché la presenza di Posidonia non permette la visualizzazione dell’alga, la visione laterale permette di comprendere meglio quanto appena detto. In questo caso risulta di fondamentale importanza il rilevamento diretto effettuato in mare. Figura 182: Punta Chiappa levante (20 m): fondale sabbioso (Foto S. Venturini) Figura 183: Punta Chiappa levante (15 m): fondale sabbioso (foto S. Venturini) Tra i 20 m e i 15 m è stata monitorata una percentuale di copertura media; solo in piccole chiazze si è riscontrata un’alta percentuale di ricoprimento; dai dieci metri in su si registra una drastica diminuzione delle percentuali dell’alga sino alla completa assenza di Caulerpa a profondità inferiori ai 7 m. Figura 184: Punta Chiappa levante (10 m) su roccia (foto S. Venturini) Cala dell’Oro Tale sito d’immersione sarà effettuato in seguito in quanto la tempistica non l’ha per ora concesso. In ogni caso da segnalazioni fatte da personale scientifico autorizzato ad entrare in tale area e osservando la distribuzione di Caulerpa nei siti immediatamente limitrofi, ci è possibile stimare una presenza di quest’alga anche in Cala dell’Oro. Si presume un limite inferiore dei 40m e un limite superiore che può variare tra gli 8m e i 5m (limiti rilevati nella maggior parte dei siti del Fronte Sud del Promontorio). Interessante sarà valutare la percentuale di ricoprimento di Caulerpa in tale area, che essendo una zona riparata, potrebbe avere caratteristiche tali da favorire l’insediarsi dell’alga, ed al tempo stesso essendo una zona “no take no entry” escludere sicuramente l’influenza dell’uomo nella distribuzione della stessa in tale sito. Punta della Torretta In questo sito di immersione Caulerpa racemosa è stata rilevata dai 5 m agli oltre 30 m di profondità con diverse percentuali di copertura (riscontrato anche un alto livello di ricoprimento) a seconda della tipologia di fondale, pendenza ed esposizione alla luce. In questo sito si è monitorata una presenza di Caulerpa diffusa ed in relazione a diverse tipologie di fondale (anche su ambienti a Posidonia oceanica, come nel sito precedente). Presenza di filloidi eretti poco sviluppati contrariamente a vescicole di grosse dimensioni e stoloni ben insediati sul substrato (figura 185). Figura 185: Caulerpa racemosa (Punta della Torretta, foto S. Venturini) Secca Gonzatti Caulerpa racemosa è stata rilevata con una distribuzione diffusa dai 15 m fino ad oltre i 30 m; le percentuali di copertura sono risultate differenti, a seconda delle caratteristiche del fondale, esposizione alla luce e presenza di correnti. Figura 186: Caulerpa racemosa (Secca Gonzatti, foto S.Venturini) Figura 187: Caulerpa racemosa Secca Gonzatti, (foto V. Cappanera) Anche in questo sito si può osservare come stoloni e vescicole dell’alga siano ben sviluppati, contrariamente ai fillodi che sono invece di piccole dimensioni. Monitoraggi futuri ci consentiranno di verificare l’evoluzione dell’alga in tali siti. Scoglio del Diamante In questo sito di immersione è stata riscontrata la presenza di Caulerpa racemosa dagli 8m ed oltre i 30m, con distribuzione diffusa in tutto il sito d’immersione. Dai 15m sino agli 8m si è monitorata una percentuale di copertura bassa e risalendo, a profondità inferiori agli 8 m, si ha la completa scomparsa dell’alga; probabilmente si hanno delle condizioni ambientali tali da non favorire la proliferazione di Caulerpa racemosa (correnti, moto ondoso ecc). Dai 15 m ai 25 m si hanno invece percentuali di copertura che passano da medio (60%) ad alte (100%) per poi passare a percentuali di ricoprimento inferiori intorno ai 30m (probabile limitazione della luce). Figura 188: Caulerpa racemosa, alta percentuale di ricoprimento (Scoglio del Diamante, foto S.Venturini) Figura 189: Caulerpa racemosa (Scoglio del Diamante, foto S.Venturini) In questo sito si è registrata una maggiore lunghezza dei filloidi ad indicare un probabile più vecchio insediamento di caulerpa rispetto ai siti precedenti. Relitto Mohawk Deer La distribuzione di C. racemosa è risultata in questo sito particolarmente diffusa, rilevata dai 5m fino ad oltre i 30m (limite presunto dei 35- 40m). Essa pare non caratterizzare zone ad alta pendenza, soggette a correnti e scarsità di luce. Rilevate tutte le percentuali di copertura; in particolare il massimo livello di copertura è stato riscontrato intorno ai 15 m. Figura 190: Caulerpa racemosa (15m), (Relitto Mohawk Deer, foto S.Venturini) In determinate circostanze sembra che l’alga cerchi di insediarsi anche in zone che dovrebbero presentare caratteristiche del tutto avverse, quali pareti particolarmente pendenti (figura 191). Figura 191: Caulerpa racemosa in tentativo di espansione su parete (Relitto Mohawk Deer, foto V. Cappanera) Dalla foto si riesce a notare solo in parte il tentativo di Caulerpa di insediarsi su una parete, limitato dall’azione della corrente che determina un continuo spostamento dei rizoidi; la sua distribuzione è comunque alta anche su diversi resti del relitto. Altare In questo sito d’immersione sono state effettuate osservazioni e campionamenti maggiormente dettagliati; questo perché, già nel 2007 erano giunte segnalazioni circa la presenza di Caulerpa racemosa. All’Altare si è rilevata una distribuzione di C. racemosa diffusa, osservata dai 9m fino ad oltre i 30m (limite presunto dei 40m). Anche in questo caso si osserva come non sia presente in zone ad alta pendenza, soggette a correnti e scarsità di luce; questo fattore si può presentare come limitante. Si nota anche una diversa % di copertura a seconda del substrato insediato, come si può osservare dalle seguenti immagini: Figura 192: Altare 30m fondale ciottoloso (foto S. Venturini) Figura 193: Altare 30m fondale sabbioso (foto S. Venturini) Nelle foto precedenti si può osservare come, alla stessa profondità (30 m) ma, in presenza di tipologia di fondale differente, si registrino diversi range di copertura; questo a sottolineare l’elevata adattabilità dell’alga. In tale sito Caulerpa risulta essere molto ben insediata al punto tale da tentare di invadere anche quelle superfici con caratteristiche a lei avverse (maggior pendenza e minore esposizione alla luce). Figura 194: Altare, tentativo di insediamento zona di maggior pendenza e ombra (foto S. Venturini) Figura 195: Caulerpa racemosa con rizoidi che tendono ad insediarsi all’interno del grottino (foto S. Venturini) Come già sottolineato precedentemente, in questo sito ritroviamo osservazioni di C. racemosa ovunque con diverse percentuali di copertura. Inoltre la ritroviamo in relazione a Posidonia oceanica, anche se non sembra preferire un substrato dove sia presente tale pianta rispetto ad un altro. Figure 196-197: Caulerpa racemosa su Posidonia oceanica (Altare, foto V. Cappanera) Il sito Altare risulta particolarmente impattato da C. racemosa, e questo lo si può capire non solo dalla distribuzione diffusa registrata, ma anche da una maggior lunghezza dei filloidi, come si può vedere in figura 197. Dai 25m ai 10m circa, riscontriamo un livello di copertura che va dal 30% al 60% pur essendo in presenza di tipologia di substrati differenti. Figura 198: Altare 18 m fondale sabbioso (foto S. Venturini) Figura 199: Altare 11m fondale roccioso (foto S. Venturini) A profondità inferiori ai 10m abbiamo una diminuzione delle percentuali di copertura sino alla completa assenza di Caulerpa tra i 7m-5m. Di seguito un esempio grafico che rappresenta la distribuzione di Caulerpa racemosa su fondale tra 15m e 0m. Figura 200: particolare distribuzione di Caulerpa racemosa (Altare) Particolare distribuzione si evidenzia nello scoglio cerchiato in rosso, di seguito riportiamo la visione laterale: Figura 201: particolare distribuzione di Caulerpa racemosa (Altare, foto S.Venturini) In questo caso la differente percentuale di copertura non può essere correlata alla diversa pendenza ed esposizione a correnti e luce (questi parametri variano in modo limitato); molto probabilmente l’alga si è prima insediata intorno ai 12m dove si registra un alta percentuale, per poi cercare di risalire. Intorno ai 7m abbiamo la totale assenza di Caulerpa racemosa. In generale in questo sito si è osservato come intorno alla profondità di 7m la distribuzione dell’alga sia scarsa o addirittura assente e ciò, è stato ipotizzato, può essere dovuto all’influenza del moto ondoso. Monitoraggi futuri ci permetteranno di capire se effettivamente a tale profondità esistono condizioni tali da poter influire negativamente sulla distribuzione di Caulerpa o se, semplicemente con il tempo, l’alga insedierà anche queste profondità. Casa del Sindaco E’stata monitorata una distribuzione diffusa tra i 9 m e i 28 m; con alta percentuale di copertura intorno ai 16m (figura 202). Rispetto ai siti precedenti è stata registrata una diminuzione nella lunghezza dei filloidi. Figura 202: alta densità di Caulerpa racemosa a 16 m di profondità (Casa del Sindaco, foto V. Cappanera) Anche in questo sito di immersione si ha presenza di Posidonia e Caulerpa che interagiscono in corrispondenza dello stesso substrato (figura 203). Figura 203: Caulerpa racemosa e Posidonia oceanica (Casa del Sindaco, foto V. Cappanera) Alle profondità dove si ha un fondale di tipo ghiaioso, la densità di Caulerpa è molto meno elevata complice anche la profondità che determina scarsità di luce. Chiesa di S. Giorgio In questo sito è stata monitorata una distribuzione a chiazze di Caulerpa racemosa tra 5m e 25m; mai registrata una copertura del 100%, dimensione filloidi ridotta. Figura 204: distribuzione di caulerpa a 5 m di profondità, limite superiore (Chiesa di S. Giorgio, foto V. Cappanera) Figura 205: distribuzione di caulerpa a 25 m di profondità, limite inferiore (Chiesa di S. Giorgio, foto V. Cappanera) Punta del Faro Questo sito d’immersione è l’unico dell’Area Marina che presenta completa assenza di Caulerpa racemosa. Si pensa che ciò sia correlato alla particolare conformazione del sito (estrema punta a levante del Promontorio) soggetto a forti correnti; infatti tale punta da anni rappresenta un sito per il monitoraggio delle correnti nella zona. Monitoraggi futuri potranno farci capire se realmente in questo sito esistono condizioni limitanti per Caulerpa racemosa o se semplicemente è questione di tempo e l’alga riuscirà ad insediarsi anche in qui. Da questa prima indagine si è osservato come Caulerpa racemosa abbia ormai assunto una distribuzione diffusa su tutto il Fronte Sud dell’Area Marina Protetta di Portofino. Si ritrovano percentuali di ricoprimento differenti, a seconda di tipologia di fondale, pendenza ed esposizione alla luce (fattori che influenzano Caulerpa). In generale abbiamo riscontrato una predilezione per i fondali sabbiosi, con scarse pendenze, buon esposizione alla luce e assenza di correnti. In tutti i siti ad eccezione di S.Giorgio e Punta Faro, sono state monitorate percentuali di ricoprimento che passano da basse (0% - 30%) ad alte (60% - 100%). A Punta del Faro in particolare si presume che la presenza di forti correnti ostacoli l’insediarsi di Caulerpa; inoltre in questi siti si registra una forte pendenza del fondale che, come già detto, potrebbe influire negativamente su quest’alga. Nella maggior parte dei siti analizzati si sono osservati stoloni e vescicole di Caulerpa racemosa ben sviluppati contrariamente ai fillodi di piccole dimensioni. In tre campionamenti (Scoglio del Diamante, Relitto Mohawk Deer e Altare) si è osservata una maggiore lunghezza dei filloidi, facendo pensare ad un probabile più antico insediamento nella zona. Per quanto riguarda i limiti superiori variano da 7 m a 5 m, mai osservata Caulerpa a profondità inferiore; si deduce quindi che esistano fattori, come il moto ondoso, che impediscono a quest’alga di insediarsi, diversamente è solo questione di dar tempo all’alga di poter colonizzare tali zone. In questo caso risulta di fondamentale importanza continuare ad effettuare dei controlli per poter valutare l’evoluzione di Caulerpa racemosa. I limiti inferiori hanno evidenziato come Caulerpa, nonostante risenta dell’influenza della luce, possa trovarsi a profondità superiori ai 30 m. solo nei siti posizionati più a levante è stato possibile determinare con esattezza il limite inferiore (vedi rappresentazione sotto); nella maggior parte dei siti è stato individuato un limite inferiore di 40m, profondità oltre la quale la crescita di Caulerpa è limitata per mancanza di luce. Figura 206: rappresentazione del limite inferiore di Caulerpa racemosa sul Fronte Sud dell’AMP Portofino Di fondamentale importanza sarà cercare di capire i danni che Caulerpa racemosa può portare alle biocenosi di pregio presenti nell’AMP e quindi continuare ed ampliare il monitoraggio di tale alga. Questa indagine deve essere considerata come un punto di partenza per gli studi futuri che dovranno comprendere anche le due zone C (ponente e levante), molto importanti per la presenza di Posidonia oceanica. Ciò soprattutto in relazione al fatto che vari studi hanno messo in evidenza l’insorgere di uno stato di insofferenza di alcune praterie a causa di relative invasioni di Caulerpa, che trova un substrato ideale per svilupparsi soprattutto su matte morta, come sottolineato anche nel lavoro di Cossu et al., 2003 in cui viene analizzata la distribuzione di Caulerpa racemosa nel Golfo dell’Asinara e rilevato un indice di ricoprimento piuttosto elevato (84%) in corrispondenza di zone a “matte morta”. In generale è possibile affermare che nella distribuzione di Caulerpa non c’è un legame con un fattor edafico particolare, ma è la contingenza di più fattori differenti che ne può limitare o favorire lo sviluppo; per questo viene rilevata soprattutto nelle zone riparate caratterizzate da scarsa idrodinamicità unitamente alla mancanza di luce. Le osservazioni dirette in situ confermano comunque la grande adattabilità di Caulerpa racemosa alle differenti tipologie di substrato (sia sabbioso, sia roccioso) e ampi intervalli batimetrici, come confermato da Russo et al., 2003. Il proseguimento in tal senso di un attento monitoraggio risulta importante se inserito in un contesto come quello di un’Area Marina Protetta e all’interno soprattutto di un bacino come quello del Mediterraneo, soggetto da qualche tempo a fenomeni di meridionalizzazione, quali la comparsa di specie “nuove” caratteristiche di zone tropicali ma anche l’innalzamento delle temperature; un esempio di quest’ultimo caso, è stata l’anomalia termica che si è verificata in Mar Ligure nell’estate 2003 e che ha causato veri e propri fenomeni di “mass mortality”, nonché un vero e proprio boom di mucillagini (alghe filamentose) in tutto il Promontorio. In questo contesto potrebbe risultare interessante andare a valutare la possibilità di un legame tra l’esplosione di mucillagini, che comunque si è avuta anche durante l’estate 2009, e lo sviluppo di Caulerpa, ovvero verificare se l’interazione delle due sia i grado di determinare un danno ulteriore alle comunità di fondo duro dell’Area Marina. Un’osservazione continua di tali fenomeni risulta importante in quanto tali introduzioni rappresentano un segnale del cambiamento globale in atto, ma soprattutto perché possono contribuire alla perdita di biodiversità, in particolare nelle zone caratterizzate già da bassi livelli in merito, quali ad esempio laghi, porti, estuari e Mari levantini in quanto più recettivi (Flagella et al., 2006); in tal senso sarà importante tenere sotto stretto controllo però quelle aree di pregio che più si trovano a contatto con zone estremamente antropizzate e Portofino, oltre ad essere caratterizzata, soprattutto nel periodo estivo, da intensi flussi turistici da ogni parte del mondo (attraverso battelli di linea, navi da crociera e singole unità da diporto), nonché continue attività di pesca, si trova a contatto con la realtà cittadina di Genova. Inoltre, anche se non è dimostrata l’affinità di Caulerpa con zone inquinate (per la prossimità a zone industriali, porti pesca sportiva, ecc), è comunque attestato che sia estremamente tollerante agli alti livelli di inquinamento (Kleine & Verlaine, 2008). Sicuramente esiste una corrispondenza tra i siti di colonizzazione e quelli più frequentati dall’attività antropica, soprattutto legata al turismo nautico e alla balneazione; non sembra invece esservi una correlazione con il turismo subacqueo, dal momento che tra i siti maggiormente frequentati risulta primeggiare Punta del Faro di Portofino, l’unico in cui la presenza di Caulerpa non è stata osservata. Nei prossimi monitoraggi le osservazioni dovrebbero quindi essere concentrate maggiormente nelle zone dove l’attività diportistica risulta più intensa soprattutto in relazione agli ancoraggi, ovvero le due zone C (a levante in particolare dove non vi sono campi ormeggio), analogamente forse, ad alcune zone dove è diffusa l’attività di balneazione, quali per esempio la baia di Niasca (sempre in Zona C). Monitoraggio dell’attività di balneazione Tra le attività di fruizione dell’AMP la balneazione è da sempre considerata quella che crea il minor impatto sull’ambiente; tuttavia, coinvolgendo decine di migliaia di persone distribuite, in pochi mesi dell’anno, su un tratto di costa molto limitato, è opportuno considerare anche tale attività all’interno della valutazione dell’impatto antropico sul territorio. L’attività di balneazione è stata, fino ad oggi, poco considerata fra le varie fruizioni dell’AMP, in considerazione del fatto che poche o quasi nulle sono le spiagge lungo il perimetro costiero del Promontorio. Ci è sembrato utile, invece, a partire da quest’anno, dimensionare il fenomeno e capire se esistono pericoli, potenzialità ed opportunità di gestione di questo importante settore dell’economia locale. Siamo perfettamente consapevoli, infatti, che il turismo balneare è sicuramente la più antica forma di fruizione delle nostre coste e, su di essa, si è sempre basata la strategia economica del comprensorio. Poiché il potersi bagnare nelle acque di un’AMP può a buon diritto costituire un ulteriore valore aggiunto a questo comparto, la prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di identificare, proprio per il contesto ambientale in cui il bagnante si trova, l’indicazione di pratiche di buona condotta da tenere in spiaggia e in mare. È evidente che la popolazione nei comuni dell’AMP durante i mesi estivi aumenta enormemente a causa di una massiccia presenza turistica; questo fenomeno porta senza dubbio benefici di natura socio-economica al comprensorio ma nel contempo anche problemi legati al sovraffollamento delle zone costiere che possono essere di natura logistica, come l’eccessivo traffico automobilistico che allunga i tempi di spostamento e crea maggiori difficoltà nel parcheggiare le autovetture, ma anche di natura ambientale, come l’aumento di immissioni di gas e polveri in atmosfera, l’eccessivo consumo con conseguente carenza di acqua potabile, la produzione di maggiori quantità di rifiuti e, non ultimo, l’aumento delle forme di inquinamento del mare. L’immissione di inquinanti in mare è proporzionale alla presenza antropica: anche ammettendo che tutti i cittadini abbiano un esemplare senso civico e perciò si comportino in maniera impeccabile dal punto di vista ambientale, è ovvio che espletando le proprie funzioni fisiologiche sarebbero responsabili almeno di un incremento della quantità di sostanza organica e batteri sversati in mare. Per quanto riguarda l’AMP tali problemi si riscontrano relativamente, poiché le condotte di scarico degli impianti scaricano i liquami in modo che la ripercussione sulle acque della riserva sia quasi nulla. Alcuni problemi sono stati riscontrati nella baia di San Fruttuoso dove non esiste un impianto di depurazione per il piccolo borgo: in estate, a causa dell’elevata presenza turistica e del debole idrodinamismo (in quanto si tratta di una baia), le analisi condotte sulla qualità del mare hanno rilevato una maggior presenza (seppur nei limiti imposti dalla legge) di coliformi e streptococchi fecali, come era stato sottolineato nel rapporto tecnico CoNiSMa (2007). I problemi legati alla balneazione aumentano quando si verificano comportamenti incivili da parte dei cittadini sulle spiagge o in mare, come l’abbandono di rifiuti, l’uso di shampoo e detergenti durante la doccia creando notevoli impatti anche dal punto di vista visivo. Per sensibilizzare la popolazione e mitigare l’effetto della pressione antropica, sul sito web dell’AMP è stato inserito un codice di condotta del tutto volontario nel quale sono presenti una serie di pratiche utili per la conservazione dell’ambiente, la civile convivenza sulle spiagge e la tutela della salute pubblica. All’interno di tale codice compare l’invito a non recarsi in mare con eccessive dosi di schermi o oli solari spalmati sul corpo: è stato dimostrato (Corinaldesi & Danovaro, 2003) che alcune sostanze contenute in tali prodotti influenzano l’abbondanza di virus batteriofagi destabilizzando così il rapporto batteri/virus; inoltre i componenti di queste creme arrecano impatti alle alghe verdi del genere Cystoseira. Siamo consapevoli che la salute pubblica abbia la precedenza sui problemi ambientali, quindi renderci fautori di una campagna contro l’uso di oli e creme solari non sarebbe comunque consona al ruolo dell’AMP; una soluzione potrebbe essere trovata congiuntamente ad altre AMP e ad associazioni ambientaliste, sensibilizzando le case produttrici alla ricerca per nuovi prodotti a minor impatto sull’ecosistema marino. Inoltre il prelievo di organismi da parte dei bagnanti è vietato, dal momento che si tratterebbe effettivamente di pesca subacquea. A causa della difficoltà nel sorvegliare metro per metro le aree balneari in realtà non possiamo escludere che tale attività si verifichi e, da colloqui informali con bagnini e altro personale sulle spiagge dell’AMP, sappiamo che non di rado sono raccolti esemplari di ricci di mare (Paracentrotus lividus, Arbacia lixula) e polpi (Octopus vulgaris). Per i motivi spiegati sinora, durante l’estate 2009 per la prima volta è stato effettuato un tentativo per definire le dimensioni del fenomeno: con la collaborazione di studenti tirocinanti sono state effettuate delle fotografie sulle spiagge delle baie di Paraggi e San Fruttuoso, ossia i siti più frequentati dai bagnanti, con l’intento di contare il numero dei visitatori ed effettuare una stima circa l’uso del territorio dell’AMP elaborando le immagini fotografiche. Il campionamento è stato condotto in sei giornate, un giorno infrasettimanale e uno festivo (poiché si operava congiuntamente al monitoraggio da battello della nautica da diporto), nel periodo di luglio e agosto. Le fotografie sono state scattate a mezzogiorno poiché riteniamo che sia l’orario del giorno in cui la frequentazione sia massima. Non possiamo affermare che il tentativo sia andato completamente a buon fine poiché spesso, a causa della scarsa qualità delle immagini (inquadratura, messa a fuoco e bassa risoluzione) non è stato possibile condurre un’elaborazione soddisfacente. Soprattutto relativamente alla spiaggia di Paraggi, complice anche le maggiori dimensioni dell’area, non possiamo parlare di dati significativi; per quanto riguarda invece la baia di San Fruttuoso, la situazione è descritta in tabella 12 e in figura 209. Tabella 12: numero dei bagnanti nella spiaggia di San Fruttuoso Data merc 15/07 sab 25/07 merc 05/08 dom 09/08 merc 12/08 dom 06/09 n° bagnanti 52 106 110 112 95 48 120 120 100 100 80 80 60 60 n° bagnanti n° bagnanti 40 40 20 20 0 0 merc sab merc dom merc dom merc sab merc dom merc dom 15/07 25/07 05/08 09/08 12/08 06/09 15/07 25/07 05/08 09/08 12/08 06/09 Figura 207: andamento del turismo balneare nella spiaggia di San Fruttuoso Si nota che per quanto riguarda la spiaggia di San Fruttuoso la presenza dei bagnanti è pressoché costante tutta la settimana e non aumenta nei weekend come ci si potrebbe attendere. I valori nettamente minori riscontrati il 15/07 e il 6/09 possono essere legati al fatto che di norma il periodo in cui si concentrano le ferie degli italiani è da metà luglio a metà agosto. Pur avendo ottenuto pochi dati non si può dire che questo monitoraggio sia stato completamente fallimentare, anzi con l’esperienza maturata in questo primo tentativo stiamo già ipotizzando nuovi metodi di campionamento al fine di raccogliere una maggiore quantità di dati da essere analizzati statisticamente. Figura 208: bagnanti sulla spiaggia di San Fruttuoso Creazione di materiale divulgativo Figura 209: depliant creati nel 2009 La produzione di materiale divulgativo ha l’intento di sensibilizzare i principali fruitori dell’AMP al fine di renderli maggiormente consapevoli dei potenziali impatti che possono provocare. Infatti, attraverso la maggiore sensibilità ambientale e l’instaurarsi di comportamenti responsabili da parte degli utenti dell’AMP sarà possibile, in un futuro, aumentare la capacità portante del sistema espressa in numero di fruitori. Analizzando la complessa legislatura europea ed italiana relativamente alla conservazione e protezione degli ambienti marini, si evince che alcuni habitat, quali ad esempio la prateria di Posidonia oceanica e alcuni organismi marini, come la cernia bruna, sono protetti. E’ importante che il fruitore impari a conoscere meglio le caratteristiche biologiche ed ecologiche delle specie caratteristiche al fine che possa condividere i motivi che hanno indotto i legislatori a instaurare una protezione “speciale”. Per questo si vuole iniziare un cammino divulgativo in modo da condividere con l’utente situazioni sensibili relative all’ambiente, che possono essere facilmente associate all’attività da essi svolta in qualità di osservatori privilegiati. Inoltre, dal 2008, è entrato in vigore il nuovo regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’AMP Portofino (posto in allegato); l’intento è quindi anche quello di divulgare tale nuovo regolamento, in modo da permettere ai vari utenti, di poter consultare in maniera rapida e semplice le nuove norme di condotta da seguire nell’AMP. Sono stati quindi creati tre depliant, relativi alle seguenti attività di monitoraggio: pesca sportiva, subacquea e nautica da diporto. Per quanto invece riguarda l’attività di balneazione, un simile supporto divulgativo è riportato, come già accennato precedentemente, sul sito internet dell’AMP (www.portofinoamp.it). In ogni depliant è presente una pagina contenente la parte del nuovo regolamento relativo all’attività considerata. Sono poi presenti alcune indicazioni volte alla mitigazione dell’impatto dell’attività di fruizione in questione, norme di sicurezza e numeri utili per gli utenti. Per alleggerire il contenuto di tale materiale divulgativo sono stati creati dei fumetti con l’intento di illustrare, in modo simpatico, alcune problematiche che le varie attività possono recare all’ambiente così come linee guida circa la condotta da seguire in mare. Ad esempio, nel fumetto che segue, è riportato un estratto del depliant dell’attività subacquea in cui si cerca di far capire che per effettuare un’immersione bisogna essere sempre in condizioni fisiche adeguate e immergersi sempre con un compagno. Figura 210. Fumetto relativo all’attività subacquea, di Matteo Anselmi Tale materiale è stato distribuito nei vari punti informativi situati sul territorio e presto sarà possibile consultarlo anche sul sito internet. In allegato la versione completa dei depliant per ciascuna attività. Allegato I Allegato II Allegato III Bibliografia AA. VV. (2008) - Pesca e gestione delle Aree Marine Protette. Abstract book. Porto Cesareo, 3031 ottobre 2008: 47. ARGYROU M., DEMETROPOULOS A., HADJICHRISTOPHOROU M. (1999) – Expansion of the macroalga Caulerpa racemosa and changes in softbottom macrofaunal assemblages in Moni Bay, Cyprus. Oceanologica acta. 22 (5): 517-528. BASSANO, E., BONIFORTI, R., PEZZANI, A. (1999) - Parametri meteorologici e idrologici. Sistema informativo e di monitoraggio marino costiero della provincia della Spezia, pp 27-50. Enea, Roma. BAVA S., CAPPANERA V., FANCIULLI G., FAVA M., CATTANEO-VIETTI R., TUNESI L., POVERO P. (2006) – Valutazione dell’impatto antropico nell’area marina protetta di Portofino. Atti V Convegno Nazionale delle Scienze del Mare, Viareggio 14 – 18 Novembre 2006: 72. BAVA S., MANGIALAJO L., CHIANTORE M., CATTANEO-VIETTI R. (2005) - Variabilità strutturale nelle comunità di substrato duro dell’AMP Portofino. Biol. Mar. Medit., 12 (1): 42-51. BERLINCK, R. G. S., BRAEKMAN, J. C., DALOZE, D., BRUNO, I., RICCIO, R., AMADE, P., ROGEAU, D. (1992) New biologically active guanidine alkaloids from the marine sponge Crambe crambe. In: Guanidino compounds in biology and medicine (Marescau, B., de Deyn, P., Qureshi, eds), John Libbey, London, pages: 53-60. BOUDOURESQUE, C.F., VERLAQUE, M. (2002). Biological pollution in the Mediterranean Sea : invasive versus introduced macrophytes. Marine Pollution Bullettin, 44: 32-38. BUIA M. C., PETROCELLI A., SARACINO O. D. (1998) Caulerpa racemosa spread in the Mediterranean Sea: first record in the Gulf of Taranto. Biol. Mar. Medit., Vol. 5(1): 527-529. CAMPODONICO P. (2009) – Caratterizzazione della pesca sportiva nell’Area Marina Protetta di Portofino. Tesi di laurea triennale, Università degli Studi di Genova. CARRIGLIO D., SANDULLI R., DEASTIS S., D'ADDABBO GALLO M., GRIMALDI DE ZIO S. (2003) - Effetti della colonizzazione di Caulerpa racemosa sulla meiofauna del Golfo di Taranto.. Biol. Mar. Medit., Vol. 10 (2): 509-511. CARLTON, J. T., 1985. Transoceanic and interoceanic dispersal of coastal marine organisms; the biology of ballast water. Oceanography and marine biology annual review, 23: 313-373. CASTELLANO M., RUGGIERI N., GASPARINI G.P., LOCRITANI M., CATTANEO-VIETTI R., POVERO P. (2008) - LTER-AMP Portofino (Mar Ligure): variabilità stagionale ed interannuale delle forzanti meteo-climatiche, delle variabili fisico-chimiche e biologiche del comparto pelagico. Atti VI Convegno Nazionale per le Scienze del Mare, Lecce 4 – 8 Novembre 2008: 60. CASU D., CECCHERELLI G., PALOMBA D., CURINI-GALLETTI M., CASTELLI A. (2005) – Effetto immediato della rimozione di Caulerpa racemosa sullo zoo benthos dell’infralitorale superficiale roccioso di Porto Torres (Nord Sardegna). XV Congresso della Società Italiana di Ecologia, Torino 12-14 Settembre 2005: Poster. CATTANEO-VIETTI R., BARBIERI M., BAVESTRELLO G., SENES L. (1989) - Analisi quantitativa di una facies a Corallium rubrum nel Mar Ligure. Nova Thalassia, 10 (suppl. 1): 575578. CATTANEO-VIETTI R., BAVESTRELLO G., SENES L. (1993) - Il popolamento a corallo rosso del Promontorio di Portofino (Mar Ligure). In: Il corallo rosso in Mediterraneo, Arte, Storia e Scienza. Red coral in the Mediterranean Sea: Art, History and Science. Cicogna F. e CattaneoVietti R. (Eds.). Min. Ris. Agr. Al. For. - Roma: 109-130. CEBRIAN E., BALLESTEROS E. (in press) – Temporal and spatial variabilità in shallow- and deep-water populations of the invasive Caulerpa racemosa var. cylindracea in the Western Mediterranean. Estuarine, Coastal and Shelf Science: 1-6. CECCHERELLI G., CAMPO D., PIAZZI L. (2001) - Some ecological aspects of the introduced alga Caulerpa racemosa in the Mediterranean: way of dispersal and impact on native species. (no PDF) Biol. Mar. Medit., Vol. 8(1): 94-99. CECCHERELLI G., PIAZZI L. (2002) - Invasion of Caulerpa racemosa and Caulerpa taxifolia in the Mediterranean: the influence of macroalgal assemblage complexity and their competitive interaction. (no PDF) Biol. Mar. Medit., Vol. 9(1): 479-483. CECCHERELLI G., PIAZZI L. (1999) - L'effetto dell'orientamento dei margini di Posidonia oceanica e della densità dei fasci sull'alga introdotta Caulerpa racemosa. Biol. Mar. Medit., Vol. 6(1): 365-367. CECCHERELLI G., PIAZZI L., CINELLI F. (2000) – Response of the non-indigenous Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh to the native seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile: effect of density of shoots and orientation of edges of meadows. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 243: 227-240. CECCHERELLI G., PIAZZI L., BALATA D. (2002) – Spread of introduced Caulerpa species in macroalgal habitats. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 280: 1-11. CERRANO, C., BAVESTRELLO, G., BIANCHI, C. N., CATTANEO-VIETTI, R., BAVA, S., MORGANTI, C., MORRI, C., PICCO, P., SARA, G., SCHIAPPARELLI, S., SICCARDI, A., SPONGA, F. (2000). A catastrophic mass-mortality episodes of gorgonians and other organisms in the Ligurian sea (NW Mediterranean), summer 1999. Ecol. Lett. (submitted). CONISMA-AMP PORTOFINO (2006) - Valutazione dell’impatto antropico sul sistema costiero, con particolare riferimento alla pressione antropica all’interno dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino a cura di Simone Bava, Valentina Cappanera, Riccardo Cattaneo-Vietti, Maddalena Fava, Paolo Povero. Rapporto tecnico: 267 pp. CONISMA-AMP PORTOFINO (2007) - Valutazione dell’impatto antropico sul sistema costiero, con particolare riferimento alla pressione antropica all’interno dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino a cura di Valentina Cappanera, Simone Bava, Sara Venturini, Riccardo CattaneoVietti, Paolo Povero. Rapporto tecnico: 182 pp. CORTEMIGLIA G. C., TERRANOVA R. (1974) - Aspetti geomorfologici, idrologici e oceanografici del Golfo di Rapallo. Atti Soc. it. Sci. nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano, 115 (3-4): 285-384. COSSU A., PALA D., RUIU A., ZANELLO A. (2003) - Distribuzione di Caulerpa racemosa nel Golfo dell'Asinara (Sardegna settentrionale). Biol. Mar. Medit., Vol. 10(2): 542-543. COSTANTINO G., QUARANTA L., DE ZIO V., PASTORELLI A. M., ROSITANI L., UNGARO N. (2002) - Sulla recente presenza di Caulerpa racemosa (Forsskäl) J. Agardh sui fondi costieri dell'Adriatico sud-occidentale. Biol. Mar. Medit., Vol. 9(1): 613-615. DE BIASI A. M., GAI F., VANNUCCI A. (1999) - Biologia delle Secche della Meloria: considerazioni sull'ecologia di Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agarth. Biol. Mar. Medit., Vol. 6(1): 376-379. DI MARTINO V., BLUNDO M.C., TITA G. (2006) – The Mediterranean introduced seagrass Halophila stipulacea in Eastern Sicily (Italy): temporal variations of the associated algal assemblage. Vie et milieu – Life and Environment, 56 (3): 223-230. DIVIACCO G., COPPO S. (2006) – Atlante degli habitat marini della Liguria: descrizione cartografia delle praterie di Posidonia oceanica e dei principali popolamenti marini costieri. Ed. Grafiche Amadeo. DIVIACCO G., TUNESI L. (1999) - Cartografia dei fondali antistanti la punta di Portofino (Mar Ligure) e osservazioni sui popolamenti bentici. Atti della Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (A.I.O.L.) 13 (1): 233-239. FLAGELLA M. M., SORIA A., BUIA M.C. (2006) – Shipping traffic and introduction of nonindigenous organisms: Study case in two Italian harbours. Ocean & Coastal Management, 49: 947960. FRASCHETTI S., TERLIZZI A., BUSSOTTIS., GUARNIERI G., D’AMBROSIO P., BOERO F. (2005) – Conservation of Mediterranean seascapes: analyses of exixting protection schemes. Marine Environmental Research, 59: 309-332. GALIL B.S. (2007) – Loss or gain? Invasive aliens and biodiversity in the Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin, 55: 314-322. GIACCONE, G., DI MARTINO, V., 1995. Le Caulerpe in Mediterraneo: un ritorno del vecchio bacino Tetide verso il dominio Indo-Pacifico. Biol. Mar. Medit. 2 (2): 607-612. JACOBS, W. P., 1994. Caulerpa. Scientific American 271 (6) :66-71. KLEIN J., VERLAQUE M. (2008) – The Caulerpa racemosa invasion: A critical review. Marine Pollution Bulletin, 56: 205-225. KLEIN J., VERLAQUE M. (2009) – Macroalgal assemblages of disturbed coastal detritic bottoms subject to invasive species. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 82: 461-468. MANGIALAJO L., BARBERIS G., CATTANEO-VIETTI R. (2004) - Contributo alla conoscenza della biodiversità macroalgale delle Aree Marine Protette liguri. Informatore Botanico Italiano, 36 (2): 550-553. MANGIALAJO L., RUGGIERI N., ASNAGHI V., CHIANTORE M.C., POVERO P., CATTANEOVIETTI R. (2007) - Ecological status in the Ligurian Sea: the effect of coastline urbanisation and the importance of proper reference sites. Mar. Poll. Bull., 55 (1-6): 30-41. MARCHETTI R. (1965) - Ricerche sul corallo rosso della costa ligure e toscana II. Il Promontorio di Portofino. Rend. Ist. Lomb. Sci. B, 99: 279-316. MEINESZ A., BELSHER T., THIBAUT T., ANTOLIC B., BEN MUSTAPHA K., BOUDOURESQUE C.-F., CHIAVERINI D., CINELLI F., COTTALORDA J.M., DJELLOULI A., EL ABED A., ORESTANO C., GRAU A.M., IVESA L., JAKLIN A., LANGAR H., MASSUTI-PASCUAL E., PEIRANO A., TUNESI L., DE VAUGELAS J., ZAVODNIK N., ZULIEJEVIC A. (2001) - The introduced green alga Caulerpa taxifolia continues to spread in the Mediterranean. Biological Invasion: 201-210. MEINESZ, A., BENICHOU, L., BLANCHIER, J., KOMATSU, T., LEMÉE, R., MOLENAAR, H., MARI, X., 1995. Variations in the structure, morphology, and biomass of Caulerpa taxifolia in the Mediterranean. Botanica Marina, 38: 499-508. MEINESZ, A., 2001. L’alga “assassina”. Caulerpa taxifolia: un attentato alla biodiversità del Mediterraneo. Bollati Borighieri Editore. MODENA M., MATRICARDI G., VACCHI M., GUIDETTI P. (2000) – Spreading of Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh (Bryopsidaceae, Chlorophyta) along the coasts of the Ligurian Sea. Cryptogamie, Algol., 21 (3): 301-304. MONTEFALCONE M., BAUDANA M., VENTURINI S., LASAGNA R., BIANCHI C. N., ALBERTELLI G. (2006) - Distribuzione spaziale delle praterie di Posidonia oceanica nell’Area Marina Protetta di Portofino. Biol. Mar. Medit., 13 (2): 90-91. MONTEFALCONE M., MORRI C., PEIRANO A., ALBERTELLI G., BIANCHI C.N. (2007) – Substitution and phase shift within the Posidonia oceanica seagrass meadows of NW Mediterranean sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 75: 63-71. MONTEFALCONE M., ALBERTELLI G., MORRI C., BIANCHI C.N. (2007) – Urban seagrass: Status of Posidonia oceanica facing the Genoa city waterfront (Italy) and implications for management. Marine Pollution Bulletin, 54: 206-213. MOLINARI A. & DIVIACCO G., 2003. L’espansione di Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh in Mar Mediterraneo: nuova segnalazione a Bergeggi (Mar Ligure occidentale). Doriana 336 (VIII): 17. OCCHIPINTI A.-AMBROGI, D.SAVINI (2003) – Biological invasions as a component of global change in stressed marine ecosystems (Review). Marine Pollution Bulletin, 46: 542-551. OCCHIPINTI A.-AMBROGI (2007) – Global change and marine communities: Alien species and climate change. Marine Pollution Bulletin, 55: 342-352. PIAZZI, L., BALATA, D. (2008) – The spread of Caulerpa racemosa var. cylindracea in the Mediterranean Sea: An example of how biological invasions can influence beta diversity. Marine Environmental Research, 65: 50-61. PIAZZI, L., BALESTRI, E., MAGRI, M., CINELLI, F. (1997) - Expansion de l’algue tropicale Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh (Bryopsidophyceae, Chlorophyta) le long de la côte toscane (Italie). Cryptogamie, Algol. 18: 343-350. PIAZZI, L., ACUNTO, S., MAGRI, M., RINDI, F., BALESTRA E. (1997) - Osservazioni preliminari sull’espansione di Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh sulle secche della Meloria (Livorno, Italia). Biol. Mar. Medit. 4: 426-428. PIAZZI L., ACUNTO S., MAGRI M., RINDI F., BALESTRI E. (1997) - Osservazioni preliminari sull'espansione di Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh sulle Secche della Meloria (Livorno, Italia). Biol. Mar. Medit., Vol. 4(1) 426 428 PIAZZI, L., BALATA, D., CECCHERELLI, G., CINELLI, F. (2001) - Comparative study of the growth of the two co-occuring introduced green algae Caulerpa taxifolia and Caulerpa racemosa along the Tuscan coast (Italy, western Mediterranean). Cryptog., Algol., 22 (4): 459-466. PIAZZI, L., BALATA, D., CECCHERELLI, G., CINELLI, F. (2005) – Interactive effect of sedimentation and Caulerpa racemosa var. cylindracea invasion on microalgal assemblages in the Mediterranean Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64: 467-474. PIAZZI, L., CECCHERELLI, G. (2006) – Persistence of biological invasion effects: recovery of macroalgal assemblages after removal of Caulerpa racemosa var. cylindracea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 68: 455-461. PIAZZI, L., CECCHERELLI, G., CINELLI, F. (2001) - Threat to macroalgal diversity: effect of the introduced green alga Caulerpa racemosa in the Mediterranean. Mar. Ecol. Progr. Ser. 210: 149159. PIAZZI, L., CECCHERELLI, G., BALATA, D., CINELLI, F. (2003) - Early patterns of Caulerpa racemosa recovery in the Mediterranean Sea: the influence of algal turf. J. Mar. Biol. Ass. U. K. 83: 27-29. PIAZZI, L., CINELLI, F. (1999) - Développement et dynamique saisonnière d’un peuplement de l’algue tropicale Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh. Cryptog., Algol., 20: 295-300. PROFETA A., BONANNO A., GIACOBBE S., MANGANARO A., POTOSCHI A. JR., SPANÒ N., TRISCARI C. (2004) - Diffusione di macrofite alloctone nello Stretto di Messina: il caso di Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh, Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh, Halophila stipulacea (Forsskål) Ascherson. Biol. Mar. Medit., Vol. 11 (2): 465-467. RELINI G. (1983) - Le motivazioni naturalistiche e biologiche della difesa dei fondali di Portofino. Atti Convegno indetto dalla Provincia di Genova su "Promontorio di Portofino, proposte per una riserva marina": 35-41. ROSSI L. (1949) - Celenterati del Golfo di Rapallo. Boll. Mus. Zool. Univ. Torino, 20: 194-235. ROSSI L. (1957) - Revisione critica dei Madreporari del Mar Ligure. Doriana, Ann. Mus. Civ. St. Nat. “G. Doria”, Genova. 65: 1-19. ROSSI L. (1959) – Le specie di Eunicella (Gorgonaria) del Golfo di Genova. Doriana, Ann. Mus. Civ. St. Nat. “G. Doria”, Genova, 71: 203-225. SERIO, D., PIZZUTO, P. (1999. Studio di un prato di Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh (Caulerpales, Chlorophyta) di Brucoli (SR) con osservazioni in coltura della specie. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. 31 (354): 201-209. RUITTON S., JAVEL F., CULIOLI J.-M., MEINESZ A., PERGENT G., VERLAQUE M. (2005) – First assessment of the Caulerpa racemosa (Caulerpales, Clorophyta) invasion along the French Mediterranean coast. Marine Pollution Bulletin, 50: 1061-1068. RUITTON S., VERLAQUE M., BOUDOURESQUE C.F. (2005) – Seasonal changes of the introduced Caulerpa racemosa var. cylindracea (Caulerpales, Chlorophyta) at the northwest limit of its Mediterranean range. Aquatic Botany, 82: 55-70. TUNESI L. (2006) – Scuba diving tourism in PAs: the experience of Portofino national MPA. Conference on Sustainable financing of Pas in the Mediterranean. Seville, January 2006. IUCNMed Office, Malaga. TUNESI L., AGNESI S., DI NORA T., (2006) - La gestione del turismo subacqueo nelle aree marine protette (AMP): gli elementi prioritari. Atti del Workshop Internazionale “Le attività subacquee nelle Aree Marine Protette e gli impatti sull’ambiente: esperienze mediterranee a confronto” – Ostia, Febbraio 2005. TUNESI L., VACCHI M. (1994) - Considerazioni sul rinvenimento di Caulerpa prolifera (Forskaal) Lamouroux sui fondali del golfo di Tigullio (Mar Ligure). Atti della Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (A.I.O.L.) 10: 413-419. VASQUEZ-LUIS M., SANCHEZ-JEREZ P., BAYLE-SEMPERE J.T. (2008) – Changes in amphipod (Crustacea) assemblages associated with shallow-water algal habitats invaded by Caulerpa racemosa var. cylindracea in the western Mediterranean Sea. Marine Environmental Research, 65: 416-426. VASQUEZ-LUIS M., SANCHEZ-JEREZ P., BAYLE-SEMPERE J.T. (in press) – Comparison between amphipod assemblages associated with Caulerpa racemosa var. cylindracea and those of other Mediterranean habitats on soft substrate. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 20: 1-10. VENTURINI S. (2005) - Area Marina Protetta Portofino: indagine sulla nautica da diporto (20062007). Tesi di laurea specialistica in scienze ambientali, Università di Genova. WALLENTINUS I., NYBERG C.D. (2007) – Introduced marine organisms as habitat modifiers. Marine Pollution Bulletin, 55: 323-332. WILLIAMS S.L. (2007) – Introduced species in seagrass ecosystems: Status and concerns. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 350: 89-110. http://www.cost.ge.it/statuto.html http://www.guritel.it/free-sum/ARTI/2008/08/04/sommario.html http://www.portofinoamp.it/it/ http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/sdm/amp/amp_reperimento/amp_reperimento.ap
Scarica