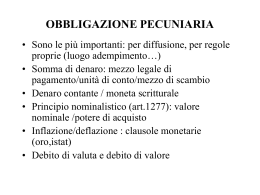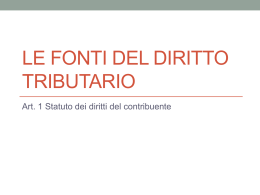IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTRATTI E RAPPORTI BANCARI L’ANATOCISMO Negli ultimi anni, il contenzioso con le banche si è sviluppato soprattutto nei rapporti di conto corrente con aperture di credito e saldi passivi a carico dei clienti: il punctum pruriens è stato, ed è tuttora, quello della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei clienti, a dispetto della capitalizzazione solo annuale degli interessi a carico della banca. La clausola dell’art. 7 delle norme bancarie uniformi, prevedenti tale meccanismo “asimmetrico”, è sempre stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza di legittimità, facendo leva sull’esistenza di un uso normativo legittimante la capitalizzazione trimestrale ai sensi dell’art. 1283 c.c.; sino a quando la Cassazione ha mutato indirizzo con la nota sentenza 99/2374, escludente l’esistenza di un uso normativo ed affermante la nullità della clausola di cui al citato art. 7, coi relativi effetti di ricalcolo delle poste passive del cliente. Dal 1999, il S.C. ha sempre seguito il nuovo indirizzo, confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 04/21095. Per la verità il Governo dell’epoca era corso quasi subito ai ripari, con l’art. 25 del D.Lgs. 342/99, che stabiliva la sanatoria di tutte le clausole anatocistiche sino a quel momento stipulate previo adeguamento per il futuro attraverso un meccanismo di parità di conteggio degli interessi attivi e passivi cliente-banca (comma 3), e con previsione per tutti i contratti futuri di un analogo meccanismo paritario per la capitalizzazione degli interessi (comma 2). Il comma 3 di tale articolo è stato però ritenuto costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Consulta con sentenza n. 425/00, per cui il problema è tornato nuovamente di attualità ed è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità confermando in modo costante, come visto, il revirement del 1999. Resta da dire che per i contratti di conto corrente in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, entrata in vigore il 20.4.2000 ed attuativa del meccanismo di parità di cui al citato art. 25 comma 2 D.Lgs. 342/99, vale la disciplina previgente, con conseguente nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, senza la possibilità per la banca di modificare unilateralmente l’assetto negoziale ed imporre, in mancanza di un accordo per iscritto, il nuovo assetto paritario nel conteggio degli interessi: ciò si tradurrebbe non in una modifica delle condizioni contrattuali, cosa consentita dall’art. 118 TUB se preventivamente concordata, bensì in una illegittima sanatoria, realizzantesi in via unilaterale, di una clausola nulla, convertita per iniziativa di una sola parte in una clausola valida (la giurisprudenza di legittimità sembra univoca in tale interpretazione, confermata anche dalla citata SU 04/21095). Del resto, simile conversione, extra-ordinem, era prevista dal comma 3 dell’art. 25 D.Lgs. 342/99 e la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma impedisce di realizzare tale effetto, si ripete eccezionale, seguendo la strada della variazione unilaterale. Per queste stesse ragioni, a fronte della regola generale della irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod.civ.), nemmeno si può ipotizzare un’applicazione della nuova disciplina in corso di rapporto, come viceversa sostenuto dalla giurisprudenza in materia di fideiussione omnibus, usura ed “usi su piazza” (vedi infra). Evidentemente, diverso è il discorso qualora il rapporto contrattuale venga rinegoziato tra le parti, sicché vi sia un nuovo consenso, appunto bilaterale, sulla regola della “parità” della capitalizzazione: in tal caso (che si può realizzare anche qualora, in corso di rapporto di c/c, vigente la delibera CICR del 9.2.2000, sia concessa un’apertura di credito prevedente la regola della parità) pare innegabile la salvezza di tale ultima clausola, legittimata appunto dall’art. 25 comma 2 D.Lgs. 342/99. Ferme queste premesse, e ribadito l’indirizzo ormai consolidato della S.C. in tema di invalidità della capitalizzazione trimestrale, va detto che per tutti i contratti di conto corrente non sorti dopo la citata delibera CICR, e dunque non regolati dalla regola della capitalizzazione “paritaria” degli interessi attivi e passivi, vi sono stati vari tentativi della giurisprudenza di merito di “salvare” l’anatocismo: - in primo luogo insistendo per la presenza in materia di rapporti bancari di un “uso normativo”, esistente già prima del codice del ’42 e comunque consolidatosi anche dopo, anche grazie alla stessa convinzione di obbligatorietà nascente dalla costante giurisprudenza favorevole della Cassazione sino all’improvviso revirement del 1999; - in secondo luogo accreditando la tesi che gli addebiti per capitalizzazione trimestrale siano irripetibili ex art. 2034 c.c. perché costituenti obbligazioni naturali (è la tesi ad esempio di Trib. Milano 11.6.2004); - ed ancora, trovando una diversa giustificazione alla capitalizzazione trimestrale, non più fondata sull’art. 1283 c.c. ma espressione delle diverse regole in materia di rapporto di conto corrente, regolato ex art. 1831 c.c. dalla disciplina della chiusura periodica del conto, chiusura che darebbe vita alla capitalizzazione periodica degli interessi nel senso che essi, subito dopo la riapertura del conto, diventerebbe automaticamente la prima posta creditoria, in conto capitale, del conto riaperto (è la tesi seguita in particolare dal Tribunale di Roma: vedi ad esempio Trib. Roma 14.4.1999 in Giur. merito ’99, I, p. 977); - infine, aggirando completamente divieto di anatocismo applicando l’art. 1194 c.c. per le rimesse in conto corrente dei clienti, che servirebbero ad estinguere innanzitutto gli interessi passivi maturati. Al di là delle critiche che si possono muovere a tali tesi, soprattutto le ultime tre (pare davvero eccessivo parlare in questa materia di obbligazione naturale e, infatti, Cass. 84/2262 esclude l’applicazione dell’art. 2034 c.c. in caso di interessi ultralegali non dovuti; quanto alla tesi romana, essa innanzitutto giustifica con un mero artificio contabile quella che è comunque una capitalizzazione di interessi, inoltre non sembra tenere conto né del fatto che l’art. 1831 c.c. non è richiamato dall’art. 1857 c.c. per le operazioni bancarie in conto corrente, né del fatto che resta comunque ingiustificata ed incomprensibile la chiusura differenziata cliente/banca; così come appare fuori luogo il richiamo all’art. 1194 c.c., che darebbe vita ad un’imputazione mai effettuata in passato dalle banche, imputazione che consentirebbe una capitalizzazione in pratica anche giornaliera e che, da un punto di vista formale, contrasta con la non liquidità ed esigibilità a priori dei crediti delle banche, che possono pretendere i rientri dei conti passivi solo previo recesso), l’indirizzo sempre più granitico della Cassazione in tema di anatocismo sembra sconsigliare soluzioni diverse. Al di là delle critiche che si possono muovere a tali tesi, soprattutto le ultime tre (pare davvero eccessivo parlare in questa materia di obbligazione naturale e, infatti, Cass. 84/2262 esclude l’applicazione dell’art. 2034 c.c. in caso di interessi ultralegali non dovuti; quanto alla tesi romana, essa innanzitutto giustifica con un mero artificio contabile quella che è comunque una capitalizzazione di interessi, inoltre non sembra tenere conto né del fatto che l’art. 1831 c.c. non è richiamato dall’art. 1857 c.c. per le operazioni bancarie in conto corrente, né del fatto che resta comunque ingiustificata ed incomprensibile la chiusura differenziata cliente/banca; così come appare fuori luogo il richiamo all’art. 1194 c.c., che darebbe vita ad un’imputazione mai effettuata in passato dalle banche, imputazione che consentirebbe una capitalizzazione in pratica anche giornaliera e che, da un punto di vista formale, contrasta con la non liquidità ed esigibilità a priori dei crediti delle banche, che possono pretendere i rientri dei conti passivi solo previo recesso), l’indirizzo sempre più granitico della Cassazione in tema di anatocismo sembra sconsigliare soluzioni diverse. Ma, una volta affermata la nullità della capitalizzazione trimestrale, quale è la conseguenza? Assenza assoluta di capitalizzazione degli interessi ovvero capitalizzazione annuale degli stessi? La seconda soluzione (suggerita da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito), che si fonda essenzialmente sul conteggio annuale degli interessi previsto dall’art. 1284 comma 1 c.c., sembra criticabile, perchè è vero che il calcolo degli interessi è annuale, ma ciò non significa che dopo un anno gli interessi debbano essere liquidati e divengano capitale, a sua volta suscettibile di produrre interessi (cfr. sul punto le affermazioni di Cass. SU 9653/01, secondo cui il debito di interessi non perde mai tale natura e resta sempre soggetto ai limiti dell’art. 1283 c.c.); in tal modo, peraltro, alla capitalizzazione trimestrale si sostituirebbe quella annuale, sempre vietata dall’art. 1283 c.c. e nemmeno legittimatesi in un uso, al limite concepibile per la capitalizzazione trimestrale; né il divieto dell’art. 1283 c.c. è superabile solo per la realizzata parità fra interessi attivi e passivi, parità che comunque costituisce un fatto neutro che non esclude la sussistenza della capitalizzazione e non vale a sanare la mancanza di un uso derogatorio ovvero di una specifica norma di legge autorizzante il superamento dei limiti dell’art. 1283 c.c. (tale norma di legge si è avuta solo dopo, appunto con l’art. 25 comma 2 D.Lgs. 432/99 e la Delibera attuativa CICR). Sotto il profilo processuale, va segnalato che nelle controversie “cliente - banca”, che spesso nascono da iniziative, anche monitorie, delle banche, ma altrettanto spesso nascono da azioni restitutorie dei clienti, valgono le seguenti regole: - l’azione volta alla restituzione (riaccredito) degli interessi anatocistici è sottoposta a prescrizione decennale il cui dies a quo decorre dalla data di cessazione del rapporto (vedi Cass. 84/2262 e, più di recente, Cass. 10127/05, che richiamando varie sentenze valorizza il legame intercorrente fra una pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico); - la banca non può fare leva sulla circostanza della mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente, perché le decadenze fissate dagli art. 1832 c.c. e 119 TUB si riferiscono solo ad errori contabili e non riguardano eventuali invalidità delle operazioni negoziali poste a fondamento delle appostazioni contabili (Cass. 06/10376, 01/10129 e 96/1978); - se è la banca a formulare la pretesa creditoria, fermo che la nullità della clausola anatocistica attenendo ad un presupposto costitutivo della domanda può essere rilevata d’ufficio dal giudice, spetta alla banca istante ex art. 2697 c.c. dare la prova dell’entità della sua pretesa, prova che se in sede monitoria può essere costituita dal certificato di salda-conto ex art. 50 TUB, nella fase di opposizione o in un normale giudizio di cognizione, in caso di contestazione, è rappresentata dagli estratti-conto relativi all’intero rapporto, i quali devono essere depositati dalla banca interessata nei termini dell’art. 184 c.p.c., onde consentire gli eventuali ricalcoli con depurazione dell’anatocismo (a meno che tale produzione non avvenga, con l’accordo delle parti, in sede di operazioni peritali ai sensi dell’art. 198 c.p.c.); e in mancanza la sua domanda andrà rigettata non essendo possibile calcolare l’entità della sua pretesa (vedi ad esempio Cass. 03/12233 e 02/2751, affermanti anche il diverso valore probatorio del certificato di salda-conto e degli estratti-conto); - se, invece, l’iniziativa giudiziaria è del cliente, che chiede la restituzione (o i riaccrediti) degli interessi anatocistici addebitati sul suo conto, non solo la nullità della clausola anatocistica deve essere dedotta dal cliente e non può essere rilevata d’ufficio (occorre conciliare la rilevabilità d’ufficio della nullità col principio della domanda), ma l’onere della prova si inverte integralmente a carico del cliente e sorge il problema dell’esibizione degli estratti conto, se non tutti depositati dal cliente ovvero non prodotti spontaneamente dalla banca: l’obiezione all’accoglimento dell’istanza ex art. 210 c.p.c. è data dal fatto che il cliente potrebbe ottenere gli estratti conto prima della causa, ai sensi dell’art. 119 comma 4 TUB, per cui la sua eventuale inerzia al riguardo, che si aggiungerebbe a quella della mancata conservazione degli estratti conto inviatigli, non potrebbe essere sopperita dallo strumento dell’art. 210 c.p.c., come noto inidoneo a rimediare a carenze probatorie della parte onerata ex art. 2697 c.c.; ma tale interpretazione, seguita da alcuni giudici di merito, che porta a conseguenze negative per il correntista, potrebbe essere evitata considerando la diversa natura del diritto riconosciuto dall’art. 119 comma 4, che è diritto soggettivo di natura sostanziale alla consegna della documentazione bancaria relativa agli ultimi dieci anni (Cass. 01/12093 e 99/11733), laddove gli estratti-conto nelle controversie di cui si discute hanno valore quali strumenti di prova, e solo come tali, per cui non sembra giusto far discendere dal mancato esercizio di un diritto soggettivo di natura sostanziale, rivolto non a fini probatori, il rigetto di un’istanza come quella ex art. 210 c.p.c., avente mero rilievo processuale e probatorio e che, oltretutto, per gli estratti-conto risalenti a dieci anni prima, costituisce l’unico strumento visto il limite temporale fissato dall’art. 119 comma 4. Tale paragrafo non può essere concluso non ricordando che vi è un campo in cui la capitalizzazione trimestrale è sempre stata ritenuta legittima: quello dei mutui fondiari, per i quali l’anatocismo in favore delle banche, per i contratti ante TUB del 1993, era ammesso senza limiti dal TU 646/1905 e Reg. Att. 472/1905, mentre la Del. CICR 9.2.2000, attuativa dell’art. 30 TUB del 1993, ha ridotto il capo di operatività della capitalizzazione trimestrale, riconoscendo una tantum la maturazione di interessi moratori sugli importi integrali delle singole rate, comprensive anche delle quote interessi. GLI INTERESSI ULTRALEGALI E LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO Spesso l’ “anatocismo” non è l’unica questione fatta valere, o da esaminare d’ufficio in caso di domande di pagamento della banca (vedi supra), nelle controversie “cliente-banca” relative ai rapporti di conto corrente, potendo venire in gioco anche il problema della mancata determinazione per iscritto degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e/o degli altri oneri bancari, o il rinvio per essi agli usi piazza. Anzi, ben prima dell’esplosione della questione “anatocismo” vi era già un ingente contenzioso, con molte sentenze di merito e di legittimità, soprattutto sul problema clausole di rinvio agli usi piazza. Infatti, se è vero che la legge sulla trasparenza bancaria 154/92 e poi l’art. 117 TUB 385/93 hanno innovato la disciplina sul punto, imponendo l’obbligo della forma scritta per i contratti bancari e prevedendo la nullità delle clausole di rinvio agli usi nonché meccanismi di sostituzione in caso di mancata indicazione delle condizioni del rapporto e/o di rinvio agli usi (vedi infra), già sotto la disciplina previgente, valida per i contratti sorti anteriormente (si rinvia alle le considerazioni fatte sopra in materia di “anatocismo”), è anche vero che la determinazione per iscritto degli interessi passivi era già imposta dall’art. 1284 comma 3 c.c. e la clausola di rinvio alle “condizioni abitualmente praticate sulla piazza” era ritenuta nulla per inosservanza del combinato disposto degli artt. 1284 comma 3 e 1346 c.c., ritenendosi “non determinabile” l’oggetto della pattuizione, ossia la misura degli interessi passivi, per l’assenza di un reale cartello bancario e per conseguenziale mancanza di criteri certi, univoci e predeterminati di individuazione delle condizioni abitualmente praticate sulla piazza (così la più recente giurisprudenza, tra cui vedi ad esempio Cass. 03/14684 e 02/13823). Oggi, nel vigore della L. 154/92, la cui disciplina è poi confluita nell’art. 117 TUB, tutto come visto è più semplice: se manca la forma scritta il contratto è nullo (art. 117 comma 3), se gli interessi e le altre condizioni non sono determinati ovvero se per essi vi è rinvio agli usi (rispettivamente commi 4 e 6 dell’art. 117) devono applicarsi il tasso e le condizioni previsti dal comma 7. La nullità, peraltro, non è mai rilevabile d’ufficio, ma trattasi di “nullità relativa”, perché ai sensi dell’art. 127 comma 2 TUB può essere fatta valere solo dal cliente. Ma tale tesi deve fare i conti con la diversa interpretazione (che sembra prevalente in dottrina e giurisprudenza) secondo cui “nullità relativa”, siccome “nullità di protezione”, significa che il vizio d’invalidità non può mai danneggiare il cliente e favorire la banca, sicché può essere rilevata d’ufficio se favorisce il cliente, ma non nel caso contrario. E’ evidente che la diversa soluzione che si scelga comporta rilevanti conseguenze pratiche, soprattutto in sede monitoria, ove, se si aderisce alla prima tesi, l’assenza del cliente-intimando dovrebbe impedire la rilevazione delle nullità di cui all’art. 117, anche se, però, il rinvio agli usi, in caso di mancanza di criteri oggettivi ed univoci di determinazione, dovrebbe determinare la nullità della clausola sugli interessi ai sensi degli art. 1284 comma 3 e 1346 c.c., nullità ordinaria e come tale rilevabile d’ufficio. Ad ogni modo, la regola della rilevabilità su eccezione, giacché riguardante solo le ipotesi di nullità, non sembra valere in caso di omessa indicazione dei tassi e/o delle altre condizioni applicate, poiché il comma 7 distingue chiaramente tra l’ “inosservanza del comma 4” e le “ipotesi di nullità del comma indicate nel comma 6”, con la conseguenza che in caso di violazione del comma 4 (appunto omessa indicazione dei tassi, etc.) non si è in presenza di una nullità. Ne deriva che tali omissioni sono rilevabili d’ufficio, dunque anche in sede monitoria, con applicazione delle lett. a) e b) del comma 7. Il principio generale dell’irretroattività della legge dovrebbe comportare l’inapplicabilità della nuova disciplina sugli usi piazza di cui alla L. 154/92 e poi del TUB. Ma, fermo che anche secondo le regole codicistiche sussiste la nullità e che, quindi, l’unica differenza in termini pratici è costituita dal tasso da applicare, quello legale dell’art. 1284 c.c. ovvero quello dell’art. 117 comma 7 lett. a) TUB (e fermo che la disciplina codicistica, per quanto detto sopra, sembra in parte sovrapporsi alla “nullità relativa” di cui al TUB), la giurisprudenza prevalente è nel senso dell’applicabilità in corso di rapporto della nuova disciplina (vedi Cass. 06/10376 e 03/13739, nonché Cass. 06/2140 e Cass. 05/4092, che, come si vedrà, riguardano anche l’applicabilità in corso di rapporto della legge sull’ “usura” e che condizionano la declaratoria di inefficacia sopravvenuta all’istanza della parte interessata; per il principio opposto, ovvero per l’applicabilità del tasso legale codicistico in casi del genere, vedi Cass. 05/28302 e 07/4853). Qualche ulteriore considerazione sulla forma scritta. Innanzitutto, il comma 2 dell’art. 117 rimette al CICR la scelta di forme negoziali diverse ove sussistano “motivate ragioni tecniche”; si tratta della medesima previsione di cui all’art. 3 comma 3 della L. 154/92, norma in base al quale è stata emanata la Circolare Bankitalia del 29 maggio 1996, che ha escluso l’ulteriore formalità del contratto scritto per “operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, facendo l’esempio proprio dei contratti collegati a quello di conto corrente. In secondo luogo, vanno valutate le conseguenze ove il contratto non abbia la forma scritta. Premesso che la nullità che ne consegue può essere fatta valere, come detto, solo dal cliente ex art. 127 comma 2 TUB (vedi supra), in tali casi deve ritenersi che nessuna norma dell’art. 117 vada applicata, ivi inclusa quella di cui al n. 7, che implica pur sempre l’esistenza di un contratto scritto anche se privo di valide indicazioni sui tassi ed altro. Invece, se difetta la forma scritta, non vi è niente di valido e non vi sono clausole da sostituire, sicché le rimesse in favore del cliente devono essere regolate dalle norme sulla ripetizione d’indebito, pure con riguardo agli interessi, da calcolare al tasso legale. Trattasi, del resto, di una soluzione che trova un preciso riscontro testuale, poiché il comma 7 dell’art. 117 fa esplicito riferimento solo alle ipotesi di cui ai commi 4 e 6, ossia mancata indicazione dei tassi (e altre condizioni) e rinvio agli usi, laddove la nullità per inosservanza della forma scritta è sancita dal non richiamato comma 3. Qualche ulteriore considerazione s’impone anche per le c.m.s.: in particolare, si discute della loro natura, vale a dire se esse siano una componente degli interessi ovvero costituiscano il corrispettivo della messa a disposizione del denaro in favore del cliente. Dubitativa è anche la giurisprudenza, che però sembra propendere per la seconda soluzione: infatti, secondo la Corte di Cassazione, la sua natura di “accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ….. potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi”; tuttavia, il S.C. ritiene preferibile attribuire alla c.m.s. “funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”, e ciò “anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108” (Cass. 02/11772). La questione non è solamente teorica, appunto perchè dall’adesione all’una o all’altra tesi derivano conseguenze di rilievo. Non per il problema “usura”, visto quanto si dirà infra, ma per la questione capitalizzazione: infatti, se la c.m.s. fosse qualificata mero accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, la sua capitalizzazione, seguendo l’odierna giurisprudenza di legittimità, incorrerebbe nei limiti dell’art. 1283 c.c.; viceversa, accedendo alla tesi, come vista preferita, della natura remunerativa della c.m.s., il conteggio su di essa degli interessi non darebbe vita a capitalizzazione vietata, che si realizzerebbe invece sulla seconda operazione contabile, ovvero sull’applicazione degli interessi sui primi interessi maturati; questo naturalmente per i contratti ante modifica ex art. 25 D.Lgs. 342/99, perché per i contratti successivi la capitalizzazione avviene nel rispetto della regola paritaria della capitalizzazione trimestrale sia per interessi attivi che passivi. Resta da dire che l’art. 2 bis comma 1 del DL 29 novembre 2008 n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, stabilisce che: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Quindi, con una disposizione non valida per il passato e ai sensi del comma 3 da inserire nei contratti in corso entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (e costituente “giusto motivo” ai sensi dell’art. 118 comma 1 TUB), si sancisce la non remunerazione in favore della banca per utilizzi temporalmente limitati (di gg. 30) e per sconfinamenti non pattuiti ma tollerati secondo una pratica poco commendevole che giovava a tutti: alla banca perché l'affidamento non dichiarato non incideva sul limite delle riserve rispetto agli utilizzi effettivi e gli utili erano notevoli e al cliente che spesso non ha le garanzie necessarie e richieste per accedere al credito, o a quel dato livello di credito. GLI INTERESSI USURARI Secondo la legge 108/96, il reato di usura, che sotto il profilo civilistico dà vita alla nullità della clausola e alla non debenza di alcun interesse (art. 1815 comma 2 c.c.), sussiste nel caso in cui sia superato un “limite” previsto dalle legge (art. 1 comma 3), limite che “è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale .... relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” (art. 2 comma 4), avendo quindi come parametri di riferimento i tassi indicati nei DD.MM. del ministro del tesoro emanati ogni tre mesi ai sensi della legge stessa (art. 2 comma 1). Tutti questi DD.MM. riportano “i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno,” relativi ai trimestri di riferimento (art. 1 commi 1), con la precisazione che i “tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata”, la quale viene “rilevata .... e riportata separatamente in nota alla tabella” (art. 1 comma 2). Quest’ultima disposizione, di natura attuativa, va peraltro letta in rapporto alla prescrizione dell’art. 1 della L. 108/96, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (comma 5). Si tratta di una norma di fondamentale importanza, perché manifesta in modo chiaro l’intento della legge di sanzionare ogni forma di onere a carico del cliente che sia connesso al rapporto di finanziamento, pur se non abbia natura di interesse e costituisca piuttosto una “commissione, remunerazione o spesa” collegata all’erogazione del credito. In questa prospettiva, appare irrilevante discutere della natura della commissione di massimo scoperto (vedi supra). Infatti, vuoi che sia interesse o remunerazione, la commissione di massimo scoperto comunque costituisce un “costo”, una “voce” da computare ai fini della determinazione del tasso effettivo globale relativo al singolo rapporto, alla luce della chiara opzione di cui all’art. 1 comma 5 della L. 108/96. Né rileva che l’usurarietà è stabilita in rapporto a tassi medi risultanti da rilevazioni che, per quel che si è detto, non comprendono le commissioni di massimo scoperto (artt. 1 comma 3 e 2 commi 1 e 4 L. 108/96 ed 1 DD.MM. attuativi), in quanto tale limitazione, a ben vedere, è solo apparente, perché le commissioni di massimo scoperto sono comunque indicate nei DD.MM., anche se in modo distinto, e questo vuole dire intenzione di tenerne conto in termini complessivi, non spiegandosi altrimenti l’esplicita determinazione. D’altro canto, i DD.MM. devono essere interpretati tenendo conto anche della regola dell’art. 1 comma 5, per la quale, si ripete, la commissione, pur se solo remunerazione, deve essere considerata ai fini del conteggio. Tuttavia, tale interpretazione non è quella maggioritaria, perché prevale la soluzione, evidentemente più favorevole alle banche, che si basa sulla non inclusione delle c.m.s. nella rilevazione base. Evidentemente al fine di ovviare a tale interpretazione pro-banche, è intervenuto il già citato art. 2 bis del DL 29 novembre 2008 n. 185, seguito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, il cui comma 2 prevede che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. E’ chiara la presa di posizione per la necessità del conteggio delle c.m.s. ai fini della verifica della “usurarietà” del tasso, Sicuramente sono escluse dal conteggio, e lo resteranno anche nel futuro, “le spese di tenuta del conto corrente” e le “spese richieste dalla banca in riferimento a specifiche operazioni” (ad es. bonifici o rilascio libretti), ciò in linea con le stesse istruzioni dell’Ufficio Italiano Cambi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 18.2.2003 n. 40, che appunto indicano il trattamento egli oneri e delle spese, indicando quelle escluse e quelle incluse. Tali istruzioni, peraltro, soccorrono anche con riferimento alla tecnica di conteggio, da effettuarsi avendo come punti di riferimento le “competenze di pertinenza del trimestre di riferimento” (punto C.3 di dette istruzioni) Altra importante precisazione riguarda il momento in cui deve essere valutata l’eventuale superamento del tasso-soglia nei rapporti di conto corrente. L’art. 1 comma 1 DL 394/00, convertito nella L 24/01 (e che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost. 02/29), detta a chiare lettere il principio che l'usurarietà degli interessi deve essere valutata, ai fini dell'art. 1815 comma 2 c. c. (e dell'art. 644 c. p.), nel momento in cui essi sono “promessi o convenuti”, con la conseguenza che occorre verificare se il contratto, con la relativa clausola sugli interessi, sia stato concluso dopo la L. 108/96, e anzi dopo l’entrata in vigore del primo DM attuativo, il DM 22.3.1997 pubblicato nella GU 2.4.1997 n. 76. Ma tutti i contratti bancari, in ossequio all’art. 118 TU 385/93, prevedono la facoltà della banca di variare unilateralmente, previa comunicazione, il tasso di interesse e le altre condizioni applicate (sul punto vedi infra), per cui se ciò accade, la valutazione dell’usurarietà va effettuata non con riferimento alle pattuizioni originarie, ma di tempo in tempo, alla stregua delle variazioni avvenute nel corso del rapporto. Solo in questi sensi e limiti può trovare condivisione l’indirizzo della giurisprudenza, sorto peraltro prima del DL 394/00 (anche se recepito in sentenze successive), secondo cui la L. 108/96 si applica anche ai contratti conclusi in data anteriore (vedi da ultimo le citate Cass. 05/4092 e 06/2140, che al riguardo parlano di inefficacia ex nunc rilevabile solo ad istanza di parte); mentre in un’ottica più generale, che è quella viceversa fatta propria in dette sentenze, l’affermazione non sembra corretta, urtando in modo palese col dettato dell’art. 1 comma 1 del DL 394/00 convertito nella L. 24/01, così come evidenziato dalla più attenta giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cass. 05/5004 e 03/4380). Pacifica è, invece, l’inapplicabilità della L. 108/96 per i rapporti ormai esauriti all’entrata in vigore della legge (Cass. 05/15497 e 03/5324). Né l’usurarietà può essere evitata dalle banche attraverso autolimitazioni unilaterali, ossia con richieste in sede giudiziaria rientranti nei limiti del tasso-soglia, in quanto la sanzione di nullità di cui all’art. 4 della L. 108/96 (oggi 1815 comma 2 c.c.) prescinde dalle scelte ed opzioni del creditore, che non può ovviare alla nullità autoriducendo il tasso; altrimenti, lo stesso spirito e la portata della legge sarebbero elusi (si noti, però, che la giurisprudenza che ritiene applicabile ex nunc la L. 108/96 ammette una “rinegoziazione” successiva del rapporto: Cass. 02/8442). Altra cosa da evidenziare in questa sede è che, seppure il fenomeno usurario per sua natura si ricollega al prestito di denaro e, quindi, sottintenda interessi “corrispettivi”, che del resto sono quelli del contratto di mutuo, in relazione al quale è stabilita la sanzione civilistica (art. 1815 comma 2 c.c.), l’indirizzo prevalente è nel senso che anche gli interessi di mora rientrano nei rigori della L. 108/96 (così Cass. 03/5324 e 00/5286, oltre alla stessa Cass. 00/14899). La tesi, al di là quanto appena esposto, sembra urtare con gli stessi meccanismi predisposti dalla legge in caso di interessi di mora “iniqui”, che infatti, equivalendo in sostanza ad una penale per il ritardo nell’adempimento, possono essere ridotti dal giudice (anche d’ufficio seguendo il più recente indirizzo delle Sezioni unite sulla riduzione della penale: SU 05/18128): l’obiezione, condivisibile, è formulata in alcune sentenze di merito (vedi ad esempio Trib. Napoli 5.5.2000 in Giur. It. 2000, p. 1665). Ma concentriamo a questo punto l’attenzione sulla sede naturale dell’ “usura”, ossia sul contratto di mutuo. Il DL 394/00, convertito nella L. 24/01, si occupa ex professo dei contratti di mutuo a tasso fisso in corso all’entrata in vigore della legge”, per i quali l’ “eccezionale caduta dei tassi d’interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale”, aveva sostanzialmente provocato un’eccessiva onerosità di tali contratti, dando quindi vita ad una sopravvenuta usurarietà degli interessi pattuiti. E il legislatore è intervenuto appunto prevedendo la sostituzione di diritto dei tassi convenuti con quello, eventualmente più favorevole, pari “al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno” (art. 1 comma 3 DL 394/00 convertito nella L. 24/01); tale sostituzione, dopo la pronunzia di incostituzionalità del 2002 (vedi la citata sentenza della Consulta 02/29), si applica a tutte le rate scadenti successivamente all’entrata in vigore del DL. In tal modo si è ovviato ad una situazione già verificatasi anni addietro con riguardo ai contratti di mutuo in ECU, per i quali la svalutazione della lira aveva provocato ingenti incrementi di costi a carico dei mutuatari. In proposito, una parte della giurisprudenza dell’epoca aveva ritenuto applicabile l’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità, onde tutelare le ragioni dei clienti. LA VARIAZIONE UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Si tratta di una facoltà riconosciuta dall’art. 118 TUB, che ne condiziona la validità ed efficacia al preventivo accordo, il quale ai sensi dell’art. 117 comma 5 TUB deve essere recepito in una clausola approvata specificamente dal cliente. Il modello di riferimento è, quindi, l’art. 1341 comma 2 c.c., ma dopo il TUB è entrata in vigore la L. 52/96, che ha introdotto gli artt. 1469 bis e ss. c.c. (oggi sostituiti da corrispondenti norme del codice del consumo); e il n. 11 del comma 3 dell’art. 1469 bis c.c. (vedi oggi la corrispondente norma del codice del consumo) individua quale clausola vessatoria quella che prevede la variazione unilaterale delle clausole contrattuali “senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”, dettando una disciplina sostanzialmente confermata dal successivo n. 2 comma 4 del medesimo articolo, che, relativamente ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di “servizi finanziari”, consente la modifica delle condizioni contrattuali ove si sia un “giustificato motivo”. La disciplina è, dunque, più rigorosa rispetto a quella del TUB, appunto perché impone una giustificazione oggettiva, e contrattualizzata, per la variazione; e trattasi di una disciplina applicabile ai contratti bancari, tipici esempi di regolamenti pattizi tra professionisti e consumatori, senza che al contrario si possa far leva su una asserita “specialità”, e perciò prevalenza, della disciplina di cui al TUB, in quanto gli artt. 1469 bis e ss. c.c., introdotti successivamente (ed oggi confluiti nel codice del consumo), hanno una portata omnicomprensiva, con espresse e limitate deroghe parziali, che non riguardano però i normali contratti bancari, ma solo i contratti aventi ad oggetto la prestazione di “valori mobiliari, strumenti finanziari” et similia (vedi il comma 6 dell’art. 1469 ter; viceversa, il comma 4, che riguarda i contratti aventi ad oggetto la prestazione di “servizi finanziari”, tra cui devono farsi rientrare anche le aperture di credito - cfr. artt. 106 e 126 TUB - , prevede una disciplina analoga a quella del n. 11, solo che il “giustificato motivo” non deve necessariamente essere previsto in contratto). Naturalmente, l’applicazione degli artt. 1469 bis e ss. c.c. presuppone che si sia in presenza di contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della L. 52/96, alla luce del generale principio della irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c. In questo senso è la prevalente giurisprudenza di legittimità (così ad esempio Cass. 02/10285, 01/10086 e 99/13339, tutte richiamate anche in tema di assicurazione, ove si evidenzieranno anche i dubbi prospettati su tale interpretazione). L’art. 10 del DL n. 223 del 4 luglio 2006 , come convertito nella L. n. 248 del 4 agosto 2006, ha modificato l’art. 118 comma 1, ribadendo la necessità di un “giustificato motivo”, peraltro “nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile”. Sono state altresì irrigidite, a tutela dei clienti-consumatori, le previsioni circa le modalità di comunicazione, prevedendosi (al comma 2) che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contrattò, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Come si vede, è stato ampliato il termine per il recesso, in origine di soli 15 giorni, mentre è stato aggiunto che “in ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura” (ultimo capoverso). E’ stato aggiunto che “le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente" (comma 4). Infine, è stata confermata la sanzione dell’inefficacia delle “variazioni contrattuali” fatte contro le norme di legge “se sfavorevoli al cliente” (comma 3). IL RECESSO DELLA BANCA Già prima dell’entrata in vigore degli artt. 1469 bis e ss. c.c. la facoltà della banca di recedere unilateralmente dai contratti di durata era stata espressamente limitata. Non solo dalla necessità della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., ma anche, e più in generale, dal rispetto del principio della buona fede nell’esecuzione del contratto. Infatti, la giurisprudenza ha in più occasioni segnalato la necessità che il recesso sia conforme a buona fede, in particolare affermando che, “in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate” (Cass. 00/9321; vedi anche Cass. 97/4538). Oggi, dopo l’introduzione degli artt. 1469 bis e s.s. c.c. (confluiti nel codice del consumo), allorchè il contratto sia stipulato con un consumatore vi è appunto la disciplina di tutela a favore di tale categoria di soggetti: in particolare la disposizione n. 7 del comma 3 dell’art. 1469 ter, che esclude la legittimità di una clausola prevedente la penale a favore solo del professionista e non anche del consumatore, e la disposizione n. 8, che ritiene illegittime le clausole che consentono al professionista il recesso senza ragionevole preavviso nei contratti a tempo indeterminato, tranne nel caso di “giusta causa”. I commi 4 e 6 dello stesso articolo (vedi oggi la corrispondente norma del codice del consumo) contengono poi delle precisazioni, perché il primo per i contratti aventi ad oggetto “servizi finanziari” ammette il recesso senza preavviso qualora vi sia un “giustificato motivo” (espressione diversa da “giusta causa”: la distinzione dovrebbe essere nel senso che la “giusta causa” sottende più che altro un comportamento colpevole della controparte, mentre il “giustificato motivo” attiene anche alla sfera del recedente), mentre il secondo per i contratti aventi ad oggetto “valori mobiliari, strumenti finanziari, etc.” esclude totalmente l’applicabilità del n. 8 del comma 3. LA CLAUSOLA DEROGATIVA ALLA COMPETENZA DEL TERRITORIO Sul punto vanno fatte le seguenti precisazioni, che varranno anche per i contratti di assicurazione. Sebbene l’interpretazione prevalente ritenga che gli artt. 1469 bis e ss. c.c. (vedi oggi le corrispondenti norme del codice del consumo) si applichino solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della L. 52/96 (vedi ad esempio Cass. 01/10086 e 99/13339), diverso è il discorso “per la disposizione dettata dall'art. 1469 bis terzo comma numero 19 cod. civ., che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima” (Cass. SU 03/14669, seguita dalla giurisprudenza successiva, da ultimo Cass. ord. 06/4439). Ciò posto, tale clausola si “interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto” (vedi la medesima giurisprudenza). Tuttavia, “ciò non preclude che il foro esclusivo risultante dalla norma dell'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., possa essere derogato dalle parti, purché la previsione di un diverso giudice abbia costituito oggetto di trattativa tra le parti medesime ai sensi art. 1469 ter cod. civ.” (Cass. ord. 04/19594 e 06/4439). LA FIDEIUSSIONE E’ un contratto tipico dei rapporti bancari, spessissimo collegato a rapporti di conto corrente con aperture di credito; in questi casi la fideiussione è prestata da terzi in favore delle banche, ma di frequente vi è anche la situazione contraria, nella quale la banca non è la garantita ma la garante di obbligazioni di un proprio cliente. Superato da tempo qualsivoglia dubbio sull’ammissibilità nel nostro ordinamento della fideiussione omnibus (garanzia personale per i tutti i debiti, presenti e futuri, dipendenti da particolari rapporti), figura peraltro limitata dalla L. 154/92 che modificando l’art. 1938 c.c. ha imposto la determinazione dell’ “importo massimo garantito”, e divenuto ormai inattuale il problema dell’applicabilità della nuova disciplina introdotta dalla L. 154/92 ai contratti conclusi in epoca anteriore (era comunque prevalsa la regola della irretroattività temperata dall’applicazione della nuova disciplina quanto agli effetti dei contratti anteriori), le questioni più interessanti che si agitano nel contenzioso in materia di fideiussione possono così sintetizzarsi: 1) “contratto autonomo di garanzia” e contratto di fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta”; 2) efficacia nei confronti del fideiussore degli elementi documentali relativi al rapporto principale; 3) portata dell’art. 1956 comma 2 c.c., introdotto dalla L. 154/92, che rafforzando la clausola generale di “buona fede” sancita dal primo comma ha sancito la invalidità della preventiva rinunzia del fideiussore ad avvalersi della liberazione nei confronti del creditore che abbia continuato a far credito al debitore pur conoscendo le cattive condizioni economiche del debitore; 4) estinzione ex art. 1957 c.c. dell’obbligazione fideiussoria per scadenza dell’obbligazione principale; 5) effetti del recesso del fideiussore garante di un’apertura di credito bancario; 6) estensione o meno al fideiussore-consumatore della qualifica soggettiva del debitore principale, coi relativi effetti sull’applicabilità della disciplina degli art. 1469 bis e ss. c.c. (come oggi confluiti nel codice del consumo). 1) Sul primo punto va detto che il “contratto autonomo di garanzia” (o performance bond) è quel contratto con cui il garante, normalmente una banca o una compagnia di assicurazione, “si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale (salvo "l'exceptio doli")” (tra le tante Cass. 01/6757 e 92/12341, che ritengono ammissibile anche la “controgaranzia autonoma”, con la quale, nei contratti collegati, a catena il controgarante garantisce nello stesso modo il garante principale); in particolare, l’exceptio doli può essere formulata quando “risulti evidente prima facie il comportamento fraudolento o abusivo del richiedente” (Cass. 91/4519), ad esempio allorché “risulti prima facie, in modo certo ed incontestabile, la ... eccedenza” delle somme pretese (Cass. 89/4006); se, ciò malgrado, il garante paghi, può ripetere le somme ai sensi dell’art. 2003 c.c. (Cass. 89/4006 appena cit.) nonché ripristinare l’equilibrio “attraverso azioni di rivalsa” o di “regresso” (vedi rispettivamente Cass. 91/4519 cit. e Cass. 99/10864). In genere, le fideiussioni prestate in favore delle banche contengono una clausola che prevede che il pagamento da parte del debitore avvenga entro un breve termine, “a semplice richiesta” o “a prima richiesta”, previo semplice avviso al debitore e senza bisogno del suo consenso, con impossibilità per il debitore di opporvisi; in tale clausola non vi è però alcun limite espresso all’opponibilità da parte del garante delle eccezioni spettanti al debitore principale. In questi casi la giurisprudenza di legittimità (anche se non seguita da tutti i giudici di merito) sembra ferma nell’escludere che il semplice impiego delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” sia indice della volontà di creare un “contratto autonomo di garanzia”, che elimini il requisito dell’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria e, quindi, la possibilità di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento del creditore (vedi da ultimo Cass. 05/19300 e 04/52). Tuttavia, se tali clausole non sono utili a trasformare la fideiussione in contratto autonomo di garanzia, esse secondo la più recente giurisprudenza hanno comunque un senso, quali clausole “solve et repete”, che ai sensi dell’art. 1462 comma 2 c.c. preclusono al garante-debitore di opporre le eccezioni di merito per evitare il pagamento, solo dopo il quale risorge tale facoltà; in questo modo il creditore è comunque garantito e l’effetto processuale è il rigetto delle difese e soprattutto delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dai fideiussori (vedi ad esempio Cass. 08/4446 e 07/4661, la prima che, però, ricorda anche che tali clausole, per il loro limitato effetto, non impediscono di far valere l’invalidità del contratto fonte dell’obbligazione garantita ovvero quella dello stesso contratto di garanzia). 2) Sulla seconda questione non sussistono dubbi, nel senso dell’opponibilità al fideiussore delle prove documentali relative al rapporto principale, in primo luogo gli estratti conto (cfr. ad esempio Cass. 03/14234 e 02/6258); del resto, specifiche clausole dei modulari dei contratti di fideiussione prevedono l’efficacia probatoria degli estratti-conti e degli altri documenti bancari nei confronti dei fideiussori. 3) Il nuovo art. 1956 comma 2 c.c. ha sì innovato rispetto alla disciplina ante ‘92, allorquando la norma era completamente neutralizzata da rinunzie preventive (ritenute legittime dalla giurisprudenza e non richiedenti specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.), ma nei moduli dei contratti di fideiussione in favore delle banche vi sono clausole che impongono al fideiussore di informarsi costantemente presso la banca delle condizioni economiche del debitore principale, e tale omissione viene spesso opposta con successo per neutralizzare gli effetti dell’art. 1956 c.c., che non può essere fatto valere dal fideiussore in colpa, ossia in grado di conoscere il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. In questo senso, si spiega la regola giurisprudenziale secondo cui l’art. 1956 c.c. è inapplicabile allorquando il garante sia anche socio della società, perchè in questi casi egli è sicuramente a conoscenza delle condizioni economiche della società stessa e, perciò, autorizza tacitamente la concessione ulteriore del credito (ad esempio Cass. 06/3761 e 98/8850). 4) La liberazione di cui all’art. 1957 c.c. si applica sia alla fideiussione solidale che a quella semplice ex art. 1944 comma 2 c.c., ma in tal caso la decadenza per mancata proposizione e continuazione delle istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (o due mesi se il fideiussore ha espressamente limitato la sua garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale) è impedita solo dall’azione contro il debitore principale (Cass. SU 79/5572), mentre nell’ipotesi di fideiussione solidale si può agire anche nei confronti del solo fideiussore (Cass. 05/19300 e 95/7345). Il termine di decadenza di sei (o due) mesi, inerendo a materia non sottratta alla disponibilità delle parti, può essere anche concordato tra le parti (Cass. 06/2263). Per la stessa ragione, il fideiussore può anche rinunziare preventivamente a far valere tale decadenza (Cass. 06/394 e 04/776), ciò anche in modo implicito (Cass. 92/9719; ma, secondo Cass. 03/10574, ciò non accade in caso di clausola di garanzia “a prima richiesta”). Inoltre, la relativa pattuizione non rientra tra quelle di cui all’art. 1341 comma 2 c.c. (Cass. 74/2034) né contrasta con l’art. 1229 comma 1 c.c. (Cass. 02/4444). Ed ancora, la liberazione non si realizza qualora sia espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l’obbligazione principale (Cass. 87/5373; vedi anche quanto si dirà infra per la polizza fideiussoria), ovvero essa sia prestata senza limiti di tempo (Cass. 92/9719 cit., che appunto in questo caso parla di rinunzia implicita a far valere la decadenza; vedi anche Cass. 89/786). Così come non si realizza allorquando sussista un ostacolo giuridico che impedisce qualsiasi azione contro il debitore principale (Cass. 96/3085 e 79/2958). Ciò posto, il termine di sei mesi (o di due mesi), che decorre dalla “scadenza” dell’obbligazione principale, non può essere derogato in base ad un accordo tra creditore e debitore principale al quale rimanga estraneo il fideiussore, con cui si dilazioni il termine di pagamento per il debitore (Cass. 93/12901). Il termine “istanza” presuppone, poi, un’azione giudiziaria, cognitiva od esecutiva, pure di natura cautelare, rivolta all’accertamento e soddisfacimento della pretesa creditoria (cfr. da ultimo Cass. 04/21524 e 04/7502; sull’istanza cautelare vedi in particolare Cass. 91/9364). 5) Quanto al recesso del fideiussore in una fideiussione prestata per un'apertura di credito bancario, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza “il recesso del fideiussore, ove consentito nel perdurare del rapporto principale, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo diventa efficace, nel senso che l'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell'accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive. d'altra parte, però, sull'obbligazione di garanzia così determinata non incidono le ulteriori rimesse dell'accreditato, le quali, stante l'unitarietà del rapporto, non possono essere considerate separatamente dai prelevamenti, occorrendo aver riguardo, per determinare l'entità dell'obbligazione principale, al saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito; e solo se tale saldo sia inferiore a quello esistente al momento del recesso, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma primo, cod. civ., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita” (Cass. 84/1572 e 74/170; sul punto vedi anche le recenti Cass. 05/5166 e 04/5316). Nè, d’altra parte, è di per sé illegittimo e contrario a buona fede il comportamento della banca che, pur dopo il recesso del garante, mantenga in vita l’apertura di credito e faccia altri finanziamenti, appunto allorquando le rimesse del correntista lascino ipotizzare un rientro dell’esposizione debitoria e conducano ad una riduzione dell’esposizione complessiva del garante (così ad esempio Cass. 04/12685). 6) Anche sull’ultima questione è intervenuta la Corte di Cassazione, che ha ritenuto l’esistenza di un indissolubile collegamento tra contratto base e contratto accessorio, con esclusione della disciplina a tutela dei consumatori per il solo fatto che la fideiussione, prestata a garanzia di un’obbligazione professionale, fosse stata contratta da un semplice consumatore (Cass. 01/314 e 05/449). Qualche breve cenno meritano, infine, alcuni istituti simili alla fideiussione. - La “polizza fideiussoria” (o “assicurazione fideiussoria”, “cauzione fideiussoria”, “assicurazione cauzionale”, “fideiussione cauzionale”) si caratterizza per il fatto di essere una garanzia personale prestata da una compagnia assicuratrice, che attraverso tale garanzia assicura il rischio dell’inadempimento del debitore principale posto a carico del creditore. Ma la funzione tipica è quella di garanzia, con la conseguenza che essa, “pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente - debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1892 cod. civ., relativa al contratto di assicurazione, ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell'annullabilità per errore o per dolo” (Cass. 01/6757, che per la medesima ragione ritiene irrilevante la modifica del “rischio” nel corso del rapporto). E’ evidente, peraltro, che le parti hanno la possibilità di derogare alla disciplina del contratto di fideiussione, inserendo clausole che richiamano norme in materia di assicurazione, ad esempio quella sulla prescrizione dell’azione di cui all’art. 2952 c.c. (Cass. 02/14656 e 88/3443) o quella sulla cessazione del rischio di cui all’art. 1896 c.c. (Cass. 84/4807). Inoltre, la stessa struttura e finalità della “polizza fideiussoria” può comportare l’inapplicabilità di alcune norme in materia di fideiussione: ad esempio se con la polizza fideiussoria si garantisce il debitore sino alla liberazione di quest’ultimo dagli obblighi inerenti ad un contratto, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. (Cass. 01/6073 e 96/6520). - L’ “avallo cambiario” è la garanzia personale prestata per un titolo di credito (art. 28 l. ass. e art. 35 l. camb.). La figura negoziale di riferimento è sempre la fideiussione, con conseguente applicabilità, ad esempio, dell’art. 1949 c.c. (Cass. 98/4618), ma l’astrattezza ed autonomia che connotano le obbligazioni cartolari riguardano anche l’obbligazione dell’avallante, che perciò è svincolata da quella del debitore principale, con conseguente inapplicabilità sia dell’art. 1956 c.c. (Cass. 76/2090) che dell’art. 1957 c.c. (Cass. 94/2782). - La pratica commerciale conosce, poi, la “lettera di gradimento” (o di patronage), che è la missiva con cui una società capogruppo o controllante chiede ad una banca il mantenimento o il rinnovo di un credito in favore della controllata. In tali casi, spetta all’interprete verificare se si tratta di mere lettere contenenti informazioni utlizzate dalla banca per concedere il credito, oppure diano vita a vere proprie garanzie fideiussorie (Cass. 85/2879). I CONTRATTI DI “CREDITO AL CONSUMO” Sono quelli previsti dagli artt. 121 e ss. TUB, che dettano una disciplina di ancora maggiore tutela del cliente, imponendo una forma di pubblicità delle condizioni ancora più precisa di quella dell’art. 116 per i normali contratti bancari (art. 123, che prevede l’integrazione con l’indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità), oneri formali ancora più incisivi (la forma scritta senza alcuna deroga - non è infatti richiamato il comma 2 dell’art. 117 – ed uno specifico ed analitico contenuto del contratto), nonchè l’osservanza dell’art. 1525 c.c. (che esclude inderogabilmente la risoluzione in caso di mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo) per i finanziamenti correlati alla concessione di un diritto reale di garanzia sul bene acquistato col denaro ricevuto in prestito. Al di là di tali norme specifiche, valgono gli artt. 115 e ss. (così il comma 3 di tale norma), così come vale la regola generale della “nullità relativa” di cui all’art. 127 comma 2 TUB (che riguarda infatti tutte “le nullità previste dal presente titolo”). Ne consegue che, poiché in genere il contenzioso su tali contratti resta limitato alla fase monitoria, in quanto al decreto ingiuntivo non segue quasi mai l’opposizione a decreto ingiuntivo, le nullità ad esempio della mancata indicazione del TAEG e dell’inosservanza degli oneri formali dell’art. 124 non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice; al quale resta solo la possibilità di verificare l’esistenza di eventuali clausole di capitalizzazione trimestrale e/o del superamento del tasso-soglia. L’APERTURA DI CREDITO DOCUMENTARIO Tale istituto, disciplinato dall’art. 1530 c.c., è spesso praticato nella prassi commerciale per gli acquisti di merce da rivenditori stranieri, allorché il pagamento è effettuato a mezzo la propria banca, che appunto su mandato del cliente/acquirente apre un credito documentario al venditore straniero, spesso servendosi di una banca del Paese dell’acquirente. L’apertura di credito, che s’inquadra in termini generali nella “delegazione cumulativa passiva titolata” (Cass. 99/3972), può essere “confermata” o “non confermata”. Nella prima ipotesi, che si ha quando la banca “confermi il credito nei confronti del beneficiario, il rapporto obbligatorio tra banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto di compravendita, e questo quale presupposto del mandato di apertura di credito incide nel rapporto obbligatorio tra la banca accreditante ed il beneficiario soltanto nel senso che l'obbligazione assunta dalla prima verso il secondo di mettere a disposizione di costui la somma oggetto dell'apertura di credito è condizionata all'esito positivo del controllo, da parte della banca (a ciò obbligata nei riguardi dell'ordinante), della regolarità dei documenti relativi alla vendita che il beneficiario ha l'onere di presentare alla banca stessa entro un certo tempo. Nel caso di apertura di (credito non confermato), invece, tra i due negozi esiste un collegamento funzionale, implicante l'attrazione dell'apertura di credito, specificamente finalizzata all'esecuzione della compravendita, nel sinallagma di questa, con collegamento alla corrispettiva obbligazione del venditore nei confronti del compratore di consegnare le merci oggetto della compravendita, per cui le vicende di detto sinallagma reagiscono nell'esecuzione del mandato e, quindi, la consegna dal venditore al compratore di merce viziata o mancante di qualità promesse o essenziali o, addirittura, di aliud pro alio costituisce giusta causa di revoca del mandato (nonostante la clausola di irrevocabilità), con la conseguenza che, comunicata tale revoca alla banca, questa, pur se ha constatato la regolarità dei documenti relativi alla vendita, non può consentire al beneficiario-venditore l'utilizzazione del credito aperto in suo favore” (così Cass. 83/3992; sulla restrizione delle eccezioni opponibili dalla banca in caso di conferma del credito, vedi anche Cass. 03/1288 e 83/813). Sovente vi sono richieste ex art. 700 c.p.c. da parte degli acquirenti italiani volte a bloccare il pagamento delle banche ai rivenditori stranieri facendo leva sulla sussistenza di vizi della merce venduta. E’ evidente che la presenza di un’apertura di credito confermata dovrebbe rendere difficilmente praticabile la sospensione in via cautelare del pagamento, perché in tal modo si elimina quella “autonomia” che invece costituisce il tratto caratterizzante della figura di cui all’art. 1530 comma 2 c.c. Ma di solito, ove sussistano vizi e difetti, si concede tale sospensiva, facendo leva sulla difficile recuperabilità degli importi nei confronti di soggetti stranieri e, quanto al fumus boni iuris, riconoscendo al delegante/acquirente il diritto di formulare un’exceptio doli al venditore straniero, revocando contestualmente per “giusta causa” il mandato conferito alla banca/delegata, revoca consentita dall’art. 1723 comma 2 c.c. anche nell’ipotesi in cui, come quella in esame, il mandato sia conferito anche nell’interesse di un terzo (il rivenditore creditore del prezzo).
Scarica