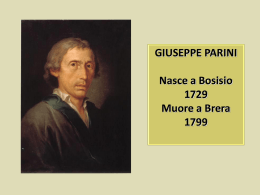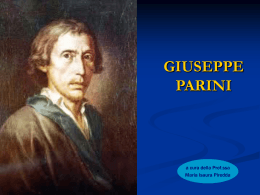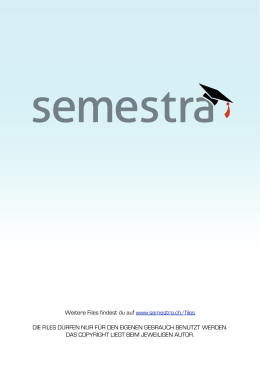Giuseppe Parini Giuseppe Parini nacque a Bosisio il 23 maggio 1729, morì a Milano il 15 agosto 1799. È stato un poeta,librettista e traduttore italiano. Membro dell'Accademia dei Trasformati fu uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo e dell'Illuminismo italiano. La vita Giuseppe Parino (che preferì più tardi modificare il proprio cognome in Parini) nacque nel 1729 a Bosisio, in Brianza, da una famiglia di modeste condizioni. Per tutta la vita fu costretto a combattere contro le difficoltà economiche e suoi primi passi negli studi furono segnati proprio da questo grave problema e da un doloroso handicap fisico che lo seguirà per tutta la vita: rimase zoppo ad una gamba a causa dell’artrite. Una prozia ricca lo accolse nel 1738 a Milano e lo mantenne agli studi presso il collegio dei Barnabiti. Qualche anno dopo, nel 1741, alla sua morte gli lasciò una piccola rendita purché diventasse sacerdote. La sua fu dunque una vocazione obbligata dalle difficoltà economiche e dal profondo amore per gli studi che, pur con grandi sforzi, era riuscito a portare a termine. Nel 1752 pubblica una raccolta di versi, Alcune poesie di Ripano Eupilino, che ottiene un buon successo nell’ambiente milanese. Ciò gli consentì di accedere all’Accademia dei Trasformati. Nel 1754 per potersi mantenere, fu costretto ad integrare la piccola rendita impiegandosi come precettore presso i duchi Serbelloni, dove rimase fino al 1762. qui conobbe la vita nobiliare soprattutto nei suo aspetti più fatui; da questa conoscenza prese avvio l’opera critica di un certo tipo di nobiltà. Proprio per protesta verso il comportamento sprezzante e inutilmente crudele dei nobili, il poeta si allontanò dalla famiglia Serbelloni; questo episodio venne ripreso nel Giorno. Sempre su questo tema scrive nel 1757 il Dialogo sopra la nobiltà. Dal 1762 divenne precettore di Carlo Imbonati conservando l’incarico fino al 1768. Nel frattempo aveva pubblicato due poemetti satirici contro la nobiltà oziosa e improduttiva, il Mattino (1763) e il Mezzogiorno (1765) che gli conferirono fama e notorietà, tale da vedersi affidare, nel 1768 dal governatore della Lombardia, il conte Firmian, la direzione della “Gazzetta di Milano” e, nel 1769, ricevere la nomina di professore di eloquenza all’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 1780 l’impero austriaco passa nelle mani di Giuseppe II che impose direttive autoritarie sulla cultura. Il poeta, ferito e deluso nelle sue più profonde convinzioni si allontanò dall’attività intellettuale militante. Scoppiata la rivoluzione francese nel 1789 inizialmente la vide con favore e speranza, come realizzazione dei principi illuministici di libertà ed uguaglianza, ma poi, dopo gli eccessi autoritari e sanguinari del Terrore, assunse posizioni sempre più negative. Con l’ingresso dei Francesi a Milano nel 1796 fu chiamato a far parte della Municipalità in una commissione che si occupava della religione e dell’istruzione pubblica. Ben presto però sorse un dissidio tra la commissione e l’indirizzo generale della Municipalità, e Parini fu allontanato. Il poeta allora, ormai vecchio e di precaria salute, si ritirò in un isolamento sdegnoso. Poche ore prima della morte, nel 1799, scrisse un sonetto, Predaro i Filistei l’Arca di Dio, in cui, con immagini bibliche, lodava Dio di aver restituito Milano all’Austria. Le Opere Le Odi Le 22 (25 nella seconda edizione) Odi furono scritte da Giuseppe Parini come poesia d'occasione in un ampio lasso di tempo che va dal1758 al 1790. La componente arcadica e quella illuministica confluiscono nell’adesione alla sensibilità neoclassica e sono divisibili in tre fasi: La prima fase giunge agli anni Settanta. È caratterizzata da una forte componente sociale, in cui la visione del Parini, fondamentalmente classicista, si fonde con riflessioni sul "come" si vive. Tra queste ricordiamo: L'innesto del vaiuolo (1765), Il bisogno (1766), La vita rustica (1758 circa), L'educazione(1764) dedicata a Carlo Imbonati. La seconda fase ha soprattutto un indirizzo educativo, e possiamo collocare l'inizio di questa fase nel 1777 circa, con La laurea. Ma è La caduta a rappresentare il vero emblema della poesia del Parini: il poeta vecchio e malandato cade, un passante lo raccoglie e gli suggerisce di comportarsi più servilmente con i potenti che lo hanno lasciato solo. Il poeta, sdegnato, rifiuta di piegare la testa. La terza fase è invece prettamente neoclassica, l'animo nobile e la dignità del ruolo del poeta sono al centro delle odi, intrise di bellezza antica, erotismo, sentimenti, che appaiono al poeta, illuminate da una luce calda e ferma che finalmente mostra al poeta ciò che egli ama ma che non riesce a vivere fino in fondo. Qui, in questa fase, l'uomo Parini, non solo poeta e sacerdote, educatore e giudice, esce fuori e si ritrova in tre odi dedicate a tre donne amate dall'ormai vecchio poeta: Il pericolo (1787) per Cecilia Tron, Il dono (1790) per Paola Castiglioni, Per l'inclita Nice (1793), nota anche come Il messaggio per Maria di Castelbarco. La Caduta (da Odi) È un inverno freddo e uggioso. Il Parini è ormai vecchio e sofferente; in un giorno di pioggia mentre se ne va zoppicando per le vie di Milano, scivola e cade. Un passante accorre, lo solleva e lo accompagna per un tratto di strada. Cammin facendo, lo consiglia di adulare i nobili e i potenti per averne benefici. Il poeta lo ringrazia dell’aiuto, ma rifiuta con fierezza i suoi consigli. È questa una delle odi più note di Parini, la cui dignità morale si mantenne inalterata anche nell’avversa fortuna, raro esempio di nobiltà d’animo in un’epoca di decadenza civile e morale. L’ode fu composta nel 1785. La Caduta (da Odi) Quando Orïon dal cielo Declinando imperversa; E pioggia e nevi e gelo Sopra la terra ottenebrata versa, Me spinto ne la iniqua Stagione, infermo il piede, Tra il fango e tra l’obliqua Furia de’ carri la città gir vede; E per avverso sasso Mal fra gli altri sorgente, O per lubrico passo Lungo il cammino stramazzar sovente. Ride il fanciullo; e gli occhi Tosto gonfia commosso, Che il cubito o i ginocchi Me scorge o il mento dal cader percosso. Altri accorre; e: oh infelice E di men crudo fato Degno vate! mi dice; E seguendo il parlar, cinge il mio lato 20 Con la pietosa mano; E di terra mi toglie; E il cappel lordo e il vano Baston dispersi ne la via raccoglie: Te ricca di comune Censo la patria loda; Te sublime, te immune Cigno da tempo che il tuo nome roda Chiama gridando intorno; E te molesta incìta Di poner fine al Giorno, Per cui cercato a lo stranier ti addita. Ed ecco il debil fianco Per anni e per natura Vai nel suolo pur anco Fra il danno strascinando e la paura: Nè il sì lodato verso Vile cocchio ti appresta, Che te salvi a traverso De’ trivii dal furor de la tempesta. Sdegnosa anima! prendi Prendi novo consiglio, Se il già canuto intendi Capo sottrarre a più fatal periglio. Congiunti tu non hai, Non amiche, non ville, Che te far possan mai Nell’urna del favor preporre a mille. Dunque per l’erte scale Arrampica qual puoi; E fa gli atrj e le sale Ogni giorno ulular de’ pianti tuoi. O non cessar di porte Fra lo stuol de’ clienti, Abbracciando le porte De gl’imi, che comandano ai potenti; E lor mercèpenètra Ne’ recessi de’ grandi; E sopra la lor tetra Noja le facezie e le novelle spandi. O, se tu sai, più astuto I cupi sentier trova Colà dove nel muto Aere il destin de’ popoli si cova; E fingendo nova esca Al pubblico guadagno, L’onda sommovi, e pesca Insidioso nel turbato stagno. Ma chi giammai potrìa Guarir tua mente illusa, O trar per altra via Te ostinato amator de la tua Musa? Lasciala: o, pari a vile Mima, il pudore insulti, Dilettando scurrile I bassi genj dietro al fasto occulti. Mia bile, al fin costretta, Già troppo, dal profondo Petto rompendo, getta Impetuosa gli argini; e rispondo: Chi sei tu, che sostenti A me questo vetusto Pondo, e l’animo tenti Prostrarmi a terra? Umano sei, non giusto. Buon cittadino, al segno Dove natura e i primi Casi ordinàr, lo ingegno Guida così, che lui la patria estimi. Quando poi d’età carco Il bisogno lo stringe, Chiede opportuno e parco Con fronte liberal, che l’alma pinge. E se i duri mortali A lui voltano il tergo, Ei si fa, contro ai mali, Della costanza sua scudo ed usbergo. Nè si abbassa per duolo, Nè s’alza per orgoglio. E ciò dicendo, solo Lascio il mio appoggio; e bieco indi mi toglio. Così, grato ai soccorsi, Ho il consiglio a dispetto; E privo di rimorsi, Col dubitante piè torno al mio tetto. Il giorno Il giorno è un componimento che mira a rappresentare in modo satirico, l'aristocrazia decaduta di quel tempo. Con esso inizia di fatto il tempo della letteratura civile italiana. Parini pubblicò nel 1763 una prima parte del poemetto intitolata “Il Mattino” e una seconda parte, nel 1765, intitolata “Il Mezzogiorno” a cui doveva seguire una terza parte intitolata “La Sera”; ma modificò il progetto e divise La Sera in due parti, il Vespro e La Notte, che uscirono postume e incompiute nel 1801. Il poemetto si compone di quattro parti; qui Parini suddivide la giornata ideale del suo pupillo, "il giovin signore", appartenente alla nobiltà milanese. Il mattino Il “giovin signore” si sveglia e affronta la difficile scelta della colazione (caffè o cioccolata); segue poi le lezioni di danza, di canto e di francese; rivolge i suoi pensieri alla donna amata (sposata con un altro nobile) e compie la faticosa attività della toilette, con tanto di cipria e parrucca. In questa sezione sono contenuti due digressioni a sfondo mitologico, la favola di Amore e Imene, che racconta come avvenne la divisione tra l’amore carnale (Amore) e l’amore coniugale (Imene), e la favola della cipria, sull’uso di questo cosmetico tipicamente settecentesco. Il poeta finge d’insegnare al “giovin signore” come deve comportarsi durante la giornata e quali debbano essere le sue più importanti occupazioni; in tal modo mette a nudo la maniera di vivere dissipata e inutile dei nobili. In questo brano l’ironia affiora dall’antitesi tra la vita operosa del contadino e dell’operaio e quella oziosa e vuota del nobile. Il mattino Sorge il mattino in compagnia dell'alba Dinanzi al sol che di poi grande appare Su l'estremo orizzonte a render lieti Gli animali e le piante e i campi e l'onde. Allora il buon villan sorge dal caro Letto cui la fedel moglie e i minori Suoi figlioletti intiepidír la notte: Poi sul dorso portando i sacri arnesi Che prima ritrovò Cerere o Pale Move seguendo i lenti bovi, e scote Lungo il picciol sentier dai curvi rami Fresca rugiada che di gemme al paro La nascente del sol luce rifrange. Allora sorge il fabbro, e la sonante Officina riapre, e all'opre torna L'altro dí non perfette; o se di chiave Ardua e ferrati ingegni all'inquieto Ricco l'arche assecura; o se d'argento E d'oro incider vuol gioielli e vasi Per ornamento a nova sposa o a mense. Ma che? Tu inorridisci e mostri in capo Qual istrice pungente irti i capelli Al suon di mie parole? Ah il tuo mattino Signor questo non è. Tu col cadente Sol non sedesti a parca cena, e al lume Dell'incerto crepuscolo non gisti Ieri a posar qual nei tuguri suoi Entro a rigide coltri il vulgo vile. A voi celeste prole a voi concilio Almo di semidei altro concesse Giove benigno: e con altr'arti e leggi Per novo calle a me guidarvi è d'uopo. Tu tra le veglie e le canore scene E il patetico gioco oltre piú assai Producesti la notte: e stanco alfine In aureo cocchio col fragor di calde Il mezzogiorno Anche la dama fa la toilette mentre aspetta l’arrivo del “giovin signore” il quale, una volta giunto, manda via tutti gli altri pretendenti; si passa poi alla descrizione del pranzo a cui si accompagna una rassegna dei più vari comportamenti umani, dal mangiatore al vegetariano che ama gli animali più degli esseri umani ( qui troviamo la “vergine cuccia”). Infine il “giovin signore” deve tenere compagnia alla dama con una conversazione in cui fare sfoggio della propria cultura. In questa parte troviamo un’altra digressione satirica, la favola del Piacere che fu mandato dagli dei agli uomini per rendere più divertente la loro vita: i nobili ne avvertirono subito la presenza e impararono ad apprezzare il bello, mentre la plebe insensibile continuò a vivere spinta dai bisogni, oppressa dalla fatica e dalla povertà. La vergine cuccia Il “giovin signore” è alle prese col suo ruolo di cavalier servente. È in casa della sua dama; il pranzo è pronto: egli offre la mano alla bella signora e s’avvia verso la mensa. La dama si siede e il giovin signore dopo averle ben accomodata la veste, prende posto al suo fianco, pronto a servirla e a prevenire ogni suo desiderio. Con loro sono altri “semidei”, due dei quali presentano caratteri particolarmente contrastanti: uno, corpulento, divoratore formidabile, concentra tutta la sua attenzione a soddisfare il palato; l’altro, ossuto, schizzinoso, guarda con disdegno la carne perché ha pietà delle povere bestie che gli uomini crudelmente uccidono per soddisfare il proprio appetito. Il poeta coglie lo spunto da questa pietà che il vegetariano dimostra verso le bestie per introdurre l’episodio della “vergine cuccia”, la cagnolina che un servo villano osò oltraggiare con “sacrilego piè”. La dama ricordando quel triste episodio , sente ridestarsi la tenerezza per la povera bestiola e divampare di nuovo lo sdegno contro il servo che l’aveva percossa. La vergine cuccia Or chi è quell’eroe che tanta parte colà ingombra di loco, e mangia e fiuta e guata e de le altrui cure ridendo si superba di ventre agita mole? Oh di mente acutissima dotate mamme del suo palato! oh da mortali invidiabil anima che siede tra la mirabil lor testura; e quindi l’ultimo del piacer deliquio sugge! Chi più saggio di lui penètra e intende la natura migliore; o chi più industre converte a suo piacer l’aria, la terra, e ’l ferace di mostri ondoso abisso? Qualor s’accosta al desco altrui, paventano suo gusto inesorabile le smilze ombre de’ padri, che per l’aria lievi s’aggirano vegliando ancora intorno ai ceduti tesori: e piangon lasse le mal spese vigilie, i sobrj pasti, le in preda all’aquilon case, le antique digiune rozze, gli scommessi cocchj forte assordanti per stridente ferro le piazze e i tetti: e lamentando vanno gl’invan nudati rustici, le fami mal desiate, e de le sacre toghe l’armata in vano autorità sul vulgo. Chi siede a lui vicin? Per certo il caso congiunse accorto i due leggiadri estremi perché doppio spettacolo campeggi; e l’un dell’altro al par più lustri e splenda. Falcato dio degli orti a cui la greca Làmsaco d’asinelli offrir solea vittima degna, al giovine seguace del sapiente di Samo i doni tuoi reca sul desco: egli ozioso siede dispregiando le carni; e le narici schifo raggrinza, in nauseanti rughe ripiega i labbri, e poco pane intanto rumina lentamente. Altro giammai a la squallida fame eroe non seppe durar sì forte: né lassezza il vinse né deliquio giammai né febbre ardente; tanto importa lo aver scarze le membra, singolare il costume, e nel bel mondo onor di filosofico talento. Qual anima è volgar la sua pietade all’Uom riserbi; e facile ribrezzo déstino in lui del suo simile i danni, i bisogni, e le piaghe. Il cor di lui sdegna comune affetto; e i dolci moti a più lontano limite sospinge. «Pera colui che prima osò la mano armata alzar su l’innocente agnella, e sul placido bue: né il truculento cor gli piegâro i teneri belati né i pietosi mugiti né le molli lingue lambenti tortuosamente la man che il loro fato, ahimè, stringea.» Tal ei parla, o signore; e sorge intanto al suo pietoso favellar dagli occhi de la tua dama dolce lagrimetta pari a le stille tremule, brillanti che a la nova stagion gemendo vanno dai palmiti di Bacco entro commossi al tiepido spirar de le prim’aure fecondatrici. Or le sovviene il giorno, ahi fero giorno! allor che la sua bella vergine cuccia de le Grazie alunna, giovenilmente vezzeggiando, il piede villan del servo con l’eburneo dente segnò di lieve nota: ed egli audace con sacrilego piè lanciolla: e quella tre volte rotolò; tre volte scosse gli scompigliati peli, e da le molli nari soffiò la polvere rodente. Indi i gemiti alzando: aita aita parea dicesse; e da le aurate volte a lei l’impietosita Eco rispose: e dagl’infimi chiostri i mesti servi asceser tutti; e da le somme stanze le damigelle pallide tremanti precipitâro. Accorse ognuno; il volto fu spruzzato d’essenze a la tua dama; ella rinvenne alfin: l’ira, il dolore l’agitavano ancor; fulminei sguardi gettò sul servo, e con languida voce chiamò tre volte la sua cuccia: e questa al sen le corse; in suo tenor vendetta chieder sembrolle: e tu vendetta avesti vergine cuccia de le grazie alunna. L’empio servo tremò; con gli occhi al suolo udì la sua condanna. A lui non valse merito quadrilustre; a lui non valse zelo d’arcani uficj: in van per lui fu pregato e promesso; ei nudo andonne dell’assisa spogliato ond’era un giorno venerabile al vulgo. In van novello signor sperò; ché le pietose dame inorridìro, e del misfatto atroce odiâr l’autore. Il misero si giacque con la squallida prole, e con la nuda consorte a lato su la via spargendo al passeggiere inutile lamento: e tu vergine cuccia, idol placato da le vittime umane, isti superba. Il vespro Il sole è ormai vicino a tramontare e per il “giovin signore” è l’ora delle visite (a due amici ammalati, a un’amica che sta per partorire); successivamente il giovane passeggia sulla sua carrozza e incontra vari personaggi che rappresentano ciascuno una condizione sociale diversa (lo scialaquatore, il nobile decaduto, le giovani damigelle ecc.) al calare della sera mentre nel buio si confondono i nobili e i plebei, il cocchiere parcheggia la carrozza in un angolo oscuro. La notte I due amanti prendono parte ad un ricevimento notturno, ed il narratore inizia la descrizione dei diversi personaggi della sala, in particolare degli "imbecilli", caratterizzati da sciocche manie. Poi si passa alla disposizione dei posti ai tavoli da gioco (che possono risvegliare vecchi amori o creare intrighi) e infine ai giochi veri e propri. Così si conclude la dura giornata del nobile italiano del 1700, che tornerà a casa a notte fonda per poi risvegliarsi il mattino dopo, sempre ad ora tarda.
Scaricare