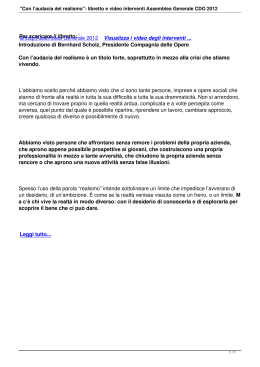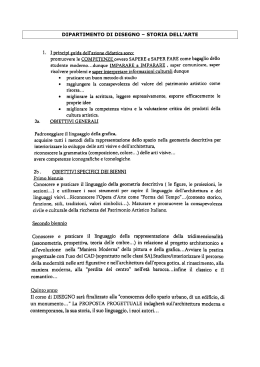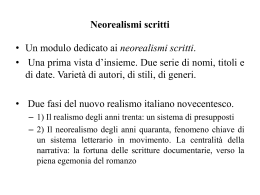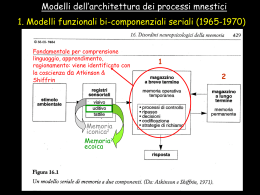MATER(I)EALISMO
EDITORIALE
Non conoscevo bene Renato Nicolini, e, pure, oltre la stima per l’uomo di cultura, nutrivo per lui molta
simpatia, non quella che si ha di solito per le persone che ci sono note attraverso i media, tanto da divenirci
familiari, ma una simpatia autentica, si direbbe un’amicizia che, credo, derivasse dalla sua persona. L’ho
incontrato una prima volta presso l’Università di Salerno, quando era giovane assessore nella giunta di Argan e
già si era inventata l’estate romana. Lo aveva invitato Filiberto Menna, ai cui corsi tenevo qualche lezione
sull’architettura, e Renato conquistò l’intero uditorio, che pure occupava l’immensa aula magna dell’Ateneo, al
solo apparire. Esordì rivelando di tenere molto alla somiglianza, che aveva annotato qualche giornalista, con Jerry
Lewis, ritenendosi a sua volta rivolto, da architetto e da politico, ad offrire agli atri più gioia di vita. La sala
rispose con una gran risata ed uno scroscio di applausi. Poi fummo a cena insieme in casa di amici dove
magnetizzò ancora tutti i presenti e dove compresi come, dietro il sorriso, vi fosse un uomo che affrontava ogni
cosa con molta serietà, un uomo persino severo. L’ho rivisto solo di tanto in tanto, in qualche convegno ed in un
concorso per una valutazione comparativa. Eravamo entrambi commissari ed ancora una volta ho potuto
constatare la sua serietà e rigore cui si univa la disponibilità, rara ormai, all’ascolto delle ragioni degli altri. Una
disponibilità ed una apertura mentale che aveva a che fare con la curiosità dello studio dove pure ha mostrato di
non essere mai pedante. L’incontro con «Bloom» si deve a tale disponibilità. Suggerii ai giovani redattori di
inviare la rivista ad alcuni docenti italiani chiedendo loro una eventuale partecipazione. Uno dei pochi a
rispondere fu Renato Nicolini che ci inviò un suo “pezzo”. Si decise di utilizzarlo come “editoriale” e lui stette al
gioco. Da quel numero Renato è stato sempre puntuale con il suo piccolo saggio di apertura e ne aveva promesso
uno anche per questo numero. Purtroppo non deve aver fatto in tempo a scriverlo ed a tutti noi già manca
l’appuntamento con lui. Non sappiamo come corrispondere ad una tale mancanza, del tutto incolmabile. Abbiamo
quindi ritenuto, tutti noi della redazione e del comitato scientifico, così come accade nelle squadre di calcio che
tolgono il numero della maglia di un loro campione non più attivo, di non offrire a nessun altro l’editoriale di
«Bloom», come è per il Napoli che gioca da tempo senza numero 10. Certo Renato non somigliava al pibe de oro,
ma il paragone con Maradona gli farà sicuramente piacere.
SOTTO LA MIA STESSA PELLE. FILOSOFIA VS SOFISTICA
Dario Giugliano
Nell’affrontare la questione posta da questa rivista, questione che comincia a far sentire eco di sé nei
cosiddetti luoghi deputati ad accogliere l’eccellenza del dibattito culturale nostrano, che son poi i luoghi canonici
della cosiddetta industria culturale, non posso non confessare preliminarmente un certo disagio. Confesso cioè
che non comprendo tutta la serietà del valore di questo dibattito – e forse per miei limiti. Ma veniamo a noi. La
questione del realismo, dunque.
Questa questione, come sanno tutti, è abbastanza antica. Non è il caso, qui, di farne la storia. Vorrei limitarmi
ad alcune considerazioni, cercando, nel ripercorrerne determinati tratti, per quanto sia nelle mie possibilità, di
pensare scrivendo – e nel senso, come spero sarà infine evidente, di questo mio dichiarato proposito, di fatto,
dovrebbe risiedere la finalità di questo scritto.
Dire realismo significa implicitamente evocare delle catene concettuali che con questo termine sono collegate.
Il concetto di realismo, infatti, richiama, inevitabilmente, quello di materialismo, per esempio, e quello di
idealismo, tra i tanti. Pur se questi appena evocati son solo due tra i tanti concetti che quello di realismo vede
collegati a sé, è immediatamente chiaro a chiunque che questi due sono tutt’altro che due concetti tra i tanti, come
a dire che se ne possa pure fare a meno, nel momento in cui ci si occupa di filosofia (ammesso che ci possano mai
essere dei concetti in filosofia di cui si possa fare a meno). Di sicuro, il concetto di materialismo e quello di
idealismo sono due concetti fondamentali del pensiero filosofico occidentale, su cui esso, quindi, risulta edificato,
proprio come accade condelle mura portanti peruna costruzione architettonica. E proprio come per questa, se
vengono meno, crolla tutto (o, alla peggio, si smette di fare filosofia, il che, come ognuno può comprendere, è già
meno grave).1
Idealismo e materialismo. Anche per questi concetti, non è il caso di farne la storia. Potremmo, però, rubare
una definizione a qualcuno che ha pensato prima di noi e che così potrebbe portarci già a un buon punto della
riflessione. Una definizione che ho sempre trovato geniale e che concerne proprio la differenza tra idealismo e
materialismo (tra filosofo idealista e materialista, per la precisione), è quella data da un filosofo a me
particolarmente caro, la lettura dei cui scritti mi accompagna ormai da decenni e da cui ho imparato tantissimo.
Louis Althusser scrive in due paginette datate 1986 e intitolate proprio “Ritratto di un filosofo materialista”, 2che
questi è come il protagonista di un western americano, la cui età “non ha nessuna importanza”, “l’essenziale è che
non sappia dov’è ed abbia voglia di andare da qualche parte. Ecco perché prende sempre il treno in corsa, come
nei westerns americani. Senza sapere da dove viene (origine) né dove va (fine)”.3Ovviamente (e Althusser l’ha
fatto altrove), basta ricavare per negazione la caratteristica essenziale del filosofo idealista, come uno che,
metaforicamente, prende sempre un treno, sapendo da dove viene e dove sta andando. In poche battute, semplici,
chiare, brillanti, il filosofo francese ci spiega l’essenza di quello che viene definito il materialismo dell’incontro o
aleatorio (che poi è il vero materialismo). Insomma, ciò che distingue un materialista da un idealista (e un
materialista autentico da uno fasullo) consiste nel fatto che il primo, a differenza del secondo, non pensa mai
un’antecedenza ideale della cosiddetta realtà, meglio: l’antecedenza di un senso su qualsiasi realtà (compreso
quella di pensiero, anzi, soprattutto su quella di pensiero). A questo livello, non si potrà più pensare l’antecedenza
di una causa sui (suoi) effetti o dei relati sulla relazione. La relazione, quindi, sarebbe sempre originaria. Ma se si
arriva a pensare una relazione originaria (come una differenza originaria), allora vain crisi il concetto stesso di
origine.
Mi rendo conto che scrivere queste cose su una rivista di architettura può suonare un po’ oltraggioso, in
considerazione del fatto che i fondamentali di questa disciplina fondano proprio su un’idea di progetto.
L’architettura è progetto, sempre e comunque.
Non so se possa essere consolante, ma queste cose suonano oltraggiose pure se vengono scritte altrove, perché
l’idealismo (che è l’altro nome della filosofia – o almeno della sua tradizione accademica), con i movimenti
logici delle sue catene concettuali, è ovunque come struttura di base del funzionamento della ragione umana,
tanto che potremmo dire che, fin dall’inizio, architettura e filosofia non solo convivono, ma finiscono per essere
l’una come il recto (o il verso, a seconda di quale angolazione si scelga per l’osser-vazione) dell’altra. Lo sapeva
bene Kant, che intitolòla chiusura4della sua prima Critica a “L’architettonica della ragion pura”. Da questo punto
1
Il vero disastro lo si ha quando si crede di star facendo filosofia e invece si fa altro che è come dire che si crede di stare edificando
un’architettura, mentre non ci si accorge che si sta contribuendo, e notevolmente, a demolire quanto ci è intorno.
2
In Id., Sul materialismo aleatorio, tr. a cura di V. Morfino e L. Pinzolo, Unicopli, Milano 2000, pp. 181-182.
3
Ivi, p. 181.
4
Il capitolo III della “Dottrina trascendentale del metodo”.
6
di vista, il pensiero non può che essere idealistico, cioè lavorare sull’idea e a partire da essa, vale a dire in un
senso riflessivo, basando sul principio di trascendenza. E la trascendenza cos’altro sarebbe, in ultima istanza, se
non progetto ovvero modo di far i conti col tempo (e con lo spazio) inteso linearmente?L’idea di una scienza
intesa come possibilità di previsione è già tutta contenuta nell’idea stessa di progetto, di calcolo progettante come
visione preliminare: cerco di vedere prima, organizzandone forme e contenuti, come sarà ciò che dovrà essere
costruito, edificato. Fonda su tutto questo discorso il motivo per cui sia Heidegger che Cassirer – divisi in un
dibattito per tanti aspetti di scarso rilievo per il nostro discorso – concordavano sul fatto, invece assolutamente
rilevante ai fini del nostro ragionamento, che l’immaginazione produttiva fosse centrale in Kant. Semplificando
brutalmente: senza immaginazione non c’è pensiero, perché non c’è trascendenza. E Kant sapeva bene, tanto da
insegnarcelo, che non è il soggetto a pensare, piuttosto questo è un effetto del pensiero. Il soggetto umano si
costituisce a partire da una possibilità di trascendenza. Ma lasciamo in sospeso questa questione abissale, per
tornare sui nostri passi.
La questione del realismo (ma, finora, invero, non abbiam discusso d’altro). Quando si parla di realismo, il
primo nome che mi viene in mente è Balzac, con la sua Comédie humaine. A lui, in verità, non piaceva
l’aggettivo “realista” applicato alla sua opera (e giustamente), ma è indubbio che rispetto ad altro tipo di
produzione letteraria, quella di Balzac fa un salto notevole (in avanti, indietro o di lato non ha alcuna
importanza), rivoluzionando schemi e scenari narrativi, portando alla ribalta le storie degli affari commer-ciali,
industriali, bancari e di come queste storie diventino le storie di ognuno dei suoi protagonisti, la cui esistenza si
giustifica a partire da esse. E quelle storie erano proprio le storie che Balzac vedeva svolgersi davanti ai suoi
occhi. Ecco il realismo. L’artista non fa altro che rappresentare, riproducendo, la realtà.
Prendiamo un autore come Pasolini. Quando decide a un certo punto della sua vita di cominciare a fare
cinema, giustificherà questa decisione affermando che, attraverso il mezzo cinematografico, riesce finalmente a
riprodurre la realtà, avvicinandosi a quell’ideale rappresentativo di tutte le arti, dalle origini. Riprodurre la realtà
tal qual è, senza trasfigurazioni idealizzanti. Niente immaginazione, quindi. Piuttosto, quello verso cui il realista
punta il proprio obiettivo coincide col suo stesso strumento di indirizzo: l’obiettività.
Ma sarà vero? Spiego meglio il senso di questa mia domanda. È possibile in ultima istanza essere obiettivi e,
se sì, in che misura? Che significano espressioni come“essere obiettivi” o “riflettere, riprodurre la realtà”?
Sappiamo bene come tutto questo fosse in qualche modo accompagnato da un dibattito anche molto aspro,
riguardo a una sorta di dovere morale dell’intellettuale in generale, fosse artista o un ricercatore impegnato in
un’analisi dell’esistente, il quale appunto aveva il dovere di non nascondere la realtà, ma, descrivendola nella sua
evidenza immediata, fornire quegli strumenti di analisi tali da consentire alla prassi politica di operare quei
cambiamenti necessari al benessere collettivo. Ecco perché, almeno a una prima risultanza, questi dibattiti intorno
al realismo nascono e si animano soprattutto in seno alle comunità intellettuali della sinistra politica.
Per rispondere alle ultime questioni sollevate, però, sarà bene operare un’apparente deviazione.
Recentemente, mi è capitato di essere impegnato nella stesura di un articolo per una rivista di filosofia, che
dedicherà un monografico al tema del “tempo e temporalità storica” – altro tema immenso. Nell’approcciare la
questione ho iniziato con un passo dall’inizio di una favola del Pentamerone di Basile, in cui si narra di un
fantomatico re di un’altrettanto fantomatica località, Rocc’Aspra, impegnato in un giuramento sul letto di morte
della moglie e per non contravvenire a esso egli penserà bene di prendere in moglie la sua stessa figlia. Questo
fantasioso esordio di una favola,che lascia prefigurare l’ipotesi di una vicenda incestuosa (che nell’iter narrativo
sarà scongiurata, non avendo, così, alcun esito), contiene un piccolo dettaglio, quasi insignificante (per noi, oggi).
Nel profferire il giuramento all’amata consorte morente, il re le promette, pena l’essere fatto come Starace,
appunto di non sposare nessun altra donna che non sia bella almeno quanto lei. Giovan Vincenzo Starace, a cui è
intitolata una strada, fu un uomo pubblico, eletto del popolo della città di Napoli, durante la dominazione
spagnola, che la mattina del 9 maggio 1585 fu ucciso, brutalmente linciato, da una folla inferocita che ne fece a
pezzi il corpo e ne consumò, mangiandone pure, alcune sueparti.
Come si vede chiaramente, Basile trasfigurava in fiaba la realtà a lui coeva, i cui eventi finivano per costituire
gli elementi di un corredo narrativo di evidente matrice fantastica. Tout se tient: particolari prelevati dalla cronaca
di quegli anni e di cui lo scrittore, ancora giovane, era stato probabile testimone (diretto o indiretto) finiscono
nella trama narrativa per essere combinati assieme a circostanze assolutamente fantastiche animate da maghi,
fate, streghe, animali fatati, regnanti e località immaginarie, in un tutto la cui ragione ultima sembra essere quella
della costruzione di un’unità narrativa coerente. Coerente rispetto a cosa? Rispetto evidentemente a una
plausibilità che non ha nulla a che vedere con un’idea di realtà, quanto piuttosto con un’idea di possibilità
(“l’impossibile credibile” di Vico). A questo livello, l’arte non riproduce nulla, non riflette nulla, non rappresenta
nulla di reale che non sia pure contemporaneamente immaginato, fantastico.
Già Aristotele, nella Poetica, nell’evidenziare i caratteri della poiesis, aveva fatto notare come questa fosse più
seria e filosofica della storia (1451 b 5), perché mentre questa è necessariamente legata al corso degli eventi,
7
dovendo riportare, oggettivamente, i particolari delle vicende realmente accadute, quella, invece, anche quando
raccontava di personaggi storici, finiva per trasfigurarne i tratti elevandoli così a una dimensione universale, a
partire dalla quale non solo poteva verificarsi quel meccanismo dell’identificazione, che tanta parte ha nella
dinamica della catarsi, ma soprattutto personaggi e tratti, trascesi dal qui e ora particolare (storico), venivano a
ricomprendersi nella dimensione del possibile, appunto, ovvero dell’eterna-mente sul punto di realizzarsi. L’arte
(la poiesis), dunque, come forma creativa per eccellenza, diventa azione politica nel senso più pieno e autentico
del termine, nel senso cioè di annunciare mondi futuri – e possibili.
Cosa c’entri tutto questo con un certo vaniloquio di cui si può rinvenire traccia, oggi, sulle terze pagine di
giornali a tiratura locale o nazionale, francamente ho difficoltà a manifestarlo.
Ritengo, infatti, che nel momento in cui non si riconosce più la caratteristica produttiva dell’immagi-nazione
come la componente essenziale del pensiero, si sortisce esattamente l’effetto opposto di quello che si vorrebbe
ottenere: la possibilità di una critica dell’esistente.
Cosa affermano, infatti, gli odierni alfieri del realismo? Che si può (anzi, si deve) affermare l’esistenza di una
realtà là fuori, di cui si rivendica la necessità di un’analisi – e giù fiumi di inchiostro a imbrattare chilometri di
carta per parlare di Babbo Natale o delle contravvenzioni elevate da vigili urbani napoletani piuttosto che svizzeri
o dei cellulari o ancora di Berlusconi e delle sue avvenenti giovani amiche. Perché è chiaro che parlare di questo,
stando ai presupposti di cui sopra, significa parlare di realtà, della vera realtà “là fuori” e quindi significa fare
ontologia, né più né meno, visto che questa è la scienza di ciò che c’è ovvero della realtà oggettiva e basterà
aprire gli occhi per vederla, considerarla, descriverla.
Mi torna alla mente un aforisma di Nietzsche, che inizia con la famosa espressione «O sancta
simplicitas!»,5che leggenda vuole sia pronunciata da Jan Hus, mentre, bruciando sul rogo, videun astante zelante
aggiungere legna alla pira.
Cosa si può ribattere a chi sostiene che esiste una realtà là fuori se non che non si comprende perché, nella
foga di rintracciarla, vada a cercarla tanto lontano?
A me questo, francamente, pare solo un sintomo, ennesimo (se ce ne fosse mai stato bisogno) della deriva
spettacolare in cui siamo tutti oramai trascinati, volenti o nolenti (anche solo come spettatori). Deriva a cui quel
che resta della riflessione filosofica (e si fa per dire) partecipa nella dissoluzione di ogni forma di pensiero.
Deleuze, spesso evocato assolutamente a sproposito da quanti si professano pop-filosofi,6ricordava spesso che
l’esercizio filosofico consisteva nella creazione di concetti. Oggi questo non accade più e credo che sia solo
un’altra modalità di manifestazione del carattere fondamentale del capitalismo attuale, che non è più una forma di
economia produttiva, essendosi trasformata lentamente, ma inesorabilmente, negli ultimi trent’anni, in
un’economia di consumo. Oggi siamo solo capaci di consumare vecchie idee, trite e ritrite, banalizzandole o, che
è lo stesso, fornendone dei surrogati – e, del resto, le riforme del sistema dell’istru-zione, alta formazione in
primis, che si sono succedute nel nostro paese, hanno solo contribuito, appoggiando un andamento al ribasso, a
peggiorare una situazione già di per sé gravissima. «Come abbiamo saputo dare a noi stessi un libero
salvacondotto per ogni superficialità e al nostro pensiero una divina brama di capricciosi salti e
paralogismi!»,7ricorda ancora Nietzsche in quell’aforisma. Già, come abbiamo potuto? Come è potuto accadere
che la pratica della filosofia sia diventata una sorta di barzelletta? Si potrebbe, a tal riguardo, ricordare quello che
diceva Foucault a proposito del sesso: più se ne parla e meno si fa. Oggi ovunque si parla di filosofia. Ovunque è
pieno di festival di filosofia. In ogni trasmissione televisiva che si rispetti c’è come ospite più o meno fisso il
filosofo (che spesso viene proprio identificato da una didascalia con la scritta “filosofo”: cosa che è sempre
trovata tra le più esilaranti), il quale, nella migliore delle ipotesi, se ne uscirà con una banalità avvilente, a
commento di un accadimento di cronaca, per esempio. Per non parlare di quelli che si sono lanciati nelle
consulenze per le aziende. Pure on line è possibile vedere dei video tristissimi di accademici italiani, che cercano
di giustificare il loro essere lì, come consulenti aziendali, a sostegno di una produttività ovvero di un «uso» più
«umano degli esseri umani» (Wiener), che vuol dire solo «un uso più redditizio…».
Una volta tutto questo aveva un nome ben preciso, si chiamava sofistica.
La filosofia è altro. Essa è prima di tutto una tensione e un esercizio infiniti. Non arrivano a un punto, come
invece deve necessariamente una critica, per esempio. La filosofia, quando è dialettica autentica (esercizio
5
Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia dell’avvenire (1886), aforisma 24, tr. a cura di F. Masini, in F. Nietzsche, Opere, a
cura di G. Colli e M. Montinari, vol. VI, tomo II, Adelphi, Milano 19864, p. 31.
6
Fin da Differenza e ripetizione, Deleuze afferma la necessità di un esercizio filosofico (di storia della filosofia, in particolare) che
recuperi la tecnica del collage impiegata nelle arti visive, facendo esplicito riferimento alla pop art (detta anche New Dada). Tecnica del
collage, ready made ecc. È evidentemente alle avanguardie artistiche e a Duchamp in particolare (a cui pure Warhol e compagni si
richiameranno, identificandosi sotto l’etichetta di nuovo dadaismo, appunto) che Deleuze si riferiva, visto che in quello stesso volume
richiamerà l’immagine di una Gioconda coi baffi. Ora, cosa abbia a che vedere un libro sulla filosofia di una serie di cartoni animati con
questo che scrive Deleuze, francamente, pure mi risulta assai difficile da comprendere.
7
Al di là del bene e del male, cit., p. 31.
8
dialettico), può (anzi, deve) osare di non scegliere (e rovinare, troppo precipitosamente, verso una conclusione) e
continuare, invece, ancora, come accade nei migliori dialoghi platonici (in tutti, a ben guardare), per esempio.
Ma per fare questo, il primo passo, che si deve compiere, non sarà in direzione della realtà, là fuori, ma di
quella piuttosto che comincia un millimetro sotto la mia stessa pelle.
9
SI FA PRESTO A DIRE “REALISTA”.
PER IL REALISMO SOCIALE1
Gian Paolo Terravecchia
1. Ci sono ancora dei realisti, anzi no, anzi forse
Il Novecento, raccogliendo a modo suo l’eredità antirealista dell’idealismo ottocentesco, può qualificarsi nel
complesso come un secolo avverso al realismo. Il postmoderno e il costruttivismo, due delle creazioni più
originali del secolo, si sono opposti al realismo in maniera radicale e sistematica. Persino la fenomenologia che
sembrava programmaticamente realista, col motto “tornare alle cose stesse”, prese invece presto un indirizzo
idealista. Se a tutto ciò si aggiunge che lo scetticismo e il relativismo sono state due presenze influenti, con
consolidata vocazione antirealista, si ha un quadro complessivo abbastanza chiaro dell’eredità con cui fare i conti
oggi. Perciò, la recente comparsa sulla scena del nuovo realismo è un fenomeno interessante, in controtendenza
rispetto alla tradizione novecentesca e consapevolmente di rottura.2
È ormai da più di un anno che assistiamo in Italia, ma non solo, a un dibattito intenso, a tratti duro, tra
postmoderni e fautori del nuovo realismo.3 A vederlo da lontano, sembrerebbe che la battaglia si svolga tra due
fronti ben distinti: quello che nega la realtà e si perde intenzionalmente nei giochi di un’ermeneutica senza
vincoli, fatta di rimandi, differimenti e ironia leggera e quello che invece è fedele ai fatti, si impegna
responsabilmente ad agganciare le interpretazioni ai documenti e alle iscrizioni e con ciò sta alla realtà. Guardato
il dibattito un po’ più da vicino, questa contrapposizione netta si sfuma di molto, forse perché i due gruppi hanno
rotto i ranghi e sono ormai entrati in mischia. I postmoderni, con Pier Aldo Rovatti, osservano che è troppo
semplicistico che si faccia di loro dei negatori dell’evidenza 4, mentre i fautori del nuovo realismo, con Maurizio
Ferraris, mostrano per alcuni importanti aspetti una continuità col postmoderno. Egli, ad esempio, sottolinea che
il nuovo realismo tiene ferma l’istanza decostruttiva e che non è affatto antiermeneutico.5 Come stanno dunque le
cose? I nuovi realisti sono davvero ciò che dicono di essere? E che dire della realtà sociale, uno dei temi di punta
del nuovo realismo? Si può difendere il realismo sociale?
In quanto segue, cercherò di rispondere alle domande appena sollevate. Lo farò in due tappe. In primo luogo,
dimostrerò che il nuovo realismo, o almeno due tra i suoi autori più rappresentativi e propositivi (Maurizio
Ferraris e Markus Gabriel), sostengono un realismo minimale e, a un certo punto, diventano persino antirealisti e
lo sono proprio quando meno ce lo si aspetterebbe. In secondo luogo, per non lasciare i cultori del realismo
sociale a bocca asciutta e disillusi, proverò a formulare un argomento a favore del realismo sociale (ma non un
argomento realista). Si tratta di un argomento leggero, forse è il più leggero tra quelli che un realista può
proporre.
2. Ma in realtà, cos’è il realismo?
Il realismo in filosofia vanta una tradizione antica, ricca, autorevole e variegata già da Platone e Aristotele.
Questo fatto ha però finito col complicare le cose. Su cosa si impegna il realista? Sull’esistenza del mondo delle
idee? Sull’esistenza del mondo fisico? Sull’esistenza dei numeri? Su quella degli universali? Che non sia facile
intendersi quando si parla di realismo lo si capisce presto: basta aprire un lessico della filosofia. Prendendo in
mano Le parole della filosofia contemporanea, dopo la voce “Realismo” si trovano Realismo critico, Realismo
etico, Realismo moderato, Realismo scientifico e Realismo strutturale, i quali rimandano ad altre undici voci per
approfondimento, tra esse spicca “Antirealismo”.6 A volte succede che autori che si presentano come realisti, in
effetti non lo siano. L’esempio più noto è quello che riguarda, per una fase del suo pensiero, Hilary Putnam.
Questi ha qualificato come “internalismo realista” la sua riflessione maturata in seguito all’abbandono del
realismo metafisico. Senonché, l’internalismo realista era tutto tranne che una posizione realista, come lo stesso
1
Desidero ringraziare Paolo Del Pozzo, Enrico Furlan, Luca Illetterati per gli acuti commenti mossi a versioni preliminari del presente
scritto.
2
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari, Laterza, 2012.
3
Per una rassegna, cfr. il sito di Gianni Vattimo: http://giannivattimo.blogspot.it/2011/09/pensiero-debole-o-nuovo-realismo-mini.html e
quello, aggiornato, del Labont: http://labont.it/rassegna-nuovo-realismo.
4
Cfr., ad esempio, P.A. Rovatti, Inattualità del pensiero debole, Udine, Forum, 2011.
5
Cfr. Presentazione. Sistema dell’iper-realismo trascendentale, in M. Gabriel, Il senso dell’esistenza. Per un nuovo realismo ontologico,
Roma, Carocci, 2012, pp. 9-17.
6
Cfr. L. Floridi, G.P. Terravecchia (a cura di), Le parole della filosofia contemporanea, Roma, Carocci, 2009. La scelta del testo si
giustifica col fatto che si tratta del lessico italiano al momento più aggiornato. La lista presentata peraltro non pretende di essere esaustiva:
si sarebbero potuti aggiungere anche, tra l’altro, Realismo metafisico, Realismo interno, Realismo pragmatico, Realismo ingenuo. Si noti,
infine, che per motivi di leggibilità non ho virgolettato tutte le voci.
10
Putnam ha poi riconosciuto, abbandonando anche questo. 7 Prima che il lettore disperi, è ormai tempo di
guadagnare una definizione, in positivo, che aiuti a fissare i termini del discorso e orienti la discussione che
seguirà.
Detto in prima approssimazione per realismo si intende la tesi secondo cui:
R
1. Esiste un mondo (M) indipendente dal mentale.
A cosa ci si riferisca in R, con M lo si specificherà di caso in caso. Per fare alcuni esempi, i realisti etici ritengono
che si tratti del mondo dei valori e dei principi etici; i realisti finzionali riterranno che a essere reale sia il mondo
dei ficta (per esempio Gandalf il bianco e Harry Potter). Tipicamente il realismo riguarda l’esistenza del mondo
fisico di esperienza quotidiana. Naturalmente, si può essere realisti in un ambito e non in un altro. Una prima
variante di rilievo, anche per quanto andrò a discutere, è il realismo epistemico. Esso si formula in due tesi:
RE
1. Esiste un mondo (M) indipendente dal mentale.
2. M è conoscibile.
In senso stretto, 2., che è una tesi epistemica, non è necessaria per parlare di realismo, che è una tesi ontologica.
Spesso però, come vedremo, le considerazioni ontologiche si mescolano a quelle epistemiche nelle discussioni
sul realismo.
Una seconda variante di R è il Realismo forte:
RF
1. Esiste un mondo (M) indipendente dal mentale.
3. M è strutturato.
RF è una tesi ontologica che si può far interagire con RE in almeno due modi: si ritiene di ottenere 3. dalla
applicazione di RE (si può dire che M è strutturato perché, essendo esso conoscibile, ne conosciamo la struttura),
oppure si ritiene di ottenere 2. da RF (si può dire che M è conoscibile, perché, essendo strutturato, lo possiamo
conoscere – se il mondo fosse una realtà blob ci resterebbe inintellegibile). Si tratta di opzioni teoretiche che si
possono anche integrare nel modello di un processo di reciproco adattamento.8
Abbiamo ora tutti gli elementi di base per affrontare alcune delle tesi centrali dei nuovi realisti e per vagliare cosa
essi intendano quando si definiscono tali.
3. I tre argomenti di Markus Gabriel contro l’esistenza del mondo
Il filosofo tedesco Markus Gabriel svolge tre argomenti a favore della tesi che il mondo non esiste. Può
sembrare un approccio strano in un filosofo che propone un “nuovo realismo ontologico”. A dire il vero, Gabriel
non intende negare in assoluto l’esistenza reale di qualcosa, ma intende “solo” che il mondo come totalità non
esiste. Anche così dettagliata, la sua posizione resta comunque bizzarra (se, come lui fa, si ammette il darsi di
qualcosa sembrerebbe che con ciò si debba ammettere anche il darsi della sommatoria di ciò che si è appena
ammesso esistente). Ad ogni modo, vediamo i suoi tre argomenti. Si tenga presente che l’espressione “campo di
senso” è usata dall’autore come sinonimica di “mondo” e sembra parafrasabile con “contesto di significanza”. 9
Il primo argomento prende le mosse dall’ipotesi che ogni esistenza sia relativa a un campo di senso: ogni
campo di senso, per esistere, dovrebbe apparire in un campo di senso; ma allora questo nuovo campo di senso
sarebbe più comprensivo del precedente e a sua volta lo sarebbe meno di quello che lo comprende. Continuando
così ne segue una forma di regresso ad infinitum.
Il secondo argomento dipende dalla vaghezza “della maggior parte dei campi di senso”. La tesi è che i campi
di senso non sono numerabili, non sono entità o elementi, alcuni di loro dipendono dalla vaghezza intrinseca
dell’ambito a cui si applicano. Perciò la formazione di un campo di senso onnicomprensivo presuppone
7
Per una ricostruzione cfr. S. Brock, E. Mares, Realism and Anti-Realism, Stocksfield, Acumen, 2007, pp. 60-77.
Per questa distinzione tra R, RE e RF sono largamente in debito con M. Soavi, Antirealismo e Artefatti. Sui limiti della natura, Milano,
FrancoAngeli, 2009.
9
M. Gabriel, Il senso dell’esistenza. Per un nuovo realismo ontologico, Roma, Carocci, 2012, pp. 50-51.
8
11
un’operazione che non può essere svolta. Ciò che dovrebbe essere riunito in unità è intrinsecamente sfuggente,
indeterminato: “Non può essere ritrovato un algoritmo che dia conto di tutte le cose”.10
Il terzo argomento prende le mosse dall’osservazione che ogni campo di senso ha proprie regole costitutive in
numero indefinito. Non vi è alcuna regola universale che le raccolga in unità, con un’unica eccezione
(“paradossale universalità”): “l’unica verità ontologica universale è che nessuna verità ontologica universale può
essere formulata, senza eccezioni”.11
Espressi con altre parole, gli argomenti di Gabriel sono (1) che M non è conoscibile, perché ogni tentativo di
definirlo fallisce in un regresso ad infinitum; (2) che M non è conoscibile, perché l’accesso epistemico a M è
inevitabilmente insoddisfacente per via di una sua vaghezza strutturale; (3) che a M non non è applicabile alcuna
regola universale, eccetto quella che stabilisce che non vi sono regole universali. I primi due argomenti vanno
palesemente contro RE, mentre il terzo è incompatibile con RF, infatti la paradossale universalità menzionata
dall’autore (“l’unica verità ontologica universale è che nessuna verità ontologica universale può essere
formulata”) non è sufficiente per sostenere neanche in forma limite 3. A prima vista quindi l’autore sembra
rigettare due versioni del realismo. Non sarebbe neanche male, dato che in fondo gli basta R per dirsi a pieno
titolo realista. Egli comunque sembra accettare R solo in una versione leggera. Il realismo di Gabriel non
rinuncia, come potrebbe sembrare, a M, ma lo riduce a singoli ambiti in cui gli eventi particolari si inquadrano in
una prospettiva di senso. Insomma, in Gabriel il realismo è difeso nella versione base R, ma si tratta di una
versione indebolita da una interpretazione minimale di M come ambito contestuale fra altri. Tale debolezza di
base si traduce poi in una generosità nelle conseguenze: per Gabriel esistono tanto tavoli e sedie, quanto il
flogisto, Harry Potter e il quadrato rotondo. A chi fatichi a mandare giù gli ultimi tre e in particolare l’ultimo,
Gabriel chiarisce che esso è presente nel campo di senso dell’impossibile e perciò esiste.12 L’ontologia di Gabriel
diventa dunque, improvvisamente, popolosa proprio mentre nega cittadinanza al mondo come totalità.
Il limite serio del realismo di Gabriel sta nel tentativo dell’autore di difendere quello che egli stesso chiama
“idealismo senso-dipendente” e che chiarisce nei termini seguenti: “L’idealismo senso-dipendente afferma che
l’esistenza implica l’intelligibilità. In questo contesto, interpreto l’’intelligibilità’ come l’apparire in un campo di
senso e sostengo che questo è sufficiente per l’esistenza”. 13 La curvatura soggettivista che qui l’ontologia di
Gabriel assume è tale da tradire le promesse realiste che l’impresa si prefiggeva. “Apparire”? A chi se non a un
soggetto? Quella di Gabriel non è una forma di RE, perché in RE 2. accompagna 1., non lo assorbe.
L’intelligibilità poi è un pessimo criterio per fissare una ontologia: a chi deve essere intelligibile? Il concetto di
intelligiblità richiede una dipendenza da qualche tipo di soggetto intelligente, almeno in qualche grado. Questo
però è proprio il punto che il realismo rifiuta. Inoltre, chi fissa i campi di senso? La stessa nozione di senso è una
nozione intenzionale, incomprensibile se non in riferimento a una mente. Così, una mente che fissi i campi di
senso, fissa, per quanto dice Gabriel, anche ciò che esiste. Ne segue che ciò che esiste finisce col dipendere
ontologicamente dalla mente. In effetti questa è una posizione idealista, peccato che non sia compatibile con R. Il
“nuovo realismo ontologico” di Gabriel, insomma, si rivela la riformulazione aggiornata del vecchio idealismo,
almeno per come questo è ordinariamente interpretato.
4. L’antirealismo di Maurizio Ferraris
A Maurizio Ferraris si devono, oltre a una meritoria opera di divulgazione della filosofia sociale in Italia,
alcuni sviluppi originali e importanti in quest’ambito. Egli si presenta in Italia, ormai da anni, come un esponente
del realismo e il suo Manifesto del nuovo realismo sembra una prova documentale inconfutabile che egli lo è
davvero. L’autore stesso fornisce una sintesi del proprio percorso e presenta il proprio contributo nei termini
seguenti: “L’elaborazione del realismo è infatti stata il filo conduttore del mio lavoro filosofico dopo la svolta
che, all’inizio degli anni Novanta dello scorso secolo, mi ha portato ad abbandonare l’ermeneutica, per proporre
una estetica come teoria della sensibilità, una ontologia naturale come teoria della inemendabilità e infine una
ontologia sociale come teoria della documentalità”.14 Il realismo dell’autore, da queste parole, sembra riguardare
tanto l’estetica, quanto l’ontologia naturale, quanto infine l’ontologia sociale. Vedremo però che le cose sono solo
in parte come l’autore le presenta.
È vero che Ferraris, diversamente da Gabriel, è coerentemente realista. Il suo realismo però riguarda
l’indipendenza dal mentale della sola realtà fisica della quale egli richiama il carattere di inemendabilità. Per
capire il suo pensiero riprendo dall’autore stesso un paio di esempi piani. In primo luogo, quale che sia lo schema
10
Ivi, p. 51.
Ibidem.
12
Ivi, p. 107.
13
Ivi, p. 64.
14
Ferraris, Manifesto cit., pp. x-xi. Cfr. anche l’entrata Maurizio Ferraris in D. Antiseri, S. Tagliagambe, Filosofi italiani contemporanei,
Milano, Bompiani, 2009, pp. 226-235.
11
12
concettuale che abbiamo quando pensiamo al fuoco, vuoi come fenomeno di ossidazione, vuoi come esito del
flogisto, oppure del calorico, resta il fatto che a metterci le mani nude sopra ci si scotta.15 Allo stesso modo vanno
le cose con la fisicità di una ciabatta: con essa dovranno fare i conti coloro che vi entreranno in contatto, tanto che
gli schemi concettuali li abbiano (se sono esseri umani), quanto che non li abbiano (se sono cani, vermi, edere o
altre ciabatte).16 Insomma, la realtà del mondo fisico ci resiste, talvolta ci contrasta, non dipende dai nostri schemi
concettuali. Ferraris non si limita a sostenere il proprio realismo con argomenti in positivo, ma attacca
frontalmente il postmoderno, denunciandone una serie di fallacie con un argomentare serrato, efficace, che
purtroppo non ho modo qui di riprendere. L’autore, dunque, accoglie R e lo difende per quanto riguarda la realtà
fisica “di taglia media”, per ciò che riguarda tavoli, sedie, falò e ciabatte, ma anche per gli eventi del passato: tutti
inemendabili.17
Il contributo più originale Ferraris non lo dà tanto criticando il postmoderno, quanto attraverso la teoria
sociale che egli ha sviluppato nel corso di molti anni e che ha raccolto sistematicamente nel suo Documentalità.18
L’autore ha sviluppato una teoria dei documenti, ponendola al centro della realtà sociale. Anche leggendo le righe
di autopresentazione che ho citato a inizio paragrafo ci si aspetterebbe di trovare in Ferraris, nell’ambito della
filosofia sociale, un difensore del realismo.19 Le cose però non stanno così, come cercherò ora di mostrare. In
primo luogo va preso atto che gli oggetti sociali, per Ferraris, esistono nello spazio e nel tempo dipendentemente
dai soggetti.20 In secondo luogo, Ferraris sostiene che la realtà sociale esiste solo perché ci sono soggetti che
hanno un accesso epistemico a essa. Egli, ad esempio, scrive: “cose come i matrimoni o i debiti esistono solo
perché ci sono persone che sanno che esistono”.21 Ciò al punto che, se tutti i soggetti perdessero irreversibilmente
memoria dei fatti sociali, stando a Ferraris, quei fatti sociali cesserebbero di esistere.22
Ora, sostenere quanto segue: 4. L’esistenza della realtà sociale dipende rigidamente dal fatto che dei soggetti
la conoscono, è una professione di antirealismo in ontologia sociale. In altre parole, contraddice R. Se poi si
avesse ancora qualche dubbio, si veda il passo in cui l’autore scrive: “c’è l’enorme categoria degli oggetti sociali
che non potrebbero esistere se non ci fossero soggetti che pensano che esistono”.23 L’esistenza degli oggetti
sociali, dice insomma Ferraris, dipende dal mentale. Detto con una parola: antirealismo. Del resto, lo stesso
Ferraris quando deve chiarire la propria posizione la qualifica in un modo che si presenta come un antirealismo
consapevole: “Quello che propongo sotto il titolo di ‘documentalità’ è così un ‘testualismo debole’ (cioè anche un
‘costruzionismo debole’): debole in quanto assume che le iscrizioni siano decisive nella costruzione della realtà
sociale”. 24 Se il lettore, trasalendo, crede di aver trovato un aggancio per il realismo nella fisicità delle iscrizioni,
si tranquillizzi: per Ferraris iscrizioni sono anche le tracce mnestiche “nella testa delle persone”. Anzi,
ultimamente tutto dipende dalla memoria, come fenomeno mentale, anche se Ferraris non vorrebbe ammetterlo.
Egli infatti insiste che si tratta anche di una documentalità fisica: “Carta canta”! Però un tale canto resterebbe
inascoltato, secondo il discorso dell’autore, se non ci fossero delle menti che ne prendono coscienza e anzi esso
non ci potrebbe essere perché non c’è ontologia sociale se nessuno pensa che ci sia, stando a Ferraris. Dunque la
mente dei soggetti è ciò da cui l’esistenza degli enti sociali ultimamente dipende.
Chiarito l’antirealismo di Ferraris circa la realtà sociale viene da osservare che in fondo non è che essere
realisti sia necessariamente meglio che non esserlo. Il punto importante è se la posizione dell’autore tiene. Per
una serie di motivi, ritengo di no. Vediamoli.
Per distinguere tra eventi fisici, come le malattie, ed eventi sociali, come i matrimoni, Ferraris sostiene che se
non sappiamo di essere malati, la malattia segue comunque il suo corso, mentre se non sappiamo di essere sposati
“è esattamente come se non lo fossimo”.25 Il punto è che “come se” non è “è”. Che due persone si comportino
come se non fossero sposate, non significa che non lo siano. Qui Ferraris è vittima dell’idea di Searle che la realtà
sociale è un come se, “conta come”: un’idea che porta alla confusione tra realtà sociale e finzione. Un medico
15
Ivi, pp. 30, 50.
Ivi, pp. 39-43.
17
Ivi p. 67.
18
M. Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 2009.
19
L’equivoco poteva già generarsi leggendo alcuni passi in Documentalità. Eccone ad esempio uno: La filosofia che propongo è una
metafisica descrittiva di impianto realistico che mira a rendere conto del mondo sociale e della esperienza quotidiana, cioè di quel mondo
che esula dall’ambito delle scienze naturali» (p. 358).
20
Cfr. ad esempio Ferraris, Manifesto cit., p. 71.
21
Ivi, p. 72.
22
Cfr. p. 67.
22
Cfr. Ferraris, Documentalità cit., p. 258.
23
Ferraris, Manifesto cit., p. 83. Non si tratta di un passo isolato, magari di un’idea mal espressa. La stessa tesi era già formulata nel già
citato Documentalità: «gli oggetti sociali stanno nello spazio e nel tempo dipendentemente dai soggetti», “Nel mondo degli oggetti sociali,
invece, la credenza risulta determinante dell’essere, nel momento che questi oggetti sono dipendenti da soggetti” (pp. 358, 359).
24
Ivi, p. 75.
25
Ivi, p. 73.
16
13
impostore si comporta come se fosse un medico. Accettiamo una banconota falsa come se fosse vera, ma
scopertolo ce ne pentiamo perché non è vera: la confusione del come se con l’è ha dei costi. Nella realtà sociale
non tutto è un come se, anzi lo è nel complesso poco e, verrebbe da aggiungere, per fortuna.
Ferraris è anche vittima di una comprensione troppo semplicistica del dipendere. Egli infatti è pronto ad
accettare che banconote, titoli di studio, debiti, premi e punizioni dipendano dai nostri “schemi concettuali”. Ci
sono dei sensi del termine “dipendere” in cui Ferraris ha ragione: quelle realtà sociali sono state generate a partire
da “schemi concettuali”, accettando per semplicità il suo modo di esprimersi. Però questo non basta a dire che
banconote, titoli, etc. per il loro essere sono dipendenti dai nostri “schemi” ed è questo il punto in questione. Non
ogni volta che un X dipende da un qualche Y, X è ontologicamente riducibile a Y. Se non fosse così, aveva
ragione quella mamma arrabbiata, interpretata dal comico Andrea Roncato, che minacciava il proprio figlio
dicendo: “stai attento che come t’ho fatto, ti disfo”. Senonché la dipendenza storica del figlio dalla madre
(fingiamo di dimenticarci dei padri, per farla semplice) non è una dipendenza capace di determinare l’ontologia.
Le automobili dipendono dai progetti degli ingegneri, dal lavoro degli operai e da tante altre cose ancora, però le
automobili, lo riconoscerebbe anche Ferraris senza difficoltà, hanno una propria consistenza ontologica. Allo
stesso modo banconote, titoli di studio, etc. dipendono per certi aspetti da “schemi concettuali”, ma per la propria
consistenza ontologica sono autonomi da essi. Ed è proprio questo il punto in questione: l’autonomia ontologica.
Ferraris insomma coglie che la realtà sociale ha una propria consistenza resistente. Con grande efficacia, ad
esempio, scrive: “la società è tutt’altro che liquida: è fatta di oggetti come le promesse e le scommesse, il denaro
e i passaporti, che spesso possono essere più solidi dei tavoli e delle sedie, e dai quali dipende tutta la felicità e
l’infelicità delle nostre vite”.26 Egli però non sa spiegare perché sia così, dato che il suo costruzionismo debole
non gliene fornisce gli strumenti. 27 In ogni caso, questa sua intuizione resta slegata dalla sua teoria sociale
antirealista.
5. Un argomento trascententale a favore del realismo sociale
In quanto segue prenderò posizione a favore del realismo sociale: svolgerò un argomento trascendentale, cioè
un argomento teso a mostrare che il realismo è la condizione della possibilità del sociale. Il realismo sociale è ciò
senza del quale la socialità diventa impossibile. Ecco dunque la tesi: il realismo è una condizione della possibilità
della ragion pratica sociale. Infatti, non c’è socialità se non a partire dal riconoscimento da parte dell’agente
sociale di agenti ed enti sociali da lui indipendenti. Ogni agente sociale, per potersi dire tale e per poter agire in
quanto tale, deve necessariamente assumere il realismo. In questo senso, l’argomento mostra il realismo come un
postulato, come una condizione necessaria per il darsi dell’agire sociale e di qui della realtà sociale tutta. 28 Vi
sono alcune considerazioni a sostegno di quanto detto. Quelle che tratterò di seguito riguardano l’agentività, il
darsi di obblighi sociali che stabiliscono la struttura di legame e, infine, la stessa possibilità di un agire giusto.
Vi sono due condizioni necessarie e insieme sufficienti per qualificare un agente come sociale.29 La prima è
che l’agente, in condizioni normali, sia capace di riconoscere gli agenti che entrano nell’ambito della sua
esperienza. La seconda condizione necessaria prevede che l’agente sia capace di agire secondo una intenzionalità
collettiva. Egli, per questa seconda condizione, deve poter compiere azioni nelle quali agisce consapevolmente
come parte di un “noi”. Un essere umano affetto da una forma gravissima di autismo sarebbe incapace di
realizzare le due condizioni dette e perciò sarebbe strutturalmente incapace di socializzare. Il riconoscimento
dell’altro come agente comporta il riconoscimento dell’indipendenza, dell’autonomia dell’altro, della sua
capacità di agire secondo finalità proprie e di cooperare in azioni comuni. Non c’è agente sociale se non c’è
capacità di riconoscere l’altro come autonomo e capace di cooperare, ma questo non può darsi se non in un
quadro realista.
Un agente non realista in ambito sociale non è in grado di riconoscere l’irriducibilità delle obbligazioni
sociali. L’obbligo è intrinsecamente altro dalla mente dell’agente obbligato. Questo assicura l’oggettività del
vincolo, altrimenti il foro interno dell’agente sociale obbligato sarebbe sufficiente per sciogliere questi dal
vincolo. In un universo abitato da un solo agente sociale non si possono generare nuovi obblighi (ovviamente
26
Ivi, p. 76.
Ferraris avrebbe bisogno almeno di una teoria dell’istituzionalità realista e di una teoria dell’emergenza. Purtroppo qui non posso
sviluppare ulteriormente questi punti e non mi resta che rimandare al mio Il legame sociale. Una teoria realista, Napoli, Orthotes, 2012, di
imminente pubblicazione.
28
Faccio qui, da filosofo sociale, qualcosa di analogo a quanto John Searle fa, da filosofo del linguaggio, nel paragrafo
“Un’argomentazione ‘trascendentale’ per il realismo esterno”, nel suo primo libro di filosofia sociale: J.R. Searle, The Construction of
Social Reality, New York, Free Press-Harmondsworth, Penguin, 1995; trad. it. di A. Bosco, La costruzione della realtà sociale, Milano,
Edizioni di Comunità, 1996, pp. 205-213. Le conclusioni che qui raggiungo sono però più forti di quelle di Searle, perché il realismo per il
quale il filosofo americano argomenta riguarda il mondo esterno, mentre io qui argomento per un realismo che riguarda oltre al mondo
esterno, anche almeno alcuni enti sociali.
29
Per una discussione più approfondita di agente e di agente sociale cfr. Terravecchia, Il legame sociale cit., pp. 96-103.
27
14
possono essercene di superstiti dal tempo, se c’è stato, in cui quell’universo era più popoloso). Ora, senza
obblighi sociali non può costituirsi alcuna struttura sociale, essendo che i legami sociali sono costituiti di
obbligazioni tra gli agenti sociali legati reciprocamente.
Una condizione necessaria per la realizzazione della giustizia sociale è l’equità, dato che una giustizia
strettamente vincolata al dettato astratto del codice finirebbe prima o poi per venire meno, essendo proprio essa la
causa di gravi ingiustizie (summum ius, summa iniuria). L’equità, cioè l’applicazione dello spirito della norma
tenendo conto della peculiarità della circostanza, comporta, quando del caso, il riconoscimento dell’agente
sociale come indipendente, autonomo e tale da diventare il destinatario di atti rivolti proprio a lui.
Insomma, senza realismo non vi sarebbero agenti sociali; se però anche ve ne fossero, non si potrebbe
costituire alcuna società; ma se anche se ne potesse costituire una, essa non potrebbe ambire alla giustizia. Il
realismo, in ambito sociale, è la condizione della possibilità del darsi della realtà sociale stessa. Negarlo, magari
in una conferenza o in un seminario di ricerca, è compiere qualcosa di analogo allo scrivere frasi come: “questo
enunciato non è composto da otto parole”, oppure “non vi sono enunciati che abbiano senso”. Detto in sintesi, si
tratta di contraddizioni performative: a ciò è condannata ogni negazione teorica del realismo in ambito sociale.
Una negazione che fosse anche pratica, se davvero fosse implementabile su scala globale, porterebbe alla
disgregazione della realtà sociale. Ma non c’è da temere: la realtà sociale dispone di forti meccanismi di
autodifesa, il primo dei quali consiste nel non prendere sul serio nella pratica l’antirealismo sociale.
6. Tre obiezioni e rispettive risposte
Qualcuno, non senza malizia, potrebbe provare a rimproverarmi di non essere un realista, mentre dico di
esserlo. Si potrebbe infatti osservare che dimostrare l’impossibilità pratica di rinunciare al realismo, non comporti
la verità del realismo. Un argomento trascendentale, detto altrimenti, non è un argomento che scenda sul campo
della realtà. Esso, piuttosto, resta alle condizioni della possibilità, senza compromettersi con l’ontologia.
Rispondo riconoscendo di buon grado che l’argomento trascendentale non è di per sé sufficiente a fare di chi lo
sostiene un realista quanto alla concezione della realtà (anche se l’argomento mostra che sul piano pratico tutti lo
sono). D’altra parte il semplice fatto che io abbia sostenuto tale argomento a maggiore ragione non fa di me un
antirealista. L’argomento trascendentale è a favore del realismo, ma effettivamente non è un argomento realista.
Esso è il modo più debole, ma anche direi il più solido, per mostrare che non è seriamente possibile mettere in
discussione il realismo sociale senza cadere in contraddizione. Così, se realista è colui che argomenta a favore del
realismo (e non necessariamente colui che usa argomenti realisti), allora non vedo come si possa negare che io sia
realista.
La seconda obiezione si insinua in uno spiraglio lasciato aperto dalla discussione della prima. Lì avevo
ammesso che l’argomento trascendentale di per sé non impegna chi lo sostiene a favore di un realismo ultimo
circa la costituzione della realtà. Dovevo ammetterlo perché questo è il limite di ogni argomento trascendentale.
Senonché, sembra che qualcuno possa assumere una posizione tale che, mentre sul piano della sua filosofia
pratica abbraccia il realismo (e non può che essere così, come ci assicura l’argomento trascendentale), sul piano
teoretico lo rifiuti. Si può insomma pensare che tutti abbiamo bisogno di un inganno collettivo per stare insieme e
interagire e che però non si tratti che di un inganno, per quanto necessario. Insomma, quello che in una teoria di
primo livello ho mostrato essere un realismo necessario, potrebbe entrare in crisi in una teoria di secondo livello.
Il problema è che ammettere una tale teoria di secondo livello compromette il realismo di primo livello. Perciò
l’argomento trascendentale interviene qui nuovamente, bloccando ogni forma di antirealismo di livello superiore
al primo, dato che esso con un effetto a cascata renderebbe il primo livello antirealista. Questa considerazione
non è stringente se si pone semplicemente sul piano ontologico, ma è un requisito pragmatico che ha una
notevole forza, almeno fino a che non vengano esibite ragioni cogenti a supporto della teoria antirealista di
secondo livello.
Una terza obiezione che mi si può muovere riguarda il tipo di antirealismo messo fuori gioco dall’argomento
trascendentale. Si può infatti osservare che l’argomento neutralizza le forme di antirealismo, sviluppate in una
prospettiva per così dire in prima persona. Esso mostra che tutti gli agenti sociali presi individualmente, che lo
vogliano o no, non possono che essere realisti sociali, pena il loro ridursi al livello delle piante. Questo però non
chiude i conti con ogni possibile forma di antirealismo. Vi è infatti una forma di idealismo che pare compatibile
col realismo qui difeso. Si tratta dell’idealismo alla Berkeley che ritiene che tutto ciò che esiste sia tale perché
pensato da Dio. La mente di Dio, insomma garantisce da un lato la pluralità irriducibile delle soggettività ed
eventualmente l’oggettività degli enti sociali e degli obblighi. Dall’altro lato essa dematerializza la fisicità del
mondo esterno. Se questa obiezione cogliesse nel segno, mostrerebbe che si può essere realisti sociali, senza
essere realisti esterni. In effetti l’argomento trascendentale non ha il potere di andare oltre i propri limiti: esso
riguarda la realtà sociale. Per contrastare l’idealismo di Berkeley si dovranno cercare altrove gli argomenti.
15
L’obiezione dunque consente di cogliere un limite dell’argomento trascendentale sul realismo sociale, un limite
che però esso non ha mai inteso superare e che, in fondo, non ne compromette le conclusioni.
7. Conclusioni
Mi premeva di mettere in guardia il lettore chiarendo gli importanti aspetti antirealisti di alcuni di quegli
autori, oggi molto influenti, che si dicono realisti e che hanno costituito un vero e proprio movimento: il nuovo
realismo. Ho mostrato che il realismo di questi autori, o almeno dei più rappresentativi fra loro, finisce, in un
modo o nell’altro per tradire le aspettative. Il realismo di Markus Gabriel è più una dichiarazione di intenti che
una teoria coerente e sfocia in una forma di idealismo. Il realismo di Ferraris, in confronto è almeno consistente
nel momento in cui accetta la realtà del mondo fisico di taglia media come indipendente dalla mente. La
posizione di Ferraris però, proprio lì ove il contributo dell’autore si fa più significativo e originale, cede al
costruttivismo e abbandona il realismo.
Ho qui svolto e difeso un argomento trascendentale per il realismo sociale. Esso mostra che se non si adottasse
il realismo, non vi sarebbero agenti sociali; se anche ve ne fossero, non si potrebbe costituire alcuna società; e se
anche se ne potesse costituire una, essa non potrebbe ambire alla giustizia. L’argomento svolto ha dei limiti
importanti: esso di per sé non è un argomento realista pur sostenendo il realismo e, soprattutto, da solo non basta
a neutralizzare l’idealismo di Berkeley circa il mondo esterno. Nondimeno, l’argomento trascendentale è
abbastanza solido da mostrare che per la vita sociale non si può non essere realisti, pena la caduta in
contraddizioni pragmatiche o la riduzione al silenzio.
16
ENGINEERING ARCHITECTURE: COME IL VIRTUALE SI FA REALE
Alberto Pugnale
Negli ultimi vent’anni l’impatto del digitale in architettura è cresciuto esponenzialmente, manifestandosi nei
‘BLOB’ informi di Greg Lynn1,come anche nelle cosiddette ‘free-form’ dei NOX2. L’aggettivo ‘free’ identifica
la libertà di generare forme architettoniche a prescindere da ogni principio compositivo, statico o costruttivo, e si
estremizza, ad esempio, nella ‘trans-architettura’ puramente virtuale di Marcos Novak3. Il computer insidia il
lavoro concettuale del progettista come la realizzazione delle sue opere. Attraverso la fabbricazione a controllo
numerico, il ‘file-to-factory’, il gruppo Objectile 4 sfida la produzione seriale dell’industrial design. Così un unico
modello digitale parametrico si concretizza in molteplici variazioni spaziali uniche, sempre nuove.
Già citando questi pochi esempi, probabilmente i più conosciuti tra quelli esposti al Centre Pompidou di Parigi
nel 2003-4, in occasione della mostra “Architectures non-standard” 5 , si evidenzia l’intrinseca difficoltà
nell’inquadrare teoricamente e storicamente l’uso di tecnologie digitaliin architettura.
L’eterogeneità dei progetti sperimentali coinvolti è etichettata dai curatori Zeynap Mennan e Frédéric
Migayrou con il termine ‘non-standard’. Originariamente coniato da Bernard Cache del gruppo Objectile con
riferimento alla fabbricazione a controllo numerico di elementi diversi 6 , cioè non seriali, allo stesso costo
progettuale e costruttivo di quelli comunemente standardizzati, è qui semplicemente usato per richiamare la
natura organica dei lavori esposti7.
Il ‘non-standard’ si presta però a un’interpretazione anche più specifica, che tende a far risaltare le peculiarità
e le diversità dei progetti sviluppati con l’ausilio di computer, ma non ne preclude necessariamente una lettura in
continuità con periodi e movimenti architettonici passati.
Gli approcci di critici e riviste di settore come “Architectural Design”, che invece coniano nuove etichette per
il fenomeno del digitale a un ritmo incessante8, come architettura generativa, evolutiva e il ‘performative design’,
fanno pensare all’informatizzazione come a una pesante massa omogenea catapultata improvvisamente
sull’architettura dal nulla. Sono termini che rivendicano una distanza dal passato e ne ignorano le eventuali
interrelazioni.
L’integrazione di tecniche informatiche nelle varie fasi progettuali e costruttive si radica nell’architettura
stessa passando attraverso i suoi specialismi. Ricerca e innovazione ne scrivono gradualmente la storia. È un
intreccio complesso che attraversa l’ingegneria strutturale e il disegno industriale, ispirandosi a campi
apparentemente lontani dal mondo delle costruzioni, come l’intelligenza artificiale e il cognitivismo.
Alcune brevi storie possono guidarci nell’impresa di sbrogliarlo, mettendo in risalto i dettagli di vicende
originariamente separate, purtroppo sempre più accorpate sotto la generica etichetta ‘digitale’9.
Il Computer-Aided Design (CAD) automatizza il lavoro paziente e preciso della rappresentazione tecnica.Non
si predispone per sua natura a stravolgere le fasi concettuali del progetto, ma facilita e velocizza il flusso di
1
Lynn G., Folds, Bodies & Blobs: collected essays, La lettre volée, Bruxelles, 1998.
Spuybroek L. (Nox), Nox, Thames & Hudson, Londra, 2004.
3
Le più significative pubblicazioni di Marcos Novak sono: Novak M., Next Babylon, soft Babylon, in “Architectural Design”, n°136,
novembre 1998, pp. 20-29; Novak M., Speciazione, trasvergenza, allogenesi: note sulla produzione dell’alien, in Sacchi L., Unali M. (a
cura di),“Architettura e cultura digitale”, Skira, Milano, 2003. Anche in: “Architectural Design”, n°157, maggio-giugno 2002, pp. 64-71;
Novak M., Trasmitting architecture, in “Architectural Design”, n°118, ottobre 1995, pp. 42-47.Disponibile anche all’indirizzo web:
http://www.mat.ucsb.edu/~marcos/Centrifuge_Site/MainFrameSet.html.
4
Il gruppo Objectile è format dagli architetti Bernard Cache e Patrick Beaucé.
5
Migayrou F. (a cura di), Architectures non standard, Centre Pompidou, Parigi, 2004.
6
Cache B., Beaucé P. (Objectile), Vers une mode de production non-standard, in “Architectures non standard”, Centre Pompidou, Parigi,
2003 (pubblicato parzialmente). Traduzione italiana: Verso un modo di produzione non-standard, in ARCH’it, integralmente pubblicato
all’indirizzo web: http://architettura.supereva.com/extended/20040214/index.htm, 2004.
7
Mennan Z., The question of non standard form, in “METU Journal of the Faculty of Architecture”, Vol.25, n°2, 2008, pp.171-183.
8
Vedi ad esempio il recente numero di Architectural Design edito da Rivka e Robert Oxmanv: “The New Structuralism: Design,
Engineering and Architectural Technologies”, luglio 2010.Sul termine ‘performative design’: Oxman R., Performance-based Design:
Current Practices and Research Issues, in “International Journal of Architectural Computing”, Vol.6, n°1. Sul termine ‘digital tectonics’:
Oxman R., Morphogenesis in the theory and methodology of digital tectonics, in “Journal of the International Association for Shell and
Spatial Structures, Vol.51, n°165, pp. 195-205.
9
Franco Purini, ad esempio, tenta una classificazione dell’architettura ‘digitale’ identificandone tre ambiti, tra loro compenetrabili e
sovrapponibili: il primo strumentale, cioè non organico alla concezione progettuale ma puramente di servizio, un secondo creativo,
complementare al precedente, e un ultimo utopico, cioè di pura sperimentazione virtuale.Partendo però da una base così generica, tale
suddivisione diventa anch’essa troppo vaga e non aiuta quindi a comprendere le reali logiche del fenomeno.Il saggio è pubblicato in:
Purini F., Digital Divide, in Sacchi L., Unali M. (a cura di), “Architettura e cultura digitale”, Skira, Milano, 2003. Un testo più specifico è
invece: Picon A., Digital Culture in Architecture, Birkhäuser, 2010.
2
17
lavoro, diffondendosia macchia d’olio negli studi professionali.Acquisito direttamente dal mondo della
meccanica,si colloca cronologicamente agli albori dell’informatizzazione in architettura,ed erroneamente si
tralasciano alcuni importanti tasselli, antecedenti il rilascio dei principali software commerciali datati Ottanta e
Novanta.
Nello studio americano SOM, acronimo di Skidmore, Owings and Merrill, i computer iniziano, infatti, a
popolare il settore amministrativo già negli anni Cinquanta. Nell’arco di un decennio si allargano poi al gruppo
progettuale, che vanta l’acquisto di un IBM-1620 da dedicare a studi strutturali complessi ed energetici degli
edifici.
Architetti e ingegneri messi di fronte a rudimentali calcolatori privi di programmi seppero immaginare, più
liberamente di oggi,come sviluppare una sinergia con i loro nuovi e inseparabili compagni di viaggio.
Col supporto di programmatori ed esperti d’informatica, tra i quali il partner Douglas Stoker, nonché con
accordi direttamente stipulati con IBM, il gruppo di SOM, capitanato da Bruce Graham e dall’ingegnere Fazlur
Khan,concepisce poi negli anni Ottanta un programma denominato Building Optimization Procedure (BOP),
volto all’abbattimento dei costi di costruzione degli edifici.
Concettualmente, è un rozzo predecessore dei software che oggi chiameremmo Building Information
Modeling (BIM) 10, i quali attraverso un unico modello tridimensionale ‘ricco’ d’informazione raccolgono e
gestiscono non solo dati geometrici, ma anche strutturali, energetici e costruttivi dell’edificio, relazionandoli tra
loro e migliorando così l’interazione e il dialogo tra le figure progettuali coinvolte nel processo.
Seppur lontane anni luce da tale definizione, le doti del BOP sono comunque affini ai prodigi dei più recenti
BIM per principio e concezione, ispirandosi e rispondendo direttamente a specifiche esigenze progettuali.
La forza delle grandi case costruttrici non concede a questo e ad altri programmi firmati SOM una lunga
sopravvivenza sul mercato. L’inevitabile vendita a IBM non frena però John Zils, partner associato e attuale
responsabile del gruppo strutturisti di SOM Chicago, di riflettere così su un nodo chiave dell’informatizzazione in
architettura: «Eravamo abituati a crearci da soli il software su misura per quello che volevamo fare… E adesso ci
troviamo a dipendere da altri che fanno le cose per noi e che, naturalmente, non le fanno nel modo in cui noi
vogliamo farle. Ci troviamo sempre a dover valutare i diversi software per trovare quello che si avvicina di più
alle nostre esigenze»11.
L’amore/odio per i computer può in parte ricondursi alla continua presenza di tale tensione, cioè alla naturale
distanza tra il programma ideale, ipoteticamente rilasciato su misura del progettista, e il software commerciale di
massa, che tenta di adattarvisi per quanto possibile.
È il dilemma al centro delle ricerche di Robert Aish, informatico di formazione e specializzato nello studio
dell’interazione uomo-macchina, che, prima in collaborazione con ARUP, poi Bentley, e infine all’interno del
gruppo Autodesk Research, concepisce e sviluppa software specifici per la progettazione architettonica.
Consapevole di come i tradizionali CADautomatizzino i dati progettuali a un livello semantico troppo basso,
avvalendosi di semplici linee, archi e cerchi per supportare il lavoro concettuale dell’architetto, non vuole però
ingabbiare potenziali sprazzi di creatività promuovendo all’opposto, e in maniera altrettanto inefficace,lo
sviluppo di programmi che già forniscono librerie di muri, porte e finestre.
Aish s’interroga quindi sull’esistenza d’invarianti all’interno del processo progettuale, ricercando quei pattern
ricorrenti e generali che ne svelino il potenziale di standardizzazione informatica.
Il rilascio di prodotti come GenerativeComponents e Autodesk Revitgli permettono di affermare che ogni
processo progettuale è sempre e comunque basato sulla definizione di elementi e di relazioni tra essi12. È cioè
fondato sulla costruzione di spazi topologici piuttosto che metrici.
Un muro di mattoni si può quindi descrivere attraverso le proprietà base dei suoi componenti, cioè i
‘parametri’di lunghezza, larghezza e altezza dei laterizi, nonché sfruttando una serie di equazioni che ne
stabiliscono le interrelazioni geometriche, in questo caso la reciproca posizione spaziale.L’informatizzazione
garantisce integrità a questo sistema, permettendo all’architetto di concentrarsi sulle modifiche numerichedelle
sue ‘variabili’, all’interno di domini continui o discreti.
È in sintesi il concetto di ‘progettazione parametrica’, sul quale Gramazio & Kohler13, architetti e ricercatori
prezzo l’ETH di Zurigo, fondano la concezione di progetti come la cantinaGautenbein, in Svizzera.
10
Per una guida completa sulla tecnologia BIM vedi: Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K., BIM Handbook: A Guide to Building
Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors, Wiley, 2008.
11
L’intervista è interamente citata da Adams N., Skidmore, Owings & Merrill. SOM dal 1936, Electa, 2006. Recentemente l’uso delle
tecnologie digitali all’interno di SOM è stato discusso in una conferenza intitolata “Digital Design at SOM: The Past, the Present and the
future”, registrata e visionabile all’indirizzo web: http://vimeo.com/42786059.
12
Aish R., Extensible computational design tools for exploratory architecture, in Kolarevic B. (a cura di), “Architecture in the Digital Age:
Design and Manifacturing”, Routledge, 2005, p. 17. Vedi anche: Shea K., Aish R., Gourtovaia M.,Towards integrated performance-driven
generative design tools,in “Automation in Construction”, Vol.14, n°2, 2005, pp. 253-264.
18
Col fine di garantire ventilazione agli spazi interni e protezione dalla luce diretta, reinventano ad esempio
l’uso del laterizio disposto a ‘treillage’.Studiano attraverso un modello parametrico del muro, sopra descritto
sinteticamente, nuovi motivi che richiamino figurativamente l’uva. Realizzano poi la facciata in moduli
prefabbricati a controllo numerico, assemblati in un telaio strutturale di calcestruzzo armato.
Gramazio & Kohler riciclano poi lo stesso modello parametrico del muro per progettare l’installazione del
padiglione svizzero alla Biennale di Venezia 2008, come anche il prototipo Pike Loop, costruito ed esposto nel
cuore di Manhattan nel 200914.
Con un singolo sistema consistente di elementi e interrelazioni esplorano rapidamente molteplici
configurazioni spaziali, in quella che Lars Spuybroek, del gruppo NOX,ribattezza nel suo ultimo libro come
‘architettura della variazione’15.
Lo stupore è assicurato se a tale lettura si affiancano un paio dei vecchi articoli di Luigi Moretti. In Forma
come struttura, pubblicato su “Spazio” nel 1957 16 , e in Ricerca matematica in architettura e urbanistica,
stampato su “Moebius” nel 197117, si ritrova infatti una curiosa definizione di ‘architettura parametrica’, nella
quale Moretti identifica come ‘parametri’ tutte quelle variabili progettuali che l'architetto deve considerare, e alle
quali deve rispondere, per soddisfare esigenze e requisiti funzionali di programma.
Peccando d’ingenuità, il suo intento è di comprendere, sistematizzare e formalizzare per quanto possibile il
processo progettuale. Un’impresa che sfiora l’impossibile,ma merita una menzione per metodo, tentando
d’inquadrare l’architettura all’interno di un programma di ricerca scientifico, uno dei primi svolti fondando
l’IRMOU, che sta per ‘Istituto per la Ricerca Matematica e Operativa applicata all'Urbanistica’.
Tali accezioni del termine ‘parametrico’ non vanno però confuse con la sua declinazione prettamente
geometrica. Nella modellazione tridimensionale CAD, in programmi come Rhinoceros o 3D Studio Max, si
definiscono parametriche quelle curve e superfici utilizzate per rappresentare accuratamente forme libere,
organiche o particolarmente complesse, cioènon riconducibili, se non con l’approssimazione, a geometrie
semplici.Nascono nel mondo dell’automotive design come frutto di una ricercaCitroën, e diventano rapidamente
un supporto indispensabile dei progettisti, che possono così visualizzare e studiare virtualmente le forme dei
futuri modelli di automobili.
Il primo standard di curve parametriche fu introdotto dal matematicoPaul de Casteljau nel 1959, il quale ne
definì l’algoritmo di calcolo basandosi sui polinomi di Bernstein. Pierre Etienne Bézier, ingegnere Renault, ne
permise poi la diffusione durante il decennio successivo e fu quindi lui a darne il nome definitivo di ‘curve di
Bézier’ 18 . Ormai obsolete per la modellazione tridimensionale di forme libere, resistono invece nel settore
grafico, e sono ancora implementate in programmi come Adobe Illustrator e CorelDraw.
L’attuale standard per la rappresentazione di curve e superfici parametriche si chiama NURBS, acronimo di
Non Uniform Rational B-Splines 19 . Si diffonde in architettura attraverso il software CAD Rhinoceros, e
sostituisce i predecessori principalmente perché permette all’utente un miglior controllo delle geometrie create,
caratteristica imprescindibile per uno strumento di progetto, quindi di modifica, più che di restituzione grafica.
Le superfici NURBS si ottengono per interpolazione di curve e si classificano, in base al metodo generativo,
inskinned, proporzionali, spine, swept e d’interpolazione bidirezionale. Massimiliano Ciammaichella,
descrivendo queste cinque tipologie in “Architettura in NURBS” 20, evidenzia come la genesi di tali superfici
segua logiche affini ai modi attraverso i quali gli architetti concepiscono gli spazi a esse sottesi.I NOX, per
esempio, progettano forme libere sulla base del criterio ‘skinned’, cioè interpolando curve di sezioni giacenti su
piani paralleli. Zaha Hadid, invece, rappresenta spesso la dinamicità dei flussi con NURBS ‘proporzionali’, vale a
dire ottenute da generatrici convergenti in un punto.
Ben diverso era l’approccio degli architetti e ingegneri del Secondo Dopoguerra. Opere caratterizzate da
un’elevata complessità spaziale, come il Kresge Auditorium di Saarinen, la stazione di servizio BP
sull’autostrada Berna-Zurigo di Isler, o il ponte sul Basento di Musmeci, erano, in quel periodo, il frutto di un
13
I progetti e le ricerche di Gramazio & Kohler sono raccolti in: Gramazio F., Kohler M., Digital Materiality in Architecture, Lars Müller
Publishers, 2008. Vedi anche: Converso S., Il progetto digitale per la costruzione: Cronache di un mutamento professionale, Maggioli
editore, 2010, pp. 61-63, 82-87; e Yudina A., Matthias Kohler & Fabio Gramazio: Digital Empirics, in“Monitor”, n°56, 2009,pp. 50-65.
14
Il modello parametrico del prototipo “Pike Loop” è ben descritto in: Bärtschi R., Knauss M., Bonwetsch T., Gramazio F., Kohler M.,
Wiggled Brick Bond, in “Advances in Architectural Geometry 2010”, Springer, 2010, pp. 137-147.
15
Spuybroek L. (a cura di), Research & Design: The Architecture of Variation, Thames & Hudson, 2009.
16
Moretti L., Forma come struttura, in “Spazio” (Estratti), giugno-luglio 1957. Anche in: Bucci F., Mulazzani M., Luigi Moretti:Opere e
scritti, Electa, 2000.
17
Moretti L., Ricerca matematica in architettura e urbanistica, in “Moebius”, n°1, pp. 30-53, 1971. Anche in: Bucci F., Mulazzani M.,
Luigi Moretti:Opere e scritti, Electa, 2000.
18
Una buona introduzione storica sui vari standard di curve e superfici parametriche si può trovare in: Rogers D.F., An introduction to
NURBS: with historical perspective, 1°Ed., Morgan Kaufmann, 2001.
19
Piegl L., Tiller W., The NURBS Book, 2° Ed., Springer, 1995 (1966).
20
Ciammaichella M., Architettura in NURBS: il disegno digitale della deformazione, Testo&Immagine, 2002.
19
processo creativo-generativo che saldava indissolubilmente il contributo disciplinare strutturale a quello della
ricerca formale. All’inizio del secolo, neppure Gaudí poté disegnare le guglie della sua Sagrada Familia senza
prima distudiarne il comportamento meccanico: dovette simulare le proprietà base della pietra con modelli di funi
catenarie, e ricondurre quindi il progetto alla risoluzione di un problema di ‘form-finding’, o ricerca di forma
strutturale.
Separare la componente rappresentativa dell’architettura dalla sua anima conformativa era, di fatto,
impossibile.
La natura parametrica di curve e superfici NURBS ne consente l’utilizzo anche come geometrie guida per lo
studio e la progettazione di configurazioni spaziali più complesse. Nel caso specifico delle superfici, il più delle
volte questo significa compiere un’operazione di ‘paneling’, cioè che discretizza la NURBS in una mesh
strutturale e/o una serie di componenti assemblabili, anch’essi parametrici.
I grid-shell della Fiera di Milano e del centro commerciale MyZeil di Francoforte, entrambi progettati da
Massimiliano Fuksas, sono due recenti esempi di procedura di paneling. Da pure e astratte superfici NURBS, le
società d’ingegneria incaricate della progettazione esecutiva, rispettivamente Schlaich Bergermann und Partner e
Knippers Helbig, hanno ricavato, o meglio progettato e calcolato,i reticoli strutturali, come anche le esatte
geometrie degli elementi vetrati di rivestimento21.Il forte impatto estetico delle superfici iniziali ha guidato i
progettisti nella ricerca di pattern sobri, che discretizzassero le NURBS senza aggiungervi nuovi elementi
decorativi.
Tuttavia,in parecchi altri progetti, la geometria di partenza è relativamente semplice, e gli sforzi dell’architetto
si concentrano proprio nello studio del paneling per conferire organicità o dinamismo all’insieme. È questo il
caso del Research Pavilion 2011 dell’università di Stoccarda, frutto del lavoro congiunto dei gruppi diAchim
Menges e Jan Knippers22. Il padiglione è infatti un poliedro relativamente semplice dalle facce ottagonali, e che si
ispira liberamenteai gusci dei ricci di mare per modularità e comportamento strutturale. Il cuore del progetto è qui
nello studio di tali moduli portanti a piastra, nonché nel modo in cui tra loro si giuntano formalmente e
assemblano costruttivamente.
I comandi base dei CADcommerciali difficilmente permettonoagli architettidi gestire complesseoperazionidi
paneling. Ancor meno consentono di progettare muri parametrici come quelli di Gramazio & Kohler. Le case
costruttrici di software, consapevoli di tali limiti, implementanoquindi nei loro prodotti dei semplici ambienti di
programmazione, basati, ad esempio, sui linguaggi interpretati come Visual Basic o Python.In altre parole,
invitano l’utente espertoa estendere da sé le potenzialità native dei programmi, concependo nuove funzionalità
attraverso lo sviluppo di piccoli codici, detti ‘script’.
All’inizio degli anni Novanta, quando le prime versioni di AutoCAD implementavano solamente il
macchinoso linguaggio LISP, l’architetto Neil Katz, associato di SOM, già ne vantava una discreta collezione. I
suoi codici formulavano parametricamente complessi pattern geometrici, e più volte hanno ispirato l’attività
progettuale dello studio: l’involucro della Lotte Tower di Seoul è statocosì rapidamente disegnato e calcolato in
quanto definito come entità parametrica, allo stesso modo dell’antenna per la Freedom Tower di New York23.
Da mezzo impiegato passivamente, la tecnologia digitale si trasforma in risorsa progettuale per formulare
diversamente i problemi e costruirne poi interattivamente gli strumenti e le strategie di risoluzione.
È il crescente fenomeno del ‘tooling’che, seppur etichettato comunemente anche con il termine di ‘scripting’,
non ne è concettualmente il sinonimo ma, al contrario, l’evoluzione24.Ricordiamoci, infatti, che lo scripting nasce
negli anni Sessanta col mero obiettivo di automatizzare operazioni lunghe e ripetitive, che necessitavano
periodiche esecuzioni dalla riga di comando25.
Rhinoceros, il software CAD di casa McNeel,è il programma in assoluto più utilizzatoper sviluppare script in
architettura. Le ragioni di tale successo sono molteplici.Nella versione 3.0, rilasciata nel 2003, già implementa un
potente motore grafico NURBS, ideale per creare e gestire forme libere, combinato con RhinoScript, un ambiente
21
I dettagli del progetto del grid-shell della Fiera di Milano sono pubblicati in: Schlaich J., Schober H., Kürschner K., New Trade Fair in
Milan – Grid Topology and Structural Behaviour of a Free-Formed Glass-Covered Surface, in “International Journal of Space Structures”,
Vol.20, n°1, 2005, pp. 1-14.Il progetto costruttivo del MyZeil di Francoforte è invece descritto in: Knippers J., Helbig T., The Frankfurt
Zeil Grid Shell, in “Proceedings of the IASS Symposium 2009: Evolution and Trends in Design, Analysis and Construction of Shell and
Spatial Structures”, Valencia, Spagna, 2009, pp. 328-329. Vedi anche: Knippers J., Digital Technologies for Evolutionary Construction, in
“Computational Design Modeling. Proceedings of the DMSB 2011”, Springer, 2011, pp. 47-54.
22
La Magna R., Waimer F., Knippers J., Nature-inspired generation scheme for shell structures, in “Proceedings of the IASS-APCS
Symposium 2012: From Spatial Structures to Space Structures”, Seoul, Corea del Sud, 2012.
23
Aqtash A., Katz N., Computation and design of the antenna structure – Tower One, in “Proceedings of the 6th International Conference
on Computation of Shell and Spatial Structures IASS-IACM 2008: Spanning Nano to Mega”, Ithaca, NY, USA, 2008.
24
Non a caso alcune recenti pubblicazioni didattiche per lo sviluppo di script in architettura riportano il termine ‘tooling’ invece di
‘scripting’. Vedi ad esempio:Aranda B., Lasch C., Pamphlet Architecture 27: Tooling, Princeton Architectural Press, 2005.
25
Maggiori dettagli sono riportati in: Ceruzzi P.E., Storia dell’informatica. Dai primi computer digitali all’era di internet, Apogeo
Editore, 2005.
20
di programmazionesemplice ma completo, basato sul linguaggio Visual Basic.Dalla versione 4.0, invita poi anche
i meno esperti a cimentarsi nello sviluppo di codici grazie a Grasshopper, un plug-in che, ispirandosi
concettualmente ai diagrammi di flusso creati in Simulink di casa MathWorks, consente agli utenti di
‘modellare’gli script attraverso un linguaggio grafico.
Grasshopper si basa sull’utilizzo di semplici routine e funzioni già compilate che, senza alcuna conoscenza di
un linguaggio di programmazione, possono essere assemblate tra loro,direttamente dall’interfaccia grafica, per
sviluppare algoritmi più complessi. Si tratta di tante piccole scatole nere che, forniti specifici dati in ingresso,
eseguono una serie di istruzioni e restituiscono nuovi dati in uscita.
I limiti di tale approccio sono evidenti e richiamano alla mente la sfortunata esperienza della
‘programmazione automatica’ degli anni Quaranta. I suoi fautori, tra i quali spicca il nome di Grace Murray
Hopper, famosa per essere stata la principale responsabile del tanto temuto ‘millenium bug’,si proponevano di
realizzare quello che Ford concepì originariamente per la produzione di automobili: impostare, cioè,un sistema
basato su parti intercambiabili, per sviluppare nuovi programmi scrivendo semplicemente codici di collegamento
tra routine preconfezionate26.Un’idea valida per la catena di montaggio che, nel mondo dell’informatica, irrigidì
la procedura di programmazione e si trasformò in un fallimento. La diagnosi è chiara: standardizzazione
prematura e a uno sbagliato livello di astrazione.
Grasshopper è per certi versi più flessibile, e ben si configura come strumento per lo studio di modelli
parametrici, da implementare poi in codici più complessi.È pura illusione però presentarlo come la versione
semplificata di Rhinoscript. Infatti, la difficoltà del tooling non sta nell’apprendere un linguaggio di
programmazione, ma nel saper formulare correttamente i problemi da risolvere in maniera parametrica.
Le tecnologie digitali stanno radicalmente modificando anche il lavoro degli ingegneri civili.Le tecniche
numeriche di calcolo come il FEM (Finite Element Method)rimpiazzano in toto i metodi sperimentali di progetto
e verifica delle strutture. Allo stesso modo, non si realizzano più modelli fisici per il form-finding di gusci leggeri
in calcestruzzo armato o tensostrutture27. Si passa invece attraverso l’ottimizzazione matematica che, sulla base di
uno o più criteri di selezione, sfrutta la potenza di calcolo del computer28 per ricercare iterativamente la soluzione
ottimale a un problema tra una serie di candidate29.
Dal punto di vista progettuale, questo cambiamento è rilevante per almeno tre motivi.
A differenza del form-finding classico, la topologia del sistema strutturale non è più necessariamente fissa.
Può diventarequindi l’oggetto stesso del processo di ottimizzazione, come nel caso del progetto per la nuova
stazione TAV di Firenze, sviluppato da Isozaki e Sasaki in occasione del concorso internazionale del
200330.Un’immensa copertura piana è qui sospesa in cielo da una struttura organica, della quale sia la topologia
sia la forma finale ad albero derivano dall’uso di una versione perfezionata della tecnica ESO, cioè Evolutionary
Structural Optimization31.
Data una configurazione spaziale iniziale,e calcolando le tensioni di Von Mises tramite analisi FEM, tale
algoritmo rimuove iterativamente le parti di struttura inefficienti, minimizzando in generale lo spreco di
materiale. In questo caso, è poi anche in grado di aggiungerne di nuove nei punti più critici, garantendo così
all’insieme un comportamento meccanico ottimale.
Con l’ESO è stata concepitala facciata dell’edificio per uffici Akutagawa West Side, opera
dell’architettoHiroyuki Futai e del gruppo di ricerca di Hiroshi Ohmori della Nagoya University32. Ed è stata poi
anche curiosamente riprogettatala facciata della passione della Sagrada Familia. Si tratta di una ricerca coordinata
da Jane Burry della RMIT University di Melbourne, volta a studiare eventuali analogie tra i risultati di
26
È bene precisare che all’epoca scrivere codici significava perforare delle schede e non utilizzare editor di testo. Per i dettagli sulla storia
della programmazione automatica si può consultare: Wilkes M., Wheeler D.J., Gill S., The preparation of Programs for an Electronic
Digital Computer, The MIT Press, 1984, pp. 26-37; e Campbell-Kelly M., Programming the EDSAC: Early Programming Activity at the
University of Cambridge, in “IEEE Annals of the History of Computing”, Vol. 2, n°1, 1980, pp. 7-36.Vedi anche: Ceruzzi P.E., Storia
dell’informatica. Dai primi computer digitali all’era di internet, Apogeo Editore, 2005.
27
Lo stato dell’arte sul form-finding classico si può trovare in: Otto F., Rasch B., Finding Form: Towards an Architecture of the Minimal,
Axel Menges, 1996. O anche in: Hennicke J. et al., IL 10. Grid shells, Stuttgart: Institute for Lightweight Structures (IL), 1974; e in: Isler
H., New Shapes for Shells -Twenty Years After, in “Bulletin of the International Association for Shell Structures”, n°71, 1979.
28
La potenza di calcolo è identificata da John Frazer come la più importante caratteristica dei computer nel suo libro “An Evolutionary
Architecture”, edito dall’Architectural Association Publications nel 1995.
29
Una buona introduzione sulle principali tecniche di ottimizzazione ingegneristica si trova in: Della Croce F., Tadei R., Ricerca operativa
e ottimizzazione, Esculapio, 2002.
30
Vedi: Cui C., Ohmori H., Sasaki M., Computational Morphogenesis of 3D Structures by Extended ESO Method, in “Journal of the
International Association for Shell and Spatial Structures, Vol. 44, n°141, 2003, pp. 51-61.Il progetto di concorso per la nuova stazione
TAV di Firenze è anche descritto in: Sasaki M., Flux Structure, TOTO, 2005.
31
La tecnica ESO è stata originariamente sviluppata da Xie e Steven, i quali hanno pubblicato i loro risultati in:Xie Y.M.; Steven G.P.,
Evolutionary Structural Optimization, Springer, 1997.
32
Ohmori akutagawa. Anche moh architects 2007 grattacielo
21
un’ottimizzazione topologica e le forme naturali originariamente concepite da Gaudì con modelli di funi
catenarie 33.
Rispetto ai lavori di Heinz Isler e Frei Otto, l’ottimizzazione permette poi anche di mutare il concetto
originario di form-finding, letteralmente mirato alla ricerca della forma ottimale, in quello che potremmo definire
di‘form-improvement’34, cioè atto invece a migliorare le prestazioni di una configurazione spaziale preesistente,
senza che per questo si debba raggiungere l’ottimo strutturale.
Nel crematorio di Kagamigahara, per esempio, nessun modello fisico col quale ricavare l’inverso della
membrana tesa35 avrebbe potuto tradurre in struttura l’idea dell’architetto Toyo Ito. Attraverso l’ottimizzazione,
invece, la copertura fluttuante in calcestruzzo armato, figurativamente ispirata a una nuvola, è stata modellata in
una prima fase come se fosse pura scultura, e in seguito affinata strutturalmente attraverso un’analisi di
sensitività, o Sensitivity Analysis (SA)36.
Con questa tecnica di ottimizzazione, Mutsuro Sasaki riduce l’energia potenziale elastica della membrana di
copertura, modificandone iterativamente la curvatura. Basandosi sul calcolo del gradiente, infatti, l’analisi di
sensitività gli permette di automatizzare il tradizionale metodo progettuale di ‘trial and error’, e di evitare così un
ripetitivo e lento processo di disegno/verifica della forma, che richiede molteplici lanci manuali di analisi
strutturali FEM37.
È la strategia utilizzata anche per il Grin Grin Park di Fukuoka e il Kitagata Community Centre di Gifu:altri
due casi nei quali il progettista ha potuto considerare configurazioni spaziali free-form, strutturalmente subottimali, solo grazie all’uso dell’analisi di sensitività 38.
Da semplici strumenti risolutivi, questa e altre tecniche di ottimizzazione numerica diventano, in architettura,
efficaci strumenti esplorativi a supporto delle fasi concettuali del progetto.Per questa ragione, sono anche spesso
identificate nella letteratura scientifica come strategie di ‘morfogenesi computazionale’39.
Le ricerche che da qualche anno conduco con Mario Sassone e altri colleghi del nostro gruppo si collocano a
pieno titolo all’interno di questo filone40. L’obiettivo è chiaro: sviluppare e applicare tecniche di ottimizzazione
per la progettazione architettonica, studiando in che misura, e secondo quali logiche, possano esse configurarsi
anche come strumenti di pensiero41.
Si parte sempre da un problema progettuale ben definito,cioè chiaramente formulabilein maniera parametrica.
Per esempio, quando nel 2007 abbiamo riprogettato strutturalmente il crematorio di Kagamigahara, ne abbiamo
rappresentato il guscio di copertura con una superficie NURBSin Rhinoceros: vincolati i suoi punti di controllo in
corrispondenza dei pilastri, le coordinate spaziali dei restanti sono automaticamente diventate le variabili
progettuali del sistema 42.
Vi si abbina poi una strategia di ottimizzazione che, sulla base di uno o più criteri di selezione, svolge il ruolo
di guida nel processo di studio e valutazione della forma architettonica.In parallelo con la geometria parametrica
33
I risultati di questa ricerca sono stati inizialmente pubblicati in: Burry J., Felicetti P., Tang J., Burry M., Xie M., Dynamical structural
modeling: A collaborative design exploration, in “International Journal of Architectural Computing”, Vol. 3, n°1, 2005, pp.27-42.Poi
anche in: Burry J., Burry M., The New Mathematics of Architecture, Thames and Hudson, 2010.
34
Il termine ‘form-improvement’ è stato coniato dal sottoscritto a puro scopo esplicativo, e non si riferisce quindi ad alcuna tecnica
riconosciuta e consolidata nella comunità scientifica di riferimento.
35
Per inversione della membrana tesa s’intende quella procedura di form-finding che, sottoponendo a carico gravitazionale una superficie
elastica priva di alcuna rigidezza flessionale, ricava prima uno stato di pura trazione, e ottiene poi dal suo inverso quello nel quale viga la
sola compressione.
36
Il progetto del crematorio di Kagamigahara è stato pubblicato su:Casabella, n°752, febbraio 2007, pp. 30-37; ArchitecturalReview,
n°1326, Agosto 2007, pp. 74-77; Detail, Vol. 48, n°7/8, luglio/agosto 2008, pp. 786-790;The Plan, n°27, giugno/luglio 2008, pp. 42-52.
37
L’analisi di sensitività è spiegata brevemente in: Sasaki M., Flux Structures, TOTO, 2005.
38
Ibid.
39
Da una conversazione informale con Makoto Katayama, professore presso il Kanazawa Institute of Technology, sembrerebbe che sia
stato Yasuhiko Hangai, ex docente dell’università di Tokyo, il primo a coniare il termine inglese ‘Computational Morphogenesis’.Con tale
nome, non è però chiaro se egli volesse mettere in risalto delle differenze rispetto alla pura ottimizzazione, o se intendesse invece crearne
un semplice sinonimo. Ancora oggi, è usato in maniera ambigua nella letteratura scientifica, il più delle volte col mero significato di formfinding computazionale, cioè non basato su modelli fisici ma simulazioni al computer. È questoil caso di: Bletzinger Kai-Uwe, Formfinding and Morphogenesis, in Mungan I., Abel J.F. (a cura di), “Fifty Years of Progress for Shell and Spatial Structures”, Multi-Science,
2011; o anche di: Ohmori H., Computational Morphogenesis: Its current State and Possibility for the Future, in “International Journal of
Space Structures, Vol. 25, n°2, 2010.
40
Vedi ad esempio: Pugnale A., Engineering Architecture: Advances of a technological practice, Tesi di Dottorato discussa presso il
Politecnico di Torino, Aprile 2010.
41
Il rapporto tra tecnologia e pensiero è stato ad esempio affrontato da Walter Ong per studiare le differenze tra culture orali e quelle
invece alfabetizzate. I risultati di tale ricerca sono pubblicati in: Ong W., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, 1986.
Nello specifico delle tecnologie digitali, Donald Norman è probabilmente l’autore più interessante a riguardo. Si può citare ad
esempio:Norman D., Il computer invisibile, 2a Ed., Apogeo, 2005.
42
Pugnale A., Sassone M., Morphogenesis and Structural Optimization of Shell Structures with the Aid of a Genetic Algorithm, in “Journal
of the International Association for Shell and Spatial Structures”, Vol. 48, n°155, 2007.
22
NURBS, abbiamo quindi sviluppato, attraverso uno script, un algoritmo genetico43.Si tratta di una tecnica di
ottimizzazione meta-euristica che, ispirandosi al principio dell’evoluzione naturale, genera‘popolazioni’ intere di
soluzioni progettuali (in questo caso configurazioni spaziali free-form), tra le quali seleziona, e ricombina
iterativamente fra loro, solo le migliori.Nel nostro caso, fa così metaforicamente sopravvivere quelle superfici
NURBS che, dal punto di vista strutturale, presentano in media bassi valori di spostamento verticale.
Un ultimo aspetto fondamentale dell’ottimizzazione è che non si limita però a risolvere unicamente questioni
di statica, caratteristica invece intrinseca del form-finding basato sui modelli fisici.Tecniche come gli algoritmi
geneticisi possono usare, infatti, in tutti quei casi in cui una prestazione architettonica sia formulabile attraverso
una funzione matematica e, tecnicamente parlando, sia quindi ‘minimizzabile’.
All’interno del nostro gruppo di ricerca,Tomás Méndez Echenagucia 44 ottimizza così l’acustica delle sale da
concerti, Dario Parigi studia la geometria e il comportamento cinematico delle strutture reciproche45 e Paolo
Basso risolve problemi economico-costruttivi dei grid-shell a forma libera46.
Quest’ultimo tema è di particolare interesse per società d’ingegneria come la RFR parigina, originariamente
fondata da Peter Rice nel 1982. Ad esempio, nella realizzazione di progetti come la stazione TGV di Strasburgo,
dove il grid-shell di copertura free-form è composto di elementi vetratia forma quadrilatera, la presenza della
doppia curvatura nelle lastre diventa economicamente non trascurabile47.
Interi gruppi di ricerca lavorano su tale problema di ottimizzazione48 che, prima dell’avvento del digitale, non
si poteva altrimenti risolvere.Tutt’altro che a forma libera erano quindi i primi grid-shell a maglia quadrilatera di
Jörg Schlaich: per garantirne la costruzione con lastre di vetro piane, egli doveva infatti disegnarli attraverso
rigide regole geometriche, cioè solo per traslazione e scalatura di curve generatrici49.
Parametrico e ottimizzazione cambiano il modo di progettare l’architettura dalla sua concezione. La
fabbricazione a controllo numerico ne trasforma invece le tecniche costruttive.
La Son-O-House dei NOX e il muro parametrico di Gramazio & Kohler sono due esempi di come un’estrema
complessità geometrica, gestita solo grazie al supporto dell’informatica, possa razionalmente realizzarsi
attraverso il ‘file-to-factory’, cioè traducendo con delle macchine di derivazione industriale dei modelli digitali
direttamente in costruzione50.
Le stazioni di Zaha Hadid per funicolare di Innsbrucksono invece un caso in cui le forme fluide dei grid-shell
di copertura, riproducibili solo conl’uso di vetri a doppia curvatura, ancora richiedono costi di costruzione elevati.
In pochi anni, potranno però ridursi con lo sviluppo di ‘casseforme dinamiche’, che permetteranno, cioè, una
produzione industrializzata dei componenti trasparenti. A questo scopo, è nata ad esempio la piccola azienda
start-up di Christian Raun Jepsen, ad Aalborg (DK), che sta attualmente testando un primo prototipo di ‘dynamic
mould’con getti di gesso e calcestruzzo 51.
43
Una buona introduzione sugli algoritmi genetici, in inglese Genetic Algorithms (GAs), si può trovare in: Floreano D., Mattiussi C.,
Manuale sulle reti neurali, Il Mulino, Bologna, 2002 (1996). Libri tecnici più completi sono invece: Goldberg D.E., Genetic algorithms in
Search, Optimizaion & Machine Learning, Addison-Wesley, Boston, 1989; e Mitchell M., An introduction to genetic algorithms, The MIT
Press, Cambridge, 1998.
44
Vedi: Méndez Echenagucia T.I., Astolfi A., Jansen M., Sassone M., Architectural acoustic and structural form, in “Journal of the
International Association for Shell and Spatial Structures”, Vol. 49, n°159, 2008. Vedi anche: Sassone M., Méndez Echenagucia T.I.,
Pugnale A., On the interaction between architecture and engineering: the acoustic optimization of a RC roof shell, in “Sixth International
Conference on Computation of Shell & Spatial Structures: Spanning Nano to Mega, Ithaca NY, USA, 2008, p. 231.
45
Vedi: Parigi D., Kirkegaard P.H., Sassone M., Hybrid optimization in the design of reciprocal structures, in “Proceedings of the IASS
Symposium 2012: From spatial structures to space structures”, Seoul, 2012. Vedi anche: Parigi D., Kirkegaard P.H.,Towards free-form
kinetic structures, in “Proceedings of the IASS Symposium 2012: From spatial structures to space structures”, Seoul, 2012.
Sull’ottimizzazione delle strutture reciproche, si possono anche citare: Baverel O., Nooshin H., Kuroiwa Y., Configuration processing of
nexorades using genetic algorithms, in “Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures”, Vol. 45, n°142, 2004,
pp. 99-108; e: Douthe C., Baverel O., Design of nexorades or reciprocal frame systems with the dynamic relaxation method, in
“Computers and Structures”, Vol. 87, n°21-22, 2009, pp. 1296-1307.
46
Vedi ad esempio: Basso P., Del Grosso A., Pugnale A., Sassone M., Computational morphogenesis in architecture: cost optimization of
free form grid shells, in “Journal of theInternational Association for Shell and Spatial Structures”, Vol. 50, n°162, 2009.Una ricerca
analoga è stata anche pubblicata da Mario Sassone e dallo scrivente in: Sassone M., Pugnale A.,On optimal design of glass grid shells with
quadrilateral elements, in “International Journal of Space Structures”, Vol. 25, n°2, 2010.
47
Vedi: Pottmann H., Schiftner A., Bo P., Schmiedhofer H., Wang W., Baldassini N., Wallner J.,Freeform surfaces from single curved
panels, in “ACM Transactions on Graphics (TOG) - Proceedings of the ACM SIGGRAPH 2008”, Vol. 27, n°3, 2008.
48
Vedi ad esempio: Pottmann H., Asperl A., Hofer M., Kilian A.,Architectural Geometry, Bentley Institute Press, 2007.
49
Vedi: Holgate A., The Art of Structural Engineering. The work of Jörg Schlaich and his Team, Edition Axel Menges, 1997. Vedi anche:
Schlaich J., Schober H., Glass-covered Lightweight Spatial Structures, in Abel J.F., Leonard J.W., Penalba C.U. (a cura di), “Spatial,
Lattice and tension structures: Proceedings of the IASS-ASCE International Symposium”, Atlanta, 1994, pp. 1-27.
50
Secondo i ricercatori del gruppo danese Digital Crafting, questo è un processo di automazione del cantiere che potrebbe in futuro anche
configurarsi come un nuovo ‘artigianato digitale’.
51
Diversi ricercatori e compagnie start-up stanno lavorando su questo tema. Vedi per esempio: Pronk A., Van Rooy I., Schinkel P.,Doublecurved surfaces using a membrane mould, in “Proceedings of the IASS Symposium 2009: Evolution and Trends in Design, Analysis and
Construction of Shell and Spatial Structures”, Valencia, 2009, pp. 618-628; e anche:Raun C., Kristensen M.K., Kirkegaard P.H., Dynamic
23
Dopo un lungo periodo di progressiva separazione, con lo sviluppo delle tecnologie informatiche architettura e
ingegneria si stanno gradualmente riavvicinando. È un fenomeno che ho qui semplicemente tentato d’introdurre e
che personalmente chiamo ‘Engineering Architecture’.
Double Curvature Mould System, in “Computational Design Modeling:Proceedings of the Design Modeling Symposium Berlin 2011”,
2011.
24
BENTORNATA REALTA’
Gianfranco Cordi
Incentrare, nuovamente, l’attenzione sulla “realtà”, a scapito delle “interpretazioni” e delle “rappresentazioni”,
vuole dire almeno due cose. Prendere le distanze dall’onnipotenza del soggetto e stabilire un punto di partenza
indubitabile dal quale incominciare ad orientarsi ed a trarre delle conclusioni questa volta veramente universali e
fondate. In definitiva la proposta di un «Nuovo Realismo» avanzata da Maurizio Ferraris comporta lo stabilirsi di
un “inemendabile” al di là del quale non è possibile né cancellare la presenza di qualcosa né sbarazzarsi, come se
niente fosse, della sostanza di qualcos’altro. L’ “inemendabile” è ingombrante ed è perentorio. E’ veramente
ineludibile. In questo senso il soggetto (la potenza, l’estensione, la forza), in quanto principio costitutivo della
realtà materiale, si pone al centro del dibattito attuale con un evidenza inedita. La “materia” (ciò che costituisce la
sostanza di un oggetto) possiede adesso delle precise cose da dire, reca in sé delle ragioni che non è più possibile
eludere, è caricata di significati e di interessi che non è affatto permesso procrastinare. Della “realtà” in sé e per
sé, come è noto, pochissimo si può sensatamente dire. Essa esiste, permane, c’è; si trova in qualche luogo ed in
qualche tempo; è perspicua. Poco o niente altro si può aggiungere a questi abbozzi o tentativi di definizione.
Sappiamo solo che la “realtà” insiste e chiede di essere considerata da noi. La “materia” - in quanto parte o brano
della “realtà” - è invece molto più definita: essa si trova all’interno delle cose, costituisce la loro natura, è la loro
radice. Materialismo o Realismo, dunque? E “Nuovo” Realismo solo in contrapposizione all’ermeneutica, al
postmodernismo e al pensiero debole? Oppure “Nuovo”, perché esso apporta un elemento di distinzione e di
novità rispetto al Realismo classico evidentemente - sempre, agli occhi di questo “Nuovo” - oggi superato? O
ancora: semplice aggiornamento del Realismo di vecchio tipo? O, infine, “Nuovo” in quanto riproposizione delle
tematiche realiste nel contesto della situazione attuale? Molte domande, dunque, su una corrente di pensiero o un
approccio finalmente idoneo per capire il mondo che ci troviamo di fronte, le sue forme, le sue dinamiche ed i
suoi tragitti. Molte domande che si aprono davanti a una proposta che, a suo modo, anche Giacomo Marramao ha
fatto propria - su altri versanti e da un altro punto di vista- all’interno cioè di un discorso “Contro il potere” delle
grandi concentrazioni di ricchezza e capacità decisionali. Insomma: da più parti in tutti questi anni è andato
venendo sempre fuori questo nuovo “bisogno di realtà”. Dopo le ubriacature soggettivistiche ed epistemologiche
anche i filosofi della mente (Searle per esempio) hanno messo in evidenza il ruolo della “intenzione” la quale
collega, appunto, la sfera dell’interiorità con il mondo esterno. C’era bisogno di realtà. E Ferraris si è fatto,
giustamente, interprete di questo desideratum andando direttamente contro le filosofie che prendevano a modello
Nietzsche e Heidegger in primis. Ma che cosa ce ne facciamo adesso di questa “realtà”? E’ vero: non si può
prescindere da essa, non la si può eliminare; ma come possiamo renderla operativa e saliente per le nostre vite?
Come ci può essere utile la “realtà”? Il «Nuovo Realismo» non vuol essere - almeno a me non sembra solamente un gesto di contrapposizione allo spirito del tempo che impera. Non vuole essere solo qualcosa che
nasce con la precisa vocazione di essere “altro” rispetto all’andazzo generale. Evidentemente, all’interno del
movimento fondato da Maurizio Ferraris esistono anche delle spinte propositive. Ripartiamo dalla realtà.
Consideriamo la realtà. Fermiamoci un attimo e osserviamo la realtà. Esiste questa cosa qui, e al di sotto di questa
cosa qui non si può scendere ed, ancora: questa cosa qui entra direttamente nelle nostre vite. L’atteggiamento
costruttivo del «Nuovo Realista» pare dunque essere prettamente conoscitivo. “Adesso so che esiste anche questa
cosa qui”. Ho allargato il bacino della mia conoscenza a questo altro elemento. Non ci troviamo più in un
monismo (del tutto interpretativo) ma siamo dentro un pluralismo (interpretazioni e fatti). Considerare la realtà
infatti non vuole affatto dire negare l’esistenza possibile delle delucidazioni e delle spiegazioni. Considerare la
realtà vuole dire solo affermare che è rilevante occuparsi di quella cosa che “non si può cancellare”. Facciamo un
altro passo avanti. La “materia” è il costituente della “realtà”. Se esiste la realtà è indubitabile che esiste anche
una certa materia che la compone. Questo “principio” si apre, dunque, a ulteriori conseguenze e ricadute. La
“materia” è un elemento in più che può essere o comunque non essere considerato. Ma, in ogni caso, si pone
come interessante, come degno di attenzione, come disponibile all’uso. Il «Nuovo Realismo» amplia la
conoscenza in molti sensi e conduce, quindi, a una consapevolezza di tipo particolare. Attraverso questa
considerazione - adesso sostenuta e consigliata - della “realtà” si ampliano gli orizzonti concettuali ed in questo
senso si entra a far parte direttamente del novero delle “scienze” e dei risultati della scoperta e del progresso
scientifico. Ma fino a qui la faccenda sembrerebbe un’operazione di puri accademici e di studiosi avulsi dal
concreto agire degli uomini. La domanda successiva da porsi è: il «Nuovo Realismo» cambia la vita degli
uomini? E se sì, come? In che modo? Se fuori sta piovendo io ho varie opzioni davanti a me: posso uscire senza
un ombrello e bagnarmi, posso uscire con l’ombrello e non bagnarmi, posso rimanere in casa, posso andare
rasente i cornicioni, posso prendere l’automobile. Una cosa sola non posso “negare”: e cioè che fuori piove.
25
Questo “innegabile” non riesce a scalfire i miei comportamenti (se devo andare a casa della mia fidanzata io ci
vado lo stesso, anche a costo di bagnarmi) ma li riesce a “condizionare”. Ne diventa parte in causa. Ne fa parte.
Entra direttamente nella questione della quale mi sto occupando. La “realtà” si fa notare, non è mai del tutto
tranquilla: morde. In un modo o nell’altro, dunque, la presenza adesso affermata e teorizzata della realtà “cambia”
il comportamento degli uomini. Le loro scelte, le loro motivazioni, le loro decisioni. Ecco che il «Nuovo
Realismo» acquista una veste pratica ed effettuale. Da dottrina conoscitiva e del tutto astratta in quanto tale, la
teoria di Maurizio Ferraris si attesta adesso su posizioni politiche e concretamente sociali. Ma considerare che
esiste la “realtà” non vincola certamente a non seguire le fantasticherie, i sogni, le illusioni più varie. Se lo si fa
quella è una libera scelta che presuppone solo un atteggiamento orientato in un certo modo dal punto di vista
della propria biografia o delle proprie motivazioni interiori del tutto private. La “realtà”, come il noumeno
kantiano, è “inconoscibile”. Ma c’è! Adesso la si deve prendere in considerazione. Poi, naturalmente, si potrà
anche scegliere in modo diametralmente opposto alla natura stessa di quello che si ha davanti. In fondo la “realtà”
per Ferraris è un altro elemento del discorso, qualcosa che era stato abbandonato al suo destino per anni e che
adesso riemerge, qualcosa che entra a far parte della logica considerazione delle cose. In questo senso essa è
indubitabile. Si presenta nelle vesti di “termine” da tenere presente e di “termine” di confronto. Di oggetto
presente. Di presenza vera. Il “materialismo” è, perciò, inevitabile. Ma non solo. A giudizio di Ferraris la “realtà”
è quella cosa che va seguita. E siamo dunque al contributo positivo del «Nuovo Realismo». Non ci sono solo più
le interpretazioni (come voleva Nietzsche): c’è qualcosa che perdura e si installa al cuore di ogni discorso. Da li
si dovrebbe ripartire. Da lì si dovrebbe nuovamente considerare il mondo per quello che è, con le sue
problematiche e le sue possibilità. Bisognerebbe insomma comportasi di conseguenza: la “realtà” è sempre
l’”inemendabile” in fin dei conti. E dunque? Non si sfugge alla realtà. Nessuno può dirsene fuori. Se ho davanti
agli occhi una camicia blu e la “interpreto” come rossa: quella mia “Interpretazione” è sbagliata. E’
inevitabilmente, assolutamente, indubitabilmente sbagliata. La “realtà” informa così il livello conoscitivo: vieta
determinate conclusioni e ne consente altre. Si incaglia a giusto titolo nelle deduzioni logiche della mente come
un “termine” oltre al quale tutto quello che si può dire di contrario è privo di significato ed è deleterio.
Eliminando moltissime “interpretazioni” (nell’esempio precedente: la camicia è gialla, è verde, è nera, è bianca
ecc.) la realtà orienta verso un'unica strada, incanala verso uno stesso margine e limite. Che, poi, sarebbe il
margine di ciò che si può discriminare ragionevolmente e in virtù del solo buon senso – il quale, sia detto per
inciso, rimane sempre quella “cosa nel mondo meglio ripartita”. Insomma: la realtà condiziona e orienta. E la
“materia” non è da meno. Una palla di acciaio non può essere trattata come un pezzo di Plastilina. Da tutto ciò
non si può uscire: non si può fare a meno di avere a che fare con una “materia” anche se, naturalmente, si può
scegliere di fare a meno di quella “realtà” che si ha di fronte in virtù di considerazioni di tipo emozionale,
sentimentale, della facoltà che presiede al piacere al dispiacere, o di altro tipo. Ma se io ho in mano un gelato alla
fragola, un cono, e qualcuno mi dice: “parlami del concetto di ironia in Socrate”, se io mi concentro nella
discussione e lascio perdere il gelato, se non rimando la spiegazione a quando l’avrò finito: il gelato mi si
squaglierà nelle mani. Certo: io posso benissimo comportarmi così ed aver perduto il denaro necessario per
acquistare quel cono ma è altrettanto vero che, se io volevo consumare quel gelato, avrei dovuto rimandare a
dopo la conversazione. La realtà, insomma, ha le sue regole, i suoi meccanismi, la sua conformazione che
prescinde dalla volontà degli uomini. E’ vero, gli uomini possono cambiare la realtà (io posso gustare il gelato e
mangiarlo fino a farlo sparire) ma è altrettanto vero che non possono tralasciare la “realtà” per comportarsi come
se essa non esistesse del tutto. La realtà è ciò di cui non si può prescindere pena la stessa insussistenza della
circostanza nella quale ci si trova. Se si trascura la realtà, la vita stessa cambia. Tutto si trasforma. Spariscono le
cose. I coni gelato si sciolgono. La pioggia “paradossalmente potrebbe non finire mai”. In fondo: ne va della
stessa esistenza singola di ogni persona che abita la terra. Se trascuro il fatto che là dove c’è la scritta “Campo
Minato” - se io ci entro lo stesso - è molto facile che io possa saltare in aria e perdere la vita, ecco allora, se
trascuro tutto questo vuol dire che non voglio vedere come stanno le cose, che ho dei problemi con il mondo il
quale è il contenitore della mia stessa esistenza. Ma le cose stanno così e non possono essere altrimenti, lo spazio
ed il tempo ci sono dati, sul mare non si può camminare a piedi come sulla terraferma. Questo «Nuovo
realismo» non vuole, cioè, racchiudere la cifra minima del nostre stesso stare al mondo. Non è questo il senso
dell’ “inemendabile”. In un certo senso, vuole ricordarci che se trascuriamo la realtà andremo incontro a delle
conseguenze certe (il cono si squaglierà). Ma vuole anche fare presente che dalla realtà possono essere tratti degli
insegnamenti. Il quadrato ha quattro lati uguali e non è propriamente un triangolo. La nicotina contenuta nelle
sigarette non è propriamente un toccasana. Ci sono cose che sono esattamente in un modo e non in un altro. E
allora volerle cambiare e renderle in un altro modo è certamente difficile. E’ ostico. E’ pericoloso. E’ arduo.
Forse è più corretto e più intelligente seguire la realtà per come essa comanda e dice. E seguire la “materia”
dentro le sue caratteristiche e particolarità. Ripartire da “questo”: non come via più “facile” da seguire - tutt’altro
- ma come via più organica, più logica, più coerente, più lineare. Il «Nuovo Realismo», dunque, come strada
26
maestra della razionalità. Ora tutto è più “chiaro”, ora tutto è più “distinto”, ora tutto è più “libero”. La tirannia
delle “interpretazioni” aveva portato ad un relativismo estremo e ad una estrema concentrazione dell’attenzione
sull’individuo (che interpreta) diventato in questo modo un assoluto non altrimenti discutibile. Siamo negli spazi
aperti della “realtà”; qui tutto possiede la gioia del finito e del transitorio. Trattando in modo nuovo la realtà ci si
innamora sempre più della realtà e si dimenticano i sogni impossibili e le sciocche elucubrazioni su enti che non
solo non sono mai esistiti ma che non esisteranno mai e che non sono neppure di alcuna utilità per la vita stessa
delle persone. Questo nuova enfasi posta sulla materia e sulla realtà ci dona più partecipazione al momento stesso
che stiamo vivendo, nella sua bellezza e nella sua verità. Ci rende più onesti e più pienamente attivi nel momento
storico in cui ci troviamo ad operare. In una parola: ci dà la possibilità di interloquire anche con altri esseri
umani. Ovvero: ci rende più simili al nostro prossimo. La “realtà” è alla fine l’uguaglianza realizzata davanti al
palcoscenico dei nostri destini personali e delle nostre infondate pretese alla singolarità dei nostri gusti e delle
nostre aspirazioni.
BIBLIOGRAFIA
R. Descartes, Discorso sul metodo, Laterza, Roma- Bari, 1989.
M. Ferraris, Manifesto del Nuovo Realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012.
G. Marramao, Contro il potere. Filosofia e scrittura, Bompiani, 2011.
F. Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, Adelphi, 1974.
J. R. Searle, La costruzione della realtà sociale, Edizioni Di Comunità, Milano, 1996.
27
NUOVI LUOGHI E VILLAGGI CONTEMPORANEI
Paolo Diociaiuti
Immaginiamo quale sarà il destino delle nostre città, quale sarà la loro forma, come saranno trasformate dalle
accelerazioni di tempo, di spazio e di “individualizzazione” che caratterizzano la nostra epoca1 e dalle
opportunità che ci si offrono con l’avvento del paradigma dell’Informazione e delle sue “nuove sostanze”2. Si
pone una domanda fondamentale: la vita nelle città della Surmodernità (utilizzando la definizione che Marc Augé
propone per la nostra epoca) somiglierà ad un sogno, alla “favola soffice”3 postmoderna di emancipazione dalle
costrizioni date dai luoghi, dalle distanze e dalla materia in genere o dovremo comunque, come è sempre
accaduto, sforzarci di delineare prospettive di sviluppo progressiste e realiste che impieghino utilmente le nuove
risorse? Come in ogni fase di crisi siamo di fronte ad una scelta: da un lato c’è la possibilità di correggere errori
con i nuovi strumenti a disposizione (è vero: oggi prevalentemente dematerializzati) per riconfigurare un mondo
migliore, dall’altro lato c’è il baratro di uno spazio ridotto ad ammasso indifferenziato in cui ciascuno appare
sempre più solo e slegato da ciò che lo circonda. Niente è già scritto a priori. C’è sempre una questione di scelta e
la scelta è sempre fatica e responsabilità, termini che volte e per alcuni hanno un sapore arcaico e fuori moda.
Mies van der Rohe scriveva nel 19304: “Il tempo nuovo è una realtà; esiste indipendentemente dal fatto che noi lo
accettiamo o lo rifiutiamo”. Bisogna accettare il nostro tempo nuovo, ma bisogna farlo consapevolmente.
Lo sviluppo della città moderna, intesa come città industriale, ha esercitato spesso un dominio ed una
aggressione nei confronti dello spazio non urbanizzato e, contemporaneamente, ha modificato in profondità il
rapporto tra uomo e città ed il significato stesso di spazio abitato. E’ la città industriale che, il più delle volte, ha
scardinato il tradizionale confine tra città e campagna. Ciò è stato necessario al “funzionamento” della città
moderna. All’interno della città-macchina, dove la funzione determina la forma, gli abitanti sono stati spesso
costretti in case-macchina standardizzate, ritenute adatte ad ogni latitudine, cultura e popolazione. Si è affermato,
così, un modello di città e di abitazione da esportazione, un modello oggettivamente buono. Guidata dalla
equazione industria = benessere, dalla fiducia e dalla assoluta certezza che dalle “macchine” derivi un
arricchimento materiale e spirituale sia delle masse che degli individui, la città moderna si afferma con la
violenza e la risolutezza di chi detiene l’unica verità. Ma, la industrializzazione nella (e della) città passa sopra
calpestandoli a tanti valori simbolici ed essenziali che si erano andati sedimentando in strati profondi finché la
città, in qualche modo, era stata un autoprodotto dei suoi abitanti. Ancora: la città industriale-moderna produce
spesso luoghi (o meglio spazi) privi di una effettiva funzione e, contemporaneamente, lascia funzioni reali – cioè
reali necessità dell’abitare – privi di spazi adeguati. Come scrive Franco La Cecla 5 “Nella sua fortuna e nelle sue
conseguenza massicce, il movimento per l’architettura funzionale continuerà il ruolo di riformatore assunto dalle
amministrazioni del diciannovesimo secolo. Si farà propugnatore di una ‘rieducazione’ degli abitanti a nuovi
valori tramite nuovi spazi … All’operare in questo senso sfuggirà per moltissimi anni il valore dell’abitare come
base della forma dello spazio e la stessa relazione forma-funzione come una relazione culturale e dinamica”. Il
caso emblematico della evacuazione forzata dei Sassi di Matera, avvenuto negli anni ’50 del secolo XX,
testimonia di una atteggiamento aggressivo e manicheo nei confronti della città auto costruita. Non è dunque un
caso che molti guardino oggi a forme superstiti di autocostruzione, anche se frutto ed espressione di condizioni di
disperazione, trovando in esse profondi legami tra forma del costruito ed abitanti. La forma urbana, come la
pianta del villaggio, era materializzazione e mezzo di comunicazione di una specifica cosmologia, di una struttura
sociale, politica e religiosa. In sintesi, la forma urbana era (e continuerebbe ad esserlo) il prodotto di ogni
specifica cultura. La città e le sue forme erano essenziali all’esistenza e alla continuità di ogni comunità umana
caratterizzata dai propri segni di identità. Queste “qualità” sono ormai una merce rara se dobbiamo cercarle nelle
favelas del mondo “in via di sviluppo”. Questo prezzo è stato pagato anche a favore della modernizzazione intesa
come industrializzazione.
La città moderna – città macchina è pur sempre uno spazio estremamente solido che conserva, almeno
secondo alcuni autori6, dei fortissimi caratteri di valore simbolico come, per esempio, nello skyline dei grattacieli
non troppo dissimili dalle alte case torre delle nostre città medievali. Questa forte carica simbolica, che si
1
M. Augé, Nonluoghi - Introduzione a una antropologia della surmodernità,trad- it- di D. Rolland e C. Milani, Elèuthera, Milano, 1999.
A. Saggio, Nuove sostanze. L’informatica e il rinnovamento dell’architettura, in Il Progetto n°6, 01/2000, pp. 32-35
(www.arc1.uniroma1.it/saggio/articoli/it/manifesto.html).
3
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari. 2012, p. 78.
4
Dal discorso di chiusura del Werkbund a Vienna nel 1930, tratto da A. Saggio, op. cit.
5
F. La Cecla, Mente locale per un’antropologia dell’abitare, Eléuthera,Milano 1995, p. 24.
6
J. Gottmann, La città invincibile – Una confutazione dell’urbanistica negativa, trad. it. di C. Muscarà, Franco Angeli, Milano, 1998.
2
28
materializza in strutture solide, sopravvivrebbe anche all’avvento del nuovo paradigma dell’Informazione
diventando il simbolo resistente della “città invincibile” di Jean Gottmann. La solidità della città-macchina è però
effettivamente intaccata dall’avvento di un nuovo paradigma tecnologico, economico e culturale: il paradigma
dell’Informazione. La forza dirompente di questo nuovo paradigma sta in una generale tendenza alla
dematerializzazione dei processi produttivi e relazionali ed alla conseguente emancipazione dalle tradizionali
logiche insediative moderne. Da ciò conseguirebbe una tendenza alla “aspazialità” delle funzioni con le
inevitabili ricadute su tutti gli aspetti della vita contemporanea. Le merci che produciamo e consumiamo sono
sempre più costituite da informazione “pura”, i luoghi della produzione si spostano in posti una volta impensabili.
Come scrive Antonino Saggio7: “sempre meno il luogo diventa in sé fattore importante”. Allora, lo spazio della
città e la società stessa tendono a perdere “solidità” venendo meno le necessità di concentrazione fisica di molte
attività e, attraversando una fase “liquida”, arriverebbero addirittura ad uno stato “gassoso” (uso qui in prestito le
parole di Maurizio Ferraris nell’articolo “Manifesto del New Realism” pubblicato sul quotidiano la Repubblica
dell’8 Agosto 2011). La localizzazione di funzioni un tempo esclusivamente urbane si fa effettivamente più
flessibile e la forma urbana si svincola da un rapporto di subordinazione assoluta ad esse. Avviene, a volte,
addirittura un ribaltamento: è la forma precostituita a rappresentare un vincolo alla ridisposizione delle attività.
Queste tendenze che fanno parte indiscutibilmente del nostro “tempo nuovo” rappresentano, come dicevo in
apertura, insieme un rischio ed una opportunità.
In questi spazi fluidi, siano essi liquidi o gassosi ma propri di una società altrettanto fluida, gli individui
appaiono dispersi come particelle o granelli di polvere, senza più il collante delle grandi ideologie, connessi tra
loro con sistemi di relazioni prevalentemente virtuali (reali?) ed immersi in uno spazio sostanzialmente
indifferenziato. Le trasformazioni accelerate che Marc Augé descrive con le tre figure dell’eccesso proprie della
Surmodernità8, operano all’interno di queste atmosfere fluide generando una proliferazione di Nonluoghi: spazi
indifferenziati, sempre uguali a se stessi, all’interno dei quali ciascuno, da solo, vive la rassicurante esperienza
della spersonalizzazione. Il Nonluogo è l’antitesi del luogo inteso in senso antropologico tradizionale. La città
sarà sempre più popolata di Nonluoghi, spazi privi di specifici caratteri di identità, cloni innumerevoli all’interno
dei quali saremo solo dei viaggiatori solitari? E’ forse questo lo scenario inquietante del “villaggio globale”?
Ma, le opportunità sono grandi almeno quanto il rischio.
La tendenza alla aspazializzazione delle funzioni e l’indebolimento del vincolo forma-funzione, sia su scala
territoriale-urbana sia al livello di singolo edificio, offrono dei potenti strumenti tanto per politiche di
riqualificazione che, e credo soprattutto, per favorire una riappropriazione della città da parte dei suoi abitanti.
Con le possibilità dell’epoca dell’Informazione potremmo rafforzare, anziché indebolire, i caratteri di identità di
ciascun luogo, rivitalizzare o rinnovare quei processi di identificazione e di auto rappresentazione caratteristici
del villaggio. Non deve essere visto come un paradosso l’impiego delle conoscenze più avanzate per ottenere un
risultato tanto antico come quello di costruirsi da soli un proprio villaggio. Le città dovrebbero tornare a farsi
“villaggio” utilizzando anche le nuove sostanze dell’architettura in combinazione e non in sostituzione degli
eterni materiali da costruzione per ricaricare di simboli efficienti lo spazio abitato. L’impiego della realtà virtuale
(per esempio attraverso la realizzazione di pelli digitali degli edifici, piazze virtuali, estensioni virtuali del reale)
come moltiplicatore dello spazio reale ed in stretta connessione con lo spazio mentale degli individui, può
rafforzare, modificandoli, i caratteri di identità di uno spazio, le sue potenzialità di relazionalità e di comunità ed
anche aiutare a conservarne la memoria storica (il Cyberspazio è in sé contenitore di memoria, può restituire nel
reale brani di memoria altrimenti perduti). Come spiega Derrick de Kerckhove9 non dobbiamo mai pensare ad
una sostituzione del reale con il virtuale. Al contrario, bisogna cercare di combinare, mescolare i vari tipi di
spazio: reale, mentale e virtuale. Con il principio di “materialità” de Kerckhove sottolinea la assoluta necessità di
ancorare il virtuale nel reale. In maniera sintetica de Kerckhove esprime questa idea sottoforma della formula RA
= R + RV dove RA è la realtà “aumentata”, R è la realtà ed RV è lo spazio virtuale. In questa prospettiva,
l’impiego del virtuale nel reale porta, quindi, ad un rafforzamento del reale.
Al di là delle idee di spazi variamente fluidi o fungibili ed altre chimere di emancipazione dalla solidità degli
ostacoli naturali e della forma urbana, l’invito di de Kerckhove a mescolare gli spazi e moltiplicare il reale porta
ad un atteggiamento di fiducia che l’uso della realtà virtuale possa rafforzare, seppure trasformandole, quelle
qualità che, da sempre, fanno di uno spazio un luogo e che la nuova era possa portare alla costruzione di nuovi
valori e condizioni di vita migliori per l’umanità. Come scrive de Kerckhove:”Ora viviamo in un periodo di
transizione. Come Le Corbusier nel 1924, abbiamo bisogno di ripensare non solo la città, ma il mondo intero.
7
A. Saggio, op. cit.
M. Augé, op. cit.
9
D. de Kerckhove, L’architettura dell’intelligenza, trad. it. di M. L. Palumbo, Testo&immagine,Torino, 2001.
8
29
Una delle nostre preoccupazioni primarie dovrebbe essere quella di trovare strategie per includere un senso
globale nelle comunità locali” 10.
Tra le pieghe di ciò che resta della città-macchina potremmo così tentare di ricomporre tanti “Nuovi luoghi”,
cioè tanti nuovi villaggi contemporanei.
10
D. de Kerckhove, op. cit., p. 81.
30
LA METAFISICA DEL NUOVO REALISMO E LE SUE IMPLICAZIONI ETICHE
Leonardo Caffo, Sarah De Sanctis
I. Un cappello pieno di conigli
Il “nuovo realismo” sarebbe tanto piaciuto a Lewis Carroll, ne siamo sicuri. Abituato a stravolgere la realtà,
passando per specchi e inseguendo conigli vestiti da sabato sera, il matematico inglese non avrebbe potuto non
notare che la rivendicazione dei realisti, seppur non abbia nulla di “nuovo,”1 è maledettamente ragionevole. Vediamo di capirci qualcosa. Carroll piegava la realtà, giocava con la modalità, rendeva ambigua ogni espressione e
festeggiava i “non-compleanni” per avere più regali. Ma lo faceva per un motivo: dimostrare il potere
dell’immaginazione nel lavorare sui fatti, stravolgendoli. Immaginazione e fatti, appunto. Qualcosa c’è, ed è indipendente da noi, ma possiamo divertirci a pensare che non ci sia, o che sia come noi lo vorremmo. Tuttavia, c’è
un “però”, ed è anche bello grosso: il nostro potere è vincolato all’immaginazione. Carroll, nella vita reale, non
sarebbe mai partito all’inseguimento di un coniglio, non avrebbe parlato con un brucaliffo, o reso onore alla regina di cuori.
Eppure, qualcuno con la stessa fantasia di Carroll, ma convinto davvero che la realtà si potesse stravolgere,
perché socialmente costruita, è esistito: i postmodernisti.
II. Un cappello pieno di postmoderni
Non banalizziamo, non è che i postmoderni fossero convinti che inseguire conigli nelle loro tane, cambiando
più volte dimensione corporea, fosse qualcosa di fisicamente possibile. Tuttavia, l’atteggiamento nei confronti
della realtà, da parte di questi filosofi, è stato tutt’altro che rispettoso e caratterizzato, essenzialmente, da tre fasi
di “decostruzione”: (a) Ironizzazione; (b) Desublimazione; e (c) Deoggettivazione. La convinzione alla base del
postmoderno, che caratterizza tutte le fasi del suo sviluppo teorico, è che i “racconti” 2 del moderno – e la sua pretesa di oggettività – costituiscano la base del dogmatismo e delle sue derive politiche: i totalitarismi, le guerre,
ecc. Contro questo presunto crimine della realtà, che nella loro visione deriva dal “prendere troppo sul serio” certe idee, i postmoderni propongono un atteggiamento di distacco, segnalato dal costante utilizzo delle virgolette –
epoché husserliana applicata alla scrittura – per i cosiddetti paroloni filosofici: “verità”, “realtà”, “oggettività” e
via dicendo. Oltre a prendere le distanze tramite il virgolettato, i postmoderni guardano con sarcasmo chi pretende di trovare il vero, ricordandogli che è solo figlio di una cultura smodatamente scientifica che va messa in discussione da un pensiero debole3 e cauto. Il Nietzsche dei “niente fatti, solo interpretazioni” diventa linea guida di
un pensiero che “desublima il represso” – come sostenevano già Adorno e Horkheimer4 – di un potere che,
all’apparenza, concede diritti civili e libertà morali, ma che proprio di queste concessioni fa un dispositivo di controllo biopolitico all’insegna di una “normalità reale” – cui va contrapposta, necessariamente, una critica del reale. Ma ciò che rimane in assoluto “la ragion sufficiente e il motore politico”5 del postmoderno è la deoggettivazione, che serba in sé la posizione metafisica di riferimento di questi pensatori: realtà e oggettività, laddove intese
come pretese di Assoluto, sono un male. Unica bussola per orientarsi nel mondo è il campo d’insieme di lotte
contro il potere,6 sola vera forza che regola il mondo, realtà e oggettività comprese. Il sapere, da strumento di emancipazione nella visione illuminista, diventa mezzo di oppressione. Il filosofo che pretende di avere raggiunto
la Verità è un arrogante “prete ascetico” in cerca di potere.
“Il mio uso del ‘prete ascetico’ di Nietzsche è deliberatamente peggiorativo... un fallocentrico ossessivo, uno
che verso le donne prova la stessa sprezzante irritazione di Socrate quando gli si chiedeva se esistessero Forme
per i capelli e per il fango. Un tale soggetto ha lo stesso infinito desiderio di Nietzsche per…la pulizia. Ha lo stesso infinito desiderio di Heidegger per la semplicità... così tende a tenere le donne al loro posto di tradizionale inferiorità, lontano dagli occhi e dalla mente, e a favorire un sistema di caste in cui i virili guerrieri, che si lavano
spesso, stanno al di sopra dei puzzolenti mercanti del bazar. Ma il guerriero, naturalmente, è surclassato dal prete,
che si lava ancor più spesso senza perdere in virilità. Il prete è più virile perché ciò che conta non è il fallo della
carne ma quello immateriale, quello che penetra il velo delle apparenze ed entra in contatto con la vera realtà…” 7
1
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, “Prologo”, pp. IX – XII, Laterza, Roma - Bari, 2012.
Cfr. R. Rorty, La filosofia e lo specchio della Natura, Bompiani, Milano, 1986.
3
G. Vattimo, P.A. Rovatti, (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 1983.
4
Cfr. M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1976.
5
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 20.
6
M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia (1971) in Id., Microfisica del potere, Einaudi, Torino, 1977.
7
R. Rorty, ‘Heidegger, Kundera and Dickens’ in Essays on Heidegger and Others, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2006,
p.72. Traduzione di Sarah De Sanctis.
2
31
C’è un senso politico per cui l’appello contro il dogmatismo da parte dei postmoderni può essere compreso:
l’idea che con la scusa della verità si possa imporre un punto di vista, spesso sbagliato, ad interi popoli e nazioni.
Quel che nasce come sano incoraggiamento verso un pensiero critico, però, sfocia in uno scetticismo a priori che
nega la possibilità che ci siano vero e falso, aprendo la strada al relativismo più selvaggio. Cosa che, per altro,
non andò giù nemmeno ai padri fondatori del postmoderno: si pensi alla riluttanza in questo senso di Lyotard e,
ancor più, a quella di Derrida, che non a caso non volle decostruire anche la giustizia, fine ultimo della decostruzione stessa. Inoltre, in questa giustificazione si cela anche una mossa concettuale che i filosofi non dovrebbero
mai fare: anteporre il fine ai mezzi o, in un linguaggio più tecnico, assumere ciò che si vuole giustificare.
III. Un cappello pieno di realtà
a) La realtà fisica
È l’era del “nuovo realismo”8: questo metodo conoscitivo nei confronti della realtà caratterizza la rivendicazione metafisica contemporanea. I postmoderni non si allarmino, in verità rivendicare l’esistenza della realtà serve proprio a contrastare il dogmatismo, come vedremo. Il dibattito è antico, proprio come l’oggettivismo. La domanda generale è fondamentalmente una: esiste un mondo reale al di là dell’interpretazione umana? In sostanza,
abbiamo accesso agli oggetti (fisici) che popolano il mondo, anche senza le nostre speculazioni mentali?
Prendiamo il celebre caso del sale9: il fatto che sia cloruro di sodio può essere considerato vero indipendentemente dal fatto che “cloruro di sodio” è una formulazione – linguistica – umana? Richard Rorty direbbe di no. In
una rigorosa applicazione del pensiero lacaniano, affermerebbe che l’uomo è un animale parlante, e che
l’ingresso nel mondo del linguaggio (l’ordine simbolico, in cui si scambiano significanti sganciati dal loro referente oggettuale) implica la perdita di un rapporto diretto con la realtà. Ora, essendo il linguaggio arbitrario e storicamente modificabile, ne consegue che anche il sapere sarà arbitrario e, in un certo senso, contingente. Sembra
insomma di arrivare a un vicolo cieco: o si proclama l’infallibilità del sapere umano, mossa quantomeno azzardata, o si arriva allo scetticismo più totale.
Il problema sarebbe piuttosto facilmente risolvibile se si ammettesse la possibilità dell’accumulazione progressiva del sapere. Come giustamente ricorda Ferraris, anche Rorty avrebbe certo preferito le cure di un medico
del nuovo millennio a quelle di Ippocrate.10 Ahimè, il Progresso è però una di quelle Grandi Narrazioni che il
postmoderno sacrifica all’altare della Contingenza, costringendolo a scegliere fra bianco e nero in un mondo di
grigi.
Qual è la risposta del nuovo realista a tutto ciò? Per dirla con la formulazione di Susan Haack, “la realtà è quel
che è al di là di quel che io o tu o chiunque ne possa pensare”11. Cloruro di sodio sarà pure una formulazione umana, e magari un giorno si deciderà di chiamare il sale “giampeppo bertoldo”, chi lo sa. Rimane il fatto che mettere il cloruro di sodio o il giampeppo bertoldo negli occhi produrrà bruciore e dolore (di cui parleremo più avanti), e che se non lo buttiamo nell’acqua la pasta avrà meno sapore.
In questo senso il nuovo realismo ha un forte sentore di “ritorno al buon senso”. Si pensi all’insistenza di De
Caro sull’immagine manifesta, che pure dobbiamo conciliare con la scienza moderna e con le nostre speculazioni. Si pensi alla risolutezza di Searle quando parla del caso allucinatorio. Alla domanda “se io percepisco una sedia, come posso sapere se questa sedia c’è davvero o è solo nella mia mente?” il filosofo americano dà la stessa
risposta che probabilmente avrebbero dato le nostre nonne. Se ti sembra che ci sia una sedia ma la sedia non c’è,
ti stai semplicemente sbagliando.
b) La realtà sociale
Altra cosa, si dirà, sono gli oggetti sociali – come le multe, o i professori universitari – che sembrano esistere
solo perché l’umano gioca al “gioco del sociale” o, come vuole la Documentalità, 12 perché esistono delle iscrizioni che rendono oggetti bruti, come le “persone”, degli oggetti sociali come i “professori”. Si pensi a quanto è
cambiato il nostro modo di pensare nel corso dei secoli: se anche il sale è sempre stato lo stesso, essere donna o
di colore è invece molto diverso oggi rispetto anche solo a cinquant’anni fa.
Il nuovo realismo, però, non sarà “nuovo”, ma non è neanche ingenuo: il postmoderno ci ha aperto gli occhi
sulla contingenza del sociale e nessuno intende fare marcia indietro. Per usare la formula di Ferraris, possiamo
8
Parte di quanto esposto in questo paragrafo è una rielaborazione dell’articolo L. Caffo, “Il nuovo realismo scopre il dolore”, in «Gli Altri:
la sinistra quotidiana», 30/03/2012.
9
Si consideri, a tal proposito, la puntuale difesa della “verità” fatta in D. Marconi, Per la verità. Relativismo e filosofia, Einaudi, Torino,
2007.
10
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 57.
11
S. Haack, nel suo intervento ‘The Pluralistic Universe of Innocent Realism’ alla conferenza internazionale: Prospects for a New Realism
(Università di Bonn, 26-28 marzo 2012).
12
M. Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce?, Laterza, Roma – Bari, 2009.
32
tranquillamente affermare che “non c’è niente di sociale al di fuori del testo”, purché limitiamo questa pretesa,
appunto, al sociale. La rivendicazione filosofica nuovo realista, contro il postmodernismo, è invece quella di un
mondo reale indipendente dall’umano: un mondo fatto di sassi e terremoti, di gerani e marmotte, di sangue e dolore. Già… proprio di sangue e di dolore: e qui si inserisce l’aspetto più interessante di questa visione della realtà,
in cui si apre, finalmente, un nuovo spazio per la filosofia.
Il problema si pone, infatti, non solo per l’epistemologia (come abbiamo già visto) ma anche, e forse soprattutto, per l’etica. L’ottica postmodernista, come quella ermeneutica (interpretativa), nelle sue conseguenze logiche
estende ironia e deoggettivazione anche a quei fatti del mondo che costituiscono la base della morale, della vita
sociale e politica. Quello che è un potentissimo strumento di emancipazione finisce per rivoltarsi contro se stesso.
Dire che gli oggetti sociali cambiano e che non ci sono valori assoluti nella realtà delle cose è un ottimo mezzo
per dimostrare che chi sostiene l’inferiorità della donna o della razza ebrea ha torto. Il problema è che il razzista o
misogino potrebbe usare, guarda un po’, questo stesso ragionamento. Se non possiamo uscire dal nostro linguaggio (e dalla nostra contingente cultura), se non possiamo accedere alla Verità delle cose, in virtù di che cosa si
può affermare che il razzismo è sbagliato? Che la tortura è un male? A quale principio appellarsi, una volta sotterrate tutte le metanarrative? Proprio come nell’episteme, ci ritroviamo nella scomoda terra del relativismo. Come uscirne?
c) La realtà del dolore
E qui entra in gioco il dolore. Il dolore – inteso tanto nella sua accezione fisica che in quella psicologica – è
quanto di più reale un filosofo interessato a comprendere “che cosa vi è” (ontologo) possa individuare. Il “nuovo
realismo”, lungi dall’essere un’inedita teoria filosofica, è anzitutto la presa d’atto di un decisivo cambio di stagione: l’esigenza, avvertita da più fronti, di porre fine ai populismi mediatici. Le ossimoriche “guerre umanitarie”, la crisi economica, la macellazione animale e la diffusione di sofferenza direttamente proporzionale al crescere del capitalismo, pongono spalle al muro l’idea che la realtà sia costruita socialmente, oltre che manipolabile
a piacimento, e, soprattutto, che la verità e l’oggettività siano nozioni inutili. Con buona pace di Rorty, quel che il
nuovo realismo vuole fare è proprio tornare alla “vecchia urgenza di distinguere tra realtà e apparenza, di fare una
distinzione sgradevole tra ciò che è giusto e ciò che è utile”.13
Il mondo reale, potremmo dire, si è palesato dinnanzi agli occhi dell’umano in tutta la sua freddezza: per
quanto si possa sperare di vedere felicità e speranze nel sistema di produzione keynesiano, questo avrà sempre
come fondamento il “sudore, il sangue, la disperazione” - direbbe Max Horkheimer – dei corpi di animali umani
e non umani. Bisogna, insomma, fare i conti coi fatti, e distinguere l’utile dal giusto. L’attualità e l’importanza
del nuovo realismo sono dunque palesi: la filosofia scende in strada, cammina tra gli uomini, e comprende che è
arrivato il momento di agire. Non possiamo più lasciare spazio ai divertissement intellettuali di certe filosofie da
salotto, (cosa in cui il postmodernismo, ahimè, si è trasformato): le vite e le morti sono reali, e non sopportano
più di essere ridotte a mere interpretazioni. Spacciando per culturali fenomeni di reale violenza, gli uomini arrivano, paradossalmente, a legittimare, sotto l’egida dell’interpretazione, crudeltà millenarie.
Osservando il mondo dall’alto, la Nottola di Minerva (metafora della filosofia per Hegel) smette di arrivare in
ritardo, e mal giustifica l’infibulazione Somala, le corride tanto difese da Fernando Savater,14 la mai cessata guerra in Afghanistan e la macellazione degli agnelli pre-pasquale, i 17 civili recentemente uccisi dal militare americano “stressato” e i visoni massacrati vivi per le pellicce di qualche elegante signora. Il terreno fertile del nuovo
realismo, ancor più che metafisico, è senz’altro etico: possiamo finalmente smascherare la barbarie travestita da
cultura, e rivendicare i diritti di tutti quegli individui che Benjamin chiamava “senza nome”, nati in un limbo che
li sospende tra la vita e la morte. Un bambino somalo, senza cibo e acqua da giorni, incrocia lo sguardo di una
vacca da latte morente: entrambi piangono e si vedono uguali, silenziosi si perdono in un abbraccio di dolore
mentre l’americano di Miami stringe il nodo alla cravatta per la messa domenicale. Tra le due scene, così distanti
non solo spazialmente, scorre l’ipocrisia dell’ermeneutica che pretendeva di opporsi ai dispotismi della realtà
preconfezionata.
IV. Un cappello pieno di etica (e di proposte)
Una metafisica realista, indipendentemente da quale “realismo” si adoperi, propone dunque un’inclusione, nel
nostro inventario del mondo, di una certa dose di oggetti cui il postmoderno guardava con sospetto. Se si poteva
pensare che il dogmatismo fosse causato dal realismo è solo perché del realismo, i filosofi postmoderni, avevano
una cattiva idea.
13
14
R. Rorty, ‘Il progresso del pragmatista’ in Umberto Eco, Interpretazione e Sovrainterpretazione, (Milano, Bompiani, 2001), p.132.
F. Savater, Tauroetica, Laterza, Roma – Bari, 2012.
33
La principale implicazione che ci sentiamo dunque di proporre del nuovo realismo è quella che possiamo definire “un’etica realista”. Parte di questa proposta verrà approfondita in futuro, in quanto parte di un’idea più vasta che vede necessaria una fondazione ontologica dell’etica affinché questa possa davvero assolvere alla sua
funzione. In un certo senso il nuovo realismo, nella sua implicazione morale, può essere inteso come un tentativo
di risposta a Hilary Putnam e al suo Ethics without ontology15, testo che raccoglie gli interventi ai due cicli di lezioni che il filosofo americano ha tenuto nel 2001, presso i dipartimenti di Filosofia dell’Università di Perugia
(Hermes Lectures) e Amsterdam (Spinoza Lectures). Analizzando alcuni problemi per l'antirealismo metafisico,
Putnam afferma che il primo obiettivo del filosofo morale non è l’elaborazione di un “sistema”, ma è quello di
fornire un contributo a soluzioni di problemi di carattere pratico: in etica vengono prima i problemi da risolvere,
non gli oggetti su cui questa si fonda. Sulla stessa cosa insisteva il famoso Rorty quando affermava che dovremmo piantarla di cercare l’assoluto e concentrarci sul coping, l’avere a che fare, concretamente, col mondo. Proprio
su tale priorità “pragmatica” è possibile costruire un'obiezione a Putnam che in parte è già contenuta nelle basi
filosofiche del nuovo realismo. Facciamo un esperimento mentale.
Il cappellaio matto arrabbiato
Un cappellaio matto, arrabbiato per aver perso la sua teiera, decide di intrappolare in due dei suoi cappelli magici un postmoderno, diciamo Derrida, e un realista, diciamo Ferraris. Dopo aver catturato maestro e allievo (ebbene sì), decide che userà soltanto uno dei due come teiera – ma è indeciso su chi. Chiede dunque ad entrambi
un’arringa per difendersi, e farsi liberare. Derrida dichiara: “Caro cappellaio, dovrebbe liberarmi perché il suo è
un atteggiamento dispotico e di dominio. Qualsiasi violenza sul corpo è un atto di controllo, e va respinto”. Ferraris dice: “La prigionia, la violenza e l’uccisione provocano dolore ad un individuo. Qualsiasi atto che provoca dolore ingiustificato va respinto”. Tuttavia, Derrida, stando al suo “non c’è nulla al di fuori del testo”, non può affermare che il dolore esiste al di là delle interpretazioni, cosa che invece può fare Ferraris. Così il cappellaio decide di liberare Ferraris, dichiarando a scapito di Derrida che “una teiera è di gran lunga più importante del dolore”. Il cappellaio assume questa strana posizione proprio in virtù degli studi postmoderni sul valore della realtà,
tutta la realtà, come socialmente costruita. Se anche il dolore fosse figlio di una costruzione sociale, dovremmo
paradossalmente accettare il punto di vista del cappellaio, e Derrida non avrebbe scampo. Questo può avvenire
solo se si scambia il “dolore” per un oggetto sociale, come il denaro o i professori. Ma il dolore, proprio come i
terremoti, esiste al di là delle concettualizzazioni umane. Possiamo chiudere gli occhi e sperare che il nostro dolore allo stomaco svanisca, ma questo continuerà a causarci “dolore” in modo del tutto indipendente dalle speranze.
Attenzione, dunque, nemici della verità che vi affrettate a dirle addio: se non esiste una realtà indipendente
dall’interpretazione, non c’è nessun motivo per sottrarre Jacques al suo destino.
Secondo Putnam, dovremmo risolvere un problema come quello del cappellaio senza curarci di formulare un
sistema metafisico: la priorità è salvare Derrida. Ma il problema è, a cosa appellarsi? Certo, è riduttivo
l’approccio in questione. Si potrebbe dire che bastano teorie metaetiche, come l’utilitarismo delle preferenze di
Peter Singer, a salvare il filosofo postmoderno: ma sbagliamo. Se non siamo in grado di riconoscere a certi oggetti morali un’esistenza che prescinde dalle faccende umane, rimaniamo impigliati nel “niente fatti, solo interpretazioni”.
E dunque, se la prossima mossa “nuovo realista” fosse proprio quella di proporre un’ontologia al servizio
dell’etica? Una sfida difficile, ma importante, forse la più importante per la filosofia oggi.
15
H. Putnam, Ethics without Ontology, Harvard University Press, Cambridge, 2005.
34
L’IMPRESSIONE DI REALTÀ E L’ERA DIGITALE
Alberto Cassani
Cosa vediamo realmente, quando guardiamo un film? O se vogliamo, cos’è realmente un film?
Fisicamente, un film non è altro che una lunga serie di fotografie proiettate in una successione talmente rapida
da dare all’occhio umano l’illusione di movimento, ossia da ingannare il nostro cervello fino a fargli credere che
le immagini fisse mostrate sullo schermo siano in realtà in movimento. Nel corso del secolo abbondante di vita
del cinema-tografo, per rendere quest’impressione più realistica si è cambiata più volte la velocità di proiezione,
fino ad arrivare a quella attuale di 24 fotogrammi al secondo, scelta all’epoca dell’introduzione del sonoro
proprio perché permetteva alle voci di non suonare distorte.
C’è però una cosa ancor più stupefacente, se si pensa a quanto il cervello umano accetti di farsi ingannare
quando ci si trova in un cinema. Il proiettore cinematografico ha in pratica un funzio-namento uguale e contrario
a quello di una macchi-na fotografica: la luce attraversa la serie di lenti dell’obiettivo, viene incanalata dall’anello
del diaframma e viene controllata da un otturatore che si apre e si richiude rapidamente, e infine arriva a una
superficie piana. La differenza è che nella macchina fotografica la luce entra nel meccanismo mentre nel
proiettore ne esce, e se nel primo caso la superficie piana è (era) quella della pellicola negativa, nel se-condo è
quella del grande schermo. Il funzio-namento dell’otturatore, però, è identico: si apre per una frazione di secondo
e poi resta chiuso per un’altra frazione di secondo così da permettere lo scorrimento della pellicola. Questo vuol
dire che, se in un secondo vengono proiettati sullo schermo 24 fotogrammi, un singolo fotogramma rimane in
realtà sullo schermo meno di 1/24 di secondo, perché quando il fotogramma non si trova esattamente davanti alla
lente l’otturatore è chiuso. Ossia: per buona parte del tempo di proiezione, noi fissiamo uno schermo
completamente buio! Eppure il nostro cervello “scarta” automaticamente quei momenti di buio e unisce le
immagini recepite, contribuendo così in maniera fondamentale all’impressione di movimento ricercata dallo
scorrimento della pelli-cola e, più in generale, all’impressione di realtà che il cinema insegue da sempre.
Ciò che il cinema ha sempre cercato di fare, infatti, è convincere gli spettatori che ciò che stanno guardando è
una fedele rappresentazione della realtà. O, al massimo, di ciò che la realtà è stata o sarà. Se le scenette dei fratelli
Lumiere preten-devano di riprendere la vita così com’era, quelle di Méliès pretendevano invece di far credere che
i trucchi cinematografici fossero vera magia. E nel secolo successivo, il cinema non si è mai veramente discostato
da queste due strade: il cinema “rea-listico” si basa sul tentativo di convincere lo spetta-tore che ciò che sta
guardando è ciò che succe-derebbe (o è già successo) a quei personaggi nella vita reale, mentre il cinema
“fantastico” aggiunge semplicemente una situazione totalmente estranea alla vita reale così come lo spettatore la
conosce. In pratica, dunque, l’impressione di realtà – l’illusione di star guardando qualcosa di “vero” – è sempre
stata alla base dello spettacolo cinematografico.
Come accennato, l’impressione di realtà la si può raggiungere solo grazie alla collaborazione dello spettatore.
Non solo quella involontaria con cui il nostro cervello elimina i momenti di buio e dà continuità di movimento
alle immagini, ma anche quella fattiva che ci permette di credere alla storia che ci viene raccontata. Quando
entriamo in una sala cinematografica, infatti, lo facciamo con l’inten-zione di attivare la sospensione
dell’incredulità, os-sia di accettare sempre e comunque come credibile la storia e i personaggi che ci vengono
raccontati: accettiamo a priori che James Bond abbia una faccia diversa da quella che aveva nei film precedenti
ma sia comunque lo stesso James Bond, accettiamo che ci venga data per vera una storia di fantascienza che per
definizione non può esserlo, accettiamo come reale l’inesistente Gotham City in cui la vicenda si svolge.
Accettiamo tutto, sempre e comunque. “Sempre e comunque” entro certi limiti, a dir la verità: il film deve infatti
convincerci a mantenere sospesa la nostra incredulità per tutta la sua durata, perché quando il troppo è troppo
allora sì che «non ci credo!»...
Sono tanti, i momenti in cui un film si trova a mettere alla prova la sospensione dell’incredulità degli
spettatori e di conseguenza la stessa im-pressione di realtà. Se alcuni di questi momenti riguardano gli snodi
narrativi previsti in sceneg-giatura, la maggior parte riguardano invece l’ef-ficacia puramente visiva del film. I
tecnici che lavorano alla realizzazione del film devono infatti far sì che gli ambienti e i personaggi ci appaiano
davvero per quello che sono nella finzione cinema-tografica: uno scorcio di Toronto deve sembrarci un angolo di
New York, un teatro di posa deve sembrarci la camera da letto del protagonista, un attore di quarant’anni deve
sembrarci un personag-gio di 25... E tutto deve sembrarci visto attraverso un occhio umano, non una serie di lenti
di vetro.
Di tutti i processi creativi alla base del cinema, però, quello che più degli altri si scontra con i limiti e le
problematiche dell’impressione di realtà è il montaggio. In effetti, l’essenza stessa del montaggio è proprio
creare l’impressione di realtà. Due inqua-drature girate in momenti e magari luoghi diversi vengono giustapposte
35
in modo non solo da avere una loro continuità, ma soprattutto da far pensare che abbiano la stessa origine.
Quando un personaggio entra in un palazzo e quindi nel proprio appartamento, sta al montaggio convincerci che
quell’appartamento si trovi realmente all’interno di quel palazzo. Quando due personaggi dialogano, sta al
montaggio farci credere che gli attori si trovino davvero dove dovrebbero essere e stiano facendo davvero ciò che
i personaggi stanno facendo. Quando due cose stanno avvenendo nello stesso momento, sta al montaggio farci
capire la loro contemporaneità e dare agli eventi il giusto ritmo per renderli comprensibili e interessanti. È il
mon-taggio, insomma, a dare alla realtà filmica vera e propria la sua forma definitiva.
Il modo in cui questa realtà filmica viene percepita dagli spettatori, però, è andato via via modificandosi nel
corso degli anni, seguendo l’evoluzione della tecnologia cinematografica e delle tecniche del racconto
cinematografico. Evo-luzione che è sempre stata volta a una maggiore “immersione” dello spettatore
nell’universo filmico, a una maggiore efficacia – tecnica e narrativa – dell’impressione di realtà. Non è un caso,
infatti, che il pubblico abbia sempre rifiutato (a prescindere dall’attuale insistenza dei produttori) il 3D al cinema:
dover indossare degli occhiali speciali per poter vedere il film è una barriera psicologica prima ancora che fisica
all’efficacia dello spettacolo, è un monito che si avverte lungo tutta la proiezione e che ci ricorda che ciò cui
stiamo assistendo è una finzione.
L’ultima importante evoluzione tecnologica del mondo del cinema, però, ha realmente e notevol-mente
cambiato il modo in cui si guarda un film in sala: la proiezione digitale. Il digitale, i computer, hanno avuto
grande parte nel processo di realiz-zazione di un film già dai primi anni 90, quando si è iniziato a mettere su harddisk tutto il girato in pellicola così da poterlo montare più comodamente per poi riversarlo nuovamente in
pellicola al momento della stampa. Per quasi vent’anni, in pratica, tutto il processo di post-produzione di un film
– ossia tutto quello che viene fatto dopo il termine delle riprese: montaggio, sonorizzazione, effetti speciali,
titoli... – è stato comunemente svolto in digitale. Le sale cinematografiche, invece, hanno sempre continuato a
proiettare su grande schermo pellicole larghe 35 millimetri e dotate di una banda sonora a lettura ottica. Era
dunque diverso il metodo di realizzazione di un film, ma non quello di fruizione. Negli ultimi 4-5 anni, però, le
cose sono cambiate molto rapidamente: l’alta definizione ha infatti permesso di girare direttamente in digitale e di
proiettare per il pubblico partendo direttamente dai file digitali, eliminando di fatto la pellicola dal processo di
produzione cinematografica. Elimina-zione che è ormai prossima a diventare definitiva, considerando che nel
2013 la 20th Century Fox smetterà di distribuire negli Stati Uniti copie in pellicola dei suoi film.
Se comunque il poter girare in digitale con la stessa qualità della pellicola è una rivoluzione tecnica che
interessa da vicino solo gli addetti ai lavori, la possibilità di effettuare proiezioni in digitale incide fortemente,
come detto, sulla fruizione dello spettacolo cinematografico. E non è solo una questione di brillantezza e
definizione dell’immagine. Il proiettore digitale, infatti, non avendo una pellicola da trascinare non ha bisogno di
un otturatore che si apra e si chiuda. Il fascio di luce illumina quindi lo schermo continuativamente, e un
fotogramma succede al precedente senza alcuna interruzione, permettendo così di eliminare i brevi momenti di
buio durante la proiezione. Questo vuol dire che il nostro occhio è sollecitato più a lungo dalle immagini e di
conseguenza il nostro cervello tiene durante una proiezione digitale un com-portamento ben diverso rispetto a
quello che tiene durante una proiezione in pellicola, col risultato di aumentare (involontariamente, perché lo
scopo della proiezione digitale è solo quello di ottenere un’immagine migliore con minori costi) l’illusione di
movimento e quindi l’impressione di realtà.
La possibilità di girare e proiettare un film direttamente in digitale offre però anche un’altra possibilità,
peraltro già sfruttata dalla televisione in alta definizione: quella di proiettare a velocità superiori ai canonici 24
fotogrammi al secondo. La velocità di 24 fps fu scelta, come detto all’inizio, perché permetteva la riproduzione
del suono senza eccessive distorsioni. Ma non fu scelta perché offriva una riproduzione ottimale del suono e una
qualità ottimale dell’immagine: era semplicemente la velocità più bassa in cui il suono era riproducibile
correttamente. Velocità più alte di scorrimento della pellicola avrebbero voluto dire che per realizzare un film
sarebbero serviti più metri di pellicola, aumen-tando di conseguenza i costi di produzione. Quella dei 24
fotogrammi al secondo è stata quindi una scelta di compromesso che sacrificava la qualità sull’altare della
sostenibilità economica del film. Più è alta la frequenza dei fotogrammi, infatti, più l’immagine appare nitida
anche negli oggetti in movimento e quindi, in linea teoria, l’impressione di realtà è più forte. In linea teoria, però.
Come accennato, la velocità di proiezione superiore allo standard è già di uso comune nella tv in alta
definizione: programmi sportivi e documentari sulla natura, ad esempio, ne hanno ormai fatto un caposaldo della
loro tecnica. Prima ancora, i parchi divertimenti l’hanno utilizzata per presentare filmati spettacolari in grado di
lasciare a bocca aperta i visitatori. E qui sta il problema: la proiezione a velocità superiore allo standard “pulisce”
l’immagine dai difetti tipici della proiezione cinematografica – baluginio dell’illumi-nazione, sfocatura durante i
movimenti di macchina, scie e aloni delle fonti di luce... – rendendola più simile alla realtà, ma così facendo le
toglie proprio la sua specificità cinematografica. Questo è stato il responso degli spettatori alle prime proiezioni
36
di prova de Lo Hobbit, che il regista Peter Jackson ha deciso di girare e far proiettare a 48 fotogrammi al secondo:
le immagini sono belle, ma non sembra di star guardando un film.
È vero che Lo Hobbit – così come il prossimo Avatar 2 di James Cameron, anch’esso a 48 fps – è anche un
film in 3 dimensioni, ma il rifiuto che questi primi spettatori hanno opposto a questo tipo di spettacolo fa
riflettere. Troppo semplice pensare, infatti, che il pubblico stia semplicemente rifiutando una novità solo perché è
una cosa nuova, perché quando in passato il cinema ha abbracciato nuove tecnologie che lo rendevano più
realistico – il sono-ro e il colore, appunto – il pubblico ha risposto con entusiasmo. Questo passo più recente nella
rincorsa del cinema all’impressione di realtà, invece, pare non piacere proprio perché arriva troppo vicino alla
realtà.
Certo, questi dubbi possono derivare sem-plicemente dalla mancanza di abitudine, e potreb-bero benissimo
essere spazzati via nei prossimi mesi (perché certamente i film di Jackson e Cameron saranno dei grandi successi
commerciali), ma non si può non notare come non si fossero manifestati quando in passato il mondo del cinema
ha sperimentato nuovi formati alla ricerca proprio di quella stessa pulizia dell’immagine che la velocità superiore
allo standard sembra ottenere. Nessuno ha mai scritto, detto o pensato che il CinemaScope di Ben Hur fosse poco
cinematografico, e nessuno penserà che le immagini del recente The Master di Paul Thomas Anderson – girato e
proiettato con una pellicola larga 70 millimetri invece di 35 – siano poco cinematografiche. Evidentemente, la
velocità superiore allo standard, seguendo una strada diversa, ottiene dei risultati diversi. Risultati che il pubblico
non vuole (ancora?) accettare.
E dunque, cosa vediamo veramente, quando guardiamo un film? Vediamo l’immagine di una possibile realtà,
non la realtà. E ne siamo consa-pevoli. Vediamo un’immagine ben precisa, diversa da quella che la televisione dà
di quella stessa realtà. Un’immagine che nel corso del secolo abbondante di vita del cinematografo è andata
modificandosi enormemente, ma che è sempre stata ben rico-noscibile per ciò che è: un’immagine, una riproduzione, prettamente cinematografica. Nel momento in cui questa riconoscibilità dovesse venire a mancare, si
verrebbe a modificare l’essenza stessa dello spettacolo cinematografico, e di conseguenza cambierebbe
radicalmente l’approccio che lo spettatore ha verso il cinema.
Lo spettatore non va al cinema per vedere la realtà, ma per avere l’illusione della realtà. E questa illusione
dev’essere sì credibile, ma dev’esserlo in quanto illusione, non in quanto realtà. A prescindere dal tipo di film che
si sceglie di vedere, quando si va al cinema ci si vuol far illudere, ma si vuole essere ben consci del fatto che si
sta guardando un’illu-sione. Si è disposti ad abbandonarsi completamente allo spettacolo cinematografico, ma lo
spettacolo dev’essere circoscritto dallo spegnimento e dall’ac-censione delle luci, non può mescolarsi con la
realtà. Vogliamo avere l’impressione di guardare qualcosa di vero, ma non il dubbio che lo stiamo guardando
realmente.
Se vogliamo, lo spettatore va al cinema così come va a vedere lo spettacolo di un mago: vuole credere che la
magia sia vera, ma non che quella magia faccia parte della sua realtà. Se un trucco magico assomigliasse troppo
alla realtà, dove sareb-be il divertimento? Col cinema, evidentemente, succede lo stesso: se manca la
riconoscibilità dell’illusione cinematografica – e quindi lo scarto tra il cinema e la realtà – si nega la meraviglia
propria dello spettacolo cinematografico. Non è un caso che si parli sempre di “magia del cinema”, no?
37
INTERVISTA A VITTORIO GREGOTTI
39
Nello Luca Magliulo
Riflettendo sulla “materia” in architettura e sul rapporto di questa con il reale non poteva mancare il
necessario riferimento al pensiero di Vittorio Gregotti che, più di altri, si è soffermato, anche di recente, su tali temi. Ho quindi ritenuto opportuno interrogarlo in proposito ritenendo che la sua opinione
possa essere sicuramente utile e preziosa per gli architetti.
N.L.M. L’attuale progresso tecnologico mette in
gioco materiali sempre più innovativi, e tecniche costruttive sempre più lontane da quelle tradizionali.
A ciò si aggiunge la maggiore complessità dei
problemi cui devono rispondere gli edifici, per cui
sembra venir meno il ruolo dell’architetto in favore
dell’engineering. Che l’architetto sia ormai una figura inutile?
N.L.M. Lei definisce il suo studio una “officina”
e l’idea dell’officina richiama un modo di “fare architettura” molto vicino a quello di un procedimento
manuale di modellazione dove l’uso della materia
sembra essere un punto fondamentale.
Quanto questa idea è presente nel suo modo di
lavorare? Quanto resta di questo nella cultura architettonica attuale?
V.G. La progressiva lateralità della figura
dell’architetto come progettista è dettata soprattutto
dai meccanismi economici, finanziari e burocratici
sempre più complessi e dall’indifferenza di clienti
interessati soprattutto alla possibilità degli usi di
mercato dei manufatti ed alla transitoria calligrafia
pubblicitaria delle facciate degli edifici.
V.G. L’interesse per i materiali è per me di interesse per la loro antichità come elemento dell’opera
di architettura in quanto metafora di eternità.
Oggi, invece, quello che conta è la novità e la
transitorietà, non la durata. L’interesse per il nuovo,
e quindi per i nuovi materiali e le loro possibilità sono i benvenuti se sono offerti alla modellazione
dell’architettura, non all’esibizione del nuovo.
N.L.M. L’atto progettuale oggi sembra spingersi
verso il superamento delle geometrie euclidee, anche grazie all’uso di software in grado di sostituire
la mano e la stessa immaginazione dell’uomo.
A ciò corrispondono nuovi sistemi di produzione
che rendono i materiali più flessibili. Non ritiene
che ciò abbia mutato anche il senso ed i modi della
“costruzione”?
V.G. È la solita confusione tra mezzi e fini. Le
geometrie hanno costituito nel tempo diverse ipotesi
strumentali importanti: nessuna da scartare.
Il software è anch’esso strumento utilissimo ma
l’immagine dell’uomo ha il compito di scegliere
strumenti adatti ai propri scopi, fondamenti, speranze, tentativi ideali che si configurano nel nostro caso
come forme dell’architettura. Il software resta uno
strumento come il righello o la squadra, non deve
diventare un fine ideologico, cioè della propria falsa
coscienza.
Peraltro senza “software” gli architetti europei del
XVIII secolo si sono inventati strutture spazialmente
molto complesse.
N.L.M. Nel suo libro “Contro la fine dell’architettura”, Lei parla del sottrarsi dell’architettura
alle proprie responsabilità di fronte al “reale” a
causa di un’eccessiva “estetizzazione”. Non pensa
che tale fuga sia dovuta anche alla complessità dei
problemi che non rientrano nella scala locale cui si
offre di solito la costruzione? Insomma, se l’architettura non modifica il mondo non le resta forse solo
il tratto estetizzante?
V.G. Il problema della forma delle cose se è dotata di intima necessità ideale non è mai inutile. La sua
“estetizzazione” è costituita dal suo asservimento
alla cultura del capitalismo finanziario globalizzato
ed al passivo rispecchiamento dei suoi valori.
N.L.M. Di recente, Maurizio Ferraris, ha scritto
della necessità di rivolgersi al “reale” il quale permane oltre le definizioni. Lei è stato membro del
“gruppo 63”, con l’attenzione al linguaggio, ed estimatore di Gianni Vattimo secondo cui “non ci sono che definizioni”, tanto che la Sua teoria della
“modificazione” è stata riferita al circolo ermeneutico dell’Heidegger vattimiano: ha cambiato idea?
Qual è la “realtà” per l’architettura e come vi si
manifesta?
V.G. Ho scritto di recente sul “Corriere della sera” un commento al libro di Ferarris in cui ho sottolineato che ciò che importa per noi è la costituzione
di una distanza critica dalla realtà come un materiale
del progetto che ci permetta di passare ad una possibile forma di relazione tra verità, libertà e giustizia.
N.L.M. Lei ha avuto esperienze progettuali in Oriente. La cultura orientale è nota per la breve vita
che hanno gli edifici a differenza che in Europa dove si è sempre costruito pensando alla continuità
dell’architettura nel tempo. L’affidarsi dell’architettura alle nuove tecnologie, le quali conoscono evoluzioni veloci ed il mutevole interesse capitalistico
sui suoli possono condurre ad un modello simile a
quello orientale, ovvero ad una valenza effimera
della costruzione?
V.G. Errore; la tradizione della grande cultura cinese (non quella genericamente orientale che ne
comprende molte altre diverse) ha un vivo senso del
tempo della storia con un’idea di lentezza nelle trasformazioni profonde.
L’idea di città e delle regole del suo disegno è durata quasi tremila anni. È solo l’autocolonialismo nei
confronti dei valori attuali della cultura occidentale
(tecnologia, denaro, provvisorietà, ecc.) che sta corrompendo quella cultura.
MATERIA, SOGNO, REALTA’ NELL’ARCHITETTURA DI NICOLA PAGLIARA
Rossana Noviello
L’architettura di Nicola Pagliara è immediatamente
riconoscibile per il suo aspetto fortemente materico,
per la ferrea logica compositiva legata alla funzione e
alla struttura, per la chiara metodologia progettuale
che rassicura i suoi allievi sui tanti dubbi legati al progetto. Se però i dieci divieti sistematizzati in una pubblicazione degli anni novanta sono dei sicuri avvertimenti su cosa non si deve fare in architettura, il decimo mette in guardia sui nove precedenti i quali assicurano sì l’esattezza grammaticale, ma non sono in grado di produrre “né sogni e neppure emozioni”.
L’architettura attraverso la funzione, la struttura e i
materiali racconta altro, l’immagine personale di un
ricordo il quale spesso non è altro che manipolazione
di ipotesi del passato mai veramente vissute, narrazioni ‘menzognere’. “In tal modo invece d restringersi la
possibilità di elaborare strutture per lo spazio manipolando il ricordo e dando corpo e forma all’immaginario, si apre un paesaggio infinito di mutazioni,
fantasie appunto di una realtà sconosciuta; almeno fin
tanto che qualcuno, interrompendo il processo, non
decida che quella, in quel luogo, in quel momento è la
forma dei nostri desideri”1.
Nicola Pagliara, facendo della sua stessa vita una
narrazione, racconta di essere giunto dall’Oriente,
come Carlo Scarpa, e attraverso la Grecia di essere poi
approdato a Vienna, alla Scuola di Wagner. Apolide
accolto nella città di Napoli, entra in scena ogni volta
che può parlare di architettura, indossando la maschera istrionica del grande narratore della storia della costruzione e raccontando della dura fatica del costruttore di luoghi di architettura, anche piccoli, piccolissimi,
mescolando ricordi veri e falsi, racconti biografici e
dialoghi improbabili. Dopotutto “l’architettura è uno
spettacolo… nel piacere sottile di rendere inafferrabile
la realtà. La quale, come in Doppio sogno, non è la
verità, ma è il ‘film’ che ciascuno di noi costruisce,
come in un sogno appunto, di ciò che vorremmo fosse
o fosse stata la realtà” 2.
Sull’ultima sua opera napoletana, un hotel in Corso
Umberto I a Napoli attiguo al Complesso ecclesiale di
San Pietro Martire, il prospetto reca inciso in piccoli
caratteri “restyling by Nicola Pagliara 2008”; nulla di
assimilabile alle griffe del nostro star system! Basterebbe infatti solo guardare l’opera calda e severa, dove anche il segno inciso nel colore e nello spessore
dell’intonaco tende a manifestarsi come parte dell’intero. La scrittura, come il racconto, ha cioè per Paglia1
N. Pagliara, Divieti, riflessioni su cosa non fare in architettura, Clean, Napoli, 1993, Conclusioni.
2
Ibidem, p. 53.
ra ancora un valore che dura, senza nessun cedimento
alla incredulità, come è nella narrazione postmoderna.
Ma se pensiamo alla postmodernità come una vicenda
nella quale tutti siamo immersi e cerchiamo di comprenderla in continuità e non come una strana deviazione dal cammino del modernismo e, se è vero che la
storia della modernità è storia della dissoluzione delle
strutture centrali, delle strutture forti della razionalità,
allora anche l’architettura di Pagliara nel suo essere
dichiaratamente racconto “menzognero”, conduce,
armata di tutta la perizia della tecnica, un suo personale gioco con la realtà e con la storia. Pagliara liquida
in poche battute il rapporto del post modern con la
storia: “Recentemente una corrente di pensiero, il Post
modern, ha interpretato, travisando e contaminando il
nostro rapporto con la storia decretando la morte del
Movimento Moderno per invitare tutti a riciclare colonne (di gesso!), archi e timpani. Nell’assenza di
pensiero la storia si fa rifugio dell’ignoranza”3. Queste
riflessioni risalgono agli anni ’80 quando il Post Modern stava per assurgere oltre che a moda artistica a
vero e proprio statuto estetico. Infatti, se capitasse di
chiedere ancora oggi al nostro qualcosa in proposito,
egli mostrerebbe con una smorfia di disappunto la sua
lontananza da ogni teoria interpretativa dell’architettura a favore del duro e infaticabile lavoro dell’architetto. Eppure la ‘sostanza’ storica della sua architettura non ha un corso unitario, non distingue tra attualità e archeologia, in-formata ad una tecnica cinematografica è rappresentazione di ricordi simultanei
confermando il problematico rapporto con il reale.
Ma entriamo in una delle sue architetture, ad esempio la Stazione Mostra a Napoli. La matrice del
progetto è circolare, ha origine da due cerchi concentrici, uno che regge la cupola e un altro ad esso esterno. La perfetta geometria del volume esterno scandito
dal basamento in porfido è spezzata dall’ingresso che
violentemente s’incastra in esso: è la soglia, pronao
della tholos, le cui colonne vibrano nell’atmosfera
grazie agli anelli di acciaio della base, tortili, e al capitello. Oltre la prima soglia i tre ingressi, la cui struttura è adesso intelaiata e dentro i quali le pensiline raccontano la loro storia, si sporgono alla maniera barocca, spinte dalla forza centrifuga del corpo centrale.
Dentro, la colonna centrale che regge la tholos. Essa è
identica a quelle esterne ma ingigantita per provocare
stupore e sorpresa, alla maniera berniniana, come il
grande baldacchino in San Pietro. Il suo capitello diventa un’enorme struttura ad anelli concentrici, come
una giostra o come il cappello di una signora bizzarra,
3
Ibidem, p. 16.
41
che occupa tutto l’invaso per reggere il sistema di illuminazione. E tutt’intorno il circolare volume metafisico è rivestito in lastre di calacatta ed è segnato da
una fascia basamentale in nero assoluto del Belgio. In
uno spazio di cosi piccole dimensioni si apre al reale
una molteplicità di racconti, uno nell’altro, uno
dall’altro: lungo la trama geometrica della pavimentazione, con i suoi otto tagli radiali in granito abbiamo
un nuovo incontro, a rompere la perfezione del volume, l’emisimmetria delle scale che conducono al piano banchina, rivestite in nero d’Africa, con fasce laterali in calacatta oro. La materia è un racconto nel racconto, nella composta unità dell’opera. Essa ha una
natura fisica e psicologica ed è “la chiave di volta”
che struttura e palesa la mistificazione dello spazio.
Nell’ambiguità del rapporto tra la sostanza dell’architettura che è nella sua ragion d’essere, e la sua interpretazione, tra l’ “essere” della forma dello spazio e
la sua “cognizione”, il forte contenuto materico dell’architettura di Pagliara è leggibile all’interno di un contesto ermeneutico. Sideralmente lontana dall’oblio
della materia dell’architettura digitale, per cui il corpo
è reso irreale ai sensi, ma ritrovando, nel richiamo a
“il mondo divenuto favola” di Nietzsche, una comune
presa di posizione contro l’atteggiamento conservatore reazionario che vagheggia la restaurazione di un
possibile luogo, l’esistenza di un reale “inemendabile” 4, ontologico, che non si conosce ma si “incontra”
con i sensi, la materia di Pagliara vive nella sua costituiva, reale, irrealtà.
La pellicceria Vecchione a Napoli, del 1980 è un
grande spazio progettato per una sola pelliccia. “Il tema, poi modificato nella realtà commerciale, era dei
più affascinanti: progettare un grande spazio per una
sola pelliccia nella centralissima via Chiaia, e su questa linea si è sviluppato l’intervento. Il primo ambiente, aperto sulla strada, doveva accogliere ed invitare
ad osservare l’oggetto esposto. Il secondo, culminante
con una colonna in nero del Belgio, è il ‘luogo dei desideri’, il terzo ambiente, interamente rivestito in calacatta dorata, con una sportelleria guardaroba in ebano
e smalti colorati, aveva due poltrone in velluto dorato,
disposte ai lati della parete specchiante. Le coperture
seguono l’arredamento delle funzioni: il primo e secondo ambiente sono voltati in legno; il terzo è coperto di vetro opaco, illuminato dall’alto. Il legno adoperato per le pareti è la piuma di radica di noce; i pavimenti policromi sono in granito rosa di Svezia, bianco
P e nero del Belgio”.
D’altronde se il pensiero debole con il Post Modern ha precisato l’alleggerimento dell’ontologia a favore del dato interpretativo Nicola Pagliara esclude
ogni possibile alleggerimento dell’architettura. Essa
“si differenzia da discipline e arti analoghe per un ca-
rattere assolutamente unico: la materialità e la consistenza dei suoi risultati. Perciò non è l’immaginario
puro che la definisce, ma elementi che poggiano sul
terreno, e che hanno in peso, un costo e una buona ragione per esistere”. Le sue opere danno la straniante
suggestione di vedere, toccare e sentire un sogno, una
nostalgia, i cui ingranaggi sono chiari fin nella più
minuta scala, che esiste nella compiutezza della natura. Ma in ciò non vi è alcun realismo mimetico, anzi i
suoi oggetti sono chiaramente congegni umani: le sue
opere non nascono dal basso verso l’alto, il racconto
della suggestione tettonica è solo uno dei molteplici
racconti della sua architettura. Esse pesantemente si
saldano al terreno e il peso scrosciante della materia fa
attrito con lo spazio intorno e, quando sfida le leggi di
natura, non dissimula in alcun modo lo sforzo in atto.
Come ogni artefatto umano non vi è fusione possibile,
il cemento è usato alla maniera brutalista, la pietra è
disposta a macchia aperta, l’acciaio è violentemente
bullonato, la lamiera rivettata.
L’architetto nella sua azione demiurgica non può
operare come fysis, non come Dio, possiede però, a
confortarlo, la téchne Il sapere per Pagliara non ha
nulla di violento, la téchne è il gran dono elargito da
Prometeo a costo del sacrificio, è filantropia. Egli sa
che il dono del titano non può eliminare la costitutiva
e originaria inferiorità dell’uomo rispetto al dio perchè
anche tutte le téchnai sono deboli rispetto ad anànche.
L’architettura per Pagliara, d’altronde è in grado, grazie alla tecnica, di inventare memoria, di vincere la
nostalgia, ovvero il desiderio profondo di vivere
un’esistenza che non si è vissuta. Essa trasforma un
mucchio di pietre in costruzione e costruendo realtà
che non esistono, offre una speranza alla nostra esistenza. Il lavoro duro e infaticabile della costruzione è
per questa speranza, il suo preteso realismo nella maniacale resa del dettaglio è per rendere credibile questa necessaria menzogna. Questa la vera colpa e il vero dono di Prometeo, il grande odiatore della morte,
non di avere rubato il fuoco fiammeggiante dal quale
s’impareranno molte arti, ma di avere allontanato gli
uomini dalla morte resi simili al dio. Difatti nel mito
prometeico delle opere classiche la téchne è elpìs, la
speranza. “La costitutiva aporeticità della téchne, il
suo non potere essere altro che un pharmacon, un ‘rimedio che avvelena’, pare essere risolta in ciò che la
speranza conferisce agli uomini: non la salvezza, certo, ma almeno una possibilità di vita, capace di strapparli dall’essere soltanto ephémeroi, dal vivere soltanto un giorno”5. Il lavoro prometeico, incessante, cieco,
nella ricerca della soluzione metafisica dei nodi funzionali è per Pagliara il modo per mantenere viva questa speranza. “Per evitare di lasciare sconnesse le va5
4
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Roma-Bari,
2012.
U. Curi, Per una rilettura del Prometeo incatenato, in Le
parole dell’essere, per Emanuele Severino, a c. di autori vari, Mondadori, Milano, 2005.
lenze funzionali non resta che dilatare ogni volta i
luoghi di contatto tra le funzioni, attribuendo ad essi
una valenza metafisica: qualcosa che resta a metà tra
la realtà e la memoria; che è sogno della potenzialità
funzionale e che dunque, non compare nell’ordinaria
consistenza del comportamento della funzione”. Il dettaglio architettonico, dilatando il tempo della lettura
dello spazio architettonico ci aiuta a intrattenerci il più
possibile, ad addentrarci in questo possibile contatto
con il futuro.
ZAHA HADID E L’ARCHITETTURA TRA REALTA’ ED EVANESCENZA
Mario Coppola
Non esiste un soggetto unico, contrapposto al proprio oggetto. Il confronto – ed anche lo scontro – che insieme
unisce e divide gli uomini verte sulla relazione insolubile di realtà e pensiero, natura e storia, tecnica e vita.
Roberto Esposito
Il dibattito filosofico contemporaneo intorno al
realismo ha senza dubbio un riverbero diretto nella
discussione architettonica, dal momento in cui tocca
un nodo cruciale: che cosa vuol dire “reale”, “tangibile”, “tracciabile” e quindi “realista” nel mondo
dell’architettura? Il tema è scottante, visto che riguarda da vicino quel baratro ideologico tra i fautori
di una libera interpretazione, di una creatività innata
capace di liberarsi da contenitori e codici, e i fautori
di una “obiettività”, cioè della presenza indiscutibile
di alcuni “fatti”, tracciabili per mezzo del loro lascito, e quindi descrivibili per mezzo delle loro orme, le loro tracce oggettive e perciò immuni
dall’interpretazione soggettiva.
L'architettura, lo scenario spaziale dove si svolge
la vita dell'uomo, è l'espressione più diretta e "concreta" della struttura del suo pensiero, ne è forse l'emanazione materiale, una sorta di concrezione spontanea dello spirito. E in architettura siamo abituati a
sentir parlare di funzionalità obiettiva, siamo avvezzi allo slogan “la forma segue la funzione”, ma, senza scomodare Alvar Aalto, sappiamo benissimo come in realtà uno slogan come questo da solo voglia
dir poco o niente, e lo stesso, a ben vedere, vale per
la questione della tracciabilità e della materialità.
D'altra parte, altrettanto note sono le derive della parola "libertà" pronunciata da architetti più o (soprattutto) meno talentuosi e sensibili, sappiamo a quali
scenari si può andare incontro lasciando davvero e a
chiunque libertà di disegno, di modellazione, di manipolazione; è sufficiente pensare agli stradoni che,
usciti dalle città, diventano fiere di orrori giustapposti uno accanto all'altro: qui ci si può imbattere in
una novella "villa savoye", in un tuboloso edificio
"stile Rogers", o in un bunker terrazzato che scimmiotta Falling Water. Risulta per questo senz'altro
comprensibile la necessità di un qualche punto di
riferimento che bilanci il libero arbitrio (il dominio
delle parole sui "fatti"), ed è senz'altro questo il legittimo mordente di Maurizio Ferraris e del suo
"Manifesto del Nuovo Realismo"; tale necessità è
ancora più comprensibile e sacrosanta se riferita al
campo architettonico. Roberto Esposito infatti,
commentando il Manifesto di Ferraris in un articolo
pubblicato su "La Repubblica", a tal proposito puntualizza: “Sul presupposto di partenza del Manifesto
del nuovo realismo di Maurizio Ferraris – il cui contenuto è già ben noto ai lettori di queste pagine - si
può senz´altro convenire. Si tratta della convinzione
che alla fine del ventesimo secolo la filosofia con-
temporanea abbia ruotato intorno al proprio asse, assumendo una diversa inclinazione. Quella che ha
mostrato la corda è l´eredità filosofica della cosiddetta "svolta linguistica" dei primi decenni del Novecento, incentrata intorno al primato trascendentale
del linguaggio. Che a tale primato si attribuisse una
connotazione analitica come in area anglosassone,
ermeneutica in Germania o decostruttiva in Francia,
l´idea che sottintendeva tale concezione era il carattere linguistico dell'intera realtà. Da qui una conseguenza di tipo dissolutivo, che investiva non solo il
reale, risolto in una serie di narrazioni prive di riscontro oggettivo, ma anche la filosofia stessa, dichiarata dai suoi stessi esponenti finita o quantomeno in perenne crisi. Sfuggendole in linea di principio
la presa sull'oggetto, essa non poteva rivolgere la
propria attitudine critica che a se stessa in una sorta
di perenne auto-confutazione. In queste condizioni,
si può dire, essa riusciva ad affermarsi solo negandosi”.1
E' inevitabile e doveroso connettere l'esperienza
architettonica "decostruttiva" europea e americana
allo stesso nodo cui Esposito attribuisce la conseguenza dissolutiva che investe innanzitutto la politica ("l'immaginazione al potere"), incapace e forse
del tutto disinteressata a occuparsi delle questioni
critiche sociali. Basta guardare allo "scatenamento"
avvenuto in architettura con il pretesto della decostruzione e moltiplicarlo alla scala urbana e territoriale per chiedersi con orrore: cosa accadrebbe se le
nostre città fossero composte interamente da scatole
frantumate, con pilastri e architravi storti? Probabilmente la follia di un simile panorama non sarebbe
più gradevole della monotona e mortificante serialità
dei palazzi-cubetto imprigionati nel tracciato ortogonale delle griglie classiche, neoclassiche e moderne delle megalopoli mondiali, e ciò risulterebbe inevitabile proprio a causa del fatto che in realtà, proprio nel voler confutare l'archetipo classico attraverso manipolazioni varie, distorsioni e frammentazioni
(l'esempio migliore è senza dubbio il Peter Eisenman degli anni '70/'80), l'architettura cosiddetta decostruttivista - così come la filosofia decostruttivista
e in generale "linguistica" resta intrappolata in una
perenne confutazione, come scrive Esposito - non
esce affatto al di fuori del dominio dell'autorità che
1
R. Esposito, Le parole o le cose tra Postmoderno e Realismo.
La filosofia non è più in crisi, in "La Repubblica" del 15 Marzo
2012
44
sembra voler combattere, restando in pieno nel guado dello scontro soggetto-oggetto, portandolo solo
alle estreme e peggiori conseguenze.
Durante un seminario a Napoli, Maurizio Ferraris, nella sua lezione-manifesto del Neo-Realismo in
architettura, paragonò esplicitamente la porta divelta
di un treno a una serie di progetti dei più vari e diversi architetti mondiali (decostruttivisti e non), in
una carrellata di immagini che metteva sullo stesso
piano Stirling e Wright, Meyer e Hadid. Ferraris intendeva dire che come la porta era stata divelta perché la sua maniglia (un pezzo di alluminio simmetrico largo quanto la porta stessa, che non lascia capire il verso di apertura della porta) non era funzionale al passaggio, scatenando così la violenza delle
persone contro di lei, allo stesso modo gli edifici
mostrati - tra questi anche il Guggenheim newyorkese di Wright - avrebbero provocato il medesimo
sentimento violento, la stessa disapprovazione e
quindi, in breve, la loro distruzione. Ferraris, cioè,
affermava il mancato realismo di tali architetture, e
il suo c.v.d. era trovato nel fatto che, essendo destinate alla distruzione “democratica”, questi edifici
non avrebbero potuto lasciare traccia di sé, e ciò accadeva proprio perché le loro forme, secondo il filosofo, sarebbero state inadeguate al loro compito (in
particolare, si trattava di musei). Proseguendo il ragionamento suggerito da Ferraris, dal momento che
in fondo nessuna forma "inedita" è all'altezza del
compito della riconoscibilità e quindi del "realismo",
un architetto che volesse praticare una architettura
realistica, in grado di lasciare tracce e cioè di restare
in piedi, dovrebbe semplicemente affidarsi alle forme della storia, alla tipologia classica, perché, ne risulterebbe chiaro, la vera e unica forma possibile per
un museo sarebbe il colonnato, per esempio quello
del Met newyorkese, e l'esedra, giacché dovrebbe
essere risaputo che timpani, triglifi e capitelli scatenano una esaltante voglia di museo e di godimento
dell’arte, che da sempre (e quindi, perché no?, per
sempre) funziona alla perfezione. Insomma, con un
pizzico d’ironia, il tutto si riassumerebbe con un
“cavallo vincente non si cambia”, e d’un tratto ci ritroveremmo tutti in un mondo dove le maniglie delle
porte, in nome del realismo e della riconoscibilità,
sarebbero legittimate ad essere “vignolate”, magari
in ottone con decorazione floreale come quella delle
case dei nonni, dove le porte avrebbero le cornicette
in stile neocoloniale, dove i palazzi, finalmente funzionali e quindi amati dalle persone, tornerebbero ad
essere Palazzi, con tanto di giacca doppiopetto e
cappello, in stile – perché no? – neoclassico anziché
moderno... del resto questo Moderno, apolide, senza
simmetrie (così ben radicate nella storia, così riconoscibili!), senza cornici, senza colonnati storicamente rintracciabili, senza esedre, a cosa ci è servito
se non a dimenticare la nostra identità culturale, il
nostro essere signori occidentali distinti e per bene,
pronti a iniziare una nuova guerra mondiale in nome
del proprio orgoglio nazionale?
Eppure, mettendo da parte l'ironia, viene naturale
chiedersi quale sarebbe il messaggio, la comunicazione o l'ispirazione, a seconda del punto di vista,
che sarebbe promulgata se tutto ciò che ci circonda
fosse e restasse il medesimo in nome della propria
desunta tracciabilità.
Scrive ancora Roberto Esposito: “Ma la questione di fondo che la prospettiva di Ferraris apre è per
me ancora un´altra. Ed è relativa al superamento della svolta linguistica di cui si diceva. Il realismo, per
quanto nuovo, ne è davvero fuori o non è che lo spostamento dall'una all'altra della sue polarità interne?
Non riprende, con altri argomenti, la polemica che
Carnap aveva, da un punto di vista logico-realistico,
rivolto al decostruzionismo di Heidegger? Non resta
dentro il perimetro definito dall´avversario che
combatte? Detto in altre parole, la rivendicazione
dell´autonomia dell´oggetto presuppone necessariamente, come contraltare logico, quella del soggetto
che pure intende contestare”.2 E' evidente allora il
parallelismo con l'architettura "decostruttiva" già citata e quella "realista" a cui accenna Ferraris pur
senza dichiararlo esplicitamente (lo dichiarano più
che esplicitamente i suoi sostenitori "architettonici"!): entrambi si pongono all'interno di una oscillazione che di fatto non genera alcun progresso. Il
problema è assai più delicato e complesso, quello
del realismo in architettura, e certo non può essere
ricondotto alla forma del passato come soluzione ai
problemi della contemporaneità, o, ancora peggio,
alla mera “funzionalità” come se ne esistesse veramente solo una: qual è la funzione dell’architettura?
Che cosa la rende reale, tangibile, materiale, e cioè
in grado di lasciare tracce storiche e di costituire una
realtà nella quale l’essere umano sia felice di passare
i suoi pochi, effimeri giorni?
Aalto l’ha detto diverse decine di anni fa che la
funzionalità è accettabile se e solo se viene estesa al
dominio psico-somatico, il che comporta un salto
infinito da un campo semplicemente ingegneristico e
filologico dell’architettura come contenitore di spazi
riconoscibile ai più all’interno di un dato contesto
socio-culturale, a quello di un’architettura connessa
alla vita umana nella sua accezione più profonda e
spirituale, dove corpo e anima non sono due mondi
separati – dicendolo con un Deleuze già post-decostruttivo – alla maniera cartesiana, ma sono invece
intessuti insieme, indissolubilmente, come suggerisce lo stesso Esposito, proseguendo: “Io credo si
tratti di capire qual è il trascendentale, vale a dire la
categoria costitutiva, che, nel pensiero e nella realtà
– difficilmente separabili, visto che il pensiero non
2
R. Esposito, ibidem.
45
soltanto nasce sempre dentro una data realtà, ma a
sua volta produce realtà – ha sostituito il linguaggio
negli ultimi decenni, se non ancora prima. La risposta che una parte significativa della cultura filosofica
internazionale ha dato a questa domanda è che si
tratta della categoria di vita, nella sua relazione
complessa con la politica e la storia”. 3
Una maniglia simmetrica posta al centro della
porta dimostra semplicemente che il designer che
l’ha pensata non brilla di talento. Invece privare anche solo una maniglia della creatività umana implica
una brutalizzazione: un mondo dove non possiamo
trovare altro da ciò che ci aspettiamo di trovare, esattamente come l’abbiamo sempre trovato perché
quello è l’unico modo possibile, è un mondo che
non vale la pena di essere vissuto, perché è un mondo privo di ricchezze, senza curiosità, senza fantasia
e senza libertà. Una maniglia Bauhaus non solo farebbe ben intendere il verso di apertura della porta
ma, cosa non da poco!, lascerebbe anche i meno
sensibili in estasi mistica, fermi lì davanti alla porta
a domandarsi i perché più profondi della Ineffabile
Bellezza, domandandosi quali siano – visto che esistono di certo – le leggi universali che governano
l’armonia dell’Universo. Se stiamo esagerando è solo per portare a galla una questione che ci sembra
palese ma che forse invece palese non è: non dovrebbe essere il primo compito – ebbene sì, primo e
non secondo all’apertura della porta! - anche dello
spazio in cui ci muoviamo e respiriamo, suggerirci
un progresso umano e civile, spronarci a credere in
un mondo migliore dove la Bellezza si traduce in
coesistenza armonica, in simbiosi tra diversità e in
amore (non semplice rispetto) per l’altro, come parte
inseparabile di sé, amore da nutrire in primis per
Madre Terra, il cui destino ci accomuna inevitabilmente tutti?
Il Guggenheim wrightiano non ha niente a che
vedere con la porta divelta dell’esempio di Ferraris:
il "conchiglione" newyorkese svolge la sua funzione
di museo dell’arte contemporanea infinitamente meglio di uno qualunque dei tantissimi, troppi, bei Palazzi rinascimentali le cui stanze sono state riempite
di opere d’arte; tanto è vero che l'organismo urbano
di Wright è uno degli edifici più amati dagli stessi
newyorkesi e da tutti i visitatori che da sessant’anni
lo riempiono ogni giorno, che non soltanto intendono subito e benissimo quale ne sia l’ingresso e la
funzione, ma che entrati nell’atrio sono in estasi mistica prima ancora di intraprendere la loro ascesa
nella promenade elicoidale. Perché il Guggenheim,
prima ancora di essere un contenitore di opere
d’arte, è un amplificatore, una cassa di risonanza per
la funzione Regina delle funzioni, per la prima vera
funzione dell’architettura del nostro tempo che è
quella di suggerire e sostenere l’incontro delle persone, lo scambio tra queste e con l’ambiente intorno,
suggerendo la preziosità dell’interazione umana,
dell’apertura alla condivisione che diventa continuità tra individui prima separati... altro che l’orrenda e
ottusa porta inapribile!
La domanda che emerge, al di là del genio assoluto wrightiano, riguarda naturalmente la natura di
un'architettura libera dallo scontro reale/irreale, soggetto/oggetto: che cosa ne determina la fuoriuscita, e
in seguito l'appartenenza non al terreno della crisi
(espressa in maniera sublime forse solo dalle architetture lecorbusiane), ma a quello nuovo suggerito
da Esposito e dalla parte di cultura internazionale
cui il filosofo si riferisce? “Cosa deve intendersi qui
per "vita"? Non certo un impulso irrazionale o, tantomeno, una forma mascherata di volontà di potenza, ma esattamente il superamento di quella contrapposizione tra soggetto e oggetto che ha condizionato la filosofia post-kantiana trattenendola al di
qua di una certa soglia epistemica. Da questo punto
di vista autori come Nietzsche, e tanto più Foucault,
indicano una direzione in singolare risonanza con
quella linea di pensiero che è stata definita Italian
Theory. Si tratta della rottura delle classiche bipolarità tra soggetto e oggetto, natura e storia, prassi e
tecnica. Oggi, sia nel campo della filosofia continentale che in quello della filosofia analitica, i programmi di ricerca più promettenti sono proprio quelli situati nella zona di indistinzione, o di oscillazione, tra poli che un tempo apparivano reciprocamente incompatibili. Mai come in questa stagione
quelle che sembrano, e di fatto sono, invariabili della natura umana vengono sussunte e, per così dire,
messe al lavoro, storicizzate, modificate, dalla tecnica in una forma difficilmente riducibile al contrasto
tra interno ed esterno o soggetto e oggetto”.4
La rottura della bipolarità, del continuo fare e disfare, affermare e confutare (viene in mente una
provocazione: forse Le Corbusier, nell'interezza della sua opera, fu il primo e unico vero architetto decostruttivista?) e la conseguente continuità tra soggetto e oggetto, che si fondono insieme proprio in
nome di quella interazione permanente e ininterrotta
che ne fa parti distinguibili ma mai separabili, è certo anche il grande tema intuito da Deleuze sette anni
prima della sua morte, il grande vero lascito del filosofo francese. E’ questo il nostro zeitgeist, la meta
dei nostri sforzi culturali, l’etica del nostro tempo;
nella parola "vita" è racchiuso il cuore pulsante del
paradigma culturale che l'umanità a fatica cerca di
imboccare, e la complessità come "intessuto insieme" ne è l'inevitabile corollario: la vita è una rete
che si correla, una rete dove tutto è connesso, tutto è
interdipendente, non ci sono parti separate giacché,
3
4
R. Esposito, ibidem.
R. Esposito, ibidem.
come spiega Morin, presupposto è proprio che l'io, il
soggetto, non sia affatto indipendente dall'oggetto
così come l'oggetto, nell'indistinzione cui accenna
Esposito, non è mai autonomo rispetto al soggetto.
Un'architettura simile, espressione di questo "paradigma della vita" e della complessità, di certo non
può trovarsi nel fuoco della guerra tra architetti decostruttivi e architetti neoclassici, così come secondo Esposito non è rintracciabile nel confronto
"apparente" tra Ferraris e Vattimo: abbiamo messo a
fuoco il parallelo tra la parabola del pensiero occidentale/europeo (Esposito si riferisce infatti alla filosofia tra Italia, Francia, Inghilterra e Germania),
che pure "contiene" l'ultimo affondo di Ferraris, e
quella dell'architettura sia "tendenziosa" sia esplicitamente e dichiaratamente ispirata alla corrente decostruttiva, di cui i protagonisti indiscussi sono Rem
Koolhaas, Daniel Libeskind, Coop Himmelblau, Peter Eisenman, Frank Gehry e Bernard Tschumi. Il
parallelo è tanto più forte se si mettono in luce i
background dei singoli architetti nominati, tutti legati in un modo o nell'altro alla cultura europea e
molti dei quali diventati "decostruttivi" solo dopo
essere stati estremamente "realisti" (basti pensare ai
"Five"), e risulta quindi chiaro e inevitabile il loro
destino così come quello della filosofia occidentale
avvinghiata senza vie d'uscita su sé stessa, come
scrive Esposito.
C'è però un'incognita, un elemento di imprevedibilità e di incertezza nella descrizione e nella lettura
del panorama generalmente ascritto all'architettura
decostruttivista, si tratta di un elemento che sfugge
alla struttura del parallelismo appena tracciato, e
questa incognita è senz'altro l'irachena Zaha Hadid.
A differenza degli altri architetti decostruttivisti
(Hadid non si dichiara mai tale, nonostante esponga
le proprie opere nella mostra "Deconstructivist Architecture" del MoMA nel 1988 insieme ai sopracitati), Zaha Hadid non affonda le proprie radici nella
crisi del pensiero occidentale, è ben consapevole5 di
5
Zaha Hadid afferma in una intervista con Richard Levene del
1992, pubblicata su «El Croquis» ("Zaha Hadid 1983 2004") , p.
24-25 (traduzione di Mario Coppola): "Il background arabo, ne
sono sicura, non so dove sia. Ero solita ridere quando loro (Rem
Koolhaas e Kenneth Frampton), ne parlavano tanto spesso. Sono
babilonese, cinquemila anni di cultura. Da irachena la mia idea
della storia è molto diversa da quella di un americano. Noi lo
diamo per scontato, è lì. La cultura è proprio attraverso i molti
strati di eventi che hanno avuto luogo nel corso dei secoli. Si
tratta di riproduzione. La calligrafia della pianta, lo sviluppo del
Suprematismo e questa idea di frammentazione per poi dar vita
a un nuovo disegno (...) questi spazi molto fluidi che sembrano
scorrere come una linea, come una frase. Perché io sono noneuropea ho una diversa struttura di pensiero, il mio ordine è diverso. Il Decostruttivismo e le teorie strutturaliste sono basate
sulle cosiddette teorie razionaliste. Non appartengo a quella tradizione. Io appartengo a una tradizione più emozionale, intuitiva. Ma intuitivo non è istintiva. Intuitivo è il matrimonio di razionalismo e di esperienza. Solo poi, dopo molti anni, si posso-
essere aliena alla questione dello scontro tra soggetto/oggetto e quindi all'espressione architettonica
della bipolarità tra "realtà" e "interpretazione"; al
contrario, la cultura nella quale cresce appartiene a
un Iraq in pieno sviluppo economico e culturale Hadid nasce nel 1950 a Baghdad - e lei stessa racconta di aver vissuto una stagione di grandi cambiamenti e speranze di un profondo progresso socioculturale che investì l'intero paese. L'"incognita"
Hadid risulta tale anche dal punto di vista religioso:
come dichiara in una intervista6, la religione non costituisce una impronta particolarmente condizionante, e la scuola dove cresce di fatto è multi-etnica,
multi-culturale e quindi anch'essa priva di un'identità
culturale forte e rigidamente definita. Le più profonde suggestioni, le connessioni profonde che la legano alla sua terra d'origine sono note: da una parte
l'interesse per l'interazione, per la continuità esistente tra gli elementi naturali in perpetuo scambio tra
loro - la Valle dell'Eden, dove s'incontrano Tigri ed
Eufrate, che Hadid riconosce come la sorgente della
sua sensibilità verso la fluidità e il tema dello scambio7 - dall'altra il tema della tessitura, dell'intreccio
forse desunto, come suggerisce Betsky, dalle trame
complesse dei tappeti intessuti dalle donne arabe. A
ben vedere questi due temi sono in realtà uno: si
tratta proprio della complessità, del cum-plexus (intessuto insieme) e cioè dell'unione fisica e insieme
spirituale degli elementi naturali che sono di fatto
inseparabili, legati insieme: anche da questa prospettiva torna la questione della relazione tra soggetto e oggetto. Sembra che fin dal principio nella
visione di Hadid questi convivano senza soluzione
di continuità, senza essere in conflitto e quindi per
no utilizzare logica e intuizione insieme. Devi essere in grado di
farlo contemporaneamente."
6
Z. Hadid afferma in una intervista pubblicata sul numero monografico “Being Zaha Hadid” di «Abitare», n. 511, 2011: "Nella scuola gestita da suore che frequentai gli insegnanti di scienza
provenivano tutti dall’università. Di conseguenza, il livello del
loro insegnamento era decisamente alto. La preside, che era una
suora, teneva molto all’istruzione femminile, tanto da poter essere considerata, in quella parte del mondo, come una vera e
propria anticipatrice. Eravamo tutte mescolate, musulmane, cristiane ed ebree, senza sapere a quale religione appartenesse
l’una o l’altra. Fino a sei anni non avevo una chiara idea di quale fosse la mia."
7
Z. Hadid afferma in ibidem p.70: "Ricordo quando mi hanno
portato a vedere il Malwiya, il minareto a spirale della Grande
moschea di Samarra, costruita nel IX secolo, ossia mille anni
prima degli edifici modernisti che le assomigliano. Facevamo
spesso lunghi giri fra le rovine di Samarra, nella Valle
dell’Eden, dove il Tigri e l’Eufrate confluiscono. Quando sei lì
provi una sensazione di sospensione temporale. Vedi i fiumi e
gli alberi sapendo che tutto è così da 10 mila anni. La sospensione temporale ti invade. C’è uno stupefacente scambio fra terra, acqua e natura che si estende fino a incorporare edifici e persone. Penso che forse al centro del mio lavoro ci sia proprio il
tentativo di catturare quella dinamica di continuità e scambio in
un contesto architettonico urbano a vantaggio delle città contemporanee e di coloro che le abitano."
questo agli albori della sua ricerca spaziale manca
l'interesse per la gerarchia, per il "divide et impera":
i primissimi progetti hadidiani sono dei dipinti che
di fatto restituiscono non soltanto l'immagine del
progetto in fieri ma anche dell'intero contesto urbano e naturale, che non è più lo sfondo di un Palazzo,
quanto piuttosto una parte inseparabile del progetto
che vi si muove all'interno e che lo scuote di rimando sfruttando cinematismi interni alla struttura spaziale preesistente, come avviene nelle discipline fisico/mentali orientali (Kung fu, Tai chi eccetera).
L'intreccio tra realtà e creatività coinvolge insieme
l'ispirazione naturale, materica, e quella astratta,
concettuale, che rimanda al flusso, alla continuità: le
pietre della Valle dell'Eden, l'acqua che vi scorre attorno, la forma del delta fluviale e le trame dei tappeti orientali, sono l'ispirazione materica sulla quale
agisce direttamente la ricerca di quella continuità
senza cuciture (che diventerà slogan dell'architetta)
ritrovata, "all'opposto", nella ricerca pittorica astratta
del Costruttivismo sovietico, in particolare nell'opera di Malevic, che propone una autocreazione dello
spazio bidimensionale e tridimensionale a partire
dalla congiunzione tra la tela, i colori e la percezione
dello spettatore, che viene letteralmente immerso
nell'idea spaziale per esserne carezzato e spintonato.
La fusione finale di materiale e spirituale costituisce il motore originale e genuino di una ricerca
spaziale affatto inedita, che sarà trampolino dell'architetta irachena portandola nell'arco di un decennio
alla conquista del panorama architettonico internazionale, e numerosi progetti costruiti esprimono al
meglio l'intreccio tematico hadidiano.
Il centro per la cura del cancro infantile "Maggie's Centre Fife", costruito tra il 2001 e il 2006 a
Kirscaldy (Scozia), nonostante alcune incoerenze
residue (come i triangoli che forano la facciata), è
tra le prime architetture a esprimere nitidamente il
tema della continuità, nella sua doppia veste di tessitura degli elementi architettonici e di fusione tra materiale utilizzato e concetto alla base. La tradizionale
divisione/separazione degli elementi architettonici
classici (pilastri, travi, finestre, partizioni, eccetera)
composta per mezzo delle geometrie platoniche giustapposte cede il posto a una scocca unica, un guscio
di cemento che acquista leggerezza e identità nel suo
piegarsi pur restando sempre unito, come un origami
giapponese. Anche la ringhiera antistante, in ferro, è
perfettamente leggibile nella sua veste materiale e
insieme in quella "immateriale", dal momento che
anche questa flette, seguendo il movimento suggerito dall'involucro cementizio, per esprimere il tema
dell'apertura. L’intero edificio è modellato in maniera da svasare, dilatando vertiginosamente la propria sezione orizzontale, senza “bloccare” la continuità del landscape come avrebbe fatto un normale
edificio estruso dal suolo: invece la svasatura fa in
modo che l’ambiente naturale penetri nell’edificio in
basso, spingendo verso l’interno, e sia penetrato
dall’edificio in alto, con il vertice che sembra voler
infilzare l’esterno come un arpione, per poi aprirsi
come una ferita nella quale lasciare entrare lo spazio
naturale. In questo modo il cemento e in generale il
materiale architettonico non è un mero "sostegno",
un'impalcatura sulla quale è poggiata una qualsiasi
forma concettuale (come avviene per la nuvola di
Fuksas, prima su tutte) o ingegneristica, ma è insieme struttura e espressione artistica, superficie continua, ininterrotta che evoca senza alcun rimando figurale (proprio come aveva intuito Malevic nella sua
pittura), lo spirito della complessità.
L'"Ordrupgaard Museum Extension", costruito a
Copenhagen tra il 2001 e il 2005, è un altro progetto
notevole: come nel Maggie’s Centre, lo spazio architettonico e il suo involucro non perdono la simultaneità di espressione materica e produzione astratta, priva cioè di alcun rimando a forme e figure
storiche e della tradizione. Il guscio strutturale, ancora una volta in cemento, resta proprietario di un
notevole spessore, che ne suggerisce il molteplice
uso (all'interno del getto in cemento vi è un pacchetto completo che assicura isolamento termico,
acustico e impermeabilizzazione); l'espressione resta
nel fatto che l'involucro si trasforma in un nastro
morbido e flessuoso, che avvolge lo spazio interno
nella sua sezione, come se quest'ultimo avesse la
forza di sostenerne il peso, che di fatto è quasi completamente auto-sostenuto dal guscio di cemento.
Aspetto essenziale del progetto è la trasparenza della
sottile membrana di vetro che distingue senza dividere spazio interno ed esterno: non vi è una reale
contrapposizione tra edificio e ambiente, come già
accadeva per l’architettura organica di Wright, il
fuori e il dentro diventano uno. L’involucro architettonico è un anello di congiunzione che accentua la
continuità scorrendo come una parte del suolo naturale che si è sollevata e arrotolata alla stessa maniera
in cui si formano colline, grotte e poi alberi e funghi,
integrando la funzione umana tra quelle naturali
senza soluzione di continuità, per poi unirsi in maniera diretta, a-gerarchica, con il museo preesistente
di cui il progetto hadidiano è espansione. Il risultato
finale dell'operazione progettuale consiste nella perdita totale della separazione tra pavimento, pareti e
tetto: scompare la figura trilitica e il materiale architettonico acquisisce contemporaneamente funzione
tecnica (di pelle strutturale e protettiva) e spirituale,
avvolgendo i visitatori, riuniti all'interno di un unico
drappo che si flette per accogliere il loro ingresso e
il loro soggiorno, in una interezza complessiva che
allude ancora una volta a quella continuità interindividuale di cui scrive Esposito.
Infine, il progetto per un piano dell’hotel Puerta
America, posto alle porte di Madrid e costruito tra il
2003 e il 2005, costituisce un esempio limite, quasi
un anello di congiunzione tra il dominio della complessità e quello dell’immaterialità intesa come sbilanciamento tra soggetto e oggetto a favore (o a sfavore) del primo. Il piano, con le sue trenta stanze,
mescola simultaneamente la fluidità, leggerezza e
scorrevolezza del corian, un materiale nuovo, composito (2/3 di alluminio e 1/3 di resina), che rende
possibile portare negli interni la stessa plasmabilità
che il cemento garantisce agli esterni, evocando
l’armonia di una grotta subacquea, la roccia più mastodontica resa curva e setosa dallo scorrere dell'acqua. L’impressione del visitatore è di essere immerso in un fluido che azzera la distanza tra il contenitore esterno e il proprio corpo, aumentando esponenzialmente il contatto sensoriale, spingendolo al limite, sulla soglia dell’erotico. Il corian naturalmente
fa la differenza: ad un primo impatto la percezione è
quella di una superficie immateriale, quasi frutto
della proiezione di un congegno fantascientifico che
rende tridimensionale un modello digitale. Ma una
volta toccato, guardato nel dettaglio della sua microporosità già suggerita dai riflessi, che ricorda un
marmo pregiato, il corian (materiale ibrido, insieme
naturale e artificiale) chiarisce la sua natura e perde
l’evanescenza iniziale, diventando un guscio materico corposo, sul quale è agevole sedersi, o anche
stendersi, che avvolge il corpo come un tessuto
morbido nel quale è piacevole distendersi, affidandosi del tutto al “fluido” nel quale si fluttua quasi
senza peso.
Si tratta di progetti che affrontano in maniera diversa ma sempre insieme e in maniera smagliante,
due nodi cruciali dell’architettura della complessità,
comunicandone lo spirito in maniera efficace.
Il primo riguarda il “distacco” dell’architettura
occidentale tradizionale tra edificio, inteso come ente a sé, e contesto urbano o, soprattutto, naturale: è il
primo elemento di disgiunzione, la prima espressione del conflitto soggetto/oggetto espressa fin dalla maniera serena, classica neoclassica e storicista,
arrivando a quella della crisi della società occidentale (raggiungendo l’apice lirico con villa Savoye) e della “decostruzione”. Hadid risolve questo
nodo nei progetti trattati e in altri ancora, ricucendo,
proprio come una tessitrice, il legame tra edificio e
sito, tra soggetto architettonico e oggetto contestuale, plasmando un ambiente complesso, ricco di correlazioni. Se il primo aspetto riguarda la relazione
tra ambiente ed edificio, il secondo riguarda direttamente la relazione tra edificio e essere umano: anche qui, l’architettura hadidiana non pretende di porsi come “altro”, “realistico” o “surreale”, austero e
didattico o ribelle e provocatore, ed il legame tra il
corpo architettonico e quello umano è evidente, diretto. E’ possibile ritrovare nella necessità di interazione, di correlazione, di connessione di questi pro-
getti la stessa necessità della nostra generazione, il
bisogno di “fare rete”, di vivere nella network (reale
e digitale) di chi vive in prima persona il crollo della
stabilità garantita, della vita prevista a lungo termine; di chi non ha altra via di salvezza che la collaborazione con gli altri per evitare di affogare nella vita
liquida che descrive Zygmunt Bauman.
Senza dubbio la geometria complessa, unita ai
materiali plastici, che si lascia alle spalle le figure
platoniche da comporre per addizione, sottrazione,
intersezione e giustapposizione, è indispensabile per
la resa di una continuità che vive nell’interdipendenza delle forme ciascuna seguito e inizio dell’altra, come avviene per gli organismi viventi, in una
bio-architettura che ricorda insieme gli scritti di bioontologia di Roberto Esposito (tra cui “Bios. Biopolitica e filosofia” edito da Einaudi nel 2004), gli
stormi di rondini e le efflorescenze subacquee.
Sembrerebbe, a questo punto della lettura, che
Hadid abbia tutti i numeri per essere una vera testa
di ponte per la cultura architettonica mondiale, per
costituire l'avanguardia architettonica del paradigma
della vita di cui abbiamo detto. Eppure, la bipolarità
della formazione hadidiana, a cavallo tra Iraq e Londra, dove studia all’Architectural Association allieva
di Rem Koolhaas – immergendosi di colpo proprio
in quella cultura occidentale post-moderna da cui le
sue origini sono lontane – viene a galla e non può
non rimbalzare nella sua produzione, producendo
ambiguità e contraddittorietà estreme, che non di rado conducono i progetti (soprattutto quelli più recenti) in territori del tutto estranei da quello fin qui trattato, sviando la stessa Hadid.
Se si guarda al progetto per le stazioni di Innsbruck come caso esemplificativo, non si può non
restare decisamente perplessi dall’accostamento tra i
basamenti in cemento – che sembrano quasi esplicitamente organici, espressionisti, discendenti della ricerca a cavallo tra Mendelsohn e Saarinen – e i gusci soprastanti. Questi ultimi, fatti da pannelli in fibra di vetro a doppia curvatura, sono del tutto privi
di corporeità, soprattutto sovrapposti ai corpi in cemento, e risultano un manifesto di distacco, una incoerenza profonda che cambia di segno la fluidità
delle curve che li descrivono. Un baratro, tra corpo e
intelletto – quello sbilanciamento a cui giustamente
si oppone Ferraris, anche se dal fronte opposto – a
favore di una fantasia tratta fuori dalla realtà, avulsa
da questa al punto tale da risultare infine disumana: i
pannelli riflettono completamente l’ambiente circostante restandone di fatto all’esterno, e il contrasto
tra questo vetro curvato al limite delle sue possibilità
e il cemento, che segue dettami linguistici così diversi (e molto più comprensibili), genera una bipolarità fortissima, che disorienta finendo per esprimere
un’estraneità, una completa immaterialità che diviene evanescenza. Le coperture sono dei finti faz-
zoletti che fluttuano sui piedistalli di cemento, e nonostante siano conformati per suggerire il movimento della funivia, per seguirne il dinamismo aprendosi
sulla vallata, non mostrano la minima connessione,
la minima relazione con la struttura che pure li sostiene, che finisce col sembrare una preesistenza alla
quale il progetto volta le spalle, appoggiandovisi
fingendo di non toccarla, mascherando persino gli
incastri reali necessari all’ancoraggio, in una composizione che comunica una distaccata indifferenza,
una scultura che venga poggiata su una base anonima paradossalmente opera dello stesso scultore. Si
tratta di una vera e propria idiosincrasia, una contraddizione profonda che tradisce il senso relazionale, spezzando la continuità per esaltare invece
lo strumento, la tecnica digitale e strutturale in grado
di realizzare una struttura tanto complicata.
Nella oscillazione hadidiana la complessità cede
il passo a un malcelato feticismo per gli strumenti di
modellazione digitale, che riduce il progetto al tentativo di massimizzare la complicazione superficiale
e geometrica in nome di una interazione che in realtà
diviene mero alibi, una giustificazione per legittimare la volontà di spingere alla massima velocità la
macchina digitale parametrica. Molti altri progetti
manifestano questa profonda incoerenza semantica,
e quanto più potenti diventano gli strumenti di modellazione digitale tanto più frequente diventa il totale distacco dal tema della complessità: i progetti
diventano così pure visualizzazioni, del tutto prive
di connotazione materica, perdendosi nella costruzione virtuale e nella morfogenesi automatica diventando composizioni aliene, del tutto distaccate dal
corpo reale dell’essere umano, lontane anni luce
dall’espressione del legame con l’oggetto che perde
ogni identità e diviene sfondo, risultando in una perdita totale di contatto tra la linea dello spirito e il
corpo della materia, tra la carne e il pensiero.
In conclusione potremmo dire che nonostante il
tema della complessità, dell’intreccio e della tessitura sia il cuore profondo del background e della
sensibilità di Zaha Hadid, probabilmente quell’intuito emozionale che l’architetta irachena si attribuisce,
contrapponendolo alla struttura logica del pensiero
occidentale, non è sufficiente a contrastare la deriva
tecnicista, quella tendenza pure umana ad innamorarsi dello strumento, che lentamente prende il posto
del tema, dello spirito profondo. Quella ricomposizione di soggetto e oggetto che pure Hadid in molti
progetti e in generale nel suo approccio sembra avere ben intuito finisce con l’essere messa da parte, in
uno spostamento dell’attenzione che scivola dallo
spazio come insieme inseparabile di materia e spiritualità alla generazione di una complessità fittizia,
che più che complessità diventa semplice complicazione priva ormai di ogni carattere umano, in una
operazione creativa che non è più al di fuori del con-
flitto soggetto/oggetto, ma che al contrario ne torna
del tutto invischiata dal momento in cui il solo scopo
diviene l’artificio, la genesi di un artefatto immateriale che risulta evidentemente separato, scisso
all’interno del monitor del computer o costruito costringendo le tecniche ingegneristiche a sfornare
forme artificiali che mancano di qualunque legame
con l’umano. Così, privo di alcuna matericità,
l’opera non riesce ad innescare alcun godimento reale, e finisce per non suggerire alcuna elevazione spirituale, alcun progresso, restando una suggestione
del tutto aleatoria, arbitraria, unilaterale.
Forse, viene da dire, quell’intuito emozionale da solo non può condurla che a metà strada, alle porte del
paradigma della complessità che però, per essere
davvero valicate, necessitano probabilmente di un
riconoscimento esplicito dei termini della questione
pur nella sua inestricabile complessità, assumendo
una posizione teorica chiara e decisa che, forse, impedirebbe alla creatività di perdersi in un dominio
astratto e artificiosamente immateriale.
50
IL NEW REALISM E LA FINE DEL POSTMODERN
Francesca Buonincontri
Il mondo attuale è attraversato da cambiamenti così
profondi da rendere tutti consapevoli della fase di
transizione che sta investendo ogni aspetto della vita,
dalla politica alla finanza, dall’arte, alla letteratura,
alla filosofia. Nella riflessione filosofica i segnali
della necessità di un cambio d’epoca sono stati colti
da Maurizio Ferraris, il quale intravvede un passaggio
dal postmoderno costruttivista, basato sul perdersi
della realtà nelle sue interpretazioni, ad un nuovo
realismo, inteso come
innovativo strumento di
confronto con il mondo, volto al recupero della
autenticità dei fatti.
La sfida di Ferraris, rivolta anche nei confronti del
'pensiero debole' del suo maestro Gianni Vattimo,
contrappone ad un postmoderno scettico nei riguardi
di certezze e grandi narrazioni, la necessità di
accettare il sapere, la verità e il reale per non scegliere
“l’alternativa, sempre possibile, che propone il Grande
Inquisitore: seguire la via del miracolo, del mistero e
dell’autorità”.
Nel Manifesto del nuovo realismo1 Ferraris
contrappone, alle “interpretazioni”, una realtà oggettiva, un mondo reale fuori dai nostri schemi cognitivi,
dunque, “non emendabile”, cioè duro e puro, “un nonio cocciuto e indifferente”2, indipendente da linguaggi, concetti, interferenze intenzionali. E spera che il
recupero della concretezza possa servire ad evitare il
pericolo di derive nichiliste derivanti dagli attuali
crolli di miti finanziari, sociali, politici, causati,
almeno in parte, a suo parere, proprio dall’assenza
del ruolo oggettivo della realtà legata al postmoderno.
Vattimo riconosce che “la trasformazione postmoderna realisticamente attesa da chi guardava alle
nuove possibilità tecniche non è riuscita” e da questo
deduce “che siamo in balia di poteri che non vogliono
la trasformazione possibile.”3 Prende atto non che “il
postmodernismo è una balla” ma che sono fallite le
sue speranze. Accetta che i fatti siano cogenti ma
pensa che non potranno mai offrirsi oggettivamente in
modo da consentire di battersi per cambiare il mondo,
perché anche per la loro lettura, e quindi per la loro
interpretazione, “sarà sempre questione di lotta e di
potere”. La discussione tra filosofi non è solo teoretica
ma si riflette in conseguenze politico-culturali diverse,
il postmoderno, offrendo grande importanza al potere
liberatorio della dissoluzione della realtà in molteplici
1
M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, 2012.
M. Ferraris, Estetica come “aisthesis”, in Dopo l’Estetica, a cura
di L. Russo, Aesthetica Preprint, 2010, p. 111.
3
M. Ferraris, L'addio al pensiero debole che divide i filosofi, La
Repubblica, 19 agosto 1211.
2
prospettive e in differenziate narrazioni, non riconosce
una verità unica, derivata da dati oggettivi, ma tante
interpretazioni che variano secondo i punti di vista e
ciò comporta, per i realisti, il rischio di strumentalizzazioni per populismi mediatici e manipolazioni.
Il ritorno alla realtà di Ferraris si pone quindi “a
fotografia… di uno stato di cose”, rappresenta
soprattutto una proposta per riflettere ed indica, in
certo modo, la chiusura del periodo postmoderno in
cui si è visto il prevalere del reality, “una quasi realtà
con forti elementi favolistici”. Il nuovo realismo
propone in tal modo il racconto della storia degli
ultimi anni, il racconto “di una svolta: l’esperienza
storica del populismo mediatico, delle guerre post 11
settembre e della recente crisi economica” che
avrebbe portato, secondo Ferraris, ad “una pesantissima smentita di quelli che.. sono i due dogmi del
postmoderno: che tutta la realtà sia socialmente
costruita e infinitamente manipolabile, e che la verità
sia una nozione inutile perché la solidarietà è più
importante della oggettività”. Se il postmoderno può
ritenersi concluso senza, purtroppo, aver raggiunto
“gli esiti emancipativi profetizzati dai professori”, lo
stesso filosofo, tuttavia, non ne disconosce l’importanza, non tanto nel campo filosofico quanto nell’arte,
nell’architettura, nella letteratura e nel cinema, e
considera che la rilettura del “postmoderno filosofico
in nome del nuovo realismo non significa minimizzarne l’importanza estetica ma anzi, proprio al
contrario, valorizzarla, distinguendola dagli effetti
collaterali del postmoderno filosofico trasformatosi in
populismo politico”.
Secondo Ferraris la degenerazione dell'utopia
postmoderna in populismo mediatico ha comportato la
necessità di una riflessione, con la conseguente
individuazione di “incongruenze filosofiche” tali da
portare alla concezione del postmoderno come
costruzionismo, nel senso che la realtà non è mai data
ma è frutto di costruzioni concettuali capaci di
sostituirsi a lei e di determinare un mondo liquido,
senza certezze, in continua trasformazione. “Nel
mondo non esistono fatti, ma solo interpretazioni”,
aveva sostenuto Nietzsche, contrapponendo una
volontà incondizionata dell’uomo alla razionalità
illuministica, e la frase, tanto ripetuta negli anni
Ottanta, non appare più credibile ai nostri giorni che,
nell’impossibilità a poter raggiungere le cose,
richiedono un 'nuovo realismo', la transizione verso l’
'età di autenticità' di Edward Docx.
Questa transizione, unita alla storicizzazione del
Postmoderno, come riconosce lo stesso Docx, permet-
51
tono di presentare in modo compiuto il movimento e
ne consentono una lettura distaccata.
Il proposito di esporre e sintetizzare un movimento particolarmente complesso, che è ancora considerato “un argomento tossico”, è alla base della mostra
aperta il 24 settembre 2011 al Victoria and Albert
Museum di Londra: “Postmodernismo. Stile e
Sovversione (1970-1990)”, curata da Glenn Adamson
e Jane Pavitt, riproposta al Mart di Rovereto, dal 25
febbraio al 3 giugno 2012. L'esposizione si propone di
dare risposte alla domanda su se “il postmodernismo è
solo ciarpame o un movimento glorioso?” e all'interrogativo che si era posto, già nel 1985, il critico d'arte
Hal Foster: “Il Postmodernismo esiste davvero, e se è
così, cosa significa? È un concetto o una pratica, una
questione di stile locale o tutto un periodo o una
nuova fase economica? Quali sono le sue forme, i suoi
effetti, il suo posto?”4 L'esposizione, collegandosi
idealmente a quella del 2009 “Cold War, Guerra
fredda 1945-1970”, mostra, attraverso numerosi
oggetti che coprono un arco di tempo che va dagli
anni Settanta, periodo cupo, di recessione economica
e turbolenza politica, fino agli anni Ottanta, di un
nuovo boom economico, come nel postmoderno tutto
è attendibile e come sia stato possibile far convivere
design lussuoso e materiali grezzi, architetture
classiche e forme eccentriche. L’intento è quello di
presentare l’arte, l’architettura, il design, la moda di
quegli anni individuando il legame che tiene insieme
tanti oggetti diversi, dai progetti architettonici degli
anni Settanta alle teiere Alessi degli anni Ottanta e
Novanta, ovvero di capire le ragioni della fine del
movimento che, per i curatori, è stata causata dal peso
schiacciante del suo stesso successo.
Il postmodernismo, irritante per molti, scherzoso,
divertente, intelligente per altri, è stato infatti lo
“stile” predominante della fine del secolo e la sua
influenza è arrivata ovunque, da Madonna a Lady
Gaga, da Paul Auster a David Foster Wallace, sino ad
essere una tendenza artistica vera e propria che è
riuscita ad assumere significato sociale e politico.
Il termine “postmodern” fu utilizzato in filosofia,
come è noto, nel 1979 da Jean Francois Lyotard nel
libro La condition postmoderne in cui veniva posta la
fine delle grani narrazioni, quella che con una
locuzione comune si dirà fine delle ideologie, fine
cioè di ogni aspirazione a determinare il reale.
Umberto Eco ricorda come il termine invece nasca
negli Stati Uniti, nel 1976, ad opera di Charles Jenks,5
nell'ambito delle teorie dell'architettura ed è rivolto ad
indicare il più leggero ed ironico ricorso dei progettisti
alla storia, negata dal modernismo. In realtà l’architettura postmoderna può farsi risalire alle esperienze
4
H. Foster, (a cura di) L'antiestetica. Saggi sulla cultura
postmoderna, Introduzione al postmoderno, Postmedia books.
5
C. Jenks, The language of Post-modern Architecture, Rizzoli,
N.Y, 1977.
degli anni '50 con alcuni progetti esemplari che hanno
ispirato quelli della seconda metà degli '70 che
diedero vita ad un vivace dibattito sulle nuove
estetiche urbane (da Robert Venturi, Imparando da
Las Vegas, 1972, considerata la Bibbia dell'architettura postmoderna, libro che ha cambiato il corso
della storia dell’architettura, in cui vengono contrapposti i valori dell’inclusione, et et, a quelli dell'
esclusione, aut aut, attraverso le immagini della Strip
di Las Vegas, a Charles Jenks, a Paolo Portoghesi,
Postmoderno. L’architettura nella società postindustriale) in contrapposizione polemica al razionalismo
e al funzionalismo, alla semplicità e al minimalismo,
proposti dal Primo Novecento fino a tutti gli anni
Sessanta. Il postmodernismo architettonico, cioè,
spezza il legame, ritenuto indissolubile nel Moderno,
tra ragione e progresso, non riconosce più il nuovo
come valore, rinnega il postulato coniato da Adolf
Loos secondo cui “ornamento è delitto” ed utilizza la
storia come un gigantesco deposito di stili da cui
trarre citazioni, riutilizzabili in modo decontestualizzato.
Per Pavitt, se il Modernismo, respingendo il
passato come reazionario, aveva puntato sul
progresso, “il Postmodernismo recupera gli stili
storici, li riduce in frammenti e li fonde con il
vocabolario moderno creando effetti anticonformisti.
Così come fa a pezzi la cultura più alta e quella pop
per ricomporle in uno strabiliante pastiche”. E il pastiche è stato, per più di un ventennio, nell’Occidente
globalizzato, il linguaggio di cui si è servito l’architettura per rivolgere una critica aspra alla dottrina
rigida del Modernismo, rilanciando la creatività
dell’artista. Il Postmoderno si è così servito
dell’artificio per creare forme esagerate, bizzarre,
complesse, dai colori vivaci e contrastanti dando vita
a travestimenti che si spingono nell’ironia.
Se il Movimento Moderno aveva sognato, con le
sue utopie, di trasformare la società per poi esaurirsi
nella cultura di massa, il postmoderno rinnega ogni
contenuto utopico in nome dello stile, diventato non
più solo loock, ma “atteggiamento di vita, modo di
comportarsi, di essere sovversivi”, sì che, sempre
secondo Edward Docx, “mentre il modernismo predilesse una profonda competenza, ambì ad essere
europeo e si occupò di universali, il Postmodernismo
ha prediletto prodotti di consumo e l’America ed ha
abbracciato tutte le situazioni politiche al mondo”.
L'elemento ironico accomuna il postmodernismo
architettonico a quello letterario, “almeno come era
stato teorizzato negli anni Settanta da alcuni narratori
e critici americani come Barth, Barthelme, Fiedler.
Se il moderno appare seguire il Nietzsche della
Seconda Inattuale, sul danno degli studi storici, il
postmoderno inventa uno stile di vita con un nuovo
linguaggio, formato dalla fusione di elementi del
presente con quelli del passato, di motivi colti con
quelli popolari e assembla, con grande ironia e poco
rispetto verso il passato,Venezia e motel, Versailles e
stazioni di servizio, colonne greche, mosaici paleocristiani e chioschi, lastre barocche e cartelloni
pubblicitari6. Esso introduce, rispondendo ai fenomeni
della “società liquida” e alle conseguenti continue
mutazioni delle città e dei territori, un profondo
mutamento del ruolo e del significato dell’architettura
e consapevole della ‘relativizzazione' e 'pluralizzazione' culturale cerca la corrispondenza tra una
etica ed una estetica nuova in una società trasformata
da grandi cambiamenti materiali-tecnologici-economici.
Il postmoderno non riconosce più il nuovo come
valore assoluto, spezza il legame, ritenuto indissolubile nel Moderno, tra ragione e progresso, rinnega i
postulati modernisti che ponevano la dipendenza della
forma dalla funzione senza prediligere il prevalere del
processo tecnico nella sua coincidenza con il progetto
che escludeva ogni aggiunta decorativa. E’ pertanto
anche per il suo pluralismo che la mostra allestita da
Glenn Adamson e Jane Pavitt è ricca di centinaia di
oggetti, progetti, materiali e documenti che spaziano
dal design alla musica, dall’architettura alla moda,
dalla grafica editoriale e musicale, agli accessori, “in
un tripudio di vanità dell’epoca reaganiana e
thatcheriana quando ogni forma d’arte danzava
appassionatamente con il Kitsch, con l’orpello, con la
tecnica della giustapposizione, col collage e la
citazione.”7 Il liberismo economico di Reagan e della
Thatcher, attraverso la creazione di nuova ricchezza, è
stato, secondo Pavitt, “uno straordinario motore del
Postmodernismo... In cerca di un proprio stile,
desiderosi di costruirsi un'identità con marchi esclusivi, gli yuppy sono i primi clienti del design anni
Ottanta” i quali, non potendosi permettere un intero
edificio firmato da una archistar, ripiegano su di una
lampada o un piatto disegnati da Gerhy, Isozaki, Aldo
Rossi. Diffondendosi poi velocemente con la pubblicità, le copertine dei dischi, le riviste di moda, il
design, gli spettacoli delle pop star, il Postmodern ha
saputo offrire oggetti di desiderio e consumo di massa
e attraverso le sue operazioni di taglia e incolla degli
elementi più vari e differenti tra loro ha dato vita ad
articoli, progetti, abiti, pensati per stupire ed essere
fermati in scatti fotografici da cui trarre innumerevoli
imitazioni.
Nel periodo della sua massima diffusione il suo
stile era riconoscibile in grattacieli, oggetti di design,
tagli di capelli, abiti, passi di danza, grafiche, musica,
cinema, nelle costruzioni di Portoghesi, le teiere
colorate di Ettore Sottsass, il cinema di Ridley Scott
(il cui Blade runner è un mix di fantascienza, noir,
giallo, in una Los Angeles del 2019 che è insieme la
Shangai degli anni Trenta e la Tokio modernissima
con inserti di colonne greche, statue egizie ed
automobili dell’immediato dopoguerra), la moda di
Karl Lagerfeld e di Vivienne Westwood con elementi
etnici, motivi da Far West e pirati, la musica pop di
Cinzia Ruggieri o di David Byrne il cui costume
oversize “Big Suit” indossato da nel video/documentario Stop Making Sense del 1984, girato durante
il concerto dei Talking Heads, si gonfia con micro
ventilatori, il look di Boy George o Annie Lennox, i
video musicali di Laurie Anderson e Grace Jones che
con Leigh Bowery è stata la perfomer musa di questo
movimento, i giradischi del dj Grandmaster Flash,
l’inventore dello scratch e del cutting, la copertina
dell’album dei Kraftwerk (Die Mensch Machine.),
l’arredo urbano di spazi pubblici disneyficati. Alcuni
oggetti di design, onde non offrirsi alla storia, sembrano creati per autodistruggersi come lo stereo di
cemento di Ron Arad o i mobili di Gaetano Pesce, ma
il più delle volte e, in special modo le produzioni del
design italiano, si caratterizzano per “...un fuoco
d’artificio di sedie a pois, teiere con le ali, elettrodomestici da fumetto.”(Pavitt).
Ettore Sottsass e il gruppo Memphis, da lui fondato
nel 1981, propongono oggetti giocattolo, pieni di
colore, come la lampada Super disegnata da Martine
Bedin, blu con ruote e lampadine,”da tirarsi dietro
come un cane”. La sedia Proust, prima opera esposta
nella mostra, è una gigantesca poltrona settecentesca
decorata con il puntinismo di Paul Signac realizzata
da Alessandro Mendini, l’architetto milanese che con
la sua rivista «Domus» contribuisce alla diffusione
del postmodernismo nel mondo e, insieme allo Studio
Alchimia, da lui fondato, realizza totem riadattando
oggetti esistenti.
Per Docxs8 la mostra segna ufficialmente la data
della fine del postmoderno e alla domanda: “come
sappiamo che il postmodernismo è alla fine, e
perché?” risponde che, anche se nelle arti l’impatto
del postmodernismo è ancora presente esso rappresenta solo una delle possibilità che si possono utilizzare, “perché tutti noi siamo sempre più a nostro agio
con l’idea di avere in testa due concetti inconciliabili:
che nessun sistema di significato possa detenere il
monopolio sulla verità, e che nondimeno dobbiamo
riformulare la verità tramite il nostro sistema scelto di
significati.”
Il percorso espositivo della mostra, che parte da un
oggetto di design e si conclude con le parole di una
canzone riprodotte sul muro del museo: Why can't we
be ourselves like we were yesterday - di Bizarre Love
Triangle, una canzone dei New Order del 19869, ci
6
8
U. Eco, Il realismo minimo, in "La Repubblica", 11 marzo 2012
U. Nespolo, Postmoderno, non idee ma vetri rotti, in “La
Stampa.it”, 21 ottobre 2011).
7
E. Docx, Addio postmoderno, "La Repubblica", 3 settembre
2011.
9
"Perché non possiamo essere noi stessi come eravamo ieri?" La
canzone si è posizionato al 201° posto nella classifica di Rolling
riconferma che il Postmoderno, utilizzando forme
spettacolari con i primi mezzi multimediali, ha ricercato effetti choc, secondo l’ispirazione dal Dada, dal
Surrealismo, dalla Pop Art, dal punk. La grande scritta
luminosa “Protect me from what I want”, che Jenny
Holzer riprodusse nel 1982 a Times Square, appare
verso la fine della mostra a segnare la chiusura del
postmodernismo, fagocitato dallo sfrenato consumismo degli anni Novanta, e, a sottolineare come il
denaro fosse diventato la sua spinta propulsiva, ecco
imporsi nella sala la serigrafia di Andy Warhol, con il
grande simbolo del dollaro.
Scrive Ferraris, “La morte dell’arte profetizzata da
Hegel due secoli fa si è realizzata alla perfezione”,
anche se “riguarda solo l’arte visiva che si autocomprende come grande arte concettuale, o post concettuale, mentre altre arti stanno benissimo e ne nascono
di nuove”, in una asserzione forse non del tutto
condivisibile cui segue però una più interessante
domanda: “cosa ci sarà dopo e se il dopo è già qui?”.
Stone del 2004 che elencava le cinquecento canzoni più belle di
tutti i tempi.
LA CONTEMPORANEITÀ MATERICA DI ALBERTO BURRI
Brunella Velardi
Passata è la tempesta:/[…]Si rallegra ogni core. / Sì dolce, sì gradita
quand'è, com'or, la vita? / quando con tanto amore / l'uomo a' suoi studi intende?
o torna all'opre? o cosa nova imprende?/ quando de' mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d'affanno;/ gioia vana, ch'è frutto / del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte / chi la vita abborria; /onde in lungo tormento, / fredde, tacite, smorte,
sudàr le genti e palpitàr, vedendo / mossi alle nostre offese / folgori, nembi e vento[…].
Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta
Una materia che si fa quadro, una tela ricoperta
di tessuto grezzo, sacco di juta. Tutta la vita, la fatica, il lavoro di quel sacco incollato tra campiture di
colore, diventa esso stesso campitura di un vissuto1.
E’ un frammento di realtà che si fa arte, non come
nei collage, in cui ogni ritaglio mantiene il suo ruolo
di sempre, poiché qui il brandello è nobilitato, innalzato a espressione artistica. L’impatto è forte, il colore è acceso, gli squarci della juta evidenti. E’ un
connubio di sofferenza e bellezza, una ferita bendata
con mezzi di fortuna: l’esperienza dell’artista è testimonianza storica 2.
Alberto Burri era medico, e come tale operò durante la seconda guerra mondiale. Si direbbe che sulle sue tele ha saputo riportare le lacerazioni di un’
epoca, lacerazioni così profonde e dolorose che non
basta il lavoro di un solo medico per guarirle; e infatti sono lì, aperte, ancora sanguinanti, ben oltre la
fine della guerra. È a partire dai primissimi anni ’50,
infatti, che nelle sue opere si attesta “una materia
che resiste a tramutarsi in forma e sembra invece animata da una vitalità sofferta e turbolenta”3. Le suture segnano i contorni di figure vagamente geometriche, come a voler ricordare che quel mondo offeso
e distrutto un tempo aveva un ordine, o almeno lo
ostentava un po’ maldestramente, tradito da tutti
quegli squarci. Se Sacco 5P del 1953 ci rivela tutta
la crudezza della carne viva, in Sacco e Rosso del
’54 l’ampia campitura monocroma fa risaltare la
rozzezza e l’invadenza della juta che si accumula sul
piano come un denso impasto di tempera e sabbia.
Con queste caratteristiche, Burri si inserisce,
seppure in contesto italiano, nella corrente denominata da Michel Tapié Informale, di derivazione fran1
“L’oggetto che Burri compone con quelle strane materie non è
né figurazione né rappresentazione […]; è un quadro o, se si
vuole, la finzione di un quadro, una sorta di trompe l’œil a rovescio, nel quale non è la pittura a fingere la realtà, ma la realtà a
fingere la pittura”, Giulio Carlo Argan, Alberto Burri, in XXX
Biennale Internazionale d’Arte, catalogo della mostra, Venezia,
giugno-ottobre 1960, Stamperia di Venezia, Venezia 1960, p.65.
2
Per riprendere le parole di Maurizio Calvesi: “L’opera e la poetica di Burri nascono dall’esperienza matura e amara di una
vita”, in M. Calvesi, Le due avanguardie, Lerici, Milano 1966,
p. 383.
3
C. Zambianchi, Arte contemporanea: dall’espressionismo astratto alla pop art, Carocci, 2011, p.80
cese4. In particolar modo, l’uso del colore in chiave
quasi scultorea, volto a modulare la superficie fino a
raggiungere l’effetto di un bassorilievo, che si manifesta già nei suoi primissimi dipinti figurativi e precedenti all’inserzione dei sacchi (si veda Nero I del
1948), è riconducibile alla tecnica con cui Jean Fautrier compone i suoi otages a partire dagli anni ‘40,
nonché, poi, a opere come Petit object sympathique
del 1958, in cui si sovrappongono sulla tela colla,
colore, cera e polvere di pastello, ricordando la sperimentazione multimaterica burriana.
Se i sacchi sono il banco di prova, la sua sperimentazione in campo materico va ben oltre, con le
numerose serie che seguono. L’artista si confronta
con tecniche di lavorazione e assemblaggio più avanzate: dapprima cucitura e incollatura, poi saldatura, poi combustione, associate di volta in volta a
sacchi, legni, ferri, catrami, plastiche e colle.
L’impatto percettivo delle Combustioni, che hanno inizio nel 1954 e coinvolgono carta, sacco, legno
e plastica, è diverso e in qualche modo associato a
quello provocato dai sacchi: gli squarci non si configurano più come ferite nuove in una carne ancora
sanguinolenta, ma vecchie escoriazioni annerite dalla cancrena, su un corpo ormai decrepito. Le plastiche sciolte si ammassano sulla tela come pelli cadenti, concrezioni di urla munchiane.
Alla dicotomia materia-colore Burri aggiunge qui
l’azione dell’elemento fuoco, che diventa artefice di
un risultato non del tutto controllabile dall’artista. In
Combustione L.A. del ’65 l’effetto del fuoco è accentuato da una campitura nera sul supporto ricoperto di cellotex su cui la plastica è stata incollata. In
questo modo sulla superficie si apre ciò che è allo
stesso tempo una bruciatura e un vuoto senza fine,
che sfonda la piattezza del bianco circostante.
Nel decennio successivo si assiste a un radicale
cambiamento nella poetica burriana. Il 1973 è l’anno
in cui elabora il primo Cretto: se nei dipinti, nei sacchi e nelle combustioni il tormento della superficie
era dovuto a un’azione insistente e voluta, qui
l’artista lascia che l’opera si concretizzi da sé. Osserva Adachiara Zevi a proposito della loro innova4
Il termine si riferisce in realtà a esperienze piuttosto disparate,
come rivela la natura delle opere degli artisti che vi fanno parte:
Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Wols, Antoni Tàpies.
55
tività, che i cretti “Si astengono, intanto, da qualsiasi
intervento manuale: il materiale, un impasto di bianco di zinco e colle viniliche, disegna, nel rapprendersi, una ragnatela di crepe più o meno sottili, più o
meno omogenee. Quando il processo raggiunge
l’esito desiderato, il vinavil steso sulla superficie ne
arresta l’erosione. In secondo luogo, se la dimensione di Sacchi è monumentale, Cretti inseguono quella
monumentale, persino paesaggistica” 5.
Con i cretti quel mondo disastrato dei sacchi
stracciati e delle superfici ustionate si pietrifica, monocromo, con le sue crepe, come se nell’armonia
delle fessure di diverso spessore, in quel meandro di
pieni e di vuoti, avesse trovato un suo equilibrio.
Se nelle prime opere dipinte durante la prigionia
in Texas la materia pittorica si accumula sporgendo
dalla tela, così come accade poi con le suture tra
brandelli di juta, con cui Burri lavora per accumulo,
nei cretti l’operazione è inversa: il supporto è il materiale, il risultato artistico è in negativo, nei solchi
che si aprono su di esso. In ogni caso si tratta in certo modo di ferite, ma come vecchi rancori si depositano sul fondo della memoria, i cretti sono ormai solo cicatrici che il mondo può esibire in tutta la loro
grandezza.
Ne è un esempio il Grande Cretto Nero che
l’artista dona al Museo di Capodimonte nel 1978, in
ceramica, lungo 15 metri e alto 5. L’opera assume,
con le sue dimensioni, un rilievo spaziale, alimentato dal dinamico luminismo della superficie lucida.
L’impressione che si ha è che ci si trovi dinanzi alla
pianta di una città abbandonata6.
Il tema, neanche a farlo apposta, è ripreso sette
anni dopo, nel 1985, quando l’artista è chiamato a
Gibellina per intervenire sul territorio interpretando
il tema del terremoto che aveva distrutto il piccolo
centro e delle macerie che ne erano rimaste. L’esito
fu la creazione di un cretto in scala territoriale, a copertura dei resti della città, le cui fenditure sono percorribili a piedi con un effetto che rivendica forse
un’indiretta paternità sull’ Holocaust Memorial di
Berlino progettato da Eisenman a partire dal 1998.
Dopo una vita di tortuose e originali sperimentazioni, identificabili in cicli differenti a seconda dei
materiali e delle tecniche usati, il lavoro di Burri si
conclude con la serie dei cellotex, dipinti astratti su
supporto di segatura mista a vinavil, che denunciano
una notevole distensione nelle superfici piane e nelle
campiture omogenee di tinte ora pacate ora solari.
Si può allora tracciare un percorso nella sua esperienza artistica che copre un arco temporale di cin5
A. Zevi, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana, Einaudi,
Torino 2006, pp. 37-38.
6
Il ricordo va velocemente all’installazione del rilievo relativo
al masterplan di Zaha Hadid per il quartiere di Kartal Pendik a
Istanbul, allestita alla Sonnabend Gallery in collaborazione con
ROVE a New York nel 2008.
quanta anni e rispecchia modalità di rapportarsi alla
realtà assai diverse tra loro, si direbbe via via più
mature col passare del tempo.
In Nero I, del 1948, ritroviamo il primo tentativo
astratto che preannuncia il tormento delle prime serie. In SZ1, risalente all’anno successivo, per la prima volta compaiono pezzi di sacco (con stampe di
scritte e della bandiera statunitense) incollati alla tela. Il terreno è ormai pronto per i suoi sacchi più celebri.
È evidente che l’estro di Burri non può accontentarsi delle potenzialità della pittura tradizionale, ormai la contemporaneità si è troppo radicalmente allontanata dai tempi in cui il mondo poteva esprimersi attraverso di essa. Il materialismo è assunto come
strumento di testimonianza di una realtà complessa,
stratificata, multiforme, alla ricerca di una nuova
armonia dopo mezzo secolo di orrori.
LUCE E COLORE VS MATERIA
57
Luisa Mauro
L’attenzione verso il reale posta dai filosofi del
“newrealism”, dopo l’orgia delle interpretazioni che
ha caratterizzato particolarmente il postmoderno, induce a chiedersi, prima ancora della domanda sul
“perché esiste qualcosa e non il nulla”, sulla consistenza del “qualcosa”, sulla struttura delle cose autonoma rispetto alle interpretazioni. L’interrogativo,
naturalmente, non è nuovo e si pone all’origine stessa del pensiero. Nei termini più generali, se per il
soggetto può assumere valore reale anche la più eterea delle fantasie, ciò che invece distinguerebbe in
sé il mondo delle cose è, già per i filosofi greci, la
sua materia, e del resto ancora per noi il termine
“materia”, derivante dal latino mater, conserva
nell’etimo il senso dell’origine, della nascita, di tutti
i corpi: la sostanza prima di cui tutto è formato. Ma,
anche riferendo il reale alla sua consistenza materiale, la domanda sulla sua struttura viene solo rinviata
e la nozione stessa di materia finisce con l’apparire
problematica. In particolare ci si chiede, partendo
dal principio che la materia presente nell’universo
permane in quantità costante, come si originino i diversi enti che la utilizzano. A ciò risponde Empedocle, secondo cui i principi della materia sono da identificare in quattro elementi, terra, acqua, aria e
fuoco, tutti presenti in ogni essere in una dose quantitativa variabile dalla quale dipende la qualità diversa che gli enti presentano. Empedocle anticipa in tal
modo la concezione di una composizione chimica
degli esseri materiali, costituiti dalla mescolanza, dal
composto di elementi primordiali, sebbene, secondo
Anassagora, egli, basandosi sul principio che la materia sia caratterizzata dall’estensione, e quindi procedendo alla sua divisione, onde rintracciare gli elementi primari, si sia fermato troppo presto nel processo, dal momento che le infinite qualità delle cose
non possono risalire solo a quattro elementi, laddove, sulla base del principio “tutto è in tutto”, appare
possibile ritenere vi siano “semi”, ovvero molteplici
elementi infinitesimali che, mantenendo la loro qualità originaria, costituiscono, componendosi in maniera diversa, ogni parte del cosmo. Il pluralismo originario della materia che induce il molteplice delle
cose già determina però una loro inafferrabilità, una
possibile incomprensibilità del reale proliferante in
enti diversi oltre ogni conoscenza. Sarà quindi nel
Timeo di Platone che viene chiarito, in termini metafisici, il ruolo fondante della materia: “Perciò non
diremo che la ‘madre’ è il ricettacolo di ciò che è
generato, visibile e in genere sensibile, sia terra o
aria o fuoco o acqua, né altra cosa nata da queste o
da cui queste siano nate. Ma non ci sbaglieremo di-
cendo che è una specie invisibile e amorfa, che tutto
accoglie e che in qualche modo molto problematico,
partecipa dell’intelligibile ed è molto difficile a
comprendersi”. Ad indicare tale carattere amorfo
Platone utilizza il termine Khora (χώρα) che vuol
dire spazio, luogo, regione, secondo un senso che
sarà ripreso da Aristotele il quale, per spiegare il
molteplice delle cose, ovvero il loro darsi nella forma, pensa esserci un sostrato originario, una materia
“prima”, sempre presente in ogni ente. L’uomo stesso è costituito da elementi corporei (sangue, ossa
ecc.) che a loro volta derivano dagli elementi fondamentali come l’acqua e il fuoco per cui, procedendo a ritroso, si perviene ad una materia prima iniziale, informe, che è difficile definire proprio perché assolutamente priva di caratteri, tale da avere
solo una definizione “negativa” come ciò “di cui
non si dice più che è fatto di qualche altra cosa”.
Ebbene, per quanto la filosofia, potremmo dire
sino al materialismo di Feuerbach e dello stesso
Marx, abbia offerto al reale la struttura fondante, più
che ontologica, metafisica, della materia, è proprio
questa, nella definizione originaria di Khora, ad essere ricondotta da Jacques Derrida all’atto del nominare, se si vuole dell’interpretare, che ne perde ogni
consistenza. Il testo del filosofo francese sul tema
esordisce in questo modo: “Khora ci giunge, come il
nome. Quando un nome viene, esso dice subito più
del nome, l’altro del nome e l’altro come tale, di cui
annuncia per l’appunto l’irruzione”. Oltre a richiamare il tema dell’evento, queste righe ci informano
che per Derrida la questione della Khora ha a che
fare con il nome o meglio, con l’innominabile. In
particolare Khora assume il valore esemplare di
qualcosa che riguarda ogni atto di denominazione
dal momento che il non esservi un significato definitivo per Khora, che è l’origine stessa del reale, implica che non vi è altresì per nessun nome, sì che per
nessun “oggetto” vi è un nome “giusto”. Derrida intende la Khora platonica appunto come qualcosa che
non possiede un’essenza determinabile e la cui presenza appare sempre differita; Khora, secondo tale
filosofo “è l’anacronia nell’essere o, meglio, l’anacronia dell’essere” e questo comporta il venir meno
di ogni essenza stabile per cui ogni possibile presenza deve essere pensata a partire da questa instabilità,
da questa différance. Platone, ovvero il platonismo,
ne risulta capovolto ed ogni traduzione di Khora in
“luogo”, “posto”, “area”, “regione”, “contrada” come ogni figura di “madre”, “nutrice”, “ricettacolo”,
“porta-impronta”, resta impigliata nell’attività interpretativa e, con essa ogni cosa,
Appare superfluo dire che, alla problematicità
che accompagna nei filosofi la definizione della materia e, quindi, del reale, si unisce l’evaporazione
della stessa materia posta dalla scienza. Le scoperte
della fisica relativistica e quantistica contemporanea,
infatti, hanno eliminato, come è noto, la distinzione
newtoniana di materia ed energia, sì che perda di
senso ogni definizione che voglia intendere il reale
in una consistenza materiale.
In architettura, se appare paradossale che gli architetti “realisti” degli anni settanta sfuggano del tutto la materia, annegandola, come accade a Rossi, nel
bianco degli intonaci, in una luce piena cioè che ne
perde la consistenza, è indicativo, di come la relazione con essa sia problematica, il fatto che, proprio
quando più si esalta il suo valore costruttivo, la sua
necessaria presenza reale cioè, questa tende ad attenuarsi e svanire nella luce o nei colori che si danno
nelle definizioni formali.
Se consideriamo che il Partenone e l’architettura
greco-romana in genere erano policromi, così come,
in seguito, le chiese romaniche dove muri, pavimenti, finestre, soffitti, colonne, capitelli, timpani, sculture erano coloratissimi, può dirsi che sin dalla origine e fino al Barocco l’intera città costruita e, quindi, la sua evidente materialità, fu, in opposizione alla
campagna, il luogo della luce e del colore, si direbbe
quello di una vita astratta, convenzionata, non naturale. Anche dopo le scoperte newtoniane sulle emissioni luminose corpuscolari, dalla seconda metà del
XVIII secolo, l’arte neoclassica, sfuggendo lo spettro cromatico ed imponendo invece il candore degli
intonaci, fece della stessa materia il luogo della luce,
quella della ragione, certo, ma anche quella della
propria evanescenza in cui era perduta la consistenza
della pietra. Del resto è di poco successivo, l’edificio tutto di luce del Crystal Palace di Joseph Paxton, il quale, a rendere meno consistente la struttura, colorò a strisce rosse, gialle e blu le membrature
di acciaio, gli impalcati di legno e le fasce di tamponamento tra i vuoti vetrati, interpretando il colore,
così come è dalla definizione latina, colorem, quale
modo del celare, nascondere.
Successivamente, l’eredità dei pittori impressionisti francesi, che concentrano i propri studi sulle
potenzialità spaziali del colore, influenzerà la produzione pittorica di cubisti e astrattisti, giungendo tra
le pareti della Bauhaus e nel movimento olandese
De Stijl, che, attraverso il pittore-architetto Theo van
Doesburg, teorizza l’uso del colore in architettura
onde destrutturare ogni fissazione formale degli edifici e di ogni oggetto. L’idea però di associare luce e
colore alla materia è già rintracciabile in Gottfried
Semper, vero iniziatore dell’architettura moderna,
riferimento costante degli architetti tedeschi che costituiscono il nucleo fondante del modernismo architettonico. Appare cioè significativo che proprio chi,
come Semper, offre all’architettura le basi per interpretarla nella sua consistenza costruttivìva, materiale, consideri altresì la luce, ed i suoi derivati cromatici, quale elemento costruttivo in cui, di fatto,
l’elemento materiale tende ad annullarsi.
La luce, dunque, anche per i moderni, è a tutti gli
effetti un materiale da costruzione con una insostituibile funzione compositiva, ed è proprio all’interno
di questo filone di ricerca che confluiscono i lavori
di due architetti contemporanei, pure di generazione
diversa e del tutto distanti nelle configurazioni formali, i quali, pur utilizzando la materialità costruttiva dell’architettura sino alle più estreme conseguenze, derealizzano la stessa pietra nella variabilità del
luminoso: Louis Kahn e Daniel Libeskind.
Nato nel 1901 in Estonia da una famiglia di origini ebraiche trasferitasi nel 1906 negli Stati Uniti,
Kahn intende come fondamento dell’architettura il
farsi degli spazi nell’aura del silenzio e della luce
dove l’aspirazione ad essere, fare ed esprimere, riconosce le leggi che dischiudono il possibile. In uno
scritto del 1968, infatti, afferma: “Ritengo che la luce sia la fonte di ogni presenza e la materia sia luce
consunta. Ciò che la luce crea, proietta un’ombra e
l’ombra appartiene alla luce. Percepisco la presenza
di una soglia, che separa la luce dal silenzio, che
porta dal silenzio alla luce, immersa in un’atmosfera
ispirata, dove il desiderio di essere e di esprimere
incontra il possibile. La roccia, il corso d’acqua, il
vento sono fonti di ispirazione. Prima con stupore e
poi consapevolmente, osserviamo ciò che di bello vi
è nella materia. Nel santuario dell’arte, la luce incontra il silenzio e il silenzio la luce”.
Nell’opera di Louis Kahn la forma stessa crea la
luce ed anche un ambiente pensato per essere buio
ha bisogno di almeno una lama di luce per comunicare la sua oscurità. Parlando in particolare del proprio progetto per il Kimbell Art Museum, egli altresì
afferma: “Sapevamo che il museo sarebbe stato ricco di sorprese. Seguendo il mutare della qualità della
luce, gli azzurri sarebbero stati diversi da un giorno
all’altro. Niente a che vedere con la staticità della
illuminazione prodotta da una lampadina elettrica,
che dà solo un barlume di quella che è la qualità della luce”. Il museo, infatti, vive tanti stati d’animo
quanti sono gli istanti del tempo e mai, nel corso
della sua vita come costruzione, trascorrerà un giorno uguale all’altro. La volta, elemento che deriva
dalla venerazione di Kahn per l’architettura romana,
è parte essenziale di questa costruzione, e la luce che
scende da una sorgente in alto, ricavata allo Zenith,
sebbene essa non si sollevi a grande altezza, le conferisce modi maestosi, tuttavia appropriati alla scala
umana, evocando così, insieme alla tensione verso la
sorgente luminosa, la sua incommensurabile altezza,
un senso di familiarità e di sicurezza. In Kahn hanno
sicuramente rilievo, a proposito del rapporto mate-
ria-forma-luce, che, nel rinvio delle pareti vuote e
delle ombre, allude ad un messianesimo, le sue origini ebraiche e sono forse queste stesse origini che
determinano la prossimità, pur nella interpretazione
di quello stesso rapporto in termini del tutto differenti, di Daniel Libeskind.
Nato in Polonia nel 1946 da genitori sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, Libeskind ha trascorso l’infanzia in patria, dove si è dedicato allo studio
della musica. Trasferitosi in Israele, a Tel Aviv, con
la famiglia, nel 1960, fruisce di una borsa di studio
negli Stati Uniti dove frequenta la facoltà di architettura della Cooper Union for the Advancement of
Science and Art e conosce Peter Eisenman. Recatosi
a Londra per specializzarsi presso l’Università
dell’Essex, in Storia e Teoria dell'Archittetura, redige i primi progetti che gli consentono di partecipare
alla mostra del 1988 “Deconstructivist Architecture”
al Museum of Modern Art di New York. Due anni
dopo vince il concorso per l’ampliamento del Museo
Ebraico di Berlino dove offre al suo progetto il motto “Between the lines” (tra le linee), essendo esso il
risultato dell’incontro, o meglio dello scontro, tra
una linea diritta e frammentata con una saetta.
L’edificio si sviluppa per un’altezza di quattro piani,
ha una superficie di diecimila metri quadrati e non
ha un accesso indipendente. Per entrarvi, è necessario scendere una scalinata che si trova nell’adiacente
palazzo barocco della Kollegienhaus, sede del Museo della Città di Berlino, e poi risalire un tunnel
sotterraneo. Da qui si sviluppa un sistema labirintico
di “pieni” e “vuoti” che si divide in tre diverse strade. La prima è quella del percorso espositivo in senso stretto. La seconda conduce al giardino, il cui
spazio è tutt’altro che confortevole in quanto è costituito da 49 alte colonne di cemento posate su un piano inclinato, tali da rendere uno squilibrato spaesamento. La terza via, infine, conduce a una torre a
forma di triangolo acuto, con una feritoia in alto che
illumina lo spazio, come la lama di un coltello. È la
Torre dell’Olocausto, lasciata volutamente priva di
impianto di riscaldamento per accrescere il senso di
orrore che attanaglia chiunque vi entri. Dentro la luce è indiretta, penetra da una stretta feritoia in alto
da cui non è possibile vedere fuori e capire dove si
è, così come accadeva agli Ebrei nei campi di concentramento. L’accesso è uno squarcio nella parete
bianca. Muri neri, spigolosi, inclinati fuoriescono.
Le scale sono molto scure. Dalla luce esterna diffusa
all’interno attraverso sottili aperture poste oltre la
vista si passa alla luce dei neon, algida, senza modulazioni, fredda, ed infine a quella piena
dell’esterno del giardino, ma tutte le tre modulazioni
del rapporto tra la luce e le forme, che all’esterno si
rivestono di metallo grigio, sembrano voler indicare
una inaccessibilità, l’assenza di un vero chiarore, si
direbbe, proprio, l’assenza di Dio, cui si può solo
alludere. Con l’inaugurazione del Museo Ebraico
Libeskind è diventato uno dei maggiori architetti dei
nostri tempi e per lui è iniziata un’altra grande serie
di eccezionali progetti: l’Imperial War Museum
North, a Trafford, in Inghilterra; lo Studio Weill,
Port d'Andratx, a Mallorca; nel 2002 il progetto del
Creative Media Center ad Hong Kong e del Militärhistorisches Museum di Dresda; nel 2004 la London
University Post Graduate Center a Londra e la riprogettazione di Ground Zero, dopo la caduta delle
torri gemelle. Tra questi lavori si fanno spazio anche
opere minori, definite tali solo per le caratteristiche
dimensionali in quanto l’autore dedica ad esse la
stessa devozione e lo stesso impegno che infonde in
opere maggiori. Nel Settembre del 2005, infatti, realizza a Padova un monumento in memoria delle vittime dell’attentato dell’11 Settembre 2001 intitolato
“Memoria e Luce”. Il monumento, unico in Europa,
è stato concepito intorno ai resti contorti di una trave
del World Trade Center, esposta al padiglione americano della Biennale di Venezia del 2002 e quindi
donata dalla città di New York alla Regione Veneto.
La struttura si compone di una parete in vetro satinato, lunga 50 metri con una altezza variabile da 2 a 5
metri, che termina in un cuneo alto 17 metri, formato anch’esso da due pareti di vetro a forma di libro
aperto. All’interno di una di queste due pareti è incastonato il frammento, lungo quasi sei metri, del
World Trade Center. L’opera cambia luce e caratteristiche a seconda dell’angolo di osservazione. La
luce si fa materia e ridisegna gli spazi e le forme per
farsi improvvisamente buia, ancora a dire l’assenza
di ogni luminosità, sia trascendente che razionale e
scritta nella sofferenza di vita degli uomini, accettabile solo in vista di una parola indicibile. Il significato di quest'opera è spiegato chiaramente dalle parole di Libeskind: “La luce della libertà splende attraverso il Libro della Storia. L’eterna affermazione
di Libertà è iscritta nella Statua della Libertà, come
è stata vista da milioni di emigranti che arrivavano
in America. La latitudine di New York è connessa al
centro di Padova dalla cerniera verticale del Libro. Il
Libro è luminoso, come il basso ed espressivo muro
che crea un luogo intimo per la meditazione”.
Luce vuole dire anche trasparenza che, con l’uso
sempre più diffuso ed esteso del vetro, un materiale
che in un certo senso si autonega, assume dalla seconda metà dell’Ottocento un ruolo determinante sia
nello spazio interno che nel rapporto tra edificio ed
esterno, tra materia e infinito. La luce infatti è diventata nel tempo protagonista di molte esperienze architettoniche, dai progetti per i grattacieli in vetro di
Mies van der Rohe alla monumentale parete concava
del fronte est della sede del Partito comunista francese a Parigi di Oscar Niemeyer, dalla casa Spiller
di Frank Owen Gehry, in cui la luce del sole, che
piove dall’alto e lateralmente, gioca con le strutture
in legno e ferro creando intrecci e arabeschi sempre
diversi, alle innumerevoli coperture trasparenti, utilizzate nei luoghi di vita associata.
Proprio Libeskind, il 18 aprile 2004, è invitato a
tenere una conferenza, in occasione del centenario
della nascita, sull’opera di uno degli architetti che
maggiormente si è affidato al vetro ed alla luce,
Giuseppe Terragni, al quale molto spesso egli sostiene di essersi ispirato. Nell’ambito di questa conferenza Libeskind, nel parlare del lavoro di Terragni,
si sofferma su due elementi che ne hanno caratterizzato l’intera attività: il rapporto con la luce, da cui
ne consegue la rivoluzione del vetro, e l’utilizzo
dell’elemento colore. Egli dice tra l’altro: “Da Terragni possiamo imparare che l’architettura è un’arte
sociale che appartiene ad ogni cittadino e influenza
ogni essere umano, ogni famiglia, ogni bambino e la
memoria di ogni nazione. La riduzione all’essenziale
e la purificazione dell’architettura come smantellamento del lavoro della memoria sono due elementi
essenziali sempre presenti nella sua architettura. La
memoria fa parte dell’architettura. Terragni intendeva l’architettura non un’arte silenziosa ma una forma
di comunicazione”. Memoria e ombra sono argomenti assolutamente propri a Terragni e la trasparenza, la riflessività e le ombre sono anche in lui un
modo per alludere alla trascendenza sebbene, come
è evidente, mentre in Libeskind, allo stesso modo
che in Kahn, la luce, simbolo appunto del trascendente, non si offre mai in una pienezza, in Terragni,
cattolico, la luce è tentata sin dentro il suo nucleo.
Massimo Cacciari ha mostrato come il tema
della luce domini la cultura filosofica e le tradizioni
religiose, non solo europee, sin dall’inizio. Basti
pensare al ruolo simbolico che la luce svolge nella
Genesi, nella filosofia greca e nel platonismo, dove
si fondono sia aspetti religiosi che filosofici. In questi contesti emerge in un duplice aspetto. Una dimensione è quella per cui la luce è condizione generale dell’apparire, e quindi un inizio sovra essenziale
dove non è l’elemento dell’apparire bensì la condizione dell’apparire stesso. In secondo luogo, la luce
emerge anche come ciò che noi vediamo, tanto che
Euripide diceva ‘dolce è vedere la luce’.
Il platonismo, secondo l’indagine speculativa che
Cacciari conduce, si riconosce in ogni pensiero, filosofico o religioso, che pone nell’Essere, in Dio, nel
Fondamento, tutto ciò di cui non possiamo fare a
meno senza rinnegare noi stessi, la nostra essenza
più profonda che si riflette nella illuminazione delle
cose. La luce rappresenta quindi, anche nel pensiero
cristiano, il potere divino che ci apre al mondo, così
come è scritto nel “Vangelo” di Giovanni, che riprende il tema di Dio come luce. Dio è in esso lux,
la sorgente; il figlio è lumen, ovvero la luce che scaturisce dalla sorgente. Il rinvio del padre al figlio
dominante nell’iconologia cristiana che fa riferimen-
to alla luce illustra pertanto anche la relazione tra
Dio e il mondo, Dio e gli esseri terreni, nel senso
che la lux, creando l’universo, si fa lumen essendo i
raggi le creature e, generalmente, il molteplice apparire delle cose. Sarà per questo che, così come non
intende Libeskind, e lo stesso Eisenman che pure offre una lettura dell’opera di Terragni, mentre per gli
architetti ebrei il differimento di muro in muro della
forma, con quello di ombra in ombra della luce, interpreta l’infinito sfuggire del divino, nell’architetto
italiano il medesimo differire di pareti ed elementi
statici possiede il senso della crisi di chi tenta, nel
ritenere di poter risalire, con Dante, dal lumen alla
lux, giungere oltre l’empireo, sino alla impossibile
comprensione dell’intero abitare, dell’intero essere.
Tale aspirazione è sicuramente riconoscibile nella
vetrata di ingresso della casa del fascio di Como dove si riflette la cattedrale, o nel Danteum, che non è
semplicemente un intervento rivolto ad interpretare
la città di Roma o il poema di Dante, quanto un modo per tentare l’assunzione dell’architettura, della
sua stessa materia costruttiva, al Paradiso, sebbene
proprio in tale progetto emerga già la sfiducia, nel
vetro posto in alto a tentare il cielo, di poter catturare, nelle definizioni costruttive, le cose. Ed è anzi il
colore, in cui si differisce ulteriormente la luce, a
mostrare il declinare di Terragni nella crisi e nella
sfiducia circa la trasparenza e la luminosità del moderno. L’errore derivante, infatti, dalla rappresentazione in bianco e nero delle sue opere ha avuto un
grande potere di dissimulazione, mostrando architetture immacolate sotto il velo di un colore bianco uniforme, il quale nella sua purezza accecante ha avvicinato inesorabilmente la sua architettura a
un’opera di pittura concettuale, al bianco su bianco
di Kasimir Malevich, o al rigore di una architettura
funzionale. Giuseppe Terragni ci ha invece tramandato opere ricche di materia e di colori che, dopo
l’iniziale gioia cromatica comune ai suoi amici astrattisti, sono confluiti nelle più corrusche atmosfere di Sironi e di Novecento. Nella Casa del Fascio di
Como, scolorita dal tempo, le ampie superfici vetrate sono lo strumento incolore per esplorare tutto lo
spettro dei colori della materia. L’assonanza, la coerenza e la rispondenza di materia e colori suscita qui
una vera emozione michelangiolesca: graniti rosso
di Baveno, sienite nera, marmi di pietra di Trani a
filetto rosso, marmi giallo Adriatico, marmi neri Col
di Lana, marmi neri del Belgio, marmi di Musso,
porfiriti ocra, cristalli colorati in pasta, vetri opalini
azzurri, vetri opalini verdi, profilati ebanizzati. Alle
grigie pietre della città medievale Giuseppe Terragni
sembra voler contrapporre l’ottimismo della materia
colorata del Novocomum e della Casa del Fascio e
la ricchezza di materia e colore emerge in tali progetti, tra i documenti originali, dal modello in scala
1:50 del primo, che riporta i colori scelti per la fac-
ciata, e da due fotografie della seconda confermate
da alcune minuziose descrizioni nella corrispondenza intercorsa con le ditte costruttrici oltre che da
campioni di colori ritrovati nelle murature. Si intravede in tale aspirazione a ricondurre la luce ai colori
della materia tutto il senso della fiducia di Terragni,
manifestata nei primi progetti, nella possibilità, per
l’architettura, di ordinare il mondo, di offrire agli
uomini una chiave onde ricercare la sintonia con esseri e cose. Fiducia che appare del tutto smarrita,
dopo il concorso per il Palazzo Littorio, proprio nei
nuovi modi coloristici del progetto del Danteum,
dove ai tenui acquerelli con cui definisce il progetto,
i quali già ne dispongono la dispersione, corrisponde
il ricorso alla materialità oscura delle “terre” propria
alla pittura di Sironi chiamato ad illustrare l’edificio
onde lasciarlo sconfinare nell’illusione.
Una sfiducia, non solo ad irretire il reale nelle
trame dell’architettura, quanto anche a riconoscere il
senso di concretezza dello stesso costruire, la quale,
prima che a Terragni, appartiene già a quei protagonisti del moderno che, con l’esito della prima guerra
mondiale, riconoscono, pur nelle nuove occasioni di
lavoro, la fine degli entusiasmi dell’avanguardia. E’
il caso di Bruno Taut il quale, partendo da un uso
istintivo del colore, ha dato vita a realizzazioni architettoniche policrome con l’intento di migliorare
la qualità della vita. Ed anche in lui, alla fantasmagoria del Glaspavillon, il padiglione per l’industria
vetraria al Werkbund di Colonia, del 1914, antecedente la guerra, corrispondono i colori squillanti, e
pure privi di festosità, degli alloggi popolari di Magdeburgo, progettati tra il 1921 ed il 1924, dove lo
stanco ricorso ai temi cromatici e formali espressionisti, utilizzati negli anni venti nei quartieri di Berlino, si perdono nella uniformità funzionalista. In un
certo senso può ritenersi che l’uso del colore in intonaci e serramenti a Magdeburgo, rivolto ad attenuare
la rigidità delle tecnologie utilizzate e l’uso di volumi e tipologie edilizie omologate, finisca von il ricondurre la variabilità cromatica ad una funzionalità,
quella di rendere più accettabile il cupo grigiore della vita del dopoguerra manifesto anche nei modi abitativi. E’ indicativo che, alla fuga di Taut, il quale
tentò di ritrovare la gioia rivoluzionaria prima
nell’unione sovietica e dopo in Turchia, dove morì,
abbiano trovato corrispondenza le trasformazioni attuate in epoca nazista, soprattutto sul colore degli
intonaci, cui si sono sovrapposti negli anni Sessanta
e Settanta interventi destinati alla riqualificazione
abitativa degli alloggi, ormai divenuti obsoleti, che
hanno finito con il modificarne radicalmente
l’assetto tipologico, tecnologico e compositivo sino
ai più recenti interventi di restauro filologico, condotti che hanno riproposto la loro originaria configurazione.
Kahn, Libeskind, Terragni, Taut, architetti differenti di epoche diverse che hanno tentato in modi
vari di offrire realtà alla stessa costruzione, esaltandola nella luce o rilevandola nel colore, i quali proprio in tale tentativo hanno scontato il silenzio. Forse la stessa realtà, oltre ogni divino, è indicibile, anche se non si può non tentare, pure nel progetto di
architettura, di dirla.
61
TOH CHI SI RIVEDE: IL VECCHIO CARO NUOVOREALISMO
Alberto Cuomo
“Contro il positivismo, che si ferma ai fenomeni:
«ci sono soltanto fatti», direi: no, proprio i fatti non
ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun fatto «in sé»; è forse
un’assurdità volere qualcosa del genere. «Tutto è
soggettivo», dite voi; ma già questa è interpretazione, il «soggetto» non è niente di dato, è solo qualcosa di aggiunto con l’immaginazione, qualcosa di appiccicato dopo. – È infine necessario mettere ancora
l’interprete dietro l’interpretazione? Già questo è invenzione, ipotesi. In quanto la parola «conoscenza»
abbia senso, il mondo è conoscibile; ma esso è interpretabile in modi diversi, non ha dietro di sé un
senso, ma innumerevoli sensi. «Prospettivismo».
Sono i nostri bisogni, che interpretano il mondo: i
nostri istinti e i loro pro e contro. Ogni istinto è una
specie di sete di dominio, ciascuno ha la sua prospettiva, che esso vorrebbe imporre come norma a
tutti gli altri istinti”.1
Giova riprodurre per intero l’aforisma che doveva far parte de La volontà di Potenza di Friedrich
Nietzsche, il testo inconcluso pubblicato con revisioni falsanti dalla sorella del filosofo dopo la sua
morte, e che viene citato anche da Maurizio Ferraris2
per tuttavia ridurlo al solo primato delle “interpretazioni” e, quindi, contraddirlo al fine di introdurre il
nuovo ritorno dei fatti, del “reale”. Giova perché tale
affermato ripresentarsi della realtà vuole confutare
l’eccesso interpretativo-narrativo proprio alla nostra
età postmoderna azionando una sorta di astratto
“pendolo” della storia che, dopo il naufragio nel
gran mare delle definizioni, delle “favole” di cui già
parlava Novalis, ci rivolgerebbe a ritrovare la solidità dello scoglio del reale, necessaria e materiale Itaca, a patto però di distorcere il testo nietzschiano, inteso fondativo del postmoderno, il quale, pur nel
privilegiamento delle interpretazioni, intende queste
come oppositive sia ad una conoscenza esaustiva dei
fatti che ne scopra persino l’ “in sé”, posta dai positivisti, sia ad una esaltazione del soggetto interpretante, a sua volta indicato come qualcosa di appiccicato alla nostra umanità troppo umana, tanto più che
il mondo, quello reale, non solo per Nietzsche esiste,
ma è l’oggetto della nostra “sete di dominio” che
scaturisce dai “nostri bisogni” e dai “nostri istinti”,
essendo la stessa asserzione di un primato delle interpretazioni intesa ancora come interpretazione.
Umberto Eco, coinvolto dai “nuovi realisti” a far
parte della propria compagine, rileva come il termine postmoderno, prima che dai filosofi, da Lyotard,
sia stato coniato ad uno studioso di architettura,
Charles Jencks, nel 1977, ad indicare il ricorso ironico alla storia, negli architetti, diverso dal prevalere
del gioco interpretativo rispetto ai fatti nei filosofi
tra Vattimo e Derrida 3. Invero, se per Charles Jencks
il postmoderno si costituisce come reazione al modernismo ed al razionalismo architettonico,
nell’invito a rivisitare la storia, che era stata intesa
come ingombro nel progressivo viaggio della modernità verso il futuro, anche i filosofi, dichiarando
la fine delle “grandi narrazioni”, introducono ad un
“pensiero debole”, alla dimagrita ontologia di un essere immerso, sebbene inaccessibile, nell’indigenza
dell’esistente, estraneo alle fuorvianti definizioni
metafisiche, alla identificazione, sempre dogmatica,
della propria Verità, perorando il ricorso alla reinterpretazione delle parole trascorse in cui pure esso
si è manifestato, all’ermeneutica, alla verwindung, il
ricircolo del pensiero passato che ha tentato di coglierlo. L’avanguardia storica e gli architetti modernisti avevano distrutto le forme della storia, e quindi
gli stili, la mimesi, il decus (dike) come decorazione
e decoro, per giungere alla secchezza della costruzione, alla tabula rasa, all’astrazione, alla purezza
della tela vuota o del curtain wall. Oltre il silenzio,
la distruzione cui pervengono, non resta quindi loro
che volgersi indietro, rivisitare la tradizione, ed essi
appaiono rinvigoriti nello sguardo verso le proprie
spalle proprio dai filosofi i quali li invogliano ad un
progetto come rimemorazione, an-denkem, al recupero cioè delle rovine dei templi trascorsi abbattuti.
E’ indicativo di una continuità tra architetti e filosofi, ad esempio, il fatto che Vattimo, oltre ad essere
invocato quale mentore della mostra Biennale di architettura allestita da Portoghesi con il titolo “La
strada novissima”, una infilata di pareti vuote, posticce, costruite solo nell’assemblaggio di forme e
stili desunti dal passato, si disponga egli stesso a
teorizzare per l’architettura l’attività della reinterpretazione rimemorativa4. Ed è altresì indicativo che
1
3
F. Nietszche, Frammenti Postumi 1885-1887, 7(60), a cura di
G. Colli e M. Montinari, versione di S. Giametta, Adelphi, Milano 1975.
2
M. Ferraris, in Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Bari
2012, il testo che raccoglie le analisi svolte in altri suoi saggi
sulla evidenza del reale, sintetiiza con la frase virgolettata “non
ci sono fatti, solo interpretazioni” (p. 5) il testo nietzschiano pure riportato in nota sebbene falsato.
Il testo di Umberto Eco, Ci sono delle cose che non si possono
dire, dove si fa riferimento all’architettura, è stato scritto in occasione di un convegno a New York tenutosi a novembre 2011
sul tema “Postmoderno e neorealismo”, organizzato da Maurizio
Ferraris, ed è pubblicato su « Alfabeta2», n. 17, marzo 2012, p.
16 e segg.
4
Gianni Vattimo scrive in «Casabella» n. 485, novembre 1982,
p. 51: “Pensato alla luce dell’An-denken heideggriano, il proget-
62
Derrida collabori con gli architetti Eisenman e
Tschumi al progetto decostruttivista de La Villette a
Parigi del 1986, mentre ancora Vattimo firmi con
l’architetto Gregotti e l’urbanista Secchi il Piano
Regolatore di Torino elaborato negli anni novanta ed
approvato nel 1995, fondato sulla fine dell’espansione urbana e sul recupero reinterpretativo della città costruita nel tempo.
Sebbene l’esangue deriva degli architetti postmoderni tra i segni, che produce un banale eclettismo, non corrisponda alla salute, pure debilitata, del
nuovo che ancora si produce nella reinterpretazione
delle parole dei padri perorata da Vattimo, e malgrado Derrida si interroghi sul persistere di un accento
metafisico nell’opera dei progettisti che si richiamano alla decostruzione, è indubbio che, a differenza di
quanto sostiene Umberto Eco, vi sia connessione tra
progetto e filosofia postmoderni, potendosi forse dire, ancora diversamente da Eco, teso a valorizzare il
presunto accento ironico dei progettisti rispetto al
paludato rinvio alle interpretazioni dei filosofi, che,
all’inverso, l’architettura banalizza e caricaturizza il
pensiero filosofico del dopomoderno mostrandone il
rischio di rendere l’ermeneutica e la decostruzione,
come accade proprio a quegli architetti che scimmiottando Heidegger si dedicano ad avventure teorico-filologiche, in un puro gioco ricreativo tra le definizioni del passato, tuttavia tese a proporre, attraverso le ricostruzioni etimologiche, assoluti confini
concettuali. Ma può condividersi, alla luce di un tale
rischio, che, secondo Ferraris, avrebbe determinato
alla filosofia “debole” la propria resa alle “interpretazioni” del mondo operate dal potere, economico,
politico, dell’informazione, l’idea che bisogna tornare al fatti, ovvero alla individuazione di “inemendabili”, verità?
Se nel recente passato l’architettura è stato lo
specchio distorto, caricaturale, della filosofia, del
pensiero debole e del decostruzionismo, è probabile
che guardando alle versioni del nuovo realismo da
parte degli architetti, cui del resto si rivolge lo stesso
Ferraris, è possibile forse scorgere le ombre che
sempre si annidano in ogni vocazione alla luce, in
ogni nuova volontà ad illuminare, è il caso di dirlo,
il reale. Oltretutto, anche per il nuovo realismo, così
come per il postmoderno, sembra sia stata l’architettura a scoprire, prima della filosofia, la necessità del ritorno alla realtà. È infatti del 2004, anteriore di qualche anno alle tesi di Ferraris, il testo di Vit-
torio Gregotti su L’architettura del realismo critico5.
Temendo di essere frainteso ed interpretato quale
tardivo seguace di Lucács, pur nella “grandezza”
che gli attribuisce, delle sue teorie sul “rispecchiamento” o, peggio ancora, di Bogdanov, Gregotti già
nella Premessa, rinvia la propria attenzione verso la
“realtà” a Massimo Piattelli Palmarini e, particolarmente, al “realismo critico” di Hilary Putnam. A differenza di Lucács il quale nella sua Estetica sostiene
che, soggetta “all’incarico sociale” della classe dominante, l’architettura non può rivendicare una azione negativa del reale che la determina, per limitarsi ad esserne “piacevole” rappresentazione ridotta
ad ottenere “effetti artistici secondari” o, con
l’avanguardia, ad offrirsi un astratto referente, Gregotti ritiene invece che, proprio nella sua specifica
azione, rivolta a definire spazi di vita, così come riconosce il medesimo studioso ungherese, essa può
avocare una autonoma capacità critica del mondo in
cui pure si pone, così come è nell’idea di Theodor
Adorno esplicitamente citato6. Se cioè il rispecchiamento dei valori, dei contenuti, quelli del socialismo, o quelli antagonisti al mondo capitalisticoborghese, non sembra potersi dare nell’arte sia per il
venir meno di quei valori sia perché l’autonomia dei
linguaggi artistici tiene viva la distanza dal reale che
si vorrebbe riprodurre, è possibile, secondo
l’architetto milanese, agire proprio tale autonomia in
termini critici rispetto alla realtà in cui essi si calano.
Formatosi alla scuola fenomenologica, si avvertono
in Gregotti gli echi del saggio di Anceschi, su Autonomia ed eteronomia dell’arte, scritto tra il 1930 ed
il 19367, nel quale si mostra come proprio nel suo
essere, attraverso il mezzo estetico, immaginativo,
autonoma manifestazione del mondo della vita,
l’arte, ed anzi l’arte pura, si fa luogo delle cose, e
nel suo ampio spettro di significazioni, aperta ai sensi e, quindi, all’evenire, messa in parentesi della
complessità del reale, e, pertanto, eteronoma nella
sua stessa autonomia. E tuttavia, malgrado riconosca
l’artisticità dell’architettura, Gregotti tende a sfuggire la sua interpretazione, oltretutto perseguita dagli
architetti dell’attuale starsystem dai quali intende
piuttosto distanziarsi, in una esclusiva chiave estetico-simbolica, cui sembra invitare la stessa nozione
anceschiana di “arte pura”, eludendo, d’altro canto,
anche il concetto di un suo realismo concentrato nel
servizio allo scopo, come era nel funzionalismo, ov5
to si qualifica piuttosto come una pro-iezione, anche nel senso
del cinema: getta sullo schermo forme già scritte nella pellicola
sottile della Uber-lieferung – la tra-dizione – e del Ge-schick –
l’invio; la luce che permette la proiezione è l’atto interpretativo.
Nella immagine di Wittgenstein, e in una prospettiva heideggeriana, l’architettura perde il suo carattere progettuale assoluto e
si qualifica come attività ermeneutica”.
V. Gregotti, L’architettura del realismo critico, Laterza, Roma-Bari 2004
6
Ibidem, cfr n. 11 a pag 20 e la frase di Adorno ripresa da una
conferenza al Deutscher Werkbund di Berlino nel 1965 pubblicata in Parva Aesthetica e riportata a pagina 29: “Proprio perché
l’architettura, oltre che autonoma, è anche, effettivamente, legata a uno scopo, non può semplicemente negare gli uomini come
sono; anche se, in quanto autonoma, deve farlo”.
7
L. Anceschi, Autonomia ed eteronomia dell’arte, Garzanti,
Milano 1976, v. l’Annotazione 1959 a p. XIII e segg.
63
vero rivolto alla opposta aspirazione, che fu degli
architetti italiani “neorealisti” degli anni settanta uniti nella cosiddetta “tendenza”, di definire una lingua assoluta, una chiusa logica del costruire, in cui
dire l’abitare.
Forse in Gregotti l’attuale realismo può farsi risalire alla sua presenza nel “Gruppo 63”, il gruppo
della “neoavanguardia”, in cui ha militato anche
Edoardo Sanguineti al quale l’architetto milanese
dichiara di aver affidato il suo testo. Del resto, lo
stesso Umberto Eco apre la propria conferenza sul
nuovorealismo chiedendosi in proposito “che cosa ci
sia di nuovo (per quanto mi riguarda) in posizioni
che sostengo almeno dagli anni Sessanta e che avevo esposte poi nel saggio Brevi cenni sull’Essere,
del 1985”. Sebbene unitario nella critica al realismo
socialista, rappresentato in Italia dai Moravia, Patroni Griffi, Guttuso, il “Gruppo63”, costituito dagli
scrittori de “Il Verri” che trovano corrispondenza nel
saggio di Eco Opera aperta, è abbastanza variegato,
proprio riguardo i diversi accenti circa il rapporto tra
linguaggio e reale, cultura e politica. Pubblicizzato
per un più vasto pubblico con l’uscita nelle edicole,
a partire dal giugno 1967, di un proprio organo, la
rivista “Quindici”, il numero 1 presenta una doppia
posizione rappresentata da due articoli, di Sanguineti
e di Eco, molto differenti: il primo, “La letteratura
della crudeltà” sulla necessità di utilizzare la parole
stesse, quelle della letteratura, sempre connotate di
ideologia e di un portato allegorico, più che i contenuti, in termini politici, il secondo, “Perché Paolo VI
non piace ai laici” in cui sono messi in parallelo alcuni passi dell’Enciclica “Populorum progressio” di
Papa Montini, con quelli del “Manifesto del Partito
Comunista” di Karl Marx onde mostrare come, di
fronte alle cose, a nuovi “fatti”, le parole non possano non confrontarsi con nuovi sensi. L’impegno
comune del “gruppo” viene ricordato, proprio da
Eco, nel numero di marzo del 1969, allorchè Alfredo
Giuliani lascia, annunciandola in un articolo, la direzione di “Quindici”, nel disagio di ritenere che il
giornale “sta diventando un’altra cosa da quella che
volevamo”, vale a dire uno strumento rivolto a rendere merce il dissenso, ad operare un “consumo del
dissenso”. Rispondendo a Giuliani, infatti, Eco ricorda che il “Gruppo 63” non si era costituito “come
atto di ribellione di giovani inesperti esclusi dal potere, emarginati dal sistema”, dal momento che la
gran parte dei suoi componenti appartenevano già
all’establishment culturale, essendo direttori di collane editoriali, di trasmissioni televisive, collaboratori di riviste e giornali, giudici di concorsi letterari,
oltretutto con un “opulento” margine di decisionalità. Per questo, secondo il riconosciuto leader del
Gruppo, la sua nascita si era posta piuttosto, per i
giovani intellettuali formatisi negli anni cinquanta,
onde discutere del potere che era stato dato loro da
gestire e che essi ritenevano dover affrontare su due
fronti, “su quello della politica culturale spicciola e
su quello della cultura come atto politico”. Di qui,
sia lo studio sulle forme della comunicazione, sul
linguaggio, sull’articolarsi interno della sovrastruttura culturale, del tutto mutata nella nuova realtà economica, sociale, politica, determinatasi dopo la guerra, e, pertanto, la “contestazione linguistica” della
società, sia la necessità di “condurre un discorso di
rottura” dal momento che “non serve comunicare
nei modi consueti la volontà di rottura (suonare il
piffero della rivoluzione) ma bisogna rompere i modi stessi della comunicazione”. Una rottura che si
lega al ribadito “impegno civile” dell’intellettuale
rivelando nello stesso discorso di Eco i due poli tra i
quali oscillano le posizioni interne al Gruppo. Rompere i modi della comunicazione infatti sembra significare anche venir via dai discorsi, dalle “interpretazioni”, per interrogarsi sul loro ruolo ed immettersi direttamente nel “reale”, ovvero, in presenza di
sovvertimenti rivoluzionari dei sistemi economici e
politici, assumere l’impegno “di analizzare quella
realtà sociale che sono le parole”, laddove se “la
contestazione di un dominio di classe passa certamente attraverso la prassi rivoluzionaria … la contestazione di quella forma specifica del dominio che è
la Kultura di classe passa anche attraverso un discorso sulla cultura – e non solo contro la cultura, o
a fianco della cultura” essendo “tutti questi… problemi politici”. Da un lato quindi si afferma un ruolo
dell’intellettuale all’interno della produzione culturale sovrastrutturale, dall’altro si pone la necessità di
agire politicamente sulle stesse strutture culturali sino alla eventualità di “rompere” i limiti delle elaborazioni linguistiche in ragione delle trasformazioni
del reale agito dalla prassi politica sì che, riflessa tale doppia posizione nel giornale che Giuliani più
non comprende, ed essendo esso divenuto una sorta
di tatze-bao dei bollettini di ogni movimento di contestazione, da Potere Operaio al più minoritario nucleo di una classe liceale, Eco, nel ricordare che “il
Gruppo63 non ha mai detto «non fate politica»”, interpreta l’apertura del giornale ai vari nuclei rivoluzionari, ovvero agli “altri”, come un modo per
l’intellettuale, pur cominciando a fare discorsi “da
politico”, di “riscoprire la sua funzione specifica,
che però dovrà manifestarsi in modi inediti”8. Non si
sa se “Quindici” concluda di lì a poco le pubblicazioni perché i suoi collaboratori si immetteranno
concretamente nelle turbolenze politiche degli anni
settanta o se la doppia posizione professata giunga
ad una ambiguità tale da non poter essere sostenuta9,
8
U. Eco, Pesci rossi e tigri di carta, in «Quindici», n. 16 Marzo
1969, p. 3 e segg.
9
«Quindici» chiude le pubblicazioni, dopo soli cinque mesi, con
il numero 19 del 1969 quasi interamente dedicato alle lotte operaie e studentesche, alla guerra in Vietnam ed alle diverse rivolte
64
ma è probabile che la duplice strategia che caratterizza, tra posizioni differenti, già il primo numero
del giornale, quella tra la concezione del lavoro intellettuale come azione per “tempi lunghi” interna ai
linguaggi o, se si vuole, alle “interpretazioni”, e
quella del suo possibile immettersi nei “tempi brevi”
della prassi politica, ovvero nella “realtà” che più
non sembra seguire i tradizionali paradigmi interpretativi, viva ancora nella adesione di Eco alla compagine dei “nuovi realisti”. In quel primo numero Edoardo Sanguineti, proseguendo un suo testo su Ideologia e linguaggio, rileva il carattere ideologico delle formazioni linguistiche, per proporre una sorta di
controideologia, di “critica dell’ideologia” del linguaggio, che ne sovverta la falsa coscienza, attraverso lo stesso linguaggio, la sua stessa propensione
all’ideologia, sino a renderlo vita materiale, “letteratura della crudeltà”, tale da avere cioè, secondo la
metafora ripresa da Antonin Artaud, la “forza della
fame”. Mentre quindi Sanguineti tende a tenere
l’impegno intellettuale all’interno degli autonomi
mezzi linguistici perché si rivelino essi stessi reali
luoghi di vita, Eco, giocando tra i testi di Montini e
di Marx, sembra a sua volta volersi tenere nei confini della letteratura, voler giocare le “interpretazioni”, per rivelare alla fine della sua analisi, qualsivoglia sia il punto di vista rispetto alla storia, quello
hegeliano che vi riconosce uno spirito del tempo o
quello di una logica più pragmatica che guardi ai fatti concreti, la necessità di far esplodere le definizioni. A proposito dell’enciclica papale, e particolarmente del punto in cui si sofferma sulla “responsabilità di fronte a Dio” nell’uso della pillola abortiva,
infatti scrive: “Qui non si tratta della interpretazione,
in termini casuistici, di una regola fissata della dottrina; qui si tratta della decisione circa un punto dottrinale, rimandata alla libera opzione del fedele faccia a faccia con la propria coscienza e con Dio, indipendentemente da una mediazione dell’autorità. Il
che è naturale, se il ricorso non è più alla Verità Intemporale, ma alla logica della storia. Ma con questo
si introduce un pericoloso elemento di «libera interpretazione» che suona ghiottamente protestante e
anti-tridentino. E quando si dice «pericoloso» ci si
mette dal punto di vista del credente. E quando si dice «pericoloso» e si insinua questo sospetto, lo si fa
per portare alle estreme conseguenze logiche certi
elementi del testo e del contesto. Ma sono dubbi che
rendono appassionante la lettura di questo libretto:
in cui sono indubbiamente contenute più cose di
proletarie nel mondo, dopo un anno in cui, pur continuando ad
interrogarsi sulla dialettica tra l’azione della cultura, la sovrastruttura, e la “struttura” che fonda le “reali” relazioni sociali, di
classe, si era aperto direttamente al dibattito politico, con posizioni prossime a quelle del comunismo sudamericano, supportate dai contributi teorici, pubblicati nella rista, di leader come
Che Guevara e Castro
quante non si possano leggere a prima vista. Tali da
eccitare sia chi crede che lo spirito soffi dove vuole,
sia chi pensa che lo spirito bussi sotterraneo alle porte della storia, sia chi ritenga che la logica obiettiva
dei fatti impone prima o poi le sue conclusioni, sia
infine chi sospetti che le circostanze creano le ragioni, interagendo con le situazioni passate, ma che in
circostanze particolari, quali che siano le situazioni
ereditate, le ragioni possono coincidere; e sono i
momenti in cui è produttivo spingere le ragioni ai loro estremi, e farle esplodere”10. La distanza tra i due
forse maggiori esponenti del “Gruppo63” si manifesta però esplicitamente nel numero 12 del giornale,
poco prima della sua chiusura, allorché Sanguineti
pubblica con Guido Davico Bonino un articolo molto critico su un editoriale di Eco che aveva manifestato la propria diffidenza nei confronti di alcune
occupazioni, dalla Biennale alla Triennale, del tutto
diverse da quelle degli operai rivolte a bloccare la
propria fabbrica. Sebbene sembri aderire allo stesso
concetto di Eco circa il lavoro intellettuale quale azione su due fronti, interno alla cultura e in adesione
alle cose, Sanguineti mostra di non credere ai due
tempi diversi per i due modi dell’impegno, nel ritenere che l’intervento nella prassi, per chi lavora la
scrittura, senza perdere lo specifico connotato sperimentalistico dell’attività letteraria, debba solo porsi sotto la direzione del movimento operaio cui riconoscere la “coscienza possibile”, laddove il direttore
aveva manifestato, anche con le sue censure, la necessità di considerare i luoghi più veri dello scontro
politico, dei “fatti”, che imponevano di rivedere le
definizioni, quelle stesse che inducevano al gioco
delle occupazioni11.
Le riflessioni di Gregotti risentono sicuramente
ancora di tale dibattito, tanto più che, successivamente al testo sul realismo critico, consegnato al
giudizio di Sanguineti, la riedizione, nel 2008, del
Territorio dell’architettura, (1965) vede la prefazione di Umberto Eco, curatore con lui della XIII Triennale del 1964, il quale si sofferma proprio sul clima culturale degli anni sessanta e sulla costituzione
del “Gruppo 63”. Dall’attenzione di Sanguineti verso il linguaggio Gregotti intende l’architettura a sua
volta come articolazione linguistica sino alla citazione di Deleuze cui sicuramente fa riferimento lo
scrittore genovese nel richiamo ad Antonin Artaud12.
10
Cfr. E. Sanguineti, La letteratura della crudeltà – riferibile al
saggio su Ideologia e linguaggio, Feltrinelli, Milano 1965 - ed
U. Eco, Perché Paolo VI non piace ai laici, entrambi in «Quindici», n. 1, Giugno 1967.
11
Cfr. G. Davico Bonino, E Sanguineti, È vietato vietare, e U.
Eco, Vietando s’impara, in «Quindici» n. 12, settembre 1968.
12
Sono proprio gli intellettuali del “Gruppo 63” ad introdurre in
Italia, negli anni sessanta, i testi francesi di Foucault, Barthes,
Althusser ed a leggere in lingua quelli di Deleuze di cui pure si
pubblicano negli stessi anni i saggi su Hume, Kant, Proust, Bergson, Nietzsche, quest’ultimo sdoganato dai “neomarxisti” ita-
Citazione paradossale in Gregotti perché Deleuze,
che interpreta appunto il linguaggio, ovvero il pensiero che in esso si articola, come vivere reale, è il
riferimento dei transarchitetti, epigoni delle archistar
del decostruttivismo poco amate dall’architetto milanese, per i quali l’intera realtà, quella anche
dell’architettura, assunta nel calcolo informatico che
ne traduce la struttura genetica in formule algoritmiche, attiva in queste, sebbene le più astratte tra le
“interpretazioni”, le proprie trasformazioni, la propria vita. Parola concreta, comunque, per Gregotti
l’architettura non è rappresentativa del reale ma realtà essa stessa che, sintetizzando in sé i diversi materiali del mondo che la circonda, da quelli intrinseci
della costruzione al contesto, non solo fisico, o agli
scopi per i quali è eretta, ovvero “il nodo dei fatti
storici”, agisce rispetto ad essi, e pertanto rispetto a
se stessa, le norme che pure si offre, in termini critici, tanto da mutarne gli statuti: “La sua appartenenza
alla realtà, che si attua nel suo essere cosa duratura,
in mezzo alle altre cose della geografia del mondo,
propone un’assunzione di responsabilità nel processo di modificazione che essa attua e in generale nella
costruzione dell’ambiente fisico, cioè una coscienza
del proprio intervento rispetto alle cose e, connesso
a questo, un riconoscimento dell’esistenza dell’altro
da sé come costitutivo dell’oggetto architettonico…Dunque la messa in valore del sistema delle relazioni, non solo nella percezione della nuova cosa
ma anche nello spostamento che essa induce nella
costituzione della cosa stessa, fa direttamente riferimento alla costruzione del paesaggio antropogeografico e all’idea che il paesaggio è, almeno in
Europa, il modo di essere fisico della storia e
l’architettura è parte della sua geologia” 13. Emerge
come è evidente, l’idea che l’architettura, abbia incidenza sul paesaggio traducendo nelle sue trasformazioni la stessa storia, contro quegli architetti che
ritengono, come scriverà più avanti, che lo spirito
della storia sia ormai immerso nell’immaterialità
della realtà virtuale, e, sebbene l’architettura “non
possa essere uno strumento per la trasformazione dei
rapporti sociali” essa non può non “scrivere sulla realtà” essendo il progetto, da un lato, luogo in cui si
collocano i materiali storici che lo producono e
dall’altro messa in opera di uno “scarto” rispetto ai
dati messi in forma, ponendosi in tale duplicità il
suo carattere di opera d’arte14.
L’esistenza dei “fatti”, del reale, per Gregotti,
quindi, induce ad una loro trasformazione, essendo
anzi, il proprio dell’arte, e dell’architettura, in tale
liani che gravitano intorno al gruppo. Gregotti cita Deleuze in
L’architettura del realismo critico, op. cit. a p. 54, riportando i
suoi concetti di Differenza e ripetizione, dall’omonimo volume
del 1968 tradotto in Italia da Il Mulino, Bologna, nel 1972
13
V. Gregotti, L’architettura del realismo critico, cit, pp. 96-97.
14
Ibidem, v, le pagine conclusive.
aspirazione trasformativa. E’ indicativo in tal senso
che, recensendo il libro di Maurizio Ferraris, Il manifesto del nuovo realismo, egli, dicendosi “felice
della sua distinzione tra realismo critico e positivismo”, lamentando il poco spazio dedicato all’arte
contemporanea, ribadisce che questa non possa non
essere caratterizzata da una intenzionalità trasformativa nei confronti dello stato generale delle cose, per
concludere che “è proprio questo ciò che Ferraris intende per realismo «nel senso kantiano del giudicare
cosa sia il reale e cosa non lo sia, e in quello marxiano del trasformare ciò che non è giusto»”15. Ma,
nel mettere in luce l’intenzione trasformativa del
progetto di architettura, Gregotti non si pone in
“continuità” con gli eroismi del modernismo architettonico rivolto a cambiare il mondo, di cui, da
tempo, da Manfredo Tafuri, è stato sottolineato il carattere ideologico di falsa coscienza. Il rischio cui si
espone la traduzione gregottiana del realismo, e
quindi anche il “nuovo realismo”, è cioè nell’idea di
un possibile dominio del reale, ovvero dell’aspirazione per il soggetto di scoprire l’”in sé” delle cose, sia pure nei suoi limiti storici, sì da poterne disporre nella trasformazione, dove il progetto è proiezione ideologica verso un ipotizzato mondo futuro,
un reale a venire rispetto al reale che assume in sé.
Ed infatti, avvertendo la possibilità di una tale ideologica interpretazione, Umberto Eco, malgrado
l’affinità tra la dizione di “realismo critico” in Gregotti ed il proprio “realismo negativo”, spiega come
tale negatività non debba essere intesa quale luogo
critico del reale quanto luogo critico di ogni progetto
che tenti di possedere il reale. Mentre cioè per Gregotti il progetto si misura con il reale per assumerlo
criticamente nelle proprie interpretazioni e trasformarlo, per Eco l’attività “negativa”, più che quella
critica verso le cose, all’inverso, è quella del reale
che si oppone, irriducibile, alle interpretazioni. Ed
infatti, nella conferenza citata, dopo aver messo in
luce come, anche a ritenere i fatti privi di effettualità
se non nel succedersi delle interpretazioni, non può
negarsi che ogni interpretazione assume quella precedente quale “punto ineliminabile di riferimento...e
dunque fatto intersoggettivamente verificabile”, nel
ricordare un proprio dibattito con Rorty, il quale pur
di affermare il primato delle interpretazioni sul reale
riteneva di poter interpretare, pericolosamente, e
quindi, in maniera improbabile, un cacciavite per
frugarsi dentro l’orecchio, Eco, dopo aver rivolto i
propri appunti a Nietzsche e Vattimo, conclude, tra
Pierce e Popper, che “se non si può mai dire definitivamente se una interpretazione sia giusta, si può
sempre dire quando è sbagliata”, dal momento che
15
V. Gregotti,, Il saggio di Ferraris e il progetto di architettura,
«Corriere della Sera» del 18.05.2012. La frase riportata da Gregotti è in M. Ferraris, op. cit. p.61.
66
vi sono casi in cui l’oggetto sottoposto alla interpretazione vi resiste ed infine la nega (ma non è il proprio delle interpretazioni, a prescindere dal confronto con le cose, la sempre possibile erroneità?). Riferendosi al testo di Nietzsche “Su verità e menzogna
in senso extra morale” egli attribuisce all’autore un
kantismo senza fondazione trascendentale secondo
cui ogni relazione apprensiva delle cose appare essere priva di verità dal momento che “la verità è solo
«un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi» elaborati poeticamente, e che poi si sono irrigiditi in sapere, «illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria», monete la cui immagine si è
consumata e che vengono prese in considerazione
solo come metallo, così che ci abituiamo a mentire
secondo convenzione, avendo sminuito le metafore
in schemi e concetti”. Pur accettando l’idea nietzschiana di ritenere l’edificio linguistico in cui si
“irreggimentano” le cose quale sistema non irrigidito di verità, Eco si chiede però che cosa costringa a
tenere fede alle definizioni che ci si è dati (utilizzare
l’aspirina invece che la cocaina in caso di febbre)
ovvero a mutare, come accade allo stesso superuomo, i propri paradigmi interpretativi. Certo, per Eco,
Nietzsche concepisce il cambiamento, ma questo
non si determina a causa delle costrizioni del mondo, della natura, del reale, cui sfuggire attraverso la
“favola”, quanto per la stessa azione creativa
dell’uomo tanto che un esponente della “posterità
nicciana”, come Vattimo, può ritenere sia l’essere
stesso a concedersi alla mutevolezza “nella sua languida debolezza e generosità” tanto da godere “nel
vedersi visto come mutevole, sognatore, estenuatamente vigoroso e vittoriosamente debole”, ovvero
“non più come «pienezza, presenza, fondamento, ma
pensato invece come frattura, assenza di fondamento, in definitiva travaglio e dolore» (e cito Vattimo,
Le avventure della differenza, p. 84)” sì da “essere
parlato solo in quanto è in declino”, in una ontologia
retta da categorie deboli (Vattimo p. 9). Ma se in altre parole, si chiede ancora Eco, si accetta “il principio che dell´essere si parla solo in molti modi, che
cosa è che ci impedisce di credere che tutte le prospettive siano buone, e che quindi non solo l´essere
ci appaia come effetto di linguaggio ma sia radicalmente e altro non sia che effetto di linguaggio, e
proprio di quella forma di linguaggio che si può
concedere i maggiori sregolamenti, il linguaggio del
mito o della poesia?” Nel senso che, ricondotto
l’essere alle sole interpretazioni, “Qual è lo statuto
ontologico di colui che dice che non vi è alcun statuto ontologico?” tanto più che “se è principio ermeneutico che non ci siano fatti ma solo interpretazioni, questo non esclude che ci possano essere per caso interpretazioni «cattive»”. Questi interrogativi
conducono quindi Eco a ritenere vi sia uno “zoccolo
duro” dei fatti che sfugge alle interpretazioni, o me-
glio, ne determina la non veridicità, il loro fallimento anche, un reale cioè che nega e si nega alla dicibilità che tenta di condurlo a sé sino a sostituirsi ad esso. E’ qui evidente come la critica a Nietszche riprenda quella heideggeriana circa la sostituzione
dell’essere con l’ente, sebbene, il fatto che le “interpretazioni” possano essere fallaci non venga negato
né dallo stesso Nietzsche né da Vattimo, essendo esse costitutivamente provvisorie, anche se, come vuole anche Eco, funzionali al nostro stare con le cose
che sono in una evidenza sempre carente del loro essere, a meno di intendere il loro “zoccolo duro” che
resiste alle definizioni un loro profondo e segreto “in
sé” che forse, in futuro potrà essere raggiunto dal
nostro dire. Ed è proprio avvertendo l’ambiguità della propria locuzione che Eco si affretta a spiegare:
“E qui debbo fare una precisazione, perché mi rendo
conto che la metafora dello zoccolo duro può fare
pensare che esista un nocciolo definitivo che un
giorno o l´altro la scienza o la filosofia metteranno a
nudo; e nello stesso tempo la metafora può fare pensare che questo zoccolo, questi limiti di cui ho parlato, siano quelli che corrispondono alle leggi naturali.
Vorrei chiarire (anche a costo di ripiombare nello
sconforto gli ascoltatori che per un attimo avevano
creduto di ritrovare una idea consolatoria della Realtà) che la mia metafora allude a qualcosa che sta ancora al di qua delle leggi naturali, che persisterebbe
anche se le leggi newtoniane si rivelassero un giorno
sbagliate – ed anzi sarebbe proprio quel qualcosa
che obbligherebbe la scienza a rivedere persino
l´idea di leggi che parevano definitivamente adeguare la natura dell´universo. Quello che voglio dire è
che noi elaboriamo leggi proprio come risposta a
questa scoperta di limiti, che cosa siano questi limiti
non sappiamo dire con certezza, se non appunto che
sono dei «gesti di rifiuto», delle negazioni che ogni
tanto incontriamo. Potremmo persino pensare che il
mondo sia capriccioso, e cambi queste sue linee di
tendenza – ogni giorno o ogni milione di anni. Ciò
non eliminerebbe il fatto che noi le incontriamo”. Di
qui l’individuazione del “reale”, paradossalmente,
attraverso la sua non possibile identificazione, la sua
impossibilità a rendersi, ovvero, con Pierce, Searle,
Hjelmslev, attraverso i limiti che esso pone alle interpretazioni pur non essendo identificabile, in un
“realismo” per così dire “debole” dove le cose sono
assunte in definizioni temporanee, convenzionate,
secondo le modalità che proprio Vattimo espone nel
suo confronto con Ferraris16. Oltre il possibile sfu16
Al termine del suo confronto con Ferraris, su “Repubblica”
del 19 agosto 2011, Vattimo afferma: “Chi dice che ‘c’è’ la verità deve sempre indicare una autorità che la sancisce. Non credo che tu ti accontenti ormai del tribunale della Ragione, con cui
i potenti di tutti i tempi ci hanno abbindolato. E che talvolta, lo
ammetto, è servito anche ai deboli per ribellarsi, solo in attesa,
però, di instaurare un nuovo ordine dove la Ragione è ridiventata strumento di oppressione. Insomma, se ‘c’è’ qualcosa come
67
mare del “realismo negativo” di Umberto Eco in una
ontologia debole, il rischio paventato circa
l’interpretazione dello “zoccolo duro” dei fatti quale
nascosto fondamento oltrestorico può essere ravvisato proprio negli architetti italiani del “nuovo realismo” degli anni settanta, i cui epigoni, figli del più
cupo provincialismo accademico, appaiono esaltarsi
alle idee di Ferraris. Sebbene la bibbia dei cosiddetti
“architetti razionali”, il testo di Aldo Rossi del 1966
su L’architettura della città, rinviasse il progetto,
secondo l’attenzione del tempo al linguaggio, alla
“forma” invece che ai contenuti funzionali, questa
veniva intesa quale luogo per una comprensività
dell’architettura, sia nella trasmissibilità didattica,
sia proprio nella relazione con i fruitori cui parlare
attraverso i modi della costruzione, i quali, rivolti ad
interpretare la città, ma anche le conformazioni territoriali, si offrivano ad una riconoscibilità collettiva,
sociale, circa la loro capacità di significare l’abitare
che, nel corso della storia, si era illustrato in precisati allestimenti tali da costituire una possibile lingua,
o “logica” 17. Di qui, il carattere “razionale”, che si
attribuiva all’architettura della cosiddetta “tendenza”, non inteso in proseguimento del razionalismo
modernista quanto nella ricerca, analoga a quella
degli architetti illuministi, dei motivi profondi, archetipi, del costruire, interpretati quali modi di rivolgere il singolo edificio all’assetto morfologico
della città, l’abitare singolare a quello collettivo, ovvero la volontà di “fondare” il progetto su basi
scientifiche, nel richiamo al kantismo degli epistemologi viennesi, secondo cui, i temi concreti del risiedere, storici e contingenti, le loro definizioni “osservative”, al fine di una acquisizione oggettiva, non
potevano non coniugarsi con definizioni “teoriche”,
appunto le “forme”, le “tipologie”, desunte
dall’analisi del costruire nel tempo e tali da costituire quasi delle categorie dell’intimo rivolte allo stare
comune. Un carattere “razionale” presente non solo
nella volontà di definire una teoria scientifica del
progetto, quanto anche nella vocazione analitica della stessa architettura, quale architettura della architettura, o, nei termini di Rossi e Bonfanti, architettura “analoga”, architettura condensativa in sé delle
ciò che tu chiami verità è solo o decisione di una auctoritas, o,
nei casi migliori, risultato di un negoziato. Io non pretendo di
avere la verità vera; so che devo render conto delle mie interpretazioni a coloro che stanno ‘dalla mia parte’ (che non sono un
gruppo necessariamente chiuso e fanatico; solo non sono mai il
‘noi’ del fantasma metafisico). Sul piovere o non piovere, e anche sul funzionamento del motore dell’aereo su cui viaggio,
posso anche essere d´accordo con Bush; sul verso dove cercare
di dirigere le trasformazioni che la post-modernità rende possibili non saremo d’accordo, e nessuna constatazione dei ‘fatti’ ci
darà una risposta esauriente”.
17
I testi di riferimento della cosiddetta “tendenza” sono: A.
Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966 e G.
Grassi, La costruzione logica dell’architettura, Marsilio, Padova 1967.
forme del tempo, laddove l’aspirazione a costruire
una lingua del costruire comprensibile e da tutti parlabile incontrava l’intenzione di trasformare la realtà, la città, il territorio, secondo la volontà popolare
di appropriarsi delle cose, in un nuovo “realismo”.
E’ indubbio che l’idea di una architettura autoanalitica, rivolta ad una autonoma anamnesi tale da giungere, come è in Rossi, sino all’autobiografia, o a rilevare l’inconscio collettivo reso nelle forme del costruito18 e, quindi, le tensioni popolari ad un abitare
comunitario, prosegua ancora l’estetica di Anceschi,
sebbene la gran parte degli esponenti della “tendenza”, nella loro vocazione alla interpretazione logica,
razionale, del progetto, e tra questi in particolare
Giorgio Grassi, tenda ad allontanare l’opera
dell’architetto dai territori dell’arte, da quelli della
sua aperta possibilità di significazione, per tentare di
determinare il costruire in rigide norme le quali assumono un senso dogmatico, sovrastorico, quasi a
definire le figure costruttive proprie all’anima, così
come era per lo studioso cui le nuove ricerche sulla
“tipologia” e “morfologia” urbana si ispirano,
l’architetto cattolico Saverio Muratori. La consacrazione della “tendenza” che, dopo aver liquidato
nell’università i vecchi docenti di progettazione e di
storia di matrice pragmatico-crociana, acquisiva
proseliti anche in campo internazionale, può riconoscersi nella mostra di architettura allestita alla XV
Triennale del 1973 da Aldo Rossi, accompagnata da
un testo-catalogo curato in particolare da Ezio Bonfanti e da un numero di «Controspazio», la rivista
diretta da Paolo Portoghesi la quale, nel compromesso tra il nuovo classicismo dei “razionali” ed il
neobarocco romano, rafforzato dalla vicenda del
commissariamento della facoltà di Architettura di
Milano presieduta proprio da Portoghesi, era divenuta l’organo dei “tendenziosi” 19. Se la versione
dell’architettura “razionale”, proposta dalla scuola
milanese, manifestava espliciti cedimenti alla metafisica, nell’aspirazione a delineare i “fondamenti”
dell’architettura, “rifondando” la disciplina e la città,
18
Chi riconosceva l’architettura come arte rilevando in quella di
Rossi le parentele con il surrealismo era Ezio Bonfanti che, a
proposito dell’architetto milanese scrisse Elementi e costruzione. Note sull’architettura di Aldo Rossi, in «Controspazio» n.
10, ottobre 1970.
19
Le turbolenze della facoltà di Architettura di Milano iniziano
nel 1963, ma è nel 1967 che, preside De Carli, in seguito alla
occupazione della sede, inizia la sperimentazione con assemblee
ed esami di gruppo che saranno censurati dal rettorato e dal ministero. In seguito alle dimissioni di De Carli, nell’ottobre del
1968, assume la presidenza Paolo Portoghesi il quale, dopo aver
confermato la necessità della sperimentazione e condotto la facoltà a prendere posizioni di apertura verso il mondo esterno dei
lavoratori e degli intellettuali, in seguito all’accoglienza, nel
1971, dei baraccati di Milano nella sede della facoltà per un
convegno sulla questione della casa, viene sospeso con altri docenti, tra i quali Aldo Rossi, dal ministro e sostituito da un ispettore, il prof. Corrado Beguinot, che condurrà alla normalizzazione.
mediante la definizione delle regole immutabili del
costruire urbano desunte attraverso le storie, si direbbe proprie a quello “zoccolo duro” di cui riferisce
Umberto Eco, le quali offrano anche le basi per
l’incontro con il “reale”, per l’incontro cioè con le
rivendicazioni di un abitare comunitario, Renato Nicolini, di scuola romana, in occasione della mostra,
tenta di definire il “razionalismo” dell’architettura di
“tendenza”, in termini meno assoluti ed assiomatici,
e, quindi, il suo “nuovo realismo” in termini dialettici più che metafisici, non legato cioè a “fondamenti”
immutabili dell’abitare concreto. Nicolini infatti intende sia il “razionalismo” che la “tendenza”, rispetto al senso univoco offerto dai milanesi, alle “chiuse
definizioni di scuola”, in termini pluralistici, citando
Gramsci, secondo il quale “porsi dal punto di vista
di una sola linea di movimento progressivo per cui
ogni acquisizione nuova si accumula e diviene la
premessa di nuove acquisizioni è grave errore: non
solo le linee sono molteplici, ma si verificano anche
passi indietro nella linea più progressiva”. Affermato quindi, contro “l’equivocità” del termine, il carattere pluralistico della “tendenza”, l’affondo di Nicolini sarà portato proprio nei confronti del concetto di
“realismo” che, distanziato sia da quello socialista
degli anni cinquanta sia dalle interpretazioni romantico-veristiche, viene assunto, si direbbe provocatoriamente rispetto a chi come Grassi manteneva
l’architettura a distanza dall’arte, nel proposito, proprio alle avanguardie atristiche, dal cubismo
all’espressionismo e, particolarmente, al surrealismo, di “conquistare le forze dell’ebbrezza per la rivoluzione”. Una “ebrezza” a sua volta non romantica ed intesa, attraverso la critica di Walter Benjiamin allo stesso surrealismo, fermo a manifestare
l’enigmatico come enigmatico, nella capacità di
“penetrare il mistero…nella misura in cui lo ritroviamo nella vita quotidiana, grazie a un’ottica dialettica che riconosce il quotidiano come impenetrabile,
l’impenetrabile come quotidiano”. Di qui la definizione di un “realismo” rivolto a penetrare il mistero
delle cose, non come immutabile fondo oltrestorico
né come loro fine ultimo, quanto immerso nella loro
mobile quotidianità, tale cioè da manifestare le molle, le vocazioni progressive, del vivere materiale. E’
indubbio come l’architettura di Rossi, che si rivolge
all’inconscio, personale e collettivo, quale luogo di
condensazione delle forme dell’abitare, coincida
maggiormente con le enunciazioni di Nicolini che
non con le chiuse determinazioni delle regole tipomorfologiche dei tendenziosi ortodossi, e del resto la
stessa mostra allestita vede la presenza di architetti
eterogenei, dai Five a Stirling a Canella, ad Aymonino, e solo l’ottusa analisi dei seguaci di Grassi,
quella di Siola e Bonicalzi, tenta di ricondurre il plu-
ralismo alla “omogeneità”, alla individuazione in essi di comuni “fondamenti logici” 20.
In tale retroterra, appare significativo che, oggi,
siano gli epigoni di Grassi, di un razional-realismo
dogmatico cioè, a salutare con entusiasmo il new
realism, tanto più che proprio Ferraris, rivolgendosi
all’architettura, si presta a non pochi equivoci. Ed
infatti, a confermare il concetto di una normatività,
fondata su “principi” oltretemporali, metafisici
quindi, dell’architettura, sempre anche “urbana”,
malgrado la palese, “reale”, perdita di confini e regole della città, Renato Capozzi, evocando il nuovo
realismo di Ferraris, chiamato a tenere una lectio a
Napoli, scrive: “L’Architettura parte da teorie e principî (supporto ideale specifico) perché non è solo
un’applicazione tecnica di alcune conoscenze o una asettica attuazione di alcune procedure ma parte da nomoi, da norme sulle quali cerca di fondarsi: nel lessico
di Ferraris potremmo dire che anche se queste teorie
vengono scritte su un supporto ideale e non materiale
tuttavia esistono allo stesso modo. L’architettura, che
pur muove dai principia, in definitiva produce exempla, produce degli oggetti concreti, ‘immanenti’ tracce,
che sono delle ‘iscrizioni particolari’: forme reali ancorché previste, che divengono in re specifici documenti ‘inscritti nelle pietre’. Il supporto generale
dell’architettura è la città che è il luogo dove vengono
accolti e radunati questi oggetti concreti: da iscrizioni
nelle pietre a iscrizioni nella città aspirando a realizzare quel passaggio – spesso evocato – tra Documento e
Monumento (supporto reale specifico)”21. In realtà
nel testo sul nuovo realismo di Ferraris il richiamo
all’Illuminismo può effettivamente far ritenere necessario definire possibili norme, razionali, delle discipline, ed in particolare dell’architettura, sebbene
sia palese in esso la diffidenza verso il “saperepotere”, l’epistemologia, che appunto si manifesta in
norme linguistiche. Distinguendo impropriamente
ontologia ed epistemologia, sebbene egli stesso convenga sulla presenza di ontologie negli atti conoscitivi e su quella di una disposizione epistemologica
nell’ontologia, Ferraris dichiara, nel suo saggio riassuntivo delle proprie posizioni filosofiche, il primato
della prima sulla seconda ovvero la necessità primaria di considerare la presenza delle cose, degli enti, il
loro essere, il loro stare di fronte al soggetto, cui si
applica il nostro conoscere, la nostra attività interpretativa, laddove il sapere, sebbene inerente la co20
Cfr. R. Nicolini, Per un nuovo realismo in architettura, in
«Controspazio», Anno V, n. 6 dicembre 1973, interamente dedicato alla XV Triennale. Nello stesso numero è anche l’articolo
di R. Bonicalzi e U. Siola, Architettura e ragione di opposto
convincimento Le divergenze tra Nicolini ed i seguaci di Grassi
emergono in parte anche nel volume catalogo Architettura razionale, Franco Angeli, Milano 1973, tra i due curatori, Ezio
Bonfanti e Daniele Vitale.
21
Renato Capozzi, così scrive nella presentazione di M. Ferraris, Lasciar tracce: documentalità e architettura, Mimesis, Milano 2012.
69
sa, nulla può sul suo presentarsi oggettivo22.
All’inverso, per l’autore, il postmoderno, in cui sono
coinvolti Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Vattimo, sino a risalire a Nietzsche ed Heidegger, messi
insieme quasi senza distinzioni, ponendo l’accento
sulle interpretazioni, attraverso “l’ironizzazione”, la
presa di distanza, la virgolettatura, dalla e della realtà con ogni sua seria considerazione (Husserl, Heidegger, Deleuze, Vattimo) e la “desublimazione” intesa nella promessa di una emenzipazione mediante
la liberazione del desiderio (Foucault, Deleuze), avrebbe condotto alla “deoggettivazione”, a ritenere
cioè inesistente ogni realtà “là fuori” e, quindi, privi
di oggettività e di progressività, del tutto paritetici, i
giudizi sulle cose, Copernico come Tolomeo, Galileo come l’Inquisizione, Pasteur come Esculapio. Al
disorientamento che deriva dal porre il tramonto della storia, il venir meno di ogni progressività, fa riscontro il fallimento della lusinga del postmoderno,
quella cioè di liberare l’uomo nella sua creatività, di
liberarlo altresì da ogni potere da disperdere nel succedersi delle “favole”, laddove all’attuale nostro
smarrimento corrisponde l’assoggettamento a poteri
più forti sebbene più sfuggenti ed evanescenti, i quali si avvalgono proprio della continua ricreatività
delle definizioni in cui ci irretiscono, modulata anche dai nuovi mezzi di comunicazione, riproduttori
di “interpretazioni” oltre ogni verità. Ucciso il realismo quale presa d’atto della oggettività dei fatti cui
si applica il sapere, il postmoderno ci ha quindi introdotto nel “realitysmo”, un termine del tutto contingente, connesso ai dispositivi televisivi con i
meccanismi di “giustapposizione”, “drammatizzazione” ed “onirizzazione”, coniato da Ferraris-De
Salvo onde definire una modalità della relazione con
il mondo già indicata da Kant, secondo cui, smontando l’ontologia, il pensare l’essere della cosa, questa non si dà se non dall’interno delle nostre figurazioni, dall’interno dei concetti, atti dell’io puro, che
lasciano intoccato il suo in sé come noumeno. Se
cioè il “realistmo”, “ritiene ci siano cose che non dipendono dai nostri schemi concettuali”, all’opposto
il “costruzionismo” riunisce chi ritiene che la realtà
sia solo quella costruita dal pensiero, inquadrata dalle nostre categorie mentali, apriori o storiche che
siano. L’indipendenza del reale dai nostri schemi
concettuali, posta dai realisti, ne determina anche la
“inemendabilità”, nel senso che vi sono cose e fatti,
come la prerogativa dell’acqua di bagnare o la morte
di Cesare, che sono immutabili anche nel mutare del
nostro sapere, sebbene il “realismo” non si ponga
solo come presa d’atto dell’esistenza di inemendabili reali, quanto, particolarmente in campo sociale,
anche in senso “critico”, dove è l’identificazione
22
Sarà perdonato se qui il testo di Maurizio Ferraris, Manifesto
del nuovo realismo, op. cit. viene ulteriormente schematizzato,
come è del resto nel destino dei “manifesti”.
della realtà a consentirne la critica e la possibile trasformazione. Abbreviando di molto il susseguirsi
delle considerazioni di Ferraris, dopo il rilievo sul
carattere estetico (percettivo) ed etico (di responsabilità rispetto alle azioni) del realismo, è nella distinzione tra “oggetti naturali”, esistenti nello spazio
e nel tempo indipendentemente dal soggetto, “oggetti sociali”, dipendenti dai soggetti, ed “oggetti ideali”, esistenti fuori dallo spazio e del tempo indipendentemente dal soggetto, che viene ipotizzata una
possibile pace duratura tra realisti e costruzionisti a
proposito degli oggetti sociali. Riprendendo la prima
tesi di Marx su Feuerbach, Ferraris afferma la stessa
realtà sociale come realtà oggettiva che, soggetta ad
interpretazioni, necessita di testimonianze documentali, scritture, testi, rivolti a circostanziarne i valori,
le convenzioni, sì da potersi dire, alterando la tesi di
Derrida “niente di sociale esiste fuori del testo”. Ciò
non induce, naturalmente, ad accettare l’idea postmoderna della liquidità dei rapporti sociali, tanto
più che nel testo viene messo in luce come la “fantasmagoria” delle interpretazioni dei valori, quelli anche economici, che muovono il nostro mondo, le sue
fluttuazioni, si sia scontrata con più pesanti determinazioni contribuendo alle crisi attuali, mentre
l’aspirazione ad una liberazione, ad “avere il mondo
in mano”, promossa dai nuovi mezzi comunicativi,
si è tradotta nel nostro essere in mano al mondo, essere assoggettati ad una mobilitazione operata da
quegli stessi mezzi. Piuttosto, confutando anche Searle, l’idea cioè che il sociale, con le sue trasformazioni, sia mosso da una intenzionalità collettiva, la
regola proposta da Ferraris, “oggetto=atto iscritto”,
testuale, documentale, o solo contrattuale tra due volontà, induce a riconoscere una oggettività dei fatti
sociali rispetto a cui operare possibili critiche, se si
vuole anche decostruzioni e ricostruzioni che siano
stringenti sulla vita concreta e non meri giochi testuali.
Le reazioni al testo di Ferraris sono state molteplici, dalle critiche, di Sini e Giammetta, che hanno
accomunato neorealismo e pensiero debole nel loro
confondere piano metafisico e piano empirico, al
quasi-consenso di Severino, il quale ha letto
nell’evidenza dei fatti sostenuta dal new realism un
sostegno alla propria critica circa l’errore fondamentale del pensiero occidentale a proposito del trascorrere dell’ente dal nulla al nulla 23. Ma, naturalmente,
23
Il dibattito sul nuovo realismo si è tenuto in gran parte sulla
rivista Micromega nel 2011. Carlo Sini è stato invitato da Ferraris a dibattere le idee contenute nel suo libro e di ciò è traccia in
un filmato su Youtube. Emanuele Severino, dopo aver confutato
su Micromega dell’Agosto 2011 l’assimilazione tra realismo e
senso commune è tornato sull’argomento, nell’inserto la lettura
del Corriere della sera del 16 settembre, dove qualche concessione a Ferraris non lo ha esentato della critica alla dimenticanza
di Gentile per il quale il pensiero stesso cui necessariamente si
offre il mondo era inteso come realtà.
70
le principali obiezioni ad una presunta oggettività
delle cose sono state mosse da Gianni Vattimo il
quale ha ribaltato l’accusa di fiancheggiamento del
“populismo” mediatico del potere politico da parte
del pensiero debole affermando all’inverso come sia
l’affermazione di una verità oggettiva del reale ad
essere già al servizio del potere, del capitale, essendo anzi la “resistenza del reale”, quella di poteri forti, economici, politici, mediatici, che tendono a costituire presunte realtà, a non consentire la liberazione promessa dal mondo della comunicazione e dei
mass media contro le rigidità tradizionali.
L’obiezione centrale di Vattimo al realismo sembra
consistere nell’addebitare ai suoi fautori l’incapacità
di prendere atto di quanto avviene, si direbbe realmente, nel mondo attuale, dove la fluidità dei discorsi si interrompe sulle pretese di realtà di chi ha il
possesso dei canali informativi, laddove l’offerta di
una realtà vera alternativa si presta ad una falsa dialettica che elude l’intervento sui flussi del senso.
Il testo di Ferraris si conclude con l’invito ad una
sorta di nuovo illuminismo e, data anche la precedente citazione di Habermas e del suo giudizio critico sul postmoderno, viene da chiedere se esso non
sia animato da una recondita nostalgia del moderno,
con tutto il suo pesante bagaglio ideologico di fini
progressivi e progetti di rinnovamento del mondo.
Una nostalgia che, oltre le letture degli architetti,
emerge proprio nell’analisi sull’architettura proposta
da Ferraris.
In “Lasciar tracce: documentalità e architettura”
il testo di una lectio tenuta presso l’università di Napoli, Maurizio Ferraris interpreta l’architettura come
oggetto sociale, ovvero come “oggetto=atto iscritto”. In tal senso, se vale l’affermazione che “niente
di sociale esiste fuori del testo”, l’architettura è da
considerare un testo, una testimonianza, una traccia
documentale di un certo status storico della società.
Per questo non vale ricercare relazioni con una scrittura che la giustifichi, la filosofia, tanto più che
l’incontro tra progetto e pensiero ha spesso condotto
ad obbrobri, come è stato per l’edificio delle facoltà
umanistiche a Torino, progettato da Levi Montalcini, architetto studioso di Croce, o all’inverso per le
case dei filosofi che pure si sono occupati di architettura, da Heidegger a Gadamer a Derrida, tutte esteticamente molto modeste. In quanto testo in cui
sono raccolti i sensi complessi dell’abitare, per Ferraris, l’architettura non può essere ridotta alla sola
funzionalità, sebbene l’eccessiva vocazione estetica
di tante opere attuali, dai musei che pretendono di
essere oggetti artistici, improntati alla bellezza, contenendo opere d’arte che invece dichiarano conclusa
ogni esteticità, ogni bellezza, ai prodotti di design
nei quali, in nome della bellezza, viene occultato il
funzionamento, pure sembra condurre ad una perdita
dei suoi intrinseci significati sociali. Considerando
l’architettura quale testo documentale appare invece
possibile la sua “interpretazione”, anche quella più
estrema della sua distruzione qualora non se ne
comprendano i significati, così come accade alla
porta del vagone ferroviario divelta dal pubblico nella difficoltà a comprendere il funzionamento della
maniglia. Naturalmente, tenendo presente il proprio
monito sulla problematica relazione tra filosofia ed
architettura, Ferraris si guarda bene dall’offrire indicazioni al progetto, anche se il suo intendere la costruzione quale testo in cui si condensa la memoria
sociale, quasi un contratto in cui si convengono i
modi dell’abitare collettivo, sembra voler indurre,
come è per i contratti, al privilegiamento dei contenuti, così come era nel paleo realismo, rispetto alla
libertà della scrittura costruttiva. Pertanto, pur non
esponendo decisamente il proprio giudizio, Ferraris
sembra essere critico di quell’architettura che utilizza i nuovi mezzi informatici rompendo i tradizionali
dispositivi linguistici in cui riconoscere possibili significati, funzionali, simbolici, estetici, la quale viene intesa nella sola, anacronistica nel mondo della
fine dell’arte, valenza artistica. Se mai così fosse egli quindi non si renderebbe conto che, ormai, i nuovi mezzi tecnologici hanno altresì mutato non solo le
condizioni del progettare quanto quelle stesse del
costruire, per cui, il fatto che la testualità architettonica si dispone, con la sua fantasmagoria, proprio
nella realtà materiale, dovrebbe determinare piuttosto l’attenzione verso le “interpretazioni” prodotte
da più effimere scritture.
E’ probabilmente il confronto con il nuovo dominio della tecnica ed i poteri che vi si nascondono
il vero fronte su cui tentare di sconfiggere il “populismo” che lo copre, mentre il rifugiarsi in testi che
tentano di riprodurre la vecchia cara stabile realtà
dell’abitare urbano, come vorrebbero gli architetti
della “postendenza”, nostalgici degli ordini e delle
circoscrizioni passate, sembra piuttosto configurarsi
come consolatoria reazione.
ideologica, costruttiva e non rassegnata della filosofia.
La fine della dialettica e di qualunque forma di trascendentalismo non consegnano all'uomo uno spettacolo catastrofico e insensato.
La crisi della modernità viene assorbita e trasfigurata
da Deleuze all'interno di un orizzonte positivo,
fondativo, costruttivo. Il co-struttivismo ontologico e
politico rappresenta la sfida deleuziana lanciata al
mondo della fine della meta-fisica politica borghese.
In questo quadro ritorna a splendere il motivo
materialista in filosofia sul doppio versante ontologico
ed etico-politico
E. Arosio,
Piccoli incontri con grandi architetti
Skira, Milano, 2012
J. Rykwert
La colonna danzante
Scheiwiller 24ore Cultura, Pero, 2010
Per quindici anni un giornalista dell’“Espresso” ha
incontrato grandi architetti internazionali autori di
opere che hanno trasformato l’identità delle città
europee e americane: maestri della professione,
ammirati e discussi, venerati come guru o al centro di
controversie politiche e culturali. Un lungo viaggio a
tappe per raccontarne la vita, le sfide, le affascinanti
personalità, da Renzo Piano a Jacques Herzog, da
Rem Koolhaas a Ettore Sottsass, ai progettisti
giapponesi, olandesi, svizzeri: la crema del dibattito
contemporaneo, vista da vicinissimo. Sullo sfondo,
una galleria di studi e cantieri frenetici, di inaugurazioni e polemiche. E le città protagoniste delle
profonde trasformazioni urbane di inizio secolo:
Berlino e New York, Milano e Barcellona, Amsterdam e Parigi, Roma e Pechino …
Una metafora antica quanto l'idea stessa di architettura
stabilisce una corrispondenza tra colonne, edifici e
corpo umano; dunque gli ordini classici che hanno
dominato in Occidente per tre millenni non sono
quell'inerte successione formale imparata a scuola
(dorico, ionico, corinzio, etc), bensì il frutto di
un'immagine archetipica che abbraccia luoghi e tempi
diversi: gli edifìci dell’Asia Minore e l’Estremo
Oriente, le antiche colonne egizie e il tempio greco. A
suo agio tra le teorie di Hegel e Schopenhauer, di
Adorno e Lukàcs, Joseph Rykwert passa da un’acuta
analisi dell’avversione all’architettura di Georges
Bataille al significato del letto di Ulissse intagliato in
un albero “grosso come una colonna”; da Vitruvio a
Leon Battista Alberti, fino alla modernità, l’idea di un
ordine proporzionato al corpo si complica e
arricchisce di elementi inattesi e sorprendenti: dalla
teoria dei numeri allo zodiaco, dal canone astrologico
e geometrico della figura umana ai simboli esoterici
degli edifici, dall’identità di genere alla fisiognomica.
Un testo imprescindibile; dopo aver letto questo libro
le costruzioni di Gaudi, Le Corbusier, Asplund, Loos,
parleranno in un modo completamente nuovo.
F. Lesce
Un’ontologia materialista
Mimesis, Milano, 2004
Della vicenda metafisica postmoderna, Deleuze
rappresenta senz'altro l'espressione positiva e non
F. Guattari
Architettura della sparizione, architettura totaleSpaesamenti metropolitani
Mimesis, Milano, 1996-2005
Le più recenti trasformazioni della realtà che ci
circonda si offrono come un orizzonte in permanente
modificazione. L’architettura, in quanto disciplina
profondamente intrecciata con la progettazione
spaziale, è chiamata ad un costante confronto con il
dispiegarsi delle nuove tecnologie, con il divenire del
territorio e le performance del ciberspazio. La
dimensione spaziale pone infatti nell’oggi, appare
radicalmente trasformato dall’accelerazione provocata
dal dispiegarsi delle tecnologie. Il territorio materiale
così come poteva essere inteso fino a qualche
decennio fa e scomparso.
Le tensioni economiche e sociali, nonché l’intera
dimensione progettuale hanno finito con il produrre
una realtà spaziale che potremmo definire come
territorio mutante. E’ un territorio che si profila come
un tessuto stratificato, neutro, in relazione alla
molteplicità che custodisce, alle sue eterotopie. Si
tratta di uno spazio in continua metamorfosi, in cui
tendenze consolatorie e decorative combattono contro
inclinazioni tese a misurarsi con il progetto di un
abitare, di un transito in grado di riscattarsi dai
meccanismi di segregazione in atto.
Scaricare