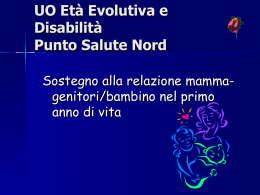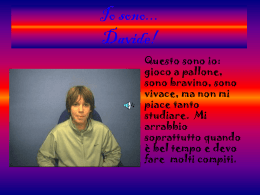MARIA JATOSTI IL CONFINATO Maria Jatosti, romana, ha esordito giovanissima come scrittrice e nel suo pluridecennale artigianato ha frequentato ogni genere, dal romanzo alla raccolta di versi, alla cura di periodici e antologie tematiche, al giornalismo, alla traduzione letteraria. Per Stampa Alternativa ha recentemente pubblicato Tutto d’un fiato definito, alla sua prima uscita nel 1977, un’autobiografia collettiva. per mio padre PARTE PRIMA I 7 Ogni mattina ci scuoteva il suono della sveglia e la voce di mia madre dal letto: – È tardi. Cosa fate? Quante volte devo chiamarvi? – Mio padre si rigirava nelle coperte e aspettava l’ultimo momento, poi lo prendeva la furia: correva in bagno a lavarsi, controllava la barba, dava un’affettuosa spuntatina ai baffi biondicci, si vestiva in fretta, ma con cura. – Dov’è la camicia pulita? Non si trova mai nulla in questa casa! – brontolava. – Quale cassetto? – Quando era pronto, si spazzolava le scarpe poggiando i piedi uno dopo l’altro su una sedia. – Scarpa vecchia, dagli di lustro, – recitava: sempre la stessa frase, lo stesso gesto, lo stesso tono. – I soldi dove sono? Mia madre alzava subito la testa dal cuscino: – Lì, nella borsetta. Li hai trovati? Bada che sono quasi finiti. – Come quasi finiti? Ma se siamo appena al venti del mese. Non capisco. Più ne porto più ce ne vogliono… – La vita rincara ogni giorno. Ho pagato le bollette della luce e del gas; la risolatura delle scarpe… I miracoli mi tocca fare, con quella miseria che ti dà lo Stato! Da parte mia, non mi compro nemmeno un paio di calze. Peggio di una serva vado in giro... Stava con la testa ritta, il gomito puntato e guardava nella penombra in direzione di papà che frugava gli spiccioli nel borsellino, borbottando: – Questi per il tram, questi per le sigarette… e questo è il caffè. – Il caffè, è proprio necessario? – Toglimi anche quel goccio di caffè al mattino… dimmi cosa mi resta. 8 – Io ne ho sempre fatto a meno. E poi… – Lo so, lo so: fa male alla salute e non serve a niente. L’hai detto mille volte. Ti saluto. – Si chinava a darle un bacio e se ne andava. La voce della mamma lo inseguiva per le scale: – Tanto tocca a me fare i salti mortali, con quella miseria che mi porti il 27. L’aria fresca del mattino coglieva mio padre di sorpresa. Appena voltato l’angolo gli cascavano di dosso i pensieri. Camminava spedito canticchiando a mezza voce un motivo d’opera. Lungo il tragitto in tram scambiava due chiacchiere col bigliettaio, col vicino, sorrideva a tutti ed era sempre il primo ad alzarsi per cedere il posto a una signora. A scuola il direttore lo stava aspettando in corridoio con l’aria corrucciata: – Cinque minuti… ieri dieci… sempre in ritardo… Lui si giustificava, entrava in classe e per quattro ore era felice. Io l’ho visto a scuola. A volte, bambina, mi portava con sé. Mi faceva sedere vicino a uno dei suoi scolari e io lo guardavo incantata e con trepidazione, e quando cominciava a passeggiare tra i banchi con le mani dietro la schiena e il capo chino da un lato, il piede destro un po’ buttato in fuori, ne ero intimidita. Sembrava più grande (era piuttosto esile e piccolo di statura, mio padre), e i suoi occhi più azzurri. Perfino la voce era diversa: non alzava mai la voce coi ragazzi ma sapeva tutto di tutti. All’uscita si fermava a lungo a chiacchierare coi genitori, accogliendo con gesto imbarazzato e colpevole i piccoli regali che solevano portargli: – Via, signor maestro, mica v’offenderete, vero? – e dimenticava il tram, il pranzo, tutto. – Brava Mariò, hai visto come mi vogliono bene? Sei contenta? Io gli stringevo la mano e camminavo orgogliosa al suo fianco. Dal finestrino del tram, mi indicava le strade, i ponti, mi diceva i nomi: Cavour, Sisto, Garibaldi, Sublicio… – Quando sarai più grande e studierai, saprai chi erano. Garibaldi, un grande eroe, eppure tanto modesto, un vero socialista. – Strizzava l’occhio e subito mi indicava un monumento: – Romagnosi, anche lui un grand’uomo, ma in un altro senso: un pensatore. Quando sarai grande… 9 Io stavo attenta e provavo un senso di sgomento. Pensavo che diventare grande, imparare tutte quelle cose, sarebbe stato difficile. Più tardi, ripassando per quelle strade, quei ponti, ricordavo la sua voce: Garibaldi, un vero socialista… Mio padre portava spesso il registro di classe a casa e il pomeriggio si chiudeva nel suo studio a lavorare, a trascrivere i voti nelle colonnine accanto ai nomi degli alunni. Qualche volta mia madre, che aveva una calligrafia da maestra, gli dava una mano: buono, lodevole, sufficiente, insufficiente… Noi stavamo di sopra, dove c’erano il bagno e la cucina, zitti e buoni a badare al più piccolo, a soffiargli il naso, a cantargli ninnenanne per farlo addormentare… Più tardi saliva la mamma a darci la cena e poi, tutti a letto. Lei restava alzata a mettere punti o a stirare, mentre mio padre usciva, come sempre. C’era tanto silenzio, allora. Nella nostra stanza arrivava un riverbero di luce e sapevamo che lei era ancora sveglia, ad aspettarlo fino a tardi. Al ritorno, papà la trovava curva sul lavoro, gli occhi arrossati. – Ancora in piedi! Lo sai che ti fa male… – Per quello che t’importa! – sospirava lei senza alzare la testa. – Mi lasci sempre sola… – Sei tu che ci vuoi stare. T’ho chiesto tante volte, io, di uscire. – Bravo, e ai ragazzini chi ci pensa? – I ragazzini! I ragazzini! Dormono come angioletti. E poi, Gioia è grande, ormai… – Sì, grande! Ha più bisogno lei di tutti e cinque messi insieme. Stasera le faceva male un orecchio… È tanto delicata, poverina… Se non ci fossi io… – Già, perché io… Non mettiamoci a litigare a quest’ora, su. Andiamocene a letto. Vieni qui brontolona, – e l’abbracciava. Ma lei continuava a tenergli il muso. – Almeno si sapesse con chi vai. Ah! Buono quello. Non m’è mai piaciuto. Un chiacchierone. Finirà per portarti alla rovina. – Ricominciamo? Smettila, posa quell’ago, che ti ciechi. Su, è ora di andare a dormire. – Va’, va’! comincia a scendere tu, io ti raggiungo. Fa’ piano, che si svegliano le creature. 10 A quel tempo le creature erano cinque. Lo stipendio di mio padre, maestro elementare, era striminzito come una coperta troppo stretta in un letto troppo grande, e ciascuno doveva tirare dalla sua parte per arrivare a coprirsi almeno le spalle. Ma tira e tira, papà logorandosi polmoni e stomaco dietro una cattedra, mamma a sbucciare patate, stirare, agucchiare, senza alzare mai la testa, si riusciva a sbarcare il lunario salvando il decoro, senza cioè rinunciare alle scarpe nuove il giorno di Pasqua e alla villeggiatura in casa del nonno ad Avezzano, un mese o due all’anno. Noi piccoli aspettavamo le feste per uscire coi genitori. I preparativi cominciavano al mattino, col bagno ai pupi. Poi c’era la pulizia delle scarpe, compito di papà. Intingeva un vecchio spazzolino da denti nella scodellina della biacca e lo passava e ripassava con cura sulla pelle bianca. Quando eravamo pronti, si usciva. La mamma in tailleur di taffettà nero, giacca a coda di rondine, camicetta con lo jabot, calze di seta e cappellino di paglia di riso con le ghiande sul davanti. Papà, camicia celeste a righine, cravatta a strisce, che odorava di smacchiatore. Camminavamo dandoci la mano davanti a loro che si tenevano in mezzo il più piccolo e sembravano preoccupati. Poi, a poco a poco, accennavano un sorriso, e cominciava la festa. Papà ci comprava il maritozzo con la panna: – State attenti a non sporcarvi, – diceva la mamma infilandoci il fazzoletto sotto la gola. – Mi raccomando, se no nonna chi la sente. Prima di baciarci, nonna Caterina ci passava in rivista, severa, con occhi inquisitori e trovava sempre qualcosa da ridire. Mia madre diventava rossa e abbassava gli occhi. – Mamma ti prego! Per fortuna arrivava il nonno. Sorridente, grande, ci prendeva in braccio uno ad uno, ci portava dentro e ci invitava a cena: pollo tutte le domeniche e quasi sempre anche il dolce. I grandi se ne andavano in camera da pranzo a parlare dell’ultimo discorso del duce, dello zio Wagner che aveva mandato una fotografia dall’Amba Alagi, con 11 la scimmietta sulla spalla, e di quando tutto questo finirà e non ci saranno più guerre, e speriamo che sia l’ultima davvero, poveri figli di mamma. La casa dei nonni era buia, vasta e silenziosa, con una grossa aquila nera impagliata ad ali aperte in salotto e la mantella da bersagliere del nonno appesa nel ripostiglio. Certe giornate fredde d’inverno, lo trovavamo intabarrato nel panno grigioverde, il fez rosso calzato sulle orecchie, la bottiglia del cordiale accanto, il volto che pareva accigliato ma che tutt’a un tratto si illuminava di un sorriso pieno di denti. Fuori, davanti alla casa, c’erano un cortile e una rimessa ingombra di camion e automobili. Ci si poteva stare fino a tardi a rincorrerci, a giocare a nascondino e a suonare i clacson. Tornavamo stanchi morti. Il più piccolo già addormentato in braccio alla mamma. Papà tirava fuori le chiavi, apriva piano piano il portone, accendeva la luce dell’ingresso e, con un frettoloso bacio – Buonanotte, buonanotte – prendeva il giornale e scompariva in bagno. Mamma faceva fare la pipì nel vasetto al più piccolo che frignava, disturbato nel sonno. Per un po’ c’era rumore di reti spostate, di scarpe lasciate cadere, risatine soffocate nelle lenzuola, poi lo scroscio dello sciacquone e i borbottii di mamma sotto le coperte, a luce spenta. La casa piombava in un silenzio caldo. Tutta la vita di quegli anni, a ripensarla, mi sembra immersa in quel silenzio vivo, in quella pace. Ricordo certi pomeriggi estivi quando mamma, papà e il più piccolo andavano a dormire e noi riparavamo dalla calura nel fresco umido della fontana. Mio fratello azzardava un tuffo nell’acqua gelata che spruzzava tutt’attorno e faceva impressione sulla pelle calda. Io avrei voluto imitarlo, ma papà ci aveva insegnato che prima di bagnarsi bisogna far passare almeno tre ore dal pasto, e così aspettavo rassegnata. Finché l’ombra non ghermiva il terrazzo e non si levava la brezza a far tremare le foglie e a scompigliare i capelli. Papà s’era alzato e appariva mezzo nudo, con le gambe bianche fuori dalle mutande celesti. Non riuscivamo a contenere il riso, ma lui faceva lo sguardo severo: – Brutte canaglie, non sono riuscito 12 a chiudere occhio, – diceva, già distratto. Fischiettando un’aria d’opera, controllava le campanelle tutte in fiore, sforbiciava, staccava una foglia ingiallita, raddrizzava un ramo, poi fissava il tubo di gomma al rubinetto della fontana e annaffiava con cura vasi e cassette. L’acqua straboccava inevitabilmente, inondando il terrazzo e facendo un bel fresco odoroso di terra. A noi non sembrava vero: a quel segnale buttavamo via le scarpe e a piedi nudi mandavamo via l’acqua con la scopa giù per il condotto mentre la mamma, per non assistere allo scempio, andava a preparare la merenda: pane mollato e condito con olio, sale e aceto. Una ricetta che le aveva insegnato mio padre: “panzanella” la chiamano dalle sue parti, e che serviva a non gettare il pane raffermo. Il pane per noi bambini era un’ossessione. Papà e mamma a tavola stavano sempre con gli occhi aperti a sorvegliare che non lo sprecassimo. Guai se ne restava sulla tovaglia: – Il pane lo mangiano i ghiotti, – recitava papà e ce lo faceva ingozzare anche dopo la frutta. – Se non mandate giù il pane e la minestra, come vi saziate? – faceva eco mia madre, sparecchiando la tavola. Anche le patate erano importanti. Papà le apprezzava cucinate in tutte le maniere, purché ci fosse un po’ di pepe a esaltarne il sapore. – Attento allo stomaco, – lo ammoniva la mamma, soddisfatta dentro di sé perché papà era di bocca buona e si accontentava di qualsiasi cosa gli mettesse nel piatto. Magari fossimo stati come lui. – Prendete esempio da vostro padre, – diceva sempre, – e vi troverete bene nella vita. Qualche volta, quando intascava i soldi delle lezioni private, papà tornava a casa con un gran cartoccio, tutto unto, colmo di gamberetti fritti e bollenti. Io e mia sorella Gioia, nella camera dei genitori, e ancora a orecchie tese, alzavamo la testa dal letto per correre al festino. La mamma sgranocchiava con gli occhi avidi, e intanto brontolava: – Chissà quanto hai speso. In quella rosticceria sono dei ladri, si vendono il sole d’agosto. – Su, su, mangia e sta’ zitta, se no ti va di traverso. Quando il cartoccio era vuoto, si restava delusi e con la voglia. 13 – Scendo a prenderne degli altri? – si offriva subito papà ma la mamma insorgeva, raccogliendo i gusci nella carta: – Sei matto? – anche se si capiva che avrebbe ceduto volentieri. – A nanna! a nanna! La festa è finita, – diceva papà. – Via, via, canaglie. Dal letto li sentivamo confabulare e sapevamo che stavano tramando di andare al cinema. Al Vittoria, la sala sotto casa, davano “La carica dei seicento”, con Errol Flynn, l’attore preferito della mamma. Allora sprofondavamo nel sonno, felici, senza accorgerci di quando rientravano. II 14 Quella primavera del ‘36 la guerra d’Africa finì. Fu una generale esplosione di gioia. Tornavano tutti, padri, mariti, figli di mamma. Anche mio zio Wagner. Il nonno e la nonna vollero andargli incontro a Napoli, per vederlo scendere dal piroscafo. Mia madre piagnucolò tutto il giorno e la sera la sentimmo parlottare più del solito sotto le coperte. Era il fratello più caro: quante notti aveva passato a piangerlo! L’ebbe vinta e partì anche lei. Per tre giorni restammo soli con papà. Fu bellissimo. Mio padre era un gran cuoco: non lesinava e se ne infischiava del disordine. La sera andavamo a dormire più tardi e il letto ce lo preparavamo da soli, con gran divertimento. Gioia, che era la più grande, pretendeva di imporci le sue regole: a tavola, nei giochi, nello studio, sempre, ma ci divertivamo lo stesso. Quando tornarono da Napoli tutti e quattro, la festa fu ancora più grande, anche se lo zio era diventato magro magro, aveva perso parecchi capelli e la nonna diceva sospirando, sottovoce, che da quella brutta malattia che s’era preso laggiù non sarebbe mai guarito. Ma era tornato, questo contava, e stava sempre in casa a giocare con noi e con la scimmietta che aveva riportato da Addis Abeba. Mia madre cantava e sfaccendava felice e ci lasciava far chiasso. Ci furono una quantità di pranzi e cene. Il nonno faceva brindisi, rideva e abbracciava il figlio con gli occhi lustri. La nonna tirava fuori dal ripostiglio le bottiglie che aveva preparato l’inverno con le essenze colorate e tutti ridevano e la prendevano in giro. – Ehi, mamma, mamma! è vero che c’è anche lo champagne? – Altro che! Vedrai che schiuma: vero bicarbonato d’annata. 1936! C’erano dolciumi, amici, confusione. La sera si stava alzati fino a 15 tardi ad ascoltare le avventure dell’eroe. Noi ne approfittavamo per scappare in cortile a provare la bicicletta nuova che mio fratello maggiore aveva ricevuto in quei giorni per l’ottavo compleanno. Anche il tempo era un trionfo. Era scoppiata la primavera. I cascherini cantavano a gola spiegata “Faccetta nera”, la radio trasmetteva canzonette a tutte le ore e ogni cosa sembrava voler fare a gara per rendere più bella la nostra festa. A scuola un giorno ci dissero di andare in divisa per fare le prove della grande parata. Mio padre le divise si era sempre rifiutato di comprarcele, alla fine provvide il patronato scolastico e tutto si aggiustò. Ci portarono inquadrati a piazza Venezia. Si stava come le sardine, attaccati l’uno all’altro e faceva un caldo insopportabile. Il berrettino di seta nera calcato sulla fronte stringeva: i capelli si appiccicavano e il sudore scendeva giù per il collo. A un certo punto la folla fu percorsa come da una grande ondata. Ne fui travolta, piegata, e mi mancò il respiro. Alto sulla mia testa si levava un urlo prolungato e possente, più forte, cento volte più forte di quello che giungeva dallo stadio la domenica. Provai a issarmi sulla punta dei piedi, ma vedevo solo la schiena di quelli che mi stavano davanti. Se alzavo gli occhi, riuscivo appena a scorgere una fetta di cielo. All’improvviso cadde un gran silenzio e nel silenzio rimbombò la Voce. Mi tolsi il berretto e mi asciugai la fronte con la manica. La voce seguitava a rombare, interrotta a ogni frase da un boato e a ogni boato corrispondeva quella specie di rollìo che mi dava il capogiro. Alla fine, tra urli, canti, spinte, sudore e mal di piedi, la folla cominciò a sparpagliarsi; il rombo si sciolse in mille voci più deboli, ma eccitate, euforiche. E sulla bocca di tutti echeggiava una sola parola: Impero, impero. Quella sera in casa si chiacchierò più del solito. Lo zio era bellissimo, attillato in una divisa nuova, nera da capo a piedi, con una frangia lucida sul berretto e un cinturone alto alla vita. Volle brindare al duce, al re imperatore, all’Africa Orientale Italiana e altre cose che non ricordo. Si fece tanto chiasso e mi passarono tutti i mali: il sonno, la stanchezza. Andammo a dormire tardissimo; per fortuna l’indoma- 16 ni era festa a scuola. Ormai era sempre festa. Soltanto mio padre mi sembrò taciturno e grave e più magro, più bianco del solito. Seguirono mesi di tranquillità. La gente aveva dimenticato la guerra. “Africa” era la marca di sigarette che fumava mio padre. I cascherini non cantavano più “Faccetta nera bell’abissina” per le strade diafane del mattino e mia madre soffriva il caldo. Fu un’estate torrida. In casa non si respirava. La notte non riuscivamo a dormire, a letto ci ritrovavamo in un bagno di sudore e al più piccolo il calore gli sfogava sulla pelle. Stavamo alzati fino a tardi ad aspettare il fresco. Papà scendeva a comprare le granatine e le bibite ghiacciate al chiosco d’angolo, ma, come diceva la mamma, erano soldi buttati via. Una mattina mia madre si sentì male. Cominciò a vomitare ed era pallida come uno straccio lavato. Accorse la nonna e se la prese con mio padre. – Benedetto incosciente! Cinque non te ne bastavano! La vuoi ammazzare questa disgraziata! Poi la crisi passò e mamma cominciò a ingrassare e a sferruzzare, come accadeva ogni tanto. Il pomeriggio, dopo mangiato, lei, papà e il più piccolo andavano a riposare e la casa sprofondava in un silenzio torpido. Qualche volta arrivava lo zio a prendere la tintarella in terrazzo. Steso sulla sdraia, ci chiamava per farsi spalmare l’olio di cocco. Mezzo nudo e unto, se ne stava ore e ore con un giornale sulla faccia ad arrostire prima da una parte poi dall’altra, – come san Lorenzo,– lo prendeva in giro papà. Al primo refolo di vento, raccoglieva il giornale volato via, si rivestiva e se ne andava, intontito e soddisfatto. Quell’anno rinunciammo alla villeggiatura. – Con cinque figli che crescono e uno in arrivo, – diceva mia madre, – bisogna pensare a una casa più grande. E ci vogliono i soldi. Fu così che si cominciò a parlare di trasloco. Il sesto nacque a marzo, prima del tempo. La levatrice disse che era colpa del grande dolore. La morte del nonno era stato un colpo terribile per tutti, ma specialmente per mia madre che, nei panni del lutto, scompariva, tanto s’era fatta magra. Il neonato fu chiamato Giovanni, come la buonanima, ma divenne subito Nino. 17 Fu una primavera molto triste. La nonna veniva ogni pomeriggio a piangere e a raccontare di quanto era buono, poveretto, e lavoratore: un sant’uomo. Anche se qualche volta, pace all’anima sua, gliel’aveva fatta grossa. Eh, quanto l’aveva fatta soffrire per via della politica e delle donne! L’appartamento dove ci trasferimmo alla fine dell’estate, era in un palazzetto a due piani, ad angolo tra un viale ombreggiato da due file di platani e una strada larga e senza edifici. D’autunno le foglie dei platani ricoprivano il viale come un tappeto di ruggine. Noi le raccoglievamo a mazzi, insieme alle bacche rotonde, delle quali ci divertivamo a sperdere nell’aria la peluria soffice. Ma più bello era salire sulle foglie ammonticchiate dagli spazzini e sentirle scricchiare allegramente sotto i piedi. Sulla terrazza dell’ultimo piano le donne, anche mia madre, ci andavano per stendere i panni e noi bambini per guardare il panorama: il monte, i giardinetti, i tre archi sul fondo e lo stadio. La domenica da lassù si poteva vedere la partita. Mio padre mangiava in anticipo, prendeva il binocolo e saliva in fretta, per assicurarsi la posizione migliore. Noi gli correvamo dietro, inseguiti dalle raccomandazioni della mamma. – Attenti a non sporcarvi. Non vi scalmanate! – Una volta, a Carnevale, ci facemmo le fotografie: la mamma con una vestaglia a fiori bianca e celeste e il viso più incipriato di quello di Giorgio mascherato da Pierrot. Io imbronciata come sempre, i capelli sulla fronte, gli occhi chiusi. Al rombo lontano delle voci dal campo, facevano eco i commenti infervorati degli inquilini. Mio padre e Proietti, il pugile gentile, il campione, che abitava porta a porta con noi, tifavano per la Roma, ma c’erano i fascisti, i ricchi e i “gagà”, come li chiamavano loro, che tenevano per la Lazio. Mentre i miei fratelli si attaccavano alle gambe di papà per farsi issare sul parapetto, Gioia e io ci sedevamo in un angolo a guardare il cielo e a indovinare le forme mutevoli delle nuvole: un elefante, una barca, un cappello da prete. Tutto il tempo col naso in su. Oppure, in piedi con le spalle al muretto, lasciavamo che il vento ci gonfiasse il 18 vestito, finché un brivido di freddo ci coglieva all’improvviso: il sole non c’era più e il colore del cielo all’orizzonte si confondeva col colore dei palazzi. Mio padre, col fratellino in braccio, tornava giù insieme agli altri, commentando animatamente il risultato. Ci aspettavano gli inevitabili rimbrotti della mamma, ma lo struggimento che provavo non era la pena del castigo: era la tristezza senza nome che mi afferrava talvolta, quando il cielo diventava scuro. Un giorno qualcuno disse che la partita si vedeva molto meglio dal monte. Il “monte”, una collinetta, poco più di un mucchio di terra a vederlo ora, si levava sull’altra parte della strada. Sotto ci stavano le fabbriche di vasi di terracotta. Prima di tutto, si stava più alti e la vista abbracciava l’intera zona che quasi non c’era bisogno di cannocchiale. Secondo poi, ci si poteva sedere, si potevano portare le signore, lasciare liberi i bambini, fargli prendere un po’ d’aria buona. Divenne un’abitudine. Qualche volta veniva anche la mamma, col cappellino e i tacchi alti, arrancando e lamentandosi per i piedi. Il chiasso dei ragazzini copriva quasi gli urli del campo… Però un paio di volte all’anno, quando c’era Roma-Lazio e LazioRoma, zio Wagner e papà andavano allo stadio. Pareva che si preparassero per un viaggio. Lo zio arrivava azzimato e lucido di brillantina, papà si vestiva a festa. – Allora, sei pronto? – Solo un attimo, aspetta. – Piuttosto, patti chiari, eh! Niente politica. Non fare che ricominci a scalmanarti. Dimmelo, che cambio strada. – Come sarebbe? Sembra che il tifo sia solo io a farlo. – Il tifo è una cosa, la politica un’altra. – Ma che politica e politica! Non fare il finto tonto! Tu credi che gli altri siano scemi. Guarda che lo stadio è pieno di poliziotti. E lascia stare quelle scarpe. Mica andiamo a ballare! – Oh! Mi stai seccando, lo sai? Porca miseria! Non vado in chiesa per non sentire le prediche, e arrivi tu! Sta’ a vedere che uno non può tifare per la squadra del cuore. – Forza Roma, abbasso la Lazio, eh? Si sa, la Lazio è la squadra dei gerarchi, dei fascisti. Che idiozie! Se non la smetti, una volta o l’altra ti capita un guaio. Io t’ho avvertito. Tu fa’ come ti pare. – Non vorrai insegnarmelo tu ciò che devo o non devo fare. Ma guarda se mi tocca arrabbiarmi con questo cretino. Andiamo, che è tardi. Ernestina, dove sono i soldi? – Che soldi? – chiedeva la mamma dalla cucina. – E vieni! – lo trascinava lo zio. – Se non ti sbrighi, il posto col cavolo che lo troviamo! Il monte Testaccio divenne la meta preferita di noi ragazzi. Senza avventurarci fino in cima, dov’era piantata una grossa croce, restavamo giù, a giocare a mosca cieca, a nascondino, ai quattro cantoni, a ruba bandiera. Infine, sporchi, sudati, pieni di strappi, con le mani e la bocca amare e appiccicose, tornavamo con le braccia cariche di fiori strappati alle siepi di oleandro e biancospino per farci perdonare dalla mamma. Lei, felice, andava subito a disporli nel vaso in mezzo al tavolo tondo col tappeto verde, in sala da pranzo. Ma un giorno accadde qualcosa e da allora io al monte non volli più tornarci, né da sola né coi fratelli. 19 Avevo fatto tardi e quando arrivai ansante per la corsa e la paura, il portone della scuola era già chiuso. Seduta sugli scalini c’era un’altra ragazzina. Si teneva la cartella fra le gambe e guardava in aria, niente affatto preoccupata. Non sapevo che fare. Il cuore mi batteva forte forte. Che cosa avrei detto alla mamma? L’altra s’era alzata come per andarsene, allora mi feci coraggio e le parlai. – Che vai a casa? – A casa? Sei matta? – Allora dove? Lei alzò le spalle. – Che m’importa? A spasso. Vuoi venire? Esitavo. Continuavo a fissare il portone sbarrato. Al di là c’era un silenzio profondo. Immaginavo le compagne sedute al loro posto, la voce sottile della maestra Usai che faceva l’appello, dritta in cattedra coi ritratti del duce e del re alle spalle e la carta dell’Italia alla parete; sen- 20 tivo l’odore dell’inchiostro e il fruscio dei quaderni… Quando cominciava a fare caldo, le finestre larghe sul giardino lasciavano entrare l’aria leggera e le rondini attraversavano il cielo coi loro voli netti e felici. A volte una mosca ronzava insistente e faceva venire voglia di chiudere gli occhi, poggiare il capo sul banco, farsi cullare dalla voce della maestra. – Oh, allora ci vieni? Andiamo al monte, dài. – E se ci vedono? – Ma chi ti vede? A quest’ora non c’è nessuno. Vuoi dire che non hai mai fatto sega? In che classe stai? – Quarta B. E tu? – Quinta C. Sono ripetente. – Quanti anni hai? – Undici, e tu? – Io otto. Come ti chiami? – Sabatini Tosca. – Tosca di lucean le stelle. – Che hai detto? – Niente. Io mi chiamo Maria. – Allora, ti muovi, Marì? Per via Alessandro Volta non parlammo, poi girammo in via Bodoni e attraversammo badando alle biciclette. Arrivate al monte, salimmo i tre gradini di cocci e ci inerpicammo per il viottolo sassoso. Nei punti dove il sentiero diventava più ripido, ci prendevamo per mano. Il caldo e la fatica alteravano il respiro. Era la prima volta che venivo al monte di mattina, e mi sembrava diverso. – Basta, – dissi. – Fermiamoci qui. – Dài, fifona, arriviamo alla croce. Mi asciugai il sudore con la manica del grembiule e mi chinai a raccogliere il nastro che mi era scivolato dai capelli. – Me lo rimetti, per piacere? – dissi a Tosca. – Dopo, dopo, – fece lei senza voltarsi. Oramai eravamo vicinissime alla cima. Davanti a noi si aprì uno spiazzo, limitato da una barriera 21 di cocci appuntiti alta almeno un palmo. Non c’era nessuno e in quel silenzio il luogo sembrava più vasto e sconosciuto. Al centro, sopra una base di cemento, si ergeva la croce di ferro nero e, sotto, in giro in giro, le mosche tripudiavano attorno a vecchi escrementi. – Ehi, guarda dove hai messo il piede! Tosca raccattò uno sterpo e sfregò la suola con indifferenza. – Di’, giochiamo ai tesori? Vince chi trova i più belli. Ci chinammo a cercare sassolini, vetrucci, pezzetti di porcellana colorata, riempiendocene le tasche. – Quello era mio. L’ho visto prima io. – Non è vero. – Sì. Ridammelo! Dopo un po’ ci stancammo e buttammo via tutto. – Facciamo un altro gioco. – E quale? In due non si può fare niente. – Andiamo a esplorare. Vieni con me. Prendemmo a corsa per la scesa, dalla parte opposta da cui eravamo venute. Giungeva a tratti un suono prolungato e sordo. Mi fermai spaventata. – Che cos’è? – C’è il mattatoio. Non lo sapevi? – Che cos’è il mattatoio? – Dove ammazzano le bestie, no? Ma non sai niente tu! Le bestie per fare la carne. Le ammazzano qui. – Poverine! – Come, poverine. E allora la carne che mangi dove la prendi? Io l’ho viste. Mio padre è macellaio. Il tuo che fa? – Il maestro, – risposi, turbata dalle sue parole e da quel lamento che non smetteva. – Andiamo via. Torniamo a casa. – Brava! E che gli racconti a tua madre? È troppo presto, bisogna aspettare l’ora di uscita. Riprendemmo la discesa, volgendo le spalle al mattatoio e cantando a squarciagola per non sentire l’agonia delle bestie. Poi ci venne la 22 stanchezza e ci sedemmo. Tosca tirò fuori la merenda dalla cartella: pizza e cioccolata, e la divise in due. Dopo mangiato ci venne sete e Tosca disse che sapeva dov’era la fontanella. Trovammo la colonnina di ghisa con lo zampillo fresco e gorgogliante che ci fece venire voglia di fare pipì. Bevendo m’ero bagnata il grembiule. – Guarda! E ora come faccio? – Levatelo, lo mettiamo al sole e vedrai che si asciuga subito. Non volli perché mi vergognavo. Sotto avevo un vestito vecchio e rammendato. – Oddio, e il nastro dov’è? – Che nastro? – Quello dei capelli, che m’era caduto prima. L’avevo messo qui, in tasca. Hai visto, te l’avevo detto di rimettermelo. Mi aiuti a cercarlo? Facemmo la strada di nuovo fino alla croce, ma inutilmente. Ero disperata e avevo voglia di piangere. – Era meglio che non ci venivo. Adesso che gli dico a mamma? – Uffa! Piantala di piagnucolare. Sei proprio una piattola! Che sarà mai! Vieni, andiamo a cercarlo laggiù. – Ma laggiù mica ci siamo state. – Non fa niente, andiamoci lo stesso. Ricominciai a frignare mentre Tosca, invece di aiutarmi, restava indietro, si chinava qua e là, tutta svagata, a raccogliere un sasso, un chiodo, una carta stagnola… A un tratto mi trovai la strada sbarrata da un uomo accovacciato. – Perché piangi? – mi chiese con un brutto sorriso sulla bocca. – Vieni qui, avvicinati, ti faccio vedere una bella cosa. Non mi mossi. Continuavo a pensare al mio nastro e mi sentivo sempre più infelice. Mi asciugai gli occhi con la manica. Forse quell’uomo poteva aiutarmi a ritrovarlo: lui era grande. – Vieni qui, vieni a vedere… Ti faccio paura?… Vieni… vieni… Scoppiai a piangere più forte. Ero tutta bagnata, avevo perso il nastro, dovevo dire una bugia alla mamma... Non avrei mai dovuto seguire Tosca. Lei mi diede uno strattone. 23 – Io me la squaglio. Scappa, stupida, scappa, scappa, scappa... Rimasi imbambolata. L’uomo si sporse in avanti, mi afferrò il polso costringendomi a chinarmi. Ritrassi la mano e fuggii col cuore che mi scoppiava. – Tosca! Tosca! Aspettami! – Inciampai e caddi. Quando mi rialzai il grembiulino era strappato, tutto sudicio. Raccolsi la cartella e ripresi la corsa giù per il viottolo sassoso, con gli occhi asciutti e le labbra strette. Per la strada non c’era anima viva: il sole stava in mezzo al cielo e bruciava sulle spalle. Mi passai una mano sui capelli spettinati e li sentii scottare. Davanti al portone di casa non ebbi il coraggio di salire. Allora feci il giro del palazzo, una, due, tre volte. Quando mi decisi ero tanto stanca e non capivo più nulla. III 24 Da quando mio padre aveva avuto l’incarico della biblioteca rionale, a volte non tornava a pranzo e passava ogni pomeriggio, fino a sera inoltrata, in uno stanzone polveroso a sistemare i libri e a catalogarli. Quel lavoro gli piaceva e non gli faceva sentire la fatica. Qualche volta Gioia e io andavamo con lui per aiutarlo a compilare le schede e a metterle in ordine alfabetico dentro delle cassettine lunghe e strette. Per tutto il tempo non ci scambiavamo una parola, non alzavamo la testa da quella polvere che faceva tossire. Per mia madre fu una vera manna. Era una divoratrice di libri. Da ragazzina aveva saccheggiato di nascosto la biblioteca paterna. A tredici anni aveva già letto Zola, Balzac, Stendhal e Tolstoj. Appena eravamo tutti a letto, si coricava anche lei, prendeva dal comodino l’ultimo libro che le aveva portato papà: I fratelli Karamazov, Il piacere, E le stelle stanno a guardare, Thérèse Raquin, Il tormento di Chopin, Bionda Maria… e stava lì, intorpidita, ore e ore con gli occhi stretti, sotto il lumino da notte, e se papà tardava non se ne accorgeva più. A casa di libri non ce n’erano molti. Mio padre non fu mai un gran lettore. – Preferisco la compagnia degli uomini, – diceva. Ricordo la piccola libreria nel suo studio, con quei pochi volumi allineati, accanto al vaso dei fiori, alla bomboniera d’argento e al busto di Dante di gesso. Ma quei pochi li amava profondamente e li citava di continuo. Il suo autore preferito era Jack London: Il tallone di ferro la sua bibbia. Ma gli piacevano anche Zola: Germinal, L’assommoir, e Anatole France, Il giglio rosso, e Dickens, Davide Copperfield, e Hugo, Il novantatré. Dei poeti amava Dante, ma anche Foscolo e Stecchetti. L’ultimo ripiano in basso dello scaffale era occupato per intero dall’enciclopedia Pomba e da una gigantesca edizione della Divina Com- 25 media. Quando nessuno mi vedeva, andavo a sfogliarla, col fiato sospeso, attratta e atterrita dalle illustrazioni del Doré. Sistemati e catalogati i libri, la biblioteca rionale fu aperta al pubblico. In principio venivano dei colleghi di papà, pochi operai, qualche signora in cappellino, rarissimi giovani. Per le signore c’era sempre quello che andava bene, ma più difficile era accontentare gli uomini. Certi avevano le idee molto chiare: I grandi iniziati dello Schuré e la Storia di San Michele di Axel Munthe andavano forte. Altri preferivano farsi consigliare. – Signor maestro, fate un po’ voi. Vorrei qualcosa di, come dire, sociale. Capite cosa intendo? – Certo. Ci penso io. Sociale erano Il padrone delle ferriere, I Borgia, I segreti di Parigi. Per non parlare de I miserabili. – Provate questo, – diceva mio padre con l’aria del farmacista che consiglia un rimedio per il mal di pancia. – Sono sicuro che vi piacerà. In ogni caso, potete cambiarlo. Il nome, per favore? Scriveva, sorrideva, faceva qualche raccomandazione e quello se ne andava guardando il titolo, un po’ dubbioso. Ben presto la gente diventò tantissima: papà stentava a soddisfare le richieste. Con nostra grande felicità, Gioia e io, quasi ogni pomeriggio, appena finito i compiti, andavamo ad aiutarlo. Quel lavoro durò un paio d’anni ed ebbe molto peso nella vita di mio padre, e anche nostra. Con lo stipendio che gli davano, la mamma, parsimoniosa com’era, fece rinfrescare la casa. Per giorni e giorni ci furono pittori e muratori e gran disordine. Bisognava camminare sui giornali e fare attenzione a non appoggiarsi alle pareti fresche. L’altra grande novità fu il telefono. I primi tempi squillava di continuo: era lo zio Wagner che si divertiva a fare scherzi. Poi arrivò finalmente la macchina da cucire per mamma. Il suo rumore nuovo ed efficiente riempiva la casa. Lei pedalava pedalava felice di non essere più costretta a stare fino a notte a consumarsi gli occhi sul cucito. Ora poteva consumarseli sui romanzi. Un giorno papà l’abbracciò euforico e disse: – Cosa ti piacerebbe in regalo? – Regalo? C’è qualcosa da festeggiare? – Che c’entra. Voglio farti un regalo, e basta. – Ci guardò con gli occhi furbi e noi aspettavamo col cuore in gola che tirasse fuori la sorpresa dalla manica. – Hai svaligiato una banca, per caso? – Andiamo! Di’ la verità, non ti piacerebbe avere la radio? – La radio? Lo sai che ci vado matta. Ieri ne ho vista una in vetrina, piccola così, una Germini. Lascia stare, va’, non prendermi in giro. – Donna di poca fede. Insomma, la vuoi o non la vuoi? Due giorni dopo arrivò la radio. Piccola, come piaceva alla mamma, con uno strano muso da bulldog e le due manopole per accendere e per prendere le stazioni: Roma prima e Roma seconda. La mamma la mise sull’étagère, con il centrino di filet; la spolverava e la lucidava ogni mattina, la teneva accesa tutto il giorno. Ascoltava qualsiasi cosa, ma la sua passione vera erano le commedie. Noi bambini amavamo la trasmissione della domenica, con Aramis che arrotava la erre, mentre la mamma scodellava i rigatoni pieni di sugo. Gioia e io imparammo subito tante canzoni: “Tornerai”, “Non sei più la mia bambina”, “Un’ora sola ti vorrei”, “Non dimenticar le mie parole”, “Parlami d’amore Mariù”… L’unico a non apprezzare la novità era proprio mio padre. Appena rientrato andava dritto dritto a spegnerla. – Bugie, fanfare, – diceva, e aggiungeva: – Propaganda, sempre propaganda! La propaganda, come la religione, è l’oppio dei popoli! Mamma protestava perché gli aveva interrotto la commedia sul più bello e lui finiva per uscire di nuovo, brontolando: – Che idiozie! Vorrei sapere che gusto ci provi. Amore! Amore! Romanzetti da cameriere. O ti abbottano col duce, o ti rimbambiscono con le canzonette, o ti scimuniscono con questa robaccia da serve. Ah! 26 Da qualche tempo mio padre era cambiato. Tra la scuola, la biblioteca e le uscite serali a casa non ci stava quasi mai. Quando c’era era ner- 27 voso, scuro, taciturno, di malumore, si arrabbiava leggendo il giornale, s’inquietava spesso anche con noi, con la mamma, e soprattutto con lo zio Wagner quando il sabato, vestito in divisa col berrettone listato d’oro, veniva a pranzo e cominciava a stuzzicarlo. – Se non ci fossimo stati noi, in Spagna i tuoi amici rossi avrebbero vinto a Barcellona. – Dovresti vergognarti solo a pronunciarne il nome. In Spagna Franco sta assassinando il popolo. Ma che discuto a fare! Io, con quelli vestiti da beccamorti come te non ci parlo nemmeno. – Perché, non te lo ricordi quando questa la portavi anche tu? – Io? Mi ci hanno obbligato una volta, ma non mi ci pigliano più, caro mio. A me queste pagliacciate fanno schifo! – Pagliacciate? Non siamo mai stati tanto temuti e rispettati nel mondo! Siamo potenti, siamo un impero! E guardati attorno: la gente è felice. Delinquenza, accattonaggio, disoccupazione: scomparsi. Il fascismo ha il consenso totalitario del popolo, degli operai. To-ta-lita-rio, sì, come ha detto il duce a Torino. – Ma fammi il piacere! Parli come i giornali. Cosa vuoi che dica la stampa imbavagliata, la stampa dei padroni? Benessere, prestigio… Che vergogna! E osi parlare della Spagna. Con le porcherie che hanno fatto i tuoi cari legionari. – E i tuoi amici, allora? Lo sai che cosa fanno i tuoi amici, laggiù? – Tu queste cose non le puoi capire. Ci penserà la storia. – Io capisco quello che vedo. Non sono un visionario come te. E quello che vedo è un’Italia risanata, una potenza. E tutto questo, non puoi negarlo, grazie a un uomo, a un genio, a un… – Un buffone delirante. Un pazzo criminale che ci porterà alla rovina. Ricordati quello che ti dico. La Francia! l’Inghilterra!… È il principio della fine. Non può durare: il popolo farà giustizia… – Il popolo! Il popolo. Che cosa ne sai tu, del popolo? Dovresti conoscerlo come lo conosco io: il popolo è compatto, ama il duce e lo seguirà sempre e dovunque. Tu vivi di illusioni, caro mio, per questo mi fai rabbia. Te e i tuoi amici sovversivi della biblioteca. 28 – Se ti sentisse tuo padre. Non hai rispetto nemmeno per la sua memoria. Da quando era tornato dall’Africa, zio Wagner era pieno di entusiasmo e di zelo. Andava a tutte le adunanze, non perdeva un discorso del duce, leggeva il giornale fino all’ultima parola e poi veniva a stuzzicare mio padre. La mamma lo diceva che scherzava, che non faceva sul serio, ma mio padre non era capace di mantenere la calma: diventava rosso e sembrava che volesse fare chissà che. Allora lei si metteva di mezzo. – Ma guarda questo cretino, – diceva – invece di andare con le ragazze, sta sempre qui a rompere le scatole con tutte queste storie: e la Spagna, e l’Albania, e Chamberlain, e adesso poi anche la Francia e Gibuti e Nizza e Savoia. Uffa! – Bisognava sentirli gli studenti, accidenti a quegli scalmanati, schiamazzare per le strade berciando slogan e strofette da trivio. Sono sempre stati i fanatici a portare alla rovina la povera gente. – Ma tu che ci fai qui, dico io, – riprendeva – trovati una donna e levati dai piedi! Il più delle volte finiva tutto in una risata. Ma quel giorno no. Quel giorno zio Wagner era infuriato davvero. Me ne accorsi quando salì in cucina a salutare la mamma e a noi non ci badò nemmeno. – Sta’ attenta a tuo marito, – fece calzandosi il berrettone. – So che si sta mettendo nei pasticci. – Ma che dici? – Da’ retta a me. Se la fa con gente pericolosa, tenuta d’occhio dalla polizia speciale. Altro che biblioteca! Pensaci tu. Io per me non gli dico più niente: uomo avvisato è mezzo salvato. E se ne andò sbattendo la porta. IV 29 Frequentavo la quinta elementare e in casa si parlava spesso di quello che avrei fatto dopo. La mamma propendeva per le magistrali, ma papà – Vedremo, vedremo, – diceva svagato, e rimandava ogni decisione. Intanto mi aveva procurato i libri per gli esami di Stato. Ogni giorno, oltre ai compiti regolari, mi faceva fare un esercizio dall’antologia Le quattro stagioni oltre a un problema e a un tema in più. Per il decimo compleanno mi aveva regalato il libro Cuore e voleva che facessi il riassunto dei racconti. Uno mi colpì più degli altri: parlava di un ragazzo che moriva accoltellato per salvare la nonna. La notte lo sognavo svegliandomi sudata e tremante di terrore. Su quel compito mio padre fece solo due correzioni e in fondo, in rosso, scrisse Brava col punto esclamativo. – Dobbiamo farle fare il ginnasio e il classico, – disse quella sera a mia madre. – Possiamo cavarne qualcosa di buono. È così portata per l’italiano, scrive così bene… – Sì, ha ripreso da me. Anch’io da ragazza… Però a che serve, mi domando, sacrificarsi tanti anni per poi maritarsi e mettere al mondo dei figli. Semmai, meglio le magistrali. Quello della maestra più che un mestiere è una missione. E lei ha un vero talento per i bambini. Coi fratelli, la vedi. È la sua strada. Sarebbe piaciuto tanto anche a me diventare maestra. Eh, se mio padre mi avesse fatto studiare! Papà scoppiò a ridere, ma senza malizia. – Ma quante cose volevi fare da ragazza? Scusa Ernestina, non hai sempre detto che volevi diventare medico, anzi giornalista, e ora maestra… – Ridi ridi, c’è poco da canzonare! Mio padre era un grande libertario, a parole, nelle idee, ma in casa… Insomma, se mi avesse dato retta, a quest’ora chissà dov’ero. Certo non con un morto di fame come te. 30 Quel compleanno lo ricordo bene. – Dieci tondi tondi, – disse mio padre. Li compivo l’11 febbraio e a scuola era festa: ricorreva non so che patto importante. Io ero nata proprio il giorno in cui l’avevano firmato, nel 1929. Mia madre raccontò per l’ennesima volta che era un inverno spaventoso, di freddo e di fame. La notte a Roma aveva nevicato e la mia nascita era stata così importante che tutte le finestre avevano messo la bandiera. Da allora ogni anno accadeva lo stesso e le compagne mi invidiavano. Ma quell’anno fu festa anche di più. Il 10 febbraio, cioè la vigilia, morì il papa e le scuole chiusero per tre giorni. La gente stava ad aspettare la fumata. Tutti dicevano chissà se sarà italiano anche questo. Alla fine fecero uno di nome Pacelli. – Buono questo, – commentò mio padre, leggendolo sul giornale. Dopo la scenata con papà, zio Wagner non era più venuto a trovarci. Lo incontravamo qualche volta dalla nonna, di sfuggita, sempre indaffarato. Ma il suo avvertimento aveva fatto breccia in mia madre, che aveva perso la tranquillità. Passava ore a spiare dietro le persiane il ritorno di papà, con gli occhi rossi di pianto, e quando finalmente lui arrivava, si lanciava in fitti interrogatori. – Dove sei stato? Che ci vai a fare con quello? Che cosa avete combinato fino a quest’ora? E se fosse una spia? – Una spia! Sei impazzita? È un amico, una persona rispettabile, onorata! Con quella famiglia, poi! Tutti vecchi antifascisti per tradizione. – Appunto! Proprio per questo sarà sorvegliato! Tu chiacchieri, chiacchieri, non ti controlli, ti fidi di tutti. Ha ragione Wagner, sei un incosciente. Non lo sai che anche i muri hanno orecchie? Chiunque può sentirti, denunciarti. La gente è cattiva, la gente… – La gente, la gente! Ma che ne sai della gente tu che vivi come una talpa? Sta’ a vedere che non posso parlare nemmeno a casa mia… – Parla, parla. Ma a me e ai tuoi figli non ci pensi? Io non mi capa- 31 cito. Possibile che per te non esista altro che la politica? Maledetta politica! Nella vita ci sono tante cose belle… – Sì, nei romanzi, al cinema, in quelle cretinate che ti propinano alla radio, forse. Ma non capisci che la politica è tutto e che tutto è politica? La politica non è una cosa astratta. Te l’ho spiegato mille volte, ma tu sei una zuccona. Che cose belle puoi aspettarti, finché questi farabutti comanderanno in qualche parte del mondo? Ma finirà, Ernestina, e più presto di quanto tu non creda. I tempi stanno maturando. Si dice che non siano d’accordo nemmeno fra di loro, pare che quello dia i numeri, e quell’altro… Lo sai cosa si racconta su Ciano e Mussolini? – No, non voglio sapere niente. Prima o poi ti farai prendere. Ti toglieranno il posto, la biblioteca, ti sbatteranno in galera. Finiremo sul lastrico, come mio padre, anzi peggio, perché lui almeno aveva un mestiere nelle mani. Sono quasi vent’anni che non ho un giorno di pace; prima lui, ora tu. Due fanatici, tutti e due… A questo punto veniva fuori immancabilmente la storia di quando i fascisti avevano preso il nonno, nel ‘24. Erano venuti di notte e lo avevano buttato giù dal letto e mia nonna, che era incinta, ebbe una crisi isterica e rimase semi-incosciente per tre giorni. Lo avevano portato via, caricato di botte, riempito di olio di ricino, sbattuto dentro, mentre davano fuoco allo stabilimento. Una storia che avevo sentito mille volte da mia madre la quale, in cuor suo, nutriva un odio anche più profondo per i fascisti. Ma proprio per questo, perché aveva conosciuto la tragedia, aveva paura che si ripetesse. – Eravamo signori, noi. Rispettati, invidiati. E guarda che fine ha fatto quel povero vecchio: a settant’anni suonati dietro un bancone con la pianuzza in mano. Finché non c’è morto. Mi piangeva il cuore a vederlo aggobbito, sputare il sangue, uno che era abituato a comandare decine di operai! Ma almeno lui era un artista, aveva un mestiere. Ma tu, se ti tolgono il posto, dove vai? A chiedere l’elemosina? – Oh, insomma! Basta! Smettila di fare l’uccello del malaugurio! Tanto lo so che è quel fanatico di tuo fratello che ti monta la testa. La prossima volta che si presenta a casa mascherato da beccamorto, lo 32 butto per le scale. È un insulto! Su, ora andiamo a letto piuttosto, che è tardi e mi si chiudono gli occhi. Quasi ogni sera era così. Il giorno dopo non si parlavano e in casa eravamo tutti tristi. Lei aveva gli occhi rossi per le lacrime che versava di nascosto, lui taceva ma era teso come una corda e spesso scattava, si spazientiva con noi senza ragione. A volte, invece, ci abbracciava all’improvviso come se stesse per partire per un lungo viaggio. – Papà! Papà! – Papà mi leggi una storia? – Papà, andiamo al cinema? – Al cinema? Che fanno? – “Riccioli d’oro”. È bellissimo, ci lavora quella bambina che balla e canta tanto bene… Ci andiamo papà? – Buoni, buoni, vi ci porta la mamma. Vero Ernestina? Va’ al cinema coi ragazzini. Ti distrai un po’, ti farà bene. – Figurati, ho proprio la testa per andare al cinema, io, beato te. – Su su, allegria. Non è successo niente. – Ancora. Ma succederà, se non la smetti. – Ha parlato Zaratustra. Ti dico di stare tranquilla, di non preoccuparti. Non mi succederà mai nulla, te lo prometto. Contenta? Su, fammi un sorriso. Per un po’ riusciva a consolarla e così tornava la pace e noi piccoli andavamo al cinema a vedere Shirley Temple, la bambina prodigio di Hollywood a cui tutte le ragazzine del mondo cercavano di assomigliare, pettinandosi e vestendosi come lei, coi suoi boccoli, i suoi abitini tutti piegoline e merlettini. Gioia a quel tempo aveva già allungato un po’ le gonne e al cinema con noi piccoli non ci veniva più. A vedere Robert Taylor, Greta Garbo o Errol Flynn ci andava con la mamma ogni sabato pomeriggio. Stavano sempre insieme loro due, in un mondo fatto di complicità, di piccoli segreti, dal quale io ero esclusa. Era diventata grande, Gioia. Non giocavamo più insieme. Una sera le era venuto mal di pancia e c’era stato tutto un accorrere, un bisbigliare, un arrossire. Più tardi sentii la mamma dire a papà: – Come si fa? Ormai Gioia è signorina, non può più dormire insieme alla sorella. Bisognerà comprare un altro letto, sistemarle la stanza. Intanto, per quella notte mi fecero coricare ai piedi del lettone, dalla parte di mamma. Non riuscii a prendere sonno e quando, molto più tardi, vennero i grandi, ero ancora sveglia, ma rimasi immobile e con gli occhi chiusi per non farmi accorgere. Li sentii parlottare a luce spenta con la bocca sotto le coperte e mi sforzai inutilmente di capire che cosa si dicevano. Da allora per molto tempo Gioia e io non dormimmo più insieme come prima che eravamo uguali, nonostante i tre anni di differenza. E d’un tratto mi ritrovai sola. Con la mamma non avevo mai avuto troppa confidenza e coi miei fratelli non mi ci trovavo bene. Loro non facevano che giocare alla guerra, disegnare aeroplani e carri armati, oppure organizzavano gare in bicicletta e io non avevo ancora imparato a pedalare. Mi chiamavano soltanto per cantare “Dancing in the dark” o “Cheek to cheek”, quando volevano imitare i film di Fred Astaire. 33 Da tempo papà non mi portava più con sé, né a scuola né in biblioteca e non faceva più progetti sul mio avvenire. Proprio quell’estate, che mi sentivo così sola e infelice, i miei genitori decisero di mandarmi in una colonia marina, con il pretesto che l’aria di Avezzano era troppo fresca per le mie tonsille perennemente infiammate. Neppure i preparativi, con le corse ai Grandi Magazzini a comprare il corredo, né il berretto di picchè bianco, né il costume a gonnellino rosso e blu o il pigiama nuovo con le cifre ricamate riuscirono a ricucire lo strappo della partenza. Nulla poté consolarmi dell’abbandono in un luogo lontano e sconosciuto. Non mi abituai mai. Per tutto il mese piansi e intristii. Le altre mi rubarono quasi tutto il corredo. Non dissi niente. Non feci amicizie. Non giocavo con nessuno e non scrissi neppure una delle cartoline che mio padre mi aveva consegnato alla stazione, già complete di indirizzo e francobollo. Allo scadere della condanna, dopo trenta giorni e trenta notti di penitenza, mio padre venne a prendermi alla stazione. Lo abbracciai col cuore stretto e una voglia irresistibile di piangere. Lui mi fissava grave e mi asciugò gli occhi col fazzoletto. – Ma non hai preso il sole, – disse. – Sei pallida, dimagrita. Che hai? – Mi hanno rubato il cappellino, – farfugliai fra le lacrime. – Che importa, ne compreremo un altro. Non piangere. Sta’ allegra, tra qualche giorno si riparte. Papà ti porta ad Avezzano. La mamma e i fratellini sono già lì, ti aspettano. – Avezzano? E la scuola, papà? – Vedremo. C’è tempo. Non pensarci. Mi tolse la valigia, mi prese per mano e s’avviò in silenzio. Andammo a mangiare in una trattoria di via Marsala e a tavola mi spiegò che probabilmente a ottobre non saremmo tornati a Roma. Soffiavano venti di guerra, disse, e ad Avezzano saremmo stati più al sicuro. Lui sarebbe venuto a trovarci ogni sabato per ripartire la domenica sera o il lunedì all’alba. Ero frastornata, stavano accadendo troppe cose. Non dissi niente e abbassai il viso sul piatto. Alla fine, dopo aver mangiato quasi nulla, vidi papà premersi le mani sullo stomaco poi prendere la magnesia bisurata e delle pastiglie nere che masticava lentamente. Solo allora mi accorsi che era tanto dimagrito e aveva la pelle come sbiadita. – Stai male, papà? – Sì. È meglio andare. Devo stendermi un po’ sul letto. Anche tu sarai stanca, povera cocca. 34 Ad Avezzano mi accolse un’atmosfera festosa, di trasloco, di novità. Gioia era ingrassata e s’era fatta più alta, superava la mamma di diversi centimetri. Aveva tagliato le trecce e portava i capelli sciolti, ondulati e biondi. Mi sembrò bellissima e irrimediabilmente cresciuta per me. La mamma era tutta presa dalla sistemazione della nuova casa, una costruzione a due piani, fuori del paese, con un enorme prato intorno e una grande acacia che proiettava la sua ombra sulla finestra del salotto. Sul retro c’era un terreno dove, disse la mamma, faremo l’orto. E sullo sfondo si ergevano le vette grigie e aguzze del Velino, così vicine che sembrava di toccarle. Mamma era felice, allegra: l’aria fina le giovava, le dava energia. Faceva lunghe passeggiate, grandi escursioni, senza lamentarsi mai per i piedi. Ben presto la novità disperse le tristezze e mi fece dimenticare la lontananza di papà. Si aprirono le scuole, venne la neve, accendemmo il camino. L’acqua gelava e la mattina bisognava infrangere lo strato di ghiaccio nella tinozza della fontana. Avevamo le mani gonfie di geloni, le gambe rosse fuori dei cappotti diventati corti. Ma tutto, la scuola, i cugini, la casa nuova, la neve, era una festa. Solo la domenica finiva per essere il giorno più bello e più brutto insieme. Nel pomeriggio veniva il nonno con gli amici: si mettevano in salotto, attorno al tavolo, col fiasco del vino, il mazzo delle carte e fumavano, vociavano, ridevano. Qualche volta, l’avvocato, che aveva una bella voce baritonale, cantava le romanze: “Torna caro ideal”, “O begli occhi di fata”, “Tre giorni son che Nina che Nina”, e tutti battevano le mani. Mio padre si alzava, insofferente, e cominciava a passeggiare per la stanza, con le mani dietro la schiena. Non amava quegli schiamazzi, il vino gli faceva veleno, lo stomaco non gli dava tregua. Così gli ospiti se ne andavano e lui si buttava sul letto senza mangiare fino all’ora in cui, pallido e affebbrato, usciva di casa e spariva nella notte pungente. Nel silenzio che seguiva, sentivo il fischio del treno che lo portava via. 35 La nostra felicità non era turbata neppure dalle sempre più insistenti voci di guerra. Da qualche parte del mondo era già cominciata. A scuola, ogni mattina i compagni più grandi irrompevano in classe urlando di uscire a manifestare contro la perfida Albione e i francesi cornuti. Dopo una debole opposizione, i professori cedevano, confortati dall’idea di una vacanza giustificata da alti motivi patriottici. Il corso straripava di giovanotti scalmanati che agitavano bandiere e cartelli, gridavano slogan, cantavano, si spintonavano per riversarsi alla fine nella piazza del municipio. Qui, sotto il palazzotto bianco e rosso del 36 podestà, inneggiavano, pestavano i piedi urlando guerraguerra. La gente li guardava con diffidenza. Tanto mica ci vanno loro, canaglie, le studiano tutte per non andare a scuola. In verità a scuola si combinava ben poco. In classe mia era arrivato un nuovo professore di matematica: Giulio Stallone, un biondino dall’aria stanca e malata di adolescente. All’appello, quando giunse al mio nome, alzò gli occhi. – Sei nipote di don Antonio? – disse. – Come sta tuo padre? Portagli i miei saluti. I saluti del professorino non feci in tempo a portarglieli, a mio padre: per un anno non lo rividi più. V Era primavera. Una primavera così splendida come non l’avevo mai vista. I monti sembravano disegnati sui vetri. La neve si scioglieva sulle vette e sulle curve della Majella. L’aria era pungente, buona a respirarsi. Il prato smaltato di mille colori, l’acacia fiorita di grappoli bianchi. Dietro casa i cavoli accartocciavano le foglie carnose e la lattuga imponeva la sua tenerezza. Le galline strillavano nel recinto. I piccoli rincorrevano le oche fino allo stagno o inseguivano i conigli impazziti nell’erba folta. Leone, il pastore dei proprietari, un bestione alto un metro che aveva il pelo dello stesso colore delle pecore e l’occhio mansueto come loro, dimenava pigro la coda in segno di saluto. Io mi riempivo le braccia di fiori di campo che poi gettavo appassiti, subito dopo. Ogni mattina ci svegliava la voce spiegata del fornaretto che infilava la pala e tirava fuori i pani caldi e odorosi, cantando a squarciagola: Torna ogni vela e tu non vuoi tornare Che lacrime amare versare fai tu… 37 Un sabato mio padre non tornò. Lo aspettammo la domenica e non venne. La sera del lunedì due uomini scuri, con l’impermeabile stretto alla vita e il feltro calato sugli occhi, picchiarono alla porta. Entrarono e subito si misero a buttare all’aria ogni cosa. Frugarono nell’armadio, nella cesta della legna, sotto i letti, come se avessero smarrito qualcosa che bisognava ritrovare ad ogni costo. La mamma li seguiva, gelida, mostrando loro le stanze. Giunti nello studio, cominciarono dagli scaffali: sfogliavano i libri ad uno ad uno, metodicamente, sof- fermandosi a interpretare appunti, chiose e sottolineature. Alcuni li trattennero, poi passarono alla scrivania, facendo cadere il busto di Dante che andò in mille pezzi. – Non preoccupatevi, signora, – disse uno dei due, – sarete risarcita del danno. – Quelle finesse! – disse mia madre tra i denti. Ora stavano rovistando nei cassetti. Sembravano molto interessati e borbottavano fra loro. – Diomio, le lettere! – trasalì mia madre stringendo il braccio di Gioia. – Gliel’avevo detto di bruciarle. – Buona, mamma, non farti capire. Non accadrà nulla, vedrai. – Le firme… i nomi… – Zitta! Gli uomini avevano finito. Presero delle carte, qualche libro e s’accostarono a mia madre. – Non c’è altro da vedere? – chiesero. – Il bagno, se v’interessa. Que… quelle cose, – balbettò, – le portate via? Perché? – Possono interessare. Bene, signora, scusate il disordine e buonanotte. – Ma, dove…? Mio marito, dov’è mio marito? Se n’erano andati in silenzio, col cappello sugli occhi, nella notte buia. 38 Mio padre era agli arresti da una settimana. Lo avevano preso mentre saliva sul diretto per Roma e trasferito alle carceri di sant’Antonio, lì ad Avezzano. Venne a dircelo Luciana, la sorella di Albertino, il sarto. Nella stessa notte avevano preso anche lui, e, insieme, il professorino biondo, Compagnoni, l’insegnante di latino, diversi studenti e perfino il cugino Brunetto. Tutte persone insospettabili. Le migliori famiglie. – Chi se l’aspettava che questa città fosse un covo di sovversivi pericolosi, – mormorava la gente, allibita. La madre del professorino era disperata. – È tanto delicato quel figlio mio! Non è come i fratelli, lui! È sem- 39 pre stato cagionevole. La prigione lo ucciderà. – Di fronte al marito, noto fascista della prima ora, era costretta a nascondere le lacrime. Non di rado, quando andavamo a trovare zia Costantina, che abitava nella casa di fronte, lo sentimmo sbraitare contro quel figlio degenere, chiamarlo teppista, disonore della famiglia. Luciana veniva spesso. Superato lo sgomento dei primi giorni, mostrava un’aria fiera. Una mattina, a casa sua, mi raccontò di quando Albertino e mio padre, tanti anni prima, s’erano presi a pugni. Allora suo fratello era avanguardista e mio padre capo dei giovani comunisti del paese. – Una scazzottata salutare, – sorrise. – È così che Albertino è diventato antifascista. Dopo la partenza di tuo padre, qui ha fatto tutto lui. Ma che pugni! Se lo ricordano tutti, quel fatto. Albertino lo racconta sempre. E pensare che ora si vogliono un bene. Meglio di fratelli… – Ma i fascisti che gli faranno? – Finché restano qui, non è tanto brutto. Il peggio verrà se li trasferiscono a Roma, come Brunetto e il gruppo di studenti. Dicono che li hanno caricati di botte per farli parlare. – Parlare? E di che? Cosa dovrebbero dire? – Vogliono che denuncino i compagni. Vogliono i nomi... – Ricordai la voce di mia madre: Oddio, le firme, i nomi… – Ma Albertino si taglierebbe la lingua piuttosto. – I nomi, – ripetei. – Ma perché, non li hanno presi tutti? – Tutti? Sì, starebbero freschi! Aveva terminato di preparare il pacco con la biancheria pulita, le sigarette, la frutta. La casa era vuota. Sul tavolo da lavoro c’erano i forbicioni neri di Albertino, il gessetto, il centimetro e in un angolo il manichino con addosso mezza giacca. Luciana serrò le imposte e chiuse la porta a chiave. – Vuoi venire anche tu? – mi disse. Il carcere di sant’Antonio era lontano, dall’altra parte del paese, in un posto molto solitario. Ci fecero entrare e lei s’avviò sicura a una specie di botteghino. Vidi affacciarsi una testa, poi una mano che ritirò il pac- 40 co e sparì. Mi parve un posto orribile e per tutta la strada del ritorno pensai a mio padre rinchiuso in quel luogo misterioso e pieno di silenzio, ai poliziotti che lo picchiavano per fargli dire i nomi dei compagni, ad Albertino che si sarebbe tagliato la lingua piuttosto che parlare. Mi vennero in mente Silvio Pellico e Piero Maroncelli e Federico Confalonieri e tutti i patrioti rinchiusi nello Spielberg. E mi sentii fiera. A casa trovai il nonno. Parlava a voce alta. Discuteva con mia madre. – Nessuna pietà per tuo marito. Io gliel’avevo detto. L’avevo avvisato che tirava una brutta aria. Ma a lui gli è sempre piaciuto fare l’eroe. Per sua fortuna, non è coinvolto in niente di serio. Lui non c’entra col gruppo grosso. Almeno lo spero. E ora, a questi pezzenti, mi dici tu chi ci pensa? Su me non ci contare. – Non ti ho chiesto nulla. Ce la caviamo, – balbettò mia madre chinando il capo per nascondere il rossore. – Guarda che io mi sono mosso. Ho fatto tutto quello che potevo. Ho messo di mezzo due grossi calibri, avvocati di Roma e dell’Aquila. Più di questo… Ho famiglia anch’io. Di teste calde in casa ne basta una. Anzi, sarà bene che qui non mi ci faccia vedere troppo. Appena avrò qualche novità, te lo farò sapere e ci incontriamo fuori, per strada. Poi arrivò la nonna da Roma. S’era messa la volpe argenté sulla spalla e il cappello. Aveva l’aria risoluta delle grandi occasioni. Prese subito in mano la situazione e studiò un piano di battaglia: bisognava dimostrare che mio padre non solo non era un sovversivo, ma anzi un vero fascista convinto e fedele. Rimuginò, complottò e alla fine, quando si ritenne pronta, ci prese tutti e cinque, compreso Giorgio di quattro anni, e ci portò al commissariato. – Guardateli, eccellenza commissario, guardate queste povere creature. Che ne sarà di loro? – Estrasse dalla borsetta una vecchia fotografia di mio padre tra un gruppo di colleghi. – Ecco, questo, il primo a destra, è mio genero. Un galantuomo. Guardatelo bene: vi sembra un delinquente? un traditore? Un nemico dello Stato e della patria? Un galantuomo, signor commissario eccellenza, tutto casa e lavoro, tutto dedito alla famiglia… 41 Giorgio cominciava a infastidirsi, in quella stanza angusta non voleva più starci. Frignava, scalciava. Miro e Livio si guardavano intorno irrequieti. Il commissario si volse, frugò nel cassetto e tirò fuori una caramella. Ma Giorgio la rifiutò e si mise a strillare. Gioia lo prese in braccio. – Zitto, zitto. Mangia la caramella, su. Tra poco andiamo via. Tieni, Gioia te la scarta. Succhiala, è buona… Approfittando della confusione, la nonna ci spinse avanti, trasse dalla borsa il fazzoletto e si mise a frignare anche lei. Io fissavo quell’uomo spietato, quel carnefice, che aveva strappato un padre ai suoi figli e che se ne stava insensibile dietro la scrivania, senza fare un gesto per riparare a quella grande ingiustizia. Ero piena di sdegno e lo odiavo. Se ne stava zitto, con gli occhi bassi, fissava un tagliacarte con l’impugnatura a forma di fascio littorio. Alla fine si rivolse a mia nonna. – Come vi dicevo, signora, non dipende da me, – sospirò. Nonna scoppiò in singhiozzi. – Vi prego, signora, controllatevi. Anche per loro. Non dovete agitarvi così. – E siccome la nonna, asciugatisi in fretta gli occhi si sporgeva cercando di afferrargli la mano, lui si tirò indietro, si ricompose e si alzò. – Ve lo ripeto, – disse con voce gelida, – non dipende da me. Stiamo aspettando disposizioni da Roma. L’unica cosa che posso fare è tenervi informata sugli sviluppi dell’inchiesta. Non dovrei, non vi prometto nulla, ma… Venite a trovarmi tra qualche giorno. Ora calmatevi e portate via questi bambini. Dopo qualche giorno si ripeteva la stessa scena. Lungo la strada la nonna ci istruiva. – Dovete fare la faccia triste, piangere, confermare quello che dico io, mica stare lì impalati come baccalà. Che vi ci porto a fare? Bisogna impietosirlo quel boiaccia fariseo. E ricominciava il teatro. – A questi innocenti chi ci pensa? Come faranno senza il padre? È stata una calunnia, signor commissario. Bisogna conoscerlo, quel galantuomo, sentirlo come parla, che cosa insegna ai suoi alunni... – E via discorrendo, con le lacrime al punto giusto. Ma le cose restarono tali e quali: si aspettavano disposizioni da Roma. Non sapendo più che cosa inventare, una volta mia nonna pensò di portarci in divisa. Bisognò in parte farcele prestare e in parte rimediare alla meglio, con un po’ di fantasia. – Domenica dovete venire al saggio ginnico, signor commissario. Ci saranno tutti e quattro. Visto come sono belli? Fascisti nella divisa e nel sangue, come li ha cresciuti il padre, una brava persona, un innocente accusato senza colpa. Venite a vederli in piazza. Su, voi, da bravi, salutate come si deve il signor commissario sua eccellenza. 42 La domenica, in argentina bianca e gonna pantaloni nera, ero in piazza con gli altri a eseguire l’esercizio di ginnastica ritmica con le clave, al suono del “Valzer della mezzanotte”. Miro, coi più grandi, fez e maglione nero col teschio, svolgeva una pantomima col moschetto. Attorno alla piazza la gente si accalcava. Le finestre, i balconi e la gradinata della cattedrale brulicavano di folla. Era la fine di maggio e splendeva un bel sole. Papà era in carcere da tre mesi: da qualche settimana lo avevano trasferito all’Aquila e tutte le recite della nonna non servirono più a niente. Del resto, il commissario aveva detto chiaro e tondo che il detenuto era reo confesso e che non sussistevano dubbi sulla sua appartenenza alla cellula sovversiva e sui suoi contatti con elementi pericolosi, sia ad Avezzano che a Roma. Per mia nonna fu la capitolazione. – Reo confesso! Reo confesso! – sbraitava. A quel punto si mosse il nonno. Andò personalmente al capoluogo a conferire con il grande avvocato, vecchio compagno di studi, ex socialista. Qualche tempo dopo ricevemmo una cartolina col motto stampato: “Credendo dubito”. Il famoso principe del Foro assicurava che nessuna imputazione precisa gravava a carico del figlio del vecchio sodale. Onde per cui il caso si sarebbe certamente risolto in un non luogo a procedere. Rassicurata dall’autorevole parere, la nonna riprese la via di Roma. VI 43 Da diversi mesi eravamo senza stipendio. Nel suo smisurato orgoglio, mia madre non avrebbe chiesto una mano a nessuno e il suo atteggiamento liberava i parenti dall’obbligo di aiutarci. Dato fondo a ogni risorsa, cominciammo a vendere i mobili: la sala da pranzo chippendale, il canapè, il trumeau, la savonarola di mio padre, il disegno di Boccioni ereditato dal nonno materno, la macchina per cucire Pfaff… Poi fu la volta della cucina economica. Pezzo per pezzo le nostre care cose se ne andavano da quella porticina sulle scale da cui erano entrate nove mesi prima, insieme alle nostre speranze. Veniva un estraneo, si metteva a contrattare con la mamma, tirava fuori il portafogli e se ne andava in fretta, con la faccia scontenta, lasciandoci con qualcosa in meno e quei pochi denari che presto sarebbero finiti. Stringeva il cuore vedere la casa svuotarsi e farsi troppo grande per noi. Poi non ci furono più soldi e più nulla da vendere e mia madre era disperata. Per fortuna c’erano i prodotti dell’orto e le uova di papera, di cui avevamo scovato il nascondiglio. Da Roma, nonna scriveva regolarmente, insistendo sempre sullo stesso tasto: Tu che sai usare la penna, manda una bella supplica a qualcuno in alto. Pensaci bene, figlia mia. Non hai nessuno. Ti hanno voltato le spalle tutti. Quanto a me, sono una povera vedova. Tuo fratello deve pensare a sposarsi e poi nella sua posizione non può compromettersi, tu lo capisci. Ascolta tua madre, insisteva, rivolgiti a donna Rachele, dicono che sia caritatevole, non come quel boia infame del marito. Prendi carta e penna e scrivile una bella lettera. Vedrai che se non è un cuore nero, si commuoverà. Metti da parte l’onore, l’orgoglio, non fare come quel fesso di tuo padre che a settant’anni suo- nati doveva sgobbare come un ragazzo di bottega per non aver mai voluto piegare la testa davanti a questi farabutti, per non aver voluto mai rinnegare le idee. Le idee, figlia mia, sono come le mutande: nessuno può togliertele se tu non vuoi. L’ideale, i princìpi, non te li può togliere nessuno, ma non riempiono la pancia e quando si hanno sei figli da tirare su… Mia madre era confusa. Non aveva nessuno con cui consigliarsi, a cui rivolgersi. Come scriveva la nonna, tutti le avevano voltato le spalle. Alla fine seguì il consiglio materno e dopo diverso tempo, quando non ci pensava più, arrivò il sussidio di donna Rachele. Trecento lire. Quella sera la sentii parlare a lungo con Gioia, che ora dormiva con lei nel lettone, al posto di papà. Era una notte dolce e placida e c’era tanto silenzio. Il borbottio delle loro voci si confondeva al limìo dei grilli. Dalla finestra spalancata guardavo le stelle e mi sentivo irrimediabilmente sola. I miei fratelli sembravano adattati alla nuova condizione. Giorgio e Livio scorrazzavano in lungo e in largo, andavano allo stagno a caccia di rane e di lucertole, organizzavano gare e sassaiole. Gioia si era fatta tanti amici nuovi e le sere d’estate, sulla via maestra, occupavano tutta la strada tenendosi a braccetto e cantando gli ultimi successi radiofonici. La domenica andavano in gita in bicicletta nei dintorni o si riunivano per ballare nella sala da pranzo vuota. Qualche volta mi univo a loro ma ero chiusa, scontrosa, timida e mi sentivo brutta, anche se qualcuno mi aveva detto che assomigliavo a Corinne Luchaire, l’interprete di “Prigioni senza sbarre”, e la cosa mi faceva sognare. L’unico raggio di sole nella mia vita fu l’arrivo dell’ultimo fratellino, quello che portava il nome di nonno Giovanni. Ce lo riconsegnò la balia, tutto biondo e rosa. Mi aveva subito scelto come mamma e mi stava sempre dietro. Rideva, si rotolava sul prato e se la faceva addosso. Guardarlo, occuparmi di lui era una festa continua. 44 Ma la lontananza di mio padre mi faceva male come una ferita: avevo sempre netto nelle orecchie il fischio modulato col quale si annunciava il sabato sera dal fondo della stradina e la notte piangevo bagnando 45 il cuscino. A consolarmi un po’ di quella pena era soltanto l’amicizia di Luciana: i suoi discorsi mi empivano di esaltazione e di orgoglio e sempre più mi rafforzavano nella convinzione di essere figlia di un eroe. Mio padre fu condannato a due anni di confino in un paese del sud e per noi cominciò l’attesa dell’autorizzazione a raggiungerlo. Intanto ci sentivamo in una terra di nessuno, fuori dal mondo, in una realtà tutta privata e particolare. Quello che stava accadendo al di fuori della nostra vicenda, non ci riguardava. Nemmeno lo scoppio della guerra ci strappò all’isolamento. Il 10 giugno dagli altoparlanti piazzati a ogni angolo, nelle strade e nelle piazze, la voce rombante annunciò l’entrata in guerra dell’Italia. Quattro giorni dopo gli stivali tedeschi calpestavano i Campi Elisi a Parigi, la città di Jean Gabin e Michele Morgan. A fine estate, il permesso di partire arrivò. Iniziarono i preparativi. Vennero due facchini a imballare le poche cose che ci era consentito di portare: i letti, un tavolo, quattro sedie, un armadio, un cassettone e una credenza di cucina. Del resto, non rimaneva molto di più. Spediti i mobili, la mamma preparò le valigie, lasciando fuori pullover e spolverini, nel caso la notte, in viaggio, facesse fresco. Vennero i parenti a salutarci, con la faccia delle grandi occasioni, e, per non far vedere la casa vuota, la mamma offrì il tè in giardino, mostrandosi serena. – Alla gente, – disse quando se ne furono andati, – non bisogna dare soddisfazione. Dentro casa tua puoi mangiare pane e cipolla, ma di fuori devi farti invidiare. Bisogna andare sempre a testa alta. Ricordatevi che vostro padre, – aggiunse, – non è né un ladro né un assassino. Essere perseguitati politici è un onore. Anche il mio ha pagato per le sue idee. E vostro padre, a parte il viziaccio di non tenere la lingua a posto e di fidarsi stupidamente di tutti, non sarebbe capace di fare del male a una mosca. Era la prima volta che la sentivo parlare in quel modo e non mi piacque. Non sapevo se essere contenta o odiarla. Consideravo mio padre un eroe, qualcuno di cui andare fiera e che un giorno sarebbe entrato nella storia, come Garibaldi di cui mi parlava da piccola, tenendomi la mano, per le strade di Roma. PARTE SECONDA I Cutro, 18 ottobre 1940 49 Mia adorata Ernestina, è trascorso un po’ di tempo dall’ultima lettera dal carcere. Spero che tu non sia stata troppo in pensiero. Appena arrivato a destinazione, sono stato riaggredito dal vecchio male. Devo dire che da più di otto mesi, diciamo da quell’infausto sabato sera di febbraio, non mi dà pace. Sono andato dal medico condotto di qui (vedessi il suo studio!) il quale mi ha ordinato, indovina un po’, le solite cartine e il solito carbone. Ha anche aggiunto, naturalmente, che dovrei smettere di fumare e fare una vita più sana e più regolare (!). Comunque, appena mi sono sentito meglio, ho cominciato a fare qualche passeggiata. Ne avevo gran bisogno, dopo le obbligate ristrettezze… Passeggiare è l’unica cosa permessa in questa landa dimenticata da Dio e dagli uomini. Cara moglie mia, non sai che impressione mi ha fatto rivedere gente, strade, una bottega di barbiere, una scuola, anche se qui comunicare con gli indigeni è virtualmente impossibile, a causa della lingua bastarda che parlano. L’unico col quale ho scambiato qualche frase intelligibile è il maresciallo dei carabinieri, ottima persona del resto, che mi dimostra, bontà sua, grande stima e simpatia. Ha capito con chi ha a che fare e chiude un occhio. Domani andrò a vedere la casa che mi hanno assegnato: speriamo bene. Ad ogni modo, si tratterà di portare pazienza per un paio d’anni. Una volta tornati a Roma tutto cambierà. Non bisogna disperare. Penserò a tutto io, vedrai, ti farò fare la signora come prima, anzi meglio. È una promessa. Ma dovete venire presto perché senza di voi non ce la faccio più. Ti accludo qui di se- guito l’itinerario preciso che dovrete seguire, con gli orari dei treni, le coincidenze e tutto il resto. Non ti nascondo che sono molto preoccupato. Ma se non fate pasticci, se seguite alla lettera le mie istruzioni, tutto dovrebbe andar bene. Raccomando a Miro che ormai, coi suoi dodici anni e mezzo, è l’ometto di casa, di essere giudizioso, di aiutare la mamma. A Gioia, di badare ai fratellini. A Maria non ho bisogno di dire nulla. A te dico soltanto di essere all’altezza della situazione. Mi rendo conto che non sarà facile: è la prima volta che affronti un viaggio così lungo, da sola e con i bambini. Tu che non sai arrivare a piazza Venezia, se non ti ci porto io! Ma ho fiducia in te e so che non mi deluderai. Non vedo l’ora di riabbracciarti. Mi sei mancata da morire. Conto i giorni, le ore. Salvo errori, dovreste arrivare il 28. Sarà… (A questo punto era tutto cancellato e c’era il timbro della censura.) Vivo nell’attesa che spunti l’alba di quel gran giorno. La separazione è stata troppo lunga, troppo ingiusta e dolorosa. Credimi, non posso più stare lontano da te e dai figlioli. A presto, dunque, ma prima scrivimi, subito, rassicurami, dimmi se sono stato chiaro, se hai capito tutto o se hai qualche dubbio. Bacia tanto le creature. A te dico solo: vieni presto. Tuo Lino 50 Era la prima lettera di mio padre dal confino. La mamma la lesse a voce alta, per via delle raccomandazioni. Volle che noi grandi imparassimo a memoria il foglio accluso con le istruzioni. Il viaggio era spiegato con tale dovizia di particolari che affrontare la grande avventura ci sembrò una cosa da nulla. C’era tutto: l’orario di ogni treno, stazione per stazione, il numero del binario, le coincidenze, i possibili ritardi, ogni cosa scritta in inchiostro violaceo nella consueta grafia di mio padre, regolare, fitta, con le righe pendenti verso il basso. Alla banchina ci furono pochi addii. Gioia pianse disperatamente continuando ad agitare il fazzoletto per salutare qualcuno che già non si vedeva più. Miro era così compreso del suo ruolo che si sedette soltanto dopo aver minuziosamente controllato che ogni cosa fosse in 51 ordine. La mamma stava di fronte, con Giorgio e Gioia ai lati. Immobile, lo sguardo fisso davanti a sé, sembrava assorta in qualche grave pensiero. Dalle tende marroni il sole filtrava una luce smorzata. I nostri compagni di viaggio sonnecchiavano o si guardavano attorno smarriti. Nino si era addormentato in braccio a me e io trattenevo il respiro per non svegliarlo. Aveva i capelli biondi fini e ricciuti, le ciglia curve sulle guance rosate. Di tanto in tanto traeva un profondo sospiro e accennava a muoversi. Allora la mamma si volgeva verso di me, ma subito il suo sguardo andava oltre, a perdersi in un punto indefinito. Non sembrava stanca, pareva piuttosto che un pensiero fisso le tendesse una molla di dentro. Serbava un’ansia pudica negli occhi, come per un pericolo non ancora passato. Riconoscevo quello sguardo, quell’angustia composta. Ricordavo quegli occhi chini su di me in una ostinazione febbrile, tanti anni prima, per tutto il tempo della malattia. Sentivo la sua mano sulla fronte nella penombra della stanza e il silenzio della casa intorno, come se tutti fossero andati via o dormissero. Il fresco delle lenzuola, il freddo del vasetto contro la pelle bruciante e il gorgoglìo della pipì che metteva un brivido; le sue parole scarne e poi di nuovo il fresco del cuscino sotto la guancia. Lei se ne andava e da lontano mi giungeva l’odore del latte sul carbone acceso: lo faceva traboccare sempre. Il suo ritorno lieve… La sera non arrivava mai. Fissavo la porta in attesa di papà. Lui entrava in punta di piedi, mi posava le labbra sulla fronte poi, mentre la mamma provava sul dorso della mano il calore dell’impiastro di semi di lino, si metteva ad armeggiare col pentolino sul fornello a petrolio. Presto l’odore acuto della trementina mi andava su per il naso facendomi tossire. Passata la crisi, la mamma mi aveva messo un altro cuscino dietro la schiena affinché potessi leggere gli album illustrati e i libriccini di fiabe che mio padre mi portava ogni sera. Avrei voluto non guarire mai, ma un giorno il contatto del termometro non mi fece rabbrividire più e il mercurio non salì. Papà mi prese in braccio e mi posò sulla poltrona accanto alla finestra, mamma mi mise una coperta sulle ginoc- chia e scostò le tende perché potessi vedere il cielo, poi se ne andò taciturna e frettolosa. Accarezzando la cima dei platani già verdi nell’ultimo sole d’inverno, il tramonto veniva a indugiare sui vetri, accendendo misteriosi arabeschi sulle pareti. Papà era uscito. La mamma non era più al mio capezzale, la sentivo cantare di là dalla porta con quella sua voce appassionata che rendeva più belle le melodie. Cantava “Violino tzigano”, “Mi chiamano Mimì”, “Come pioveva”… La immaginavo seduta a cucire o davanti allo specchio a pettinare le onde brunodorate dei capelli sulle guance bianche di cipria. Il viaggio fu interminabile. A ogni stazione il treno faceva lunghe soste. Tra frotte di militari che affollavano la banchina, stretti a una donna in lacrime o si sporgevano dai finestrini delle tradotte a salutare, o spenzolavano le gambe grigioverdi dal vagone, o se ne stavano stravaccati sulle reticelle dei bagagli, o vociavano senza allegria, o cantavano sgangherati: Si stato ‘o primm’ammore ‘o primmo e l’urtimo sarraje pe’ mme Oj vita, oj vita mia… 52 Era la prima immagine di guerra vista da vicino. Anche mio padre una volta era partito vestito come quei soldati, con una brutta divisa ruvida e le gambe avvolte da certe strane fasce. Ci baciò tutti alla stazione con le lacrime agli occhi e grandi sventolii di fazzoletti, ma dopo un po’ lo avevano rimandato a casa perché la guerra non si faceva più. Anche loro sarebbero tornati presto, molto presto. Si diceva che la guerra sarebbe durata pochissimo: questione di mesi. Lo scompartimento era pieno come un uovo. Appiccicati, sudati, quasi non respiravamo. Gioia, infastidita, si faceva vento con una cartolina, Nino si era innervosito e la mamma ed io facevamo a turno a baloccarlo e tenerlo buono con un biscotto, una carezza. Miro e Livio chiacchieravano fra loro e Giorgio faceva mille domande. Molti pas- 53 seggeri dormivano con le braccia incrociate sul petto e la bocca aperta. Quando il treno si avvicinò a Napoli, corremmo ai finestrini del corridoio per vedere il Vesuvio e il mare. Ma non si distingueva nulla. Non si capiva neppure che fosse proprio Napoli. Fu una grande delusione. A Sant’Eufemia scaricammo i bagagli e scendemmo perché, come stava scritto nella lettera che mamma consultò per l’ennesima volta, bisognava cambiare, aspettare venti minuti la coincidenza e salire al binario numero tre. Attenzione a non sbagliare: numero tre, salvo avviso diverso del personale ferroviario. Il treno, una littorina aerodinamica, bellissima, moderna, portò molto ritardo. Carichi di valigie, ragazzini, pacchi, borse, provammo imbarazzo e apprensione a occupare i bei sedili imbottiti. Ma andò tutto bene e la notte trascorse tranquilla. Alle prime luci vidi la sfera rossa del sole emergere dall’acqua e restai ammutolita. Il mare era una distesa enorme, ferma, chiara, misteriosa: per quanto spingessi lo sguardo, non ne vedevo la fine. Non poteva essere lo stesso piccolo mare accecante, chiassoso e triste del mio lontano esilio scolastico. Dopo l’ultimo cambio di Catanzaro, salimmo su un treno brutto, zeppo di gente sporca, malmessa, ingrugnita e a poco a poco ci addentrammo nel paese, così che il mare scomparve e cominciò a vedersi una campagna brulla e chiara spezzata qua e là da colline smozzicate e dure. Smettemmo di guardare dal finestrino. Ci aveva preso un’ansia, un tremore e non potevamo stare fermi. Cominciammo a prepararci, a ravviarci i capelli, a sistemare i bagagli in corridoio, ad abbottonare giacche e soprabiti, benché pareva che fuori dovesse fare un gran caldo. La mamma rimase seduta. Trasse dalla borsa specchietto e rossetto e si tinse le labbra. II 54 Avevo sempre pensato le stazioni come luoghi pieni di confusione, di rumore: fischi, sbattere di sportelli, treni in arrivo e in partenza, venditori di panini e di giornali, edicole, binari, facchini e poi tante porte con la scritta: sala d’aspetto di prima, di seconda, di terza classe con la gente annoiata, qualcuno che dormiva sulle panchine, i gabinetti per le signore e per gli uomini, i telefoni pubblici, la polizia… Qui il treno si arrestò di fronte a una costruzione bianca a due piani senza nemmeno scritto il nome del paese. Non scese nessuno e nessuno era ad aspettarci. Scaricate le valigie ci guardammo in giro perplessi e delusi. Finalmente uscì un ometto grigio sotto il berrettone rosso. – Ah, la famiglia del confinato, – disse senza alcuna inflessione. – Pensavo… – cominciò mia madre intimidita, ma l’uomo aveva già voltato le spalle ed era scomparso. Oltre la stazione s’inerpicava a perdita d’occhio una strada bianca. Mi allontanai dagli altri per guardare il paesaggio: era lo stesso notato dal treno dopo la sosta a Catanzaro, forse ancora più desolato, più aspro, ma il colore era quello e anche la forma delle colline. Affrettai il passo. Il sole era già alto e la salita dura. Non si vedeva un riparo, una casa, un albero. Solo qualche cespo stento, un’agave, un ficodindia carico di frutti viola lungo i bordi. L’aria era pallida e da un lato, in lontananza, pareva di indovinare una striscia luminosa. Forse il mare. Forse un miraggio. Avevo il fiatone. Mi sbottonai il soprabito, mi tolsi i capelli dalla fronte sudata. All’eccitazione del viaggio era subentrata una debolezza che mi stroncava le gambe. Alti sopra di me volteggiavano enormi uccelli neri che tutt’a un tratto precipitavano, come colpiti a morte e facevano paura. Mi volsi indietro, incerta se continuare. I miei fratelli seduti sulle valigie, attorno alla mamma, mi parvero lontanissimi, piccoli piccoli. Abbozzai un gesto col braccio ma non mi videro. Esitai. Poco oltre, la strada faceva una curva a gomito. Cosa avrei trovato là dietro? Mi guardai ancora alle spalle, poi decisi di riprendere il cammino. All’improvviso sentii il cuore spingere contro le costole e lo stomaco chiudersi a pugno. Nel profondo silenzio che mi circondava giunse alta e chiara la voce di mio padre insieme al trotto d’un cavallo e a un rotolìo di ruote. Poi, quasi subito, dalla svolta apparve un barroccio. Mi misi a correre, almeno credo che ci provai. Ma la salita era erta e le gambe mi tradirono. Non so quanto tempo impiegai a coprire quel minimo tratto di strada che mi separava da mio padre, dalla stretta delle sue braccia. – Sei sempre la stessa. La mia Mariò, – mi diceva accarezzandomi. – Su, su, bella di papà, non piangere, non piangere. 55 Il barroccio procedeva al passo carico di noi e dei bagagli verso il paese che distava ancora un paio di chilometri. Il sole ardeva alto e sulle nostre teste scuri e precisi o indistinti e lontani, volteggiavano i falchi. Stretti stretti, aggrappandoci ai bordi del carretto per non cadere, parlavamo tutti insieme. Papà s’era preso Nino sulle ginocchia ma lui non lo conosceva e si mise a strillare. Mia madre tratteneva l’emozione, ma ogni tanto fissava gli occhi su mio padre, preoccupata. – Diomio come sei pallido, magro, invecchiato. – Grazie alla villeggiatura e allo stomaco. Non mi dà tregua! Tu, invece… La lontananza ti ha fatto bene. Ma il rossetto perché te lo sei messo? Per farmi un dispetto, proprio oggi? Lo sai che non mi piace: ti fa sembrare una pocodibuono. – Ero tanto sbattuta. Sai, la notte in treno. Non volevo che mi trovassi sciupata. – Hm, vabbè, vabbè. – I mobili sono arrivati? Ma come! Li ho spediti da una settimana. E allora stanotte dove andiamo a dormire? 56 – Non preoccuparti. Ci penso io. Una soluzione si trova. – Papà, ma quando arriviamo? – Mamma, ho fame. – Papà, quant’è lontano il mare da qui? – Lo sai che l’abbiamo visto dal finestrino? Com’era bello! – Tu ci sei stato, papà? – Qualche volta ci andiamo? Io mi sono portato la bicicletta. – Eh, bravo, la bicicletta! Ci sono la bellezza di sedici chilometri. Sedici a andare sedici a venire, che fanno trentadue. Cosa credevi, che fosse qui alla svolta? – Be’, dalla cartina sembrava più vicino. – Insomma, tanto lontano non è. È come da Roma a Ostia. Comunque vedremo, se sarete buoni. Oh, eccoci arrivati! Vi presento la metropoli! Guardate, guardate che meraviglia! Rifatevi gli occhi! La metropoli! Due file di casupole si allineavano ai bordi della strada. Fuori stavano donne sedute al sole a spidocchiare un marmocchio accovacciato tra le gambe. Altre, sentendo arrivare il barroccio, venivano sull’uscio a guardare o a rovesciare bacili di acqua sporca. Ragazzini scuri e sbrindellati giocavano strillando come aquile. Un uomo col somaro carico di fascine tentennò la testa in segno di saluto. Figure vestite di nero, con in testa un panno spesso che dalla fronte scendeva a coprire metà della faccia ed era trattenuto con una mano sotto la bocca, avanzavano dondolando il passo con un barile in bilico sul capo o poggiato all’anca. – Papà, cosa portano quelle donne? – Acqua. – Acqua! Perché? – Perché in questo posto l’acqua in casa non esiste. Non esce dai rubinetti, come nel mondo civile. Di conseguenza, bisogna andarla a prendere alla fontana, quando va bene. Mettersi in fila, riempire i barili e incollarseli. A volte è a secco anche la fontana e allora sono guai. Belli miei, la vacanza è finita, ci sarà da sgobbare per tutti. Coraggio, tra poco si scende. 57 Il barroccio aveva imboccato un vicolo angusto, seminato di pozze scure dalle quali saliva un fetore nauseabondo. – Toilette all’aperto,– spiegò papà. Ci facevano festa mosche e monelli seminudi. Vedendoci ci si affollarono intorno. Gridavano e allungavano le mani per toccarci, poi scappavano ridendo. Le donne, i vecchi ci fissavano sospettosi dalle soglie, muti, senza fare un gesto. Entrammo in un cortile non molto grande, limitato da tre costruzioni a ferro di cavallo. La vista di un pozzo ci incuriosì. – Non è potabile, – disse papà, stroncando le nostre speranze. Delle teste si affacciarono da finestre e ballatoi e all’improvviso una voce squillante ci riscosse dallo stupore. – Che bello, professore! Arrivò la famiglia! Contento sarete finalmente! Mammà, mammà, uscite a vedere: arrivarono i bambini del professore. Sei ne sono, benedica. Sei. Ben arrivata signora. Venite, venite, date a me, non sono lavori per voi, questi. Seguitemi, vi mostro la casa... Tutti e sei figli a voi? La Madonna li protegga. Attenta al picciriddo, due scalini ‘mbalusi, difettosi ci sono… La ragazza, capelli neri e crespi che sfuggivano da un foulard a fiori, parlava senza riprendere fiato. Guardavo le sue gambe secche e nere come chiodi saltellare su per la scala con le nostre valigie. In cima, quando tutto fu scaricato, si presentò. – Con permesso, la vostra vicina sono, Agnese Scalia mi chiamo e vi do il benvenuto anche a nome della mia famiglia. Tutto quello che vi fa bisogno, dovete chiederlo senza complimenti. Il professore lo sa, eh professore? Ora non piangerete più. Che bella famiglia! Che bella sposa! Arrivò anche la mamma, grande il doppio di lei e rigida come un carabiniere. Aveva una corona di capelli bianchi, il volto arcigno e le spalle ossute avvolte in un pesante scialle. Notai l’ago appuntato sul petto e un ditale da sarta infilato al dito medio della mano destra. Alla sinistra spiccava un grosso anello d’oro. Con voce cavernosa rinnovò le offerte della figlia. Intanto papà aveva aperto la porta in cima alle scale e appena fu possibile sottrarci alla logorroica accoglienza 58 delle vicine entrammo col cuore in gola, come ogni volta che si penetra in un luogo nuovo e sconosciuto. Case di campagna ne avevamo già viste. Anche quella di Avezzano non era perfetta: gli scuri sconnessi sbattevano tutta la notte, la cucina era troppo piccola e nel bagno non c’era la vasca. Negli ultimi tempi, poi, senza mobili e senza luce elettrica… Ma non ero preparata a ciò che vidi. Non era una casa. Non poteva essere la nostra casa quello stanzone buio col pavimento di terra battuta e una specie di mangiatoia di pietra sul fondo, come una stalla. Mio padre richiuse l’uscio alle nostre spalle, fissando il battente con una sbarra di ferro. Sulla destra, oltre una tenda, si apriva un bugigattolo cieco con un giaciglio accostato al muro e di lì si andava in una camera abbastanza grande con una finestrella sul fondo che affacciava sul verde di un orto inselvatichito. L’unico particolare che mi parve bello. Tornata nell’ingresso, mi accorsi di una cosa che non avevo notato: un grande camino, così grande che nelle sere d’inverno ci si poteva stare seduti dentro. Mi consolò. Immaginai riunioni davanti alla fiamma scoppiettante a mangiare e a fabbricare storie. L’irruzione delle vicine interruppe le mie fantasticherie. In un paio d’ore, con grande imbarazzo di mia madre, ci procurarono qualche branda, delle sedie, delle coperte rattoppate, alcune pentole, un tavolino… Aggiunsero un po’ di ricotta per il picciriddo, due arance, un bicchierino d’olio, un pugno di zucchero, due fette di pane e soprattutto, ciò che contava di più, un’anfora d’acqua. – Al paese, – spiegò Agnese a mia madre, – c’è una ragazza, Caricedda, il professore la conosce, gli lavava la biancheria, basta darle qualcosa, un tanto a barile e all’acqua ci pensa lei. Mica potete andarci voi alla fontana, o la signorina. Se volete, la chiamo. – Grazie grazie. Non so come avremmo fatto senza di voi e come faremo a disobbligarci, – si schermiva mia madre umiliata ma arresa all’invadenza delle vicine. – Per fortuna si tratta di pochi giorni. I mobili arriveranno. Dovevano già essere qui da un pezzo. – Su, su, mangiate, mangiate e non ci pensate. Ora ce ne andiamo. 59 Vi lasciamo. Chissà quante parole ci avrete da dirvi! Ma se qualcosa vi serve, noi siamo di là. Voi bussate nel muro dello stanzino e noi arriviamo. Sapete, in questa cameretta ci stava il mio zito, prima che partisse a lavorare a Badolato. Quello è ancora il suo letto. Ora ce ne andiamo… Non vi disturbate… Rimasti soli sistemammo alla meglio la roba nelle stanze e finalmente se Dio vuole tirammo fuori dai bagagli qualcosa che mia madre, previdente, aveva pensato di portare e ci sedemmo a mangiare. Era la prima volta dopo tanto tempo che ci ritrovavamo uniti attorno a una tavola e sarebbe stato bello goderci un po’ di pace, ma la porta continuava a spalancarsi e – permesso permesso – entravano le due infaticabili protettrici con qualcosa nel grembiule. La mamma, sempre più umiliata, tentava di opporsi. – Non dovevate disturbarvi. Abbiamo già approfittato troppo… Noi abbassammo la testa sui panini con la mortadella o la frittata. Alle mele ci sentivamo stanchi e tristi senza sapere perché e nessuno aveva più voglia di parlare. Papà disse di preparargli il letto: dopo mangiato, spiegò, aveva bisogno di stendersi per aiutare la digestione. In realtà aveva lasciato quasi tutto nel piatto. A tavola lo avevo osservato a lungo: era molto cambiato, invecchiato, o forse solo dimagrito, ingiallito. Anche gli occhi avevano perso la loro chiarità grigioazzurra e avevano uno sguardo che non gli conoscevo, iroso, insofferente. Cambiava umore di continuo, stava a lungo in silenzio o si arrabbiava per nulla. Non pareva nemmeno felice che fossimo lì. III 60 Nella camera sull’orto dormivamo in sei: mamma e papà nel lettone con il piccolo in mezzo e Giorgio da piedi. Restava un lettuccio per me e Gioia, strette ma di nuovo insieme, come ai bei tempi. Miro e Livio, ben felici di stare soli, dividevano il giaciglio nel bugigattolo senza finestra. La mattina si svegliavano presto e cominciavano a saltare sulla branda che a volte, rovesciati i cavalletti, crollava con un fracasso infernale. – Ehi, voi due, canaglie! Cosa fate? – giungeva la voce di papà. – Alzatevi e mettetevi al lavoro! Andate in paese a prendere l’acqua, poltroni! Quando si svegliava aveva sempre la faccia cattiva, la voce aspra e dura. Era diventato nervoso. Irascibile. Cupo. Litigava continuamente con la mamma. La offendeva, la insultava, faceva discorsi strani, allusivi, senza curarsi della nostra presenza. Dopo quelle liti, per giorni interi mia madre aveva il muso lungo, gli occhi bassi e non parlava; si muoveva per la casa con un’aria umile e avvilita che stringeva il cuore. Lui stava quasi tutto il tempo buttato sul letto, con una coperta militare addosso, a chiedere, a lamentarsi. – Preparami il bicarbonato. Manda Miro in farmacia a comprare il carbone, che è quasi finito, non lo vedi? Se non ci penso io… Ahi, questi maledetti dolori! Ho freddo, ho freddo. La mamma correva col bicarbonato, un’altra coperta. Ma non c’era nulla che gli andasse bene. – Troppa acqua, troppa acqua. Ancora non hai imparato. Ah, che veleno. Quanto ce ne hai messo? Basta una punta di cucchiaino, te l’ho insegnato mille volte. Chissà dove hai la testa, tu! Del resto, ve ne fregate tutti. Aspettate solo la mia morte. Poi il dolore si placava e lui finiva per assopirsi. Allora bisognava parlare piano, camminare in punta di piedi e se Nino faceva i capricci, mamma me lo affidava. – Va’, va’, portalo un po’ giù, che se si sveglia tuo padre… Se si svegliava erano guai. Ormai vivevamo tranquilli solo quando dormiva, ma succedeva di rado. Perfino di notte si alzava e andava in cucina, riattizzava il fuoco nel camino e se ne stava seduto lì davanti con la testa fra le mani, oppure cominciava a camminare in su e in giù premendosi lo stomaco con quella smorfia amara sulla bocca, gli occhi incattiviti. A volte, dal nostro letto, Gioia ed io lo sentivamo borbottare e tremavamo per la paura che si mettesse a strillare con la mamma e ricominciassero a litigare. Certi giorni andavano avanti per ore, prima a bassa voce e noi, lì tremanti, col cuore che ci batteva forte forte e se a un tratto il tono si faceva alto e minaccioso, accorrevamo, – Mamma! Papà! – e scoppiavamo a piangere. 61 Un giorno mio padre si infilò a letto e cominciò a tremare come una foglia. Mamma gli mise addosso coperte, cappotti, noi gli preparammo la borsa dell’acqua calda, ma lui continuava a battere i denti. – Corri, va’ a chiamare il dottore, – si agitò la mamma. – Digli che è urgente. Prendi la bicicletta, vola. Miro tornò dopo un’ora col dottore, un vecchietto intabarrato in una mantella nera, un cappellaccio nero in testa, il vestito nero di panno che sembrava un corvo. Invece era simpatico: ci sorrise, fece il ganascino al piccolo, prima di entrare in camera da letto, di dove uscì dopo pochissimo. – Malaria, – disse. – Malaria? Cos’è? – Corri, corri Miro. Va’ in farmacia a spedire la ricetta. E Miro riprendeva la bicicletta, le mani rosse di geloni strette al manubrio gelido, gli occhi bruciati dal vento. C’era sempre vento in quel paese. Un vento secco di tramontana che non cessava mai, sibilava sferzandoci le orecchie, sbatteva le imposte, s’insinuava nelle fessure 62 della casa, fischiava sotto gli infissi, spazzava le strade, frustava gli arbusti, faceva gemere i fogliami nel vecchio orto, rendeva il paesaggio anche più deserto e spettrale. Le donne camminavano rasente i muri bassi delle case, la faccia seminascosta nella coperta scura che portavano a mo’ di scialle, tenendola stretta sulla bocca. Lo sguardo obliquo, sospettoso, si infilavano nei vicoli, dritte, nere, sgonnellando nelle ampie vesti alla caviglia, l’incedere ondulato che gli veniva dall’abitudine di portare pesi sulla testa e sull’anca: il barile, un moccioso, la fascina, sparivano inghiottite dal buio. Dall’attacco di malaria mio padre si alzò scheletrito, con gli occhi e la pelle ancora più gialli, debole da non stare in piedi per le febbri e la gran quantità di chinino che aveva ingurgitato. Passò l’inverno col cappotto addosso, accanto al fuoco, in un angolo del camino, da dove osservava tutto quello che accadeva brontolando, disapprovando con un gesto del capo. Oppure stava chino sulle carte a fare il solitario di Napoleone e se la mamma per caso si assentava, subito la chiamava. – Che stai facendo? Perché te ne vai sempre? Non mi sopporti, vero? Lo vedi che non ho forze, che non ce la faccio nemmeno a fiatare. Se ho bisogno di un bicchiere d’acqua, posso anche crepare, qui da solo. Sempre a pulire, pulire, lustrare… A che serve? Aspetti visite? Poi, se la mamma trascurava le pulizie per stargli accanto, e magari per farlo contento si metteva a giocare a carte con lui, benché le odiasse, cominciava a guardarsi attorno. – Una stalla sembra questa casa! Non capisco, siete tre donne e si deve vivere in questo disordine, in questo porcile! Non vedo l’ora di stare meglio, così esco, me ne vado. La mamma ormai non ci faceva più caso. Inghiottiva, rassegnata. – È nervoso, non sta bene, poverino, – lo giustificava. – Speriamo che si rimetta presto, – aggiungeva sospirando. Appena usciva una spera di sole, spalancava le finestre. – C’è il sole, – gli diceva. – Va’, va’ a fare due passi, ti farà bene. Stai sempre al chiuso. Non prendi mai una boccata d’aria. – Lo so, lo so che non mi vuoi tra i piedi, che ti peso, che vorresti liberarti di me. Era più divertente lassù quando stavi sola, vero? – Che vorresti dire? – Lascia stare. Tu mi capisci… Attenta a te. Ma poi finiva col darle retta: usciva sul pianerottolo, si sedeva sul primo gradino, al sole, e apriva il giornale. 63 Fu un inverno lunghissimo. La malaria attaccò anche Miro. Così le compere ora toccavano a me, qualche volta anche a Livio. Andare in paese era un’avventura. Salivo in bicicletta e la gente si voltava a guardarmi, i ragazzini mi inseguivano, si attaccavano alla ruota posteriore: – Ebbìde ebbìde, – gridavano, – una himmena sulla bricichetta! – e ridevano sfrontati. Io acceleravo, tenendo con una mano il manubrio e con l’altra la veste gonfia di vento. Arrivavo in piazza tutta rossa e sfiatata. Nei negozi erano gentili, mi accoglievano col sorriso, ma io mi impappinavo, un po’ perché stentavo a capirli e un po’ perché non mi raccapezzavo con quella faccenda delle tessere e dei bollini. – Spiacente, signorina, le fettine ci sono solo il sabato la domenica e il lunedì. Oggi frattaglie e coniglio. Lo zucchero no, quest’altra settimana. Ma dovete prenotarvi in tempo e venire molto presto la mattina. Anche per la pasta e il burro e tante altre cose come il sapone bisognava prenotarsi e fare la fila. Ce n’era voluto per abituarsi! Per fortuna farina e olio si trovavano dai contadini, di contrabbando, e questo ci permetteva di fare la pasta in casa e qualche volta anche il pane. L’olio locale era denso e verde e la mamma diceva che quando partivamo bisognava portarne via qualche lattina, perché quello di Roma non era così buono. Per un anno mangiammo olive nere infornate e spruzzate col limone, fichi secchi e zuppa di fave. La sera andavo a prendere il latte dai pastori, lontano dal paese. Nell’oscurità della stalla, indovinavo delle presenze vive: forse un asino, un maiale, forse dei bambini che mi spiavano con gli occhi spalancati… Gli attrezzi da lavoro proiettavano ombre grandi e minacciose sui muri. L’uomo accendeva il lumino a olio o la candela, si rimboccava le maniche e attaccava a spremere le mammelle turgide della capra. Non riuscivo a 64 distogliere gli occhi da quelle mani e mi chiedevo se la poverina soffrisse. Il latte colava in un secchio, spumoso e caldo e ne pregustavo il buon sapore amaro. Pagato il pastore, me ne andavo in fretta. La strada era lunga. La notte inghiottiva la campagna. Il buio e la solitudine mi facevano paura. Alfine giunse la primavera. All’improvviso, da un giorno all’altro tutto divenne verde e colorato. Gli ulivi non avevano più l’aria contorta e intirizzita, il cielo era pulito, la brezza era dolce e portava profumi dal mare. La gente uscì dalle case, il passo più lento, lo sguardo più lontano. Mio padre riprese le sue passeggiate. Stava un po’ meglio, era attivo e sollevato, sorrideva e faceva progetti. – Se domani è bello, – disse una sera rientrando, – si prende la bicicletta e via, si va a Crotone! – Evviva, papà. Posso venire anch’io? – Calma, calma. Cos’è questa gazzarra? Lo dico io chi ci viene. Avanti. Domani Gioia e Maria. Poi toccherà a Miro e Livio. – E io? Ti sei scordato di me, – protestò Giorgio battendo i piedi. Scoppiammo tutti a ridere. – Buoni, buoni. Papà vi ci porta tutti, a due a due. Anzi, sapete cosa vi dico? la prossima volta ci andiamo tutti insieme con il treno. Va bene? Intervenne la mamma: – Non sarà troppo pesante per te con Maria sulla canna? – Vuoi che non ce la faccia? Tranquilla. Mi sento pieno di forze e ho voglia di muovermi. Sono stufo di fare la talpa. Il letargo è finito. Piuttosto, auguriamoci che sia una bella giornata. Gioia era subito scappata fuori in cortile a controllare la bicicletta, che non mancasse nulla e tutto fosse in ordine: le gomme ben gonfie, la pompa al posto, la catena oliata e nella borsetta tutto l’occorrente per una eventuale foratura: carta vetrata, caucciù, mastice e chiave inglese. – Io sono a posto, papà, – disse rientrando. La sera si fece tardi per accordarci sulle spese da fare a Crotone. Del cretonne a fiori per ricoprire i letti, le scarpe per Gioia e per Nino, due 65 o tre pentole di varia grandezza e un paio di calze di seta color carne. La mamma desiderava anche una scatola di cipria Petalia e un rossetto per le labbra rosé ciclamino, ma questo lo disse in segreto a Gioia, che ci pensasse lei, se no quel brontolone… Papà segnava ogni cosa, calcolava, tentennava il capo. – Tutta questa stoffa, non se ne può fare a meno? Come la portiamo? Mica andiamo col pullman, – obiettò, ma la mamma non cedette di un centimetro. – E le scarpe per Gioia sono proprio indispensabili? – tentò ancora. – La poverina è praticamente scalza. Quelle dell’anno scorso non le vanno più. Non vedi com’è cresciuta! – E va bene, va bene, ho capito. Dopo innumerevoli aggiunte e sottrazioni, finalmente i conti quadrarono, le discussioni ebbero termine e la lista fu copiata in bella. Non restava che l’eccitazione dell’attesa, come alla vigilia di una festa. A mezzanotte passata da un pezzo, mio padre caricò la sveglia, fece un’ultima ispezione, scoprì una macchia sulla giacca e mamma dovette levarsi dal letto in sottoveste. In cucina intinse un batuffolo d’ovatta nel flacone della benzina, lo strofinò due, tre volte sulla parte e tornò a coricarsi. Papà si tolse i pantaloni, li ripiegò con cura sulla spalliera della sedia, e la raggiunse. Gioia ed io tardammo a prendere sonno. Dal letto grande non giungeva il solito parlottio petulante o astioso, ma un fruscio di coperte, un brusio affannato, una specie di gemito accompagnato dallo scricchiolio della rete. Alla fine tutto si spense in un lungo sospiro e la casa piombò nel silenzio vivo della notte. IV 66 Mio padre uscì sul ballatoio, scrutò il cielo, si insalivò un dito e lo espose all’aria. Rientrò, si mise un giornale sul petto, tra canottiera e camicia. – Ci berremo un sacco di vento su quella strada, – disse. – Questo vale più di dieci maglie. La strada dal paese a Crotone era liscia, asfaltata e tutta in discesa. A tratti diventava così ripida che bisognava andare coi freni quasi bloccati, col rischio di rompersi il collo. A un certo punto, ci si presentò una terribile curva a ferro di cavallo e papà disse che era meglio scendere e fare qualche metro a piedi. Gioia non ne volle sapere e la vedemmo sfrecciare via, rossa, con la gonna svolazzante e le gambe scoperte. Quando le fummo di nuovo a fianco, papà le gridò: – Forza bella, il più è passato. Siamo a Isola. Dopo poco, infatti, imboccammo un grande viale fiancheggiato da oleandri rosa. Mi ricordarono acutamente i giardinetti sotto casa dove da piccoli ci attardavamo a giocare a nascondino dietro le siepi. Venivano i maschi ad acquattarsi con noi e poi dicevano che eravamo fidanzati. A me capitava sempre il figlio del premiato vapoforno, un ragazzino obeso coi calzoni tirati sul sedere che quando si abbassava sembravano sul punto di scoppiare. Il viale degli oleandri attraversava la città e portava dritto al mare. Già da quel punto, la strada era ancora in discesa, lo si poteva vedere: una striscia luminosa che abbacinava. Gioia e io guardavamo incantate e morivamo dalla voglia di correre laggiù. – Oh, ora sì che si ragiona! – esclamò papà. – In quella landa di cafoni m’ero dimenticato che faccia ha la gente civile. Per prima cosa, – aggiunse soffiandomi sul collo, – lasciamo le biciclette in un posto sicuro, poi andiamo a fare una ricca colazione. Ho un certo languorino allo stomaco. – Davvero, papà? 67 – Ma sì. Crepi l’avarizia: semel in anno licet insanire. Sistemate le biciclette, lo seguimmo trepidanti, tenendoci per mano. Il bar tutto lucido di specchi era pieno di giovanotti indolenti appoggiati al banco che si misero a sbirciare Gioia. Lei faceva finta di niente e si ravviava i lunghi capelli biondi. Ci sedemmo in un angolo e papà ordinò cioccolata con panna per tre. Io mangiai lentamente la panna poi bevvi d’un fiato la bevanda densa e calda. Papà mise in bocca un pasticcino con una smorfia. – Robaccia autarchica, – disse. – Ringraziate Iddio. Oggi non sarebbe nemmeno giorno di dolci. Rischio anche una multa, – fece la cassiera, una ragazza bruna con due file di denti aggressivi. – Che gente! Ma da dove vengono? – aggiunse, cercando la complicità dei giovani fannulloni. – Come se non lo sapessero che siamo in guerra. – Andiamo, signorina, non è il caso di arrabbiarsi. Era solo un modo di dire, – intervenne subito papà. – Anzi, devo complimentarmi: la cioccolata è ottima. La ragazza gli sorrise ammansita e lui ricambiò, felice. La cioccolata gli parve squisita e i pasticcini di fecola deliziosi. Sperammo che, nell’entusiasmo, ordinasse qualche altra cosa, ma restammo deluse. – E adesso, figliole, al mare! Via, filare! Fuori il sole ci abbagliò. Al mare ci arrivammo col cuore in gola più per l’emozione che per la corsa. Stava infinito e luccicante davanti a noi. Papà sembrava aver dimenticato le raccomandazioni della mamma, la lista delle spese, i conti della sera prima, la lunga invernata. Era quasi tornato quello di Roma, di quando la vita era piena di sogni. Si avvicinò un ometto. – La facciamo una foto con queste belle signorine? Papà disse subito di sì e ci mettemmo in posa tutti e tre, con le spalle al mare e il sole negli occhi. Dopo il primo scatto ne seguì un altro, e poi un altro. L’ometto non la finiva più. – Venite, venite. Una vicino alla barca. Ecco, così, stringetevi. No, la signorina è meglio qui. Brava. Non vi muovete. Un bel sorriso. Via! 68 – Favorite i documenti, – disse uno in divisa, che non avevamo visto arrivare. – Documenti? Come? Perché? Stiamo solo facendo una foto ricordo, – disse mio padre impallidito. – Non li sapete leggere i cartelli? È un po’ che vi osservo: state fotografando una zona proibita, il porto. – Proibita? Il porto? Ma no, scusate, c’è un equivoco. Questo signore, gentilmente… – Poche chiacchiere. Favorite i documenti. Da dove venite, dalla luna? Non lo sapete che siamo in guerra? Ancora quella frase minacciosa. Questa volta mi colpì più brutalmente, guastando di colpo la mia felicità. La guerra, sicuro, l’avevamo dimenticata per un momento. Sembrava così astratta e lontana. – Ma noi veramente. Credetemi. Dovete darmi atto della mia buona fede. Ho portato le mie figliole in gita. Volevamo solo scattare qualche foto ricordo, del tutto innocente, ve l’assicuro. Sapete, da tanto tempo non venivano in città. Noi stiamo a Cutro, conoscete Cutro? Be’, non si può dire che sia una metropoli e lì si vive un po’ all’oscuro di tutto… L’uomo in camicia nera sembrava più infastidito che arrabbiato. Con un gesto di insofferenza si allontanò per parlare col fotografo. Lo vedemmo discutere, gesticolare. Alla fine si fece consegnare il rullino e lo intascò. Poi tornò da papà che si era acceso una sigaretta e tirava boccate una dietro l’altra, pallido come un cencio. – Mi dispiace guastarvi la gita, ma dovete seguirmi al Fascio. Le leggi sono leggi. La guerra è guerra, e la vostra diciamo così disattenzione potrebbe essere di grande aiuto al nemico. Ora mio padre era veramente preoccupato. Traccheggiò, balbettava, cercando di convincere il guardiano della legge, che sembrava sempre più irritato. A quel punto si mise di mezzo Gioia e tra moine e sorrisi, spiegò che la colpa era tutta sua che aveva insistito tanto, e di quell’uomo che continuava a dire: facciamone un’altra, un’altra… e che era la prima volta che ci trovavamo lì e non ci avevamo nemmeno fatto caso che quello era il porto e, anzi, papà ci metteva fretta perché dovevamo andare a fare delle spese per la mamma che ci aspettava con ansia e… La guardavo sbalordita e ammirata, ma quando il milite ci lasciò andare, dopo aver accettato l’offerta di mio padre di una cioccolata calda dalla ragazza bruna, finalmente persuaso che non eravamo spie pericolose, tutta la nostra euforia era svanita. Senza più voglia di parlare e di perdere tempo ci incamminammo verso il centro della città. S’era fatto buio e la strada del ritorno fu taciturna e faticosa. Gioia aveva paura dei falchi che ci volteggiavano sulla testa. Diceva che la notte li avrebbe sognati, quegli uccellacci. Il peso dei pacchi rendeva più ardua la salita. Alla curva di Isola scendemmo per farla a piedi. – Quell’animale! – disse papà. – Mettersi a scattare fotografie nella zona proibita! Fortuna che abbiamo trovato una persona ragionevole. Ma fa che ti capitava un tipo zelante, tutto d’un pezzo. Poteva finire male, molto male. Quel milite, però, che brav’uomo. Non doveva essere di queste parti. Aveva un accento… – Però Gioia è stata brava a recitare la parte, eh papà? Meglio di Alida Valli! – Altro che! È stata fantastica! Se non c’era lei, a quest’ora… 69 La mamma ci corse incontro ansiosa e felice come se tornassimo dal giro del mondo. Ci tolse i pacchi dalle mani e ci fece sedere a tavola. Era riuscita non so come a mettere insieme una buona cenetta e a quel calore la lingua ci si sciolse. L’episodio del milite l’allarmò molto, ma poi tutto passò perché papà aveva fatto le spese proprio per bene e le aveva perfino portato in regalo una boccetta di profumo marca Borsari di Parma, quello con le violette. Vennero le vicine e siccome la serata era fresca, accendemmo il braciere. Seduti attorno alla pedana, la mamma con in braccio il piccolo addormentato, cominciammo a chiacchierare, cantare, e la vecchia, che raccontava bene, narrò la storia favolosa di uno zar d’America ricoperto di brillanti che sposava la figlia di un cacciatore. La stanchezza, le fantasie della vicina, il puzzo della carbonella facevano ciondolare la testa. Papà disse che era ora, e andammo a letto. V 70 Mio padre aveva ricominciato a uscire tutti i giorni e la sera tornava allegro. Lo stomaco era molto migliorato e anche dai postumi della malaria si era completamente rimesso. In paese aveva fatto molte nuove conoscenze: il farmacista, l’avvocato, il proprietario di una fabbrica di liquirizia con due figli maschi un po’ zucconi, che qualche ripetizione non gli avrebbe fatto male, – Eh, che ne dite professore? – A disposizione, don Turi. Mandatemeli a casa quando volete. Papà fece mettere un tappeto sul tavolo di cucina, rafforzò le gambe delle sedie che zoppicavano e ogni giorno, alle tre e mezzo, li aspettava. Pasqualino e Carmine erano due bietoloni grandi e grossi e buffi: ridevano sempre e non capivano nulla. Dopo qualche tempo si aggiunsero Peppinedda, la figlia del fornaio Palma, e altri due o tre ragazzini. Papà li faceva sedere tutti attorno al tavolo e passeggiando su e giù con una mano dietro la schiena e nell’altra un libro all’altezza del viso, declamava regole di grammatica, capitoli di storia, pagine scelte e se uno non stava attento gli batteva la costola del libro sulla testa, scuotendo il capo. – Animalia et universa pecora! – esclamava. Ho sempre ignorato il significato di quel latinismo, che non sono sicura di ricordare esattamente. Quei pomeriggi ci restituivano la normalità, col ricordo della scuola e della vita di Roma. Anche la mamma ne era contenta. Oltretutto, gli allievi venivano a mani piene: un pacco di pasta, un cartoccio di farina, un cesto di castagne, un fiasco d’olio: tutta grazia di Dio, meglio dei soldi che non valevano più nulla. La sera, seduti fuori, sul ballatoio, a lume spento, aspettavamo il sonno chiacchierando, e, gira gira, si parlava sempre del ritorno a Roma e della guerra che non finiva mai. Avevano pronosticato che sarebbe 71 durata qualche mese, che i nostri soldati avrebbero festeggiato il Natale a Parigi o a Londra. Invece, più di un anno era già passato e di vittoria non si parlava più. Ogni giorno arrivavano notizie di bombardamenti. Era di giugno, il cielo era bianco e pulito, le notti chiare e stellate, un tempo ideale per le incursioni aeree. Cominciarono in Altitalia: a Genova, Torino, Milano, poi fu la volta di Foggia e di Napoli. Cinque ore d’inferno, riportavano i giornali. Le fortezze volanti si erano abbassate in picchiata sulle strade in pieno giorno mitragliando donne e bambini. Centinaia di morti sotto le macerie. Leggevamo di città in fiamme, di centri abitati rasi al suolo dal barbaro nemico. La paura ci faceva trasalire a ogni rumore insolito, a ogni tuono nel cielo. Un giorno o l’altro, per via del porto, si diceva, sarebbero venuti anche a Crotone. A poco a poco l’idea del pericolo, della morte, si fece strada nella coscienza. La gente era incupita e neanche le barzellette sul regime aveva più voglia di raccontare. Noi ragazzini cominciammo a renderci conto di vivere in un tempo speciale, in cui non solo i soldati al fronte, ma anche le persone nelle case potevano morire da un giorno all’altro, da un momento all’altro. Quell’autunno le autorità locali, pur continuando a ostentare patriottico ottimismo, ordinarono che si rispettassero il coprifuoco e l’oscuramento. Il bar tabacchi sulla piazza incollò la carta azzurra alle vetrine e la sera, appena fatto buio, chiudeva i battenti. Dopo una certa ora era obbligatorio stare in casa con le porte e le finestre sprangate, attenti che non filtrasse un filo di luce. Perfino in quell’angolo sperduto di mondo, dimenticato da Dio, dove l’energia elettrica era quasi inesistente e nelle case si accendevano i lumini a olio o le candele giusto il tempo di mangiare e andare a letto, si videro in giro degli uomini con una fascia al braccio che bussavano agli usci e alle imposte gridando – Luce! Luce! – Mio padre rideva e si metteva a canticchiare: – Un-pa-pà Un-pa-pà. Ma c’era un’altra novità. Il paese pullulava di militari in transito. Sostavano accampati in qualche modo, pochi giorni, una settimana al massimo, poi ripartivano per imbarcarsi a Napoli o a Bari e ne arri- 72 vavano altri. A volte, all’imbrunire, giungevano dalla piazza i loro canti un po’ sgangherati e un po’ tristi. A distanza, o da dietro le persiane, i paesani li guardavano, seduti attorno alla fontana, passarsi il fiasco con un’espressione così sperduta e solitaria che anche il loro chiasso faceva male all’anima. Prima c’erano stati i bersaglieri col fez rosso e il fiocco blu sulla spalla, come quello di nonno Giovanni, poi arrivarono le camicie nere. Ne conoscemmo una, un napoletano pieno di vita e di cuore. Veniva ogni sera e col suo piglio scanzonato e scettico, di sotto la giubba, come un prestigiatore, tirava fuori una fetta di lardo, un pugno di caffè vero, un pacco di pasta. – Signo’, signo’, – faceva vicino a mia madre, – v’aggio portato la pasta che s’appiccia. Mettete l’acqua al fuoco, facite ampresso. – Lentamente sfilava uno spaghetto dal pacco e lo accostava alla fiamma. – Guardate, signo’, ccà facimmo Piedigrotta… Quando arrivava era sempre festa. Ma una sera, dopo la consueta spaghettata, disse a mio padre che aveva fatto domanda per andare volontario in Russia. Mio padre trasalì. – Ma dimmi un po’, ti dà di volta il cervello? Ti puzza la pelle? – sbraitò. – Professo’, io ccà non ci tengo niente che fare. Non tengo avvenire. Se mi va bene, mi faccio una posizione, aiuto la famiglia. – Bravo! E tu per farti l’avvenire, la posizione, per aiutare la famiglia vai a farti ammazzare! Un bel ragionamento! A te il cervello te l’ha mangiato il gatto, te lo dico io. Ma, come, con quello che sta succedendo! In Russia c’è l’iradiddio. Sarà la catastrofe, la loro tomba. Ma se perfino un genio come Napoleone ci ha rimesso le penne! E lui, questo buffone, questo pagliaccio, questo pazzo criminale… – Professo’, professo’, statevi accorto. Vuje parlate troppo forte. Jammo, non è come dite voi. E poi, io non mi metto paura… Non gridate accussì, calmatevi, professo’. – Ricordati queste parole, amico mio: siamo alla fine. Le stanno prendendo su tutti i fronti, guarda in Africa, in Grecia… E la Russia sarà il colpo di grazia. Saranno cancellati dalla faccia della terra. – Che dite, professo’! Quelli, i tedeschi sono imbattibili. – Non farti illusioni. Tu sei un bravo figlio, ma sei ingenuo. Si capisce, sei cresciuto sotto la loro propaganda, nutrito a bugie. Ragiona con la tua testa. Non farti fregare, non partire. Sono finiti. Purtroppo ci andranno di mezzo ancora tanti figli di mamma come te. Dammi retta, ragazzo, non lo fare, non andare in quell’inferno. Non andare in Russia, ripensaci. Ripensaci. Il ragazzo scuoteva il capo, rideva. – Non vi prendete collera, professo’. Io tengo la pellaccia dura, non mi frega nessuno. Io vado e torno vincitore. – Dammi retta. È questione di mesi, di giorni forse. È finita, ti dico. Questi buffoni pagheranno, te lo assicuro. Il popolo è stanco, non ne può più di fame, sofferenze, di figli che non tornano, di bombe, e presenterà il conto, e loro pagheranno, fino all’ultimo centesimo. L’Italia diventerà un Paese libero… – Professo’, alluccate chiano pe’ carità, ccà i muri tengono recchie. Statevi accorto con chi parlate. Se non c’ero io qui, ma qualcun altro… Era diventato improvvisamente serio. Mise una mano sulla spalla di mio padre e continuò: – Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Nella vostra posizione? Vi risbattono in galera e stavolta si perdono pure la chiave. Mannaggia a vuje! So’ cose ‘e pazze. Signo’, signo’, dicitencello di starsi accorto. Papà non disse più nulla. Si chiuse in un silenzio amareggiato. Le sue parole non servirono. La domanda fu accolta e il nostro giovane amico partì. Quando venne a salutarci aveva le lacrime agli occhi. Ci abbracciò e ci lasciò per ricordo un bastardaccio mezzo orbo che gli stava sempre alle calcagna. Lo chiamammo col suo nome: Donato. 73 Mio padre non diede ascolto alle raccomandazioni di Donato. Non si stava accorto, parlava con i militari di passaggio, con gli amici notabili, coi bottegai e coi fascisti. La nostra casa era un viavai, veniva perfi- 74 no il figlio del podestà. Mia madre sospettava che fosse un informatore della polizia e stava sulle spine, cercava di metterlo in guardia, di frenare i suoi entusiasmi. Ma era tutto inutile. Un giorno fu convocato dal maresciallo dei carabinieri. – Cosa ci vengono a fare tutte quelle persone, quei giovanotti, a casa vostra? Non lo sapete che a un confinato è tassativamente proibito ricevere visite? L’avete scambiato per la villeggiatura, il confino? E se faccio rapporto alla polizia politica, lo sapete a che cosa andate incontro? Non vi è bastato? Con tutti quei figli… Statevi attento, professore. Non dovrei essere io a dirvelo, ma in paese c’è gente che vi vuole male e può rovinarvi. Ci vuole poco di questi tempi. Siamo in guerra, non ve lo scordate: il nemico ci ascolta. Io vi ho avvertito. Mettete la testa a posto. Tentennava il capo, conteso tra il dovere e l’imbarazzo. Accidenti. Non aveva visto su tutti i muri i manifesti che invitavano al silenzio, e le scritte nei locali pubblici: al caffè, dal barbiere, dal macellaio, in farmacia, con le parole d’ordine che vietavano di parlare di politica e di alta strategia? Che si era messo in testa, benedetto incosciente, di mettere nei pasticci anche lui? Un padre di famiglia che aveva avuto il torto di essere stato troppo indulgente, finora… Mio padre replicò candidamente. Dopotutto, che male c’era se un amico veniva a trascorrere qualche ora da noi, a giocare a carte, a scacchi, o a bere un bicchiere di vino? Cosa c’entravano la politica e l’alta strategia? – Allora, professore, non volete proprio capirla con le buone. Ve lo ripeto per l’ultima volta, per il vostro bene e quello della vostra famiglia, dei vostri sei figli: state attento. Basta con le riunioni. Basta andare a Crotone. Non dovete allontanarvi dal paese per nessuna ragione al mondo. Finora ho chiuso un occhio, ho lasciato correre, ma da adesso, fine di tutto. Intesi? Non costringetemi a prendere provvedimenti. Uomo avvisato… Niente visite, niente riunioni, niente gite in città, al mare. Del resto, dopo la prima volta, a Crotone non c’eravamo più stati. L’inverno scorreva lento. Interminabile. Non accadeva mai nulla. Gioia riceveva let- 75 tere da Avezzano che leggeva di nascosto. I segreti ci allontanavano. Avrei voluto anch’io un segreto tutto per me. I miei sogni viaggiavano paralleli ai suoi, senza incontrarsi. I tre anni che ci separavano scavavano ogni giorno un abisso più profondo, segnando un distacco irreparabile. Nelle lunghe serate al buio, senza poter leggere, covavo la mia solitudine come una malattia. La vita, mi dicevo, non poteva essere tutta lì, in quelle stanze lontane dai rumori del mondo. Respirare. Sognare. Andare via. Fuggire… Crotone diventò un miraggio, un pensiero insinuante come un’ansia, una smania da soffocare, tenere segreta. Sognavo di tornarci. Sognavo fughe, avventure, inseguimenti… Una mattina di primavera uscii di nascosto, presi la bicicletta di Gioia, attraversai il paese e col cuore in gola imboccai la strada del mare. Ecco, c’ero, stavo andando. Pedalavo e il cuore mi batteva forte. Volevo vedere fin dove sarei arrivata. La strada mi risucchiava, scendeva scendeva e senza accorgermi di quanto mi fossi allontanata, all’improvviso fui in vista di quella paurosa curva a gomito dove papà e io eravamo scesi mentre Gioia sfrecciava bellissima nel vento. Ricordai le parole di mio padre: Forza, bella. Il più è fatto. Siamo a Isola. La tentazione fu irresistibile. Arrivare a Crotone ormai sembrava uno scherzo. La strada davanti a me era deserta, il sole ancora non troppo alto. Cominciavo ad avvertire la presenza, l’eccitazione del mare. Quando mi ritrovai sul viale degli oleandri, quasi non credevo ai miei occhi. Mi sentivo leggera, senza peso. La bicicletta avanzava da sola. Dunque era così facile! Tutti quei giorni e quelle notti a sognare… Il mare era laggiù, scintillava come uno specchio pulito e c’era tanta gente per le strade: ragazze chiare, i capelli biondi sciolti sulle spalle con una banda sugli occhi, come li portava Gioia, le braccia scoperte, le gambe nude sotto gonne cortissime, arrampicate su buffe scarpe alte e tutte d’un pezzo, mai viste prima. Avanzai quasi a passo d’uomo, per vedere tutto, riempirmi gli occhi. Riconobbi il posto delle fotografie che s’era prese l’uomo con la camicia nera. Chissà com’erano riuscite! Io venivo sempre male, con gli occhi chiusi che pareva piangessi. Riconobbi il bar della ragazza stizzita che aveva redarguito 76 mio padre ricordandogli che c’era la guerra. Sembrava che quel giorno si affannassero tutti a ricordarglielo. La guerra. Era passato quasi un anno e c’era ancora, c’era sempre. Laguè-rra. Laguè-rra. Laguè-rra, cantavano ora i pedali con più lena. Il caldo cominciava a farsi sentire. Mi venne il fiatone. E la fame. Ripensai alla cioccolata calda e dolce e alla smorfia di mio padre. Robaccia autarchica. Lo stomaco gorgogliò. Cercai di ricordare il sapore della panna di prima, di quando ero piccola e la domenica si usciva e papà ci offriva il maritozzo e io lambivo lentamente il ripieno con la punta della lingua fino ad arrivare alla mollica soffice. Pensai alle paste cremose che mi offriva nonno Giovanni quando andavo a trovarlo nella sua bottega. Mi portava al bar e mi lasciava scegliere quella che preferivo, tenendomi issata con le sue mani forti davanti al banco troppo alto. – Non dirlo alla nonna, – diceva sorridendo dentro la barba morbida. – Mi raccomando, – aggiungeva nel salutarmi facendomi scivolare in tasca una monetina da quattro soldi come pegno del nostro segreto. Deglutii saliva amara. Il sole era alto in mezzo al cielo, scottava. Deve essere molto tardi, pensai. È tempo di tornare. A casa mi staranno cercando, si chiederanno dove sia finita. O più semplicemente non si erano accorti della mia assenza. Non si accorgevano mai di me. Non si vede e non si sente. Ti dimentichi che c’è, diceva mia madre con inconsapevole crudeltà. Mi avvicinai a un signore per chiedergli l’ora. – Dieci minuti a… La risposta fu coperta dall’urlo delle sirene. L’uomo si allontanò in fretta lasciandomi sbigottita, un piede a terra l’altro sul pedale. Le sirene ululavano, le persone attorno a me correvano in ogni direzione, si urtavano, cadevano, si rialzavano, imprecavano, si chiamavano l’un l’altra. Il bar abbassò le saracinesche con gran fracasso. Ero come paralizzata. Qualcuno mi spintonò. – Scappa! Riparati! Arrivano! Finalmente mi mossi, pigiai sui pedali e infilai il viale degli oleandri. Corri. Corri, mi dicevo. Il rombo era sordo, occupava tutta l’aria, sem- 77 pre più forte, più vicino. Arrancavo, spingevo e mi sembrava di essere ferma, che il viale non finisse mai, che non sarei mai arrivata, come nei sogni, quando qualcuno ti insegue e tu vuoi fuggire, devi fuggire, e invece non ti muovi, resti lì… Diomio Diomio ora cosa faccio? Cosa racconto alla mamma? Non riuscivo a connettere i pensieri, a trovare una scusa da raccontare. I pedali erano di piombo. La strada mi stava sempre davanti, infinita. Scoppiai a piangere. Piangevo e spingevo, spingevo su per la salita e sudavo, mentre un lungo brivido mi gelava la schiena. Alle spalle c’era un frastuono spaventoso di voci, di boati. Mi rintronavano le orecchie, il cuore mi batteva forte. Mi sembrava di avere la febbre. Quando arrivai a casa, ce l’avevo veramente. Un febbrone da cavallo e tanti dolori di pancia. Mi misi a letto e dopo qualche giorno mi spuntarono dei grossi foruncoli in tutto il corpo. La mamma disse che era stato lo spavento a guastarmi il sangue. – Così impari, – aggiunse. Se non fossi stata male me l’avrebbe data lei la gita al mare, brutta stupida! VI 78 Col caldo arrivarono le mosche, in fitti nugoli neri, le avevi sempre addosso, tenaci. Non si riusciva a mandarle via in nessun modo. Attaccammo la carta moschicida alla lampada in mezzo alla cucina, a picco sul tavolo, e la sera la toglievamo completamente nera. Seduti fuori non si resisteva: le nemiche, attratte dalle stalle vicine, non concedevano tregua. Il puzzo, il caldo africano, la penuria d’acqua facevano il resto. Ricordavo la casa di Roma, raccolta nella penombra. Le raccomandazioni della mamma: Non aprite le finestre, non lasciate in giro piatti sporchi, torsoli di frutta, marmellata… In quel buio fresco si dimenticava la calura della città arsa sotto il cielo immobile. La sera, quando si spalancavano le finestre, il ponentino fugava l’odore dell’insetticida e portava sentore di mare, di giardini, di giochi all’aperto. In terrazza, mamma apparecchiava e papà metteva la carta azzurra attorno alla lampada per tenere lontane le zanzare. Lungo i fili tesi come un pergolato, si arrampicavano i fogliami che facevano riparo, e tutt’intorno fiorivano le campanule viola. Là sotto, in quella pace, in una fragranza forte di pomodoro e di basilico, scorreva la vita. Di fronte, nel cortile della chiesa, proiettavano i film all’aperto. Giungeva a tratti la voce degli attori, mescolandosi alle chiacchiere dei grandi. Papà versava nei bicchieri l’acqua frizzante fatta con le cartine e noi mordevamo il freno per alzarci da tavola e sporgerci dalla ringhiera per catturare qualche immagine obliqua dei “Capitani coraggiosi” o della “Carica dei seicento”. Il giorno dopo avevamo il torcicollo. Qui il caldo era una pellicola untuosa, come la carta moschicida che pendeva a picco sul tavolo. Per respirare bisognava attendere il tramonto. Allora iniziavano i preparativi per la passeggiata al Fronte. Per lavarci avevamo la soda: il sapone che ci spettava con la tessera serviva per il bucato. Bagnavamo le mani nell’acqua viscida tirata su dal pozzo, le passavamo sul viso e sulle ginocchia, ad uno ad uno, tutti nella stessa bacinella. Ci lisciavamo i capelli davanti allo specchio appeso alla parete e sulle scale aspettavamo i genitori, che ci raggiungevano di lì a poco. Mamma controllava che i vestiti fossero in ordine. Era lei a fare e disfare, rattoppare, tagliare, cucire con le sue piccole dita leste in cui l’ago scompariva. – L’importante è non sfigurare, salvare il decoro, – diceva. Oltre a essere la più bella, Gioia era sempre una delle ragazze più eleganti del paese. A quell’ora si incontravano tutte lassù, sul punto più alto e panoramico della strada che portava alla ferrovia, di dove si dominava la campagna e in fondo, lontanissimo, si indovinava il mare. 79 In autunno partirono le ultime camicie nere lasciando il paese ancora più deserto. Il vento riprese a frustare strade e cantoni, a ululare attorno alle case. Finirono le passeggiate, le corse in bicicletta, le scorpacciate di fichi negli orti bagnati di brina al primo sole. Finirono le chiacchierate notturne sul ballatoio a guardare le stelle. Ma la guerra non finiva. L’inverno si avvicinava, più duro di quello passato... Mio padre ricominciò a sentirsi male: faccia lunga, svogliatezza, misantropia, notti insonni. Raramente, se non faceva troppo freddo, si copriva, metteva il cappello, la sciarpa e, scuro e taciturno, usciva di casa. Andava a trovare Francesco, un vecchio confinato che aveva messo radici in paese. Toscano, anarchico, tirava avanti una bottega di falegname in fondo alle case. – Come va? – chiedeva mio padre mettendo dentro la testa. – O come vuoi che vada: alla marinara! Chiudi quel troiaio di porta, che si gela. Sbucciava una grossa cipolla bianca, ne sfogliava le tuniche carnose ad una ad una, le intingeva nel sale e le masticava lentamente mandando giù un sorso di rosso dal fiasco. Mio padre lo guardava disgustato. – Ma come farai a mangiare quella roba. Francesco si passava sulla bocca la mano macchiata di marrone. – Pe’ lo stomaco, un c’è di meglio, bello mio, – era la risposta. Si strofinava i denti con l’indice e tornava al banco a dare di pianuzza. Papà 80 ne studiava i gesti in silenzio, con quell’atteggiamento di devozione quasi religiosa che aveva di fronte al lavoro manuale. Francesco era un uomo lento. Chiacchierava per sé, senza badare a chi aveva davanti. Quando nella bottega faceva buio, accendeva la lampada ad acetilene. – O cosa c’entrava, madonnina, il patto con la Germania. Questa bischerata la Russia un la doveva mica fare. E che si scherza davvero? Se fanno culo e camicia anche loro, noi da che parte ci si rigira? Da anarchico anticomunista, tirava sempre fuori quella storia e le canagliate fatte in Spagna, che s’erano ammazzati fra di loro, diobono. Mio padre non sapeva che cosa rispondere. La storia del patto era rimasta in gola anche a lui, a suo tempo, ma ormai ci aveva messo una pietra sopra. Visto come erano andate le cose, era una questione superata, che gusto c’era a parlarne? Del resto, considerava Francesco un personaggio poco più che folcloristico e dopo un po’ si stancava di starlo a sentire, in quel puzzo di vino, di cipolla e segatura. – Qui, – borbottava Francesco, accompagnando l’attrezzo, se un si fa fori preti e fascisti un se n’esce, bello mio. Preti e fascisti. Mangiapane a uffo forcaioli affamatori del popolo. Finché a comanda’ son codesti bucaioli, un si compiccerà nulla di bono… te lo dice un bischero. – D’accordo, d’accordo. Quando verrà l’ora, sarà il popolo a fare giustizia, a fare piazza pulita dei fascisti. Quanto ai preti, li manderemo a lavorare, a zappare la terra, a dissodare il latifondo, a portare la cofana. – Lo vedi indove te tu sbagli? Sarebbe comoda a lavorare! Al muro! Uno per uno… E si fa il tirassegno… Pum pum! Uno a uno, come le beccacce. – E menava giù martellate come se fra le mani ci avesse davvero la testa di un prete. Per lo più nella bottega di Francesco l’anarchico toscano trapiantato, si parlava di questo, come eliminare preti e fascisti. In paese lo sapevano tutti, ma lo lasciavano dire, perché Francesco era una pasta d’uomo e quando serviva di correre a dare una mano qua e là, era sempre il primo. Dicevano che il veterinario ricorresse spesso al suo aiuto. Perfino don Domenico, quando passava di là, s’affacciava a salutarlo. – Come va, Francescaccio? 81 – O come l’ha da andare, secondo voi, reverendo? Tanto noi due, ci si rivede all’inferno, un dubitate. Don Domenico insegnava alla scuola elementare e scriveva versi un po’ azzardati. Gli piaceva la compagnia, compresa quella femminile, e non faceva nulla per nasconderlo, stava sempre in mezzo a feste, cerimonie e riunioni salottiere. – Caro professore, – diceva ampollosamente a mio padre del quale era diventato amico, – conversare con una persona come voi è un piacere dello spirito. Fra questa gente “zotica e vil”, parlare e sentirsi compresi è una soddisfazione che va ben al di là della materia. Perché non venite domani dalle care signorine Sessa? Ci riuniamo a fare quattro chiacchiere, a bere una buona tazza di caffè. Be’, caffè per modo di dire, diciamo caforzo. – Rideva della battuta fino a diventare paonazzo e tirava fuori di tasca un fazzolettone colorato per contenere i colpi di tosse catarrosa che rischiavano di soffocarlo. Poi riprendeva ispirato: – In questi tristi tempi di lutti e di macerie, avere degli amici veri, essere in sintonia con delle anime superiori è come trovarsi su un’isola felice, in un approdo di eletti, lontani dalle miserie e dalle amaritudini della vita. Voi mi comprendete, professore. Allora, professore, vi aspettiamo. Quei discorsi erano balsamo per mio padre. Gli davano una sensazione di benessere, di vanità appagata. Dopo tanto abbrutimento l’atmosfera decorosa del salotto delle signorine Sessa, il sorriso delle tre gentili sorelle, il bicchierino di maraschino offerto dalla servetta cerimoniosa sul vassoio di porcellana con le viole del pensiero dipinte a mano, il vecchio pianoforte, le tende pesanti che mantenevano l’ambiente sempre in una assonnata penombra… e quel don Domenico, così colto, sensibile, spregiudicato. Finalmente poteva parlare sapendo di essere ascoltato, compreso, di più: apprezzato; poteva esporre le sue idee, i suoi princìpi. Che differenza, che abisso con la vita nella casa degli insetti, della miseria, dello squallore, dove i suoi pensieri, i suoi sogni non importavano a nessuno, anzi, venivano considerati noiosi, visionari, incoscienti e pericolosi dalla donna che aveva sposa- to, la madre dei suoi figli, la quale mal sopportava la sua compagnia. – Non sei stanco? – gli diceva, – va’ a stenderti, vai a dormire, ti farà bene. – Oppure lo esortava a uscire, – vai vai, vai a prendere un po’ d’aria fresca, – e poi, al ritorno, lo tormentava sottoponendolo al terzo grado: – Con chi sei stato fino a quest’ora? attento a chi frequenti, bada a quello lì, ti porterà alla rovina, ai ragazzini non ci pensi? – faceva l’impossibile per farlo sentire colpevole di tutte le loro disgrazie; lo torturava con assurde gelosie che nascevano dal senso di inferiorità, dalla incapacità di vivere in un consesso civile. Ora stava tentando di infangare anche quella storia innocente. – Lo so perché ci vai. Mi prendi per scema? Per quelle sgualdrinelle che ti incantano coi sorrisetti, il bicchierino, la suonatina. Gliela darei io una suonatina a quelle sfacciate! – Tanta volgarità lo feriva. Perché non voleva ammettere che esistessero persone superiori come don Domenico, per esempio, che lo portava in palmo di mano? – Ora te la fai coi preti, bel comunista! – diceva sprezzante. Così era lei. Non sapeva distinguere. Don Domenico era una lampante eccezione, uno che studiava, si teneva al corrente dei fatti del mondo, amava la dialettica e conosceva Il capitale come le Scritture sacre. Come poteva capirlo, lei? Se avesse visto che stima e considerazione avevano di lui quelle signorine così graziose, distinte, istruite! Ah, se avesse avuto al fianco una donna diversa, che lo sostenesse, lo seguisse nei suoi ideali! – Ideali? parole, parole al vento. Gli ideali non ti danno da mangiare e ti portano alla catastrofe. Guarda mio padre! – Suo padre, vecchio socialista, era morto povero e malato per essere rimasto fedele e coerente agli ideali. Quante volte aveva cercato di farglielo capire, ma lei aveva la capacità di volgere ogni cosa in negativo, di immeschinire tutto, e quando non aveva più argomenti, allora faceva la vittima rassegnata, si chiudeva nel mutismo per giorni e giorni o borbottava. – Ma sì, vai, vai, tanto di me che te ne importa? che cosa rappresento io per te? guarda come sono ridotta, io che se avessi voluto… 82 In casa era sempre la stessa musica. Allora mio padre si lucidava le scarpe, metteva il cappello e usciva. Strada facendo si rasserenava e 83 cominciava a fischiettare tra i denti un’aria d’opera. Andava da don Domenico, da don Turi, anche lui una brava persona, gran giocatore di scacchi. Certo, non antifascista, anzi! ma tollerante e bonario: badava ai suoi interessi e della politica se ne infischiava. Anche noi ragazzi andavamo a trovare don Turi. Lui ci riempiva le tasche di castagne abbrustolite o di taralli. Poi ci portava a visitare la fabbrica di liquirizia e a me pareva di essere nell’inferno tra quei fiotti e quelle nere bolge gommose dall’odore nauseabondo che dei dannati sospingevano e rivoltolavano dentro voraci calderoni in un moto che non s’arrestava mai. Ce ne riportavamo a casa grossi tocchi e per giorni e giorni continuavamo a succhiare, con le mani appiccicose. Una di quelle sere mio padre tardò a rincasare. Era passata l’ora del coprifuoco e lui non tornava. La mamma, con la faccia incollata alla porta, spiava il cortile. Aveva deciso di mandare Miro a cercarlo dalle Sessa o da don Turi o da Francesco, – Vai, prendi la bicicletta, ma sta’ attento, mi raccomando, – quando l’uscio si aprì e mio padre comparve sorridente. Lei lo investì, senza dargli il tempo di aprire bocca: – Ma di’, sei impazzito? Vuoi rovinarci? Dove sei stato fino a quest’ora? – Ehi, ehi! Calma! Ho solo fatto un po’ tardi, non è il caso di farne una tragedia. Chiacchierando chiacchierando non ci siamo accorti che il tempo passava. Comunque, eccomi qua, non è successo niente. – Chiacchierando chiacchierando! Eh già. Ma ti senti? Ti rendi conto di quello che dici? Sei il solito incosciente. La tua linguaccia è la nostra rovina! Oddio! Mai un’ora di bene, da quando t’ho sposato. Stramaledetta politica! Non ne posso più. Basta! Basta! Preso alla sprovvista, col sorriso ancora sulle labbra, mio padre sembrava disorientato. Dopotutto, aveva tardato un’ora, forse meno. – Insomma che ti prende? Che significa questa scena madre? – Ma dove vivi? Non lo sai che possono inasprirti la pena, risbatterti in galera e buttare via la chiave? Non sa niente, lui! Lui chiacchiera. Che c’è di male, dice. Mentre io sto qui a dannarmi, a morire di pena. E pensare che se la smettessi, se ti comportassi bene, si potrebbe chiedere la grazia e… 84 – Ah, ecco! Ora capisco! E chi te l’avrebbe messa in testa questa bella pensata? La grazia! E a chi? Al duce magari! È incredibile! Scommetto che ti ha scritto tua madre, o magari quel fanatico di tuo fratello! Chiedere la grazia! Io! La grazia di che? Piuttosto mi metto a fare il manovale, vado a rubare, mi butto a fiume! Capito? Avete capito tutti? Non farmi più sentire queste bestemmie, intesi? Diglielo a quel beccamorto di tuo fratello! – Certo. Dovevo immaginarlo. Stupida io che mi faccio ancora illusioni. Sei un egoista. Pensi solo a te stesso e al tuo ridicolo orgoglio, e di queste creature innocenti, del loro avvenire, te ne infischi. Quanto a me, ho deciso: tu fai quello che ti pare, buttati pure a fiume se preferisci, ma io non starò a guardare. Io così non ci vivo. Prendo i ragazzini e torno a Roma. Ti pianto. È finita! Me ne vado, e a dargli un tozzo di pane ai figli ci penso da sola. Tanto, che cosa se ne fanno di un padre come te. Meglio orfani. Come se questo fosse già accaduto, mia madre abbassò il capo e cominciò a muoversi per la stanza con quell’aria bastonata che mi faceva pena e rabbia insieme. Si mise a raccogliere la spazzatura, a lavare i piatti, piccola piccola. Era in momenti come quello che la sua presenza diventava più incombente e più penosa. Mio padre sbalordito, sopraffatto, sedette in un angolo del tavolo senza guardare nessuno. Zitto, nero, con gli occhi fissi e tristi. Dopo un silenzio interminabile, alzò la testa e disse: – Non si mangia stasera? La mamma tirò via dal fornello spento un piatto coperto e glielo mise davanti con gesto brusco. Poi prese le posate dal cassetto, un bicchiere d’acqua, una fetta di pane e posò tutto sul legno nudo. – Come il cane, – commentò senza ira mio padre, cominciando a mangiare. A vederlo così, solo, con quella miseria davanti, chino sul piatto a raccogliere con l’ultima crosta di pane il poco che restava, provai uno struggimento acuto. Non so che cosa avrei dato perché mia madre gli andasse vicino, a fargli una carezza sulla testa, a dirgli una parola gentile. La guardai. Lei non c’era. Mi venne una gran voglia di piangere e andai a letto. VII 85 Il secondo inverno quarantuno-quarantadue mio padre fece provvista di legna e ci chiudemmo in casa coi giornali ripiegati sotto le porte e le finestre per evitare gli spifferi. Seduti in cerchio fin dentro il camino che non tirava e sprigionava sbuffate di fumo, “a scaldare il fuoco”, non ci decidevamo mai ad andare a letto. Verso le otto la mamma scolava la verdura, raccogliendo in un catino l’acqua da usare più tardi per lavare i piatti. La condiva con olio e limone e la distribuiva un po’ per ciascuno. Poi prendeva dalla credenza il cestino della ricotta fresca e la tagliava in tante rondelle, da mettere nel piatto, due, tre per ciascuno, accanto alla verdura. Intanto papà aveva affettato il pane, con attenzione, raccogliendo le briciole nel cavo della mano. Seguivamo in silenzio ogni gesto, inghiottendo la saliva e appena ricevuto il piatto dalle mani della mamma, riprendevamo posto davanti al fuoco, con la cena sulle ginocchia, divorandola più con gli occhi che con la bocca. – Piano, piano, – raccomandava mio padre. – Se vi affogate così, non sentite neanche il sapore delle cose. E tu, hai già finito! Ma che fai, lecchi il piatto! Chi te l’ha insegnata l’educazione? Ti comporti come un bifolco! – Ho fame, – si lamentava Livio. – Fame, fame. Preti, frati, ragazzini e polli non furon mai satolli, – recitava immancabilmente mio padre. Alla fine c’era il rito dell’arancia. Uno o due frutti da dividere erano considerati un lusso, una festa. Papà tirava fuori dalle tasche il suo temperino col manico di madreperla, incideva lentamente la scorza in senso longitudinale e buttava sul fuoco ogni striscia, perché facesse buon odore. Gli tenevamo gli occhi addosso pregustando il sapore aspro e dolce insieme, mentre lui continuava a roteare il frutto con dita esperte. 86 La mamma sospirava, raccoglieva i piatti sporchi. Papà aggiungeva un ceppo, attizzava la brace e noi a guardare la fiamma scoppiettante, in silenzio. Era bello incantarsi, sapere che la giornata era finita, che non bisognava correre in paese a prendere l’acqua o a fare la spesa, o lavare i piatti, spazzare con le mani gonfie di geloni. Anche di parlare si poteva fare a meno e lasciare che il sonno ci prendesse a poco a poco, avvolgendoci come una coperta calda. In quel tepore iniziava la cerca. Li sentivamo brulicare sotto le ascelle e sulla pancia e cominciavamo a grattarci, dapprima con pudore poi via via sempre più scoperti. Il primo era papà a togliersi la camicia e la maglia. A torso nudo, bianco e magro nel riverbero della fiamma che gli arrossava il volto, scrutava intento. Li snidava, tenendoli tra la punta del pollice e quella dell’indice. Li osservava, e poi, sporgendosi sullo scalino di mattoni, li gettava sulla brace, aspettando con l’orecchio teso l’impercettibile scoppiettio. – Crepa, maledetto parassita. Ecco la fine riservata a chi succhia il sangue della povera gente! – diceva, con un guizzo di gioia negli occhi. – Le cuciture. È nelle cuciture che bisogna guardare. È lì che depongono le uova. È lì che si annida il nemico. – La mamma non si spogliava. Rannicchiata sulla seggiolina nana, sfilava la maglia da sotto la cintura della veste e la tirava da tutte le parti. Cercava in silenzio, a testa bassa, il fuoco nei capelli, e di tanto in tanto tirava su col naso. Quando era stanca si alzava, scamiciata e assente, e se ne andava a letto portandosi dietro Gioia che cascava dal sonno. Io e mio padre eravamo gli ultimi a ritirarci, non prima che il fuoco fosse morto del tutto. A volte lui restava da solo, allora prendeva dal cassetto le carte napoletane e le allineava sul tavolo, a ranghi compatti, per il Napoleone che non gli riusciva mai. A marzo chiese il permesso di andare a Crotone, questa volta col treno, per ragioni di salute. Si era deciso a consultare uno specialista, il quale decretò che bisognava intervenire chirurgicamente a breve termine. Mio padre non volle saperne e continuò a curarsi con le bustine e il carbone. In quello scorcio d’inverno, con gli ultimi freddi, si era fatto anche più sparuto. Era piombato in una cupa misantropia e non voleva vedere più nessuno: né don Domenico, né le care signorine Sessa, né don Turi. Raramente, tornando dal paese, si affacciava a salutare Francesco, a bottega. Ma non gli piaceva più. – È una fissazione, la sua, – brontolava. – Ripete sempre le stesse cose, le stesse cose. E il puzzo! Tra cipolle, vino, sigari e quel che segue, è impossibile stargli vicino. Non voglio andarci più. Basta, basta. – Finalmente l’hai capito, – approvava subito la mamma. – Te l’ho sempre detto io di lasciarlo perdere, quell’ubriacone. – Lì per lì papà sembrava persuaso, ma poi, la prossima volta che capitava in paese, infilava la testa nella porta. – Come va? Ci vieni a prendere un caffè? – Caffè, caffè: cicoria! 87 Quando arrivò l’estate ci prese l’arteteca, come la chiamava mio padre: l’ansia, la smania. Non potevamo stare fermi, non facevamo che parlare, parlare, sognare, e la notte, distratti da tante fantasticherie, non c’era verso di dormire. Mio padre aveva appeso un calendario accanto alla porta d’ingresso. Ogni sera, prima di coricarsi, faceva un fregaccio con la matita rossa sul giorno appena trascorso. – Meno uno, – sospirava. Mancavano poco più di tre mesi. Non sembrava vero. – I cento giorni di Sant’Elena, – diceva papà. – Novantotto. Novantasette. Novantasei… Allegri, figlioli, la fine s’avvicina. Ma a noi le giornate sembravano interminabili. Aspettavamo ansiosi la sera per assistere al rito del calendario, col pensiero fisso a Roma. Ricordi e immagini si affollavano e si confondevano nella mente. La nostra casa, il bagno di maioliche azzurre, il viola delle campanule sul terrazzo, il cinema dirimpetto, il cortile della nonna, con l’autorimessa, i giardinetti fioriti di biancospino, il monte dei cocci, la scuola, le scarpette bianche, le domeniche con mamma e papà. Tutto sarebbe ricominciato come allora. Dentro di noi, nel profondo, sapevamo che nulla sarebbe stato come prima. Mia madre non faceva che ricordarcelo. – Conta, conta, – diceva amara. – Roma sarà la nostra via crucis, il salto nel buio. – Era sempre triste, chiusa nel silenzio, curva, spetti- 88 nata, le vesti in disordine. Il tempo in quei due anni aveva lasciato su di lei un’impronta impietosa. Era così cambiata! Parlava poco. Non cantava più, che quasi non ricordavo la sua bella voce. A Roma sarà diversa, mi dicevo, ritroverà il sorriso. Sarebbero tornati a scherzare, ad abbracciarsi, a parlottare segretamente dentro le coperte, come allora, quando lei si schermiva tutta rossa di piacere e si toglieva le sue mani di dosso accennando a noi che guardavamo turbati. – Smettila, ci sono le creature! Su, su, siediti che è pronto da mangiare… – Era bella, mia madre. Piccola e morbida, coi capelli folti e scuri e un sorriso che incantava. Quando si vestiva bene, la domenica, col cappellino, la veletta, le calze di seta, i tacchi alti, era una vera signora. Ora invece le rare volte che usciva di casa il cappello non lo metteva più. Del resto, era passato di moda. Le donne si fasciavano la testa come i principi indiani dei libri di Salgari, ma senza le perle e la piuma. Quando sul calendario i giorni divennero trenta, fummo presi dall’agitazione dei preparativi. Venne Francesco a darci una mano. Costruiva delle gabbie attorno ai mobili e scoprimmo che cantava: conosceva a memoria tutte le opere di Puccini, compresa la trilogia, tanto che mia madre cominciò a chiamarlo Giannischicchi. Era matto, portava scompiglio ma, strano a dirsi, mia madre finì per prenderlo in simpatia e qualche volta credo di averla sentita duettare con lui da una stanza all’altra. Insisteva perché restasse a cena e non gli lesinava il vino. Ne assaggiavamo un goccio anche noi, ma poco poco, perché il vino è veleno per i bambini. E poi c’erano le vicine. La porta restava aperta tutto il giorno e loro andavano e venivano, prodighe di aiuti, consigli, raccomandazioni. Ci dettero perfino l’indirizzo di un loro lontano parente, un pezzo grosso del fascio, insistendo perché a Roma andassimo a trovarlo. L’unico a non condividere l’entusiasmo era Tonino, un giovanotto così chiaro, alto, robusto, disinvolto e simpatico che non sembrava nato in quel paese. Era venuto una sera a trovare papà e per ore e ore avevano parlato di politica. Tonino aveva studiato a Detroit e parlava in un modo curioso. Presto le sue visite diventarono assidue e prolungate, ma aveva occhi solo per Gioia. Le regalò anche un gram- mofono a manovella e dei dischi di canzoni americane. – Lo swing, – le diceva, – ha il ritmo del cuore. Ascolta: tu-tum, tu-tum, tu-tum… – Ce n’era una che mi piaceva moltissimo, sebbene non ci capissi nulla. Il ritornello suonava pressappoco così: Tu lovisìn tu lovisìn Tu lovisìn maiar… 89 Imparai quelle parole senza significato e le ripetevo tutto il giorno anche se, come avvertiva mia madre, non erano tempi da cantare roba straniera. Una delle ultime notti prima della partenza, Tonino rimase fino all’alba sotto casa, sperando che Gioia uscisse. Ma Gioia pensava a Roma, alla vita e al mondo che l’aspettava nella grande città che aveva lasciato bambina e che certo ora le sarebbe apparsa diversa. Era assente, incantata e non le importava di nessuno. La mattina trovammo sotto la porta un biglietto misterioso e accorato. E da allora di Tonino non si seppe più nulla. Una fredda sera di novembre tutto fu pronto e ammassato nella vasta cucina. Papà passeggiava in silenzio, arrotolando una sigaretta; la mamma, seduta accanto al fuoco, guardava fisso la fiamma estinguersi lentamente; noi parlavamo fitto fitto, a bassa voce, ma i discorsi morivano in una grande tristezza. All’improvviso la porta si spalancò e irruppe la vicina. Accese di colpo la luce e ci trascinò in casa sua. Avevano preparato un cenone col cinghiale cacciato due giorni prima dal padre. Tutta la casa era impregnata di un odore disgustoso, un miscuglio di sangue e aceto che sembrava di averlo in bocca e ora quella carne nera e dura ce la trovavamo nel piatto. Io preferii le olive e il formaggio. C’era lo zito, il fidanzato di Agnese, giunto dalla città, una specie di rotolo di muscoli. Cantò due canzoni napoletane, ritto su una sedia, la salvietta intorno al collo e le vene che rischiavano di scoppiare. Dopo i brindisi venne il turno delle storielle. A ogni scoppio di riso seguiva un silenzio lungo e pesante, come se ognuno nascondesse in cuore una gran pena. Il vento faceva vibrare i vetri delle imposte e animava la notte di voci sinistre. Il giorno dopo partimmo. PARTE TERZA I 93 La stazione di Roma quella mattina non aveva l’aria festosa che ricordavo a ogni nostra partenza per le vacanze; l’andare e venire di persone ben vestite, sorridenti o commosse, che s’abbracciavano, sventolavano fazzoletti; facchini che spingevano carrelli; venditori urlanti; ritardatari affannati. La prima cosa che mi colpì fu il sudiciume e la tristezza: gente nera, soldati accosciati dappertutto, donne cariche di fagotti, ragazzini che piangevano. I capitreno correvano da un capo all’altro e la voce monotona dell’altoparlante annunciò a più riprese che il direttissimo da Bari portava dieci ore di ritardo. Ad aspettarci non c’era nessuno e fu difficile trovare un facchino. Mentre papà si preoccupava di cercare un taxi, ci sistemammo in qualche modo nella sala d’aspetto, coi viaggiatori pigiati intorno intorno, sulle panche, sulle valigie, con gli occhi arsi di febbre. Eravamo in viaggio dal giorno prima senza dormire tutta la notte e da Napoli in poi quasi sempre in piedi. Avevo le gambe gonfie e mi girava la testa. La mamma sembrava invecchiata di dieci anni. Gli altri si guardavano attorno smarriti, zitti, le palpebre arrossate per il sonno perduto. A casa della nonna ci stravaccammo sui letti senza spogliarci. Dormii dieci ore filate sul divano della sala da pranzo e quando mi svegliai una fitta penombra inghiottiva gli angoli e i vecchi mobili. Il grande lampadario di ferro battuto incombeva a picco sul tavolo nero con le zampe ad artiglio di leone e l’aquila impagliata con le ali aperte sembrava sul punto di spiccare il volo su di me. La fissavo e temevo che mi rapisse come il pastorello di un libro che papà mi mostrava da piccola. Ricordai i falchi, laggiù, in quel paese lontano: come mi parve lontano! richiusi gli occhi e restai immobile, intorpidita, le gambe pesanti e un ronzio nella testa. A poco a poco distinsi le voci della casa e riconobbi il parlottio acido della nonna. 94 Gioia trovò subito un impiego presso una ditta di trasporti che aveva l’ufficio dentro un cortile. Non era stato difficile: aveva sedici anni, era bella e scoppiava negli abiti risicati. Poi toccò a Miro. Lui non era un colosso: piccolo, linfatico, con un carattere pavido, ma era una vergogna vedere un ragazzo di quattordici anni stare tutto il giorno con le mani in mano. A furia di agitarsi e di battere a destra e a sinistra, la nonna gli trovò un lavoro come apprendista alla vetreria San Paolo. La mattina lo buttava giù dal letto alle sei, gli metteva la testa sotto il rubinetto, avvolgeva la merenda in un foglio di giornale e gli strillava dietro le raccomandazioni, finché non aveva oltrepassato il cancelletto del giardino. C’era un bel po’ di strada a piedi prima di arrivare e bisognava aspettare la sera perché ritornasse sfiancato e inebetito. Nino gli correva incontro e gli frugava nelle tasche gonfie di quadrucci di vetro colorato. Il sabato la mamma gli prendeva dalle mani arrossate la busta con la paga e le brillava negli occhi la speranza. Andare via di lì, al più presto. Non aspettavamo altro. Quanto a mio padre, in casa cercava di starci il meno possibile. A volte non tornava nemmeno per mangiare. Sapevo che non sopportava lo sguardo di mia nonna, che pareva gli contasse i bocconi in bocca. Andavo spesso con lui. – Va’, vagli dietro, – mi aveva detto la mamma, – se no, una volta o l’altra fa qualche sciocchezza, quel poveraccio. Scoraggiati, intirizziti, muti, salivamo e scendevamo da tram straripanti. Capitava spesso di restare aggrappati sul predellino lungo tutto il tragitto e le dita si aggranchivano, gli occhi piangevano sotto la sferza della tramontana, ma almeno si risparmiano i soldi del biglietto, diceva papà. Per la strada mi tenevo attaccata al suo braccio e quando ero più stanca mi appoggiavo tutta a lui. Se chiudevo gli occhi, la testa mi girava e mi sembrava di volare e ogni sofferenza scivolava via dal corpo leggero. 95 – Forza Mariò, – mi disse un giorno fregandosi le mani. – È fatta. Ho trovato lavoro e con un po’ di fortuna ce ne andiamo via di là. Affittiamo un bell’appartamento tutto per noi, come prima. Vedrai, Mariò, vedrai. Sembrava tornato di colpo quello di un tempo, pieno di fiducia, di entusiasmo, di energia. Ero orgogliosa di essere con lui. Mi piaceva seguirlo in quelle camminate. Scendevamo a Monte Savello, costeggiavamo la misteriosa sinagoga con le sue casupole aggrappate alle spalle, raggiungevamo ponte Garibaldi, sulla sinistra, poi ponte Sisto e declinavamo per la nobile via Giulia. Di lì ci perdevamo in un dedalo di stradine. Entravamo in portoni solenni, in androni bui, salivamo scale silenziose, col fiatone e lo spago dei pacchetti che mi segava le dita. Ma ero felice. Usciva dalle tenebre una suora. Con passo lieve e occhi bassi, la cuffietta orlata di bianco, la pelle stinta, ci introduceva in una sala coi soffitti che si perdevano nell’ombra e spariva dietro un muro. Ne arrivava un’altra grassa con lo sguardo dritto: guardava i quaderni, le matite, i gessetti, i cancellini, discuteva sui prezzi, severa e inflessibile, e con mio padre l’aveva vinta facilmente. – Prendile per sceme, le monachelle. Visto come sanno farsi gli affari loro? – Non ti hanno dato troppo poco, papà? – Non fa niente. Sai come si dice? Meglio l’uovo oggi che la gallina domani. Bisogna avere la vista lunga. Se riesco ad accaparrarmi il giro dei conventi, siamo a cavallo. Quando si tratta di grosse ordinazioni come questa, la convenienza c’è sempre. La sera si infilava tra le case alte e severe, scendeva sull’acciottolato grigio e con la sera ci arrivavano addosso la fatica e la fame. – Sei stanca, Mariò? – Noo, – mentivo. – Brava. Io non sono mai stanco. Camminare mi è sempre piaciuto. Da ragazzino andavo nei boschi, in montagna. Mi arrampicavo su su fino in cima. Però, un certo languore allo stomaco me lo sento. Uno spuntino ci starebbe bene, che ne dici? 96 – Be’, insomma. – Ho scoperto un posto non lontano dove fanno i supplì come prima della guerra. C’è un po’ da scarpinare, è in una di quelle stradine dietro la Chiesa Nuova, dalle parti di piazza Navona. – Ma, papà… – Andiamo, andiamo. Per una volta, crepi l’avarizia. E poi ce lo siamo meritato, no? Dobbiamo festeggiare l’affare con la scuffiona. Speravo che papà evitasse la piazza. La prima volta che c’ero stata, da piccola, mi aveva impaurita: così lunga, grande, con chiese enormi e palazzoni e soprattutto con quella terribile fontana al centro, piena di mostri contorti, minacciosi… Dal Governo vecchio mio padre si imbucò in un labirinto di vicoli. L’odore mi colpì inaspettato, da far male. Era un buchetto con un calderone ribollente che prendeva tutta la porta e dentro ci galleggiavano i supplì: rosei, poi rossi, dorati, bruni. Te li mettevano in mano avvolti nel tovagliolino di carta: scottavano che quasi non riuscivi a tenerli. Sparivano in due bocconi e subito l’occhio ricadeva nel paiolo sfrigolante. Quella sosta peccaminosa divenne il nostro segreto, consolante come una promessa, pesante come un rimorso. Non sempre andava bene, però. Spesso entravamo e uscivamo a mani vuote da negozietti angusti dagli scaffali inzeppati di libri. Con l’aria di chi non ha nessuna voglia di parlare, un uomo ci sbirciava da dietro il banco e raramente si tirava su dalla sedia a dare un’occhiata al campionario. – Il guaio è la miseria, – sospirava papà. – Viviamo in una schifosa città senza soldi, una città parassita. Non circola una lira. – Che vuol dire parassita, papà? – Vuol dire che qui non si produce niente, si consuma soltanto. Roma vive alle spalle delle grandi industrie del Nord. – Allora nel Nord si sta meglio, papà? – Non c’è paragone! Intanto, si respira un’altra aria. Mica è pieno di preti così. Là c’è la classe operaia. Ci sono le grandi fabbriche, il cuore del Paese. È da lì che partirà la riscossa. Il mio sogno è sempre stato di portarvi lassù. 97 – Dove, papà? – A Milano a Torino a Genova! Ecco, soprattutto a Genova! Che città! – C’è il mare, vero papà? – Sì. E il porto. È tutta bianca, altera, bellissima. E che vita! Il fatto è che ci sono gli operai, capisci, i portuali. Non devi elemosinare il centesimo, hai il tuo lavoro. Il lavoro è un diritto e se lavori sei rispettato, hai dignità. Mi capisci, Mariò? È la base di tutto, il lavoro. Ah, come vorrei portarvici! Chissà se ci arriverò. Quei discorsi, quei sogni, insieme alle soste rubate dal friggitore di supplì, formarono un legame speciale tra noi: erano il nostro segreto. Sapevo che quelle cose papà non le aveva dette a nessuno. Il suo sogno di una città bianca e alta sul mare dove l’uomo ha la sua dignità, divenne anche il mio sogno. Mi riempiva la fantasia, scacciava la fatica e il freddo. Quando venne primavera e l’attività sembrò avviata, fu deciso che mia madre avrebbe chiesto dei soldi in prestito alla nonna per affittare un appartamento. La nonna fece la commedia, si schermì, e alla fine concluse che se li sarebbe fatti dare da uno strozzino e volle un impegno firmato che a ogni fine mese papà le avrebbe restituito una certa somma, più gli interessi. Così fu fatto e qualche mese più tardi avevamo la nostra casa. – Dio com’è bella! – esclamò mia madre entrando. – Com’è grande, luminosa! Ma la pigione quant’è? Ce la faremo? – Non preoccuparti. Ti prometto che da oggi comincia una vita nuova e che non ti darò più preoccupazioni. Te lo giuro sui nostri figli. Eravamo tutti commossi. La mamma aveva le lacrime agli occhi. – Quante ne abbiamo passate! – Sì, ma è finita. D’ora in poi tutto sarà diverso. Però anche tu devi aiutarmi, devi essere al mio fianco. Ho bisogno di fiducia, di incoraggiamento. Dovremo ricominciare da zero e dimenticare quello che è stato. Ma ce la faremo, vedrai Ernestina, ce la faremo. I figli diventeranno grandi e ci daranno una mano, saranno la nostra consolazione. Vedrai, Ernestina, vedrai… II 98 Guardai l’orologio sulla parete di cucina: le cinque e mezza. Non mi ero mai alzata tanto presto. La frusta dell’acqua gelida sul viso mi fece rabbrividire. Quell’inverno ci sarebbe voluta davvero la stufa. Infilai il cappotto, mi avvolsi la testa con una sciarpa di lana, staccai la sporta dal chiodo dietro l’uscio, presi il borsellino coi soldi e uscii. L’aria era grigia e spessa, il freddo mi feriva il volto: sentivo il naso gelato e rosso. I negozi erano tutti chiusi e le strade deserte. Anche al mercato non c’era ancora nessuno. I banchi dormivano allineati sotto i teloni di cerata nera, tetri e lugubri. Le suole di legno risuonavano sul selciato e dalle case giunse lo sbattere di qualche persiana. Il primo tram sibilò sulle rotaie: un fischio straziante. Guardai il cielo: pioverà. Me lo aveva insegnato mio padre: Quando il tram fischia vuol dire che piove. Mi appoggiai al muro sotto le arcate per ripararmi dalla tramontana battendo i tacchi per scaldarmi i piedi. Il bar tirò su con fracasso la saracinesca e il barista in camice bianco si mise a spolverare tavoli e sedie con gesti approssimativi. Il giorno cominciava a schiarare e il secondo tram passò pieno di gente dalla faccia imbambolata. Giunsero due o tre donne, mi guardarono senza simpatia. Avevano le sporte vuote al braccio e lo scialletto di lana sulle spalle. Le sentii parlottare e capii che volevano andare dall’ortolano. S’incamminarono leste e io le seguii un po’ a distanza, senza azzardare una parola. Prendemmo una strada in salita che dal quartiere portava fuori, verso la basilica di San Paolo e alla fine ci trovammo in uno sterrato tagliato in due da un sentiero chiuso da un cancelletto di legno. Le donne si fermarono, presero a vociare. – Ehi voi, non c’è nessuno? Ehi, voi, laggiù, veniteci ad aprire! 99 Apparve un uomo con l’espressione incattivita. – Che volete? – chiese. – Non ci sarebbero un po’ di broccoletti, di patate? – Le patate ce l’avete voi in testa! Qui non c’è più niente. Andatevene! – E su, non fate lo scorbutico. Ve li paghiamo, sapete, mica li vogliamo regalati. Venite qua, siate buono. Non ce l’avete un cuore? L’uomo alzò un braccio e fece un segno di diniego. – Ma guardatelo ‘sto boia approfittatore. St’infame! Restammo un pezzo lì fuori al freddo con la speranza che tornasse indietro. Io tremavo e continuavo a battere i piedi nella terra umida. – È vita questa, dico io. Per un po’ di verdura… – E chissà quando finirà! – Ormai, neanche alla borsa nera si trova più niente. – La borsa nera! E chi ce l’ha i soldi? Io mi sono già venduta tutto l’oro, quello mio e di mio marito, e pure i ricordi di povera mamma. Non me so’ rimasti nemmanco l’occhi pe’ piagne. – ‘Sti boiaccia, affamatori del popolo, come ci hanno ridotti… ‘Sti mascalzoni… In quel momento un grande carretto colmo di verdure, di frutta, di patate apparve in fondo alla strada. – Ehi, voi! dove la portate ‘sta roba? L’uomo, lo stesso di prima, scrollò le spalle e abbassò la faccia chiusa sulle stanghe. – Hai capito, ‘sto burino! – Diteci almeno dove andate, no? Ci mettemmo a correre, decise a raggiungerlo, ma dopo un po’ eravamo sfiancate; a una faceva male la milza e dovette appoggiarsi al muro. Il carretto era ormai lontano col suo carico di bendidio. Quando arrivammo di nuovo al mercato, la merce era sui banchi e s’erano già formate delle file interminabili. La piazza, fino a poco prima deserta e silenziosa, echeggiava di grida, di richiami, di alterchi. Mi venne da piangere. Tutto per andare dietro a quelle donne. Se fossi rima- 100 sta qui ora sarei la prima della fila e chissà quanta roba potevo portare a casa, mi dissi, disperata. E adesso che faccio? Che gli dico a mamma quando torno? Pensai con nostalgia al calduccio del letto, a quando la mamma veniva a svegliarci da piccoli. La fragranza di caffellatte e di pane fresco, la corsa fino alla scuola, sempre in ritardo: l’odore dei quaderni, lo sfrigolio del gessetto sulla lavagna, la quiete dei pomeriggi con le canzonette sentimentali dell’Eiar che facevano sognare, viaggiare lontano con la mente… Pensai ai piedi diacci, allo stomaco vuoto, alla vita grama e a quella brutta guerra che non finiva più, e avevo sempre più voglia di piangere. Guardai la fila davanti a me e mi misi in coda ad aspettare il mio turno, badando a chi cercava di intrufolarsi, difendendomi dalle spinte, dalle gomitate. Bastava distrarsi un momento che subito qualcuno ne approfittava per rubarti il posto. I venditori se la prendevano comoda e tra un passo avanti e l’altro sembrava trascorrere un secolo. Una donna con un pancione ai ginocchi si sentì male. La fila si scompose. – Oddio, correte, questa si sturba! – Reggetela, reggetela! – Ehi, militare, questa bisogna portarla a casa. Un milite che bighellonava tra le file scherzando o facendo il duro a seconda dei casi, accorse e, insieme a un altro, presero in braccio la poveretta e la portarono via. – Speriamo che non si sgrava pe’ strada. – Una di meno, – soffiò una voce dietro di me. Passato il trambusto, il vocio s’attutì. Sulla fila ricompattata calò un silenzio torpido e anche quelle che avevano inalberato la grinta più bellicosa, ora stavano zitte, guardando con aria sconsolata il mucchio di verdure farsi sempre più piccolo sul banco. Eravamo rimaste in poche e potevo seguire i gesti dell’ortolano, il movimento convulso delle stadere, le fortunate che si allontanavano frettolosamente con la borsa gonfia stretta al fianco e l’aria insolente. A volte c’era chi all’ultimo minuto dirottava su un’altra fila. Allora tutto ricominciava: il chiacchiericcio, le gomitate, gli scherzi volgari del milite, l’attesa, la delusione. Quando non restò più nulla, l’uomo rovesciò le ceste e il piatto della stadera. – Andatevene a casa, donne, – disse. – Non c’è più nulla. La strada del ritorno sembrava senza fine. Era uscito un po’ di sole e quel tepore mi illanguidiva. La borsa pendeva dal mio braccio e io mi sentivo come lei: vuota. Non risposi nulla alle domande e ai rimproveri di mia madre. Tutto mi scivolava dalla testa in un’assenza di dolore. Passata anche la voglia di piangere alla quale pochi minuti prima, di fronte all’ultimo banco deserto, avevo ceduto per il freddo e la disperazione. Desideravo soltanto sparire, non sentire nulla, non pensare a nulla. Mi chiusi nella mia cameretta e dalla finestra vidi Miro e Livio arrivare coi piedi inzaccherati e il gelo sulla faccia. Sentii la mamma raccomandargli di fare attenzione. – Ho appena finito di lavare per terra. Lo sapete che non ce la faccio. – È pronto? – chiese Livio soffiandosi sulle mani. – Pronto un accidente. Ringraziate vostra sorella: anche oggi è tornata con la borsa vuota. Si fa passare avanti tutti, quella stupida. Sempre con la testa fra le nuvole. Ah, se non fosse per questa maledizione! – Si accarezzò la pancia sformata e rimase qualche minuto in silenzio a guardare i fornelli dove la fiamma azzurrognola lambiva inutilmente i fianchi anneriti della pentola. – Anche questa mi ci voleva! Che disgrazia! – sospirò. 101 Avevo ripreso gli studi. Molte scuole erano chiuse o funzionavano coi turni, la mia era aperta di pomeriggio. L’edificio era in fondo a un lungo viale che partiva dallo slargo davanti alla nostra casa e per un tratto tagliava in due tanti piccoli appezzamenti coltivati a orto. La sera tornavo quasi a buio. Le imposte erano già serrate e le strade immerse in una penombra azzurra. Dalle vetrine oscurate dei negozi filtrava una luce tenue. Qualcuno già abbassava le saracinesche. Trovavo la mamma sotto la lampada ad agucchiare o sferruzzare assorta, e 102 nel silenzio avvertivo quasi il suo respiro affannoso. Sembrava che non ci fosse nessuno oltre lei. I piccoli, intanati in un angolo, aspettavano la cena con gli occhi sgranati. Quando arrivava mio padre era ora di mangiare. La tavola non si apparecchiava più da tempo perché col razionamento del sapone la biancheria non si poteva lavare troppo spesso. La tovaglia la mettevamo solo la domenica o le rare volte che avevamo un ospite. La mamma passava lo straccio bagnato sul piano di legno e metteva giù i piatti. La guardavamo ansiosi, in attesa che papà avesse finito di infilarsi il tovagliolo nel colletto della camicia per attaccare con un farfugliato buon appetito altrettanto. La cena si consumava in fretta: un bicchiere d’acqua ed era finita. Dopo aver rigovernato e aiutato i fratelli minori a coricarsi, Gioia e io ci sedevamo attorno alla mamma, in cucina, a fare qualche lavoro, con la radio accesa. Più tardi, quando tutti erano a letto, mia sorella e io, di nuovo insieme nella stessa stanza, per un po’ stavamo in silenzio con la testa dentro le coperte ad aspettare il sonno che non arrivava, poi cominciavamo a parlare. Era la nostra ora, l’ora dei sogni, delle fantasie, delle confidenze. Certe notti ci sorprendeva l’urlo delle sirene. – Io non vengo, tanto a Roma non bombarderanno mai. A Roma c’è il papa, – diceva Gioia girandosi verso il muro. Io buttavo giù le gambe, mi infilavo il cappotto sulla sottoveste e, la mamma il papà e i ragazzini dietro, eccitati che non riuscivano a stare fermi, scendevamo in cantina. Il trambusto e le voci coprivano il rombo lontano degli apparecchi e il crepitio della contraerea. Si intrecciavano discorsi, nascevano amicizie. I primi ad arrivare erano i “marocchini” del quarto piano: prendevano posto in un angolo e borbottavano fitto fitto nel loro dialetto isolano, le donne a testa bassa facendo scorrere fra le dita la coroncina del rosario. Poi entrava la famiglia Vetrillo al completo, levriere afgano compreso. Walter, il maggiore dei figli, bellissimo, con l’inseparabile fisarmonica in spalla e la madre altera come una regina fra gli appestati. Il gerarca del terzo piano scendeva con la maschera antigas. Poi arrivava la mia amica Marcella, vestita di tutto punto. I capelli di 103 un castano dorato ben pettinati alla paggio. Girava per i corridoi del rifugio studiando le volte solide e la quadratura dei locali. – Ci si potrebbe organizzare una recita, il palco lì, qui le sedie o le panche, – diceva sorridendo coi suoi denti da puledrina a un ipotetico pubblico, senza accorgersi di niente e di nessuno. Alla fine si sedeva con le gambe accavallate i piedi dentro scarpe troppo lunghe e troppo alte, la testa rovesciata all’indietro, quieta e silenziosa. Solo di tanto in tanto si rivolgeva alla madre che passeggiava e fumava nervosamente. Per ultima scendeva la moglie del capo caseggiato, discinta e debordante nella vestaglia a fiori. Si raccoglieva la pancia nelle braccia, facendosi posto fra gli altri e fino al cessato allarme chiacchierava ininterrottamente: riuscendo a tenere il filo con tutti. – Per carità, signora bella, copritelo, copritelo quel cittino. Un s’è nemmeno svegliato, poverino! E voi che ne dite, signor console, quando finirà codesto finimondo? O madonnina, o che dite? certo che la ci voleva, perbacco! E siamo tutti italiani, ci mancherebbe! ma s’era detto che la finiva presto presto! Nevvero signora Vetrillo? Di vostro marito avete notizie? Oh madonnina e che sarebbero codesti tonfi? Mia madre non parlava con nessuno. Si stringeva il cappotto sotto il mento, preoccupata che non si vedesse la biancheria logora e si teneva un panno davanti per nascondere la gravidanza che si portava appresso come una vergogna. Prima di scendere s’era ravviata i capelli, passato il piumino sulle guance. Sceglieva sempre l’angolo più buio e se qualcuno le rivolgeva la parola, rispondeva a monosillabi. La signora Vetrillo si informava della sua salute, di quanto tempo era, poi cambiava argomento. – C’è il mio Walter che s’allunga tanto. L’avete visto? Io sono disperata. Non so più cosa dargli. È tanto delicato di polmoni! Ma voi come fate, con tutti quei bambini. – Ci facciamo bastare quel po’ che ci danno con la tessera. Io i miei ragazzi li ho abituati ad accontentarsi. – E stanno tutti bene, Dio li benedica. – Chissà, forse c’è qualche santo che ci aiuta. Magari Maria è un po’ 104 troppo magra, anemica, non ce la fa a sviluppare. E Miro… Loro due non mi crescono tanto, ma nel complesso sono tranquilla. – Io invece sono tanto in pensiero. Non so più che inventare. – Avete provato col sorgo? – Il sorgo? Che cos’è? – È… Ecco, sono dei semini piccoli e scuri. Come quelli che si davano agli uccelletti… – Ma, come si prepara? – È semplice: si macinano i semi, anche col macinino del caffè va bene, e poi si cuociono come, diciamo come la polenta o il semolino. – Ma che sapore ha? E come si condisce? – Be’, certo se ce l’avete un goccio d’olio è meglio, altrimenti… Insomma, bisogna arrangiarsi. Pensate un po’, oggi ho preparato il castagnaccio senza un’unghia di zucchero, eppure me l’hanno mangiato tutto. Non ne è rimasta neanche una briciola. Per questa sera è andata e domani si vedrà. L’urlo delle sirene del cessato allarme metteva fine alla conversazione e risalivamo in casa, col sonno incollato alle palpebre. III 105 Mia madre aveva ragione. Non crescevo. Appena camminavo un po’ mi illanguidivo, mi girava la testa e mi toccava sedermi o addirittura stendermi sul letto. Le mie coetanee, le compagne di scuola, Marcella, erano già sviluppate come donne, io invece ero magra e piatta come una tavola. Mi sentivo diversa, infelice, tradita nel corpo, e molto sola. Gioia usciva dall’ufficio e andava con le amiche. Dopo la vetreria San Paolo, Miro aveva trovato lavoro in una cappelleria di via Nazionale: lavava, metteva in forma e stirava i feltri e la sera andava a scuola. Livio o disegnava o era in cortile a dare calci a una palletta di carta insieme ai suoi compagni. Avrei voluto fare qualcosa per aiutare la famiglia, ma non avevo le forze, ero sempre stanca. Mia madre mi guardava e sospirava: – Almeno ci avessi la salute tu, – diceva. – Tua sorella all’età tua era un fiore. Tu non cresci e non crepi… hai fatto una faccia gialla, povera cocca. Guardati, a quattordici anni suonati è come ne avessi dieci. Che ne faremo di te… Io inghiottivo amaro, nascondevo le lacrime. – L’hai preso il calcio stamattina? E oggi a pranzo? Non te ne scordare come al solito. E datti un po’ di vita, figlia mia, sembri tubercolosa! – Non è malata poverina, è solo denutrita, – interveniva mio padre. – È la fame. Se andiamo avanti di questo passo, moriremo tutti d’inedia. Intanto io mi struggevo e mi consumavo e la notte, quando nessuno poteva vedermi, affidavo a un quaderno i miei pensieri e i miei turbamenti segreti. La sola persona al mondo in grado di capire la mia sofferenza era la mia amica Marcella. Appena potevo, scappavo da lei, su al quinto piano, a farle leggere quello che avevo scritto. 106 – Basta! Io così non ci resisto più, – scoppiò un giorno mio padre. – E che vorresti fare? – Quello che fanno tanti. Come credi che viva la gente? – Non lo so! Ci avranno i soldi e noi non ce li abbiamo. Amen. – Amen un corno! Quello che ci vuole è un po’ d’iniziativa, di coraggio. Come si dice, chi pecora si fa… Non si può aspettare sempre la manna dal cielo, dal cielo giusto le bombe possono arrivare! Io sono stufo, voglio fare qualcosa. – Sì, ma che cosa? – Insomma. Tutti si arrangiano in un modo o nell’altro. C’è gente che si mette in tasca fior di quattrini. – Già. Guarda quei terroni morti di fame qui di fronte: si sono fatti d’oro. Un chilo di farina l’hanno messo centocinquanta lire, razza di ladri! – Lascia stare quella gentaccia, adesso. Stammi a sentire. – Veramente non ho ancora capito che cos’hai in testa. Che cosa vorresti fare, in sostanza? – Andare fuori, nei paesi, nelle campagne, a comprare un po’ di roba. Lì si trova ogni bendidio, farina, olio, fagioli, mentre noi stiamo qui a morire di fame. – E i soldi dove li prendi? – I soldi, i soldi… Non te ne incaricare, ci penso io. Li rimedio, trovo chi me li anticipa. Basta, ho deciso: audaces fortuna juvat… Io vado. – Ma dove vuoi andare? Mi sembri matto, mi sembri. Se non ci sono nemmeno i treni. È tutto fermo. – Chi ha parlato di treni? Si va coi mezzi di fortuna. Sono già d’accordo con uno che è pratico, che lo fa di mestiere. – Di mestiere? Vuoi dire un borsaro nero? Non ti sarai messo con quelli. Ma te lo immagini, con la fortuna che hai, ti arrestano prima che cominci. E col tuo passato… – E dagli col malaugurio. Lui non l’hanno mai beccato e sono due anni che fa su e giù. E poi, io mica voglio fare la borsa nera, speculare sulla povera gente, io ci andrei per necessità, per noi. Possibile che tu debba avere sempre questa benedetta paura? Non sono mica uno stupido, no? Fa’ il piacere, smettila di lamentarti e tira fuori una valigia, la più grossa che abbiamo. Domattina alle sei passano a prendermi. 107 Una sera lo sentimmo tornare, a buio fatto. Svoltato l’angolo cominciò a fischiare. Un fischio cauto ma insistente. Saltammo giù dalla finestra sulla strada e gli volammo incontro con le ali ai piedi e il cuore in gola. Era curvo sotto un valigione, carico di pacchi. – Eccomi qua. Visto? Ce l’ho fatta, ringraziando il padreterno. Sei contenta? – disse a mia madre. – Coraggio, apri, apri, guarda che grazia di Dio t’ho portato. Apri, apri. Noo! non così. Dài a me, faccio io. Mise da parte le forbici con cui mia madre si accingeva a tagliare le cordicelle dei pacchi e, con pazienza certosina, cominciò a sciogliere i nodi che aveva stretto con la stessa cura, a uno a uno. Poi attorcigliò lo spago tra pollice e indice, formando una matassina e disse di riporla, che poteva servire ancora, e che in una casa non bisogna mai buttare niente. Alla fine svolse la carta con gesti accurati e quasi amorosi, come stesse spogliando un neonato. Sistemata ogni cosa, si accasciò su una sedia con un gran sospiro. – Sapessi, Ernestina, quello che ho passato! Per poco non ci lasciavo la pelle… – Incosciente, – fece la mamma con voce commossa. – Un giorno o l’altro mi farai morire di crepacuore. Togliti le scarpe. Vieni a letto. Chissà come sarai stanco. IV 108 Erano passati due anni ma sembrava un secolo dall’ingresso nella casa nuova coi finestroni aperti sulla strada da una parte, che con un salto eri fuori, e sul cortile dall’altra, con le aiole e la ghiaia bianca. Una mattina chiara di mezza estate nacque Paola. L’ambulanza venne a prendersi mia madre in fin di vita e mio padre era corso dietro di lei, pallido e affaccendato. Noi restammo sbigottiti con quel fagottello fra le braccia nella casa silenziosa e disfatta, col grosso letto chiazzato di sangue e l’eco delle grida che ci avevano strappato al sonno. La piccola Paola fu affidata a una balia che se l’attaccò al petto e se la portò via. L’ospedale di San Giovanni non era molto lontano ma i tram scarseggiavano o erano troppo affollati, così per recarci a trovare la mamma ogni mattina, col fagotto della biancheria pulita e il pentolino del brodo, Gioia e io preferivamo andare a piedi. Un giorno fummo sorprese in strada dall’urlo delle sirene. Ci guardammo attorno, ma in quello stradone lungo e antico non vedemmo nessun riparo possibile. – Andiamo, andiamo. Sarà un falso allarme, come sempre, – disse Gioia noncurante. – Tanto non bombardano. A Roma c’è il papa, lo sai. Diceva sempre così lei e anche quando c’era l’allarme di notte, al rifugio non ci veniva, preferiva restare a letto a dormire. Io invece mi sentivo le gambe molli e mi fermai a guardare il cielo quasi bianco. – Muoviti, che mamma starà in pensiero. – E se vengono? – Ma va’, fifona! – Hai sentito? Queste sono bombe! Sono bombe! Mi misi a correre senza aspettarla. I piedi mi facevano male, in- 109 ciampai, mi distorsi una caviglia ma continuai su quella maledetta strada che non finiva mai. Il rombo era assordante e sempre più vicino. Pareva di averli sul capo. Gioia correva anche lei, adesso, e quando mi ebbe raggiunta mi prese per mano e mi teneva salda. Stava zitta e la sentivo ansimare. I boati si susseguivano sempre più ravvicinati e regolari, ma il rombo s’era un po’ allontanato. Ci fermammo addossate a un portone a riprendere fiato, a guardare il cielo. Mi sembrava di essere morta e che non avrei potuto mai più muovermi da lì, ma Gioia mi diede uno strattone e riprendemmo la corsa. Mia madre ci aspettava bianca e tremante. – Maria! Gioia! Non dovevate venire! È il finimondo, il finimondo. Che ne sarà delle creature sole in casa? Poveri noi, poveri noi… Una monachella si precipitò in corsia strillando, agitando le ali della cuffia. – È San Lorenzo, San Lorenzo! Venite a vedere! Guardate! Maria santissima abbi pietà di noi peccatori! Verso nord-est, in direzione del Verano, si levava una colonna di fumo e un polverone che faceva opaca e grigia l’aria. Dopo un’eternità – si seppe più tardi che l’incursione era durata tre ore – la sirena lugubre annunciò la fine, ma quel rombo cupo ci rimase nelle orecchie. La monachella ora s’era chetata: piangeva e pregava sommessa. Tutt’attorno regnava un gran caos: i malati strillavano, qualcuno voleva buttarsi giù dal letto, infermiere e portantini non riuscivano a tenerli a bada e urlavano, imprecavano a loro volta. Noi tre ci guardavamo immobili e ammutolite. Nel pentolino era rimasto un fondo di brodo rassegato. Gioia non volle staccarsi dalla mamma e restò in ospedale. Tornai a casa da sola. Preparai la cena e aspettai il ritorno di papà. Quando rincasò, molto tardi, era svogliato e nervoso. Volevo raccontargli di quella mattina, ma lui chiese notizie della mamma, sospirò, si tolse la giacca, la camicia sudata sotto le ascelle, i pantaloni, si infilò i calzoni del pigiama sulla canottiera e poi, riposto tutto con la solita cura, se ne andò in camera, senza mangiare. Sentii la porta cigolare, come tutte le sere, e me ne andai a letto. Sapevo che non avrei dormito. Avrei potuto tenere la luce accesa e leggere, oppure scrivere sul mio quadernino segreto, ma non ci sarei riuscita. Non quella sera. Con le braccia nude sul fresco del davanzale, guardai il cielo fitto di stelle. Solo qualche notte prima, Gioia e io le avevamo guardate insieme. La sua mancanza mi faceva male. Se fosse stata lì ci saremmo abbracciate, forse avremmo pianto insieme, in silenzio, o forse avremmo commentato quella terribile giornata. Invece ero sola. Nessuno poteva ascoltarmi, nessuno voleva parlare del bombardamento e presto la notte fu inghiottita dal sonno. 110 Mia madre tornò a casa dopo circa una settimana. La sera della domenica facemmo una piccola festa per lei e andammo a letto molto tardi. Ci eravamo appena addormentati quando ci svegliò uno straordinario clamore. Gioia e io ci vestimmo in qualche modo e corremmo nella stanza dei grandi. Mio padre era già in piedi, mezzo svestito, davanti alla finestra spalancata. Grida, canti, scampanii salivano dalla strada trasformata in fiume. Tutte le finestre intorno erano illuminate. L’aria era calda e serena. Sembrava la notte di san Giovanni. – Che succede? – gridò mio padre alla folla. – È finita! È finita! – La guerra! È finita la guerra? – Oh, mio Dio! – bisbigliò Gioia, aggrappandosi al davanzale. – È finita la guerra? – domandò ancora mio padre, incredulo. Il fiume ingrossava sotto la finestra, rombava. – Che succede? – Hanno preso Mussolini. – Preso! Come preso? Chi! Chi! Che significa? – Il duce, Mussolini, non c’è più! Non comanda più! – A morte il duce! – Corriamo! Andiamo! – Dove si va? – A piazza Venezia! – A piazza Venezia? A che fare? Lì non c’è più nessuno: sono scappati tutti. 111 – Te lo dico io dove si va. Una soddisfazione dopo vent’anni, me la devo prendere, no? Seguitemi! Gioia e io ci abbracciammo con le lacrime agli occhi. Anche per strada s’abbracciavano, si chiamavano forte per nome, da una finestra all’altra, si tenevano per mano, ridevano, piangevano, ballavano. Non avevo mai visto tanta folla così esultante e scomposta. L’eco degli spari che giungeva da lontano aveva un suono festoso, metteva allegria nel cuore. Il cielo era chiaro come di giorno. Mi vennero in mente le adunate da bambina sotto il balcone del duce. Le grandi folle inneggianti. Non era la stessa cosa. Era diverso anche dalle feste della Madonna. In quell’occasione le vie del quartiere si illuminavano di lampadine colorate, venivano le giostre in piazza, la gente stava tutta fuori, alle osterie, a bere, a mangiare ciambelle fino a notte tarda, i balconi e le finestre si ornavano di fiori e di drappi sgargianti, dovunque si accendeva il nome di Maria e la notte composti, impettiti, vestiti a nuovo, le mogli sottobraccio ai mariti, i ragazzini col cono gelato o il bastone dello zucchero filato, tutti col naso in su a guardare i fuochi d’artificio. Mio padre tirò fuori dal nascondiglio la pistola scacciacani e sparava botti verso il cielo acceso di riverberi. Gioia e io non avendo trovato niente di meglio agitavamo una gonnella rossa. Tante bandiere uscite da chissà dove sventolavano alte sulle teste, c’era chi brandiva bastoni con aria minacciosa e festosa insieme; un uomo in canottiera si trascinava dietro un grande ritratto del duce con l’elmetto e la mascella dura. Proprio sotto di noi si fermò, appoggiò il ritratto al muro, si sbottonò la patta e diresse il getto. Scoppiò una grande risata e qualcuno lo imitò. Le donne sputavano, tiravano calci finché il vetro andò in frantumi. Dalle finestre piovevano camicie nere, distintivi, busti di gesso, fotografie, libri. Era come la notte di Capodanno, quando si getta via la roba che non serve più. Quelli armati di bastoni picchiavano sui muri, sui lampioni, dovunque figurasse una scritta o un emblema del regime. La folla ingrossava, straripava, sempre più rabbiosa, scarmigliata, sporca, brutta, patita, arrabbiata, urlante e felice. 112 – Alla Villetta! Alla Villetta! Al Fascio! A quell’urlo, ci fu un istante di esitazione, poi la corsa riprese. Alla palazzina rossa i primi arrivati entrarono scavalcando il cancello o il recinto. Calpestando le aiole attraversarono il giardino e salirono la ripida scaletta. Le porte erano aperte e dentro non c’era nessuno. Dalle finestre cominciarono a piovere tavolini, lampadari, sedie, quadri, libri, registri, cartelle. La gente sotto salutava quel bombardamento con strepiti di gioia. Poi un uomo scuro e quadrato, s’affacciò, gridò qualcosa, agitando una bandiera fece un gran gesto con le braccia, come per chiedere silenzio. – Lo conosco, – disse qualcuno. – È Spartaco del terzo lotto. S’è fatto dieci anni. Stiamolo a sentire. Lasciamolo parlare… Ma nessuno gli diede retta. Poco più in là, nella piazza davanti alla scuola, le donne avevano acceso un enorme falò e si misero in cerchio a ballarci attorno. Ai ragazzini non pareva vero di partecipare a quel diavoleto, di poter urlare, picchiarsi, tirare bastonate dove capitava. I canti e la confusione durarono tutta la notte. Dopo il falò noi volevamo tornare a casa, a letto, ma papà sembrava esaltato, si faceva largo tra la gente, cercava di attirare l’attenzione. Aveva voglia di parlare, di spiegare che lui l’aveva sempre detto, di raccontare quello che i fascisti gli avevano fatto subire, a lui e alla sua famiglia, eccole, qui c’erano due figlie e potevano dirlo anche loro, così come a tanti altri galantuomini che stavano in galera e bisognava andare a liberarli, ma ora finalmente il popolo avrebbe avuto la sua rivincita e quando il popolo si desta Dio si mette alla sua testa, bisognava fare piazza pulita, prima di tutto dello straniero e poi degli assassini della libertà, dei buffoni, degli approfittatori e di tutta la genia di mangiapane a uffo, questa è la volta buona e occorre darci dentro, rendere giustizia ai perseguitati, alle vittime del regime. Dovranno pagare, perdìo. Ma dov’erano? Dove s’erano intanati, i vigliacchi? Perché non venivano fuori adesso? Ma la gente non poteva star ferma. Non voleva ascoltare niente e nessuno. Voleva solo urlare, festeggiare, fare qualcosa, sentirsi libera. V 113 Ma la guerra non finì. Certo, le cose ora sarebbero precipitate. Questo governo Badoglio non durerà, è una soluzione provvisoria, in attesa che il popolo faccia la sua scelta di democrazia, di socialismo. Questo diceva mio padre deluso, ricordando l’esaltazione di quella notte. Intanto la vita riprese come e peggio di prima: paura, privazioni, fame, file estenuanti, e la sera, a letto, la voglia di piangere. – Quando finirà? – Papà ha detto… – Oh, papà dice tante cose. – Però col fascismo aveva ragione. Il duce non c’è più. – Sì. Ma questa maledetta guerra non finirà mai, – sospirava Gioia dopo un lungo silenzio. – Mai. Io non ce la faccio più. – Nemmeno io. – Troppi anni… Lo sai? io quasi non me lo ricordo com’era prima. La vita, la scuola, il cinema, il Natale, le vacanze… – Già. Io non ricordo il sapore del pane. – Mamma ci rimproverava perché non ne mangiavamo abbastanza. – E papà diceva il pane lo mangiano i ghiotti. Te la ricordi quella poesia sul libro di terza, quella che aveva scritto il duce? Onora il pane… – Sudore della fronte… – Fragranza della mensa… – Gioia del focolare… – Ma secondo te, che fine ha fatto? Sarà morto? – Chi, il duce? Io dico di no. Io dico che sarà nascosto, magari in Germania, dai suoi amici nazisti. 114 – Ah…. Io me lo sogno sempre. – Il duce? – No! il pane. Croccante, appena uscito dal forno. Ne compravi quanto ne volevi, e come aggiunta, ti mettevano nella busta un pezzo di pizza calda. L’estate era buona coi fichi. – I fichi! Ti ricordi quella volta a Cutro, che scorpacciata! E che mal di pancia dopo! nell’orto di don… come si chiamava?… Mi sembra così lontano… – Sì, il tempo passa e intanto gli anni più belli se ne vanno e non li riavremo più. – Tu cosa vuoi fare da grande? – L’attrice. – Come Alida Valli? – No, non al cinema, in teatro. – Ah. Anche Marcella vuole diventare un’attrice di teatro. Sua madre scrive le commedie. Tu a teatro ci sei mai stata? – No. – Quando finisce la guerra ci andiamo insieme una volta? Mettiamo i soldi da parte e non lo diciamo a nessuno… – Cicale! La volete smettere? – faceva la voce di papà dietro la porta. – Poi la mattina ci vuole il cannone per buttarvi giù dal letto. Dormite, su, è quasi l’una. – Buonanotte papà, – dicevamo noi due in coro. – Buonanotte, buonanotte, – borbottava lui, allontanandosi. – Notte, Gioia. – Notte, Marì. Ci addormentavamo così, deluse, infelici. Passavano i giorni, le settimane e non accadeva nulla. Tutto era come prima. Verso la metà d’agosto c’era stata un’altra incursione. Questa volta così vicina che lo spostamento d’aria aveva fracassato i vetri del palazzo di fronte e uno spezzone aveva ucciso un bambino nel prato oltre le case. Venne Livio di corsa, tutto sudato, pallido e tremante. Quel ragazzino stava giocando con lui. Si rinchiuse nella sua stanza a piangere, seduto in un angolo, per terra. Fu lì che lo trovai dopo diverse ore, addormentato, con la testa sulle ginocchia. – Vieni, è finito. Saliamo in terrazza a vedere. Lassù faceva molto caldo. Il cielo aveva un colore strano, opaco, e in lontananza, davanti a noi, si alzava una nuvola spessa e nera. Era già pieno di inquilini: Marcella con la madre, Walter e suo fratello Piero, la siciliana col rosario, i “marocchini” taciturni, il ragioniere, il compositore di canzoni, la mia maestra di latino. Parlavano tutti insieme: quante ore era durato, il calibro delle bombe, il numero delle vittime. – Ci pensate se avessero colpito il gazometro? – Che giorno è oggi? – chiese qualcuno. – Venerdì. Venerdì tredici. – Un numero disgraziato, – borbottò la siciliana giovane, facendosi il segno della croce. – Tredici agosto millenovecentoquarantatré: Roma ha subito il secondo bombardamento aereo delle Fortezze Volanti… – declamò la madre di Marcella. – Tredici! Oh, scusa. M’ero completamente dimenticata di farti gli auguri. – Tanto se lo sono scordato tutti, il mio compleanno, – disse Livio con amarezza. – Ormai, che senso ha? E poi con quello che è successo! – Che giornata! Non la dimenticherò mai. Se non fossi scappato in tempo, ci restavo anch’io… Povero Luigino. Gliel’avevo detto, andiamo via, corri, ma lui è voluto tornare a riprendersi il pallone… – Scoppiò a piangere di nuovo. – Non pensarci più, non piangere. È la guerra. Vieni, scendiamo. Quassù non si respira. 115 La mattina del quindici papà tornò all’ora di pranzo con un enorme cocomero sotto il braccio. – Ecco qua, è ferragosto anche per noi, – disse mettendolo in fresco nel lavabo. 116 A tavola si alzò in piedi e lo tagliò in tante fettine sottili, solennemente, parlando di calotte, di meridiani e di emisferi mentre noi, ansiosi, allungavamo le mani. – Adagio! Adagio, maleducati! Aspettate che vi serva io. – Volevo solo prendere dei semi. – Niente, non si tocca. Alla fine avrete anche quelli, un po’ per uno. – Sta’ a vedere che sono razionati pure i semi di cocomero, adesso! – Tu è meglio che stai zitto, se no non avrai proprio niente. – Buoni, buoni che ve lo fate diventare veleno, – intervenne la mamma a mettere pace. In realtà non ce n’era bisogno, perché eravamo tutti allegri e papà cominciò a raccontare di quando era bambino e quel giorno in casa si ammazzavano non meno di otto polli. La sera prima si sentivano strillare le povere bestiole inseguite. Dopo averle sgozzate e spennate le appendevano fuori della finestra, all’addiaccio tutta la notte, per intenerirle. E poi le scorpacciate di gnocchi, le gare a chi ne mangiava di più: una volta uno ne aveva contate centoquaranta coppie. La mamma non volle essere da meno e si mise a vantare le fettuccine delle sue parti. – Come le faceva zia Assuntina non le sa fare nessuno: trasparenti e non una che si spezzi, servite calde nello scifo di legno, col sugo di porcini. E pensare che si viveva in quella grascia senza apprezzarla! Averla adesso! E noi ad ascoltare a occhi spalancati quei racconti meravigliosi, a fare domande schiacciando i semi neri tra gli incisivi. Sul tavolo nudo restarono le scorze rosicchiate fino al verde e la notte ci venne il mal di pancia. Fu un continuo viavai per il corridoio. Papà si torceva per il dolore allo stomaco e maledì quell’accidente di cocomero. VI 117 Approfittando dell’assenza di mio padre, partito di nuovo alla ricerca di viveri, la mamma decise di andare a trovare la nonna e di portare con sé i due più piccoli, Giorgio e Nino. Iniziava settembre e le serate erano dolci. Io stavo fuori fino a tardi a passeggiare in cortile con Marcella. Guardavamo la luna, interrompendo raramente i fitti silenzi che ci univano. I segreti ci rendevano sempre più complici. Lo zio di Marcella aveva disertato l’esercito e si era unito ai partigiani sull’Appennino toscano. Io ascoltavo rapita le sue confidenze e un po’ la invidiavo: mio zio invece era sperduto in chissà quale fronte, forse in Russia. L’unica cosa che non riuscivo a conciliare era il fatto che Marcella e sua madre ogni domenica andassero in chiesa. Com’era possibile essere contro i tedeschi, i fascisti, combattere per la libertà e non odiare anche i preti? Marcella disse che quelli erano brutti discorsi da comunisti e che i comunisti erano peggio dei fascisti. Una cosa che mi offese, mi addolorò profondamente, mi riempì di dubbi e di pensieri e decisi di parlarne in seguito con mio padre. Per qualche giorno non la cercai e se ci incontravamo non le rivolgevo la parola. Una mattina fummo svegliati da un rumore sordo, martellante, quasi ininterrotto, spezzato da scoppi isolati e da scrosci di fucileria, in nulla simile al rombare degli apparecchi e al crepitio della contraerea, ma altrettanto inquietante. I miei fratelli scesero subito in cortile e Gioia cominciò a strillare che tornassero indietro, che chissà cosa stava succedendo ancora. La cosa migliore da fare era raggiungere la mamma, che di certo stava in ansia per noi. Arrivò Marcella, trafelata. – Vieni, corri, dalle mie finestre si vede tutto: c’è la guerra a San Paolo, alla Piramide… 118 – La guerra? Allora sono arrivati gli americani. – Ma no, stupida. Gli italiani contro i tedeschi. I nazisti sono in fuga. E anche Badoglio, e il re, tutti scappati… Mussolini è morto e i tedeschi se ne vanno. Non hai ascoltato la radio ieri sera? E stanotte, non hai sentito il cannone? Presto, vieni a casa mia. Da lì si vede bene, come un film. In realtà non si vedeva quasi nulla, a parte delle nuvolette di polvere e a tratti un bagliore rossastro seguito da uno scoppio, ma lontano, si sarebbe detto, oltre la basilica, verso la Montagnola. La signora Ruffo andava e veniva agitatissima, parlava, declamava, abbracciava freneticamente Marcella, continuando a ripetere: – Ci siamo, ci siamo. Quando scendemmo per la spesa le strade erano vuote, i negozi chiusi, il mercato deserto, i tram non passavano. – Dove andate, è pericoloso girare, c’è la guerra, – ci disse qualcuno. Ma noi dovevamo andare al Testaccio, dalla nonna. Nostra madre a quell’ora doveva essere in preda al panico pensandoci soli in casa e in pericolo. Passavano le ore e non sapevamo deciderci. Arrivavano notizie frammentarie, contraddittorie, confuse. Chi diceva la Montagnola, chi San Paolo, la Piramide e noi bisognava andare proprio in quella direzione. La notte suonò l’allarme e il tuono dei cannoni riprese più forte, spaventandoci e togliendoci il sonno. La mattina dopo sembrava tornata la calma e Gioia disse che dovevamo approfittarne per muoverci. Ma all’ora del pranzo ci fu di nuovo l’allarme e dovemmo rimandare ancora. Nel pomeriggio finalmente ci incamminammo, i due maschi davanti, Gioia e io dietro, a braccetto, chiacchierando svagate. Il cielo s’era annuvolato e l’aria era afosa e greve. I cannoni avevano ripreso la loro musica, ma non facevano più paura: ormai quel rombo sordo e regolare era diventato familiare, ci faceva compagnia nel lungo cammino. Incrociammo per via qualche militare dall’aria smarrita, furtiva, i panni laceri, in disordine, senz’armi. Li vedemmo correre e sparire verso le case di San Saba. Quando arrivammo in vista della Piramide era quasi buio. 119 – Presto ragazzi, affrettiamo il passo! – disse Gioia. – Cerchiamo di farcela prima di notte. – Io sono stanco, ho paura… – Oh! Guardate! Venite a vedere! – gridò Livio che era corso avanti. Di fronte al palazzo bianco delle poste e telegrafi, da una grossa sagoma scura si sprigionava un fumo rossastro, di fuoco appena morto. – Che cos’è? – Un Tigre. Un carro armato tedesco, non lo vedi? – Tornate qui voi due! Miro! Livio! Loro non ci diedero ascolto. Correvano eccitati verso quel rogo languente. Più in là ce n’era un altro, ma più piccolo, non sembrava un carro armato. Da lontano giungevano ancora scoppi isolati. Livio tornò indietro. – Avete visto? Bene! ‘tacci loro! Gioia gli rifilò un ceffone. – Se ti sentisse papà parlare in questo modo! – Papà è contento quando lo sa… – Ma che sarà successo? – Secondo me i nazi se la so’ filata. – Ehi, qui ci sta un morto! Era un soldato con una grossa ferita in fronte e una pozza di sangue sotto la testa. Calmo che pareva dormisse. – Ti sta bene, boia nazista! Tiè! – fece ancora Livio con un gesto sconcio. Gioia lo tirò per un braccio e gli mollò un altro ceffone. Proseguimmo in silenzio. Morti ce n’erano altri per via Marmorata, ma non ci fermammo, anzi volgemmo lo sguardo e affrettammo il passo, turbati. A uno, sull’angolo di via Galvani, gli avevano steso addosso un lenzuolo. – Mamma! mamma! Lo sai che abbiamo visto i morti a via Marmorata? – disse Miro, tutto d’un fiato. – Quattro tedeschi. – Ma che quattro, scemo! Erano cinque! Quello vicino al Tigre non ce lo conti? – Zitti, zitti, per carità, non parlate di queste brutte cose. Dimenticate ciò che avete visto. Grazie a Dio siete qui. Stavo morendo di pena. – Povere creature mie, – chiocciò la nonna abbracciandoci. – Adesso come si fa? Due donne sole, con sei ragazzini, senza un uomo in casa. Dio solo lo sa dove sarà finito quell’acchiappanuvole di tuo marito. La mattina dopo, molto presto, uscii con la nonna per fare la spesa. Fuori era nuvolo e già caldo. I negozi erano ancora chiusi. Dei militari tedeschi armati di tutto punto avanzavano in mezzo alla strada guardando le finestre. Un carretto carico di materassi arrotolati, tavolini, sedie, fagotti e ragazzini arrancava a fatica, seguito da un gruppetto di povera gente dall’aria sperduta e gli occhi di chi non ha dormito o ha pianto tutte le sue lacrime. Aspettammo che il fornaio tirasse su le saracinesche unendoci alla piccola folla che già s’era formata in silenzio. Due militari ci sorvegliavano col mitra puntato e la faccia cattiva. Mi appoggiai al braccio della nonna, ma mi accorsi che anche lei stava tremando. Ci fermammo con le spalle al muro, per riprendere animo, ma i due ci fecero un gesto col mitra, come a dire di muoverci in fretta. Dalle finestre faceva capolino qualche faccia impaurita. Un vecchio tutto bianco spalancò le persiane, si sporse dal davanzale, prese la mira e scaracchiò rumorosamente. 120 Del suo ultimo viaggio mio padre non volle mai parlare. Tornò con le braccia vuote. Lacero, sporco, sfinito, la barba lunga, gli occhi stralunati, scosso da una specie di singhiozzo convulso, un pianto senza lacrime. La mamma lo aveva messo a letto con un febbrone da cavallo, senza fargli domande. Solo molto tempo dopo riuscimmo a strappargli che al ritorno, carico di roba, era salito su un camion tedesco e che a un certo punto erano stati mitragliati. Aveva fatto appena in tempo a buttarsi giù per una scarpata, prima che il camion saltasse in aria insieme al soldato – un ragazzino biondo e gentile – che lo aveva fatto salire. Lui se l’era cavata con una caviglia distorta e qualche contusio- 121 ne. Dopo una notte all’addiaccio, senza neppure un albero per copertura, un contadino l’aveva trovato e se l’era portato in casa, dove era rimasto un paio di giorni, prima di rimettersi in cammino, a piedi, verso Roma. Si alzò dopo una decina di giorni, ma continuava ad avere un colorito che faceva spavento e un po’ di febbre al pomeriggio che gli toglieva le forze e gli impediva di uscire. Per non stare in ozio, si costruì un deschetto da ciabattino, si procurò qualche arnese e passava le ore con un grembiulaccio davanti a rappezzare suole e tomaie con le bullette tra le labbra e il martello che andava su e giù, che pareva ci sfogasse tutta la frustrazione e la rabbia che aveva in corpo. Quello che più lo rodeva era il pensiero di tutto il bendidio andato in fumo. Non ci si poteva rassegnare. Ricordava ogni cosa: tanti chili di farina, tanti di fagioli, due lattine d’olio, un prosciutto intero che avrebbe fatto resuscitare i morti, e poi lardo, formaggio, zucchero, sale… – Ringrazia Dio che non ci hai rimesso la pelle e non pensarci più. A che serve angustiarsi, piangere sul latte versato? Pensa alla salute, piuttosto, – sospirava la mamma. – Sei ridotto in uno stato… VII 122 La salute di mio padre aveva subito un grave colpo. Come sempre, era all’inizio dell’inverno che il suo male si acuiva. Ora, come nei momenti peggiori, rimaneva a casa tutto il giorno, scontento, neghittoso. Il medico, come già lo specialista di Crotone, disse che doveva operarsi prima che fosse troppo tardi, o almeno sottoporsi a una cura molto seria. In casa, denutriti e senza riscaldamento, senza luce, senza gas, la vita era sempre più grama. Le razioni erano state ulteriormente ridotte e al mercato non si trovava più nulla. I tedeschi requisivano tutto. La sera, nel lucore giallo di una candela consumavamo senza lamentarci un piatto di crusca senza sale o un pugno di castagne secche che sapevano di muffa. Raramente, quando c’era l’energia elettrica, ascoltavamo radio Londra, ma da quei messaggi sibillini non riuscivamo a trarre nessun motivo di speranza. Tranne mio padre. – Sono vicini, me lo sento, – concludeva ogni volta. – Stanno arrivando. Al massimo a Natale saranno qui e saremo liberi. Invece la situazione peggiorava. Un giorno sentivi dire che i tedeschi avevano portato via tutti gli ebrei, un altro che rastrellavano le strade, prendevano gli uomini, giovani o meno giovani, per mandarli in Germania, e non passava notte senza echi di sparatorie, scariche di mitra, rombi lontani di aerei. Una mattina arrivò Livio affannato. – Papà, papà, i tedeschi! Hanno circondato il lotto! La mamma si precipitò a sprangare le finestre sulla strada. Dalle fessure delle persiane vedemmo sfrecciare le moto e ci si gelò il sangue. – Scappa! Nasconditi! – strillò mia madre. Ma papà non si mosse. Era pallido come un cencio. – Oddìomio, le armi! 123 – Che armi? – La pistola! Miro prese la scacciacani da un cassetto del comò e corse in cantina a nasconderla. Restammo tesi e ammutoliti ad aspettare un rumore, una voce, ma sembravano tutti morti. Intorno, sopra di noi, in cortile, in strada, non si muoveva foglia. Non ricordo quanto tempo passò in quell’attesa. Nulla accadde. Nessuno venne. Non da noi. Se ne andarono e non si capì cosa o chi cercassero. Si seppe molto tempo dopo che erano venuti per una famiglia di artisti ebrei, musicisti, pittori, che abitavano alla scala A, e grazie a Dio non avevano trovato anima viva. Ma alla mamma non glielo toglieva nessuno dalla testa che erano lì per papà. Lui invece, passato lo spavento, ricominciò come prima a picchiare il martello e a fare discorsi campati in aria. – Zitto, per carità, non farti sentire, – si disperava la mamma. – Da chi, dai muri? – Anche i muri hanno le orecchie... sei il solito incosciente. Tu non ci metteresti nulla a parlare così con chiunque. Siamo circondati da spie… – Aaah! Ci risiamo! Tu leggi troppi romanzi. In realtà i romanzi facevano parte del passato di mia madre. Ora la sua vita era scandita dalla paura, dall’attesa. Appena buio incollava la faccia ai vetri a spiare il ritorno di papà o di Miro o di Gioia, che col nuovo lavoro qualche volta faceva tardi e arrivava dopo il coprifuoco. Quando tornava, stanca, col viso lungo, il cappotto vecchio di tre anni che le cascava da tutti i lati, le calze piene di smagliature nelle scarpe bucate, non salutava nessuno, si buttava sul letto senza spogliarsi e non veniva neppure a tavola. – Su, bella di mamma, vieni a mangiare un boccone. Lei non rispondeva. Alzava le spalle. – Che hai? Non sei più tu. Cosa t’è successo? Dillo a mamma tua, non farmi stare in pena. – Non ho niente! Sono stanca. Avrò diritto di essere stanca? – Hai ragione, cocca mia. E chi non è stanco morto? Prendi me, mi lamento io? Eppure: la casa è grande e con sei di voi, sette con vostro 124 padre che sta male e mi dà più da fare di tutti messi insieme… Sapessi che divertimento accendere il fuoco con la legna, fare a meno dell’acqua, della luce, del gas… Ma a che serve lamentarsi? Con chi te la vuoi prendere, figlia mia? Sono tempi neri. Passerà, tornerà la vita normale, vedrai. Bisogna portare pazienza. – Ma io non ne posso più. Vorrei buttarmi a fiume vorrei. – Eh, eh, che paroloni! Su, vieni a mangiare, sei tanto sciupata. Non me lo vuoi dire che cos’hai? Eh? – Uffa mamma! Se lo vuoi proprio sapere, mi vergogno. Ecco. Mi vergogno di andare in giro come una pezzente. Nessuna è come me. Eppure lavoro, no? Avrei diritto a qualcosa. Guarda le mie calze, le mie scarpe… Scusami, io queste cose non te le volevo dire, ma tu sempre a insistere, a stuzzicarmi, a provocarmi. Io desidero solo starmene in pace. Non chiedo altro. – Hai ragione, ti capisco. Però ora vieni a mangiare. Siamo tutti a tavola. Diventa freddo. – Non ho fame. Vai tu. – Oh, sai che ti dico? Arrangiati. Il male lo fai a te. Guardati allo specchio quanto sei carina: pelle e ossa. – Cosa succede di là? – urlava mio padre dalla cucina. – Chi se ne va da una parte chi dall’altra! Volete venire a mangiare, voi due? – La signorina dice che non ha fame. – E tu lasciala stare. Uccello che non becca ha già beccato. – Ma sta’ zitto, tu e i tuoi proverbi! Non hai mai capito niente! Sei buono solo a parlare! Con questo, mia madre crollò a sedere in punta alla sedia, tirò via il piatto mezzo vuoto, posò la testa sulle braccia, le braccia sul tavolo e cominciò a tirare su col naso. – Peggio delle bestie siamo ridotti! Dio, come siamo disgraziati, – si commiserava. – Falla finita con queste tragedie! Se le cose vanno così, con chi te la vuoi prendere, con me? E tu smettila, animale! Livio posò il piatto che stava leccando. Aveva approfittato della confusione per divorare il resto della zuppa di mamma. 125 – La verità è che gliele dài tutte vinte, – riprese mio padre, – l’hai sempre viziata, quella figlia, è sempre stata la preferita, da quando era piccola. Questi sono i risultati. Cosa vuoi aspettarti dai figli! – Ma piantala, che ne sai tu! Quando mai ti sei occupato dei figli, tu! Ha diciott’anni! Porta i soldi a casa e nemmeno un paio di calze si può comprare. Si vergogna, poverina, e ha ragione. Come una pezzente va in giro. – Alzò la testa e lo sfidò con lo sguardo. – E la colpa è tutta tua se siamo ridotti così, ricordatelo. Sei tu, con la tua incoscienza, con le tue chiacchiere, le tue idee pazze che ci hai portati alla rovina. – Ecco, ci risiamo. Lo so che ce l’hai con me. Ogni scusa è buona per rinfacciarmi le disgrazie, – sbottò mio padre. – Idee pazze, dice… I fatti mi danno mille volte ragione e lei dice idee pazze. – Abbassò gli occhi e parlava col mento sul piatto, senza smettere di mangiare. – La signorina fa i capricci, non ha fame? colpa mia! Soffre, poverina? tutti a piangere per lei! E io allora che dovrei dire? Ma già, in questa casa il padre conta quanto il due di picche. Qualcuno si interessa di me se sto male, se campo o se crepo? – Si pulì la bocca col tovagliolo, tirò fuori dalla tasca una vecchia scatolina delle pastiglie del Re sole dove riponeva le cicche, ritagliò con le mani una strisciolina dal margine del giornale, vi sbriciolò un mozzicone e si mise ad arrotolarla con cura come una sigaretta, poi ne inumidì un lembo con la lingua, la tastò, la pareggiò alle estremità e l’accese. Dopo aver tirato due boccate, raccattò il giornale, si alzò e andò al gabinetto. Mia madre stava immobile, zitta, senza piangere. – Posso mangiare la minestra di Gioia? – chiese Livio intimidito. Sentii mio padre andare in camera, la porta richiudersi delicatamente dietro di lui, e tirai un sospiro. Scene così non accadevano da tanto tempo. Di solito mamma e papà passavano ore quasi ignorandosi. Il loro silenzio pesava su noi che non eravamo capaci di romperlo. Finito di rigovernare, me ne andai nello stanzino vuoto e mi misi alla finestra a guardare fuori. Mi piaceva stare sola, a pensare, a covare la tristezza, a compiangermi e soffrire per poi registrare tutto sul mio quadernino e farlo leggere a Marcella per provare la gioia di 126 essere compresa. Dopo un po’ venne Livio e si mise anche lui con la faccia ai vetri. Fuori il cortile era desolato. La gente aveva da tempo divelto le staccionate di legno, scosciato ad uno ad uno i rami degli alberi nelle aiole devastate. Dietro le persiane chiuse contro il vento gelido di tramontana, non c’era nessuno. – Visto quegli alberi, laggiù? – È il vento. – Quest’anno l’inverno non vuole finire. – Fra poco gennaio è andato, febbraio è corto, fa presto a passare. – Sì. Restammo a guardare in silenzio i due scheletri piegati dal vento finché non divennero un’unica macchia scura contro il cielo senza colore. VIII 127 Ai primi caldi Marcella e io salivamo in terrazza e stendevamo le gambe nude al sole per farle abbronzare. Lei si tirava su il vestito fino alle mutandine, poi cominciava a specchiarsi, a lisciarsi i capelli, a provare nuove pettinature, o si curava le unghie lunghe e rosate. Intanto parlava. I suoi argomenti preferiti restavano il teatro e lo zio partigiano. Era sempre molto informata, sapeva tutto quello che accadeva a Roma: centinaia di uomini portati via, incarcerati, torturati, fucilati… – L’hai saputo di Balelli? – Balelli chi? – Quello della scala D, il papà di Gaspare. L’hanno preso l’altra notte. È a via Tasso. – Via Tasso? – Sì, via Tasso, dove c’è la Gestapo, vicino a San Giovanni. – Abbassò la voce. – Pare che di lì non si esca vivi. La mamma dice che è peggio dell’inquisizione spagnola. Se zio Nicola dovessero prenderlo, – aggiunse dopo essersi spalmata le gambe di olio di cocco, – per me sarebbe meglio che si uccidesse, piuttosto che cadere vivo nelle mani degli aguzzini. Dio mio, non posso pensarci: mi vengono i brividi. Lo tortureranno sicuramente. – Chi, tuo zio? – Ma no. Balelli, quello della scala D, il papà di Gaspare. – Ma tu come l’hai saputo? – Ho sentito la mamma che lo diceva a papà, oggi a colazione. La mia mamma sa tutto. Scriverà un libro sulla guerra, su Mussolini, Hitler e tutte queste cose che succedono. L’aria in quei giorni era così dolce lassù, il cielo così sereno, così vi- cino ai nostri occhi incantati che mi era impossibile credere a quegli orrori. Mollemente distesa, con la brezza che mi entrava nei capelli, nelle vesti, le parole di Marcella mi giungevano come il racconto di un incubo passato. Eppure i bombardamenti erano reali, e la fame, la guerra, e i tedeschi e gli americani che non venivano a salvarci, e i tonfi dell’artiglieria che arrivavano dal mare, erano reali. Ma io mi sentivo pigra e torpida e chiusa in un mistero soltanto mio, e soprattutto sola dentro quel cielo che non sarebbe mai più stato così chiaro. 128 Un pomeriggio di giugno salii come sempre dalla mia amica e venne ad aprirmi sua madre. – Oh, sei tu. Vieni, vieni, cara. Marcellina ti aspetta in camera sua. Mi raccomando, non fate rumore, – disse, e scomparve discinta e scarmigliata in una nuvola di fumo. Faceva troppo caldo per andare in terrazza, così decidemmo di stare in casa ad aspettare il tramonto. La camera di Marcella era bellissima: linda come uno specchio. Il lettino bianco con sul cuscino l’orsacchiotto spelato di quando era piccola, la scrivania col piano di vetro e la foto incorniciata della madre, l’armadio di acero dove erano riposti i vestiti, vecchi ma lindi e eleganti, i suoi fazzolettini con le cifre ricamate e le sottovesti orlate di merletto: tutto in ordine dentro i cassetti. – Che ha tua madre? – chiesi. – Mi è sembrata strana… – Sta lavorando al nuovo libro. Quando scrive è sempre così. Ha l’emicrania. Non bisogna disturbarla, fare rumore. – Sì, me l’ha detto. Vennero due ragazzi del piano di sotto e ci mettemmo a giocare a Monopoli, ma Marcella era più irrequieta del solito. Si stancò subito e quando quelli se ne furono andati ci mettemmo alla finestra a chiacchierare. Lei attaccò a parlare dello zio Nicola. Io l’ascoltavo eccitata pensando a quando i partigiani avrebbero fatto giustizia, scacciando per sempre i fascisti, i ricchi, tutti i nemici della povera gente, e tutti coloro che avevano perseguitato mio padre e tanti altri come lui, quel- 129 li che avevano voluto la guerra e fatto venire i tedeschi in Italia… Ero così compenetrata in quei pensieri che mi venne spontaneo esprimerli con fervore e ci rimasi molto male quando Marcella si arrabbiò di nuovo con me. – Non ricominciare con questi discorsi da comunista. I comunisti sono porci, in Russia affamano la gente, trucidano i preti e gli ebrei e mandano gli scrittori come mia madre in Siberia. Ecco chi sono i comunisti. Finiva sempre così quando parlavamo di quelle cose: lei si infuriava, io ci soffrivo e per un po’ la odiavo. Ma poi Marcella ricominciò a scherzare, volubile, a parlare di mille cose e non ci pensai più. – Sta’ a sentire, – disse a un tratto prendendo un libro dallo scaffale. – Ai em veri, veri eppi. Ai em veri veri… – Che cos’è? Scoppiò a ridere. – Inglese, ignorante: vuol dire: io sono tanto tanto felice. – Io preferisco il francese. Come mai ti sei messa a studiare l’inglese? – Mi piace! E poi la mamma dice che sarà molto utile. Che è la lingua dell’avvenire e che aprirà molte porte, soprattutto a noi giovani. Quando arriveranno gli americani… – Sì. E quando arrivano quelli! – Arrivano, arrivano. Sono praticamente alle porte. – Lo diciamo da mesi. – Ma adesso è vero! Non hai sentito il cannoneggiamento? Sembrava qui, a due passi. Sono stata sveglia tutta la notte ad ascoltare. Sai, non volevo dormire nel caso arrivassero. – Ma va’! – È solo questione di ore, anzi di minuti, forse. La mamma… – Io non ci credo più. Ho smesso di aspettarli, almeno quando arrivano la festa sarà più grande. Si affacciò la madre. – Cosa fate? Non vi sentivo. Dove sono i ragazzi? 130 – Se ne sono andati. Oh, mammina, ascolta! Ai em veri veri eppi ai am… Scoppiarono a ridere e si abbracciarono. – Sì, sì, stellina mia, se credi che l’inglese sia tutto lì. E, dimmi, perché saresti così veri veri eppi? Marcella la prese alla vita e cominciò a ballare. – Basta tesoro, mi fai girare la testa. Sto lavorando e non posso perdere la concentrazione, lo sai. Facevano sempre così, anche quando si incontravano per la strada: tesoro, cara, stellina, anima mia, ti prego... Consideravo manierate, teatrali tutte quelle moine, in realtà invidiavo Marcella, la sua allegria, la sua disinvoltura come invidiavo la sua casa, i suoi abiti sempre in ordine. Io non sarei mai stata come lei. Marcella non aveva più voglia di studiare l’inglese e ci sedemmo sul letto a parlare. – A cosa stai pensando? – A quando saranno qui. Che felicità! Ne parlava come se l’arrivo degli americani fosse un fatto suo privato. Come se dovessero venire solo per far felici lei e sua madre. Come se per me non significasse la stessa cosa: fine dell’incubo, pace, libertà… Mi sentivo esclusa ma non mi dava fastidio, non ci trovavo nulla di strano. Marcella era così: il centro del mondo. – Li vuoi i lupini? – No, grazie. – Non fare complimenti. Sono buoni. – Lo so, noi li mangiamo sempre. Ma ora non ho fame, – mentii. – Io invece tra poco svengo! Quando eravamo a casa nostra, a Caltagirone, a quest’ora arrivava Geltrude con la merenda. Com’era brutta Geltrude, poverina: nera, baffuta e pelosa. Una volta la vidi che faceva quelle cose col figlio del custode. Su, vieni con me, fai piano. Dal balcone della cucina si dominava il cortile fino al cancello e, oltre lo slargo antistante al portone, un bel tratto di strada, su su, dalla via delle Sette Chiese fino all’Appia antica. 131 – Ehi, guarda! Guarda! – Cos’è quello? Bussarono alla porta. – Signora Ruffo! Marcella! Correte! Dicono che dalla terrazza si vedono i carri armati. Arrivano, signora! Sono loro! Scesi a precipizio le scale e trovai mio padre in mutande sul balcone, davanti al suo deschetto che picchiava il martello con una bulletta tra le labbra. – Papà, papà! Lui si tolse il chiodino dalla bocca, batté due tre volte sul piede di porco senza guardarmi. – Hm. Che c’è? Cosa strilli? Va a fuoco la casa? – Sono arrivati! Gli americani! Sono qui! Balzò in piedi come una molla lasciando cadere tutto. In un attimo il cortile s’era gremito di gente che correva vociando verso il cancello. Là fuori, nello slargo davanti all’ingresso del lotto, giù fino all’imbocco della stradina di dove giungeva sempre più vicino un rumore sordo e regolare, già esultava una piccola folla. A un tratto lo vedemmo. Avanzava piano, come al rallentatore. Giunto sul piazzale si fermò, ansante, enorme al centro della calca che si aprì, trattenendo il fiato, ammutolita. Poi, come a un segnale, tutte le voci si unirono, le braccia si levarono, le mani si protesero in uno sventolio colorato di fazzoletti e bandierine e fiori… Due giovanotti neri di polvere e di sudore sporsero la faccia attonita dalla torretta. Volsero attorno lo sguardo, poi alzarono le dita a V e sorrisero. PARTE QUARTA I Un giorno il postino ci recapitò una lettera raccomandata. Veniva dal ministero e mio padre l’aprì con trepidazione. – Ah, bene, perdìo, bene. – Che c’è, che c’è? – Un momento, fammi finire. Dunque… – Si può sapere cosa dice? – Ernestina, è fatta! Mi reintegrano! E come se non bastasse, mi danno anche tutti gli arretrati. Siamo ricchi! Era vero, lo avevano riammesso in servizio per l’anno scolastico 1945-46 con il riconoscimento degli arretrati per tutto il tempo che era rimasto sospeso. – Evviva, evviva, siamo ricchi! – Proprio così, ragazzi. È una bella sommetta: ho fatto i conti mille volte. Ci rimetteremo in sesto e tu la smetterai di piangere. – Finalmente una bella notizia… – Ma io lo sapevo, io te lo dicevo… – Prima di tutto dobbiamo sistemare la casa: non ne posso più di vivere come zingari! E poi i figli, che hanno bisogno di tante cose, e… – Non soltanto loro. Dobbiamo pensare anche a noi due. Te, voglio rivestirti da capo a piedi come una signora, non voglio più vederti così trasandata. – Oh, sì, ma prima la casa. Ce lo compriamo un bel salotto? L’ho sempre tanto desiderato! – Certo, certo, tutto quello che vuoi. Pur di vederti contenta. 135 Vennero gli imbianchini a tinteggiare, a cambiare la carta da parati e finalmente la mamma ebbe il suo bel salotto: divano, poltrone, pouf, tavolinetto col piano di cristallo con il vaso di fiori sempre freschi al 136 centro, il mobile-radiogrammofono lucido e pieno di manopole, qualche stampa alle pareti, il ritratto di Garibaldi col poncho e un nuovo busto di Dante, i due personaggi prediletti da papà, che ci avevano seguiti dappertutto. In un angolo fu sistemato lo scaffale dei libri e per ultimo mettemmo le tendine di voile alla finestra che affacciava sulle scale. La mamma spolverava, lavava tutti i giorni il pavimento e, dopo averlo cosparso di borotalco, ci pattinava sopra con le pianelle di lana, per lucidarlo. Poi chiudeva la porta e guai a chi entrava. Qualche volta, la sera, quando la cena non era ancora in tavola, mio padre andava a sedersi in poltrona a leggere il giornale e fumare una sigaretta. Dopo qualche minuto arrivava lei e spalancava i vetri. – Non potresti fare a meno di fumare qui? Senti che puzza! Se viene qualcuno… Comunque, ti ho messo un portacenere apposta, non capisco perché continui a buttare i mozziconi dove capita. – Insomma, per chi lo abbiamo comprato questo salotto? Chi deve goderselo? Se viene qualcuno… Ma chi? Si può sapere chi deve venire? È una fissazione la tua, – sbuffava mio padre, che però si alzava e la seguiva, un po’ per farla contenta e un po’ perché, in fondo, non gli dispiaceva vedere tutto perfettamente in ordine, tutto lindo e lustro. – Che si mangia stasera? – Fegato alla pizzaiola e insalata di patate. – Sempre le stesse cose. – A chi lo dici? Piacerebbe anche a me variare menu. Provaci tu a andare al mercato. I prezzi sono alle stelle. Alla carne non ti ci puoi avvicinare. Prima c’era la guerra, si poteva capire, ma adesso… – Brava! La guerra non sarebbe niente, è dopo che viene il peggio, il caos. E ad approfittarne sono sempre gli stessi. Dovresti saperlo. Anche dopo il diciotto fu la stessa cosa. – Beato a te! E chi se lo ricorda? Ero piccola così e del resto a noi non ci mancava niente, fino… fino a quando non arrivarono le squadracce e fu il disastro, la rovina. Povero papà mio, non si riprese più e bello e vecchio… Insomma, ne abbiamo passate di disgrazie! – Be’, finché si possono raccontare… 137 A poco a poco rientravamo tutti, ci sedevamo attorno al tavolo nella cucina ritinteggiata di bianco e celeste, sotto la luce vivida della lampada smerigliata, e alla fine la mamma accendeva la radio. Era tornata la pace in casa, papà aveva ripreso le sue abitudini, la passeggiatina, il giornale, gli amici, e lei sembrava soddisfatta, specialmente adesso che la balia ci aveva riconsegnato Paola e la famiglia era al completo. Ma in principio l’arrivo degli americani aveva portato, insieme alla libertà, una grande confusione. Nel prato oltre i palazzi del nostro lotto s’era accampata una compagnia e, per tutta la pazza e breve estate del ‘44, la notte ci fu un gran bordello, un andare e venire di camionette, musica, strepiti, schiamazzi, risate. I primi erano stati i ragazzini, per nulla intimiditi dalla lingua o dal colore di quei giovanottoni. Gli giravano intorno, li toccavano, li tiravano per la manica, ricevendone cioccolato e gomma da masticare, poi andavano a razzolare nei mucchi di rifiuti intorno al campo e facevano commercio fra loro degli scarti che vi pescavano. Ben presto li seguirono le sorelle maggiori, anche loro niente affatto impacciate. Qualcuna, come le due belle figlie del colonnello del palazzo dirimpetto, frequentava solo ufficiali e i festini preferiva organizzarli in casa. Ma la gente mormorava e non faceva distinzione di rango chiamandole sbrigativamente “segnorine”, come le altre. Quando gli americani smobilitarono, non rimasero che silenzio e rifiuti a salutare l’inverno. La mia amica Marcella era andata ad abitare in centro lasciandomi un grande vuoto. Sapemmo che s’era fidanzata con un giovane ufficiale scozzese e che l’autunno prossimo si sarebbe sposata. In casa e nel palazzo non si parlava d’altro. – Hai visto quella che fortuna? – disse mia madre. – Di che parli? – chiese papà distratto, alzando gli occhi dal giornale. – Di Marcella, l’amichetta di Maria, la figlia della scrittrice, quell’antipatica dell’ultimo piano… – Ah. – Hai capito? Si sposa con un ufficiale americano. Un barone, dicono... 138 – Ma chi, quella ragazzina coi denti di fuori? – Ragazzina! Ha diciassette anni, uno più di tua figlia. E poi è sviluppata, formata bene come una donna. Mica come Maria. – Ma fammi il piacere! Roba da matti! Che, gli pesava a suo padre? Diciassette anni! – Che c’entra? Allora, quando ci siamo fidanzati noi, io non ne avevo sedici? – Erano altri tempi. E non è detto e dimostrato che sia un bell’esempio da portare. – Ah, grazie tante. Guarda che sei tu che sei venuto a cercarmi. Io nemmeno ti volevo. Tu e la buonanima di mio padre avete combinato tutto. Fosse stato per me, caro mio… – Sì, lo so che aspettavi il principe azzurro sul cavallo bianco. Su, calmati, parlavo così, in generale. Io penso che, in linea di massima, non bisognerebbe sposarsi troppo giovani. È meglio conoscere un po’ la vita, farsi qualche esperienza, non affogarsi alla prima occasione, senza sapere niente. Insomma, io mia figlia a sedici anni non la darei al primo che capita. – Diciassette. Comunque, dipende dall’occasione. La fortuna, come si dice, ha il ciuffo davanti ed è calva di dietro. Bisogna afferrarla al volo. Oh, dicono che è un barone, dicono che ha un castello e tanti possedimenti, tanta servitù. – Un americano barone e col castello giuro che non l’avevo mai sentito. – Guarda che io l’ho visto, quando abitavano ancora qui. È proprio americano. Scozzese. – Deciditi. Americano o scozzese? – È lo stesso, la divisa è quella. Uno scozzese che vive in America, o il contrario, che importa? Papà scoppiò a ridere. – Che baccalina che sei! Ti bevi tutto quello che ti racconta la gente! Un barone! Non è tutt’oro quello che riluce, dài retta a me. 139 Ora che Marcella se n’era andata, mi sentivo più sola che mai. Non parlavo con nessuno, la sera stavo ore alla finestra a guardare il cielo. Mi sentivo dentro passare tante cose e mi struggevo e avevo voglia di piangere. Quel cortile dilatato dalla luna, dalle ombre dei palazzi, dei pini adolescenti. L’aria dolce, la brezza, le voci lontane, le finestre chiuse di Marcella, lassù, come macchie scure, tutto mi illanguidiva e mi faceva soffrire. Mi sembrava di avere la febbre, desideravo essere malata, morire. Ma poi in autunno si riaprirono le scuole e cominciò una vita nuova, normale e serena. Ogni pomeriggio, appena mangiato, mi preparavo in fretta e correvo a prendere il tram. Scendevo alla fermata di via Cavour, imboccavo la salita dei Serpenti e finalmente arrivavo in via IV novembre angolo XXIV maggio e varcavo il grande portone dell’Istituto magistrale “Faà Fusinato”. Qualche volta, al ritorno, con le nuove compagne rifacevamo tutto il tragitto a piedi, da via Nazionale al Colosseo, fino alla Garbatella. Calava il buio, si levava il vento fresco della notte, ma noi camminavamo spavalde, i cappotti sbottonati sulle camicette sbracciate, fatte con la seta dei paracadute. A volte per accorciare la strada ma anche attratte e turbate da certe immagini intraviste nel buio, ci spingevamo tra il fitto degli alberi e i poggetti solitari della passeggiata archeologica per sbucare sulla via Imperiale. All’improvviso diventavamo taciturne, affrettavamo il passo fino a quando, familiare e rassicurante, appariva il piazzale aperto, col cancello di fronte e le case alte e chiare. II 140 Qualche volta, tornando da scuola, andavo alla Villetta a cercare Gioia e Miro che da un anno si erano iscritti al partito e, come diceva mia madre, l’avevano scambiato per la casa. Là c’era un’aria di festa, di allegria, e tante persone che mi trattavano come se mi conoscessero da sempre: donne grasse che fumavano una sigaretta dopo l’altra, giovani seri e indaffarati, ragazze alacri, uomini in panni da lavoro e mani dure. Mi piaceva salire la scaletta interna, ripida e buia, entrare nella sala della biblioteca, guardare i volumi sistemati nella libreria a vetri che ricopriva le quattro pareti. Un uomo appoggiato alle stampelle mi veniva incontro roteando il corpo a ogni passo. – Perché non ti abboni? – mi disse un giorno con un grande sorriso. – Puoi prendere tutti i libri che vuoi, uno alla volta, è naturale. Basta tenerli con cura e restituirli puntualmente. – Senza pagare nulla? – mi sorpresi. – Certo. Vedi, nel nostro partito l’istruzione è una regola. Ognuno di noi ha il dovere di migliorarsi, elevarsi, andare avanti e studiare, studiare, studiare… – Io studio. Sono all’ultimo anno delle magistrali. – Brava, ma non intendevo in quel senso. Cioè non solo, ma va bene. E dopo, che cosa vuoi fare? – Non so. Mi piacerebbe diventare giornalista. Chissà. – Ah! Come il compagno Ingrao. Brava, brava. Entra, scegli, prendi quello che vuoi. Me ne andai tutta contenta con Per chi suona la campana di cui avevo già visto il film. Il compagno con le stampelle mi disse con un sorrisetto che per cominciare non avevo scelto mica tanto bene. 141 – Ritorna, eh, ti aspettiamo, – aggiunse dall’alto della scaletta. – C’è bisogno di elementi in gamba come te. Chissà come farà a salire e scendere con le sue gambe, mi chiesi allontanandomi. Gioia aveva lasciato l’impiego per dedicarsi all’attività politica: riunioni, tesseramenti e altro che non capivo bene. Era così brava che presto fu chiamata in federazione, dove qualche volta andavo a trovarla. Là era tutto diverso dalla Villetta. Appena oltre il portone c’era un custode seduto dietro un tavolo che mi chiedeva scrutandomi dove andavo, chi cercavo e perché. Io diventavo rossa, mi impappinavo e provavo l’istinto di tornare indietro. Mi facevano passare per grandi sale misteriose in mezzo a pile di carte, giornali, libri accatastati, dove uomini alti e importanti si aggiravano senza badare a me, finché giungevo alla stanza delle ragazze. Gioia era lì, ma mi sembrava così diversa. Era insieme ad altre tre o quattro che andavano, venivano, non stavano mai ferme, si spostavano da un tavolo all’altro con un passo che pareva greve, affaticato, parlavano in modo strano, rispondevano al telefono e intanto scrivevano o facevano scarabocchi su un taccuino. Trasandate, i capelli sugli occhi, i maglioni scuri sfilacciati ai polsi, non si accorgevano nemmeno della mia presenza o mi dedicavano appena uno sguardo assente, un saluto distratto. Ne ricordo una diversa dalle altre: preziosa, elegante, con una pelliccia lunga fino ai piedi e degli orecchini d’oro come breccole, che appariva, attraversava la stanza sui tacchi altissimi, e scompariva senza fiatare. Non sentii mai la sua voce. Io mi facevo trasparente, in un angolo, ma poi arrivava una, mi metteva a un tavolino con un paio di forbici a tagliuzzare pezzetti di nastro o di carta colorata. Tacevo e obbedivo restando lì finché non ne veniva un’altra a dirmi che poteva bastare, che potevo andarmene, che dovevano chiudere, che non c’era più nessuno. Gioia chissà dov’era finita. Scendevo la grande scala di marmo poco illuminata e ripassavo davanti al custode che questa volta mi sorrideva e non faceva domande. Per strada mi sentivo subito meglio, raggiungevo a piedi ponte Ga- 142 ribaldi lasciandomi alle spalle le luci e il buio dell’Argentina, la festa delle vetrine, dei bar luccicanti; salivo sulla circolare rossa stracolma a quell’ora e lì, stretta tra la folla, all’improvviso mi calavano addosso stanchezza, malinconia e giuravo a me stessa che non sarei tornata mai più in quel posto dove nessuno si interessava di me, dove mi sentivo inutile e sciocca. Invece tornai sempre più spesso alla Villetta dal compagno con le grucce, e cominciai anch’io a rientrare tardi. Mio padre non aveva nulla da ridire, gli bastava sapere che eravamo al partito, che lavoravamo per il partito. Era fiero di noi: raccoglieva i frutti del suo insegnamento, diceva orgoglioso. Per Gioia che era la più qualificata, nutriva una sorta di rispetto e di soggezione che aumentarono quando portò in casa il fidanzato: un bravo compagno, piccolo, biondino, con gli occhi acuti e il sorriso aggressivo: un intellettuale, una promessa, un quadro di prim’ordine. – Tanti anni di sofferenza, di umiliazioni non sono niente di fronte a questi risultati, – diceva. Era ringiovanito e il giorno, tornando da scuola, si sedeva a tavola pieno di appetito, mangiava quello che trovava senza fare osservazioni. Teneva “l’Unità” piegata al posto del tovagliolo e appena mandato giù l’ultimo boccone e accesa la sigaretta, l’apriva e cominciava a leggere. Lo entusiasmavano soprattutto i resoconti parlamentari. – Bene, gliele ha proprio cantate. Senti, senti questa, Ernestina. Ernestina vieni qui, sta’ a sentire… Mia madre scrollava le spalle. La politica non l’aveva mai appassionata. – Bravo, bravo, perdìo! Così va bene. È ora di finirla, – continuava lui sbattendo il dorso della mano sul foglio aperto. – Che forza questo Pajetta! Che dialettica! Ce ne vorrebbero come lui! Non ha peli sulla lingua. Li mette tutti a tacere. Gioia, senti questo passo. Eh, che ne dici? – Papà, l’ho già letto. Devo scappare. Ciao. – Aspetta un momento, volevo commentare con te. Lui sì che ha fegato, altro che Togliatti! Secondo me Togliatti come oratore è troppo 143 freddo, troppo intellettuale, troppo diplomatico. A volte mi sembra un prete. – Un prete? Ma papà, cosa dici? Se quando parla incanta tutti. Perfino gli avversari… – protestava Gioia dalla porta. – Sì, sì, ma intanto i democristiani la fanno da padroni e con questa politica non andremo da nessuna parte. Con le belle chiacchiere, cara mia, non si cambia il mondo. Almeno Pajetta gliele canta. Senti, senti… Ernestina, vieni qui, lascia perdere i piatti. Ernestina, dove sei? Insomma, se ne vanno tutti. Parla il padre, il capo di famiglia, come se parlasse il cane: chi sparisce da una parte chi dall’altra. Ho capito. Meglio che me ne vada anch’io. Si alzava, si chiudeva in bagno, si lavava le mani, spazzolava la dentiera, le scarpe, poi fischiettando usciva di casa in cerca di qualcuno che gli desse spago, al caffè o in piazzetta. Alla Villetta non ci andava volentieri. Subito dopo l’arrivo degli americani aveva fatto domanda di iscrizione ma la risposta si faceva attendere. Bisognava avere pazienza. L’ufficio quadri doveva fare i dovuti accertamenti, chiarire, approfondire… Sarebbe troppo facile, uno fa domanda e subito ti danno la tessera. Il partito deve sapere chi sei, bisogna avere le carte in regola e aspettare. Ma a lui di fare anticamera non gli andava giù. Era impaziente, scalpitava. – Aspettare. Chiarire. Che cosa? Sono comunista dal ‘21, da quando tu, caro compagno segretario, non eri ancora nato... – Non arrabbiarti, compagno. La disciplina del nostro partito impone… – La disciplina, la disciplina. Me ne infischio della disciplina. Si tratta così un vecchio compagno che è stato in galera e al confino e che ha sofferto tutta la vita per l’idea! Da quegli incontri mio padre tornava avvilito. – Con gente così non cambieremo mai le cose, – diceva scuotendo la testa. – Non faremo mai la rivoluzione. Questi vogliono solo far carriera. Sono dei ragionieri, dei burocrati. E vorrebbero insegnare a me che cosa significa essere comunisti. A me! – Papà non prendertela, – provavo a dirgli anch’io, – è la regola, la disciplina. È così per tutti. Non dovresti giudicare in questo modo dei bravi militanti. – E dagli con la disciplina! Ti ci metti anche tu! Ti hanno indottrinata per bene, eh? Il fatto è che là dentro io non mi ci ritrovo. Nessuno mi dà retta. Si tratta così un vecchio compagno, secondo te? Ti sembra giusto? – Oh, papà, che ti devo dire? Vai in federazione, chiarisciti con l’ufficio quadri, ma intanto frequenta, impegnati. Ora per esempio con la campagna del tesseramento c’è un sacco da fare… Lui mi guardava sconsolato e mi voltava le spalle. In federazione non ci andò mai. Un giorno prese carta e penna e scrisse una lunghissima lettera ai compagni dell’ufficio quadri della direzione. Ma la risposta non arrivava. All’inizio era stupito, deluso e non poteva darsi pace, poi smise di sperare. Intanto la tessera non gliela davano e in sezione cominciavano a guardarlo con sospetto. A poco a poco non ci mise più piede. – Il tuo segretario, quello nuovo, e tutti quei ragazzetti saccenti, – diceva, – non mi piacciono, mi sembrano dei gesuiti. Con gente così la rivoluzione non la faremo mai. Per il suo compleanno, quell’inverno in casa si fece festa. Regali, fiori e una bella cena con antipasto, dolce e spumante. Era molto tempo che non passavamo una serata così, tutti insieme. Venne anche il vicino, un maestro elementare, socialista saragattiano, con la moglie e i due figli. Grazie al vino e all’allegria, mio padre dimenticò le polemiche e, dopo il brindisi, finimmo a cantare, prima qualsiasi cosa, poi l’ “Inno dei lavoratori” e “Bandiera rossa”. Papà tirò fuori il libretto delle canzoni di Spartacus Picenus e noi tutti attorno per leggere le parole. 144 La pallida figliola della via sui marciapiedi il corpo trascinò ma la vile sensuale borghesia per un tozzo di pane lo comprò. Sì, dice l’afflitta, sì, verrà Lenin che mi darà il mio pane e punirà l’infamia del destin. 145 L’aria era quella di “No cara piccina no, così non va” e cantò perfino la mamma, con la sua bella voce intonata da soprano leggero, mentre finiva di sgranocchiare di nascosto un pezzo di dolce che teneva sotto il grembiule. In ultimo, rosso per il vino e l’eccitazione, mio padre si alzò in piedi e levando un braccio con gesto teatrale, attaccò da solo: “Addio Lugano bella, o dolce terra mia”. Gioia scosse la testa e lasciando la tavola disse che le canzoni degli anarchici non si dovevano cantare, che il partito… Allora papà tornò a sedersi buono buono e la festa finì. Aspettammo un po’ per vedere che cosa avrebbe fatto, ma lui disse che aveva mal di stomaco e se ne andò a dormire. III 146 Si avvicinavano gli esami e io ero preoccupata. La sera non uscivo più. Alla Villetta ci andavo molto meno e in federazione non ci avevo più messo piede. – Come! sparisci proprio ora che c’è bisogno di tutte le forze per la grande battaglia! – protestava Gioia. – Non sparisco! faccio quello che posso. Era vero, non tralasciavo occasione per fare propaganda. A scuola ero riuscita a conquistare altre due o tre compagne e insieme ci battevamo con fervore per la causa della Repubblica. Spesso anche i professori si facevano prendere dall’entusiasmo e trascuravano le lezioni per parlare di politica. Quando sotto le finestre passavano cortei o frotte di dimostranti che tornavano dal comizio, a volte scappavo per raggiungerli oppure ci affacciavamo cercando di farci notare, gesticolando e urlando slogan, ma se arrivava la preside erano guai per tutti. – Mi meraviglio di te che sei una ragazza intelligente, – diceva, – una delle nostre migliori allieve. Fare propaganda a scuola! Chi ti ha messo in testa queste idee sovversive? Avanti, voi, a posto, altrimenti vi sospendo tutte! – Magari, – bisbigliava qualcuna, e finiva lì. A giugno fui bocciata. – Che delusione, – disse mio padre sconsolato. – Da te non me lo sarei mai aspettato. Lo sai quanto ci tenevo. E invece anche tu… Stai prendendo una brutta piega… Io tacevo e tenevo la testa bassa perché sapevo di avergli dato un dispiacere vero. – Sì sì, – continuò – una brutta piega. Non mi piace. Nella vita bisogna saper conciliare le cose, non fare come te che pensi solo al par- 147 tito e ti scordi di tutto il resto. Lo sai quanto speravo in te. Tra poco avrai vent’anni. Gioia si è sistemata, presto farà un bel matrimonio, tuo fratello ha un buon lavoro, gli altri hanno ripreso la scuola, perfino Livio, che pareva il più sbandato, si è messo sotto, ha trovato la sua strada e pare che faccia sul serio. Insomma si cominciava a stare tranquilli, a ritirarci su. E invece... Proprio tu… Uffa, sbuffavo, già con un po’ di rabbia, dopotutto era soltanto un ritardo di qualche mese. Quel maledetto diploma lo avrei preso a ottobre. Il partito aveva bisogno di me. Una sera rincasando trovai Gioia davanti a una cesta di fettuccia rossa. – Oh, finalmente sei arrivata. Vieni ad aiutarmi. – Che stai facendo? – Le coccarde per domani. Guarda, ti insegno: prendi un pezzetto di nastro, lo pieghi così, ci metti un puntino al centro, e via. – Ancora coccarde! Ma a che servono? – Alla sottoscrizione. Naturalmente bisogna metterci il cartellino de “l’Unità”. Li sta preparando Miro. Dovrebbe portarli a momenti. – Ci faremo mezzanotte, se basta. – Non chiacchierare, lavora. Fa’ un po’ vedere? Ma no, leggermente più piccole, così. – Come al solito, devi pensare a tutto tu. – Che vuoi farci? ‘Ste ragazze sono un disastro: o si vergognano, o il padre non le fa uscire, o il fidanzato non vuole, o devono aiutare la mamma. Va’ un po’ a parlargli di emancipazione a questa gente! Che medioevo! Ho fatto una sgobbata per andarle a snidare una per una a casa e convincerle a venire domani. E si tratta di una festa. – Io l’ho detto a Irene e a Franca, sai quelle mie compagne di scuola. Il padre è socialista. – Brava. L’appuntamento è alla Villetta, alle nove. Ma lavora, non distrarti. – Mi hai presa a cottimo? Sono stanca, ho fame. A proposito, non si mangia stasera? 148 – Ma che ne so. Sembrano spariti tutti. – Mamma dov’è? – In camera. Papà sta male un’altra volta. – Lo stomaco? – Lo stomaco, il fegato, boh! Se si decidesse a curarsi sul serio! – Dovrebbe operarsi, ma non vuole. Ha paura dei ferri. – Che sciocchezze! Cosa vuoi che sia un’operazione oggigiorno? Su, su, spicciati che abbiamo quasi finito. Arrivò Miro coi cartellini. Aveva la camicia fuori dei pantaloni, tutta imbrattata. – Non è niente, – disse, – è tinta ad acqua, va via subito. Vanno bene? Gioia trovò che erano troppo grandi e si stizzì. – Più piccoli, più piccoli ti avevo detto, accidenti! – Ma no. Guarda come spicca la scritta. Si vede da lontano un miglio! Sono bravo, eh? Che artista! – Piantala! Gli spilli almeno li hai portati? – Cos’è questa baraonda, – disse la mamma entrando, – vostro padre ha la febbre alta. – Il dottore l’hai chiamato? Che ha detto? – Che dovrebbe andare in ospedale. Ma lui non ci pensa nemmeno. Convincilo tu quel testone, se sei capace. Sono anni che si trascina… Un giorno o l’altro, – frignò. – Oh, dài, non cominciare a fare la tragedia. Qui bisogna prendere una decisione. Ecco fatto, abbiamo finito. I cartellini possiamo attaccarli dopo cena. – Su me non ci contate. Io vado al cinema. Andammo a dormire molto tardi. – Sarà una festa bellissima. – Pensi che verrà molta gente? – Te lo immagini? Parla Togliatti! Ma tu hai pensato a quell’idea dello spettacolo? – Sì, ci ho riflettuto. Pensavo a tre o quattro sketch: uno sugli americani che non se ne vanno più. Hai in mente quella strofetta: “Ades- so gli alleati ci chiamano fratelli, ci mandan dall’America la zuppa di piselli”? Che schifo, m’è arrivata fino agli occhi. Poi uno sul mercato nero; uno sui gagà di via Veneto… E tra una scenetta e l’altra una canzone, un a solo di fisarmonica, un balletto, oppure qualcuno che legge delle poesie... Che ne dici? – Mi sembra un’ottima idea. Ne parlo subito in federazione. Intanto mettiti a scrivere le scenette. – Io? – Ma sì, non è difficile. Ora però dormiamo se no domani chi si sveglia alle sette? Notte, Marì. – Notte, Gioia. 149 Il giorno dopo i prati del Palatino erano accecati di sole, colorati di gente festosa; c’era chi se ne stava nell’erba senza scarpe, col fiasco vicino, a mangiare panini, ridere, cantare, a richiamare il pupo che s’era allontanato… I più giovani correvano o passeggiavano sui pendii dolci, qualche coppia bisbigliava appartata nel verde. Bandiere e cartelli giacevano abbandonati da una parte, ma la mattina era stato tutto un garrire, un inneggiare. “Viva Togliatti, cellula Pantanella”, “Viva la Repubblica, sezione Esquilino”, “Viva il PCI”, “Viva il 2 giugno”, “Fiat Mirafiori”... Ce n’era uno immenso, portato a spalla da quattro operai in tuta della Manifattura Tabacchi, c’era scritto a caratteri cubitali: “Il popolo ha vinto”, e sotto, più piccolo, “Sezione Trastevere”. Fu una bella giornata. Togliatti aveva parlato, piccolo piccolo dal palco altissimo pieno di bandiere. La sua voce metallica aveva raggiunto ogni angolo del colle, le sue frasi taglienti avevano riempito l’aria per due ore. – Non ci si stancherebbe mai di ascoltarlo, – dicevano i compagni, la gente, in uno sventolio di bandiere e di fazzoletti rossi e un coro di acclamazioni festose che non finivano più. Mio padre il discorso di Togliatti per la vittoria della Repubblica lo lesse a letto il martedì mattina, sul numero speciale de “l’Unità”. – Un discorso magnifico! – disse. Ma l’entusiasmo non gli accese le guance smorte e scavate. IV 150 – A nome delle ragazze democratiche del quartiere, – cominciai con un tremito nella voce, afferrando con tutt’e due le mani l’asta del microfono. Il cinema-teatro Garbatella era gremito all’inverosimile. In prima fila vedevo mio padre, pallido, solo, rigido, con la testa reclina da una parte e gli occhi stretti. Sul palco, al mio fianco, seduti a un grande tavolo coperto di rosso, tre o quattro compagni si scambiavano foglietti o scarabocchiavano distrattamente. Una donna anziana e grassa fumava di continuo. – La nostra adesione al fronte democratico popolare… La voce mi veniva dalla testa, falsa, tremula. Ma ce l’avevo fatta! Avevo vinto la paura che da una settimana non mi faceva vivere. Erano venuti a casa, i compagni della Villetta, a chiedermi di fare un intervento a nome delle ragazze del quartiere. In quanto non ancora iscritta al partito e studentessa, ero l’elemento perfetto per rappresentare il ceto medio indipendente giovanile. Le mie timide proteste non servirono a nulla. Stamparono il mio nome in rosso su fondo bianco insieme ad altri quattro o cinque e adesso eccomi lì, di fronte a duemila persone, ma soprattutto di fronte a mio padre. Quando scrosciò l’applauso lo vidi scattare in piedi, vidi i suoi occhi rossi di lacrime sul viso scavato. Venne il segretario dei giovani a stringermi la mano. – Brava, compagna, proprio un bel discorso. Ma non ti ho mai vista in sezione, da quant’è che sei iscritta? – Veramente non sono iscritta. Ho la tessera delle brigate garibaldine, quella dell’Uri, quella dei comitati della pace, quella dell’Anpi… ma penso di non essere ancora matura per entrare nel partito. Io credo che iscriversi al partito sia una cosa molto seria e che bisogna aspettare di arrivarci da soli. 151 – Ma che aspettare! Il partito ha bisogno di elementi come te, non ha senso starne fuori, specialmente in vista delle elezioni. C’è tanto da fare. E tu, che sai parlare così bene, che sai trovare le parole giuste, potresti fare un prezioso lavoro in provincia. Ci verresti a fare il lavoro della provincia? – Ma io, io non… – Non fare la modesta, la modestia non è una virtù, nel nostro partito. Bisogna essere consapevoli delle proprie capacità, e anche dei propri limiti, certo, per potersi migliorare, ma di questo parleremo un’altra volta. Stasera in sezione c’è una riunione della commissione stampa e propaganda. Sai dov’è la Villetta, vero? – Figurati, ci vengo sempre. Sono la sorella di Gioia e di Miro. – Ah, ma allora nel partito praticamente già ci sei. Ti manca solo la tessera. Stasera ti aspetto, non mancare. A casa la mamma stava già apparecchiando. – Com’è andata? – chiese senza alzare la testa. – Benone. All’inizio avevo un po’ di tremarella, ma poi è stato come se tutta quella gente non esistesse, o che fosse una persona sola, non so spiegartelo, ma è stato bello. Entusiasmante. Mi hanno fatto tanti complimenti. Il segretario mi ha invitato a una riunione importante... – Ho capito. Adesso comincerai anche tu. Farai la fine di tua sorella che non vede altro che il partito. Il partito, il partito… Tutta colpa di vostro padre che vi ha messo in testa queste idee pazze. – Sacrosante e onorate, non dar retta a tua madre, – intervenne papà arrivando, – ti sei fatta onore, figlia mia. Brava, brava Mariò. Non starla a sentire, – ripeté, – lei di politica non ha mai capito niente. È sempre stata un’ignorante e con le sue paure mi ha impedito di fare qualsiasi cosa. È tutta colpa sua se non ho combinato nulla nella vita. – Bravo. Bel modo di parlare ai figli. Poi ci lamentiamo se non hanno più nessun rispetto e considerazione per i genitori. Te sei sempre stato un illuso, uno spostato, ora staremo a vedere loro, quello che faranno. Ce lo sapremo ridire. 152 La domenica veniva qualcuno a prendermi con un camioncino già carico di materiale: volantini, manifesti, giornali, brochures. Fischiavano e, per fare prima, saltavo giù direttamente dalla finestra sulla strada. I primi chilometri, infreddoliti dall’aria frizzante del mattino, stavamo zitti e rannicchiati, ma a mano a mano che il giorno scaldava, cominciavamo a infervorarci e a cantare. Si tornava a sera, stanchi, storditi dal vento che c’era sempre nei paesi, ma soddisfatti del lavoro svolto, con il cuore e la mente pieni di speranze e di felici previsioni. Agli esami non pensavo più. Li darò a ottobre come privatista, mi dicevo mentendo a me stessa. C’era tutta l’estate per prepararsi, e poi, che importanza potevano avere i miei esami di fronte alla battaglia che ci aspettava? Dobbiamo vincere le elezioni, arrivare al governo. Sarà una vittoria piena e incontrastata, aveva giustamente detto il compagno Togliatti nel grande comizio di apertura a San Giovanni. Il voto democratico salverà la pace, la libertà, il benessere del nostro Paese. Il Fronte Democratico Popolare vincerà. Votate e fate votare Fronte. Ma il tempo che seguì quel 18 aprile fu tempo di amarezza e delusione. Mi sentivo svuotata. I discorsi di mio padre a tavola mi irritavano. – Ce lo avevano assicurato, ci hanno illuso con la maggioranza schiacciante e tutte quelle chiacchiere trionfaliste, – lamentava. – Un grande errore di valutazione politica. – Papà, era propaganda. Noi lo sapevamo come stavano le cose. Ci aspettavamo di più, è vero, ma dopotutto il trentuno per cento quasi, più di otto milioni di voti, in un Paese che esce da vent’anni di fascismo non è un risultato da sottovalutare, – obiettavo – e poi, guarda i progressi rispetto a due anni fa. Ma lui non si convinceva, scuoteva la testa e io mi accaloravo. – Senza contare le condizioni obiettive in cui il nostro partito ha operato e opera: l’influenza dell’imperialismo atlantico, le pressioni del clero. Hanno mobilitato la Chiesa. Hanno portato a votare le suore di clausura, i moribondi... E non ultimi i brogli elettorali. – Parli come un libro stampato, come il tuo giornale. A chiacchiere 153 riuscite sempre a far sembrare le cose come volete. Ma a me non mi incanti. Io dico che è il sistema che non va. Con il Parlamento, anzi con la rivoluzione democratica, come dite voi, non arriveremo mai a un bel niente. In questo Paese, con le elezioni non avremo mai la maggioranza! Bisognava pensarci quand’era il momento, battere il ferro finché era caldo, invece di disarmare e perseguire i partigiani. Ormai siamo fregati per altri cinquant’anni. I reazionari, la grande borghesia nera, hanno preso il sopravvento. I fascisti hanno rialzato la cresta. Questo il tuo partito non avrebbe mai dovuto permetterlo. Altro che amnistia! Me lo dici cosa ci azzeccava l’amnistia? Non l’ho mai capita e non l’ho mai mandata giù: mistero. E ce l’ha all’anima proprio il tuo caro Togliatti. E come se non bastasse, l’articolo 7. Errore madornale! Altro errore, il voto alle donne. Ci siamo scavati la fossa con le nostre mani. Roba da matti: in un Paese bigotto, ignorante, retrogrado come l’Italia… Tra poco non ci resterà neppure la magra consolazione di parlare. Vedrai, vedrai se mi sbaglio. È una vergogna. Con tutto il vostro studiare e parlare da borghesucci non arriveremo a niente. La rivoluzione non si farà mai. Scrollavo le spalle. Non c’era verso di fargli capire che le condizioni erano cambiate, che le regole della democrazia, gli equilibri internazionali, gli Stati Uniti, la guerra fredda… Era profondamente amareggiato e sempre più critico verso la politica del partito e verso i compagni, fermo alle idee di suo padre e non poteva accettare la lotta pacifica, legale, il grande lavoro che il partito portava avanti giorno dopo giorno, nelle fabbriche, sulle terre, e nella coscienza degli uomini. Se qualche volta riuscivo a trascinarlo alla Villetta, quando c’era il corso Stalin o la conferenza ideologica del venerdì, dopo un po’ tagliava la corda e poi, a casa, ricominciava la musica. – Non ho bisogno di scuola, io! Fammi il piacere! Che cosa vuoi che ne sappia quello lì di comunismo, di lotta di classe, con quell’aria da figlio di papà. Certo che la fame lui non l’ha mai conosciuta e ci scommetto che suo padre era anche un fascistone. 154 – E questo che significa? Anzi, sarebbe ancora più apprezzabile da parte sua avere capito e rotto con la famiglia… E poi è un compagno molto qualificato, quadrato, con una grande preparazione ideologica. Il partito ha bisogno di questi elementi. Forse, è vero, è ancora un po’ borghese nei modi, ma è proprio per questo che il partito lo manda a fare il lavoro più duro nelle borgate, proprio perché si spogli dei residui borghesi… – Certo che ti ammaestrano bene. Comunque i fatti restano quelli: ci stiamo calando le brache e di rivoluzione neanche la puzza. Hanno paura perfino a pronunciare la parola. Altro che chiacchiere, figlia mia. L’hai visto quanta gente c’era alla tua conferenza ideologica? – Finché c’è chi la pensa come te, per forza! – Io sono sicuro che verrà il giorno in cui la gente saprà quello che bisogna fare, senza aspettare l’imbeccata di nessuno. – Ma lo senti che parli come un anarchico? Il mondo cammina, va avanti, cambia. E così anche il partito… Se studiassi, leggessi, ti aggiornassi… Il compagno Togliatti lo dice sempre… Ma lui non cedeva, testardo, fossilizzato nelle sue idee. Per non ascoltarlo, inventavo una scusa e me ne andavo. Provavo rabbia e scontento, ma anche incredulità e tristezza. Non mi capacitavo uno che ci aveva sempre parlato di libertà, di emancipazione, di democrazia, potesse fare discorsi simili. Non ci capivo più niente. In questo modo si stava isolando e più si isolava più diventava amaro. Non parlava con i compagni, non frequentava la sezione, non leggeva il giornale, dava un’occhiata a “l’Unità” e morta lì. Mentre nel nostro partito non bisognava mai smettere di discutere, di conoscere, di approfondire l’insegnamento dei maestri: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Gramsci e Togliatti. Per questo ogni settimana alla Villetta veniva un compagno della federazione a tenere una conferenza e a spiegarci i grandi testi. E così, per sapere conoscere approfondire, a ottobre mi dimenticai di nuovo del diploma. In fondo, si tratta solo di un pezzo di carta, mi dicevo. 155 – Ci riproverò, mi impegnerò, – dissi a mio padre. – Per un po’ la smetterò con la sezione. Ho tutto il tempo… e poi c’è un compagno universitario che è disposto a darmi una mano, se voglio. – Sì, sì, lo so come te la dà la mano il tuo universitario. Non prendermi in giro. Abbi almeno il pudore di stare zitta. Dici che ti impegnerai, ma io non ci credo. Tu dici di sì, e va bene, staremo a vedere. Del resto, quello che fai lo fai per te. Il cervello per ragionare grazie a Dio non ti manca. – Fece qualche passo nella stanza, accese una sigaretta e si fermò davanti alla finestra, dandomi le spalle. – Hai promesso tante volte di limitare l’attività, e invece ci sei più dentro di prima. Io non dico che devi allontanarti dal partito, tradire la fede politica. Chi meglio di me può capirti? Sapessi come mi prudono le mani a stare così inattivo, quando si vedono certi sbarbatelli presuntuosi, burocrati a caccia di carriera, a capo delle sezioni, e non solo… Buttarmi via così, dopo tutto quello che ho passato. Essere trattato con sufficienza dagli stessi compagni… Ora parlava per sé, dimentico della mia presenza. Cominciava a fare buio e con la fronte poggiata ai vetri, un po’ curvo, sembrava più piccolo, più fragile e dava un senso penoso di solitudine. Mi venne una gran voglia di abbracciarlo. Ma non lo feci, non mi mossi. Qualcosa mi bloccava: ostilità, rabbia. O pudore. – Quel Galli, quella faccia da gesuita, sempre pronto a farti la lezione, a darti dell’imbecille col sorriso sulle labbra. Parlate tutti uguali, come pappagalli ammaestrati: “anacronista”, “estremista”, “anarchico”. Come fosse una bestemmia… Non capivo il suo vittimismo. Perché non lottava, non andava a fondo, non spazzava equivoci, malintesi, perché non si chiariva con i compagni, a cuore aperto come ci insegnava il partito? – Te ne stai lì a roderti il fegato, – dissi, – isolato, assediato dai fantasmi. Tutti borghesi, tutti cretini, tutti che ti odiano… In questo modo sei tu che ti metti dalla parte del torto, papà, non lo capisci? – Che dovrei fare? Umiliarmi? Mettermi in ginocchio? Mandar giù bocconi amari? No grazie. So solo io quanto soffro. Non è questo che 156 avevo sognato tutta la vita. Non mi hanno piegato vent’anni di fascismo, la galera, l’esilio e nessuno mi farà cambiare idea. Del resto, cosa credi? il mio dovere lo faccio anche senza la tessera in tasca, sai? Non te lo immagini nemmeno quanta gente guadagno alla causa, quanti voti porto io al tuo partito. Diglielo al tuo segretario, a chi ti pare… La mamma fece capolino dalla porta e ci guardò con quella sua aria apprensiva e sospettosa. – Cosa fate, voi due, vi confessate? Non vi sentivo. Che ha tuo padre? Avete litigato? – Ma no, è la solita storia. Non ci puoi ragionare. – Ah, ho capito: la politica. Maledetta politica. Il partito, accidenti al partito. Ma perché non la piantate? Come se nella vita non ci fosse altro. Bel risultato! Guardalo: almeno fosse contento… Chiusi la porta del salotto e la seguii in cucina col cuore grosso per essere stata dura con lui. Sapevo quanto soffriva. Forse anche ora stava piangendo tutto solo. Avrei voluto aiutarlo, ma era più forte di me, non sopportavo che facesse la vittima. Non potevo pensare che il partito fosse ingiusto con lui. Perché non lottava? Sapevo che non aveva niente da rimproverarsi. Sapevo come aveva sempre creduto in un’idea sola. Ricordavo i suoi discorsi, il suo entusiasmo, i suoi insegnamenti, le sue speranze e non riuscivo a capire. La sua sconfitta non mi faceva pena, mi irritava. – È sempre stato un gran chiacchierone e basta. Sempre diverso, sempre polemico, sempre fuori posto. Con quel caratteraccio bastian contrario che gli fa scostare la gente. Ecco perché ci ha sempre rimesso nella vita. Prima con quelli, ora con quest’altri. Ma tanto non la vuol capire. Sono più di vent’anni che predico inutilmente. Se mi avesse dato retta! Fatti gli affari tuoi, non fidarti di nessuno, gli dicevo, pensa alla famiglia, a tutti questi figli da mantenere… Ma lui, niente. Non mi ha voluto mai sentire. Almeno fosse servito a qualcosa… Me ne andai per non ascoltare i borbottii di mia madre. V 157 Quando il partito lanciò la gara del tesseramento, il mio impegno scolastico passò di nuovo in seconda linea. Questa volta mio padre non se la prese. Gli avevano finalmente promesso di dargli la tessera e intanto gli avevano affidato un’attività, sia pure marginale, che lo assorbiva parecchio. Sembrava un altro, in casa ci stava poco e la mamma era contenta. Bastava che non lo sentisse brontolare e lamentarsi con tutte quelle storie che non aveva mai capito, e in casa, meno ci stava meglio era. Io avevo un gran daffare tra il quartiere e la borgata Sciangai. Alla Villetta ci eravamo messi in testa di portare via il primo premio. E andò così. Una domenica al cinema Adriano ci fu una grande manifestazione. Parlarono il compagno Togliatti, poi Natoli e D’Onofrio, detto papà Edo. Salii sul palco con gli altri a ricevere il premio dal segretario generale. Mi tremavano le gambe: tutti quei compagni famosi che mi stringevano la mano, al di là del tavolo bardato di rosso e dicevano brava brava Garbatella, fu un momento emozionante. Quando tornai a casa avevano già mangiato, la mamma sembrava di malumore e non mi disse niente. Non era una novità. A causa dei miei impegni, dei miei orari, succedeva a volte che non ci incontrassimo per giorni e lei non apriva bocca. Pensai al solito litigio con papà e non me ne curai. A che serviva chiedere, discutere? Meglio tacere, starsene per proprio conto, ognuno nel suo guscio senza badare ai musi lunghi, alle eterne querele. A volte la notte quando rientravo la sentivo bisbigliare nel letto e sapevo parola per parola cosa stava dicendo a mio padre: – Hanno scambiato la casa per l’albergo, e chissà che cosa vanno facendo fino a quest’ora di notte, pazienza i maschi, ma quella lì, non si vergogna, che cosa dirà la gente, dovresti metterci 158 un freno, pensarci tu, ma tu te ne infischi, non sai mai niente, dormi da piedi… Papà le rispondeva a grugniti, a monosillabi, le diceva di sì per quieto vivere, che un giorno o l’altro sarebbe intervenuto e le cose sarebbero cambiate. – Ci penso io, ora dormi, su, che è tardi. Mio padre si era tuffato con fervore nella nuova attività e per un po’, finché aveva avuto carta bianca, era andato tutto bene. Ma poi vennero le critiche sul suo modo troppo personalistico di concepire il lavoro di massa e di rapportarsi al quadro dirigente e ricominciarono le lamentele, le incomprensioni. – Mi disapprovano, sabotano ogni iniziativa, mi bocciano ogni proposta, mi mettono i bastoni tra le ruote, mi sorvegliano, mi limitano. Come posso lavorare in queste condizioni, in questo clima di sospetto? Inoltre, lo sforzo, l’eccitazione lo avevano affaticato e così, giorno dopo giorno, un po’ alla volta, si tirò indietro e si rifugiò nella solitudine ad aspettare che i fatti, prima o poi, gli dessero ragione. VI 159 L’ultima domenica di settembre, alla festa della stampa comunista, alla Villetta c’erano anche un regista che stava girando alla Garbatella, accompagnato da un’attrice. Stentammo a riconoscere in quella ragazza scialba, magra, spettinata, senza trucco, la famosa diva dello schermo. I compagni erano increduli e delusi. Ci fu l’elezione di miss “Vie nuove” e le aspiranti sfilavano sul palco mostrandosi davanti e di dietro. Il pubblico rumoreggiava. Il regista si lisciava i baffi. Vinse una moretta strizzata dentro un vestito di seta verde, tutta riccioletti e curve alla Lollo. Le misero la fascia tricolore, le regalarono un servizio da toeletta, un abbonamento al settimanale del partito e, prima di andarsene in gran fretta, il regista le assicurò un provino. Seguì lo spettacolo d’arte varia: sketch balletto stornellata, sketch balletto stornellata, e per finire concerto per pianoforte e violino offerto dalla famiglia Pradella. I giovani volevano ballare, si spazientirono e cominciarono a battere i piedi, così si tagliò corto sul programma classico e sul palco prese posto l’orchestrina col cantante. Si spostarono le sedie e iniziarono le danze mentre i vecchi giocavano a carte o stavano al bar a bere e a mangiare i supplì fatti sul momento dalle compagne della cellula degli Alberghi. A tarda sera ci fu un incidente: dei ragazzi di Sciangai volevano a tutti i costi ballare il boogie-woogie, che era severamente proibito. Ma poi le cose si calmarono e la festa durò fino a tardi. C’era una puzza di sudore e di fritto che non si respirava nemmeno all’aperto. Allora noi giovani ce ne andammo fuori, a cantare a squarciagola per le strade le nostre canzoni di lotta per provocare i fascisti, nella speranza che uscissero dalle fogne e accettassero la sfida. Ci sentivamo orgogliosi 160 della nostra festa e nessuno avvertiva la stanchezza, anche se eravamo in piedi dalle sei per la diffusione de “l’Unità”. Quella mattina, porta a porta e per le strade del quartiere, isolati o a gruppetti, ne avevamo vendute cento copie di più. Io come sempre in coppia con Wanda della cellula Pantanella a cantare sfrontate la strofetta romanesca: “L’Unità è il giornale de chi lavora de chi lotta e de chi spera/ l’Unità è la voce più sincera che nel monno pòi trovà...!”. Anche di libri ne erano andati via parecchi, alla bancarella davanti alla Villetta. Lo spettacolo e il concorso di bellezza, poi, avevano fruttato bene, senza contare il peso propagandistico dell’iniziativa. Per tutto il giorno in sezione era stato un continuo viavai: facce che non s’erano mai viste, giovani, donne. La mattina si era svolta perfino una gara podistica. La gente, uscendo dalla messa, si fermava a guardare i corridori e durante la sfilata delle miss le finestre dei palazzi attorno erano gremite che sembrava la festa della Madonna quando passa la processione. Ma non era sempre così. Più spesso il lavoro era ingrato. La gente ti voltava le spalle oppure ti dava ascolto un momento, poi tornava ai fatti propri. In sezione non ci veniva quasi più nessuno. Alle elezioni del ‘48 e all’attentato a Togliatti era seguita un’ondata di sfiducia. Tanti compagni erano usciti dal partito; altri, dirigenti, che in quelle giornate accese s’erano esposti di più, li avevano arrestati, o licenziati dai posti di lavoro, o erano in attesa del processo. Secondo mio padre ci eravamo lasciati sfuggire l’ennesima occasione, e ora eravamo fottuti per sempre. Bisognava lasciar fare al popolo, alla classe operaia, diceva. Nelle grandi città industriali, dove esiste il proletariato cosciente, predicava, si era visto di che cosa era capace il popolo: fabbriche occupate, poliziotti disarmati, sequestrati nelle caserme, strade, ferrovie, telefoni bloccati. Nord e Sud, l’Italia spaccata in due. A Genova, a Napoli, a Taranto, c’erano stati morti, si contavano feriti dappertutto, anche nella polizia di Scelba che non aveva esitato a sparare sui rivoltosi. – E il partito, che fa? Quando non si aspettava che una parola, un gesto, ancora una volta frena l’impeto insurrezionale. 161 Non si capacitava e non ammetteva ragioni. Era inutile cercare di convincerlo che sarebbe stata la fine per noi, che quell’attentato era stato una precisa azione provocatoria, messa in atto allo scopo di dichiarare il Partito comunista fuori legge. Nella sua grande saggezza, appena ripreso dal coma, Togliatti aveva esortato i compagni a non perdere la testa. Ma che giornate erano state! La notizia ci giunse verso l’una, mentre eravamo a tavola. Papà diventò pallido, lasciò a metà la minestra nel piatto e si alzò. Sotto casa già passavano a frotte gli operai che avevano abbandonato spontaneamente i cantieri senza aspettare l’ordine di sciopero del sindacato, e si dirigevano al centro, coi badili i visi rossi e le mani ancora sporche di calce. Mio padre prediceva la fine del mondo e intanto si spazzolava le scarpe come se dovesse andare a teatro. La mamma lo scongiurava di non muoversi, di finire di mangiare che, se usciva, chissà che ora avrebbe fatto fuori di casa, a digiuno. A me venne un feroce mal di pancia e appena arrivai alla Villetta dovettero darmi un calmante. A piazza Colonna già volavano i primi sampietrini… Poi tutto era passato. La delusione, l’amarezza allontanò molti compagni e anch’io, che avevo trovato lavoro e la sera facevo spesso tardi, frequentavo meno. I compagni della Villetta mi guardavano con un rimprovero negli occhi e io mi sentivo in colpa anche se mi sembrava ingiusto che mi giudicassero perché quando c’era un impegno straordinario o di fare a botte con la Celere ero la prima a correre, come quella volta della manifestazione contro il Patto Atlantico sotto l’ambasciata USA che mi presero e finii alle Mantellate per tre giorni. – Se stasera non mi vedi tornare, non preoccuparti, vuol dire che mi hanno beccata, – avevo detto a mia madre uscendo. Lo dicevo sempre, con un’aria spavalda e noncurante, in realtà desideravo che stesse in ansia per me, che aspettasse il mio ritorno, per leggerle una pena negli occhi. Ma lei non rispondeva nulla. Da tempo avevamo rinunciato anche a parlare. Tanto, a che scopo discutere, litigare? Tutto restava come prima. PARTE QUINTA I 165 La sede del sindacato provinciale degli edili dove lavoravo era in uno scantinato della Camera del Lavoro, a piazza Esquilino. Ci faceva un gran freddo umido e mi presi subito la tonsillite. Ma ero orgogliosa e piena di entusiasmo e alla stanchezza o al mal di gola non ci badavo. Mi piaceva la sera quando arrivavano i muratori, appena staccato dai cantieri, con le mani spaccate dalla calcina e l’alito aspro di vino. Restavano in piedi in un angolo senza aprire bocca, aspettando il loro turno. Bisognava strappargli le parole con le tenaglie e mettere giù i dati per i conteggi. Dovevo controllare sulla busta paga se il padrone aveva corrisposto il dovuto, se non mancavano l’indennità di licenziamento o il caro pane o la rivalutazione. Una volta imparato, era semplice, bastava moltiplicare la differenza per i giorni lavorativi. Poi si mandava la cartolina-invito al datore di lavoro e, nel cinquanta per cento dei casi, la vertenza si risolveva in sede sindacale. Per l’altro cinquanta bisognava adire le vie legali, cioè passare la pratica all’avvocato. E non se ne sapeva più niente. Quando il padrone conciliava, sborsava i soldi e se ne andava, il segretario mi faceva un segno di intesa e il muratore attonito veniva subito sequestrato al mio tavolo. La tessera della CGIL non vogliamo farla? E il bollino speciale, non lo mettiamo? E guarda, compagno, c’è il numero straordinario de “Il lavoro”, il nostro settimanale, col discorso del compagno Di Vittorio al congresso di Napoli e tante fotografie sull’occupazione delle terre nel sud, prendi prendi… E una piccola offerta per aiutare la baracca, non la faresti? Il muratore guardava assottigliarsi il mucchietto dei soldi ma taceva e annuiva rassegnato. Io leccavo svelta svelta i bollini, li applicavo sulla tessera nuova fiammante e gliela porgevo col più bel sor- 166 riso. Prendevo il denaro e, dopo aver registrato tutto in un quaderno, lo chiudevo in un cassetto. Prima di uscire, la sera, il segretario mi veniva accanto e mi bisbigliava: – Attenta ad Alfredo. Non dargli più acconti. Quello piange sempre. Mi raccomando: tieni chiuso, altrimenti sabato che ci portiamo a casa? Io ho la moglie malata e tre ragazzini che vanno a scuola… Per il sessantesimo di Di Vittorio “Il lavoro” aveva bandito un concorso per un racconto inedito. Un giorno, invece di andare a pranzo a casa, mi comprai un panino e restai in ufficio. Scrissi una storia, la rilessi, la infilai in busta e la mandai al direttore del settimanale, Gianni Toti. Quando, qualche tempo dopo, la vidi pubblicata, per poco non svenni. I compagni vennero a felicitarsi, a dirmi brava, chi se l’aspettava, ora devi pagare da bere. Non era proprio il primo premio, ma fui felice lo stesso. Consisteva in diecimila lire (circa un terzo del mensile di un operaio) con le quali mi comperai delle scarpe eleganti col tacco a spillo e un materasso nuovo. A casa nessuno disse niente. La mamma commentò che due paia di scarpe come quelle erano un’esagerazione mai vista. Nel partito il mio racconto fece una certa impressione. Parecchi compagni e compagne mi telefonarono per farmi complimenti e critiche. Franco Longo, che lavorava in tipografia e in segretezza scriveva, venne a trovarmi al sindacato e mi chiese di uscire insieme. – Mi dispiace, stasera ho il direttivo. Però se passi verso le undici e mezza alla Villetta per quell’ora dovremmo aver finito. – Va bene, giusto dovevo vedere il segretario. Ti aspetto e facciamo due passi, d’accordo? Allora a più tardi, ciao. La riunione non finiva mai. C’era da definire il piano per il mese della stampa comunista e ognuno doveva esporre le sue idee e le sue proposte. Quando terminammo Franco era ancora seduto in giardino con una grossa busta sotto il braccio. Appena mi vide mi venne incontro. – Sei ancora qui! Me n’ero dimenticata. Ma lo sai che è quasi mez- zanotte? Ho una fame che non ci vedo. Credi che Natali sia ancora aperto? – Sicuro. Quello prima dell’una, le due non chiude mai. – Scusa, quanti soldi hai in tasca? – Fammi vedere: tre, quattro, quattrocentoventicinque lire. – Io ne ho più di duecento. Siamo ricchi. 167 – Sai che buona come la fanno qui non l’ho mangiata in nessun posto? Sottile, croccante, ben condita, – dissi accartocciando uno spicchio di pizza bollente. – Allora, dici che ti è piaciuto davvero il mio racconto? – Nel complesso è buono. Ma, se me lo permetti, vorrei farti qualche critica. Per esempio, secondo me hai mancato la figura dell’ingegnere. Non è corretto, politicamente, identificare l’ingegnere col padrone. È inesatto e semplicistico. In fondo l’ingegnere, almeno in potenza, è un alleato dell’operaio. Poi, un’altra cosa: la moglie, così come la rappresenti, anche se ne fai una descrizione bellissima, molto realistica, in ultima analisi che cos’è? Una donna vinta, che si rassegna. Insomma, quello che voglio dire è che nella sua reazione non c’è speranza, peggio ancora, non c’è rivolta. È il messaggio che conta. Però, te l’ho detto, nell’insieme è un bel racconto. Sai scrivere, hai forza, ma è proprio per questo, nella misura in cui… Ecco, io non so spiegarmi bene ma tu mi capisci, vero? Per esempio, ecco, mi viene in mente la Panova. L’hai letta la Panova? E L’Agnese va a morire? Devi leggerli. Te li presterò. – Ma lì cosa c’è? – chiesi indicando il pacco che aveva posato sul tavolo. – Ah, niente. Certe cose che ho buttato giù. Volevo fartele vedere. Ma non importa, sarà per un’altra volta. Si è fatto troppo tardi, qui devono chiudere. Finisci quel vino, così paghiamo e ce ne andiamo. – Cosa sono, racconti? – Non proprio. Non saprei come definirli: riflessioni, pensieri, sfoghi. E poesie, ma quelle sono vecchie, l’ultima l’ho scritta tre anni fa, il 14 luglio, per l’attentato al nostro compagno Togliatti. Vedi, per me 168 scrivere è un bisogno prepotente. Mi sento qualcosa premere dentro e devo esprimermi. A dirle le cose non sono buono, devo scriverle. Troppo scriverei se ne avessi il tempo! Ho fatto leggere qualcosa a Bigiaretti. È un bravo compagno, lo conosci? Mi ha detto di continuare, di provare con un vero racconto, con personaggi reali, eccetera. I camerieri abbassarono le saracinesche. Per strada non girava più nessuno e s’era levato un po’ di vento. Mi strinsi il foulard attorno alla gola. – Vedi cara Maria, – continuò Franco prendendomi a braccetto, – una storia vera io ce l’avrei, ambientata in fabbrica, con un grande sciopero. L’hai letto La fabbrica parla di… come si chiama? Forte! Sai, in fabbrica io ci sto da quando ero alto così e i problemi, la psicologia dell’operaio li conosco. – Allora coraggio, buttati. – È una parola! E poi è il tempo che non c’è. Tra il lavoro, la politica, la stampa, i libri da leggere. Tu lo sai com’è nel nostro partito, se non leggi, non studi, resti indietro. La sera finisce che faccio sempre tardi e la mattina per alzarmi… – A chi lo dici! È così per tutti. Guarda da noi: stasera oltre ai corsi di taglio, alla squadra di pallacanestro femminile e tutto il resto abbiamo deciso di organizzare un gruppo teatrale. Non so come farò. Ci vorrebbe che le giornate non fossero di ventiquattr’ore e che il tempo potesse allungarsi a nostro piacere. E le notti… Io non ho nessunissima voglia di andare a dormire, adesso. Si sta così bene fuori. – È vero. – La notte si parla meglio: ti senti la testa lucida, le idee più chiare. Se avessi la macchina da scrivere a casa potrei lavorare. Sarebbe il momento migliore. Il guaio è che appena infilo il foglio mi vengono mille pensieri, mille paure. Penso a tutti i libri che ho letto e mi pare che non potrò mai dire nulla di nuovo e di bello. Insomma, mi sento scoperta, fragile, piena di dubbi. Forse non dovrei pensarci troppo. Quel racconto l’ho scritto di getto, senza rifletterci neanche un minuto. Da una parte è stato meglio, no? 169 – Ma va’, tu sei brava, sai scrivere, hai studiato. A me invece mancano i mezzi, le basi; non mi raccapezzo coi verbi, la punteggiatura poi, un macello! Eravamo arrivati al portone. Ci fermammo a parlare ancora un po’. – Ho appena finito le Cronache di Pratolini. L’hai visto il film di Lizzani? Ora sto attaccando Pavese. Ti piace Pavese? – Scherzi? Lui è Dante! La luna e i falò l’ho letto due volte di seguito. Che libro! – Mammamia Franco, ma lo sai che ore sono? E chi si alza domani? Stiamo chiacchierando dalla bellezza di tre ore. Ti rendi conto? – Ma io sono contento e ti ringrazio. Sei proprio una brava compagna. Allora, la vuoi davvero questa roba? Però, mi raccomando, Maria, non dire niente a nessuno. – Sta’ sicuro. E buttati, non pensare alla punteggiatura. Lui voleva dire ancora qualcosa, ma io gli strinsi la mano e attraversai di corsa il cortile deserto e addormentato sotto la luna. II 170 C’era la luce accesa in cucina. Pensai fosse Livio. La mamma gli aveva tolto la lampada in camera perché non consumasse la luce e lui se ne stava lì fino a notte tarda a leggere, piegato sul tavolo con un libro davanti. Mi affacciai per salutarlo ma vidi mio padre seduto a testa china, che mi voltava le spalle. Si alzò e mi indicò la sveglia sulla credenza. – L’hai guardato l’orologio? – attaccò. – Ti pare l’ora di rientrare? Dove sei stata? – Lo so, ho fatto tardi in sezione… – Fino a quest’ora? – No. Dopo ho fatto una chiacchierata con un compagno. Dovevamo discutere di certe cose e il tempo è volato. – Discutere? A chi la dài a bere? – Le cose stanno così e se non ci vuoi credere, affari tuoi. – Non usare questo tono con me, e vergognati. Andare in giro di notte come una di quelle. Neanche i maschi lo fanno. I tuoi fratelli sono a letto da ore. Bada, ti avverto, è ora di finirla: o cambi vita o ti sbatto fuori di casa. Per causa tua siamo diventati lo zimbello del palazzo, anzi del quartiere. – Come sarebbe per colpa mia? Che cosa faccio di male? – E me lo domandi, svergognata! I compagni! La sezione! Bella scusa! Il partito è diventato il tuo paravento! È ora di finirla, te l’ho detto e te lo ripeto: se non metti la testa a posto, se non cambi vita e ti comporti come tutte le ragazze perbene del mondo, quella è la porta. Tanto, che cosa significano per te la casa, la famiglia? Te ne infischi di tutto e di tutti. Tua madre poverina si ammazza di fatica, io non mi reggo in piedi eppure sgobbo per tirare avanti la baracca, e tu fai i tuoi porci comodi tutto il giorno. – Veramente io tutto il giorno lavoro, se non ti dispiace. Picchio sui tasti di una macchina da scrivere che mi rompe le spalle, io, tutto il giorno. 171 – Ah, sì? E dove sarebbero i proventi di questo lavoro? Tua madre dice che non le dài un soldo. – Do quello che posso, quel poco che prendo ogni sabato. Mica lavoro in banca. Che dovrei fare, andare a rubare? – Tua madre dice che non dài niente. Io queste cose non le so e non voglio saperle. Lei dice così. Si lamenta che i soldi non bastano. – È colpa mia forse? Io do quello che mi danno, ed è già molto, dovresti saperlo. Lo sai dove lavoro, o no? – No, io non so nulla. Io sono l’ultimo a sapere le cose, in questa casa… Tua madre dice che da un po’ di tempo ti sei data alle spese pazze. Scarpe di lusso, ristoranti, sigarette americane… Dice che ha trovato un mozzicone sotto il tuo letto. Io non sapevo nemmeno che fumassi. Che vergogna! Anche quest’altro vizio! Dove li prendi i soldi? Non risposi. Con un gesto meccanico scoprii il piatto della cena con un pezzo di frittata. Sospirai, lo ricoprii e alzai gli occhi su mio padre: mi fissava triste. Lo osservai a lungo. Era molto dimagrito, sembrava sofferente. Restammo a guardarci in silenzio. – Hai preso una brutta piega, – sospirò infine. – E dire che avevo riposto tante speranze in te. Da piccola eri così brava, così buona, così affezionata. Non dimenticherò mai il giorno che arrivaste in quel paesaccio. Neanche tua madre era tanto commossa… Sei così cambiata! Non ti riconosco. Sei diventata dura, insensibile, egoista. Te ne infischi di tutti: di tua madre, di me… – Non è vero. Siete voi che vi ricordate di me solo per rimproverarmi, insultarmi… Siete capaci solo di vedere il male e per il resto ve ne fregate. Le buone parole, l’affetto, i riconoscimenti, devo aspettarmeli dagli estranei. I piaceri della famiglia! Da quanto tempo mia madre non mi chiede come sto, non mi fa una carezza… – La colpa è vostra. Prima, quando eravate piccoli, non era così. Vi siete staccati, disamorati un po’ alla volta, noi genitori non ci calcolate niente… Eppure basterebbe così poco: una parola, un gesto. Invece… Potremmo anche crepare per quello che ve ne importa… – Non è vero, – mormorai senza convinzione. 172 Che cosa ci era successo? Da quando era cominciato? Da cosa era nata quell’insofferenza, quell’ostilità verso i loro discorsi, il loro modo di vivere. Davvero più nulla ci teneva uniti? Perché ognuno di noi non sognava che andarsene, fuggire, ricominciare da capo, ma altrove, fuori, lontano di lì? Perché siamo arrivati a questo punto? Basterebbe così poco, aveva detto, una parola, un gesto… Forse. O forse no. Forse troppe parole erano state dette e avevano fatto il marcio. Perché non taci? Non smetti di farti del male? – Credevo di aver formato una famiglia, lavora, mi dicevo, fai sacrifici, un giorno ti ricompenseranno, sarai orgoglioso di loro, diventeranno la tua consolazione. E invece… Tuo fratello si è messo con quell’analfabeta, che mi devo vergognare quando la incontro per strada; quell’altro è uno scioperato, un imbrattacarte e non ha un filo di rispetto per nessuno. E te… te non ti riconosco. Ho rinunciato a capirti… Non ho più forze, mi toccherà entrare in ospedale e chissà se ne uscirò mai. A volte penso che tutto sommato sarebbe meglio. Tanto, che cosa ci sto a fare? Non parlava più per me. S’era seduto e poggiò il capo sulle braccia incrociate sul tavolo. Vedevo il cranio bianco sotto i capelli fini e radi. Feci il conto degli anni: non arrivava a cinquanta ed era ridotto così. Era davvero tanto avvilito da desiderare la fine? Aveva parlato di ospedale, di morte. Era veramente così ammalato? Come mi sembrò vecchio! Lo sentivo borbottare, senza capire le parole e non mi riuscì di dirgli qualcosa, di fargli una domanda. Alla fine si alzò, prese il bicarbonato e un bicchiere dalla credenza. Glieli tolsi dalle mani. – Dài qua, te lo preparo io, – dissi. L’offerta di pace naufragò nella durezza del gesto e della voce. Versai l’acqua nel bicchiere e mescolai finché la polvere fu ben sciolta. – Come ti senti? – chiesi. – Eh, che vuoi… – Perché non vai a letto? Credi che ti facciano bene queste scenate? Tutta questa amarezza? – Lo so, lo so. Anche tu. Hai una faccia… Non mi piace affatto come stai. Sei sciupata. Vai a dormire, va’. E non me le far dire più certe cose. Mi ripugna. A volte si diventa cattivi. – Sì. Non è colpa di nessuno. – Perché non mi abbraccia? – Va’, va’, buonanotte. E cerca di capirla, tua madre. Sii indulgente con lei. Stalle più vicina, se puoi. Non è felice. Non ha fatto una bella vita. Mi posò una mano sulla testa. Perché non lo abbraccio? Chinai il capo affinché non si accorgesse delle lacrime e rimasi tesa e rigida mentre si allontanava fino a che sentii il cigolio della porta che si chiudeva alle sue spalle. 173 Dopo quella scena, avevo cercato di stare un po’ di più in casa, con mia madre. Una domenica l’aiutai a fare le faccende e per tutta la mattina cantammo, ridemmo, che pareva tornata la vita di una volta. Appena mangiato papà andò a letto e noi due restammo a sparecchiare, lavare i piatti, passare lo straccio sul pavimento di cucina e intanto chiacchieravamo di attrici, di canzonette, di programmi radiofonici. Lei sembrava contenta: parlava, parlava. – Sofia, bella sì, ma esagerata, volgare, Nilla, la vera signora della canzone, i film italiani uno schifo: uno va al cinema per sognare, dimenticarsi i guai, vedere qualcosa di diverso dalla vita grama di tutti i giorni, e invece... Io facevo di sì col capo, tenendo gli occhi bassi perché non vi si leggesse la voglia di sbottare, cambiavo discorso per non dire tutto quello che pensavo. Parlammo di vestiti. Per l’autunno, giusto per il suo compleanno, disse, le sarebbe piaciuto un completino d’angora Giulietta-eRomeo color grigio perla, tanto fine. Poi ci mettemmo alla finestra, con la faccia fissa a guardar fuori, e non sapevamo più che cosa dire. Passò la ragazza del quinto piano con l’impermeabile nero e il cappellino abbassato sugli occhi. – Deve venire un’acqua… – Pensi? – Guarda: cielo a pecorelle, acqua a catinelle. – Già. – Certo che quest’anno abbiamo avuto una stagione! Mah, non ci si 174 capisce più niente. Una volta l’estate era estate. La rabbia è che si guasta proprio la domenica. – In fondo è un giorno come un altro. – Non è vero, la domenica è domenica. Tu che fai oggi, non esci? – Non lo so, forse stasera… Aspetto una telefonata. Mi scrutava di traverso con quel suo sguardo che sembrava indifferente e invece indagava e leggeva anche nei pensieri più riposti. – Non ti stanno mica bene i capelli così. – Dici? – Perché non ti fai più la riga in mezzo? Quella sera che andasti a ballare insieme a Gioia stavi tanto bene, col vestito nero lungo. Dovresti sempre vestire di nero: sfina. Sai che potresti fare ai capelli? Lavarli con la camomilla. Gli dà dei bei riflessi. Io da ragazza lo facevo sempre. Tua nonna era una fanatica! Li avevo lunghi fino a qui e per pettinarli era uno strazio! Che stupida però sono stata a tagliarli. Ormai, passata una certa età non ricrescono più. Aveva cominciato a piovere. Delle gocce grosse e rade. La mamma accostò le persiane. – Che ti dicevo? Cielo a pecorelle… Non mi sbaglio mai. Stanotte il callo mi faceva un male... Però, che bello l’odore della terra bagnata! Mi è sempre piaciuto tanto. – Senti, – dissi dopo un lungo silenzio, – perché non andiamo a vedere “Ladri di biciclette” tutti e quattro? Lo danno al Tirreno. – Al Tirreno? Mm, lì non si trova mai posto. – La domenica è così dappertutto, però se andiamo presto… – Tocca prendere il tram. – Solo poche fermate. – Mah, che vuoi che ti dica? Non mi va tanto. Sai cosa facciamo? Qui alla sala parrocchiale danno un film bellissimo con Ava Gardner. Si paga poco e l’ambiente è tranquillo, familiare, signorile. Magari al Tirreno ci vai tu con tuo padre, sai quanto lo faresti contento? e io e Paola ce ne andiamo dai preti. – Pensavo che era bello per una volta andare tutti insieme. 175 – Ma quello dai preti non ci viene manco a morire, lo sai. E poi i film americani non li sopporta. E io di prendere il tram non ho proprio voglia. La pioggia aveva preso a scrosciare rumorosa. Picchiava sulla ghiaia con un rumore di grandine. Chiudemmo i vetri e andammo a riposare senza dirci altro. A letto mi misi a sfogliare un libro, ma dopo un po’ mi venne sonno e dormii fino alle otto di sera. Quando mi svegliai in casa non c’era nessuno. Il telefono non aveva squillato. Raccolsi il libro e ripresi da dove ero rimasta, cercando di concentrarmi. A mano a mano che andavo avanti, la lettura mi dava una specie di esaltazione. Mi colpiva la verità del testo: i protagonisti, i loro discorsi, il loro dramma. Il vecchio mondo agonizzante contrapposto a quello dei giovani; lo sfacelo di una società incapace di guardare all’avvenire, di superare i propri errori; la viltà, la meschinità, la fiacchezza dei personaggi piccolo-borghesi… Quante volte avevo sentito e odiato le loro argomentazioni. Come somigliavano alla nostra vita! A mio padre, con tutta la sua anarchia fatta di chiacchiere, di fumo, che si inebriava di parole come libertà, giustizia, emancipazione, rivoluzione, e in realtà disprezzava il popolo sporco, ignorante, volgare. Aveva odiato il fascismo e adesso era incapace di inserirsi nella nuova realtà, e odiava tutti. In fondo era sempre stato uno schiavo, anche delle sue idee, schiavo della miseria, della paura, della fame, della moglie, di tutto. Che cos’era dunque il suo comunismo, che cos’era stato per tutti quegli anni? Soltanto chiacchiere. Provai un profondo disgusto. Dovevo fuggire, ribellarmi. Fuori da quelle mura ogni cosa si chiariva, acquistava il suo giusto senso, io stessa mi sentivo diversa. Fuori di lì i rapporti con gli altri, col mondo, erano schietti, sinceri. Fuori di lì c’era la vita, intera, coi suoi chiari e i suoi scuri ben definiti. Fuori c’era l’avvenire, la libertà. Non volevo finire come mio padre. Dovevo rompere una volta per tutte con l’ipocrisia, il conformismo, i compromessi, seguire la mia strada fino in fondo, senza remore e senza sciocchi sentimentalismi. Dovevo andarmene. Subito. Mi preparai e uscii sbattendo la porta. III 176 La pioggia aveva lasciato l’aria pulita. Le strade erano lucide e dai campi vicini veniva un forte odore di terra bagnata. L’odore che piace tanto a mia madre, pensai. Ma l’umidità me la sentivo tutta nei capelli, con una sensazione di freddo alla nuca. Camminavo a passi decisi, ignorando dove sarei andata. Salgo sul primo tram che passa, poi vedremo, mi dissi. Non c’era molta gente in giro. Dalle osterie venivano voci ancora sobrie. Le finestre delle case splendevano accese. Tutti a cena. Tutti contenti. Chissà cosa mangeremo noi stasera. Mamma al cinema con Paola a vedere un film con Ava Gardner, tanto bello e commovente, papà in giro con qualcuno a chiacchierare. Gli altri chi lo sa. Tutti contenti. Arrivai alla piazzetta del capolinea. Un capannello di giovanotti sostava in silenzio. Aspettavano annoiati che passasse una ragazza per fischiare o lanciare un commento. Un tram semivuoto passò sibilando tristemente sulle rotaie. Mi mancò il coraggio di salire. Mi sentivo sconsolata. E se andassi al cinema anch’io, mi dissi, oppure in sezione: lì qualcuno troverò. – Toh, guarda chi si vede! Dopo tanto tempo! Almeno tre anni! Ciao Maria! Ti trovo proprio bene, sei diventata più carina. – Ciao, Clara, come mai da queste parti? – Sono venuta a vedere l’appartamento. Sai, tra un mese mi sposo. A proposito, permetti? ti presento Michele, il mio fidanzato. – Piacere. – Vedessi che bella casetta: un nido, dalle tue parti, sulla via Imperiale. – Cristoforo Colombo, ora si chiama Cristoforo Colombo. E con lo studio del canto come va? 177 – Ah, l’ho lasciato. Il mio fidanzato non era d’accordo. Tanto ormai a che mi serve? Canto per me, per soddisfazione personale, e mi basta. Ma parlami di te. Sei fidanzata? No? E cosa aspetti? Una bella ragazza come te, mica vorrai restare zitella! – Sposarmi, io? Non ci penso proprio. Non c’è solo il matrimonio nella vita. Cominciavo a sentirmi imbarazzata. Non sapevo più che cosa dire. Provavo rabbia, e fastidio. Queste ragazze appena trovano marito rinunciano a tutto: aspirazioni, sogni, non esiste più nulla. – Be’, sono contenta di averti vista e ti faccio tanti auguri. Magari vengo a trovarti, se ti fa piacere. – Ci mancherebbe! Ti manderò l’invito, e guarda che se non vieni al matrimonio mi offendo. Abiti sempre lì, al primo lotto? – Sì, non è cambiato niente. Lei invece era cambiata. Dimostrava almeno dieci anni di più con quell’abito scuro, il cappellino, l’aria soddisfatta. Più grassa e meno bella, soprattutto meno viva di come la ricordavo, di quando sognava di diventare una soprano d’opera. Avrebbe dovuto continuare. L’insegnante diceva che una voce come quella non la si sentiva dai tempi della Toti. Una volta ero andata a casa sua, uno di quegli appartamenti all’antica, coi canarini, gli acquarelli alle pareti, i mobili di stile e le piante in anticamera. La mamma, una donnetta garbata già tutta bianca, ci portò il tè e restò un po’ con noi. Era orgogliosa di Clara ma non avrebbe mai voluto che cantasse in pubblico, solo per sé, per soddisfazione personale, disse, esattamente come aveva detto lei poco fa. – Come sta tua madre? – chiesi bruscamente. – Mica tanto bene, poverina. Sono in pena per lei. Dovrà operarsi al fegato. – Anche mio padre, – dissi macchinalmente. Già, anche lui dovrebbe operarsi. Chissà quando si deciderà a entrare in ospedale. – Allora ciao Clara. Mi ha fatto tanto piacere rivederti. E mille auguri anche a lei, Michele. 178 Strinsi frettolosamente la mano a tutt’e due e, senza dargli il tempo di replicare, me ne andai. Quell’incontro aveva aumentato il mio malumore. Odiosa quella Clara stupida, grassa e soddisfatta. Di che? Sciocca piccolo-borghese che si porta il fidanzato come un trofeo. Che schifo! Feci quasi di corsa l’ultimo tratto di strada e quando varcai il cancello della Villetta mi vennero incontro Mario e Giulia con la faccia allarmata. – Ma dove t’eri cacciata? Ti abbiamo cercato, telefonato… – Che avete? Che succede? – Ma come, non sai niente? Ieri sera la polizia ha circondato la federazione. Sono entrati, hanno perquisito, hanno fatto un bordello. – Siete sicuri? Non sarà una balla! – No, no, è vero. Bisogna avvertire i compagni, mobilitarli. Domani c’è una manifestazione. Dài, muoviamoci. – Ma il partito che dice? Con quale pretesto sarebbero andati in federazione? Che cercavano? – Pretesto! Sai, questi stanno perdendo le staffe, con le botte che prendono in Corea. – Che c’entra la Corea? – C’entra, c’entra. Ma venerdì non c’eri alla conferenza? Il compagno della federazione ci ha spiegato tutto. Bisogna darci dentro con la propaganda per la pace, contro l’aggressione USA. Domani è fondamentale essere in tanti. Tu pensa alle ragazze. – Le ragazze? Va bene. – Dividiamoci le zone. Io faccio gli Alberghi, i Bagni e la Scuola. Tu l’Incis, le Case rapide e Sciangai. Ci troviamo più tardi in sezione. Mi raccomando: appuntamento domani alle sei alla Villetta. Mi ci volle del bello e del buono per convincere quelle che trovai. Le sei era un orario scomodo per chi lavorava, altre dovevano badare al pupo, altre la mamma o il papà o il fidanzato non ce le mandava. Quando finii il mio giro erano passate più di due ore. Mi sentivo a pezzi, ero sudata e mi era andata via la voce. In sezione era ancora pieno di compagni, fuori in giardino e dentro, in tutte le stanze. Chiac- 179 chiericcio animato, occhi lustri, facce accaldate. Trovai tanti che non vedevo da tempo, quelli che appena c’era da fare spuntavano come funghi. Faceva piacere ritrovarli tutti, ansiosi, eccitati, seri. C’era anche Livio: insieme a due compagni imbianchini scrivevano slogan in una confusione di carta, pennelli, bidoni di tinta e di colla. – Aho, ciao, Marì! Hai qualcosa da masticare? Sto morendo di fame. – M’hai scambiato per la mensa popolare? – Magari! Dacci una mano, dài. Qui ci sono pennelli e colori, lì la carta. Le parole d’ordine le sai: Giù le mani dalla Corea; La Corea ai coreani; e poi la pace come ti pare, sbriglia la fantasia. – Ragazzi, pietà, io sono distrutta. Mi fanno male i piedi. – Mica devi scrivere coi piedi, – risero. Mi feci largo fra loro. Mi sentivo ripresa da quella eccitazione febbrile di certe giornate di preparativi. Eravamo tutti allegri. I ragazzi scherzavano. – Ehi, senti un po’, signora maestra. Giù si scrive con l’accento o senza? – Guardate che capolavoro! Eh, cosa ne dite? Altro che Picasso! Sono sì o no un artista? – Più che una colomba sembra una gallina, – e giù a ridere. – Ma le scritte stanotte chi le fa? – Chi è l’artista? – Eh no, cari miei. Io ho le braccia che non me le sento più. E poi mi è finita l’ispirazione. Stacco e vi saluto. Mandateci Benito. Lo specialista è lui. Lo sapevate che quando c’erano i tedeschi, Benito fece una scritta al Testaccio grossa come un tram. Solo che fece la zeta alla rovescia e la mattina sui muri si lesse: A morte i nasi! – Ah ah. A morte i nasi e viva i cosi! – Calma compagni. – E che sarà mai signora maestra. Che ho detto? Affamati, rotti dalla stanchezza, alla fine andammo a mangiare la pizza da Natali. – Ma voi non avete nessuno a casa che vi aspetta? – disse l’oste sversando il vino. – Qui tra poco si chiude bottega. 180 In realtà era ancora pieno di famiglie. I mariti ubriachi raccontavano storielle sporche, ridevano e toccavano le mogli grasse. I ragazzini dormivano con la testa ciondoloni sul tavolo, in mezzo alle bottiglie e ai piatti unti. – Certo, – mi soffiò Livio all’orecchio, – se penso che lottiamo per questa gente… – Perché? Sono belli. Sono veri. – Ma va’, non fare la populista. E poi dicono il proletariato sano. Ci vuoi scommettere che quelle ciccione ci hanno tutte l’amico, che magari è il compare, il cognato, e che magari il marito lo sa e ci mangia pure, magari? – Ma piantala! Oh, ce la facciamo un’altra pizza in due? – Sì, dài, una marinara con tanto aglio. Qualcuno tentò di mettersi a parlare sul serio dei soprusi della polizia, del governo liberticida, delle vittorie in Corea, della guerra batteriologica, del generale Ridgway detto peste, ma nessuno aveva voglia di ascoltarlo. Ci andava di cantare, di stare allegri e non pensare a niente. IV 181 Quel Natale Miro doveva portare in casa la fidanzata per presentarla ufficialmente a papà. Noi eravamo tutti preoccupati ma ci sforzavamo di stare calmi e allegri per non turbare quell’unica occasione di stare insieme, uniti e sereni. La mamma era in faccende fin dal mattino perché la cena di vigilia fosse scrupolosamente secondo tradizione: capitone, frittelle di cavolfiore, spaghetti di mare, panettone, frutta secca e torroni. Livio si era occupato dell’albero, perché lui era un artista e sapeva addobbarlo proprio bene. Io avevo lavorato fino a tardi, e per fortuna quella sera i soldi da spartirci al sindacato non erano mancati. Tornammo a casa tutti con un bel gruzzoletto. Mamma fu contenta del regalino che avevo fatto in tempo a comprarle. I ragazzini eccitati e pettinatissimi correvano dai fornelli al salotto dove c’era l’albero coi doni. Gioia e il marito erano già arrivati pieni di pacchi. Più tardi Gioia, che aveva imparato a fare le fotografie, riprese tutto il gruppo attorno alla tavola, con le candeline accese e poi papà da solo, col gatto in braccio e il sorriso tirato. La mamma scolava già la pasta quando giunsero Miro e la ragazza. Vestita a festa, coi tacchi alti e il rossetto, Ada sembrava anche più impacciata. Aveva portato un ramo di vischio e non sapeva dove metterlo. Le andai incontro per aiutarla, feci le presentazioni e se Dio volle ci sedemmo a tavola. Mio padre non aveva aperto bocca e Miro era sulle spine. Fu Ada a sciogliere il ghiaccio. Sedette accanto al futuro suocero e fece di tutto per entrare nelle sue grazie. Lo sollecitava a parlare di politica, stava a sentire le sue tirate, gli dava ragione, era solerte nel servirlo, cambiargli il piatto, versargli da bere: alla fine della cena lo aveva conquistato, con soddisfazione di tutti, tranne di mia madre che sembrava contrariata e lo faceva vedere. 182 – Quello lì, basta fargli due moine, te lo sei bell’e comprato. Due ore fa non voleva neppure farla entrare in casa, – borbottò. I guai iniziarono dopo il panettone. Livio si alzò da tavola. – Be’, allora noi andiamo. Sei pronta, Marì? Ci aspettavano per il brindisi di mezzanotte in casa di un’amica pittrice. Io dovevo solo infilarmi le scarpe col tacco e ritoccarmi il trucco. – Cosa, cosa? – insorse mio padre, già nero. – Cosa vorresti fare tu? Stasera non si va in nessun posto. Stasera è Natale e si sta a casa, in famiglia. – Mi dispiace, papà, ma abbiamo preso un impegno. – E allora vi spegnate. Se permetti, la famiglia è più importante. – Non possiamo fare questa figura. Ci aspettano in una casa, in una famiglia per bene. – Una famiglia perbene! Perché, noi cosa siamo? Questo è il ristorante, forse, che uno mangia e se ne va? – Andiamo, papà! Tanto ormai il cenone l’abbiamo fatto tutti insieme, no? La tradizione è rispettata. Cosa ci stiamo a fare, adesso, a giocare a tombola coi ragazzini? – Sicuro. Non mi sembra un disonore giocare a tombola coi fratelli, col padre e con la madre, la sera di Natale. – Papà, ti prego, non mettiamoci a discutere, a litigare. Ci hanno invitato, non possiamo mancare, veramente, sarebbe uno sgarbo. Tanto ci sono loro, no? Gioia, Giuliano, Ada… Dài, Maria, muoviti. – Sai che ti dico? – sbottò mio padre. – Me ne infischio dello sgarbo! Stasera non si esce. Si sta in casa come in tutte le famiglie del mondo. I tuoi amici me li saluti. Gli fai una telefonata e gli dici che ti dispiace tanto ma non puoi uscire perché tuo padre vuole così. Livio fremeva. – Non esiste, – disse sedendosi e poi rialzandosi e sedendosi di nuovo, masticando rabbiosamente un pezzo di torrone. – Andiamo, Maria. Si sta facendo tardi. – Tu sta’ ferma, non provare a muoverti! – urlò papà. – O qui succede il finimondo! 183 Livio sogghignò: – Non farmi ridere. Papà scattò in piedi, pallidissimo. Mamma si interpose. – E lascia che vadano, che t’importa? Mica puoi obbligarli. Non si può stare in paradiso a dispetto dei santi. Se se ne vogliono andare, che vadano. Non è il caso di fare queste chiassate davanti agli estranei. – Sta’ zitta tu e non spalleggiarli. Fino a prova contraria chi comanda è il padre di famiglia. Finché avrò gli occhi aperti, si fa a modo mio. Quando non ci sarò più, allora farete quello che volete, nessuno ve lo impedirà. Ada, cui non era sfuggita la frecciata di mia madre, volle dire la sua. – Via professore, non se la prenda così. Sua moglie ha ragione: non vale la pena arrabbiarsi. C’è Gioia, suo genero, ci siamo Miro e io, siamo in tanti per giocare. Noi non ce ne andiamo. Su, su, si calmi, che se poi si sente male, chi ci rimette è lei. – È una questione di principio, di autorità. Qui è diventata un’anarchia. Ognuno fa i comodi suoi. Non c’è più rispetto… E non ci si metta anche lei a difenderli. Sono dei mascalzoni, dei maleducati, dei villani. Hanno preso la casa per l’albergo, ma stasera non transigo. Livio scrollò le spalle, mi fece cenno di muovermi e si alzò pulendosi la bocca col tovagliolo. – Chi ti ha dato il permesso di alzarti da tavola? Chi ti ha insegnato l’educazione? Dove sei cresciuto, in una stalla? – Pressappoco, – ridacchiò livido Livio. – L’educazione! Tu e lei me l’avete insegnata! Tu e lei! Mia madre chinò la testa sul piatto e non fiatava. – Io t’ammazzo, delinquente! – urlò mio padre afferrando un piatto e scagliandolo. – T’ammazzo quant’è vero Iddio! Ma Livio con un balzo era già alla porta. – Buon Natale a tutti, – disse con aria beffarda e la voce che gli tremava. – Andiamo Marì. – Possibile che non si possa vivere come persone civili, in questa casa maledetta? – dissi alzandomi. – Non potreste piantarla una buona volta, tutti quanti? – Zitta tu, che sei peggio di lui. E andatevene dove volete. Andate al diavolo! Se vi fa tanto schifo, la via di casa scordatevela! Non fatevi più vedere! Mai più! S’era seduto e aveva ricominciato a mangiare. Faceva sempre così, mio padre: dopo lo sfogo bastava andargli vicino, chiedergli scusa, dirgli una parola gentile, che gli passava tutto. Io invece mi sentivo lo stomaco e la bocca pieni di veleno, tremavo e mi sarei messa a urlare. Livio mi incalzava dalla porta, presi il cappotto, la borsetta, e lo seguii senza nemmeno un’occhiata allo specchio. Sentii dietro di me la voce di Ada. – Però il professore ha ragione, non è bello. Sono serate che si sta in famiglia, tutti uniti, queste. 184 La festa da Maria Eugenia durò tutta la notte. Lei ci venne incontro scuotendo la zazzeretta bionda. Baciò Livio, mi portò in camera a togliermi il cappotto e poi mi presentò gli amici, tutti personaggi importanti che conoscevo di nome e di fama: pittori, giornalisti, politici… La casa era piena di quadri, di luci, di fiori, di fumo, di risate e di divani dove si sprofondava. Il bar era zeppo di liquori e quando arrivammo erano già tutti brilli. I discorsi restavano appesi per aria, incompiuti, accavallati. Ogni tanto dal chiasso emergeva una frase, un nome: Guttuso, Levi, Neruda, Visconti, Gene Kelly… Un paio di volte incontrai la mia faccia in uno specchio: spettrale. Non ingranavo. Mi sentivo fuori luogo, impacciata, fredda. Non riuscivo a dimenticare quello che era successo e invece di distrarmi, quella baldoria acuiva la mia solitudine e il mio malumore. Livio lo perdevo continuamente di vista, ma anche lui non doveva essere contento. Lo conoscevo troppo bene per credere che gli fosse passato tutto e che quella baraonda lo divertisse davvero. Ci ritrovammo fuori, nell’aria livida e gelida del primo mattino. Chi se n’era andato in macchina chi in taxi e noi restammo soli. Respirai a fondo e mi ingolfai nei pensieri, finalmente libera. I pensieri di Livio si muovevano paralleli ai miei e questo mi aiutava, dandomi una sensazione riposante di complicità e di sicurezza. – Queste baldorie, questa gente, queste feste, ti lasciano il mal di testa e la bocca amara. 185 – Già. Loro però si divertono, a quanto pare. Sono così, ci credono. Forse. – Non mi piace. Non ti resta niente: parole, sciocchezze… – In fondo li invidio. Bevono e tirano fuori quello che hanno in corpo. – Io invece non so divertirmi. Non riesco a sputare la rabbia, il veleno che ho dentro. – Non avresti dovuto impuntarti così, stasera. A che serve? Bastava recitare il ruolo dei bravi ragazzi per una volta e tutti erano felici e contenti. – Credi che non mi piacerebbe? Credi che ami questi borghesi di merda? Il fatto è che io non riesco a essere diplomatico come Miro o come Gioia… Che senso ha fare i bravi ragazzi, recitare alla famiglia unita a Natale? Quale Natale? Quale famiglia? Non puoi ricordarti di essere una famiglia una volta l’anno, magari per farti bello davanti a un’estranea. È l’ipocrisia che non sopporto. Mi dà il voltastomaco. – Lo so. Per me è la stessa cosa. Quello che mi dà più fastidio è l’equivoco. È il non sapere quello che vogliamo, confondere le carte, oscillare sempre tra velleità e speranza. Non siamo né rivoluzionari né borghesi. Non apparteniamo a nessuna classe. Che vuol dire esattamente essere comunisti per gente come noi? Io mi sento in gabbia, vorrei fuggire e so di non esserne capace. Di non averne la forza. Bisognerebbe avere il coraggio di rompere, tagliare netto, fare tabula rasa. – Sì, ma come? In fondo è quello che vorrebbero anche loro, che ci togliessimo dai piedi. Ma non abbiamo né i mezzi né la forza per farlo. Tu, piuttosto, potresti sposarti e andartene, come ha fatto Gioia. – Un bel modo di risolvere il problema! Fuggire da una gabbia per infilarsi in un’altra! Guardati intorno: ti sembra di vedere degli esempi incoraggianti? Guarda loro due. – Già, in realtà sono degli sconfitti, dei falliti. Forse anche loro hanno avuto dei sogni. Forse meritavano di più. Forse hanno sbagliato tutto. Forse se le cose fossero andate diversamente oggi non sarebbe- ro così amareggiati, non dovrebbero rimpiangere o vergognarsi di nulla. Se… se… se… – Con i se e con i forse non si va da nessuna parte. Povero papà. Se ricordo com’era, pieno di speranze, di entusiasmi. Le cose che ci diceva, che ci insegnava! Mi fa tanta pena. In fondo si è logorato per noi che ora lo giudichiamo, lo condanniamo. – Non l’abbiamo chiesto noi di metterci al mondo e se questo è un mondo disgraziato la colpa non è nostra. – Ora sei ingiusto. – La giustizia non c’entra. È così e basta. – Povero papà, – ripetei. – È tanto cambiato, è come spento. A volte mi sembra che non ce la faccia più, e la cosa terribile è che non possiamo farci niente. Hai ragione tu: non abbiamo colpa. E adesso è troppo tardi. 186 Le strade del quartiere erano silenziose, immerse in un riposo greve, come se l’affanno festoso di tutti quei giorni le avesse sfiancate. C’era un senso pacato e malinconico di cosa finita. Consumata. La porta di casa era chiusa dall’interno. Le chiavi non entravano. – Aspettami qui, – disse Livio. – Attento, non fare rumore. Lui si tolse le scarpe, saltò dalla finestra sulle scale e venne ad aprirmi. – Che bellezza le feste, – disse sorridendo triste. – Già. Evviva il bambin Gesù. – Vado a dormire. Notte Marì. – Notte Livio e buon Natale. V 187 Non fu un buon Natale, per nessuno. Soprattutto per mio padre. La mamma diceva che quella scenata era stata il colpo di grazia. In realtà dovevano essere stati il capitone, i fritti e le mandorle della cena, ma questo non alleviava il mio senso di colpa. Si mise a letto e ci restò quasi un mese. Livio e io evitavamo di entrare in camera: ci mancava il coraggio di dire la prima parola e ci angosciava saperlo sofferente. Quando una mattina venne a prenderselo l’ambulanza, non ero in casa e siccome la sera ritornai come sempre che tutti già dormivano, lo seppi soltanto il giorno dopo. Saltai sul tram col cuore in tumulto, scesi a Monte Savello e attraversai di corsa il ponte sull’isola. Era in corsia, tra una fila di lettini bianchi e stentai a ritrovare il suo volto fra gli altri, tutti uguali. Mi baciò, ma sembrava indifferente, neanche preoccupato per se stesso. Disse che gli stavano facendo i dovuti accertamenti e che poi, forse, lo avrebbero operato. Quella mattina, prima dei raggi, gli avevano fatto bere un bicchierone di robaccia torbida. – Che schifo! Neanche le purghe di Mussolini, – disse con la smorfia di un sorriso. – E non mi danno da mangiare. Parlò di una quantità di cose, ma senza anima e senza rancore. Gli dissi che sarei tornata l’indomani, di stare tranquillo, di non avvilirsi, che noi gli eravamo tutti vicini. Lui mi salutò con un sorriso smorto e con un debole cenno della mano. I platani sul lungotevere erano agitati da un vento freddo e furioso. Il fiume era buio e sporco. Mi sporsi dalla spalletta a guardare giù nella corrente che in quel punto ruggisce e fa paura. Mi sentivo stanca, svuotata e non avevo voglia di salire su un tram e tornare al lavoro. Guardavo l’acqua, il riverbero fioco delle finestrelle in fila sui muri tetri e bagnati e rivedevo il suo volto pallido, la sua smorfia triste, quel gesto debole della mano. La notte sarebbe stata lunga là dentro quelle mura, senza rumori e bianca, mai completamente buia. Forse neanche il rombo sordo del fiume giungeva a turbarne il silenzio, né il fruscio dei platani nel vento, né le voci della strada, lo stridio del tram. Chissà perché l’hanno fatto proprio qui in mezzo, pensai, così isolato, così triste, senza speranza, come un carcere. 188 Il freddo passò e tra gli alberi spirò la brezza dolce della primavera. Nel giardino dei malati sbocciarono i fiori e gli uomini uscirono. Paludati di bianco, esili, sconci, camminavano tenendosi a braccetto, o solitari, guardandosi i piedi. Poi venne anche il caldo e le larve bianche cercarono riparo all’afa sotto i grandi alberi del parco attorno all’edificio di pietra. – Si sta bene qui. C’è un filo d’aria. – Sì, ma fai attenzione, sei tutto sudato. – Quando sarò guarito e uscirò da questa galera, – disse un giorno, – voglio andare a trovare mio padre. – Ad Avezzano? – Sì. È tanto che non so nulla di lui. Voglio vederlo, parlargli. Non doveva fare quella sciocchezza, lasciare il partito dopo tanti anni, farsi lusingare dai saragattiani per l’ambizione di diventare senatore. Non gliel’ho mai perdonata. – È stata una debolezza di vecchio. Bisogna capirlo. E poi la moglie… – Già, già. Prendersi una donna così giovane alla sua età… Ma devo andarci, è passato troppo tempo. Voglio rivedere la nostra vecchia casa di famiglia. Te la ricordi, Mariò? Altro che se la ricordavo! Poco oltre il verde della villa incolta, il viale dei tigli e giù, che sta in piedi per miracolo, il castellaccio di don Titta dalle cento chiavi, come dicono in paese e ci sembrava una favola. E lì a fianco la casetta bianca con l’orto sul retro, il poggiolo e dentro 189 la penombra fresca delle stanze odorose di pulito, le librerie disordinate, il pianoforte, i busti di Goethe e di Schiller… – Eh? Te la ricordi la casa di nonno Antonio? – ripeté. – Ci andavamo d’estate… Le vacanze! I giorni spensierati! Le sere attorno al primo fuoco con le castagne a saltare nella padella bucata, le tasche piene di croccanti e lui di là a discutere di politica con gli amici e a fare la passatella. E zia Crocifissa, dritta come un tronco, la testa alta e bianca a sorvegliare il mondo intero, seduta con le mani in grembo, il busto incollato alla spalliera. E l’altra, la dolce zia Costantina col passo dondolante e le mani a paletta che preparava merende: pane rotondo e prosciutto salato che metteva sete di aranciata frizzante… Poi un giorno scrosciava la prima pioggia ed era la fine dell’estate. Ricominciava il turbine della partenza: le valigie, i saluti, il treno, il ritorno in città, la scuola… – Povero papà. Forse sono stato troppo severo con lui. Non sapeva che era morto un mese prima. Nessuno aveva voluto dirglielo. Era strano che proprio ora, dopo tanto tempo, ne parlasse e sentisse il bisogno di rivederlo. – Sì, sì, andremo a trovarlo. Ora devi pensare a guarire e rimetterti in forze. Quando ti avranno operato, tutto andrà a posto, vedrai. – Di’ a Livio che venga a trovare suo padre. Non è mai venuto in tutti questi mesi. Digli che non ce l’ho con lui. Ha un caratteraccio, ribelle, ma non è cattivo. Digli di venire. Digli che gli ho perdonato… diglielo… Scendeva la sera e mi veniva la smania di fuggire, di vedere gente sana, pulita. Appena fuori ripercorrevo quella strada che avevo fatto tante volte, mi voltavo a guardare l’edificio grigio e provavo solo un grande peso nel petto. Com’è piena di luci la strada di sera, com’è dolce la brezza che passa tra gli alberi e come risuona chiara la voce del fiume nei crepuscoli di ultima estate! Sarei tornata tra qualche giorno e l’avrei visto: un’ombra di sorriso, un gesto vago… Mi sarei seduta accanto al suo letto e per lunghe ore opprimenti non ci saremmo detti quasi nulla. Solo bugie. – Vuoi che andiamo in giardino? – No, oggi non me la sento. Sono tre giorni che non mi alzo dal letto nemmeno per andare al bagno. – Quando si decideranno a operarti? – Non si sa. Non si sa niente di niente. – Ma i dottori che dicono? – Niente di niente. Veniva il portantino col carrello a ritirare i pappagalli. – Dovete portarmi via. Qui mi faranno morire. – Non dire queste cose. Aspettavo con ansia che arrivasse l’infermiera a mandarci fuori. – L’ora delle visite è passata da un pezzo, ci decidiamo? Uscita! Uscita! Lui mi fissava con lo sguardo vuoto e rassegnato. Gli baciavo la fronte secca e fuggivo, leggera. 190 Lo spostarono in uno stanzino da solo, in fondo al corridoio, dove non vedeva nessuno. Teneva gli occhi fissi alla porta, pieni di rimprovero e di tristezza a vederci arrivare sempre troppo tardi. Poi, per tutto il tempo stava zitto. Faceva finta di dormire, per non guardarci, non parlare. Quando ce ne andavamo e ci volgevamo a salutarlo un’ultima volta, i suoi occhi erano di nuovo pieni di tristezza e di rancore. – Resta, – disse una sera a mia madre. – Ti prego, non andare via. Stai con me. È brutto la notte, da solo. – Come faccio coi ragazzini? Se me lo dicevi ieri mi organizzavo… Domani, domani rimango, te lo prometto, va bene? Domani. Su, sii buono, cerca di dormire, porta pazienza. Ormai c’è rimasto poco. Era vero. Mia madre non ebbe più bisogno di trovare giustificazioni per non restare con lui. Morì il pomeriggio del giorno dopo, mentre gli lisciavo i capelli sulla fronte e lui mi faceva segno disperatamente di dargli la matita che era sul comodino. Non riusciva a parlare, come avesse un sasso in gola. Livio mi guardò con gli occhi smarriti, pallidissimo, ma io continuavo a non capire. Quando gli porgemmo la matita, la mano non si sollevò e le dita non la strinsero. Uscii. Il sole gentile di settembre inondava i viali, gli oleandri piegavano sotto il peso dei fiori, i malati girellavano a coppie o solitari, tranquilli, svagati, o bisbigliavano in crocchio tra loro. Varcai il cancello, avvertii il custode che sarei rientrata tra poco: – Vado al bar di fronte a telefonare. – Va bene, – borbottò sbirciandomi occhialuto dalla guardiola. Attraversai la strada. Mi fermai ad aspettare il passaggio del tram. Il sole accendeva i finestrini e le facce della gente che pareva allegra, festosa. Il bar stava dall’altro lato, oltre le rotaie. Entrai. – Un gettone, per favore. – Non ce l’ha le quindici lire? – Come? C’era la radio a tutto volume. Vedevo la cassiera muovere le labbra di pesce. – Le quindici lire! – quasi urlò. – Ah, sì… un momento… Eccole. – L’apparecchio è là dietro, in fondo. Mi raccomando: telefonate brevi. Formai lentamente il numero. – Pronto sei tu? – Guardai l’orologio sulla parete, sopra il bancone. La radio continuava ad assordarmi. – È morto. Dieci minuti fa. Riattaccai. Dissi buongiorno, spinsi la porta a vetri, riattraversai la strada chiara nel sole, tagliata dalle rotaie. Vidi mia madre scendere dal tram. Lei non sa nulla, pensai guardandola arrancare verso il cancello. E mi parve estranea, buffa. 191 Milano, luglio 1960 – Roma, febbraio 2013 eretica S P E C I A L E S T A M P A direttore editoriale A L T E R N A T I V A MARCELLO BARAGHINI http://www.stampalternativa.it e-mail: [email protected] CONTRO IL COMUNE SENSO DEL PUDORE, CONTRO LA MORALE CODIFICATA, CONTROCORRENTE. QUESTA COLLANA VUOLE ABBATTERE I MURI EDITORIALI CHE ANCORA SEPARANO E NASCONDONO COLORO CHE NON HANNO VOCE. SIANO I MURI DI UN CARCERE O QUELLI, ANCORA PIÙ INVALICABILI E RESISTENTI, DELLA VERGOGNA E DEL CONFORMISMO. Visita il “Fronte della Comunicazione” di Stampa Alternativa, il nostro blog per discussioni e interventi collettivi: www.stampalternativa.it/wordpress “Libera Cultura”: la collana online che raccoglie i libri storici e le novità di Stampa Alternativa, liberamente diffusi sotto le licenze Creative Commons: www.stampalternativa.it/liberacultura MARIA JATOSTI IL CONFINATO progetto grafico impaginazione ANYONE! ROBERTA ROSSI © 2013 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri Casella postale 97 – 01100 Viterbo fax 0761.352751 e-mail: [email protected] ISBN 978-88-6222-334-8 Finito di stampare nel mese di febbraio 2013 presso ARTI GRAFICHE LA MODERNA (Roma)
Scarica