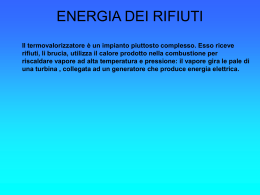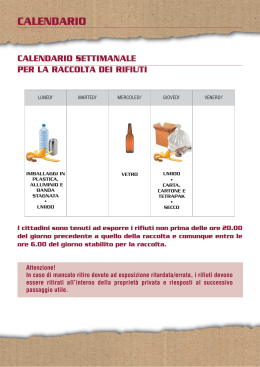RIFIUTI maggio 2010 n. 173 (05/10) mensile Euro 14,00 Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano bollettino di informazione normativa “Playlist” ovvero smembramento dell’unità artistica. Così, oggi, tutti possiamo scaricare un brano da iTunes ed inserirlo nella nostra “playlist”. Bello il brano, ma l’emozione dell’opera nella sua interezza l’abbiamo persa. Sulla base di questa perdita, la High Court britannica ha riconosciuto il diritto dei Pink Floyd a non consentire alla propria casa discografica (Emi) lo smembramento dei propri album e la cessione ad iTunes dei diritti di riproduzione dei singoli brani. Quindi, nessuna “atomizzazione”. A parte i Pink Floyd, iTunes continuerà a vivere perché ciascuno di noi vuole ascoltare solo quello che vuole e che gli piace, creando le proprie “playlist”. Credo che tale concetto sia ascrivibile anche al variegato mondo dei rifiuti, dove ciascuno scrive e legge solo quello che vuole scrivere e leggere smembrando l’unità di fondo della costruzione logica. Le emergenze rifiuti, in fondo, sono “playlist”; come, a volte, lo sono le autorizzazioni e, non di rado, le condotte dei singoli. Condotte personali, sempre meno ispirate al senso del reale e all’osservanza delle regole della legislazione, improntate al perseguimento del possibile (per sé), e armate di volontà ferrea ma lontana dall’educazione ad un apprendimento attivo (unico antidoto alla passività cui ci inducono i sistemi di “intrattenimento”). Il tutto alimentato da un’allarmante incapacità di dettare norme chiare e semplici da parte dei sistemi a ciò deputati. Ne deriva un novello Ser Agilulfo, il “Cavaliere inesistente” di Italo Calvino. Puro spirito che vive grazie alla sua forza di volontà, votato a Carlo Magno, privo di corpo ma dotato di un’armatura che si muove come se davvero l’eroe l’abitasse. Pensato per non esistere, come la gestione dei rifiuti in Italia. L’armatura è l’imponente sistema normativo, l’ubiquitario Sistri, l’immenso repertorio giurisprudenziale, l’infinità di competenze e funzioni amministrative. Lo spirito è la forza di volontà nel voler continuare a dettare regole (simili ma sempre diverse), salvo averne la reale capacità. E così i rifiuti si trasformano, come il pazzo Gurdulù che (ancora nel “Cavaliere inesistente”), non sapendo di esistere, imita quello che incontra (anatre, meli e zuppe). Anche i rifiuti, spesso, non sanno di esistere, imitano altro: materie prime secondarie e sottoprodotti nel tentativo di sottrarsi alla volontà del puro spirito e alla sua armatura cercando di trasformarsi nella bella Bradamante (con l’armatura sempre bianca e lucente). In questo disordine, l’economia di scala che sottende alle vere materie prime secondarie ed ai veri sottoprodotti, incarnando l’intelligenza di un sistema evoluto, cade sotto i colpi della casualità, dell’istinto e della confusione. Il risultato è semplice: disaffezione, distrazione e “incattivimento” a vario titolo declinato. Paola Ficco L’intervento Il “placet” costituzionale alle sanzioni penali a “macchia di leopardo” ci allontana dall’Europa di Alessandro Amato e Maria Rosaria Mola Via e Grandi opere: il Consiglio di Stato fissa importanti principi di Leonardo Filippucci Responsabilità e possibili cautele nella caratterizzazione dei rifiuti di Pasquale Fimiani 5 9 Legislazione norme nazionali Trasporto interno merci pericolose: dal recepimento della direttiva 2008/68 le novità per i rifiuti Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35 il commento di Roberto Montali Scarichi industriali: chiariti i limiti per l’arresto Legge 25 febbraio 2010, n. 36 il commento di Gabriele Taddia 15 19 23 23 Giurisprudenza Smaltimento abusivo: consente la misura cautelare detentiva Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 3 marzo 2010, n. 8299 26 Inerti da C & D: spanderli e livellarli è smaltimento di rifiuti Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 9 marzo 2010, n. 9252 28 La nozione di rifiuto non è una “catalogazione chiusa” Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 24 marzo 2010, n. 11260 30 Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco e Claudio Rispoli Finestra Sistri Edizioni Ambiente pag. 2 32 36 La presente nota viene redatta a commento della sentenza Corte Costituzionale 24 febbraio 2010, n. 83. La sentenza è reperibile in reteambiente.it, “Area normativa”, Settore “Rifiuti”, Sezione “Giurisprudenza”. Premessa L’intervento RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Il “placet” costituzionale alle sanzioni penali a “macchia di leopardo” ci allontana dall’Europa di Alessandro Amato Università di Bari e Maria Rosaria Mola Funzionario Ufficio legale di Acquedotto Pugliese S.p.A. Con sentenza n. 83 del 24 febbraio 2010 la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata, in relazione all’articolo 6, lettere a) e d) del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, nella parte in cui ha introdotto tra le “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania”, il delitto di abbandono di “rifiuti ingombranti (…) nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n. 225, 24 febbraio 1992”. Nei territori interessati da tale specifico regime emergenziale continua dunque ad assumere rilevanza penale e ad essere sanzionata con la reclusione fino a tre anni e sei mesi una condotta, l’abbandono di rifiuti appunto, che in altri territori regionali viene, invece, sanzionata con l’ammenda compresa tra 105 e 620 euro (articolo 255, Dlgs 152/2006). Continua, inoltre, a configurare un delitto punibile con reclusione da tre mesi a tre anni o (in caso di rifiuti pericolosi) da sei mesi a cinque anni, l’abbandono di rifiuti imputabile a titolari di imprese o responsabili di enti, benché la medesima condotta costituisca, nel resto del territorio nazionale, una contravvenzione oblabile (punita, in alternativa, con arresto o ammenda). Il “famigerato” Dl 172/2008, che tante perplessità ha sollevato per la singolare limitazione del sistema sanzionatorio introdotto col suo articolo 6 a pochi ambiti ristretti del territorio nazionale (1), è stato prima convertito in legge (30 dicembre 2008, n. 210) ed ha poi superato il vaglio della Corte Costituzionale. Pochi sanno, tuttavia, che il cosiddetto “delitto di abbandono incontrollato del materasso” (2), ideato per “salvare” la Regione Campania dalla morsa dei rifiuti, oggi non è più applicabile a quel territorio. L’apparato sanzionatorio introdotto dall’articolo 6 del Dl 172/2008 trova applicazione “nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Nella Regione Campania l’emergenza rifiuti (dichiarata nel 1994 e costantemente prorogata per più di un decennio) è stata ufficialmente superata. Il Dl 195/2009, a sua volta convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha istituito, infatti, un’unità operativa preposta alla “chiusura dei conti” del regime emergenziale. Lo stato di emergenza per le difficoltà di smaltimento dei rifiuti è stato invece prorogato nella Regione Calabria (Dpcm 18 dicembre 2009) e nella Provincia di Palermo (Dpcm 13 gennaio 2010). L’oggetto delle contestazioni e la risposta della Corte 2 Al fine di valutare la portata e l’ambito di applicazione delle controverse disposizioni esaminate dalla Corte Costituzionale, può essere interessante considerare le censure sollevate dall’Autorità giudiziaria remittente (il Tribunale di Torre Annunziata) e le argomentazioni che ne hanno consentito il superamento, con il conseguente rigetto della questione di incostituzionalità. All’attenzione del Giudice delle Leggi era stata prospettata la sospetta illegittimità dell’articolo 6 del Dl 172/2008 sotto tre diversi profili: • violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Si sosteneva che l’introduzione di una fattispecie di reato perseguibile solo in alcuni ambiti territoriali nazionali avrebbe violato il principio di La decisione risulta coerente, in effetti, con la posizione già assunta dalla Corte in passato, in relazione ad analoghe censure sollevate contro leggi regionali tacciate di introdurre “discriminazioni penali ratione loci” (3). In merito a precedenti leggi destinate a trovare applicazione solo in alcuni ambiti territoriali, in quanto caratterizzati da particolari contesti socio – culturali, il Giudice delle leggi aveva infatti affermato l’insussistenza della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in presenza di un provvedimento (nella forma di decreto) che limitava la propria efficacia soltanto in alcune province “ben potendo il legislatore emanare una disciplina normativa differenziata quando questa è obiettivamente giustificata da diversità di situazioni”. Per tale ragione, aveva già superato il vaglio della Corte Costituzionale il Rd 14 luglio 1898, n. 404 (normativa rimasta in vigore fino al 1999), che aveva introdotto in Sardegna e Sicilia i reati di omessa custodia di animali al pascolo e di introduzione di bestiame sul fondo altrui. La problematica non va confusa, infatti, con l’esclusiva competenza statale ad emanare leggi in materia penale. La declaratoria di incostituzionalità di alcune leggi regionali è stata infatti determinata non già dal limitato ambito di applicazione della legge penale regionale, ma dall’esigenza che le limitazioni di un diritto fondamentale qual è quello alla libertà personale discendano necessariamente dal Legislatore nazionale, in quanto unico depositario di una “visione generale dei beni e valori dell’intera collettività. Ad esso deve perciò riconoscersi il monopolio delle vicende costitutive della punibilità, e le leggi regionali (anche nelle materie ad esse esclusivamente riservate) non possono legittimamente abrogare norme statali incriminatrici, ma soltanto concorrere – analogamente alle fonti secondarie sta- Sotto il secondo profilo (violazione della riserva di legge sancita dall’articolo 25 della Costituzione), la Corte respinge la censura, affermando che la dichiarazione dello stato di emergenza costituirebbe una mera condizione di fatto, presupposta all’applicazione delle disposizioni contestate e non una fonte governativa deputata a integrare la norma penale incriminatrice. Le disposizioni censurate, secondo il Giudice delle Leggi, non costituirebbero neppure delle norme penali “in bianco” (categoria comunque avallata ormai da tempo dalla giurisprudenza costituzionale), ma conterrebbero, già di per sé un “precetto penale (…) completo ed autosufficiente” rispetto al quale la dichiarazione dello stato di emergenza rappresenterebbe un mero antefatto giustificativo del particolare rigore sanzionatorio introdotto. L’ultima censura respinta dalla Corte Costituzionale attiene alla presunta violazione dei presupposti necessari a consentire il ricorso alla decretazione d’urgenza. L’assenza di condizioni di eccezionali necessità ed urgenza emergeva, secondo il giudice a quo, dall’ammissione dell’avvenuto conseguimento di “risultati positivi”, con conseguente superamento della “fase acuta dell’emergenza”. Sul punto la Corte osserva che “l’esigenza di consolidare i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza, quale quella concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania, può essere valutata dal Governo e dalla Camere come urgenza essa stessa, alla scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati da condotte illegali, potenzialmente idonee a ricreare le condizioni che avevano fatto insorgere l’emergenza medesima”. Le questioni insolute Eccessiva indeterminatezza delle disposizioni controverse Fugati i primi dubbi di incostituzionalità, resta il sospetto di eccessiva indeterminatezza delle disposizioni controverse. Dove si applicano? Fino a quando? Cosa resta della “certezza della pena”, attesa la necessaria precarietà del regime emergenziale? Al di là della coerenza e ragionevolezza delle considerazioni che hanno portato la Corte Costituzionale a respingere le censure sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata, permangono, a nostro modesto avviso, forti dubbi sulla legittimità dell’impianto sanzionatorio introdotto con il Dl 172/2008, sotto aspetti non sollevati dall’ordinanza di rimessione o forse non del tutto esplicitati. Si dubita, in particolare, della compatibilità delle disposizioni in oggetto con il principio di necessaria determinatezza della fattispecie penale – quale corollario del principio di riserva di legge di cui all’articolo 25 Cost.. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Sotto il primo profilo, la Corte ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità sollevata dal Giudice a quo, in quanto il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione deve essere inteso non solo come “uguaglianza formale” (applicazione a situazioni uguali di uguali conseguenze) ma anche come “uguaglianza sostanziale”, concetto che consente e anzi giustifica “la previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendono responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o a mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute della popolazione dei territori interessati”. In altri termini, “corrisponderebbe ad una corretta applicazione del principio di uguaglianza l’imposizione di una disciplina diversa per situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore”. tali – a precisarne, “secundum legem”, i presupposti di applicazione, ovvero emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali operate da quelle” (Corte Costituzionale n. 487 del 10 ottobre 1989). L’intervento Rifiuti e sanzioni penali uguaglianza, comportando una netta disparità di trattamento tra cittadini e penalizzando, particolarmente, i residenti nelle zone interessate, esposti più di altri al rischio di incorrere nelle nuove fattispecie criminose formulate; • violazione della riserva di legge statale sancita dall’articolo 25, comma 2 della Costituzione. A giudizio del Tribunale campano sarebbe stata illegittima la formulazione di una fattispecie di reato attraverso il combinato disposto di una norma di legge (il Dl) ed una fonte normativa di rango secondario (generalmente lo stato di emergenza è dichiarato e prorogato con Dpcm o con Dm); • assenza dei requisiti di necessità ed urgenza imposti dall’articolo 77 della Costituzione come condizioni imprescindibili per il ricorso alla decretazione d’urgenza. L’articolo 1 C.p. prescrive, infatti: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. La norma penale deve essere chiara e ben definita per consentire al cittadino di orientarsi nella scelta dei comportamenti da assumere, evitando quelli che possano mettere a rischio la sua libertà personale. Non assolve di certo a tale funzione una norma penale che individua come presupposto applicativo del pesante sistema sanzionatorio introdotto nell’ordinamento il sussistere 3 di uno “stato di emergenza” previsto e disciplinato da un’altra legge dello stato (legge 225/1992) ed operativo solo a seguito di un’espressa dichiarazione ministeriale (dichiarazione dello Stato di emergenza) limitata nel tempo e nell’ambito spaziale di riferimento (a volte riferita al territorio regionale, a volte a singole province, altre ancora a singole città). RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Tra l’altro il sussistere di uno “stato d’emergenza”, dalla Corte definito “presupposto di fatto”, lungi dal costituire una situazione oggettiva agevolmente evincibile da parte del comune cittadino, è costituito da un regime giuridico-amministrativo non sempre riconducibile a concrete circostanze fattuali. La dichiarazione dello stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti non è conseguenza dell’avvento di una “catastrofe naturale”, ma di difficoltà operative, generalmente sconosciute al comune cittadino, che il Governo in carica sceglie discrezionalmente di affrontare “con mezzi straordinari”. In altri termini, la decisione di dichiarare lo stato d’emergenza discende da “considerazioni politiche o comunque soggettive del Governo, sul migliore modo di intervenire. Pertanto può avvenire che l’Esecutivo ritenga inopportuno dichiarare lo stato d’emergenza, ritenendo sufficiente il ricorso agli ordinari strumenti di governo del territorio (come avvenuto nella regione Lazio, laddove è pur presente una situazione ambientale alquanto critica per lo smaltimento dei rifiuti)” (4). La dichiarazione istitutiva di uno stato d’emergenza, piuttosto che essere necessariamente effetto di un “disastro ambientale, costituisce una forma di “sostegno” all’azione del Governo e degli organi preposti ad affrontare l’emergenza nel settore” (5). Anche volendo intendere il riferimento del Dl 172/2008 al decreto dichiarativo dello stato d’emergenza non già come “presupposto di fatto” (come inteso dalla Corte) ma come rinvio recettizio ad una fonte di rango secondario, in funzione di specificazione del precetto penale, andrebbe osservato che la condizione cui la giurisprudenza costituzionale subordina la legittimità delle norme penali in bianco è data dalla loro idoneità a garantire un rapporto di integrazione legge-fonte secondaria adeguato a costruire una fattispecie penale certa e determinata (si richiama sul punto la sentenza n. 26 del 1966 della Corte Costituzionale). Il rapporto di reciproca integrazione tra fonti penali di diverso rango è ammissibile e compatibile con il principio di riserva di legge a condizione che “la norma secondaria sia richiamata in funzione di specificazione soprattutto tecnica o, in altri casi, se la legge è sufficientemente specifica” (sentenze Corte Costituzionale n. 282 del 1990 e n. 133 del 1991). Le sanzioni introdotte dal Dl 172/2008 sono talmente incerte che Note (1) Dubbi sulla legittimità costituzionale del Dl 172/2008 erano stati sollevati da eminenti costituzionalisti come Baldassarre e Onida sul Corriere della Sera pubblicato in data 8 novembre 2008. Onida, in particolare, aveva sottolineato che “la limitazione territoriale è un problema anche perché l’ab- 4 bandono di un frigo o di un mobile arreca lo stesso pregiudizio all’ambiente in qualsiasi regione d’Italia”. (2) Espressione usata da Vergine Alberta Leonarda, in Ambiente e Sviluppo, 2009, 1, 5. (3) E. Epidendio Tomaso, Il Corriere del Merito, 2009, 2, 193. (4) E. Epidendio Tomaso, Il Corriere ben pochi cittadini sarebbero in grado, oggi, di individuare il contesto spazio-temporale in cui l’abbandono sulla strada di un materasso o di altro genere di “rifiuto ingombrante” comporterebbe l’integrazione di un fatto di reato. Tra l’altro la stessa terminologia utilizzata dal Legislatore “rifiuti ingombranti domestici e non” (identificati per volumetria ed altezza), “rifiuti diversi”, sembra ben lontana da quei principi di tassatività e determinatezza della norma penale che concorrono ad esprimere il principio di legalità del diritto penale di cui all’articolo 1 C.p.. Contrasto tra Dl 172/2008 e la prospettiva di un diritto penale ambientale comunitario In ambito comunitario, la crescente sensibilità per i problemi ambientali e la consapevolezza che “i reati ambientali e le loro conseguenze… sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui vengono commessi” (direttiva 2008/99/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) ha indotto alla creazione di Linee guida per l’adozione di “regole comuni” nel perseguimento degli illeciti commessi nel settore. Con sentenza del 13 settembre 2005 (C-176/03) la Corte di Giustizia ha avallato la legittimità di direttive di armonizzazione del diritto penale ambientale nei vari Stati membri finalizzate a “ravvicinare tra loro i rispettivi diritti penali nazionali in vista di una migliore tutela ambientale”. Con le direttive del 21 maggio 2008 e del 19 novembre 2008 (2008/99/Ce), il Legislatore comunitario ha dunque imposto una complessiva rivisitazione del diritto penale ambientale per la predisposizione di “efficaci misure di contrasto dei comportamenti dannosi o concretamente pericolosi per le risorse ambientali realizzati con dolo o grave negligenza”. Rispetto all’esigenza di una riforma organica della normativa penale ambientale, l’introduzione di severissime sanzioni penali da applicarsi, per così dire “a macchia di leopardo” sul territorio nazionale, limitatamente ai territori interessati dal regime emergenziale e limitatamente al periodo di vigenza di tale regime non può che stupire. Ancor più stupisce la circostanza che un’emergenza determinata dall’incapacità delle Amministrazioni locali di adottare misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente con l’effetto di riversare “55000 tonnellate di rifiuti per le strade” (6) l’emergenza campana sia stata “superata” sanzionando penalmente il cittadino che si sia reso colpevole di “abbandono incontrollato di materassi o lavatrici”. del Merito, 2009, 2, 193. Si rimanda alle considerazioni espresse dal Presidente del Consiglio dei Ministri sul Corriere della Sera, 14 novembre 2008, laddove si accomunavano le criticità presenti in Campania, Lazio e Calabria. (5) Irene Pellizzone, “Riserva di legge ed efficacia nel tempo e nello spazio della norma penale”, in Giurispruden- za costituzionale, 2008, fascicolo 5. (6) Si veda la sentenza del 4 marzo 2010 (causa C-297/08) con cui la Corte di Giustizia Ue ha condannato l’Italia per inadempimento degli impegni assunti a livello comunitario per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, giudicando inadeguate le misure adottate in Campania. La presente nota viene redatta a commento della sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, 28 dicembre 2009, n. 8786. La sentenza è reperibile in reteambiente.it, “Area normativa”, settore “Via/Vas”, sezione “Giurisprudenza”. La procedura di Via per le grandi opere L’intervento Via e grandi opere: il Consiglio di Stato fissa importanti principi Link di approfondimento Via e Vas nella ripartizione di competenze tra Stato e Regioni (Lavinia Basso, in Reteambiente.it, Via/Vas, Commenti e sintesi) Opere soggette a Via, il divieto di frazionamento secondo la Giustizia amministrativa (Lavinia Basso, in Reteambiente.it, Via/Vas, Commenti e sintesi) L’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta “legge obiettivo” o “legge Lunardi”): • da un lato, ha previsto che il Governo, mediante un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui “le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali”; • dall’altro, ha delegato lo stesso Governo ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati nel predetto programma, a tal fine riformando le procedure per la Via e l’Aia, nel rispetto del disposto dell’articolo 2 della direttiva 85/337/Cee. In attuazione dell’articolo 1 della legge 443/2001 è stato emanato il Dlgs 20 agosto 2002, n. 190, il cui capo II conteneva una specifica disciplina delle procedure di Via per le cosiddette grandi opere. Il Dlgs 190/2002 è successivamente confluito nel Codice dei contratti pubblici (Dlgs 12 aprile 2006, n. 163) e precisamente negli articoli 161 e seguenti. L’elemento caratterizzante della procedura speciale di Via per le grandi opere risiede nel fatto che l’accertamento della compatibilità ambientale viene compiuto dal Cipe contestualmente all’approvazione del progetto preliminare. Infatti, mentre, in generale, le opere pubbliche – al pari di quelle private – sono sottoposte a Via sulla base di un progetto definitivo, nel caso delle grandi opere la Via è anticipata al progetto preliminare. A livello procedimentale, è previsto che il progetto preliminare dell’infrastruttura sia corredato da uno studio di impatto ambientale redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme tecniche di cui all’allegato XXI al Dlgs 163/2006. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’ambiente ed è reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Il Ministro dell’ambiente tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati. Il Ministro dell’ambiente si avvale della Commissione tecnica ViaVas istituita dall’articolo 9 del Dpr 90/2007, la quale ha assorbito la Commissione speciale Via precedentemente prevista dall’articolo 184 del Dlgs 163/2006. La Commissione Via-Vas può operare attraverso sottocommissioni e, per le attività già di competenza della Commis- RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) di Leonardo Filippucci Avvocato in Macerata Prima di esaminare le questioni affrontate dai giudici di Palazzo Spada, vale la pena ripercorrere brevemente i tratti essenziali della disciplina speciale della Via prevista per le grandi opere, in deroga alla disciplina generale attualmente contenuta nella Parte Seconda del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. 5 L’intervento Via e grandi opere sione speciale Via, è costituita una sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture. La Commissione provvede all’istruttoria tecnica e, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla Via. Ove la Commissione verifichi l’incompletezza della documentazione presentata, il predetto termine di 60 giorni è differito di 30 giorni per le necessarie integrazioni. Le integrazioni sono richieste entro 30 giorni dall’apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i 30 giorni successivi, il parere si ritiene negativo (il che, come si dirà a breve, costituisce l’oggetto della sentenza in commento). Il Ministro dell’ambiente e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell’opera, comunicandola alle Regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture, nonché, per le opere di cui all’articolo 179 del Dlgs 163/2006 (insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico), anche al Ministro delle attività produttive. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei 30 giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L’aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell’inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell’eventuale rinnovo dell’istruttoria. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) La valutazione espressa dal Ministro dell’ambiente ed eventualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali non costituisce accertamento della compatibilità ambientale dell’opera. Come accennato, infatti, il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal Cipe, contestualmente all’approvazione del progetto preliminare; l’eventuale dissenso del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i beni e le attività culturali comporta solamente che l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale sia demandata al Consiglio dei Ministri. Nell’approvare il progetto preliminare il Cipe decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l’opera. In caso di motivato dissenso delle Regioni o Province autonome interessate, sono previste procedure aggravate per l’approvazione del progetto, diverse a seconda che si tratti di infrastrutture di carattere interregionale o internazionale ovvero di altre infrastrutture e insediamenti produttivi. Ove il Cipe disponga una variazione di localizzazione dell’opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione Via-Vas o della Regione competente in materia di Via, e il Ministro dell’ambiente o il Presidente della Regione competente in materia di Via ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il Cipe, su conforme richiesta del Ministro dell’ambiente e del Presidente della Regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di Via sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all’intera opera. La procedura di Via è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica di ottemperanza sul progetto definitivo. L’approvazione del progetto preliminare determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell’impatto ambientale, la Commissione Via-Vas riferisce al Ministro dell’ambiente, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al Cipe la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 349/1986 (oggi articolo 29, Dlgs 152/2006). Poiché, come detto, il giudizio di compatibilità ambientale viene formulato in base al semplice progetto preliminare, è prevista una successiva verifica di ottemperanza sul progetto definitivo. Questo, infatti, deve essere integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera; esso è corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale. 6 ta di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare; • esprimere al predetto Ministero, entro 60 giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull’esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale. La Commissione Via-Vas è tenuta a: • comunicare al Ministero dell’ambiente, entro 30 giorni dalla da- In una chiave preventiva piuttosto che repressiva, è stabilito che la Commissione Via-Vas, su richiesta dei soggetti esecutori dell’opera, possa fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale. Natura ordinatoria dei termini procedimentali Così riassunti i tratti generali della disciplina della Via sulle grandi opere, veniamo ora alla sentenza in commento. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato viene chiamato a sindacare la legittimità della delibera con la quale il Cipe aveva approvato il progetto preliminare della “Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta” ed aveva riconosciuto la compatibilità ambientale I giudici d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado con la quale il Tar Veneto aveva respinto le censure di legittimità avanzate da una pluralità di proprietari di immobili direttamente o indirettamente pregiudicati dalla realizzazione dell’opera approvata dal Cipe, stabilisce alcuni principi di indubbio interesse. La prima questione che il Consiglio di Stato è chiamato a dirimere riguarda la natura del termine di 30 giorni previsto per la produzione delle integrazioni da parte del soggetto aggiudicatore. Infatti, l’articolo 20, commi 2 e 3 del Dlgs 190/2002 (al pari dell’articolo 185, commi 2 e 3 del Dlgs 163/2006) stabilisce che la Commissione speciale Via (oggi sottocommissione della Commissione Via-Vas), qualora verifichi l’incompletezza della documentazione presentata e necessaria ad esprimere il proprio parere sul progetto, richieda al soggetto aggiudicatore le necessarie integrazioni; nel caso in cui questi non provveda alle richieste integrazioni entro i 30 giorni successivi, il parere si ritiene negativo. Da ciò, ad avviso del Collegio, consegue che: • l’unico effetto ricollegabile all’inutile decorso del termine per la presentazione delle integrazioni sia rappresentato dalla possibilità, per chi ha interesse alla realizzazione dell’opera, di porre in essere azioni sollecitatorie; • sia consentito alla Commissione Via ammettere una produzione tardiva. L’interpretazione sostenuta dal Consiglio di Stato (e prima ancora dal Tar Veneto nella sentenza di primo grado) appare certamente condivisibile. La ratio della norma, infatti, va correttamente ravvisata nella volontà del Legislatore di chiarire, in un’ottica di tutela preventiva dell’ambiente, che, anche nell’ambito di una procedura di Via semplificata qual è quella prevista per le grandi opere, la Commissione Via, vale a dire l’organo tecnico di cui si avvale il Ministero dell’ambiente, non possa esprimere un parere favorevole in assenza delle integrazioni documentali che la stessa Commissione ha giudicato necessarie per la formulazione di un giudizio compiuto. Se così è, non ha senso ritenere che il potere consultivo della Commissione si consumi irrimediabilmente per effetto del decorso del termine di 30 giorni e che il parere della medesima Commissione non possa più essere rilasciato neanche quando le integrazioni richieste, pur oltre il predetto termine, siano state effettivamente fornite. Le stesse argomentazioni formulate a sostegno della natura ordinatoria del termine di 30 giorni per la produzione delle integra- Obbligo di motivazione sulle osservazioni Appaiono, infine, meritevoli di sottolineatura due ulteriori passaggi della sentenza in commento nei quali il Collegio affronta le censure relative alle asserite carenze dello studio di impatto ambientale e del progetto preliminare. In primis, al punto 8 del “Considerato in diritto”, i giudici di appello, nel rigettare l’eccezione secondo cui la P.a. avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in ordine ad alcune osservazioni formulate dal cosiddetto pubblico interessato, affermano che “l’Amministrazione non può essere onerata dell’obbligo di discutere dialetticamente tutte le proposte pervenute una volta che l’impostazione conclusiva sia logica e coerente e, soprattutto, l’incidenza di un’eventuale insufficienza dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione deve essere dimostrata chiarendo come le osservazioni cui si fa riferimento evidenziano l’illogicità di taluni aspetti del progetto”. In altri termini, il Collegio sostiene che l’autorità competente ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale, seppur chiamata ad esprimersi sulle osservazioni del pubblico interessato (2), non abbia l’obbligo di confutare analiticamente ogni singolo punto oggetto di contraddittorio, purché l’iter motivazionale renda nella sostanza percepibile le ragioni del non adeguamento alle traiettorie difensive dei privati e ne attesti la relativa consapevolezza (3). Inoltre, ad avviso dei giudici, a livello processuale, la parte che deduca l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione non può limitarsi ad affermare che la doglianza espressa nell’ambito del procedimento amministrativo debba essere esplicitamente respinta dall’Amministrazione in sede motivazionale, bensì ha l’onere ulteriore di illustrare in quali termini tale doglianza, seppur non specificamente confutata, si traduca in una valutazione di illogicità del progetto. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Nel caso di specie, le integrazioni, ad avviso dei ricorrenti, erano state fornite oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta della Commissione, sicché questa non avrebbe potuto esprimere successivamente un parere favorevole, in quanto, per effetto del richiamato articolo 20, Dlgs 190/2002, si doveva ritenere che fosse già stato espresso, in forma tacita, un parere negativo sul progetto. I giudici amministrativi, invece, osservano che, a dispetto del tenore letterale della norma invocata dai ricorrenti, il termine in questione ha natura ordinatoria (cioè non perentoria), in quanto “la norma in discussione non prescrive affatto che decorso il suddetto termine l’opera non possa essere realizzata”. zioni da parte del soggetto aggiudicatore, inducono poi il Consiglio di Stato a ritenere non perentorio anche il termine di 90 giorni (dalla presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale) entro il quale il Ministro dell’ambiente e (per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica) il Ministro per i beni e le attività culturali devono provvedere, sulla scorta dell’istruttoria tecnica della Commissione speciale Via, ad emettere la propria valutazione sulla compatibilità ambientale dell’opera (valutazione che confluirà poi nella decisione finale assunta dal Cipe con l’approvazione del progetto preliminare) (1). L’intervento Via e grandi opere dell’opera, nonché di ogni atto presupposto, tra cui il parere della Commissione regionale Via ed il parere della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Rapporti tra progettazione preliminare e progettazione definitiva Degno di nota, in ultimo, è anche il successivo punto della sentenza, nel quale il Collegio respinge l’assunto di parte ricorrente secondo cui il fatto che il Cipe, in sede di approvazione del progetto preliminare, abbia prescritto determinati approfondimenti da integrare nella redazione del progetto definitivo, dimostrerebbe l’insufficienza e l’inadeguatezza dello studio di impatto ambientale facente parte integrante del progetto preliminare. Al riguardo, il Collegio valorizza massimamente la peculiarità del procedimento di Via previsto dal Dlgs 190/2002 (oggi Dlgs 163/2006), il quale, come sopra illustrato, si svolge su un progetto preliminare anziché su uno definitivo (4). Affermano i giudici amministrativi: “… appare condivisibile l’assunto della difesa erariale, la quale rileva come il progetto approvato abbia carattere preliminare per cui giustamen- 7 te l’Amministrazione lo ha approvato con prescrizioni che dovranno essere recepite nel progetto definitivo. Di conseguenza, non appare illogica la scelta dell’Amministrazione di ritenere lo studio sufficiente in questa fase del procedimento, fermo restando l’obbligo di correggere i punti critici nel progetto definitivo”. Il Consiglio di Stato, dunque, conferma il proprio orientamento (5) secondo cui l’anticipazione della valutazione dell’impatto ambientale alla fase della progettazione preliminare non è incompati- RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Note (1) Il termine di 90 giorni per l’espressione della valutazione sulla compatibilità ambientale dell’opera è previsto dall’articolo 18, comma 5, Dlgs 190/2002 (oggi articolo 183, comma 5, Dlgs 163/2006), anche se nella sentenza in commento si fa errato riferimento agli articoli 2 e 20 del Dlgs 190/2002. (2) L’articolo 183, comma 4, Dlgs 163/2006 stabilisce che “il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”. In termini generali, poi, l’articolo 24, comma 5, Dlgs 152/2006 prevede che “il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi”. (3) La sentenza in commento si pone RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 ( 05/10 ) 8 in linea con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito all’obbligo motivazionale previsto, in termini generali, dall’articolo 10 della legge 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 marzo 2010, n. 1439; sezione V, sentenza 11 dicembre 2007, n. 6386; sezione VI, sentenza 7 gennaio 2008, n. 17; sezione VI, sentenza 11 aprile 2006, n. 1999). (4) Giova ricordare i contenuti del progetto preliminare e del progetto definitivo, così come indicati rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 93, Dlgs 163/2006: “3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, del- Direttore responsabile Paola Ficco Redazione Simona Faccioli Lavinia Basso Vincenzo Dragani Progetto grafico Laura Petri Videoimpaginazione Maria Franca Perrottelli Hanno collaborato Alessandro Amato Leonardo Filippucci Pasquale Fimiani Alessandro Geremei Maria Rosaria Mola Roberto Montali Claudio Rispoli Gabriele Taddia bile con i dettami della direttiva comunitaria 85/337/Cee, in quanto il Dlgs 190/2002, da un lato, prescrive che il progetto definitivo debba essere integrato da una relazione attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso e, dall’altro, contempla specifiche garanzie di tutela ambientale nel caso in cui il progetto definitivo si discosti significativamente da quello preliminare o non recepisca le prescrizioni ovvero ancora nel caso in cui, con l’approvazione del progetto preliminare, il Cipe disponga una variazione di localizzazione dell’opera. la sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa. 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali Le opinioni sono espresse a titolo personale, impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle Istituzioni o agli Enti di appartenenza, né alla Rivista Abbonamento annuo: Euro 130,00 Arretrati: Euro 14,00 Numeri speciali: Euro 22,00 Il presente numero è stato chiuso in Redazione il 26 aprile 2010 Finito di stampare nel aprile 2010 Stampa: Moderna srl via Passo Resia 10, 21013 Gallarate (Va) nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.” (5) Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 novembre 2006, n. 6831; sezione VI, sentenza 12 maggio 2006, n. 2694; sezione IV, sentenza 22 luglio 2005, n. 3917. © copyright 1994 – 2010 Edizioni Ambiente srl, Milano Tutti i diritti sono riservati: è vietato qualunque uso, anche parziale, dei testi. Edizioni Ambiente via Natale Battaglia 10 20127 Milano tel. 02.45487277 fax 02.45487333 www.reteambiente.it [email protected] Premessa L’intervento di Pasquale Fimiani Giudice presso la Corte di cassazione Link di approfondimento P. Fimiani, “Analisi sui rifiuti: aspetti tecnici e aspetti giuridici in ordine alle responsabilità del produttore, del gestore e del laboratorio di analisi”, in Rivista Rifiuti, n. 169. Segnalazioni Sull’argomento segnaliamo il seminario di formazione sui rifiuti “Le analisi sui rifiuti: aspetti tecnici e aspetti giuridici in ordine alle responsabilità del produttore, del gestore e del laboratorio di analisi” (Roma, giovedì 27 maggio 2010) Il tema della falsità delle analisi assume, allora, un ruolo centrale nell’ambito degli illeciti ambientali, non intaccato dall’introduzione del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) da parte del Dm 17 dicembre 2009. L’articolo 5, comma 8, del decreto prevede, infatti, che “durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri – Area Movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato “pdf “ (portable document format) alla Scheda Sistri – Area Movimentazione”. Nulla cambia, quindi, circa l’obbligo di certificazione analitica dei rifiuti e, conseguentemente, per il relativo regime sanzionatorio. La centralità del tema della falsità del certificato, oltre che per i plurimi risvolti di natura sanzionatoria, si spiega anche sotto un altro versante. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Responsabilità e possibili cautele nella caratterizzazione dei rifiuti In un nostro recente intervento (1) abbiamo esaminato i vari profili di responsabilità in tema di analisi, ricordando come la falsità dei certificati rilevi non soltanto come reato in sé, ex articolo 258, comma 4, del T.u., ma anche perché da essa conseguono altri illeciti ambientali. Le false indicazioni, infatti, si trasfondono nel formulario, con conseguente configurabilità del reato di trasporto di rifiuti pericolosi con dati incompleti o inesatti. Di regola, poi, la falsità del certificato determina anche la commissione del reato di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 T.u.). È evidente che il certificato fa riferimento a rifiuti diversi da quelli effettivamente conferiti nell’impianto di destinazione, attribuendo una qualifica proprio al fine di consentirne l’ingresso, non essendo tali rifiuti previsti nell’autorizzazione allo smaltimento o nella comunicazione per il recupero. Vale, allora, il principio più volte affermato dalla Suprema Corte per cui smaltire un rifiuto diverso da quelli previsti dal provvedimento autorizzatorio (in senso lato) equivale a svolgere tale attività in sua assenza (2). La certificazione, infatti, non rappresenta un momento isolato, avulso dalla complessiva gestione del rifiuto, ma costituisce il punto di arrivo di un percorso che parte dalla sua produzione e passa per una serie di procedure finalizzate alla relativa qualificazione per la conseguente destinazione al recupero o smaltimento. La legge non disciplina le cautele da osservare per arrivare ad una corretta e credibile qualifica del rifiuto, ma impone un obbligo di risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione, come si evince dalla previsione del reato di falso nella certificazione analitica e dalla previsione (espressione, come si vedrà, di un principio generale) dell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2005 (3) secondo cui “al produttore dei rifiuti (…) spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette”. Tale norma, peraltro, non è accompagnata dall’indicazione di specifiche modalità con cui va svolta la caratterizzazione, limitandosi a prevedere il momento in cui va fatta per la pri- 9 L’intervento Caratterizzazione dei rifiuti e responsabilità ma volta (in corrispondenza del primo conferimento) e la periodicità (ripetizione ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno). Al contrario più specifiche sono le previsioni degli articoli 3 e 4 rispettivamente in tema di verifica di conformità e verifica in loco. In tema di caratterizzazione, poi, alla figura del produttore si affianca quella dell’analista, almeno nei casi (che sono la regola) in cui la classificazione del rifiuto richieda una certificazione analitica. È quindi all’interno del rapporto tra questi due soggetti, nella prassi articolato secondo diverse modulazioni, che vanno individuate le linee guida per possibili prassi virtuose idonee, se non ad eliminare, almeno a ridurre il rischio di inadeguatezza nella risposta agli interventi degli organi di controllo. Norme e prassi nella caratterizzazione dei rifiuti RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) L’obbligo del produttore di qualificare il rifiuto è previsto sia in materia di recupero che in tema di smaltimento. Sul primo versante, gli articoli 8, comma 4, del Dm 5 febbraio 1998 (recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) (4) e 7, comma 3, del Dm 12 giugno 2002, n. 161 (recante individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate) (5), impongono al titolare dell’impianto di effettuare il campionamento e le analisi dei rifiuti. In materia di discariche, l’articolo 11, commi 1 e 2, del Dlgs 36/2003 (6) fa genericamente riferimento all’obbligo per il detentore, ai fini della collocazione dei rifiuti, di fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali, imponendo la presentazione di certificazione analitica attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica. È l’articolo 2 del Dm 3 agosto 2005 citato a prevedere l’obbligo per il produttore dei rifiuti di effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Pur nelle diverse modulazioni, tali previsioni devono ritenersi espressione del principio generale per il quale gli obblighi della corretta gestione dei rifiuti impongono al produttore l’onere di osservare la massima diligenza fin dalla fase di qualifica iniziale del rifiuto, al fine di individuare il regime giuridico di riferimento e le regole per il recupero o smaltimento; è lui, infatti, ad avere la disponibilità dei rifiuti ed essere, quindi, in condizioni di attivarsi per il rispetto degli obblighi di legge. Un principio che trova la sua fonte non soltanto nella regola generale di cui all’articolo 178, comma 3, del T.u., per il quale “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga”, ma anche nell’articolo 2050 C.c. che delinea, in tema di responsabilità per danni, una presunzione di responsabilità, salvo prova contraria, da esercizio di attività pericolose quale è stata ritenuta quella di gestione dei rifiuti. 10 Con riferimento a fattispecie di inquinamento verificatasi in epoca anteriore all’entrata in vigore del Dlgs 22/1997 la Suprema Corte (7) aveva ritenuto applicabile l’articolo 2050 C.c. sul rilievo che: “Il soggetto produttore dei rifiuti tossici, è comunque soggetto agli articoli 2043 e 2050 c.c., e non può esonerarsi da siffatta responsabilità attraverso una fittizia distinzione tra soggetto produttore dei rifiuti, e soggetto tenuto allo smaltimento e stoccaggio degli stessi, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti tossici, ed in particolare il soggetto produttore, sono ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare quelle misure di sicurezza, anche nella fase di smaltimento, affinchè lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avvenga senza danni a terzi”. Anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, quindi, la redazione del certificato è di regola opportuna se non, in alcuni casi, praticamente indispensabile (8). Può anzi attribuirsi una valenza generale al concetto di caratterizzazione di base, così come definito nel Dm 3 agosto 2005 e, quindi, affermarsi, a carico del produttore dei rifiuti, l’obbligo di determinare le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la gestione in condizioni di sicurezza (definizione mutuata dall’articolo 2 del Dm 3 agosto 2005, che però fa riferimento allo smaltimento e non alla gestione, avendo ad oggetto il conferimento in discarica). Il concetto di caratterizzazione di base, quindi, è più ampio di quello di classificazione, che di esso rappresenta il momento finale nel quale si colloca l’analisi dei rifiuti. La classificazione fa fede fino a quando non esista la prova od anche il dubbio di una diversa provenienza o natura dei rifiuti stessi, in virtù di indizi gravi, precisi e concordanti (9), in quanto la natura, in base alla quale è stata effettuata una classificazione con assegnazione di un determinato codice Cer, non può essere considerata un dato di fatto destinato a permanere indefinitamente nel tempo, dovendo il produttore farsi carico della possibilità che la stessa muti e, pertanto, che i rifiuti vadano nuovamente sottoposti ad analisi (10), anche a prescindere dalle specifiche previsioni di legge. Il ragionamento sulle regole comportamentali nella fase di caratterizzazione di base diventa più articolato quando vengono in evidenza le possibili varie modulazioni del rapporto tra produttore ed analista, così come emerse nella prassi corrente. L’attività finalizzata alla redazione del certificato di analisi richiede il concorso della conoscenza di elementi di fatto e l’applicazione ad essi di specifiche conoscenze tecniche: al primo profilo attiene tutto ciò che concorre a descrivere compiutamente il ciclo di produzione del rifiuto, mentre rientrano nel secondo l’attività di campionamento e di analisi. Tuttavia, pur richiedendo competenze tecniche ed essendo strumentale alla successiva analisi, l’attività di campionamento non sempre viene svolta dall’analista; risulta, infatti, dalla prassi che, non di rado, il produttore consegna direttamente il campione all’analista, senza coinvolgerlo nella fase di prelievo o che, in altri casi, tale attività è sì richiesta all’analista, ma con indicazioni vincolanti circa il momento ed il luogo in cui il prelievo stesso deve essere effettuato. Nella fase propedeutica all’effettuazione dell’analisi, quindi, la prassi evidenzia tre ipotesi: • nessun campionamento viene svolto dall’analista, che riceve il rifiuto con richiesta di analisi; • l’analista viene richiesto di effettuare anche il prelievo e campionamento, senza vincoli in ordine alla localizzazione ed ai tempi; Anche per quanto concerne lo svolgimento dell’analisi, si registrano diversi moduli operativi. Il primo è quello del conferimento diretto dal produttore dei rifiuti (committente) all’analista dell’incarico di svolgimento delle analisi. Questa ipotesi può avere una variante qualora il laboratorio incaricato si avvalga di altro laboratorio per eseguire una parte delle analisi. Una soluzione del tutto diversa è quella dell’affidamento della gestione dei rifiuti a terzi che hanno rapporti in via diretta con i laboratori di analisi: in pratica il soggetto gestore si occupa di reperire il laboratorio affidandogli direttamente l’incarico di effettuare le analisi. Da questa breve ricognizione, possono ricavarsi due distinti versanti nei quali le condotte relative alla fase di caratterizzazione del rifiuto vanno indirizzate secondo parametri di prudenza e cautela: • le attività di conoscenza del ciclo produttivo, di prelievo e campionamento del rifiuto e di redazione del certificato di analisi; • la scelta di un laboratorio idoneo. Le esigenze di trasparenza nella caratterizzazione di base La conoscenza dell’impianto rientra nella sfera di disponibilità del produttore del rifiuto. Nel silenzio della legge, egli è libero di indirizzare il rapporto con l’analista e può decidere se coinvolgerlo nella fase propedeutica all’analisi (chiedendogli di effettuare il prelievo od il campionamento), ovvero tenerlo al di fuori, consegnandogli il rifiuto e limitandosi a chiederne l’analisi. Tuttavia, la mancata previsione di obblighi comportamentali in ordine alla fase propedeutica alla redazione del certificato, non comporta che la soluzione adottata sia priva di qualsiasi rilevanza. Al contrario, per il tipo di problematiche tecniche che si pongono, le scelte operative relative a tale fase sono in grado di determinare un maggiore o minore livello di affidabilità della classificazione e, quindi, sono sintomatiche del grado di buona fede del produttore e dell’analista. Ne deriva che le decisioni del produttore in ordine all’impostazione, più o meno trasparente, dei rapporti con l’analista, possono assumere rilevanza ai fini della valutazione della colpevolezza: è evidente che la mancanza di procedure trasparenti in sede di caratterizzazione, la consegna di campioni all’analista in assenza di precise indicazioni sulla provenienza e, in genere, comportamenti caratterizzati da superficialità (se non vera e propria opacità o contraddittorietà), possono essere letti come sintomatici della volontà di non rispettare la legge od eluderne lo scopo. L’accertamento analitico, però, può ritenersi compiuto in buona fede solo se la selezione delle sostanze pericolose da ricercare sia avvenuta in base a criteri oggettivi, verificabili, coerenti con la natura dei cicli produttivi e tecnicamente attendibili. Appare, quindi, fondamentale ai fini della redazione di un certificato di analisi affidabile, la conoscenza da parte dell’analista della tipologia di ciclo produttivo, nonché delle metodologie di prelievo e campionamento. Nella prassi la risposta dell’analista si atteggia diversamente a seconda della richiesta del produttore e del livello di suo coinvolgimento nella fase propedeutica di prelievo e campionamento. In particolare, qualora l’analista riceva il rifiuto con semplice richiesta di analisi, capita, non di rado, di rinvenire certificati che si limitano a determinare solo alcuni dei valori, classificando il rifiuto con singolari diciture standard quali: “in base ai parametri analitici considerati…, il campione può essere considerato quale: …” e “in base a quanto previsto dal decreto…, la codifica relativa consigliata può essere la seguente…” o “può essere codificato come: …”. Tali locuzioni utilizzate per l’assegnazione dei codici fanno, invero, sorgere il dubbio sulla veridicità dei certificati, perché se il chimico/analista non è a conoscenza dei cicli produttivi e delle relative materie utilizzate e non ha effettuato accertamenti in loco con il campionamento dei rifiuti, potrebbe non essere in grado di assegnare un codice. Il rischio, in tali casi, è che pur non essendo falso, il certificato sia considerato comunque inidoneo allo scopo. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Nell’ambito del primo versante, il momento conoscitivo (acquisizione di dati relativi all’impianto, prelievo e campionamento del rifiuto) pur distinguendosi da quello strettamente valutativo (la classificazione tramite le analisi), lo influenza in modo determinante, in quanto il contenuto del certificato è in funzione del livello di conoscenza che l’analista ha dell’oggetto dell’analisi: quanto più ampia è tale conoscenza, tanto più stringente è l’obbligo di corretta qualificazione; ma, per converso, quanto più trasparente è la procedura di caratterizzazione, quanto meno opinabili e sindacabili saranno i relativi risultati. E così, in tema di terre da scavo, si è ritenuto (11) che “l’attività dell’indagato sostanziatasi nel fare analizzare da un laboratorio privato solo 5 Kg di materiale a suo dire scavato nel cantiere di una erigenda discarica, corrobora la tesi di un comportamento complessivo tendente ad eludere le disposizioni vigenti”. In tal caso la parzialità del campione sottoposto ad analisi e la sua non rappresentatività, fanno ritenere “comunque probante del superamento dei limiti anche l’esame della sola massa disponibile in quanto, diversamente opinando, sarebbe agevole per il reo attraverso la attività di dispersione del terreno, disperdere anche la prova del reato” (12). Le esigenze di cautela nella fase di caratterizzazione si pongono soprattutto quando sia necessario verificare, a fronte dei c.d. codici a specchio, la presenza nei rifiuti di sostanze classificate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche (13). L’esclusione della presenza di tali sostanze, in teoria, richiederebbe un accertamento esteso a tutte quelle con tale classificazione, ma ciò ovviamente non avviene, trattandosi di operazione estremamente onerosa sotto il profilo pratico ed economico e l’operatore opera una selezione delle sostanze da ricercare sulla base di criteri di probabilità indicati dal produttore o da lui selezionati (a seconda dell’impostazione data al rapporto). L’intervento Caratterizzazione dei rifiuti e responsabilità • l’analista viene richiesto di effettuare anche il prelievo e campionamento, con precisi vincoli imposti dal produttore circa la localizzazione ed i tempi. Ed infatti, se le predette equivoche locuzioni si accompagnano all’indicazione di parametri di riferimento all’evidenza insufficienti ed incongrui, il certificato è “ex se” inidoneo a svolgere la funzione che deve adempiere; avendo un contenuto dubitativo e non assertivo, non rappresenta una realtà falsa ed inventata, ma formula ipotesi, sì da essere di fatto inutilizzabile per manifesta incompletezza, in ragione dei ragionevoli dubbi che ingenera nel lettore. In tema di delitto di falsità ideologica dell’esercente un servizio di pubblica necessità, si ritiene che non rientrano nella nozione di “certificati” quegli atti che non assolvono alla funzione di dare un’esatta informazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare 11 L’intervento Caratterizzazione dei rifiuti e responsabilità la verità di quanto in essi affermato, ma che sono espressivi di un giudizio, di valutazioni e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i fatti (14). Ed è proprio quello che si verifica quando un certificato di analisi non raggiunga quel contenuto minimo di affidabilità scientifica che lo renda idoneo a svolgere il suo scopo. In questo caso l’inidoneità equivale ad inesistenza; e se ciò rende impossibile la contestazione del delitto di falso, non preclude la configurabilità dei reati inerenti il trasporto con formulario (ed, ora, con il documento equivalente di cui all’articolo 5, comma 8, del Dm 17 dicembre 2009) recante dati inesatti od incompleti, né quello di gestione di rifiuti non autorizzata, venendo comunque conferiti nell’impianto rifiuti al di fuori dell’autorizzazione. Il coinvolgimento dell’analista nella fase di prelievo e campionamento, costituisce, quindi, la strada più trasparente per giungere ad una certificazione analitica idonea allo scopo. In ogni caso (quindi anche nell’ipotesi in cui al campionamento provveda lui direttamente), il produttore ha l’onere di assicurarsi e di provare che il campione da analizzare sia effettivamente rappresentativo della natura dei rifiuti, al fine di evitare che ciò sia fatto in via presuntiva dal Giudice, operazione a lui possibile, “purché fornisca una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica” (15), sulla base degli elementi a sua disposizione, quali la provenienza e le caratteristiche dei cicli produttivi. Linee guida per prassi virtuose RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Le esigenze di trasparenza nella caratterizzazione di base rendono opportuna l’adozione di prassi gestionali virtuose, anche in previsione di eventuali contestazioni da parte degli organi di controllo. Si indicano, di seguito, i punti fondamentali di procedure gestionali sufficientemente idonee a rappresentare correttamente l’intero percorso di caratterizzazione. In primo luogo, il produttore dovrebbe avere cura di effettuare l’esatta ricognizione del ciclo produttivo, documentandone il funzionamento attraverso reports da aggiornare periodicamente a disposizione dell’analista e degli organi di controllo. Laddove, come avviene di regola, la classificazione dei rifiuti presuppone lo svolgimento di analisi, va preferito il coinvolgimento dell’analista anche nella fase di prelievo e campionamento, in quanto scelta idonea ad attuare i principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione alla base della gestione, secondo l’articolo 178 T.u.. Per la stessa ragione, l’intera procedura finalizzata alla redazione delle analisi deve essere svolta in stretta collaborazione tra produttore ed analista, avendo cura di evidenziare e documentare, nei singoli passaggi, tutti i dati necessari per una classificazione corretta ed affidabile. I passaggi essenziali di questo rapporto collaborativo sembrano essere i seguenti: 12 1. conoscenza da parte dell’analista delle modalità di esecuzione del prelievo e campionamento dei rifiuti, perché svolti da lui o in sua presenza, ovvero perché adeguatamente documentati; 2. verbalizzazione di tali operazioni, anche in forma sintetica, con specificazione della provenienza, della data e modalità di prelievo e delle caratteristiche: peso, natura (omogenea, secca, umida, eccetera), odore, colore, dati esteriori sintomatici della provenienza, caratteristiche organolettiche. Se necessario, od opportuno, al verbale possono allegarsi riproduzioni fotografiche o video; 3. verbalizzazione, anche in forma sintetica, delle operazioni di consegna dei campioni, con allegazione dei verbali di prelievo contenenti le indicazioni di cui al punto 2); 4. formalizzazione delle richieste del produttore circa l’oggetto delle analisi e della certificazione commissionata, comprensive delle informazioni sul ciclo produttivo da cui origina il rifiuto e sulle modalità di prelievo e campionamento; 5. redazione dei certificati in funzione delle richieste come sopra formalizzate e secondo criteri di massima trasparenza possibile, accompagnando, quindi, la classificazione con l’indicazione dei metodi utilizzati, dei parametri normativi di riferimento e dell’oggetto delle analisi, ed avendo altresì cura di descrivere accuratamente il rifiuto (con le indicazioni di cui al punto 2), così come previsto dalla circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati del 4 agosto 1998, n. 812, al punto n. 1, lettera o) (16); 6. inserimento della documentazione di cui sopra in un fascicolo della caratterizzazione, da aggiornare periodicamente, nel quale inserire anche il (necessario) contratto tra produttore ed analista (sul quale si rinvia al punto che segue); 7. adeguate previsioni contrattuali tra il produttore ed il laboratorio di analisi (si rinvia al paragrafo successivo). Queste cautele, se possono sembrare onerose dal punto di vista operativo, rappresentano certamente una soluzione con caratteri di trasparenza e correttezza, valutabile positivamente in sede di controllo. Esse possono applicarsi, con i dovuti adattamenti, anche all’ipotesi di laboratorio di analisi interno all’azienda, essendo le fasi di produzione del rifiuto e di successiva analisi distinte sotto il profilo operativo ed afferenti a settori diversi dello stabilimento. Inoltre “questi documenti inquadrano completamente il rifiuto anche in diversi ambiti normativi: trasporto di merci pericolose, classificazione ai fini del Dlgs n. 334 del 1999 sugli incidenti rilevanti e, attraverso le fasi di rischio, ai fini della sicurezza sul lavoro e del rischio chimico” (17). Anche la scelta delle sostanze pericolose da ricercare in sede di analisi, dovrebbe rappresentare il momento finale dell’esame del contesto in cui il rifiuto è stato prodotto, con la considerazione dell’intero ciclo produttivo e delle sostanze utilizzate. La scelta, in quanto parte di una consapevole ed informata attività di caratterizzazione, dovrebbe nascere dal confronto tra il produttore, committente il certificato di analisi, e l’analista. Della stessa dovrebbe darsi conto in sede di formalizzazione della richiesta del certificato. Per le stesse ragioni, dovrebbe provenire dal produttore, o comunque essere condivisa con le stesse modalità, la scelta di qualificare il rifiuto pericoloso pur non avendo lo stesso tale qualifica (di regola ciò avviene per ragioni di cautela del produttore o dell’analista). Nel nostro precedente intervento, la falsità è stata, in tal caso, esclusa sulla base dell’articolo 1, comma 4, del Dm 3 agosto 2005 (in tema di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), per il quale: “Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore”. Si è detto che la norma è espressione del “principio della non offensività” della maggior tutela ambientale rispetto a quella dovu- Ma proprio perché è l’articolo 1, comma 4, del Dm 3 agosto 2005 a consentire l’esclusione della responsabilità per falso, il criterio di individuazione del soggetto legittimato a compiere tale scelta deve reperirsi all’interno di tale norma, il cui oggetto è l’obbligo di caratterizzazione e, quindi, un comportamento tipico del produttore, che non può restare estraneo ad una valutazione inerente compiti assegnatigli dalla legge. L’idoneità del laboratorio di analisi Trattandosi del conferimento di un incarico professionale, la sede propria in cui tale controllo può essere effettuata è quella del contratto, sia nella fase di formazione, che in quella esecutiva. E così, egli dovrebbe, sotto il primo profilo, pretendere contrattualmente la garanzia di idoneità tecnica e di indipendenza da parte del laboratorio e prevedere procedure chiare e trasparenti di verifica “in loco” e di campionamento da parte dell’analista; quanto al Note (1) Il riferimento è a P. Fimiani, Analisi sui rifiuti: aspetti giuridici in ordine alle responsabilità del produttore, del gestore e del laboratorio di analisi, in questa Rivista, n. 169, 1/2010, 2. (2) Cass. pen., Sez. III, sentenza 2 dicembre 2002, n. 40506 (ud. 17 ottobre 2002, rv. 222697); Sez. III, sentenza 9 febbraio 2005, n. 12349 (rv. 231068). (3) Per il quale: “1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’articolo 4 del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato. 2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smalti- mento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 al presente decreto. 3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l’inammissibilità dei rifiuti a tale categoria. 5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o) del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informa- Nel primo caso, il produttore, cui l’affidamento sia noto (o conoscibile) ha l’onere di estendere i controlli relativi alla fase genetica e/o esecutiva del contratto anche al laboratorio esterno. Nel secondo, vale il principio – ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di delega di funzioni (19) – per il quale il ricorso ad incarichi esterni da parte di un soggetto titolare di una posizione di garanzia (e tale è il produttore dei rifiuti, almeno rispetto alla sfera gestoria a lui riconducibile, nella quale rientra la fase di caratterizzazione), deve necessariamente salvaguardare l’esigenza di evitare di violare il principio di legalità e di tipicità dei reati e di svilire la tassatività della fattispecie del reato proprio, vale a dire rendere derogabili gli obblighi penalmente sanzionati, rimettendo la determinazione del loro ambito agli stessi soggetti destinatari delle norme. Non può essere, in definitiva, un atto di autonomia privata a trasferire obblighi di rilevanza pubblicistica. L’affidamento a terzi, quindi, non può comportare il passaggio “in bianco” degli obblighi di gestione, che rimangono comunque in capo al produttore, ma può riguardare solo la loro materiale esecuzione, restando il produttore tenuto al controllo dell’operato dei soggetti che con lui cooperano. In via generale, infatti, il soggetto garante primario dell’attuazione di un obbligo penalmente sanzionato, ne resta destinatario anche quando trasferisca ad altri l’adempimento dei suoi doveri; egli crea posizioni di garanzia – derivate ed autonome – che si affiancano a quella primaria, assumendo il rischio dell’inadempimento del delegato e rispondendo se viene meno ai suoi doveri di controllo. zioni fornite per la caratterizzazione sono corrette. 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni”. (4) La norma prevede che “Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione”. (5) La norma prevede che “Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione”. (6) Che recitano: “1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla compo- sizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. 2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell’ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all’articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l’anno, e devono essere conservati dal gestore”. (7) Cass. civ., Sez. I, sentenza 1° settembre 1995, n. 9211. (8) Si pensi alle terre da scavo: solo una puntuale analisi e certificazione può rappresentare il presupposto dell’esclusione della normativa in ma- RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) In virtù della posizione di garante della corretta qualificazione dei rifiuti, il produttore deve farsi carico, secondo i consueti canoni di diligenza, dell’idoneità del laboratorio di analisi, cioè della concreta possibilità del laboratorio di eseguire le analisi richieste, nonché dell’adeguatezza di queste in relazione agli elementi da lui conoscibili ed esigibili. secondo, verificare la congruità dei criteri seguiti nella ricerca delle sostanze pericolose, in relazione alla natura dei cicli produttivi dell’azienda ed intervenire nei casi di palese incongruenza. Tali obblighi valgono non soltanto nel caso di affidamento diretto dell’incarico al laboratorio, ma anche in quelli di: • esternalizzazione di una parte delle analisi dal laboratorio ad altro laboratorio; • affidamento della gestione dei rifiuti a terzi che hanno rapporti in via diretta con i laboratori di analisi. L’intervento Caratterizzazione dei rifiuti e responsabilità ta. Pertanto il certificato di analisi che qualifichi il rifiuto pericoloso pur non avendo lo stesso tale qualifica è sì falso, sotto il profilo oggettivo; ma in tale ipotesi si può invocare la nozione di falso innocuo, che sussiste “quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l’atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto” (18). 13 teria di rifiuti. Analogamente dicasi nell’ipotesi di trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in cui il soggetto che chiede di poter accedere al depuratore per smaltire i rifiuti liquidi ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per compiere tale operazione in deroga al divieto di carattere generale, onere che può dirsi soddisfatto solo da una adeguata certificazione. (9) Cass. pen., Sez. III, sentenza 32143/2002, cit. (10) Come precisato da Cass. pen., Sez. III, sentenza 24 luglio 2008, n. 31160 (ud. 12 giugno 2008), secondo cui è evidente che, a seguito della esposizione ad agenti fortemente inquinanti protrattasi per un sufficiente periodo di tempo (nel caso in esame per vari decenni), il rifiuto perde le caratteristiche originarie, dovendo essere qualificato, quale materiale destinato ad essere bonificato, in quanto proveniente da sito inquinato da sottoporre a bonifica. (11) Cass. pen., Sez. III, sentenza 29 dicembre 2009, n. 49826 (ud. 1 dicembre 2009). (12) La sentenza ha, poi, evidenziato la legittimità dell’accertamento presuntivo della natura di rifiuto della terra, atteso che “la natura di rifiuto di un materiale può legittimamente essere individuata in relazione alla provenienza dei terreni ed all’accertamento sulla concentrazione di inquinanti riscontrata in superiore ai limiti massimi consentiti, né si può ritenere in alcun modo rilevante in tale contesto l’esistenza della Via ed il rispetto delle condizioni imposte”. (13) Cass. pen., Sez. III, sentenza 9 aprile 2008, n. 14750 (ud. 11 marzo 2008), ha affermato in proposito: “Dal primo gennaio del 2002 è entrata in vigore in tutta la Comunità europea la decisione Ce n 532 del 3 maggio 2000 e successive modificazioni –, con la quale è stato sostituito l’elenco dei rifiuti pericolosi che sono passati da 234 a 405 A seguito di tale nuovo elenco essi sono distinguibili da quelli non pericolosi per mezzo di un asterisco. Inoltre allorché la pericolosità venga fatta derivare dalle sostanze pericolose in esso contenute, sarà necessa- ria un’analisi per verificare se tali sostanze superino i limiti stabiliti. Quindi esistono due tipi di rifiuti pericolosi: a) quelli contrassegnati con l’asterisco che sono tout court pericolosi senza alcun riferimento espresso alla sostanza pericolosa in esso contenuta, b) quelli considerati pericolosi sub condicione ossia quelli individuati come pericolosi mediante il riferimento alla sostanza contenuta. In tale caso esso è considerato pericoloso solo se la sostanza pericolosa raggiunge determinate concentrazioni. Tale classificazione è stata ribadita con il quinto comma dell’articolo 185 del decreto legislativo n 152 del 2006 e con il comma 6 dell’introduzione all’allegato D)”. Conforme Sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 19882 (ud. 11 marzo 2009). (14) Cass. pen., Sez. II, sentenza 31 gennaio 2007, n. 3628 (c.c. 12 dicembre 2006, rv. 235934). (15) Cass. pen., Sez. III, sentenza 21 giugno 2007, n. 24481 (c.c. 30 maggio 2007, rv. 236890), in una fattispecie in cui erano incontestate la natura del ciclo produttivo e l’identità dei rifiuti trattati (lavaggio di autocisterne che trasportavano acido solforico, cloridrico, acetico e nitrico, ipoclorito di sodio, soda caustica e colla ureica). (16) Per il quale: “deve essere emesso un formulano per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (Cer) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione” dovrà riportarsi l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del Cer non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre “99”;”. (17) C. Rispoli, Atti del Seminario organizzato da Edizioni Ambiente su “Le analisi sui rifiuti: aspetti tecnici e giuridici”, Milano, 18 febbraio 2010. (18) Cass. pen., Sez. V, sentenza 23 gennaio 2008, n. 3654 (ud. 7 novembre 2007, rv. 238875). (19) Da ultimo, si veda Cass. pen., Sez. IV, sentenza 2 aprile 2009, n. 14440 (ud. 5 marzo 2009). RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) La seconda vita delle cose Il riutilizzo, nuova frontiera per la gestione dei rifiuti a cura del Centro di Ricerca Economica e Sociale dell’Occhio del Riciclone Il volume presenta una serie di ricerche sulle pratiche del riuso dei beni presenti nei flussi dei rifiuti so- lidi urbani, effettuate dall’Occhio del Riciclone nel territorio del Comune e della Provincia di Roma. 2009 pagine 208 20,00 e tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02/45487333 www.edizioniambiente.it e-mail [email protected] Sì, desidero acquistare in contrassegno il volume (contributo: 3,00 e) La seconda vita delle cose a 23,00 e Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999. nome e cognome ragione sociale via n. città 14 prov. tel. fax P. Iva/C.F. e-mail data firma cap 1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003. 2) Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra: [ ] autorizzo [ ] non autorizzo l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative della Casa Editrice. Firma ............................................................................ R Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (Gu 11 marzo 2010 n. 58) Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose Legislazione norme nazionali Trasporto interno merci pericolose: dal recepimento 2008/68 le novità per i rifiuti Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 2 e l’Allegato B; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/Ce, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/Ce relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/Ce relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/Ce, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di con- certo con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato: a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale; b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne; c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Adr: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; b) Rid: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (Cotif), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; c) Adn: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino ad una veloci- RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) della direttiva Il Presidente della Repubblica 15 Legislazione norme nazionali Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35 tà superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose; e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci; f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall’articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Articolo 3 Disposizioni generali 1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto: a) negli allegati A e B dell’Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: “parte contraente” sono sostituiti dai seguenti: “Stato membro”, come opportuno; b) nell’allegato del Rid che figura come appendice C della Cotif, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009; c) nei regolamenti allegati all’Adn, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) ed h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’Adn, nei quali i termini: “parte contraente” sono sostituiti dai seguenti: “Stato membro”, come opportuno. Articolo 4 Paesi terzi 1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell’Adr, nel Rid e nell’Adn, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8. 16 Articolo 5 Recepimento modifiche all’Adr, al Rid ed all’Adn 1. Con provvedimento dell’amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche: a) degli allegati A e B dell’Adr; b) dell’allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif; e c) dei regolamenti allegati all’Adn. Articolo 6 Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 1. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui alcomma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.”; c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.”; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.”; e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: “Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2”; f) al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.”. 2. All’espletamento delle attività autorizzative di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Articolo 7 Modifiche all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto 1. L’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto è sostituito dal seguente: “Articolo 35 – 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (Rid) di cui all’allegato I dell’appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (Cotif), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1, recepiti nell’ordinamento in conformità alle normative vigenti. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei Articolo 8 Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose 1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. La circolazione delle unità navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonchè le prescrizioni re- lative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unità navali sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unità navali, purché non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del Rid sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorità amministrativa competente è il Prefetto del luogo ove la violazione è accertata.”. 2. All’espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Legislazione norme nazionali Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35 permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 17 Legislazione norme nazionali Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 18 b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica delle unità navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unità navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del Adn sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorità amministrativa competente è il prefetto del luogo ove la violazione è accertata. 15. All’espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all’ entrata del bilancio dello Stato. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. Articolo 9 Ulteriori limitazioni in caso di incidente 1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgen- za, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell’amministrazione, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione. Articolo 10 Disposizioni transitorie aggiuntive 1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/Ce, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le disposizioni contenute negli allegati all’Adr, Rid, Adn e successive modificazioni, in merito all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati. Articolo 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose 1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall’Adr, Rid, Adn. 2. Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. 3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa. 4. Con provvedimento dell’amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l’attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell’Adr, del Rid e dell’Adn. 5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell’impresa. 6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni. 7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell’Adr, Rid, Adn è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’incidente medesimo al legale rappresentante dell’impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 8. Il certificato di formazione professionale di cui all’Adr, Rid, Adn è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 9. 9. L’esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell’Adr, del Rid e dell’Adn. 10. Con provvedimento dell’amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell’Adr, del Rid e dell’Adn. 11. Con provvedimento dell’amministrazione è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa. 12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all’esame di primo rilascio, aggiornamento per l’integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonché per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato. L’importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Nelle more dell’adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000. Articolo 13 Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa Adr, Rid e Adn 1. Le attività di riconoscimento degli esperti per l’esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa Adr, Rid e Adn è effettuata da una commissione nominata con decreto dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Le attività relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell’autorità competente, secondo quanto stabilito dagli allegati il commento Adr 2009 e rifiuti: cambia completamente il modello di scheda da tenere a bordo del mezzo di Roberto Montali Chimico – Esperto Adr Articolo 14 Abrogazione di norme precedentemente in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce e 2000/18/Ce trasposte nell’ordinamento interno con i sotto elencati decreti: a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel Premessa Con la pubblicazione in Gu del Dlgs 11 gennaio 2010 n. 35 (1), in vigore dal 13 marzo 2010, l’Italia ha recepito, anche se con notevole ritardo rispetto alla deadline del 30 giugno 2010, la direttiva 2008/68/Ce (2) con la quale gli Stati membri devono adottare nel proprio ordinamento nazionale l’edizione 2009 degli allegati A e B all’Accordo Adr (3) relativo al trasporto su strada di merci pericolose. Il ritardo nel recepimento è dovuto al fatto che, a differenza di quanto accaduto in passato, la direttiva di cui trattasi ha previsto anche l’adozio- supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/Ce relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto; b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5; c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/Ce relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto. Articolo 15 Disposizioni finanziarie 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica. 2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, e dell’articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse. Articolo 16 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Articolo 12 Sanzioni relative al consulente alla sicurezza 1. Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. 2. Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. 4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 5. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Adr, Rid e Adn, è effettuata da una commissione, nominata con provvedimento dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Le attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall’ Adr, Rid e Adn, sono effettuate da una commissione nominata con provvedimento dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Gli importi delle tariffe per l’espletamento delle attività di verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per il funzionamento delle commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti richiedenti e sono stabiliti con decreto dell’amministrazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’importo delle tariffe di cui al presente comma è rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. Legislazione norme nazionali Rifiuti e Adr 14. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011. Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010 ne sul territorio comunitario delle norme inerenti il trasporto per ferrovia (Rid) (4) e per vie navigabili interne (Adn) (5); pertanto si è reso necessario emanare un decreto legislativo, non essendo idoneo un semplice decreto ministeriale. La norma stabilisce che, fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (6) (nuovo Codice della Strada) e dell’articolo 35, comma 5 e 7, del Dpr 11 luglio 1980, n. 753 (7), come modificati, è vietato il trasporto di merci pericolose nella misura in cui questo non è consentito dalle disposizioni contenute: 19 Legislazione norme nazionali Rifiuti e Adr RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 20 • negli allegati A e B all’Adr, applicabili dal 1° gennaio 2009; • nell’allegato del Rid che figura come appendice C della Cotif (8) applicabile dal 1° gennaio 2009; • nei Regolamenti allegati all’Adn, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011. Tralasciando quanto previsto in materia di trasporto ferroviario e per vie navigabili interne, preme in questa sede segnalare le novità di interesse introdotte per il trasporto stradale, sia dall’edizione 2009 dell’Adr, che dal decreto in parola, essendo tale modalità di trasporto quella quasi esclusivamente utilizzata per i rifiuti: in particolare le nuove disposizioni riguardano anche la figura del Consulente la Sicurezza dei trasporti (Dgsa), figura già regolamentata, a livello nazionale, dal Dlgs 40/2000 (9). In virtù del fatto che la recepita norma comunitaria (direttiva 2008/68/Ce) ha abrogato, per quanto non compatibili con essa, le precedenti direttive 94/55/Ce (10), 94/69/Ce (11), 96/35/ Ce (12), e 2000/18/Ce (13), il decreto in parola ha conseguentemente abrogato il Dm 4 settembre 1996 (14), e s.m.i., il Dlgs 41/1999 (15), e il Dlgs 40/2000. Le disposizioni del Dlgs 35/2010 Precisando che le sue disposizioni, e quindi anche quelle dell’Adr 2009, devono essere applicate oltre che alle operazioni di trasporto, effettuate sia all’interno dello Stato nazionale, sia tra gli Stati dell’Ue, anche alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da una modalità di trasporto ad un altra ed alle soste eventualmente rese necessarie dalle condizioni di trasporto. In particolare la norma: • definisce il suo campo di esclusione che, nello specifico del trasporto su strada, comprende il trasporto di merci pericolose effettuato mediante unità di trasporto appartenenti alle forze armate o interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa; • fornisce una nuova definizione di “veicolo” testualmente ripresa dal dettato comunitario: “qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno 4 ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino ad una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose”; • con l’articolo 6, apporta sostanziali modifiche all’articolo 168 del Codice della strada, stabilendo che le sanzioni già in precedenza previste, non si applichino più solo a chi violi le disposizioni previste da norme nazionali bensì a chi, in sostanza, violi le prescrizioni dell’Adr: “(…) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: ‘Chiunque viola le prescrizioni fissate o re- cepite con i Dm di cui al comma 2’ sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ‘Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2’”. Molto interessante, soprattutto per le figure dello speditore e del trasportatore, appare l’ultima modifica apportata, sempre dall’articolo 6, lettera f) (16), al comma 9 dello stesso articolo 168 del Cds che, con la sostituzione dell’ultimo periodo, espressamente stabilisce che la sanzione amministrativa accessoria, già prevista dal medesimo articolo 168 del Cds ed altresì applicabile in caso di infrazione alle norme Adr e prevedente la sospensione da 2 a 6 mesi della patente del conducente e del libretto di circolazione del veicolo con cui è stata commessa la violazione, si applichi solo quando le violazioni siano dovute a responsabilità del trasportatore (quale definito dall’Adr e cioè: “l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto”) ovvero a quelle del conducente. In tal modo viene finalmente eliminato il rischio che pesanti provvedimenti di sospensione di patente e libretto di circolazione vengano presi anche nei casi in cui il non rispetto delle norme Adr non siano imputabili a responsabilità dell’impresa di trasporto o a comportamenti errati del conducente bensì ad irregolarità commesse da altre figure della catena del trasporto (es. speditore, caricatore, riempitore, scaricatore…). In merito al Dgsa, il decreto in parola, abrogando il Dlgs 40/2000, in sintesi stabilisce che: • le disposizioni applicabili agli obblighi previsti in materia di Dgsa sono quelle previste dall’Adr, Rid, Adn; • l’esame per il conseguimento del Cfp necessario allo svolgimento della mansione deve essere svolto secondo le modalità di cui al capitolo 1.8 dell’Adr; • la nomina deve essere effettuata dal legale rappresentante di un’impresa la cui attività comporti trasporti di merci pericolose, e/o operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti; • lo stesso legale rappresentante deve, entro 15 giorni dalla nomina del Dgsa, comunicare all’ufficio periferico competente per territorio del Dipartimento Trasporti, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le complete generalità di questi; • con successivo provvedimento il Ministero detterà le condizioni alle quali le imprese le cui attività comportino trasporti di merci pericolose, e/o operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a detti trasporti, possono essere esonerate dalla nomina del Dgsa ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell’Adr, del Rid e dell’Adn. Fino all’adozione del provvedimento si applicheranno le attuali disposizioni in vigore; • entro 60 giorni dalla nomina il Dgsa, controllate le procedure messe in atto dall’impresa presso la quale opera, deve provvedere alla ste- sura di una relazione tecnica nella quale, siano indicate le eventuali modifiche procedurali e strutturali necessarie per il rispetto di tutte norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni di sicurezza; • la relazione deve essere redatta almeno con cadenza annuale e, in ogni caso, ogni volta che intervengano modifiche delle procedure riportate nella relazione stessa, o modifiche e aggiornamenti delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose; • la relazione deve essere consegnata al legale rappresentante dell’impresa il quale è tenuto a conservarla per cinque anni; • in caso di incidente, entro 45 giorni dall’evento, il Dgsa dovrà trasmettere una “relazione di incidente” al legale rappresentante dell’impresa e al Dipartimento per il trasporto, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Per quanto attiene al regime sanzionatorio, il decreto in parola rivaluta le precedenti sanzioni amministrative previste, sia per il Dgsa sia per il legale rappresentante dell’azienda; in particolare sono previste sanzioni pecuniarie: • da 6.000 euro a 36.000 euro per il legale rappresentante che non nomini il Dgsa • da 2.000 euro a 12.000 euro per il legale rappresentante che non comunichi o comunichi in ritardo le complete generalità del consulente; • da 4.000 euro a 24.000 euro per il consulente che non rediga o rediga in ritardo le relazioni annuali o di incidente; • da 2.000 euro a 12.000 euro per il consulente che non ottemperi agli obblighi di trasmissione delle relazioni. Giova a questo punto esaminare le principali novità introdotte dall’edizione 2009 dell’Adr per quanto attiene al trasporto su strada di materie pericolose e di particolare interesse per i rifiuti. Le più salienti novità dell’Adr 2009 riguardanti i rifiuti Le nuove disposizioni introdotte con l’edizione 2009 dell’Adr riguardano, per quanto di interesse per il trasporto dei rifiuti, gli aspetti elencati di seguito e oltre descritti: A) la classificazione di rifiuti a composizione non esattamente nota B) la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente C) l’introduzione di nuove materie nella lista delle materie ammesse al trasporto D) la previsione di nuove istruzioni di imballaggio E) l’etichettatura e la marcatura F) il documento di trasporto (Ddt) G) le istruzioni di sicurezza (Tremcard) H) l’equipaggiamento previsto per il veicolo e per l’equipaggio. Criteri dell’Adr 2009 per la classificazione di materie pericolose per l’ambiente acquatico Categoria: tossicità acuta 1 CL50 96 hr (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o CE50 48 hr (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96 hr (per le alghe ≤ 1 mg/l o altre piante acquatiche) CL50 96 hr (per i pesci) ≤ 1 mg/l e/o CE50 48 hr (per i crostacei) ≤ 1 mg/l e/o CEr50 72 o 96 hr (per le alghe ≤ 1 mg/l o altre piante acquatiche) e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il log Kow ≥ 4 (salvo se il fattore di bioconcentrazione, determinato sperimentalmente è < 500). Categoria: tossicità cronica 2 CL50 96 h (per i pesci) > 1 ma ≤ 10 mg/l e/o CE50 48hr (per i crostacei) > 1 ma ≤ 10 mg/l e/o CEr50 72 o 96 hr (per le alghe o per altre piante acquatiche) > 1 ma ≤ 10 mg/L e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il log Kow ≥ 4 (salvo se il fattore di bioconcentrazione determinato per via sperimentale è < 500), a meno che i Noec di tossicità cronica siano > 1 mg/L. Le materie (sostanze o miscele) pericolose per l’ambiente acquatico n.a.s. che non siano assegnabili ad altre classi di pericolo, vengono invece, come già in precedenza, designate con le rubriche: • 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. • 3082 – Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s. ed assegnate al gruppo di imballaggio III. Devono essere così designate anche le sostanze e le miscele che, pur non rispecchiando i descritti criteri della descritta sottosezione 2.2.9.1.10, sono classificate pericolose per l’ambiente (simbolo di pericolo N e frasi di rischio R50, R50/53, R51/53) in base ai criteri delle direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e s.m.i. relative alla classificazione ed all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e non possono essere assegnate ad altre rubriche delle classi di pericolo previste dall’Adr I colli contenenti queste materie devono, riportare oltre all’etichetta n. 9, il nuovo introdotto marchio del pesce ed albero neri su sfondo bianco o su altro idoneo fondo di contrasto, perfettamente simile a quello già previsto dal sistema armonizzato per la classificazione e l’etichettatura e che deve avere le dimensioni minime di 100 x 100 mm salvo che per i colli che sono di dimensioni tali da poter riportare solo marchi di dimensioni più piccole. C) Sono state aggiunte all’elenco delle materie ammesse al trasporto alcune nuove rubriche tra cui le cartucce per pile a combustibile (n. Onu da 2476 a 3479) e le pile al litio (n. Onu 3480 e 3481). D) Sono state aggiunte o modificate alcune istruzioni di imballaggio tra le quali la: • P004: applicabile alle materie con n. Onu 3473, 3476, 3477, 3478, 3479 relative alle cartucce per pile a combustibile • P010: applicabile ad alcuni clorosilani delle classi 3, 6.1. ed 8 di g. di imballaggi II • P804: applicabile alla materia bromo e bromo in soluzione (n. Onu 1744) • P001 nella quale la disposizione speciale PP1 è stata estesa anche agli adesivi, agli inchiostri da stampa, alle materie simili agli inchiostri da stampa, alle pitture e alle materie simili alle pitture e alle resine in soluzione assegnate al n. Onu 3082. E) I colli contenenti materie che siano anche pericolose per l’ambiente (ad eccezione degli imballaggi semplici o combinati di capacità ≤ 5 l per i liquidi e ≤ 5 Kg per i solidi) devono recare in modo durevole, oltre alle etichette di pericolo previste in funzione della classe di appartenenza, anche il succitato marchio: marchio per materie pericolose per l’ambiente Tale marchio deve essere apposto a lato del n. Onu preceduto dalle lettere UN, avere dimensioni minime 100 x 100 mm (a meno che i colli abbiano dimensioni tale da permettere solo marchi più piccoli), essere facilmente leggibile e visibile, e non degradabile. Per i grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa aventi capacità > 450 l e per i grandi imballaggi il marchio deve essere apposto sui due lati opposti. Ad eccezione delle materie aventi n. Onu 3077 o 3082, questa disposizione diviene obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2011. Riassumendo, mentre le materie designate con n. Onu 3077 o 3082 devono già allo stato attuale recare sugli imballaggi l’etichetta n. 9 + il marchio descritto, quelle che siano anche pericolose per l’ambiente devono recare, obbligatoriamente, le etichette di pericolo di loro pertinenza e, a partire dal 1° gennaio 2011, il marchio descritto. F) Le più importanti nuove disposizioni sul Documento di Trasporto (Ddt) prevedono che: • ove previsto, debba essere indicato anche l’eventuale codice di restrizione al transito in gallerie riportato (colonna 15 della tabella A del capitolo 3.2). Detto codice deve essere indicato in lettere maiuscole e tra parentesi ma RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) B) Devono essere valutate, ai fini della classificazione come “pericoloso per l’ambiente acquatico” anche quelle materie alle quali sia già stata assegnata una delle classi di pericolo da 1 a 9 (17). La valutazione deve essere effettuata in base ai nuovi criteri di cui alla sottosezione 2.2.9.1.10, che si basano su dati di tossicità cronica ed acuta per l’ambiente acquatico, e su fattori di bioaccumulo e di degradazione dei componenti organici, criteri peraltro molto simili a quelli adottati già da tempo dalle norme che regolamentano il trasporto marittimo (Imdg Code) ai fini della assegnazione della categoria “MARINE POLLUTANT” (inquinante marino). Su tali basi le materie pericolose per l’ambiente (acquatico) vengono suddivise in tre categorie (tossicità acuta 1, tossicità cronica 1, tossicità cronica 2), se soddisfano i criteri della sottosezione 2.2.9.1.10.3 dell’Adr 2009 che riporta anche lo schema della procedura da seguire per stabilire se una materia soddisfa i criteri di tossicità acuta o cronica. Tali criteri sono indicati di seguito. Categoria: tossicità cronica 1 Legislazione norme nazionali Rifiuti e Adr A) La nuova sottosezione 2.1.3.5.5 prevede che in caso di trasporto di un rifiuto a composizione non esattamente conosciuta, la sua assegnazione ad un N. Onu e ad un gruppo di imballaggio può essere effettuata basandosi sulle conoscenze che lo speditore ha del rifiuto, come anche su tutti i dati tecnici e di sicurezza quali richiesti dalla legislazione di settore in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente (in particolare dalla Decisione 2000/532/Ce). In caso di dubbio si deve comunque scegliere il grado di pericolo più alto mentre, se in base alle conoscenze della composizione e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto tal quale non corrispondono ad un gruppo di imballaggio I, questo può essere assegnato ad un gruppo di imballaggio II. Questa procedura non può essere applicata però ai rifiuti contenenti materie di classe 7; 1; 2; 4.1; 4.2; 5.2; 6.1 o 3 di gruppo di imballaggio I, a materie di classe 6.2, nonché a materie di classe 4.3 o a soluzioni e miscele di materie comburenti o che presentino un rischio sussidiario di comburenza con rischio potenziale di esplosione. 21 Legislazione norme nazionali Rifiuti e Adr RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 22 non è tuttavia richiesto quando sia già noto in anticipo che il trasporto non prevede l’attraversamento di una galleria alla quale si applichi la restrizione al transito; • nel caso in cui per la classificazione sia stata applicata la succitata disposizione relativa a “classificazione di rifiuti a composizione non nota” alla denominazione ufficiale indicata nel Ddt deve seguire la dicitura “Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5”, es: UN 3266, Liquido inorganico corrosivo, basico n.a.s. 8, II, “Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5”. In questi casi non è necessario aggiungere la denominazione tecnica della materia trasportata come richiesto, in linea generale, per le rubriche n.a.s. dalla disposizione speciale 274 del capitolo 3.3; • non sussiste più, nei casi di trasporto in regime di esenzione parziale, l’obbligo di riportare nel documento la dicitura “Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti all’1.1.3.6”. G) Le disposizioni relative alle istruzioni scritte (Tremcard) sono state completamente riviste. Tali nuove disposizioni stabiliscono che la fornitura di questo documento all’equipaggio del veicolo non è più responsabilità dello speditore, bensì del trasportatore: questa è quindi ora la figura che ha l’obbligo di assicurarsi che i membri dell’equipaggio siano stati informati sulla natura delle materie che devono trasportare, abbiano compreso tali istruzioni e siano capaci di applicarle in caso di evento. La tremcard deve essere consegnata prima della partenza ed in una lingua che ogni membro dell’equipaggio sia in grado di leggere Note (1) Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose” (in vigore dal 13 marzo 2010). (2) Direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (3) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Adr) applicable as from 1 January 2009 – United Nations Economic Commission for Europe (Unece) 2009 edition (ECE/TRANS/202, Vol. I and II), as amended by document ECE/TRANS/WP.15/199, annex 1. (4) Règlement concernent le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses (Rid). (5) Adn, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways under the joint auspices of the United Nations Economic Commission for Europe (Unece) and the Central Commission e comprendere. Pertanto, ove il mezzo sia carente di tale documento o questo non sia conforme, non è consentito allo speditore di affidare il carico di rifiuti. Non è più richiesto che le schede a bordo siano in tutte le lingue dei Paesi interessati al trasporto ma in ogni caso queste devono essere fornite nella lingua dell’equipaggio. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo all’interno della cabina di guida in luogo facilmente accessibile. Anche il modello di scheda cambia completamente: non è più previsto l’obbligo di avere a bordo del veicolo una scheda per ciascuna materia trasportata in quanto è stato previsto un modello unico valido per tutte le materie. Questo è riportato per intero nella sezione 5.4.3.4 dell’Adr 2009 e si compone di quattro pagine. La pagina 1 indica le misure generali da prendere in caso emergenza o di incidente. Le pagine 2 e 3 indicano, in relazione alle diverse classi di pericolo delle materie trasportate, le caratteristiche del pericolo e le ulteriori azioni specifiche da intraprendere in relazione alle circostanze prevalenti: allo scopo sono riportate in esse tutte le etichette di pericolo previste per le varie classi di pericolo con accanto a ciascuna etichetta le relative caratteristiche di pericolosità e le ulteriori azioni da intraprendere in caso di evento. La pagina 4 indica infine l’equipaggiamento di protezione, generale e individuale, che deve trovarsi a bordo del veicolo. Le istruzioni devono corrispondere esattamente for the Navigation of the Rhine (Ccnr). Geneva, 26 May 2000 (in force on 29 February 2008). (6) Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”. (7) Dpr 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. (8) Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (Cotif, Berne 9 Mai 1980 – Vilnius 3 Juin 1999). (9) Dlgs 4 febbraio 2000, n. 40 “Attuazione della direttiva 96/35/Ce relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose”. (10) Direttiva 94/55/Ce del Consiglio del 21 novembre 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. (11) Direttiva 96/49/Ce del Consiglio al modello descritto nell’Adr 2009 del quale un fac-simile viene rappresentato più oltre; il modello non è modificabile e pertanto ulteriori disposizioni o informazioni che il trasportatore ritenga necessarie devono essere riportate in allegato alla scheda. La nota 2 in calce al documento dice infatti espressamente: “Le indicazioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate ed al mezzo di trasporto” e si ritiene che tale dicitura stia a significare che è intenzione del Legislatore quella di consentire al trasportatore di fornire istruzioni supplementari di comportamento senza modificare il modello di scheda proposto. H) In sincronia con quanto previsto dalle nuove istruzioni scritte (Tremcard), è stata notevolmente modificata la sezione 8.1.5 dell’Adr incrementando gli equipaggiamenti di protezione richiesti a bordo (“Borsa Adr”) e che devono ora consistere in: • almeno un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote, due segnali d’avvertimento autoportanti, liquido lava occhi (non richiesto per i numeri di etichetta di pericolo 1; 14; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2 e 2.3) per ciascun veicolo; • un’imbracatura fluorescente (ad es. quella descritta nella norma europea EN 471), una lampada portatile conforme alle disposizioni della sezione 8.3.4 (priva di qualunque superficie metallica suscettibile di produrre scintille), un paio di guanti protettivi, un dispositivo di protezione degli occhi (occhiali protettivi), per ogni componente dell’equipaggio. del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. (12) Direttiva 96/35/Ce del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (13) Direttiva 2000/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose. (14) Dm 4 settembre 1996 “Attuazione della direttiva 94/55/Ce del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada”. (15) Dlgs 13 gennaio 1999 n. 41 “Attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia”. (16) “… al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.»”. (17) In precedenza per tali materie non era necessario prevedere anche la classificazione di pericolosità ambientale, in quanto si assumeva che le misure di sicurezza da adottare per esse già coprivano anche i rischi di natura ambientale. Legge 25 febbraio 2010, n. 36 (Gu 12 marzo 2010 n. 59) Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue Legislazione norme nazionali Scarichi industriali: chiariti i limiti il commento Sanzioni graduate in base alla pericolosità degli inquinanti Il commento di Gabriele Taddia Avvocato in Ferrara Link di approfondimento P. Fimiani, “Scarichi: la giurisprudenza su prelievo e campionamento” in Rivista Rifiuti, n. 167 Articolo 1 1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’alle- Premessa Con l’emanazione della legge 25 febbraio 2010, n. 36 si è finalmente conclusa la ormai insostenibile diatriba circa l’applicabilità delle sanzioni amministrative o penali in caso di superamento dei limiti di emissione stabiliti nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) per gli scarichi di acque reflue industriali (1). Prima del citato intervento legislativo, l’articolo 137, comma 5, del “Codice ambientale” puniva con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 3 mila a 30 mila euro chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superasse i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006 oppure superasse i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o alle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto (2). La legge 25 febbraio 2010, n. 36 (come esplicitato sia nella relazione governativa di accompagnamento che nella scheda di lettura del provvedimento, redatta dal Servizio Studi del Senato ed abbinata al disegno di legge n. 1755 poi approvato in via definitiva e divenuto legge), ha inteso risolvere alcune incongruenze gato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro”. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 2010 derivanti dalla originaria (infelice) formulazione del sopra citato articolo 137, comma 5, primo periodo, Dlgs 152/2006, il cui nucleo dispositivo era peraltro già contenuto nei commi 5 e 6, Dlgs 152/1999, successivamente modificato dal Dlgs 258/2000. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità A seguito della citata modifica legislativa apportata dal Dlgs 25 agosto 2000 n. 258 (come detto la norma poi venne sostanzialmente così recepita nel “Codice ambientale”), si era formato un duplice orientamento giurisprudenziale uno dei quali – seppur minoritario – estremamente restrittivo e legato alla semplice e rigorosissima lettura della norma, ha portato notevoli incertezze applicative (dal rilevante impatto pratico sugli operatori economici e sui gestori di impianti di depurazione, come recita il comunicato di accompagnamento al disegno di legge 1755/09, esitato poi in legge 36/2010). Come detto, la giurisprudenza aveva assunto due diverse linee direttrici: • da un lato, Cassazione penale, Sez. III, 28 aprile 2004, n. 25752, riteneva che per l’applicabilità delle sanzioni penali occorresse la simultanea presenza del superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o (nel caso di scarichi al suolo) nella tabella 4 dell’allegato 5 e RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) per l’arresto La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: 23 Legislazione norme nazionali Scarichi industriali e sanzioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 24 della presenza di una delle sostanze individuate nella tabella 5 del medesimo allegato; • dall’altro lato, in particolare con la sentenza 29 ottobre 2003 n. 48076 (3), si erano invece ricondotte all’ipotesi penale (anziché amministrativa) due distinte fattispecie (4), e cioè: – lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o fognatura quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico di acque reflue industriali sul suolo quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento non riguarda le 18 sostanze più pericolose indicate nella tabella 5 (5); – qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura o sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni e dalle Province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle 18 sostanze indicate nella tabella 5. Con la citata sentenza la Corte ebbe a chiarire che “sul piano logico e funzionale si giustifica lo spostamento della frase ‘in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5’ con il riferimento al solo ruolo aggiuntivo e non sostitutivo delle Regioni, senza alcuna interferenza con le autonome sanzioni penali per il superamento dei valori posti dallo Stato nelle tabelle 3 e 4”, enucleando così un principio di segno opposto alle precedenti interpretazioni e privilegiando ed ampliando in tal modo l’applicabilità della sanzione penale rispetto a quella amministrativa. In altre parole, l’inciso “in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, è stato posposto al riferimento ai limiti più restrittivi fissati da autorità diverse dallo Stato (Regioni, Province autonome, autorità competente ex articolo 33 comma 1) per significare che è consentito ad esse – in casi particolari – l’abbassamento dei limiti fissati dal legislatore delegato nelle tabelle 3 e 4 del decreto 152 ma – in questa ipotesi di accentuato rigore, la risposta sanzionatoria penale è subordinata ad una condizione ulteriore, e cioè che si tratti delle 18 sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell’allegato 5. Altrimenti trova applicazione il disposto che – in ossequio alla riserva statale dello ius puniendi – sanziona solo in via amministrativa il superamento dei limiti di emissione più restrittivi fissati da “autorità diverse”. Si è quindi ritenuto che l’uso della congiunzione disgiuntiva “ovvero” impedisce alla proposizione subordinata finale di riferirsi ad entrambe le fattispecie anziché esclusivamente alla seconda” (6). La legge 25 febbraio 2010, n. 36 La legge 25 febbraio 2010, n. 36 (7) è stata emanata proprio con il dichiarato intento di risolvere una volta per tutte il problema dell’interpretazione della norma: infatti, a parere del Legislatore, l’intero impianto normativo del “Codice ambientale” tenderebbe a richiamare l’applicabilità delle sanzioni penali alle sole violazioni di maggiore gravità, prevedendo come regola generale la sanzione amministrativa, derogata solamente in ipotesi tassative dalla fattispecie penale: le sentenze sopra indicate al secondo punto, ribaltavano invece la prospettiva ed il rapporto sussistente fra i due apparati sanzionatori, violando – a parere del Legislatore – non solo il criterio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni, ma anche la clausola di riserva contenuta nell’articolo 133, comma 1, “Codice ambientale” (8). Con la versione novellata del comma 5 dell’articolo 137, viene pertanto superata l’interpretazione restrittiva della norma fatta propria da parte della giurisprudenza che si fondava sulla semplice lettura dell’articolo 137 come a suo tempo recepito dal Dlgs 152/2006: come detto, tale lettura aveva portato alla sostanziale inapplicabilità delle sanzioni amministrative e ad un ampliamento della fattispecie penalmente rilevante che il Legislatore in realtà non sembrava aver messo in conto (infatti non sembra esservene traccia nei lavori preparatori delle novelle del 2000 e del 2006), tanto da prevedere espressamente nell’articolo 133 l’applicazione della sanzione amministrativa da 3 mila a 30 mila euro, “salvo che il fatto costituisca reato”: in effetti, se la lettura corretta fosse quella restrittiva della sentenza 29 ottobre 2003, sarebbe difficilmente giustificabile nel contesto normativo in discorso una “riserva punitiva” fatta propria dal primo comma dell’articolo 133 già citata. Dunque, modificando il comma 5 dell’articolo 137, si dispone l’applicazione di sanzioni penali al solo caso in cui il superamento tabellare dei valori limite stabiliti nelle tabelle 3 e 4 (rispettivamente scarichi in acque superficiali e fognatura e scarichi sul suolo, sempre intesi come di acque reflue industriali) dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 152/2006, nonché eventualmente dalle Regioni, Province autonome o autorità di gestione del servizio idrico integrato ai sensi del’articolo 107 comma 1 del medesimo decreto legislativo, riguardi le 18 sostanze più pericolose (per la puntuale elencazione di tali sostanze si veda la precedente nota 5). Negli altri casi sarà applicabile la sola sanzione amministrativa da 3 mila a 30 mila euro. Gli effetti della norma La nuova versione del comma 5 dell’articolo 137 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 ed è pertanto entrata in vigore il 27 marzo 2010. In ogni caso, la norma potrà avere efficacia anche in relazione a comportamenti illeciti contestati prima dell’entrata in vigore della norma e ciò in base al principio costituzionale in base al quale si applica sempre la norma più favorevole al reo. Ciò significa che i procedimenti penali deri- vanti dal contestato superamento di limiti tabellari non riguardanti una o più delle diciotto sostanze pericolose indicate non potranno condurre ad una condanna: – per quelli che si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero dovrà chiedere l’archiviazione e la trasmissione degli atti all’ente preposto all’irrogazione della sanzione amministrativa cioè la Provincia; – per quelli già in fase dibattimentale (o per il quale è in corso la celebrazione di riti alternativi), il Giudice dovrà pronunciare assoluzione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, secondo periodo C.p.p., in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato e provvedere come in precedenza alla trasmissione degli atti; – infine, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, C.p., secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata una condanna ne cessano esecuzione ed effetti penali”, in caso di avvenuta condanna, cessa ogni effetto pregiudizievole della stessa. Conclusioni Senza voler entrare nel merito dell’opportunità di prevedere sanzioni amministrative per “inquinamenti light”, la norma ha comunque certamente il pregio risolvere in modo chiaro un dubbio interpretativo che stava portando a sanzionare in modo qualitativamente diverso comportamenti identici a seconda dell’interpretazione più o meno restrittiva adottata dal Giudice. È innegabile che la precedente formulazione del comma 5 dell’articolo 137 fosse assolutamente infelice, e occorre prendere atto del fatto che il Legislatore ha a più riprese chiarito che (in ossequio alla riserva posta dall’articolo 133, comma 1, “Codice ambientale”) l’apparato sanzionatorio si basa in via principale sulla sanzione amministrativa e solo in via residuale su quella penale. Come detto, si può essere o meno d’accordo su questa impostazione “strategica”, ma è certamente positivo che si lavori applicando norme di indubbia interpretazione piuttosto che dover far ricorso a contorti esercizi giuridici per far prevalere l’interpretazione più confacente al proprio caso e ai propri convincimenti personali. Riferimento normativo Condotta penalmente rilevante Lo scarico di acque reflue industriali oltre i “valori limite” è fonte di responsabilità penale se supera: – i valori limite stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla Parte Terza del Codice ambientale, – in caso di scarico sul suolo, i limiti della tabella 4 del medesimo allegato 5, – nel caso contenga sostanze elencate nella tabella 5, allegato 5, i limiti stabiliti dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti. Dal 27 marzo 2010 (*) Lo scarico di acque reflue industriali oltre i “valori limite” è fonte di responsabilità penale solo se ha ad oggetto una o più sostanze elencate nella tabella 5, allegato 5 alla Parte Terza del Codice ambientale e se contemporaneamente supera uno dei seguenti valori limite: – valori indicati dalla tabella 3 per gli scarichi nei corpi idrici; – valori indicati dalla tabella 4 per gli scarichi sul suolo; – valori limite fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti. Dlgs 152/2006 Articolo 137, comma 5 – Sanzioni penali (Come modificato dalla legge 36/2010) “5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”. In tutti gli altri e diversi casi costituisce illecito amministrativo sanzionato ex articolo 13, Dlgs 152/2006. (*) Si ricorda che in base all’articolo 2 C.p. “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna ne cessano esecuzione e gli effetti penali.”. Note (1) Per la nozione di acque reflue industriali, ad abundantiam, si veda anche Cassazione penale, Sez. III, 5 febbraio 2009, n. 12865 in base alla quale “nella nozione di acque reflue industriali dfinita dall’articolo 74, comma primo, lettera h, del Dlgs 152/2006 (come modificato dal Dlgs 4/2008) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque domestiche, come definite dall’articolo 74, comma primo, lettera g) del citato decreto”. (2) L’allegato 5 alla parte terza del Te- sto unico riguarda i limiti di emissione degli scarichi idrici, la tabella 5 precisa le sostanze per le quali le regioni, le provincie autonome o le autorità di gestione del servizio idrico, non possono legittimamente adottare limiti meno restrittivi di quelli indicati nella tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria o, nella tabella 4, per lo scarico al suolo. (3) In tal senso si vedano anche Cass. penale, Sez. III, 20 febbraio 2004, n. 14801, Cass. penale, Sez. III, 13 aprile 2005, n. 19254, Cass. penale, Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37279, Cass. penale, Sez. III, 11 marzo 2009, n. 19875. (4) Si veda a questo proposito il citato documento del servizio studi del Senato della Repubblica. (5) Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, nichel, piombo, rame, solenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno e sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi del Dlgs 52/97 e ss.mm. (6) Testualmente dalla “scheda di lettura Disegno di Legge 1755. settembre 2009. Ufficio Studi Senato”. (7) “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro”. (8) “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato (omissis) è punito con la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro” (omissis). RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Fino al 26 marzo 2010 (*) Dlgs 152/2006 Articolo 137, comma 5 – Sanzioni penali “5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.”. Legislazione norme nazionali Scarichi industriali e sanzioni Termini 25 Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 3 marzo 2010, n. 8299 La massima Giurisprudenza Smaltimento abusivo: Smaltimento di rifiuti senza autorizzazione – Articolo 260, Dlgs 152/2006 – Ricorso alla misura cautelare detentiva – Necessità Lo smaltimento di rifiuti senza apposita autorizzazione è senz’altro “abusivo” ai sensi dell’articolo 260, Dlgs 152/2006 e comporta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano il ricorso alla misura cautelare detentiva. La decisione di non applicare la misura cautelare deve pertanto essere quantomeno supportata da idonea motivazione. Infatti, tutte le attività non conformi al preciso dato normativo svolte nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sono senz’altro connotate, a parere della Corte, dal carattere dell’abusività di cui al primo comma dell’articolo 260 citato. (L.B.) consente la misura cautelare detentiva RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 26 Repubblica italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione III Penale Pres. Grassi Rel. Marmo Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: (omissis) ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: Pmt presso Tribunale di Perugia nei confronti di: 1) (…), avverso l’ordinanza n. 289/2009 Tribunale Libertà di Perugia, del 27/05/2009 – sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. (…); – sentite le conclusioni del Pg Dott. (…) che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata; – Uditi difensori Avv.ti (…) che hanno chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 27 maggio 2009 il Tribunale del riesame di Perugia accoglieva l’istanza di riesame proposta da (…), avente ad oggetto la revoca delle misura della custodia cautelare in carcere disposta il 4 maggio 2009 dal Gip del Tribunale di Terni in relazione al reato di cui agli articoli 81, 112 c.p. e 260 del Dlgs n. 256 del 2006, sul rilievo che gli specifici elementi addotti dall’accusa sarebbero stati asintomatici in merito alla sussistenza del reato in oggetto. Il Tribunale del riesame riteneva che erano insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in riferimento al reato contestato, di cui all’articolo 260 del Dlgs n. 152 del 2006, l’unico che giustificava l’irrogazione della misura cautelare disposta nei confronti dell’indagato. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Terni lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine al reato contestato, specie con riferimento al concorso di quest’ultimo nel reato di illecito smaltimento di rifiuti contestato al coindagato (…). Il 9 novembre 2009 il (…) ha presentato memoria difensiva, con la quale rileva che l’ordinanza impugnata era condivisibile atteso che, nel caso in esame, poteva, al più, ritenersi sussistente a carico di esso indagato esclusivamente la violazione di cui all’articolo 485 c.p. per la quale non è prevista la misura cautelare detentiva. Tanto premesso il Collegio rileva che, come ha correttamente osservato il Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale del riesame di Perugia, pur rilevando che l’attività di ricerca, raccolta e conferimento delle batterie esauste al centro di raccolta gestito dal (…) svolta dai coindagati, ed in particolare dal (…), era illecita poiché le dichiarazioni che accompagnavano il conferimento delle batterie al piombo esauste venivano camuffate sotto la falsa dicitura: “rottami misti da selezionare”, aveva incongruamente ritenuto che comunque, nonostante ciò, ganizzate, cede, riceve e trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Nel caso in oggetto il Tribunale del riesame non ha spiegato come e perché la ricezione da parte dell’indagato di ingenti quantitativi di batterie al piombo esauste sotto falsa denominazione, da chi non aveva alcuna autorizzazione di legge alla raccolta ed al conferimento, non dovesse considerarsi abusiva. Deve in proposito affermarsi il principio che l’avverbio “abusivamente” di cui al primo comma dell’articolo 260 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa. È comunque assorbente il rilievo che il Tribunale del riesame, come ha correttamente rilevato il Pm, ha preso in considerazione soltanto un segmento di condotta del (…), esaminando la fattispecie solo dal punto di vista del titolare del centro di raccolta che riceve le batterie, ma ha omesso di considerare del tutto la condotta del (…) con la quale il (…) ha concorso, come specificamente precisato nel capo di imputazione, con ciò incorrendo nel vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione. Risulta infatti dal provvedimento impugnato che il (…) non è un privato cittadino che ha conferito all’indagato una batteria di piombo esausta; è un soggetto che ricercava, raccoglieva, trasportava e conferiva abitualmente, continuativamente a fine di lucro e con allestimento di mezzi, siffatto materiale senza essere in possesso di alcuna autorizzazione, tant’è che doveva necessariamente ricorrere al falso nei documenti di accompagnamento. Il provvedimento del Tribunale del riesame è quindi carente di motivazione in ordine alle ragioni per cui i giudici non hanno ritenuto che la condotta dell’indagato, il quale, secondo la prospettazione accusatoria, aveva impartito ai dipendenti istruzioni di accettare conferimenti da parte di soggetti non abi- litati, ovvero non titolari di specifiche autorizzazioni, oppure non iscritti all’apposito albo, non avesse comunque agevolato la condotta del (…) nel compimento dei fatti riconducibili all’ipotesi sanzionata dall’articolo 260 del citato decreto legislativo. Considerato quindi che l’ordinanza impugnata è carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata ritenuta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato in ordine al reato ipotizzato, il detto provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame. Così deciso in Roma il 25 novembre 2009 Depositata in cancelleria il 3 marzo 2010 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Dizionario delle definizioni normative in campo ambientale a cura di Giancarlo Chiara 2009 pagine 240 28,00 e Un testo completo e fruibile che raccoglie le definizioni normative in materia di ambiente, sicurezza, igiene degli alimenti, beni culturali e del paesaggio, codice della strada. Le definizioni, aggiornate in base alle ultime disposizioni normative, vengono riportate nella loro esatta formulazione di legge. tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02/45487333 www.edizioniambiente.it e-mail [email protected] Sì, desidero acquistare in contrassegno il volume (contributo: 3,00 e) Dizionario delle definizioni normative in campo ambientale a 31,00 e Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999. nome e cognome ragione sociale via n. città prov. tel. fax P. Iva/C.F. e-mail data firma cap Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 3 marzo 2010, n. 8299 non sarebbero configurabili in capo all’indagato gli estremi del reato perché egli era in possesso delle necessarie autorizzazioni per ricevere siffatte batterie anche da privati. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che la falsificazione dei documenti di accompagnamento non sarebbe stata finalizzata all’occultamento del materiale che veniva ricevuto dal centro rottami, ma era dovuta solo a ragioni di carattere contabile e alla mancanza di formulari che precisassero, a monte, le caratteristiche del rifiuto, sicché avrebbe potuto ipotizzarsi esclusivamente a carico dell’indagato il reato di cui all’articolo 485 C.p. non contemplato quod poenam ai fini dell’emissione del provvedimento restrittivo. Viceversa, secondo il Procuratore ricorrente, avrebbe dovuto ipotizzarsi quanto, meno, il concorso del (…) nella illecita condotta del (…). Rileva in proposito il Collegio che l’articolo 260 del Dlgs n. 256 del 2006 sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative or- R 1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003. 2) Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra: [ ] autorizzo [ ] non autorizzo l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative della Casa Editrice. Firma ............................................................................ 27 Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 9 marzo 2010, n. 9252 La massima Giurisprudenza Inerti da C & D: spanderli e livellarli è smaltimento di rifiuti Deposito permanente di rifiuti – Smaltimento – Articolo 183, comma 1, lettera g) – Spandimento sul suolo di materiali di risulta di demolizione – Rientra L’attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta di una demolizione, destinati a livellare un terreno sul quale dovrà essere costruito un parcheggio, rientra senz’altro nell’ipotesi di “deposito permanente” di rifiuti, ossia attività di smaltimento degli stessi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera g), Dlgs 152/2006. L’operazione di smaltimento è individuabile nel D12 allegato B, Parte quarta, Dlgs 152/2006. Pertanto, tale attività necessita di autorizzazione come qualsiasi altra attività di gestione dei rifiuti. (L.B.) Repubblica italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione III penale RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Composta dagli ill.mi Signori: Pres. Grassi Rel. Petti (omissis) ha pronunciato la seguente: Sentenza Sul ricorso proposto dall’Avv. (…), difensore di fiducia di (…), avverso la sentenza in data 11.3.2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, con la quale venne condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda quale colpevole del reato di cui all’articolo 51, comma primo, del Dlgs 22/1997. – Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; – Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. (…); – Udito il P.m., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. (…), che ha concluso per il rigetto del ricorso; Svolgimento del processo 28 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, ha affermato la colpevolezza di (…) in ordine al reato di cui all’articolo 51, comma primo, del Dlgs n. 22/1997, come sostituito dall’articolo 256 del Dlgs n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato Io smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da pezzi di mura- tura, tegole, cemento ed altri residui provenienti dalla demolizione di un fabbricato, senza la prescritta autorizzazione. È stato accertato in punto di fatto che tale (…), titolare dell’omonima ditta, aveva effettuato, per conto del Comune di Vairano, lavori di demolizione di una palestra e successivamente aveva depositato i materiali di risulta provenienti dall’attività di demolizione su un terreno sul quale la ditta (…) stava realizzando un parcheggio; che l’imputato aveva provveduto a spianare il predetto materiale di risulta al fine di innalzare il piano di campagna del suolo sul quale doveva essere realizzato il parcheggio. Il giudice di merito ha affermato che il materiale di risulta di cui alla contestazione costituisce rifiuto, secondo la classificazione contenuta nell’allegato A al Dlgs n. 22/97, codice Cer 170700, e che l’attività posta in essere dall’imputato integra, in ogni caso, un’ipotesi di smaltimento dei predetti rifiuti. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’articolo 568, ultimo comma, C.p.p.. Con motivi aggiunti il difensore dell’imputato ha dedotto la intervenuta prescrizione del reato, verificatasi anche prima dell’ordinanza con la quale la Corte territoriale ha trasmesso gli atti in cassazione. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame il ricorrente chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non te nell’allegato B dei rispettivi decreti (parte quarta per quello vigente). Tra le operazioni di smaltimento descritte nell’allegato B, il cui contenuto è rimasto immutato, alla lettera D12 é indicato il “deposito permanente” dei rifiuti. Orbene, non vi è dubbio che l’attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno posta in essere dall’imputato rientra nella ipotesi di cui alla citata lettera D12 dell’allegato B, essendo evidentemente destinata a rendere permanente il deposito dei rifiuti in precedenza effettuato dalla ditta (…). È appena il caso di rilevare sul punto che la previsione specifica contenuta nella lettera D12 di una condotta che integra il deposito permanente ha carattere meramente esemplificativo, come indicato dallo stesso disposto. Il secondo motivo di gravame è inammissibile in quanto presuppone un accertamento di fatto in ordine al’elemento psicologico del reato, non consentito in sede di legittimità. Inoltre la relativa questione non risulta essere stata proposta nella sede di merito, sicché in ogni caso è inammissibile ai sensi dell’articolo 606, ultimo comma, C.p.p.. Peraltro, trattandosi di contravvenzione, il fatto è punibile anche a titolo di colpa, mentre risulta evidente il mancato accertamento da par- te dell’imputato della natura di rifiuto dei materiali che ha provveduto a spandere sul suolo. Il terzo motivo è inammissibile per la genericità assoluta della doglianza, che peraltro è di merito. Egualmente di merito è il successivo motivo di gravame e, perciò, inammissibile in sede di legittimità. Peraltro, costituisce motivazione sufficiente in ordine alla quantificazione della pena il riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 C.p., considerato che nella specie è stata inflitta la pena pecuniaria, prevista alternativamente a quella detentiva per le ipotesi di condotte connotate da maggiore gravità. L’ultimo motivo è inammissibile, non essendo stata chiesta al giudice di merito la concessione del beneficio della non menzione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell’articolo 616 C.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella pubblica udienza dei 21 gennaio 2010. Depositata in cancelleria l’8 marzo 2010 Comitato Scientifico di Coordinamento RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) l’applicazione della pena nella misura del minimo edittale, deducendosi la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione della pena inflitta. Con l’ultimo motivo, infine, si censura la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’articolo 175 C.p.. Il ricorso non è fondato. Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato ascritto all’imputato. Con decorrenza dalla data del fatto (10.5.2005), invero, tenuto della sospensione del decorso del termine, per rinvio del dibattimento a seguito della astensione del difensore dalle udienze, per il complessivo periodo di mesi quattro e giorni ventotto, la prescrizione del reato verrebbe a verificarsi in data 8.4.2010, ai sensi degli articolo 157, primo comma n. 5), e 160 C.p. nella formulazione previgente. Osserva, poi, la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, per quanto riguarda la definizione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, sia l’articolo 6, primo comma lettera g), del Dlgs n. 22/97, vigente alla data del fatto, che l’articolo 183, primo comma lettera g), del Dlgs n. 152/06, come sostituito dall’articolo 2, comma 20, del Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, si limitano a rinviare alle descrizioni contenu- Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 9 marzo 2010, n. 9252 sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Si osserva che unico detentore dei rifiuti era la ditta (…), giudicato separatamente ed al quale era stata applicata la pena ai sensi dell’articolo 444 C.p.p., avendo proceduto alla esecuzione dei lavori di demolizione da cui erano residuati i rifiuti ed al successivo trasporto e deposito degli stessi su un altro terreno; che l’attività posta in essere dall’imputato, di spianamento dei materiali depositati, di cui non si contesta sostanzialmente la natura di rifiuto, dovendo i materiali essere sottoposti a test di cessione prima del loro eventuale reimpiego, non può essere qualificata di smaltimento dei rifiuti, non essendo riconducibile ad alcuna delle condotte previste dall’articolo 6 lettera g) del Dlgs n. 22/1997 e dall’allegato, cui la norma rinvia. Con il secondo motivo di gravame si chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato. Si deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere insussistente l’elemento psicologico del reato ai sensi dell’articolo 47 C.p., avendo l’(…) fatto affidamento sulla apparente legalità del contesto in cui è stata posta in essere la condotta ascrittagli. Con il terzo motivo si chiede l’assoluzione dell’imputato per carenza o insufficienza di prove della sua colpevolezza. Con il successivo motivo si chiede delle attività di Edizioni Ambiente in campo normativo – Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” – Attività di formazione sulla normativa ambientale – Area normativa di Reteambiente Presidente: Componenti: Paola Ficco (Giurista ambientale; Docente universitario; Responsabile attività normativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile) Fabio Anile (Avvocato in Roma) Mannino Bordet (Esperto presso la Segreteria tecnica della Direzione Generale Energia del Ministero Sviluppo Economico) Tommaso Campanile (Responsabile nazionale Ambiente e Sicurezza CNA) Marco Casini (Università degli Studi di Roma La Sapienza) Paolo Cesco (Segretario FISE – Assoambiente, Confindustria) Sebastiano Cipriano (Colonnello, Guardia di Finanza – Nucleo Repressione Frodi, Milano) Sonia D’Angiulli (Avvocato in Roma) Alessandro Geremei (Redazione Reteambiente) Maurizio De Paolis (Direttore Servizio Massimario e Ruolo Generale del Consiglio di Stato) Fausto Giovanelli (Avvocato, già Presidente della Commissione Ambiente e Territorio del Senato nella XIII Legislatura) Pasquale De Stefanis (Enea – Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile) Giancarlo Longhi (già Direttore Generale CONAI) Vincenzo Dragani (Redazione Reteambiente) Simona Faccioli (Redazione Reteambiente) Leonardo Filippucci (Avvocato in Macerata) Franco Gerardini (Regione Abruzzo – Servizio gestione rifiuti) Massimo Medugno (Vice Direttore generale Assocarta, Confindustria) Maurizio Musco (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa) Alessandro Muzi (Direttore smaltimento finale AMA Roma) Maria Letizia Nepi (Vice Segretagio FISE UNIRE – Confindustria) Renato Nitti (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari) Andrea Sillani (Università degli Studi di Roma La Sapienza) Gabriele Taddia (Avvocato in Ferrara) Loredana Musmeci (Direttore Reparto Suolo e Rifiuti – Istituto Superiore di Sanità) 29 Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 24 marzo 2010, n. 11260 La massima Giurisprudenza La nozione di rifiuto non è una “catalogazione chiusa” RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Pres. Onorato Rel. Amoroso Abbandono di rifiuti – Nozione di rifiuto – Articolo 183, Dlgs 152/2006 – Individuazione – Definizione “aperta” di rifiuto Ricomprendendo qualsiasi sostanza od oggetto – di cui il detentore si disfa – che rientra nelle categorie previste dall’allegato A del Dlgs 152/2006, la definizione di rifiuto stabilita dall’articolo 183 del Dlgs 152/2006 è “aperta”. La mancata indicazione da parte del Giudice di merito di quale sia la categoria (tra le 16 contenute nell’allegato A del Dlgs 152/2006) alla quale ascrivere i rifiuti non comporta necessariamente l’illegittimità della decisione di merito, allorchè la sentenza contenga una descrizione dei materiali abbandonati che consente al Giudice di ritenere motivatamente che gli stessi costituiscano rifiuti: in questo caso, non serve l’indicazione puntuale della categoria di rifiuti “tabellati” nella quale gli stessi rientrano. (A.G.) Repubblica italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione III Penale Composta dagli ill.mi signori Magistrati: (omissis) ha pronunciato la seguente Sentenza – sul ricorso proposto da (omissis); – avverso la sentenza del 2.7.2008 del Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Porretta Terme; – Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere (omissis); – Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. (omissis) che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; la Corte osserva: Svolgimento del processo 30 1. (omissis) era imputato a) del reato p. e p. dall’articolo 192 comma 1 del Dlgs n.152/06, sanzionato dall’articolo 256 comma 2 del medesimo decreto, perché, quale titolare dell’azienda agricola d.lvo, in varie aree adiacenti alla stalla, depositava in modo incontrollato vari rifiuti non pericolosi, quali materiali ferrosi, carta, contenitori vuoti ed altri rifiuti provenienti dall’attività (in Castel d’Aiano (BO) fraz. Villa d’Aiano il 19.05.2006). Con decreto di giudizio immedia- to ritualmente notificato all’imputato (omissis) veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in rubrica ascrittogli. All’esito dell’udienza dibattimentale, il Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme, con sentenza del 2 luglio 2009 dichiarava (omissis) colpevole del reato ascrittogli e per l’effetto lo condanna alla pena di euro 6.000,00 (seimila) di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denuncia l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione rilevabile dal corpo del testo della decisione impugnata. Sottolinea come la nozione di rifiuto sia contenuta nel comma 1, lettera a), dell’articolo 183 Dlgs n. 152/2006 secondo la quale è da considerarsi tale “qualsiasi sostanza od oggetto che attualmente rientri nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi”. Tale normativa, riproducente l’allegato I della direttiva n. 75/442/Cee e della direttiva n. 2006/12/Cee, che riporta l’elenco delle sedici categorie di rifiuti individuate in sede comunitaria, si pone come vera e propria linea di confine sull’appartenenza o stati rinvenuti, costituiscano rifiuti. Infatti l’articolo 183 Dlgs n. 152 del 2006 (recante le definizioni) non contiene una catalogazione chiusa; rinvia sì all’allegato A, ma comunque contiene una definizione aperta: rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. La natura del materiale rinvenuto e le circostanze di fatto che caratterizzavano il deposito dello stesso hanno consentito al Giudice di ritenere che si trattava di materiale di cui il detentore aveva deciso di disfarsi. La volontà dell’imputato di disfarsi di tale materiale è emersa dalle cir- costanze di fatto della condotta contestata, stante l’abbandono all’aperto senza protezione e cautela di sorta e la risalenza nel tempo di tale abbandono comprovata dalla produzione del fascicolo fotografico. 3. Quanto poi al rilievo sull’entità della pena, si tratta di censura inammissibile stante la discrezionalità del Giudice di merito di apprezzare le circostanze di cui all’articolo 133 C.p.. Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 C.p. (Cass., sez. VI, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. 4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l’11 febbraio 2010 Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2010 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Imprese e ambiente 2010 Guida agli adempimenti normativi a cura di Paola Ficco 2009 pagine 432 29,50 e Guida ragionata a tutti gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza previsti dalla normativa vigente. Giunto ormai alla decima edizione, il volume è uno strumento prezioso per indirizzare con certezza le imprese che devono affrontare un sistema di obblighi e disposizioni. tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02/45487333 www.edizioniambiente.it e-mail [email protected] Sì, desidero acquistare in contrassegno il volume (contributo: 3,00 e) Imprese e ambiente 2010 a 32,50 e Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999. nome e cognome ragione sociale via n. città prov. tel. fax P. Iva/C.F. e-mail data firma cap Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 24 marzo 2010, n. 11260 meno di un particolare oggetto nella prefata categoria. Orbene – secondo il ricorrente – il Giudice di merito non ha indicato a quale di quelle categorie dovrebbero ascriversi i materiali oggetto dell’imputazione. 3. Il ricorso è infondato, trattandosi di abbandono di rifiuti, penalmente rilevante (articolo 256, secondo comma, Dlgs n. 152 del 2006) perché posto in essere da imprenditore (agricolo). È vero che la sentenza impugnata non indica in quale categoria di rifiuti “tabellati” rientrano quelli nella specie abbandonati. Ma la descrizione che ne fa la sentenza (carta, materiale ferroso, contenitori vuoti) ha consentito al Giudice, motivatamente, di ritenere che tali oggetti, nel contesto in cui sono R 1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003. 2) Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra: [ ] autorizzo [ ] non autorizzo l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative della Casa Editrice. Firma ............................................................................ 31 a cura di Paola Ficco Claudio Rispoli Chimico – Esperto industriale Le opinioni presenti nelle risposte ai quesiti, al pari di tutte le altre presenti nella Rivista, sono espresse a titolo personale. Esse impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle istituzioni, né agli enti di appartenenza, né alla Rivista. Rubriche RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 32 La Rubrica si propone di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. La Rubrica non esercita attività di consulenza, diretta o indiretta, e non fornisce supporto a privati per motivi personali. I Curatori risponderanno solo a quesiti ritenuti, a loro insindacabile giudizio, di valenza generale. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche. Il servizio fornito dalla Rubrica è gratuito ed è riservato agli abbonati alla Rivista (sia cartacea che on line) e agli abbonati di “Osservatorio di normativa ambientale” di ReteAmbiente; pertanto si prega di evidenziare nel quesito il nome del soggetto intestatario dell’abbonamento. I quesiti (la cui formulazione non deve superare le 10 righe) possono essere inviati al seguente indirizzo [email protected] e troveranno risposta, ogni mese, su queste pagine. Risponde Paola Ficco 451. Formulario: per il trasporto dei rifiuti urbani non è richiesto Un consorzio di cooperative sociali ottiene l’appalto per il servizio di manutenzione delle aree verdi di un Ente Pubblico e lo affida alla propria Consorziata. Premesso che l’articolo 184, comma 2, Dlgs 152/2006 definisce quali rifiuti urbani, fra l’altro, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (lettera e) ; considerato che la circolare Ministri ambiente ed industria del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 testualmente ha affermato, alla lettera n), che “in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato da formulario di identificazione (…) è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per il quali il servizio medesimo è gestito”; ritenuto che la cooperativa con- Quesiti sorziata, con la sua attività, pone in essere le fasi di produzione iniziale – raccolta e trasporto dei rifiuti vegetali, in virtù di un appalto pubblico (stipulato con il Consorzio) avente ad oggetto la manutenzione delle aree verdi pubbliche e ricordato che nella quasi totalità di questi appalti gli oneri economici dello smaltimento sono a completo carico dei Comuni, si chiede di sapere se la cooperativa consorziata che effettivamente gestisce il servizio di manutenzione aree verdi pubbliche possa essere considerata “il gestore pubblico” previsto dalla lettera n) della circolare Ministri ambiente ed industria del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98, e dunque possa ritenersi esonerata dalla compilazione dei formulari. Si ritiene che il gestore del servizio pubblico, di cui alla citata Circolare 4 agosto 1998 e di cui all’articolo 193, comma 4, Dlgs 152/2006, in difetto di precisazioni particolari da parte di tale articolo 193, sia chiunque in virtù di un titolo legittimo espleti tali servizio. Pertanto, se ricorre tale condizione di legittimità di affidamento del servizio ed essendo i rifiuti di cui al quesito qualificabili come urbani, si ritiene che nel caso di specie, il formulario non sia necessario. 452. Modifica sostanziale: ricorre se c’è un potenziamento dell’impianto Si vuole sapere se per un’azienda autorizzata in procedura ordinaria al trattamento di rifiuti la richiesta di aumento delle quantità di rifiuti non pericolosi da trattare in R13 o D15 configuri o meno variante sostanziale rispetto al progetto originariamente approvato. Si precisa che la possibilità di trattare maggiori quantità di rifiuti non deriva da modifiche impiantistiche o di processo, ma da un migliore sfrutta- mento degli impianti esistenti la cui potenzialità non era precedentemente utilizzata al 100% (quindi, ad esempio, aumentando il numero delle ore di trattamento). La disciplina relativa alla gestione dei rifiuti non contempla la definizione di modifica, né quella di modifica sostanziale. Nella disciplina relativa alla Aia, Dlgs 59/2005, articolo 2, comma 1, lettere m) e n), si reperiscono le seguenti definizioni e sono riferite all’impianto: “m) modifica dell’impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente; n) modifica sostanziale: una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”. Nella disciplina relativa alla Via/Vas, Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 4/2008, articolo 5, comma 1, lettere l) e lbis) si reperiscono le seguenti definizioni e sono relative al progetto: “l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente; l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull’ambiente;”. La società X, insieme ad un’altra società Y, ha costituito una ditta Z, per poter acquistare un impianto di stoccaggio dei rifiuti che si chiama W. W ha venduto il 13 novembre 2009 a Z l’impianto. La voltura dell’autorizzazione dell’impianto è del 7 dicembre 2009. Come comportarsi per il Mud? Si ritiene che il nuovo gestore debba comunicare i rifiuti stoccati al 31 dicembre 2009 e le operazioni intervenute dalla data di inizio della sua gestione fino alla fine dell’anno. Per il pregresso, l’alienante deve rendere conto di quanto prodotto e gestito nel 2009, fino alla data della voltura. 454. Recupero: le limitazioni regionali vanno eccepite La Regione Campania ha emanato una delibera regionale con la quale vieta l’ingresso dei rifiuti recuperabili in piattaforme della Regione stessa. Si chiede di sapere se in virtù della sentenza della Corte costituzionale del 23 gennaio 2009, n. 10, si possono ritirare questi rifiuti extra regionali. La Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza 23 gennaio 2009, n. 10 nei confronti dell’articolo 3, comma 1, della legge Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per 455. Sistri: per le unità locali senza dipendenti dove si generano rifiuti da manutenzione il registro cronologico si compila nella sede legale Sede a Forlì ma unità locale “anomala” ad Udine ove si producono rifiuti pericolosi; ma non vi sono dipendenti. Nello specifico: a Udine vi è solo un motore (di nostra proprietà); è un impianto di cogenerazione che produce energia presso uno stabile non nostro. Contrattualmente però, essendo nostro il motore, è nostro compito occuparci della manutenzione e smaltimento olio-filtri, che finora abbiamo gestito direttamente dalla sede legale in quanto, appunto, non vi sono dipendenti ad Udine. Come dobbiamo comportarci? L’articolo 7, comma 2, Dm 17 dicembre 2009 stabilisce che “Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva.”. Tale disposizione, dunque, prevede che la compilazione del registro cronologico (in caso di manutenzione, come nel caso di specie) possa avvenire da parte del delegato della sede legale. L’assetto sistematico della norma, infatti, individua il delegato in modo “promiscuo” non apponendo un termine che si riferisca univocamente ad una delle due attività (es. “rispettivamente”). Pertanto, in entrambi i casi, si può provvedere in un modo oppure nell’altro. In ragione di tale previsione, si ritiene che in caso di rifiuti derivanti da attività di manutenzione il registro cronologico possa essere compilato dal delegato della sede legale, entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto. Poi il sistema, a seguito della movimentazione dei rifiuti, compila in automatico la riga dell’Area registro cronologico corrispondente alla movimentazione effettuata. 456. Sistri: la possibilità di porre in essere un’attività non obbliga alla iscrizione immediata Una società cooperativa sociale onlus, iscritta all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 gestisce il servizio di creazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulla base di contratto pubblico di appalto con un Ente pubblico. Essa ha 16 lavoratori (tra soci e lavoratori non soci). Durante questa attività pone in essere raccolta e trasporto di rifiuti da essa prodotti (non pericolosi 170405 e pericolosi 150110). Ai fini dell’iscrizione al sistema Sistri si chiede: – se detta attività, per quanto riguarda la produzione dei rifiuti non pericolosi, rientra fra quelle indicate alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184 comma 3; – se la mera possibilità di raccogliere e trasportare sino ad un massimo di 30 kg. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 453. Mud: il nuovo gestore deve comunicare lo stoccaggio a fine anno e le operazioni fatte lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia), nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale. A motivo di tale pronuncia, ex plurimis, la Corte ha posto la seguente considerazione: “La disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito della ‘tutela dell’ambiente e dell’ecosistema’, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma regionale impugnata – prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – viene a porsi in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 182 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (che riproduce l’espressione precedentemente contenuta nel comma 3 dell’articolo 5 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso ‘una rete integrata ed adeguata di impianti per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi’. Laddove nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne ‘permette’ anche altre, nella disciplina regionale impugnata costituisce la soluzione obbligata. Tale divieto viene, altresì, a contrastare con lo stesso concetto di ‘rete integrata di impianti di smaltimento’ che presuppone una possibilità di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato e non ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l’accesso ad alcune sue parti. Il divieto è legittimo, (…) con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi in quanto è la normativa statale che lo prevede, mentre si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui una fonte di produzione legislativa regionale lo venga a contemplare nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale.”. Come noto, non è questa la prima sentenza in tal senso enunciata dalla Consulta che più volte ha espunto dall’ordinamento nazionale disposizioni similari. Essa afferma un principio importantissimo. Tuttavia, questa sentenza non può essere utilizzata per non rispettare il divieto regionale della Campania. Per fare questo è necessario impugnare la delibera campana dinanzi alla Corte costituzionale. Rubriche Quesiti L’articolo 269, comma 8, Dlgs 152/2006 (per la parte relativa alla qualità dell’aria) stabilisce che per “Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.”. Pertanto, è necessario avere a riferimento le definizioni evidenziate. Tuttavia, trattandosi di rifiuti non pericolosi soggetti a D15 o R13 il problema Via non si pone. Nel caso di specie, non si verificherebbero modifiche all’impianto né al progetto ma solo un potenziamento della produzione (cioè una maggiore quantità di rifiuti stoccati). Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, non possa esservi una modifica sostanziale in ordine alla gestione dei rifiuti, a meno che non si renda necessario un potenziamento dell’impianto inteso – si ritiene – con l’aggiunta di linee produttive o attrezzature fisse. Laddove tale modifica incida sulla quantità di emissioni in atmosfera, sarà necessario ottenere apposita autorizzazione ai sensi della parte V (aria) del “Codice ambientale”. Se si tratta di operazioni di “stoccaggio”, però, si tratta di una possibilità remota. 33 Rubriche Quesiti al giorno di rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8) determina, indipendentemente dalla risposta al quesito di cui sopra, l’obbligo inderogabile all’iscrizione al sistema sistri. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) I rifiuti di cui al Cer 170405 sono non pericolosi. I rifiuti di cui al Cer 150110 sono pericolosi. Nel caso di specie, la onlus non cede beni ma presta servizi. Quindi i rifiuti da essa prodotti scaturiscono da un’attività di servizio, quindi da attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera f), Dlgs 152/2006. In tale qualità, per i rifiuti non pericolosi, il Lettore “può” (e non “deve”) aderire al Sistri, su base volontaria, a decorrere dal 12 agosto 2010 (articolo 1, comma 4, Dm 17 dicembre 2010). I trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti, devono iscriversi al Sistri entro il 29 aprile 2010. Tuttavia, se il soggetto interessato, allo stato attuale, non raccoglie né trasporta rifiuti pericolosi fino a 30 kg. al giorno, costui non è obbligato alla iscrizione. Però, quando questa ipotesi si concreterà, costui non potrà raccogliere e trasportare i rifiuti da sé fino a quando non avrà proceduto alla iscrizione medesima. Risponde Claudio Rispoli 457. Oli minerali esausti: la presenza di cloruri va valutata con riferimento anche alle schede di sicurezza Un’azienda produttrice ha finora smaltito l’olio minerale esausto estratto da alcuni impianti con il Cer 130110 (oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati). Ora l’azienda ha commissionato analisi chimiche su campioni del rifiuto a un laboratorio ed è emersa la presenza di dicloropropano in quantità di 1,5 mg/kg, 5,2 mg/kg e 18,1 mg/kg rispettivamente per i tre campioni di olio analizzati (metodo utilizzato per le analisi: EPA 5021 A 2003 + EPA - 8260 C 2006). Si sta, quindi, valutando il passaggio al Cer 130109 (oli minerali per circuiti idraulici, clorurati). Si chiede: per l’attribuzione del Cer 130109 è necessario che i cloruri superino una certa soglia stabilita dalla normativa oppure al contrario la semplice presenza di cloruri (a prescindere dalla loro concentrazione) è già sufficiente per richiedere l’applicazione del Cer 130109? Se esiste una soglia, qual è il valore e il relativo riferimento normativo? Non è corretto riferire il codice 130109 (o comunque altri codici per “clorurati”) alla presenza di cloruri (forma inorganica ionica del cloro, relativa a composti del tutto differenti da molecole organiche contenenti cloro, quali appunto solventi o oli clorurati); bensì, occorre tenere conto della eventuale presenza significativa di sostanze organiche clorurate (appunto come il dicloropropano, additivo diffusissimo dei comuni solventi per vernici); però né le disposizioni comunitarie né quelle nazionali dettano indicazioni in termini di soglie limite da considerare per l’attribuzione dell’uno o dell’altro codice. Le concentrazioni misurate dal laboratorio rientrano nell’ordine di grandezza delle tracce (circa 0,002% per il valore più grande riscontrato), non sufficiente a qualificare tale olio usato come “clorurato”; basterebbe poi consultare le schede di sicurezza degli oli in uso presso l’azienda per scoprire se si tratta di oli clorurati o che contengono additivi clorurati. Pertanto si ritiene opportuno mantenere il codice già attribuito proprio perché le concentrazioni riferite non sono significative né in termini di rischi associati, né ai fini del Cer. Produrre meno rifiuti Politiche e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti a cura di Emanuele Burgin, Pinuccia Montanari 2009 pagine 152 20,00 e Gli interventi più significativi por- nificazione e comunicazione, ap- tati al tavolo di coordinamento A- profondimenti di tecnici e specia- gende 21 locali. Esperienze di listi sui temi della riduzione dei ri- consorzi ed enti locali, casi di pia- fiuti e delle raccolte porta a porta. tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02/45487333 www.edizioniambiente.it e-mail [email protected] Sì, desidero acquistare in contrassegno il volume (contributo: 3,00 e) Produrre meno rifiuti a 23,00 e Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999. nome e cognome ragione sociale via n. città 34 prov. tel. fax P. Iva/C.F. e-mail data firma cap 1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003. 2) Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra: [ ] autorizzo [ ] non autorizzo l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative della Casa Editrice. Firma ............................................................................ R OFFERTA PROMOZIONALE DI LANCIO PER I LETTORI DELLA RIVISTA RIFIUTI Il Codice dei Rifiuti 2010 A cura di Paola Ficco con la Redazione normativa di Edizioni Ambiente Legislazione Prassi Giurisprudenza Albo Gestori il Codice della Rivista Rifiuti Il Codice più completo e sistematico in materia di gestione dei rifiuti. Con testi annotati e completi di richiami ad altri provvedimenti. A corredo, un sistema di parole-chiave, una serie di indici cronologici e analitici e un repertorio di percorsi tematici guidati e di riferimenti incrociati, che si integrano con il rimando ad altri atti e provvedimenti disponibili nel sito reteambiente.it. In collaborazione con i Consorzi nazionali per il riciclo: Conai (con Comieco, Corepla, Coreve, Cial, Cna, Rilegno), Cobat, Coou, Conoe, Ecopneus e i Consorzi Raee (Ecodom, Ecolight, Remedia). Via N. Battaglia 10 20127 Milano tel. 02. 45487277 fax 02. 45487333 pagine 1840, euro 65,00 PREZZO SPECIALE: EURO 50,00 ANZICHÉ EURO 65,00 OFFERTA VALIDA FINO AL 31-7-2010 Tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02.45487333 Sì, desidero acquistare in contrassegno il volume il Codice dei Rifiuti 2010 a euro 50,00 + 3,00 (spedizione) nome e cognome ragione sociale via n. città prov. tel. fax p.iva/c.f. e-mail data cap firma Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999. www. edizioniambiente.it e-mail [email protected] 1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003. 2) Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra: [ ] autorizzo [ ] non autorizzo l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative della Casa Editrice. Firma.............................................................................................. R Link di approfondimento P. Fimiani “Sistri per registri e formulari, cambia la forma e non la sostanza. Vigono le sanzioni del “codice ambientale” e si conferma il sistema delle responsabilità” in Rivista Rifiuti, n. 171 G. Taddia “Funzioni e responsabilità del delegato nel sistema Sistri” in Rivista Rifiuti, n. 172 Il quadro delle norme in tema di Sistri costantemente aggiornato: “Speciale Sistri” (Reteambiente.it) Seminario di formazione sui rifiuti: “Rifiuti e Sistri: come operare” (Roma, venerdì 21 maggio 2010 – Milano, lunedì 10 maggio 2010) Rubriche Finestra Sistri DM SISTRI: IL TESTO VIGENTE Facendoci interpreti del bisogno di certezze che ci comunicano i nostri Lettori, pubblichiamo nuovamente il testo del Dm 17 dicembre 2009, cd. “Dm Sistri”, coordinato con le modifiche apportate dal Dm 15 febbraio 2010, e corredato da note. Decreto 17 dicembre 2009 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 36 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” e, in particolare, l’articolo 14-bis; Considerata la necessità di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità di attivazione nonché la data di ope- ratività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonché le modalità di elaborazione dei dati stessi; Considerata la necessità di definire le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo; Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio; Considerata la necessità di definire le modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli altri sistemi informativi; Articolo 1 Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri 1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche Sistri, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente, è operativo: a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legi- slativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del presente decreto; b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesim o decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il Sistri. 3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all’articolo 3. 4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al sistema Sistri a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b). 5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dai predetti impianti. L’installazione, la manutenzione e l’accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri (1). (So n. 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n. 9) Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decretolegge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Adotta il seguente decreto: (1) Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 2, Dm 15 febbraio 2010. iscriversi al sistema Sistri entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell’atto di cessione dell’azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli allegati IA e IB. 9. In caso di variazione dei dati identificativi dell’impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all’utilizzo del dispositivo Usb provvedono, successivamente all’iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all’apposita area del portale del sistema Sistri. 10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall’impresa al Sistri, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell’allegato IA. 11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprietà del Sistri e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d’uso. (1) Termini d’iscrizione prorogati di trenta giorni dall’articolo 1, Dm 15 febbraio 2010. (2) Si veda l’articolo 3 del Dm 15 febbraio 2010: “Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti. 1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al Sistri anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro i termini previsti dall’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) di detto decreto, come prorogati dall’articolo 1 del presente decreto.”. (3) Periodo così sostituito dal Dm 15 febbraio 2010. Il testo precedente era: “Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”. (4) Si veda l’articolo 4 del Dm 15 febbraio 2010: “Attività di raccolta e trasporto di rifiuti. 1. Le imprese di cui all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo Usb relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 6, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo Usb per ciascuna unità locale, fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all’iscrizione al Sistri, qualora intendano usufruire della facoltà di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.”. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Articolo 3 Modalità di iscrizione al Sistri 1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2, aderiscono al Sistri iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (1) (2). 2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle rispettive attività. 3. Le modalità di iscrizione al Sistri sono descritte nell’allegato IA. 4. Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (3). Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212. 6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati: a) un dispositivo elettronico per l’accesso in sicu- rezza dalla propria postazione al sistema informatico, d’ora in avanti definito dispositivo Usb, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo Usb relativo alla sede legale dell’impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti (4). Ciascun dispositivo Usb può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per ciascun dispositivo Usb, l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (Pin) e il codice di sblocco personale (Puk); c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. È necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all’impresa. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo Usb e disponibile sul portale del sistema Sistri. I costi di installazione e per l’acquisto della necessaria carta Sim sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell’allegato IB. 7. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema Sistri il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo Usb ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all’installazione. 8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda avente ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda dovrà Rubriche Finestra Sistri Articolo 2 Rifiuti urbani della Regione Campania 1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione. 2. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (Sitra) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo. 37 Rubriche Finestra Sistri RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 38 Articolo 4 Contributo di iscrizione al Sistri 1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale. 2. Il contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti. 3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l’iscrizione di cui all’articolo 3, comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell’anno al quale i contributi si riferiscono. L’importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell’allegato II. I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Articolo 5 Informazioni da fornire al Sistri 1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al Sistri è riportata nelle schede di cui all’allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema Sistri (www.sistri.it). 2. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica. 3. I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Produttori le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi. 4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Intermediari le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione stessa. 6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda Sistri – Area movimentazione. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico (1). 7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico (2). 7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda Sistri – Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso (3). 8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri – Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato “pdf “ (portable document format) alla Scheda Sistri – Area movimentazione. 9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato “pdf” il documento di movimento di cui al regolamento Ce n° 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall’impianto di destinazi10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema Sistri anche i seguenti soggetti: a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impre- sa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. 11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda Sistri – Area movimentazione, debitamente compilata. Il comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni. 13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda Sistri –Area movimentazione relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. 14. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell’impianto di recupero o smaltimento. (1) Periodo così sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del Dm 15 febbraio 2010; il testo precedente era: “Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l’opreazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.”. (2) Periodo così sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del Dm 15 febbraio 2010; il testo precedente era: “Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i prorpi dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell’operazione di movuimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell’Area Registro Cronologico.”. (3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c) del Dm 15 febbraio 2010. Articolo 6 Particolari tipologie 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri – Area movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la (1) Si veda l’articolo 8, comma 1, Dm 15 febbraio 2010: “Ulteriori tipologie particolari. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di cui all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. (2) Si veda l’articolo 8, comma 2, Dm 15 febbraio 2010: “Ulteriori tipologie particolari. 1. Le dispo- sizioni di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di cui all’articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7 e 8 del Dm 17 dicembre 2009.”. Articolo 7 Modalità operative semplificate 1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo l’iscrizione al Sistri ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale Sistri, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema Sistri per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede Sistri. La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema Sistri rimane a carico del soggetto delegante. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produt- RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema. 5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda Sistri – Area movimentazione contenente l’indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l’assolvimento della responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema Sistri e chiude la relativa scheda confermando l’arrivo a destinazione del rifiuto. 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri – Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti. 7. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dilla sede dell’unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell’impresa o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività manutentiva (2). 8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d’opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall’attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unità locale dell’impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda SistriArea movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione (2). Rubriche Finestra Sistri sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri – Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all’obbligo di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità (1). 3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 dello stesso decreto legislativo. 4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda Sistri si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema Sistri, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita scheda Sistri in bianco tenuta a disposizione, 39 Rubriche Finestra Sistri RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) 40 tore e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell’impresa di trasporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti. 3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema Sistri per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all’iscrizione al Sistri ai sensi dell’articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri – Area movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede. Nei casi di cui al presente comma, la responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Articolo 8 Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale gestori ambientali 1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa). 2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Ispra. 3. L’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l’interconnessione diretta tra i sistemi informativi. 4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell’Albo. Articolo 9 Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo 1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all’articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto. 2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province. Articolo 10 Catasto dei rifiuti 1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati: a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l’interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 8 del presente decreto; b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all’Ispra, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell’impresa autorizzata, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, le quantità auto- rizzate, la scadenza dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione stessa; c) una banca dati relativa alle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta; d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all’articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale. 2. L’Ispra elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifi Articolo 11 Comitato di vigilanza e controllo 1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente; b) uno da Ispra; c) uno da Unioncamere; d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti. Articolo 12 Disposizioni transitorie 1. Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer; b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza. 2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzio- ti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel- la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Allegato IA (*) Procedura di iscrizione al Sistri Rubriche Finestra Sistri nalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimen- Allegato IB (*) Procedura per l’installazione dei dispositivi black box Allegato II (*) Allegato III (*) (*) I testi degli Allegati, coordinati con le modifiche apportate dal Dm 15 febbraio 2010, sono disponibili su www.reteambiente.it, Speciali normativa, “Speciale Sistri”. DOMANDE E RISPOSTE TRATTE DAL SITO WWW.SISTRI.IT ISCRIZIONE E OPERATIVITÀ Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi Un’azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine), può ritenersi esonerata dall’obbligo di iscriversi al Sistri previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di “rifiuti pericolosi”? Se sì, deve smaltire i “rifiuti prodotti” prima della scadenza del termine di iscrizione al Sistri o è sufficiente che smaltisca prima dell’avvio dell’operatività del Sistri (sempre rispettando i limiti del “deposito temporaneo”)? L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del Sistri per il gruppo di riferimento. Iscrizione al Sistri nel caso di smaltimento di autoveicoli Un’azienda, non obbligata all’iscrizione al Sistri, che, una volta operativo il Sistri, avrà necessità di smaltire (radiare) un autoveicolo (rifiuto speciale pericoloso) dovrà preventivamente iscriversi al Sistri, pagare il contributo annuo e quindi cancellarsi per non continuare a pagare negli anni successivi? Esatto. L’azienda dovrà iscriversi al Sistri come produttore di rifiuti pericolosi e quindi cancellarsi se non prevede di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se però la proprietà del veicolo viene ceduta ad un concessionario, il quale provvederà successivamente alla radiazione e demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato, eventualmente nell’ambito di una compravendita di un veicolo nuovo, l’azienda che cede il veicolo non dovrà iscriversi al Sistri. Iscrizione di cantieri e possesso di tecnologie informatiche I 6 mesi sono per il cantiere nel suo complesso o sono per la singola ditta operante in cantiere? Se prevedo di stare 5 mesi e non mi iscrivo, poi sforo e sto più di 6 mesi (come spesso accade) come mi comporto? L’articolo 6, comma 6, Dm 17 dicembre 2009 (Particolari tipologie – cantieri) parla di “rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri.” In altre parole, un’azienda che opera per un tempo anche inferiore a 6 mesi in un cantiere dotato di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri dovrà provvedere ad iscrivere il cantiere come propria Unità locale. Nel caso in cui il cantiere originariamente previsto per un numero di mesi inferiori a 6 e non dotato di tecnologie adeguate, debba protrarre la propria operatività oltre i 6 mesi, allora le ditte operanti in quel cantiere dovranno iscrivere il cantiere come propria unità locale e dotarsi delle tecnologie adeguate per l’accesso al Sistri. RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il Dm 17 dicembre 2009 recante l’istituzione del Sistri. I problemi sul tappeto sono ancora moltissimi e mancano le linee guida gestionali che consentano un passaggio soft dalla tenuta delle scritture ambientali su carta alla loro informatizzazione. Ad oggi, si dispone solo delle Faq (Frequently asked questions) pubblicate sul sito “www.sistri.it” (oltre alle Linee Guida per l’iscrizione fornite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; pubblicate in rielaborazione grafica sul n. 170 di questa Rivista). Certamente, le Faq non assolvono alla funzione di una circolare né di una guida gestionale e non sono vincolanti per nessuno. Per giunta, alcune delle risposte fornite, sotto il profilo del merito, non sono condivisibili. Al pari di una serie di cose contenute nel Dm 17 dicembre 2009 che ci si augura possano essere oggetto di riflessione e di più meditata stesura. Tuttavia, le Faq costituiscono l’unico materiale di fonte ufficiale oggi esistente (oltre alle citate Linee Guida per l’iscrizione); pertanto, in questo momento di grande incertezza operativa, e in pieno spirito collaborativo, si ritiene utile pubblicarle affinché la Pa e le imprese possano costituirsi un repertorio ordinato e facilmente consultabile. La nuova Rubrica “Finestra Sistri”, mese dopo mese, riporterà documentazioni aggiornate e una serie di considerazioni in ordine al nuovo sistema. 41 Rubriche Finestra Sistri Rifiuti prodotti da cantieri Una ditta iscritta al trasporto c/ proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all’iscrizione al sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione? RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 173 (05/10) Sono soggette ad iscrizione al Sistri le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b)) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l’impresa non è tenuta all’iscrizione al Sistri come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati. Classificazione delle bombolette spray (contenitori a pressione vuoti) Il Codice Cer 150111 riguarda solo contenitori a pressione vuoti che abbiano “ospitato” delle “matrici solide porose pericolose” oppure concerne tutti i contenitori a pressione vuoti, a prescindere dal contenuto delle suddette matrici pericolose? 15 01 11* [Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti] Premesso che la domanda non riguarda il Sistri, ma la classificazione dei rifiuti in generale, va ricordato che Il Codice Cer 150111 riguarda tutti i contenitori a pressione vuoti. Qualora ci fossero gas residui, si potrebbero utilizzare anche i codici relativi alla subcategoria 16.06. Impianti mobili di recupero/smaltimento I gestori di impianti mobili di recupero/smaltimento di cui all’articolo 208, comma 15, Dlgs 42 152/2006 per i quali ad oggi non è possibile l’iscrizione all’Albo e per i quali ad oggi non c’è l’obbligo di Mud (almeno per le attività di recupero) (era previsto nel nuovo Mud): devono iscriversi, come ed in che tempi? Gli impianti mobili sono a tutti gli effetti impianti di gestione dei rifiuti e quindi sono soggetti all’iscrizione al Sistri. I gestori degli impianti mobili iscrivono l’impianto mobile prima dell’inizio della campagna di trattamento come unità locale, riportando come indirizzo quello del sito prescelto per la campagna di attività. Successivamente al termine dell’attività, il gestore dell’impianto mobile provvederà alla cancellazione dell’unità locale dal Sistri, avvalendosi di quanto previsto all’articolo 3, comma 7. Rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica Per le altre categorie di iscrizione all’Albo (es. bonifica siti contaminati categoria 9, bonifica beni contenenti amianto categoria 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si iscrivano anche per l’attività di gestione dei rifiuti che conducono? Poiché il Sistri non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali soggetti dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente nell’ambito delle attività di bonifica. In altre parole, se nell’ambito di un’attività di bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o recuperatori/ smaltitori, dovranno iscriversi al Sistri come tali. Se nell’ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente come operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing per la bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei terreni contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al proprietario del sito contaminato, allora sarà quest’ultimo che dovrà iscriversi come produttore. SOGGETTI DESTINATARI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE Modalità operative semplificate e possesso delle tecnologie informatiche I soggetti iscritti al Sistri che, pur avendone facoltà (articolo 7, comma 1), non delegheranno le Associazioni, dovranno disporre permanentemente, nell’unità locale, di tecnologie adeguate (pc, stampante, collegamento internet) o sarà sufficiente il possesso del dispositivo Usb? Il Dlgs 152/2006 prevede all’articolo 190, comma 3, che i registri di carico e scarico siano “tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari”. Nel caso in cui i soggetti iscritti al Sistri, pur avendone la facoltà, decidano di non delegare le associazioni, dovranno essere loro stessi a garantire la presenza del registro cronologico (che nel Sistri sostituisce il registro di carico scarico) nelle loro sedi. Questo potrà essere fatto o rendendo disponibile presso la sede una stampa aggiornata del registro, oppure garantendo la disponibilità presso la sede di tecnologie adeguate (pc, stampante, collegamento internet) che consentano la visualizzazione e la stampa dei registri. In sintesi, il solo possesso del dispositivo Usb non è sufficiente. ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI Iscrizione delle associazioni imprenditoriali Entro quando devono iscriversi al Sistri per la specifica categoria le associazioni o loro società di servizi che intendono gestire il Sistri per i propri soggetti deleganti? In base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1 (Modalità operative semplificate), i soggetti che intendono delegare le associazioni “dopo l’iscrizione al Sistri ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte.” Ciò vuol dire che le associazioni potranno ricevere la delega dai soggetti in un qualsiasi momento successivo all’iscrizione al Sistri dei soggetti deleganti. Il Dm 17 dicembre 2009 non stabilisce una data specifica per l’iscrizione delle associazioni. Tuttavia, in base all’allegato 1A al Dm 17 dicembre 2009, “ciascuna articolazione territoriale dell’associazione imprenditoriale, o società di servizi che abbia ricevuto delega ai sensi dell’articolo 7, comma 1, richiede un dispositivo Usb”. L’iscrizione delle associazioni è quindi finalizzata all’ottenimento di una Usb con cui gestire i registri dei soggetti deleganti. Tale iscrizione dovrà quindi avvenire dopo aver ricevuto la delega da parte del primo soggetto delegante. RIFIUTI bollettino di informazione normativa RIFIUTI bollettino di informazione normativa testata mensile (11 numeri) disponibile per abbonamento nelle seguenti formule: abbonamento annuo alla rivista stampata con spedizione in abbonamento postale euro 130,00. La rivista può oggi essere ordinata anche con spedizione in Posta prioritaria, con un contributo spese di euro 23,00 annue. Numeri arretrati euro 14,00; numeri doppi e speciali euro 22,00. abbonamento annuo a “Rifiuti on-line” nel sito www.reteambiente.it, con accesso tramite password euro 130,00 + iva euro 26,00. Indispensabile per gli operatori che hanno l’esigenza di avere a disposizione la rivista in tempo reale, cioè al momento della chiusura in redazione, entro i primi giorni di ogni mese. Il servizio dà diritto a scaricare gratuitamente qualunque numero arretrato della rivista. abbonamento abbinato rivista stampata e “Rifiuti on-line” euro 105,00 abbonamento base, più servizio telematico al prezzo di euro 105,00 + 21,00 (iva). Ideale per chi ha l’esigenza di avere a disposizione immediatamente le notizie più recenti e desidera comunque conservare le annate complete della rivista stampata. Edizioni Ambiente via N. Battaglia 10, 20127 Milano tel. 02 45487277 fax 02 45487333 sito internet www.reteambiente.it e-mail [email protected] offerta valida fino al 31/12/2010 173 Tagliando di abbonamento a RIFIUTI bollettino di informazione normativa da spedire via fax a Edizioni Ambiente 02 45487333 l’abbonamento è effettivo dal ricevimento del presente modulo compilato e sottoscritto per accettazione q Sì, desidero abbonarmi a RIFIUTI bollettino di informazione normativa nella formula: q Rivista stampata, spedizione in abbonamento postale (euro 130,00) q Rivista stampata, spedizione in posta prioritaria (euro 153,00) q Rifiuti on-line (euro 130,00 + iva euro 26,00 = euro 156,00) q Abbinata rivista stampata e Rifiuti on-line (euro 105,00 + euro 105,00 + iva euro 21,00 = euro 231,00) Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite: b versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente srl di cui allego fotocopia b bonifico Banca Popolare di Lodi (IBAN IT94K0516401626000000031450) di cui allego fotocopia b carta di credito: b CartaSì b Visa b Mastercard Numero Carta Nome Cognome Ragione sociale Cod.Fisc./ P.Iva Via n. Città Prov. e-mail Data sito internet Firma tel. CAP CV2 Scadenza 1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003. 2) Consenso al trattamento dei dati. Letta l’informativa di cui sopra: [ ] autorizzo [ ] non autorizzo l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali e iniziative della Casa Editrice. Firma ...........................................................................
Scarica