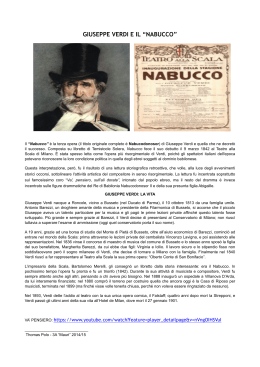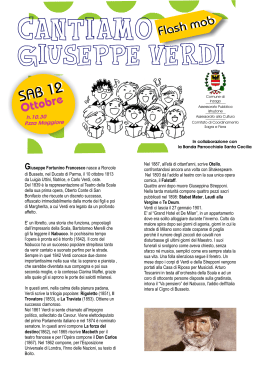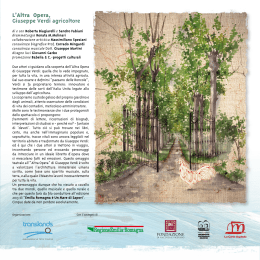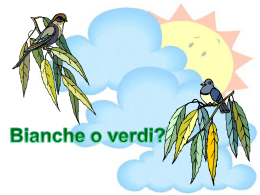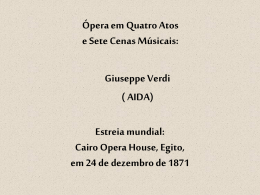anno XIX - numero 56 - 16 luglio 2013 Riflessioni sull’opera Parlano il maestro Riccardo Muti ed il regista-scenografo J.-P. Scarpitta A Pag. 2 La Storia dell’Opera Il successo dopo le delusioni delle prime due opere A Pag. 6 L’Analisi musicale Primo lavoro ben strutturato del giovane ed irruento Verdi A Pag. 7 Il vero Nabucodonosor Il conquistatore di Gerusalemme che riedificò la torre di Babele A Pag. 8 e 9 Giuseppina Strepponi La chiacchierata prima Abigaille, poi seconda moglie di Verdi A Pag. 14 nabucodonosor di Giuseppe Verdi nabucodonosor 2 Il Giornale dei Grandi Eventi Questo Nabucco nelle riflessioni di Muti e del regista Jean-Paul Scarpitta Un’opera simbolo di libertà universale, ma che non può essere inno nazionale U na cosa è certa: il Nabucco per Riccardo Muti è l’opera della vita, l’opera che segnò il suo esordio nella sua travagliata esperienza a La Scala, quando la diresse il 7 dicembre 1986, al suo primo Sant’Ambrogio scaligero, con Bruson ottimo protagonista, per la tradizionale apertura della stagione. Una serata in cui l’allora 45enne direttore di Molfetta, in quel tempio della musica in cui famosa divenne la regola «Toscanini non ripete», decise a sorpresa di concedere il bis proprio del “Va’ pensiero”. Ma già precedentemente Muti vantava una lunga frequentazione con questa partitura. La prima volta risale al Maggio Musicale Fiorentino del 1977: uno spettacolo pregevole con la regia metastorica di Luca Ronconi, le scene e costumi di Pier Luigi Pizzi e le presenze importanti di Sigmund Nimsgern e di Cristina Deutekom. Nello stesso anno l’incisione per l’etichetta Emi, caratterizzata da un incedere drammatico inesorabile, con la Philarmonia Orchestra e le voci di Matteo Manuguerra, Renata Scotto, Nicolaj Ghiaurov e Elena Obraztsova. Con Nabucco, il giovane Verdi compone un’opera in grado di coinvolgere il sentimento popolare, capace di trascendere i propri limiti per divenire poi simbolo dello spirito risorgimentale. Al di là dei caratteri specifici d' una partitura indubbiamente acerba e caratterizzata da un’estrema economia di mezzi ma comunque sempre attenta ai valori del dramma, Muti nota «una musica concisa, travolgente, poetica», vera incarnazione dell’anima italiana. Così ora Muti, nell’ambito dei suoi tre titoli l’anno da contratto con l’Opera dio Roma, in quest’anno verdiano dopo Simon Boccanegra e I due Foscari, al Costanzi ripropone questo titolo con lo stesso allestimento ideato da JeanPaul Scarpitta per la stagione del 2011, la stagione del 150° dell’Unità d’Italia. Otto serate allora, tra le quali quella – tutta ad inviti - del 17 marzo (terza replica) nel giorno dell’anniversario della trasformazione del Regno di Sardegna in Regno d’Italia ed alla quale partecipò tutto il Gotha dell’economia, della politica e della finanza italiana e che in sala, oltre al Presidente della Repubblica Napolitano, vide la presenza, proprio di fronte al sipario sormontato dallo stemma sabaudo, del principe Vittorio Emanuele e della principessa Marina di Savoia, mentre dall’alto, al “Va’ pensiero” cantato da tutta la sala, scendevano a pioggia riproduzioni del Tricolore reale del 1861. Ma proprio quel “Va’ pensiero”, così semplice, così popolare, divenuto – forse anche un poco a sproposito tanto evocativo del nostro Risorgimento, lo stesso Muti ha più volte detto che non può divenire l’Inno nazionale d’Italia. «Mi sono sempre espresso contro questa Il G iornale dei G randi Eventi Direttore responsabile Andrea Marini Direzione Redazione ed Amministrazione Via Courmayeur, 79 - 00135 Roma e-mail: [email protected] Editore A. M. Stampa Tipografica Renzo Palozzi Via Vecchia di Grottaferrata, 4 - 00047 Marino (Roma) Registrazione al Tribunale di Roma n. 277 del 31-5-1995 © Tutto il contenuto del Giornale è coperto da diritto d’autore Visitate il nostro sito internet www.ilgiornalegrandieventi.it dove potrete leggere e scaricare i numeri del giornale idea… Verdi nella partitura scrive che il tempo deve essere lento, greve, con il canto quasi sussurrato, mentre un inno dovrebbe essere trascinante, forte, trionfale. Questo è invece il canto di dolore di un popolo oppresso, contestato subito dopo, nello stesso libretto, dal Gran Sacerdote Zaccaria, il quale, invece, di slancio sprona il suo popolo alla riscossa. Come potrebbe dunque rappresentare l’orgoglio di una Nazione?». Poi Muti col suo humour meridionale chiosa: «E’ un brano che dura quasi cinque minuti, dove il clou arriva tardi.. v’immaginate i calciatori della nazionale immobili fin’anche alle parole “o mia Patria si bella e perduta”… con che spirito entrerebbero in campo… sicuramente si perderebbe la partita!!!». «Siamo, comunque, di fronte ad un vero monumento nazionale – dice il Maestro, che della difesa della cultura del nostro Paese di è voluto fare portavoce e paladino -, in cui ritroviamo tutto lo spirito e l’irruenza giovanile di Verdi, velata però di malinconia, forse dovuta oltre al carattere del testo anche a quegli insuccessi (Oberto e Un giorno di regno, n.d.r.) che avevano preceduto quest’opera». Su quest’allestimento, il regista Jean-Paul Scarpitta intende la messa in scena come «una riflessione sulla storia più che una rappresentazione». L’idea portante è quella di un minimalismo che riduca al massimo gli elementi scenici, privando gli accessori di qualsiasi valenza decorativa, «permettendo una vera drammaturgia». L’ambientazione storica è suggerita da pochi essenziali elementi, una piramide, una sola porta del palazzo, qualche albero davanti a un muro d’oro e rovine che emergono dalle nuvole. Tutto concepito per «comprendere e far comprendere - sottolinea il regista - senza ottenebrare lo sguardo dello spettatore cercando di imporgli idee preconcette». Importante è poi il discorso sull’attualità del teatro verdiano. Nelle parole di Scarpitta, «il genio di Verdi ci rimanda al nostro tempo, ai nostri drammi, e li chiarisce, perché oggi più che mai, il nostro destino è la politica». La conclusione della vicenda introduce una nota di speranza, una nuova nascita, «l’apparizione di una bella e giovane donna di oggi che culla fra le braccia un bam- bino, in mezzo a giovani uomini d’oggi, cuori puri appassionati di libertà. Questo messaggio - conclude Scarpitta - dovrebbe risuonare nel cuore degli uomini che vedono un’Europa che stenta a costruirsi, mentre le dittature faticano a disfarsi, a scomparire». andrea Marini stagione 2013 del Teatro dell’opera di roma stagione Estiva alle Terme di caracalla 2 e 7 agosto TErra E cIElo di Nino Rota Micha van Hoeche Gaetano D’Espinosa Coreografia Direttore cavallErIa rusTIcana di Pietro Mascagni 1 - 6 agosto Tosca di Giacomo Puccini Renato Palumbo Direttore 23 - 31 ottobre TurandoT di Giacomo Puccini Pinchas Steinberg Direttore ~~ La Locandina ~ ~ Teatro Costanzi, 16 - 23 luglio nabucodonosor Dramma lirico in quattro atti Libretto di Temistocle Solera dal dramma Nabucodonosor di Anicète Bourgeois e Francis Cornue (1836) Prima rappresentazione: Milano, Teatro Alla Scala 9.3.1842 (Terza opera teatrale di G. Verdi) Musica di Giuseppe Verdi Direttore Regia e Scene Maestro del Coro Costumi Luci Riccardo Muti Jean-Paul Scarpitta Roberto Gabbiani Maurizio Millenotti Anne-Claire Simar Personaggi / Interpreti Nabucodonosor (Bar) Luca Salsi Ismaele (T) Francesco Meli Zaccaria (B) Riccardo Zanellato Abigaille (S) Tatiana Serjan Fenena (Ms) Sonia Ganassi / Anna Malavasi (20, 23) Il Gran Sacerdote di Belo (B) Luca Dall’Amico Abdallo (T) Saverio Fiore Anna (S) Simge Büyükedes ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DELL’OPERA Allestimento del Teatro dell’Opera del 2011 ~ ~ La Copertina ~ ~ La Torre di Babele (1563), di Pieter Bruegel il Vecchio (1525 – 1569); Kunsthistorischer Museum – Vienna. Il nabucodonosor Giornale dei Grandi Eventi S olo quattro spettacoli in Teatro, in questo metà luglio che sta divenendo sempre più caldo, per il Nabucco di Verdi, nella stessa edizione ideata da Jean-Paul Scarpitta - e sempre diretta da Muti - per la stagione 2011, quella del 150° dell’Unità d’Italia. Quattro spettacoli, in contemporanea con la Stagione dell’Opera a Caracalla, che rappresentano il terzo impegno stagionale di Muti con l’Opera di Roma, per onorare il contratto che prevede, infatti, da parte del maestro di Molfetta la direzione di tre titoli d’opera l’anno. Così dopo Simon Boccanegra (apertura di Stagione in novembre) ed I Due Foscari di marzo, ecco questo Nabucco, titolo da Muti molto praticato. Una ripresa che, insieme alla recita in forma di concerto di Sabato 13 luglio scorso al Pala De Andrè di Ravenna, nell’ambito del Ravenna Festival (la cui direttrice artistica è la moglie di Muti, Cristina) serve da rodaggio alla tournée dell’orchestra dell’Opera al Festival di Sali- sburgo, dove questo allestimento sarà proposto per tre recite il 28 e 31 agosto e 1° settembre con un cast leggermente migliorato nelle principali voci maschili. Intanto, la stagione 2013/2014 si dovrebbe aprire a novembre prossimo, a conclusione di questo anno del Bicentenario verdiano, con l’Ernani, 3 Le Repliche Giovedì 18 luglio, h. 20.30 Sabato 20 luglio, h. 20.30 Martedì 23 luglio, h. 20.30 quinta opera di Verdi, andata in scena per la prima volta a Venezia nel marzo del 1844, due anni dopo il Nabucco. La direzione sarà sempre di Riccardo Muti. Un Nabucco per Muti in vista di Salisburgo Nella prima parte la vicenda è ambientata a Gerusalemme, nelle altre tre a Babilonia, intorno al 587 a.C.. La Trama ParTE I – (Gerusalemme) – Radunati nel tempio di Salomone ebrei e leviti piangono la sorte del popolo d’Israele sconfitto da Nabucco (contrazione del nome Nabucodonosor) Re d’Assiria, che alla testa del suo esercito sta per entrare in città. Il Gran Sacerdote Zaccaria rincuora i fedeli. Israele ha in ostaggio Fenena, figlia di Nabucco che viene consegnata in custodia ad Ismaele, nipote del Re di Gerusalemme Sedecia. I due giovani sono però innamorati e progettano una fuga comune. Lui le ricorda quando da ambasciatore andò a Babilonia e, imprigionato, fu salvato proprio da lei sia dalla prigione che dall’amore furente della di lei sorella Abigaille. Così mentre Ismaele sta per aprire una porta segreta entra Abigaille, schiava creduta figlia primogenita di Nabucco, seguita da alcuni guerrieri babilonesi travestiti da ebrei. Abigaille, ancora innamorata, impedisce la fuga e, gridando vendetta, accusa Ismaele di tradire la patria per una donna babilonese. Confessando di averlo amato e di avergli offerto il regno di Babilonia, la donna si dichiara pronta a salvarlo se tornerà da lei. Gli ebrei sono in preghiera quando avanza Abigaille inneggiando a Nabucco con i guerrieri che entrano nel tempio. Giunge anche Nabucco il quale viene affrontato da Zaccaria. Questo minaccia di uccidere Fenena se Nabucco osasse profanare il tempio. Mentre Zaccaria sta per vibrare il pugnale su Fenena, Ismaele gli blocca la mano e la ragazza fugge tra le braccia di Nabucco che annuncia vendetta ed ordina il saccheggio della città. ParTE II – (L’empio) – Tornata a Babilonia, Abigaille scopre, da una carta sottratta a Nabucco, di essere solo una schiava e non sua figlia. Questa condizione la rende furente contro Fenena, Nabucco ed il Regno e nei suoi propositi di vendetta e di acquisizione del potere si fa aiutare dal Gran Sacerdote di Belo. Intanto Fenena, che ha ricevuto pieni poteri dal pa- dre, libera gli ebrei e chiede a Zaccaria di essere convertita alla religione ebraica. Abigaille si appresta ad impadronirsi della corona di Fenena quando giunge Nabucco che afferra la corona e si proclama dio. A tali parole blasfeme sul suo capo cade un fulmine che allontana la corona, immediatamente raccolta da Abigaille che se la pone in testa. ParTE III – (La profezia) – Nella reggia di Babilonia Abigaille è sul trono. Entra Nabucco con le vesti lacere e la barba incolta. Dopo una discussione Abigaille lo convince a firmare l’ordine di morte per gli ebrei prigionieri. Nabucco è perplesso e firma, ma poi quando si rende conto che tra essi c’è anche la figlia Fenena vorrebbe tornare sui suoi passi. Abigaille non lo permette e Nabucco l’appella schiava e cerca il foglio attestante la nascita servile. Abigaille lo tira fuori dal seno e lo distrugge. Abigaille fa condurre in prigione Nabucco, il quale chiede almeno Fenena. Intanto sulle sponde dell’Eufrate gli ebrei invocano con nostalgia la loro patria. Giunge poi Zaccaria che profetizza la liberazione del suo popolo. Parte Iv – (L’idolo infranto) - Negli appartamenti della reggia Nabucco, ancora prigioniero ma ormai rinsavito, sente rumori di guerra ed affacciatosi alla finestra vede la figlia Fenena trascinata verso la morte. Colto da ispirazione chiede perdono al Dio e riacquista le forze. A liberarlo arrivano guerrieri rimasti fedeli. Nabucco prende la spada di Abballo e corre verso gli orti pensili dove il Sacerdote di Belo sta per giustiziare Fenena. Irrompe Nabucco che infrange l’idolo e libera i prigionieri, unendosi poi agli ebrei per esaltare la gloria di Dio e ringraziarlo della nuova libertà. Entra Abigaille, che nel frattempo ha bevuto del veleno. In fin di vita chiede perdono a Fenena benedicendo il suo amore per Ismaele. Muore invocando la pietà di Dio, mentre Zaccaria saluta Nabucco re dei re. Il Giornale dei Grandi Eventi nabucodonosor 5 Tatiana Serjan Luca Salsi Abigaille, schiava e non figlia di Re, innamorata di Ismaele Nabucodonosor, re degli Assiri A cantare nel ruolo della protagonista femminile Abigaille è il soprano Tatiana serjan. Nata a San Pietroburgo, dove ha cominciato gli studi musicali in pianoforte presso il Collegio Musicale e in seguito al Conservatorio. Si è perfezionata in Italia all’Accademia delle Voci di Torino con Franca Mattiucci. Nel 1994 ha debuttato all’Opera Studio di San Pietroburgo nella Traviata, dove successivamente ha cantato ne La bohéme e Così fan tutte; nel 1997 è stata diretta dal Maestro Mstilav Rostropovič con la San Pietroburgo Philarmonic Society. Nel 2001 È stata finalista in alcuni concorsi di canto internazionali. Il suo debutto in Italia è stato al Regio di Torino nel dicembre 2002 nel ruolo di Lady Macbeth. Ha debuttato Aida al Festival di Bregenz, I due Foscari a Parma e Modena. Ha partecipato al concerto finale del Festival di Ravenna. Sotto la guida di Muti, si è esibita nel Requiem di Verdi a Londra ed a Tolosa con la Philarmonia Orchestra. All’Opera di Roma è stata ne La battaglia di Legnano e nel Macbeth del novembre 2011 andato poi al Festival di Salisburgo (2012). Sempre al Costanzi l’abbiamo sentita lo scorso anno in maggio in Attila (Odabella) e quindi quattro mesi fa, a marzo, nel ruolo di Lucrezia Contarini ne I Due Foscari. Riccardo Zanellato Zaccaria, Grande Sacerdote dalla voce possente I l basso riccardo Zanellato, Gran Sacerdote Zaccaria in questo cast, dopo essersi aggiudicato il premio Operalia nel 1996, ha debuttato con Dom Sébastien di Donizetti al Comunale di Bologna ed al Donizetti di Bergamo, riscuotendo il plauso di pubblico e critica. Da li ha iniziato ad affermarsi come uno degli artisti di nuova generazione per i ruoli di basso verdiani. Ha poi preso parte a La vedova scaltra, Assassinio nella cattedrale, Le nozze di Figaro ed Ifigenia. Importante la collaborazione con Muti che lo ha scelto per le produzioni romane di Iphigenié en Aulide, Nabucco e Moïse et Pharaon. Regolare ospite del Festival Verdi ed al Regio di Parma, ha interpretato Nabucco, La forza del destino con la direzione di Gelmetti. Nel 2011 ha debuttato al Rossini Opera Festival nel Mosè in Egitto, mentre nel luglio 2012 in Norma a Caracalla. All’Opera di Roma nel novembre 2011 è stato Banco, generale del re Duncano, nel Macbeth diretto da Muti che ha aperto la stagione come nel novembre 2012 secondo cast di Jacopo Fiesco nel Simon Boccanegra sempre con Muti. Francesco Meli Ismaele, nipote del Re di Gerusalemme e traditore per amore E ’ Francesco Meli a cantare come Ismaele, ruolo da tenore che in quest’opera è da comprimario. Nato a Genova nel 1980, ha iniziato gli studi di canto a diciassette anni e nel 2002 ha debuttato con Macbeth di Verdi. Nello stesso anno ha cantato come solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini e nella Messa di gloria di Puccini, trasmessa dalla RAI durante il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Meli ha calcato con successo i più importanti palcoscenici italiani ed europei. Nel 2005 ha inaugurato le stagioni del Teatro alla Scala con Idomeneo di Mozart, del Carlo Felice con Don Giovanni di Mozart, del Rossini Opera Festival in una nuova produzione di Bianca e Falliero. Inol- A l baritono luca salsi è affidato il ruolo di Nabucodonosor. Nato a San Secondo Parmense (PR) nel 1975 si è diplomato in canto presso il conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, e si è perfezionato con il baritono Carlo Meliciani. Nel 1997 ha debuttato presso il Teatro Comunale di Bologna nella (Scala di Seta di Rossini). Nel 2000 ha vinto il premio assoluto al concorso “Gian Battista Viotti” di Vercelli; ha iniziato così un’intensa attività che lo ha condotto sui palcoscenici di tutto il mondo. Nella stagione 2008/09 ha preso parte a diverse produzioni tra cui Il Corsaro al Festival Verdi di Parma, La Bohème, al Carlo Felice di Genova, I Pagliacci, al teatro lirico di Cagliari ha continuato poi con la stagione 2009/10 interpretando con grande successo la Traviata, Falstaff, L’Elisir d’Amore, Ernani e Lucia di Lammermoor. Nel 2012 consensi ne L’Elisir d’amore (bilbao), Rigoletto (Trieste) e Don Carlo ne La Forza del destino (Buenos Aires). In questo ruolo ha inaugurato a Barcellona la stagione attuale. Tra i suoi prossimi impegni: I Puritani, al Teatro Lirico di Cagliari, Attila, al Teatro Reggio di Parma, Un ballo in maschera, alla Washington Opera, e la Madama Butterfly, al Maggio Musicale Fiorentino ed al Metropolitan di New York. Nel marzo scorso all’Opera di Roma ha cantato nel ruolo del Doge Foscari ne I Due Foscari. Sonia Ganassi / Anna Malavasi Fenena, figlia di Nabucco ed innamorata di Ismaele A cantare nel ruolo di Fenena saranno i mezzosoprani sonia Ganassi (16 e 18 /7) anna Malavasi (20 e 23 /7). sonia Ganassi, è nata a Reggio Emilia nel 1966, ha collaborato con direttori quali Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Myung-Wung Chung, Daniele Gatti. A seguito dei suoi numerosi successi, nel 1999 i critici musicali italiani le assegnano il Premio Abbiati. Molti i ruoli interpretati, diversi dei quali incisi in CD o DVD. All’impegno operistico alterna un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose sale da concerto. Nella stagione 2008/09 ha cantato Norma all’Accademia di Santa Cecilia, I Capuleti e Montecchi a Genova, Anna Bolena a Lione e a Parigi, La Damnation de Faust a Napoli, Maria Stuarda a Venezia, La Favorite a Siviglia. Nel settembre 2010 ha cantato nel Roberto Devereux di Gaetano Donizetti all’Opera di Roma e nel dicembre 2010 è stata per 5 delle 6 recite Sinaïde nel Moïse et Pharaon di Rossini, diretto da Muti per l’inaugurazione della stagione 2010. anna Malavasi, mantovana, si diploma nel 2003 in canto e pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro con il massimo dei voti e lode, anno in cui vinse il Concorso Internazionale di Musica Sacra di Roma. Dopo aver interpretato ruoli sopranili, nel 2008 si sposta verso un repertorio mezzosopranile. Nello stesso anno vinse la trasmissione Serata d’onore su RaiUno dedicata all’opera. Diretta da Muti ha cantato la Missa Defunctorum di Paisiello al Festival di Salisburgo 2009. Tra le altre opere, alla Fenice di Venezia Manon Lescaut (Musico) e Rigoletto (Maddalena). E’ stata Azucena ne Il trovatore a Ravenna con la regia di Cristina Mazzavillani Muti. Ancora con Muti ha cantato come Fenena (primo cast) nel Nabucco del 2011 al all’Opera di Roma e Macbeth al Festival di Salisburgo, nonché “I Concerti della via dell’amicizia”. Ha poi preso parte al Concerto dedicato a Verdi il 21 marzo scorso all’Opera di Roma. tre è stato interprete di recital solistici a Londra, Tokyo, Oslo, Poznan e del Requiem di Verdi sotto la direzione di Gatti, Maazel, Noseda e Temirkanov. Torna ora a cantare all’Opera di Roma sotto la bacchetta di Muti dopo essere stato nel novembre 2012 Gabriele Adorno in Simon Boccanegra e quindi nel marzo scorso il figlio del Doge Jacopo Foscari ne I Due Foscari, sempre di Verdi. Il giornale va in stampa senza le foto degli interpreti, poiché a meno di 24 ore dalla “Prima” ancora non ci sono state fornite dall’ufficio stampa del Teatro. ce ne scusiamo con i lettori. Pagina a cura di Tina Alfieri 6 nabucodonosor Il Giornale dei Grandi Eventi La storia dell’opera Nabucodonosor, la gloria dopo la sventura «C vinse a seguirlo a Teatro. on quest’opera Tanto fece l’impresario, si può dire verache Verdi, ritroso e deciso mente che ebbe a snettere con la musica, principio la mia carriera arsi ritrovò a casa (viveva a tistica». Verdi si accorse Milano ormai dal 1839) subito che Nabucco era con il libretto di Nabucco, nato sotto una stella favoscritto da Temistocle Sorevole ed anche dopo rilera sulla base di passi biconobbe che il suo destiblici e del dramma Nabuno di operista dipese in chodonosor di Aguste Anigran parte da quel giovacèt-Bourgeois e Francis nile successo. Curioso, viCornu (andato in scena a sti i preamboli, non certo Parigi nel 1836), libretto incoraggianti: il composiappena rifiutato dal giotore, nel pieno di un terribile lutto familiare la morte improvvisa dei due figlioletti e poco dopo quella dell’amatissima moglie Margherita Barezzi - e profondamente amareggiato dal fiasco della sua opera buffa Un giorno di regno, andata in scena alla Scala il 5 settembre del 1840, era infatti più che mai deciso ad abbandonare la composizione. Aveva allora 27 anni. «Mi persuasi che dall’arte avrei invano aspettato consolazioni e decisi di non Giuseppina Stepponi con lo spartito del Nabucodonosor comporre mai più». vane musicista prussiano Tutto questo nonostante Otto Nicolai. Si dice che il suo Oberto, conte di San Verdi aprendo il testo a Bonifacio gli avesse invece caso, rimase folgorato da regalato soddisfazioni, quel verso Va, pensiero, dopo la buona accogliensull’ali dorate che ancora za, sempre alla Scala, pooggi è l’identificativo di co meno di un anno priquest’opera. Insomma, ma, il 17 novembre del una sorta di ”forza del ‘39. destino” che avrebbe guiLe circostanze che portadato Verdi nella composirono al mutamento d’anizione d’un lavoro così demo sul comporre, sono cisivo per la sua carriera. parzialmente aneddottiche. Grande parte ebbe decisiva fu la stepponi Bartolomeo Merelli – impresario della Scala ed tra In realtà decisivo fu l’ini grandi impresari italiani tervento presso Merelli di dell’Ottocento, insieme a Giuseppina Stepponi, Barbaja, Jacovacci e Lanadapprima compagna di ri - da cui dipendevano le Verdi dopo la morte nel sorti del teatro musicale a 1840 della prima moglie Milano, il quale intuì suMargherita Barezzi e bito le doti del giovane quindi sposata dopo 13 bussetano. Il farcito racanni di convivenza nel conto autobiografico, det1859. Quando s’incontratato da Verdi all’editore rono lei, Clelia Maria JoGiulio Ricordi una quasepha Stepponi, era molrantina d’anni dopo, rito più nota di Verdi come porta che il compositore, soprano di successo ed in una fredda serata inaveva alle spalle vita vernale, incontrò per caso chiacchierata e tre figli ilil Merelli, il quale lo con- relli avrebbe preferito legittimi di cui uno – che nella programmazione morirà a 25 anni di colera successiva. Naturalmente – con l’impresario Merelciò scatenò le ire del busli. E proprio con due suoi setano, «giovane e dal sanex amanti Merelli e Mogue bollente», deciso più riani, Giuseppina si adche mai a vedere Nabucco doperò nel 1839 perché sull’imminente cartellovenisse rappresentato a ne, che con una «letteracLa Scala la prima opera di cia» sfogò sull’impresario Verdi, Oberto, conte di tutto il proprio risentiSan Bonifacio. Intercessiomento. Fu allora che Mene ripetuta due anni più relli, che troppo conoscetardi proprio con il Nava il mestiere per tagliare bucco. con l’irruente maestro, gli Fioriture a parte, sappiamo che Nabucco cominciò gradualmente a prendere forma, tra momenti di incupimento e rinnovata ebbrezza, con l’assidua collaborazione del librettista e amico Solera, con cui il confronto, se a tratti si manifestò assai burrascoso, nondimeno fu proficuo e costruttivo. Verdi racconta di aver chiesto a Solera di sostituire un duettino amoroso tra Fenena e Ismaele, che a lui non piaceva perché raffreddava l’azione, con una profezia da affidare al Bartolomeo Merelli personaggio di Zacfece sapere che aveva mocaria; richiesta accettata dificato il cartellone e che con riluttanza dal librettiNabucodonosor (titolo orista, che tuttavia promise ginale fino al settembre di scriverla nei giorni del 1844, quando il Teatro successivi. Ma Verdi, teS. Giacomo in Corfù lo acmendo di dover aspettare corcerà in Nabucco) sarebtroppo, sbottò, serrò be andato in scena. «Darel’uscio e si mise in tasca la mo questo Nabucco; bisochiave «Non sorti di qui se gna tener calcolo però che io non hai scritto la profezia: avrò spese gravissime per le eccoti la Bibbia, hai già le altre opere nuove: non potrò parole bell’e fatte». Rischiò fare apposta pel Nabucco né forse una reazione collescene né vestiario e dovrò rica da parte dell’amico, raffazzonare alla meglio ciò «..un pezzo d’uomo…», ma che si troverà di più adatto in un quarto d’ora dopo la magazzino». Scene che, inprofezia era scritta. Insieme ai riutilizzati costusomma, tra scambi e mi del precedente balletto scontri, Nabucco fu ultiNabucodorosor di Cortesi, mato nell’autunno del grazie allo scenografo Fi1841. Nel frattempo, la lippo Peroni sortirono coScala aveva già replicato munque un effetto straor17 volte Oberto, a riparadinario. Secondo alcune zione del fiasco di Un fonti poi, lo stesso compogiorno di regno e la stagiositore avrebbe in parte fine di carnevale-quaresinanziato l’impresa, rinforma era già definita con zando a proprie spese il tre opere nuove di artisti coro del Teatro, a quel conosciuti, tra cui Maria tempo né solido, né nuPadilla di Donizetti. Non meroso. Le prove di Nac’era posto, dunque, per bucco ebbero così inizio l’opera di Verdi, che Me- negli ultimi giorni di febbraio del 1842. la “Prima” alla scala Giunse la sera del 9 marzo 1842: la Scala era affollatissima, con il fior fiore della Milano musicale, artistica e letteraria tra cui, in un palco di prima fila, Gaetano Donizetti. Del resto il cast si preannunciava brillante: la Strepponi (Abigaille), Giorgio Ronconi (Nabucco), Giovannina Bellinzaghi (Fenena), Corrado Miraglia (Ismaele), Prosper Derivis (Zaccaria). Verdi prese posto in orchestra, con la scusa di girare le pagine ai collaboratori, ma in realtà per assistere da vicino al proprio trionfo od alla propria caduta. E il trionfo arrivò. Già il finale del primo atto fu accolto da un’ovazione tanto chiassosa da lasciar di stucco lo stesso compositore, che sulle prime scambiò le acclamazioni per fischi di disapprovazione. «Credetti che volessero farsi beffe del povero compositore, e poi che mi cadessero addosso per farmi un brutto tiro». E invece il successo fu clamoroso. Al calare del sipario applausi ed evviva furono interminabili. Enorme l’entusiasmo per il celebre coro “Va pensiero” e pure per la Sinfonia, approntata negli ultimi giorni sotto la caparbia insistenza del cognato Giovanni Barezzi. Otto furono le recite, ma il successo fu tale che alla Scala venne riproposta 75 volte entro la fine di quell’anno. Insomma, il pubblico del tempio lirico milanese quella sera consacrò definitivamente Verdi, che meno di un anno dopo avrebbe trionfato ancora con I Lombardi alla prima crociata (11 febbraio1843), opera che idealmente s’accoppia con Nabucco, dando il via quasi d’istinto all’azione politica del compositore. barbara catellani Il Giornale dei Grandi Eventi nabucodonosor 7 Analisi dell’opera Nabucco, il primo lavoro teatrale ben strutturato di Verdi N abucco, libretto di Temistocle Solera, tratto da un episodio del Vecchio Testamento, costituisce, dopo le prove mediocri o fallimentari di Oberto, conte di San Bonifacio e di Un giorno di Regno, l’avvio autentico del teatro verdiano, di un teatro, cioè, che pur attingendo all’esperienza dell’ultimo Rossini o del Donizetti tragico italiano, si imponeva con caratteri propri e di forte potere emozionale. Caratteri che emergono già nella Sinfonia. L’avvio lento e nobile affidato ai fiati lascia il posto a un tema nervoso, scattante, marziale cui segue il riferimento al tema ampio e disteso del “Va pensiero”. Un bitematismo, dunque, giocato sul contrasto fra due elementi caratterialmente assai diversi che riflettono le due anime musicali dell’opera: da una parte il Verdi quasi bandistico, esuberante, aggressivo, dall’altro la sua verve cantabile, distesa, con una delle melodie più popolari del suo intero repertorio. E’ significativo che mentre il primo tema ritornerà più volte a sottolineare i momenti più eroici, quello lirico risuonerà nella sua completezza solo nel celebre coro degli ebrei sul finire della terza parte. Verdi, dopo averlo annunciato, se lo tiene in serbo per la pagina su cui evidentemente più conta in termini di impatto emotivo. L’opera s’articola in quattro parti, ognuna con un proprio sottotitolo e una citazione dal libro di Geremia. La prima parte si intitola “Gerusalemme” con la seguente citazione: «Così ha detto il Signore; ecco, io do questa città in mano al re di Babilonia, egli l’arderà col fuoco» (Geremia XXXII); la seconda “L’Empio” è introdotta co, o il condottiero no elementi questi nei dai versetti «Ecco… il Ismaele. I due immettoquali emerge la genialiturbo del Signore è uscito no nella storia la comtà drammaturgica oltre fuori, cadrà sul capo delponente sentimentale che musicale di Verdi. l’empio» (Geremia XXX); con un recitativo amoA tale proposito va sotla terza, “La profezia” riroso nella IV scena che tolineato che il Verdi chiama Geremia LI: «Le spezza la tensione accudel Nabucco, come delle fiere dei deserti avranno in mulata. altre opere risorgimenBabilonia la loro stanza inPiù attenzione sul piano tali, è tutt’altro che sieme coi gufi e l’upupe vi dell’approfondimento “bandistico”: la sua irdimoreranno». Infine la caratteriale, Verdi pone ruenza (con scatti ritmiquarta, “L’idolo ci, fiati in primo infranto”: «Bel è piano, accompaconfuso: i suoi gnamenti balidoli sono rotti in danzosamente pezzi» (Geremia scanditi) è perXLVIII). fettamente calGià la prima scecolata e alternata na nel Tempio di a passi strumenSalomone si tali raffinatissiapre con uno dei mi. Cori più famosi, Il protagonista “Gli arredi festiNabucco è, come vi”. L’avvio coAbigaille, persorale rientra nella nalità controvertradizione delsa. Entra in scel’opera italiana, na nella prima anche se qui è Parte annunciadifferente la funto dalla banda zione. In genere con un tema il coro fungeva marziale, che rida “prologo”, correrà poi più raccontando volte a sottolil’antefatto, qui neare momenti Verdi lo trasforguerreschi, moma subito in strando subito, protagonista, col con vocalità bapopolo che canta Verdi in un ritratto del Torriani. La data dovrebbe essere ritonale violen1842, anno del Nabucco, ma la riga dei capelli è a sinistra e lamenta la pro- anzichè a destra (cambiamento che avvenne qualche anno ta, la sua bellicopria condizione dopo) e gli occhi sono scuri anzichè chiari. Probabile che il sità e crudeltà. in una pagina pittore abbia lavorato a memoria. Nabucco incarna con interventi a l’oppressore ed sezioni e poi un finale a agli altri due protagoniè abile Verdi ad indivicompagine intera. sti, Abigaille e Nabucco. duare per ogni “simboNella scena successiva, La prima, schiava ritelo” dell’umanità rapal Coro si affianca Zacnuta figlia del Re, appapresentata una adeguacaria, un basso, come si re come la personalità ta scrittura vocale. Doaddice alle figure “guipiù complessa dell’opepo essersi proclamato da” e linea di canto spiera. In lei si scontrano Dio ed essere stato fulgata, nobile come nel passionalità amorosa e minato, il terribile Re di Mosè rossiniano. sete di potere, ispirando Babilonia conosce il a Verdi momenti musipentimento, la pietà, la la caratterizzazione cali espressivamente dimisericordia. Il suo candei personaggi versi: dall’aria “Anch’io to “Deh perdona” nella dischiuso”, al duro sconParte III, si ammorbidiAspetto interessante del tro con Nabucco, al pensce, si fa più lirico, per primo Verdi è il trattatimento finale, al motornare poi ad un piglio mento riservato ai permento della morte. Abimarziale e trascinante sonaggi, spesso non gaille partecipa pure a nella Parte IV quando “scavati” sul piano psiscene di insieme. Da cirientrato in sé, vuole cologico, non definiti “a tare, ancora, il canto a riprendere il proprio tutto tondo” come sacappella “Immenso Jehoruolo. ranno poi Violetta, Rivah” (Parte IV) che con goletto, Azucena, ma la sua profonda suggeIl “Va pensiero…” trasformati in “simboli”. stione religiosa conferiCosì sono ad esempio sce quasi un aspetto Resta da menzionare la Fenena, figlia di Nabucpagina più famosa deloratoriale all’opera. So- l’opera, il coro che gli ebrei schiavi nella Parte III. Sulle sponde dell’Eufrate, incatenati, levano al cielo il loro rassegnato e doloroso lamento: «Va, pensiero, sull’ali dorate; /Va, ti posa sui clivi, sui colli,….». Le principali particolarità lessicali della pagina riguardano la presenza di termini aulici, come voleva la prassi di prosa e poesia ottocentesca, in particolare: clivi, membranza, favella, fatidici, traggi, nonché i nomi propri Sionne e Solima, dove Sionne indica Gerusalemme, mentre Solima deriva dall’antica denominazione greca della stessa città (Hierosólyma). Si tratta di 16 decasillabi, divisi in 4 quartine. Le strofe presentano un ritmo anapestico, con gli accenti che cadono sulle sedi 3-6-9. È per questo che al verso 13 la parola “simile” si legge con l’accento piano sulla seconda sillaba (“simìle”) anziché con l’accento sdrucciolo sulla prima. Secondo la prassi della poesia musicale, l’ultimo verso d’ogni quartina è tronco, cioè costituito da nove sillabe metriche. Verdi costruisce una melodia ampia, distesa su un accompagnamento arpeggiato d’archi. Andamento doloroso, dinamiche soffuse con scatti di passionalità come sulla frase «Oh mia patria sì bella e perduta»; ovvero allo slancio lirico «Arpa d’or dei fatidici vati». Un coro, però, va ricordato, d’oppressi e rassegnati. Non a caso, quando il tutto si spegne, pianissimo sulla parola “virtù”, irrompe Zaccaria che apostrofa i suoi: «Oh chi piange? Di femmine imbelli/ Chi solleva lamenti all’Eterno?/ Oh sorgete, angosciati fratelli, /sul mio labbro favella il Signor». roberto Iovino 8 nabucodonosor Il Giornale dei Grandi Eventi La figura storica di un grande Re, offuscato dalla perdita de Nabucodonosor, il conquistatore di Gerusalemm Giardini pensili di Babilonia G li ultimi decenni del VII secolo a.C. furono certo vissuti dalle genti di ogni lingua e cultura che abitavano per amplissime contrade in gran parte dell’Asia Occidentale, dall’Iran occidentale alle coste del Mediterraneo, come un tempo crudele di inattese speranze e di terribili incertezze. L’irresistibile dominio di Ninive e dei suoi re, i “vicari” del terribile dio Assur, che da oltre due secoli aveva annientato ogni potere politico rivale ed era arrivato ad estendersi dalla lontana Assiria fino a comprendere l’intera valle del Nilo, vacillava e i suoi eserciti faticavano a mantenere il controllo della Mesopotamia meridionale, dove sorgeva la città santa di Babilonia, centro del mondo, tanto metaforico quanto reale, per gli abitanti della terra dei due fiumi. Un energico principe caldeo, emerso dalle paludose e impenetrabili terre dove si alternavano palmizi e deserto sulle sponde del Golfo, forse erede di un antico illustre lignaggio, Nabopolassar, aveva levato un’armata che era riuscita a tenere in scacco l’invincibile esercito d’Assiria, si era proclamato re di Babilonia e pretendeva di scuotere lo spietato “giogo di Assur”. Dopo qualche tentativo sfortunato, quando l’audace Nabopolassar riuscì ad unirsi ad un altro generoso principe affermatosi nelle montagnose regioni della Media, Ciassare, gli eserciti congiunti della Babilonia e della Media, con l’ausilio forse di orde di Sciti, riu- scirono a espugnare, nel 612 a.C., la crudele Ninive, la “frusta di Yahwe”, come la definivano i profeti d’Israele, riconoscendo nell’Assiria l’inesorabile esecutore terreno dei terribili castighi che il dio d’Israele infliggeva al suo popolo per le sue ripetute ed imperdonabili infedeltà. Parvero cessare allora prolungate sofferenze di popoli sterminati, depredati e deportati dagli inflessibili signori d’Assiria – da Sargon II, a Sennacherib, a Asarhaddon, ad Assurbanipal, il Sardanapalo dei Greci -, se si dà ascolto alla voce degli sconfitti Ebrei, che avevano visto nel 722 a.C. cadere sotto i colpi dell’Assiria Samaria, capitale del regno settentrionale di Israele: dopo le trepidanti incertezze la speranza che al giogo d’Assiria succedesse per le popolazioni d’Oriente un più mite governo nell’equilibrio tra Ciassare e Nabopolassar. E così certo fu, perché quelli che presto divennero a loro volta i signori del mondo – i re di Babilonia – non regnarono più vantando un primato implacabile rivendicato in nome di un dio crudele, Assur, bensì si professarono, secondo una millenaria tradizione babilonese, pastori delle genti, restauratori di culti antichissimi, devoti piissimi di un dio ordinatore del mondo e signore dell’universo, Marduk. nabucodonosor il grande Uno dei leoni del rilievo della porta di Ishtar a Babilonia (604-562 a.C.) Colui che affermò e consolidò, fiaccando definitivamente la resistenza assira e sconfiggendo gli Egiziani accorsi in soccorso degli ultimi resti del potere assiro, fu il grande figlio di Nabopolassar, Nabucodonosor, che orgogliosamen- Figurino del personaggio di Nabucodonosor di Attilio Comelli per la rappresentazione a La Scala del 1913 te aveva assunto il nome di un grande re del XII secolo a. C., il quale aveva trionfato degli Elamiti, aveva riportato a Babilonia la statua cultuale della divinità Marduk, sacrilegamente asportata dal suo veneratissimo tempio dell’Esagil ed aveva dato corso all’esaltazione teologica universalistica del culto dello stesso Marduk. costruttore della Torre di babele Nabucodonosor II, salito al trono di Babilonia nel 604 a. C., fu un grande sovrano e divenne nella coscienza delle genti della Mesopotamia un eroe nazionale, tanto che, dopo il crollo dell’impero babilonese nel 539 a.C. di fronte all’urto dell’achemenide Ciro II il Grande, ogni personaggio di Babilonia che tentò, senza fortuna, di scuotere il do- minio persiano, assunse di nuovo il suo nome. Riorganizzato l’impero e delimitato ad Oriente il potere dei Medi, il gran Re si dedicò al più spettacolare programma di rinnovamento edilizio della sua capitale, estesa allora per circa 1000 ettari e di ricostruzione di tutti i maggiori santuari della Babilonia che mai si fosse visto in Oriente. Fu questo straordinario costruttore che portò a termine, contro ogni aspettativa, l’impresa memorabile del completamento della torre templare di Marduk a Babilonia, l’Etemenanki, la “Casa fondamento del cielo e della terra”, che da allora per alcuni decenni dominò con la sua altezza di poco meno di 100 metri il panorama verdeggiante di palme dell’immensa Babilonia. La celeberrima fabbrica ciclopica della “Torre di Babele”, la cui ricostru- Il nabucodonosor Giornale dei Grandi Eventi 9 elle fonti scritte e dalla tradizione biblica me che riedificò la Torre di Babele zione era stata forse iniziata da Nabucodonosor I secoli prima, rimase a lungo incompleta ed abbandonata come un’immensa rovina urbana, tanto da far nascere, forse nella stessa Babilonia o più probabilmente nella Palestina apparire come un personaggio di straordinaria devozione religiosa assai più che come condottiero illustre. Ma il suo nome è rimasto legato in tutta la tradizione occidentale alla conquista di Gerusalemme, alla distruzione del Robert Koldewey tra il 1899 e il 1913 - fortemente voluta dall’Imperatore di Germania, il Kaiser Guglielmo II (1859-1941, imperatore dal 1888 al 1918), animato dalla ferrea volontà che i Musei Statali di Berlino potessero riva- Babilonia - ricostruzione ideale di Johann Bernhard Fischer von Erlach (1721) dell’VIII-VII secolo a. C., la non meno famosa storia biblica del suo disfacimento da parte di Dio come punizione di un disegno umano di arroganza e orgoglio inammissibili. Ribaltando il mito e le sue ragioni, Nabucodonosor II non solo completò fino al più alto fastigio quell’opera immane, ma profuse un’immensa quantità d’oro nella decorazione della cella del tempio di Marduk posto sulla sua sommità, creando attonito stupore anche in chi, come forse Erodono, quel gigantesco monumento vide già in decadenza. Il conquistatore di Gerusalemme Poche sono le gesta militari che le iscrizioni del gran Re di Babilonia hanno tramandato, perché egli certo teneva ad tempio salomonico ed all’abbattimento delle mura della capitale del regno di Giuda, dove regnava l’ultimo successore di David: i testi amministrativi scoperti nella Babilonia di Nabucodonosor II ricordano, tra i nomi dei principi stranieri sottomessi ed ospitati alla corte di Babilonia, anche quello dell’infelice re di Giuda (Yehoiakin che appare nei testi babilonesi nella forma “Yaukin, re di Giuda”), il quale fu portato in esilio con l’élite intellettuale di Gerusalemme nella nuova capitale del mondo. la riscoperta archeologica di babilonia La rinascita archeologica della Babilonia di Nabucodonosor II, restituita alla conoscenza storica dall’epocale esplorazione tedesca di leggiare con i musei di concezione imperiale dell’Impero Britannico e della Repubblica Francese (il British Museum ed il Louvre) -, ha documentato nelle straordi- narie fortificazioni, nei templi numerosi, negli estesissimi palazzi reali, nella sontuosa strada cerimoniale della dea Ishtar un’attività edilizia del tutto corrispondente alle ripetute celebrazioni delle opere architettoniche contenute nelle iscrizioni reali del sovrano. L’immagine storica di Nabucodonosor II è stata indubbia- La grande via trionfale di Nabucodonosor che dalla mente sfigurata Porta di Ishtar conduceva al Tempio del dio Marduk dalla sorte avunificatore e pacificatoversa che, nel naufragio re e della nazione partitotale delle fonti scritte colare, gelosa custode della civiltà mesopotadella sua specificità e mica verificatosi dopo delle sue tradizioni, sol’età ellenistica ed il susprattutto dall’età del seguente completo Romanticismo, Babilooblio di ogni testimonia è divenuta il simbonianza diretta, ha fatto lo dell’oppressione trusì che nella memoria del ce e cieca, spietata e mondo occidentale essa inaccettabile, e gli Ebrei sia stata filtrata dalla in cattività il simbolo tragica esperienza, così del popolo ingiustaefficacemente espressa mente soggiogato, malnella tradizione biblica, vagiamente disperso, della Cattività babilonesofferente e irredento. se e dell’Esilio degli Ebrei. Nella contrapposizione secolare dei due opposti ideali politici dell’impero universale Paolo Matthiae Accademico dei Lincei Archeologo Opposte visioni della figura storica Nabucodonosor esaltato ma da alcuni criticato N abucodonosor II morì nell’ottobre del 562 a.C. Durante l’età ellenistica si svilupparono nel mondo seleucide due opposti miti attorno alla sua figura, uno greco positivo e l’altro ebraico negativo. Da un lato, anche sulla base dei dati accumulati dal dotto Berosso, sacerdote di Bel, astronomo ed astrologo babilonese vissuto tra IV e III sec. A. C. che scrisse sull’antico mondo mesopotamico per un sovrano ellenistico, nella tradizione greca, affascinata dalla sua fama di rifondatore di una città immensa di straordinaria suggestione, cui non si sottrasse neppure Alessandro Magno, il re babilonese divenne un nuovo Belo, travestimento greco della divinità Marduk, in quanto fon- datore di una città eccezionale dalla triplice, gigantesca, cerchia di mura costruite in quindici giorni, ed un eroe semidivino, «più potente di Eracle, che invase la Libia e l’Iberia». Dall’altro lato, soprattutto sulla base della storia biblica di Daniele, nella tradizione ebraica, antica e medioevale, inorridita dalla sua crudele idolatria, il gran Re responsabile del sacco di Gerusalemme e della distruzione del Tempio di Salomone, condannato ad un destino atroce di follia e di inselvatichimento, diviene un essere bestiale con le sembianze di un bue dai fianchi in su e di leone dai fianchi in giù, «che si aggirava tra i dirupi e ruggiva tra le fiere selvagge». Pa. Mat. 10 nabucodonosor Il Giornale dei Grandi Eventi Il Nabucco nelle scenografie L’invenzione scenica dell’Oriente antico L a prima rappresentazione del Nabucco di Giuseppe Verdi alla Scala di Milano, fu salutata con grandissimo entusiasmo, decretando, fin dell’inizio, la fortuna dell’opera verdiana. Non solo la musica, ma anche costumi e scene hanno contribuito alla riuscita dell’opera, come lo stesso Verdi racconta in una lettera, dove il Maestro menziona il magnifico ed accurato lavoro di Filippo Peroni (Perroni come scrive Verdi) che, riaccomodando e ridipingendo vecchie scene, riesce tuttavia ad ottenere l’effetto desiderato. Quali fossero queste vecchie scene è difficile dirlo: l’ipotesi più logica, sebbene, allo stesso tempo, non del tutto convincente, è che per la prima del Nabucco di Verdi siano state riutilizzate scene del balletto Nabuccodonosor di Antonio Cortesi, messo in scena alla Scala di Milano il 27 ottobre 1838 od anche alcune di Oberto, Conte di San Bonifacio dello stesso Verdi che aveva debuttato nello stesso teatro Milanese il 17 novembre 1939. Il nome di Peroni, tuttavia, non compare sul libretto della prima dell’opera di Verdi a Milano: lo scenografo indicato è Baldassarre Cavallotti, ma l’intervento dello stesso Peroni è confermato dall’esplicito riferimento che ne fa il Maestro nella già citata lettera. Molti anni dopo Verdi avrebbe così rievocato la serata: «Il Nabucco nacque sotto una stella favorevole, giacché anche tutto ciò che poteva riuscire a male contribuì invece in senso favorevole […] I costumi raffazzonati alla meglio riescono splendidi! Scene vecchie, riaccomodate dal pittore Peroni, sortono invece un effetto straordinario: la prima scena del tempio in specie produce un effetto così grande che gli applausi del pubblico durarono per ben dieci minuti». Il nome di Filippo Peroni sarà legato ad altri cinque allestimenti dell’opera verdiana. Fra i bozzetti conservati (difficilmente databili con precisione), si possono osser- vare i primi esempi di utilizzo di elementi dell’architettura mesopotamica antica che, proprio in quegli anni, gli archeologi francesi e britannici stavano riportando alla luce nelle capitali assire (Khorsabad e Nimrud) dell’Iraq settentrionale. Rispetto alle scene di Romolo Liverani per il Nabucco di Faenza del 1843, dove è ancora diffuso l’uso di elementi architettonici prevalentemente egiziani per caratterizzare l’oriente, Peroni fa esplicito riferimento all’architettura e scultura assire (con l’impiego dei caratteristici tori androcefali presso gli stipiti dei passaggi) che egli deve aver potuto vedere nei disegni degli scavi francesi a Khorsabad di Paul-Émile Botta (1849) e britannici di Austen Henry Layard (1849-50, 1853) e nelle contemporanee notizie, accompagnate da illustrazioni, pubblicate sui giornali L’Illustration e The Illustrated London News, oppure nelle riproduzioni di reperti isolati, come quelli rinvenuti da Claudius James Rich negli anni 1811 – 21 (ora al British Museum di Londra) ed immagini di tavolette cuneiforme, note già nel Settecento ma non ancora decifrate. È verosimile, quindi, che i bozzetti di Peroni si collochino in questi anni, quando le antichità assire erano oramai giunte ed erano state ampiamente pubblicate in Europa. All’elemento architettonico e figurativo egiziano, fino a quel momento largamente impiegato (ma di fatto non totalmente abbandonato anche dallo stesso Peroni e da altri scenografi) si sostituisce la componente assira, adoperata anche per raffigurare la città di Babilonia (luogo dell’azione del Nabucco), le cui vestigia verranno scoperte solo alla fine dell’800 con gli scavi diretti dal tedesco Robert Koldewey dal 1899 al 1917. davide nadali Archeologo Iconografia Verdiana Il Busto di Verdi al Conservatorio di Milano C oglie Giuseppe Verdi nell’età di mezzo, nei cosiddetti “anni di galera” in cui maggiore e più vivida fu la scintilla del suo genio, il busto che ricorda il compositore nel Conservatorio di Musica di Milano, intitolato proprio al “Cigno di Busseto”. Un’intitolazione quasi riparatoria visto che l’istituzione è passata alla storia per non aver ammesso Verdi tra gli studenti nel 1832. La commissione lo considerò, infatti, troppo anziano (aveva 18 anni e 14 era l’età massima per l’ammissione), accusandolo anche di avere un’errata tecnica nella postura della mano. Come se non bastasse, era anche straniero, poiché proveniva dal Ducato di Parma. L’episodio è narrato dallo stesso Verdi in una lettera a Jacopo Caponi dell’11 ottobre 1880: « Non nel 1833, ma nel 1832 nel mese di giugno (non avevo compiti 19 anni) feci domanda in iscritto per essere ammesso come alunno pagante al Conservatorio di Milano. Di più subii una specie di esame al Conservatorio presentando alcune mie composizioni e suonando un pezzo sul pianoforte dinanzi a Basily, a Piantanida, Angeleri ed altri ecc. ecc., più il vecchio Rolla, al quale ero raccomandato dal mio maestro di Busseto, Ferdinando Provesi. Circa otto giorni dopo mi recai dal Rolla, il quale mi disse: “Non pensate più al Conservatorio: scegliete un maestro in città: io vi consiglio o Lavigna o Negri”. Non seppi più nulla del Conservatorio. Nissuno rispose alla mia domanda. Nissuno mi parlò, né prima, né dopo l’esame, del Regolamento. E non so nulla del giudizio di Basily narrato da Fétis. Ecco tutto! » Un busto opera di quell’Achille Alberti (1860 – 1943) che fu scultore apprezzatissimo nella Milano di fine’800 inizi ’900 ed a cui si devono numerose statue ad ornamento delle tombe nel cimitero monumentale di Milano, oltreché il bassorilievo, del 1888, che riproduce fedelmente il progetto neogotico della facciata del Duomo di Milano ricordando il suo progettista Giuseppe Brentano. Il busto di Verdi dell’Alberti fu collocato nel Conservatorio milanese nel 1908, anno del Centenario dell’istituzione musicale, nata con Regio Decreto napoleonico nel 1807 che prevedeva nella struttura, sita nei chiostri di uno dei gioielli dell’architettura barocca meneghina come la Chiesa di S. Maria della Passione, la pensione completa per gli interni. L’inaugurazione del Conservatorio si tenne il 3 settembre 1808, offrendo allora la possibilità di studiare a 18 convittori tra maschi e femmine. Nella struttura hanno poi studiato in tanti, tra i quali Catalani, Ponchielli e Puccini. Mic. Mar. Il Giornale dei Grandi Eventi nabucodonosor 11 L’impegno politico del compositore Una identificazione risorgimentale, più che vera partecipazione I l 9 marzo 1842, con il trionfo alla Scala di Nabucco iniziò, insieme alla vera e propria carriera artistica di Verdi, la sua identificazione con il Risorgimento: il giovane compositore di Busseto divenne l’artista simbolo dell’Italia in lotta per la propria unificazione. Vissuto 88 anni, nato nel 1813 quando la sua terra era sotto il dominio napoleonico, morto nel 1901 in una Italia unita, ma agitata da lotte sociali e dal recente assassinio di Umberto I, Verdi ha in effetti vissuto il suo tempo da protagonista non limitandosi al ruolo di musicista, ma partecipando attivamente, per diversi anni, anche alle vicende politiche. Quando scoppiarono i moti del Quarantotto, Verdi da Parigi scrisse all’amico e librettista Francesco Maria Piave per proporgli un’opera di soggetto italiano, incentrata su «Ferruccio, personaggio gigantesco, uno dei più grandi martiri della libertà italiana». vadino a godersi il loro clima […]. Quanti prodigi in pochi giorni! Non par vero. E chi avrebbe creduto tanta generosità nei nostri alleati?». Il giorno seguente, 24 giugno, i Francesi vincevano a Solferino e i Piemontesi a San Martino. Ma lì si arrestò l’offensiva di Napoleone III e Verdi, deluso, scrisse alla Maffei il 14 luglio: «La pace è fatta... La Venezia rimane all’Austria..!!! E dov’è dunque la tanto sospirata e promessa Indipendenza d’Italia? Cosa significa il proclama di Milano? O che la Venezia non è Italia?». II 4 settembre Busseto nominò Verdi suo rappresentante all’Assemblea delle Province Parmensi. Il 12 quest’assemblea votò l’annessione al regno dell’Alta Italia; il 15 settembre 1859 una Delegazione di cui faceva parte Verdi fu ricevuta da Vittorio Emanuele, cui presentò il voto un Inno per Mazzini Poi, su invito di Mazzini compose anche un Inno su versi di Mameli, Suona la tromba che il 18 ottobre 1848 inviò allo stesso Mazzini con poche parole di accompagnamento: «Vi mando l’inno e sebbene un po’ tardi, spero vi arriverà in tempo. Ho cercato d’essere più popolare e facile che mi sia stato possibile…. Possa quest’inno fra la musica del cannone essere presto cantato nelle pianure lombarde...». Un Inno, sottolineava Verdi, deve essere “facile” e quindi popolare. Nel 1859 Verdi si trasformò addirittura in contrabbandiere per acquistare 172 fucili da donare alla Guardia nazionale di Busseto. Scrisse all’amico direttore d’orchestra Angelo Mariani il 27 novembre 1859: «La tua del 23 m’annuncia che i fucili saranno ora a Piacenza e tu non puoi immaginare la mia gioia e la gratitudine che te ne professo. Dio voglia che tutto sia in buon stato e vi siano le rispettive bajonette come spero». L’intervento della Francia accanto ai Piemontesi, nel 1859, lo entusiasmò: «Finalmente se ne sono andati – scrisse alla contessa e amica Maffei, il 23 giugno - o almeno si sono allontanati, e voglia la nostra buona stella allontanarli di più in più, finché cacciati oltr’Alpi plebiscitario di quelle province emiliane. Fu quello il primo atto politico pubblico di Verdi. Evviva Garibaldi Il 5 maggio 1860, dalla scoglio di Quarto Garibaldi salpò con i Mille alla conquista della Sicilia. «... Evviva dunque Garibaldi – così Verdi a Mariani il 27 maggio 1860 - Per Dio è un uomo veramente da inginocchiarsi davanti!» Amico di Mazzini, estimatore di Garibaldi, inizialmente repubblicano convinto, Verdi si convertì poi alla monarchia ed ebbe il suo idolo in Cavour. Alla fine del 1860 Cavour, torna- to alla presidenza del Consiglio, aveva deciso di indire le elezioni per la formazione del primo Parlamento nazionale ed il nome di Verdi era stato ventilato per una candidatura nel collegio di BorSan Donnino go (l’odierna Fidenza), di cui faceva parte Busseto, per sfruttarne – ieri come oggi – la popolarità. Verdi era contrario: «Non ti sorprendere se mi vedi a Torino – scriveva il 16 gennaio 1861 a Mariani - Sai perché sono qui? Per non essere Deputato. Altri brigano per essere, io faccio di tutto il possibile Verdi presenta a Vittorio Emanuele il plebiscito delle proper non esserlo». La de- vince emiliane terminazione di Verdi Il musicista, che nei banchi si era tuttavia già incrinata quanparlamentari sedette a fianco di Quintino Sella, fu tra l’altro presente alla seduta del 14 marzo 1861, che dava a Vittorio Emanuele II il titolo di Re d’Italia (titolo che sarà poi sancito dalla Legge n° 4671 del Regno di Sardegna promulgata il 17 marzo) ed anche a quella del 27 marzo 1861, in cui Roma (ancora pontificia) venne proclamata Capitale del nuovo regno. La morte, il 6 giugno 1861, di Cavour, divenuto punto di riferimento politico di Verdi, lo addolorò profondamente e lo privò della sua “bussola” nella difficile navigazione parlamentare, tanto che gradualmente egli s’allontanò dalla politica attiva. Nei decenni postunitari Verdi guardò in modo sfiduciato alle vicende politiche dell’Italia unido, il 10 gennaio, lo stesso Cata, limitandosi a qualche duro vour gli aveva scritto: «Ella concommento nelle lettere indiriztribuirà al decoro del Parlamento zate agli amici più fidati. dentro e fuori d’Italia, essa darà creIl 27 maggio 1881, ad esempio, dito al gran partito nazionale che scrivendo all’amico Arrivabene vuole costituire la nazione sulle sochiarì così il suo ideale di uomo lide basi della libertà e dell’ordine, di governo: «Poco m’importa la ne imporrà ai nostri imaginosi colleForma o il Colore. ghi della parte meridionale d’Italia, Guardo la storia, e leggo grandi suscettibili di subire l’influenza del fatti, grandi delitti, grandi virtù genio artistico assai più di noi abitanei Governi dei Rè, dei Preti, delle tori della fredda valle del Po». Repubbliche!... Non m’importa, ripeto; ma quello deputato in Parlamento che domando si è che quelli che reggono la cosa pubblica sieno CitEletto, Verdi entrò, dunque nel tadini di grande ingegno e di specprimo Parlamento italiano, inchiata onestà…». sediato il 18 febbraio 1861, preroberto Iovino sieduto da Urbano Rattazzi. 12 nabucodonosor Il Giornale dei Grandi Eventi La teatralità dell’Inno di Mameli L’Italia s’è desta… I mmaginiamo una scena d’opera, di quelle opere di carattere risorgimentale che negli anni Quaranta dell’800 entusiasmavano le platee di tutta Italia. Non solo Verdi affrontava temi patriottici, riferimenti erano disseminati un po’ ovunque, a cominciare da Donna Caritea di Mercadante. «Chi per la Patria muor/ vissuto è assai» avevano cantato i fratelli Bandiera al momento della fucilazione, il 25 luglio 1844 nel vallone di Rovito vicino a Cosenza. Dunque, immaginiamo nel corso di un atto, il nostro eroe in scena di fronte al coro, il popolo. Con aria marziale e imponente, forte ed energico, a gambe ben piantate in terra, il tenore (perché di tenore certamente si tratta) attacca: «Fratelli d’Italia,/ l’Italia s’è desta/ Dell’elmo di Scipio,/ s’è cinta la testa/ Dov’è la Vittoria?/ Le porga la chioma/ Chè schiava di Roma,/ Iddio la creò». Abbiamo giocato con l’immaginazione, naturalmente. Ma è un gioco solo apparente. Il nostro Inno ha davvero un piglio teatrale, è figlio di un’epoca, quell’Ottocento che in Italia vedeva l’opera non solo come uno spettacolo nazionalpopolare, ma come il più autentico, diretto, immediato canale di diffusione degli ideali patriottici. Possono essere utili alcuni dati. Nel 1785/86 l’annuale “Indice de’ teatrali spettacoli” registrava un centinaio di teatri attivi in Italia. Fra il 1821 e il 1847 il numero si era più o meno raddoppiato e nel 1871 i teatri presi in conside- razione per un censimento e una ripartizione in categorie risultavano 940. novaro e Mameli Quando si parla del nostro Inno lo si indica in genere come l’Inno di Mameli. In un Inno patriottico, effettivamente, la musica ha una importanza tale da far passare la parte poetica in secondo piano. Ma nel caso di Mameli va riconosciuto al patriota genovese di aver scritto versi non di circostanza, ma profondamente vissuti e sofferti se pensiamo che egli fu davvero “pronto alla morte” e morì ad appena 22 anni nel 1849 in difesa di Roma. Goffredo Mameli Tuttavia, il musicista ha la sua rilevanza per la capacità di trasformare dei versi in un canto di facile pose l’Inno. «Tornando a que’ tempi - fu la sua sucpercezione, stimolando passione e sentimento. cessiva testimonianza - io non vidi il Mameli se non a Michele Novaro ha mostrato, nell’arco della sua più Milano, nell’aprile ‘48. Si discorreva in piazza del Duolunga esistenza, una coerenza morale che se non ne mo di tutte le cose nostre genovesi, quando ad un tratto ha fatto un esponente di primo piano della cultura la banda Nazionale intuona il “Fratelli d’Italia”. Un italiana dell’Ottocento, gli ha consentito di svolgere urrà generale si levò per la piazza; Goffredo ebbe come un con straordinario impegno civile un intenso lavoro lampo negli occhi, mi gittò le braccia al collo e mi baciò. di musicista e di didatta spesso al servizio della cauFu l’ultima volta che lo vidi…». sa risorgimentale e dei ceti sociali più deboli. Il Canto degli Italiani Anche lui genovese, Novaro (1818 – 1885) si era formato nella Scuola Gratuita di Canto (l’attuale ConLo stile vocale di Novaro è prevalentemente sillaservatorio “Paganini”) dove aveva studiato canto e bico, a volte tendente al declamato piano, disteso. composizione per poi iniziare la sua attività come In generale, comunque, anche nell’evoluzione mecantante lirico. lodica più intensa, mantiene un totale rispetto per Nel 1847 Novaro si la parola. Sul piano armonico Novaro concepisce trasferì a Torino un supporto estremamente semplice. Poche moquale secondo tedulazioni, sempre alle tonalità vicine, con frenore e maestro dei quenti casi di lunghe frasi sulla stessa armonia. cori al Regio e al Anche l’accompagnamento ha i caratteri della esIn difesa dell’Inno di Mameli Carignano. E prosenzialità e della pienezza per una immediata perprio a Torino comcezione armonica. Ne scaturisce insomma un repose nel giro di popertorio “facile”, dove la qualifica non è giudizio on capisco il revisionismo mu- amor patrio, dalla storia alla nazioche ore il “Canto denegativo, ma presupposto alla diffusione. sicale che si accanisce periodi- nale. Allora ci mettiamo Volare o Azgli Italiani”. In tal senso occorre interpretare anche il “Canto decamente sull’Inno di Mameli. Dicono zurro al posto di Fratelli d’Italia? Ma Una sera di novemgli Italiani” che appare come il più riuscito lavoro che sia brutto e sgraziato, ed a volte l’Inno di Mameli fu scritto ad hoc, fu bre, Novaro si trodi questo genere musicale. Dal 1831 per tutto il Ritestimoniato col sanlo accostano all’Altavava in casa dello sorgimento e fino al 1946, inno italiano fu la “Margue del suo giovane re della Patria che scrittore e patriota cia reale” di Giuseppe Gabetti, che rimase in uso fiautore, che riassume quest’anno compie Lorenzo Valerio no al 1946. Il “Canto degli Italiani” fu adottato, di nei suoi vent’anni spe106 anni ed è considequando arrivò il fatto e non formalmente, come inno nazionale dosi e sacrificati all’Itarato l’equivalente arpittore Ulisse Borpo la proclamazione della Repubblica. E’ intereslia, il senso più alto di chitettonico di Fratelli zino con un testo di sante tuttavia notare che quando nel 1862 Verdi un legame con la Pad’Italia. Ma gli inni Mameli per il mucompose l’Inno delle Nazioni per l’Esposizione di tria. E si è legato alle nazionali, come i nosicista. Novaro lo Londra, su testo di Arrigo Boito, il musicista vi inimprese risorgimentami di persona, i molesse rimanendone serì tre canti di altrettante Nazioni: per l’Inghilterli, alla Grande Guerra, numenti e le cose che colpito, abbozzò lì ra God save the Queen, per la Francia La Marsigliese alle altre imprese eroiper lì un tema, poi ci sono più care, non e per l’Italia l’”Inno di Mameli”. roberto Iovino che, ai soldati della secorse a casa e comsi dividono in belli e conda guerra mondiabrutti, ma in significativi e insignificanti. So benissimo le, all’Italia repubblicana che ne seche ci sono canti e inni più belli e for- guì. Un inno nazionale ha valore per se più popolari, sia nella lirica, nella quel che si raggruma dentro le sue musica classica e nella grande opera note e le sue parole, se ricorda la viche nella musica moderna, leggera e ta, l’anima e il sangue di più generapopolare. Si, per carità, il coro del zioni, allora merita di restare l’inno terzo atto del Nabucco, il “Va pensie- di una comunità. Certo, i lupi della ro” verdiano, è certamente più bello retorica sono sempre in agguato, ane solenne, indipendentemente dal- drebbe fatto conoscere fin nelle l’uso padano dei leghisti o per la sto- scuole elementari. Ma in un paese ria di schiavitù che evoca. So, ad parricida e a volte anche infanticida, esempio, che la musica che più è ri- evocare la fratellanza nazionale e un masta nelle orecchie e nel cuore de- po’ commuoversi a cantarlo insieme, gli italiani è Volare di Domenico Mo- in piedi, magari con la mano sul cuodugno o Azzurro di Adriano Celen- re, è un segno di coesione, di memotano che avrebbe pure l’alibi croma- ria e di fiducia. L’Italia chiamò. Marcello veneziani tico di ricordare il colore del nostro Tomba di Goffredo Mameli al Cimitero Verano di Roma. I resti mortali furono però trasferiti nel 1943 Il Commento E l’Italia chiamò… N nell'ossario garibaldino del Gianicolo Il Giornale dei Grandi Eventi nabucodonosor 13 Le note simbolo di una Nazione Dall’Inno inglese, alla disputa sul “Va’ pensiero…” I il patrimonio culturale e Lavagna «O Roma felix, O Roma nobilis» apl concetto di Inno sociale del Paese che li ha pena ratificato ufficialmente. Nazionale e la adottati. Ad esempio la Nel nostro Paese l’Inno degli Italiani di Gofsua funzione istiMarcia Trionfale dell’Aida fredo Mameli, adottato solo de facto nel tuzionale sono reladi Verdi è stata dal 1872 1946 al posto della Marcia Reale, è stato tivamente recenti, (ovvero pochi mesi dopo più volte criticato per la sua non grande anche se l’origine è la prima esecuzione) l’inqualità musicale e poetica. Come inno soda ricercare, come no egiziano fino al 1979 no stati ciclicamente ed a più riprese invoespressione di ideali quando è stata sostituita cati il «Va pensiero» del Nabucco che però è e sentimenti naziodal Biladi Biladi Biladi (Teril grido di un popolo in schiavitù e comunnalistici, maturato ra mia, Terra mia, Terra que è stato poi adottato dalla Lega come per la prima volta mia) di Sayed Darwish che proprio simbolo ed anche – forse più a raprobabilmente in per il testo adottò un digione - “La leggenda del Piave” di E. A. Maambiente rivoluzioscorso di Mustafa Kamil. rio (iniziali e nome sono uno pseudonimo nario nelle Fiandre Anche l’Inno Pontificio ha di un napoletano impiegato delle poste, da parte dei ribelli un autore celebre, il franGiovanni Ermete Gaeta (1884 – 1961)) braall’oppressione spacese Chares Gounod. no che celebra la vittoria che realmente nel gnola nel 1570. Nel L’autore dell’opera lirica 1918 creò storicamente e geograficamente 1743 al Drury Lane Faust e della soavissima la vera ed unica Unità d’Italia. Theatre di Londra Charles Gounod autore dell'Inno Pontificio Ave Maria contrappuntata rob. Iov. fu eseguito per la sul primo preludio di J. S. Bach, lo compoprima volta God save the King (oppure se come Marcia Queen, quando regna una Regina), canto per l’anniversario patriottico che divenne talmente popolare dell’incoronazioda essere ripetuto in ogni manifestazione ne di Pio IX e venconnessa con la Monarchia. Ma il termine ne eseguita per la ed il concetto di Inno Nazionale si affermò prima volta l’11 solo nell’Ottocento, ancora a partire dalaprile 1869 in l’Inghilterra e da lì si estese via via negli piazza San Pietro altri Paesi. L’esecuzione dell’Inno inizialin occasione del mente era motivato dalla necessità di rendi Vittorio Emanuele di Savoia giubileo sacerdodere omaggio ad un Capo di Stato straniepositore bussetano, la cui musitale del Papa. Un a rappresentazione del Naro, in seguito l’impiego fu generalizzato a ca fu recepita dall’opinione pubInno Ufficiale già bucco di Giuseppe Verdi è tutte le occasioni di particolare ufficialità. blica come sprone di libertà. esisteva dal 1857 certamente il modo miglioScorrendo tra gli Inni Nazionali, raramenE quel “moto” unito al “grido di composto dall’au- re per riportarci sulle ali della te questi traggono spunto dal repertorio dolore” che veniva dal cuore del striaco Vittorino musica ai gloriosi anni del Rimusicale di tradizione orale, quello, per inRe Vittorio Emanuele II, furono Hallmayr. Ma alla sorgimento, fondamento dei Satenderci, popolare. Normalmente sono il “leit motiv” che unirono gli vigilia dell’Anno cri Valori della Patria! brani appositamente composti, oppure animi più illuminati e decisi di Santo del 1950 Pio Con il “Va pensiero” è stato accreati per particolari occasioni e talmente tanti uomini illuXII il 16 ottobre ceso negli aniradicati nello spirito di quel popolo da distri, i quali con1949 disponeva mi, da tempo ventarne automaticamente il simbolo mutribuirono con la che l’Inno Ufficia- anelanti della lisicale. loro intelligenza, le fosse cambiato bertà, quello Un Inno, è stato a ragione sostenuto, non si impegno e sacricon quello Pontifi- spirito patriottivaluta secondo i parametri usualmente seficio, ad unificare cio di Gounod, co del quale guiti nel giudicare qualsiasi altra pagina la nostra Italia più consono ai Verdi divenne musicale. Il giudizio dipende in realtà dalsotto una sola tempi, che fu ese- un simbolo. la sua capacità di farsi simbolo, di diventaBandiera. E proguito per la prima Il suo animo re un elemento d’aggregazione, pagina prio la straordivolta come tale sensibile, genedavvero popolare in grado di tradurre con naria musica del nel Cortile di S. roso, attento a immediatezza i sentimenti di un intero ponostro grande Damaso il pome- cogliere pensiepolo. Verdi, fece da riggio del 24 di- ri, desideri apNon c’è dubbio che la Marsigliese sia per i “colonna sonora” cembre 1949 gior- pena accennati Francesi il simbolo di quegli ideali che, naa tutte le imprese no dell’apertura ma profondi che ti dalla Rivoluzione, hanno cambiato non vittoriose e non, della Porta Santa. serpeggiavano solo la loro società, ma tutta l’Europa. E di questo perioUna curiosità è tra la sua gente, non c’è dubbio che i Tedeschi si possano do così intenso e che ufficialmente dai più umili ai riconoscere nel Kaiserlied scritto da Haydn difficile, ma che tra tante soffel’Inno rimase sen- più colti, seppe con la sua musiper l’Impero asburgico, una pagina di elerenze seppe arrivare al traguarza parole (anche ca infondere sentimenti di risvegante e nobile espressività. Tra l’altro, neldo. Le note immortali di questo se ne esisteva un glio e di unanime ribellione agli l’Impero Austro-Ungarico questo inno, digrande Musicista e Italiano siatesto di mons. oppressori. La sua grande musivenuto dal 1922 l’inno della Germania no sempre simbolo, oggi come Antonio Allegra ca, divenuta poi immortale, fu (Das Lied der Deutschen - Il canto dei Tedeallora, di fratellanza ed unità ed «Roma immortale capace di infiammare gli animi schi) e di quella occidentale nel dopogueramore per la nostra Patria, come di martiri e di san- tanto da far gridare, prima sotto ra, ne esisteva una variante esclusivamenil grande Maestro ci ha insegnati») fino al 16 otto- voce, poi sempre più forte, “VIte nelle parole da eseguirsi alle presenza to. bre 1993 quando VA V.E.R.D.I.” un acronimo che della sola Imperatrice. Ma allargando il divenne eseguito rimandava parimenti a Vittorio scorso, tutti gli inni, siano essi allegre e vicon il testo latino Emanuele Re d’Italia ed al combranti marcette o temi più lirici e cantabili, di mons. Raffaello tutti in qualche modo hanno a che fare con L’Intervento Una musica capace di unire l’Italia sotto una sola bandiera L dal mondo della musica 14 Il Giornale dei Grandi Eventi Prima interprete di Abigaille e seconda moglie del compositore Giuseppina Strepponi e l’amore per Verdi N on dovette essere semplice fare da moglie ad un uomo come Verdi, ma la Strepponi ne fu all’altezza. Giuseppina Strepponi, nata a Lodi l’8 settembre 1815 studiò musica fin da piccola col padre Feliciano, anche se ebbe sempre a noia la musica religiosa, preferendole di gran lunga quella teatrale. Fu ammessa quindicenne al Conservatorio e si rivelò un’ eccellente pianista, tanto da chiedersi se fosse più adatta a lei la carriera di strumentista: alla fine opto per la scena, pur conseguendo, dopo la morte del padre, sia il diploma di canto che quello di clavicembalo. Uscì dal Conservatorio nell’ottobre 1834 e sempre a Lodi, appena diciottenne, fece il suo debutto in diversi concerti, ammirata per le qualità vocali e soprattutto per la presenza vista della scena. Qui fu introdotta da Alessandro Lanari, detto il “Napoleone degli impresari”, tuttavia Giuseppina dovette i primi successi a un agente teatrale di minore importanza, tale Domenico Cirelli, il quale la conosceva da quando era ancora vivo il padre, e che rappresentò per la giovane una figura paterna e protettiva, divenendone poi amante ma anche l’agente che le avrebbe spalancato le porte dei principali teatri. Gli anni 1836-1837 furono estremamente intensi: richiestissima, si sottopose a un’incessante attività lavorativa, moltiplicando gli impegni e passando da un amante all’altro. Ad aggravarle la salute, oltre alle tensioni, si aggiunsero gli effetti devastanti di numerose gravidanze che costrinsero la donna a riposi forzati lontano dalle scene. Nemmeno la paternità Caricatura di Melchiorre Delfico di Verdi e la Stepponi al loro arrivo a Napoli scenica. A Udine, Gorizia, Verona, Brescia, Trieste, Piacenza, Vienna, e presto alla Fenice di Venezia, ottenne trionfi nelle opere più amate dal pubblico: Matilde di Shabran di Rossini, Norma di Bellini, Anna Bolena e Lucia di Lammermoor di Donizetti. Il cammino della gloria passava obbligatoriamente attraverso la “protezione” di un agente o di un impresario abbastanza influente, e Milano era la città che contava i personaggi più in del primo figlio fu certa, ma Cirelli, che figurò come compagno quasi ufficiale, nonostante fosse sposato e padre di famiglia, fu disposto a riconoscere il bambino nato ai primi di gennaio del 1838. Giuseppina fece il suo debutto al Teatro Argentina nel ruolo di Lucia nella Lucia di Lammermoor ed ottenne un successo trionfale. Nello stesso periodo intrattenne una relazione con un altro impresario, Bartolomeo Merelli, che si Giuseppina Strepponi in un ritratto di K. Gyurkovich ed in età matura prodigò per portarla sul palcoscenico della Scala di Milano, per la stagione di primavera del 1839: avrebbe dovuto interpretare il ruolo principale in Oberto, conte di San Bonifacio, la prima opera di Verdi, per cinque rappresentazioni a settimana. Fu durante un breve soggiorno a Milano, dopo aver ottenuto un enorme successo nei Puritani di Bellini e nell’ Elisir d’amore di Donizetti, che fece la conoscenza di Verdi. Lui, giovane provinciale ancora poco inserito nel bel mondo della lirica, non poté che restare folgorato dalla presenza di Giuseppina. Sappiamo che si incontrarono nell’aprile 1839, e che ebbero lunghe e amichevoli conversazioni. Tra i due nacque una relazione che, inizialmente, non andò oltre un’amichevole complicità. Gli anni 1839-40 furono segnati da nuove disavventure. Era una donna straziata e depressa quella che Verdi ritrovò a Milano durante le prime prove di Nabucco, alla fine del dicembre 1841. Entrambi provenivano da esperienze traumatiche con nell’animo ferite difficili da rimarginare. Eppure si riconobbero al primo sguardo: il sentimento di complicità di un tempo era sedimentato e parve essere maturo per la costruzione di quel legame che non terminerà che con la morte di Giuseppina, cinquantasei anni più tardi. Nel frattempo la prima donna doveva ancora dare il suo addio alle scene. Da un controllo medico risultò che, proseguendo con i ritmi della carriera, avrebbe messo a repentaglio la propria vita. Nonostante ciò, cantò con successo la prima assoluta del Nabucco, il 9 marzo 1842 alla Scala di Milano. Giuseppina divenne poi la collaboratrice inseparabile del Maestro, ma il declino della sua voce era ormai in atto e la obbligò a ritirarsi per poi trasferirsi a Parigi. Verdi rimase a Milano fino a giugno del 1847, quando sulla via di Londra si fermò nella capitale francese. Con la sua “Peppina”, Verdi ritrovò una felicità che aveva dimenticato. Lei era affascinante, divertente, sensibile, dotta: era inoltre una splendida linguista, addirittura una «Parisienne parfaite», come disse di lei un editore. La coppia frequentò i salotti più importanti, nei quali il famoso soprano, la cui bellissima voce poteva ancora reggere per un pubblico limitato, interpretava i nuovi pezzi di Verdi, rendendolo ancora più famoso nella società parigina. Un po’ alla volta, però la coppia si ritirò dalla vita pubblica, preferendo la quiete della campagna. Lasciarono la città (come Violetta ed Alfredo) e comprarono un villotto a Passy, per vivere in pace. La coppia tornò in Italia, nel 1849 ed andò ad abitare a Sant’Agata, dove Verdi aveva comprato delle terre. Come gli amanti di Dumas, Verdi e Strepponi furono criticati in modo inflessibile dal punto di vista morale. Quando Giuseppina si trasferì a Busseto si scatenarono le critiche e i pettegolezzi, ma Verdi si preoccupò di chiarire la situazione solamente al suo ex suocero e benefattore Antonio Barezzi. Durante i cinquanta anni di convivenza, tra la tenuta di S. Agata e la residenza invernale di Genova nel Palazzo Sauli Pallavicino, l’amore di Giuseppina rimase sempre un punto fermo. Tra le varie testimonianze in tal senso, si segnala una lettera datata 1860 in cui lei professa tutta l’ammirazione per l’uomo e per il genio Giuseppe Verdi. La loro unione divenne ufficiale il 29 agosto 1859, quando i due si sposarono nella chiesa di Collognes-sous-Saléve, in Savoia, alla presenza del campanaro e del cocchiere, unici testimoni del matrimonio. li. Mag. Il Giornale dei Grandi Eventi dal mondo della musica 15 Dal 26 ottobre la Stagione sinfonica 2013/’14 di Santa Cecilia Opera di Britten per inaugurare, poi un direttore che diventa soprano L a solidità progettuale è la regola sottesa alla programmazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che anche quest’anno, dal 26 ottobre, offre una Stagione di ampio respiro con repertori variegati, affidati a un’Orchestra che, per unicità di suono, duttilità e originalità interpretativa, è oggi considerata tra le migliori del panorama nazionale e internazionale. Una Stagione lunga nove mesi, sulla quale calerà il sipario il 17 giugno 2014. Per l’inaugurazione del 26 ottobre, è stata scelta un’opera Peter Grimes di Benjamin Britten diretta da Antonio Pappano, nel centenario della nascita del compositore inglese. Si tratta di un titolo in un prologo e tre atti, su libretto di Montagu Slater tratto dal poema The Borough di George Crabbe, ovviamente in forma di concerto, continuando così, con un cast eccellente, la fortunata linea dell’Accademia di presentare anche il melodramma a fianco del repertorio sinfonico. Peter Grimes fu rappresentato per la prima volta il 7 giugno 1945 al Sadler’s Wells di Londra, e fu subito un trionfo per il quale Britten non solo diventò improvvisamente famoso, ma venne considerato il nuovo paladino della musica inglese. La rappresentazione del Peter Grimes, in una Londra gravemente ferita dalla guerra, era, infatti, uno sguardo verso il futuro e riposizionava la musica inglese sulla scena internazionale. Nel Peter Grimes Britten esalta la musicalità della lingua inglese e la inserisce in un organico orchestrale ampio e potente, adottando e rinnovando le convenzioni operistiche ottocentesche per raccontare un dramma che contiene in sé la grandezza del mare e la chiusura di un piccolo borgo nel quale si consuma una tragedia che nessuno tenta di impedire. Gli appuntamenti con antonio Pappano – sem- pre sul podio dell’Orchestra e Coro dell’Accademia - saranno caratterizzati, oltreché dalla varietà dei programmi, dalla presenza di solisti d’eccezione tra i quali pure un debutto, quello della giovane violoncellista argentina Sol Gabetta, divenuta una delle più apprezzate interpreti del panorama internazionale e qui impegnata nel Concerto di Elgar. Nello stesso concerto, Pappano leverà la bacchetta su Gli occhi che si fermano, intensa pagina del compositore contemporaneo Francesco Antonioni. Di particolare interesse i programmi dei due concerti di dicembre. Oltre ad accogliere due solisti del calibro di Leonidas Kavakos nel primo e Radu Lupu (al pianoforte per il Concerto n. 23 K 488 di Mozart) nel secondo, essi prevedono un omaggio a Brahms con il Concerto per violino e la Sinfonia n. 1, un’incursione di Pappano nel ‘900 italiano con l’Elegia di Ponchielli e il Magnificat di Petrassi e infine Britten con l’esecuzione della sua Sinfonia da Requiem. Ancora Brahms nel concerto di gennaio. Questa volta Pappano dedica il suo gesto alla Sinfonia n. 2 che segue al Concerto per pianoforte n. 2 di Prokof’ev, interpretato dalla giovane Yuja Wang che idealmente passa la staffetta a Lang Lang nel concerto di marzo in cui l’altrettanto straordinario pianista si farà interprete del Concerto n. 3 del compositore russo. In apertura un omaggio a Meyerbeer di cui nel 2014 ricorrono i 150 anni dalla morte, l’Ouverture dell’opera Dinorah. Dopo il successo incondizionato della Passione secondo Matteo, Pappano continua il suo percorso nell’amatissima musica di Bach con la direzione della Messa in si minore. Ultimo appuntamento con il direttore anglo-italiano ad aprile: ancora Dallapiccola con Il Prigioniero, Beethoven con “Gott! Welch Dunkelhier!” dal Fidelio e con il terzo e quarto movimento della Sinfonia n. 9. direttori: ritorni celebri e debutti importanti Santa Cecilia è divenuta ribalta importantissima per le nuove generazioni di direttori, che anche quest’anno guideranno l’Orchestra e il Coro. La nuova stagione, accanto ai “giovani podi”, riserva una particolare attenzione al gotha della scena direttoriale mondiale allineando i nomi di Claudio Abbado (che sarà presente due volte), Kent Nagano, Lorin Maazel, Valery Gergiev, Ton Koopman, Yuri Temirkanov, Semyon Bychkov, Fabio Luisi, per citarne solo alcuni. claudio abbado, quindi, torna sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart per di- rigere a novembre la Sinfonia n. 2 di Beethoven e la Sinfonia n. 2 di Mendelssohn “Lobgesang” nell’interpretazione di Sara Mingardo, Julia Kleiter e Maximilian Schmitt e a febbraio per un programma dedicato alle musiche di Haydn, Mozart e Mendelssohn. A dicembre a dirigere sarà Kent nagano per la Sinfonia n. 3 di Bruckner, anticipata dal mozartiano Concerto per pianoforte n. 24 K 241 nell’interpretazione del giovane Rafal Blechacz. Sempre per i “grandi podi” a gennaio tornano Georges Prêtre e lorin Maazel seguiti a febbraio da valery Gergiev con la Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di Mahler. Ad aprile, per due settimane, Yuri Temirkanov sarà a Santa Cecilia per dirigere il grande repertorio russo: Rimskij-Korsakov, Musor- gskij, Brahms del quale, inoltre, Rudolf Buchbinder sarà interprete del Concerto n. 2 per pianoforte. Per i debutti, a novembre il podio sarà al femminile e di assoluta originalità: è un soprano, canadese, acclamata sulle più importanti ribalte internazionali, già diretta dai maggiori Maestri, e direttore anche lei: è l’avvenente barbara Hannigan che tra la direzione di rossini, ligeti, Fauré, Mozart, con un scenderà dal podio e vestirà i panni di soprano, non tralasciando la bacchetta. Infine, una nota per il pubblico: a partire da questa stagione i concerti del lunedì (Turno B di abbonamento), avranno inizio alle ore 20.30 (con un anticipo, quindi, di mezz’ora rispetto alle stagioni precedenti). lo. di di. Novità in libreria La Strenna dei Romanisti al suo 74° volume N ell'ultimo numero, fra gli argomenti relativi alla musica spicca il saggio con un confronto fra Wagner e Verdi, coetanei così diversi, attraverso la lettura dei diari di Cosima Wagner e gli scritti di Giuseppe Verdi, dai quali si può comprendere il giudizio che avevano l'uno dell'altro. Ma c’è anche, in pagine diverse, un’altra analisi dei personaggi e momenti della rinascente vita musicale romana dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono due dei 47 saggi dell’edizione n° 74 della Strenna dei Romanisti, quella del 2013 uscita tradizionalmente nel giorno del Natale di Roma, pubblicazione che racchiude dal 1940 annualmente, una raccolta di saggi inediti sulla Città Eterna, sulla sua cultura, sulle sue tradizioni, con curiosità, spigolature, approfondimenti ed è l’espressione di quel gruppo dei Romanisti, massimo cenacolo di studiosi e cultori di Roma, di cui diversi membri sono nostri insigni collaboratori. Molto affascinante, in tutti gli articoli, visitare le opere dei grandi artisti del passato, collocandone la creazione in una attualità storica. Così nel saggio su Verdi e Wagner, l'autore trae spunto da Roma come argomento centrale delle ambientazioni e cita l'opera Rienzi del compositore tedesco, storia del tribuno romano nel medioevo e della volontà di Verdi di realizzare un melodramma con lo stesso soggetto a distanza di pochi anni. Ma l’excursus romanistico guarda a tutto tondo ed ecco che solletica la curiosità l’approfondimento sul piccolo album da tasca di Bartolomeo Pinelli, appena ritrovato, in cui spicca la spontaneità di tanti minuscoli disegni, ma pure uno sguardo sugli ultimi anni di vita del “Sor Meo”, il Pittore di Trastevere. Così anche, in altro saggio, si indaga su Emilio Stramucci, architetto romano arbitrum elegantiarum nei Palazzi Reali d’Italia. Non possono mancare, ovviamente, sguardi alla realtà e storia d’Oltretevere, visto che il Vaticano da due millenni è aspetto fondamentale della Città. Interessante la spigolatura, emersa dalle carte dell’Archivio segreto vaticano, i cui addetti si sono trovati ad un faccia a faccia documentaristico con Napoleone Bonaparte. Insomma, saggi vari ed eclettici, per un volume da tenere a portata di mano per rapide, interessanti e rilassanti letture, prima di porlo ordinatamente in libreria a formare una vera enciclopedia della romanità a tutto tondo. La Strenna dei Romanisti – Pag. 630 + 8 tavole f.t. a colori. rilegata - Editore romaamor 1980 - € 44,00. Tina alfieri
Scarica