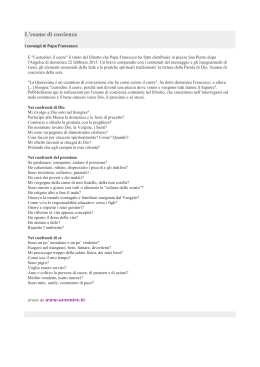Domenica La di DOMENICA 18 APRILE 2010/NUMERO 272 Repubblica la memoria Cina, gli anni terribili della Rieducazione RENATA PISU cultura Lo humor nero di Edward Gorey PAOLO MAURI PACO TAIBO II L’altro Che FOTO ROBERT VAN DER HILST/CORBIS Un grande romanziere racconta un rivoluzionario carismatico e sconosciuto: Tony Guiteras, che incendiò Cuba negli anni Trenta PACO IGNACIO TAIBO II OMERO CIAI o detto chissà quante volte in conversazioni con amici, giornalisti, editori, che le tre figure rivoluzionarie dell’America Latina che più mi affascinavano erano Pancho Villa, Che Guevara e Tony Guiteras. Quasi sempre mi sono sentito chiedere «Tony chi?». E ogni volta cresceva la mia volontà di scrivere questo libro. Purtroppo, al di fuori di Cuba, trattato unicamente dalla storiografia nazionale che si occupa della rivoluzione e dell’esilio, Tony rimane uno sconosciuto. Ma un personaggio simile, in un continente come il nostro, che lotta per recuperare la propria memoria storica, non merita questo destino. *** Lo spagnolo è una lingua perversa che usa parole come gracia per riferirsi indistintamente a uno stato di santità o a uno scherzo; e parole come materialista per parlare di un autocarro da trasporto merci o di un seguace di Friedrich Engels. (segue nelle pagine successive) l primorivoluzionario di Cuba fu un indio e veniva da Haiti (allora Hispaniola). Si chiamava Hatuey e guidò a Baracoa la rivolta contro l’invasione degli spagnoli. I soldati di Diego Velazquez, il capo dei conquistatori, lo inseguirono sulla Sierra Maestra, lo catturarono e lo bruciarono vivo. Era il 1512, vent’anni dopo l’approdo delle caravelle di Colombo. La conquista di Cuba non fu un affare per gli spagnoli finché non scoprirono le ricchezze dello zucchero, del tabacco e del caffè. Tanto che nel corso del Cinquecento l’assenza di oro e altri metalli preziosi spinse i conquistatori altrove. Decisiva però fu sempre la sua posizione strategica, come ultima postazione prima di affrontare la traversata dell’Oceano con i pregiati minerali sottratti al Messico o al Perù da portare in Europa. Da quel momento in poi Cuba, tra eserciti invasori, pirati e rivolte di schiavi, fu una autentica fabbrica di rivoluzionari. (segue nelle pagine successive) H I spettacoli Jerry Lee Lewis, il “killer” del rock GINO CASTALDO i sapori Africa-Francia, la fusion di Marrakech DARIA GALATERIA e LICIA GRANELLO l’incontro Jeremy Irons, il bello di fare il cattivo ANTONIO MONDA Repubblica Nazionale 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina L’altro Che DOMENICA 18 APRILE 2010 Sostiene Paco Ignacio Taibo II che i grandi rivoluzionari latino-americani del Novecento sono tre: Pancho Villa, Che Guevara e Tony Guiteras, protagonista della spallata popolare che nel 1933 rovesciò il dittatore cubano Machado. Ora il grande romanziere completa il suo ciclo e racconta Guiteras in un libro che qui anticipa per “Repubblica” PACO IGNACIO TAIBO II (segue dalla copertina) l termine guapo a Cuba significa audace, come del resto in Venezuela. Mentre in Spagna e in Messico (meno e ormai in disuso) si riferisce alla bellezza maschile. Nella zona costiera della Colombia è sinonimo di buono, benevolo, bonaccione. In Argentina rispetto alla versione cubana si aggiunge la valenza di forte, resistente; e in posti come Salta, ponerse guapo significa riprendersi da una malattia. Ma usato per definire Tony Guiteras guapo recupera tutte queste accezioni. *** Alla fine degli anni Venti, si instaurò a Cuba una dittatura capeggiata da Gerardo Machado. La tardiva indipendenza cubana (fu l’ultima dell’America Latina) e l’intervento nordamericano avevano imposto al Paese un’immensa dipendenza dai gringos, espressa dall’Emendamento Platt che permetteva l’ingerenza statunitense nella vita pubblica del Paese fino a prevedere invasioni militari. Machado rinforzò sempre più questa relazione, unita a una potente dose di corruzione. Nel 1927 si sarebbe dichiarato ammiratore di Mussolini («L’opera di Benito Mussolini è di eccezionale importanza. Guida l’Italia sul cammino del progresso in ogni campo») e avrebbe sostenuto: «Gli unici a lamentarsi della situazione sono i biscazzieri e i vagabondi». Curiosa interpretazione della realtà cubana, perché a Cuba i giocatori d’azzardo non si lamentavano di nulla, vivevano come al solito in quella combinazione di paradiso e inferno in cui sono soliti vivere. Comunque, una manifestazione di disoccupati avrebbe innalzato questo striscione: «Generale, i biscazzieri e i vagabondi ti salutano». Fu un movimento studentesco, nel quale apparvero per la prima volta le donne, ad affrontarlo. Per cinque anni, prima nelle strade e poi rispondendo alla violenza crescente della polizia con la violenza. Anni terribili. Nel 1933 uno sciopero generale dei lavoratori lo rovesciò. L’ambasciatore americano cercò di sostituire Machado I La storia di un ambasciatore Usa democratico e liberale alleato con latifondisti, sergenti golpisti CHE GUEVARA Icona della rivoluzione cubana del 1959 Fu ucciso mentre combatteva in Bolivia il 9 ottobre 1967 TONY GUITERAS Padre della rivoluzione cubana del 1933 Fu ucciso nel 1935, nella provincia di Matanzas e generali conservatori per salvare un tiranno sanguinario con una figura fantoccio, ma il movimento prese la forma di un’insurrezione dei sottufficiali e portò al potere un medico e docente universitario, Grau San Martín, e come segretario al Governo uno studente della sinistra radicale, Tony Guiteras. Per cento giorni il Paese visse la rivoluzione. Ci fu poi un contro golpe e due anni di una nuova dittatura filostatunitense che uno sciopero generale nel 1935 tentò di rovesciare. *** In questo contesto, questa sarà la storia di molti personaggi straordinari. Tony Guiteras, un adolescente che affrontava la malattia con la forza di volontà, uno studente di farmacia al quale piacevano le piante curative, un leader studentesco che si giocava la vita tutti i giorni, un rivoluzionario che, assunto l’incarico di ministro degli Interni, espropriò le imprese dell’energia elettrica statunitensi a colpi di decreti e in punta di pistola, promulgò la legge sul salario minimo, sulla giornata lavorativa di otto ore, che cercò di togliere i cimiteri dal controllo della Chiesa e che nominò le prime donne sindaco dell’America Latina; uno a cui piaceva farsi fotografare accanto a due donne bellissime, ma che raramente sorrideva; che si sedeva sul pavimento come un Budda e fumava sigarette accendendole con il mozzicone di quella precedente; uno così puro ideologicamente che suscitava l’amore incondizionato degli amici e un brivido nella schiena dei nemici. Un uomo che fece una lettura non bolscevica della Rivoluzione russa e mescolò le lezioni di Bakunin e di Durruti alla logica dei socialdemocratici adleriani e agli insegnamenti dello Stalin-Kamo espropriatore. Ma questa è anche la storia di un ambasciatore statunitense che voleva dominare un Paese che non era il suo. Da buon democratico liberale newyorchese non poté evitare di salvare la pelle a un dittatore sanguinario, di allearsi con terroristi, filofascisti, latifondisti della canna da zucchero, generali conservatori e sergenti golpisti; perché era un uomo dell’impero e governato dalla logica imperiale. Che spostava trenta navi da guerra con duecento cannoni mentre si dannava l’anima; uno che per la smania di dimostrare la propria intelligenza, posseduto dalla brama di controllare e cospirare, finì per diventare machiavellico. Fanno parte di questa storia anche un sergente stenografo, buon lettore di libri non molto buoni e accanito RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA Poeta, malato di tisi, partecipò attivamente alla rivoluzione del ’33 nonostante la malattia PABLO DE LA TORRIENTE Scrittore in lotta contro il dittatore cubano Machado, fu incarcerato e poi esiliato. Partirà per la Spagna nel ’33 CUBA La rivoluzione guapa compratore di biglietti della lotteria, che nel giro di poche ore diventò colonnello; al quale una volta avevano negato l’accesso nello Yachting Club de L’Avana perché si diceva avesse nelle vene sangue cinese, indio e africano; che senza quasi rendersene conto scalò le vette del potere assoluto in nome di una rivoluzione che non era più tale finendo per macchiarsi le mani con il sangue. In primo piano, c’è senza dubbio un giovane avvocato dirigente comunista. Pur essendo pervaso dal settarismo stalinista, in fondo all’anima e a fior di pelle era un grande poeta e sarebbe morto precocemente di tubercolosi. Un uomo votato con fedeltà assoluta a una sola causa e ai suoi principi, alla guida di un gruppo di eroici e generosi operai pericolosamente in possesso della verità rivoluzionaria. Personaggi a metà strada fra la tragedia byroniana e il realismo socialista. E ci sono altri personaggi singolari, come uno scrittore di nome Pablo, forse uno dei migliori giornalisti dell’America Latina, preso dalla passione di vivere la storia per raccontare storie, e che passò buona parte della giovinezza in carcere e in esilio e che era talmente cubano da farsi scendere le lacrime nella nebbia di New York. E con loro c’è un presidente che avrebbe potuto perdere tutto a causa di uno scherzo, ma che neppure rinunciava a farne; un paio di avvocati aristocratici che inventarono un movimento civico terrorista di destra; un dittatore butterato dal vaiolo che chiamavano “l’asino con gli artigli”; un torturatore che trasformò la polizia di Santiago de Cuba nel suo strumento privato di lucro e di terrore; un venezuelano che partecipò a tutte le rivoluzioni; una cubano-irlandese dai capelli rossi che sequestrava milionari con un mitra in mano. Una storia che si svolse a Cuba. Con il 1933 come asse portante, l’anno della Revolución: suffragiste, studenti bombaroli, scioperi generali, allusioni a Lindbergh, Mussolini e King Kong, orchestre femminili, locali a luci rosse incendiati, torturatori impazziti, masse insorte alla maniera di Fuenteovejuna, marines statunitensi nel porto de L’Avana. Con tanto materiale c’era da scrivere un romanzo, ma ne è venuta fuori una storia narrata. *** Il miglior prologo a questa storia lo avrebbe scritto Pablo de la Torrente Brau a New York qualche mese dopo la morte di Guiteras; e lo avrebbe fatto nonostante le diffe- LE IMMAGINI Sopra, scene di guerriglia a Cuba negli anni ’30 A destra, la tessera di Guiteras Sotto, il capo dell’esercito Fulgencio Batista Repubblica Nazionale DOMENICA 18 APRILE 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 IL LIBRO Un hombre guapo, la biografia del rivoluzionario cubano Tony Guiteras scritta da Paco Ignacio Taibo II, sarà in libreria dal 22 aprile (Marco Tropea Editore, traduzione di Pino Cacucci, 384 pagine, 19,50 euro) Di Taibo II, autore di una cinquantina di opere tradotte in venti paesi, Marco Tropea Editore pubblicherà nel 2011, per le celebrazioni salgariane, il romanzo Ritornano le Tigri della Malesia (più antimperialiste che mai) GERARDO MACHADO Quinto presidente di Cuba, il suo governo reazionario fu rovesciato dalla rivolta guidata da Guiteras Dittature e rivolte dell’isola bipartisan OMERO CIAI (segue dalla copertina) l culmine furono gli ultimi cinquant’anni dell’Ottocento, tra le guerre d’indipendenza dalla Corona spagnola e l’intervento degli Stati Uniti. Da Manuel de Cespedes a José Martì. La liberazione dell’isola dal giogo straniero inizia con la “guerra dei dieci anni” nel 1868, quando i proprietari terrieri bianchi si alleano con i neri (sia schiavi che liberti) — i famosi mambì — contro gli spagnoli, e finisce con lo sbarco dei volontari Usa, tra i quali c’era anche il futuro presidente Roosevelt, il primo luglio del 1898. Una sovranità condizionata, quella di Cuba, prima dall’occupazione americana che durò quattro anni e poi dall’emendamento Platt, pietra miliare di tutti i guai successivi, che consentiva a Washington di intervenire pesantemente nella politica interna dell’isola. La storia cubana del Novecento si può anche leggere come un succedersi di dittature, rivoluzioni e repubbliche che hanno sempre come punto di snodo i rapporti dell’isola con la Casa Bianca. Filo americani o anti americani. Sempre e comunque. Non solo, spesso gli Stati Uniti hanno prima aiutato i dittatori a prendere il potere e poi i rivoluzionari a toglierglielo. È il caso di Gerardo Machado che cadde, con la rivoluzione del ‘33 (quella di cui fu protagonista anche Tony Guiteras), proprio grazie al fatto che Washington lo costrinse ad accomodarsi in esilio. Copione non molto diverso da quello del 1959, quando Batista, perso l’appoggio degli uomini di Eisenhower, fuggì in Florida lasciando l’Avana ai barbudosche avevano iniziato la guerriglia anche grazie a dollari e armi americane. La rivoluzione di Guiteras e Grau San Martin durò poco più di cento giorni e dovette soccombere proprio per le ingerenze Usa dopo che il nuovo governo si era rifiutato di pagare i debiti di Machado ed aveva iniziato a nazionalizzare le imprese americane. Sembra il preludio di quello che accadrà con Fidel Castro, come se la rivoluzione del ‘33 a Cuba corrispondesse a quella russa del 1905. Fu il nazionalismo radicale la ragione per cui caddero Grau e Guiteras. Ma contro di loro, insieme agli Usa, c’erano anche gli immigrati spagnoli più recenti e i neri degli altri paesi dei Caraibi colpiti da un decreto che imponeva alle imprese di assumere per primi solo i nati a Cuba. Nell’ultimo mezzo secolo, l’isola delle rivolte e dei rivoluzionari ha vissuto la dittatura più lunga, figlia di una ennesima rivoluzione. E un motivo che può spiegare la sua longevità sta proprio nel nazionalismo. La rivoluzione guidata da Castro è stata molto più nazionalista che socialista — come dimostra ancora oggi il modo in cui il regime si chiude su se stesso quando viene criticato e come esalta la “diversità” cubana. Un’altra spiegazione sono le valvole di sfogo. L’area grigia di scontenti e oppositori ha abbandonato l’isola in massa con grandi esodi successivi (1960, ‘80, ‘94). Così, a partire dal ‘59, intellettuali critici, studenti ribelli e professionisti scontenti, invece di fabbricare nuove rivolte, se ne sono semplicemente andati. I © RIPRODUZIONE RISERVATA FULGENCIO BATISTA Capo dell’esercito dopo la caduta di Machado Diventa presidente di Cuba nel 1952. Sarà rovesciato nel 1959 renze di scelte politiche e l’involontaria distanza. «Nella sua appassionante carriera politica ci sono pagine allettanti per uno storico coraggioso disposto a raccontare la verità e insieme l’angoscia di un uomo onesto giunto al crocevia di tremendi dilemmi [...] Antonio Guiteras, come uno che sopravvive a un’imboscata, attraversò quei momenti, sentendosene oppresso, ma fermo nella propria fede, in preda alla febbre della rivoluzione. Perché la rivoluzione fu come una febbre nell’immaginazione di quest’uomo. E per questo visse terribili deliri, potenti allucinazioni, affascinanti fantasie e sogni meravigliosi e per lui irrealizzabili. Era come un uomo che, al risveglio, voglia realizzare ciò che ha concepito in sogno. Spesso non seppe riconoscere gli uomini, dando fiducia a chi non la meritava e chiamando amico chi si sarebbe rivelato un traditore, ma intuì il talento in qualche idiota. Trascinato dalla febbre, ebbe l’impulso di fare tutto. E fece più lui che migliaia di altri. E serbava il segreto della fede nella vittoria finale. Irradiava calore. Era come una calamita che attirava gli uomini e gli uomini si sentivano attratti da lui. Per loro era misteriosa, ma irresistibile, quella silenziosa determinazione, quell’immaginazione fissa su un solo punto: la rivoluzione. Ebbe anche difetti. Nel giorno del castigo non avrebbe concepito il perdono. Era un uomo della rivoluzione. E anche lui non aveva nulla di perfetto». *** Questo è un libro complesso, troppi personaggi, troppe storie, troppe forze sociali in azione; ma la complessità non solo è attraente e affascinante, è anche molto più vicina alla realtà di quei materiali semplificati che ci hanno spacciato per storia. La complessità induce ad amori contrastanti, a riflessioni più lucide e meno facili. Raccontare di uomini d’azione è essenzialmente un compito di ricerca sugli eventi, il contesto, le interazioni e, solo a quel punto, le riflessioni che si facevano al riguardo e il modo in cui si pensava di loro. Come dice Martínez Heredia: «La storia che si limita a osservare le organizzazioni politiche attraverso gli atti e le dichiarazioni è cieca e viene a patti con i fantasmi». *** Un uomo votato a una sola causa alla guida di un gruppo di operai in possesso della verità ribelle A metà strada tra la tragedia byroniana e il realismo socialista RAMÓN GRAU SAN MARTÍN Dopo la rivoluzione del 1933, diventa presidente della repubblica cubana FIDEL CASTRO Lider maximo cubano dal febbraio 1959 al febbraio 2008. È stato sostituito dal fratello Raúl Castro Ho cercato di situare i personaggi nel loro presente, gli eventi accaduti tra il 1930 e il 1935, e in parte gli antecedenti. Quello che poi sarebbe stato della storia di Cuba fu fatto dopo, e guardare il passato dal futuro provoca nel migliore dei casi una distorsione a discapito della genuinità. Su questo aspetto particolare, la rivoluzione cubana del gennaio 1959 con le sue conseguenze impone senza volerlo sfumature che deformano la storia della rivoluzione del 1933. I personaggi sopravvissuti verrebbero giudicati per come si sono comportati di fronte alla grande spaccatura sociale del ‘59, e non solo per le azioni compiute nel ‘33. Da L’Avana e da Miami la storia della rivoluzione del ‘33 è stata letta come un prolungamento della polemica tra castrismo e dissidenti reazionari, liberali filoimperialisti, anarchici, socialdemocratici. Accadrà lo stesso con le figure dei morti. Quasi tutti subiranno aggiustamenti storici in funzione di un’altra polemica. Ho cercato di raccontare le storie della rivoluzione del ‘33 all’interno della loro prospettiva, con i miei amori e le mie simpatie, ma senza alcuna autocensura e calandole nel contesto degli anni Trenta; che gli uni e gli altri mi perdonino, compresi i guardiani delle ortodossie, coloro che vigilano sulle dottrine del passato, ai quali questo libro non piacerà. *** Il dio del politicamente corretto mi scampi dal far parte del suo club, ma nel tracciare i personaggi le questioni legate alla loro vita sessuale sono essenziali, e mi è sembrato giusto invaderla; tra l’altro perché la forzata clandestinità dell’omosessualità, ancor più nella Cuba machista degli anni Trenta, e peggio ancora se eri un diplomatico o un presidente, creava una particolare tensione nei personaggi e nella storia. Nel tentativo di raccontare questo assunto spinoso, mi sono imbattuto in denigrazioni ingiuriose, disinformazione, voci che possono ricondursi a calunnie e a fervente puritanesimo, figlio più di una doppia morale che di una presunta rettitudine. *** Un libro di storia è, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, una versione assolutamente non definitiva degli avvenimenti. Un’altra tessera del grande mosaico. Traduzione di Pino Cacucci © Paco Ignacio Taibo II © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 18 APRILE 2010 la memoria Persecuzioni Siamo negli anni Sessanta, nella Cina della Rivoluzione culturale. Kang Zhengguo, come tanti intellettuali, viene condannato a “trasformarsi con il lavoro”. Ora, in un libro in uscita per Laterza, racconta la sua odissea: una storia esemplare tra le altre, come testimonia una giornalista-scrittrice italiana che ha vissuto quella terribile stagione Rieducazione, le vite a perdere RENATA PISU o conosciutotanti ragazzi come Kang Zhengguo quando, negli anni Cinquanta e Sessanta, studiavo all’Università di Pechino. Erano miei amici, era facile comunicare con i cinesi allora, prima che la Rivoluzione culturale, nel 1966, troncasse ogni possibilità di confronto tra Noi e Loro. Quei ragazzi e quelle ragazze avevano tutti delle storie da raccontare, storie della loro infanzia e delle loro speranze, deluse al punto che erano diventati increduli e scettici sulla futura umanità che gli era stata promessa. Mi raccontavano le loro giovani storie del passato mentre vivevamo assieme un assurdo presente, episodi dei quali ero a volte testimone, a volte involontaria catalizzatrice. Frequentarmi era proibito in quanto venivo da un paese capitalista e quindi propagavo germi. Chi osava frequentarmi lo faceva a proprio rischio e pericolo. Ne fece le spese, per esempio, Wang Zhangmei alla quale avevo regalato una mia giacca imbottita con una manica bruciacchiata. Per riscaldarmi mi ero accostata troppo al fornelletto elettrico che tenevo in camera e con me c’erano due amici cinesi che risero del mio infortunio. Quando però riconobbero come mia quella giacca con la bruciatura indossata dalla loro compagna di corso, la denunciarono alla sezione universitaria del partito. Zhangmei, che era già in odore di dissidenza, fu mandata poco dopo a «trasformarsi con il lavoro». Non l’ho più vista e non ho più saputo niente di lei. Non ha scritto la sua storia come ha fatto Zhengguo, ma tutte le storie degli studenti cinesi di quegli anni per molti versi si assomigliano per il fatto di essersi svolte sotto il segno delle varie campagne di critica o di educazione di massa che si sono succedute come ondate fino al punto di far perdere la testa, di ridurre al silenzio i testimoni, di creare alla fine una connivenza tra carnefici e vittime. E questa connivenza ancora è di ostacolo oggi, in Cina, al libero fluire della narrazione di quegli anni che non furono, come qualcuno sostiene, «grandi e terribili» ma soltanto terribili. Ricordo una ragazza che studiava lingua e letteratura tedesca. Si chiamava Huang Hua. Era alta, con delle lunghe trecce e una naturale eleganza di portamento che nemmeno la più proletaria giacca blu riusciva a mascherare. Era in corso la campagna contro gli sprechi e ovunque, all’Università come in città, campeggiavano grandi cartelli con su scritto «Non sprecare nemmeno un chicco di riso». Lei venne accusata, in un’assemblea della sua facoltà, di voler «affamare il popolo», perché le compagne di stanza, rovistando nel suo cassetto, avevano trovato dei mantou, che sarebbero dei pani cotti a vapore, rinsecchiti. Lei si giustificò dicendo che li aveva conservati per portarli a una povera vecchia che elemosinava fuori dalle mura dell’Università. La seduta di critica era gremita da almeno due-trecento ragazzi che urlavano in preda a un’esaltazio- H ne allora per me incomprensibile. Era la prima volta che assistevo a un simile spettacolo. Poi capii che in simili occasioni bisognava che tutti si comportassero così, altrimenti sarebbero stati incolpati di simpatizzare per l’accusato di turno. Non erano in preda alla furia, recitavano. Avevano fatto salire Huang Hua in piedi su di una panca con indosso una specie di collana fatta con i suoi vecchi mantou. Le gridavano: «Abbassa la testa!», «Confessa!». Lei non riusciva a parlare, singhiozzava disperata. Un ragazzo le si scagliò addosso e le premette una mano sulla nuca obbligandola ad abbassare la testa, a sottomettersi. Due giorni dopo quella ragazza si gettò dal quarto piano del suo dormitorio e morì sul colpo. Non ha scritto la sua storia, non ha avuto abbastanza anni per soffrire e raccontare la sua vita. Di un’altra ragazza, la chiamerò Anne, ho invece seguito le vicende, dai giorni dell’Università a oggi. Venne accusata di essere un «elemento di destra» perché, alla trasmittente del campus dove prestava servizio volontario, lesse i comuni- Regalai una giacca vecchia alla mia amica Wang. Fu denunciata per il ragazzo che aveva affidato alle cure di sua madre. Anne era a Parigi quando, nel 1989, scoppiarono i fatti di Tiananmen, e suo figlio, a Pechino, era sceso in piazza con gli altri ragazzi. Fu arrestato, costretto a sconfessare sua madre, a rinnegarla perché tramava all’estero contro la Repubblica popolare cinese. La sconfessò, la ripudiò. Ora è un imprenditore di successo, uno dei milionari della nuova Cina. Me lo ha raccontato Anne pochi mesi fa. Le ho chiesto perché mai non andasse a trovarlo. E lei: «Neanche pensarci, non mi fido, non mi fido». Anne non aveva ancora ottenuto la cittadinanza francese e non si fidava. Non avrebbe dovuto fidarsi nemmeno il nostro autore quando nel 2001 tornò in Cina con il suo passaporto cinese e ripiombò in un mondo di sospetto e delazioni che credeva scomparso. In Cina nessuno ancora si fida, chi ha sofferto teme il ritorno dell’epoca delle ombre, delle umiliazioni, delle amicizie negate. Ma tutti quelli che hanno più di cinquanta, sessanta anni, avrebbero delle storie da raccontare, non storie estreme ma della loro quotidianità tanto segnata dagli eventi di una politica omnipervasiva. Se non lo fanno è perché ancora hanno paura. Preferiscono allora affidare la memoria alle immagini, alle foto di famiglia, piccole istantanee in Huang fu umiliata in un “processo” pubblico per aver sprecato del pane Due giorni dopo si gettò dal quarto piano bianco e nero con brevi ma intense didascalie che pubblica, dal 1996, una rivista che si chiama Vecchie foto. Immagini in bianco e nero accompagnate da semplici didascalie, storie tragiche di vita che riportano alla memoria collettiva il passato, meglio forse di tanta narrativa contemporanea in cui la fantasia non riesce a superare la crudezza della realtà, quel vivere giorno per giorno nell’assurdo ed essere costretti a farsene complici. La memoria, in una società che sta subendo una grande mutazione e cioè non è più formata da persone che agiscono in un contesto comunitario e pubblico ma piuttosto familiare e privato, se non addirittura individuale, non è più ancorata come una volta a testimonianze e biografie di grandi uomini che hanno fatto la storia. La gente si sta riappropriando delle proprie storie minime, e sente il bisogno di rivalutare la propria apparizione sulla scena con immagini sbiadite di luoghi, di persone, di interni di famiglia o di foto di gruppo degli studenti di una scuola o degli operai di una fabbrica [...]. È un passato privatizzato, non quello per questo e mandata via dall’Università Non l’ho mai più vista cati «anti-partito» che le passavano studenti e insegnanti. Era l’inizio della «campagna dei Cento fiori», lanciata dal partito per sollecitare critiche e idee nuove: «Fioriscano cento fiori. Gareggino cento scuole!». «Non capivo neanche il senso dei testi che mi davano da leggere ma ero molto orgogliosa di essere stata scelta per la mia ottima pronuncia», mi disse Anne. Solo che quando, per controbattere le critiche che erano piovute sul partito e i suoi burocrati, venne lanciata la campagna contro gli elementi di destra, ad Anne venne messo in testa il cappello (si diceva così allora, il cappello da destrorso) e fu mandata a «lavarsi il cervello» in una vetreria. Persi completamente ogni sua traccia fino a quando, morto Mao e salito Deng Xiaoping al potere, venni a sapere da amici francesi che era riuscita a raggiungere Parigi con un visto di studio. La rintracciai, ci incontrammo in Francia e a lei pareva di sognare. Anche a me. Eravamo ormai delle quarantenni con dei ricordi. Anne mi raccontò la sua storia: cinque anni in fabbrica, alla vetreria, due anni rinchiusa in una «gabbia di demoni e mostri», un marito defunto, un figlio che aveva abbandonato per poter «uscire dal paese», ma al quale continuava a scrivere tutti i giorni, o quasi. Anne era sincera, amava suo figlio, ma non era disposta a dare la sua vita, quella vita parigina da badante (era il suo primo impiego), Repubblica Nazionale DOMENICA 18 APRILE 2010 ‘‘ Mao Zedong L’arte per l’arte, l’arte al di sopra delle classi, l’arte al di fuori della politica e indipendente da essa in realtà non esiste LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 ‘‘ Noi esigiamo unità tra politica e arte, unità tra contenuto politico rivoluzionario e una forma artistica il più possibile perfetta ‘‘ La rivoluzione non è un’opera letteraria, un disegno, un ricamo... È un’insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un’altra Le citazioni sono tratte dal LIBRETTO ROSSO che è stato imposto ma quello che è stato vissuto, e si scopre che ognuno l’ha vissuto a modo proprio, anche se la grande livella del Potere ha sempre tentato di ridurlo allo stesso denominatore: la lotta di classe, la grande causa della rivoluzione, le campagne e i movimenti di massa. La ragazza con le trecce e il viso pulito, i pantaloni larghi e la camicetta bianca a maniche corte che sorride sotto un cartello con la scritta «Grande balzo in avanti» è stata fotografata nel 1958 dall’uomo che sarebbe poi diventato suo marito. Nel breve testo che accompagna l’immagine, la donna, ormai settantenne, propone il ritratto del suo bambino e racconta come il padre non l’abbia mai visto perché, prima che il piccolo nascesse, «andò volontario nel Xinjiang a imparare dai contadini» e non fece mai ritorno a Pechino. Non traspare nessun giudizio politico, nessuna recriminazione, soltanto il desiderio che di quel marito e padre svanito nel nulla rimanga una traccia di ricordo anche se di lui non è rimasta neanche un’istantanea. Tante sono le immagini di gruppi familiari, come se l’antica tradizione che glorificava le leggende e le storie degli avi rispuntasse in tono minore su queste pagine, dove gente che non ha legami di sangue con coloro che sono ritratti si riconosce tuttavia in particolari che accomunano, per esempio, quelli che vivevano in una casa a corte: l’arredo della stanza della famiglia che si è messa in posa in quel lontano giorno degli anni Quaranta assomiglia a quello di tante altre, con l’orologio a pendolo in bella mostra su di una consolle, l’ultimo nato in grembo alla madre avvolto in una coperta imbottita a fiori, il nonno con la corta pipetta in mano, la nonna con i piedi minuscoli che tenta di nascondere ripiegandoli sotto lo sgabello e non accenna nemmeno un vago sorriso. Numerose anche le foto di classi scolastiche alla fine dell’anno di corso, gli insegnanti seduti in prima fila, dietro gli studenti, ragazzi e ragazze, vestiti tutti uguali ma non in uniforme: nella Cina degli anni Sessanta, dove il tessuto di cotone era razionato, non ci si poteva per- IL LIBRO Laterza manda in libreria Esercizi di rieducazione (traduzione di Serena Zuccheri, 488 pagine, 22 euro). L’autore, Kang Zhengguo, bollato come criminale nella Cina di Mao, racconta il suo percorso di rieducazione negli anni in cui anche appassionarsi alla poesia era considerato reato. Anticipiamo la prefazione di Renata Pisu mettere di pretendere altra uniformità oltre quella imposta dalla penuria. E così tutti con gli stessi pantaloni, le stesse giacche imbottite di colore blu. Nel testo che accompagna una di queste foto di classe, inviata da un uomo che specifica di essere il terzo, a partire da destra, della seconda fila, si dice soltanto che l’immagine è stata scattata nel luglio del 1966, nella Scuola superiore Numero Due di Pechino, e che loro speravano tutti di andare all’Università ma nessuno vi riuscì; e tutti i cinesi sanno perché, di lì a poco sarebbe divampata la Grande rivoluzione culturale proletaria. Anche Kang Zhengguo, che si presume si sia liberato da ogni remora grazie a una drastica scelta di vita, a commento delle pagine della sua biografia inserisce delle vecchie foto di famiglia, come se sentisse la necessità di chiamare a testimoni quei volti e quei luoghi, per comunicare un di più, il non-dicibile [...]. È doloroso per un cinese smettere di essere tale, ci sono cose profondamente connaturate alla sua cultura. Il nome, per esempio, sempre prima il nome di famiglia (Kang, nel caso del nostro autore) seguito dal nome proprio, Zhengguo. È costretto a rinunciarvi una prima volta quando accetta il nome di famiglia del vecchio contadino che lo ha adottato, e diventa Li. Avrebbe potuto conservare il suo nome proprio, ma rinuncia anche a quello scegliendone un altro che gli pare di buon auspicio, Chunlai, due ideogrammi che significano «arriva la primavera». Soltanto una speranza: per lui e per la Cina l’inverno era ancora lungo. Quando, anni e anni dopo, viene riabilitato, riacquista anche il suo nome e cognome ma, alla fine della vicenda, quando ottiene la cittadinanza e il passaporto americani, commenta semplicemente che, ancora una volta, aveva dovuto ridefinire la propria identità: «Questa volta il mio nome era Zhengguo Kang», scrive. E così firma queste sue memorie. Sembrerebbe una modifica da niente, invece ha un significato intenso per un cinese, perché il nome davanti al cognome, secondo l’uso occidentale, in Cina si pensa che sottolinei l’individualismo, l’affermazione del soggetto rispetto alla famiglia, al clan. Un atto di ribellione, insomma. Come un atto di ribellione egualmente significativo è quello di non voler mai più rimettere piede in Cina. Neanche da morto. Zhengguo, a conclusione del lungo racconto della sua vita, dice alla moglie: «Quando saremo vecchi, ci preoccuperemo di farci seppellire in America». Se questo libro è una «confessione» (come titola l’edizione originale), il finale è forse un’amara «sconfessione» della cinesitudine più profonda, quel modo di essere, di sentire e di rapportarsi di una civiltà tradizionale che vuole indissolubile il legame dell’uomo con la terra. Come d’inverno le foglie dell’albero che si spoglia fanno ritorno alle radici della pianta che le ha generate per rinnovarne il futuro rigoglio, così l’uomo deve essere sepolto là dove ha visto la luce. A questo si conformano, o per lo meno ambiscono, da generazioni e generazioni, tutti i cinesi della diaspora o dell’esilio. Ma Zhengguo e sua moglie vi rinunciano. È veramente una «sconfessione» totale della cinesitudine? Se il capitolo finale non fosse dedicato al futuro del loro figlio maschio che decide di fare ritorno in patria, a Shanghai, con la sua laurea americana in Economia e commercio, così si potrebbe dedurre. Invece, il ciclo si rinnova in maniera fino a pochi anni fa impensabile. La cinesitudine si prolunga nell’ibridazione: per questo, per quel che vale, è salva. © Editori Laterza Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 18 APRILE 2010 CULTURA* Personaggio bizzarro, collezionista eccentrico, maniaco ossessivo con la passione del cinema e del balletto, scrittore e vignettista enigmatico, misterioso, di cupezza vittoriana, torna ora in libreria a dieci anni dalla morte per iniziativa di Adelphi con “L’arpa muta” Un lavoro che, col consueto mix di parole e illustrazioni, mette ferocemente alla berlina l’esercito dei romanzieri inutili e degli editori che li pubblicano Humor nero Edward Gorey Repubblica Nazionale DOMENICA 18 APRILE 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 PAOLO MAURI n una fotografia degli anni Novanta, pubblicata nel 2007 da Harvard Magazine a corredo di un servizio su Edward Gorey, si vede un uomo calvo e barbuto disteso in mezzo a libri e giornali, mentre alcuni gatti sono sdraiati qua e là. Un lettore, neppure troppo distratto, potrebbe chiedersi: chi, tra queste creature, è il vero Edward Gorey? In fondo Gorey potrebbe benissimo essere (o meglio essere stato) un gatto. Basta scorrere Category (pubblicato in Italia da Adelphi nel 2003 col titolo Gattegoria) per convincersene: non si sa se è Gorey ad interpretare la gattitudine, o se è un gatto a leggere il mondo. Si tratta comunque di cinquanta disegni molto eleganti e divertenti, ma anche fortemente allusivi. Nel secondo, per esempio, si vede un gatto di schiena che scruta l’orizzonte marino deserto stando su una barca rovesciata. Che cosa accadrà dopo l’evidente naufragio? Ogni lettore è libero di interpretare questa storia senza parole, che molto probabilmente finisce bene, visto che i gatti, specie quelli delle vignette finali, sono sorridenti e l’ultimo, vittorioso, indossa una sciarpa svolazzante stando ritto su un muro alla cui base c’è una porticina. Dove porterà? Il mistero è insoluto. Se non fosse stato un gatto, Edward Gorey avrebbe potuto essere un pinguino, come il protagonista de L’ospite equivoco, tradotto da Matteo Codignola per Adelphi nel 2004. In una cupa casa vittoriana (Gorey ama muoversi tra lo stile vittoriano e l’edoardiano) si sente suonare alla porta, ma chi va ad aprire non trova nessuno. Però, guardando meglio, ecco uno strano figuro appollaiato su un vaso che, esigenze di rima, lascia tutti «con un palmo di naso». Il pinguino non è un ospite fa- I IL LIBRO L’arpa muta di Edward Gorey esce da Adelphi mercoledì (traduzione di Matteo Codignola, 72 pagine, 16 euro) vetri purché azzurri. Ma, a leggere il già citato saggio di Codignola, Gorey era un maniaco ossessivo fin da quando a undici anni giocò a Monopoli per un anno intero da solo. Era nato nel ‘25 e sarebbe vissuto fino all’aprile del 2000. Aveva letto almeno tre volte tutte le opere di Agatha Christie, aveva visto tutto quello che il cinema gli offriva e anche il balletto: non perse una sola replica del New York City Ballett il che voleva dire 150 Schiaccianoci e 39 Lago dei cigni… Il gusto per il nero (e il mortuario) lo portò a mettere in scena (nel ‘77) un Dracula che a Broadway fu applaudito ad apertura di sipario per la scena interamente nera. In questi giorni Adelphi, sempre per le cure di Codignola, manda in libreria L’arpa muta-ovvero Mr Earbrass scrive un romanzo che fu in pratica il suo esordio nel 1953, quando era fresco della laurea in letteratura francese presa a Harvard. Mr Earbrass è un tipico scrittore senz’anima oltre che un autentico idiota, il che già mette in agitazione chi considera il mondo delle lettere pieno di geniali creatori. Nella prima vignetta Earbrass si trova su un campo da croquet, nel Mortshire, dove vive abitualmente: «È intento a studiare una partita lasciata in sospeso l’estate scorsa». Nella seconda vignetta vediamo Earbrass intento, questa volta, a prendere il tè, mentre il testo ci informa che un anno sì e un anno no, il 18 novembre lo scrittore pone mano al suo “nuovo romanzo”. Il titolo lo ha già, è L’arpa muta, ma della trama non ha per ora la più pallida idea. Gorey sta prendendo in giro se stesso? È probabile, ma credo abbia in mente anche certe teorie critiche sulla scrittura. Ad un certo punto Mr Earbrass fa il bagno e medita intorno ad un brano del romanzo che non lo soddisfa. Vorrebbe spostarlo, ma poi pensa: «Già, ma dove? Ci sono cose che neppure un autore onnisciente può per- Il nonsense in punta di penna mettersi — ad esempio, interrompere la narrazione per tornare indietro e raccontare una storiella qualsiasi ambientata a Ladderback, in Tibet, proprio mentre i personaggi si stanno dannando l’anima per decidere se sia o no il caso di dragare il laghetto vicino al Dishiver Cottage». Sebbene sia all’epoca un esordiente, Gorey sembra conoscere a fondo il mondo dei letterati: ne individua manie, sorprese, desolazioni. Il povero Earbrass quando scrive si mette sempre una tuta al contrario e gli capita persino di vedere un personaggio che lo apostrofa sulle scale. Ad un certo punto il poveretto rilegge la parte già scritta dell’Arpa muta e la giudica atroce. Vorrebbe bruciare tutto. Poi si riprende e va avanti. Gorey ritrae lo scrittore alle prese con il finale e con la revisione del testo. Lo accompagna fino in casa editrice dove vogliono sottoporgli un piano per tradurre tutte le sue opere in urdu… Ma quali sono le opere di Mr Earbrass? Lo si dice all’inizio: Un sacchetto di polvere, Più pugni che grugni e Di cosa sparliamo?. Più in là troviamo citato anche il suo secondo romanzo Il significato della casa: Earbrass ne trova una copia da un venditore di libri usati con una sua dedica di cui non ricorda nulla. Il suo primo romanzo si intitola invece La piantagione di tartufi. Comunque, ora L’arpa muta è in libreria. Gli editori mandano a Earbrass tutte le recensioni uscite, ma lui si incaponisce a leggere un Compendio delle eresie minori nell’Asia Minore del Dodicesimo secolo. In due anni ne ha lette solo trentatré pagine, ma ora vuole andare avanti. Mr Earbrass è lo scrittore di cui nessuno ha bisogno, ma che, sembra dirci Gorey, si pubblica lo stesso. Con successo crescente. In inglese, in urdu e magari anche in italiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA ILLUSTRAZIONI © 1953, 1981 EDWARD GOREY © 2010 ADELPHI EDIZIONI SPA MILANO cile: se siede a tavola mangia anche le stoviglie, se acchiappa il grammofono (uno di quelli vecchi, a tromba) non ne vuol sapere di rimetterlo al suo posto. In biblioteca manomette i libri e sposta i quadri. Sotto forma di pinguino il nonsense entra nella vita di tutti i giorni di una famiglia dickensiana. Ma sebbene abbia illustrato Dickens e oltre a Dickens moltissimi altri scrittori (Beckett, Eliot, Updike, Chandler…) i veri padri nobili di Gorey sono Lewis Carroll e Edward Lear. Anche Gorey compose limerick, un po’ funerei, come questo che trascrivo: «Ogni notte papà mi riempie di affanni/ quando siede sul mio letto a far danni/ Non mi importa se si esprime/ con borbottii o false rime/ ma perché è morto da diciassette anni». Sebbene nei suoi libretti (ne ha pubblicati quasi cento) compaiano spesso dei bambini, l’opera di Gorey non è affatto destinata all’infanzia, come ribadisce in un suo gustoso e informatissimo saggio (Adelphiana 2003) Matteo Codignola, che della fortuna di Gorey in Italia è ora il maggior artefice. «Quando si sentiva chiedere che esperienza avesse dei bambini, e perché nei suoi libri infliggesse loro i tormenti più indicibili, Gorey rispondeva molto tranquillamente: “Nessuna. Li uso soltanto perché sono così indifesi”». C’è anche un limerick su un curato un po’ pedofilo… Ma la violenza e addirittura la morte si celebra anche nella Bicicletta epiplettica dove i due fratelli Embley e Yewbert «hanno una mazza da croquet per uno, e se la danno in testa». Personaggio bizzarro, Gorey in America è da tempo oggetto di culto: la televisione lo ha reso popolare e la sua casa a Cape Cod è meta di pellegrinaggi. Nella sua vita ha collezionato di tutto e tutto è ancora lì: ferri da stiro, sassi e rane, confezioni di medicinali purché di color arancio, Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 18 APRILE 2010 SPETTACOLI Rock and roll killer Re degli eccessi e delle classifiche, il cantante di “Great balls of fire” torna protagonista in una biografia che scorre come un romanzo L’abbiamo letta in anteprima GINO CASTALDO diciassette anni è già bigamo. Un bel record. E neanche l’unico nella focosa vita della leggenda del rock’n’roll Jerry Lee Lewis, detto “the killer”, micidiale performer che nei suoi anni d’oro era capace di ribaltare intere platee con quel modo sfrenato di cantare, in evidente ambiguità sessuale, i suoi cavalli di battaglia, Whola lotta shakin’goin’on o Great balls of fire, pestando a pugni e calci il suo incandescente pianoforte boogie. Dire che sia una vita da romanzo è riduttivo, ma come tale la tratta Nick Tosches, abilissimo narratore che trasforma la vicenda umana e musicale di Lewis in quello che a tutti gli effetti risulta un grande romanzo americano, dominato dai contrasti tra l’arretratezza della campagna e le tentazioni di città, tra la voglia di essere un predicatore timorato di Dio e diventare invece un testimone vivente della musica del diavolo, “the killer” appunto, il più inguaribile e sistematico dei peccatori. Dall’infanzia povera negli stati del Sud, tra cerimonie religiose, teppismo giovanile, miseria rurale; alla perdizione della notte nei locali più malfamati; fino agli illusori splendori del successo, pun- A tualmente rovinati dall’indole ribelle e autolesionista, dall’incontrollabile demonio interiore che lo spingeva sempre a guastare ogni cosa, la storia di Lewis attraversa quella dell’America, ne in- www.ant.it Ai nostri malati non chiediamo nulla. Aiutarci non vi costa nulla. Ogni giorno in Italia i nostri Professionisti assistono gratuitamente e a domicilio più di 3000 persone che soffrono di tumore. Con il tuo 5x1000 possiamo fare di più. Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione ANT. Codice Fiscale: 01229650377 terpreta le contraddizioni ma anche la mobilità, il fervore, la speranza, la tracotante energia. Il libro (in uscita per le edizioni Alet) si intitola Con me all’inferno (Hellfire nell’originale), rende molto bene questa storia di fuoco e peccato, di costante lotta tra Dio e Mammona, ed è stato accolto in America come un capolavoro. Addirittura, si è detto, la migliore biografia rock mai scritta. Di sicuro Jerry Lee sembra perfino irreale nella tenacia con cui sa trasformare la sua vita in un drammatico, agrodolce romanzo. E la scrittura di Tosches segue con brillante passione le tappe di questa vicenda. Quando, dopo tanto vagabondare, arriva al successo, si sposa per la terza volta con Myra, sua cugina di terzo grado, che il giorno del matrimonio ha appena tredici anni. La cosa viene tenuta nascosta per un po’, ma nel 1958 i giornali inglesi la tirano fuori e lo scandalo distrugge la sua carriera. Viene abbandonato da tutti, tranne che dal dj Alan Freed, quello a cui la leggenda attribuisce l’invenzione del termine rock’n’roll. Freed continua a far ascoltare i suoi dischi, ma neanche lui è uno stinco di santo: viene devastato dallo scandalo payola, una sorta di tangentopoli che fece luce sul sistema di corruzione nelle radio americane. Così anche l’ultimo amico di Jerry Lee viene neutralizzato. Seguono altre tragedie, la morte di due dei suoi figli, l’alcol, la droga, ma anche momenti di pura esaltazione. Ci sono pagine, in questo libro, di inquietante bellezza. Ad esempio, la descrizione delle cerimonie religiose rurali, dove improvvisamente i fedeli cominciano a dimenarsi come indiavolati e a parlare lingue sconosciute. O la potente descrizione della più clamorosa jam session mai capitata nella storia del rock’n’roll. Quel giorno, il 4 dicembre 1956, nello studiolo della Sun, l’etichetta di Memphis che aveva lanciato Presley e altri fondatori del rock’n’roll, tra cui lo stesso Jerry Lee, si ritrovano per caso insieme Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins e l’appena scritturato Jerry Lee Lewis. Cominciano a giocare e cantare insieme, depositando sui nastri dell’etichetta un autentico tesoro. Sam Phillips, il capo della Sun, lo definì “Million dollar quartet”, anche se la seduta fu registrata in modo rudimentale e non è stato possibile sfruttarla adeguatamente. Sorprende casomai che quei quattro, tutti in diversi modi esponenti di spicco della musica del diavolo, si mettessero a cantare gospel, musica da chiesa. Ma è proprio questo il punto. Quella musica discendeva dallo slancio di possessione che tutti, neri e bianchi, avevano assaporato nelle chiese protestanti. Poco tempo dopo Phillips vende il suo più luccicante gioiello, Elvis, alla Rca per quarantamila dollari: per quei tempi una cifra più che ragguardevole. A Phillips sembra un buon affare. Ma non lo è. Anzi, passa agli archivi come il peggior errore mai commesso in tutta la storia della discografia. Elvis è stato ed è tutt’ora una miniera inesauribile di denaro, paragonabile solo ai Beatles e a Michael Jackson. Lewis da parte sua, dopo lo scandalo, deve ricominciare praticamente da capo, suonando a cento dollari a sera in locali minori e proponendo una più mori- Repubblica Nazionale DOMENICA 18 APRILE 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 “Dicono che sono cattivo ma ho ucciso solo zanzare” NICK TOSCHES arlavamo della Bibbia, e hai detto che il tuo libro preferito è quello della Rivelazione… «Non è quello che ho detto. Ho detto dalla Genesi alla Rivelazione. Prendilo come una cosa unica. Ma è difficile scegliere un libro nella Bibbia. Ce ne sono così tanti. Ho studiato la Bibbia tutta la mia vita». C’è qualcosa nella Bibbia che ti sembra di non aver capito? «Sai perché non capisci? È perché stai cercando una facile via di fuga. Ora, se puoi mostrarmi qualcosa che mi indichi come uscirne fuori senza bruciare il mio didietro all’inferno, io saprò dov’è. Io e te bruceremo all’inferno. Siamo nei guai. Siamo peccatori, andremo all’inferno». Non ne sono così certo. Davvero pensi che ci andremo? «Dritti come una zucca. Penso che ci siamo attardati abbastanza a lungo. Il tempo è vicino». Nessuno andrà in paradiso? «Molto pochi. È difficile arrivarci, figliolo. E di sicuro non passando attraverso il Palomino Club. La Chiesa non può garantirti il paradiso, e neanche la religione. La Bibbia non parla mai di religione, parla di salvezza». È vero che una volta hai spinto un pianoforte nel mare? «Puoi giurarci che l’ho fatto. Successe a Charleston, nella Carolina del Sud. L’ho spinto fuori del teatro, fino in strada, l’ho spinto lungo il molo e poi l’ho spinto dritto nell’oceano. Ho solo cominciato a spingere e poi si è annebbiato tutto. Non ricordo bene perché l’ho fatto. Doveva essere un pessimo pianoforte. Non credo che l’abbiano mai recuperato. Sarà diventato cibo per gli squali». Secondo te, Elvis è finito all’inferno o in paradiso? «Non mi tirerai dentro una cosa del genere. Elvis ha avuto molto tempo per prepararsi. Ho parlato con lui della sua anima. Sai una cosa? Ci sono stati solo quattro che contano: Al Jolson, Jimmie Rodgers, Hank Williams e Jerry Lee Lewis. Il resto di questi idioti cavalcano un maledetto cavallo, suonano una chitarra o ammazzano qualcuno in qualche stupido maledetto film». Non ti sei mai stancato di cantare Great balls of fire notte dopo notte? «Ho dovuto, sempre. Altrimenti la gente avrebbe voluto i soldi indietro. In fondo abbiamo venduto qualcosa come trentotto milioni di copie di quel disco». È vero che i tuoi antenati possedevano Monroe, in Louisiana? «È un dato di fatto. Il mio bis-bisnonno era il proprietario. Poteva stendere un cavallo con un pugno. Un diavolo di uomo, Old Man Lewis. I Lewises hanno una grande storia. Bevitori incalliti. Giocatori incalliti. Tutti peccatori. Te l’ho detto, io sono un cattivo». Davvero pensi di essere così cattivo? «Non so, non vorrei pensare così. Sono gli altri a dirlo. Mi hanno sempre chiamato “the killer”. Mi sono sempre chiesto perché. Credo che lo dicessero in senso musicale, non perché io sarei andato in giro a uccidere persone. All’inferno, la sola cosa che ho ucciso è una zanzara della Louisiana. The killer. Dio, odio questo dannato nome». L’intervista è apparsa integralmente nel libro The Nick Tosches Reader, Da Capo Press 2000 © Nick Tosches P © RIPRODUZIONE RISERVATA LE IMMAGINI Jerry Lee Lewis all’apice della carriera: a destra, a colori, il suo disco più recente, Last Man Standing. Foto gentilmente concesse da Alet edizioni gerata musica country. Ma è ovvio che tra il santo e il peccatore, a prevalere è sempre il peccatore. Da sottolineare una della pagine più travolgenti del libro: il racconto della prima volta che Lewis IL LIBRO Con me all’inferno. La vita di Jerry Lee Lewis è la biografia della rockstar scritta da Nick Tosches È in uscita il 21 aprile da Alet (traduzione di Fabio Zucchella, 224 pagine, 18 euro) canta dal vivo Whola lotta shskin’goin’on, l’improvviso infiammarsi del locale, il delirio che si impossessa delle ragazze lanciate verso il palco come offerte devote allo sciamano. Chi ha assaporato un potere del genere, difficilmente può dimenticarsene. E sicuramente non ha dimenticato il vecchio Jerry Lee Lewis, oggi settantacinquenne, rassegnato forse alla vit- toria del peccato, ma senza smettere per tutta la vita di credere nella salvezza. Anche se per conquistarla ha fatto davvero poco, come quella volta che va fino alla casa di Elvis, la mitica Graceland, pretendendo di essere ricevuto dal “re” in persona. Dice di essere atteso, ma dalla casa non arriva alcuna conferma. Lui allora tira fuori la pistola e minaccia di sparare a chiunque cerchi di fermar- lo. Viene chiamata la polizia e Lewis finisce una volta ancora in prigione. E solo perché il re del rock’n’roll non ha voluto riceverlo nella sua reggia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 18 APRILE 2010 i sapori Contaminazioni Tra le mille seduzioni della città marocchina anche quella di essere diventata una meta gourmand. Non solo couscous e tajine, ma spezie, frutta secca, pesci e verdure, mix agrodolci, echi di ricette europee danno vita a piatti cult dove l’abbinamento fa davvero la differenza Cucina Marrakech Datteri Tè Olio d’Argàn Mandorle Ras el-hanout Arrivano dall’oasi di Tafilalet, dove prospera un maestoso palmeto di 700mila alberi (con festa dedicata a metà ottobre) Dolcissimi, sono immancabili in pietanze, insalate e dessert La menta profuma irresistibilmente il tè verde che scandisce la giornata: tonico, digestivo, rituale, viene servito in bicchieri alti, stretti, colorati, versato da teiere d’argento istoriato Occorrono le bacche di sei piante d’Argania Spinosa per fare un litro di questo nettare di tradizione berbera, dalle proprietà lenitive Il profumo originale battezza pesci e minestre Amatissime e indispensabili in cucina, dal latte (sharbat billuz) all’olio, fino alla pasta, con cui si farciscono i dolcetti (kaab al ghazal) Sono una costante per couscous, tajine, focacce e insalate La risposta marocchina al curry indiano è “il meglio del droghiere”, un poderoso mix di spezie tostate e macinate, con cui si insaporisce, tra gli altri, lo stufato di agnello al miele (mrouziya) Africa-Francia, capolavoro fusion LICIA GRANELLO l’appuntamento Si svolgerà dal 16 al 24 luglio la quarantacinquesima Festa Nazionale delle Arti Popolari di Marrakech, il più antico festival culturale del Marocco. Mille artisti e 350mila spettatori (dati della scorsa edizione), per una nove giorni – e notti – ininterrotta di spettacoli, parate, cene, dibattiti, presentazioni che animeranno l’intera città Numerosissimi baracchini di bevande e cibi di strada Q uestionedi olfatto. Annusare Marrakech è come sentirsi Alice nel paese delle meraviglie: un attimo e ci si ritrova catapultati in un mondo magico, coloratissimo, odoroso come nessun altro. Se gli afrori del Cairo sono concentrati nel mercato delle spezie e quelli di Barcellona tra Barrio Gotico e Boqueria, i sentori della Medina, la zona centrale di Marrakech, divampano e si ricompongono come stormi di uccelli. Ne segui uno e quando stai per afferrarlo un altro ti assale, mascalzone e irresistibile, a braccetto con una tavolozza di colori abbaglianti. Se è vero che si mangia con la bocca ma si gusta con tutti e cinque i sensi, allora Marrakech è davvero il paradiso dei gourmet. Pazienza se il mare è a un’ora di macchina e all’imbrunire il traffico vi mette a dura prova. La città trionfa accendendo la fantasia dei suoi frequentatori. Lo sguardo passa in rivista le cento bancarelle di Jamaa el Fna, la grande piazza dove si mischiano incantatori di serpenti e bancarelle di datteri. Il naso freme per il misto seducente di polveri che battezza le carni di manzo e d’agnello, le frasi accattivanti dei venditori di spremute d’arancia tentano le gole assetate. Immergere le mani nelle ceste di frutta secca è questione di un attimo, quasi come scrocchiarne un paio sotto i denti. «Say couscous» gridano i fotografi più intraprendenti, traducendo il sempiterno «Cheese» con cui si immortalano le facce sorridenti nelle foto di tutto il pianeta. Certo, la natura aiuta. Basta inseguire l’orizzonte da una delle terrazze della città vecchia per scoprire fattorie e palmeti immensi, prodromi di deserto e oasi da Mille e una notte, giardini lussureggianti e inaspettate coltivazioni biologiche. Qui, i francesi non sono passati invano. Al di là di couscous e tajine, che ancora si contendono il primato del piatto più popolare in città, la contaminazione tra gourmandise e tradizione araba ha prodotto una cucina di fusione franco-africana curiosa e golosa. Tutto, ovviamente, comincia negli sto- rici luoghi del cibo, che qui si dividono tra la distesa brulicante dei venditori di strada e il nido d’ape di botteghe assiepate nelle viscere dei palazzi d’antàn. Assemblare materie prime e spezie in quantità è pratica sapiente, da cui nascono i piatti-culto della Marrakech gourmand. Così, il battuto di melanzane prende quota grazie a frutta secca e passita, la croccante pasta millefoglie si accoppia con la morbida carnalità del foie gras, pesci e crostacei incontrano le verdure sul bilico dell’agrodolce. Se la cucina marocchina vi tenta, ma avete bisogno di un incoraggiamento, tra la visita alla moschea della Koutoubia e una passeggiata lungo i vialetti dei giardini di Majorelle — ex casa di vacanze di Yves Saint-Laurent — entrate al glorioso hotel La Mamounia, riaperto lo scorso autunno dopo un meticoloso restauro: mentre ammirate gli arredi magnifici e la sequenza di opere d’arte, un tuffo negli enormi piatti di datteri appoggiati sui tavoli vi folgorerà il palato, come novelli San Paolo sulla via del Marocco gourmand. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale Consulente della famiglia reale e veterana de “La Mamounia”, l’hotel amato da Churchill e Yves Saint Laurent, Liliane Humbert dirige “L’Italian par Don Alfonso”, dove lo chef napoletano delizia gli ospiti con il meglio della cucina mediterranea DOVE DORMIRE itinerari LA MAMOUNIA Avenue Bab Jdid Tel. 00212-24-388600 Camera doppia da 500 euro, colazione inclusa RIAD 72 (con cucina) 72 Arset Awsel - Bab Doukkala Tel. 00212- 24-387629 Doppia da 160 euro, colazione inclusa TALAA 12 12 Talaa Ben Youssef Tel. 00212-24-429045 Doppia da 150 euro, colazione inclusa RIAD MERIEM 154 Rue Mohamed El Beqal Tel. 00212-24-437062 Doppia da 125 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 DAR MOHA 81 Rue Dar el-Bacha Tel. 00212-24-386400 Chiuso lunedì, menù da 30 euro LE GRAND CAFÉ LA POSTE Boulevard el-Mansour Eddahbi Tel. 00212- 024-433038 Sempre aperto, menù da 25 euro LA TABLE DU MARCHÉ (con camere) 4 Rue du Temple Tel. 00212-24-424100 Sempre aperto, menù da 28 euro KSAR ESSAOUSSAN 3 Derb El Messaoudyenne Tel. 00212-24-440632 Chiuso domenica, menù da 35 euro DOVE COMPRARE DOMENICA 18 APRILE 2010 ASSOUSS COOPERATIVE D’ARGANE Rue el-Mouassine angolo Rue Sidi el-Yamani MARCHÈ MUNICIPALE Nouvelle Ville Rue ibn Toumert MOUHASSIN EPICES Riads Zitoun 10 Rue de la Bahia PATISSERIE AL-JAWDA Nouvelle Ville 11 Rue de la Liberté Tel. 00212-24-433897 MERCATO DEL MELLAH Ave Houmane el-Fetouaki Place des Ferblantiers SOUQ BAB DOUKKALA Rue Fatima Zohra Tajine M’semmen Briwat Harira Pastilla Il piatto-simbolo della tradizione marocchina è di spettanza maschile Marinate carne e spezie, la pentola di terracotta viene portata al farnatchi, (il forno a legna pubblico) per una cottura sotto la cenere In coppia con le ciambelline (sfenji), le frittelle abbondano nella colazione delle famiglie marocchine Le schiacciate di farina, acqua e sale, fritte nel burro, vanno servite caldissime con miele A forma di sigaro o di triangolo, gli involtini di sottile pasta sfoglia (brik) sono un appetitoso cibo da strada. Si gustano come snack dolci o salati, farciti con gamberi o con le mandorle col miele Ricca la zuppa che accompagna i pasti del Ramadàn. Piccoli pezzi di carne cotti, poi assemblati con un brodo di ceci e limone (tka-tàa) e una crema di pomodori A cotè, datteri e dolcetti Polposo, lo sformato di piccione dal sapore dolce-salato Si prepara infilando nella farcitura, carne cotta con burro, cipolle e zafferano, ma anche zucchero e mandorle al vizir della guerra, quarti di montoni, piramidi di polli, pesci in forma di montagna, couscous «per orchi» sotto grandi coni di giunco bianco e rosso, che, nel cortile, formano un deposito di giganteschi cappelli cinesi; dall’alto dei muri, si affacciano teste velate. Pranzi su cuscini, e senza vino; il tè è sempre pronto negli alti samovar d’argento. Le ventidue portate sono accompagnate da una musica stridente e veloce; il vizir siede lontano — un buon musulmano non può mangiare con dei nazzareni. Solo nel quartiere ebreo il cibo è innaffiato da due o tre qualità di vecchi vini rosé coltivati nelle colline attorno a Meknès, con grande scandalo dei musulmani. Ma Pierre Loti — lo scrittore ufficiale di marina in missione nel 1889 dal sultano del Marocco a Fèz — preferisce il «Marocco intimo» delle tribù; gli spostamenti in cui le ragazzine D Quarti di montone, couscous “per orchi” il mito del Marocco nella letteratura DARIA GALATERIA portano gli agnelli sul collo e le mule dondolano nelle ceste i puledri. La mouna firmata dal sultano — l’indispensabile “diritto di riscatto” che consente di attraversare le tribù e di essere accolti — si esprime ovunque in un lungo e grave corteo di cibi. Couscous al latte e zucchero; e montoni e polli vivi, sacrificati sul posto alla voracità della scorta. Ma meglio ancora, per Loti, il tè offerto dai beduini con un fornello preistorico in terra secca; hanno da offrire arance, pane e un’acqua incerta in cui affondano le dita. Tutto è meglio degli alberghi in cui il personale in cravatta bianca porge il couscous a ore fisse, mentre clienti bionde giocano a tennis. Il turismo infatti già avanza. «Da quando fabbrichiamo soli a volontà / soli prêt-à-porter», lamenta in versi Tahar Ben Jelloun, «abbiamo fatto venire il mare fino a Marrakech». Così i profumi cambiano: «Le spezie venute dal fondo dell’Oriente al passo indolente delle carovane — cumino — chiodi di garofano — sessi doppi — ambra — cocacola — benzoino (…) il nostro mondo è posseduto». L’etnologo Michel Leiris, militare in Africa del Nord, mangia da legionario «frutta, caffè e ammazzacaffè». Jean Genet — circondato come un tempo André Gide da ragazzi che carezzano «lo zob di Monsieur» — prende casa per un figlioccio a Larache; e lui, sempre senza bagagli, è invaso di colpo dall’universo degli oggetti: tegami soprattutto — non una cucina chiavi in mano, ma casseruola per casseruola. A scuola porta al bambino secchi di limonata e dolci “corna di gazzella”. Paul Bowles non osa incontrarlo, sa che non frequenta i bianchi, che si moltiplicano. Nel ‘17 è arrivata Edith Wharton; nel ‘54 Elias Canetti offrirà una moneta a un mendicante, che la mette in bocca e ve la gira e rigira: è cieco, e la sta leggendo. Da Bowles passano Tennessee Williams e Ruth Fainlight, che viene trascinata a una cerimonia nel deserto per «un santo berbero»; sui bassi tavolini sorti dalla sabbia arrivano i tre tè rituali, dolci e bollenti; gli indemoniati non mangiano più rospi e serpenti, e così Bowles indica agli ospiti la danza del ventre: da vicino, la ballerina accaldata sembra proprio un ragazzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 18 APRILE 2010 le tendenze Non solo fiori ACQUA DI PARMA Divide ex aequo con Miyake il premio miglior creazione olfattiva da donna: distilla il raro profumo della magnolia Peonia e geranio, ma anche vaniglia e pompelmo, tabacco, caffè puro e tè del Sudafrica. Al Cosmoprof di Bologna premiate le fragranze dell’anno, con un ritorno ai fioriti verdi, freschi e allo stesso tempo retrò e con l’avanzata di speziati e agrumati La conferma riguarda i consumi: nonostante la crisi le italiane (e gli italiani) hanno speso in essenze novecento milioni di euro D&G Vince il premio uomo come miglior comunicazione: cardamomo, ginepro, betulla per Le Bateleur ispirato ai tarocchi CALVIN KLEIN Miglior profumo dell’anno da uomo Ck Free: all’assenzio, all’anice dalle insolite note aromatiche e speziate MISS DIOR Premio miglior comunicazione Firma lo spot Sofia Coppola MIYAKE Vince ex aequo il premio come miglior creazione olfattiva da donna: verbena, giacinto e gelsomino DSQUARED2 Miglior creazione olfattiva da uomo: ambra minerale, incenso e giglio del Canada Wood vince anche il premio per il miglior packaging da uomo Oscardel profumo LAURA LAURENZI I MIYAKE Vince come miglior packaging donna: il flacone ha origine da un pezzo di vetro grezzo dal fascino primitivo BOLOGNA l profumo dell’anno è Lola di Marc Jacobs, un bouquet floreale che sa di peonia e geranio ma anche di pepe rosa, vaniglia e pompelmo. Quello da uomo invece è CK Free, legnoso e aromatico, con accenti di tabacco, caffè puro e tè del Sudafrica. I cosiddetti Oscar del profumo, tributati a sei diverse categorie, sono stati assegnati durante una serata di gala venerdì a Bologna nel corso del Cosmoprof, la più importante fiera della cosmesi del mondo. I profumi sono stati votati da una giuria di 40 mila italiani in 401 punti vendita diversi, fra profumerie e grandi magazzini. A loro si è affiancata una giuria speciale affollata di nomi celebri: da Franco Battiato a Mario Biondi, da Carlo Ancelotti a Paola Barale, da Marella Ferrera a Massimo Ghini, da Simona Ventura a Zlatan Ibrahimovic. A condurre la serata, non senza qualche impaccio, Victoria Cabello. La crisi non ha inciso più di tanto sul consumo dei profumi, erodendo solo l’uno per cento, secondo gli ultimi dati resi noti al Cosmoprof. Il valore totale della cosmetica è stato lo scorso anno di 9,1 miliardi di euro; quello che riguarda profumi e fragranze è pari a 897,47 milioni di euro. Ovviamente si profumano più le donne degli uomini, ma il distacco non è poi così schiacciante. Le donne incidono infatti con una spesa di circa 549 milioni di euro, gli uomini si attestano sopra i 348. Dato significativo: aumenta sensibilmente (più 4,1 per cento) l’uso dei deodoranti e degli antitraspiranti. La recessione taglia implacabilmente le spese voluttuarie, ma sui profumi, dotati di grande valore aggiunto, si tende a fare qualche sacrificio in più. Profumo come benessere diffuso e insieme come piccolo lusso abbordabile. Quanto ai gusti imperanti, la tendenza da segnalare sembra quella di un ritorno ai fioriti verdi, freschi e allo stesso tempo retrò, gli speziati, i fruttati, soprattutto gli agrumati, ma Gian Andrea Positano, responsabile dell’ufficio studi Unipro, sostiene che i trend sono i più diversi e coesistono pacificamente: «Il classico tiene sempre moltissimo, ma i premi conferiti dall’Accademia confermano la validità di numerose nuove esplorazioni creative». Crescono (anche se solo con un fioco più 0,3 per cento) i consumi della cosmetica. Se le aziende hanno fatturato complessivamente il 2,5 per cento in meno ciò è dovuto alla diminuzione dell’export. Si vendono bene i prodotti per il corpo, crescono anche i solari mentre precipitano (meno 9,1 per cento) gli anticellulite. Si acquistano i prodotti di base, legati all’igiene e considerati indispensabili, mentre su molto altro si tira la cinghia. SERGE LUTENS Miglior prodotto di nicchia è Fémineté du bois: prevale il legno di cedro con note cremose ETRO Miglior prodotto di nicchia da uomo, l’agrumato Pegaso: bergamotto e cedro con sentore di neroli e basilico © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 18 APRILE 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 ACQUA DI PARMA Frizzante e agrumato, Magnolia vince ex-aequo il premio come miglior prodotto made in Italy per donna BULGARI Vince ex aequo come miglior prodotto made in Italy da donna: Blu sa di violetta, anice, liquirizia e mandarino COSTUME NATIONAL Miglior prodotto made in Italy da uomo: Homme ha una fragranza sobria con tracce di uva, timo, sandalo, bergamotto Luciano Bertinelli, presidente dell’Accademia del profumo “Ogni nuova miscela è un messaggio che parla al nostro inconscio” MARC JACOBS È Lola il miglior profumo dell’anno da donna: pepe rosa in grani, pera, peonia Di Marc Jacobs uciano Bertinelli è il presidente di Accademia del Profumo, che da vent’anni assegna i suoi “Oscar”. Quali sono le nuove tendenze? «I profumi premiati, selezionati dai consumatori, esprimono chiaramente la voglia da un lato di conservare saldi i canoni della tradizione olfattiva e dall’altro di esplorare nuove interpretazioni di modernità». I creatori di fragranze hanno a disposizione una tavolozza di circa tremila materie prime. Chi detta i criteri con cui sono selezionate? «I criteri sono di due ordini, quello tecnico e quello creativo. Dal punto di vista tecnico la selezione si opera sull’attendibilità della fonte di approvvigionamento, che significa non solo migliore qualità, ma anche regolarità e continuità delle forniture. Dal punto di vista creativo, il profumiere seleziona le materie prime a seconda del proprio stile e dell’obiettivo da raggiungere. Mi piace paragonarle alle lettere di un alfabeto che il “naso” utilizza per scrivere un messaggio ogni volta diverso. Per questo ci sono creatori che attingono ad una vasta selezione di materie prime ed altri che si limitano ad un numero molto ridotto, poche centinaia». Perché tanti profumi si somigliano? «Anche se non esistono più da tempo i diktat olfattivi, è evidente che i numerosi profumi lanciati ogni anno si iscrivono in grandi correnti che rispecchiano gusti e tendenze. In questa dimensione è possibile che fragranze diverse possano contenere inflessioni e concetti vicini. È come nella moda: ci sono per ogni sta- L gione temi dominanti». Perché i profumi di marca costano tanto? «Perché si spende moltissimo in marketing, in comunicazione, in pubblicità. Il liquido che è dentro la bottiglia alla fine è la cosa che costa di meno». Vengono lanciati sempre nuovi profumi. Quest’anno oltre trecentocinquanta. In che percentuale sopravvivono? «Uno su dieci a dir molto. Gli altri finiscono nel dimenticatoio». Quanto incide un testimonial famoso? «Il valore del testimonial varia da campagna a campagna, ma non dimentichiamo che è più importante il brand. Questo spiega perché i testimonial vengono molto spesso cambiati». Quanto è importante il packaging? «In generale un packaging attraente contribuisce molto all’affermazione di un prodotto, ma quel che fa la differenza è, e rimane, la qualità del profumo». Che vuol dire che un profumo, attraverso il suo percorso olfattivo sensoriale, può aumentare il nostro benessere? «Le essenze hanno la capacità di influenzare a nostra insaputa il nostro inconscio: studi scientifici hanno evidenziato che alcuni odori possono avere un effetto stimolante o al contrario rilassante sul nostro tracciato encefalografico, quindi sulla nostra mente». (l. lau.) © RIPRODUZIONE RISERVATA L’ANTEPRIMA Presentata in anteprima al Cosmoprof di Bologna nel corso di una serata di gala, l’ultima fragranza donna di Ferragamo: si chiama Attimo. Fra i componenti meno conosciuti la pera Nashi, il Kumquat e il fiore di frangipani. A questi accenti si mescolano il fiore di loto, il profumo della gardenia e gli effluvi rosati e particolarmente femminili della peonia. La scia, lieve ma persistente, è data dal mix di muschio, legno di cedro e patchouli. La famiglia olfattiva è fiorita, verde, legnosa. Ecologico il cartone utilizzato per il packaging, secondo la tendenza che va verso “una bellezza che non inquina” La testimonial è Dree Hemingway, pronipote dello scrittore Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 18 APRILE 2010 l’incontro Oscar, Tony, Emmy, cinema, teatro e televisione. Ha fatto incetta dei massimi premi, ma non smette di voler “continuare ad assaporare la gioia di recitare davanti a un pubblico in carne e ossa” Predilige i personaggi ambigui o decisamente negativi e difende le sue scelte: “Se dovessi interpretare persone perbene e cristalline, temo che mi annoierei I cattivi sono più divertenti” Carismatici Jeremy Irons a mostrato il proprio magnifico talento in ogni forma di spettacolo, alternando continuamente cinema, teatro, televisione e musica. Ha ricevuto un’educazione classica estremamente rigorosa, che tuttavia non lo ha mai portato a disdegnare forme di intrattenimento più leggere. È stato insignito di ogni tipo di riconoscimento, ed è uno dei pochi attori ad aver ricevuto il premio Oscar (Il mistero Von Bulow), il Tony (The Real Thing) e due volte l’Emmy (The Great War and Shaping of the 20th Century e Elizabeth I). Parteciperà stasera al “Viaggio nel cinema americano” all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e ci tiene a spiegarmi che non ha alcun atteggiamento di snobismo nei confronti del cinema statunitense, anche quello più mainstream e commerciale. «Sono un attore, e come tale lavoro quando vengo scritturato. Se la storia, il personaggio e il regista sono interessanti, sono felice di accettare l’offerta di lavoro. Si fanno buoni film sia in Europa che negli Stati Uniti, così come brutti film». È nato con il nome di Jeremy John Irons a Cowes, nell’isola di Wight, in una famiglia di origini irlandesi. Il bisnonno era un attivista politico, dal quale ha ereditato una concezione dell’esistenza che non ignora mai l’impegno nella vita sociale. È stato per molto tempo un generoso sostenitore del partito laburista, e non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a cause nobili con azioni concrete e gesti simbolici, come l’indossare tra i primi a Hollywood il nastro rosso di solidarietà per La donna del tenente francese. Sin da questi inizi appare evidente l’eclettica intelligenza delle scelte e la continua ricerca della qualità: gli autori dei romanzi rispondevano al nome di Evelyn Waugh e John Fowles. Per non parlare di Harold Pinter, che sceneggiò il film per la regia di Karel Reisz, e per il quale interpretò subito dopo la versione cinematografica di Tradimenti, accanto a Ben Kingsley. Irons divenne immediatamente una star e cominciò ad alternare le interpretazioni per il cinema europeo a quelle per Hollywood, non disdegnando mai i ruoli interessanti nei film americani indipendenti. Sin da quegli anni mostrò di preferire personaggi ambigui, se non dichiaratamente malvagi: è il caso di Inseparabili di David Cronenberg; di Lolitadi Adrian Lyne, nel quale interpreta Humbert Humbert immortalato in precedenza da James Mason; di Il mistero Von Bulow di Barbet Schroeder. Non sono certo mancati personaggi nobili, positivi, o comunque caratterizzati da una profonda umanità, come quelli interpretati in Mission di Roland Joffé e in Io Nessuna automobile, nessun altro mezzo di trasporto, anche nei viaggi lunghi, mi dà il piacere della moto: la mia Ducati è come una Ferrari a due ruote FOTO © FABRICE DALL'ANESE /CORBIS OUTLINE H NEW YORK gli ammalati di Aids. «Ritengo che la cosa da fare per rendere utile la propria celebrità sia quella di enfatizzare cause che hanno bisogno di ossigeno per essere visibili», mi spiega, senza alcuna enfasi. Poi assume un tono disincantato: «Riguardo alla politica, ho cercato di aiutare con convinzione i laburisti, ma ora non appoggio alcun partito. Troppi politici non hanno null’altro da fare che concepire leggi non necessarie, specialmente a livello di parlamento europeo. Penso che dovremmo educare ed incoraggiare la gente a comportarsi in modo da rendere la vita più piacevole per tutti, e non guardare costantemente al governo per ottenere risposte». Al crescente atteggiamento di distacco verso lavoro e politica si contrappone l’attenzione dedicata alla vita familiare (è sposato dal 1978 con Sinead Cusack, dalla quale ha avuto due figli, Samuel e Maximilian) e alle attività sportive. È un ottimo cavallerizzo e un magnifico sciatore, oltre che un grande tifoso della squadra calcistica del Portsmouth. Ma la passione più divorante è rappresentata dalle motociclette, che usa come mezzo di locomozione anche per i lunghi viaggi: definisce la sua Ducati una «Ferrari a due ruote» e spiega: «Poche forme di trasporto mi procurano lo stesso piacere della motocicletta: è necessario essere sempre attenti e rispettosi delle condizioni meteo, delle strade, dei limiti di velocità. Inoltre la moto ti permette di non restare intrappolato nel traffico a quattro ruote». La Ducati tuttavia non è l’unico amore: la sua scuderia, che si arricchisce continuamente di nuovi acquisti, è composta da una Audi A6 Quattro Estate, da una Cruising Bike Bmw, da una Morris Minor, da una Honda 50 e da un Maggiolone Volkswagen. Ai tempi della scuola, un liceo chiamato Sherborne nel Dorset, cominciò a suonare la batteria e l’armonica e insieme a un gruppo locale chiamato ironicamente “The Four Pillars of Wisdom” conquistò una discreta fama con una versione di Moon River. È il periodo in cui scoprì la passione per l’esibizione in pubblico e per la recitazione. Cominciò a studiare presso la Bristol Old Vic Theatre School e debuttò nel musical Godspell, alternandosi in due ruoli diversissimi: Giuda e Giovanni Battista. Lo spettacolo ebbe un grande successo ma, dopo un ruolo di contorno in Nijinski, il vero lancio avvenne grazie all’interpretazione di Charles Ryder nella produzione della Bbc di Brideshead Revisited. Il passaggio al cinema fu immediato e a distanza di pochi mesi duettò meravigliosamente con Meryl Streep in ballo da soladi Bernardo Bertolucci, ma l’immagine prevalente è sempre, volutamente inquietante: seducente e nello stesso tempo luciferina. Ne è prova la scelta fatta dalla Disney, che lo chiamò a prestare la voce a Scar, il felino che uccide il proprio fratello nel Re Leone per strappargli lo scettro. «Sono affascinato dai personaggi ambigui ed enigmatici», mi spiega con un sorriso, «una delle aree più interessanti del mio lavoro è imparare perché costoro sono quello che sono. La lavorazione di un film può essere lenta e tortuosa e, se dovessi interpretare persone perbene e cristalline, temo che mi annoierei. Ovviamente i “cattivi” sono persone che non seguono le regole della società: sono destinati ad essere scoraggiati nella vita ed è il motivo per cui è divertente interpretarli». Queste caratterizzazioni, sempre raffinate e spesso sorprendenti, sono state bilanciate costantemente dalle scelte teatrali. Una delle interpretazioni che ha lasciato un segno nei palcoscenici inglesi è stata quella di Henry Higgins in My Fair Lady, il raffinato glottologo che si innamora della semi-analfabeta Eliza Doolittle nella versione musicale del Pigmalione di George Bernard Shaw. Dopo il successo nel ruolo di Alfred Stieglitz nella biografia televisiva di Georgia O’Keeffe, Irons sta preparandosi adesso per il ruolo di Rodrigo Borgia, l’uomo che divenne papa con il nome di Alessandro VI: «Sto leggendo tutto quello che è stato scritto sulla famiglia Borgia e mi colpisce di non aver trovato una biografia accurata su Rodrigo: molti pettegolezzi e sospetti ma nessun fatto provato con certezza». Tuttavia, tra tutti i ruoli affrontati, è con ogni probabilità quello di Claus Von Bulow che presenta maggiori pericoli e sfumature. L’uomo che venne condannato e poi assolto in appello per l’omicidio della moglie non ha nulla di attraente o simpatico, e il grande avvocato Alan Dershowitz utilizzò abilmente questa caratteristica per costruire un’accusa di pregiudizio che invalidò prove schiaccianti a suo carico. Un personaggio che portava con sé il rischio di intrappolare per sempre una carriera, ma nel suo caso condusse al premio Oscar. Dopo la fine del processo e la discussa assoluzione Von Bulow si è ritirato a Londra e ha diradato le apparizioni pubbliche, limitandosi a scrivere occasionalmente di teatro. Irons lo ha incontrato soltanto molti anni dopo averlo impersonato sullo schermo, e non deve essere stato un incontro piacevole: «Ho avuto l’impressione che la mia interpretazione non fosse troppo distante dalla realtà». Ancora oggi coltiva le passioni della gioventù, e sono in pochi a sapere che ha diretto un video musicale per Carly Simon. Il filmato, intitolato Tired of being blonde, negli anni è diventato di culto. La musica rappresenta un momento importante del suo percorso creativo, e non si è mai tirato indietro anche di fronte a incisioni e esecuzioni difficili. La scelta di interpretare Henry Higgins in My Fair Lady testimonia infatti sia l’amore per la musica che per il palcoscenico, dove al talento naturale unisce una tecnica acquisita con caparbietà e una grande presenza scenica: è alto quasi un metro e novanta, ma è in grado di muoversi con raffinata scioltezza. Così non ha mai abbandonato il teatro, anche nei momenti di maggiore successo cinematografico: lo scorso anno ha interpretato con successo a Broadway Impressionism, ed è appena andato in scena a Londra in The God’s weep. L’alta qualità della sua formazione teatrale, che lo ha visto interpretare ripetutamente Shakespeare, ha lasciato il segno anche nel cinema: tra le interpretazioni più intense e sensibili c’è quella di Antonio nel recente Mercante di Venezia con Al Pacino. «La mia educazione teatrale ha dato forma a tutto quello che ho fatto. Lavorando come attore e come stage manager ho visto di quale disperato talento ci sia bisogno per realizzare uno spettacolo. Il fatto che a teatro esistano molti ruoli straordinari, mi ha reso più esigente nella scelta dei ruoli cinematografici». A questo punto Irons si ferma un attimo, come se volesse confidarmi qualcosa: «Ho assaporato la gioia di recitare di fronte a un pubblico in carne e ossa. Si tratta di un elemento che nel cinema, inevitabilmente, mi manca». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ ANTONIO MONDA Repubblica Nazionale
Scarica