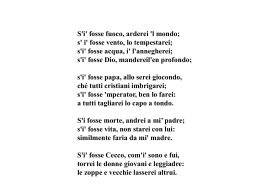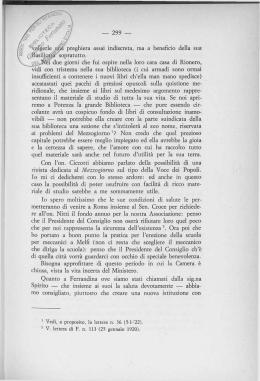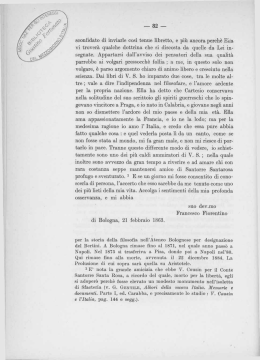Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” CARLO VECCE LE STAGIONI DELLA LETTERATURA ITALIANA Antologia di testi per il corso di letteratura italiana Facoltà di Lingue e Letterature Straniere ML (gruppo M-Z) / LC (gruppo A-I) / PM (gruppo A-I) a.a. 2007 - 2008 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) Iacopo da Lentini, Meravigliosamente; Io m’aggio posto in core a Dio servire Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole Iacopone da Todi, Donna de Paradiso Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore Cavalcanti, Fresca rosa novella; Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira Dante, Vita nova Dante, Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra Dante, Inferno, XXVI Dante, Purgatorio, XXVI Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, XXIII Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, LII; XC; CCCLXI Boccaccio, Decameron, IV,5 Cronica dell’Anonimo Romano Poliziano, Orfeo Sannazaro, Arcadia Machiavelli, De principatibus Ariosto, Orlando Furioso Tasso, Gerusalemme liberata Marino, Adone Metastasio, Didone abbandonata Parini, Il Giorno Goldoni, La bottega del caffé Alfieri, Vita Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis; A Zacinto Leopardi, L’infinito; A Silvia Leopardi, La ginestra Manzoni, Promessi sposi Carducci, Alla stazione in una mattina d’autunno Pascoli, Italy D’Annunzio, La pioggia nel pineto Verga, I Malavoglia Svevo, La coscienza di Zeno Pirandello, Una giornata Saba, Trieste; Città vecchia; Dopo la tristezza Ungaretti, Tre fiumi; Amaro accordo Montale, L’anguilla Caproni, 1944 2 Iacopo da Lentini, Meravigliosamente; Io m’aggio posto in core a Dio servire [Giacomo da Lentini, Poesie, a cura di Roberto Antonelli, Roma, Bulzoni, 1979] Meravigliosa-mente un amor mi distringe e mi tene ad ogn'ora. Com'om che pone mente in altro exemplo pinge la simile pintura, così, bella, facc'eo, che 'nfra lo core meo porto la tua figura. In cor par ch'eo vi porti, pinta come parete, e non pare difore. O Deo, co' mi par forte non so se lo sapete, con' v'amo di bon core; ch'eo son sì vergognoso che pur vi guardo ascoso e non vi mostro amore. Avendo gran disio dipinsi una pintura, bella, voi simigliante, e quando voi non vio guardo 'n quella figura, par ch'eo v'aggia davante: come quello che crede salvarsi per sua fede, ancor non veggia inante. Al cor m'ard'una doglia, com'om che ten lo foco a lo suo seno ascoso, e quando più lo 'nvoglia, allora arde più loco e non pò star incluso: similemente eo ardo quando pass'e non guardo a voi, vis'amoroso. S'eo guardo, quando passo, inver' voi no mi giro, bella, per risguardare; andando, ad ogni passo getto uno gran sospiro ca facemi ancosciare; e certo bene ancoscio, c'a pena mi conoscio, 3 tanto bella mi pare. Assai v'aggio laudato, madonna, in tutte parti, di bellezze c'avete. Non so se v'è contato ch'eo lo faccia per arti, che voi pur v'ascondete: sacciatelo per singa zo ch'eo no dico a linga, quando voi mi vedite. Canzonetta novella, va' canta nova cosa; lèvati da maitino davanti a la più bella, fiore d'ogn'amorosa, bionda più c'auro fino: «Lo vostro amor, ch'è caro, donatelo al Notaro ch'è nato da Lentino». [XXVII] Io m'aggio posto in core a Dio servire, com'io potesse gire in paradiso, al santo loco, c'aggio audito dire, o' si mantien sollazzo, gioco e riso. Sanza mia donna non vi voria gire, quella c'à blonda testa e claro viso, che sanza lei non poteria gaudere, estando da la mia donna diviso. Ma no lo dico a tale intendimento, perch'io pecato ci volesse fare; se non veder lo suo bel portamento e lo bel viso e 'l morbido sguardare: che·l mi teria in gran consolamento, veggendo la mia donna in ghiora stare. 4 Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima [Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960] «Rosa fresca aulentis[s]ima ch'apari inver' la state, le donne ti disiano, pulzell' e maritate: tràgemi d'este focora, se t'este a bolontate; per te non ajo abento notte e dia, penzando pur di voi, madonna mia.» «Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare. Lo mar potresti arompere, a venti asemenare, l'abere d'esto secolo tut[t]o quanto asembrare: avere me non pòteri a esto monno; avanti li cavelli m'aritonno.» «Se li cavelli artón[n]iti, avanti foss'io morto, ca'n is[s]i [sì] mi pèrdera lo solacc[i]o e 'l diporto. Quando ci passo e véjoti, rosa fresca de l'orto, bono conforto dónimi tut[t]ore: poniamo che s'ajunga il nostro amore.» «Ke 'l nostro amore ajùngasi, non boglio m'atalenti: se ci ti trova pàremo cogli altri miei parenti, guarda non t'ar[i]golgano questi forti cor[r]enti. Como ti seppe bona la venuta, consiglio che ti guardi a la partuta.» «Se i tuoi parenti trova[n]mi, e che mi pozzon fare? Una difensa mèt[t]oci di dumili' agostari: non mi toc[c]ara pàdreto per quanto avere ha'n Bari Viva lo 'mperadore, graz[i'] a Deo! Intendi, bella, quel che ti dico eo?» «Tu me no lasci vivere né sera né maitino. Donna mi so' di pèrperi, d'auro massamotino. Se tanto aver donàssemi quanto ha lo Saladino, e per ajunta quant'ha lo soldano, toc[c]are me non pòteri a la mano. » «Molte sono le femine c'hanno dura la testa, e l'omo con parabole l'adimina e amonesta: tanto intorno procàzzala fin che ·ll' ha in sua podesta. Femina d'omo non si può tenere: guàrdati, bella, pur de ripentere.» «K'eo ne [pur ri]pentésseme? davanti foss'io aucisa ca nulla bona femina per me fosse ripresa! [A]ersera passàstici, cor[r]enno a la distesa. Aquìstati riposa, canzoneri: le tue parole a me non piac[c]ion gueri.» 5 «Quante sono le schiantora che m'ha' mise a lo core, e solo purpenzànnome la dia quanno vo fore! Femina d'esto secolo tanto non amai ancore quant'amo teve, rosa invidïata: ben credo che mi fosti distinata.» «Se distinata fósseti, caderia de l'altezze, ché male messe fòrano in teve mie bellezze. Se tut[t]o adivenìssemi, tagliàrami le trezze, e consore m'arenno a una magione, avanti che m'artoc[c]hi 'n la persone.» «Se tu consore arènneti, donna col viso cleri, a lo mostero vènoci e rènnomi confleri: per tanta prova vencerti fàralo volonteri. Conteco stao la sera e lo maitino: besogn'è ch'io ti tenga al meo dimino.» «Boimè tapina misera, com'ao reo distinato! Geso Cristo l'altissimo del tut[t]o m'è airato: concepìstimi a abàttare in omo blestiemato. Cerca la terra ch'este gran[n]e assai, chiù bella donna di me troverai.» «Cercat'ajo Calabr[ï]a, Toscana e Lombardia, Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa e Soria, Lamagna e Babilonïa [e] tut[t]a Barberia: donna non [ci] trovai tanto cortese, per che sovrana di meve te prese.» «Poi tanto trabagliàsti[ti], fac[c]ioti meo pregheri che tu vadi adomàn[n]imi a mia mare e a mon peri. Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri, e sposami davanti da la jente; e poi farò le tuo comannamente.» «Di ciò che dici, vìtama, neiente non ti bale, ca de le tuo parabole fatto n'ho ponti e scale. Penne penzasti met[t]ere, sonti cadute l'ale; e dato t'ajo la bolta sot[t]ana. Dunque, se po[t]i, tèniti villana.» «En paura non met[t]ermi di nullo manganiello: istòmi 'n esta grorïa d'esto forte castiello; prezzo le tuo parabole meno che d'un zitello. Se tu no levi e va'tine di quaci, se tu ci fosse morto, ben mi chiaci.» «Dunque vor[r]esti, vìtama, ca per te fosse strutto? Se morto essere déb[b]oci od intagliato tut[t]o, di quaci non mi mòs[s]era se non ai' de lo frutto 6 lo quale stäo ne lo tuo jardino: disïolo la sera e lo matino. » «Di quel frutto non àb[b]ero conti né cabalieri molto lo disïa[ro]no marchesi e justizieri, avere no'nde pòttero: gìro'nde molto feri. Intendi bene ciò che bol[io] dire? Men'este di mill'onze lo tuo abere. » «Molti so' li garofani, ma non che salma 'nd'ài bella, non dispregiàremi s'avanti non m'assai. Se vento è in proda e gìrasi e giungeti a le prai, arimembrare t'ao [e]ste parole, ca de[n]tr'a 'sta animella assai mi dole.» «Macara se dolés[s]eti che cadesse angosciato: la gente ci cor[r]es[s]oro da traverso e da ·llato; tut[t]'a meve dicessono: 'Acor[r]i esto malnato'! Non ti degnara porgere la mano per quanto avere ha 'l papa e lo saldano.» «Deo lo volesse, vìtama, te fosse morto in casa! L'arma n'anderia cònsola, ca dì e notte pantasa. La jente ti chiamàrano: ‘Oi perjura malvasa, c'ha' morto l'omo in càsata, traìta!’ Sanz'on[n]i colpo lèvimi la vita. » «Se tu no levi e va'tine co la maladizione, li frati miei ti trovano dentro chissa magione. [. . .] be ·llo mi sof[f]ero pèrdici la persone, ca meve se' venuto a sormonare; carente néd amico non t'ha aitare.» «A meve non aìtano amici né parenti: istrani' mi so', càrama, enfra esta bona jente. Or fa un anno, vìtama, che 'ntrata mi se' ['n] mente. Di canno ti vististi lo maiuto, bella, da quello jorno so' feruto.» «Di tanno 'namoràstiti, [tu] Iuda lo traìto, como se fosse porpore, iscarlato o sciamito? S'a le Va[n]gele jùrimi che mi sï' a marito, avere me non pòter'a esto monno: avanti in mare [j]ìt[t]omi al perfonno.» «Se tu nel mare gìt[t]iti, donna cortese e fina, dereto mi ti mìsera per tut[t]a la marina, [e da] poi c'anegàs[s]eti, trobàrati a la rena solo per questa cosa adimpretare: conteco m'ajo a[g]giungere a pec[c]are.» 7 «Segnomi in Patre e 'n Filïo ed i[n] santo Mat[t]eo: so ca non se' tu retico [o] figlio di giudeo, e cotale parabole non udi' dire anch'eo. Morta si [è] la femina a lo 'ntutto, pèrdeci lo saboro e lo disdotto.» «Bene lo saccio, càrama: altro non pozzo fare. Se quisso non arcòmplimi,làssone lo cantare. Fallo, mia donna, plàzzati, ché bene lo puoi fare. Ancora tu no m'ami, molto t'amo, sì m'hai preso come lo pesce a l'amo.» «Sazzo che m'ami, [e] àmoti di core paladino. Lèvati suso e vatene, tornaci a lo matino. Se ciò che dico fàcemi, di bon cor t'amo e fino. Quisso t'[ad]imprometto sanza faglia: te' la mia fede che m'hai in tua baglia.» «Per zo che dici, càrama, neiente non mi movo. Inanti pren[n]i e scànnami:tolli esto cortel novo. Esto fatto far pòtesi inanti scalfi un uovo. Arcompli mi' talento, [a]mica bella, ché l'arma co lo core mi si 'nfella.» «Ben sazzo, l'arma dòleti, com'omo ch'ave arsura. Esto fatto non pòtesi per nell'altra misura: se non ha' le Vangel[ï]e, che mo ti dico “Jura”, avere me non puoi in tua podesta; inanti pren[n]i e tagliami la testa. » «Le Vangel[ï]e, càrama? ch'io le porto in seno: a lo mostero présile (non ci era lo patrino). Sovr'esto libro jùroti mai non ti vegno meno. Arcompli mi' talento in caritate, ché l'arma me ne sta in sut[t]ilitate.» «Meo sire, poi juràstimi, eo tut[t]a quanta incenno. Sono a la tua presenz[ï]a, da voi non mi difenno. S'eo minespreso àjoti, merzé, a voi m'arenno. A lo letto ne gimo a la bon'ora, ché chissa cosa n'è data in ventura.» 8 Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole [Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960] Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. Ad te solo, Altissimo, se konfano, et nullu homo ène dignu te mentovare. Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual'è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de te, Altissimo, porta significatione. Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle: in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. Laudato si', mi' Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue creature dài sustentamento. Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. Laudato si', mi' Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore et sostengo infirmitate et tribulatione. Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare: guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male. Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate e serviateli cum grande humilitate. 9 Iacopone da Todi, Donna de Paradiso [Iacopone da Todi, Laude, a cura di Franco Mancini, Bari, Laterza, 1980] Lauda 70 "Donna de Paradiso, lo tuo figliolo è preso Iesù Cristo beato. "Traiàn for li latruni, che sian soi compagnuni; de spine s'encoroni, ché rege ss'è clamato!". Accurre, donna e vide che la gente l'allide; credo che lo s'occide, tanto l'ò flagellato". "O figlio, figlio, figlio, figlio, amoroso giglio! Figlio, chi dà consiglio al cor me' angustiato? "Como essere porria, che non fece follia, Cristo, la spene mia, om l'avesse pigliato?". Figlio occhi iocundi, figlio, co' non respundi? Figlio, perché t'ascundi al petto o' sì lattato?". "Madonna, ello è traduto, Iuda sì ll'à venduto; trenta denar' n'à auto, fatto n'à gran mercato". "Madonna, ecco la croce, che la gente l'aduce, ove la vera luce déi essere levato". "Soccurri, Madalena, ionta m'è adosso piena! Cristo figlio se mena, como è annunziato". "O croce, e que farai? El figlio meo torrai? E que ci aponerai, che no n'à en sé peccato?". "Soccurre, donna, adiuta, cà 'l tuo figlio se sputa e la gente lo muta; òlo dato a Pilato". "Soccurri, plena de doglia, cà 'l tuo figliol se spoglia; la gente par che voglia che sia martirizzato". "O Pilato, non fare el figlio meo tormentare, ch'eo te pòzzo mustrare como a ttorto è accusato". "Se i tollit'el vestire, lassatelme vedere, com'en crudel firire tutto l'ò ensanguenato". "Crucifige, crucifige! Omo che se fa rege, secondo nostra lege contradice al senato". "Donna, la man li è presa, ennella croc'è stesa; con un bollon l'ò fesa, tanto lo 'n cci ò ficcato. "Prego che mm'entennate, nel meo dolor pensate! Forsa mo vo mutate de que avete pensato". L'altra mano se prende, ennella croce se stende e lo dolor s'accende, ch'è plu multipiicato. Donna, li pè se prènno 1 e clavellanse al lenno; onne iontur'aprenno, tutto l'ò sdenodato". entro 'n le man' te metto de Ioanni, meo eletto; sia to figlio appellato. "Et eo comenzo el corrotto; figlio, lo meo deporto, figlio, chi me tt'à morto, figlio meo dilicato? Ioanni, èsto mea mate: tollila en caritate, àginne pietate, cà 'l core sì à furato". Meglio aviriano fatto ch'el cor m'avesser tratto, ch'ennella croce è tratto, stace desciliato!". "Figlio, l'alma t'è 'scita, figlio de la smarrita, figlio de la sparita, figlio attossecato! "O mamma, o' n'èi venuta? Mortal me dà' feruta, cà 'l tuo plagner me stuta, ché 'l veio sì afferato". Figlio bianco e vermiglio, figlio senza simiglio, figlio, e a ccui m'apiglio? Figlio, pur m'ài lassato! "Figlio, ch'eo m' aio anvito, figlio, pat'e mmarito! Figlio, chi tt'à firito? Figlio, chi tt'à spogliato?". Figlio bianco e biondo, figlio volto iocondo, figlio, perché t'à el mondo, figlio, cusì sprezzato? "Mamma, perché te lagni? Voglio che tu remagni, che serve mei compagni, ch'êl mondo aio aquistato". Figlio dolc'e placente, figlio de la dolente, figlio àte la gente mala mente trattato. "Figlio, questo non dire! Voglio teco morire, non me voglio partire fin che mo 'n m'esc' el fiato. Ioanni, figlio novello, morto s'è 'l tuo fratello. Ora sento 'l coltello che fo profitizzato. C'una aiàn sepultura, figlio de mamma scura, trovarse en afrantura mat'e figlio affocato!". Che moga figlio e mate d'una morte afferrate, trovarse abraccecate mat'e figlio impiccato!". "Mamma col core afflitto, 1 Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore [Poeti del Duecento, a cura di Gianfranco Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960] Al cor gentil rempaira sempre amore come l'ausello in selva a la verdura; né fe' amor anti che gentil core, né gentil core anti ch'amor, natura: ch'adesso con' fu 'l sole, sì tosto lo splendore fu lucente, né fu davanti 'l sole; e prende amore in gentilezza loco così propiamente come calore in clarità di foco. Foco d'amore in gentil cor s'aprende come vertute in petra preziosa, che da la stella valor no i discende anti che 'l sol la faccia gentil cosa; poi che n'ha tratto fòre per sua forza lo sol ciò che li è vile, stella li dà valore: così lo cor ch'è fatto da natura asletto, pur, gentile, donna a guisa di stella lo 'nnamora. Amor per tal ragion sta 'n cor gentile per qual lo foco in cima del doplero: splendeli al su' diletto, clar, sottile; no li stari' altra guisa, tant'è fero. Così prava natura recontra amor come fa l'aigua il foco caldo, per la freddura. Amore in gentil cor prende rivera per suo consimel loco com'adamàs del ferro in la minera. Fere lo sol lo fango tutto 'l giorno: vile reman, né 'l sol perde calore; dis'omo alter: “Gentil per sclatta torno”; lui semblo al fango, al sol gentil valore: ché non dé dar om fé che gentilezza sia fòr di coraggio in degnità d'ere' sed a vertute non ha gentil core, com'aigua porta raggio e 'l ciel riten le stelle e lo splendore. Splende 'n la 'ntelligenzia del cielo Deo criator più che ['n] nostr'occhi 'l sole: ella intende suo fattor oltra 'l cielo, e 'l ciel volgiando, a Lui obedir tole; 1 e con' segue, al primero, del giusto Deo beato compimento, così dar dovria, al vero, la bella donna, poi che ['n] gli occhi splende del suo gentil, talento che mai di lei obedir non si disprende. Donna, Deo mi dirà: “Che presomisti?”, siando l'alma mia a lui davanti. “Lo ciel passasti e 'nfin a Me venisti e desti in vano amor Me per semblanti: ch'a Me conven le laude e a la reina del regname degno, per cui cessa onne fraude”. Dir Li porò: “Tenne d'angel sembianza che fosse del Tuo regno; non me fu fallo, s'in lei posi amanza”. 1 Cavalcanti, Fresca rosa novella; Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira [Guido Cavalcanti, Rime, a cura di Domenico De Robertis, Torino, Einaudi, 1986] Fresca rosa novella, piacente primavera, per prata e per rivera gaiamente cantando, vostro fin presio mando - a la verdura. Lo vostro presio fino in gio' si rinovelli da grandi e da zitelli per ciascuno camino; e cantinne gli auselli ciascuno in suo latino da sera e da matino su li verdi arbuscelli. Tutto lo mondo canti, po' che lo tempo vène, sì come si convene, vostr'altezza presiata: ché siete angelicata - criatura. Angelica sembranza in voi, donna, riposa: Dio, quanto aventurosa fue la mia disianza! Vostra cera gioiosa, poi che passa e avanza natura e costumanza, ben è mirabil cosa. Fra lor le donne dea vi chiaman, come sète; tanto adorna parete, ch'eo non saccio contare; e chi poria pensare - oltra natura? Oltra natura umana vostra fina piasenza fece Dio, per essenza che voi foste sovrana: per che vostra parvenza ver' me non sia luntana; or non mi sia villana la dolce provedenza! E se vi pare oltraggio ch'ad amarvi sia dato, non sia da voi blasmato: ché solo Amor mi sforza, contra cui non val forza - né misura. Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira, che fa tremar di chiaritate l'âre e mena seco Amor, sì che parlare null'omo pote, ma ciascun sospira? O Deo, che sembra quando li occhi gira! dical'Amor, ch'i' nol savria contare: cotanto d'umiltà donna mi pare, ch'ogn'altra ver' di lei i' la chiam'ira. Non si poria contar la sua piagenza, ch'a le' s'inchin'ogni gentil vertute, e la beltate per sua dea la mostra. Non fu sì alta già la mente nostra e non si pose 'n noi tanta salute, che propiamente n'aviàn canoscenza. 1 Dante, Vita nova [Dante Alighieri, Vita nova, a cura di Guglielmo Gorni, Torino, Einaudi, 1996] 1 In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Sotto la quale rubrica io trovo scripte le parole le quali è mio intendimento d'asemplare in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sententia. Nove fiate già apresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo puncto quanto alla sua propria giratione, quando alli miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era già in questa vita stata tanto, che nel suo tempo lo Cielo Stellato era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, e io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. In quel puncto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia nelli menomi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: «Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur michi!». In quel puncto lo spirito animale, lo quale dimora nell'alta camera nella quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro perceptioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spetialmente alli spiriti del viso, disse queste parole: «Apparuit iam beatitudo vestra!». In quel puncto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: «Heu, miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!». D'allora innanzi, dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a·llui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la virtù che li dava la mia ymaginatione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercassi per vedere questa angiola giovanissima; onde io nella mia pueritia molte volte l'andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Homero: «Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Dio». E avegna che la sua ymagine, la quale continuatamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio della Ragione in quelle cose là dove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare alle passioni e acti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse, e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre dello exemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scripte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi. Poi che fuoro passati tanti dì che apuncto erano compiuti li nove anni apresso l'apparimento soprascripto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi dì avenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga etade; e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutòe virtuosamente tanto, che mi parve allora vedere tutti li termini della beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quel giorno. E però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire alli miei orecchi, presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partio dalle genti, e ricorso al solingo luogo d'una mia camera, puosimi a pensare di questa cortesissima. E pensando di lei, mi sopragiunse uno soave sonno, nel quale m'apparve una maravigliosa visione. Che mi parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore, di pauroso aspecto a chi la guardasse; e pareami con tanta letitia quanto a·ssé, che mirabile cosa era; e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non 1 poche, tra le quali io intendea queste: «Ego Dominus tuus». Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggieramente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi ch'era la donna della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta; e pareami che mi dicesse queste parole: «Vide cor tuum!». E quando elli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Apresso ciò poco dimorava che la sua letitia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che si ne gisse verso lo cielo. Onde io sostenea sì grande angoscia, che lo mio deboletto sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui disvegliato. E immantanente cominciai a pensare, e trovai che l'ora nella quale m'era questa visione apparita era stata la quarta della nocte, sì che appare manifestamente ch'ella fue la prima ora delle nove ultime ore della nocte. E pensando io a·cciò che m'era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti li quali erano famosi trovatori in quel tempo: e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, propuosi di fare uno sonetto, nel quale io salutasse tutti li fedeli d'Amore; e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a·lloro ciò che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo sonetto, lo quale comincia A ciascun'alma presa. A ciascun'alma presa e gentil core nel cui cospecto ven lo dir presente, in ciò che mi riscriva 'n suo parvente, salute in lor segnor, cioè Amore. Già eran quasi che aterzate l'ore del tempo che omne stella n'è lucente, quando m'apparve Amor subitamente, cui essenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava Amor tenendo meo core in mano, e nelle braccia avea madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava, e d'esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea. Apresso gir lo ne vedea piangendo. Questo sonetto si divide in due parti, che nella prima parte saluto e domando risponsione, nella seconda significo a che si dêe rispondere. La seconda parte comincia quivi Già erano. 17 Questa gentilissima donna, di cui ragionato è nelle precedenti parole, venne in tanta gratia delle genti, che quando passava per via, le persone correvano per vedere lei, onde mirabile letitia me ne giugnea nel cuore. E quando ella fosse presso d'alcuno, tanta onestà giugnea nel cuore di quello, che non ardia di levare gli occhi, né di rispondere al suo saluto. E di questo molti, sì come esperti, mi potrebbono testimoniare a chi no·llo credesse. Ella coronata e vestita d'umiltà s'andava, nulla gloria mostrando di ciò ch'ella vedea e udia. Diceano molti, poi che passata era: «Questa non è femina, anzi è de' bellissimi angeli del cielo». E altri diceano: «Questa è una maraviglia; che benedecto sia lo Signore, che sì mirabilemente sa operare!». Io dico che ella si mostrava sì gentile e sì 1 piena di tutti li piaceri, che quelli che la miravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto, che ridire no·llo sapeano; né alcuno era lo quale potesse mirare lei, che nel principio nol convenisse sospirare. Queste e più mirabili cose da·llei procedeano virtuosamente. Onde io pensando a·cciò, volendo ripigliare lo stilo della sua loda, propuosi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed excellenti operationi, acciò che non pur coloro che la poteano sensibilemente vedere, ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere. Allora dissi questo sonetto Tanto gentile. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogne lingua deven tremando muta e gli occhi no l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta; e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che 'ntender no·lla può chi no·lla prova; e par che della sua labbia si mova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima: Sospira. Questo sonetto è sì piano ad intendere per quello che narrato è dinanzi, che non abisogna d'alcuna divisione. 1 Dante, Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra [Dante Alighieri, Rime, a cura di Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1973] Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra son giunto, lasso, ed al bianchir de' colli, quando si perde lo color ne l'erba: e 'l mio disio però non cangia il verde, sì è barbato ne la dura petra che parla e sente come fosse donna. Similemente questa nova donna si sta gelata come neve a l'ombra: ché non la move, se non come petra, il dolce tempo che riscalda i colli, e che li fa tornar di bianco in verde perché li copre di fioretti e d'erba. Quand'ella ha in testa una ghirlanda d'erba, trae de la mente nostra ogn'altra donna: perché si mischia il crespo giallo e 'l verde sì bel, ch'Amor lì viene a stare a l'ombra, che m'ha serrato intra piccioli colli più forte assai che la calcina petra. La sua bellezza ha più vertù che petra, e 'l colpo suo non può sanar per erba: ch'io son fuggito per piani e per colli, per potere scampar da cotal donna; e dal suo lume non mi può far ombra poggio né muro mai né fronda verde. Io l'ho veduta già vestita a verde, sì fatta ch'ella avrebbe messo in petra l'amor ch'io porto pur a la sua ombra: ond'io l'ho chesta in un bel prato d'erba, innamorata com'anco fu donna, e chiuso intorno d'altissimi colli. Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli prima che questo legno molle e verde s'infiammi, come suol far bella donna, di me; che mi torrei dormire in petra tutto il mio tempo e gir pascendo l'erba, sol per veder do' suoi panni fanno ombra. Quandunque i colli fanno più nera ombra, sotto un bel verde la giovane donna la fa sparer, com'uom petra sott'erba. 1 Dante, Inferno, XXVI [Dante Alighieri, Commedia, a cura di Giorgio Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994] Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande, che per mare e per terra batti l'ali, e per lo 'nferno tuo nome si spande! Tra li ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai, di qua da picciol tempo, di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo. Così foss'ei, da che pur esser dee! ché più mi graverà, com' più m'attempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee che n'avean fatto iborni a scender pria, rimontò 'l duca mio e trasse mee; e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra ' rocchi de lo scoglio lo piè sanza la man non si spedia. Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio, perché non corra che virtù nol guidi; sì che, se stella bona o miglior cosa m'ha dato 'l ben, ch'io stesso nol m'invidi. Quante 'l villan ch'al poggio si riposa, nel tempo che colui che 'l mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede a la zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dov'e' vendemmia e ara: di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi tosto che fui là 've 'l fondo parea. E qual colui che si vengiò con li orsi vide 'l carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che nol potea sì con li occhi seguire, ch'el vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta, in sù salire: tal si move ciascuna per la gola del fosso, ché nessuna mostra 'l furto, e ogne fiamma un peccatore invola. Io stava sovra 'l ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù sanz'esser urto. E 'l duca, che mi vide tanto atteso, disse: "Dentro dai fuochi son li spirti; 1 catun si fascia di quel ch'elli è inceso". "Maestro mio", rispuos'io, "per udirti son io più certo; ma già m'era avviso che così fosse, e già voleva dirti: chi è 'n quel foco che vien sì diviso di sopra, che par surger de la pira dov'Eteòcle col fratel fu miso?". Rispuose a me: "Là dentro si martira Ulisse e Dïomede, e così insieme a la vendetta vanno come a l'ira; e dentro da la lor fiamma si geme l'agguato del caval che fé la porta onde uscì de' Romani il gentil seme. Piangevisi entro l'arte per che, morta, Deïdamìa ancor si duol d'Achille, e del Palladio pena vi si porta". "S'ei posson dentro da quelle faville parlar", diss'io, "maestro, assai ten priego e ripriego, che 'l priego vaglia mille, che non mi facci de l'attender niego fin che la fiamma cornuta qua vegna; vedi che del disio ver' lei mi piego!". Ed elli a me: "La tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto; ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, ch'i' ho concetto ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi, perch'e' fuor greci, forse del tuo detto". Poi che la fiamma fu venuta quivi dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi: "O voi che siete due dentro ad un foco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco quando nel mondo li alti versi scrissi, non vi movete; ma l'un di voi dica dove, per lui, perduto a morir gissi". Lo maggior corno de la fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica; indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori, e disse: "Quando mi diparti' da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enëa la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né 'l debito amore lo qual dovea Penelopè far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto 2 e de li vizi umani e del valore; ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola da la qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e ' compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dov'Ercule segnò li suoi riguardi acciò che l'uom più oltre non si metta; da la man destra mi lasciai Sibilia, da l'altra già m'avea lasciata Setta. "O frati", dissi, "che per cento milia perigli siete giunti a l'occidente, a questa tanto picciola vigilia d'i nostri sensi ch'è del rimanente non vogliate negar l'esperïenza, di retro al sol, del mondo sanza gente. Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Li miei compagni fec'io sì aguti, con questa orazion picciola, al cammino, che a pena poscia li avrei ritenuti; e volta nostra poppa nel mattino, de' remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già de l'altro polo vedea la notte, e 'l nostro tanto basso, che non surgëa fuor del marin suolo. Cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto da la luna, poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avëa alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; ché de la nova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fé girar con tutte l'acque; a la quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, com'altrui piacque, infin che 'l mar fu sovra noi richiuso". 2 Dante, Purgatorio, XXVI [Dante Alighieri, Commedia, a cura di Giorgio Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994] Mentre che sì per l'orlo, uno innanzi altro, ce n'andavamo, e spesso il buon maestro diceami: "Guarda: giovi ch'io ti scaltro"; feriami il sole in su l'omero destro, che già, raggiando, tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di cilestro; e io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma; e pur a tanto indizio vidi molt'ombre, andando, poner mente. Questa fu la cagion che diede inizio loro a parlar di me; e cominciarsi a dir: "Colui non par corpo fittizio"; poi verso me, quanto potëan farsi, certi si fero, sempre con riguardo di non uscir dove non fosser arsi. "O tu che vai, non per esser più tardo, ma forse reverente, a li altri dopo, rispondi a me che 'n sete e 'n foco ardo. Né solo a me la tua risposta è uopo; ché tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda Indo o Etïopo. Dinne com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte intrato dentro da la rete". Sì mi parlava un d'essi; e io mi fora già manifesto, s'io non fossi atteso ad altra novità ch'apparve allora; ché per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. Lì veggio d'ogne parte farsi presta ciascun'ombra e basciarsi una con una sanza restar, contente a brieve festa; così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica, forse a spïar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica, prima che 'l primo passo lì trascorra, sopragridar ciascuna s'affatica: la nova gente: "Soddoma e Gomorra"; e l'altra: "Ne la vacca entra Pasife, perché 'l torello a sua lussuria corra". Poi, come grue ch'a le montagne Rife volasser parte, e parte inver' l'arene, queste del gel, quelle del sole schife, l'una gente sen va, l'altra sen vene; e tornan, lagrimando, a' primi canti e al gridar che più lor si convene; 2 e raccostansi a me, come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltar ne' lor sembianti. Io, che due volte avea visto lor grato, incominciai: "O anime sicure d'aver, quando che sia, di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. Quinci sù vo per non esser più cieco; donna è di sopra che m'acquista grazia, per che 'l mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che 'l ciel v'alberghi ch'è pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi, acciò ch'ancor carte ne verghi, chi siete voi, e chi è quella turba che se ne va di retro a' vostri terghi". Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico s'inurba, che ciascun'ombra fece in sua paruta; ma poi che furon di stupore scarche, lo qual ne li alti cuor tosto s'attuta, "Beato te, che de le nostre marche", ricominciò colei che pria m'inchiese, "per morir meglio, esperïenza imbarche! La gente che non vien con noi, offese di ciò per che già Cesar, trïunfando, "Regina" contra sé chiamar s'intese: però si parton "Soddoma" gridando, rimproverando a sé com'hai udito, e aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito; ma perché non servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci, il nome di colei che s'imbestiò ne le 'mbestiate schegge. Or sai nostri atti e di che fummo rei: se forse a nome vuo' saper chi semo, tempo non è di dire, e non saprei. Farotti ben di me volere scemo: son Guido Guinizzelli; e già mi purgo per ben dolermi prima ch'a lo stremo". Quali ne la tristizia di Ligurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi fec'io, ma non a tanto insurgo, quand'io odo nomar sé stesso il padre mio e de li altri miei miglior che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre; 2 e sanza udire e dir pensoso andai lunga fïata rimirando lui, né, per lo foco, in là più m'appressai. Poi che di riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio con l'affermar che fa credere altrui. Ed elli a me: "Tu lasci tal vestigio, per quel ch'i' odo, in me, e tanto chiaro, che Letè nol può tòrre né far bigio. Ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi che è cagion per che dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro". E io a lui: "Li dolci detti vostri, che, quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri". "O frate", disse, "questi ch'io ti cerno col dito", e additò un spirto innanzi, "fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti; e lascia dir li stolti che quel di Lemosì credon ch'avanzi. A voce più ch'al ver drizzan li volti, e così ferman sua oppinïone prima ch'arte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guittone, di grido in grido pur lui dando pregio, fin che l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai sì ampio privilegio, che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale è Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un paternostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro". Poi, forse per dar luogo altrui secondo che presso avea, disparve per lo foco, come per l'acqua il pesce andando al fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco, e dissi ch'al suo nome il mio disire apparecchiava grazïoso loco. El cominciò liberamente a dire: "Tan m'abellis vostre cortes deman, qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; consiros vei la passada folor, e vei jausen lo joi qu'esper, denan. Ara vos prec, per aquella valor que vos guida al som de l'escalina, sovenha vos a temps de ma dolor!". Poi s'ascose nel foco che li affina. 2 Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, XXIII [Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1992] Nel dolce tempo de la prima etade, che nascer vide et anchor quasi in herba la fera voglia che per mio mal crebbe, perché cantando il duol si disacerba, canterò com' io vissi in libertade, mentre Amor nel mio albergo a sdegno s' ebbe. Poi seguirò sí come a lui ne 'ncrebbe troppo altamente, e che di ciò m' avenne, di ch' io son facto a molta gente exempio: benché 'l mio duro scempio sia scripto altrove, sí che mille penne ne son già stanche, et quasi in ogni valle rimbombi il suon de' miei gravi sospiri, ch' acquistan fede a la penosa vita. E se qui la memoria non m' aita come suol fare, iscúsilla i martiri, et un penser che solo angoscia dàlle, tal ch' ad ogni altro fa voltar le spalle, e mi face oblïar me stesso a forza: ché tèn di me quel d' entro, et io la scorza. I' dico che dal dí che 'l primo assalto mi diede Amor, molt' anni eran passati, sí ch' io cangiava il giovenil aspetto; e d' intorno al mio cor pensier' gelati facto avean quasi adamantino smalto ch' allentar non lassava il duro affetto. Lagrima anchor non mi bagnava il petto né rompea il sonno, et quel che in me non era, mi pareva un miracolo in altrui. Lasso, che son! che fui! La vita el fin, e 'l dí loda la sera. Ché sentendo il crudel di ch' io ragiono infin allor percossa di suo strale non essermi passato oltra la gonna, prese in sua scorta una possente donna, ver' cui poco già mai mi valse o vale ingegno, o forza, o dimandar perdono; e i duo mi trasformaro in quel ch' i' sono, facendomi d' uom vivo un lauro verde, che per fredda stagion foglia non perde. Qual mi fec' io quando primer m' accorsi de la trasfigurata mia persona, e i capei vidi far di quella fronde di che sperato avea già lor corona, e i piedi in ch' io mi stetti, et mossi, et corsi, 2 com' ogni membro a l' anima risponde, diventar due radici sovra l' onde non di Peneo, ma d' un piú altero fiume, e 'n duo rami mutarsi ambe le braccia! Né meno anchor m' agghiaccia l' esser coverto poi di bianche piume allor che folminato et morto giacque il mio sperar che tropp' alto montava: ché perch' io non sapea dove né quando me 'l ritrovasse, solo lagrimando là 've tolto mi fu, dí e nocte andava, ricercando dallato, et dentro a l' acque; et già mai poi la mia lingua non tacque mentre poteo del suo cader maligno: ond' io presi col suon color d' un cigno. Cosí lungo l' amate rive andai, che volendo parlar, cantava sempre mercé chiamando con estrania voce; né mai in sí dolci o in sí soavi tempre risonar seppi gli amorosi guai, che 'l cor s' umilïasse aspro et feroce. Qual fu a sentir? ché 'l ricordar mi coce: ma molto piú di quel, che per inanzi de la dolce et acerba mia nemica è bisogno ch' io dica, benché sia tal ch' ogni parlare avanzi. Questa che col mirar gli animi fura, m'aperse il petto, e 'l cor prese con mano, dicendo a me: Di ciò non far parola. Poi la rividi in altro habito sola, tal ch'io non la conobbi, oh senso humano, anzi le dissi 'l ver pien di paura; ed ella ne l' usata sua figura tosto tornando, fecemi, oimè lasso, d' un quasi vivo et sbigottito sasso. Ella parlava sí turbata in vista, che tremar mi fea dentro a quella petra, udendo: I' non son forse chi tu credi. E dicea meco: Se costei mi spetra, nulla vita mi fia noiosa o trista; a farmi lagrimar, signor mio, riedi Come non so: pur io mossi indi i piedi, non altrui incolpando che me stesso, mezzo tutto quel dí tra vivo et morto. Ma perché 'l tempo è corto, la penna al buon voler non pò gir presso: onde piú cose ne la mente scritte vo trapassando, et sol d' alcune parlo che meraviglia fanno a chi l' ascolta. 2 Morte mi s' era intorno al cor avolta, né tacendo potea di sua man trarlo, o dar soccorso a le vertuti afflitte; le vive voci m' erano interditte; ond' io gridai con carta et con incostro: Non son mio, no. S' io moro, il danno è vostro. Ben mi credea dinanzi agli occhi suoi d' indegno far cosí di mercé degno, et questa spene m' avea fatto ardito: ma talora humiltà spegne disdegno, talor l'enfiamma; et ciò sepp' io da poi, lunga stagion di tenebre vestito: ch' a quei preghi il mio lume era sparito. Ed io non ritrovando intorno intorno ombra di lei, né pur de' suoi piedi orma, come huom che tra via dorma, gittaimi stancho sovra l' erba un giorno. Ivi accusando il fugitivo raggio, a le lagrime triste allargai 'l freno, et lasciaile cader come a lor parve; né già mai neve sotto al sol disparve com' io sentí' me tutto venir meno, et farmi una fontana a pie' d' un faggio. Gran tempo humido tenni quel vïaggio. Chi udí mai d' uom vero nascer fonte? E parlo cose manifeste et conte. L' alma ch' è sol da Dio facta gentile, ché già d' altrui non pò venir tal gratia, simile al suo factor stato ritene: però di perdonar mai non è sacia a chi col core et col sembiante humile dopo quantunque offese a mercé vène. Et se contra suo stile ella sostene d' esser molto pregata, in Lui si specchia, et fal perché 'l peccar piú si pavente: ché non ben si ripente de l' un mal chi de l' altro s' apparecchia. Poi che madonna da pietà commossa degnò mirarme, et ricognovve e vide gir di pari la pena col peccato, benigna mi redusse al primo stato. Ma nulla à 'l mondo in ch' uom saggio si fide: ch' ancor poi ripregando, i nervi et l' ossa mi volse in dura selce; et cosí scossa voce rimasi de l' antiche some, chiamando Morte, et lei sola per nome. Spirto doglioso errante (mi rimembra) per spelunche deserte et pellegrine, 2 piansi molt' anni il mio sfrenato ardire: et anchor poi trovai di quel mal fine, et ritornai ne le terrene membra, credo per piú dolore ivi sentire. I' seguí' tanto avanti il mio desire ch' un dí cacciando sí com' io solea mi mossi; e quella fera bella et cruda in una fonte ignuda si stava, quando 'l sol piú forte ardea. Io, perché d' altra vista non m' appago, stetti a mirarla: ond' ella ebbe vergogna; et per farne vendetta, o per celarse, l' acqua nel viso co le man' mi sparse. Vero dirò (forse e' parrà menzogna) ch' i' sentí' trarmi de la propria imago, et in un cervo solitario et vago di selva in selva ratto mi trasformo: et anchor de' miei can' fuggo lo stormo. Canzon, i' non fu' mai quel nuvol d' oro che poi discese in pretïosa pioggia, sí che 'l foco di Giove in parte spense; ma fui ben fiamma ch' un bel guardo accense, et fui l' uccel che piú per l' aere poggia, alzando lei che ne' miei detti honoro: né per nova figura il primo alloro seppi lassar, ché pur la sua dolce ombra ogni men bel piacer del cor mi sgombra. 2 Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, LII; XC; CCCLXI [Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1992] LII Non al suo amante piú Dïana piacque, quando per tal ventura tutta ignuda la vide in mezzo de le gelide acque, ch' a me la pastorella alpestra et cruda posta a bagnar un leggiadretto velo, ch' a l' aura il vago et biondo capel chiuda, tal che mi fece, or quand' egli arde 'l cielo, tutto tremar d' un amoroso gielo. XC Erano i capei d' oro a l' aura sparsi che 'n mille dolci nodi gli avolgea, e 'l vago lume oltra misura ardea di quei begli occhi, ch' or ne son sí scarsi; e 'l viso di pietosi color' farsi, non so se vero o falso, mi parea: i' che l' ésca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di súbito arsi? Non era l' andar suo cosa mortale, ma d' angelica forma; et le parole sonavan altro, che pur voce humana. Uno spirto celeste, un vivo sole fu quel ch' i' vidi: et se non fosse or tale, piagha per allentar d' arco non sana, CCCLXI Dicemi spesso il mio fidato speglio, l' animo stanco, et la cangiata scorza, et la scemata mia destrezza et forza: –Non ti nasconder piú: tu se' pur vèglio. Obedir a Natura in tutto è il meglio, ch' a contender con lei il tempo ne sforza.– Súbito allor, com' acqua 'l foco amorza, d' un lungo et grave sonno mi risveglio: et veggio ben che 'l nostro viver vola et ch' esser non si pò piú d' una volta; e 'n mezzo 'l cor mi sona una parola di lei ch' è or dal suo bel nodo sciolta, ma ne' suoi giorni al mondo fu sí sola, ch' a tutte, s' i' non erro, fama à tolta. 2 Boccaccio, Decameron, IV,5 [Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Milano, Mondadori, 1976] I fratelli d'Ellisabetta uccidon l'amante di lei: egli l'apparise in sogno e mostrale dove sia sotterato; ella occultamente disotterra la testa e mettela in un testo di bassilico, e quivi sù piagnendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono, e ella se ne muore di dolor poco appresso. Finita la novella d'Elissa e alquanto dal re commendata, a Filomena fu imposto che ragionasse: la quale, tutta piena di compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro incominciò: –La mia novella, graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione come costor furono de' quali Elissa ha raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa: e a ricordarmi di quella mi tira Messina poco innanzi ricordata, dove l'accidente avvenne. Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano; e avevano una loro sorella chiamata Elisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale, che che se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano. E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in un lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva; il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Lisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente piacere. Di che Lorenzo accortosi e una volta e altra, similmente, lasciati suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'animo a lei; e sì andò la bisogna che, piacendo l'uno all'altro igualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più disiderava ciascuno. E in questo continuando e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare, che una notte, andando Lisabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggior de' fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, per ciò che savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infino alla mattina seguente trapassò. Poi, venuto il giorno, a' suoi fratelli ciò che veduto aveva la passata notte d'Elisabetta e di Lorenzo raccontò; e con loro insieme, dopo lungo consiglio, diliberò di questa cosa, acciò che né a loro né alla sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e d'infignersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa infino a tanto che tempo venisse nel quale essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso. E in tal disposizion dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano, avvenne che, sembianti faccendo d'andare fuori della città a diletto tutti e tre, seco menaron Lorenzo; e pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendosi il destro, Lorenzo, che di ciò niuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se n'accorse. E in Messina tornatisi dieder voce d'averlo per loro bisogne mandato in alcun luogo; il che leggiermente creduto fu, per ciò che spesse volte eran di mandarlo da torno, usati. Non tornando Lorenzo, e Lisabetta molto spesso e sollecitamente i fratei domandandone, sì come colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto instantemente, che l'uno de' fratelli disse: “Che vuol dir questo? che hai tu a far di Lorenzo, che tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene.” Per che la giovane dolente e trista, temendo e non sappiendo che, senza più domandarne si stava e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse; e alcuna volta con molte lagrime della sua lunga dimora si doleva e senza punto rallegrarsi sempre aspettando si stava. 3 Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava e essendosi alla fine piagnendo adormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato e co' panni tutti stracciati e fracidi: e parvele che egli dicesse: “O Lisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora t'atristi e me con le tue lagrime fieramente accusi; e per ciò sappi che io non posso più ritornarci, per ciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisono.” E disegnatole il luogo dove sotterato l'aveano, le disse che più nol chiamasse né l'aspettasse, e disparve. La giovane, destatasi e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa a' fratelli, propose di volere andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero che nel sonno l'era paruto. E avuta la licenzia d'andare alquanto fuor della terra a diporto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto più tosto poté là se n'andò; e tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove men dura le parve la terra quivi cavò; né ebbe guari cavato, che ella trovò il corpo del suo misero amante in niuna cosa ancora guasto né corrotto: per che manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piagnere, se avesse potuto volentier tutto il corpo n'avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura; ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che poté gli spiccò dallo 'mbusto la testa, e quella in uno asciugatoio inviluppata, e la terra sopra l'altro corpo gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si dipartì e tornossene a casa sua. Quivi con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille basci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel testo, di questi ne' quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo; e poi messavi sù la terra, sù vi piantò parecchi piedi di bellissimo bassilico salernetano, e quegli da niuna altra acqua che o rosata o di fior d'arancio delle sue lagrime non innaffiava giammai. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina e quello con tutto il suo disidero vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso: e poi che molto vagheggiato l'avea, sopr'esso andatasene cominciava a piagnere, e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava, piagnea. Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra procedente dalla testa corrotta che dentro v'era, divenne bellissimo e odorifero molto; e servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da' suoi vicin fu veduta. Li quali, maravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti, il disser loro: “Noi ci siamo accorti che ella ogni dì tiene la cotal maniera.” Il che udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecero portar via questo testo; il quale non ritrovando ella con grandissima instanzia molte volte richiese, e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lagrime, infermò, né altro che il testo suo nella infermità domandava. I giovani si maravigliavan forte di questo adimandare, e per ciò vollero vedere che dentro vi fosse; e versata la terra, videro il drappo e in quello la testa non ancora sì consumata, che essi alla capellatura crespa non conoscessero lei essere quella di Lorenzo. Di che essi si maravigliaron forte e temettero non questa cosa si risapesse: e sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi si ritraessono, se n'andarono a Napoli. La giovane non restando di piagnere e pure il suo testo adimandando, piagnendo si morì, e così il suo disaventurato amore ebbe termine. Ma poi a certo tempo divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compuose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè: Qual esso fu lo malo cristiano, che mi furò la grasta, et cetera.– 3 Cronica dell’Anonimo Romano [Anonimo Romano, Cronica, a cura di Giuseppe Porta, Milano, Adelphi, 1979] XXVII Era dello mese de settiembro, a dìi otto. Staieva Cola de Rienzi la dimane in sio lietto. Avease lavata la faccia de grieco. Subitamente veo voce gridanno: «Viva lo puopolo, viva lo puopolo». A questa voce la iente traie per le strade de·llà e de cà. La voce ingrossava, la iente cresceva. Nelle capocroce de mercato accapitao iente armata che veniva da Santo Agnilo e da Ripa e iente che veniva da Colonna e da Treio. Como se ionzero insiemmori, così mutata voce dissero: «Mora lo traditore Cola de Rienzi, mora!» Ora se fionga la ioventute senza rascione, quelli proprio che scritti aveva in sio sussidio. Non fuoro tutti li rioni, salvo quelli li quali ditti soco. Curzero allo palazzo de Campituoglio. Allora se aionze lo moito puopolo, uomini e femine e zitielli. Iettavano prete; faco strepito e romore; intorniano lo palazzo da onne lato, dereto e denanti, dicenno: «Mora lo traditore che hao fatta la gabella, mora!» Terribile ène loro furore. A queste cose lo tribuno reparo non fece. Non sonao la campana, non se guarnìo de iente. Anco da prima diceva: «Essi dico: 'Viva lo puopolo', e anco noi lo dicemo. Noi per aizare lo puopolo qui simo. Miei scritti sollati so'. La lettera dello papa della mea confirmazione venuta ène. Non resta se non piubicarla in Consiglio». Quanno a l'uitimo vidde che·lla voce terminava a male, dubitao forte; specialemente ché esso fu abannonato da onne perzona vivente che in Campituoglio staieva. Iudici, notari, fanti e onne perzona aveva procacciato de campare la pelle. Solo esso con tre perzone remase, fra li quali fu Locciolo Pellicciaro, sio parente. Quanno vidde lo tribuno puro lo tumuito dello puopolo crescere, viddese abannonato e non proveduto, forte se dubitava. Demannava alli tre que era da fare. Volenno remediare, fecese voglia e disse: «Non irao così, per la fede mea». Allora se armao guarnitamente de tutte arme a muodo de cavalieri, la varvuta in testa, corazza e falle e gammiere. Prese lo confallone dello puopolo e solo se affece alli balconi della sala de sopra maiure. Destenneva la mano, faceva semmiante che tacessino, ca voleva favellare. Sine dubio che se lo avessino scoitato li àbbera rotti e mutati de opinione, l'opera era svaragliata. Ma Romani non lo volevano odire. Facevano como li puorci. Iettavano prete, valestravano. Curro con fuoco per ardere la porta. Tante fuoro le valestrate e·lli verruti, che alli balconi non potéo durare. Uno verruto li coize la mano. Allora prese questo confallone e stenneva lo sannato da ambedoi le mano. Mostrava le lettere dello auro, l'arme delli citatini de Roma, quasi venissi a dicere: «Parlare non me lassate. Ecco che io so' citatino e popularo como voi. Amo voi, e se occidete me, occidete voi che romani site». Non vaize questi muodi tenere. Peio fao la iente senza intellietto. «Mora lo traditore!» chiama. Non potenno più sostenere, penzao per aitra via campare. Dubitavase de remanere su nella sala de sopra, perché anco stava presone missore Bettrone de Narba, a chi fatta aveva tanta iniuria. Dubitava che non lo occidessi con soie mano. Conosceva e vedeva che responneva allo puopolo. Penzao partirse dalla sala de sopra e delongarese da missore Bettrone per cascione de più securitate. Allora abbe tovaglie de tavola e legaose in centa e fecese despozzare ioso nello scopierto denanti alla presone. Nella presone erano li presonieri; vedevano tutto. Tolle li chiavi e tenneli a sé. Delli presonieri dubitava. De sopra nella sala remase Locciolo Pellicciaro, lo quale a quanno a quanno se affaceva alli balconi e faceva atti con mano, con vocca allo puopolo e diceva: «Essolo che vene ioso dereto», e issino dereto allo palazzo, ca dereto veniva. Puoi se volvea allo tribuno, confortavalo e diceva che non dubitassi. Puoi tornava allo puopolo facenno li simili cenni: «Essolo dereto, essolo ioso dereto». Davali la via e l'ordine. Locciolo lo occise. Locciolo Pellicciaro confuse la libertate dello puopolo, lo quale mai non trovao capo. Solo per quello omo poteva trovare libertate. Solo Locciolo se·llo avessi confortato, de fermo non moriva; ché 3 fu arza la sala, lo ponte della scala cadde a poca d'ora. Ad esso non poteva alcuno venire. Lo dìe cresceva. Li rioni della Regola e li aitri forano venuti, lo puopolo cresciuto, le voluntate mutate per la diverzitate. Onne omo fora tornato a casa, overo granne vattaglia stata fora. Ma Locciolo li tolle la speranza. Lo tribuno desperato se mise a pericolo della fortuna. Staienno allo scopierto lo tribuno denanti alla cancellaria, ora se traieva la varvuta, ora se·lla metteva. Questo era che abbe da vero doi opinioni. La prima opinione soa, de volere morire ad onore armato colle arme, colla spada in mano fra lo puopolo a muodo de perzona magnifica e de imperio. E ciò demostrava quanno se metteva la varvuta e tenevase armato. La secunna opinione fu de volere campare la perzona e non morire. E questo demostrava quanno se cavava la varvuta. Queste doi voluntate commattevano nella mente soa. Venze la voluntate de volere campare e vivere. Omo era como tutti li aitri, temeva dello morire. Puoi che deliverao per meglio de volere vivere per qualunche via potéo, cercao e trovao lo muodo e·lla via, muodo vituperoso e de poco animo. Ià li Romani aveano iettato fuoco nella prima porta, lena, uoglio e pece. La porta ardeva. Lo solaro della loia fiariava. La secunna porta ardeva e cadeva lo solaro e·llo lename a piezzo a piezzo. Orribile era lo strillare. Penzao lo tribuno devisato passare per quello fuoco, misticarese colli aitri e campare. Questa fu l'uitima soa opinione. Aitra via non trovava. Dunque se spogliao le insegne della baronia, l'arme puse io' in tutto. Dolore ène de recordare. Forficaose la varva e tenzese la faccia de tenta nera. Era là da priesso una caselluccia dove dormiva lo portanaro. Entrato là, tolle uno tabarro de vile panno, fatto allo muodo pastorale campanino. Quello vile tabarro vestìo. Puoi se mise in capo una coitra de lietto e così devisato ne veo ioso. Passa la porta la quale fiariava, passa le scale e·llo terrore dello solaro che cascava, passa l'uitima porta liberamente. Fuoco non lo toccao. Misticaose colli aitri. Desformato desformava la favella. Favellava campanino e diceva: «Suso, suso a gliu tradetore!» Se le uitime scale passava era campato. La iente aveva l'animo suso allo palazzo. Passava la uitima porta, uno se·lli affece denanti e sì·llo reaffigurao, deoli de mano e disse: «Non ire. Dove vai tu?» Levaoli quello piumaccio de capo, e massimamente che se pareva allo splennore che daieva li vraccialetti che teneva. Erano 'naorati: non pareva opera de riballo. Allora, como fu scopierto, parzese lo tribuno manifestamente: mostrao ca esso era. Non poteva dare più la voita. Nullo remedio era se non de stare alla misericordia, allo volere altruio. Preso per le vraccia, liberamente fu addutto per tutte le scale senza offesa fi' allo luoco dello lione, dove li aitri la sentenzia vodo, dove esso sentenziato aitri aveva. Là addutto, fu fatto uno silenzio. Nullo omo era ardito toccarelo. Là stette per meno de ora, la varva tonnita, lo voito nero como fornaro, in iuppariello de seta verde, scento, colli musacchini inaorati, colle caize de biada a muodo de barone. Le vraccia teneva piecate. In esso silenzio mosse la faccia, guardao de·llà e de cà. Allora Cecco dello Viecchio impuinao mano a uno stuocco e deoli nello ventre. Questo fu lo primo. Immediate puo' esso secunnao lo ventre [?] de Treio notaro e deoli la spada in capo. Allora l'uno, l'aitro e li aitri lo percuoto. Chi li dao, chi li promette. Nullo motto faceva. Alla prima morìo, pena non sentìo. Venne uno con una fune e annodaoli tutti doi li piedi. Dierolo in terra, strascinavanollo, scortellavanollo. Così lo passavano como fussi criviello. Onneuno ne·sse iocava. Alla perdonanza li pareva de stare. Per questa via fu strascinato fi' a Santo Marciello. Là fu appeso per li piedi a uno mignaniello. Capo non aveva. Erano remase le cocce per la via donne era strascinato. Tante ferute aveva, pareva criviello. Non era luoco senza feruta. Le mazza de fòra grasse. Grasso era orribilemente, bianco como latte insanguinato. Tanta era la soa grassezza, che pareva uno esmesurato bufalo overo vacca a maciello. Là pennéo dìi doi, notte una. Li zitielli li iettavano le prete. Lo terzo dìe de commannamento de Iugurta e de Sciarretta della Colonna fu strascinato allo campo dell'Austa. Là se adunaro tutti Iudiei in granne moititudine: non ne remase uno. Là fu fatto uno fuoco de cardi secchi. In quello fuoco delli cardi fu messo. Era grasso. Per la moita grassezza da sé ardeva volentieri. Staievano là li Iudiei forte affaccennati, afforosi, affociti. 3 Attizzavano li cardi perché ardessi. Così quello cuorpo fu arzo e fu redutto in polve: non ne remase cica. Questa fine abbe Cola de Rienzi, lo quale se fece tribuno augusto de Roma, lo quale voize essere campione de Romani. 3 Poliziano, Orfeo [Angelo Poliziano, Orfeo, a cura di Antonia Tissoni Benvenuti, Padova, Antenore, 1986] Angelo Poliziano a Messer Carlo Canale suo, salute. Solevano i Lacedemonii, humanissimo messer Carlo mio, quando alcuno loro figliuolo nasceva o di qualche membro impedito o delle forze debile, quello exponere subitamente, né permettere che in vita fussi riservato, giudicando tale stirpa indegna di Lacedemonia. Così desideravo ancora io che la fabula di Orpheo, la quale a requisizione del nostro reverendissimo Cardinale Mantuano, in tempo di dua giorni, intra continui tumulti, in stilo vulgare perché dagli spectatori meglio fusse intesa havevo composta, fussi di subito, non altrimenti che esso Orpheo, lacerata: cognoscendo questa mia figliuola essere qualità da far più tosto al suo padre vergogna che honore, e più tosto apta dargli maninconia che allegrezza. Ma vedendo che e voi e alcuni altri troppo di me amanti, contro alla mia volontà in vita la ritenete, conviene ancora a me havere più rispetto allo amor paterno e alla voluntà vostra che al mio ragionevole instituto. Havete però una giusta excusazione della voluntà vostra, perché essendo così nata sotto lo auspizio di sì clemente Signore, merita essere exempta da la comun legge. Viva adunque, poi che a voi così piace; ma bene vi protesto che tale pietà è una expressa crudelità, e di questo mio iudizio desidero ne sia questa epistola testimonio. E voi che sapete la necessità della mia obedienza e l'angustia del tempo, vi priego che con la vostra autorità resistiate a qualunche volessi la imperfezione di tale figliuola al padre attribuire. VALE. FABULA DI ORPHEO Mercurio annunziatore della festa: Silenzio. Udite. E' fu già un pastore figliuol d'Apollo, chiamato Aristeo. Costui amò con sì sfrenato ardore Euridice, che moglie fu di Orpheo, che seguendola un giorno per amore fu cagion del suo caso acerbo e reo: perché, fuggendo lei vicina all'acque, una biscia la punse; e morta giacque. Orpheo cantando all'Inferno la tolse, ma non poté servar la legge data, ché 'l poverel tra via dietro si volse sì che di nuovo ella gli fu rubata: però ma' più amar donna non volse, e dalle donne gli fu morte data. Seguita un pastore schiavone: State tenta, bragata! Bono argurio, ché di cievol in terra vien Marcurio. Mopso pastor vecchio: Hai tu veduto un mio vitelin bianco, ch'ha una macchia nera in sulla fronte e duo piè rossi et un ginocchio e 'l fianco? Aristeo pastor giovane: 3 Caro mio Mopso, a piè di questo fonte non son venuti questa mane armenti, ma senti' ben mugghiar là drieto al monte. Va', Tyrsi, e guarda un poco se tu 'l senti. Tu, Mopso, intanto ti starai qui meco, ch'i' vo' ch'ascolti i mie' lamenti. Hier vidi sotto quello ombroso speco una nympha più bella che Diana, ch'un giovane amatore havea seco. Com'io vidi sua vista più che humana, subito mi si scosse il cor nel pecto e mie mente d'amor divenne insana: tal ch'io non sento, Mopso, più dilecto ma sempre piango, e 'l cibo non mi piace, e senza mai dormir son stato in letto. Mopso: Aristeo mio, questa amorosa face se di spegnerla tosto non fai pruova, presto vedrai turbata ogni tua pace. Sappi ch'amor non m'è già cosa nuova; so come mal, quand'è vecchio, si regge: rimedia tosto, or che 'l rimedio giova. Se tu pigli Aristeo, suo dure legge, e' t'uscirà del capo e sciami et horti e vite e biade e paschi e mandre e gregge. Aristeo: Mopso, tu parli queste cose a' morti: sì che non spender meco tal parole, acciò che 'l vento via non se le porti. Aristeo ama e disamar non vuole, né guarir cerca di sì dolce doglie: quel loda Amor che di lui ben si duole. Ma se punto ti cal delle mie voglie, deh, tra' fuor della tasca la zampogna, e canteren sotto l'ombrose foglie: ch'i' so che la mia nympha el canto agogna. Canzona. Udite, selve, mie dolce parole, poi che la nympha mia udir non vuole. La bella nympha è sorda al mio lamento e 'l suon di nostra fistula non cura: di ciò si lagna el mio cornuto armento, né vuol bagnar il grifo in acqua pura; non vuol toccar la tenera verdura, tanto del suo pastor gl'incresce e dole. Udite, selve, mie dolce parole, poi che la nympha mia udir non vuole. Ben si cura l'armento del padrone: 3 la nympha non si cura dell'amante, la bella nympha che di sasso ha 'l core, anzi di ferro, anzi l'ha di diamante. Ella fugge da me sempre davante com'agnella dal lupo fuggir suole. Udite, selve, mie dolce parole, poi che la nympha mia udir non vuole. Digli, zampogna mia, come via fugge cogli anni insieme suo bellezza snella e digli come 'l tempo ne distrugge, né l'età persa mai si rinnovella: digli che sappi usar suo forma bella, che sempre mai non son rose e viole. Udite, selve, mie dolce parole, poi che la nympha mia udir non vuole. Portate, venti, questi dolci versi drento all'orecchie della donna mia: dite quante io per lei lacrime versi e la pregate che crudel non sia; dite che la mie vita fugge via e si consuma come brina al sole. Udite, selve, mie dolce parole, poi che la nympha mia udir non vuole. Mopso: El non è tanto el mormorio piacevole delle fresche acque che d'un saxo piombano, né quanto soffia un ventolino agevole fra le cime de' pini e quelle trombano, quanto le rime tue son sollazzevole, le rime tue che per tutto rimbombano: s'ella l'ode, verrà com'una cucciola. Ma ecco Tyrsi che del monte sdrucciola. Ch'è del vitello? ha'lo tu ritrovato? Tyrsi: Sì, così gli avessi el collo mozzo! ché poco men che non m'ha sbudellato, sì corse per volermi dar di cozzo. Pur l'ho poi nella mandria raviato, ma ben so dirti che gli ha pieno il gozzo: i' ti so dir che gli ha stivata l'epa in un campo di gran, tanto che crepa. Ma io ho vista una gentil donzella che va cogliendo fiori intorno al monte. I' non credo che Vener sia più bella, più dolce in acto o più superba in fronte: e parla e canta in sì dolce favella che i fiumi isvolgerebbe inverso il fonte; di neve e rose ha 'l volto e d'or la testa, tutta soletta e sotto bianca vesta. 3 Aristeo: Rimanti, Mopso, ch'i' la vo' seguire, perché l'è quella di chi io t'ho parlato. Mopso: Guarda, Aristeo, che 'l troppo grande ardire non ti conduca in qualche tristo lato. Aristeo: O mi convien questo giorno morire, o tentar quanta forza habbia 'l mie fato. Rimanti, Mopso, intorno a questo fonte, ch'i' vogl'ire a trovalla sopra 'l monte. Mopso: O Tyrsi, che ti par del tuo car sire? Vedi tu quanto d'ogni senso è fore! Tu gli potresti pur talvolta dire quanta vergogna gli fa questo amore. Tyrsi: O Mopso, al servo sta bene ubidire, e matto è chi comanda al suo signore. Io so che gli è più saggio assai che noi: a me basta guardar le vacche e ' buoi. Aristeo ad Euridice: Non mi fuggir, donzella, ch'i' ti son tanto amico e che più t'amo che la vita e 'l core. Ascolta, o nympha bella, ascolta quel ch'i' dico; non fuggir, nympha, chi ti porta amore. Non son qui lupo o orso, ma son tuo amatore: dunque rafrena il tuo volante corso. Poi che el pregar non vale e tu via ti dilegui, e' convien ch'io ti segui. Porgimi, Amor, porgimi hor le tue ale! Seguitando Aristeo Euridice, ella si fugge drento alla selva, dove punta dal serpente grida, e simile Aristeo. Segue poi un pastore ad Orpheo così: Crudel novella ti rapporto, Orpheo: che tuo nympha bellissima è defunta. Ella fuggiva l'amante Aristeo, ma quando fu sopra la riva giunta, da un serpente venenoso e reo 3 ch'era fra l'herb'e fior, nel piè fu punta: e fu tanto possente e crudo el morso ch'ad un tratto finì la vita e 'l corso. Orpheo: Dunque piangiamo, o sconsolata lira, ché più non si convien l'usato canto. Piangiam, mentre che 'l ciel ne' poli agira e Philomela ceda al nostro pianto. O cielo, o terra, o mare! o sorte dira! Come potrò soffrir mai dolor tanto? Euridice mia bella, o vita mia, senza te non convien che 'n vita stia. Andar convienmi alle tartaree porte e provar se là giù merzé s'empetra. Forse che svolgeren la dura sorte co' lacrimosi versi, o dolce cetra; forse ne diverrà pietosa Morte ché già cantando abbiam mosso una pietra, la cervia e 'l tigre insieme avemo accolti e tirate le selve, e ' fiumi svolti. Pietà! Pietà! del misero amatore pietà vi prenda, o spiriti infernali. Qua giù m'ha scorto solamente Amore, volato son qua giù colle sue ali. Posa, Cerbero, posa il tuo furore, ché quando intenderai tutte e' mie mali, non solamente tu piangerai meco, ma qualunque è qua giù nel mondo cieco. Non bisogna per me, Furie, mugghiare, non bisogna arricciar tanti serpenti: se voi sapessi le mie doglie amare, faresti compagnia a' mie' lamenti. Lasciate questo miserel passare ch'ha 'l ciel nimico e tutti gli elementi, che vien per impetrar merzé da Morte: dunque gli aprite le ferrate porte. Pluto: Chi è costui che con suo dolce nota muove l'abisso, e con l'ornata cetra? I' veggo fixa d'Ixion la rota, Sysifo assiso sopra la sua petra e le Belide star con l'urna vota, né più l'acqua di Tantalo s'arretra; e veggo Cerber con tre bocche intento e le Furie aquietate al pio lamento. Orpheo: O regnator di tutte quelle genti ch'hanno perduto la superna luce, 3 al qual discende ciò che gli elementi, ciò che natura sotto 'l ciel produce, udite la cagion de' mie' lamenti. Pietoso amor de' nostri passi è duce: non per Cerber legar fei questa via, ma solamente per la donna mia. Una serpe tra' fior nascosa e l'herba mi tolse la mia donna, anzi il mio core: ond'io meno la vita in pena acerba, né posso più resistere al dolore. Ma se memoria alcuna in voi si serba del vostro celebrato antico amore, se la vecchia rapina a mente havete, Euridice mie bella mi rendete. Ogni cosa nel fine a voi ritorna, ogni cosa mortale a voi ricade: quanto cerchia la luna con suo corna convien ch'arrivi alle vostre contrade. Chi più chi men tra' superi soggiorna, ognun convien ch'arrivi a queste strade; quest'è de' nostri passi extremo segno: poi tenete di noi più longo regno. Così la nimpha mia per voi si serba quando suo morte gli darà natura. Hor la tenera vite e l'uva acerba tagliata havete colla falce dura. Chi è che mieta la sementa in herba e non aspetti che la sia matura? Dunque rendete a me la mia speranza: i' non vel cheggio in don, quest'è prestanza. Io ve ne priego pelle turbide acque della palude Stigia e d'Acheronte; pel Caos onde tutto el mondo nacque e pel sonante ardor di Flegetonte; pel pomo ch'a te già, regina, piacque quando lasciasti pria nostro orizonte. E se pur me la nieghi iniqua sorte, io non vo' su tornar, ma chieggio morte. Proserpina: Io non credetti, o dolce mie consorte, che Pietà mai veisse in questo regno: hor la veggio regnare in nostra corte et io sento di lei tutto 'l cor pregno; né solo i tormentati, ma la Morte veggio che piange del suo caso indegno: dunque tua dura legge a lui pieghi, pel canto, pell'amor, pe' giusti prieghi. Pluto: Io te la rendo, ma con queste leggi: 4 che la ti segua per la ceca via, ma che tu mai la suo faccia non veggi finché tra' vivi pervenuta sia; dunque el tuo gran disire, Orpheo, correggi, se non, che subito tolta ti fia. I' son contento che a sì dolce plectro s'inchini la potenza del mio sceptro. Orpheo vien cantando alcuni versi lieti e volgesi. Euridice parla: Oimè, che 'l troppo amore n'ha disfatti ambendua. Ecco ch'i' ti son tolta a gran furore, né sono hormai più tua. Ben tendo a te le braccia, ma non vale, ché 'ndrieto son tirata. Orpheo mie, vale! Orpheo: Oimè, se' mi tu tolta, Euridice mie bella? O mie furore, o duro fato, o ciel nimico, o Morte! O troppo sventurato el nostro amore! Ma pur un'altra volta convien ch'i' torni alla plutonia corte. Una furia: Più non venire avanti, anzi 'l piè ferma e di te stesso omai teco ti dole: vane son tuo parole, vano el pianto e 'l dolor. Tuo legge è ferma. Orpheo: Qual sarà mai sì miserabil canto che pareggi il dolor del mie gran danno? O come potrò mai lacrimar tanto ch'i' sempre pianga el mio mortale affanno? Starommi mesto e sconsolato in pianto per fin ch'e' cieli in vita mi terranno: e poi che sì crudele è mia fortuna, già mai non voglio amar più donna alcuna. Da qui innanzi vo' côr e' fior novelli, la primavera del sexo migliore, quando son tutti leggiadretti e snelli: quest'è più dolce e più soave amore. Non sie chi mai di donna mi favelli, po' che mort'è colei ch'ebbe 'l mio core; chi vuol commerzio haver co' mie' sermoni di feminile amor non mi ragioni. Quant'è misero l'huom che cangia voglia per donna o mai per lei s'allegra o dole, o qual per lei di libertà si spoglia o crede a suo' sembianti, a suo parole! 4 Ché sempre è più leggier ch'al vento foglia e mille volte el dì vuole e disvole; segue chi fugge, a chi la vuol s'asconde, e vanne e vien come alla riva l'onde. Fanne di questo Giove intera fede, che dal dolce amoroso nodo avinto si gode in cielo il suo bel Ganymede; e Phebo in terra si godea Hyacinto; a questo santo amore Hercole cede che vinse il mondo e dal bello Hyla è vinto: conforto e' maritati a far divorzio, e ciascun fugga el feminil consorzio. Una Baccante: Ecco quel che l'amor nostro disprezza! O, o, sorelle! O, o, diamoli morte! Tu scaglia il tirso; e tu quel ramo spezza; tu piglia o saxo o fuoco e gitta forte; tu corri e quella pianta là scavezza. O, o, facciam che pena el tristo porte! O, o, caviangli il cor del pecto fora! Mora lo scelerato, mora! mora! Torna la Baccante colla testa di Orpheo e dice: O, o, ! O, o, ! mort'è lo scelerato! Euoè! Bacco, Bacco, i' ti ringrazio! Per tutto 'l bosco l'habbiamo stracciato, tal ch'ogni sterpo è del suo sangue sazio. L'habbiamo a membro a membro lacerato in molti pezzi con crudele strazio. Or vadi e biasimi la teda legittima! Euoè Bacco! accepta questa vittima! El coro delle Baccante Ognun segua, Bacco, te! Bacco, Bacco, euoè! Chi vuol bevere, chi vuol bevere, venga abevere, venga qui. Voi 'mbottate come pevere: i' vo' bevere ancor mi! Gli è del vino ancor per ti, lascia bevere inprima a me. Ognun segua, Bacco, te! Bacco, Bacco, euoè! Io ho voto già il mio corno: damm'un po' 'l bottazzo qua! Questo monte gira intorno, e 'l cervello a spasso va. Ognun corra 'n za e in là come vede fare a me. Ognun segua, Bacco, te! 4 Bacco, Bacco, euoè! I' mi moro già di sonno: son io ebria, o sì o no? Star più ritte in piè non ponno: voi siate ebrie, ch'io lo so! Ognun facci come io fo: ognun succi come me! Ognun segua, Bacco, te! Bacco, Bacco, euoè! Ognun cridi: Bacco, Bacco! e pur cacci del vin giù. Po' co' suoni faren fiacco: bevi tu, e tu, e tu! I' non posso ballar più. Ognun cridi: euoè! Ognun segua, Bacco, te! Bacco, Bacco, euoè! 4 Sannazaro, Arcadia, I [Iacopo Sannazaro, Opere volgari, a cura di Alfredo Mauro, Bari, Laterza, 1961] Giace nella sommità di Partenio, non umile monte de la pastorale Arcadia, un dilettevole piano, di ampiezza non molto spazioso però che il sito del luogo nol consente, ma di minuta e verdissima erbetta sì ripieno, che se le lascive pecorelle con gli avidi morsi non vi pascesseno, vi si potrebbe di ogni tempo ritrovare verdura. Ove, se io non mi inganno, son forse dodici o quindici alberi, di tanto strana et eccessiva bellezza, che chiunque li vedesse, giudicarebbe che la maestra natura vi si fusse con sommo diletto studiata in formarli. Li quali alquanto distanti, et in ordine non artificioso disposti, con la loro rarità la naturale bellezza del luogo oltra misura annobiliscono. Quivi senza nodo veruno si vede il drittissimo abete, nato a sustinere i pericoli del mare; e con più aperti rami la robusta quercia e l'alto frassino e lo amenissimo platano vi si distendono, con le loro ombre non picciola parte del bello e copioso prato occupando. Et èvi con più breve fronda l'albero, di che Ercule coronar si solea, nel cui pedale le misere figliuole di Climene furono transformate. Et in un de' lati si scerne il noderoso castagno, il fronzuto bosso e con puntate foglie lo eccelso pino carico di durissimi frutti; ne l'altro lo ombroso faggio, la incorruttibile tiglia e 'l fragile tamarisco, insieme con la orientale palma, dolce et onorato premio de' vincitori. Ma fra tutti nel mezzo presso un chiaro fonte sorge verso il cielo un dritto cipresso, veracissimo imitatore de le alte mete, nel quale non che Ciparisso, ma, se dir conviensi, esso Apollo non si sdegnarebbe essere transfigurato. Né sono le dette piante sì discortesi, che del tutto con le lor ombre vieteno i raggi del sole entrare nel dilettoso boschetto; anzi per diverse parti sì graziosamente gli riceveno, che rara è quella erbetta che da quelli non prenda grandissima recreazione. E come che di ogni tempo piacevole stanza vi sia, ne la fiorita primavera più che in tutto il restante anno piacevolissima vi si ritruova. In questo così fatto luogo sogliono sovente i pastori con li loro greggi dagli vicini monti convenire, e quivi in diverse e non leggiere pruove esercitarse; sì come in lanciare il grave palo, in trare con gli archi al versaglio, et in addestrarse nei lievi salti e ne le forti lotte, piene di rusticane insidie; e 'l più de le volte in cantare et in sonare le sampogne a pruova l'un de l'altro, non senza pregio e lode del vincitore. Ma essendo una fiata tra l'altre quasi tutti i convicini pastori con le loro mandre quivi ragunati, e ciascuno, varie maniere cercando di sollacciare, si dava maravigliosa festa, Ergasto solo, senza alcuna cosa dire o fare, appiè di un albero, dimenticato di sé e de' suoi greggi giaceva, non altrimente che se una pietra o un tronco stato fusse, quantunque per adietro solesse oltra gli altri pastori essere dilettevole e grazioso. Del cui misero stato Selvaggio mosso a compassione, per dargli alcun conforto, così amichevolmente ad alta voce cantando gli incominciò a parlare: Selvaggio et Ergasto Selv. Ergasto mio, perché solingo e tacito pensar ti veggio? Oimè, che mal si lassano le pecorelle andare a lor ben placito! Vedi quelle che 'l rio varcando passano; vedi quei duo monton che 'nsieme correno come in un tempo per urtar s'abassano. Vedi c'al vincitor tutte soccorreno e vannogli da tergo, e 'l vitto scacciano e con sembianti schivi ognor l'aborreno. E sai ben tu che i lupi, ancor che tacciano, fan le gran prede; e i can dormendo stannosi, 4 però che i lor pastor non vi s'impacciano. Già per li boschi i vaghi ucelli fannosi i dolci nidi, e d'alti monti cascano le nevi, che pel sol tutte disfannosi. E par che i fiori per le valli nascano, et ogni ramo abbia le foglia tenere, e i puri agnelli per l'erbette pascano. L'arco ripiglia il fanciullin di Venere, che di ferir non è mai stanco, o sazio di far de le medolle arida cenere. Progne ritorna a noi per tanto spazio con la sorella sua dolce cecropia a lamentarsi de l'antico strazio. A dire il vero, oggi è tanta l'inopia di pastor che cantando all'ombra seggiano, che par che stiamo in Scitia o in Etiopia. Or poi che o nulli o pochi ti pareggiano a cantar versi sì leggiadri e frottole, deh canta omai, che par che i tempi il cheggiano. Erg. Selvaggio mio, per queste oscure grottole Filomena né Progne vi si vedono, ma meste strigi et importune nottole. Primavera e suoi dì per me non riedono, né truovo erbe o fioretti che mi gioveno, ma solo pruni e stecchi che 'l cor ledono. Nubbi mai da quest'aria non si moveno, e veggio, quando i dì son chiari e tepidi, notti di verno, che tonando pioveno. Perisca il mondo, e non pensar ch'io trepidi; ma attendo sua ruina, e già considero che 'l cor s'adempia di pensier più lepidi. Caggian baleni e tuon quanti ne videro i fier giganti in Flegra, e poi sommergasi la terra e 'l ciel, ch'io già per me il desidero. Come vuoi che 'l prostrato mio cor ergasi a poner cura in gregge umile e povero, ch'io spero che fra' lupi anzi dispergasi? Non truovo tra gli affanni altro ricovero che di sedermi solo appiè d'un acero, d'un faggio, d'un abete o ver d'un sovero; ché pensando a colei che 'l cor m'ha lacero divento un ghiaccio, e di null'altra curomi, né sento il duol ond'io mi struggo e macero. Selv. Per maraviglia più che un sasso induromi, udendoti parlar sì malinconico, e 'n dimandarti alquanto rassicuromi. Qual è colei c'ha 'l petto tanto erronico, 4 che t'ha fatto cangiar volto e costume? Dimel, che con altrui mai nol commonico. Erg. Menando un giorno gli agni presso un fiume, vidi un bel lume in mezzo di quell'onde, che con due bionde trecce allor mi strinse, e mi dipinse un volto in mezzo al core che di colore avanza latte e rose; poi si nascose in modo dentro all'alma, che d'altra salma non mi aggrava il peso. Così fui preso; onde ho tal giogo al collo, ch'il pruovo e sollo più c'uom mai di carne, tal che a pensarne è vinta ogni alta stima. Io vidi prima l'uno e poi l'altro occhio; fin al ginocchio alzata al parer mio in mezzo al rio si stava al caldo cielo; lavava un velo, in voce alta cantando. Oimè, che quando ella mi vide, in fretta la canzonetta sua spezzando tacque, e mi dispiacque che per più mie' affanni si scinse i panni e tutta si coverse; poi si sommerse ivi entro insino al cinto, tal che per vinto io caddi in terra smorto. E per conforto darmi, ella già corse, e mi soccorse, sì piangendo a gridi, c'a li suo' stridi corsero i pastori che eran di fuori intorno a le contrade, e per pietade ritentàr mill'arti. Ma i spirti sparti al fin mi ritornaro e fen riparo a la dubbiosa vita. Ella pentita, poi ch'io mi riscossi, allor tornossi indietro, e 'l cor più m'arse, sol per mostrarse in un pietosa e fella. La pastorella mia spietata e rigida, che notte e giorno al mio soccorso chiamola, e sta soperba e più che ghiaccio frigida, ben sanno questi boschi quanto io amola; sannolo fiumi, monti, fiere et omini, c'ognor piangendo e sospirando bramola. Sallo, quante fïate il dì la nomini, il gregge mio, che già a tutt'ore ascoltami, o ch'egli in selva pasca o in mandra romini. Eco rimbomba, e spesso indietro voltami le voci che sì dolci in aria sonano, e nell'orecchie il bel nome risoltami. Quest'alberi di lei sempre ragionano e ne le scorze scritta la dimostrano, c'a pianger spesso et a cantar mi spronano. Per lei li tori e gli arïeti giostrano. 4 Machiavelli, De principatibus [Niccolò Machiavelli, Il principe, a cura di Giorgio Inglese, Torino, Einaudi, 1995] XXV QUANTUM FORTUNA IN REBUS HUMANIS POSSIT ET QUOMODO ILLI SIT OCCURRENDUM. E' non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo sieno in modo governate, da la fortuna e da Dio, che li uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo potrebbono iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne' nostri tempi per le variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì, fuora di ogni umana coniettura. A che pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione loro. Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l'altra metà, o presso, a noi. E assimiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e' piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano da questa parte terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all'impeto loro sanza potervi in alcuna parte ostare. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi queti, non vi potessino fare provedimento e con ripari e con argini: in modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono per uno canale o l'impeto loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta e' sua impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini né e' ripari a tenerla. E se voi considerrete la Italia, che è la sedia di queste variazioni e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna sanza argini e sanza alcuno riparo: che, s'ella fussi riparata da conveniente virtù, come è la Magna, la Spagna e la Francia, o questa piena non arebbe fatto le variazioni grande che la ha, o la non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti aver detto, quanto allo opporsi alla fortuna, in universali. Ma ristringendomi più a' particulari, dico come si vede oggi questo principe felicitare e domani ruinare, sanza avergli veduto mutare natura o qualità alcuna; il che credo che nasca, prima, da le cagioni che si sono lungamente per lo addreto discorse: cioè che quel principe, che si appoggia tutto in su la fortuna, rovina come quella varia. Credo ancora che sia felice quello che riscontra il modo del procedere suo con la qualità de' tempi: e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano e' tempi. Perché si vede gli uomini, nelle cose che gli conducono al fine quale ciascuno ha innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente: l'uno con rispetto, l'altro con impeto; l'uno per violenzia, l'altro con arte; l'uno con pazienza, l'altro col suo contrario; e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora dua respettivi, l'uno pervenire al suo disegno, l'altro no; e similmente dua equalmente felicitare con diversi studi, sendo l'uno rispettivo e l'altro impetuoso: il che non nasce da altro, se non da la qualità de' tempi che si conformano, o no, col procedere loro. Di qui nasce quello ho detto, che dua, diversamente operando, sortiscono el medesimo effetto: e dua equalmente operando, l'uno si conduce al suo fine e l'altro no. Da questo ancora depende la variazione del bene; perché se uno, che si governa con rispetti e pazienza, e' tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono, e' viene felicitando: ma se e' tempi e le cose si mutano, rovina, perché e' non muta modo di procedere. Né si truova uomo sì prudente che si sappia accommodare a questo: sì perché non si può deviare da quello a che la natura lo inclina, sì etiam perché, avendo sempre uno prosperato camminando per una via, non si può persuadere che sia bene partirsi da quella. E però l'uomo respettivo, quando e' gli è 4 tempo di venire allo impeto, non lo sa fare: donde e' rovina; che se si mutassi natura con e' tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna. Papa Iulio II procedé in ogni sua azione impetuosamente, e trovò tanto e' tempi e le cose conforme a quello suo modo di procedere che sempre sortì felice fine. Considerate la prima impresa ch'e' fe' di Bologna, vivendo ancora messer Giovanni Bentivogli. Viniziani non se ne contentavano; el re di Spagna, quel medesimo; con Francia aveva ragionamenti di tale impresa. E lui nondimanco con la sua ferocità e impeto si mosse personalmente a quella espedizione. La qual mossa fece stare sospesi e fermi Spagna e viniziani, quegli per paura e quell'altro per il desiderio aveva di recuperare tutto el regno di Napoli; e da l'altro canto si tirò dietro il re di Francia perché, vedutolo quel re mosso e desiderando farselo amico per abbassare e' viniziani, iudicò non poterli negare gli eserciti sua sanza iniuriarlo manifestamente. Condusse adunque Iulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro pontefice, con tutta la umana prudenza, arebbe condotto. Perché, se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusioni ferme e tutte le cose ordinate, come qualunque altro pontefice arebbe fatto, mai gli riusciva: perché il re di Francia arebbe avuto mille scuse e li altri li arebbono messo mille paure. Io voglio lasciare stare le altre sua azioni, che tutte sono state simili e tutte gli sono successe bene: e la brevità della vita non li ha lasciato sentire il contrario; perché, se fussino sopravvenuti tempi che fussi bisognato procedere con respetti, ne seguiva la sua rovina: né mai arebbe deviato da quegli modi alli quali la natura lo inclinava. Concludo adunque che, variando la fortuna e' tempi e stando li uomini ne' loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme e, come e' discordano, infelici. Io iudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che respettivo: perché la fortuna è donna ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. E si vede che la si lascia più vincere da questi, che da quegli che freddamente procedono: e però sempre, come donna, è amica de' giovani, perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la comandano. 4 Ariosto, Orlando furioso [Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 1966] Canto X 92 E vide Ibernia fabulosa, dove il santo vecchiarel fece la cava, in che tanta mercé par che si truove, che l'uom vi purga ogni sua colpa prava. Quindi poi sopra il mare il destrier muove là dove la minor Bretagna lava: e nel passar vide, mirando a basso, Angelica legata al nudo sasso. 93 Al nudo sasso, all'Isola del pianto; che l'Isola del pianto era nomata quella che da crudele e fiera tanto et inumana gente era abitata, che (come io vi dicea sopra nel canto) per varii liti sparsa iva in armata tutte le belle donne depredando, per farne a un mostro poi cibo nefando. 94 Vi fu legata pur quella matina, dove venìa per trangugiarla viva quel smisurato mostro, orca marina, che di aborrevole esca si nutriva. Dissi di sopra, come fu rapina di quei che la trovaro in su la riva dormire al vecchio incantatore a canto, ch'ivi l'avea tirata per incanto. 95 La fiera gente inospitale e cruda alla bestia crudel nel lito espose la bellissima donna, così ignuda come Natura prima la compose. Un velo non ha pure, in che richiuda i bianchi gigli e le vermiglie rose, da non cader per luglio o per dicembre, di che son sparse le polite membre. 96 Creduto avria che fosse statua finta o d'alabastro o d'altri marmi illustri Ruggiero, e su lo scoglio così avinta per artificio di scultori industri; se non vedea la lacrima distinta tra fresche rose e candidi ligustri far rugiadose le crudette pome, e l'aura sventolar l'aurate chiome. 4 97 E come ne' begli occhi gli occhi affisse, de la sua Bradamante gli sovenne. Pietade e amore a un tempo lo traffisse, e di piangere a pena si ritenne; e dolcemente alla donzella disse, poi che del suo destrier frenò le penne: - O donna, degna sol de la catena con chi i suoi servi Amor legati mena, 98 e ben di questo e d'ogni male indegna, chi è quel crudel che con voler perverso d'importuno livor stringendo segna di queste belle man l'avorio terso? Forza è ch'a quel parlare ella divegna quale è di grana un bianco avorio asperso, di sé vedendo quelle parte ignude, ch'ancor che belle sian, vergogna chiude. 99 E coperto con man s'avrebbe il volto, se non eran legate al duro sasso; ma del pianto, ch'almen non l'era tolto, lo sparse, e si sforzò di tener basso. E dopo alcun'signozzi il parlar sciolto, incominciò con fioco suono e lasso: ma non seguì; che dentro il fe' restare il gran rumor che si sentì nel mare. 100 Ecco apparir lo smisurato mostro mezzo ascoso ne l'onda e mezzo sorto. Come sospinto suol da borea o d'ostro venir lungo navilio a pigliar porto, così ne viene al cibo che l'è mostro la bestia orrenda; e l'intervallo è corto. La donna è mezza morta di paura; né per conforto altrui si rassicura. 101 Tenea Ruggier la lancia non in resta, ma sopra mano, e percoteva l'orca. Altro non so che s'assimigli a questa, ch'una gran massa che s'aggiri e torca; né forma ha d'animal, se non la testa, c'ha gli occhi e i denti fuor, come di porca. Ruggier in fronte la ferìa tra gli occhi; ma par che un ferro o un duro sasso tocchi. 102 Poi che la prima botta poco vale, ritorna per far meglio la seconda. L'orca, che vede sotto le grandi ale l'ombra di qua e di là correr su l'onda, lascia la preda certa litorale, 5 e quella vana segue furibonda: dietro quella si volve e si raggira. Ruggier giù cala, e spessi colpi tira. 103 Come d'alto venendo aquila suole, ch'errar fra l'erbe visto abbia la biscia, o che stia sopra un nudo sasso al sole, dove le spoglie d'oro abbella e liscia; non assalir da quel lato la vuole onde la velenosa e soffia e striscia, ma da tergo la adugna, e batte i vanni, acciò non se le volga e non la azzanni: 104 così Ruggier con l'asta e con la spada, non dove era de' denti armato il muso, ma vuol che 'l colpo tra l'orecchie cada, or su le schene, or ne la coda giuso. Se la fera si volta, ei muta strada, et a tempo giù cala, e poggia in suso: ma come sempre giunga in un diaspro, non può tagliar lo scoglio duro et aspro. 105 Simil battaglia fa la mosca audace contra il mastin nel polveroso agosto, o nel mese dinanzi o nel seguace, l'uno di spiche e l'altro pien di mosto: negli occhi il punge e nel grifo mordace, volagli intorno e gli sta sempre accosto; e quel suonar fa spesso il dente asciutto: ma un tratto che gli arrivi, appaga il tutto. 106 Sì forte ella nel mar batte la coda, che fa vicino al ciel l'acqua inalzare; tal che non sa se l'ale in aria snoda, o pur se 'l suo destrier nuota nel mare. Gli è spesso che disia trovarsi a proda; che se lo sprazzo in tal modo ha a durare, teme sì l'ale inaffi all'ippogrifo, che brami invano avere o zucca o schifo. 107 Prese nuovo consiglio, e fu il migliore, di vincer con altre arme il mostro crudo: abbarbagliar lo vuol con lo splendore ch'era incantato nel coperto scudo. Vola nel lito; e per non fare errore, alla donna legata al sasso nudo lascia nel minor dito de la mano l'annel, che potea far l'incanto vano: 108 dico l'annel che Bradamante avea, per liberar Ruggier, tolto a Brunello, 5 poi per trarlo di man d'Alcina rea, mandato in India per Melissa a quello. Melissa (come dianzi io vi dicea) in ben di molti adoperò l'annello; indi l'avea a Ruggier restituito, dal qual poi sempre fu portato in dito. 109 Lo dà ad Angelica ora, perché teme che del suo scudo il fulgurar non viete, e perché a lei ne sien difesi insieme gli occhi che già l'avean preso alla rete. Or viene al lito, e sotto il ventre preme ben mezzo il mar la smisurata cete. Sta Ruggiero alla posta, e lieva il velo; e par ch'aggiunga un altro sole al cielo. 110 Ferì negli occhi l'incantato lume di quella fera, e fece al modo usato. Quale o trota o scaglion va giù pel fiume c'ha con calcina il montanar turbato, tal si vedea ne le marine schiume il mostro orribilmente riversciato. Di qua di là Ruggier percuote assai, ma di ferirlo via non truova mai. 111 La bella donna tuttavolta priega ch'invan la dura squama oltre non pesti. - Torna, per Dio, signor: prima mi slega (dicea piangendo), che l'orca si desti: portami teco e in mezzo il mar mi anniega: non far ch'in ventre al brutto pesce io resti. Ruggier, commosso dunque al giusto grido, slegò la donna, e la levò dal lido. 112 Il destrier punto, ponta i piè all'arena e sbalza in aria e per lo ciel galoppa; e porta il cavalliero in su la schena, e la donzella dietro in su la groppa. Così privò la fera de la cena per lei soave e delicata troppa. Ruggier si va volgendo, e mille baci figge nel petto e negli occhi vivaci. 113 Non più tenne la via, come propose prima, di circundar tutta la Spagna; ma nel propinquo lito il destrier pose, dove entra in mar più la minor Bretagna. Sul lito un bosco era di querce ombrose, dove ognor par che Filomena piagna; ch'in mezzo avea un pratel con una fonte, e quinci e quindi un solitario monte. 5 114 Quivi il bramoso cavallier ritenne l'audace corso, e nel pratel discese; e fe' raccorre al suo destrier le penne, ma non a tal che più le avea distese. Del destrier sceso, a pena si ritenne di salir altri; ma tennel l'arnese: l'arnese il tenne, che bisognò trarre, e contra il suo disir messe le sbarre. 115 Frettoloso, or da questo or da quel canto confusamente l'arme si levava. Non gli parve altra volta mai star tanto; che s'un laccio sciogliea, dui n'annodava. Ma troppo è lungo ormai, Signor, il canto, e forse ch'anco l'ascoltar vi grava: sì ch'io differirò l'istoria mia in altro tempo che più grata sia. 5 Tasso, Gerusalemme liberata [Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Milano, Mondadori, 1992] Canto XII 51 Poi, come un lupo tacito s'imbosca dopo occulto misfatto, e si desvia, da la confusion, da l'aura fosca favorita e nascosa, ella se 'n gìa. Solo Tancredi avien che lei conosca; egli quivi è sorgiunto alquanto pria; vi giunse allor ch'essa Arimon uccise: vide e segnolla, e dietro a lei si mise. 52 Vuol ne l'armi provarla: un uom la stima degno a cui sua virtù si paragone. Va girando colei l'alpestre cima verso altra porta, ove d'entrar dispone. Segue egli impetuoso, onde assai prima che giunga, in guisa avien che d'armi suone, ch'ella si volge e grida: – O tu, che porte, che corri sì? – Risponde: – E guerra e morte. 53 – Guerra e morte avrai; – disse – io non rifiuto darlati, se la cerchi –, e ferma attende. Non vuol Tancredi, che pedon veduto ha il suo nemico, usar cavallo, e scende. E impugna l'uno e l'altro il ferro acuto, ed aguzza l'orgoglio e l'ire accende; e vansi a ritrovar non altrimenti che duo tori gelosi e d'ira ardenti. 54 Degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno teatro, opre sarian sì memorande. Notte, che nel profondo oscuro seno chiudesti e ne l'oblio fatto sì grande, piacciati ch'io ne 'l tragga e 'n bel sereno a le future età lo spieghi e mande. Viva la fama loro; e tra lor gloria splenda del fosco tuo l'alta memoria. 55 Non schivar, non parar, non ritirarsi voglion costor, né qui destrezza ha parte. Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi: toglie l'ombra e 'l furor l'uso de l'arte. Odi le spade orribilmente urtarsi a mezzo il ferro, il piè d'orma non parte; sempre è il piè fermo e la man sempre in moto, né scende taglio in van, né punta a vòto. 5 56 L'onta irrita lo sdegno a la vendetta, e la vendetta poi l'onta rinova; onde sempre al ferir, sempre a la fretta stimol novo s'aggiunge e cagion nova. D'or in or più si mesce e più ristretta si fa la pugna, e spada oprar non giova: dansi co' pomi, e infelloniti e crudi cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi. 57 Tre volte il cavalier la donna stringe con le robuste braccia, ed altrettante da que' nodi tenaci ella si scinge, nodi di fer nemico e non d'amante. Tornano al ferro, e l'uno e l'altro il tinge con molte piaghe; e stanco ed anelante e questi e quegli al fin pur si ritira, e dopo lungo faticar respira. 58 L'un l'altro guarda, e del suo corpo essangue su 'l pomo de la spada appoggia il peso. Già de l'ultima stella il raggio langue al primo albor ch'è in oriente acceso. Vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico, e sé non tanto offeso. Ne gode e superbisce. Oh nostra folle mente ch'ogn'aura di fortuna estolle! 59 Misero, di che godi? oh quanto mesti fiano i trionfi ed infelice il vanto! Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti) di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. Così tacendo e rimirando, questi sanguinosi guerrier cessaro alquanto. Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, perché il suo nome a lui l'altro scoprisse: 60 – Nostra sventura è ben che qui s'impieghi tanto valor, dove silenzio il copra. Ma poi che sorte rea vien che ci neghi e lode e testimon degno de l'opra, pregoti (se fra l'arme han loco i preghi) che 'l tuo nome e 'l tuo stato a me tu scopra, acciò ch'io sappia, o vinto o vincitore, chi la mia morte o la vittoria onore. – 61 Risponde la feroce: – Indarno chiedi quel c'ho per uso di non far palese. Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi un di quei due che la gran torre accese. – Arse di sdegno a quel parlar Tancredi, 5 e: – In mal punto il dicesti; – indi riprese – il tuo dir e 'l tacer di par m'alletta, barbaro discortese, a la vendetta. – 62 Torna l'ira ne' cori, e li trasporta, benché debili in guerra. Oh fera pugna, u'l'arte in bando, u' già la forza è morta, ove, in vece, d'entrambi il furor pugna! Oh che sanguigna e spaziosa porta fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna, ne l'arme e ne le carni! e se la vita non esce, sdegno tienla al petto unita. 63 Qual l'alto Egeo, perché Aquilone o Noto cessi, che tutto prima il volse e scosse, non s'accheta ei però, ma 'l suono e 'l moto ritien de l'onde anco agitate e grosse, tal, se ben manca in lor co 'l sangue vòto quel vigor che le braccia a i colpi mosse, serbano ancor l'impeto primo, e vanno da quel sospinti a giunger danno a danno. 64 Ma ecco omai l'ora fatale è giunta che 'l viver di Clorinda al suo fin deve. Spinge egli il ferro nel bel sen di punta che vi s'immerge e 'l sangue avido beve; e la veste, che d'or vago trapunta le mammelle stringea tenera e leve, l'empie d'un caldo fiume. Ella già sente morirsi, e 'l piè le manca egro e languente. 65 Segue egli la vittoria, e la trafitta vergine minacciando incalza e preme. Ella, mentre cadea, la voce afflitta movendo, disse le parole estreme; parole ch'a lei novo uno spirto ditta, spirto di fé, di carità, di speme: virtù ch'or Dio le infonde, e se rubella in vita fu, la vuole in morte ancella. 66 – Amico, hai vinto: io ti perdon...perdona tu ancora, al corpo no, che nulla pave, a l'alma sì; deh! per lei prega, e dona battesmo a me ch'ogni mia colpa lave. – In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. 67 Poco quindi lontan nel sen del monte scaturia mormorando un picciol rio. 5 Egli v'accorse e l'elmo empié nel fonte, e tornò mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì la man, mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprio. La vide, la conobbe, e restò senza e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza! 68 Non morì già, ché sue virtuti accolse tutte in quel punto e in guardia al cor le mise, e premendo il suo affanno a dar si volse vita con l'acqua a chi co 'l ferro uccise. Mentre egli il suon de' sacri detti sciolse, colei di gioia trasmutossi, e rise; e in atto di morir lieto e vivace, dir parea: <<S'apre il cielo; io vado in pace.>> 69 D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a' gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso sembra per la pietate il cielo e 'l sole; e la man nuda e fredda alzando verso il cavaliero in vece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna, e par che dorma. 70 Come l'alma gentile uscita ei vede, rallenta quel vigor ch'avea raccolto; e l'imperio di sé libero cede al duol già fatto impetuoso e stolto, ch'al cor si stringe e, chiusa in breve sede la vita, empie di morte i sensi e 'l volto. Già simile a l'estinto il vivo langue al colore, al silenzio, a gli atti, al sangue. 5 Marino, Adone [Giambattista Marino, Adone, a cura di Giovanni Pozzi, Milano, Mondadori, 1976] Canto X Le Meraviglie ALLEGORIA Che Adone sotto la condotta di Mercurio e di Venere saglia in cielo, ci disegna che con la favorevole costellazione di questi due pianeti può l'intelletto umano sollevarsi alle più alte specolazioni eziandio delle cose celesti. La grotta della Natura, posta nel cielo della luna, con tutte l'altre circostanze, allude all'antica opinione che stimava in quel cerchio ritrovarsi l'idee di tutte le cose; ed essendo ella così prossima al mondo elementare, madre della umidità e concorrente insieme col sole alla generazione, meritamente le si attribuisce la giuridizione sopra le cose naturali. L'isola de' sogni, che nel medesimo luogo si finge, esprime il dominio e la forza che ha quel pianeta sopra l'ombre notturne e sopra il cerebro umano. La casa dell'Arte, situata nella sfera di Mercurio, lo studio delle varie scienze, la biblioteca de' libri segnalati, l'officina de' primi inventori delle cose, il mappamondo, dove si scorgono tutti gli accidenti dell'universo ed in particolare le moderne guerre della Francia e della Italia, sono per darci ad intendere la qualità di quella stella, potentissima, quando è ben disposta, ad inclinare gli uomini alla virtù e ad operare effetti mirabili in coloro che sotto le nascono. 33 Con più diffuso ancor lungo sermone il fisico divin volea seguire, quando a mezzo il discorso il bel garzone la favella gli tronca e prende a dire: – D'una cosa a spiar l'alta cagione caldo mi move e fervido desire, cosa, che daché pria l'occhio la scorse sempre ha la mente mia tenuta in forse. 34 D'alcune ombrose macchie impressa io veggio dela triforme dea la guancia pura; dimmi il perché; tra mille dubbi ondeggio, né so trovarne opinion secura. Qual immondo contagio, i' ti richeggio, di brutte stampe il vago volto oscura? – Così ragiona; e l'altro un'altra volta la parola ripiglia e dice: – Ascolta, 35 poiché cotanto addentro intender vuoi, al bel quesito sodisfar prometto; ma di ciò la ragion ti dirà poi l'occhio vie meglio assai che l'intelletto. Non mancan già filosofi tra voi che notato hanno in lei questo difetto; studia ciascun d'investigarlo aprova, 5 ma chi s'apponga al ver raro si trova. 36 Afferma alcun che d'altra cosa densa sia tra febo e febea corpo framesso, laqual delo splendor ch'ei le dispensa in parte ad occupar venga il reflesso. Ilche se fusse pur, com'altri pensa, non sempre il volto suo fora l'istesso, né sempre la vedria chi 'n lei s'affisa in un loco macchiata e d'una guisa. 37 Havvi chi crede che, per esser tanto Cinzia vicina agli elementi vostri, dela natura elementare alquanto convien pur che partecipe si mostri. Così la gloria immacolata e 'l vanto cerca contaminar de' regni nostri, come cosa del ciel sincera e schietta possa di vil mistura essere infetta. 38 Altri vi fu ch'esser quel globo disse quasi opaco cristal che 'l piombo ha dietro e che col suo reverbero venisse l'ombra dele montagne a farlo tetro. Ma qual sì terso mai fu che ferisse per cotanta distanza acciaio o vetro? e qual vista cerviera in specchio giunge l'imagini a mirar così da lunge? 39 Egli è dunque da dir che più secreta colà s'asconda ed esplorata invano altra cagion, che penetrar si vieta al'ardimento del'ingegno umano. Or io ti fo saver che quel pianeta non è, com'altri vuol, polito e piano, ma ne' recessi suoi profondi e cupi ha, non men che la terra, e valli e rupi. 40 La superficie sua mal conosciuta dico ch'è pur come la terra istessa, aspra, ineguale e tumida e scrignuta, concava in parte, in parte ancor convessa. Quivi veder potrai, ma la veduta nol può raffigurar se non s'appressa, altri mari, altri fiumi ed altri fonti città, regni, province e piani e monti. 41 E questo è quel che fa laggiù parere nel bel viso di Trivia i segni foschi, bench'altre macchie, ch'or non puoi vedere, vo' ch'entro ancor vi scorga e vi conoschi, 5 che son più spesse e più minute e nere e son pur scogli e colli e campi e boschi; son nel più puro dele bianche gote, ma da terra affisarle occhio non pote. 42 Tempo verrà che senza impedimento queste sue note ancor fien note e chiare, mercé d'un ammirabile stromento per cui ciò ch'è lontan vicino appare e, con un occhio chiuso e l'altro intento specolando ciascun l'orbe lunare, scorciar potrà lunghissimi intervalli per un picciol cannone e duo cristalli. 43 Del telescopio, a questa etate ignoto, per te fia, Galileo, l'opra composta, l'opra ch'al senso altrui, benché remoto, fatto molto maggior l'oggetto accosta. Tu, solo osservator d'ogni suo moto e di qualunque ha in lei parte nascosta, potrai, senza che vel nulla ne' chiuda, novello Endimion, mirarla ignuda. 44 E col medesmo occhial, non solo in lei vedrai dapresso ogni atomo distinto, ma Giove ancor, sotto gli auspici miei, scorgerai d'altri lumi intorno cinto, onde lassù del'Arno i semidei il nome lasceran sculto e dipinto. Che Giulio a Cosmo ceda allor fra giusto e dal Medici tuo sia vinto Augusto. 45 Aprendo il sen del'ocean profondo, ma non senza periglio e senza guerra, il ligure argonauta al basso mondo scoprirà novo cielo e nova terra. Tu del ciel, non del mar Tifi secondo, quanto gira spiando e quanto serra senza alcun rischio, ad ogni gente ascose scoprirai nove luci e nove cose. 46 Ben dei tu molto al ciel, che ti discopra l'invenzion del'organo celeste, ma vie più 'l cielo ala tua nobil opra, che le bellezze sue fa manifeste. Degna è l'imagin tua che sia là sopra tra i lumi accolta, onde si fregia e veste e dele tue lunette il vetro frale tra gli eterni zaffir resti immortale. 47 Non prima no che dele stelle istesse 6 estingua il cielo i luminosi rai esser dee lo splendor, ch'al crin ti tesse onorata corona, estinto mai. Chiara la gloria tua vivrà con esse e tu per fama in lor chiaro vivrai e con lingue di luce ardenti e belle favelleran di te sempre le stelle. – 6 Metastasio, Didone abbandonata [Pietro Metastasio, Opere, a cura di Mario Fubini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968] ARGOMENTO Didone vedova di Sicheo, uccisole il marito da Pigmalione, re diTiro, di lei fratello, fuggì con ampie ricchezze m Africa, dove edificò Cartagine. Fu ivi richiesta in moglie da molti, e soprattutto da Iarba, re de' Mori, e ricusò sempre per serbar fede alle ceneri dell'estinto consorte. Intanto portato Enea da una tempesta alle sponde dell'Africa, fu ricevuto e ristorato da Didone, la quale ardentemente se ne invaghì. Mentr'egli, compiacendosi di tale affetto, si trattenea presso lei, gli fu dagli dei comandato che proseguisse il suo cammino verso Italia, dove gli promettevano una nuova Troia. Partì Enea, e Didone disperatamente si uccise Tutto ciò si ha da Virgilio, il quale con un felice anacronismo unisce il tempo della fondazion di Cartagine agli errori di Enea. Ovidio,lib. III de' Fasti , dice che Iarba s'impadronisse di Cartagine dopo la morte di Didone, e che Anna di lei sorella (che sarà da noi chiamata Selene) fosse anch'essa occultamente invaghita d'Enea. Per comodo della scena si finge che Iarba, curioso di veder Didone, s'introduca in Cartagme come ambasciadore di se stesso, sotto nome d'Arbace. ATTO PRIMO SCENA XVII DIDONE ed ENEA DIDONE Enea, salvo già sei dalla crudel ferita. Per me serban gli dei sì bella vita. ENEA Oh Dio, regina! DIDONE Ancora forse della mia fede incerto stai? ENEA No: più funeste assai son le sventure mie. Vuole il destino... DIDONE Chiari i tuoi sensi esponi. ENEA Vuol... (mi sento morir) ch'io t'abbandoni. DIDONE M'abbandoni! Perché? ENEA Di Giove il cenno, l'ombra del genitor, la patria, il Cielo, la promessa, il dover, l'onor, la fama alle sponde d'Italia oggi mi chiama. La mia lunga dimora pur troppo degli dei mosse lo sdegno. DIDONE E così fin ad ora, perfido, mi celasti il tuo disegno? 6 ENEA Fu pietà. DIDONE Che pietà? Mendace il labbro fedeltà mi giurava, e intanto il cor pensava come lunge da me volgere il piede! A chi, misera me! darò più fede? Vil rifiuto dell'onde, io l'accolgo dal lido; io lo ristoro dalle ingiurie del mar: le navi e l'armi già disperse io gli rendo; e gli do loco nel mio cor, nel mio regno; e questo è poco. Di cento re per lui, ricusando l'amor, gli sdegni irrìto: ecco poi la mercede. A chi, misera me! darò più fede? ENEA Fin ch'io viva, o Didone, dolce memoria al mio pensier sarai: né partirei giammai, se per voler de' numi io non dovessi consacrare il mio affanno all'impero latino. DIDONE Veramente non hanno altra cura gli dei che il tuo destino. ENEA Io resterò, se vuoi che si renda spergiuro un infelice. DIDONE No: Sarei debitrice dell'impero del mondo a' figli tuoi. Va pur: siegui il tuo fato: cerca d'Italia il regno: all'onde, ai venti confida pur la speme tua; ma senti. Farà quell'onde istesse delle vendette mie ministre il Cielo: e tardi allor pentito d'aver creduto all'elemento insano, richiamerai la tua Didone in vano. ENEA Se mi vedessi il core... DIDONE Lasciami, traditore! ENEA Almen dal labbro mio con volto meno irato prendi l'ultimo addio. DIDONE Lasciami, ingrato. 6 ENEA E pur con tanto sdegno non hai ragion di condannarmi. DIDONE Indegno! Non ha ragione, ingrato, un core abbandonato da chi giurogli fé? Anime innamorate, se la provaste mai, ditelo voi per me! Perfido! tu lo sai se in premio un tradimento io meritai da te. E qual sarà tormento, anime innamorate, se questo mio non è? SCENA XVIII ENEA solo ENEA E soffrirò che sia sì barbara mercede premio della tua fede, anima mia! Tanto amor, tanti doni... Ah! pria ch'io t'abbandoni, pèra l'Italia, il mondo; resti in obblio profondo la mia fama sepolta; vada in cenere Troia un'altra volta. Ah che dissi! Alle mie amorose follie, gran genitor, perdona: io n'ho rossore. Non fu Enea che parlò, lo disse Amore. Si parta... E l'empio moro stringerà il mio tesoro? No... Ma sarà frattanto al proprio genitor spergiuro il figlio? Padre, Amor, Gelosia, numi, consiglio! Se resto sul lido, se sciolgo le vele, infido, crudele mi sento chiamar. E intanto, confuso nel dubbio funesto, non parto, non resto, ma provo il martìre, che avrei nel partire, che avrei nel restar. (parte) FINE DELL'ATTO PRIMO 6 Parini, Il Giorno [Giuseppe Parini, Il Giorno, a cura di Dante Isella, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969] Mattino. Sorge il mattino in compagnia dell'alba Dinanzi al sol che di poi grande appare Su l'estremo orizzonte a render lieti Gli animali e le piante e i campi e l'onde. Allora il buon villan sorge dal caro Letto cui la fedel moglie e i minori Suoi figlioletti intiepidìr la notte: Poi sul dorso portando i sacri arnesi Che prima ritrovò Cerere o Pale Move seguendo i lenti bovi, e scote Lungo il picciol sentier da i curvi rami Fresca rugiada che di gemme al paro La nascente del sol luce rifrange. Allora sorge il fabbro, e la sonante Officina riapre, e all'opre torna L'altro dì non perfette; o se di chiave Ardua e ferrati ingegni all'inquieto Ricco l'arche assecura; o se d'argento E d'oro incider vuol gioielli e vasi Per ornamento a nova sposa o a mense. Ma che? Tu inorridisci e mostri in capo Qual istrice pungente irti i capelli Al suon di mie parole? Ah il tuo mattino Signor questo non è. Tu col cadente Sol non sedesti a parca cena, e al lume Dell'incerto crepuscolo non gisti Ieri a posar qual nei tugurj suoi Entro a rigide coltri il vulgo vile. A voi celeste prole a voi concilio Almo di semidei altro concesse Giove benigno: e con altr'arti e leggi Per novo calle a me guidarvi è d'uopo. Tu tra le veglie e le canore scene E il patetico gioco oltre più assai Producesti la notte: e stanco alfine In aureo cocchio col fragor di calde Precipitose rote e il calpestio Di volanti corsier lunge agitasti Il queto aere notturno; e le tenèbre Con fiaccole superbe intorno apristi Siccome allor che il Siculo terreno Da l'uno a l'altro mar rimbombar fèo Pluto col carro a cui splendeano innanzi Le tede de le Furie anguicrinite. Tal ritornasti a i gran palagi: e quivi Cari conforti a te porgea la mensa 6 Cui ricoprien prurigginosi cibi E licor lieti di Francesi colli E d'Ispani e di Toschi o l'Ungarese Bottiglia a cui di verdi ellere Bromio Concedette corona, e disse: or siedi De le mense reina. Alfine il Sonno Ti sprimacciò di propria man le còltrici Molle cedenti, ove te accolto il fido Servo calò le ombrifere cortine: E a te soavemente i lumi chiuse Il gallo che li suole aprire altrui. Dritto è però che a te gli stanchi sensi Da i tenaci papaveri Morfèo Prima non solva che già grande il giorno Fra gli spiragli penetrar contenda De le dorate imposte; e la parete Pingano a stento in alcun lato i rai Del sol ch'eccelso a te pende sul capo. Or qui principio le leggiadre cure Denno aver del tuo giorno: e quindi io deggio Sciorre il mio legno, e co' precetti miei Te ad alte imprese ammaestrar cantando. Già i valetti gentili udìr lo squillo De' penduli metalli a cui da lunge Moto improvviso la tua destra impresse; E corser pronti a spalancar gli opposti Schermi a la luce; e rigidi osservàro Che con tua pena non osasse Febo Entrar diretto a saettarte i lumi. Ergi dunque il bel fianco, e sì ti appoggia Alli origlier che lenti degradando All'omero ti fan molle sostegno; E coll'indice destro lieve lieve Sovra gli occhi trascorri, e ne dilegua Quel che riman de la Cimmeria nebbia; Poi de' labbri formando un picciol arco Dolce a vedersi tacito sbadiglia. Ahi se te in sì vezzoso atto mirasse Il duro capitan quando tra l'arme Sgangherando la bocca un grido innalza Lacerator di ben costrutti orecchi, S'ei te mirasse allor, certo vergogna Avria di sè più che Minerva il giorno Che di flauto sonando al fonte scorse Il turpe aspetto de le guance enfiate. Ma il damigel ben pettinato i crini Ecco s'innoltra; e con sommessi accenti Chiede qual più de le bevande usate Sorbir tu goda in preziosa tazza. Indiche merci son tazza e bevande: Scegli qual più desii. S'oggi a te giova 6 Porger dolci a lo stomaco fomenti Onde con legge il natural calore V'arda temprato, e al digerir ti vaglia, Tu il cioccolatte eleggi, onde tributo Ti diè il Guatimalese e il Caribeo Che di barbare penne avvolto ha il crine: Ma se noiosa ipocondria ti opprime, O troppo intorno a le divine membra Adipe cresce, de' tuoi labbri onora La nettarea bevanda ove abbronzato Arde e fumica il grano a te d'Aleppo Giunto e da Moca che di mille navi Popolata mai sempre insuperbisce. Certo fu d'uopo che da i prischi seggi Uscisse un regno, e con audaci vele Fra straniere procelle e novi mostri E teme e rischi ed inumane fami Superasse i confin per tanta etade Inviolati ancora: e ben fu dritto Se Pizzarro e Cortese umano sangue Più non stimàr quel ch'oltre l'Oceàno Scorrea le umane membra; e se tonando E fulminando alfin spietatamente Balzaron giù da i grandi aviti troni Re Messicani e generosi Incassi, Poi che nuove così venner delizie O gemma de gli eroi al tuo palato. 6 Goldoni, La bottega del caffé [Carlo Goldoni, Teatro, a cura di Marzia Pieri, Torino, Einaudi, 1991] L'AUTORE A CHI LEGGE Quando composi da prima la presente Commedia, lo feci col Brighella e coll'Arlecchino, ed ebbe, a dir vero, felicissimo incontro per ogni parte. Ciò non ostante, dandola io alle stampe, ho creduto meglio servire il Pubblico, rendendola più universale, cambiando in essa non solamente in toscano i due Personaggi suddetti, ma tre altri ancora, che col dialetto veneziano parlavano. Corse in Firenze una Commedia con simil titolo e con vari accidenti a questa simili, perché da questa copiati. Un amico mio di talento e di spirito fece prova di sua memoria; ma avendola una o due volte sole veduta rappresentare in Milano, molte cose da lui inventate dovette per necessità framischiarvi. Donata ho all'amicizia la burla ed ho lodato l'ingegno; nulladimeno, né voglio arrogarmi il buono che non è mio, né voglio che passi per mia qualche cosa che mi dispiace. Ho voluto pertanto informare il Pubblico di un simil fatto, perché confrontandosi la mia, che ora io stampo, con quella dell'amico suddetto, sia palese la verità, e ciascheduno profitti della sua porzione di lode, e della sua porzione di biasimo si contenti. Questa Commedia ha caratteri tanto universali, che in ogni luogo ove fu ella rappresentata, credevasi fatta sul conio degli originali riconosciuti. Il Maldicente fra gli altri trovò il suo prototipo da per tutto, e mi convenne soffrir talora, benché innocente, la taccia d'averlo maliziosamente copiato. No certamente, non son capace di farlo. I miei caratteri sono umani, sono verisimili, e forse veri, ma io li traggo dalla turba universale degli uomini, e vuole il caso che alcuno in essi si riconosca. Quando ciò accade non è mia colpa che il carattere tristo a quel vizioso somigli; ma colpa è del vizioso, che dal carattere ch'io dipingo, trovasi per sua sventura attaccato. Personaggi Ridolfo, caffettiere; Don Marzio, gentiluomo napolitano; Eugenio, mercante; Flamminio, sotto nome di Conte Leandro; Placida, moglie di Flamminio in abito di pellegrina; Vittoria, moglie di Eugenio; Lisaura, ballerina; Pandolfo, biscazziere; Trappola, garzone di Ridolfo; Un Garzone del parrucchiere; Altro Garzone del caffettiere; Un Cameriere 6 di locanda; Capitano di birri, che parla. Birri non parlano Altri Camerieri di locanda, che non parlano Altri Garzoni della bottega del caffè, che non parlano Atto primo Scena prima Ridolfo, Trappola e altri garzoni. RIDOLFO Animo, figliuoli portatevi bene; siate lesti, e pronti a servir gli avventori, con civiltà, con proprietà: perché tante volte dipende il credito d'una bottega, dalla buona maniera di quei che servono. TRAPPOLA Caro signor padrone, per dirvi la verità: questo levarsi di buon'ora non è niente fatto per la mia complessione. RIDOLFO Eppure bisogna levarsi presto. Bisogna servir tutti. A buon'ora vengono quelli che hanno da far viaggio, i lavoranti, i barcaruoli, i marinai, tutta gente che si alza di buon mattino. TRAPPOLA È veramente una cosa, che fa crepar di ridere, vedere anche i facchini venir a bevere il loro caffè. RIDOLFO Tutti cercan di fare quello che fanno gli altri. Una volta correva l'acquavite, adesso è in voga il caffè. TRAPPOLA E quella signora, dove porto il caffè tutte le mattine, quasi sempre mi prega, che io le compri quattro soldi di legna, e pur vuol bevere il suo caffè. RIDOLFO La gola è un vizio, che non finisce mai, ed è quel vizio, che cresce sempre quanto più l'uomo invecchia. TRAPPOLA Non si vede venir nessuno a bottega; si poteva dormire un'altra oretta. RIDOLFO Or ora verrà della gente; non è poi tanto di buon'ora. Non vedete? Il barbiere è aperto, e in bottega lavorano di parrucche. Guarda, anco il botteghino del gioco è aperto. TRAPPOLA Oh in quanto poi a questa biscazza è aperta che è un pezzo. Hanno fatto nottata. RIDOLFO Buono. A messer Pandolfo averà fruttato bene. TRAPPOLA A quel cane frutta sempre bene; guadagna nelle carte, guadagna negli scrocchi, guadagna a far di balla co i baratori. I denari di chi va là dentro, sono tutti suoi. RIDOLFO Non v'innamoraste mai di questo guadagno, perché la farina del diavolo va tutta in crusca. TRAPPOLA Quel povero signor Eugenio! Lo ha precipitato. 6 RIDOLFO Guardate anche quello, che poco giudizio! Ha moglie, una giovane di garbo, e di proposito, e corre dietro a tutte le donne, e poi di più giuoca da disperato. TRAPPOLA Piccole galanterie della gioventù moderna. RIDOLFO Giuoca con quel conte Leandro, e gli ha persi sicuri. TRAPPOLA Oh quel signor Conte, è un bel fior di virtù. RIDOLFO Oh via, andate a tostare il caffè, per farne una caffettiera di fresco. TRAPPOLA Vi metto degli avanzi di ieri sera? RIDOLFO No, fatelo buono. TRAPPOLA Signor padrone, ho poca memoria. Quant'è che avete aperto bottega? RIDOLFO Lo sapete pure. Saranno in circa otto mesi. TRAPPOLA È tempo da mutar costume. RIDOLFO Come sarebbe a dire? TRAPPOLA Quando si apre una bottega nuova, si fa il caffè perfetto. Dopo sei mesi al più, acqua calda, e brodo lungo (parte). RIDOLFO È grazioso costui. Spero che farà bene per la mia bottega; perché in quelle botteghe, dove vi è qualcheduno, che sappia fare il buffone, tutti corrono. Scena sesta Don Marzio, poi Ridolfo. DON MARZIO Ridolfo. RIDOLFO Signore. DON MARZIO Se voi non sapete niente della ballerina, vi racconterò io. RIDOLFO Io per dirgliela, dei fatti degli altri, non me ne curo molto. DON MARZIO Ma sta bene saper qualche cosa, per potersi regolare. Ella è protetta da quella buona lama del conte Leandro, ed egli dai profitti della ballerina ricava il prezzo della sua protezione. In vece di spendere, mangia tutto a quella povera diavola; e per cagione di lui forse è costretta a fare quello, che non farebbe. Oh che briccone! RIDOLFO Ma io son qui tutto il giorno, e posso attestare, che in casa sua non vedo andare altri, che il conte Leandro. DON MARZIO 7 Ha la porta di dietro; pazzo, pazzo! Sempre, flusso, e riflusso. Ha la porta di dietro, pazzo! RIDOLFO Io bado alla mia bottega, s'ella ha la porta di dietro che importa a me? Io non vado a dar di naso a nessuno. DON MARZIO Bestia! Così parli con un par mio? (s'alza) RIDOLFO Le domando perdono, non si può dire una facezia? DON MARZIO Dammi un bicchier di rosolio. RIDOLFO (Questa barzelletta mi costerà due soldi) (fa cenno ai giovani che dieno il rosolio). DON MARZIO (Oh questa poi della ballerina, voglio che tutti la sappiano) (da sé). RIDOLFO Servita del rosolio. DON MARZIO Flusso, e riflusso, per la porta di dietro (bevendo il rosolio). RIDOLFO Ella starà male quando ha il flusso e riflusso per la porta di dietro. 7 Alfieri, Vita [Vittorio Alfieri, Vita, a cura di Giampaolo Dossena, Torino, Einaudi, 1967] INTRODUZIONE Plerique suam ipsi vitam narrare, fiduciam potius morum, quam arrogantiam, arbitrati sunt TACITO, Vita di Agricola Il parlare, e molto più lo scrivere di sé stesso, nasce senza alcun dubbio dal molto amor di sé stesso. Io dunque non voglio a questa mia Vita far precedere né deboli scuse, né false o illusorie ragioni, le quali non mi verrebbero a ogni modo punto credute da altri; e della mia futura veracità in questo mio scritto assai mal saggio darebbero. Io perciò ingenuamente confesso, che allo stendere la mia propria vita inducevami, misto forse ad alcune altre ragioni, ma vie più gagliarda d'ogni altra, l'amore di me medesimo; quel dono cioè, che la natura in maggiore o minor dose concede agli uomini tutti; ed in soverchia dose agli scrittori, principalissimamente poi ai poeti, od a quelli che tali si tengono. Ed è questo dono una preziosissima cosa; poiché da esso ogni alto operare dell'uomo proviene, allor quando all'amor di sé stesso congiunge una ragionata cognizione dei propri suoi mezzi, ed un illuminato trasporto pel vero ed il bello, che non son se non uno. Senza proemizzare dunque più a lungo sui generali, io passo ad assegnare le ragioni per cui questo mio amor di me stesso mi trasse a ciò fare; e accennerò quindi il modo con cui mi propongo di eseguir questo assunto. Avendo io oramai scritto molto, e troppo più forse che non avrei dovuto, è cosa assai naturale che alcuni di quei pochi a chi non saranno dispiaciute le mie opere (se non tra' miei contemporanei, tra quelli almeno che vivran dopo) avranno qualche curiosità di sapere qual io mi fossi. Io ben posso ciò credere, senza neppur troppo lusingarmi, poiché di ogni altro autore anche minimo quanto al valore, ma voluminoso quanto all'opere, si vede ogni giorno e scrivere e leggere, o vendere almeno, la vita. Onde, quand'anche nessun'altra ragione vi fosse, è certo pur sempre che, morto io, un qualche libraio per cavare alcuni più soldi da una nuova edizione delle mie opere, ci farà premettere una qualunque mia vita. E quella verrà verisimilmente scritta da uno che non mi aveva o niente o mal conosciuto, che avrà radunato le materie di essa da fonti o dubbi o parziali; onde codesta vita per certo verrà ad essere, se non altro, alquanto meno verace di quella che posso dare io stesso. E ciò tanto più, perché lo scrittore a soldo dell'editore suol sempre fare uno stolto panegirico dell'autore che si ristampa, stimando ambedue di dare così più ampio smercio alla loro comune mercanzia. Affinché questa mia vita venga dunque tenuta per meno cattiva e alquanto più vera, e non meno imparziale di qualunque altra verrebbe scritta da altri dopo di me; io, che assai più largo mantenitore che non promettitore fui sempre, mi impegno qui con me stesso, e con chi vorrà leggermi, di disappassionarmi per quanto all'uomo sia dato; e mi vi impegno, perché esaminatomi e conosciutomi bene, ho ritrovato, o mi pare, essere in me di alcun poco maggiore la somma del bene a quella del male. Onde, se io non avrò forse il coraggio o l'indiscrezione di dir di me tutto il vero, non avrò certamente la viltà di dir cosa che vera non sia. Quanto poi al metodo, affine di tediar meno il lettore, e dargli qualche riposo e anche i mezzi di abbreviarsela col tralasciare quegli anni di essa che gli parranno meno curiosi, io mi propongo di ripartirla in cinque epoche, corrispondenti alle cinque età dell'uomo, e da essa intitolarne le divisioni, puerizia, adolescenza, giovinezza, virilità e vecchiaia. Ma già, dal modo con cui le tre prime parti e più che mezza la quarta mi son venute scritte, non mi lusingo più ormai di venire a capo di tutta l'opera con quella brevità che più d'ogni altra cosa ho sempre nelle altre mie opere adottata o tentata; e che tanto più lodevole e necessaria forse sarebbe stata nell'atto di parlar di me stesso. Onde tanto più temo che 7 nella quinta parte (ove pure il mio destino mi voglia lasciar invecchiare) io non abbia di soverchio a cader nelle chiacchiere, che sono l'ultimo patrimonio di quella debole età. Se dunque, pagando io in ciò, come tutti, il suo dritto a natura, venissi nel fine a dilungarmi indiscretamente, prego anticipatamente il lettore di perdonarmelo, sì, ma, di gastigarmene a un tempo stesso, col non leggere quell'ultima parte. Aggiungerò nondimeno, che nel dire io che non mi lusingo di essere breve anche nelle quattro prime parti, quanto il dovrei e vorrei, non intendo perciò di permettermi delle risibili lungaggini accennando ogni minuzia; ma intendo di estendermi su molte di quelle particolarità, che, sapute, contribuir potranno allo studio dell'uomo in genere; della qual pianta non possiamo mai individuare meglio i segreti che osservando ciascuno sé stesso. Non ho intenzione di dar luogo a nessuna di quelle altre particolarità che potranno risguardare altre persone, le di cui peripezie si ritrovassero per così dire intarsiate con le mie; stante che i fatti miei bensì, ma non già gli altrui, mi propongo di scrivere. Non nominerò dunque quasi mai nessuno, individuandone il nome, se non se nelle cose indifferenti o lodevoli. Allo studio dunque dell'uomo in genere è principalmente diretto lo scopo di questa opera. E di qual uomo si può egli meglio e più dottamente parlare, che di sé stesso? Quale altro ci vien egli venuto fatto di maggiormente studiare, di più addentro conoscere, di più esattamente pesare, essendo, per così dire, nelle più intime di lui viscere vissuto tanti anni? Quanto poi allo stile, io penso di lasciar fare alla penna, e di pochissimo lasciarlo scostarsi da quella triviale e spontanea naturalezza, con cui ho scritto quest'opera, dettata dal cuore e non dall'ingegno; e che sola può convenire a così umile tema. Epoca Quarta, Capitolo Vigesimosecondo. Erasi frattanto rotta la guerra coll'imperatore, che poi divenne generale e funesta. Venuto il giugno, in cui si tentò già di abbattere intieramente il nome del re, che altro più non rimaneva; la congiura di quel giorno 20 giugno essendo andata fallita, le cose strascinarono ancora malamente sino al famoso dieci d'agosto, in cui la cosa scoppiò come ognuno sa. Accaduto quest'avvenimento, io non indugiai più neppure un giorno, e il mio primo ed unico pensiero essendo di togliere da ogni pericolo la mia donna, già dal dì 12 feci in fretta in fretta tutti i preparativi per la nostra partenza. Rimaneva la somma difficoltà dell'ottenere passaporti per uscir di Parigi, e del regno. Tanto c'industriammo in quei due o tre giorni, che il dì 15, o 16, già gli avevamo ottenuti come forestieri, prima dai ministri di Venezia io, e di Danimarca la signora, che erano quasi che i soli ministri esteri rimasti presso quel simulacro di re. Poi con molto più stento si ottenne dalla sezione nostra comunitativa detta du Montblanc degli altri passaporti, uno per ciascheduno individuo, sì per noi due, che ogni servitore, e cameriera, con la pittura di ciascuno, di statura, pelo, età, sesso, e che so io. Muniti così di tutte queste schiavesche patenti, avevamo fissato la partenza nostra pel lunedì 20 agosto; ma un giusto presentimento, trovandoci allestiti, mi fece anticipare, e si partì il dì 18, sabato, nel dopo pranzo. Appena giunti alla Barrière Blanche, che era la nostra uscita la più prossima per pigliar la via di San Dionigi per Calais, dove ci avviavamo per uscire al più presto di quell'infelice paese; vi ritrovammo tre o quattro soli soldati di guardie nazionali, con un uffiziale, che visti i nostri passaporti, si disponeva ad aprirci il cancello di quell'immensa prigione, e lasciarci ire a buon viaggio. Ma v'era accanto alla Barriera una bettolaccia, di dove sbucarono fuori ad un tratto una trentina forse di manigoldi della plebe, scamisciati, ubriachi, e furiosi. Costoro, viste due carrozze che tante n'avevamo, molto cariche di bauli, e imperiali, ed una comitiva di due donne di servizio, e tre uomini, gridarono che tutti i ricchi se ne voleano fuggir di Parigi, e portar via tutti i loro 7 tesori, e lasciarli essi nella miseria e nei guai. Quindi ad altercare quelle poche e tristi guardie con quei molti e tristi birbi, esse per farci uscire, questi per ritenerci. Ed io balzai di carrozza fra quelle turbe, munito di tutti quei sette passaporti, ad altercare, e gridare, e schiamazzar più di loro; mezzo col quale sempre si vien a capo dei Francesi. Ad uno ad uno si leggevano, e facevano leggere da chi di quelli legger sapeva, le descrizioni delle nostre rispettive figure. Io pieno di stizza e furore, non conoscendo in quel punto, o per passione sprezzando l'immenso pericolo, che ci soprastava, fino a tre volte ripresi in mano il mio passaporto, e replicai ad alta voce: “Vedete, sentite; Alfieri è il mio nome; Italiano e non Francese; grande, magro, sbiancato; capelli rossi, son io quello, guardatemi; ho il passaporto; l'abbiamo avuto in regola da chi lo può dare; e vogliamo passare, e passeremo per Dio”. Durò più di mezz'ora questa piazzata, mostrai buon contegno, e quello ci salvò. Si era frattanto ammassata più gente intorno alle due carrozze, e molti gridavano: “Diamogli il fuoco a codesti legni”. Altri: “Pigliamoli a sassate”. Altri: “Questi fuggono; son dei nobili e ricchi, portiamoli indietro al Palazzo della Città, che se ne faccia giustizia”. Ma insomma il debole aiuto delle quattro guardie nazionali, che tanto qualcosa diceano per noi, ed il mio molto schiamazzare, e con voce di banditore replicare e mostrare i passaporti, e più di tutto la mezz'ora e più di tempo, in cui quei scimiotigri si stancarono di contrastare, rallentò l'insistenza loro; e le guardie accennatomi di salire in carrozza, dove avea lasciato la signora, si può credere in quale stato, io rientratovi, rimontati i postiglioni a cavallo si aprì il cancello, e di corsa si uscì, accompagnati da fischiate, insulti e maledizioni di codesta genia. E buon per noi che non prevalse di essere ricondotti al Palazzo di Città, che arrivando così due carrozze in pompa stracariche, con la taccia di fuggitivi, in mezzo a quella plebaccia si rischiava molto; e saliti poi innanzi ai birbi della Municipalità, si era certi di non poter più partire, d'andare anzi prigioni, dove se ci trovavano nelle carceri il dì 2 settembre, cioè quindici giorni dopo, ci era fatta la festa insieme con tanti altri galantuomini che crudelmente vi furono trucidati. Sfuggiti di un tale inferno, in due giorni e mezzo arrivammo a Calais, mostrando forse quaranta e più volte i nostri passaporti; ed abbiamo saputo poi che noi eramo stati i primi forestieri usciti di Parigi, e del regno dopo la catastrofe del 10 agosto. Ad ogni Municipalità per istrada dove ci conveniva andare e mostrare i nostri passaporti, quei che li leggevano, rimanevano stupefatti ed attoniti alla prima occhiata che ci buttavan sopra, essendo quelli stampati, e cassatovi il nome del re. Poco, e male erano informati di quel che fosse accaduto in Parigi, e tutti tremavano. Son questi gli auspici, sotto cui finalmente uscii della Francia, con la speranza, ed il proponimento di non capitarvi più mai. 7 Foscolo, Ultime lettere di Iacopo Ortis; A Zacinto AL LETTORE Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e di consecrare alla memoria del solo amico mio quelle lagrime, che ora mi si vieta di spargere su la sua sepoltura. E tu, o Lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell'eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, darai, spero, la tua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. LORENZO ALDERANI PARTE I 1 Da' colli Euganei, 11 ottobre 1797. Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli sventurati? E noi, pur troppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl'italiani. Per me segua che può. Poichè ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da' pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de' miei padri. 2 13 Ottobre. Ti scongiuro, Lorenzo; non ribattere più. Ho deliberato di non allontanarmi da questi colli. È vero ch'io aveva promesso a mia madre di rifuggirmi in qualche altro paese; ma non mi è bastato il cuore: e mi perdonerà, spero. Merita poi questa vita di essere conservata con la viltà, e con l'esilio? Oh quanti de' nostri concittadini gemeranno pentiti, lontani dalle loro case! perchè, e che potremmo aspettarci noi se non se indigenza e disprezzo; o al più, breve e sterile compassione, solo conforto che le nazioni incivilite offrono al profugo straniero? Ma dove cercherò asilo? in Italia? terra prostituita premio sempre della vittoria. Potrò io vedermi dinanzi agli occhi coloro che ci hanno spogliati, derisi, venduti, e non piangere d'ira? Devastatori de' popoli, si servono della libertà come i Papi si servivano delle crociate. Ahi! sovente disperando di vendicarmi mi caccerei un coltello nel cuore per versare tutto il mio sangue fra le ultime strida della mia patria. E questi altri? — hanno comperato la nostra schiavitù, racquistando con l'oro quello che stolidamente e vilmente hanno perduto con le armi. — Davvero ch'io somiglio un di que' malavventurati che spacciati morti furono sepolti vivi, e che poi rinvenuti, si sono trovati nel sepolcro fra le tenebre e gli scheletri, certi [di] vivere, ma disperati del dolce lume della vita, e costretti a morire fra le bestemmie e la fame. E perchè farci vedere e sentire la libertà, e poi ritorcela per sempre? e infamemente! 3 16 Ottobre. 7 Or via, non se ne parli più: la burrasca pare abbonacciata; se tornerà il pericolo, rassicurati, tenterò ogni via di scamparne. Del resto io vivo tranquillo; per quanto si può tranquillo. Non vedo persona del mondo: vo sempre vagando per la campagna; ma a dirti il vero penso, e mi rodo. Mandami qualche libro. Che fa Lauretta? povera fanciulla! io l'ho lasciata fuori di sè. Bella e giovine ancora, ha pur inferma la ragione; e il cuore infelice infelicissimo. Io non l'ho amata; ma fosse compassione o riconoscenza per avere ella scelto me solo consolatore del suo stato, versandomi nel petto tutta la sua anima e i suoi errori e i suoi martirj — davvero ch'io l'avrei fatta volentieri compagna di tutta la mia vita. La sorte non ha voluto; meglio così, forse. Ella amava Eugenio, e l'è morto fra le braccia. Suo padre e i suoi fratelli hanno dovuto fuggire la loro patria, e quella povera famiglia destituta di ogni umano soccorso è restata a vivere, chi sa come! di pianto. Eccoti, o Libertà, un'altra vittima. Sai ch'io ti scrivo, o Lorenzo, piangendo come un ragazzo? — pur troppo! ho avuto sempre a che fare con de' tristi; e se alle volte ho incontrato una persona dabbene ho dovuto sempre compiangerla. Addio, addio. A Zacinto Nè più mai toccherò le sacre sponde Ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde Del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde Col suo primo sorriso, onde non tacque Le tue limpide nubi e le tue fronde L'inclito verso di colui che l'acque Cantò fatali, ed il diverso esiglio Per cui bello di fama e di sventura Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, O materna mia terra; a noi prescrisse Il fato illacrimata sepoltura. 7 Leopardi, L’infinito; A Silvia L'INFINITO Sempre caro mi fu quest'ermo colle, E questa siepe, che da tanta parte Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati Spazi di là da quella, e sovrumani Silenzi, e profondissima quiete Io nel pensier mi fingo; ove per poco Il cor non si spaura. E come il vento Odo stormir tra queste piante, io quello Infinito silenzio a questa voce Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, E le morte stagioni, e la presente E viva, e il suon di lei. Così tra questa Immensità s'annega il pensier mio: E il naufragar m'è dolce in questo mare. A SILVIA Silvia, rimembri ancora Quel tempo della tua vita mortale, Quando beltà splendea Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, E tu, lieta e pensosa, il limitare Di gioventù salivi? Sonavan le quiete Stanze, e le vie dintorno, Al tuo perpetuo canto, Allor che all'opre femminili intenta Sedevi, assai contenta Di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso: e tu solevi Così menare il giorno. Io gli studi leggiadri Talor lasciando e le sudate carte, Ove il tempo mio primo E di me si spendea la miglior parte, D'in su i veroni del paterno ostello Porgea gli orecchi al suon della tua voce, Ed alla man veloce Che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, Le vie dorate e gli orti, E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice Quel ch'io sentiva in seno. 7 Che pensieri soavi, Che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia La vita umana e il fato! Quando sovviemmi di cotanta speme, Un affetto mi preme Acerbo e sconsolato, E tornami a doler di mia sventura. O natura, o natura, Perchè non rendi poi Quel che prometti allor? perchè di tanto Inganni i figli tuoi? Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, Da chiuso morbo combattuta e vinta, Perivi, o tenerella. E non vedevi Il fior degli anni tuoi; Non ti molceva il core La dolce lode or delle negre chiome, Or degli sguardi innamorati e schivi; Nè teco le compagne ai dì festivi Ragionavan d'amore. Anche peria fra poco La speranza mia dolce: agli anni miei Anche negaro i fati La giovanezza. Ahi come, Come passata sei, Cara compagna dell'età mia nova, Mia lacrimata speme! Questo è quel mondo? questi I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi Onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? All'apparir del vero Tu, misera, cadesti: e con la mano La fredda morte ed una tomba ignuda Mostravi di lontano. 7 Leopardi LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO Qui su l'arida schiena Del formidabil monte Sterminator Vesevo, La qual null'altro allegra arbor nè fiore, Tuoi cespi solitari intorno spargi, Odorata ginestra, Contenta dei deserti. Anco ti vidi De' tuoi steli abbellir l'erme contrade Che cingon la cittade La qual fu donna de' mortali un tempo, E del perduto impero Par che col grave e taciturno aspetto Faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol, di tristi Lochi e dal mondo abbandonati amante, E d'afflitte fortune ognor compagna. Questi campi cosparsi Di ceneri infeconde, e ricoperti Dell'impietrata lava, Che sotto i passi al peregrin risona; Dove s'annida e si contorce al sole La serpe, e dove al noto Cavernoso covil torna il coniglio; Fur liete ville e colti, E biondeggiàr di spiche, e risonaro Di muggito d'armenti; Fur giardini e palagi, Agli ozi de' potenti Gradito ospizio; e fur città famose Che coi torrenti suoi l'altero monte Dall'ignea bocca fulminando oppresse Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno Una ruina involve, Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi I danni altrui commiserando, al cielo Di dolcissimo odor mandi un profumo, Che il deserto consola. A queste piagge Venga colui che d'esaltar con lode Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto È il gener nostro in cura All'amante natura. E la possanza Qui con giusta misura Anco estimar potrà dell'uman seme, Cui la dura nutrice, ov'ei men teme, Con lieve moto in un momento annulla In parte, e può con moti Poco men lievi ancor subitamente Annichilare in tutto. 7 Dipinte in queste rive Son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Qui mira e qui ti specchia, Secol superbo e sciocco, Che il calle insino allora Dal risorto pensier segnato innanti Abbandonasti, e volti addietro i passi, Del ritornar ti vanti, E procedere il chiami. Al tuo pargoleggiar gl'ingegni tutti, Di cui lor sorte rea padre ti fece, Vanno adulando, ancora Ch'a ludibrio talora T'abbian fra sè. Non io Con tal vergogna scenderò sotterra; Ma il disprezzo piuttosto che si serra Di te nel petto mio, Mostrato avrò quanto si possa aperto: Ben ch'io sappia che obblio Preme chi troppo all'età propria increbbe. Di questo mal, che teco Mi fia comune, assai finor mi rido. Libertà vai sognando, e servo a un tempo Vuoi di novo il pensiero, Sol per cui risorgemmo Della barbarie in parte, e per cui solo Si cresce in civiltà, che sola in meglio Guida i pubblici fati. Così ti spiacque il vero Dell'aspra sorte e del depresso loco Che natura ci diè. Per questo il tergo Vigliaccamente rivolgesti al lume Che il fe palese: e, fuggitivo, appelli Vil chi lui segue, e solo Magnanimo colui Che se schernendo o gli altri, astuto o folle, Fin sopra gli astri il mortal grado estolle. Uom di povero stato e membra inferme Che sia dell'alma generoso ed alto, Non chiama sè nè stima Ricco d'or nè gagliardo, E di splendida vita o di valente Persona infra la gente Non fa risibil mostra; Ma se di forza e di tesor mendico Lascia parer senza vergogna, e noma Parlando, apertamente, e di sue cose Fa stima al vero uguale. Magnanimo animale 8 Non credo io già, ma stolto, Quel che nato a perir, nutrito in pene, Dice, a goder son fatto, E di fetido orgoglio Empie le carte, eccelsi fati e nove Felicità, quali il ciel tutto ignora, Non pur quest'orbe, promettendo in terra A popoli che un'onda Di mar commosso, un fiato D'aura maligna, un sotterraneo crollo Distrugge sì, che avanza A gran pena di lor la rimembranza. Nobil natura è quella Che a sollevar s'ardisce Gli occhi mortali incontra Al comun fato, e che con franca lingua, Nulla al ver detraendo, Confessa il mal che ci fu dato in sorte, E il basso stato e frale; Quella che grande e forte Mostra sè nel soffrir, nè gli odii e l'ire Fraterne, ancor più gravi D'ogni altro danno, accresce Alle miserie sue, l'uomo incolpando Del suo dolor, ma dà la colpa a quella Che veramente è rea, che de' mortali Madre è di parto e di voler matrigna. Costei chiama inimica; e incontro a questa Congiunta esser pensando, Siccome è il vero, ed ordinata in pria L'umana compagnia, Tutti fra sè confederati estima Gli uomini, e tutti abbraccia Con vero amor, porgendo Valida e pronta ed aspettando aita Negli alterni perigli e nelle angosce Della guerra comune. Ed alle offese Dell'uomo armar la destra, e laccio porre Al vicino ed inciampo, Stolto crede così qual fora in campo Cinto d'oste contraria, in sul più vivo Incalzar degli assalti, Gl'inimici obbliando, acerbe gare Imprender con gli amici, E sparger fuga e fulminar col brando Infra i propri guerrieri. Così fatti pensieri Quando fien, come fur, palesi al volgo, E quell'orror che primo Contra l'empia natura Strinse i mortali in social catena, 8 Fia ricondotto in parte Da verace saper, l'onesto e il retto Conversar cittadino, E giustizia e pietade, altra radice Avranno allor che non superbe fole, Ove fondata probità del volgo Così star suole in piede Quale star può quel ch'ha in error la sede. Sovente in queste rive, Che, desolate, a bruno Veste il flutto indurato, e par che ondeggi, Seggo la notte; e su la mesta landa In purissimo azzurro Veggo dall'alto fiammeggiar le stelle, Cui di lontan fa specchio Il mare, e tutto di scintille in giro Per lo vòto seren brillare il mondo. E poi che gli occhi a quelle luci appunto, Ch'a lor sembrano un punto, E sono immense, in guisa Che un punto a petto a lor son terra e mare Veracemente; a cui L'uomo non pur, ma questo Globo ove l'uomo è nulla, Sconosciuto è del tutto; e quando miro Quegli ancor più senz'alcun fin remoti Nodi quasi di stelle, Ch'a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo E non la terra sol, ma tutte in uno, Del numero infinite e della mole, Con l'aureo sole insiem, le nostre stelle O sono ignote, o così paion come Essi alla terra, un punto Di luce nebulosa; al pensier mio Che sembri allora, o prole Dell'uomo? E rimembrando Il tuo stato quaggiù, di cui fa segno Il suol ch'io premo; e poi dall'altra parte, Che te signora e fine Credi tu data al Tutto, e quante volte Favoleggiar ti piacque, in questo oscuro Granel di sabbia, il qual di terra ha nome, Per tua cagion, dell'universe cose Scender gli autori, e conversar sovente Co' tuoi piacevolmente, e che i derisi Sogni rinnovellando, ai saggi insulta Fin la presente età, che in conoscenza Ed in civil costume Sembra tutte avanzar; qual moto allora, Mortal prole infelice, o qual pensiero 8 Verso te finalmente il cor m'assale? Non so se il riso o la pietà prevale. Come d'arbor cadendo un picciol pomo, Cui là nel tardo autunno Maturità senz'altra forza atterra, D'un popol di formiche i dolci alberghi, Cavati in molle gleba Con gran lavoro, e l'opre E le ricchezze che adunate a prova Con lungo affaticar l'assidua gente Avea provvidamente al tempo estivo, Schiaccia, diserta e copre In un punto; così d'alto piombando, Dall'utero tonante Scagliata al ciel profondo, Di ceneri e di pomici e di sassi Notte e ruina, infusa Di bollenti ruscelli O pel montano fianco Furiosa tra l'erba Di liquefatti massi E di metalli e d'infocata arena Scendendo immensa piena, Le cittadi che il mar là su l'estremo Lido aspergea, confuse E infranse e ricoperse In pochi istanti: onde su quelle or pasce La capra, e città nove Sorgon dall'altra banda, a cui sgabello Son le sepolte, e le prostrate mura L'arduo monte al suo piè quasi calpesta. Non ha natura al seme Dell'uom più stima o cura Che alla formica: e se più rara in quello Che nell'altra è la strage, Non avvien ciò d'altronde Fuor che l'uom sue prosapie ha men feconde. Ben mille ed ottocento Anni varcàr poi che spariro, oppressi Dall'ignea forza, i popolati seggi, E il villanello intento Ai vigneti, che a stento in questi campi Nutre la morta zolla e incenerita, Ancor leva lo sguardo Sospettoso alla vetta Fatal, che nulla mai fatta più mite Ancor siede tremenda, ancor minaccia A lui strage ed ai figli ed agli averi Lor poverelli. E spesso 8 Il meschino in sul tetto Dell'ostel villereccio, alla vagante Aura giacendo tutta notte insonne, E balzando più volte, esplora il corso Dal temuto bollor, che si riversa Dall'inesausto grembo Su l'arenoso dorso, a cui riluce Di Capri la marina E di Napoli il porto e Mergellina. E se appressar lo vede, o se nel cupo Del domestico pozzo ode mai l'acqua Fervendo gorgogliar, desta i figliuoli, Desta la moglie in fretta, e via, con quanto Di lor cose rapir posson, fuggendo, Vede lontan l'usato Suo nido, e il picciol campo, Che gli fu dalla fame unico schermo, Preda al flutto rovente, Che crepitando giunge, e inesorato Durabilmente sovra quei si spiega. Torna al celeste raggio Dopo l'antica obblivion l'estinta Pompei, come sepolto Scheletro, cui di terra Avarizia o pietà rende all'aperto; E dal deserto foro Diritto infra le file Dei mozzi colonnati il peregrino Lunge contempla il bipartito giogo E la cresta fumante, Che alla sparsa ruina ancor minaccia. E nell'orror della secreta notte Per li vacui teatri, Per li templi deformi e per le rotte Case, ove i parti il pipistrello asconde, Come sinistra face Che per vòti palagi atra s'aggiri, Corre il baglior della funerea lava, Che di lontan per l'ombre Rosseggia e i lochi intorno intorno tinge. Così, dell'uomo ignara e dell'etadi Ch'ei chiama antiche, e del seguir che fanno Dopo gli avi i nepoti, Sta natura ognor verde, anzi procede Per sì lungo cammino Che sembra star. Caggiono i regni intanto, Passan genti e linguaggi: ella nol vede: E l'uom d'eternità s'arroga il vanto. E tu, lenta ginestra, Che di selve odorate 8 Queste campagne dispogliate adorni, Anche tu presto alla crudel possanza Soccomberai del sotterraneo foco, Che ritornando al loco Già noto, stenderà l'avaro lembo Su tue molli foreste. E piegherai Sotto il fascio mortal non renitente Il tuo capo innocente: Ma non piegato insino allora indarno Codardamente supplicando innanzi Al futuro oppressor; ma non eretto Con forsennato orgoglio inver le stelle, Nè sul deserto, dove E la sede e i natali Non per voler ma per fortuna avesti; Ma più saggia, ma tanto Meno inferma dell'uom, quanto le frali Tue stirpi non credesti O dal fato o da te fatte immortali. 8 Manzoni, I promessi sposi Capitolo XI La strada era deserta, dimodochè, se non avesse sentito un ronzìo lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso d'entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici, come di neve; ma neve non poteva essere; che non viene a strisce, nè, per il solito, in quella stagione. Si chinò sur una di quelle, guardò, toccò, e trovò ch'era farina. - Grand'abbondanza, - disse tra sè, - ci dev'essere in Milano, se straziano in questa maniera la grazia di Dio. Ci davan poi ad intendere che la carestia è per tutto. Ecco come fanno, per tener quieta la povera gente di campagna. - Ma, dopo pochi altri passi, arrivato a fianco della colonna, vide, appiè di quella, qualcosa di più strano; vide sugli scalini del piedestallo certe cose sparse, che certamente non eran ciottoli, e se fossero state sul banco d'un fornaio, non si sarebbe esitato un momento a chiamarle pani. Ma Renzo non ardiva creder così presto a' suoi occhi; perchè, diamine! non era luogo da pani quello. - Vediamo un po' che affare è questo, - disse ancora tra sè; andò verso la colonna, si chinò, ne raccolse uno: era veramente un pan tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiarne che nelle solennità. - È pane davvero! - disse ad alta voce; tanta era la sua maraviglia: - così lo seminano in questo paese? in quest'anno? e non si scomodano neppure per raccoglierlo, quando cade? Che sia il paese di cuccagna questo? - Dopo dieci miglia di strada, all'aria fresca della mattina, quel pane, insieme con la maraviglia, gli risvegliò l'appetito. - Lo piglio? - deliberava tra sè: - poh! l'hanno lasciato qui alla discrezion de' cani; tant'è che ne goda anche un cristiano. Alla fine, se comparisce il padrone, glielo pagherò. - Così pensando, si mise in una tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo, e lo mise nell'altra; un terzo, e cominciò a mangiare; e si rincamminò, più incerto che mai, e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena mosso, vide spuntar gente che veniva dall'interno della città, e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. Erano un uomo, una donna e, qualche passo indietro, un ragazzotto; tutt'e tre con un carico addosso, che pareva superiore alle loro forze, e tutt'e tre in una figura strana. I vestiti o gli stracci infarinati; infarinati i visi, e di più stravolti e accesi; e andavano, non solo curvi, per il peso, ma sopra doglia, come se gli fossero state peste l'ossa. L'uomo reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne seminava un poco, a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna: un pancione smisurato, che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate: come una pentolaccia a due manichi; e di sotto a quel pancione uscivan due gambe, nude fin sopra il ginocchio, che venivano innanzi barcollando. Renzo guardò più attentamente, e vide che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo, con dentro farina quanta ce ne poteva stare, e un po' di più; dimodochè, quasi a ogni passo, ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutt'e due le mani sul capo una paniera colma di pani; ma, per aver le gambe più corte de' suoi genitori, rimaneva a poco a poco indietro, e, allungando poi il passo ogni tanto, per raggiungerli, la paniera perdeva l'equilibrio, e qualche pane cadeva. «Buttane via ancor un altro, buono a niente che sei,» disse la madre, digrignando i denti verso il ragazzo. «Io non li butto via; cascan da sè: com'ho a fare?» rispose quello. «Ih! buon per te, che ho le mani impicciate,» riprese la donna, dimenando i pugni, come se desse una buona scossa al povero ragazzo; e, con quel movimento, fece volar via più farina, di quel che ci sarebbe voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. «Via, via,» disse l'uomo: «torneremo indietro a raccoglierli, o qualcheduno li raccoglierà. Si stenta da tanto tempo: ora che viene un po' d'abbondanza, godiamola in santa pace.» 8 In tanto arrivava altra gente dalla porta; e uno di questi, accostatosi alla donna, le domandò: «dove si va a prendere il pane?» «Più avanti,» rispose quella; e quando furon lontani dieci passi, soggiunse borbottando: «questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini, e non resterà più niente per noi.» «Un po' per uno, tormento che sei,» disse il marito: «abbondanza, abbondanza.» Da queste e da altrettali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi ch'era arrivato in una città sollevata, e che quello era un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava, a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Aveva così poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose, che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera. E del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione comune, che la scarsezza del pane fosse cagionata dagl'incettatori e da' fornai; ed era disposto a trovar giusto ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, secondo quell'opinione, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo. Pure, si propose di star fuori del tumulto, e si rallegrò d'esser diretto a un cappuccino, che gli troverebbe ricovero, e gli farebbe da padre. Così pensando, e guardando intanto i nuovi conquistatori che venivano carichi di preda, fece quella po' di strada che gli rimaneva per arrivare al convento. Dove ora sorge quel bel palazzo, con quell'alto loggiato, c'era allora, e c'era ancora non son molt'anni, una piazzetta, e in fondo a quella la chiesa e il convento de' cappuccini, con quattro grand'olmi davanti. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con que' nostri lettori che non han visto le cose in quello stato: ciò vuol dire che son molto giovani, e non hanno avuto tempo di far molte corbellerie. Renzo andò diritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levò fuori e tenne preparata in mano la lettera, e tirò il campanello. S'aprì uno sportellino che aveva una grata, e vi comparve la faccia del frate portinaio a domandar chi era. «Uno di campagna, che porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristoforo.» «Date qui,» disse il portinaio, mettendo una mano alla grata. «No, no» disse Renzo: «gliela devo consegnare in proprie mani.» «Non è in convento.» «Mi lasci entrare, che l'aspetterò.» «Fate a mio modo,» rispose il frate: «andate a aspettare in chiesa, che intanto potrete fare un po' di bene. In convento, per adesso, non s'entra.» E detto questo, richiuse lo sportello. Renzo rimase lì, con la sua lettera in mano. Fece dieci passi verso la porta della chiesa, per seguire il consiglio del portinaio; ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto. Attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada, e si fermò, con le braccia incrociate sul petto, a guardare a sinistra, verso l'interno della città, dove il brulichìo era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. - Andiamo a vedere, - disse tra sè; tirò fuori il suo mezzo pane, e sbocconcellando, si mosse verso quella parte. Intanto che s'incammina, noi racconteremo, più brevemente che sia possibile, le cagioni e il principio di quello sconvolgimento. 8 Carducci, Alla stazione in una mattina d’autunno [Odi barbare, II, xxix] Oh quei fanali come s'inseguono accidiosi là dietro gli alberi, tra i rami stillanti di pioggia sbadigliando la luce su 'l fango! Flebile, acuta, stridula fischia la vaporiera da presso. Plumbeo il cielo e il mattino d'autunno come un grande fantasma n'è intorno. Dove e a che move questa, che affrettasi a' carri foschi, ravvolta e tacita gente? a che ignoti dolori o tormenti di speme lontana? Tu pur pensosa, Lidia, la tessera al secco taglio dài de la guardia, e al tempo incalzante i begli anni dài, gl'istanti gioiti e i ricordi. Van lungo il nero convoglio e vengono incappucciati di nero i vigili, com'ombre; una fioca lanterna hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei freni tentati rendono un lugubre rintocco lungo: di fondo a l'anima un'eco di tedio risponde doloroso, che spasimo pare. E gli sportelli sbattuti al chiudere paion oltraggi: scherno par l'ultimo appello che rapido suona: grossa scroscia su' vetri la pioggia. Già il mostro, conscio di sua metallica anima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammei occhi sbarra; immane pe 'l buio gitta il fischio che sfida lo spazio. Va l'empio mostro; con traino orribile sbattendo l'ale gli amor miei portasi. Ahi, la bianca faccia e 'l bel velo salutando scompar ne la tènebra. O viso dolce di pallor roseo, o stellanti occhi di pace, o candida tra' floridi ricci inclinata pura fronte con atto soave! 8 Fremea la vita nel tepid'aere, fremea l'estate quando mi arrisero; e il giovine sole di giugno si piacea di baciar luminoso in tra i riflessi del crin castanei la molle guancia: come un'aureola più belli del sole i miei sogni ricingean la persona gentile. Sotto la pioggia, tra la caligine torno ora, e ad esse vorrei confondermi; barcollo com'ebro, e mi tocco, non anch'io fossi dunque un fantasma. Oh qual caduta di foglie, gelida, continua, muta, greve, su l'anima! io credo che solo, che eterno, che per tutto nel mondo è novembre. Meglio a chi 'l senso smarrì de l'essere, meglio quest'ombra, questa caligine: io voglio io voglio adagiarmi in un tedio che duri infinito. 8 Pascoli, Italy Sacro all'Italia raminga CANTO PRIMO I A Caprona, una sera di febbraio, gente veniva, ed era già per l'erta, veniva su da Cincinnati, Ohio. La strada, con quel tempo, era deserta. Pioveva, prima adagio, ora a dirotto, tamburellando su l'ombrella aperta. La Ghita e Beppe di Taddeo lì sotto erano, sotto la cerata ombrella del padre: una ragazza, un giovinotto. E c'era anche una bimba malatella, in collo a Beppe, e di su la sua spalla mesceva giù le bionde lunghe anella. Figlia d'un altro figlio, era una talla del ceppo vecchio nata là: Maria: d'ott'anni: aveva il peso d'una galla. Ai ritornanti per la lunga via, già vicini all'antico focolare, la lor chiesa sonò l'Avemaria. Erano stanchi! avean passato il mare! Appena appena tra la pioggia e il vento l'udiron essi or sì or no sonare. Maria cullata dall'andar su lento sembrava quasi abbandonarsi al sonno, sotto l'ombrella. Fradicio e contento veniva piano dietro tutti il nonno. II Salivano, ora tutti dietro il nonno, la scala rotta. Il vecchio Lupo in basso non abbaiò; scodinzolò tra il sonno. E tentennò sotto il lor piede il sasso davanti l'uscio. C'era sempre stato presso la soglia, per aiuto al passo. E l'uscio, come sempre, era accallato. Lì dentro, buio come a chiuder gli occhi. Ed era buia la cucina allato. La mamma? Forse scesa per due ciocchi... forse in capanna a mòlgere... No, era al focolare sopra i due ginocchi. Avea pulito greppia e rastrelliera; ora, accendeva... Udì sonare fioco: era in ginocchio, disse la preghiera. Appariva nel buio a poco a poco. "Mamma, perché non v'accendete il lume? Mamma, perché non v'accendete il fuoco?" "Gesù! che ho fatto tardi col rosume..." 9 E negli stecchi ella soffiò, mezzo arsi; e le sue rughe apparvero al barlume. E raccattava, senza ancor voltarsi, tutta sgomenta, avanti a sé, la mamma, brocche, fuscelli, canapugli, sparsi sul focolare. E si levò la fiamma. III E i figli la rividero alla fiamma del focolare, curva, sfatta, smunta. "Ma siete trista! siete trista, o mamma!" Ed accostando agli occhi, essa, la punta del pannelletto, con un fil di voce: "E il Cecco è fiero? E come va l'Assunta?" "Ma voi! Ma voi!" "Là là, con la mia croce". I muri grezzi apparvero col banco vecchio e la vecchia tavola di noce. Di nuovo, un moro, con non altro bianco che gli occhi e i denti, era incollato al muro, la lenza a spalla ed una mano al fianco: roba di là. Tutto era vecchio, scuro. S'udiva il soffio delle vacche, e il sito della capanna empiva l'abituro. Beppe sedé col capo indolenzito tra le due mani. La bambina bionda ora ammiccava qua e là col dito. Parlava, e la sua nonna, tremebonda, stava a sentire e poi dicea: "Non pare un luì quando canta tra la fionda?" Parlava la sua lingua d'oltremare: "... a chicken-house" "un piccolo luì..." "... for mice and rats" "che goda a cinguettare, zi zi" "Bad country, Ioe, your Italy!" IV ITALY, penso, se la prese a male. Maria, la notte (era la Candelora), sentì dei tonfi come per le scale... tre quattro carri rotolarono... Ora vedea, la bimba, ciò che n'era scorso! the snow! la neve, a cui splendea l'aurora. Un gran lenzuolo ricopriva il torso dell'Omo-morto. Nel silenzio intorno parea che singhiozzasse il Rio dell'Orso. Parea che un carro, allo sbianchir del giorno, ridiscendesse l'erta con un lazzo cigolìo. Non un carro, era uno storno, uno stornello in cima del Palazzo abbandonato, che credea che fosse marzo, e strideva: marzo, un sole e un guazzo! Maria guardava. Due rosette rosse aveva, aveva lagrime lontane negli occhi, un colpo ad or ad or di tosse. 9 La nonna intanto ripetea: "Stamane fa freddo!" Un bianco borracciol consunto mettea sul desco ed affettava il pane. Pane di casa e latte appena munto. Dicea: "Bambina, state al fuoco: nieva! nieva!" E qui Beppe soggiungea compunto: "Poor Molly! qui non trovi il pai con fleva!" V Oh! no: non c'era lì né pie né flavour né tutto il resto. Ruppe in un gran pianto: "Ioe, what means nieva? Never? Never? Never?" Oh! no: starebbe in Italy sin tanto ch'ella guarisse: one month or two, poor Molly! E Ioe godrebbe questo po' di scianto! Mugliava il vento che scendea dai colli bianchi di neve. Ella mangiò, poi muta fissò la fiamma con gli occhioni molli. Venne, sapendo della lor venuta, gente, e qualcosa rispondeva a tutti Ioe, grave: "Oh yes, è fiero... vi saluta... molti bisini, oh yes... No, tiene un fruttistendo... Oh yes, vende checche, candi, scrima... Conta moneta: può campar coi frutti... Il baschetto non rende come prima... Yes, un salone, che ci ha tanti bordi... Yes, l'ho rivisto nel pigliar la stima..." Il tramontano discendea con sordi brontoli. Ognuno si godeva i cari ricordi, cari ma perché ricordi: quando sbarcati dagli ignoti mari scorrean le terre ignote con un grido straniero in bocca, a guadagnar danari per farsi un campo, per rifarsi un nido... VI Un campettino da vangare, un nido da riposare: riposare, e ancora gettare in sogno quel lontano grido: Will you buy... per Chicago e Baltimora, buy images... per Troy, Memphis, Atlanta, con una voce che te stesso accora: cheap!... nella notte, solo in mezzo a tanta gente; cheap! cheap! tra un urlerìo che opprime; cheap!... Finalmente un altro odi, che canta... Tu non sai come, intorno a te le cime sono dell'Alpi, in cui si arrossa il cielo: chi canta, è il gallo sopra il tuo concime. "La mi' Mèrica! Quando entra quel gelo, ch'uno ritrova quella stufa roggia per il gran coke, e si rià, poor fellow! O va per via, battuto dalla pioggia. Trova un farm. You want buy? Mostra il baschetto. 9 Un uomo compra tutto. Anche, l'alloggia!" Diceva alcuno; ed assentiano al detto gli altri seduti entro la casa nera, più nera sotto il bianco orlo del tetto. Uno guardò la piccola straniera, prima non vista, muta, che tossì. "You like this country..." Ella negò severa: "Oh no! Bad Italy! Bad Italy!" VII ITALY allora s'adirò davvero! Piovve; e la pioggia cancellò dal tetto quel po' di bianco, e fece tutto nero. Il cielo, parve che si fosse stretto, e rovesciava acquate sopra acquate! O ferraietto, corto e maledetto! Ghita diceva: "Mamma, a che filate? Nessuna fila in Mèrica. Son usi d'una volta, del tempo delle fate. Oh yes! filare! Assai mi ci confusi da bimba. Or c'è la macchina che scocca d'un frullo solo centomila fusi. Oh yes! Ben altro che la vostra rócca! E fila unito. E duole poi la vita e ci si sente prosciugar la bocca!" La mamma allora con le magre dita le sue gugliate traea giù più rare, perché ciascuna fosse bella unita. Vedea le fate, le vedea scoccare fusi a migliaia, e s'indugiava a lungo nel suo cantuccio presso il focolare. Diceva: "Andate a letto, io vi raggiungo". Vedea le mille fate nelle grotte illuminate. A lei faceva il fungo la lucernina nell'oscura notte. VIII Pioveva sempre. Forse uscian, la notte, le stelle, un poco, ad ascoltar per tutto gemer le doccie e ciangottar le grotte. Un poco, appena. Dopo, era più brutto: piovea più forte dopo la quiete. O ferraiuzzo, piccolino e putto! Ghita diceva: "Madre, a che tessete? Là può comprare, a pochi cents, chi vuole, cambrì, percalli, lustri come sete. E poi la vita dite che vi duole! C'è dei telari in Mèrica, in cui vanno ogni minuto centomila spole. E ce n'ha mille ogni città, che fanno ciascuno tanta tela in uno scatto, quanta voi non ne fate in capo all'anno". Dicea la mamma: "Il braccio ch'io ricatto 9 bel bello, vuole diventar rotello. O figlia, più non è da fare, il fatto". E tendeva col subbio e col subbiello altre fila. La bimba, lì, da un canto, mettea nello spoletto altro cannello. Stava lì buona come ad un incanto, in quel celliere della vòlta bassa, Molly, e tossiva un poco, ma soltanto tra il rumore dei licci e della cassa. IX Tra il rumore dei licci e della cassa tossiva, che la nonna non sentisse. La nonna spesso le dicea: "Ti passa?" "Yes", rispondeva. Un giorno poi le disse: "Non venir qui!" Ma ella ci veniva, e stava lì con le pupille fisse. Godeva di guardare la giuliva danza dei licci, e di tenere in mano la navicella lucida d'oliva. Stava lì buona a' piedi d'un soppiano; girava l'aspo, riempìa cannelli, e poi tossiva dentro sé pian piano. Un giorno che veniva acqua a ruscelli, fissò la nonna e chiese: "Die?" La nonna le carezzava i morbidi capelli. La bimba allora piano per la gonna le salì, le si stese sui ginocchi: "Die?" "E che t'ho a dir io povera donna?" La bimba allora chiuse un poco gli occhi: "Die! Die!" La nonna sussurrò: "Dormire?" "No! No!" La bimba chiuse anche più gli occhi, s'abbandonò per più che non dormire, piegò le mani sopra il petto: "Die! Die! Die!" La nonna balbettò: "Morire!" "Oh yes! Molly morire in Italy!" CANTO SECONDO ITALY allora n'ebbe tanta pena. Povera Molly! E venne un vento buono che spazzò l'aria che tornò serena. I Vieni, poor Molly! Vieni! Dove sono le nubi? In cielo non c'è più che poca nebbia, una pace, un senso di perdono, di quando il bimbo perdonato ha roca ancor la voce; all'angolo degli occhi c'era una stilla, e cade, mentre gioca. Vieni, poor Molly! Porta i tuoi balocchi. Dove sono le nubi nere nere? qualche lagrima sgocciola dai fiocchi delle avellane, e brilla nel cadere. 9 II Porta the doll, la bambola, che viene, povera Doll, anch'essa dal paese lontano, ed essa ti capisce bene. E quando tu le parli per inglese, presso le guance pallide ti pone le sue color di rosa d'ogni mese. Dal suo lettino lucido, d'ottone, levala su, che l'uggia non la vinca. Non dorme, vedi. Vedi, dal cantone sgrana que' suoi due fiori di pervinca. III O Moll e Doll, venite! Ora comincia il tempo bello. Udite un campanello che in mezzo al cielo dondola? È la cincia. O Moll e Doll, comincia il tempo bello. Udite lo squillar d'una fanfara che corre il cielo rapida? È il fringuello. Fringuello e cincia ognuno già prepara per il suo nido il mustio e il ragnatelo; e d'ora in ora primavera a gara cantano, uno sul pero, uno sul melo. IV Altre due voci ora dal monte al piano s'incontrano: uno scampanare a festa, con un altro più piano e più lontano. L'una tripudia, e i mille echi ridesta del monte, bianco ancora un po' di neve. Di tanto in tanto ecco la voce mesta; ecco un rintocco, appena appena un breve colpo, che pare così lungo al cuore! No, non vorrebbe, o gente, no; ma deve. C'è là chi sposa, ma c'è qua chi muore. V Buoni villaggi che vivete intorno al verde fiume, e di comune intesa vi dite tutto ciò che fate il giorno! Si levano. Ora vanno tutti in chiesa, ora son tutti a desinare, ed ora c'è in ogni casa la lucerna accesa. Poi quando immersi ad aspettar l'aurora sembrano tutti, ecco più su più giù, più qua più là, le loro voci ancora. Pensano a quelli che non sono più... VI Lèvati, Molly. Gente ode parlare la tua parlata. Sono qui. Cammina, se vuoi vederle. Hanno passato il mare. Fanno un brusìo nell'ora mattutina! Ma il vecchio Lupo dorme e non abbaia. È buona gente e fu già sua vicina. 9 Vengono e vanno, su e giù dall'aia alla lor casa che da un pezzo è vuota. Oh! la lor casa, sotto la grondaia, non gli par brutta, ben che sia di mota! VII Sweet... Sweet... Ho inteso quel lor dolce grido dalle tue labbra... Sweet, uscendo fuori, e sweet sweet sweet, nel ritornare al nido. Palpiti a volo limpidi e sonori, gorgheggi a fermo teneri e soavi, battere d'ali e battere di cuori! In questa casa che tu bad chiamavi, black, nera, sì, dal tempo e dal lavoro, son le lor case, là sotto le travi, di mota sì, ma così sweet per loro! VIII O rondinella nata in oltremare! Quando vanno le rondini, e qui resta il nido solo, oh! che dolente andare! Non c'è più cibo qui per loro, e mesta la terra e freddo è il cielo, tra l'affanno dei venti e lo scrosciar della tempesta. Non c'è più cibo. Vanno. Torneranno? Lasciano la lor casa senza porta. Tornano tutte al rifiorir dell'anno! Quella che no, di' che non può; ch'è morta. IX Quando tu sei venuta, o rondinella, t'hanno pur salutata le campane; ti venne incontro il nonno con l'ombrella, ti s'è strusciato alle gambine il cane. Pioveva; ma tu, bimba, eri coperta; trovasti in casa il latte caldo e il pane. Il tuo nonno ansimava su per l'erta, la tua nonna pregava al focolare. Brutta la casa, sì, ma era aperta, o mia figliuola nata in oltremare! X Ha la pena da parte, oggi, e la vita gli sente, e il capo, alla tua nonna, e il cuore; e siede al focolare infreddolita. Ieri si colse malva ed erbe more. Oggi sta peggio. Ha due rosette rosse, che non le ha fatte il fuoco che rimuore. Molly, tu vieni e guardi. Ecco, ha la tosse che avevi tu. Tosse ogni tanto un po'. Sta lì nel canto come non ci fosse. E non tesse e non fila. Oggi non può. XI Ha tessuto e filato, anche ha zappato, anche ha vangato, anche ha portato, oh! tanto 9 che adesso stenta a riavere il fiato! O dolce Molly, tu le porti accanto Doll nel lettino lucido, e tu resti con loro... Tanto faticato e pianto! pianto in vedere i figli o senza vesti o senza scarpe o senza pane! pianto poi di nascosto, per non far più mesti i figli che... diceano addio, col canto. XII Addio, dunque! Ed anch'essa Italy, vede, Italy piange. Hanno un po' più fardello che le rondini, e meno hanno di fede. Si muove con un muglio alto il vascello. Essi, in disparte, con lo sguardo vano, mangiano qua e là pane e coltello. E alcun li tende, il pane da una mano, l'altro dall'altra, torbido ed anelo, al patrio lido, sempre più lontano e più celeste, fin che si fa cielo. XIII Cielo, e non altro, cielo alto e profondo, cielo deserto. O patria delle stelle! O sola patria agli orfani del mondo! Vanno serrando i denti e le mascelle, serrando dentro il cuore una minaccia ribelle, e un pianto forse più ribelle. Offrono cheap la roba, cheap le braccia, indifferenti al tacito diniego; e cheap la vita, e tutto cheap; e in faccia no, dietro mormorare odono: DEGO! XIV Ma senti, Molly? Dopo pioggie e brume e nevi e ghiacci, con la sua gran voce canta passando a' piè dei monti il fiume. Passa sotto la gran Pania alla Croce cantando, ed una lunga nube appare, bianca di sole, al suo passar veloce. Passa cantando: Al mare! Al mare! Al mare! e l'Alpe azzurra ne rimbomba in cerchio, e il cielo azzurro vede là fumare l'alito che si lascia addietro il Serchio. XV O fiumi, o delle rupi e dei ghiacciai figli rubesti, che precipitate a pazza corsa senza posar mai, con l'eterno fragor delle cascate, ruzzando come giovani giganti, senza perché, per atterrir le fate delle montagne; e trascinate infranti boschi e tuguri, urtate le città, struggete i campi, sempre avanti, avanti, 9 avanti, pieni di serenità... XVI Acqua perenne, ottima e pessima, ora morte ora vita, acqua, diventa luce! acqua, diventa fiamma! acqua, lavora! Lavora dove l'uomo ti conduce; e veemente come l'uragano, vigile come femmina che cuce, trasforma il ferro, il lino, il legno, il grano; manda i pesanti traini come spole labili; rendi l'operare umano facile e grande come quel del Sole! XVII La madre li vuol tutti alla sua mensa i figli suoi. Qual madre è mai, che gli uni sazia, ed a gli altri, a tanti, ai più, non pensa? Siedono a lungo qua e là digiuni; tacciono, tralasciati nel banchetto patrio, come bastardi, ombre, nessuni: guardano intorno, e quindi sé nel petto, sentono su la lingua arida il sale delle lagrime; infine, a capo eretto, escono, poi fuggono, poi: - Sii male... XVIII Non maledite! Vostra madre piange su voi, che ai salci sospendete i gravi picconi, in riva all'Obi, al Congo, al Gange. Ma d'ogni terra, ove è sudor di schiavi, di sottoterra ove è stridor di denti, dal ponte ingombro delle nere navi, vi chiamerà l'antica madre, o genti, in una sfolgorante alba che viene, con un suo grande ululo ai quattro venti fatto balzare dalle sue sirene. XIX Non piangere, poor Molly! Esci, fa piano, lascia la nonna lì sotto il lenzuolo di tela grossa ch'ella fece a mano. T'amava, oh! sì! Tu ne imparavi a volo qualche parola bella che balbetti: essa da te solo quel die, die solo! Lascia lì Doll, lasciali accosto i letti, piccolo e grande. Doll è savia, e tace, né dorme: ha gli occhi aperti e par che aspetti che li apra l'altra, ch'ora dorme in pace. XX Prima d'andare, vieni al camposanto, s'hai da ridire come qua si tiene. Stridono i bombi intorno ai fior d'acanto, ronzano l'api intorno le verbene. E qui tra tanto sussurrìo riposa 9 la nonna cara che ti volle bene. O Molly! O Molly! prendi su qualcosa, prima d'andare, e portalo con te. Non un geranio né un bocciuol di rosa, prendi sol un NON-TI-SCORDAR-DI-ME! "Ioe, bona cianza!..." "Ghita, state bene!... "Good bye". "L'avete presa la ticchetta?" "Oh yes". "Che barco?" "Il Prinzessin Irene". L'un dopo l'altro dava a Ioe la stretta lunga di mano. "Salutate il tale". "Yes, servirò". "Come partite in fretta!" Scendean le donne in zoccoli le scale per veder Ghita. Sopra il suo cappello c'era una fifa con aperte l'ale. "Se vedete il mi' babbo... il mi' fratello... il mi' cognato..." "Oh yes". "Un bel passaggio vi tocca, o Ghita. Il tempo è fermo al bello". "Oh yes". Facea pur bello! Ogni villaggio ridea nel sole sopra le colline. Sfiorian le rose da' rosai di maggio. Sweet sweet... era un sussurro senza fine nel cielo azzurro. Rosea, bionda, e mesta, Molly era in mezzo ai bimbi e alle bambine. Il nonno, solo, in là volgea la testa bianca. Sonava intorno mezzodì. Chiedeano i bimbi con vocìo di festa: "Tornerai, Molly?" Rispondeva: - Sì! Note Il lettore non ha certo bisogno dei miei lumi per leggere e interpretare il povero inglese de' miei personaggi. Gioverà tuttavia ricordare la pronunzia netta in a o aa che hanno, nella bocca dei nostri reduci di Mèrica, le parole come flavour (pr. fléva), never (pr. néva), steamer (pr. stima) e simili. Il grido dei figurinai, Buy images (= comprate figure); suona, in bocca loro, bai imigìs. E cheap (pr. cip) vale : a buon mercato. Molte parole inglesi sono da loro accomodate a italiane: bisini (per business) = affari; fruttistendo (per fruitstand) = bottega di fruttaiolo; checche (per cakes) = paste, pasticci; cand (da candy) = canditi; scrima (per ice cream) = gelato di crema; baschetto (per basquet) = paniere per metterci le figure; salone (per saloon) = trattoria, bettola: bordi (da board) = pensioni, abbonati; stima (per steamer) = piroscafo; ticchetta (per ticket) = biglietto; cianza (per chance) = sorte, occasione. Barco dicono per bastimento. Molly è vezzeggiativo casereccio per Mary o Maria; doll significa bambola, ed è anche vezzeggiativo di Dorothy. Sweet (pr. suìt) vale dolce, ed è, per dir cosi, consacrato a home. Casa mia! Casa mia! Brutta parola, dopo queste così dolci, è dego, così pronunziata. Deriva, mi pare, da dagger = pugnale. Quanto alle rime con Italy, mi difenda, se accade, Shelley che rima, per esempio, she con poesy e die con purity (The Witch of Atlas! 26,36). 9 D’Annunzio, La pioggia nel pineto Taci. Su le soglie del bosco non odo parole che dici umane; ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove su le tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove su i mirti divini, su le ginestre fulgenti di fiori accolti, su i ginepri folti di coccole aulenti, piove su i nostri volti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggeri, su i freschi pensieri che l'anima schiude novella, su la favola bella che ieri t'illuse, che oggi m'illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade su la solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, stromenti diversi sotto innumerevoli dita. E immensi noi siam nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi; e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, Ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce; ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco s'allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta. La figlia dell'aria è muta: ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chi sa dove, chi sa dove! E piove su le tue ciglia, Ermione. Piove su le tue ciglia nere 1 sì che par tu pianga ma di piacere; non bianca ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti (e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli c'intrica i ginocchi) chi sa dove, chi sa dove! E piove su i nostri volti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggeri, su i freschi pensieri che l'anima schiude novella, su la favola bella che ieri m'illuse, che oggi t'illude, o Ermione. 1 Verga, I Malavoglia XV Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non riconobbe ‘Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava più quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane gli abbaiava, ché non l'aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi ‘Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si sentì balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita: «Te ne vai?» «Sì!» rispose ‘Ntoni. «E dove vai?» chiese Alessi. «Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non posso starci, ché tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono.» Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli faceva bene a dir così. ‘Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva risolversi ad andarsene. «Ve lo farò sapere dove sarò;» disse infine, e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro, disse anche: «E il nonno?» Alessi non rispose; ‘Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto: «E la Lia, che non l'ho vista?» E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo: «È morta anche lei?» Alessi non rispose nemmeno; allora ‘Ntoni che era sotto il nespolo, colla sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando: «Addio! addio! Lo vedete che devo andarmene?» Prima d'andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima; ma adesso, a lui che gli era bastato l'animo di lasciarla e di dare una coltellata a don Michele, e di starsene nei guai, non gli bastava l'animo di passare da una camera all'altra se non glielo dicevano. Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla, col pretesto del vitello che aveva comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c'era pure la chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei. ‘Ntoni guardava ogni cosa, e approvava col capo, e diceva: «Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello; qui c'erano le chiocce, e qui dormivano le ragazze, quando c'era anche quell'altra...» Ma allora non aggiunse altro, e stette zitto a guardare intorno, cogli occhi lustri. In quel momento passava la Mangiacarrubbe, che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e ‘Ntoni disse: «Questa qui l'ha trovato il marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a dormire nella loro casa.» Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: «Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c'è apposta il letto per te.» «No! – rispose ‘Ntoni. – Io devo andarmene. Là c'era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate 1 che si facevano la sera, mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch'io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene.» In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. «Addio, – ripetè ‘Ntoni. Vedi che avevo ragione d'andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti.» E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico. Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo. Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero, e ascoltando il mare che gli brontolava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch'ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d'imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara che annunziava l'alba, come l'aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c'era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. – Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta, – pensò ‘Ntoni, e si accoccolerà sull'uscio a cominciare la sua giornata anche lui. – Tornò a guardare il mare, che s'era fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta, e disse: «Ora è tempo d'andarsene, perché fra poco comincierà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu. 1 Svevo, La coscienza di Zeno Fu qui che cominciò la mia avventura. Ad uno svolto di via, mi trovai arrestato da una sentinella che urlò: — Zurück! — mettendosi addirittura in posizione di sparare. Volli parlargli in tedesco giacché in tedesco aveva urlato, ma egli del tedesco non conosceva che quella sola parola che ripeté sempre più minacciosamente. Bisognava andare zurück ed io guardandomi sempre dietro nel timore che l'altro, per farsi intendere meglio, sparasse, mi ritirai con una certa premura che non m'abbandonò neppure quando il soldato non vidi più. Ma ancora non avevo rinunciato di arrivare subito alla mia villa. Pensai che varcando la collina alla mia destra, sarei arrivato molto dietro la sentinella minacciosa. L'ascesa non fu difficile specie perché l'alta erba era stata curvata da molta gente che doveva essere passata per di là prima di me. Certamente doveva esservi stata costretta dalla proibizione di passare per la strada. Camminando riacquistai la mia sicurezza e pensai che al mio arrivo a Lucinico mi sarei subito recato a protestare dal capovilla per il trattamento che avevo dovuto subire. Se permetteva che i villeggianti fossero trattati così, presto a Lucinico non ci sarebbe venuto nessuno! Ma arrivato alla cima della collina, ebbi la brutta sorpresa di trovarla occupata da quel plotone di soldati dall'odore di selvatico. Molti soldati riposavano all'ombra di una casetta di contadini che io conoscevo da molto tempo e che a quell'ora era del tutto vuota; tre di essi parevano messi a guardia, ma non verso il versante da cui io ero venuto, e alcuni altri stavano in un semi circolo dinanzi ad un ufficiale che dava loro delle istruzioni che illustrava con una carta topografica ch'egli teneva in mano. Io non possedevo neppure un cappello che potesse servirmi per salutare. Inchinandomi varie volte e col mio più bel sorriso, m'appressai all'ufficiale il quale, vedendomi, cessò di parlare coi suoi soldati e si mise a guardarmi. Anche i cinque mammelucchi che lo circondavano mi regalavano tutta la loro attenzione. Sotto tutti quegli sguardi e sul terreno non piano era difficilissimo di moversi. L'ufficiale urlò: — Was will der dumme Kerl hier? — (Che cosa vuole quello scimunito?). Stupito che senz'alcuna provocazione mi si offendesse così, volli dimostrarmi offeso virilmente ma tuttavia con la discrezione del caso, deviai di strada e tentai di arrivare al versante che m'avrebbe portato a Lucinico. L'ufficiale si mise ad urlare che, se facevo un solo passo di più, m'avrebbe fatto tirare adosso. Ridivenni subito molto cortese e da quel giorno a tutt'oggi che scrivo, rimasi sempre molto cortese. Era una barbarie d'essere costretto di trattare con un tomo simile, ma intanto si aveva il vantaggio ch'egli parlava correntemente il tedesco. Era un tale vantaggio che, ricordandolo, riusciva più facile di parlargli con dolcezza. Guai se bestia come era non avesse neppur compreso il tedesco. Sarei stato perduto. Peccato che io non parlavo abbastanza correntemente quella lingua perché altrimenti mi sarebbe stato facile di far ridere quell'arcigno signore. Gli raccontai che a Lucinico m'aspettava il mio caffelatte da cui ero diviso soltanto dal suo plotone. Egli rise, in fede mia rise. Rise sempre bestemmiando e non ebbe la pazienza di lasciarmi finire. Dichiarò che il caffelatte di Lucinico sarebbe stato bevuto da altri e quando sentì che oltre al caffè c'era anche mia moglie che m'aspettava, urlò: — Auch Ihre Frau wird von anderen gegessen werden. — (Anche vostra moglie sarà mangiata da altri). Egli era oramai di miglior umore di me. Pare poi gli fosse spiaciuto di avermi dette delle parole che, sottolineate dal riso clamoroso dei cinque mammalucchi, potevano apparire offensive; si fece serio e mi spiegò che non dovevo sperare di rivedere per qualche giorno 1 Lucinico ed anzi in amicizia mi consigliava di non domandarlo più perché bastava quella domanda per compromettermi! — Haben Sie verstanden? — (Avete capito?) Io avevo capito, ma non era mica facile di adattarsi di rinunziare al caffelatte da cui distavo non più di mezzo chilometro. Solo perciò esitavo di andarmene perché era evidente che quando fossi disceso da quella collina, alla mia villa, per quel giorno, non sarei giunto più. E, per guadagnar tempo, mitemente domandai all'ufficiale: — Ma a chi dovrei rivolgermi per poter ritornare a Lucinico a prendere almeno la mia giubba e il mio cappello? Avrei dovuto accorgermi che all'ufficiale tardava di esser lasciato solo con la sua carta e i suoi uomini, ma non m'aspettavo di provocare tanta sua ira. Urlò, in modo da intronarmi l'orecchie, che m'aveva già detto che non dovevo più domandarlo. Poi m'impose di andare dove il diavolo vorrà portarmi (wo der Teufel Sie tragen will). L'idea di farmi portare non mi spiaceva molto perché ero molto stanco, ma esitavo ancora. Intanto però l'ufficiale a forza d'urlare s'accese sempre più e con accento di grande minaccia chiamò a sé uno dei cinque uomini che l'attorniavano e appellandolo signor caporale gli diede l'ordine di condurmi già della collina e di sorvegliarmi finché non fossi sparito sulla via che conduce a Gorizia, tirandomi addosso se avessi esitato ad ubbidire. Perciò scesi da quella cima piuttosto volontieri: — Danke schön, — dissi anche senz'alcun'intenzione d'ironia. Il caporale era uno slavo che parlava discretamente l'italiano. Gli parve di dover essere brutale in presenza dell'ufficiale e, per indurmi a precederlo nella discesa, mi gridò: — Marsch! — Ma quando fummo un po' più lontani si fece dolce e familiare. Mi domandò se avevo delle notizie sulla guerra e se era vero ch'era imminente l'intervento italiano. Mi guardava ansioso in attesa della risposta. Dunque neppure loro che la facevano sapevano se la guerra ci fosse o no! Volli renderlo più felice che fosse possibile e gli diedi le notizie che avevo propinate anche al padre di Teresina. Poi mi pesarono sulla coscienza. Nell'orrendo temporale che scoppiò, probabilmente tutte le persone ch'io rassicurai perirono. Chissà quale sorpresa ci sarà stata sulla loro faccia cristallizzata dalla morte. Era un ottimismo incoercibile il mio. Non avevo sentita la guerra nelle parole dell'ufficiale e meglio ancora nel loro suono? Il caporale si rallegrò molto e, per compensarmi, mi diede anche lui il consiglio di non tentare più di arrivare a Lucinico. Date le notizie mie, egli riteneva che le disposizioni che m'impedivano di rincasare sarebbero state levate il giorno appresso. Ma intanto mi consigliava di andare a Trieste al Platzkommando dal quale forse avrei potuto ottenere un permesso speciale. — Fino a Trieste? — domandai io spaventato. — A Trieste, senza giubba, senza cappello e senza caffelatte? A quanto ne sapeva il caporale, mentre parlavamo, un fitto cordone di fanteria chiudeva il transito per l'Italia, creando una nuova ed insuperabile frontiera. Con un sorriso di persona superiore mi dichiarò che, secondo lui, la via più breve per Lucinico era quella che conduceva oltre Trieste. A forza di sentirmelo dire, io mi rassegnai e m'avviai verso Gorizia pensando di prendere il treno del mezzodì per recarmi a Trieste. Ero agitato, ma devo dire che mi sentivo molto bene. Avevo fumato poco e non mangiato affatto. Mi sentivo di una leggerezza che da lungo tempo m'era mancata. Non mi dispiaceva affatto di dover ancora camminare. Mi dolevano un poco le gambe, ma mi pareva che avrei potuto reggere fino a Gorizia, tanto era libero e profondo il mio respiro. Scaldatemi le gambe con un buon passo, il camminare infatti non mi pesò. E nel benessere, battendomi il tempo, allegro perché insolitamente celere, ritornai al mio ottimismo. Minacciavano di qua, minacciavano di là, ma alla guerra 1 non sarebbero giunti. Ed è così che, quando giunsi a Gorizia, esitai se non avessi dovuto stabilire una stanza all'albergo nella quale passare la notte e ritornare il giorno appresso a Lucinico per presentare le mie rimostranze al capovilla. Corsi intanto all'ufficio postale per telefonare ad Augusta. Ma dalla mia villa non si rispose. L'impiegato, un omino dalla barbetta rada che pareva nella sua piccolezza e rigidezza qualche cosa di ridicolo e d'ostinato — la sola cosa che di lui ricordi — sentendomi bestemmiare furibondo al telefono muto, mi si avvicinò e mi disse: — È già la quarta volta oggi che Lucinico non risponde. Quando mi rivolsi a lui, nel suo occhio brillò una grande lieta malizia (sbagliavo! anche quella ricordo ancora!) e quel suo occhio brillante cercò il mio per vedere se proprio ero tanto sorpreso e arrabbiato. Ci vollero un dieci buoni minuti perché comprendessi. Allora non ci furono dubbii per me. Lucinico si trovava o fra pochi istanti si troverebbe sulla linea del fuoco. Quando intesi perfettamente quell'occhiata eloquente ero avviato al caffè per prendere in aspettativa della colazione la tazza di caffè che m'era dovuta dalla mattina. Deviai subito e andai alla stazione. Volevo trovarmi più vicino ai miei e — seguendo le indicazioni del mio amico caporale — mi recavo a Trieste. Fu durante quel mio breve viaggio che la guerra scoppiò. 1 Pirandello, Una giornata Strappato dal sonno, forse per sbaglio, e buttato fuori dal treno in una stazione di passaggio. Di notte; senza nulla con me. Non riesco a riavermi dallo sbalordimento. Ma ciò che più mi impressiona è che non mi trovo addosso alcun segno della violenza patita; non solo, ma che non ne ho neppure un'immagine, neppur l'ombra confusa d'un ricordo. Mi trovo a terra, solo, nella tenebra d'una stazione deserta; e non so a chi rivolgermi per sapere che m'è accaduto, dove sono. Ho solo intravisto un lanternino cieco, accorso per richiudere lo sportello del treno da cui sono stato espulso. Il treno è subito ripartito. È subito scomparso nell'interno della stazione quel lanternino, col riverbero vagellante del suo lume vano. Nello stordimento, non m'è nemmeno passato per il capo di corrergli dietro per domandare spiegazioni e far reclamo. Ma reclamo di che? Con infinito sgomento m'accorgo di non aver più idea d'essermi messo in viaggio su un treno. Non ricordo più affatto di dove sia partito, dove diretto; e se veramente, partendo, avessi con me qualche cosa. Mi pare nulla. Nel vuoto di questa orribile incertezza, subitamente mi prende il terrore di quello spettrale lanternino cieco che s'è subito ritirato, senza fare alcun caso della mia espulsione dal treno. È dunque forse la cosa più normale che a questa stazione si scenda così? Nel bujo, non riesco a discernerne il nome. La città mi è però certamente ignota. Sotto i primi squallidi barlumi dell'alba, sembra deserta. Nella vasta piazza livida davanti alla stazione c'è un fanale ancora acceso. Mi ci appresso; mi fermo e, non osando alzar gli occhi, atterrito come sono dall'eco che hanno fatto i miei passi nel silenzio, mi guardo le mani, me le osservo per un verso e per l'altro, le chiudo, le riapro, mi tasto con esse, mi cerco addosso, anche per sentire come son fatto, perché non posso più esser certo nemmeno di questo: ch'io realmente esista e che tutto questo sia vero. Poco dopo, inoltrandomi fin nel centro della città, vedo che a ogni passo mi farebbero restare dallo stupore, se uno stupore più forte non mi vincesse nel vedere che tutti gli altri, pur simili a me, ci si muovono in mezzo senza punto badarci, come se per loro siano le cose più naturali e più solite. Mi sento come trascinare, ma anche qui senz'avvertire che mi si faccia violenza. Solo che io, dentro di me, ignaro di tutto, sono quasi da ogni parte ritenuto. Ma considero che, se non so neppur come, né di dove, né perché ci sia venuto, debbo aver torto io certamente e ragione tutti gli altri che, non solo pare lo sappiano, ma sappiano anche tutto quello che fanno sicuri di non sbagliare, senza la minima incertezza, così naturalmente persuasi a fare come fanno, che m'attirerei certo la maraviglia, la riprensione, fors'anche l'indignazione se, o per il loro aspetto o per qualche loro atto o espressione, mi mettessi a ridere o mi mostrassi stupito. Nel desiderio acutissimo di scoprire qualche cosa, senza farmene accorgere, debbo di continuo cancellarmi dagli occhi quella certa permalosità che di sfuggita tante volte nei loro occhi hanno i cani. Il torto è mio, il torto è mio, se non capisco nulla, se non riesco ancora a raccapezzarmi. Bisogna che mi sforzi a far le viste d'esserne anch'io persuaso e che m'ingegni di far come gli altri, per quanto mi manchi ogni criterio e ogni pratica nozione, anche di quelle cose che pajono più comuni e più facili. Non so da che parte rifarmi, che via prendere, che cosa mettermi a fare. Possibile però ch'io sia già tanto cresciuto, rimanendo sempre come un bambino e senz'aver fatto mai nulla? Avrò forse lavorato in sogno, non so come. Ma lavorato ho certo; lavorato sempre, e molto, molto. Pare che tutti lo sappiano, del resto, perché tanti si voltano a guardarmi e più d'uno anche mi saluta, senza ch'io lo conosca. Resto dapprima 1 perplesso, se veramente il saluto sia rivolto a me; mi guardo accanto; mi guardo dietro. Mi avranno salutato per sbaglio? Ma no, salutano proprio me. Combatto, imbarazzato, con una certa vanità che vorrebbe e pur non riesce a illudersi, e vado innanzi come sospeso, senza potermi liberare da uno strano impaccio per una cosa - lo riconosco - veramente meschina: non sono sicuro dell'abito che ho addosso; mi sembra strano che sia mio; e ora mi nasce il dubbio che salutino quest'abito e non me. E io intanto con me, oltre a questo, non ho più altro! Torno a cercarmi addosso. Una sorpresa. Nascosta nella tasca in petto della giacca tasto come una bustina di cuojo. La cavo fuori, quasi certo che non appartenga a me ma a quest'abito non mio. È davvero una vecchia bustina di cuojo, gialla scolorita slavata, quasi caduta nell'acqua di un ruscello o d'un pozzo e ripescata. La apro, o, piuttosto, ne stacco la parte appiccicata, e vi guardo dentro. Tra poche carte ripiegate, illeggibili per le macchie che l'acqua v'ha fatte diluendo l'inchiostro, trovo una piccola immagine sacra, ingiallita, di quelle che nelle chiese si regalano ai bambini e, attaccata ad essa quasi dello stesso formato e anch'essa sbiadita, una fotografia. La spiccico, la osservo. Oh! È la fotografia di una bellissima giovine, in costume da bagno, quasi nuda, con tanto vento nei capelli e le braccia levate vivacemente nell'atto di salutare. Ammirandola, pur con una certa pena, non so, quasi lontana, sento che mi viene da essa l'impressione, se non proprio la certezza, che il saluto di queste braccia, così vivacemente levate nel vento, sia rivolto a me. Ma per quanto mi sforzi, non arrivo a riconoscerla. È mai possibile che una donna così bella mi sia potuta sparire dalla memoria, portata via da tutto quel vento che le scompiglia la testa? Certo, in questa bustina di cuojo caduta un tempo nell'acqua, quest'immagine, accanto all'immagine sacra, ha il posto che si dà a una fidanzata. Torno a cercare nella bustina e, più sconcertato che con piacere, nel dubbio che non m'appartenga, trovo in un ripostiglio segreto un grosso biglietto di banca, chi sa da quanto tempo lì riposto e dimenticato, ripiegato in quattro, tutto logoro e qua e là bucherellato sul dorso delle ripiegature già lise. Sprovvisto come sono di tutto, potrò darmi ajuto con esso? Non so con qual forza di convinzione, l'immagine ritratta in quella piccola fotografia m'assicura che il biglietto è mio. Ma c'è da fidarsi d'una testolina così scompigliata dal vento? Mezzogiorno è già passato; casco dal languore: bisogna che prenda qualcosa, ed entro in una trattoria. Con maraviglia, anche qui mi vedo accolto come un ospite di riguardo, molto gradito. Mi si indica una tavola apparecchiata e si scosta una seggiola per invitarmi a prender posto. Ma io son trattenuto da uno scrupolo. Fo cenno al padrone e, tirandolo con me in disparte, gli mostro il grosso biglietto logorato. Stupito, lui lo mira; pietosamente per lo stato in cui è ridotto, lo esamina; poi mi dice che senza dubbio è di gran valore ma ormai da molto tempo fuori di corso. Però non tema: presentato alla banca da uno come me, sarà certo accettato e cambiato in altra più spicciola moneta corrente. Così dicendo il padrone della trattoria esce con me fuori dell'uscio di strada e m'indica l'edificio della banca lì presso. Ci vado, e tutti anche in quella banca si mostrano lieti di farmi questo favore. Quel mio biglietto - mi dicono - è uno dei pochissimi non rientrati ancora alla banca, la quale da qualche tempo a questa parte non dà più corso se non a biglietti di piccolissimo taglio. Me ne danno tanti e poi tanti, che ne resto imbarazzato e quasi oppresso. Ho con me solo quella naufraga bustina di cuojo. Ma mi esortano a non confondermi. C'è rimedio a tutto. Posso lasciare quel mio danaro in deposito alla banca, in conto corrente. Fingo d'aver compreso; mi metto in tasca qualcuno di quei biglietti e un libretto che mi dànno in sostituzione di tutti gli altri che lascio, e ritorno alla trattoria. Non vi trovo cibi per il mio gusto; temo di non poterli digerire. Ma già si dev'esser sparsa la voce ch'io, se non proprio ricco, non sono certo più povero; e infatti, uscendo dalla trattoria, trovo una automobile che m'aspetta e un autista che si leva 1 con una mano il berretto e apre con l'altra lo sportello per farmi entrare. Io non so dove mi porti. Ma com'ho un'automobile, si vede che, senza saperlo, avrò anche una casa. Ma sì, una bellissima casa, antica, dove certo tanti prima di me hanno abitato e tanti dopo di me abiteranno. Sono proprio miei tutti questi mobili? Mi ci sento estraneo, come un intruso. Come questa mattina all'alba la città, ora anche questa casa mi sembra deserta; ho di nuovo paura dell'eco che i miei passi faranno, movendomi in tanto silenzio. D'inverno, fa sera prestissimo; ho freddo e mi sento stanco. Mi faccio coraggio; mi muovo; apro a caso uno degli usci; resto stupito di trovar la camera illuminata, la camera da letto, e, sul letto, lei, quella giovine del ritratto, viva, ancora con le due braccia nude vivacemente levate, ma questa volta per invitarmi ad accorrere a lei e per accogliermi tra esse, festante. È un sogno? Certo, come in un sogno, lei su quel letto, dopo la notte, la mattina all'alba, non c'è più. Nessuna traccia di lei. E il letto, che fu così caldo nella notte, è ora, a toccarlo, gelato, come una tomba. E c'è in tutta la casa quell'odore che cova nei luoghi che hanno preso la polvere, dove la vita è appassita da tempo, e quel senso d'uggiosa stanchezza che per sostenersi ha bisogno di ben regolate e utili abitudini. Io ne ho avuto sempre orrore. Voglio fuggire. Non è possibile che questa sia la mia casa. Questo è un incubo. Certo ho sognato uno dei sogni più assurdi. Quasi per averne la prova, vado a guardarmi a uno specchio appeso alla parete dirimpetto, e subito ho l'impressione d'annegare, atterrito, in uno smarrimento senza fine. Da quale remota lontananza i miei occhi, quelli che mi par d'avere avuti da bambino, guardano ora, sbarrati dal terrore, senza potersene persuadere, questo viso di vecchio? Io, già vecchio? Così subito? E com'è possibile? Sento picchiare all'uscio. Ho un sussulto. M'annunziano che sono arrivati i miei figli. I miei figli? Mi pare spaventoso che da me siano potuti nascere figli. Ma quando? Li avrò avuti jeri. Jeri ero ancora giovane. È giusto che ora, da vecchio, li conosca. Entrano, reggendo per mano bambini, nati da loro. Subito accorrono a sorreggermi; amorosamente mi rimproverano d'essermi levato di letto; premurosamente mi mettono a sedere, perché l'affanno mi cessi. Io, l'affanno? Ma sì, loro lo sanno bene che non posso più stare in piedi e che sto molto molto male. Seduto, li guardo, li ascolto; e mi sembra che mi stiano facendo in sogno uno scherzo. Già finita la mia vita? E mentre sto a osservarli, così tutti curvi attorno a me, maliziosamente, quasi non dovessi accorgermene, vedo spuntare nelle loro teste, proprio sotto i miei occhi, e crescere, crescere non pochi, non pochi capelli bianchi. - Vedete, se non è uno scherzo? Già anche voi, i capelli bianchi. E guardate, guardate quelli che or ora sono entrati da quell'uscio bambini: ecco, è bastato che si siano appressati alla mia poltrona: si son fatti grandi; e una, quella, è già una giovinetta che si vuol far largo per essere ammirata. Se il padre non la trattiene, mi si butta a sedere sulle ginocchia e mi cinge il collo con un braccio, posandomi sul petto la testina. Mi vien l'impeto di balzare in piedi. Ma debbo riconoscere che veramente non posso più farlo. E con gli stessi occhi che avevano poc'anzi quei bambini, ora già così cresciuti, rimango a guardare finché posso, con tanta tanta compassione, ormai dietro a questi nuovi, i miei vecchi figliuoli. 1 Saba Trieste Ho attraversata tutta la città. Poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo: un cantuccio in cui solo siedo; e mi pare che dove esso termina termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore; come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva. Città vecchia Spesso, per ritornare alla mia casa prendo un'oscura via di città vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale, e affollata è la strada. Qui tra la gente che viene che va dall'osteria alla casa o al lupanare, dove son merci ed uomini il detrito di un gran porto di mare, io ritrovo, passando, l'infinito nell'umiltà. Qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il dragone che siede alla bottega del friggitore, 1 la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore; s'agita in esse, come in me, il Signore. Qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro dove più turpe è la via. *** Dopo la tristezza Questo pane ha il sapore d'un ricordo, mangiato in questa povera osteria, dov'è più abbandonato e ingombro il porto. E della birra mi godo l'amaro, seduto del ritorno a mezza via, in faccia ai monti annuvolati e al faro. L'anima mia che una sua pena ha vinta, con occhi nuovi nell'antica sera guarda una pilota con la moglie incinta; e un bastimento, di che il vecchio legno luccica al sole, e con la ciminiera lunga quanto i due alberi, è un disegno fanciullesco, che ho fatto or son vent'anni. E chi mi avrebbe detto la mia vita così bella, con tanti dolci affanni, e tanta beatitudine romita! 1 UNGARETTI I FIUMI Mi tengo a quest'albero mutilato abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna mani che m'intridono mi regalano la rara felicità Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato Questi sono i miei fiumi Ho ripassato le epoche della mia vita L'Isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso Questo è il Serchio al quale hanno attinto duemil'anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre Ho tirato su le mie quattr'ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere dell'inconsapevolezza nelle estese pianure Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole Questa è la Senna e in quel torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto Questo è l'Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia Questi sono i miei fiumi contati nell'Isonzo Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora ch'è notte che la mia vita mi pare una corolla di tenebre Cotici, il 16 agosto 1916 Ma quelle occulte 1 AMARO ACCORDO Oppure in un meriggio d'un ottobre Dagli armoniosi colli In mezzo a dense discendenti nuvole I cavalli dei Dioscuri, Alle cui zampe estatico S'era fermato un bimbo, Sopra i flutti spiccavano (Per un amaro accordo dei ricordi Verso ombre di banani E di giganti erranti Tartarughe entro blocchi D'enormi acque impassibili: Sotto altro ordine d'astri Tra insoliti gabbiani) Volo sino alla piana dove il bimbo Frugando nella sabbia, Dalla luce dei fulmini infiammata La trasparenza delle care dita Bagnate dalla pioggia contro vento, Ghermiva tutti e quattro gli elementi. Ma la morte è incolore e senza sensi E, ignara d'ogni legge, come sempre, Già lo sfiorava Coi denti impudichi. 1 Montale, L'anguilla L'anguilla, la sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi che risale in profondo, sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi di capello in capello, assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorielli di melma finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acquamorta, nei fossi che declinano dai balzi d'Appennino alla Romagna; l'anguilla, torcia, frusta, freccia d'Amore in terra che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione; l'anima verde che cerca vita là dove solo morde l'arsura e la desolazione, la scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito; l'iride breve, gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo, immersi nel tuo fango, puoi tu non crederla sorella? 1 Caproni, 1944 Le carrette del latte ahi mentre il sole sta per pungere i cani. Cosa insacca la morte sopra i selci nel fragore di bottiglie in sobbalzo? Sulla faccia punge già il foglio del primo giornale col suo afrore di piombo - immensa un’acqua passa deserta nel sangue a chi muove a un muro, e già a una scarica una latta ha un sussulto fra i cocci. O amore, amore che disastro è nell’alba! Dai portoni dove geme una prima chiave, o amore non fuggire con l’ultimo tepore notturno - non scandire questi suoni, tu che ai miei denti il tuo tremito imponi. 1
Scaricare