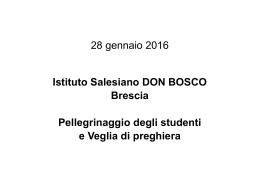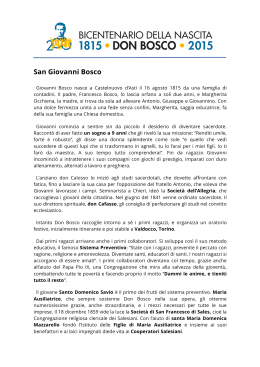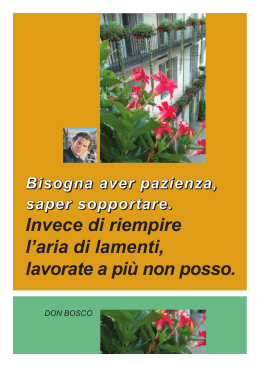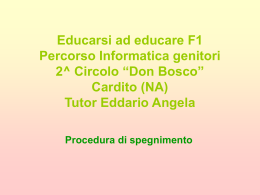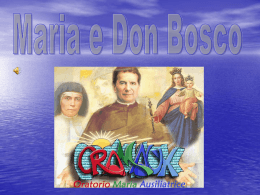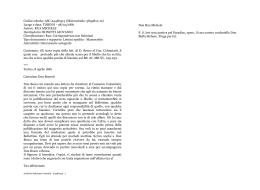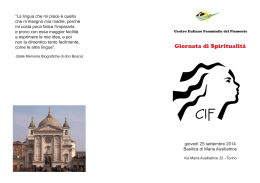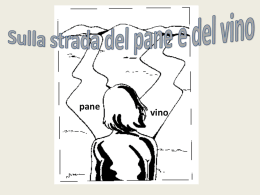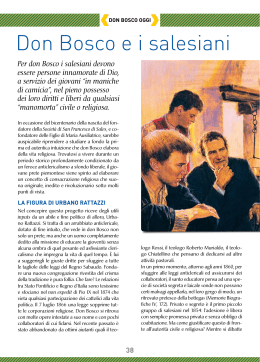90[[ETTINU'SALESIANO
ORGANO DEI COOPERATORI SALESIANI
ANNO XCIV • N. 17 • 1° SETTEMBRE 1970
Spediz . i n abbon . post. - Gruppo 2- (70) - 1 ° quindicina
I N QUESTO NUMERO
La voce del Cielo è al Pastore dei pastori
l 75 anni del Venezuela salesiano
La sterzata salesiana in America Latina
ll Rettor Maggiore nell'America Latina
Congresso mondiale Exallievi Don Bosco (1870-1970)
Perché non è sorta la chiesa di Mika washima a Tokyo
Invece della « fiesta », una scuola per i poveri
142 topolini all'Isola del Ratón
Nelle terre vergini dell'Alto Orinoco (3a puntata)
Conosciamo poco la Corea
I N COPERTINA
Asia del Ratón (Alto Orinoco - Venezuela). «Hanno un cortile pieno
di verde e di pappagalli variopinti,
grossi come galline o piccoli come
passeri, che si lasciano prendere
come gattini e sono compagni di
gioco» (servizio a pagina 20).
CARACAS (Venezuela) - TEMPIO
NAZIONALE A S. GIOVANNI BOSCO
Sorge al largo dell'eAvenida S. Juan
Bosco». Di fronte al Tempio si
estende la piazza dedicata al Santo.
Moderno, sobrio, funzionale, questo
Tempio è omaggio delle tre Famiglie
Salesiane con i loro allievi, exallievi
e amici al Padre e Maestro della
gioventù, nel 75° dei Salesiani nel
Venezuela. Vi hanno lavorato artisti
venezuelani, spagnoli, italiani.
La nuova Liturgia celebra continuamente il trionfo di Gesù Cristo risorto; è giusto che
vi si associ il trionfo della Chiesa, sua sposa, sempre intenta a liberarsi da ogni scoria
mondana, per apparire, come dice San Paolo, « tutta splendente, senza macchia o ruga...
ma santa e immacolata» (Efes., 5, 27). Don Bosco lo previde più di un secolo fa.
La voce del Cielo
è all~astor~e dei Pastori
1870: l'anno della grande svolta storica, religiosa e politica.
Lo caratterizzano tre avvenimenti importantissimi: il Concilio Vaticano I, la guerra franco-tedesca
• la caduta del potere temporale dei Papi, con la conseguente promozione di Roma a capitale d'Italia.
Succedutisi nel giro di quindici mesi, questi fatti influirono fortemente sulla storia dell'ultima parte
del secolo XIX e di mplti decenni nel ventesimo.
Don Bosco li previde o vi prese parte indiretta. Il 5 gennaio 1870, in una visione profetica, gli si squarciò
il velo del futuro; gli fu quindi possibile parlare dei tre avvenimenti con la sicurezza di chi li ha visti
svolgersi sotto i propri occhi.
1l Concilio Vaticano 1
Anzitutto il Concilio Vaticano, aperto un mese prima, l'8 dicembre 1869.
Nella storia della Chiesa ha avuto un'importanza primaria, e il suo influsso si fece sentire per quasi
un secolo, fino al Vaticano II, che di esso - come ha affermato Paolo VI il 4 dicembre 1963 - è
« naturale continuazione e complemento ».
Fin dall'inizio, l'attenzione dei Padri fu polarizzata dalla proposta di definizione dell'infallibilità del
Papa: caldeggiata da una larga maggioranza di vescovi, ma osteggiata da una agguerrita minoranza
che la diceva inopportuna, data l'avversione degli Stati e governi, e che agitava fantasmi di reazioni
• di scismi, qualora venisse definita.
Don Bosco, informato della cosa, credette bene di portarsi a Roma. Vi giunse alla fine di gennaio, e
cominciò subito un lavoro estenuante di accostamento dei Padri favorevoli per animarli a resistere,
• di vescovi contrari o incerti, per attirarli alla tesi infallibilista. In colloqui con singoli e con gruppi,
egli smantellava le obiezioni che gli venivano fatte: in tal modo esercitò un influsso sensibilissimo,
perché quanti trattavano con lui, se ne partivano decisi a sostenere la tesi dell'infallibilità.
Il 12 febbraio ebbe udienza dal Papa, che gli parlò ampiamente delle cose del Concilio. Allora Don
Bosco ritenne opportuno presentargli la parte della visione avuta, che ne trattava con precisione fotografica. « La voce del cielo - vi si diceva - è al Pastore dei pastori. Tu sei nella grande conferenza coi
tuoi assessori; ma il nemico del bene non istà un istante in quiete; egli studia e pratica tutte le arti contro di
te. Seminerà la discordia fra i tuoi assessori; susciterà nemici fra i figli miei. Le potenze del secolo vomiteranno fuoco e vorrebbero che le parole fossero soffocate nella gola ai custodi della mia legge... Tu accelera;
se non si sciolgono, le difficoltà siano troncate... ». La situazione politica europea si faceva ogni giorno
più precaria, come apparve qualche mese dopo, quando il Concilio, proprio per questo motivo,
venne, sospeso.
Gli sforzi di Don Bosco, uniti a quelli di quanti cercavano il vero bene della Chiesa, ottennero
il loro scopo. Il 18 luglio, la definizione dogmatica dell'infallibilità pontificia veniva approvata
dalla quasi totalità dei Padri presenti.
1
La guerra franco-prussiana
Parve che Dio avesse tenuto
sospesi gli avvenimenti fino a
quel momento: poi ripresero libero corso. Proprio il giorno dopo,
iq luglio, Napoleone III dichiarava guerra alla Prussia. L'esito fu ben diverso dal previsto:
una nazione cattolica venne sconfitta; sorgeva all'orizzonte l'astro
di una potenza che avrebbe esercitato un ruolo di primo piano
nella politica mondiale di questi
cent'anni.
Anche questa guerra Don Bosco
l'aveva prevista.
« Le leggi di Francia - diceva
egli nella visione profetica non riconoscono più il Creatore,
• il Creatore si farà conoscere
• la visiterà tre volte con la verga
del suo furore (...). Nella seconda
sarà privata del suo capo, in preda
al disordine: (resa di Napoleone
III a Sédan , il io settembre
1870). Parigi... nella terza cadrai
in mano straniera (gennaio 1871).
I tuoi nemici di lontano vedranno
i tuoi palazzi in fiamme, le tue
abitazioni divenute un mucchio di
rovine»: (gli orrori della Comune,
marzo-maggio 1871).
La fine del potere temporale
La sconfitta della Francia, che
si era impegnata a difendere lo
Stato pontificio, apriva la via
all'occupazione di Roma da parte
del Regno d'Italia. Don Bosco
l'aveva previsto.
« Roma! - sentì dire nella visione - Io verrò quattro volte a te ».
Nella terza « abbatterò le difese
• i difensori» e cesserà « il comando
del Padre ». Questo avvenne il
2o settembre 1870. In quel giorno
cadeva il potere temporale dei
Papi.
Di questa eccezionale istituzione
politica e della sua lunga storia
di dodici secoli si possono dare
i giudizi più opposti: o di esaltazione, per aver provveduto alla
indipendenza del papato dalle potenze terrene in ogni tempo bramose di asservirselo come docile
strumento; o di biasimo intinto
di spregio - come sogliono fare
gli storici inclini alla parzialità 2 quasi sia stato, per la Chiesa
e per l'Italia, una fonte inesausta
di mali.
Lo Stato pontificio sorse in
una maniera del tutto diversa
da qualunque altro: per volere di
popolo, non per conquista di
armi. Un'origine di altissima nobiltà. Per dodici secoli si mantenne
sempre quasi negli identici confini, mentre le occasioni di allargarli
erano continue: altro segno di
nobiltà, escludente bramosia di
potere terreno.
Al potere teocratico univa gli
aspetti di una democrazia, quale
raramente si trova nella storia
passata. Non per nulla portava il
nome di « Stati pontifici*, una
unione cioè di città e staterelli
sotto un unico sovrano, ma con
leggi e privilegi propri larghissimi.
Ancora, esso - come disse Pio
XI - fu quasi l'unico lembo
d'Italia, rimasto sempre italiano
e libero da dominio straniero.
Soprattutto il suo merito si è
di aver difeso l'indipendenza del
Pontefice dalle pretese dei vari
Cesari, succedutisi nel lungo arco
di dodici secoli, in Europa.
Ma ormai aveva assolto alla sua
missione: era ridotto a un brandello, sostenuto per di più da
armi straniere. Doveva fatalmente cadere.
Don Bosco ne prevede
l a caduta
Negli anni roventi del Risorgimento, quando veniva imposto
come un dovere del buon cittadino
presentare il Papa come un usurpatore, nemico d'Italia, Don Bosco
aveva difeso apertamente il potere
temporale e i diritti di Pio IX sui
suoi domini; ma non si nascondeva
che il movimento unitario, facente
capo al Piemonte, avrebbe dato
il colpo di grazia a questa secolare
istituzione, non più valida per
i tempi moderni. Con gli intimi,
anzi, non nascondeva il suo pensiero. Nell'ottobre del 1867, scrivendo a persona amica, diceva:
« Stia tranquilla che avanti sia
compiuta l'unità italiana (ciò sarà
presto) il libro sarà ultimato*.
Persino al Papa manifestava la
sua persuasione. Parecchi anni
prima, nel 1863, servendosi di mezzo sicuro, aveva fatto sapere a
Pio IX che si preparasse a perdere
i suoi domini temporali. E avrebbe
desiderato che almeno i responsabili degli Ordini e Congregazioni monastiche si preparassero
a salvare il salvabile, in vista
dell'estensione al Lazio e a Roma,
delle leggi eversive contro i religiosi. Ma come far capire queste
elementari norme di prudenza a
gente convinta di un intervento
straordinario e miracoloso del cielo,
a impedire la presa di Roma: o
che, se ammetteva possibile la cosa,
la riteneva passeggera,' cosicché
dopo qualche mese tutto sarebbe
tornato allo stato di prima? Quelle
teste si erano fermate al 1849, e
al ritorno di Pio IX dall'esilio di
Gaeta.
I n azione per la Chiesa italiana
Quando gli venne comunicata
la presa di Roma, Don Bosco
non diede alcun segno di meraviglia. Sembrava che ne fosse
già a conoscenza.
l/ 18 luglio 1870 1/ Concilio
della infallibilità pontificia.
E non si perdette in lamentele
e recriminazioni. Da uomo pratico,
cercò subito di portare un rimedio
ai mali che affliggevano la Chiesa
in Italia. Anzi tutto, bisognava
provvedere alla libertà del Papa,
che la nuova situazione politica
assoggettava all'autorità italiana.
Né la legge delle Guarentigie
migliorò la situazione perché aveva
ignorato il punto capitale: il Papa
era costretto ad abitare in casa non
sua, in maniera precaria, affidata
agli umori dei padroni, dai quali
riceveva il salario, con l'obbligo
di accettarne una legge, quasi
fosse un suddito qualunque. Con
la mentalità liberale di allora non
era possibile migliorare tale condizione.
Tuttavia Don Bosco prese l'iniziativa, perché tante diocesi italiane
- quasi cento - non restassero
più a lungo prive dei loro pastori.
E riuscì nell'impresa, che sembrava
inattuabile, mostrandosi abilissimo
mediatore fra il Papa e il governo.
Sarebbe pure riuscito a otte -
Vaticano 1 approvava la definizione dogmatica
nere per i vescovi le temporalità ossia il sussidio fissato per legge
dopo l'incameramento dei beni
ecclesiastici - ma gli intrighi della
setta massonica resero vani i suoi
sforzi. Il suo sogno, però, restava
la conciliazione completa tra i
due Poteri, che ponesse fine a
un conflitto deleterio sia per la
Chiesa che per l'Italia.
La sospirata Conciliazione...
Una situazione così anormale,
con punte di acre ostilità e di
tacita intesa, durò per lunghi
decenni, fino al 1929, quando
col trattato del Laterano, stipulato tra la Santa Sede e l'Italia,
ebbe fine il doloroso dissidio.
Con la creazione della Città del
Vaticano, il Pontefice vide riconosciuta la sua indipendenza, mentre
il Concordato offriva una salvaguardia ai diritti della Chiesa
contro le pretese autoritarie, ieri,
e quelle democratiche, oggi, di
chi per ignoranza o avversione
ne contrasta l'opera e il ministero.
Parve coincidenza voluta da Dio,
che tale Conciliazione avvenisse
prima della beatificazione di Don
Bosco, per opera di Pio XI, il
quale affermò d'aver udito il novello Beato dire quanto « questa composizione del deplorevole dissidio
stava veramente in cima ai suoi
pensieri e agli affetti del cuore »:
e doveva avvenire « in modo tale
che innanzi tutto si assicurasse
l'onore di Dio, l'onore della Chiesa,
il bene delle anime ».
... preannunciata da Don Bosco
Don Bosco aveva preveduto questo
importante avvenimento, che ha
avuto conseguenze considerevoli
per il nostro secolo travagliato.
E ne aveva fatto cenno più volte.
La prima fu quando Pio IX
era incerto se rimanere a Roma
come prigioniero, oppure trasferire la propria residenza all'estero
- e parecchie nazioni cattoliche
gli offrivano decoroso asilo -. 3
La corte pontificia e parecchi
cardinali premevano per questa
soluzione, ritenuta la più sicura
e dignitosa. La voce pubblica
la dava già come certa, e l'esempio
dell'andata del Papa a Gaeta nel
1848 era invitante. Ma Pio IX
restava dubbioso se affrontare un
passo, il cui esito poteva essere
negativo e non facilmente riparabile: una seconda cattività di Babilonia, senza speranza di ritorno ?
Alla fine egli volle conoscere il
parere di Don Bosco, come aveva
fatto tante altre volte in situazioni
scabrose. Il Santo pregò a lungo
per ottenere una illuminazione
celeste, poi, a mezzo persona
fidatissima, fece giungere al Pontefice la voce di Dio: « La sentinella,
lui onerosissima, della chiesa del
Sacro Cuore a Roma, egli disse
a un suo salesiano:
- Sai perché abbiamo accettato
la casa di Roma?
- Proprio no - rispose quegli.
- Ebbene sta attento - gli disse
Don Bosco -: quando il Papa
sarà quello che ora non è e come
deve essere, metteremo nella nostra
casa la stazione centrale per evangelizzare l'agro romano».
Parola profetica, se si pensa che
la parrocchia di Littoria (ora, Latina) nell'agro di recente bonificato,
fu affidata ai Salesiani, quando già
la Conciliazione era una felice
realtà.
Ancora qualche squarcio
sul futuro
l'angelo d'Israele, si fermi al suo
posto, e stia a guardia della rocca
di Dio- e dell'arca santa ». Ricevuto
Le previsioni, o meglio, le predizioni di Don Bosco
si sono
«rivestito
avverate. Il Papa,
degli
antichi abiti, è come dev'essere».
Libero e indipendente: padrone di
radunare un concilio in casa sua,
o di partire missionario a evangelizzare le genti di ogni continente.
Tutto questo, che nel 187o nessuno immaginava, né al di qua,
né al di là del Tevere, Don Bosco lo
predisse: anzi andò ancor più oltre.
Dopo il 1929 egli prevedeva
questo messaggio, di partire non
si parlò più. Agli intimi che
insistevano, il Papa rispondeva:
« Dinanzi a Dio non mi sento
ispirato ad abbandonare Roma, come
mi sentii ispirato nel novembre
1848 ».
Noi che viviamo a un secolo di
distanza possiamo valutare quanto
sia stata felice, per la Chiesa e per
l'Italia, la soluzione proposta da
Don Bosco e accettata da Pio IX .
Un altro accenno alla Conciliazione si trova nella succitata profezia del 5 gennaio 1870. Dopo
aver affermato: « Queste cose do-
«un violento uragano, »... Poi, « l'iride
di pace comparirà sulla terra...
In tutto il mondo apparirà un
sole così luminoso, quale non fu
mai dalle fiamme del Cenacolo,
fino ad oggi... ».
vranno inesorabilmente venire l'una
dopo l'altra », il Veggènte continua:
« Le cose si succedono troppo lentamente. Ma l'augusta Regina del
cielo è presente. La potenza del
Signore è nelle sue mani; disperde
come nebbia i suoi nemici. Riveste
il Venerando Vecchio (del Lazio)
di tutti i suoi antichi abiti ». Fu
appunto nella festa della Madonna
di Lourdes ( ii febbraio) che al
Papa venivano riconosciute in un
patto solenne, la sua libertà e
podestà, con tutti i diritti di
Sovrano indipendente. Avvenimento grandioso, che ebbe un influsso straordinario sulla storia,
non solo d'Italia, ma d'Europa
e del mondo.
Una terza volta, nel 188o, Don
Bosco annunziò la futura indipendenza del Papa. Nel giorno
4 in cui accettò la costruzione, per
Pio /X. il Papa
del Concilio Vaticano /,
sul quale Don Bosco
ebbe una visione profetica.
• forse quella pace di cui
continuamente si parla e che da
25 anni è per tutti i popoli il
sospiro più ardente?
• si tratta della grande primavera pentecostale, preannunziata
anche da Pio XII e da Papa
Giovanni, che dovrà spuntare dopo
il buio e la confusione attuale ?
Affermazioni profetiche, fatte da
uomini di alta santità e così
distanti nel tempo, lo lasciano
supporre.
• se è così, possiamo pure
guardare con fiducia al grande
« trionfo della Chiesa», da Don
Bosco più volte vaticinato con
certezza e convinzione, espresse
pure con le parole: «« Se non
potremo assistervi quaggiù, vi assisteremo, spero, dal paradiso ».
a
Attesi con impazienza da duemila cooperatori salesiani, 75 anni fa i primi sette pionieri della Congregazione entravano in Venezuela. Ora i salesiani sono 350, ben preparati e pronti a fronteggiare
gli enormi problemi che la gioventù crea in una nazione proiettata verso un vorticoso futuro.
1 75 ANNI
DEL VENEJUELA SALESIANO
' è a Caracas in Venezuela un piccolo prete consuC
mato dagli anni, che è uno scrigno di ricordi e
si vanta di poter dire riguardo ai primi salesiani giunti
laggiù: «Io c'ero, io li ho visti arrivare ». Ha 93 anni,
è monsignore e si chiama Antonio Pacheco .
« Avevo diciassette anni - ricorda, - ero alunno
del seminario di Valencia». Quel giorno, 2o novembre 1894, erano accorsi in molti a ricevere i forestieri,
erano corsi sóprattutto loro seminaristi, perché il compito di accompagnare ufficialmente i primi salesiani
fin lì a Valencia era toccato proprio al vice-rettore del
seminario, monsignor Arocha, un " aficionado " di
Don Bosco, che per essere davvero sicuro che finalmente i salesiani sarebbero venuti in Venezuela era
andato a prelevarli direttamente a Torino.
Monsignor Arocha aveva preparato in Valencia per
i salesiani una vasta casa in cui aprire il collegio. La
spedizione mandata da Don Rua comprendeva sette
confratelli: due sacerdoti, quattro chierici e un coadiutore. Avevano lasciato Genova venti giorni prima,
i mbarcati sul piroscafo Rosario, che si portava oltre
oceano molti emigranti ricchi solo di speranza, salutati
da mille mani che disegnavano nell'aria la carezza di
un ultimo addio. Solo tre salesiani erano destinati a
Valencia, gli altri quattro andavano a Caracas, la capitale. Venezuela, Caracas, Valencia: un mondo lontano come la luna, carico di mistero come il disegno
di Dio che li chiamava a immolare giorno dopo giorno
la vita per ragazzi sconosciuti e predestinati.
IMPRUDENZA CONSIGLIATA DAL VANGELO
Monsignor Pacheco nei suoi 93 anni ricorda molto
bene don Bergeretti - l'unico sacerdote mandato con
due chierici a Valencia - che era andato a incontrare
alla stazione di Puerto Cabello. '« Ricordo - dice che alla stazione c'era la banda musicale e una grande
animazione. E la banda suonò lungo tutto il percorso
da Puerto Cabello a Valencia, senza interruzione, finché
fummo arrivati ».
Don Bergeretti era un pioniere d'acciaio, uscito forgiato dalle mani di Don Bosco, e presto seppe conquistarsi l'amicizia di tutti. Pochi giorni dopo l'arrivo mise
in piedi l'oratorio e fece pubblicare sul giornale che il
collegio stava per aprirsi, perciò i buoni lo aiutassero
soprattutto portando il mobilio, e i genitori gli portassero i « muchachos ». Ormai si sentiva venezuelano
nell'anima.
Monsignor Pacheco ricorda poi l'epidemia di vaiolo
che qualche anno più tardi setacciò la città di Valencia
falciando diecimila abitanti. Don Bergeretti allora chiuse
momentaneamente il suo collegio e con gli altri salesiani corse a prestare aiuto ai malati. Un salesiano restò
contagiato e pagò l'abnegazione di tutti con il prezzo
della sua vita. Passato il contagio, il governo si sdebitò
conferendo a don Bergeretti una decorazione. Poi
don Bergeretti compì un'imprudenza consigliata dal
Vangelo, e ospitò un fuggitivo nemico personale del
capo dello Stato di allora. Non l'avesse mai fatto. Il 5
governo dimenticò abnegazione e meriti, e fra la costernazione degli amici lo cacciò fuori dal Venezuela.
Le cose a quei tempi andavano così.
Ma c'era posto anche altrove per fare del bene, e
don Bergeretti visse e morì negli Stati Uniti. Ora il
suo esilio è finito: gli exallievi - venezuelani sono andati
a Oakland (USA) a riprendersi le sue reliquie, e le hanno
riportate a Valencia.
Gli altri quattro salesiani (don Riva con due chierici
e un coadiutore) giunti a Caracas trovarono festose
accoglienze e una sgradita sorpresa. Pensavano che sarebbe stata loro affidata una scuola di Arti e Mestieri,
per questo erano venuti dall'Italia, e invece si videro
offrire solo l'insegnamento, mentre i programmi erano
già fissati dall'alto, e la direzione e amministrazione erano
tenute da un gruppo di laici. Era come lasciarsi legare
le mani, mentre a quei salesiani piaceva rimboccarsi
le maniche e impastare la pasta alla loro maniera.
Don Riva dichiarò subito che quelle condizioni erano
inaccettabili, e le trattative naufragarono lì.
Del resto anche per loro c'erano tante possibilità di
fare del bene altrove. Un benefattore li tolse di mezzo
alla strada offrendo una casetta in un villaggio di duemila abitanti, il « Rincon del Valle », alla periferia di
Caracas, privo di ogni forma di assistenza e di scuole.
Riattivarono la chiesetta e aprirono una scuola per i
figli del popolo. L'anno dopo affittarono una grande
casa in Caracas, vi aprirono i loro laboratori, e quando
ebbero tanti ragazzi da non saper più dove metterli
costruirono il collegio di Sarría, con l'attigua « Scuola
per i poveri », ancor oggi aperta dopo 73 anni.
Nonostante le disavventure degli inizi, i primi salesiani si trovarono bene in Venezuela, perché circondati dalla solidarietà affettuosa di tante persone che a
lungo li avevano invocati e attesi.
Caracas. ti Presidente della Repubblica del Venezuela,
dr. Rafael Caldera, dopo aver assistito all'inaugurazione
del monumento a Don Bosco sulla —Piazza Don Bosco',
firma la pergamena da collocarsi nella prima pietra
della nuova opera che sorgerà alla periferia di Caracas.
DUEMILA COOPERATORI IMPAZIENTI
Aveva cominciato col farsi avanti l'arcivescovo di
Caracas, nel 1886, piombando a Torino per sollecitare
da Don Bosco una spedizione di salesiani. Don Bosco
aveva promesso che gliela avrebbe mandata appena
possibile.
L'anno dopo un sacerdote
di Caracas, il padre Ri,
cardo Arteaga, buon conoscitore delle cose salesiane,
scriveva a Don Bosco per chiedergli l'autorizzazione
a fondare in Venezuela un centro di Cooperatori salesiani. Don Bosco così rispondeva a quel lontano
"Fratello in Corde Christi": « La sua dell'8 marzo mi
causò grande consolazione e allegria, perché constato
che anche lontano da noi ci sono anime ottime che si
interessano della nostra umile . e incipiente Congregazione.
L'idea che mi propone è eccellente sotto ogni punto
di vista, e la asseconderemo il più possibile. Fra breve
invierò il diploma di Direttore di codesti Cooperatori,
e un altro diploma di Decurione, che lei nominerà
d'intesa con l'Arcivescovo. Desidereremmo sapere i
nomi di questi Cooperatori, con i rispettivi indirizzi, per
mandar loro tutti i mesi il Bollettino Salesiano ». Allora,
del Bollettino si stampava già l'edizione spagnola, e fu
questa a prendere il volo per Caracas.
Come conseguenza, due anni ,,dopo la cooperatrice
di Valencia Maria Pérez de Sanfander bussava all'ufficio di don Rua a reclamare che venisse mantenuta la
promessa di Don Bosco. Due anni più tardi, un salesiano diretto in Colombia, passando per Caracas,
6 trovava i Cooperatori saliti a duemila, organizzati e
efficienti. Alcuni di essi nel 1893 convinsero il governo
a chiamare i salesiani per la scuola di Arti e Mestieri.
Anche se l'idea fallì, l'occasione fu decisiva perché i
salesiani sbarcassero finalmente in Venezuela.
Da sette, i salesiani sono ora 350, molti venuti dall'Italia e dalla Spagna, ma molti ormai « venezuelani
di Venezuela ». Hanno venti case con ogni sorta di
opere, e una dozzina di centri avanzati nella foresta,
tenuti da missionari alle prese con i primitivi.
LE NUOVE OPERE MODERNE
Sono ancora oggi efficienti molte opere tradizionali
avviate dai primi coraggiosi pionieri, come le Scuole
Professionali a Caracas e Valencia, la prima Scuola
Agraria sorta in Venezuela e aperta dai salesiani a
Naguanagua, un Liceo, le Scuole Popolari gratuite, le
parrocchie (anche recenti) accettate per aiutare le diocesi povere di clero, eccetera.
Accanto a queste opere, ne sorgono di nuove e moderne, rispondenti a precise esigenze dei luoghi e dei
tempi. Tipico è il Centro Agricolo di Carrasquero ,
dove trecento ragazzi provenienti dall'interno rurale
arrivano ogni anno e si fermano un solo anno, giusto
il tempo per imparare a fondo tutti i segreti di una
coltivazione (quella principale della loro terra) e per
rispolverare l'alfabeto e il catechismo. L'estrazione del
petrolio - ricchezza inesauribile della nazione - richiede sempre più braccia al lavoro, e i salesiani hanno
aperto un collegio che accoglie i5oo figli dei lavoratori
petrolieri.
Dal 1968 lo sforzo organizzativo è orientato verso i
Circoli giovanili, moderne versioni dell'oratorio di
Don Bosco. Maggiore cura viene rivolta ai cooperatori
e agli exallievi (trenta di essi dopo le ultime elezioni
siedono sui banchi del parlamento). E a loro volta ex,
allievi e coperatori
danno un efficace aiuto ai salesiani nelle loro opere.
Da alcuni anni funziona la "Libreria Editorial Salesiana", che lancia libri utili per la pastorale giovanile.
Il Bollettino Salesiano esce in edizione nazionale da
più di venti anni.
L'Ispettoria ha case di formazione efficienti, a volte
bellissime, per l'aspirantato , il noviziato e lo studentato
filosofico. I chierici teologi, per una saggia politica di
aggiornamento, sono mandati a fare gli studi in Europa. Tornano con mentalità aperta, sovente dopo aver
compiuto studi superiori che permettono apostolati di
specializzazione.
A Caracas salesiani preparati nella pastorale giovanile dirigono un Centro apposito, un Club, un Servizio
di Orientamento giovanile, opere poste in zone strategiche della città dove è possibile un efficace lavoro
sociale e di evangelizzazione.
Gli ultimi tre superiori dell'Ispettoria sono di origine venezuelana; uno di essi, don Castillo , è stato
chiamato al centro della Congregazione e fa parte del
Consiglio Superiore. I " muchachos " d'oratorio, incantati dal fascino salesiano di don Bergeretti e dei primi
pionieri, sono dunque cresciuti e maturati, e ora divenuti salesiani (il primo di essi è ancora vivo, si chiama
Francesco Alvares , e ha 95 anni) occupano con autorità e competenza il loro posto nella Congregazione e
nella Chiesa.
È una fortuna che sia così, perché il compito che li
attende è enorme.
VENEZUELA E GIOVENTÙ
Un recente articolo del Bollettino Salesiano locale intitolato « Venezuela e gioventù » riporta alcuni dati impressionanti. In Venezuela l'8o,88 per cento della popolazione è di età inferiore ai trent'anni, il 54,3 per cento
al di sotto dei venti.
Dice l'articolo che si tratta di una gioventù cittadina:
per, il 73 per cento vive in città. Ma in gran parte è
sradicata dalla campagna, vive ammonticchiata in agglomeraii di fuggitivi, non integrata, in situazioni alienanti.
Aggiunge l'articolo: è una gioventù abbandonata. Si
parla di 400.000 ragazzi abbandonati, si parla di figli
illegittimi in misura del 53 per cento. Quanto a situazione scolastica solo il 33 per cento di quelli che cominciano le scuole primarie le finiscono; solo il 34
per cento di quelli che cominciano le medie le concludono; solo il 26 per cento degli iscritti all'università
si laureano.
L - prosegue l'articolo - una gioventù disoccupata.
Manca a troppi un'occupazione per il tempo libero,
manca a troppi anche un posto di lavoro. Gioventù
sradicata, abbandonata, disoccupata, disorientata.
Articoli chiari come questi, arrivano col Bollettino
Salesiano nelle case della Congregazione e nelle case dei
Cooperatori perché tutti insieme vogliono guardare con
realismo in faccia alla realtà.
Il problema che queste cifre sui giovani pongono è
così complesso che solo la collaborazione di tutti gli
l/ salesiano coadiutore Sebastiano Pagliero
firma la pergamena
della prima pietra della
erigenda Scuola Tecnica popolare
che dovrà dirigere a Caracas-Boleita.
adulti può risolverlo. Ma solo il 19 per cento dei venezuelani è al di sopra dei trent'anni, solo il 40 per cento
ha più di venticinque anni. E c'è da togliere i troppo
anziani, i malati, gli incapaci per ignoranza o miseria...
Per la pattuglia qualificata dei 350 salesiani in Venezuela, il compito è immenso. Con la loro preparazione sono chiamati a fare, e più ancora a far vedere
agli altri come si fa. Da molte parti si guarda a loro
con fiducia.
La sera del 2o novembre 1969 - 75 anni tondi dopo
l'arrivo dei primi salesiani al suono della banda ascoltata
da monsignor Pacheco - a Caracas in piazza Don Bosco
(una bella piazza circolare tutta verde, di fronte al collegio Altamira) veniva inaugurato un monumento al
Santo dei giovani. Tra i presenti era anche il Presidente del Venezuela, Rafael Caldera. Forse era lì per
esprimere un cortese grazie, come si usa in simili circostanze, ma più ancora forse era lì perché si aspettava
qualcosa dai salesiani. Nel silenzio teso della folla, il
superiore dei salesiani, padre José Henriquez pronunciò
una «buona notte » programmatica e impegnativa. « I
salesiani - disse come scandendo una promessa si compromettono a lavorare con tutte le loro forze
perché i prossimi 25 anni siano segnati da un impegno
più vivo, più audace, più visibile, verso tutti i giovani,
specialmente i più bisognosi».
E perché questa promessa non sembrasse un vuoto
giro di parole, tre giorni più tardi inaugurava - nella
periferia di Caracas - la costruzione di un Centro
Giovanile e di una Scuola Tecnica popolare.
a7
LA STERZATA SALESIANA
I N AMERICA LATINA
« Sterzata coraggiosa
brata» . Queste parole,
ma
equili-
pronunciate
due anni fa a Caracas dal Rettor
Maggiore, suonarono allora, all'orecchio degli ispettori latino-americani, assai più che un facile slogan:
come un programma da realizzare.
E caratterizzano bene questi tempi
della Congregazione e della Chiesa:
tempi di esami di coscienza, di ripensamenti, di programmazioni e di
realizzazioni.
La Congregazione salesiana tre
anni prima, nel '65, aveva celebrato
a Roma un Capitolo Generale innovatore. La riunione degli ispettori
latino-americani nel '68 terminava
8 mettendo a punto una serie di « con-
clusiones » programmatiche. Pochi
mesi più tardi, i Vescovi dell'America
Latina riuniti a Medellin compilavano una serie di documenti che
giustamente sono considerati la continuazione dei decreti conciliari . In
quegli stessi giorni il Papa Paolo VI,
in visita a Bogotà, elogiava in pubblico le « conclusiones » degli ispettori salesiani. Un anno dopo, nel `6q,
i superiori delle Congregazioni religiose tenevano nuove riunioni in
Cile e Colombia: si interrogavano sul
preoccupante fenomeno sociale del
sottosviluppo, e sulla testimonianza
di povertà che il religioso deve
rendere al mondo. Questa ondata di
riunioni, discussioni, puntualizzazio -
ni , documenti e conclusioni, ha fatto
progredire l'appassionante discorso
sulle responsabilità dei religiosi nell' America Latina.
Ed ecco le nuove riunioni degli
ispettori salesiani, nel giugno scorso.
Don Ricceri li ha incontrati con i
loro vicari ispettoriali e i direttori
delle case di formazione, in tre
riunioni successive, di quattro giorni
ciascuna, tenute a Caracas, a Brasilia e ad Asunción . E la Congregazione in America Latina che si interroga. Deve controllare il cammino
percorso, confrontare le esperienze
fatte, mettere a punto nuovi princìpi
operativi. Deve insomma verificare
se la famosa sterzata - il viraje ,
I
Tre riunioni tenute nel giugno
scorso dal Rettor Maggiore con
gli Ispettori dell'America Latina offrono l'occasione per fare il punto
sul lavoro che i salesiani svolgono in quel continente esplosivo.
sull'argoAbbiamo intervistato
mento l'ispettore del Venezuela,
Don José Henriquez, che prese
parte agli incontri.
come lo chiamano laggiù - sta
davvero avvenendo.
Sui lavori svolti, sui motivi di
fondo, sui temi affrontati, abbiamo
sollecitato un'intervista a uno dei
partecipanti, l'Ispettore del Venezuela don José Henriquez . Questo
giovane Ispettore - 42 anni, figlio
dell'America latina - ci è parso
particolarmente indicato a tracciare il
quadro della situazione.
Bollettino
Salesiano.
Quali
problemi pone oggi l'America
Latina alla coscienza della Congregazione?
Don Henriquez . In primo luogo,
come è ovvio, l'America Latina pone
a noi salesiani i problemi stessi che
già interrogano l'uomo comune, qualsiasi uomo per il fatto di essere cittadino di questo pianeta. In concreto
è un ventaglio di problemi enormi
e fuori del comune che si apre davanti allo sguardo nell'odierna geografia umana e religiosa del nostro
continente. Tutto è in movimento
nell'America Latina: gli uomini e i
gruppi, le masse dei marginali e
degli spostati, la società tradizionale
che si disgrega, lo sviluppo economico,
la vita politica, la famiglia, la cultura,
la religione, l'esplosione demografica,
la stessa « coscienza » latino-americana. Tutto è in movimento.
Ciò accade anche in altri continenti,
ma da noi assume il carattere del
dramma, a volte della tragedia.
Non si è stati a far niente. Si è già
realizzato molto; in alcuni aspetti
dell'integrazione economica, culturale e religiosa, si è più avanti che
in ' alcuni paesi dell'Europa. Ma è
solo una minima parte, praticamente
qui è ancora tutto da fare. In moltissimi
settori le piste di decollaggio sono
ancora intatte. La nostra crescita non
è stata proporzionale alla velocità e
all'accelerazione con cui hanno fatto
irruzione i problemi e le loro complicazioni. La Chiesa, e in essa la
Congregazione, hanno davanti a sé
un compito quasi incredibile; ci si
ritrova di nuovo come il piccolo
David alle prese con lo smisurato
Golia...
In secondo luogo, la coscienza
salesiana ha da far sua la problematica della Chiesa. Ora c'è stata la
Conferenza di Medellin , tutti i nostri
Vescovi riuniti, un nuovo Vaticano Il
per l'America Latina. Riprendendo le
parole del cardinal Suhard all'indomani della seconda guerra mondiale,
possiamo dire che con Medellin « è
morto qualcosa che non risorgerà
mai più ». La Chiesa ha auscultato
il cuore del Continente, ha misurato
le profondità abissali dei suoi problemi, ha preso come parola d'ordine
quello « sviluppo dei popoli propugnato da Paolo VI che si adatta così
bene ai nostri popoli afflitti da quelle
terribili malattie che sono il benessere
di gruppi ristretti e la miseria e il
«sub-desarrollo » dei piú .
In terzo luogo, la Congregazione
in America Latina ha i suoi propri
problemi, che le derivano dalla sua
particolare missione nella Chiesa.
Fra cinque anni la Congregazione
compirà i cento anni di presenza
operante in America. Le sue benemerenze passate sono fuori discussione: dal Messico alla Terra del
Fuoco c'è stata una vigorosa fioritura
di iniziative e di opere, quasi seimila salesiani e altrettante salesiane
sono attualmente al lavoro, un valido servizio di umanizzazione e di
evangelizzazione è stato reso ai popoli latino-americani. Ma in un
recente passato era trapelato qualche
segno di stanchezza, e il bisogno di
affrontare con soluzioni nuove i
nuovi problemi.
Bollettino Salesiano. Quali sono questi nuovi problemi?
Don Henriquez. Il problema dei
giovani, per esempio, vissuto nelle sue
nuove dimensioni. Il lavoro spesso
febbrile nelle nostre opere sovente
ci assorbiva al punto da farci quasi
dimenticare che nel frattempo stava
sorgendo una nuova classe giovanile,
che un nuovo continente si era affacciato alla storia: i giovani. Assorbiti
dal nostro ordinato lavoro quotidiano,
quasi non ci accorgevamo che milioni
di giovani rimanevano al margine
della nostra azione. Numericamente
essi superavano le nostre possibilità;
qualitativamente si profilavano situazioni nuove, per le quali occorreva
richiamarsi alla vocazione salesiana
primigenia. Forse si era persa quella
speciale «vibrazione* per i giovani.
Forse non era più altrettanto chiaro
che il cuore della Congregazione deve
battere dove batte il cuore dei giovani, che i salesiani sono legati alla
gioventù per la loro peculiare consacrazione, che sono votati corpo e
anima ai giovani.
Collegato con quello precedente, è
il problema della creatività. Una
Congregazione consacrata ai giovani
dev'essere costantemente creatrice,
altrimenti non sarà capace di tenere
il passo rapido della gioventù. Don
Bosco diceva: « Quando si tratta di
fare il bene ai giovani, io sono disposto a tutto: perfino all'audacia ».
L'America Latina sta chiedendo ai
salesiani - specialisti dei giovani questa creatività e audacia che fa
superare i momenti di stanchezza e
allarga lo sguardo, le braccia e il
cuore, e porta ad avanzare, a impastarsi con la gioventù latino-americana.
Un terzo problema, posto in forma
pressante e ansiosa dall'America Latina, è il problema del sottosviluppo.
La Congregazione, pur con il suo
brillante passato, oggi non appariva
più come consacrata in pieno al
servizio dei giovani e delle classi
popolari ; nuovi fattori rendevano meno decifrabile il suo impegno, per
esempio con i giovani lavoratori 9
americani. Si avvertiva quindi più
acuta - di fronte al sottosviluppo
dei popoli - l'insufficienza della
testimonianza e del servizio da rendere alle classi giovanili popolari,
che costituiscono come il cuore del
carisma salesiano.
Tutta questa problematica non
poteva non far presa sulla coscienza
della Congregazione, e lo dimostra
il fatto che è stata affrontata e discussa ampiamente nei recenti convegni e incontri, ai vari livelli.
Bollettino Salesiano. Nella riunione tenuta con gli ispettori
due anni fa a Caracas, don
Ricceri parlò per la prima volta
di una sterzata della Congregazione nell'America Latina.
Che cosa intese dire? E come
si configurò questa sterzata
nelle discussioni di Caracas?
Don Henriquez . Fu nel discorso
introduttivo. Dopo un lungo preambolo sulla «conversione» nella vita
religiosa, don Ricceri aggiunse: «Per
ottenere questa conversione è necessario impugnare il volante e fare
una vera sterzata. Come si dice in
spagnolo ? (Qualcuno suggerì: virale).
Sì, viraje, ma viraje a fondo, un autentico viraje nella nostra azione di
governo. Viraje nella pianificazione;
non più empirismo e improvvisazione, ma lavoro di gruppo. Viraje del
superiore, che finora faceva tutto lui.
Viraje nel nostro apostolato, tanto
nel modo di farlo che nelle sue forme.
Viraje nella formazione dei giovani
e dei confratelli. Viraje nell'organizzazione e anche nell'amministrazione ».
E dopo altre considerazioni del
genere, il Rettor Maggiore indicava
come frutto del viraje « l'offrire alla
Chiesa e all'America Latina non solamente una Congregazione che lavora, ma una Congregazione che
pensa ».
Nelle intenzioni di don Ricceri il
viraje comportava quindi un cambiamento e una conversione a tutti i
livelli dell'azione salesiana nell'America Latina. Nello svolgimento del
convegno vennero fissati alcuni punti
di questa sterzata. Accenno ai principali.
In primo luogo il concetto già
espresso dal Capitolo XIX, che
« preoccupazione centrale della Congregazione non sono le opere ma i
salesiani ». Cioè il primato dell'uomo
sulle istituzioni e sulle strutture. Don
Ricceri non esitò a chiamare « politica del suicidio » il continuare a
gettare nella « hoguera de las obras »,
i o nel braciere delle opere, un personale
non abbastanza preparato o maturo, e
quindi destinato a fallire e a soccombere.
Come conseguenza, l'assemblea degli ispettori convenne nella necessità di costruire delle vere comunità
salesiane, in cui il confratello occupasse il primo posto nelle preoccupazioni, in cui il «senso pastorale»
fosse al di sopra delle altre considerazioni, e il lavoro e la vita di famiglia nascessero veramente, come da
una fonte, dalla realtà operante dell' Eucaristia.
L'assemblea degli ispettori constatò pure che il viraje applicato all'apostolato della Congregazione verso i giovani doveva portare a una
San Antonio de los Altos (Caracas).
I/ Rettor Maggiore
in un momento di sosta nelle
laboriose giornate degli incontri
con gli Ispettori Salesiani
del Venezuela, Messico, Antille,
Centro America, Colombia, Ecuador.
G
maggior pastoralizzazione delle opere
educative. In questo senso si dove-
vano spingere rapidamente i salesiani ad aprirsi nuove prospettive
di lavoro extrascolastico , per arrivare
di più alle grandi masse giovanili
del continente.
Dall'esame dello scottante problema delle classi popolari, della povertà e del sottosviluppo, emersero
nuove linee direttive per dare alla
Congregazione una sterzata anche
in questo campo.
E finalmente si concretò una nuova
metodologia di lavoro nella pastorale delle vocazioni, sia nella scelta
dei candidati alla vita religiosa, che
nella loro formazione.
L'approvazione del Papa alle conclusioni ricavate dal Convegno (e
raccolte in un volumetto di una
trentina di pagine) fu per gli ispettori una garanzia che la strada tracciata era buona, e un motivo in più
per percorrerla.
Bollettino Salesiano. Tornando a riunirsi quest'anno con
il Rettor Maggiore, gli Ispettori dell'America Latina hanno tentato un primo bilancio
sulla sterzata. Quali valutazioni hanno fatto?
Don Henriquez . Devo premettere
che le conclusioni di Caracas non
erano veramente arrivate alla coscienza di tutti i salesiani. A volte è
mancata l'informazione capillare nelle ispettorie o la riflessione in comune sui documenti, a volte riunioni d'altro genere hanno distratto
l'attenzione. Ma i resoconti tracciati
dagli ispettori nell'ultimo incontro
con il Reggor Maggiore sono risultati nel complesso largamente positivi. Nel '68, di fronte all'estensione
dei compiti assegnatici, eravamo presi
quasi da un senso di sgomento.
Ancora l'anno scorso la situazione
sembrava scoraggiante. Quest'anno
invece, alla resa dei conti, si è visto
che molto è stato realizzato.
Un buon viraje lo si è fatto nella
costruzione di vere comunità. Comunità orante , comunità educativa, comunità aperta alla collaborazione
degli allievi, degli insegnanti esterni,
dei genitori: ci sono state relazioni
molto incoraggianti. Ma esistono
ancora case con confratelli oberati
dal lavoro, impossibilitati a fare
comunità. E questo è un pericolo. In
una delle riunioni sono stati letti i
dati che esprimono la crisi della vita
religiosa oggi nella Chiesa: la Congregazione salesiana risultava meno
danneggiata delle altre, e ci parve
di poterne indicare il motivo proprio
nella vita comunitaria vissuta secondo lo spirito di Don Bosco.
Si sono notati molti passi avanti
nell'introdurre un nuovo tipo di
pastorale per promuovere le vocazioni alla vita religiosa. Si è riconosciuto ehe il problema di fondo è
nella pastorale giovanile: educare
veramente i nostri giovani alla fede,
è il modo migliore perché essi possano sentire la chiamata del Signore
e seguirla. Alcune ispettorie un tempo
avevano nelle loro « case per vocazioni » tutti ragazzi raccolti fuori delle
opere salesiane; oggi alcune ispettorie
hanno solo ragazzi provenienti dalle
nostre opere. Indubbiamente la selezione risulta migliore.
L'idea di pastorale giovanile ha
avuto le sue vicende. In un primo
genere, i maestri e professori e le
comunità civili e locali, creando così
un bel centro di irradiazione pastorale. Si sono visti anche i limiti
di altri tipi di lavoro tra i giovani.
E si è arrivati alla conclusione che è
tanto inutile un collegio non pastoralizzato , quanto un oratorio, un
centro giovanile o un pensionato
non pastoralizzati . Che è una questione soprattutto di idee, di uomini,
della loro preparazione. Che in sostanza va rispolverato il vecchio principio di Don Bosco: « Il soprannatu rale sia al centro di tutto ».
tempo, a essere sinceri, non molti
ci credevano. Nel 1968 in America
Latina forse c'erano solo due o tre
ispettorie col delegato per la pastorale
giovanile. Nel '69 era ancora un po '
tutto per aria. In pratica non si
sapeva come e dove preparare i confratelli a questa incombenza, e anche
il Centro Internazionale di Pastorale
Giovanile non aveva ancora una
fisionomia precisa. In sostanza, come
riconoscemmo, si era ancora tutti
«presi dall'immediatismo e da scarsa
visione del futuro». La necessità di
una sterzata in questo campo come in altri - fu ben espressa da
don Ricceri con un aneddoto su
Rockefeller. Al noto magnate nordamericano avevano domandato: « Se
lei perdesse tutte le sue immense
ricchezze, e le rimanessero solo più
diecimila dollari, che cosa farebbe?».
Rispose: « Impiegherei una metà del
mio capitale in una ricerca di mercato
per stabilire come spendere l'altra
metà». La morale della favola per
noi era: è preferibile impiegare le
nostre energie nel preparare dei dirigenti, piuttosto che nell'aprire nuove
opere.
Ora tutte le ispettorie hanno il
loro delegato della pastorale giovanile, molte hanno un centro giovanile
funzionante, le idee cominciano a
circolare e a diventare operanti. I
confratelli vengono sensibilizzati, nuove iniziative vengono introdotte. Ma
siamo tutti convinti che resta ancora
moltissimo da fare.
Bollettino Salesiano. E della
cosiddetta
pastoralizzazione
delle opere salesiane si è parl ato?
Don Henriquez. Sì, e molto. Per
prima cosa si è riconosciuto che si
tratta di una realtà finora poco
vissuta, a livello di Chiesa latinoamericana. In Brasile per esempio la
Chiesa tempo fa aveva il 65% delle
opere educative del paese, in Paraguay il 56%; ma troppe di queste
opere non rispondevano a veri criteri di pastorale.
Nel Capitolo Generale di Roma si
era detto chiaro che le nostre scuole
per giustificarsi dovevano elevare il
livello del sottosviluppo spirituale,
dovevano diventare scuole di avanguardia, dovevano esprimere dei leaders cattolici, religiosamente e socialmente impegnati. Le successive riunioni di ispettori portarono a costatare che in campo salesiano c'era
molto da correggere; era nata una
certa opposizione o sfiducia al collegio e alle opere salesiane. Si era
pensato alla necessità di lasciare le
scuole per aprirsi a nuove presenze
tra i giovani. La riflessione degli ultimi
incontri è servita a mettere meglio a
fuoco il problema. Si è costatato che
nessun'altra opera quanto il collegio
offre la possibilità di raccogliere
tanti giovani,, di convocarli quando è
necessario, di incidere su di loro,
e di esercitare un'azione pastorale
ampia sui genitori, le famiglie in
Si è poi rilevato nelle riunioni
con il Rettor Maggiore, che anche
nel settore del sottosviluppo e della
testimonianza di povertà religiosa si è
lavorato praticamente in tutte le
ispettorie . La riflessione sul problema del sottosviluppo in America
Latina creò o rinnovò in tutti una
decisa volontà di lavorare con tutta
l'anima in questo senso. I salesiani
sanno che seguendo Don Bosco, la
loro strada non è tanto quella della
«denuncia profetica* delle ingiustizie; i salesiani non rimangono
indifferenti di fronte alle ingiustizie
dell'America Latina; ma preferiscono
agire nel senso del servizio ai poveri,
ai più poveri; buttarsi al lavoro per i
giovani operai, piantare un oratorio
nel cuore di una « barriada ». Oggi
più che mai il loro carisma di servizio
alle classi popolari è apparso come
una realtà intramontabile.
Un lavoro appassionante e doveroso, questo della sterzata. Del resto
voluto anche da Don Bosco. Una
sera del 1875 Don Bosco parlava con
don Barberis e lo chiamava scherzando « il bastone della mia vecchiaia ».
- Se posso esserle utile in qualcosa - rispondeva don Barberis lo farò ben volentieri.
- Voi completerete l'opera che
io incomincio - continuò Don Bosco.
Si era a un anno appena dall'approvazione della Congregazione. - Io
faccio l'abbozzo, e voi metterete i
colori.
- Purché non finiamo per sciupare ciò che Don Bosco sta facendo!
- riprese don Barberis . E Don Bosco con vivacità:
- Oh, no ! Guarda. Io ora sto
facendo la brutta copia della Congregazione, e lascio a quelli che verranno dopo di me il compito di metterla in bella copia.
Questo è il punto, e lo scopo delle
nostre riunioni: vedere come mettere
in bella copia l'immagine della Congregazione in America Latina, in
quest'ora che volge il suo sguardo
verso il « duemila ».
• 11
i primi missionari in partenza per l'America consegnando il libretto delle Regole della Società
Salesiana, Don Bosco disse: « Ecco Don Bosco che
viene con voi! ». Allora la lentezza e la difficoltà dei
viaggi non permettevano a Don Bosco quello che oggi
può fare il suo Successore. In America non c'era ancora nessuna Opera salesiana da visitare; oggi una fitta
rete di opere si stende su tutta l'America Latina.
A
Scopo principale di questo nuovo viaggio del Rettor
Maggiore era quello di convocare tutti gli Ispettori
dell'America Latina in tre grandi centri, per studiare
i problemi dell'ora presente in quelle Nazioni. Di
queste riunioni abbiamo parlato nelle pagine precedenti.
Qui vogliamo seguire con rapide note le peregrinazioni
di don Ricceri soprattutto attraverso l'immenso Brasile.
Partì da Torino il 25 maggio, il mattino dopo
la festa in onore di Maria Ausiliatrice. Una breve
tappa a Londra per compiacere i Salesiani e le Figlie
di Maria Ausiliatrice inglesi, che non avevano ancora
avuto la gioia di accogliere il Rettor Maggiore nella
loro terra. Il 26 riprende il volo per il Venezuela.
Sbarca all'aeroporto di Caracas e vi trova numerosis simi confratelli e suore che gli dànno il benvenuto in
terra americana.
I primi tre giorni don Ricceri li consacra ai sacerdoti
convenuti da tutte le repubbliche dell'America Latina per compiere il loro secondo noviziato, o meglio
il « Curso salesiano de actualización ». Di questo primo
esperimento diremo in un prossimo numero.
Nel pomeriggio del 30 maggio il Rettor Maggiore
si porta a Los Teques per un incontro familiare
con circa Zoo confratelli dell'Ispettoria Venezuelana,
convenuti dalle varie case della Repubblica. A Los
Teques i salesiani hanno tre grandi complessi: il « Liceo San José » con 70o alunni, il « Colegio San Domingo
Savio » con oltre soo allievi di scuola media e ginnasio,
e l' Aspirantato « Santa Maria » con i5o aspiranti.
Lo stesso giorno, nello Studentato filosofico di San
Antonio de los Altos (Caracas), ha inizio la prima delle
tre riunioni di ispettori, vicari e delegati ispettoriali .
Provengono dal Messico, Antille, Centro America,
Colombia, Ecuador. Giornate intense di studio; si
protraggono fino al 3 giugno.
Il 4 giugno il Rettor Maggiore raggiunge Brasilia,
la nuova capitale dove, il 3o aprile del 196o - 77 0
anniversario della visione di Don Bosco sull'Opera
salesiana nell'America Latina - il presidente Juscelino Kubitschek aveva inaugurato il « Colegio Dom Bosco », presente il quinto Successore del Santo, don Renato Ziggiotti . Qui ha luogo l'incontro degli Ispettori
delle sei Ispettorie salesiane del Brasile.
« L'America Latina scotta, non è vero? ».
Ecco l'interrogativo che tutti ci si pone. Ma andrebbe
completato con un'altra domanda: è il fuoco di un incendio rovinoso e devastatore, oppure il fuoco che
rende il metallo malleabile e docile nel crogiuolo delle
grandi avventure umane ? Don Ricceri è di quest'ul12 timo parere. Il Brasile è una specie di altoforno dove
L'arrivo del Rettor Maggiore
all'aeroporto di Caracas
(Venezuela)
26 maggio 1970
Il
RETIOR
MAGGIORE
NELL'AMERICA
LATINA
« Programma e finalità del viaggio
- ha detto don Ricceri alla partenza sono: trovarci insieme con i fratelli
di un altro continente, guardarci in faccia,
parlare, dialogare, programmare.
Gli scritti hanno certamente un grande valore,
ma l'incontro personale è tutt'altra cosa».
si sono amalgamate tutte le razze umane. Un popolo
intelligente, coraggioso, che ha il senso dell'ospitalità,
della convivencia (una delle parole-chiave che si sentono pronunziare laggiù: l'arte di vivere insieme). Il
paese è immenso e splendido: detiene le più grandi
possibilità dell'America Latina: il massimo di terre
arabili, di ricchezze minerarie, di risorse umane.
Terminate le riunioni a Brasilia, don Ricceri vola
a Manaus , nell'Amazzonia. Il caldo soffocante (la temperatura oscilla tra i 3o e i 36 gradi) dà modo di sperimentare la vita sacrificata dei confratelli dell'Ispettoria .
In una intensa giornata di lavoro e di incontri il Rettor
Maggiore può far sentire la sua parola distintamente
ai salesiani e alle Figlie di Maria Ausiliatrice, convenuti
da tutte le case dell'Amazzonia .
A sera, quando le ombre hanno già avvolto uomini e cose, il Rettor Maggiore pensa ai figli lontani
che non può visitare, ai missionari dislocati nella sconfinata foresta amazzonica, tra gli Indi delle prelature di
Humaità , Porto Velho e Rio Negro, e lancia via radio
un paterno messaggio di saluto, di compiacimento, di
ammirazione e di incoraggiamento a proseguire nel loro
arduo lavoro di evangelizzazione. A tutti augura l'assistenza materna di Maria Ausiliatrice, della quale imparte loro la benedizione.
Altre giornate piene attendono il Rettor Maggiore
ad Asunción nel Paraguay, dove si svolge il terzo incontro
di Ispettori per le cinque Ispettorie dell'Argentina e
per quelle del Cile, Paraguay, Uruguay, Perù e Bolivia.
Qui il clima, anche se invernale, è dolce come quello
della primavera italiana.
Nella casa ispettoriale , sede delle riunioni, funziona
un attrezzato « Centro Don Bosco Film », che fa sentire
la presenza della Chiesa nel campo cinematografico,
per opporsi alla propaganda materialistica e sessuale,
con una selezione di pellicole dirette a dare al pubblico paraguayano cultura e divertimento informati
a spirito cristiano.
Nella sola capitale Asunción , sono circa venti i centri
che settimanalmente si servono di materiale filmico
del «Don Bosco Film », e altri venticinque nella repubblica. Nella -quaresima si proiettano una quarantina
di ' pellicole sulla tematica umano-religiosa; e nella
Settimana santa la TV presenta pellicole del «Don
Bosco Film».
13
Brasilia. I/ " Colegio Dom Bosco" dove hanno avuto luogo le
riunioni degli Ispettori del Brasile, presiedute dalRettor Maggiore.
Asunción (Paraguay). Il Rettor Maggiore accolto a festa dai
Salesiani e dalle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Asunci6n. Omaggio delle Cooperatiici del Paraguay al Successore di Don Bosco.
Tra una seduta e l'altra degli Ispettori, il. Rettor
Maggiore visita gli aspiranti, i novizi e gli studenti di
filosofia delle due case di Ypacaraj . Prima di lasciare
Asunción , ha la gioia di rivolgere la sua parola a un
bel gruppo di salesiani dell'Ispettoria , venuti dalle
case vicine e lontane, e anche alle Figlie di Maria Ausiliatrice. Visita pure il Nunzio Apostolico che aveva
già partecipato a un'agape con tutti gli Ispettori. Una
delle serate di Asunción era stata dedicata a un cordiale
i ncontro con i Cooperatori e gli Exallievi .
La serie delle tre riunioni ispettoriali era terminata,
ma don Ricceri volle utilizzare il suo viaggio per altri
i ncontri con il maggior numero possibile di confratelli
dell'immenso Brasile. Ed eccolo, il iq giugno, a San
Paolo. Su 248 salesiani che conta l'Ispettoria, ne trovò
230 presenti alla sua conferenza. C'erano pure tutti i
chierici teologi delle altre Ispettorie del Brasile, ai quali
il Rettor Maggiore volle parlare a parte sui problemi
che più li riguardano.
Il z I giugno, suo giorno onomastico, lo trascorse
nella sede ispettoriale di Porto Alegre , circondato dall'affetto di quei confratelli, ai quali non parve vero di
avere con sé il Rettor Maggiore nella loro intima cerchia
di vita.
In tutti i centri ispettoriali del Brasile trovò numerosi
i confratelli accorsi per incontrarsi col Padre. Alcuni di
essi avevano dovuto affrontare fino a 30-35 ore di viaggi lunghi e faticosi in treno, in autobus, in camionette,
per strade impervie e battute dalle piogge torrenziali
dell'inverno brasiliano.
Il viaggio del Rettor Maggiore era strettamente privato; non di rado però si mossero le autorità per riceverlo e ossequiarlo negli aeroporti o in casa salesiana,
come a Recife , dove il Governatore dello Stato di
Pernambuco volle accompagnarlo con la sua macchina
dall'aeroporto a Recife e il giorno dopo offrirgli nella sua
residenza un ricevimento d'onore.
Viaggio lungo e faticoso. Ma i confratelli che vivono
tanto lontani dal centro hanno potuto vedere, ascoltare il
Rettor Maggiore, intrattenersi con lui. Don Ricceri
si prestava per tutti: salesiani, exallievi , cooperatori.
Presiedette concelebrazioni , portò la sua parola illuminatrice a riunioni di Consigli e di Capitoli ispettoriali .
Familiarizzò con aspiranti alla vita salesiana, con novizi, con studenti di filosofia e di teologia. S'incontrò
con tante Figlie di Maria Ausiliatrice, a cui tenne conferenze e portò la benedizione della Madonna.
Le concelebrazioni di Manaus , Brasilia, San Paolo,
Porto Alegre, Campo Grande, Recife e Belo Horisonte
raccolsero attorno al Padre ai piedi dell'altare i cuori e
le volontà di centinaia di confratelli, felici di ritrovarsi
una volta tanto riuniti ad attingere alla sorgente dell'Eucaristia coraggio e forza per il loro apostolato.
In tutti i campi l'America Latina afferma ogni giorno
di più la sua ricca e complessa personalità. Su tutti
i piani essa vuol prendere nelle proprie mani il suo
destino. E fa sentire la sua voce: originale e spesso
sorprendente. È impossibile, impensabile non ascoltarla. ∎
CONGRESSO MONDIALE
EXALLIEVI DON BOSCO
Ricorre quest'anno il Centenario della organizzazione degli
Exallievi di Don Bosco e il Cinquantenario del
Monumento di Don Bosco eretto dagli Exallievi sulla
Piazza della Basilica di Maria Ausiliatrice. La data
centenaria sarà celebrata dalla Confederazione Mondiale
Exallievi Don Bosco con un Congresso Mondiale
che si terrà a Torino dal 17 al 20 settembre e a Roma
dal 21 al 23 settembre. Saranno presenti le
delegazioni di 70 l spettorie salesiane, rappresentanti
60 nazioni. Numerosissimi Exallievi affluiranno
da tutte le Unioni d'Italia.
i
Coi cuore stesso di Don Bosco la
Famiglia Salesiana attende l'incontro degli
Exallievi di tutto il mondo.
« Eravate un piccolo gregge:
questo è cresciuto, cresciuto molto,
ma si moltiplicherà ancora.
Voi sarete luce che risplende
in mezzo al mondo»
(Don Bosco agli Exallievi
il 13 luglio 1884).
15
Perché _noli do s<
diMikawashirr:
c'è al mondo una città vasta, aggrovigliata, caotiN onca come
Tokyo, e neppure una città che cambi continuamente
fisionomia come questa metropoli del Sol Levante. L'esplosione demografica è forte come l'esplosione dell'edilizia. Tokyo
si sta trasformando con ritmo così intenso che le sue caratteristiche
orientali vanno scomparendo rapidamente per lasciare il posto
a una immensa e disordinata metropoli occidentale. Alcuni
quartieri però mantengono ancora la loro vecchia fisionomia,
anche se in mezzo al gregge compatto delle casette di legno,
sorgono come giganti moderni edifici in cemento armato. Sono
i quartieri della città bassa, operai e perciò poveri, quartieri
in cui fiorisce l'artigianato e la piccola industria. Qui la vita
si svolge come prima della guerra, anche se sono aumentate le
case di divertimento, e le vie principali si sono allargate per
dare spazio all'ininterrotto rosario di automezzi, responsabili
dell'inquinamento dell'aria.
Mikawashima o « Isola dei tre fiumi » è uno di questi quartieri poveri. Qui è sorta la prima opera salesiana della capitale,
in terreno adatto per attecchire e svilupparsi. I primi salesiani
vi giunsero trentasette anni fa e vi trovarono povertà e squallore.
Così poterono aiutare e consolare tante famiglie e attirarsi la
benevolenza di tutto ' il quartiere. Erano famosi i bazar che si
tenevano periodicamente. Con pochi soldi la gente poteva acquistare
molte cose di prima necessità, perciò il giorno del bazar era come
la sagra del quartiere e la parrocchia veniva conosciuta e amata,
tanto che i salesiani che vi lavoravano erano chiamati indistintamente col nome di « Don Bosco ».
Tempi evangelici, tempi felici quelli. L'oratorio festivo era
frequentatissimo e nelle feste oltre un migliaio di ragazzi invadeva letteralmente la Missione. In questo modo funzionò
per parecchio tempo la parrocchia di Mikawashima .
Oggi molte cose sono cambiate; la povertà c'è ancora, ha
assunto un altro volto, ma è sempre « sorella povertà ». Avere un televisore, possedere gli elettrodomestici non vuol dire
essere ricchi o benestanti; è solo un benessere apparente, frutto
dei tempi nuovi e delle nuove esigenze. La povertà resta, anche
se vestita di moderno progresso.
L'opera salesiana di Mikawashima ha cambiato volto an16 ch'essa; le vecchie baracche in legno sono scomparse per dar
irta Ja chiesa
a a Tokyo
luogo a un grande fabbricato di quattro piani con un complessivo
di 1285 metri quadrati. Anche qui si può pensare alla ricchezza,
mentre è solo un segno dei tempi. Il terreno fabbricabile in Tokyo
costa delle cifre astronomiche, perciò non c'è altra alternativa
che andare verso l'alto se si vogliono raggiungere con minor spesa
gli obiettivi necessari alle esigenze dell'opera. In questo fabbricato ci sono gli uffici parrocchiali, le abitazioni dei salesiani e
una fiorente scuola materna con trecento piccoli allievi.
Solo la chiesa è rimasta la capanna di Betlemme , ma penso che il Signore non se l'abbia a male per questo. I lettori del
Bollettino Salesiano conoscono lo zelo di don Liviabella e il
suo grande lavoro per arrivare a costruire una chiesa più ampia
e funzionale; ma dovette rimandare la realizzazione del progetto
per due ragioni che i lettori troveranno certamente valide. Anche
a me don Liviabella ha spiegato le cause del ritardo e devo dire
che mi ha convinto.
Molti anni fa un signore pagano aveva regalato alla parrocchia
di lIIikawashima un terreno da adibirsi per un'opera sociale,
ma per mancanza di mezzi e di persone non si era potuto fare
nulla. Nel frattempo la località dove era posto il terreno si andò
sviluppando così intensamente che si rese necessaria la costruzione
di un nido d'infanzia. Si pensò alla sua realizzazione, ma il
terreno era piccolo per la necessità della nuova opera, tanto più
che si voleva costruire anche una piccola chiesa, essendone la
regione completamente priva. Don Liviabella , pensando alla
bontà dell'opera, non esitò a evolvere una grossa somma per
l'acquisto di un terreno adiacente. Così sorse la nuova opera
di Tokyo - Kaminumata , accolta con gratitudine dalla popolazione
• con gioia dall'Arcivescovo di Tokyo, perché un nuovo faro
di luce cristiana si era acceso dove Cristo non era per nulla
conosciuto.
La seconda ragione che fece ritardare la costruzione della
chiesa parrocchiale fu la seguente. Il rinnovamento dell'opera
di Mikawashima doveva iniziarsi con la costruzione della chiesa
• dei locali necessari alla parrocchia; in un secondo tempo, con
la costruzione della scuola materna. Quando però il municipio
del distretto di Arakawa da cui dipende Mikawashima seppe dei
progetti, pregò i salesiani a voler invertire l'ordine delle costruzioni dando la precedenza alla scuola materna per aiutare tante
famiglie che altrimenti si sarebbero trovate in serie difficoltà
finanziarie, non potendo le mamme recarsi al lavoro per accudire
ai loro figlioletti. Per questo il municipio non si limitò a parole,
ma volle concorrere con una somma abbastanza rilevante alla
costruzione della scuola materna. Vinse la -carità per i poveri
• la parrocchia salesiana acquistò molto prestigio e benevolenza
presso le autorità come presso le famiglie.
Ora finalmente è venuta anche l'ora della chiesa. I progetti sono pronti. Sorgerà non solo la chiesa, ma anche un ampio
salone e gli uffici parrocchiali. Il fabbricato centrale potrà così
essere usufruito tutto per la scuola materna, e la vita parrocchiale potrà svolgersi in un ambiente più adatto e indipendente.
Tutta la costruzione sarà di 913 metri quadrati; la spesa ammonterà a parecchi milioni, ma don Liviabella ha la Provvidenza
dalla sua parte e non dubita che Dio manderà tutto il necessario
per questa opera che, sorta in un ambiente ideale per il lavoro
salesiano e cattolico, continuerà a essere un faro di luce per tante
anime che cercano con cuore semplice Dio.
DON GIOVANNI MANTEGAZZA
Parroco salesiano a Tokyo
17
INVECE DELLA
FIESTA»
UNA SCUOLA
PER I POVERI
I ragazzi di un Liceo salesiano in Venezuela
hanno rinunciato alla loro «festa della promozione»
e deciso di costruire col denaro risparmiato una
scuola per i bambini poveri della periferia.
L'iniziativa - che sarà continuata negli anni
a venire dai loro compagni più giovani e
sostenuta dalle nuove leve di exallievi del
Liceo - è segno di una maturazione sociale
schiettamente cristiana.
le altre lettere quel mattino il
Tzuelarasuperiore
dei salesiani del Venene trovò una proveniente dal
suo Liceo di Los Teques (Caracas).
Strano, a scrivergli non erano i suoi
salesiani ma i loro ragazzi, quelli dell'ultimo anno, prossimi all'esame di
maturità. Era una lunga lettera, zeppa
dei paroloni che piacciono ai ragazzi
d'oggi, come «alla luce delle conclusioni del Vaticano Il», e «coscienti
dei problemi dell'America Latina», e
ancora « disoccupazione, fame materiale e spirituale, sottosviluppo culturale ed economico», eccetera. A un
certo punto arrivavano al dunque:
« Guardando al panorama di miseria
che circonda il nostro Liceo, abbiamo
deciso che alla fine dell'anno scolastico non faremo la Festa della Promozione ».
Una festa di solito opulenta - ricordava il superiore dei salesiani
don José Henriquez -, che ogni
anno tra premi, banchetti, musica,
divertimenti e fronzoli si mangiava
tutti i risparmi pazientemente rastrellati durante l'anno, cioè la cifra iperbolica di 50-60.000 bolívares . Qualcosa, in lirette , come sette o otto milioni. I ragazzi nella lettera dicevano
che si sentivano « fermamente convinti che non si giustifica, né come
1 8 cristiano, né come latino-americano,
né come venezuelano, che un gruppo
di giovani spendano in sei brevi ore,
e per una feesta , quella smisurata
quantità di denaro ». Il superiore era
perfettamente d'accordo. E si chiedeva cos'avessero ancora in mente.
Detto che il loro corso si era
sempre «distinto nell'aprire nuove
vie al Liceo », e che si erano proposti
di « rivoluzionare l'ambiente e creare
una coscienza umana nazionale »,
esprimevano finalmente la loro idea
« centrale »: essi avrebbero « costruito
una scuola per i bambini poveri », in
un sobborgo poverissimo chiamato
La Macarena. Questa sì, si disse il,
superiore, è un'idea buona.
L'edificio sgangherato
e inabitabile
L'idea era nata durante un ritiro
spirituale. I ragazzi quel pomeriggio
facevano i soliti due passi per prendere una boccata d'aria, e lì alla
Macarena osservarono con occhio
nuovo l'edificio sgangherato e inammissibile che usurpava il titolo di
scuola elementare. Si chiesero come
fosse possibile educarci dentro dei
bambini, e conclusero che bisognava
fare qualcosa.
Il sobborgo La Macarena non era
affatto sconosciuto a questi ragazziche da tempo se ne occupavano. Di,
versi gruppi, sensibili ai problemi sociali, nei pomeriggi liberi vi si recavano a visitare le baracche più
povere, si rimboccavano le maniche
per aggiustare tetti e' pareti, pagavano
di tasca propria quando bisognava far
saltare fuori l'indispensabile. Ora ecco
l'idea della scuola.
Non che fin dall'inizio l'accettassero tutti; al contrario, i quattro o
cinque promotori dell'iniziativa incontrarono non poche resistenze.
« C'è un certo spirito borghese in
mezzo a noi», dicono, e ammettono
che per tanti era uno schianto rinunciare alla fantastiga festa di fine
d'anno scolastico. I pochi promotori,
ragazzi in gamba, si misero in testa
di sensibilizzare ai problemi sociali
tutti i loro compagni di corso. Tennero riunioni e discussioni, costituirono comitati e assemblee, e quando
l'ambiente fu preparato, invitarono
tutti a votare il progetto. E tutti dissero "no" alla festa e "sì" alla scuola
per i bambini poveri.
Il denaro occorrente per la scuola
è molto, e i ragazzi pensano a racimolarlo anche attraverso le solite
svariate attività: lotterie, spettacoli,
feste a pagamento. E poi le rinunce
personali.
UNA RISPOSTA
CHE VALE
Recentemente il Ministro della Pubblica Istruzione, accogliendo le istanze di alcuni Provveditori agli studi,
ha diramato una circolare contro la
diffusione di materiale pornografico
nelle scuole. Vi si legge tra l'altro:
« La stampa più accreditata del Paese
ha denunciato, con frequenza sempre maggiore, episodi che non possono non allarmare gli educatori.
Si tratta di difendere i valori culturali genuini del Paese e di preservare
i giovani da una offensiva alla quale
essi non hanno ancora maturati i
mezzi propri di difesa.
Richiamo, pertanto, l'attenzione sul
penoso fenomeno, e prego di studiare e realizzare ogni opportuno
sistema per scoraggiare iniziative del
genere, non limitandosi a una pura
opera repressiva, ma soprattutto svolgendo ogni opera perché si ponga
un autentico freno al dilagare del
fenomeno.
La realizzazione del progetto è già cominciata. Si è
comperato il terreno, i piani della costruzione sono
pronti e approvati, il materiale viene a poco a poco
accumulato. Il padre di un alunno, ingegnere, seguirà
i lavori.
Ma tirar su dei muri non basta, questi ragazzi
pensano che dopo la scuola dovranno costruire un
dispensario, un centro psicotecnico e le altre opere
sociali. Per questo hanno associato alla loro impresa
anche i compagni più giovani del quarto e terzo
corso, che continueranno. Quelli del terzo hanno
addirittura fondato un'organizzazione che - curioso
segno dei tempi - si chiama °"Movimiento Social Revolucionario".
Intanto le generazioni uscite dal collegio potranno
continuare ad aiutare, con l'insegnamento, con prestazioni professionali, con l'aiuto finanziario. Così gli allievi
ed exallievi del Liceo si salderanno insieme verificando
il loro cristianesimo operante in quest'opera generosa e
necessaria.
Il Liceo salesiano di Los Teques ha tante benemerenze. Non pochi in giro lo considerano il miglior
collegio del Venezuela. Ha dato al paese, in 35 anni di
esistenza, molti uomini che si distinguono per la fede
che portano nella prpfessione e nella vita. Non ultimo
il presidente del senato, José Antonio Pérez Díaz , che
recentemente - dopo che erano trascorsi tanti anni
da perderne la memoria - ha osato di nuovo pronunciare in parlamento il nome di Dio.
Questi ragazzi hanno già sostenuto i loro esami e
forse non tutti sono stati ritenuti maturi sotto il punto
di vista scolastico: certo - pensano i loro superiori sono maturi sotto il punto di vista sociale e cri stiano.
a
Le riviste DIMENSIONI OGGI,
PRIMAVERA, RAGAZZI DUEMILA svolgono questa azione positiva
nel campo dei giovani, delle adolescenti e dei ragazzi.
Il pubblico di DIMENSIONI OGGI
sono i giovani più pensosi, che « si
i nterrogano», che si chiedono cosa
sia questa società in cui devono vivere, che cercano una chiave per
decifrarla cristianamente.
PRIMAVERA è l'unica rivista giovanile per un pubblico femminile di
adolescenti. Quelle attualmente esistenti in Italia sono a carattere prettamente maschile. Può quindi offrire
ai genitori e agli insegnanti la risposta valida e concreta alle esigenze
educative di oggi e una interessante
l ettura alle giovanissime.
RAGAZZI DUEMILA si rivolge al
ragazzo d'oggi e lo informa sul mondo degli adulti e dei ragazzi perché
sappia vederlo bene, con gli occhi
non di un consumatore ma di un
figlio di Dio.
Per informazioni e richiesta di omaggi:
Per Dimensioni Oggi e Ragazzi Duemila
rivolgersi a: Periodici SEI - Piazza Maria
Ausiliatrice 9 - 10100 TORINO
Per Primavera scrivere a: Direzione Primavera
- Via Laura Vicufia, 1 - CINISELLO BALSAMO
( Milano)
19
142 TOPOLINI All'ISOLA
I n un'isola sull'Orinoco , nel Venezuela, a pochi gradi
dall'equatore ho incontrato tre salesiani olandesi che
hanno aperto un internato per i ragazzi indi. I missionari non vogliono sottrarre questi indi alle loro tribù
perché vadano a vivere tra i bianchi, li preparano
i nvece perché tornino poi alla loro gente, per aiutarla a sollevarsi dalla miseria e a incontrare Cristo.
V
aleva la pena tentare l'avventura sui piccoli aerei
della linea interna venezuelana, che se ne impipano
degli orari come le antiche diligenze del Far West; e
affidarsi al leggero guscio di alluminio del bongo per
qualche ora di navigazione sull'Orinoco gonfio di
pioggia; e sottoporsi alla fame impietosa di mosquitos,
zancudos , garrapatas , jejenes e altri i nsetti forestali:
valeva la pena, per arrivare fino all'isola del Ratón ,
a pochi gradi dall'equatore, e imbattersi in un'idea.
Un'idea incarnata, si capisce, e non evanescente fra
le nuvole. Incarnata appunto nei 142 topolini dell'isola del Ratón . Hanno la pelle scura e gli occhi a
mandorla come i cinesi, sgattaiolano da tutte le parti,
si sorridono come fratellini, si parlano le loro lingue
misteriose, e giocano alle birille colorate (un cerchio
disegnato sul terreno e tante birille di vetro dentro,
da colpire tirando con l'unghia del pollice).
Monsignor Secondo García , il Vicario apostolico di
Puerto Ayacucho che ha voluto accompagnarci, sceso
dal bongo , corre verso un uomo aitante sulla quarantina,
biondo nordico, e me lo presenta:
« Don Ermanno Féddema: olandese, ma cattolico»:
La battuta è trasparente: ridono anche i due nuovi
sopravvenuti, anch'essi biondi nordici, anch'essi olandesi ma cattolici, i due coadiutori salesiani che lavorano con don Feddema . Inoltre ci sono tre suore; Figlie
di Maria Ausiliatrice, che si interessano delle " topoline".
E poi cinque o sei maestri indigeni poco più alti e poco
più anziani dei ragazzi. Lì vicino, a ridosso della missione, vedo un villaggio di indi guahibo , in tutto sull'isola saranno 250 indi più o meno civilizzati, non
pochi venuti per stare ,vicino ai loro figli che frequentano
il collegio della missione (tanto, per loro, sovrani della
foresta, vivere da una parte o dall'altra fa proprio lo
stesso). E ci saranno ancora 250 creoli neppur essi
troppo civilizzati, su quest'isola tutta verde che l' Orinoco aggredisce da ogni parte, lunga venti chilometri
e larga sei, a forma di grosso topo senza coda. L'influsso
della missione s'irradia molto più lontano, fino a cento
o duecento chilometri, fino a raggiungere l'intera popolazione della zona, cioè due o tremila persone in tutto,
metà creoli e metà i ndios , a volte appena sfiorati dalla
civiltà.
Quanto a cifre questo è tutto. Ci sediamo a parlare
perché rimane da svelare il segreto di questa missione
20 di cui il Vicario apostolico è tanto fiero.
Dal nostro inviato DON ENZO BIANCO
Il visetto all'acqua e sapone
# Da nove anni - comincia don Feddema - sono
qui missionario nell'isola del Ratón . Ho sostituito
don Luigi Algeri, un missionario italiano ormai anziano,
consumato dalle fatiche, un martire del lavoro. Un
uomo che aveva portato tutto il peso della vita missionaria come la si conduceva fino a una decina di anni
fa. Il missionario era quasi tagliato fuori dal mondo
civile, doveva dedicare il più del suo tempo ai lavori
materiali del costruire la missione, del disboscare per
inventare i campi, del coltivarli per strappare alla terra
di che nutrire se stesso e gli indi. Quanto agli indi,
vivevano ancora in condizioni deplorevoli, nella sporcizia, attaccati dalle malattie, setacciati dalle epidemie».
E vero che le cose ora sono diverse: lo si vede. Molte
missioni hanno il campo d'atterraggio, sono raggiunte
per fiume da imbarcazioni veloci, hanno perfino il
piccolo frigorifero per quando la colonna di mercurio
dà la scalata ai 40° all'ombra e l'acqua fresca è una
medicina. Ogni mattina alle sette i missionari si collegano per radio con il centro del Vicariato e parlano
tra loro informando, domandando e scambiando battute. Quanto ai loro indi, molti hanno la casetta in
muratura, fatta con i mattoni che il missionario ha
insegnato a fabbricare, anche se poi non sanno bene
come usarla e hanno da metterci dentro solo il mobilio
forestale. Nel collegio missionario del Ratón vedo gli
indietti con il loro vestito anche se non tanto pulito
perché gli piace troppo rotolarsi per terra; ma le bambine vestono con proprietà e hanno il visetto all'acqua
e sapone.
Si ha netta l'impressione che la società dei bianchi
urge da vicino ai bordi della foresta e già vi lascia filtrare qualche spiraglio di comfort. E il missionario ne
trae tutti i vantaggi perché, libero dalle schiaccianti
preoccupazioni materiali, può dedicarsi di più a risolvere i veri problemi della pastorale.
Maestri dei loro genitori
« Come mi resi conto della situazione - continua
don Feddema - mi domandai: che cosa posso fare
per questi indi ? Certo non potevo andare da loro.
Erano una sessantina di gruppi sparpagliati, molto lontani da me e tra di loro; al massimo avrei potuto, gi -
DEL RATO
della sua origine, voleva vivere da bianco. Noi decidemmo di agire in modo semplicemente opposto. Cioè,
avremmo preparato gli indietti a tornare in mezzo alle
loro tribù, per aiutare i loro fratelli a evolversi a tutti
i livelli. Sarebbero stati, per genitori, nonni, fratelli,
zii, cugini, come maestri: nell'agricoltura, nella costruzione delle case, nella caccia e pesca con strumenti
più efficaci, nell'imparare la lingua dei bianchi. E inoltre
sarebbero stati infermieri e medici. E soprattutto, catechisti. In questo modo avrebbero preparato la loro
razza all'incontro ormai inevitabile e prossimo con i
bianchi.
« Questa la nostra idea. La stiamo realizzando a poco
a poco. Abbiamo nell'internato iio maschietti, i più
grandicelli stanno per terminare il corso elementare.
Abbiamo poi 32 bambine, sono al loro primo anno.
Col prossimo settembre saliranno anch'esse a un centinaio ».
Gli exallievi della foresta
't
Isola del Ratón (Venezuela). P. Ermanno Féddema e i
suoi calciatori.
rando tutto il tempo, visitarli una volta all'anno. Non
sarebbe servito a nulla. Oppure avrei potuto starmene
qui ad aspettare che venissero da me, per dare loro
una medicina, un paio di pantaloni vecchi, un buon
consiglio e un pensiero cristiano. Quanto alla loro vera
evangelizzazione, avrei dovuto affidarla agli angeli perché
a me sarebbe risultata impossibile. E i bambini, quelli
da cui Don Bosco dice di cominciare, che sono i soli
veramente ricettivi, essi avrebbero continuato a vegetare nella selva, spesso sottoalimentati, senza imparare
nulla. Decidemmo di aprire un collegio per questi
bambini indi.
« Non doveva essere un collegio qualunque, ma con
finalità particolari. Don Bosco diceva che conquistati i
ragazzi, sarebbero stati essi a portare ai salesiani i genitori.
Così noi attraverso gli indietti avremmo raggiunto gli
adulti delle tribù. Il nostro non era il primo internato
per bambini indi, ma avrebbe avuto qualcosa di radicalmente di'rso dagli altri. Negli altri, ottenuto dai
genitori un bambino indio, di solito lo si educava perché
vivesse lontano dalla sua tribù, nella missione, tra i
bianchi. Non lo si lasciava più tornare a casa dai suoi,
per anni, neppure durante le vacanze scolastiche, al
punto che il ragazzo finiva per non riconoscere più i
genitori, e viceversa. Non era più capace di vivere
presso la sua tribù, la ripudiava, provava vergogna
« Non è stato facile --- riprende il missionario - convincere i genitori indi a affidarci i loro figli. Gli indi
amano i figli forse più di qualsiasi altro genitore al
mondo. Formano famiglie sane, legate da un affetto
profondo, che coinvolge anche i parenti più lontani.
Ma erano rimasti scottati dalle esperienze precedenti:
quei loro figli inviati alle missioni erano diventati degli
estranei, erano andati perduti per la loro gente. Ora
io mi presentavo di nuovo a chiedergli i figli. Era come
perderli, proprio non si sentivano di darmeli. Preferivano tenerli con sé, anche sporchi, ignoranti, affamati,
denutriti, ma loro.
« Promisi che glieli avrei restituiti durante le vacanze,
che essi avrebbero potuto venirli a trovare in qualsiasi
momento, che li avrei educati nell'amore ai genitori.
Stentavano a credermi. Giunsi a regalare a un capo
tribù una casetta in mattoni, a regalare un motore per
la barca, dei machete. A tutte queste condizioni, riuscii
infine a portare sull'isola del Ratón sette indietti .
«Era settembre, a dicembre li riaccompagnai a casa
per le vacanze di Natale. Dicevo ai loro genitori: "Vedete che mantengo la parola, che i vostri figli non sono
schiavi nella missione ma sono liberi". Mi credettero,
e alla fine delle vacanze me ne consegnarono quattordici. Ora sono 142. Presto arriveremo a duecento.
« A volte i ragazzi, arrivate le vacanze, non vogliono
partire. "Padre, non voglio tornare a casa, voglio restare con te". "Tu devi andare -- gli rispondo perché i tuoi genitori ti vogliono bene, e tu devi voler
bene a loro". Vanno, si abituano a vivere nei due ambienti, a passare dall'uno all'altro. Già 24o di essi, dopo
anni di internato sono ritornati alla tribù, e ci sono rimasti. Con enorme vantaggio della loro gente. Il loro
ambiente naturale migliora sotto tutti gli aspetti. Conducono una vita sana, alcuni sono sposati, con figli,
vengono continuamente alla missione, insegnano agli
altri lo spagnolo che sta diventando il loro esperanto.
« Durante le vacanze estive io salto sul bongo e vado
a trovare tutti quelli che posso. Sento di aver guadagnato definitivamente la loro fiducia, che grandi e piccoli sono con me ».
Don Feddema non riesce a nasconderlo: è fiero dei
suoi exallievi della foresta.
Vita da i ndietto
La vita da i ndietto nell'internato del Ratón è semplice e piena di meraviglie. Ci sono tanti oggetti miste- 21
riosi di cui scoprire il funzionamento, come le sedie,
i cucchiai, il sapone.
I nuovi, come arrivano, sono taciturni e chiusi in
se stessi. Parlano solo con quelli della loro tribù, si
sentono in lotta con gli altri come i loro padri, ignorano
le lingue altrui, non conoscono ancora lo spagnolo.
Dopo tre mesi le barriere sono cadute, l'amicizia è fatta,
sono tutti fratelli, si scambiano le birille .
Cominciano la giornata alle 6,30, vanno in cappella
per una preghiera e un pensiero sul Vangelo. Poi studiano o lavorano, fanno colazione, e via alla scuola.
Nel pomeriggio hanno lezione di lingue. Don Feddema
conosce le loro tre principali lingue, li porta a leggere
• scrivere, li fa lavorare su brani del Vangelo che ha
tradotto per loro e fatto stampare in Olanda. Altri
lavorano esercitandosi in tutto quel «fatelo da voi »
che la selva richiede: dal costruire scope e mattoni,
al coltivare, al fabbricare ami da pesca.
E poi i giochi, i campionati di calcio appassionati,
disputati - da questi ragazzi che non hanno mai visto
una vera partita - con tecniche piuttosto curiose e
originali.
Le 32 indiette , sotto la guida delle suore, conducono
una vita simile, praticando giochi e lavori adatti alle
loro condizioni e al loro futuro destino. Hanno un
cortile rettangolare pieno di verde e di pappagalli variopinti, grossi come galline o piccoli come passeri,
che si lasciano prendere come gattini e sono compagni
di gioco. Le tre suore hanno già saputo compiere prodigi, con un intuito che ho potuto verificare anch'io
durante il pranzo. Saputo che ero italiano, hanno scodellato in tavola gli spaghetti al sugo.
A sera, meraviglia delle meraviglie, le filmine
Don Bosco, per tutti. «Quelli che hanno fatto le filmine - esclama don Feddema , - che il Signore
li benedica! Piacciono ai piccoli, e piacciono ai grandi.
I grandi arrivano sulle loro barche, mi vengono vicino
• mi supplicano: "Padre, una filmina!".
«Se non c'è spettacolo, si canta. Gli indi hanno un
orecchio formidabile, hanno piccole chitarre, e cantano
molto volentieri.
« Diamo loro molta libertà - spiega padre Feddema . Però nelle cose essenziali, la vita morale e lo studio,
esigiamo il massimo. E non ci limitiamo a educare l'intelligenza, come succede in tante scuole, ma miriamo
al principale, all'educazione del cuore, del sentimento,
della volontà.
« Sono ragazzi di razze diverse, per prima cosa li persuadiamo che sono come fratelli, che devono rispettarsi
• trattarsi bene tra loro. Poi, prendendo gli aspetti più
pratici della religione, insegno loro a vivere cristianamente. La morale che hanno imparato nella tribù ha
tantissimi punti in contatto con la morale cristiana;
comincio da essi per approfondire a poco a poco, in
modo che i ragazzi si costruiscano una propria sintesi
ben armonica. Cerco di evitare le contrapposizioni; mi
rendo conto del pericolo che sarebbe se questi ragazzi
si riempissero metà del cervello di princìpi cristiani
• nell'altra metà conservassero intatte le credenze del
gruppo, senza giungere a fonderle e unificarle.
« Do loro una teologia molto semplice, con pochi riti,
ma mi preoccupo di formarli al sentimento religioso
tutto incentrato sulla presenza di Dio, e sul duplice
comandamento dell'amor di Dio e del prossimo. Di
battesimo, subito subito non se ne può parlare; arrivano
qui che sono animaletti. Ma dopo due o tre anni, quando
vedo che hanno raggiunto una certa maturità umana,
li preparo e li battezzo ».
22
Cosi i figli della selva diventano figli di Dio.
Il motore corrompe gli indi?
Domando a don Feddema come prepara i suoi indi
all'incontro con la civiltà dei bianchi. Perché l'urto ci
sarà, anzi è già cominciato. Sul piano economico, psicologico e religioso.
« Qui - dice - prima che i missionari riuscissero
a far sentire il loro influsso, si stava instaurando una vera
e propria schiavitù. Non c'era praticamente indio che
non lavorasse per qualche bianco che lo sfruttava. Av -
venivano dei baratti incredibili, gli indi lavoravano per
niente.
« Ma è molto facile sbagliare in campo economico. È
facile anche per noi missionari assumere un atteggiamento paternalistico che danneggia l'indio invece di
fargli del bene. Si dice: "Poveri indi, non hanno nulla,
andiamo a regalar loro qualcosa". È trattarli da bambini,
non da persone. Devono imparare il valore delle cose.
Io invece dico loro: "Non ti do nulla, se non te lo guadagni".
« Senza sfruttarli, si capisce. Ho distribuito tra gli indi
una sessantina di motori da imbarcazione. Così, quando
hanno un malato possono portarlo a curare in poche
ore, e non più impiegando giornate intere, durante le
quali il malato poteva anche morire. Se vogliono visitare i figli nella missione, possono farlo. Possono portare i loro prodotti al mercato. Questi motori non li
ho regalati, e neppure li ho ceduti a condizioni da strozzinaggio, come facevano certi bianchi. Essi esigevano
che l'indio lavorasse quattro anni, finché non avesse
pagato il motore otto volte il suo prezzo, e alla fine
.glielo portavano via dicendo che non lo aveva pagato.
Cose capitate.
« Io cedo il motore al suo prezzo, do tempo due o tre
anni per pagarlo, con rate a base di prodotti della terra.
Dico all'indio: "Me lo pagherai con granturco". Risponde: "Non so coltivarlo". Replico: "Vengo a insegnarti. Andiamo a vedere la tua terra". E così impara
anche l'agricoltura, facendo da un giorno all'altro un
balzo verso la civiltà di cinquecento anni.
« È curioso, nel campo economico, l'atteggiamento dei
missionari protestanti che lavorano qui vicino. Essi dicono: "Perché dare i motori agli indi? Gesù Cristo
viveva sul mare di Genezaret e non aveva nessun motore. La povertà è ciò che apre la porta del cielo. Fortunati i poveri che non hanno motori perché di loro
è il regno dei cieli". E così si disinteressano di tutto
l'aspetto economico e sociale degli indi, limitandosi allo
stretto insegnamento religioso. Io penso che l'uomo
dev'essere salvato tutto intero.
« Curioso è anche l'atteggiamento degli etnologi, nei
confronti del motore. L stato qui uno studioso francese,
professore alla Sorbona , e l'ho aiutato nei suoi studi.
sione che i loro parenti - all'incontro con i bianchi,
io cerco per prima cosa di distruggere l'ingiusta generalizzazione che li qualifica tutti come sfruttatori. Dico
loro che tra i bianchi ci sono i buoni e i cattivi, proprio
come tra gli indi. Dico che non è questione di razza
ma di cuore, che nessuno nasce buono o cattivo ma si
diventa tali secondo la propria volontà, che tutto dipende dall'ascoltare o no la voce di Dio ».
Quanto a me, gli indietti del Ratón mi hanno studiato
un poco, e mi hanno accettato. Tutto merito della mac -
// provicario don Fontana
dal Centro missionario
di Puerto Ayacucho realizza
il ponte-radio
con tutti i missionari
de/ Vicariato Apostolico.
A destra, i missionari
con un gruppo
di sportivi forestali.
Un giorno mi dice: "Padre, perché corrompe questi
indi con un motore?". Era preoccupato perché il motore cambiava le naturali condizioni di vita degli indi.
Gli dissi in belle maniere che lui vedeva gli indi soltanto
come oggetti da museo, che dovevano essere conservati
tali e quali per poterci fare sopra gli studi. Che se fosse
possibile evitare l'impatto degli indi con i bianchi,
forse il motore sarebbe inutile; ma i bianchi ormai
sono arrivati. Che se non lo avessi venduto io il motore,
e a prezzo onesto, glielo avrebbero venduto altri bianchi,
e a quell'altro prezzo. Rispose il professore: "Ha ragione, padre"».
Noi siamo gli ultimi missionari
« Per prepararli all'incontro con i bianchi - continua
don Feddema - mi è stato indispensabile capire che
cosa essi pensino dei bianchi. La loro tradizione orale,
trasmessa di padre in figlio, descrive il bianco come uno
sfruttatore. Hanno una sfiducia naturale nei suoi confronti.
« Anche il missionario appartiene al mondo dei bianchi,
ma è l'uomo che ha poteri divini, che è a contatto con
lo Spirito, che può influire sulle malattie. All'immagine
dello sfruttatore sostituiscono quella dello stregone, del
grande capitano, dell'uomo potente che tutto ha e
tutto sa. In più, il missionario si accosta all'indio con
atteggiamento da amico, dimostrando con i fatti che
gli vuole bene. Se parlo con indi anziani, io li chiamo
papà, mamma; se hanno la mia età li chiamo fratelli.
Allora mi considerano come uno della loro famiglia.
«Per preparare gli indi - sia i cuccioli della mia mis -
china fotografica. Quando hanno visto il primo lampo
del flash, nel loro refettorio, hanno applaudito. Poi
sono venuti in sette, uno per tribù, a fare la foto ricordo.
Poi tutti sul trattore. Poi le bambine con i pappagalli
docili come micini . Tutti fotogenici, gli occhi dolcissimi, felici di mettersi in posa.
Domando a don Feddema se riuscirà a salvare gli
indi come popolo.
« Non lo so - risponde. - I loro gruppi etnici sono
piccolissimi, tendono a sciogliersi, alcuni si sono già
disgregati. Io cerco di convincere i miei ragazzi a restare fedeli alla loro gente. Dico per esempio: "Tu
che sei indio piaroa , devi sposare una piaroa ". Faccio
il possibile per renderli capaci di difendere il loro costume. Ma solo se riusciranno a costituire nuclei abbastanza numerosi e compatti potranno sopravvivere come
popolo. Altrimenti saranno schiacciati dal numero, assorbiti nella massa. Comunque andranno le cose, sento
che noi siamo gli ultimi missionari, che le missioni
presto qui non avranno più motivo di esistere*.
Se fossi ateo
Don Feddema si scalda nell'esporre le sue opinioni.
Punta il microfonò del registratore in tutte le direzioni
meno quelle giuste. Ogni poco mi domanda se ho
capito, come se dubitasse del mio quoziente intellettuale, poi mi accorgo che è una felice deformazione professionale: quella dell'insegnante puro sangue che non va
avanti finché non è sicuro di essersi fatto comprendere.
Gli domando che cosa prevede per il futuro religioso
dei suoi indi.
23
« Molto lavoro da fare - risponde. - Ora negli
indi sta avvenendo soprattutto un cambio di mentalità,
non ancora di religione. Noto in loro più umanità,
più rispetto reciproco, più comprensione tra le diverse
tribù. In pratica è un avvicinamento al cristianesimo,
ma la strada è ancora lunga e devo andare adagio.
« Soprattutto, non devo distruggere. Non ne ho il diritto, c'è libertà di pensiero anche per gli indi. Come
missionario non posso imporre la mia dottrina, la propongo soltanto, cercando di renderla il più possibile
convincente.
« Loro amano la danza: sono danze religiose, che eseguono con maschere. Dovrei proibirgliele? Parole e
gesti non sono contro la morale, lascio fare. Con la
confidenza che mi sto guadagnando, a poco a poco
faccio pressione perché cambino certi comportamenti
che vanno raddrizzati. Ma posso farlo solo quando essi
siano capaci di mettere, al posto lasciato vuoto, dei
valori cristiani. Distruggere soltanto è pericoloso. Conosco certi piaroa che sono stati convertiti dai protestanti. Dicono: "Io non sono piaroa , io non sono indio,
io sono cristiano». Per diventare cristiani hanno fatto
un salto nel vuoto, hanno rinnegato la loro gente, la
loro razza. Non era necessario. Io voglio che diventino
cristiani, senza cessare di essere indi, di essere piaroa .
Cioè senza cessare di essere se stessi».
Gli domando come farà.
« La soluzione ce l'ho. La mia idea - e ritorna alla
sua idea, non l'ha ancora esposta tutta, quel che vedo
è solo una parte, c'è il resto dell'iceberg invisibile sotto
l'acqua, nascosto nel futuro. - La mia idea è di allargare la missione per far posto a una quarantina di indi
che dopo aver frequentato le scuole primarie si fermino
qui ancora per un biennio. In questi due anni essi
approfondiranno l'apprendimento di tutte quelle cose
pratiche (agricoltura, medicina, falegnameria) che sono
indispensabili per migliorare il livello di vita dei loro
fratelli; ma soprattutto studieranno per diventare catechisti. Essi saranno i catechisti delle loro tribù. Questi
quaranta ragazzi dovranno essere scelti con il criterio
geografico, in modo che tutti i gruppi vengano rappresentati. A distanza di qualche anno, in ogni gruppo di
indi ci saranno alcuni catechisti che con l'insegnamento
e con l'esempio della loro vita porteranno alla fede tutti
gli altri ».
Ecco, ora l'idea di don Feddema è rotonda e completa.
Gli chiedo cosa manca per renderla operante.
« L'aspetto economico non è il più difficile - dice gli aiuti finora ci sono stati, e non mancheranno in futuro. Il governo dà qualcosa, mi arrivano borse di studio,
la Shell mi dà benzina, il più naturalmente mi viene dalla
Congregazione. E poi tanti aiuti, piccoli e grandi, da
amici vicini e lontani. Non ho nulla da parte, ma il
necessario non mi è mai mancato, al punto che posso
dire: anche se fossi ateo, dovrei credere alla Provvidenza.
« Il più difficile è trovare i missionari e gli insegnanti
adatti per questa scuola». E mentre dice a me queste
parole, guarda con intenzione verso il suo Vicario apostolico, monsignor García . Capisco: è lui il capo dei
missionari, l'idea rotonda e brillante di don Feddema
dipende da lui.
Guardo gli indietti che all'ombra di un grande mango
giocano tranquilli con le loro birille colorate. I 142 topolini dell'isola del Ratón tra qualche anno potrebbero
essere i catechisti dei loro genitori e dei loro fratelli.
Monsignor García nasconde, dietro un sorriso stentato, un interrogativo che - si vede - gli fa male:
24 «Dove li prendo, i missionari? ».
a
TERZA
PUNTATA
I SEGRETI DEI GUAICAS
Don Cocco conosce tre grossi segreti della vita dei Guaicas . « Uno
glielo voglio far conoscere direttamente » mi dice, e mi accompagna
presso uno sciapuni . È una enorme
capanna a tronco di cono, dove abita
il clan, da 30 a 50 persone di ogni età
e sesso. Il brujo (stregone) sta iniziando un giovane alla vita del clan.
Mediante una canna gli inala dentro
le narici una polverina chiamata
iopo, che è un allucinogeno. A poco
a poco il giovane cade in uno stato
di ubriachezza, e allora lo stregone
gli conferisce il potere di vincere i
venti e le acque, di cacciare questo
o quell'altro animale selvatico; e intanto ne imita la voce e il modo di
camminare. La cerimonia si ripeterà
molte volte, anche per un mese intiero.
« Non è soltanto in questa occasione che usano la droga - mi spiega
don Cocco. - Essa è entrata profondamente nella loro vita, e la prendono
soprattutto quando vogliono tramandare di generazione in generazione la
loro storia e le loro leggende. I Guaicas non hanno ancora nulla di scritto,
allora si soffiano nelle narici la polvere di iopo , e sotto l'influsso di questo allucinogeno raccontano. Lo stato
di ebbrezza crea in essi l'illusione di
venire in contatto con gli spiriti buoni
della natura (gli Hekurà ) e di allontanare gli spiriti cattivi. Così credono di poter liberare i corpi sofferenti dalle malattie, di poter ricondurre nel corpo l'anima perduta, e
perfino di volare verso il sole e la
luna, nel regno della Notte. La loro
salute ne resta scossa, naturalmente;
ma molto meno che sotto l'effetto
dell'alcool. Per ora non mi sento di
togliere loro questa abitudine: distruggerei la loro cultura. Del resto,
questi allucinogeni sono rigorosamente vietati alle donne e ai non
iniziati ».
i
7NELLE TERRE VERGINI
DELL'ALTO ORINOCO
S. Maria de los Guaicas (Alto Orinoco-Venezuela). Sulle sponde deli'Orínoco il missionario don Cocco e tre Figlie di Maria Ausiliatrice con alcuni indi Guaicas, che hanno ucciso un anaconda, il gigantesco serpente acquatico.
IL CULTO DEI MORTI
Il secondo segreto è il culto dei
morti, profondamente radicato nell'animo dei Guaicas . A questi riti, di
cui sono gelosissimi, non ammettono
la presenza di estranei, ad eccezione
di don Cocco, a cui non nascondono
nulla.
Quando muore uno della tribù, il
corpo viene incenerito nello spiazzo
antistante la capanna. Se il cadavere
stenta a bruciare, brutto segno: vuol
dire che è stato un poco di buono.
Compiuta la cremazione, le ossa vengono raccolte, ridotte in polvere, e
mescolate con pappa di banane. Poi
i parenti, gli amici e i vicini del
morto sono invitati a mangiarla, dopo
una grossa battuta di caccia per procurarsi selvaggina. Consumato il pasto, dicono i Guaicas , l'anima inquieta del defunto, trova finalmente
pace e riposo.
Ma la vera e propria festa dei morti
ha luogo in autunno, quando maturano i frutti. Dura parecchi giorni,
con danze, canti notturni e chiacchierate interminabili. L'aspetto più
drammatico di tale festa sono le lotte
violente tra uomini che vogliono dissipare malintesi, rafforzare amicizie,
ristabilire posizioni di onore e di prestigio. Don Cocco mi mostra lo strumento usato per la lotta: una pesante
ascia di legno, simile a un remo. Basterebbe un colpo ben assestato per
spedire all'istante un uomo all'altro
mondo; ma i Guaicas lo sanno maneggiare in modo da... lasciare soltanto i segni, senza uccidere. Che se
uno sbagliasse e uccidesse davvero
l'avversario, sarebbe immediatamente ucciso a sua volta dagli spettatori,
che stanno osservando attentamente
con le frecce pronte.
LE VISITE
La terza caratteristica dei Guaicas
è la frequenza delle visite reciproche
e il modo con cui le compiono. Lo
scopo è di stabilire relazioni amichevoli, combinare nuovi matrimoni, o
stipulare alleanze contro nemici comuni. In ogni caso, si scambiano
tutte le notizie possibili, e si chiedono
oggetti in regalo. Coloro che compiono la visita domandano sempre
qualcosa, e l'ospite deve accontentarli. Mostrarsi avaro, sarebbe il peccato più grave per un Guaica .
Così vive questa gente semplice,
per la quale finora i pesci dell'Orinoco , gli animali e i frutti della selva
sono bastati per nutrimento e la luce
del sole e delle stelle per vestito.
Gente che prima dell'arrivo del missionario non conosceva la scrittura e
sapeva contare soltanto fino a tre.
E tuttavia, gente ricca di intelligenza,
di umanità e di buon gusto, che manifestano nelle forme più svariate.
Uomini e donne amano dipingersi
il corpo, con disegni vari ed eleganti:
linee larghe e nere indicano lutto;
tratti più sottili, rosso e marrone, indicano gioia. L'ornamento è completato da foglie, da bastoncini levigati,
e da piume, che infilano nei lobi delle
orecchie, nel setto nasale e agli angoli
della bocca. Amano il canto, a cui si 25
abbandonano con voce melodiosa.
Amano gli animali, in particolare i
cani. Non è raro vedere una donna
che allatta un cagnolino o una scimmietta. Una caratteristica curiosa è
l'uso che fanno del tabacco: arrotolano una foglia e se la pongono tra i
denti e il labbro inferiore della bocca,
creando così una grossa prominenza
sul mento.
Gli uomini si dedicano di preferenza alla caccia e all'allestimento
delle barche. Conoscono un veleno
potentissimo, il curaro, che usano sia
a caccia che in guerra.
Le donne fanno tutti i lavori di
casa, anche i più pesanti; sanno intrecciare cesti di fibra e filare il cotone, portandosi l'ultimo figlioletto
allacciato al dorso.
Questi sono i Guaicas : un popolo
aperto al progresso civile e alla redenzione cristiana.
Ieri don Cocco ha compiuto 60 anni. Gli abbiamo fatto un po' di festa.
Non è mancato neppure lo champagne, uno champagne di prima qualità procurato dalla dottoressa Inga
Steinvorth de Goetz , delicata e generosa come una mamma. Un brindisi
in piena regola nel cuore della selva;
anche le Suore, una volta tanto,
hanno trascurato l'acqua del fiume.
IL VIAGGIO DI RITORNO
Dobbiamo partire. Il dolore del
congedo è attenuato dall'impegno di
ritrovarci per la fine del mese a Puerto Ayacucho . El almirante Teofilo de
la Fuentes riprende il comando della
voladora e corre veloce, evitando con
sicurezza scogli, banchi di sabbia,
tronchi galleggianti, e abbordando le
curve con maestria.
Dopo cinque ore di viaggio, ci fermiamo a una stazione di rifornimento. Gli indigeni riconoscono don Fontana, e gli chiedono un cigarrillo . Di
solito ne è fornito: gli amici gliene
fanno dono, a conforto e sollievo della
sua solitudine. Ma don Fontana conosce modi molto più evangelici di
vincere la solitudine, e non si permetterebbe mai consumi voluttuari in
un mondo di povertà; perciò li regala
ad altri; ma questa volta ne è del
tutto sprovvisto, peccato.
Alle 19 esatte facciamo alt a
S. Antonio di Macuruco . Don Fontana vi incontra un amico dottore,
26 che fa parte del Centro governativo
per la lotta contro la malaria e il paludiamo. « L'avete presa la pastiglia
contro la malaria? ». Don Fontana
si dà una manata sulla fronte: « Già!
Ce ne siamo del tutto scordati! ». Il
dottore ci fa immediatamente ingollare due pillole ognuno, invitandoci
a ringraziare Iddio per essere passati
i mmuni tra legioni di insetti. I quali,
comunque, non disarmano per questo, e ci martirizzano tutta la notte.
Verrebbe la voglia di strapparsi la
pelle, tanto è il prurito e il bruciore
delle punture. L'unico conforto è il
pensiero che ad ogni modo non ci
prenderemo la malaria.
A SAN JUAN DE MANAPIARE
Alle prime luci dell'alba siamo dinuovo in acqua. Imbocchiamo prima
il Ventuari , ampio e maestoso come
l'Orinoco nel quale si scarica, e poi
il Manapiare , affluente del Ventuari .
Un grosso stormo di uccelli si alza in
volo al nostro passaggio, e ci precede
ingrossandosi sempre più, quasi scorta festosa al nostro arrivo.
È centro in piena espansione. La
civiltà batte impaziente alle porte.
Come primo risultato, ha sconfitto ed
eliminato gli insetti nocivi, specialmente gli insopportabili mosquitos , e
quei fastidiosi parassiti che si arrampicano sulle gambe e arrivano fino
alle spalle, lasciando larghi segni sariguigni sulla pelle.
Sul piazzale esuberante di verde
davanti alla missione è atterrato un
elicottero. Il pilota, dalla poderosa
corporatura, è un exallievo salesiano,
e porta un capitano e un professore
di geologia nucleare, venuto per studiare rocce e raccogliere campioni. In
compagnia loro e di don Arranz , che
dirige questa residenza, facciamo un
largo giro per tutta la missione..
Don Arranz, uomo di dinamismo formidabile, mi espone con calore i suoi
progetti per l'avvenire. Sono tali da
far venire il capogiro; ma gli altri interlocutori non sono da meno, e sognano il Duemila, quando le rive dell'Orinoco saranno fiorite di villini, si
alzeranno al cielo le ciminiere delle
fabbriche e le antenne della TV.
« Purché la civiltà non ci rubi il verde, l'aria pura e l'acqua limpida,
come nelle grandi metropoli d'Europa e d'America... ». La conversazione ne prosegue animatissima durante
la cena; poi usciamo all'aria aperta,
per ammirare la luna piena che si
specchia nelle acque del grande Rio.
Un fresco venticello carezza piacevolmente le nostre guance. Il dottore ci
offre un delizioso whisky al ghiaccio.
Il pilota si impegna in una partita al
pallone con i ragazzi di don Arranz .
Pare una gara tra i moscerini e
l'elefante.
Il giorno dopo con don Arranz vado
a visitare le tribù dei Piaroa . Mi accorgo subito che sono a un livello di
civiltà nettamente superiore. Non
abitano in capanne, ma in casette di
mattoni e di fango; e hanno il senso
della previdenza: si fanno scorte di
generi alimentari, come pesce secco
e ben confezionato, sacchi di mafloco
e altro ancora. È gente attiva e intraprendente, saranno gli industriali
e i commercianti del Duemila. Perciò
don Arranz non vorrebbe lasciarsi
sorprendere dal tempo, e sogna una
vasta opera parrocchiale, con un'ampia cappella che possa accogliere
tutti, mentre ora metà dei fedeli è
regolarmente costretta a starsene
fuori, sulla piazzetta.
CONGEDO
La mia visita ai missionari dell'Alto
Orinoco è terminata. Lascio Manapiare con un bimotore del Code Sur ,
che punta su Puerto Ayacucho , levandosi in volo da una pista costruita, anch'essa, dai missionari. Fuggono
alle nostre' spalle i monti, vestiti di
verde fin oltre i duemila. Tutta la
pianura appare nella sua sconfinata
vastità, tagliata in due da un interminabile nastro luccicante, l'Orinoco .
Conservo negli occhi e nel cuore le
i mmagini delle meravigliose realtà
che ho vissuto. I missionari meritano
davvero la gratitudine dell'umanità
intera. Soli, spesso senza mezzi, ma
animati da una fede e da un coraggio
che vanno oltre ogni speranza, spalancano la via della civiltà umana e
cristiana ai popoli più soli e trascurati. Senza nessun interesse, senza la
più piccola ricompensa, pagando di
persona. Un giorno spariranno, saranno dimenticati, altri mieteranno
ove essi hanno seminato.
Ma davanti al Padrone della messe, il Signore dei popoli, nessuna lacrima, nessuna goccia di sudore o di
sangue, sarà caduta invano dalla loro
fronte.
DON FRANCESCO LACONI
CONOSCIAMO POCO LA COREA
Dal nostro inviato DON CARLO DE AMBROGIO
i
el dicembre del 1950 la semidistrutta città di Seul , capitale della Corea
del Sud, fu sul punto di essere occupata dai nord-coreani comunisti.
Rimanevano da salvare i tesori nazionali più preziosi; una nave governativa
si teneva alla fonda per caricare all'ultimo momento. Cosa si poteva mettere
in salvo? Si seppe che il governo voleva salvare a tutti i costi l'Orchestra
Sinfonica di Seul. Senza musica la Corea non poteva esistere.
La musica coreana è meravigliosa. « Venga con me alla Korea's House »,
mi dice gentilmente don Mario Ruzzeddu , che è il superiore dei Salesiani
nella Corea del Sud e quindi il capo di quella pattuglia di coraggiosi
del Signore che sono i missionari dislocati agli ultimi lembi dell'Asia. La
proposta mi attirava. Sapevo che la musica coreana è la sola musica asiatica
che può competere con quella europea per la ricchezza e la complessità dei
sentimenti.
La sala di audizione della Korea's House, quando ci arrivammo, era già
piena di gente, in maggioranza americani. Mi accorsi che le canzoni coreane
hanno il ritmo di valzer indiavolati. Basta che una dozzina di coreani si
riuniscano insieme perché qualcuno di loro cominci a cantare. I ragazzi delle
scuole prediligono i vecchi canti popolari.
N
Un popolo paziente
Ma l'amore dei Coreani per la musica non significa che essi siano un popolo molle. Tutt'altro. I Coreani sono per tradizione un popolo duro, inossidabile. Nessun'altra nazione al mondo ha patito tante distruzioni come la
Corea. Primi irruppero gli antichi predoni cinesi. Poi vi si rovesciarono le
orde spietate di Genghis Khan. Nel 1592 i Giapponesi distrussero quasi tutte
le città della Corea. Nel 1636 i Cinesi rincararono la dose. Nel 1910 i Giapponesi occuparono tutta la Corea. Quando infine venne la liberazione nel
1945 i Russi s'insediarono nella Corea del Nord. Poi nel 1950 scoppiò la
guerra che tornò a devastare il paese.
Nessun altro popolo della terra - escluso il popolo polacco - ha saputo
conservare la propria unità nazionale in simili condizioni. La sopravvivenza
della Corea è un fenomeno storico difficilmente riscontrabile. I Coreani come
nazione hanno uno straordinario potere di ricrescita; sanno incassare molto
bene i colpi inflittigli dalla storia. Sono un popolo estremamente paziente.
Il Coreano, individualista a oltranza
Conversai a lungo con il Delegato ispettoriale don. Mario Ruzzeddu (un
uomo che passò gran parte della sua vita in Thailandia , a Bangkok, e ne
conserva un'inguaribile nostalgia), scambiai parole col maestro dei novizi
don Molero Gesù e con i Salesiani dello Studentato filosofico e teologico di
Shintorim Dong; mi venne quindi messa maggiormente a fuoco un'immagine
più precisa della Corea e dei simpaticissimi Coreani.
Capisco bene che la Corea fa da ponte tra il continente asiatico e il Giappone. Fin dai tempi più remoti, infatti, i Cinesi di antichissima civiltà e le
tribù della Siberia e della Manciuria si raggrumarono nel Nord, mentre nel
Sud si insediavano gli industriosi Giapponesi. La storia della Corea va considerata come un continuo fluire e pendolare di queste genti. Il popolo coreano ha quindi raccolto e assimilato gli influssi del Giappone e della Siberia. 27
« Attenzione, - mi diceva don Vincenzo Donati, musico brillante e conoscitore perfetto della lingua coreana - il Coreano è di per sé un individualista a oltranza ». Come si spiega? Forse perché il paese è montagnoso
al massimo grado, molto di più che l'Italia. A spianarne le cime dei monti,
la terra coreana ricoprirebbe tutto il nostro pianeta. Un terreno così accidentato permette a piccole comunità compatte di rifugiarsi in valli remote
e di viverci isolate nelle loro usanze millenarie.
1 professori dell'Oriente
La civiltà giapponese, praticamente, subì il filtro della Corea. Tre religioni passarono attraverso il ponte della Corea: il Confucianesimo dalla Cina,
il Buddismo dall'India, e lo Sciamanismo (o culto degli spiriti) dalla Siberia.
Ognuna delle tre s'impiantò in Giappone; vi prosperarono, il Buddismo senza
cambiar nome, e lo Sciamanismo tramutato e perfezionato nello Scintoismo.
Le pagode e i tempietti con il tetto rivoltato in su vengono dalla Corea.
I Coreani sono artisti finissimi. L'industria giapponese delle ceramiche è dovuta ai vasai coreani che fabbricavano coppe e piatti rifiniti a smalto.
I Cinesi hanno sempre chiamato i Coreani « i professori dell'Oriente ».
La maggiore affermazione coreana nel campo intellettuale è l'alfabeto nazionale. Per i primi 1500 anni della loro storia, i Coreani si erano serviti dei
caratteri cinesi per la loro lingua scritta. Ma la popolazione rimaneva analfabeta perché il coreano parlato differisce dal cinese quanto l'italiano dall'ungherese. Fu nel 1445 che, un geniale re coreano dette al suo popolo un
alfabeto di uso pratico che chiunque può imparare nel giro di poche ore.
Oggi l'analfabetismo è quasi scomparso in Corea.
I n casa del signor Kim Yung Sik
Un gentilissimo signore coreano, Kim Yung Sik , mi volle invitare a cena
in casa sua. Accettai, benché fossi per lui uno sconosciuto. Gli bastava sapere che ero un prete e che venivo dall'Italia, felice che si andasse da lui.
Venne a prenderci in macchina: don Ruzzeddu e io ci sfilammo le scarpe
prima di entrare in casa. È di prammatica. Anche nelle chiese coreane ci si
leva le scarpe. Ammirai la bella invenzione coreana della casa col pavimento
riscaldato. Probabilmente, mi spiegavano, il primo germe di quest'idea si
era avuta in Manciuria. ma i Coreani avevano perfezionato ir sistema semplice e ingegnoso, che consiste nel far passare vapore d'acqua e fumo attraverso delle tubature nel pavimento; queste vengono poi ricoperte da larghi
fogli di cartone compresso laccati con olio di soia: così il pavimento della
casa coreana è sempre caldo e lucidissimo. Già ai tempi di Cristo, i Coreani
godevano del riscaldamento radiante.
Era l'inizio dell'autunno. Al mattino una nebbiolina lieve, come una coltre
di seta quale nelle regioni dell'Italia nord, si leva a Seul . Nelle case dei
Coreani è in auge il culto dei fiori. I giardini di tutto il mondo si sono arricchiti della flora meravigliosa giunta dalla Corea. Alcune piante, come la
forsythia , il susino. l'azalea, sono, è vero, native della Cina, ma il tanto decantato ciliegio giapponese è originario della Corea, che ancor oggi possiede
i più bei boschetti di quest'albero pittoresco.
Nazione segnata dalla fatalità
La Corea è l'unica in Asia a non avere una religione nazionale riconosciuta. Un tempo vi predominò il Buddismo, che però non s'impose mai in
tutto il Paese. In epoca posteriore, gli uomini praticarono il Confucianesimo,
mentre le donne rimanevano per lo più fedeli allo Sciamanismo e al suo
caldo mondo di spiriti. Oggi la religione che predomina in Corea è il Cristianesimo. Basta osservare le numerose chiese che vi sorgono. Le conversioni sono in un ritmo di aumento paragonabile a poche altre nazioni.
Il popolo è meraviglioso. Ma la Corea come nazione sembra segnata dalla
fatalità. Geograficamente sarà sempre una nazione che farà da ponte di pas -
saggio; e la sorte di tali nazioni è di venire invase periodicamente. Oggi al
diciottesimo parallelo montano la guardia le forze dei due blocchi che si
contendono la supremazia sul mondo. L'amore della patria è vivissimo in
ogni coreano. Il popolo si difende dalla fiumana dei disastri, che gli si abbattono addosso, aggrappandosi alla propria terra.
I giovani coreani
Un rapido panorama delle opere salesiane nella Corea del Sud è presto
fatto. Nella capitale Seul a Shintorim Dong sorge lo Studentato filosofico
e teologico insieme al noviziato e al magistero di perfezionamento professionale per coadiutori. Non sono molti i giovani salesiani coreani, ma sono promettenti. C'è la parrocchia di San Francesco di Sales a Kuro Dong con addetti due salesiani spagnoli, don Paolo Bahillo e don Alfredo Moreno e un
coadiutore coreano, Kim Mosè . E terzo, il magnifico Centro Giovanile Don
Bosco a Shintaebang Dong con una scuola professionale per meccanici, un
pensionato e una scuola serale. La dirige don Edoardo McNeill , allegro, intraprendente, instancabile.
Anche a,Seul - mi dicono - come in tutte le grandi città del mondo
i gruppi di giovani « irrequieti » sono più numerosi degli « irrequieti » di
una volta che sono sempre esistiti. Cercano ed esigono un mondo « migliore »;
sono delusi dalla realtà, di cui tuttavia non possono fare a meno; da una
parte avvertono con particolare evidenza la loro mancanza di incidenza
nella società che li ha cresciuti e d'altra parte sono convinti della loro propria
forza creativa.
Don Gesù Molero, che conosce molto bene gli ambienti universitari di
Seul e i giovani di avanguardia (insegna spagnolo all'università), mi dice
che i giovani più avanzati mostrano una fede, nonostante tutto, quasi utopistica nella comunità, nella rivoluzione sociale e nella società futura. L'escatologia, in definitiva, ha sempre forte presa sui giovani. Mi ricordai quello
che mi diceva a Hong Kong un espertissimo studioso di marxismo cinese, il
gesuita padre Melis : « Legga il libriccino rosso Parole del Presidente Mao
Tse-tung. Vi troverà il segreto del marxismo nel far leva sulle aspirazioni a
un mondo migliore che fermenta nell'anima soprattutto dei giovani ».
La terza via
A Seul , in un'ora di quiete, sfilai dalla valigia il libriccino rosso Parole
del Presidente Mao Tse-tung e lessi: « In tempi antichi visse nel nord della
Cina un vegliardo dei monti nordici di nome "Vecchio Pazzo". Due grandi
montagne sbarravano la strada che dalla sua porta di casa andava verso il sud:
il Taihang e il Wangwu . Vecchio Pazzo prese la decisione di abbattere con
zappe queste montagne insieme ai suoi figli. t'n altro vegliardo di nome Vecchio
Saggio rise quando li vide all'azione e commentò: "È veramente assurdo quello
che fate. Pochi come siete, non potete spianare due montagne di simili dimensioni". Vecchio Pazzo gli replicò: "Muoio io, restano i miei figli; muoiono i
figli, restano i nipoti; e così le generazioni in una serie senza fine. Queste montagne sono alte, ma non possono diventare più alte; caleranno anzi di tutto
quello che noi riusciremo ad abbattere. Perché non le dovremmo spianare?".
Poi Vecchio Pazzo senza nemmeno tentennare e senza più discutere si mise a
demolire le montagne un giorno dopo l'altro. Ciò commosse l'Imperatore del
Cielo che mandò due suoi messaggeri sulla terra. Essi presero sulle spalle le
due montagne e le portarono via». Mao Tse-tung fa subito l'applicazione:
« Attualmente ci sono due grandi montagne che pesano sul popolo cinese: una
si chiama imperialismo, l'altra si chiama feudalesimo ». Quello che segue non
mi interessava più.
Riflettei: due popoli pesano da sempre sulla Corea e la chiudono come in
un sandwich: la Cina e il Giappone. Ma la Corea è un popolo duro, un popolo sacrificato, un popolo ostinato, un popolo fedele. Lo saranno anche le
nuove generazioni coreane, che più delle precedenti conoscono il Cristo?
Tra il marxismo cinese e il materialismo giapponese, l'unica soluzione possibile è il cristianesimo. Non ce n'è altra.
a
E DEL
SUO APOSTOLO
SAN
GIOVANNI
BOSCO
PER
INTERCESSIONE
DI
MARIA
AUSILIATRICE
COME SE UNA VOCE
GLI AVESSE DETTO:
« FERMATI »
un mese, sentendomi meglio, volli fare
una nuova radiografia. Risultato: sana
come se non fossi mai stata ammalata.
Ho ringraziato Don Bosco e sono diventata una sua propagandista. Sento
anche il dovere di ringraziare il giovane
Kokkinis , che mi ha fatto conoscere un
Santo così caro e così grande.
Atene (Grecia)
SPIRIDULLA GHEORGHIN
Assolvo a un mio debito di profonda
riconoscenza alla Madonna di Don Bosco
- anche come Cooperatore salesiano
che ogni giorno affida le proprie bambine
alle premure delle Figlie di Maria Ausiliatrice - per un suo materno intervento
col quale ella mi salvò la vita.
Tempo fa stavo percorrendo via Stra- SPACCIATA DAI MEDICI
della (in Torino), diretto verso il centro PER TROMBOSI CEREBRALE
della città, a bordo di una autovettura
di piccola cilindrata. Dietro me un grosso Nostra sorella Giulia, colpita da trombosi
autocarro con rimorchio. A un tratto, cerebrale, fu trasportata all'ospedale e vi
di colpo, senza motivo, senza alcuna rimase parecchie ore in coma. I medici
giustificazione - come per una voce non ci davano alcuna speranza di salche mi dicesse: « Férmati » - mi sentii varla. Allora con tanta fede rivolgemmo
stranamente ispirato ad arrestarmi al li- l e nostre preghiere e tutte le nostre spemite estremo della carreggiata destra. ranze a Maria Ausiliatrice e a San GioEbbene, il grosso camion, che un attimo vanni Bosco, che le ascoltarono e ci
prima si era affiancato alla mia sinistra, ottennero la guarigione. Per la grande
per evitare una vettura che aveva invaso grazia ricevuta le sorelle inviano l'offerta
l a sua corsia in senso opposto, si spo- promessa e desiderano che la grazia
stava tutto a destra bruscamente, sa- venga pubblicata.
l endo anche i gradini del binario del Genova-Pegli
ANGELINA DELLA NOCE
trami Senza quel mio improvviso arresto,
l a mia vettura sarebbe stata inevitabilmente schiacciata. L'impressione che
ne provai fu choccante , e la rivivo tuttora. lo ritengo che fu la Madonna, che
tutti in famiglia onoriamo, a volere che Sr. Fiorina Parmiggiani ( Triuggioi o arrestassi la mia marcia qualche attimo Milano ) si rende interprete della riconoprima, perché altrimenti avrei proseguito scenza a M.A. e a Don F. Rinaldi della
regolarmente. Infatti nulla mi avrebbe nipote Bruna per l'assistenza avuta nella
i mpedito di continuare, e sarei stato stri- sistemazione al lavoro.
tolato pochi metri più avanti.
GIOVANNI B. RIGHETTI Sr. Elisa Zuliani ( Udine) ringrazia M.A.
Torino
per la prodigiosa guarigione di un cugino
e per molte altre grazie ottenute per sé e
per altri.
DON BOSCO PREMIA LA CARITÀ Rarri Maria ved. Sala (Busero-MiDI UN EXALLIEVO
l ano) è grata a S.G.B . per la guarigione
I o, per essere sincera, non conoscevo da pleurite e polmonite, quando umananemanco il nome di San Giovanni Bo- mente parlando non c'erano più speranze.
sco. La mia famiglia è tanto legata a A. A. C. (Lodi-Milano). Con la novena a
un giovane greco di nome Giorgio M.A. consigliata da S.G.B .,' ottenne la
Kokkinis , exallievo salesiano nel Medio guarigione della figlia da i ttiosi (malattia
Oriente. Da lui ho sentito parlare di definita inguaribile).
Don Bosco e dei Salesiani. Noi siamo
ortodossi e solo mia madre è cattolica Maria Bizzotto Frigo (S. Zenone Ezzeperché di origine francese. lo lavoravo li ni-Treviso) dichiara: « Mio figlio Alalla società aerea greca « Olymbic». Ma fonso rimase vittima di un incidente stradallo scorso ottobre ero malata di tu- dale e fu in coma per 11 giorni. Dopo
bercolosi e ricoverata in un sanatorio. avergli applicata l'immagine di M.A. e
Quando il giovane Kokkinis l o seppe, messa al collo la reliquia di S.G.B ., rimi portò una reliquia di Don Bosco e prese vita ».
cominciò a pregare per me. In quel
periodo ero anche ammalata di nervi e Dott. Rosalba Alberghina (Catania)
due volte ho tentato di mettere fine alla scendendo la scalinata che dalla chiesa
mia vita: avevo perduto la salute e il porta alla strada, cadde con la faccia in
posto di lavoro, e mi pareva di non avanti. La caduta poteva essere mortale.
poter più vivere. Giorgio pregò molto L'intervento di M.A. le impedì di farsi il
30 e fece tante Comunioni per me. Dopo minimo male.
Olimpia Fabrici Lecon ( ClauzettoPordenone ) rende grazie a M.A., a S.G.B .
e a S.D.S . perché hanno salvato il figlio
i n un incidente stradale e per altre segnal ate grazie concesse a lei, al marito e al
figlio.
Maria S. ( Gela-Caltanissetta) dichiara
di dovere alla intercessione di M.A. la
guarigione di un fratello affetto da stenosi
mitralica al cuore e di una sorella da un
attacco alla pleura.
Nelly Roux ( Montjovet-Aosta ) attribuisce a M.A. e a S.G.B . l' aver scongiurato
il pericolo - che sembrava già in atto di un male insidioso.
Anita di Gregorio (Tunisi) desidera rendere pubblica la guarigione di un nipotino, il buon esito negli studi di un figlio
e altre grazie.
CI HANNO PURE
SEGNALATO GRAZIE
Accornero fam . - Amerio Rosina - Andrenezioli
Argia - Antonietto Secondina - Antonini Santina Appendino N. - Arduino Lucia ved. Bianco Argenio Concetta - Bacuzzi Adele - Bagnati
Caterina - Baldi Francesca - Barbaglia Cerutti
Francesca - Barbero Antonietta - Barbero Maria
Ernesta ved. Garbarino - Bedeschi Marianna Bellini Elsa - Benedetti Pia - Benedetto Felice e
Giuseppina - Benzi Rina - Bergaglio fam . - Bergna
Fernanda - Bergomi Anna - Bermand Rosina Bernardini Maria - Bernello Giuseppe - Bertoldo
Teresa - Besseghini Caspani Caterina - Bethaz
Sidonia - Bianciotto Paola - Bigliardi Battini
Oddolina - Biscaldi Luigina - Boccuccio Alfieri
- Bonfrisco Elena - Bonifacio Erminia - Bonizzoni
Francesca - Bordin Erlinda - Borgarino Nini Borgo Caterina - Borgo Bruno Giuseppina Bosconero fam ; - Brandi Teresa - Brioschi Gianni
- Bruni Marietta - Brusco Maddalena - Burchesi
Rosaria - Caccia Assunta - Cai Teresa - Calabrò
Giuseppa - Calicante Laura - Cammarata Grazia Cangiano Francesca - Cappellini Elisa - Caputo
Teresa - Cardinale Maria Concetta - Careggio
Francesca - Carelli Rosa - Casati Ausilia - Castellani Rosina - Castelli Necchi Renata - Castrucci
Ottaviani Iris - Cavallo Onorata - Caverni Anna Celia Simone Rosina - Ceranto Angela - Cerocchi
Teodolinda - Cesario Bianca - Chiofalo Perrelli
Teresa - Chistoni Maria - Clementi Cattane Lilla Coali Giuseppina - Coghi Piera - Colussi Romana
- Coppola Anna - Core Ferraro Maria - Corti
Teresa - Costalbloz Alfredo - Crippa Culacciati
Albina - Crippa Villa Carla - Crisafulli Maria
Teresa - Cristiani fam . - Crotti Costanza - Curto
Emma - Dacasto Giuseppina - Dadò Giuseppe Daina Rina - Dall'Oro fam. - Damiani Eledis D'Angelo Angela - De Cicco Modesta - Dedoni
Maurizio - De Gangi Rosa - Dei Cas Luigi De Mare Giuseppa - Dester Luigi - De Vito Maria Di Fresco Anna - Di Mussi Rosalia - Di Nuoro
Concetta - Disconzi Elisabetta - Donato Pietro Dorato Adele ved . Bianco - Ejdallin G. Battista
Facci Goldina - Fantoni Rina - Farello Giacomo Ferrero Giuseppina - Ferrero Maddalena - Ferrero Maria - Ferretti Lucia - Fidelbo Antonietta
- Filipozzi fam . - Fiorentino Anna - Fisichella
Paolo - Floris Pasqualina - Jojeusaz Margherita
- Fontana Aurelia - Franci Elisabetta - Frantantonio
Carmela - Fresia Clotilde - Fulco dott. Paolo Gabri Nerina - Gallo Grazia - Gambaruto Teresa
- Garzonio Maria - Ghirardi Bosio Laura - Ghisu
Giuseppe - Giacomini Rosa - Gilberti M. Maddalena - Giuffrida Giacoma - Giustetto fam . -
Don Filippo Rinaldi
Simone Srugi
I L CAVALLO ROTOLA GIÙ
E LUI, SOTTO
Dalla Missione salesiana di Sevilla Don
Bosco, nel Vicariato Apostolico di Méndez (Ecuador), viaggiavo a piedi diretto
a Méndez, con undici ragazzi chivari .
Guadato l' Upano e raggiunta Macas ,
potemmo approfittare per dieci chilometri del camion della Missione, poi
continuammo a piedi. Dopo altri 16 chil ometri, arrivammo a Sucúa e vi pernottammo. Il giorno dopo, con la carretta trainata dal trattore della Missione,
raggiungemmo Huambi (altri 8 chilometri) e avanti a piedi. La carità dei
salesiani di Sucúa però mi aveva fornito di un cavallo.
A metà strada tra Huambi e Logrono ,
presso il torrente Changachangaza , il
cavallo, stanco di camminare nel fango,
mentre saliva un sentiero strettissimo,
mise un piede in fallo e cadde. Fu un
salto pauroso. Il cavallo rotolò due
volte su se stesso e io, sotto. Invocai
Maria Ausiliatrice e Don Rinaldi . Mi
fermai vari metri più in basso. Il cavallo
finì un metro più sotto. Feci per rialzarmi. Il petto mi doleva forte, essendo
stato mezzo schiacciato dall'animale. Il
braccio destro non lo potevo articolare.
L'omero era andato fuori posto, sotto
l a clavicola.
I ragazzi, passata la collinetta, erano andati avanti senza accorgersi di niente.
Gridai forte, ma non mi sentivano. Finalmente, attratta dalle grida, venne una
contadina, che mi ricondusse il cavallo
e mi spinse in sella. A tanta distanza
da Sucúa , alle sei di sera, in quelle
condizioni, non sapevo che pesci pigliare. Mi misi a invocare Don Rinaldi ,
che in fatto di ossa se ne intende, e
continuai a farlo con grande fiducia
finché potei incontrare i ragazzi, che
mi accolsero spaventatissimi . Allora mi
venne un'idea. Dissi loro: « Afferratemi
il braccio e tirate anche se grido: com'è
uscito, deve rientrare». Detto fatto. Il
braccio ritornò buono buono al suo
posto. Mi doleva, ma potevo articolarlo.
Solo il petto mi preoccupava per il
dolore e per il timore che si producesse
una pleurite da schiacciamento.
A Logroiio arrivammo alle 9 con un
buio già fitto. Nel cammino - tutto
fango e pozze d'acqua profonde caddi un'altra volta e il braccio uscì
fuori di posto come prima. I ragazzi
me lo tirarono forte di nuovo, mentre
i o invocavo Don Rinaldi . Con facilità
me lo fecero ritornare a posto. Dormimmo in una scuoletta . Per me dormire su di un tavolato fu il martirio che
si può immaginare. Mi tormentava anche la preoccupazione di complicazioni
Zeffirino Namuncurà
Laura Vicuna
ai polmoni, perché il colpo ricevuto dal
cavallo era stato fortissimo. Temevo
pure che ci fosse qualche costola rotta.
Misi tutto nelle mani di Dio per intercessione di Don Rinaldi .
La mattina dopo ci rimettemmo in marcia.
A Méndez - pensavo - c'è un ospedaletto . Giungemmo alle 5 di sera.
Non sentivo più alcun male. Quindi non
feci neppur parola dell'accaduto e i
ragazzi furono bravi e non mi tradirono.
Come mai non sentivo più nessun disturbo in nessuna parte? Non posso
spiegarmelo se non pensando che Don
Rinaldi aveva fatto la grazia completa.
AI mio ritorno a Sevilla un colono
esperto in slogature volle palparmi il
braccio. Si meravigliò di non notare
nulla. « Lei ha saputo curarsi bene», mi t
disse. « lo non so curare le slogature»,
risposi. Il medico era stato Don Rinaldi ,
e non solo della slogatura. Ho tardato
qualche anno a rendere questa pubblica testimonianza perché la grazia
fosse collaudata dal tempo.
PER
INTERCESSIONE
DI ALTRI
SERVI
DI DIO
stare in piedi per un tempo prolungato,
i l che da 15 giorni non mi era possibile
effettuare. In breve tempo ottenni la
guarigione completa, senza il ricorso ad
alcun rimedio umano. Dico un «grazie»
cordiale al mio protettore, e desidero
venga pubblicata la grazia affinché anche
altri ricorrano alla sua intercessione.
Nazareth (Israele)
una FIGLIA di MARIA AUSILIATRICE
GUARITO DA TUMORE MALIGNO
Il signor Alejo Puyssegur di 70 anni
di età da molto tempo soffriva di un
male al labbro. L'analisi dei medici dimostrò che si trattava di un cancro localizzato. Con i suoi familiari invocò
l'intercessione di Zeffirino Namuncurà
e dopo dieci giorni di applicazioni di
radio la ferita si cicatrizzò. Trascorso un
anno e mezzo, si recò nuovamente alla
capitale per sentire il parere degli specialisti. Mentre il male avrebbe dovuto
DON ALFREDO GERMANI riprodursi trattandosi di un tumore di
Taisha (Ecuador)
natura maligna, i medici gli confermarono la perfetta guarigione. Tornò una
seconda volta a Fortín Mercedes presso
Per intercessione di Don Rinaldi : l a tomba di Zeffirino a ringraziarlo, e
questa volta lo accompagnò anche la
Don De Stefanis Natale, salesiano
figlia medico residente a Cordoba.
( Courgné - Torino) soffriva da molti c
anni di gravi disturbi senza che si riu- Fortín Mercedes (Argentina)
DON ALBERTO GREGHI
scisse a individuare la causa del suo
male. Si affidò al servo di Dio Don Fili ppo Rinaldi e ben presto poté costatare l' efficacia del suo intervento in GUARITO DA EPILESSIA
una nuova diagnosi e nell'atto operatorio felicemente riuscito.
Un mio figliuolo di tredici anni, tre anni fa, .
Cuneo) dice a cominciò a presentare sintomi epilettici.
(
Bra
Rita Begese
Curato, non migliorò, anzi il suo male
Don Rinaldí tutta a sua riconoscenza peggiorò e divenne vera e del
p
l
epi
per aver ottenuto alla figlia il lavoro l essia . Le cure del medico
l uogo
uogo e
desiderato e i n un l uogo non troppo
degli specialisti consultati non portarono
distante.
alcun giovamento. Angosciata per il suo
stato compassionevole, mentre da vari
giorni si trovava preso da continue convulsioni e quasi del tutto incosciente,
GUARISCE SENZA RICORRERE
misi sotto il suo guanciale un'immagine
A MEDICINE
della serva di Dio Laura Vicuna, racAvevo raggiunto da pochi giorni la Casa comandandole con grande fede mio
destinatami dall'obbedienza, quando mi figlio.
Dopo essere rimasto per un po' nelle
si gonfiarono le gambe producendomi
stesse penose condizioni, d'un tratto il
i n pari tempo dolori acuti, tanto da non
poter attendere alle mie occupazioni, mio figliuolo venne in cucina per dirmi,
con grave disagio della comunità. II tutto meravigliato, d'aver veduto una
ragazza presso di lui. Dalla descrizione
medico non fu in grado di diagnosticare
l a causa del male e quindi non mi diede che ne fece, risulta essere proprio Laura
alcun rimedio. In quei giorni mi pervenne Vicuna . Da quel momento cominciò a
un'immagine con reliquia del servo di star bene e, senza far uso di medicinali,
non ebbe più alcuna ricaduta nel male.
Dio Simone Srugi e l'applicai sulla
I mmensamente grata a Laura, desidero
parte malata, iniziando una novena. Il
miglioramento si verificò fin dal giorno sia pubblicata questa grande grazia.
seguente, tanto da poter cominciare ad Palmares (Costa Rica)
attendere ai miei doveri che esigono lo
CLEMENTINA VARGAS DE ROJAS
31
PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
SALESIANI DEFUNTI
Don Ermenegildo Murtas t a Castellammare di Stabia (Napoli) a
6z anni.
I molti che hanno avuto la fortuna di accostarlo lo ricorderanno come
s maestro di vita,.
Insegnante sicuro e profondo, sapeva dire a tutti una parola chiara,
che gli proveniva dall'intimo del proprio spirito, dal contatto continuo con i Padri della Chiesa e della Congregazione, dalla preghiera
che gli era abituale.
Salesiano stimato, ha profuso le sue energie nelle case di formazione,
nello studio della spiritualità salesiana, nell'approfondimento dello
spirito di Don Bosco.
Superiore prudente ed esperto, ha dato a tutti esempio di lavoro sacrificato, anche nei momenti in cui la sua salute avrebbe imposto un necessario riposo.
Sacerdote sempre disponibile al ministero, in questi ultimi anni è stato
confessore apprezzato e ricercato, non solo della comunità dei chierici
studenti, ma anche dei sacerdoti della diocesi, che hanno avuto modo
di conoscerlo nel Consiglio Presbiteriale , di cui era membro.
Anche la sua serena e silenziosa dipartita, preparata da tempo e quasi
attesa, resta l'ultimo suo insegnamento.
Don Luigi Ornaghí t a Sondrio a 64 anni.
Dopo un'adolescenza angelica trascorsa nell'Istituto salesiano di Milano, dove era soprannominato - il San Luigi
a 1 8 anni divenne
figlio di Don Bosco. L'entusiasmo per la sua vocazione, la pietà profonda, la dedizione sempre gioiosa nell'apostolato della scuola e dell'oratorio festivo lo fecero amare ed apprezzare nelle nostre case di Chiari,
Modena, Faenza, Milano e Sondrio. Negli ultimi 25 anni della sua
vita fu soprattutto esperto direttore spirituale. Lo ricordano al Signore
con grande riconoscenza parecchie comunità di Figlie di Maria Ausiliatrice e di altri Istituti religiosi.
Don Francesco Nee
t
a Ispwich ( USA) a
41
anni.
Ch. Restituto Arnanz t a Madrid (Spagna) a zb anni.
COOPERATORI DEFUNTI
Topino Bertogalli t a Neviano Arduini (Parma) a 33 anni.
Lo stroncava un violento attacco cardiaco mentre lavorava nel podere
di famiglia, il 23 maggio scorso. Giovane di formazione morale e religiosa perfetta, divenne presto animatore di ogni attività giovanile, con
profondo spirito salesiano, nella sua parrocchia di Neviano Arduini .
i,
i Tonino
come tutti lo chiamavano, resterà indimenticabile per limpidità di vita, zelo apostolico e spirito dì preghiera. I suoi funerali
furono onorati dalla presenza del Vescovo e del Vicario Generale della
Diocesi di Parma.
Maria Rosso ved . Gallenca t a Foglizzo (Torino) a 93 anni.
Madre esemplare di dieci figli, di cui sette ancora viventi, fu felicissima
di dare a Don Bosco il suo decimo figlio don Angelo, per il quale aveva
una predilezione particolare per la sua dignità sacerdotale.
Ricordava con esattezza di particolari le accoglienze trionfali che
Don Bosco aveva avuto nelle sue visite a Foglizzo per la fondazione
della casa.
Fino agli ultimi mesi la preoccupazione sua fu l'assistenza alla santa
Messa quotidiana nelle primissime ore del giorno: era sempre la prima
ad arrivare. Per lei era un giorno perso quello in cui non poteva partecipare alla santa Messa e fare la santa Comunione.
Nutriva una particolare devozione per il Papa ed era felice quando riceveva, tramite il figlio sacerdote addetto alla Segreteria di Stato, qualche
dono dai Sommi Pontefici Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI, che
si è ricordato di lei in occasione del XXV di Messa del figlio e in
punto di morte.
Una fede senza incrinature e mezze misure l'ha sorretta e resa invulnerabile contro ogni attacco e difficoltà della vita.
Avv. Giuseppe Gavazzo t a Vicenza a 88 anni.
Fu allievo del Collegio Manfredini di Este al quale si mantenne sempre
affezionato. Cattolico militante, copri importanti uffici nella città natale. Sulle orme di Don Bosco, fu zelatore della buona stampa. Attese
n
per oltre sessant'anni a redigere e dirigere
La Crociata contro la
bestemmia i, periodico mensile popolare, unico nel suo genere, diffuso
in tutta Italia.
Giuseppe Caraballese t a Molfetta (Bari) a 78 anni.
Un vero patriarca, aureolato da dieci figli, dei quali due sono religiose:
una Figlia di Maria Ausiliatrice e una i Ancella del Sacro Cuore*.
l'a carità che lo animava lo rese ottimista e promotore di opere buone,
in spirito di fedeltà a Don Bosco. Nei mesi di grave malattia predicò
con l'esempio piena rassegnazione alla volontà di Dio.
La Forgia Crescenzo t a Molfetta (Bari) a 8o anni.
Attivo cooperatore salesiano fin dai tempi di fondazione dell'Opera
nostra in Molfetta. Devoto di San Giuseppe, ne zelò la devozione e fu
generoso benefattore del ,' Tempio votivo » eretto dai salesiani nella
sua città in onore del Santo.
Sebastíana Belardo t a S. Teresa Riva (Messina).
Cooperatrice molto affezionata all'Unione, aveva una grande devozione
a Maria Ausiliatrice e a San Giovanni Bosco. Il 24 di ogni mese era per
lei un giorno di festa. Si diceva particolarmente felice perché il figlio
era stato educato a Randazzo dall'attuale Rettor Maggiore.
Ernesta Borreani ved. Gíberti f a Torino.
Devotissima di Don Bosco, seppe compiere con fede la sua missione
di sposa e di madre lasciando al figlio - che volle educato alla scuola
del Santo -- l'esempio di una vita intessuta di bontà, carità, rettitudine
e lavoro.
Adele Maria Mori in Doveri T a Buti (Pisa).
Di cuore nobile e generoso, edificò la sua vita nell'onestà e nella rettitudine cristiana. Trasformò i beni terreni in opere per i futuri missionari, accumulando tesori per il Cielo. Ora ha raggiunto quelli che
l'amarono e attende quelli che l'amano.
Carmela Corvino t a Napoli a 66 anni.
Cooperatrice salesiana profondamente religiosa, visse nel lavoro santificato e nel sacrificio. Rimasta vedova, prodigò tutte le sue forze per il
bene dei figli, che educò con lo spirito di Don Bosco, sull'esempio di
mamma Margherita. Amò la parrocchia salesiana del S. Cuore al Vomero . Vi si era inserita vitalmente anche con la parte attiva che prendeva alle celebrazioni liturgiche, animando il canto sacro con la sua
voce armoniosa. La lunga malattia ne purificò lo spirito e la morte
serena rivelò la sua maturità spirituale.
Rosa Turla ved . Loríní e Rosa Lorini, morte a Chiari (Brescia),
mamma e figlia, a poche settimane l'una dall'altra.
Erano di quelle anime generose che si tramandano di generazione in
generazione un ricca tradizione di fede. Rosa Turla rivive con il candore
della sua giovinezza e la laboriosità forte e tenace della sua famiglia nel
romanzo i La statua di sales del fratello Agostino. La figlia Rosa
s
alla catechesi, all'assistenza
Lorini si dedicò s con passione apostolica
ai fanciulli, al decoro della chiesa e alla preghiera.
Giustetto Lucia t a Torino a 74 anni.
Cooperatrice salesiana insieme con la sorella deceduta lo scorso anno,
per trent'anni prestò la sua opera generosa e disinteressata nei laboratori del Centro della Congregazione: i Mamma Margherita i e i San
Francesco di Sales s. Trascorse la sua vita nella pietà e nel nascondimento , dissimulando la carità che sapeva esercitare con tatto e delicatezza. Beneficò le Missioni salesiane fondando diverse Borse Missionarie, ma conservando sempre l'anonimo. Offriva le sue sofferenze
- che ultimamente erano divenute lancinanti - per la Chiesa, per il
Papa e per i Sacerdoti.
Maria Guíllaro t a Napoli a 8z anni.
Tutta la vita di questa ardente Cooperatrice e Zelatrice è stata intessuta di fede e di carità operosa. Era devotissima di Maria Ausiliatrice;
a lei con grande amore donò una sua figliuola . Piena di senso apostolico,
aiutava con gioia le opere di Don Bosco. Seppe santificare i suoi dolori
con un'intima unione con Dio. L'ultimo suo pensiero fu per Maria
Ausiliatrice e per le sue figlie.
Francesca Esposito t a Napoli a 71 anni.
Donna di esemplari virtù, amò con forte senso cristiano la sua famiglia
e quella di Don Bosco. Era Cooperatrice zelante e assidua del Centro
di via Don Bosco.
Vincenzo Buscema t a Modica Alta (Ragusa) a 84 anni.
Brillò per integrità di vita e per lo spiccato senso religioso che dimostrò nell'educare i suoi dieci figli e come primo consigliere d'amministrazione nella società Carlo Papa. Nella i San Vincenzo s e nell'Azione
Cattolica, di cui fu presidente per tanti anni, rivelò un'abnegazione
pronta, fraterna e delicata per le famiglie più povere e bisognose. Come
Cooperatore salesiano, amava e aiutava le Opere di Don Bosco e diffondeva con amore la devozione a Maria Ausiliatrice. Spirò con la
preghiera sulle labbra.
L'ISTITUTO SALESIANO PER LE MISSIONI con sede in TORINO, eretto in Ente Morale con Decreto 12 gennaio 1924, n. 22, può legalmente ricevere Legati ed Eredità. Ad evitare possibili contestazioni si consigliano le seguenti formule:
Se trattasi d'un legato: «...lascio all'Istituto Salesiano per le Missioni con sede in Torino a titolo di legato la somma di Lire... (oppure) l'immobile
sito in... ».
Se trattasi, invece, di nominare erede di ogni sostanza l'Istituto, la formula potrebbe essere questa:
32
«... Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mio erede universale
l asciando ad esso quanto mi appartiene a qualsiasi titolo».
(luogo e data)
l'istituto Salesiano per le Missioni con sede in Torino
(firma per esteso)
CROCIATA
MISSIONARIA
TOTALE MINIMO PER BORSA
L. 50.000 • Avvertiamo che la
pubblicazione di una Borsa incompleta si effettua quando il
versamento iniziale raggiunge
la somma di L. 25.000, ovvero
quando tale somma viene raggiunta con offerte successive.
Non potendo formare una Borsa, si
può contribuire con qualsiasi somma a completare Borse già fondate
BORSE DA COMPLETARE
Borsa:
Francesco Secco, chierico salesiano, in
cura del fratello Luigi (Venezia).
memoria, a
L. 30.000.
Borsa: Gesù, Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco,
in suffragio delle Anime del purgatorio, le più abbandonate, p. gg . rr . e invocando protezione, a cura
della famiglia Unia ( Genova). L. 30.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, S. G. Bosco e ven.
don M. Rua, in suffragio di Vanda Filippone ,
a cura di Pietro e Rita Stoppani (Ghemme - Novara). 1. 25.ooo .
Borsa: Maria Ausiliatrice e Don Bosco, implorando grazie e protezione, a cura di Odino Rollandin
( Ayas - Aosta). L. 30.000.
Borsa: Don Bosco, a cura di Carmela Safelice
( Sansevero - Foggia). L. 25.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, invo -
cando protezione, a cura di Beppe e Sandro Strata
(Vesime - Asti). L. 30.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, in
ringraziamento e invocando grazia, a cura di N. N.
( Como). L. 25.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. M. Mazzarello ,
in ringraziamento, a cura di Lina Reggiori (Savona).
L. 31.000.
Borsa: Gesù Sacramentato, Maria Ausiliatrice e Santi Salesiani, a cura di Francesca
Rinaldi (Castagneto Po - Torino). L. 40.000.
Borsa: Sacro Cuore di Gesù, Maria Ausiliatrice e Santi Salesiani, p. gg. rr. e invocandone
altre, a cura di Maria Ribaldone ( Omegna - Novara).
L. 25.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, invocando grazia, a cura di N. N. (Cuneo). L. 30.000.
Borsa: Don Bosco e S. D. Savio, a cura dei
coniugi Pia (Montegrosso d'Asti). L. 25.000.
Borsa: Don Pietro Berruti, a cura del dottor
Carlo Panizzi , exallievo di Alassio (Imperia).
L. 25.000.
Borsa: Papà Lorenzo, a cura di Giuseppe Pagani
(Saronno - Varese). L. 40.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, p. g. r., a cura di
Raffaele Micillo ( Calvizzano - Napoli). L. 25.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, S. G. Bosco e don
Filippo Rinaldi, in ringraziamento, a cura dei
coniugi Moretto (Torino). L. 25.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, S. G. Bosco e Santi
Salesiani, proteggeteci! a cura di M. R. (Alessandria). L. ;5.000.
Borsa: Don Bosco, in suffragio dei propri defunti,
a cura di Cristina e Alessandro Marchese (Genova).
L. 25.000.
( coxrsxva)
BORSE COMPLETE
Borsa: Maestro Giuseppe Enrico Loss-Rubin ,
in memoria e suffragio, a cura del fratello Don Giovanni Loss. L. 50.000.
Borsa: Don Bosco e Don Rinaldi, a cura di
Mario Rondolini ( Pallanzeno - Novara). L. 15.000;
Peota Bisognin Elisa (Vicenza). L. i 5.ooo ; Erminia
Facchin ( Vicenza). L. 15.000; Gisella Damiano
( Saluzzo ) L. 2500; Incoronata Gambone ( Foggia).
L, 2.000; Franca Nascimbene (Pavia) L. 1.000.
Borsa: San Giovanni Bosco e Mamma Margherita, invocando protezione, a cura di Maria
Cerutti (Asti). L. 12.000; N. N,, L. zo.ooo ;
Eugenia Magliano ( Cuneo). L. 12.000; Alda
Gullino (Savigliano). L. 4.000; Emma Pressenda
Rolfo ( Cuneo). L. 1.000; Elia Valzolgher (Trento)
L. a.ooo .
Borsa: Maria Ausiliatrice e Don Bosco, invocando protezione, a cura di Aida Barbieri (Siena).
L. 10.000; Graziella Spiganti, p, g. r. (Perugia).
L. 15.000; Maria Colombo (Varese). L. 15.000;
Pietro Massa (Cuneo). L. 5.000; Teresa Cutaia ,
p. g. r. ( Agrigento). L. 2.000; Lella e Mario
Ernesto (Torino). L. 2.000; Gabriele Perugini
( Forli ) L. 5oo ; Ersilia Damiano (Benevento).
L. 5oo .
Borsa: Maria Ausiliatrice, S. G. Bosco e S. D.
Savio, p. g. r., a cura di Fiorentina Robiano
Baldizzone (Asti), L. zo.ooo ; Antonio Fenili
( Lecco). L. 24.000; Aurelia Valesi (Varese).
L. S.ooo ; Pietro Dallapiccola ( Trento). L. 1.500.
Borsa: Don Cojazzi , a cura del dottor Angelo
Bondelli (Sassari). L. 30.000; Candida Zambelli
(Trento) L. 1 2.000; Tilde Avanzi ('l'orino).
L. 1.500; V. Macchelletta ( Frosinone). L. 5.ooo ;
N. N. (Vercelli). L. 2.ooo .
Borsa: Gli educatori al loro Santo, a cura di
N. N. 20.000; N. N. L. 30.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, Don Bosco, S. D.
Savio e S. Antonio, invocando grazia, a cura
di A. P. (Varese). L. 10.000; Can. Giovanni
Solinas (Sassari), L. 2o.ooo ; Attilia Crovini
( Torino). L. S.ooo ; Ermenegildo Brena (Bergamo).
L. i2.ooo ; Pietro Bortolato (Venezia). L. 3.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, invocando protezione,
a cura di Barberis Canonico Molina (Vercelli).
L. 25.000; Bianca Abbo (Sanremo). L. 20.000;
N. N. L. 5.000.
Borsa: San Domenico Savio, a cura di Carmela
Raiola (Torre del Greco). L. S.ooo ; Famiglia
Guerretta , invocando protezione. L. 25.ooo ; Lina
Bianchi, (Genova). L. 20.000.
Borsa: Giulia Coli, in ricordo e suffragio, a cura
del padre Onorato (Reggio Emilia). L. 1z.ooo ;
Alice Cappone, (Bergamo). L. 12.000; Giuseppe
Rossi (Bolzano). L. 1o.ooo ; Gina Colombo (Lecco).
L. 1z.ooo ; Cesarina Puppi Vietti ( Como). L. 25.000.
Borsa: San Domenico Savio, a cura di Olga
Pisotti ( Genova). L. t1.ooo ; Maria Travaglia
(Trento). L. 36.000; Vittorio Bielli. L. 2.000;
Franca Nascimbene (Pavia). L. 1.000.
Borsa: Don Bosco, a cura di Enrica Chizzola
( Trento). L. 4.000; Maria Chiri ( Torino). L. 12.000;
Luigi Casale (Varese). L. 10.000; Giovanni
Chiodini (Varese). L. 25.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, S. G. Bosco e S. D.
Savio, proteggete la mia famiglia e in special modo
la mia nipotina, a cura di E. M. (Roma). L. 50.000.
Borsa: Don Angelo Amadei , in memoria, a
cura di Guido Rizzolio ( Rivoli - Torino). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, Grazie!
proteggeteci sempre, a cura di Angela Rita Leone
( Cesarò - Messina). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e Don Bosco, p. g. r.,
a cura di Edoardo Alifredi ( Torino). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, invocando protezione,
a cura di Adriana Marcosanti (Bologna). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, S. G. Bosco e S. D.
Savio, invocando grazie e protezione, a cura di
Giuseppina Bellotti (Oleggio - Novara). L. 50.000.
Borsa: Don Angelo Amadei , in suffragio di Rita,
a cura di Italo Zucca (Torino). L. So.ooo .
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, in
ringraziamento, a cura di Matteo Olivero ( Mazzé Torino). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e Santi salesiani,
esaudite le mie preghiere, a cura di M. C. (Asti).
L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, implorando grazie, a cura di Antonio e Anna Visconti
(Cermenate - Como). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, in
suffragio dei nostri cari defunti e implorando protezione in vita e in morte, a cura delle sorelle Vergna-
no ( Chieri - Torino). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. G. Bosco, in
ricordo e suffragio dei miei genitori Giovanni e
Caterina Bertola , a cura di Carolina Bertola
( Aglié Canavese - Torino). L. 50.000.
Borsa: Sacro Cuore di Gesù, Cuore Immacolato
di Maria, confidiamo e speriamo in Voi: proteggeteci, a cura di P. G. e C. (Torino) L. 50.000.
Borsa: Sacro Cuore di Gesù, Maria Ausiliatrice,
Don Bosco e Santi Salesiani, invocando suffragio
per i defunti e protezione per i vivi, a cura di Maria
Gattoni e famiglia (Gattico - Novara). L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice, Auxilium nostrum,
a cura di N. N. L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e Don Bosco, adempiendo promessa e implorando protezione, a cura
di M. N. (Torino). L. 50.000.
Borsa: Bosio Virgilio, in ricordo e suffragio,
a cura di N. N. L. 50.000.
Borsa: Maria Ausiliatrice e S. D. Savio, a cura
di M. T. P. L. 50.000.
Borsa: Prof. Mario Biglia, a cura della moglie
Maria. L. 50.000.
Borsa: Gaetano, Clarice Marimpietri Di Marco
e Lidia Di Marco, in memoria e suffragio, a cura
dei nipoti Annarita Villani e Antonio Di Marco.
L. 50.000.
(c.suNUa )
BOLLETTINO SALESIANO
Si pubblica il 1° de/ mese per i Cooperatori Salesiani: il 15
del mese per i Dirigenti dei Cooperatori
S'invia gratuitamente ai Cooperatori, Benefattori e Amici delle Opere Don Bosco
Direzione e amministrazione: via Maria Ausiliatrice, 32 - 10100 Torino - Tel. 48.29.24
Direttore responsabile Don Pietro Zerbino
Autoriz . del Trib . di Torino n. 403 del 16 febbraio 1949
Per inviare offerte servirsi del C.C. Postale n. 2-1355
intestato a: Direz. Generale Opere Don Bosco - Torino
Per cambio d'indirizzo inviare anche l'indirizzo precedente
,
Spediz. i n abbon . postale - Gruppo 2 (70) - 1 • quindicina
a1]pO111
p 11
LIBRI COME
MONDI NUOVI
11
storia~ scienza~ narrativa
Eroi e avventure di tutti i tempi. Leggenda e storia, scienza e tecnica, mondi
che affascinano.
Miti e uomini, pianeti sconosciuti e antichi castelli medioevali : mondi diversi
da scoprire e da conoscere.
Una collana per tutti i ragazzi. Una lettura formativa per la scuola e per la vita.
Ogni volume L. 1.600
---- >< --- -
•
Spett. SEI: Speditemi contrassegno (più spese postali)
n._ copie de:
•
11191111 SEI • Società Editrice Internazionale
n. _ copie de:
Nome e cognome
Indirizzo
C.A.P.
Firma
PER ACQUISTARE I LIBRI
Compilate, ritagliate e spedite il tagliando a:
n - copie de:
•
T. Bosco, SEGRETI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA • F. Zani , GLI AVVENTURIERI
DEL FAR WEST ∎ O. Visentini , L'ARDITO DEL
CONTE VERDE • L. Wallace , BEN-HUR ∎
H. Tichy, I L BIANCO SAHIB ∎ R. L. Stevenson ,
L'ISOLA DEL TESORO ∎ A. M. Pennyless , I L
NIDO DELLE AQUILE ∎ G. Verne, I FIGLI
DEL CAPITANO GRANT ∎ F. C. M. Quilici ,
ESPLORATORI E ESPLORAZIONI ∎ A. Rutgers, UOMO O LUPO? ∎ T. Bosco, CINEMA
DEL BRIVIDO ∎ O. Visentini, 1 CAVALIERI
AZZURRI ∎ M. Twain , LE AVVENTURE DI
TOM SAWYER ∎ T. Berna, LA TESTIMONIANZA DEL GATTO NERO ∎ M. Pascucci ,
SULLA VETTA ∎ F. Molnar , I RAGAZZI DELLA VIA PAAL ∎ P. Lewis , ALCIDE DE GASPERI .
UFFICIO PUBBLICITÀ
Città
B S 19170
Casella Postale 470 (Centro)
10100 TORINO
Scarica