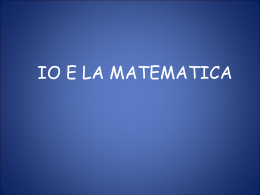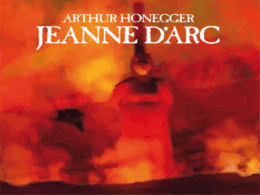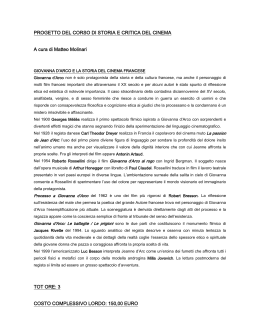VENTIQUATTRO TRASLOCHI (LA STORIA DI 74 ANNI DELLA MIA VITA) (DAL 1938 AL 2012) di Giuseppe Amato (iniziata a scrivere il 25 maggio 2012) Dediche: A Nicoletta per la pazienza che ha sempre avuto per me A Emanuele per fargli conoscere chi è stato suo padre 1 Capitolo 1 l’1 giugno1938 sono entrato a far parte di questa “meravigliosa” comunità” che è l’umanità. Non potevo sceglierne un’altra né avevo il potere fisico e psicologico di farlo. E non avevo altre alternative se non quella di rifiutarmi di nascere, il che sarebbe stato molto difficile. Ho quindi dovuto abituarmi a viverci dentro quasi come se lo avessi voluto io. I miei genitori non ne hanno colpa, anche se sono loro che mi hanno voluto mettere al mondo mescolando due tipi di DNA, di cromosomi e di tante altre particelle più o meno intelligenti, più o meno vitali. Mio padre, nato nel 1908, veniva da Agrigento, era arrivato fino a Milano come impiegato in polizia (lui diceva sempre “nell’amministrazione civile”) e intorno al 1930, dopo le avventure di D’Annunzio su Fiume e la “conquista” della Slovenia, si trasferì a Postumia dove pagavano uno stipendio più alto perché zona di frontiera, essendo il territorio allora denominato “Protettorato”. Mia madre era nata a Manzano (quindici chilometri da Udine sulla direzione per Gorizia). Mio padre proveniva da una famiglia piuttosto povera, con mio nonno da cui presi il nome di Giuseppe, mia nonna, Concetta Mamo, morta prematuramente a32 anni sembra di parto (o qualcosa d’altro, non si sa bene), un fratello maggiore di mio padre e tre sorelle rimaste per quasi tutta la vita zitelle1 (più una figlia nata dopo mio padre, Albina, morta con la spagnola nel 19, quindi a meno di nove anni). Mio nonno faceva il sarto da uomo in piazza del municipio (ho una foto dell’insegna del suo negozio) ad Agrigento dove visse fino al 1940 e morì proprio il 10 giugno mentre da Palazzo Venezia a Roma il Duce sbraitava la dichiarazione di guerra e mio padre, precipitatosi in treno per poterlo vedere ancora una volta, era rimasto bloccato allo Stretto proprio per colpa di Mussolini in quel fatidico e maledetto giorno. Mia madre faceva parte di una famiglia abbastanza agiata e numerosa, il padre era un abile falegname che però aveva contratto un mutuo con la banca locale per incrementare la sua attività. Ma la crisi del 1929 lo mise a terra: il direttore della banca, un certo Villa, fece scattare l’ipoteca sulla casa che mio nonno materno (si 1 Eufemia, la più piccola, riuscì a sposare in tarda età un vedovo anziano con quattro figli maggiorenni e morì ad Acireale. 2 chiamava Vito Danielis) aveva accettato a garanzia del prestito (o mutuo, non so) e mio nonno con tutta la famiglia dovette andarsene. Scelse Fiume da dove riuscì a mantenere la famiglia lavorando in Jugoslavia, in Serbia e in Montenegro come carpentiere. Poco tempo dopo la sua maledizione colpì il Villa che si sparò proprio dentro la casa che aveva confiscato a mio nonno, perché stracarico di debiti. Con la moglie vivevano quattro figli maschi e due femmine. Mia nonna, Lucia Maestrutti aveva partorito anche due coppie di gemelli che però morirono subito dopo nati. Dei quattro figli il maschio più giovane, Timo, con forti velleità libertine, si sposò con una “Bearzi” famiglia un po’ su a Udine ed ebbe subito un figlio che però morì di meningite a quindici anni cadendo dal fienile al primo piano della casa che ra stata di mio nonno (due palme davanti lo ricordavano) e che aveva nel frattempo ricomprato. Era l’unico che non aveva seguito il padre a Fiume. Capitolo 2 Qui devo però aprire una parentesi su quello che accadde durante la prima guerra mondiale alla famiglia di mia madre. Durante la prima guerra mondiale gli austriaci incalzavano il territorio italiano scendendo con truppe e cannoni dalla Carnia verso Udine attraverso Cividale. Tutti gli abitanti di Manzano scapparono in direzione ovest ma dovettero fermarsi al ponte sul Tagliamento dove stavano arrivando le cannonate austriache. Mia nonna con tanti figli fu aiutata dalla sorella (che oggi in Canada credo abbia dei discendenti,miei parenti): si fece carico dei più grandi perché nonna Lucia aveva mia madre ancora piccolina che stava morendo di fame e di inedia. La sorella si inoltrò oltre il ponte con i suoi figli e con i due di Lucia (Livio e Mario), mentre Lucia rimase di qua dal ponte a cercare qualcosa per Mariannina, mia madre. Un soldato si accorse e le diede otto chicchi di caffè che Lucia fece bollire in una marmitta militare per poi far ingurgitare il liquido caldo a Marianna, dopo averle aperto la bocca agendo tra i denti con una forchetta. E questo la salvò. Finito il bombardamento, anche Lucia attraversò il Tagliamento e si mise in cerca di sua sorella e dei due figli ma i due ragazzi erano scomparsi. 3 Dal racconto della sorella si doveva dedurre che fossero morti sotto un colpo di cannone e così nonno Vito si mise in cerca inutilmente presso ogni baracca o distaccamento militare. Alla fine si arrese e disse alla moglie Lucia che li avevano persi. Ma Lucia non gli credette e si mise a pregare la madonna di Monte Berico (santuario vicino a Vicenza), promettendo che avrebbe detto il rosario di notte per tutta la vita se avesse ritrovato i suoi due figli. Passarono due anni e un giorno (terminata la guerra e tornati a casa) giunse la notizia da Milano: i due ragazzi erano stati portati tra i Martinitt, una istituzione benefica che a Milano esiste ancora (vedere ad esempio il film di Zavattini “Miracolo a Milano”). Mia nonna e Vito andarono a Milano nel 1919 a riprendersi i figli, quasi incolumi (Mario aveva un occhio di vetro e aveva perso due dita, mentre Livio era senza menomazioni). E mia nonna per tutta la vita rispettò il suo voto, anche contro il parere del suo “plevan”, cioè il parroco in friulano che le diceva a novant’anni che era ora di smetterla con il suo voto assurdo. Quasi in contemporanea ad Agrigento mio padre, che aveva circa dodici anni, rischiò di morire per un colpo di pistola: aveva trovato con un suo cugino in un cassetto del grande comò la pistola a tamburo del nonno Alfonso e sparò un colpo che gli bucò la mano. Accorsero i parenti e provvidero a curarlo, oltre a dargli una lezione coi fiocchi. Perciò se io sono nato lo devo al fatto che i miei due genitori da bambini rimasero vivi per miracolo! Capitolo 3 Nel 1929 nonno Vito, per le vicenda cui ho già alluso, con la famiglia si trasferì a Fiume dove si installarono in una casa sulla collina di Kosala, sopra la città. Mentre mio nonno partiva per la Serbia e il Montenegro a fare il carpentiere, mia madre, che aveva quindici anni circa, trovò lavoro come sarta in un laboratorio. Ogni tanto andava in treno a Postumia dove la sorella maggiore, Beatrice, viveva, sposata con un ferroviere che aveva trovato lavoro in quella cittadina. Bice (diminutivo di Beatrice) aveva due figlie, la seconda era ancora allattata quando avvenne la disgrazia: il marito, Mario Verona, beveva e spesso era ubriaco. In una manovra a mano tra i vagoni di un treno merci rimase schiacciato tra i due respingenti. Mio padre, che era entrato in contatto da poco con la famiglia di mia madre riuscì a far passare la disgrazia per colpa del treno e non del manovratore ubriaco, in modo che la zia Bice ottenne la pensione. 4 Ma questo accadde molto tempo dopo. In una delle sue scappate a Postumia, mia madre partecipò con la sorella ad una festa di carnevale in cui si ballava. Durante la serata arrivava il momento del cosiddetto “ballo delle dame” in cui le donne si sceglievano il partner maschile per ballare. Fu allora che mia madre scelse un giovane che credeva seduto, tanto era basso di statura, mentre in realtà era in piedi: era quello che poi sarebbe diventato suo marito (e mio padre). Mia madre aveva un fisico bellissimo e un volto molto bello. E mio padre si innamorò subito di lei, tanto che andava spesso a Fiume e passava sotto le finestre della casa di mia madre per cercare di parlarle, ma mia madre teneva duro perché aveva saputo che era siciliano e si sentiva ancora troppo giovane per iniziare un innamoramento (almeno così mi confessò molti anni dopo!). Ma mio padre era tenace e testardo e a furia di passare ogni giorno sotto le sue finestre fischiettando il valzer con cui si erano conosciuti, allafine ottenne che si fidanzassero, anche se nonno Vito fosse contrario al fatto che sua figlia si impegnasse così presto. Una sera che erano rientrati dal cinema in ritardo per la cena, Vito sferrò un pugno sul tavolo e un “Can da l’osti!! (espressione tipicamente friulana) fece capire a mio padre chi comandasse in quella casa. Nel frattempo mio padre manteneva contatti epistolari con suo padre ad Agrigento e, tra le varie cose, aveva annunciato il fidanzamento e aveva descritto a suo padre la ragazza e la famiglia e aveva annunciato che l’avrebbe presto sposata. Per vari motivi un giorno tornò ad Agrigento per parlare con suo padre ma nonno Giuseppe gli gettò in faccia tutte le lettere che mio padre gli aveva scritto, ricordandogli che prima dovevano trovare marito le tre sorelle ancora zitelle. Mio padre ebbe una reazione emotiva molto forte tanto da ritrovarsi una paresi al viso che gli fece diventare storta la faccia. Al rientro a Postumia, dove lavorava in polizia, non osò incontrare mia madre e decise di lasciarla. Per caso la zia Bice lo incontrò e lo convinse a curarsi. Fece in modo che si facesse curare a Trieste mentre agì con dolcezza perché i due si rimettessero insieme. Mio padre, che nel frattempo si era trasferito a Lubiana per stare lontano, rientrò e finalmente nel 1937, il 12 settembre, si sposò con mia madre. Il giorno stesso partirono per la Sicilia in viaggio di nozze e la prima tappa fu la prima sera a Trieste all’Hotel Posta dove mio padre mise 5 subito incinta mia madre, dicono alle ore 22,30 /che famiglia precisa!). Io nacqui otto mesi e mezzo dopo, il giorno 1 giugno. Alla mia battuta di qualche anno fa quando insinuai a mia madre che avevano fatto la frittata prima di sposarsi, mia madre mi disse che la differenza erano solo i quindici giorni che si dicono “della “Madonna”. Io risi e lei pure. Capitolo 4 Devo tornare indietro nel tempo perché mi sono accorto che non ho citato il nome di mio padre: Narciso! Nel 1908 dare un nome così ad un figlio appena nato può sembrare strano ma non se aveste conosciuto mio nonno. La mattina del parto, il 27 marzo, poi dichiarato il 28, mio nonno stava sull’uscio di casa, una stanza unica. dove si dormiva, si mangiava e si viveva tutto il giorno. Alle spalle dell’entrata un’altro ambiente, ma sarebbe stato difficile chiamarlo stanza: senza finestre, alcuni armadi contenenti vecchi abiti ammuffiti nella naftalina, mobili ammonticchiati e un passaggio in un bugigattolo che fungeva contemporaneamente da cucina e da gabinetto Ho detto “gabinetto” e non bagno ma preferisco non approfondire l’argomento. Arrivavano molte persone per congratularsi con mio nonno, padre del bimbo appena nato. Tra questi arrivò una donna giovane che faceva la cameriera in una casa di fronte. Entrata per fare gli auguri ebbe la malaugurata idea di dire: “Né, don Peppino, lo chiamerete Salvatore?”. Mio nonno aveva intenzione di dare questo nome all’ultimo nato della famiglia, ma non poteva accettare che poi si dicesse in giro che gli aveva dato il nome suggerito da “na criata” (una cameriera). E, dopo aver detto di no col mento alzato come fanno i siciliani, disse: “Lo chiamerò Narciso”. Questo episodio come molti altri fanno capire il suo carattere (ed anche il mio, purtroppo). Ma ve ne racconto solo un altro a conferma di quello che dico. Una sera, al teatro che c’è proprio in piazza Municipio, davanti il negozio di mio nonno, dall’altra parte della piazza in discesa, durante un intervallo tra il primo ed il secondo atto di un’opera di cui non conosco il nome, passò in mezzo al pubblico l’acquaiolo. 6 Allora era uso che un incaricato arrivasse con un recipiente stagnato appeso sul davanti, pieno di acqua fresca, e con alcuni bicchieri appesi, pure di stagno o di qualche misteriosa lega che allora si usava. Potete immaginare con quale igiene. Contemporaneamente mio nonno e un altro signore del pubblico richiamarono l’attenzione dell’acquaiolo e ne sorse un piccolo diverbio su chi avesse il diritto di bere per primo. Il signore alla fine, molto gentilmente, dette la precedenza al nonno che, per lasciarlo senz’acqua, si bevve ben tredici bicchieri d’acqua. Forse così potrete meglio capire chi fosse l’uomo. A suo vanto devo ricordare che era amico di Pirandello perché frequentavano lo stesso circolo. Chiudo questa parentesi e torno al viaggio di nozze. Voi provate ad immaginare che cosa potesse provare un ragazza di ventitré anni, vissuta sempre al nord tra Manzano, Fiume e Postumia, che si trovasse all’improvviso catapultata nella Sicilia del 1937, accolta in una famiglia fortemente siciliana con tutti i pregi e difetti di un tipo di gente completamente diversa dagli italiani che abitavano al nord: è proprio vero che nel 1937 era stata fatta da tempo l’Italia (al punto da avere perfino le colonie in Africa!) ma non c’erano ancora gli italiani: al nord non sapevano nemmeno come fosse fatta la Sicilia e la Sicilia non parlava di “Italia” ma di “Continente”, espressione che si usa ancora oggi nell’isola. Mio nonno, colpito dalla bellezza di mia madre, la trattò con l’eleganza che contraddistingue l’elegante galanteria dei siciliani (vedi il comportamento del Gattopardo nel film di Visconti), ma non so nulla di come padre e figlio si parlarono allora, dopo che il nonno conobbe mia madre. Durante la loro permanenza ad Agrigento (chiamatelo, se volete, “viaggio di nozze”!) fu un susseguirsi di incontri ed accoglienze in decine di case di parenti vicini e lontani, con abbuffate cui mia madre non era abituata. Avvennero due disgrazie: la prima fu la morte della vecchia nonna Peppina, madre di mio nonno e la seconda ve la racconto dopo. Nonna Peppina era stata in gioventù l’ostetrica di decine e decine di parti ad Agrigento. Essendo molto povera, arrivava a casa di ritorno dai battesimi e relative feste con il grembiule pieno di ogni ben di Dio, che aiutava a sfamare i dodici figli che aveva. Alla sua morte, una delle sorelle di mio padre, Amalia, che sembrava avesse il compito di “storica” dei fatti della famiglia, raccontò a mia madre cosa era stata capace di fare nonna Peppina; e qui vi riporto quest’episodio. 7 Era il 1872, e mio bisnonno, Alfonso, detto da tutti “papà Affò”, aveva diciotto anni ed era guardia municipale. Alto, corporatura robusta, una figura imponente, arricchita da poderosi baffi, era molto ammirato e desiderato come un “buon partito”. Nonna Peppina aveva solo sedici canni e riuscì a farsi sposare, ma dopo tre mesi di matrimonio il marito sparì. Avevano una casetta modesta nella parte bassa di Agrigento, verso l’Addolorata, e mia bisnonna decise di tenere il segreto di questa fuga che certamente era finita da qualche parte con un’altra donna. Nonna Peppina ogni mattina andava a fare la spesa “na putia” (nel negozio dove era abituata a fare compere dal primo giorno del matrimonio e acquistava quantità come se il marito fosse presente in casa, per non destare sospetti. Teneva le orecchie aperte per cogliere eventuali notizie e la sua perseveranza fu premiata: una mattina una donna stava raccontando alla negoziante che la figlia si era fidanzata con un “bellissimo ufficiale” della gendarmeria di Agrigento, alto, i baffi che lo rendevano ancora più importante. E nel raccontare dimostrava la felicità del prossimo fidanzamento o addirittura matrimonio. Alla fine aveva aggiunto che il fidanzato della figlia era ospitato in casa, non avendo altre possibilità, anche se la cosa non era molto giusta. Come la signora uscì dal negozio, mia nonna chiese timidamente con aria sorniona alla negoziante: “Dunnè ca è?” (di dove è?)””Di Raffadali” rispose la negoziante e nonna Peppina dopo aver pagato, tornò a casa. Secondo voi, oggi una ragazza di sedici anni, anche se sposata, avrebbe fatto quello che mia bisnonna fece? Non credo! Nonna Peppina scese nella stalla, staccò la mula e la lupara appesa al muro e si avviò sulla strada per Raffadali, allora un paesaccio dove bisognava perfino stare attenti a camminare per le strade al mattino perché dalle finestre delle stanze superiori le donne svuotavano direttamente in strada il contenuto dei “cantari” (vasi per urinare di notte). Davanti ad una casa che aveva facilmente individuato con poche domande agli abitanti del paese, chiamò ad alta voce: “Affò, esci e torniamo a casa!” Più che voce fu un urlo imperioso che all’interno della casa si sentì benissimo. Dopo alcuni minuti di silenzio, dall’uscio venne fuori Affò timidamente e, senza voltarsi a salutare, seguì mogio sua moglie, che intanto si era già incamminata sulla strada di ritorno ad Agrigento, senza dire una sola parola. 8 Vi chiederete come finì la storia? Molto semplicemente vissero, forse felici e contenti, mettendo al mondo dodici figli. Affò era poi morto nel 1919 con la “Spagnola” che si era portata via anche l’ultima sorellina di mio padre “Albina”, di cui non seppi mai nulla se non che fu l’ultimo parto di mia nonna. Quando molti anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, vennero dagli U.S.A. in Italia alcuni parenti di mio padre in viaggio di piacere, conobbi un altro Amato e un altro “Mamo” che mi regalarono cinque dollari che mio padre sequestrò “per cambiarli in lire” e che non vidi più. Quando un giorno gli chiesi che fine avessero fatto i miei cinque dollari, imparai la lezione perché mi rispose: “Scrivitillo a muro e quando hai tempo leggi!” A coronamento di questa sfortuna tempo dopo ci giunse da Brooklyn una foto di due donne, evidentemente nostre parenti anch’esse, che stavano in piedi al fianco di una lapide di una tomba del cimitero americano. E mi colpì il fatto che sulla lapide era scritto in chiare lettere “Joseph Amato”. Molti anni dopo, quando andai a New York per lavoro avrei voluto ritrovare quella tomba ma non ci riuscii. E passiamo ora all’altra storia che capitò purtroppo durante il viaggio di nozze a mia madre: mio padre ebbe l’infelice idea di accontentare sua sorella Eufemia e suo padre tornando dal viaggio di nozze, portandosela dietro fino a casa a Postumia dove mia madre iniziava ad avere i primi sintomi della sua gravidanza, cioè del mio prossimo arrivo. Stava arrivando l’inverno e la zia, una donna ignorante, capricciosa, con tante voglie represse e una morale sotto le scarpe, dovette affrontare un freddo che non conosceva. Mia madre non poteva sopportarla ma per amore di suo marito taceva e inghiottiva. Ma un giorno scoprì chela zia stava nascondendo nella sua valigia sacchetti di zucchero, di pasta, di cioccolato e altre cose. Tacque fin che poté ma un giorno esplose una litigata tanto forte che mio padre, rientrato mentre litigavano per farle azzittire pensò bene di sparare un colpo in aria con la pistola d’ordinanza. Non so se prima o dopo ci fu un altro episodio ancora più grave: un giorno mia madre si vide arrivare a casa una guardia municipale che riaccompagnava Eufemia, colpevole di essere stata colta in flagrante mentre rubava un paio di calze in un negozio. La guardia disse che non procedeva all’arresto perché conosceva mio padre che era in polizia, ma raccomandava di tenerla sotto controllo. 9 Mia madre non ci pensò due volte; riempì una valigia di poche cose necessarie e abbandonò mio padre e sua sorella. Partì per Fiume a casa di sua madre portandomi in grembo già avanti nella gravidanza. Quando mio padre si rese conto, si decise a rispedire sua sorella col primo treno ad Agrigento. La sorella di mia madre che abitava a Postumia da tempo poté finalmente darle una mano e si diede da fare per riunire la famiglia. Mio padre accorse a Fiume a riprendere la moglie ma si beccò una ramanzina con i fiocchi da mio nonno Vito e da allora le cose andarono meglio. Finalmente in giugno nacqui e l’ostetrica del luogo che aiutò mia madre, vedendo che io tenevo la braccia in alto, disse a mia madre che sarei stato molto fortunato nella mia vita. Non so dire se ci azzeccò, ma da quelle parti le abitudini slave riguardano anche le predizioni che fanno le zingare, tipiche del luogo, zingare e previsioni. Era ormai ora di cambiare casa: fu il primo dei 24 traslochi che ho fatto nella mia vita; infatti io non ho radici, sono cittadino del mondo, del pianeta e di qualunque luogo mi dovesse accettare! L’ultimo sarà il cielo di Perugia dove il fumo della cremazione (stavo per scrivere “creazione”, ma basta una emme per cambiare il destino di un uomo!) salirà verso il cielo, a perdersi nell’infinito da dove forse sono venuto! Capitolo 5 Dopo aver abitato per un po’ a Postumia mio padre ottenne un trasferimento a Lubiana dove abitammo presso un anziano e gentile signore dallo stile austriaco, che chiamavamo “Papa oce”; e questo fu il secondo trasloco, cioè la terza casa abitata da noi. Ma prima io ebbi due guai: una gastroenterite che mi sono poi trascinato come conseguenze per tutta la vita e una caduta dal tavolo in cucina a Postumia su dei vetri appoggiati all’armadio. Non so quale angelo mi salvò la vista e all’ospedale locale mi dovettero dare quattro punti dove inizia l’attacco del naso all’altezza degli occhi. Ma la storia stava maturando nuovi e gravi eventi che avrebbero coinvolto anche me e la mia famiglia. Non so se per motivi di lavoro o altro mio padre decise di tornare ad abitare a Milano intorno alla fine del 1940, primi del 1941, questa volta portandosi anche mia madre e me. 10 Così ci trasferimmo in via Beato Angelico ma, non so perché, in casa di una vecchia che puzzava di pipì lontano un miglio. Di lei ricordo solo la puzza e una frase che un giorno mi disse: “Fin quando non riuscirai a pisciare a muro non sarai un uomo”. Forse mio padre in quei mesi aveva avuto sentore che le cose stavano radicalmente cambiando in Europa; ecco perché decise di trasferirsi a Milano. Ma ci rimanemmo poco tempo: mia madre era nuovamente incinta e credo avesse bisogno e desiderio di avere aiuto da sua sorella a Fiume. E questo fu il quarto trasloco della mia vita. I miei genitori decisero di trasferirci ancora a Kosala, a casa di nonno Vito. Nel frattempo mia madre nel settembre del ‘42 a Kosala partorì mio fratello Gianfranco. Sto cercando di ricordare il pancione di mia madre ma non ho immagini in memoria. Invece ricordo come padre e madre mi fecero rimbalzare dall’uno all’altra quando chiesi loro cosa volesse dire incinta, anche se conoscevo bene il significato della parola. Eravamo tutti fuori nel vialetto che portava ala casa ad aspettare e, quando arrivò l’ostetrica con la borsa dei ferri, mia zia mi disse sottovoce che mio fratello era dentro quella borsa. Io finsi di crederle e attesi. Purtroppo mia madre, tra il parto, la lontananza dal marito, le cognate che la ossessionavano con troppe pretese come se fosse ancora la ragazza che era costretta a lavare e stirare per i fratelli e relative consorti, non riusciva più a vivere a Kosala. Ricordo una domenica pomeriggio, d’estate, nel silenzio e nel caldo, che uscivamo dalla casa attraversando il corridoio, mia madre con in braccio Gianfranco e in mano una valigia e io di fianco che mi chiedevo cosa stessimo facendo. Fu così che ci trovammo a vivere giù in città dalla zia Bice fino all’agosto del 43. Era il mio quinto trasloco. Ricordo che andavamo ad Abbazia (oggi Opatia) a fare i bagni e nei miei ricordi non è mai scomparso il profumo delle alghe a riva tra gli scoglietti o quello della marmellata sul pane. Ancora ricordo la figlia minore di Bice, Mariolina che, addentando un pezzo di pane con la marmellata, non si era accorta della vespa che si era posata golosa sulla fetta di pane. E Mariolina subì una puntura dolorosissima sulla lingua che la afflisse per giorni e giorni. Era il periodo in cui i ferrovieri venivano a farsi fare il bucato da mia zia e si fermavano ad ascoltare la radio che trasmetteva i messaggi di radio Londra per i nostri partigiani. 11 Ricordo che avevamo le finestre oscurate anche di girono di carta blu scuro. Io allora non capivo niente ma ero impressionato dai racconti e dalle corse in rifugio. Purtroppo erano iniziati i bombardamenti e all’urlo della sirena dovevamo uscire di casa e correre a rifugiarci, con le borse già pronte vicino all’uscio, nel tunnel della ferrovia che allora attraversava il viale principale di Fiume. Era un’immagine terribile che ancora ho negli occhi: lungo i binari, illuminati da una luce fioca che scendeva dal tetto del tunnel, erano allineati in silenzio e avvolti in un lenzuolo bianco, i matti del vicino manicomio. E noi dovevamo camminare tra loro e i binari per sistemarci più in giù tra altre persone “normali”. Lì si rimaneva fin che la sirena non urlava il cessato allarme. Mio fratello (aveva meno di un anno) subì tutte le conseguenze di una vita tesa e nervosa, aveva i vermi e mordeva tutti per una rabbia di dentro improvvisa che io non capii mai. Cercavo di giocare con le bambine sotto il portico e avevo la figlia maggiore di Bice, Jole (che è ancora viva ed abita oggi a Manzano) che mi faceva da balia e aiutava così mia madre. Ricordo il “suff”, una specie di piatto di semolino con il latte: l’unico cibo che avevamo e che ovviamente consideravamo un miracolo averlo a disposizione. Ma gli eventi precipitarono: nell’agosto del 43 un bombardamento micidiale distrusse quasi tutte le case di Milano e i miei genitori, uno indipendentemente dall’altra partirono per Milano (mio padre da Postumia e mia madre da Fiume) per capire se era rimasto qualcosa della casa dove avevano lasciato le loro poche cose. La casa non era stata distrutta ma mio padre dovette minacciare il custode che si era impadronito di molti oggetti nostri, approfittando del fatto che aveva le chiavi di casa. Il bello è che i miei genitori, partiti da luoghi diversi si ritrovarono sotto casa a Milano quasi contemporaneamente. Si organizzarono e portarono via tutto quello che poterono. Mi raccontavano che a Treviso dovettero scendere perché il treno si era fermato in aperta campagna perché aerei militari si erano gettati a mitragliare tutto e tutti. I miei passarono la notte in una locanda vicina trovata per fortuna; nella stanza dove avrebbero voluto dormire, passarono tutta la notte a lavarsi la fuliggine dai loro corpi. Il giorno dopo il treno ripartì ma a questo punto mio padre costrinse mia madre a rifugiarsi ancora una 12 volta a Manzano con noi due figli. Ci sistemò presso una bella friulana, Gemma, di cui ricordo ancora le prosperose tette. Era il sesto trasloco della mia vita. Fu in quei giorni che dovetti assistere ad una cosa che non avrei mai immaginato. Avevo cinque anni ma le scene che vidi sono ancora vive nella mia memoria: Gemma allevava una preziosa oca (per quei tempi veramente preziosa) e la nutriva con un aggeggio come un frullino a mano con cui la ingozzava di semi di mais costringendola ad ingoiare. Ma un giorno giunse il momento di uccidere l’oca perché non avevamo altro e Gemma tagliò la testa all’oca e accadde la scena terribile di vedere l’oca senza testa che correva per il cortile sbandando non avendo né la testa, né gli occhi e nemmeno il cervello. Scappai spaventato. In quei giorni si saliva nel solaio che aveva delle piccole finestrelle dalle quali osservavamo i bombardamenti nel vicino paese di Buttrio. Capitolo 6 E arriviamo all’8 settembre 1943! Mio padre era a Postumia, in divisa della polizia che allora era militarizzata. Alla radio sentì l’annuncio dell’armistizio a Cassibile (Siracusa) e si sarebbe trovato nei guai se non avesse preso una decisione rapida. In bicicletta, con due pistole e due macchine fotografiche si avviò a nord, dopo essersi tolta la divisa, col progetto di rientrare in Italia attraverso l’Austria. Ma nella notte in un bosco scoprì di essere vicino ad un gruppo di titini (partigiani jugoslavi che furono poi autori di stragi di italiani e di morti nelle foibe), più pericolosi dei tedeschi che ormai erano diventati nostri nemici. Sparò un colpo di pistola in aria; i titini fuggirono da una parte e mio padre da un’altra, così poté proseguire e dopo un lungo giro ci raggiunse a Manzano da dove partimmo per rientrare a Milano definitivamente. Era l’autunno del 1943. E a Milano tornammo nella vecchia casa di via Beato Angelico: era il settimo trasloco della mia vita. Qui passammo alcuni mesi, con un muro aperto sulla strada sottostante che provocò a me bronchite ma a Gianfranco una seria broncopolmonite. Capitolo 7 E da questo momento incomincia la storia delle nostre peregrinazioni in diverse case di Milano: 13 Dopo via Beato Angelico, a fine 1943 in via Amedeo fino al 1946 (ottavo trasloco) In via Morgagni al 37 dal 1946 al 1948 (nono trasloco) In via Telesio dal 1948 al 1951 (decimo trasloco) E, finalmente, nell’estate del 1951 una prima volta in un appartamento in affitto tutto per noi: in Largo Boccioni, oggi all’inizio del Bronks, come viene chiamato il quartiere malfamato di Quarto Oggiaro (undicesimo trasloco). Nell’estate del 2011 ho deciso di fare un viaggio a Milano (da molti anni ormai abito ad Assisi) per filmare e fotografare dall’esterno le case in cui abbiamo abitato in “coabitazione” dal 1941 al 1951. Spiego: durante la guerra le case bombardate a Milano erano molte e c’era bisogno di alloggi. Nacque il “Commissariato alloggi” che attribuiva a coloro che erano senza casa una coabitazione con altre famiglie in uno stesso appartamento se c’erano locali sufficienti. Mio padre si diede da fare e la prima casa dopo via Beato Angelico fu in fondo a Via Amedeo (all’Ortica, quella cantata molti anni dopo da Jannacci), l’ultima casa della via che era separata dalla ferrovia che passava alla fine della via da un bel prato irrigato con lunghi canaletti sempre pieni d’acqua. In fondo alla via c’era un ponte che passava sotto la ferrovia e portava in una vasta area chiamata “Smistamento” dove giacevano su decine e decine di binari molti carri merce. Lì subimmo molte corse in rifugio (in realtà era la cantina) durante molti bombardamenti fino al 25 aprile 1945. Di giorno spesso mia madre con altre donne del quartiere si recava a “Smistamento” dove riempiva delle borse di fortuna di carbone coke con il quale ci si scaldava. Non capisco come mai mio padre non solo non ne sapesse niente ma nemmeno si preoccupava di sapere da dove arrivava quel carbone (forse faceva finta?). A volte le andava bene ma qualche volta, o era uno schiaffo del tedesco di guardia o era una sventagliata di mitra in mezzo alle rotaie dei vagoni e vicino alle gambe, doveva tornare a mani vuote. Una volta tornò a casa con la faccia gonfia e rossa per una sberla di un militare e non so quale scusa inventò per mio padre. E passiamo ad altro: Dalla finestra si vedeva il gasometro a meno di un chilometro al di là della ferrovia e in pieno giorno più volte un aereo, un cicognino degli inglesi arrivava a bombardarlo per farlo incendiare. Per fortuna non riuscirono a farlo esplodere, altrimenti avremmo fatto una brutta fine. In quei giorni però un bombardamento disgraziato fece una strage alla scuola elementare di Gorla dove morirono circa trecento bambini. 14 La mattina dopo ero in strada accanto a mia madre che ne parlava con le vicine. Osservavo i fili elettrici del tram in aria e attribuivo i fiocchi bianchi attaccati ai fili (materiale tipo cotone che ricordavo di aver visto nelle finestre della vicina scuola dove avevo incominciato a fare lo scolaro e dove le finestre venivano oscurate proprio con una specie di bambagia bianca per nascondere la luce di sera quando le suore proseguivano la loro attività di preghiera dopo che eravamo tornati a casa). E nella mia mente di bambino pensai che quei fiocchi arrivavano dalle macerie della scuola di Gorla, portati dal vento e rabbrividivo pensando a quei miei coetanei. Le discese rapide in rifugio rispettavano una procedura sempre uguale: mio padre, ci accompagnava giù in cantina, portandosi una borsa con le cose essenziali e una torcia a manovella che si accendeva appunto continuando a schiacciare una leva per azionare una specie di dinamo. Insieme agli altri abitanti della casa ci sedevamo sulle panche messe lì apposta e, mentre le donne iniziavano la recita del rosario, i maschi o giocavano a carte o discutevano sulle vicende della guerra, dei tedeschi, di Mussolini e dei fascisti, delle tessere annonarie con le quali era permesso acquistare il pane e lo zucchero in dosi limitate. Il fischio acuto precedeva l’esplosione e subito si rimaneva al buio e in silenzio in attesa, sperando che la bomba cadesse lontano. Una notte ci sembrò che crollasse la casa ma era una bomba che aveva colpito la casa di fronte a noi dall’altra parte della via: tutti morti. Però due vecchietti che vivevano in una capannina dietro la casa distrutta, erano rimasti illesi e vivi: strane coincidenze della vita. Ricordo un episodio divertente: una sera, un allarme improvviso arrivò mentre mio padre era seduto sulla tazza del gabinetto; si pulì, prese il rotolo di carta igienica, e si precipitò in cantina con noi. Seduto sulla solita panca, era convinto di avere in mano la pila a dinamo e continuava schiacciare la carta igienica fin che gli fecero notare che non era la pila: imbarazzo prima e risate dopo che sollevarono un po’ lo spirito ai presenti. Mia madre non scendeva mai in rifugio: “non voio morir come un topo!” diceva e rimaneva in casa a pregare. Raccontare queste cose oggi mi sembra naturale ma spero che spaventino abbastanza chi leggerà per capire che cosa significa la guerra che in molte parti del mondo ancora oggi distrugge uomini e case. Si mangiava poco e si usava spesso un fornello elettrico sul quale si scaldava l’acqua per la pasta (quando c’era). Ricordo come oggi un venerdì santo in cui mio padre era riuscito a procurarsi una scatoletta di acciughe. Per noi era una grande festa e stavamo pregustando gli 15 spaghetti che avremmo condito con le acciughe, quando la resistenza del fornello su cui stavano cuocendo gli spaghetti si ruppe e dovemmo attendere che il filamento si raffreddasse per poterlo ricollegare e proseguire la cottura. Ricordo che mangiammo tutto gustando una specie di colla di pasta, ma la fame era fame! A Milano in vari quartieri erano sorte delle mense di legno dove si poteva andare a mangiare con pochi soldi o con dei buoni (forse i primi buoni pasto aziendali?) che venivano dati ai bisognosi. Mio padre riceveva una piccola dose di questi buoni e ogni tanto si andava in tram a mangiare in una di queste mense, sita in fondo a viale Tunisia, davanti alla piscina Cozzi. Mio padre chiamava il “pidocchietto” la mensa per l’odore sgradevole che si sentiva dentro. Eppure si mangiava un “succulento” passato di ceci o di piselli, dal gusto anonimo. Qualche volta una fetta di mortadella ci rallegrava e ricordo che una volta avevo tanta fame che chiesi a mio padre se potevo avere un buono per una seconda porzione di mortadella: potete immaginare di che cosa fosse composta ma per me fu buonissima e ne ricordo ancora il gusto. Un giorno che stavamo andando in tram io a voce alta chiesi a mio padre: “Andiamo al pidocchietto?”. Lo sguardo degli altri passeggeri si concentrò su di me, mentre mio padre e mia madre con mio fratello e me ci avvicinammo alla porta d’uscita vergognandoci come bestie, per scendere appena il tram si fermò alla sua prima sosta e proseguire a piedi. Evitai d’un pelo una sberla di mio padre. Sul momento non capii ma la successiva lavata di capo mentre raggiungevamo il “pidocchietto”, pardon, la mensa, da parte di mio padre mi insegnò che noi eravamo evidentemente più poveri degli altri passeggeri sul tram. Una volta, proprio mentre il tram n. 22 stava arrivando al capolinea, che era dopo i prati dietro casa nostra, sentimmo degli spari. Il tram si fermò e aprì le porte. Mio padre ci urlò di scendere e di buttarci di corsa distesi nel prato. Feci in tempo a vedere vicino al ponte due uomini che, distanti tra loro meno di venti metri, si sparavano con delle pistole. Vidi cadere in terra uno dei due prima che mio padre mi mettesse la mano davanti agli occhi per non farmi vedere. Restammo così per un po’ di tempo ma dopo essere rientrati in casa mio padre non volle rispondere alle mie domande; così non seppi mai che cosa fosse successo; oggi posso pensare che era un partigiano che sparava ad un fascista e viceversa, ma non di più. Una mattina dalla terrazza dove abitavamo al terzo piano ne vidi ben altri che si sparavano col mitra dagli angoli delle strade sotto di noi: erano i giorni della confusione e io ascoltavo di nascosto episodi che 16 mio padre, lavorando in questura, veniva a conoscere di giorno in giorno. Capitolo 8 Il 22 aprile 1945 mio padre, come ogni domenica mi portò a messa in Duomo; all’uscita, forse anche perché sapeva già qualcosa che aveva saputo nei corridoi della questura, mi portò verso la galleria e all’improvviso, vedendo molta folla che si precipitava dalla piazza per qualcosa che stava accadendo, mi trascinò gridandomi “corri!” e alla fine, per farmi vedere meglio, mi mise in groppa sulle spalle e, mentre entrava nel braccio orizzontale della Galleria, mi gridò: “Sta per passare un uomo su un carro blindato; guardalo bene perché lo vedrai per l’ultima volta nella tua vita” Era Mussolini; lo vidi impettito in piedi che salutava militarmente la folla che era accorsa, mentre il blindato deviava per via Tommaso Grossi. Aveva ragione mio padre: alcuni giorni dopo fu ucciso sul lago di Como insieme alla Petacci. Avrei voluto farmi portare in piazza Loreto ma mio padre me lo vietò tassativamente per non farmi impressionare da quei corpi appesi e offesi dai passanti increduli. Il 24 aprile eravamo tutti scesi in strada ed aspettavamo davanti al portone l’arrivo annunciato ma non sapevo di chi, quando vidi arrivare dal centro città una specie di colonna militare: erano partigiani a piedi, il mitra a tracolla, preceduti da una moto Guzzi con sidecar su cui un graduato in piedi, con una bandiera a fianco che sventolava, stava ritto nel saluto militare, impettito e tronfio perché (così mi disse mia madre) stava andando oltre il ponte a Smistamento per far arrendere i militari tedeschi che erano lì accampati. Dopo oltre un’ora la colonna di partigiani tornò ma questa volta erano mesti e in silenzio mentre all’andata suonavano squilli di tromba: i tedeschi si erano rifiutati di arrendersi, affermando che lo avrebbero fatto solo con gli inglesi: temevano atti assurdi da parte dei partigiani che avevano grande fame di vendetta. Ed infatti alcune ore dopo arrivarono i carri armati inglesi seguiti a piedi dai tedeschi che si erano arresi e passavano davanti a noi con l’onore delle armi e volti di ragazzi giovanissimi emaciati e pieni di fame e di divise sporche. Ho ancora negli occhi lo sguardo pietoso di uno di quei ragazzi che mi fissò in volto come fossi stato suo fratello, ma doveva avere pochi anni più di me. 17 Mia madre mi strinse a sé e si voltò per rientrare a casa: stava piangendo per la tristezza nel vedere quei ragazzi o per la gioia nel rendersi conto che finalmente la guerra era finita? Capitolo 9 Nella casa dove abitavamo la vita ritornò piano piano normale ma un giorno in agosto mio padre che era sceso nel pomeriggio per andare a lavorare, tornò in casa con una lettera destinata a mia madre. Era del fratello Giovanni che era stato preceduto da un telegramma che non era mai giunto e iniziava dicendo: “Dopo la dipartita del nostro caro papà ….” Mio nonno Vito era morto il 23 luglio all’ospedale di Udine un’ora dopo che mia nonna era tornata a casa a Manzano. Ricordo mia madre distesa sul letto, a faccia in giù, che piangeva e piangeva. E mio padre cercava inutilmente di consolarla. Non ho quasi mai parlato di mio fratello; nel 1945 aveva tre anni e io dovevo essere il suo angelo custode perché era una peste. Un pomeriggio scesi per andare a giocare nel prato di fianco a casa ma, appena in strada, mentre mio fratello correva verso il prato, vidi nella strada di fronte a noi un gruppetto di curiosi che circondavano un carro armato posteggiato per metà sul marciapiede. Mi avviai per vederlo anch’io, affascinato e dimenticandomi completamente di mio fratello, perché non avevo mai visto da vicino un carro armato vero, anche se a Fiume avevo avuto un carro armato di legno (questi erano i giocattoli in tempo di guerra) che sparava proiettili di legno con un’apposita molla e un grilletto. Rimasi a guardarlo per un certo tempo e quando tornai a casa mia madre mi chiese: “E tuo fratello?” Mi sembrò che mi crollasse il mondo addosso e mi precipitai in strada inseguito dai rimproveri che mia madre mi stava urlando. Io non ricordo se ciò che vidi fu vero o no ma ho uno strano ricordo: il prato, che era di una fattoria che oggi non c’è più perché sostituito da case alte una decina di piani, era solcato da una serie di piccoli fossi in cui l’acqua era alta forse trenta/quaranta centimetri. Io ricordo, ma ripeto, non so se è vero o fu la mia immaginazione, vidi mio fratello dentro il fosso a testa in giù e le gambe per aria. Feci in tempo a estrarlo dall’acqua e lo riportai a casa. Era bagnato fradicio (e questo era vero) e presi tane sberle da mia madre mentre mi sgridava ed io scomparivo dentro il mio io, pensando di essere colpevole di aver rischiato di far annegare mio fratello. 18 A circa duecento metri dalla nostra casa c’erano case a suo tempo costruite per i ferrovieri e in una di queste, che aveva un ampio cortile nel centro del caseggiato una sera avevano organizzato una festa da ballo con musica. Io stavo dormendo e non mi accorsi di nulla e i miei genitori fecero una delle più grosse fesserie della loro vita: decisero di scendere a ballare, anche se per pochi minuti ma non mi avvisarono. Sarà stato il sesto senso o più semplicemente il suono della musica che arrivava dalla strada, avvenne che mi svegliai di soprassalto e non trovando in camera da letto i miei genitori mi spaventai. Dopo un po’ d’incertezza, mi decisi, svegliai mio fratello, ci vestimmo e scendemmo in strada. Seguendo il suono dei balli ci avviammo in quella direzione ed entrammo nel cortile dove rimanemmo a vedere la coppie che ballavano. Ad un certo punto scoprimmo i miei che stavano volteggiando in un valzer, spensierati. Ma quando ci videro si spaventarono, interruppero la danza e ritornammo tutti e quattro a casa. Non ricordo esattamente che cosa mi dissero ma cercarono di dire qualcosa per giustificarsi e cercando di rimproverarci per la nostra imprudenza. Secondo loro avremmo dovuto rimanere a casa a dormire: fu il colmo e io non parlai, ma ho ancora chiaro il ricordo dello spavento subito, perché un bambino a sette anni, reduce da tanti avvenimenti della guerra, poteva essere più sensibile a certe sorprese. I Gravina: lui era collega di mio padre e lei era la seconda moglie, sorella della prima, morta prematura, lasciando Pasquale Gravina vedovo con tre figli, Lucio, Anna e Rita. Con la seconda moglie era nato Edoardo, più piccolo di me, che tutti chiamavano Ado. Spesso si andava a casa dei Gravina che abitavano vicino in via Aselli e, insieme ad altre famiglie amiche, si cercava di passare ore liete e di divertimento, per cacciare dalla mente il ricordo delle brutture della guerra e perché non avevamo altro con cui divertirci. Allora non esisteva la TV e non si andava al cinema molto spesso perché avevamo pochi soldi. 19 Capitolo 10 Ed arrivò il nono trasloco: da via Amedeo in via Morgagni, una parallela del più noto Corso Buenos Aires, all’angolo con via Ozanam e piazzale Bacone. La causa fu la richiesta del proprietario di via Amedeo, un collega/amico di mio padre, un certo Fiorillo che aveva bisogno dell’appartamento per le sue sorelle che dovevano venire su dalla Sicilia Mio padre dovette rivolgersi al Commissariato alloggi, dove si recò portando dietro moglie e figli per impressionare meglio gli addetti. Ci concedettero la coabitazione in casa di un medico, dott. Morandi, fratello di un noto onorevole socialista, che viveva con moglie e figlia già zitella. Aveva un altro figlio ma era in Russia, dove si era sposato con una ragazza del luogo. A noi furono riservate due stanze, una per viverci di giorno e una da usare come camera da letto. Fu una buona sistemazione e traslocammo rapidamente da via Amedeo, rimanendoci per due anni fino al 1948. Ho molti ricordi di quei due anni, ma cito solo i più importanti. L’appartamento era abbastanza vecchio e le stanze ampie. Si viveva nella stanza che dava sul cortile, dove a pianterreno stavano avviando un nuovo ristorante: Il Coccodrillo. Io frequentai per un certo periodo una scuola privata ma finalmente fui iscritto alla “Stoppani” che però, avendo subito danni durante la guerra, era stata trasferita come uffici e aule in piazza Leonardo da Vinci, proprio davanti al Politecnico, in una traversa di viale Romagna. Mi ricordo il tragitto giornaliero con mia madre e la sosta all’edicola della piazzetta Carlo Erba dove sorgeva la sede dell’omonima industria farmaceutica e si incrociavano due diverse serie di binari di tram. Allora la mia passione era Salgari, ma avere un libro delle edizioni Carroccio era un regalo raro. Avevamo in comune il bagno con la famiglia del dottore e a volte c’erano piccoli scontri sul suo uso. Una volta sentii mia madre che raccontava a mio padre ridendo che la “vecchia” aveva attraversato il corridoio centrale (piuttosto grande) di corsa, perdendo la cacca sulle piastrelle del pavimento perché aveva forse la diarrea. Fu in quell’epoca che fui colpito da una forma antipatica di itterizia (una specie di epatite). Non so se per questo o per altri motivi, durante l’estate andammo in ferie a Venezia ed abitare presso dei lontani parenti di mio padre: lui 20 era siciliano, la moglie di Milano e le due figlie (Concetta e Aurora) nate a Venezia e ormai grandicelle. Ma non ricordo che ci fosse molta simpatia tra me e le due bambine. Andavano ogni giorno al Lido a fare i bagni ma io rimanevo a casa, non so se per l’itterizia o cosa, con il lontano parente di mio padre che veniva a casa dal lavoro solo per il pranzo, servito da una vecchia che non ricordo se fosse la madre della moglie o una cameriera. Ricordo che mangiavo sempre riso in bianco condito con il prezzemolo. In un momento di allegria una sera mia madre con la lontana parente vollero recarsi in un locale dove finalmente dopo le tristezze della guerra si ballava ed erano presenti molti militari americani. C’eravamo anche io e mio fratello. Ad un certo punto un americano invitò a ballare mia madre che, dopo un po’ di ritrosia, accettò e ballò molto volentieri perché sapeva ballare bene e il ballo le piaceva molto. Mentre rientravamo a casa, mia madre raccomandò a mio fratello (era ancora piccolino ma furbetto) di non dire nulla a mio padre. Cosa che Gianfranco invece fece appena sceso dal treno alla stazione di Milano, di ritorno da Venezia. Per la mia itterizia, mio padre, per non chiedere l’intervanto del dott. Morandi (non so perché) aveva chiamato un altro medico. Appena nella camera da letto, pretese un cuscino per inginocchiarsi vicino a me per visitarmi ed auscultarmi. Per lui avevo una forma di reumatismo da curare con rinforzi nel cibo, specialmente uova. Mia madre, non convinta chiese al dott. Morandi una visita e così si scoprì che io non volevo mangiare perché non potevo avere fame a causa dell’itterizia. Mio padre restò mortificato perché a causa della diagnosi del medico ignorante mi costringevano a mangiare uova (cibo deleterio per chi ha una forma di itterizia o di epatite). Spesso mia madre usciva o per le spese o per portare i suoi lavori ad un sarto di cui non so nulla. Mio padre era al lavoro e così io rimanevo in casa da solo con mio fratello che aveva quattro anni circa. Per riscaldarci avevamo una “parigina” (così si chiama una piccola stufa che va a legna o anche a carbone). Io mi sedevo vicino per scaldarmi mentre leggevo Salgari. Un pomeriggio mia madre si era procurata uno di quei recipienti di latta che gli americani usavano per conservare il prosciutto cotto di forma quadrata, adatto per i toast. Il recipiente, alto circa trenta/quaranta centimetri era ancora pieno di grasso e mia madre pensò bene di metterlo sulla parigina pieno d’acqua per far sciogliere il grasso con il caldo. 21 Ad un certo punto mio fratello, agitato e ribelle come sempre, si lanciò di corsa e credo che inciampò provocando una paurosa oscillazione della stufa. Mentre il tubo di scarico dei fumi crollava dall’alto, cadendo a terra con un forte fracasso, il contenitore oscillò tanto da rovesciarsi. D’istinto feci in tempo a sollevare da terra mio fratello salvandolo da scottature certe di acqua bollente e ad alzarmi su un piede, ma su uno solo! L’altro fu colpito dall’acqua bollente e subii una forte scottatura. Mia madre, rientrata poco dopo, spaventata per il disastro, cercò di strapparmi la pantofola friulana dal piede, ottenendo di strapparmi la pelle aggravando così la scottatura. Risultato: la scottatura divenne più grave e il giorno dopo una grande bolla si era formata sul piede mentre io me ne rimanevo dolorante a letto. Ci fu l’intervento del dottor Morandi e le conseguenze me le porto ancora oggi: sul piede destro ho una grande cicatrice. La notte di Natale, di nascosto uscii dal letto a scoprire i regali che i miei genitori avevano preparato dicendomi che sarebbero stati portati da Gesù Bambino. E io, per continuare a ricevere i regali, continuai a far finta di credere alle loro bugie, così mi andò bene per altri due anni. Finalmente la scuola “Stoppani” riprese a funzionare ed io andavo in terza elementare nella sua vecchia sede in fondo a via Morgagni, piazza Lavater. Ricordo ancora il nome della mia maestra che mi voleva molto bene perché ero il primo della classe e il più disciplinato: la maestra Beneducci. In una traversa, via Francesco Redi, c’era l’oratorio dove una volta di notte sognai che sopra la porta addobbata in viola era seduto ghignante il diavolo: mi stavo preparando per la prima comunione e ci avevano terrorizzato con le storie sul diavolo e sui peccati. Strana coincidenza: 64 anni dopo circa mio figlio Francesco frequentava la sede di una importante On Lus, la Action Aid, proprio in via Redi. Ma in quell’epoca l’episodio più importante fu vedere la morte in diretta di un povero ciclista: aveva affiancato un camion con rimorchio in curva, ma aveva forse perso l’equilibrio ed era finito sotto i doppi pneumatici del rimorchio. Ricordo ancora il suo urlo agghiacciante mentre rotolava intorno ai pneumatici rimanendo poi in mezzo alla strada senza vita, la bici maciullata. Non ebbi il coraggio di avvicinarmi e scappai a casa piangendo da mia madre. Tempo dopo il dottore si ammalò (aveva tra l’altro uno studio molto importante dietro la Scala) e fu colpito da una broncopolmonite molto 22 grave. La moglie, prima sempre astiosa con mia madre, questa volta divenne dolce e premurosa: la pregò di recarsi non so dove a sud di Milano e mia madre dovette andare in bicicletta a ritirare una delle prime confezioni di penicillina (si otteneva credo solo di contrabbando ed era molto difficile averla) in una località a me sconosciuta, portandosi in tasca la somma per allora enorme, di ben cinquecentomila lire! Il dottore guarì e ci fu riconoscente ma tornò dalla Russia l’altro figlio con relativa moglie che sembrava più un’abitante della Mongolia per i tratti somatici. Aveva questa donna una strana abitudine: si ricopriva la faccia di burro per mantenere, così disse a mia madre, la pelle lucida. Il loro arrivo provocò la necessità di lasciare loro i locali e quindi di trovare per noi una nuova casa e così avvenne il decimo trasloco. Capitolo 11 Grazie ad informazioni presso il commissariato alloggi nel 1948 mio padre ottenne in affitto un appartamento che era vuoto, di proprietà di un avvocato, un certo Colli, in via Telesio, una traversa di via Mario Pagano, un quartiere piuttosto lussuoso della zona Magenta. Al n. 14 a pian terreno ottenemmo un appartamento di due grandi stanze con finestre su strada, più una cucina che dava sul cortile interno e un grande bagno. C’era ancora una stanza ma era rimasta chiusa a chiave perché il proprietario volle conservarla per sé. Per alcuni mesi vivemmo in un appartamento tutto per noi e ci sembrò di rivivere. Mia madre poco prima del trasferimento aveva ricevuto in regalo una bella gattina nera alla quale eravamo tutti affezionati e la chiamavamo Tuli, ma il portinaio, un essere spregevole, approfittò un giorno che la gattina in cui si infilò nella cantina dalla parte del cortile, per avvelenarla. Mia madre pianse calde lacrime ma mio padre non volle più animali per casa e non fece nulla contro il portinaio perché non avevamo prove che fosse stato lui. L’appartamento doveva aver ospitato o degli ebrei o una qualche setta orientaleggiante perché la stanza che usavamo per mangiare aveva nell’aria uno strano profumo denso simile all’incenso e sulla parete sopra una specie di alcova che poteva ospitare un letto erano rimaste le impronte di strane lettere che potevano assomigliare a caratteri dell’alfabeto ebraico. 23 In autunno incominciai la scuola in fondo a via Pagano, esattamente in via Rasori a pochi passi dal luogo in cui alcuni anni dopo fu ucciso proditoriamente il commissario Calabresi. In fondo a via Telesio si apriva al di là della via Pallavicini, un’enorme superficie cosparsa di macerie di mattoni e muri di un precedente scalo ferroviario, lo scalo Sempione, distrutto dai bombardamenti in tempo di guerra: era il nostro regno dove sfogavamo la nostra voglia di giocare alla guerra. Avevamo inventato la nostra banda, la banda della dea Kalì, contro quella che avevano i ragazzi della vicina via Alberto da Giussano. Lì fingevamo di combattere nella giungla e spesso ammiravamo un barbone che si metteva a torso nudo, dietro un grosso avanzo di muro di mattoni alto quasi due metri, a cuocere con un fuocherello dei pezzi di profumata cotenna di prosciutto che costituivano il suo pasto. L’idea ci venne alcuni giorni dopo e, dopo aver raccolto alcuni pneumatici di bicicletta abbandonati, demmo loro fuoco e correndo da via Giotto in su incendiammo tutte le sterpaglie che calpestavamo correndo verso la via Vincenzo Monti. Non so come mai non combinammo qualche guaio. Mia madre aveva trovato lavoro: faceva pantaloni per un sarto che abitava in via Washington, oltre piazza Piemonte e io spesso dovevo fare la spola tra casa e il sarto. Approfittavo per attraversare il prato incolto e pieno di macerie percorrendo un sentierino naturale che si era formato nel frattempo e che nella mia immaginazione di ragazzo pieno di sogni immaginavo essere un grande fiume africano che attraversava una giungla. Con la mia fantasia riuscivo a immaginare avventure meravigliose che davano un senso positivo al tempo che dovevo dedicare a quell’incombenza. Fu un periodo felice della mia vita anche se poco tempo dopo l’avvocato affittò la stanza chiusa ad una coppia di sposini, i signori Piazza. Lui lavorava alle cartiere Binda e mi regalava spesso dei quaderni per i miei compiti scolastici e lei era già incinta e divenne molto amica di mia madre. Il figlio, che chiamarono Celio, nacque in quella casa e sembrava che fosse nato Gesù Bambino. Da via Telesio la parrocchia era quella di Santa Maria Segreta (non so perché “segreta”) in fondo a via Ariosto dove frequentavo l’oratorio. Qui conobbi un sacerdote, don Fausto Bigi, una figura ascetica e santa che spesso alla sera, quando ci facevamo le prove del coro, mi accompagnava fino a casa per non farmi fare da solo la strada di ritorno. Solo molti anni dopo seppi che era morto molto giovane, colpito, credo, da una malattia ai polmoni. Come mi resi conto solo molti anni dopo che per due anni vissi vicinissimo alla sede dell’Opus Dei, e del24 la sede femminile che era /ed è tuttora) ospitata in una bella villa in fondo alla via Telesio. In quel periodo non eravamo in grado di fare vacanze estive al mare e ci accontentavamo noi ragazzi dell’oratorio, seguiti da don Fausto, di organizzare un giro d’Italia nella vicina via Tamburini, una parallela di viale XX settembre, di fianco alla villa della facoltosa famiglia Falk; non sapevo allora che al liceo avrei avuto in classe Alberto, il figlio erede della grande azienda di acciaierie di Sesto San Giovanni e che divenne poi amico mio e mio aiuto economico quando mi sposai, anche grazie alla generosità di sua madre. Ogni giorno si disegnava sull’asfalto della via col gesso il percorso della tappa e i ciclisti si costruivano con i tappi della birra (li chiamavamo i tollini): si asportavano alcuni parti di sughero dal fondo dei tappi, si avvolgevano di carta del colore della squadra del corridore e si ritagliavano dalla Gazzetta dello sport i nomi dei corridori. Esempio: su fondo azzurro e con una striscia bianca trasversale (maglia della Bianchi) si sovrapponeva il nome ritagliato di Fausto Coppi e possibilmente anche la foto del volto. Per tenere tutto insieme si usava il cellophan dei pacchetti di sigarette che si avvolgeva stretto stretto e si incastrava nel tollino in modo farne un corpo unico molto elegante. Sull’asfalto due righe parallele indicavano il percorso e le montagne (che chiamavamo Pirenei) venivano disegnate con un tratto unico e stretto. Si tirava con la punta delle dita della mano un colpo a testa a turno e chi era più abile sopravanzava sugli altri. Il premio di tappa era una bevanda di aranciata. Ricordo che vinse un certo Guerra (una coincidenza?) il primo giro d’Italia per tollini. Altre volte ci recavamo con don Fausto a giocare ala guerra tra le macerie della caserma Mainoni, all’angolo tra via Mario Pagano e via Vincenzo Monti. Non c’erano pericoli perché la macerie erano state ammucchiate dai militari; noi ci nascondevamo dietro muri diroccati e montagne di detriti e il gioco consisteva nell’organizzare due “eserciti” muniti di un cartone stretto da uno spago sulla fronte e riportante un numero di tre cifre. L’abilità consisteva nel giocare come a guardia e ladri e di riuscire a leggere a voce alta il numero dell’avversario prima di essere letti a nostra volta dal nemico. Era un modo semplice ma felice di giocare e non avevamo bisogno di tutte le fantasticherie costose delle generazioni di oggi. Nasceva l’Italia repubblicana risorgendo dalle macerie della guerra e si sentiva nell’aria qualcosa di nuovo anche se non era un boom economico. Si mangiava meglio e ci si incontrava spesso con amici e parenti. 25 In quell’epoca mia madre dovette farsi operare di appendicectomia all’ospedale Fatebenefratelli. Scese da Manzano mia zia Bice a sostituire mia madre e un giorno mi accompagnò in tram all’ospedale a fare visita a mia madre. In tram, in piedi dietro un signore seduto a leggere il giornale, allungai lo sguardo per leggere anch’io e ricevetti uno stupido rimprovero perché mi ero permesso di allungare l’occhio sul suo giornale. Ci resi molto male, oggi gli straccerei il giornale per insegnargli che non ci si rivolge così ad un bambino curioso ma anzi lo si aiuta a leggere! All’ospedale era vietata l’entrata ai bambini minori di dieci anni io risposi alla domanda del custode che avevo undici anni. Allora mi chiese che classe facessi ed io ingenuamente mi feci fregare, ma mi fece passare. Da allora mia madre ricevette la triste notizia che l’intervento aveva leso un’ovaia e che difficilmente avrebbe potuto avere altri figli. Pianse a lungo mentre mio padre, fingendo il dispiacere, era invece tutto contento perché pensava che da allora sarebbe andato con mia madre a ruota libera. Nel frattempo, poiché d’inverno mangiavamo accanto al calorifero ma mia madre andava avanti e indietro dalla cucina fredda, si prese una pleurite. Era consigliabile cambiar aria per guarire e mio padre decise di portarci a Manzano per qualche mese dove io fui iscritto alla quarta elementare della scuola del paese. Fu un trasloco breve di alcuni mesi che non metto nel conto dei traslochi. Ricordo la forte differenza tra me e i miei nuovi compagni ma un giorno incappai in un errore dialettale in un tema: descrivevo la campagna e parlai di coioni anziché di covoni di fieno. Furono grasse risate in classe e a casa di mia zia. Mia madre si rimise e io finalmente conobbi tanti miei parenti e un paese meraviglioso addossato ad una collina al di qua del fiume Natisone. Fu allora che mia madre con altre parenti donne e relativi figli decise di andare al santuario di Castelmonte sopra Cividale, dove trascorremmo la notte nel locale alberghetto per i pellegrini, tutti ammassati in una sola stanza. Io ebbi poca fortuna perché mi fecero dormire su una coperta per terra ma mi vendicai. Nel mezzo della notte imitai il verso di un topo e gridai “Un topo! Un topo!”. Ci fu una grande confusione ma nel frattempo io mi conquistai un posto nell’unico letto matrimoniale di quella stanza. A Manzano sulla piazza della chiesa, con l’aiuto di mio padre e una piccola bicicletta di una mia cuginetta imparai ad andare in bicicletta. 26 La piazza della chiesa era grande e il campanile troneggiava su tutto il paese. Quando era l’ora in cui si suonavano le campane a mano, correvamo nella torre campanaria ad appenderci alle corde, specie a quella del campanone più grosso perché ci permetteva di volare in aria, appesi alla corda trascinata dal peso della campana. Nella viuzza dietro la casa dove abitavano mia nonna e mia zia Bice con le due figlie lungo i muri venivano distese le paglie colorate che poi sarebbero state usate per costruire l’impagliato delle sedie (Manzano tutt’oggi è nota per le sue sedie e una grande sedia alta alcune decine di metri sorge in mezzo al cortile delle scuole elementari!). E dietro la casa della nonna c’era il cinema che era gestito da mio zio Timo. Alla sera, mentre la nonna rivolta verso la stufa economica, in ginocchio su una sedia iniziava il rosario per adempiere al suo voto, io e mia cugina Mariolina sgattaiolavamo di nascosto ed entravamo dietro il telone dove veniva proiettato il film. Guardavamo i film gratis e le scritte al contrario. Fu allora che vidi così il film “La signora Miniver”. Cercavo di imitare i ragazzi del paese che andavano in giro scalzi ma i miei erano piedi di città e non mi veniva facile correre scalzo nei fossetti lungo lo stradone davanti a casa dopo un’abbondante pioggia. Passai quattro mesi meravigliosi, mentre mia madre guarì definitivamente e purtroppo una mattina fredda dovemmo salire sul treno che ci riportava a Udine e da qui a Milano, dove rientrammo in via Telesio. Capitolo 12 Durante l’estate le nostre vacanze si svolsero a Manzano; con Mariolina imparai a nuotare nel Natisone anche se un giorno la vista del “madrach” mi spaventò a morte: una serpe nuotava con la testa fuori dall’acqua, ma si vedeva bene la sua pelle maculata gialla e nera anche sotto il pelo dell’acqua. Mariolina faceva la furba ma si era spaventata anche lei. Dopo alcune volte in cui avevo preso confidenza con l’acqua del fiume, relativamente bassa, imparai a sfruttare uno stretto passaggio che si era fatto strada a fianco della piccola diga che frenava l’acqua del fiume. Qui la corrente era fortissima e il piacere maggiore era quello di lasciarsi trascinare nel gorgo che aggirava la diga, sfociando in una larga ansa del fiume dove arrivavamo felici, senza pensare al pericolo di farci del male. Avevamo molta più paura quando dovevamo fare un certo percorso per raggiungere il fiume attraverso una scorciatoia: era il muretto del cimitero che divideva i morti dal precipizio scosceso che avevamo sul27 la sinistra mentre raggiungevamo il punto in cui potevamo metterci a riva e poi nuotare. Per oltre trenta metri dovevamo camminare sul muretto un po’ in bilico e avevamo paura ma non di cadere, bensì dei morti nel cimitero! A Milano riprese la scuola a ottobre e l’inverno incombente ci portava le prime nebbie che rendevano ancora più affascinante il mio viaggio con la fantasia nel prato che consideravo la mia Africa. La nebbia di Milano di quegli anni era ancora pulita e oggi, anno 2012, ad Assisi al mattino ogni tanto ritrovo quel tipo di nebbia. Da non confondersi con quella che oggi a Milano è sporca e puzzolente. A proposito di nebbia: i veri milanesi sono rimasti in pochi (nel 1989 quando lasciai Milano i veri milanesi, cioè nati a Milano da genitori nati a Milano erano meno di 160 mila!) e anche meno quelli che veramente conoscono il dialetto milanese. Se chiedete a un milanese qualunque come si dice nebbia, ti risponde “nebiaa” e non sa che nel vero dialetto milanese la nebbia si chiama”scighera!”. Ma nella tarda primavera finalmente arrivò la bella notizia: ci avevano sorteggiato per avere in affitto tutto per noi un appartamento nuovo alla periferia di Milano, in Largo Boccioni, all’inizio di quello che oggi è chiamato il “Bronks”, cioè il malfamato (oggi) quartiere di Quarto Oggiaro. E così facemmo l’undicesimo trasloco! Capitolo 13 Quando nell’estate del 1951 entrammo nella nostra prima vera casa (nostra anche se in affitto) ci fu sembrò un sogno. Largo Boccioni allora non era l’anticamera del Bronks, del quartiere malfamato che è oggi ma l’ultimo avamposto di case dopo le quali la campagna e la brughiera ci accoglievano nelle nostre gite di Pasqua o nelle nostre giornaliere scorribande fino alle cave piene di acqua verdissima, contenente non si sa che cosa. I caseggiati costruiti dall’ente delle Case Popolari erano otto e noi avevamo l’appartamento nel secondo palazzo al terzo piano: una sala da pranzo, un cucinino, una camera da letto, un bagno e un piccolo corridoio: ci sembrava una reggia. Mio padre si era rilassato un po’e alla sera spesso con amici e colleghi si recava a giocare a carte nel bar dall’altra parte della piazza, mentre mia madre si accontentava della musica della radio. Non esisteva ancora la televisione e non avevamo nemmeno il telefono. Io dormivo in 28 un divano nella stanza che di giorno usavamo per tutto, mangiare, studiare io, stirare mia madre, giocare mio fratello. Una sera mentre mi ero appena addormentato una litigata tra i miei mi svegliò di soprassalto. Non capivo perché litigavano mentre loro non si preoccupavano di avermi spaventato. Il giorno dopo seppi tutto: mia madre, contrariamente alle previsioni dei medici, era rimasta incinta e mio padre si vergognava e le aveva raccomandato di tenere il segreto con tutti; eppure aveva solo 43 anni! Mia madre però parlò con la moglie di Liberti, un collega di mio padre che abitava nella scala vicina e lei a sua volta informò il marito che una sera al bar davanti a tutti, a sua insaputa, fece le congratulazioni a mio padre. Da qui l’incazzatura di mio padre, assurda e ingiustificata, anche perché man mano che passavano i giorni della gravidanza aveva incominciato a ripetere che l’arrivo di quella che ormai si sapeva fosse una femmina, sarebbe stata il segno “della provvidenza”. In quei giorni accaddero contemporaneamente due episodi che cambiarono la nostra vita: nel primo palazzo una famiglia se ne andò e mio padre, essendo l’appartamento abbandonato con una stanza in più, ottenne il trasferimento: e fu il dodicesimo trasloco. Ma la felicità di una stanza per me e mio fratello fu presto eliminata dall’arrivo di un cugino da Tripoli: mio padre aveva un fratello, ispettore delle poste a Tripoli dove ancora risiedeva dopo la fine della guerra. Aveva due figli ma il grande, che si chiamava Giuseppe come me (ma lo chiamavano Peppuccio), doveva frequentare il Politecnico a Milano e così ci ritrovammo in casa un estraneo, visto che avevamo già passato tanti anni con altri estranei. Per giunta mia madre stava per partorire ma doveva servirlo di tutto perché lo “studentello” del politecnico pagava un mensile a mio padre e pretendeva tutto, pranzo completo, lavare e stirare. Della sua permanenza presso di noi, che si prolungò anche dopo che nacque Concetta il 2 marzo del 1952, ricordo solo una cosa positiva: mi spiegò bene come era la “consecutio temporum” in latino. Per il resto fu una schiavitù ulteriore che durò fino a che suo padre con tutta la famiglia non ottenne il trasferimento alla dogana di Milano e una casa in viale Forlanini, verso l’aeroporto. Avevo quattordici anni e già da quando abitavamo in via Telesio frequentavo la scuola media vicino a piazza Aquileia: via s. Michele del Carso, un grosso edificio che ospitava anche ragioneria. La porta si apriva propri davanti al Fopponino, un caratteristico posto di Milano che ben pochi conoscono: si tratta di un cortile della parroc29 chia vicina dove c’era una giostra nella quale spesso ci divertivamo a combinarne di tutti i colori, indifferenti di trovarci vicino ad una piccola cappella-edicola che si affacciava sul marciapiede, piena di teschi. Questa zona ospitò un cimitero dal 1576 al 1912. Le lapidi commemorative ricordano la storia di questo cimitero e alcuni illustri defunti un tempo qui accolti. Al mattino c’era davanti al portone sempre il venditore del castagnaccio che però vendeva i pezzi di questa gustosa pasta di castagne con la tombola: dieci lire; se usciva dispari le perdevi, se usciva pari avevi diritto a due pezzi. Chissà perché usciva più spesso il dispari! In classe avevamo come professoressa di disegno una nana vecchia, gobba e balbuziente e tra noi il migliore in disegno era Poggi. Mandavamo avanti sempre lui che la professoressa classificava con un otto. Come tornava al posto cancellavamo il voto e andavamo alla cattedra uno per volta con lo stesso disegno. Chissà perché il massimo poteva essere un sei meno meno. I banchi avevano la superficie di legno un po’ grezzo, a due posti affiancati con il contenitore dell’inchiostro in vetro. Io ero al primo banco e con il mio compagno scavavamo dei solchi che nella nostra fantasia erano rotaie di un fantastico treno. Il bidello, un pover’uomo ignorante non per colpa sua, aveva notato i trucioli per terra sotto il banco e ci aveva accusato di rovinare il banco. Noi ci difendemmo dicendo che non eravamo stati noi ma il bidello, dovendo parlare in italiano per farsi capire e non in dialetto ci accusò con una traduzione del milanese che ancora oggi ricordo e che mi fece ridere allora come ora: “I tapeliti non vanno giù in de per lui!”. Da via Telesio la strada per andare a scuola non era molta; il bello che per due anni io per andare e tornare passavo sempre per via Alberto da Giussano, proprio davanti alla villa sede dell’Opus Dei e non potevo certo sapere che un giorno … ma è una storia che viene dopo. Ma da Largo Boccioni dovevo usare il tram e il tragitto era molto lungo: mezz’ora al mattino e mezz’ora alla una. Del resto, finita la terza media, mio padre mi iscrisse al liceo Manzoni e i viaggi per andare a scuola dalla quarta ginnasio alla fine del liceo classico (anno 1955) furono sempre in tram. Per giunta allora esisteva ancora la buona educazione che i ragazzi cedevano il posto in tram agli anziani e io avrei dovuto fare sempre il viaggio in piedi, ma avevo trovato un sistema che funzionava bene: I tram di allora, specie perché percorrevano corso Sempione che, a causa dei platani, riempiva le rotaie di foglie che emettevano un olio 30 che impediva un buona frenata, avevano, vicino alla porta di discesa, una specie di gabbiotto di legno con il coperchio inclinato, pieno di sabbia. Il manovratore, quando ne aveva bisogno faceva cadere un po’ di sabbia sulle rotaie davanti al tram in modo che la frenata fosse regolare. Quello era il mio posto dove, messi due libri per compensare la parte obliqua del coperchio di legno, studiavo e traducevo prima latino e negli successivi anche il greco. Gli anni più belli della mia adolescenza si svolsero in largo Boccioni, specialmente nei prati che circondavano allora le poche case che erano sorte dopo la guerra, infatti il nome originale del quartiere era Musocco, una frazione che aveva dato il nome al non lontano cimitero che era da anni in fondo a Viale Certosa e che allora si intravedeva dal nostro balcone. Ma col tempo, oltre la piazza, al di là dell’autostrada e al di là dei campi di frumento che allora c’erano, sorsero decine di palazzi per uffici che oggi, specialmente di notte con le loro insegne pubblicitarie sembrano tristi fantasmi di una cittadina americana. Capitolo 14 Io frequentavo la parrocchia in fondo a via Aldini e il relativo oratorio. Aiutavo i due preti con la buona stampa: andavo in tram il sabato pomeriggio in centro fino in via s. Antonio, una traversa di via Larga, per ritirare i giornali che poi rivendevo sulla porta della chiesa la domenica mattina dopo la messa delle sei. Costruivamo insieme gli aeromodelli della Movo; ricordo il T5, con le ali ad angolo diedro che provavamo nei prati dietro via Dossena e fu grande il nostro dispiacere nell’aver perso l’aereo un giorno per un termica che ce lo aveva portato via. Ma la zona era per me un luogo di meditazione e di piacere perché ero in cerca di qualcosa che non trovavo. Era un’età delicata e la mia vita in famiglia non mi dava molte soddisfazioni, Mio padre considerava normale che io fossi quasi un genio e trattava molto male Gianfranco perché non era alla mia altezza negli studi: non si rendeva conto che ogni uomo nasce con un cervello suo diverso da quello degli altri anche se sono fratelli di sangue. Fu in quel periodo che conobbi la Gioventù Studentesca, gestita da don Giussani e che poi si chiamò Comunione e Liberazione, rovinandosi completamente. Studenti e studentesse erano attratti dal linguaggio un po’ libero e sfacciato di don Giussani ma mancava la cosa principale: nessuno insegnava agli studenti l’importanza della meditazione 31 e della lettura dei testi sacri ad incominciare dai vangeli: come puoi buttar fuori qualcosa che non hai dentro? Ma questo non interessava nemmeno a don Giussani che ci raccomandava di andare la domenica “in bassa”: in bassa voleva dire andare a sud di Milano nelle fattorie a portare il messaggio di Cristo. Ma quale? I contadini la domenica lavorano o, se riposano, è perché hanno accumulato tanta stanchezza che non vogliono altro che una bella dormita nel loro letto. E così “andare in bassa” era una scusa per andare in “camporella” e quante coppie si formavano e di queste molte poi si univano in matrimonio, come, ad esempio, mio fratello; che però, sposato e con un figlio, divorziò dalla moglie dopo nove anni di matrimonio. L’unico episodio positivo di quel periodo fu un intervento un pomeriggio nella sede di via Statuto a Milano di Giuseppe Lazzati, il rettore della Cattolica che ci parlò commentando le prime parole del vangelo di Giovanni. Ho ancora il ricordo della sua voce pacata mentre ripeteva “et verbum caro factum est” e del commento che seguì per oltre due ore. Ma lasciamo questo ricordo e torniamo alla mia vita di ogni giorno. Ricordo che studiavo latino, greco o storia con la mia sorellina in braccio per alleviare le fatiche a mia madre che lavorava come una dannata per fare più pantaloni possibile; questo le permetteva di portare a casa più quattrini che supplivano al fatto che a metà mese i soldi dello stipendio di mio padre erano finiti. Eravamo poveri e spesso, a parte le sontuose pastasciutte, il piatto era il pancotto con un goccio d’olio. In questi giorni di crisi economica (parlo del maggio 2012!) ho sentivo alla radio una donna che lamentava la stessa situazione in cui noi vivevamo normalmente: a metà mese non c’erano più soldi per mangiare. Eppure si viveva, si andava a scuola, in chiesa, a volte perfino a fare una gita (severamente a piedi) oltre il capolinea di Roserio, dove sorgeva l’ospedale Sacchi. Mio padre aveva smesso di fumare, sia per risparmiare sia per la salute ma in poco tempo ingrassò eccessivamente e questo gli provocò gravi conseguenze alcuni anni dopo. Uno dei figli di Liberti, Nino, aveva circa la mia età e una sera in cui stava andando in motorino a vedere un film in via Poliziano, mi invitò ad andare con lui. Io, pensando che i miei si sarebbero dispiaciuti sia per non aver chiesto prima il permesso, sia per il fatto che non avevo mai dei soldi miei, gli dissi che preferivo rimanere a casa e lo salutai proprio davanti alla portineria delle nostre palazzine. Non lo vidi più, perché mezz’ora do32 po era stato investito ed era morto sul colpo. Ancora una volta una delle mie vite era stata consumata nel nulla ma ero ancora vivo. E arrivò l’autunno: ero stato promosso bene e mio padre mi iscrisse al quarto ginnasio del liceo Manzoni, ottenendo di farmi mettere nella sezione A dove insegnava lettere la professoressa Bianca Ceva: due anni di ginnasio che mi segnarono per tutta la vita grazie alla severità e alla profonda preparazione di una vera insegnante, eroe partigiano della guerra,medaglia d’oro e sorella di un eroe della resistenza. Per capire la mia ammirazione per lei copio qui una pagina che le è stata dedicata su internet: Nata a Pavia nel 1897, deceduta a Milano nel 1982, insegnante e letterata. Sin dal 1930, nello stesso anno in cui moriva in carcere il fratello minore Umberto, Bianca Ceva fu in contatto con esponenti dell'opposizione democratica al fascismo, da Benedetto Croce a Ferruccio Parri. Per le sue idee fu allontanata dall'insegnamento nel 1931 e poté tornare a scuola (al liceo statale "Beccaria" di Milano), soltanto con la caduta di Mussolini. Pochi mesi dopo l'armistizio e l'allontanamento, questa volta volontario, dell'insegnante dalla scuola. Bianca Ceva, infatti, entra subito nella Resistenza, militando nel Partito d'Azione. Nel dicembre del 1943 la professoressa è arrestata e nell'agosto del 1944 compare davanti al Tribunale militare di Milano, che la rinvia al Tribunale Speciale. Ma i giudici fascisti non riescono a condannarla. Bianca, infatti, nell'ottobre evade dal carcere e si unisce ai partigiani dell'Oltrepò Pavese, collaborando alla lotta armata contro i nazifascisti. Dopo la liberazione è preside per due anni del liceo "Beccaria" e contribuisce alla fondazione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, di cui diviene segretaria generale dal 1955 al 1971. Bianca Ceva ha anche fatto parte, negli stessi anni, del comitato direttivo della rassegna "Il Movimento di liberazione in Italia". Traduttrice di Tacito e studiosa di problemi storici, filosofici e letterari, la professoressa Ceva ha lasciato molti scritti sulla lotta antifascista, tra cui: "Storia di una passione" del 1948, "Tempo dei vivi. 1943-1945" del 1954, "Cinque anni di storia italiana" del 1964. Nel 1979 è uscito "La storia che ritorna. La Terza Decade di Tito Livio e l'ultimo conflitto mondiale". Qui non riportano che fu insegnante di lettere al liceo Manzoni per gli studenti del ginnasio per molti anni, divenendo anche vicepreside alcuni anni dopo. Ci rivelò molto della sua vita di partigiana quando comandava una postazione di mitragliatrici sulle colline di Bobbio e di Varzi e degli assalti dei prigionieri polacchi e mongoli che i tedeschi mandavano avanti con il permesso di fare di tutto: uccidere, stuprare, rubare ecc. La sua mitragliatrice era infuocata ma i prigionieri mandati all’assalto non si fermavano e passavano sopra i cadaveri per assalire i partigiani: erano stati prima abbondantemente ubriacati e riempiti di droga. Ascoltavamo i suoi racconti e capivamo di aver di fronte una donna che aveva combattuto per salvare l’Italia. 33 Il suo volto era caratteristico: assomigliava a quelle teste di bronzo che si mettono sui pianoforti con la faccia di Beethoven: aveva uno sguardo severo come il suo o anche come Toscanini. Quando ci fu in via Durini il funerale del grande direttore d’orchestra, la cui salma era tornata dall’America, lei ci invitò, anzi ci obbligò ad andare alla cerimonia. La mia classe che aveva 38 studenti finì l’anno dopo con solo 28 alunni. La classe era piena di nomi illustri perché evidentemente la sua fama faceva muovere i genitori raccomandati. Come mio padre fosse riuscito a farmi entrare in quella sezione fu sempre un mistero. Furono due anni molto duri ma ricchi di apprendimento. Era una classe composta da figli di gente importante e che nella vita sono poi diventati grandi professionisti. In classe avevamo, solo a titolo di esempio, il nipote del presidente del Touring, Cesare chiodi, oggi uno dei più importanti notai di Milano, Paolo Occhipinti che divenne il direttore responsabile di Oggi della Rizzoli, Alberto Falck erede delle Acciaierie, Riccardo Conca, primario di ortopedia, Annamaria Delitala, figlia del grande avvocato nella causa tra Guareschi ed Einaudi, con alle spalle una ricca dinastia di origine sarda e tutt’oggi diffusissima sia in Sardegna che a Milano. Avevamo poi De Franceschi che divenne presidente dell’Istituto del Commercio con l’estero, Elena Frasio, figlia dell’allora amministratore delegato della Lanerossi, Lele Zerboni che poi sposò il ricchissimo Rivolta, Prota che divenne il segretario di Lama a Narni, Polvara, modesta figlia di un noto professore del liceo Berchet, Caracciolo, che si dilettava di jazz col banjo ma soprattutto fece poi l’ingegnere in Arabia Saudita, Francesca Meli, figlia di un noto giudice di Milano, Pisani, pazzo figlio di un noto professore di sanscrito, Wittgens, nipote dell’autrice del noto trattato di storia dell’arte “Wittgens-Gengaro, Bosio, primo della classe in italiano che divenne un importante professore di filosolfia e che scrisse anche alcuni libri monografici, Riboldi, figlia di un importante agente di cambio che aveva in pieno centro di Milano una casa tanto ricca (con cortile interno su via Magenta e una portantina del settecento nell’atrio a pianterreno sotto il grande scalone che portava al primo piano e che veniva usata come cabina telefonica); suo padre alcuni anni dopo fece un “piccolo” crack in borsa per conto di suoi clienti per circa due miliardi di lire negli anni 60! Mi fermo qui ma molti altri in classe avevano alle spalle famiglie ricche o comunque potenti. Io ero il più povero della classe e mi vergognavo un po’ per come andavo vestito. 34 Avevo in classe anche una ragazza ebrea, Luciana Pardo che la maggior parte teneva a distanza quasi avesse la peste; e fu così che divenimmo molto amici. Il professore di religione era un monsignore che riempiva la lezione leggendoci le avventure di Tom Sawer. Ma i tre episodi più importanti di quei due anni furono: fui scelto per leggere nelle ore finali della mattinata le pagine del Cirano di Bergerac nell’edizione in italiano e poi la decisione della Ceva di farci leggere in quarta all’ultima ora, tanto per alleggerirci la fatica, l’Apologia di Socrate in greco, con traduzione in diretta, solo per il piacere di imparare la bellezza dello scritto di Platone e i principi contenuti nell’opera. Era atea al punto che quando doveva arrivare il sacerdote per la benedizione pasquale, il bidello aveva l’incarico di avvisarla in modo che usciva e rientrava solo dopo la benedizione. Eppure aveva una grande ammirazione per Gesù come uomo, tanto che durante la quinta ginnasio usava l’ultima ora per farci leggere (e ovviamente tradurre), sempre in e dal greco il vangelo di S. Giovanni. Capitolo 15 Il passaggio dal ginnasio al liceo segnò la mia vita per sempre e in molti modi non tutti spiacevoli. Innanzi tutto ottenni per ogni anno del liceo una borsa di studio della Provincia di Milano talmente alta (160.000 lire all’anno) da competere (positivamente) con lo stipendio mensile di mio padre, il quale fu ben contento. Purtroppo pretendeva lo stesso rendimento scolastico da mio fratello che non aveva molta voglia di studiare. Io non posso e non voglio fare paragoni ma mio padre li faceva e pretendeva che mio fratello fosse bravo come me. Al primo giorno dell’anno scolastico della prima liceo classico, riuniti nella palestra fummo chiamati per la formazione delle sezioni ed io mi aspettavo, dato il mio cognome, di essere chiamato per primo nella sezione A. Invece fu chiamata una certa Giovanna Agostini, con mio forte disappunto perché questo mi avrebbe tolto il privilegio di gestirmi durante l’anno la scadenza delle interrogazioni in ordine alfabetico. Nel 1954 non potevo immaginare che nel 1961 sarebbe diventata mia moglie! Avevamo ottimi professori ma in filosofia e storia gli avvicendamenti dei vari sostituti furono negativi. 35 Nel costituire la classe entrarono a far parte della sezione A alcuni che arrivavano da altre sezioni, mentre Giovanna proveniva dalle Orsoline dove aveva vissuto un po’ nella bambagia ed ora si trovava in difficoltà nell’affrontare l’ambiente della scuola pubblica. Sua madre la voleva portare ad un livello sociale maggiore e per questo le aveva fatto fare le scuole private ma poi un rovescio finanziario provocato dal padre aveva costretto la famiglia a ripiegare verso la più economica scuola pubblica. Tra i nuovi arrivati c’era Franco Moro Visconti. Già i due cognomi faceva capire il tipo. Per giunta era un bel ragazzo, molto distinto, famiglia ricca, e modi molto gentili. Non era una cima ma sapeva arrangiarsi per andare avanti negli studi. Fu l’artefice del mio destino negli anni successivi: mi invitò a frequentare una sera una specie di circolo (così mi formulò l’invito) dove anche Alberto Falck era presente, anzi avrebbe proiettato un filmato su Cortina (era l’anno in cui si erano svolte le Olimpiadi invernali a Cortina e per me era un attraente richiamo che stimolava mia curiosità, oltre a permettermi di avere dei rapporti meno anonimi con i miei compagni di scuola). Venne lui a prendermi fino in largo Boccioni per portarmi alle nove di sera in quella via Alberto da Giussano cui ho accennato più sopra. Non potevo ancora sapere che era la sede dell’Opus Dei. La serata era un po’ strana: si scendeva in una specie di cantina, finemente arredata e organizzata con luci, giradischi e una collezione ricca di dischi a 33 giri. C’erano divani in un salone molto grande, col pavimento di legno tirato a lucido e molti erano ragazzi bene, altri studenti universitari, ma tutti di un alto livello economico: lo si deduceva facilmente da come erano vestiti e da come si presentavano e parlavano. Ci furono delle presentazioni informali e poi Alberto iniziò la proiezione da un treppiede e così ammirai la ripresa che aveva fatto con una sua cinepresa superotto (io a casa avevo una modesta macchina fotografica di mio padre, a soffietto, sei per nove Voiglander, ed era istintivo fare dei paragoni). Poco dopo apparve un signore già più anzianotto che si presentò con accento fortemente spagnolo (era Pedro Rueda che poi seppi si trattava del Direttore della casa) e poco dopo apparve con mia meraviglia anche un prete: era don Luigi Tirelli, il sacerdote della residenza. Alla fine della serata, quando stavamo per tornare a casa, Franco mi offrì di riaccompagnarmi in largo Boccioni (in tram ci sarebbe voluta una buona mezz’ora). 36 Ma, prima di uscire, mi invitò ad entrare in un’altra stanza a pian terreno che scoprii essere una cappella (loro la chiamavano “oratorio”), dove chi entrava si inginocchiava; anch’io lo feci istintivamente perché era acceso un lumino rosso che indicava la presenza sacra nel tabernacolo. Nessuno disse nulla, solo uno iniziò la recita del rosario e da quel momento incominciai a conoscere lo spirito dell’Opus Dei (o Opera di Dio come Franco mi spiegò il giorno dopo a scuola). Ricordo ogni minimo particolare di quella strana avventura dall’inizio a quando accettai di entrare a far parte dell’Opera. Ma io avevo anche iniziato a innamorarmi di Giovanna e le due cose pensavo potessero camminare parallele; invece fui costretto molto tempo dopo ad una scelta che fu più dolorosa per Giovanna che per me, perché io avevo preso una decisione molto forte per la mia vita mentre della vita non avevo capito niente! Per i particolari su questa parte della mia vita preferisco rimandare alla lettura di un mio scritto completo, contenuto nel sito www.cristotranoi.it 2 ed intitolato “Opus Dei: cinque anni in quattro giorni” , che spiega questa movimentata avventura della mia vita (come se fino ad allora fosse stata tranquilla!). Qui mi limito ad alcuni cenni per capire che cosa accadde in quegli anni. Ma torniamo per un momento in largo Boccioni, in seno alla mia famiglia per prendere nota che per la prima volta per molti anni non traslocammo più. E questa affermazione fa un po’ ridere perché io, entrando nell’Opus Dei, avevo traslocato prima il mio spirito e poi, alla fine del liceo, anche il mio corpo in altri quattro assurdi traslochi, due a Catania e due a Palermo. Capitolo 16 Il mio innamoramento per Giovanna si fortificò di giorno in giorno al punto che, potendo scegliere il posto occupammo i primi due banchi affiancati del quartiere di mezzo dell’aula, proprio di fronte alla cattedra. Fu un anno di letterine, di aiuti nei compiti anche da casa perché Giovanna faceva fatica ad abituarsi ai metodi della scuola pubblica. 2 Il testo del romanzo è anche disponibile in formato pdf e-boock su Boorp, in internet 37 Il primo bacio (ho anche uno foto di quel giorno) fu al parco di Milano in un giorno in cui si faceva sciopero a scuola per i fatti che stavano accadendo in Ungheria. A scuola ci prendevano in giro e a casa mia madre conduceva una seria battaglia contro il mio rapporto con Giovanna come se già si sentisse sua suocera. Qui però devo fare una precisazione: tutto quello che ho raccontato si è svolto in tempi diversi, accavallato tra la prima e la seconda liceo. Ho dovuto fare così per far capire meglio la contemporaneità degli accadimenti di allora, per me importanti, perché il destino stava gettando le basi di tutta la mia vita futura. In realtà il rapporto con Giovanna crebbe durante il primo anno e si rafforzò durante l’inizio del secondo, mentre l’inizio dei rapporti con Franco Moro e l’Opus Dei si avviò nei primi mesi della seconda liceo. Ora che abbiamo sistemato, spero, anche il calendario, posso proseguire nel racconto. Nel novembre del 1956 io “pitai”, un termine in uso nell’Opus Dei che in spagnolo sembra voglia dire “fischiare” e che veniva usato per indicare il chiedere per iscritto di entrare nell’Opera come socio. La struttura dell’Opera era semplice: i laureati diventavano soci “numerari”, non si sposavano ma pronunciavano per cinque anni a San Giuseppe i tre voti di castità, povertà e obbedienza e alla fine pronunciavano il voto di fede definitivo per tutta la vita. Ovviamente restavano scapoli mentre i sopranumerari erano degli sposati che aderivano all’Opera da soli o con la moglie. Poi c’erano i fratelli oblati: erano come i numerari, ma la divisione di classe era netta: erano quelli che non si laureavano o che facevano comunque gli operai. La differenza era solo nel fatto che i numerari entravano ad abitare nelle case dell’Opera mentre gli oblati restavano con la famiglia di origine. Non mi sono mai chiesto come sarebbero vissuti da vecchi senza i genitori o altri parenti. Era una netta divisione di ceto sociale perché i laureati, soci numerari, diventavano professionisti e versavano tutti i loro guadagni nelle casse dell’Opus Dei, riprendendosi solo quello che serviva per vivere: eventuali uffici, automezzi, ecc. Svolgevano la loro attività professionale come qualunque altro ma vivevano la castità e gli altri voti senza far sapere di appartenere all’istituto: dovevano tenere il segreto tranne dei casi eccezionali. Uno ad esempio diventò il chirurgo prof. Raffaello Cortesini che era anche responsabile dell’esame dei miracoli presentati alla chiesa per l’approvazione. 38 Lo ricordo bene perché durante gli intervalli negli esercizi spirituali ad Urio (una villa del settecento che aveva anche ospitato Bellini quando componeva la Norma, sul lago di Como di proprietà dell’Opera, regalo di un munifico benefattore e che usavamo per gli esercizi spirituali o per quelli annuali) lo vidi spesso tirare di fioretto, sport di cui era appassionato. Esisteva anche la sezione femminile ma l’unico contatto era tenuto sempre per telefono dal Direttore della casa, per organizzare il pranzo o altre incombenze. La struttura interna è descritta in un libro della BUR (Rizzoli), autore Ferruccio Pinotti, che porta varie testimonianze, tutte di donne che hanno abbandonato la sezione femminile dell’Opera, alcune perfino di alto livello gerarchico interno. Fu proprio in quel novembre che un pomeriggio in piazza Conciliazione, a quattro passi della sede dell’Opera dichiarai a Giovanna che la lasciavo perché (scusate la mia deficienza e stupidità ma fu proprio così) “andavo a farmi santo”. Giovanna fuggì piangendo e poche mattine dopo, mentre discutevamo in via Lanzone con don Giovanni Barbareschi della mia decisione, Giovanna alla fine, non convinta disse (e fu profeta): “Tanto il Beppe non rimarrà dentro”. Giovanna per il dolore lasciò gli studi e il liceo e trovò lavoro da Avandero, grazie a suo padre ma l’ambiente dei camionisti non era il più adatto per una giovane ragazza di sedici anni. Quando ero a Urio spesso pensavo a volte a lei anche perché ero a breve distanza da Moltrasio dove i suoi genitori avevano un piccolo appartamento in affitto e dove spesso lei trascorreva i fine settimana. Ebbi una rara occasione durante un ritiro: il Fondatore era arrivato da Roma e volle conoscermi: erano i primi tempi della mia “vocazione” e per quasi mezz’ora passeggiammo nei giardini mentre lui mi parlava dell’Opera e di come doveva essere la mia vocazione: fu un incontro particolare che ricordo molto bene e che oggi mi permette di vantarmi di aver parlato con un uomo fatto santo subito dopo la sua morte. E la vita prese una svolta diversa tra studio, orazione e meditazione, come era in uso nella giornata di un numerario. Io non feci molta fatica dopo qualche mese a dimenticarmi di lei, salvo il rosario che dicevo spesso proprio per lei. Fu in quel periodo che preparai alcune tesi in scienze e in filosofia, per ottenere voti più alti alla maturità. Allora mi illudevo ancora che avrei realizzato il mio sogno di diventare un grande neurochirurgo come lo svedese Olivecrona. 39 Durante la seconda liceo preparai una tesi su “Il finalismo nei fenomeni biologici”, aiutandomi con gli scritti di padre Marcozzi (un gesuita) e di Sofia Vanni Rovighi (dell’Università cattolica). Ricordo che illustrai la mia tesi dalla cattedra mentre la Bola (così chiamavamo la professoressa Bevilacqua) aveva preso il mio posto tra i banchi. Ad un certo punto la vidi piangere dalla commozione per la mia esposizione. Alla fine ci fu un bacio accademico, un battimani di tutti e un bel dieci in scienze che mi avrebbe aiutato per le borse di studio all’università. Così io mi illudevo e perseverai con una tesi di filosofia in terza sul libro di Croce “Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel”. Portai la tesi agli esami di maturità (il bello è che, essendo un libro all’indice, avevo dovuto chiedere il permesso al fondatore dell’Opera per la consultazione!). Questa tesi fu utile per compensare il voto di storia dell’arte, dove presi un sei assurdo perché durante l’anno avevo litigato col professore. Erano i tempi in cui mi sentivo un paladino della religione e il prof. Onorato, un maleducato che alludeva solo ai rapporti con le ragazze della classe (arrivò un giorno a paragonare le sperma al sangue per la richiesta che ci era arrivata di diventare donatori di sangue: lui era disposto a donare ma “quel tipo di liquido!”) Aveva sostituito il validissimo prof. Monteverdi e aveva anche l’abitudine di bestemmiare spesso. Quando si accorse che la cosa mi dava fastidio aumentò la dose al punto che un giorno, dopo l’ennesima bestemmia, presi mille lire e gliele misi sulla cattedra, dicendogli: “Porco sarà tuo padre!” e me ne uscii dalla classe. Da allora ci rivedemmo solo agli esami di maturità e il vigliacco pensò di vendicarsi ma non poteva darmi meno di sei. Giunsi così alla fine del liceo; avevo lasciato Giovanna nei ricordi e cercavo di far entrare nell’Opus Dei (azione di apostolato!) altri ragazzi ,organizzando nella “casa” dell’Opera concerti di musica sinfonica e conversazioni periodiche in cui commentavo passi delle letture spirituali dai vangeli a Santa Teresa di Avila. I miei fratelli di vita sulla strada della “santificazione” erano di diverse estrazioni e diverse età: dai giovani liceali ai professionisti con un lavoro preciso (ad esempio un ingegnere, Giorgio Carimati, era figlio del proprietario dell’azienda che produceva caldaie ma anni dopo lo rividi sacerdote) Il sacerdozio era teoricamente il destino di tutti, ma la scelta dipendeva dal fondatore. 40 Alla fine del liceo si imponeva la necessità di uscire dalla casa dei miei ed andare ad abitare in una casa dell’Opera. Fui destinato a Catania e uno dei soci numerari che era avvocato (mi pare si chiamasse Cerciello) trovò il modo: mi fu conferito una borsa di studio dalla RUI (Residenza Universitaria Internazionale) comprendente tutto tranne le tasse universitarie presso una delle residenze universitarie italiane dell’Opera (che non esistevano ma facevano passare per tali le case che aprivano nelle varie città). Mio padre abboccò (non aveva il coraggio di opporsi (come invece seppi poi come fecero molti genitori, denunciando l’Opera per circonvenzione di minorenne) anche se ero allora minorenne anch’io forse perché andandomene di casa sarei stato una bocca in meno da sfamare!Almeno così io pensai malignamente, e oltretutto la concessione della borsa di studio arrivava a fagiolo perché proprio l’ultimo trimestre del liceo accadde un episodio spiacevole nei corridoi della scuola. Io avevo l’abitudine di imitare con la bocca la tromba e un giorno in corridoio, proprio davanti alla classe dove stava insegnando la Ceva ai ginnasiali, attaccai un pezzo famoso :”Ciliegie rosa a primavera”. La Ceva, uscita dall’aula, mi mandò in presidenza e mi fece dare un sette in condotta. Alla maturità mi mantennero questo voto e questo tagliò la possibilità di proseguire ad avere le borse di studio della provincia e fu un grave danno per mio padre. La Ceva, che aveva capito la mia appartenenza all’Opus Dei e che mi aveva invitato un giorno a casa sua per convincermi a uscirne dopo un probabile intervento di mio padre, si era data da sola zappa sui piedi perché in questo modo l’arrivo della borsa di studio della RUI (lettera sontuosa che arrivò un giorno a mio padre per posta) risolveva il problema economico della mia prosecuzione di studi all’università. Forse fu questo il vero motivo per cui mio padre, dopo aver cercato di convincermi inutilmente che ero entrato a far parte di una “massoneria bianca”, si era ormai rassegnato (e intanto aveva risolto un grosso problema economico con la mia uscita dalla famiglia). Fu così che in ottobre partii in treno per Catania e in quella città iniziò così il tredicesimo trasloco della mia vita! Prima di partire avvennero due cose che ricordo bene; una fu l’asiatica che a quei tempi colpì mezzo mondo con febbre alta e tanto malessere e l’altro episodio fu una strana gita nel Trentino che organizzammo dalla casa dell’opera a Milano: partimmo in otto, divisi tra due seicento Fiat. Una arrivò a Ortisei mentre l’altra passò in basso al passo di Costalunga. 41 I due equipaggi erano formati da gente dell’opera e da ragazzi che cercavamo di far entrare. Io ero nell’equipaggio che passò per Vigo di Fassa e dormimmo al rifugio Ciampedie per ripartire il giorno dopo per il passo dell’Antermoia. L’appuntamento con l’altro gruppo che scendeva da Ortisei in direzione sud attraversando la Val di Non era proprio al laghetto dell’Antermoia e lì ci incontrammo per pranzare e scambiarci le chiavi delle automobili. Con nostra sorpresa le donne dell’Opus Dei che avevano preparato per noi le vettovaglie ci avevano foraggiato tutto doppio e con nostra meraviglia ci trovammo a dover riportare a casa metà delle cibarie e delle bevande. Poi noi proseguimmo per Ortisei mente l’altro equipaggio scese a Vigo a prendere la nostra seicento. Fu una gita splendida, di cui non sto a raccontarvi i particolari, che mi rimase impressa perché non avevo mai avuto un’occasione così ricca di esperienza in montagna: questo provocò anche all’inizio un piccolo disguido ma interessante come avventura. Lasciati i due che salivano con la macchina fino al rifugio Ciampedie, salimmo in due con la seggiovia, ciascuno credendo nell’esperienza di montagna dell’altro mentre eravamo completamente digiuni di come ci si deve comportare. Proseguimmo a piedi ma sbagliammo strada per cui, dopo un’ora di cannino, grazie alle indicazioni di un montanaro, dovemmo scavalcare una sella tra due cime e scendere nella valle dove c’era il nostro rifugio al buio, guidati solo dalla luce di un lumicino che si intravedeva in fondo al ghiaione dove stavamo praticamente scivolando. Il guaio fu il buio e il fatto che, man mano che si scendeva, la luce scomparve dietro gli alberi di un bosco inaspettato. Per giunta alla fine ci trovammo di fronte alla necessità di scavalcare un torrente. E finalmente raggiungemmo gli altri due che erano in attesa ansiosa del nostro arrivo. Durante la discesa, grazie alle mie nozioni di astronomia, riuscii ad indovinare il percorso migliore per non perderci ma la paura non fu poca. La vita in Sicilia ed in particolare a Catania era completamente diversa da Milano. La mia fortuna erano le origini di mio padre (Agrigento) e le mie discese precedenti in Sicilia a conoscere meglio i parenti che avevo, comprese le famose tre sorelle di mio padre, rimaste zitelle e che vivevano non so come, ma certo con un buon contributo mensile (un vaglia) che mio padre inviava loro, considerandolo come un suo dovere nei confronti di suo padre. 42 Ma non teneva conto della rabbia di mia madre che spesso insultava il comportamento delle cognate perché lei doveva lavorare anche di notte per sfamare la famiglia, mentre le “signorine” se la “spassavano gratis”. Anche mio padre si era dato da fare per guadagnare di più: aveva studiato diritto costituzionale ed amministrativo per sostenere un esame interno per passare da archivista a Ispettore di polizia; e ci riuscì, ottenendo così un buon aumento di stipendio. Poi trovò un lavoro supplementare la domenica sera: fare lo scrutatore delle schedine del Totocalcio a Porta Vittoria: non erano grossi guadagni ma tutto serviva per sbarcare il lunario. Per questo era fissa nella mia mente l’immagine della povertà della mia famiglia, contrapposta a quella dell’Opus Dei dove vedevo che il voto di povertà, in confronto con il modus vivendi dei miei era un voto che io definitivo di “ricchezza”. La prima casa (come dicevo più sopra era il quattordicesimo trasloco) era un appartamento al primo piano di una palazzina alle spalle del “grande” giardino Bellini che per i catanesi era il più bel giardino d’Europa. Ma bisognava accettare la loro fantasia! Come si dovevano accettare certe affermazioni quando fino a poco tempo prima, per ragioni stupide, esistevano degli autobus riservati solo alle donne? Avevano forse paura di essere stuprate? Avevo anche l’immagine, mentre mi avviavo a piedi all’università, di automobili lunghe e vecchie che fungevano da autobus (o taxi privati, come volete chiamarli) che portavano ogni giorno circa una decina di persone dai paesi dell’Etna giù a Catania per le spese ai mercati rionali. Non parliamo poi della sporcizia: mi avvisarono per tempo di stare attento quando si attraversavano le strade del quartiere di San Berillo (bonificato solo pochi anni fa) in cui poteva capitarti un lancio di avanzi di bucce di pomodori dalle porte a pianterreno dalle “casalinghe” che preparavano il pranzo per la famiglia. Davanti alle stanze della nostra “casa” si stendeva un quartiere dove stavano scavando le fondamenta per un nuovo condominio. Accaddero due cose:l’ingegner Carchiolo (non è un nome inventato!) era il progettista e un giorno gli scavi per le fondamenta affrontarono un vecchio muro di cinta alto circa due metri che costeggiava un lato della futura costruzione. Si trattava in verità di un muro a secco che in campagna in Sicilia si chiama “Trazzera”. Con una scavatrice stavano scavando lungo la base del muro senza preoccuparsi del fatto che stavano togliendo la base del terreno che sosteneva il muro. Ad un certo punto con un grande tonfo il muro ce43 dette e crollò all’interno del cantiere. Quelli della scavatrice si salvarono per miracolo schizzando via ma nessuno si preoccupò delle conseguenze: nel muro passavano due tubature, una per il gas di città, l’altra per l’acqua potabile. Mente le nostre stanze e la strada si riempivano della puzza del gas, nel cantiere il tubo rotto dell’acqua incominciò a riempire il terreno raggiungendo la base della gru che era già stata montata su un terrapieno composto da sbarre di cemento. In poco tempo l’acqua salì al punto che ad un certo punto con un boato vedemmo la gru crollare verso la facciata della nostra casa. Per puro miracolo sfiorò le nostre finestre finendo in pezzi sulla strada sottostante. Immaginate da soli le conseguenze. Ma l’ing. Carchiolo nel frattempo aveva combinato altri due guai: si era dimenticato di inserire le scale interne nel progetto e quindi dovette aggiungerle all’esterno. Tempo dopo scoprimmo che in un palazzo vicino avevano aperto un negozio di vendita di bombole di gas e scoprimmo che Carchiolo si era dimenticato anche l’impianto di collegamento nei vari appartamenti per il gas di città. Questa era Catania che, tra l’altro, si vantava di essere la “Milano del sud”. Fu il periodo in cui sperimentammo dei missili con la polvere nera, lanciandoli dalla spiaggia della Plaia ma, dopo aver inventato un nuovo combustibile a base di perborato di potassio mescolato a paraffina che produsse una fiammata alta due metri e annerì il soffitto, ci fu severamente ordinato di smetterla di fare i ragazzini. Catania però aveva un pregio: in certi momenti dell’anno si poteva fare il bagno a Ognina (oggi è una pozzanghera di sporcizia, allora era un sogno per subacquei) e nel pomeriggio andare a sciare sulla neve dell’Etna sui campi vicini al rifugio Citelli che oggi non esiste più, perché travolto da una colata di lava. Infatti anni dopo la colata era giunta fino a Milo e, con la fermezza del credere nella Madonna, fu fermata proprio alle porte del paese davanti alla statua della Madre di Gesù. Ebbi un’altra avventura quando decidemmo di salire in cima all’Etna per ammirare il sorgere del sole in fondo all’orizzonte dalla parte del mare. E’ un racconto che ho già riportato in un mio libro sul mio sito3 e che qui riporto senza cambiamenti. Racconto: 3 In www.cristotranoi.it nel libro “Opus Dei: cinque anni in quattro giorni”, pag. 101 e segg. 44 “Ho progettato con Giuliano di salire sull’Etna di notte con i ragazzi che frequentano casa, per vedere il sorgere il sole dalla cima. Arriviamo alle due di notte in macchina all’Osservatorio e da lì incomincia la salita: è un dislivello di alcune centinaia di metri ma si cammina sui granuli di lava, grossi come noci e si fanno due passi avanti e uno indietro, perché si scivola. E’ ancora buio, ma Giuliano conosce come muoversi e guida in testa; mettiamo in mezzo i ragazzi più giovani e in coda sto io per verificare che nessuno si perda per strada. E’ buio pesto, ma ognuno di noi ha una torcia elettrica che accendiamo a tratti per vedere gli ostacoli. L’aria è freddissima e rarefatta perché siamo già ad oltre duemila e ottocento metri e il vento di tramontana ci colpisce con folate violente che, superata la cresta, scendono lungo il pendio molto inclinato, investendoci violentemente e portando l’odore di zolfo. Facciamo una sola sosta e mi siedo a riposare, dando le spalle al cratere: davanti a noi si stende nel buio tutta la piana. La notte è luminosissima e si vedono le luci di tutta la costa fino a Siracusa. Il cielo è meraviglioso: il Sagittario splende in mezzo alla Via Lattea e sembra veramente che cerchi di scoccare la freccia verso lo Scorpione che, a queste latitudini, è alto nel cielo con Antares che da qui sembra come se guardassimo il nostro sole dalla superficie di Plutone. Nessuno di noi parla, presi dallo spettacolo quando tutti veniamo sorpresi dalla lunghissima scia di luce che solca il cielo silenziosa e resta per un istante ancora ferma, prima di svanire: un altro meteorite si è disintegrato a contatto con la nostra atmosfera; è un coro di meraviglia, ma subito dopo Giuliano ci invita a riprendere il cammino. L’ultimo tratto è più faticoso, anche perché dobbiamo evitare di infilarci tra il cratere centrale e quello di nord-est: sarebbe veramente pericoloso. Manca il respiro e mi concentro nell’orazione che è tutta un ringraziamento a Dio per questi momenti magici. Saliamo a zigzag ed il percorso si fa più lungo, ma meno ripido. Arrivano ogni tanto zaffate di zolfo e sentiamo che il freddo si sta facendo più intenso; ma basta toccare con le mani i granuli di lava su cui saliamo per renderci conto che sono tiepidi: sotto di noi il vulcano palpita di vita propria. Arriviamo in cima quasi a sorpresa: Giuliano ci avvisa e, superato l’ultimo dislivello, improvvisamente ci troviamo sull’orlo del cratere centrale. E’ un’impressione molto brutta, specie per me che soffro le vertigini; siamo arrivati sul sentiero che cammina lungo tutto il bordo e ci tro45 viamo, nel buio della notte, con ai nostri fianchi due strapiombi da incubo. A destra e sinistra dello stretto sentiero c’è il vuoto, delimitato dalla cresta irregolare del bordo del cratere che si staglia minaccioso nel buio della notte contro un cielo pieno di stelle. Ci fermiamo a ridosso di un masso lavico che ci ripara dal vento che soffia fortissimo e facciamo un po’ di colazione con cioccolata, biscotti e acqua. Nessuno di noi osa parlare: la stanchezza e la paura scompaiono nella meravigliosa, immensa bellezza di quello che ci circonda. Sembra di essere in groppa ad un gigantesco animale; l’Etna non è una montagna, è un essere vivo e ... si fa sentire: una lieve scossa di terremoto, preceduta da un boato che sembra risalga dal fondo del cratere, ci mette addosso una gran paura, ma Giuliano ci rassicura: è una cosa normale. Mentre aspettiamo il sorgere del sole (verrà dal mare alla nostra sinistra) penso ad Empedocle e alla leggenda del suo sandalo, ma penso soprattutto a al suo “eris” ed “eros”, odio e amore che secondo il filosofo di Agrigento governa l’Universo in cicli che si alternano: è sconcertante l’accostamento con i Veda, ma ancor più con la teoria del Big Bang. Quante volte l’Universo si sarà contratto per “eris” ed espanso per “eros” durante la sua vita? Quante volte sono passati cicli da quindici miliardi di anni? E come Empedocle ha potuto intuire una verità molto probabile, senza alcuno strumento scientifico, affermando qualcosa che solo negli ultimi cinquant’anni la scienza pensa di aver scoperto e cerca di riuscire a dimostrare? Giuliano è andato in ricognizione e torna poco dopo, mentre il cielo verso est incomincia a impallidire: “Ci siamo” e ci spiega: “Ora costeggiamo il cratere percorrendo tutto il sentiero con molta prudenza. Arriviamo all’altezza del cratere di nord-est e lì aspettiamo il sorgere del sole”. “Ma il cratere di nord-est è attivo!” osserva uno dei ragazzi. “Sì, ma sono andato a verificare: manda pochissimo fumo che la tramontana porta in basso verso la valle del Bove. Se non si sveglia all’improvviso ...”. “E se si sveglia?” gli chiedo con una certa apprensione. “Si scappa di corsa!” mi risponde ridendo e si mette in marcia. Lo seguiamo, stando molto attenti a dove mettiamo i piedi, aiutandoci con le torce elettriche. 46 Dieci minuti dopo siamo tutti seduti al riparo di una incrostazione lavica, una specie di muro lungo una decina di metri e alto quasi due metri; subito sotto di noi il cratere di nord-est manda a tratti piccole sbuffate di fumo e l’odore di zolfo, nonostante il vento di tramontana, ci arriva piuttosto intenso. Davanti a noi l’infinito: nel chiarore che aumenta siamo in silenzio ad osservare una sottile linea all’orizzonte che, ad ogni minuto, diventa sempre più nitida: è la linea che divide il cielo dal mare. Giuliano ed io vogliamo fare orazione ed io invito gli altri, già abituati a casa nostra, a fare lo stesso. Nel silenzio, interrotto solo dalle brusche folate e dai fischi della tramontana tra i massi di lava, la mia mente si perde in Dio e in quello che ci sta donando: il cielo immenso sembra diventare lattiginoso e le stelle impallidiscono lentamente. Il mare Ionio diventa un’immensa distesa dal colore indefinito; lontano si scorgono luci di barche da pesca che stanno ancora lavorando. Proprio sotto di noi incomincia prendere forma la valle del Bove: un baratro immenso che da nero sta diventando grigio scuro e sta rivelando tutta la sua orrenda bellezza, ricco di statue di giganti fatte di lava di vecchie colate. Alla nostra destra, più in basso, oltre i Monti Rossi, si stende tutta Catania, le luci delle strade ancora accese e, più lontano, la costa è tutta segnata dalle luci dei vari paesini, fino a Siracusa. Abbiamo scelto la notte giusta. La mia preghiera non è fatta di pensieri, né di emozioni: sembra di essere direttamente immersi in Lui, di vivere con Lui la gioia della creazione. Il grido improvviso di uno dei ragazzi mi riporta al presente: “Eccolo!” e indica un punto dell’orizzonte. Gli occhi di tutti sono puntati verso un piccolo punto rosso che è apparso: è il sole! Non c’è foschia né nebbia; non c’è nemmeno una nuvola in tutto il cielo; tutto il visibile intorno a noi è terso, limpido, puro e il puntino rapidamente si ingrandisce, uscendo dal mare; pochi secondi e intorno a noi tutto prende colore, lo stesso colore che ha perso al tramonto della sera prima. Ora possiamo ammirare nitidamente l’interno del cratere di nord-est sotto di noi: molte fumarole si levano sonnecchianti da piccole fessure del fondo. La parte del sole emersa è già per metà fuori dall’orizzonte e tutta prende luce e vita. Dall’orizzonte fino alla costa sotto di noi si è formata una lunga striscia di lamine d’oro che scintillano al muoversi 47 della superficie del mare; il loro riverbero diventa sempre più forte e già il mare riprende il suo colore verde scuro e qua e là, appaiono gli sbuffi bianchi delle onde provocate dalla tramontana che soffia e dilaga giù dal monte, libera di allargarsi sulla superficie del mare come un canto che va incontro al suo dio, il sole. Ognuno di noi, in silenzio, è immobile ad ammirare lo spettacolo incandescente della natura che si risveglia nel silenzio religioso, pieno di vita e di speranza. I raggi del sole hanno raggiunto la Valle del Bove: ora si possono vedere nitidamente gli orrendi canaloni, interrotti qua e là da strane, gigantesche figure di mostri che allungano verso di noi le loro ombre sinistre; esse sembrano voler risalire le ripide pareti formate dalle migliaia di colate che si sono riversate per secoli in questo enorme canyon; viene facile il confronto: sotto di noi si stende la sinistra entrata all’inferno, davanti e sopra di noi si apre la serena pace del paradiso. Il sole è già tutto fuori dall’orizzonte e, nella nitidezza del mattino, è diventato una palla gigantesca che già ci scalda con i suoi raggi; il mare incomincia a diventare blu, un blu vivo, come se si fosse anche lui svegliato ai primi tocchi dei raggi del sole; e ora si vede chiaramente sulla sua superficie la schiuma bianca delle onde che si formano al largo. Dapprima il tremore sembra leggero, ma vedo Giuliano che si alza in piedi, preoccupato. Il tremore continua, crescendo d’intensità, accompagnato da un rumore sordo che cresce di momento in momento e di cui non si riesce a distinguere la provenienza; sembra sotto di noi o a fianco: non si sa. Improvvisamente il rumore diventa un orribile boato inaccettabile alle nostre orecchie: il vulcano ci avvisa che si è svegliato e arriva la prima vera scossa. Ci siamo tutti levati in piedi e non sappiamo cosa fare, mentre la terra sembra volersi togliere da sotto di noi. Perdiamo il senso dell’equilibrio; è come se galleggiassimo sopra un terreno non più solido. Anche Giuliano è spaventato e ci grida di restare calmi, ma come si può reagire alla paura istintiva, al panico che ti assale e ti toglie ogni razionalità? Nessuno più si interessa del sole, della bellezza del mare, dello spettacolo appena ammirato: vogliamo solo salvarci, ma non sappiamo come. Uno dei ragazzi mi passa di corsa davanti, il suo sacco in mano, e cerca di lanciarsi verso il basso; riesco a prenderlo appena in tempo per la giacca a vento e a fermarlo. 48 Il boato che ci ha spaventato è scomparso e la terra non trema più. Giuliano riesce a dominarsi e ci calma con le sue parole: “Calmi! - grida - State calmi, ho detto! Ora ci incamminiamo sulla strada del ritorno e scendiamo al rifugio con calma. Mi raccomando: con ...”. Ma non fa in tempo a finire di parlare: un’esplosione improvvisa, come se saltassero centinaia di chili di tritolo, ci investe da sotto: il tappo del cratere di nord-est è saltato e un’enorme palla di pietrisco, di fumo e di lava si alza orribile davanti a noi e ci raggela. Vorremmo buttarci direttamente giù dal pendio, per la strada più corta, ma Giuliano ci grida di seguirlo e si mette a correre lungo il sentiero che costeggia il cratere centrale. Spingo gli altri, incitandoli a non avere paura, ma mi rendo conto quando, in coda alla colonna mi metto a correre anch’io, che le gambe mi tremano: non posso far vedere che ho paura, come del resto anche Giuliano, che corre più avanti, seguito dagli altri. Per fortuna il vento spinge la grande fumata verso sud, ma l’aria è già irrespirabile e si sentono dei fischi sinistri. Un proiettile fiammeggiante grande come un uovo di struzzo passa sopra la testa di tutti con un fischio spaventoso e cade incandescente davanti a Giuliano che si ferma. Gli siamo tutti addosso e, per un istante che sembra una vita, attendiamo le sue istruzioni, mentre guardiamo inorriditi alle nostre spalle lo spettacolo di fuoco e fumo che ci sta inseguendo; ci sembra di aver percorso centinaia di metri ma la nuvola incombe su di noi, minacciosa, mentre la terra riprende a tremare. Giuliano osserva il pendio e calcola rapidamente la direzione da prendere; improvvisamente grida: “Giù tutti dietro di me!” e si lancia a rompicollo sprofondando fino al ginocchio nella graniglia di lava. Ci lanciamo tutti dietro di lui, mentre intorno a noi piove di tutto. E’ una discesa senza fine, con la paura che ci attanaglia, Giuliano in testa ed io sempre in coda, per essere sicuro di non perdere nessuno per strada. Stiamo percorrendo gli ultimi metri che ci separano dal rifugio, quando sembra che tutto esploda sotto di noi: una scossa di terremoto, più forte delle altre, ci sbatte da tutte le parti e rotoliamo senza riuscire a fermarci per l’ultimo tratto del pendio. Dal rifugio escono due tecnici che ci vengono incontro per aiutarci e finalmente ci troviamo al sicuro. E’ a questo punto che Giuliano, fatta la conta di tutti, riprende la sua sicurezza e, con la voce ancora rotta dall’emozione, ci dice: 49 “Beh! E’ stata una bella corsa!”. Scoppiamo a ridere, ma siamo ancora scombussolati. Seduti lungo il muro di cinta del rifugio, al riparo, ora più rassicurati, mentre beviamo del caffè caldo che ci viene offerto dal personale del rifugio, restiamo a guardare quello che succede in alto: dal cratere di nord-est esce una lingua di fuoco che si ingrossa sempre più e che, ad ogni ostacolo, si divide per riunirsi più in basso, si divide ancora e forma decine di fontane di oro fuso che cercano la strada più rapida per scendere a valle. Mentre percorriamo in macchina la strada del ritorno, sto ripensando al pericolo che abbiamo corso e alla ramanzina che ci hanno fatto i tecnici del rifugio. Hanno ragione: l’Etna non è una semplice montagna, è una creatura viva, paziente ma imprevedibile. Ma ci ha regalato momenti raramente ripetibili e, quando lo guardo dalla piana, alto e imponente, come se fosse a sé stante rispetto a tutto quello che lo circonda e che lui stesso nei millenni ha creato, ho per lui un senso di grande rispetto. Studiavo con due amici le varie materie giuridiche con una certa fatica non tanto per lo sforzo per imparare centinaia di nozioni, quanto per il caldo che spesso ci costringeva a studiare di notte. La maggior parte del tempo dedicato allo studio però la vissi con Roberto Sorge. A volte ci furono pomeriggi in cui studiavo Storia del Diritto Romano immerso in una vasca di acqua fredda mentre in altre occasioni andavo a studiare a casa di Roberto che aveva una terrazza che ci permetteva di respirare un po’ di aria di mare. Da quella terrazza ammiravamo la meraviglia della montagna che avevamo osato sfidare e che rimaneva silenziosa e sorniona salvo, ogni tanto, a sparare in cielo colonne impressionanti di fumo grigio, a volte a oltre tre o quattro chilometri di altezza. Roberto era un ragazzo accanito nello studio, ma quanto ad una sua possibile entrata nell’Opera non c’erano molte speranze, anzi, era propenso a sposarsi presto con un ragazza che conobbi un giorno: una bellezza isolana da togliere il fiato, studentessa anche lei alla facoltà di giurisprudenza. Capivo i programmi di Roberto e negli anni successivi ebbi occasione di ammirare la sua perseveranza che lo portò prima a diventare il prefetto di Milano e poi a gestire il Gabinetto del Ministro degli Interni. Provai anche con Tano Palumbo, era figlio di un noto avvocato che esercitava a Catania ma era di Palagonia dove possedeva aranceti in gran quantità. Ricordo le sue pazzie a bordo di un’Aurelia 2000 sui 50 tornanti dell’Etna: era matto. Oggi è un importante avvocato a Catania. Dopo quasi un anno cambiammo casa, andando ad abitare in una villa in una traversa di via Etnea molto vicina al “Tondo Gioeni” allora il punto di partenza per salire sull’Etna. Capitolo 17 E così feci il quindicesimo trasloco della mia vita. La villa era in una via in discesa e i ragazzini del quartiere la usavano per correre sui carrettini costruiti con tavole di legno e ruote con cuscinetti a sfera recuperati da qualche parte. Ma non erano come quelli che usavano i ragazzini a Milano; più complicati, erano dotati di due parti con doppio carrello per tenere più persone. Dietro la villa dove andammo ad abitare c’era un piccolo giardino con piante e una colombaia che si affacciava verso il retro di palazzine fatiscenti della via a monte. Di fianco un lungo tratto di terreno sconnesso era costellato di resti di macerie di qualche vecchia abitazione: il tutto era abbastanza squallido All’inizio della via, partendo da via Etnea, dopo una palazzina dotata di solide inferriate alle finestre di pian terreno (da quelle parti erano una precauzione indispensabile), sorgeva un costruzione che sembrava una capanna verticale in muratura con cupola come se fosse tra gli arabi. Aveva una sola apertura: una specie di entrata della dimensione di una porta coperta da un tenda fatta di tela di sacco. Era il simbolo della povertà di chi ci abitava, un’intera famiglia con molti figli, tutti racchiusi in un ambiente che non superava i tre metri per lato. Un giorno mentre rientravo dalle lezioni all’università il caldo era insopportabile e, quasi davanti alla villa della residenza dell’Opera, sul marciapiede di fronte, da una fontanella sgorgava un getto di acqua freschissima che finiva in un quadrato più basso di circa venti centimetri e largo un metro e mezzo, come fosse una specie di vasca Descrivo questo dettaglio per l’episodio che segue: dalla tenda della casa fatiscente, mentre mi avvicinavo alla fontanella per bere, uscì un ragazzino che non poteva avere più di quattro/cinque anni, nudo, ricoperto solo di un corta maglietta che non gli arrivava neanche all’ombelico. Aveva in mano una bottiglia di vetro e si avviò alla fontanella per riempire la bottiglia di acqua: doveva essere il servizio per la tavola della famiglia perché era l’ora del pranzo. Arrivato alla fontanella, scese nel quadrato che la limitava per non far uscire il getto 51 d’acqua e, mentre riempiva la bottiglia si mise a pisciare con il suo bel getto col quale si divertiva a mirare qua e là. “Attìa!” gli gridai “non puoi pisciare dentro, sotto la fontanella!” Non mi dette retta e continuò. Ripetei il rimprovero e a questo punto il ragazzino si voltò verso di me e, continuando a pisciare, mi gridò: “Fatti li cazzi tua!”. Me ne andai ridendo e pensando a come crescessero velocemente i ragazzini da quelle parti. Del resto era facile vedere delle automobili che passavano per le vie senza autista: avevano a bordo due ragazzini che avevano rubato il mezzo; uno sotto schiacciava i pedali su comando di quello di sopra che arrivava appena alla base del parabrezza e manovrava il volante nel traffico con la massima disinvoltura. Si studiava preferibilmente di notte a causa del caldo opprimente oltre i 44 gradi ma avevamo spesso la compagnia di un gatto che miagolava sul retro della villa dal lato delle cucine. Un giorno, esasperato, raccolsi un grosso ceppo di legno e lo portai sul tetto che era in realtà una grande terrazza dalla quale si poteva ammirare la distesa di tetti degradanti verso il mare. La notte seguente il gatto iniziò la sua sinfonia ed io dall’alto del tetto centrai al buio il gatto. Ma con mia sorpresa i gatti erano molti di più e fuggirono arrampicandosi sul muro di cinta di fronte a me che costeggiava la villa e che era alto almeno sei metri. Il gatto colpito si stava arrampicando velocemente ma ad un certo punto sembrò fermarsi, tentando di mantenersi attaccato al muro con le unghie, Un secondo dopo ricadde mentre le sue unghie cercavano disperatamente di tenerlo attaccato al muro. E tornai a dormire soddisfatto. Ma la mattina dopo mentre durante la colazione raccontavo l’accaduto stupidamente orgoglioso di aver tolto di mezzo il disturbatore notturno, Gino, il direttore della casa, mi chiese: “E’ per caso quel gatto che da qui si intravede disteso sotto lo scalone esterno della villa?” Uscii e trovai il gatto maledetto disteso e immobile: era morto. Rientrai: “Evidentemente era lui e l’ho colpito in pieno” confessai.”Bene; adesso ti occupi tu di seppellirlo!” e la voce di Gino era piuttosto incavolata verso di me. Seppellii il gatto sotto una Euphorbia che cresceva in fondo al giardino. Si chiama volgarmente “Stella di Natale “ ma di solito faceva pochi fiori rossi striminziti. Invece quell’anno la sua fioritura fu splendida, forse perché le avevo dato un buon concime con il corpo del gatto? 52 Capitolo 18 La frequenza all’università era assidua e, dopo un avvio infelice a causa di un assistente di diritto privato assillato dal bisogno di eliminare un buon numero di iscritti al primo anno, gli altri esami incominciarono ad andare bene. La vita universitaria era positiva per me anche perché cercavo di fare molte amicizie come potenziali frequentatori dell’Opus Dei. Ma a Catania gli studenti universitari erano in parte bambini in parte molto più sgamati del nord. Per esempio un giorno un gruppo dopo aver tolto i pantaloni ad una matricola e trattenutolo in mutande mentre i suoi pantaloni partivano attaccati ai fili di un autobus che riprendeva la sua corsa da una fermata, lo lasciarono poi inseguire l’autobus per almeno cento metri in mutande. Oppure assistevo a fanatiche riunioni di affiliati del FUAN, una specie di nuova organizzazione del fascismo. Di fatto Catania nelle elezioni di quegli anni ha sempre avuto un alto numero di voti per il MSI. E arrivò un episodio triste: la zia Amalia ad Agrigento si era ammalata da tempo ma, terziaria francescana molto bigotta, non voleva farsi visitare dei medici perché avrebbe dovuto spogliarsi davanti ad un medico: un uomo! E il suo male peggiorò al punto che, troppo tardi, i medici si resero conto che un tumore al fegato se la stava portando via. I contatti tra me e mio padre erano frequenti e un paio di volte andai ad Agrigento per sincerarmi del suo stato di salute ma venne il giorno in cui la malattia si aggravò e morì; mio padre decise di scendere in Sicilia. Con l’occasione si fermò a Catania per passare alcune ore con me. Il Direttore della casa mi diede il permesso di andare a ricevere mio padre in stazione ma mi proibì, non so perché, di portarlo alla residenza. Fu un incontro falso con una facciata apparentemente occupata col pensiero della zia, in realtà mio padre non sapeva come toccare il tasto” sei felice nell’Opus Dei?” oppure: “Come ti trovi a Catania?” o ancora “come passi la tua vita e pensi di rimanere con loro per molto tempo?”. Non si rendeva conto di che cosa fosse l’Opera né io gli davo la possibilità di entrare in particolari che forse avrebbero aiutato lui e me a convivere meglio la nostra vita. Pranzammo in un ristorante vicino alla stazione e poi mio padre ripartì per Agrigento. 53 Nel frattempo maturò il momento della verità. Intendo dire che io non portavo soldi miei per il mio mantenimento nell’Opus Dei e questo veniva momentaneamente accettato, forse per capire se la mia vocazione sarebbe stata duratura. Ma i problemi economici li aveva anche l’Opera e quindi era necessario che io trovassi un lavoro per giustificare il mio sostentamento. Così i miei superiori trovarono la soluzione: trasferimento a Palermo in una delle due case (c’era la casa dei “piccoli” come venivano affettuosamente chiamati i giovani studenti liceali, e quella dei professionisti, dove due architetti, un medico e due ragionieri formavano un secondo nucleo). Io fui destinato alla casa degli studenti e così ebbi il mio sedicesimo trasloco della mia vita. Mi fu chiarito che sarei andato a lavorare in un magazzino di libri della filiale delle Messaggerie Italiane, dove il direttore era un sopranumerario dell’Opus Dei (ma la moglie no, anche se lavorava anch’essa in filiale) e c’era tra i quattro magazzinieri anche un ex dell’Opus Dei che però stava per passare a lavorare in una libreria. Così imparai un nuovo “mestiere” che mi piaceva anche molto perché avevo sempre avuto una particolare passione per la carta stampata, cosa che mi è poi rimasta per sempre fino ad oggi: per me il libro è una cosa talmente sacra che, se potessi, anche se ho 74 anni, aprirei subito una libreria qui ad Assisi, anche se so che non legge nessuno e col tempo questa negatività aumenterà sempre più, tanto è vero che gli editori stanno correndo ai ripari con internet, e-book e cose simili, pur di mantenere alte le tirature, specie dei quotidiani. I contatti con la mia famiglia erano sempre molto sporadici e le lettere sia in andata che in arrivo dovevano sempre passare dal direttore della Casa. A Palermo avevamo un certo Calafat che era un venditore di candele speciali per auto e come direttore spirituale don Giorgio che era stato per molto tempo l’autista del Fondatore a Roma. Perché ora fosse a Palermo restava un mistero. E conobbi finalmente la vita di Palermo, una città ricchissima di cose belle e brutte, di misteri e di meraviglie. L’università viveva una vita diversa: dei debosciati sia tra gli studenti che tra i professori, con esami che passavano la maggior parte solo per raccomandazioni. Studiare e lavorare era più faticoso ma mi ci buttavo dentro a pesce per imparare, per vivere una vocazione che ritenevo sincera. Quante domeniche dedicavamo ai più giovani in gite dietro Palermo, a Monreale, sui monti sopra Boccadifalco. Con uno dei ragazzi appas54 sionato di aeromodellismo costruimmo un aereo con motore da un cc. di cilindrata, detto “a testa calda” che collaudammo con un successo insperato: lanciammo col telecomando il modello dal monte Pellegrino in un mattinata senza vento in direzione dell’aeroporto di Boccadifalco, che da tempo non veniva più usato per i voli di linea. Nel frattempo altri amici si erano piazzati all’inizio della pista del vecchio aeroporto per cercare il posto più vicino e libero in direzione otticamente rettilinea con noi. Dopo alcune centinaia di metri il nostro velivolo continuò il volo da solo perché non avremmo più potuto raggiungerlo con i nostri telecomandi. La nostra speranza era che non cambiasse all’improvviso direzione. Da Boccadifalco aspettavano di scoprire col binocolo la sagoma del piccolo aereo e finalmente lo videro. Misero in azione il telecomando e poco tempo dopo si accorsero che erano riusciti ad agganciarlo, dopo di che lo guidarono fino alla pista dove atterrò gloriosamente tra le grida di gioia di tutti, dandoci la soddisfazione di essere riusciti a fare qualcosa di grande. Ci sentivamo come Lindbergh quando vide le coste della Francia nella sua trasvolata atlantica! Fu in quel periodo che una domenica accompagnai il sacerdote della casa dei professionisti e uno degli architetti a Terrasini dove ci incontrammo con il sindaco (almeno dai discorsi tra di loro mi sembrò tale). Fui gentilmente invitato ad andarmene a visitare il museo dei carretti siciliani lì vicino mentre gli adulti confabularono tra loro per molto tempo confusi tra i tavoli stesi nella piazza principale alberata dove si stava svolgendo una delle sagre del paese.. Molto tempo dopo capii perché non volevano testimoni: era un incontro per concordare la concessione della parte migliore del bagnasciuga e del retroterra di Calarossa, una delle più belle cale della zona, dove poi nacque una costruzione che sembrava un albergo: era la sede della sezione femminile dell’Opus Dei! E arrivò il momento del diciassettesimo trasloco: fui trasferito nella casa dei professionisti perché stava arrivando un cambiamento nel mio lavoro. Con una società fittizia l’Opera, in persona di uno dei membri, Franco Rocca, aveva da un anno acquistato una libreria, la ex-Taddei di via Maqueda e l’aveva affidata a quell’ex-Opus Dei, Raoul, che aveva poi ottenuto il trasferimento alla sede di Milano delle Messaggerie. Era quindi necessario un nuovo direttore e solo molto tempo dopo mi resi conto che il piano predisposto di un certo Pin e da altri che si occupavano degli affari della “famiglia” era a lungo termine: prima a Catania per provarmi e farmi ambientare, poi la decisione di scegliere 55 la facoltà di legge anziché di medicina in modo da avere più tempo libero e meno obbligo di frequenza (solo allora capii i discorsi ripetitivi e persuasivi di Don Francesco Angelicchio, un prete dell’Opus Dei invischiato con l’ambiente del cinema e di Cinecittà, attori e registi, non ché finanziatori). Da qui una preparazione nel commercio dei libri e nella gestione dei magazzini mentre Raoul si occupava della libreria ed infine, quando Raoul fu chiamato a fare carriera a Milano (anche se libero da vincoli con l’Opus Dei aveva tutta la convenienza ad andare a Milano), mi dettero l’incarico della conduzione della libreria come responsabile. E incominciò una nuova esperienza, bella, interessante e nella quale mi tuffai con entusiasmo, assolutamente senza capire i programmi e i piani di chi mi stava segretamente guidando con le redini più occulte! Restava il problema dell’università e gli esami erano momentaneamente fermi, ma ne parleremo tra poco. Capitolo 19 La libreria: Aveva una piccola vetrina, un locale ristretto a pian terreno e una serie di stanze al primo piano dove Franco Rocca era riuscito ad avviare anche delle mostre di quadri moderni (ottenne perfino Vedova e Kokoscia!). Raoul aveva lasciato in libreria un’impiegata e un fattorino. In particolare l’impiegata era una bella donna, vedova giovane di Agate, quello che era stato il fondatore della libreria Dante ai quattro Canti di città, una delle più gloriose librerie che ospitava ancora Pupella, poi diventato direttore della libreria Rizzoli in Galleria a Milano e Magnolfi, un toscano che morì con la moglie di ritorno da Firenze sull’aereo che si schiantò pochi anni dopo sulla Montagna Grande vicino all’aeroporto di Punta Raisi. La donna, Marisa Ficara, aveva trentadue anni e da commessa era diventata moglie del vecchio Agate ma che era morto di infarto mentre faceva all’amore con Marisa. Aveva tutte le caratteristiche di una bellissima siciliana, era molto sensibile, fine e molto attraente. Capii subito che per me sarebbe stato un problema perché si notava che aveva ancora tanta fame di amore fisico. Mentre in libreria svuotammo montagne di titoli vecchi con una svendita che mandò su tutte le furie l’avv. Domino, proprietario di una libreria in via Roma e presidente dei librai palermitani, io tentavo, con non molto successo, di studiare per preparare gli esami alla vicina u56 niversità dove nel frattempo avevo trasferito la mia iscrizione da Catania. Passò in tutto un solo anno ma le cose si precipitarono una sull’altra molto rapidamente. Intanto mi ero accorto che ero oggetto di particolari attenzioni da parte di Marisa che ignorava la mia appartenenza all’Opus Dei. Spesso arrivava in libreria una bella donna sui quaranta, anch’essa chiaramente affamata e moglie di un socio sopranumerario dell’Opera, ignaro delle voglie della moglie. Se avessi voluto avrei potuto divertirmi molto e bene con ambedue le donne. Invece credevo nella mia “vocazione” e tenevo duro, ma era una grossa fatica. Si può immaginare quali voglie può avere un giovane di 22 anni: era il 1960 e man mano che passava il tempo un tarlo mi rodeva dentro dicendomi che era ora di ritornare a Milano dai miei e di ricominciare a vivere una vita normale. Una sera dovetti trattare male la moglie del sopranumerario, di cui non faccio il nome per carità: era arrivata in libreria all’ora di chiusura e si offrì di accompagnarmi a casa. Le sue intenzioni erano chiare m a io dovetti chiederle di accostare la vettura in via Ruggero Settimo e, scendendo, le chiedi scusa se non potevo accontentarla. Mi guardò con aria stupita, ma poi capì e ripartì incavolata come una bestia. All’università succedeva di tutto: il professore di economia politica poneva domande assurde agli studenti (ad esempio: Lei è di Agrigento; mi sa dire quanti lampioni ci sono lungo il viale di San Leone, la passeggiata a mare? Se me lo sa dire le do un 18). E l’allievo, ancora più sgamato, da buon siciliano, dopo aver fatto finto di contarli a mente in un’immagine dei suoi ricordi, rispose “39”. Il professore scrisse il voto e gli chiese come aveva fatto a contarli. Lo studente prima si fece dare il libretto e poi rispose: “passeggiando con sua moglie”. Ci fu un putiferio ma il professore non poteva più rimangiarsi il voto e nemmeno le corna che gli furono attribuite). Più grave fu il caso del mio esame di diritto penale: non sapevo che un dodici bolli (era un anziano studente che vantava dodici anni di iscrizione alla facoltà di legge) si faceva pagare una cifra non indifferente per poter sostenere con successo gli esami di diritto penale. Era perennemente iscritto all’università perché una zia gli aveva lasciato una rendita consistente “fin che non si fosse laureato”. E lui continuava a “non laurearsi”. Questo era l’ambiente alla facoltà di legge. Ma passiamo la mio esame. Arrivato davanti all’assistente (il professore, man mano che procedevano gli esami, moltiplicava le commissioni tra lui, gli assistenti e gli 57 studenti che avevano passato l’esame con un trenta) mi sentii chiedere come mai il mio nome non c’era in un elenco che aveva prima sbirciato in un cassetto della scrivania, dopo aver letto il mio libretto. Capii l’antifona e feci finta di niente. Accettai di fare ugualmente l’esame e alla fine rifiutai un misero 19 che l’assistente voleva propinarmi. Ne nacque un alterco con voci sempre più alte fin che tutto finì davanti al professore. L’assistente mormorò qualcosa all’orecchio del professore che mi invitò ad attendere e, dopo aver finito con lo studente che aveva davanti, ricominciò con me l’esame andando contro ogni regola. Alla fine mi disse che meritavo un 23 e io lo accettai anche se nei suoi occhi si leggeva l’imbarazzo per non poter sputtanare il suo assistente in quanto avevo fatto un esame da trenta. Questo era l’ambiente universitario e io facevo molta fatica ad accettare di viverci sforzandomi di studiare e lavorare. Incominciai a parlarne con don Michelangelo, il sacerdote della casa e con il direttore laico, un architetto. Cercavo di far capire loro che così le cose non potevano andare avanti ma loro nicchiavano pensando forse alla figura che avrebbero fatto con il fondatore se mi avessero perso e mi proposero di attendere e di riposare negli esercizi spirituali che stavano per arrivare. Verso la fine di aprile dovevo partecipare agli esercizi spirituali sulle colline davanti a Pollina, vicino a Cefalù , in una fattoria molto vasta, di proprietà proprio di quel povero marito sopranumerario e potenzialmente cornuto: lì avrei avuto modo di chiarirmi le idee e di riposarmi, rivedendo positivamente la mia vocazione. Ma non fu così: tra un’orazione e l’altra giravamo per la fattoria a meditare e io mi arrampicai verso la cima del crinale che sovrastava la tenuta in direzione di Milazzo. Mentre salivo ammirai due lepri che, sorprese dal mio arrivo, fuggirono spaventate. Proseguii e arrivato in cima mi accorsi che vi erano della pietre larghe e piatte che sembravano messe apposta lì per ammirare seduti il panorama: mi sedetti e rimasi a lungo a osservare le isole dell’arcipelago delle Eolie. Poi, come se mi avesse preso una specie di torpore, mi sdraiai sulla nuda pietra osservando in cielo il passare veloce di nuvole dalle forme bellissime. Fu allora che accadde qualcosa di misterioso: niente di speciale ma sopra la mia testa, a circa venti metri apparve un grande uccello, credo un’aquila, che si mise a girare in cerchio sopra di me per alcun istanti. Poi con un urlo acuto si tuffò nel burrone sottostante dalla parte opposta da cui ero arrivato e scomparve. 58 Non so come ma da quel momento mi sentii fuori dall’Opera e, questo era per me più importante, in pace con Dio. Quando scesi parlai con il sacerdote e la sera stessa tornai con Franco Rocca a Palermo, approfittando di un suo passaggio perché doveva rientrare per lavoro. Ancora una volta parlai con i miei superiori ma non ci fu verso: non mi lasciavano andare. Presi la decisione definitiva alcuni giorni dopo e mi organizzai nei giorni successivi. A Milano mia sorella la domenica 14 maggio 1961 avrebbe fatto la cresima e per me sarebbe stata una buona occasione per parlare con i miei, ma loro mi negarono ogni possibilità. Tacqui e organizzai tutto in silenzio: prenotai una cabina sulla nave da Palermo a Napoli e acquistai i biglietti. Trattenni cinquanta mila lire come stipendio del mese e il giorno 12 , prima di recarmi al porto, affidai al fattorino una lettera da consegnare al direttore di via Leopardi, dove c’era l’appartamento dei professionisti e dove io abitavo. Salii a bordo della nave e …. E per il resto vi rinvio alla lettura del libro “OPUDEI: CINQUE ANNI IN QUATTRO GIORNI”, contenuto nel mio sito www.cristotranoi.it, che incomincia proprio così: “Sul ponte più alto: ho paura che mi scoprano e da qui penso di controllare meglio il movimento su tutto il molo d’imbarco, sulla folla che si accalca sotto la nave fino all’ultimo per vedere e salutare chi parte, sulle auto che arrivano di corsa e scaricano persone che sono in ritardo e che si incrociano con chi scende dalla passerella dopo aver abbracciato ancora una volta i parenti che partono.” Capitolo 20 Il 14 maggio con la scusa di essere arrivato a Milano per la cresima della sorellina, affrontai i miei genitori e nel pomeriggio, incominciai a dire a loro che … quando squillò il telefono. Il giorno prima avevo parlato con don Giambattista Torellò, il responsabile di tutta l’Opus Dei italiana che tentò ancora una volta di convincermi. 59 Mia madre tornò dal telefono in corridoio dicendo che c’era in linea una mia vecchia compagna di scuola. “Chi è? “ chiesi, ma mia madre disse che non aveva detto il nome. Andai all’apparecchio e all’improvviso mi crollò il mondo addosso: dall’altra parte riconobbi la voce di Giovanna. Il seguito al prossimo capitolo ma prima devo precisare che con il prete dell’Opera ci fu il giorno dopo un ultimo penoso incontro perché commisi l’ingenuità di fargli notare la felice coincidenza: avevo lasciato Giovanna il 6 novembre 1956 in piazza Conciliazione “per andare a farmi santo” e la ritrovavo il 14 maggio 1961 al telefono, libera, non sposata, non fidanzata. Dedussi che il Padreterno o il destino avevano voluto una tale coincidenza che può sembrare epr lo meno pazza. Seguirono giorni felici ma l’Opus Dei per il comportamento di don Giambattista e degli altri suoi simili mi offese in profondità e mi cadde dagli occhi e dalla mente. Il prete si era permesso di insinuare che nei cinque anni io avevo avuto dei contatti per non dire dei rapporti con la ragazza che avevo lasciato cinque anni prima! Gli chiesi allora di confessarmi e, terminata la confessione, ottenni finalmente di stilare la lettera di dimissioni. Oggi raccomando vivamente di stare alla larga da loro anche perché col tempo si è snaturata la vera intenzione del fondatore e l’Istituto che si definisce prelatura col diritto di fare quello che vuole senza chiedere il permesso né al papa né ai vescovi, oggi è diventato uno strumento deleterio e venefico in campo finanziario per noi e anche dentro il Vaticano dove spadroneggia anche al di sopra di Gesuiti e Domenicani, il che è tutto dire! Nei giorni successivi dovetti risolvere molti problemi ma soprattutto dovetti tornare a Palermo per definire la chiusura del mio rapporto con la libreria. Non potevo più abitare in casa dell’Opus Dei e dovetti anche cambiare casa andando ad abitare in una pensioncina dietro il Politeama, squallida ma economica. E questo lo possiamo chiamare il diciottesimo mio trasloco, anche se per poco tempo. Ovviamente ruppero tutti i ponti con me con una “carità cristiana” degna della loro bigotta ipocrisia. Una sera fui ospite di Marisa che aveva preparato una magnifica aragosta apposta per me: c’era in tutto il suo modo di fare il dirmi che aveva capito tutto e la speranza di avere finalmente la possibilità di un rapporto fisico che tanto desiderava: per lei, in una città come Palermo non c’erano molte possibilità di evadere dalla morale siciliana che im60 pone alle vedove una castità assoluta e nel contempo uno scopare di nascosto a tutto spiano e in piena libertà. Ma io avevo altre intenzioni. Intanto acquistai con i pochi soldi che avevo un piccolo anello di fidanzamento per Giovanna che mi asciugò i pochi soldi che avevo da un gioielliere davanti alla libreria e che feci spedire: un fidanzamento per posta è sempre qualcosa di originale! E quando rientrai a Milano il racconto meravigliato di Giovanna e delle facce dei suoi genitori fu per me la conferma che finalmente la mia vita stava prendendo la strada giusta. Fatte le consegne, raccolte poche cose mie (il resto mi fu consegnato in un ufficio di uno dei numerari che, tra l’altro era anche gay, solo quando tornai in ottobre a Palermo in viaggio di nozze). A Milano intanto Giovanna dovette operarsi di appendicite ed io tornai di corsa a Milano un’altra volta per starle vicino. Ma dovevo tornare a Palermo a sistemare tante cose. E da quel momento gli eventi precipitarono in un modo assurdo ma terribilmente reale: ripartii da Milano il 15 giugno con la Freccia del sud per arrivare a Palermo il sedici. La mattina dopo, mentre ero ancora nella pensione mi arrivò una telefonata di Marisa: mia madre aveva telefonato in libreria avvisando che mio padre era stato male di notte, colpito da una paresi e che era stato ricoverato al Fatebenefratelli con prognosi riservata. Per fortuna il fratello di Marisa era pilota dell’Alitalia e questo mi permise di trovare un posto sul primo volo per Milano. Per distrarmi durante il volo mi fece compagnia il fratello di Marisa che non stava pilotando, sostituito da un vecchio pilota militare che, per mantenere il brevetto, doveva fare ancora un po’ di ore di volo. Fece un atterraggio perfetto a Linate ma se il fratello di Marisa non fosse intervenuto in tempo la vetrata dell’aeroporto sarebbe esplosa, colpita dall’urlo dei motori a mille del DC-6 che il pilota si era dimenticato di spegnere. Da quel momento avevo chiuso definitivamente con l’Opus Dei e avevo sostituito mia madre in ospedale per la notte. Seppi finalmente che cosa era successo: mio padre durante la notte si era voltato nel letto per pisciare come al solito nel pitale ma cadde a terra perché la parte sinistra del corpo era improvvisamente paralizzata. Da qui iniziò per lui una tragedia che durò tredici anni, culminando poi in un intervento doppio al retto per un tumore; terminò di vivere tra le mie braccia il 10 novembre 1974 alle quattro di mattina, assistito anche da mia madre e da mia sorella. Io credetti per molto tempo che la causa fosse il dispiacere di aver saputo che ero uscito dall’Opus e che mi ero rimesso con Giovanna, con 61 la paura conseguente che non mi sarei più laureato. E vissi per molto tempo con questo rimorso ma un giorno scoprii la probabile causa del suo male: mia madre mi raccontò che la sera prima erano andati allo Smeraldo dove avevano assistito ad un varietà con molte ragazze succinte che avevano eccitato mio padre al punto che, tornati a casa, aveva voluto sfogare la sua voglia di sesso per più volte. E questo forse fu la vera causa del suo male. Amen, non voglio commentare ulteriormente il mio destino e quello di mio padre (e anche quello di mia madre che, per aiutarlo ad andare in ufficio con una gamba semiparalizzata ed il braccio completamente inutile, aveva dovuto prendersi la patente a cinquantacinque anni e comperare una cinquecento a rate per accompagnarlo). Capitolo 21 E dal giugno 1961 la mia “nuova” casa fu quella dei miei genitori, con mio fratello che aveva poca voglia di studiare (aveva 19 anni e non si era ancora diplomato in ragioneria) e mia sorella che a nove anni dovette iniziare la sua vita di bambina con la compagnia giornaliera di un padre paralitico. E questo fu il mio diciannovesimo trasloco ma non era ancora finita qui. Gli scontri con mio padre sui miei rapporti con Giovanna erano giornalieri ed io avevo bisogno di trovare lavoro mentre mio padre rompeva con la storia che io, sposandomi con Giovanna e avendo lasciato l’Opus Dei, non mi sarei laureato: era la sua fissazione e non potevo farci nulla (anche perché non potevo dirgli chiaro il mio sospetto: uscendo io dall’Opera lui ora mi avrebbe dovuto ora mantenere!). Mia madre poi, invece di difendermi, dava corda a mio padre ma in un altro modo e manifestava apertamente cose pensasse di Giovanna. Ero praticamente tagliato fuori da ogni rapporto umano: famiglia, università, lavoro. L’unico sollievo era Giovanna che, dopo un breve periodo in cui ci raccontammo tutti i cinque anni trascorsi lontano una dall’altra nel primo pomeriggio del 16 maggio al bar di via Borgogna dalle cinque fino a tarda sera, incominciammo a conoscerci meglio, da ragazzi del liceo ad adulti pronti ad affrontare la vita nel matrimonio. Il nostro amore era puro e sincero. Ma senza lavoro come potevo fare? Mentre mi iscrivevo all’Università di Milano per riprendere gli studi (mi mancavano ancora pochi esami), Giovanna che lavorava alla Total (allora ancora Pe62 troli Aquila), riuscì a farmi assumere nella contabilità e questo mi permise di respirare un po’. I suoi genitori avevano a Moltrasio, come ho già detto, un piccolo appartamento in affitto e durante l’estate la madre si spostava stabilmente in questa casa con il cocker che avevano, lontano dai genitori di lei, mentre il padre e la figlia facevano la spola con Milano per il lavoro con corriera o battello e treno delle Ferrovie della Nord. A mezzogiorno andavano a mangiare in un vicino servizio mensa abbastanza economico; mi unii anch’io e questo mi permise di conoscere meglio la bontà d’animo del mio futuro suocero. Alla sera dovevo tornare in Largo Boccioni ed ogni volta era un tormento, anche perché mio padre, anche a causa della malattia, si era invelenito. A volte li accompagnavo a Moltrasio per cenare con loro e tornavo a Milano la sera tardi. Da Moltrasio scendevo per la lunga scalinata che portava all’imbarcadero mentre il battello, lasciata Torno, attraversava il lago per attraccare al molo di Moltrasio. Dal battello a Como prendevo l’ultimo treno per Milano e, per arrivare a casa prima, scendevo dal treno in movimento all’altezza della nuova fermata (quella di Quarto Oggiaro che era in costruzione) perché il treno rallentava per i lavori in corso. E di qui a piedi erano circa due chilometri per arrivare a casa. Mio padre faceva come suo padre quando lui abitava ancora giovane ad Agrigento: mi aspettava in piedi dietro la porta con l’orologio in mano. Così, dopo essere stato fuori di casa per quattro anni ( e lui non poteva sapere come fossero state le mie serate a Catania o a Palermo) mi faceva la guardia alle 23 e trenta mostrandomi l’orologio e protestando. La vita in quella casa per me era diventata impossibile e un giorno decisi che dovevo andarmene. Ne parlai con Giovanna che trovò la soluzione con i suoi: abitavano a sud di Milano in zona porta Ticinese (via Bonghi 6) al primo piano con i genitori di quella che poi divenne mia suocera e avevano preso in affitto (per mia fortuna) da oltre un anno un appartamento al secondo piano che usavano solo di giorno per il pranzo o la cena, volendo stare alla larga dei suoceri che avevano un caratterino non facile. Fu così che decidemmo di avviare una poltrona letto al secondo piano mentre al mattino andavamo poi al lavoro insieme. Una sera presi la decisione definitiva dopo che mio padre aveva insultato il nome di Giovanna e mi aveva detto: “Approfitti del mio male altrimenti ti schiaffeggerei!” Non l’avesse mai detto. Gli risposi freddo: 63 “Non accetto che tu insulti la mia fidanzata e se vuoi schiaffeggiarmi, ti aiuto a tenerti in piedi dal braccio malato, così puoi soddisfarti!” Lui lo fece e mi schiaffeggiò: avevo 23 anni e quattro anni fuori casa: aveva superato il limite. Di notte di nascosto raccolsi quel poco che mi sarebbe servito e la mattina uscii per ritornare in quella casa solo molti mesi dopo, ma sposato. Fu allora che dissi a mio padre: “Quando mi laureerò, perché alla faccia tua io mi laureerò anche se tu non ci credi, tornerò con Giovanna e tu dovrai chiederle scusa degli insulti che ti sei permesso nei suoi confronti”. E dai primi di agosto del 1961 andai ad abitare al secondo piano di via Bonghi, in casa dei miei futuri suoceri. Era il ventesimo trasloco della mia vita. Risolsi i miei problemi economici per potermi sposare grazie all’aiuto generoso di Alberto Falck, forse anche perché era riuscito a non entrare nell’Opera, pur frequentandola e capiva in quali condizioni mi ero trovato io dopo quei cinque anni. Fu la madre di Alberto a prestarmi ben due milioni di lire che poi non volle mai in restituzione. Potemmo così mettere su casa e arredare il nostro nido, oltre a partire per un viaggio di nozze in aereo fino a Roma e poi a Palermo e da lì con una moto a noleggio, una vecchia Agusta 125 monosellino con la quale portai Giovanna proprio nella fattoria in cui avevo deciso di tornare alla vita normale. A Palermo fummo ricevuti quasi a calci nel sedere: una valigia con quello che era rimasto nella casa di mio mesi prima mi fu consegnato in un ufficio da Giancarlo, il gay e don Luigi Tirelli mi accusò nientemeno di “essermi permesso di portarmi la moglie nella città in cui avevo lasciato praticamente la mia fidanzata”. Ora va bene tutto ma paragonare l’Opera a una fidanzata mi parve talmente stupido che non risposi all’offesa, anche perché offendeva mia moglie e la mia libertà di cittadino del mondo, i cui problemi eventuali interiori erano miei e non dell’Opera. L’ultima tappa del viaggio di nozze fu Assisi dove restammo due giorni e di allora ho ancora foto ricordo. Al rientro a Milano restava il problema del lavoro ma presto rimediammo; Giovanna proseguiva con la Total mentre io andavo in giro per Milano con Toti, mio suocero, a vender sali da bagno e cose simili. Intanto avevo ripreso a studiare e preparare uno degli esami più difficili: procedura penale. Ma rimanevano altri esami altrettanto fastidiosi che però riuscii a superare. La mia tigna era dovuta alla scommessa 64 che avevo fatto con mio padre e non vedevo l’ora di sbattergli sul muso il certificato di laurea. Pochi mesi dopo entrai nel corso della Standa per gerente (grazie ad una parola buona del parroco di Moltrasio ad un membro della famiglia Monzino proprietari della Standa di allora. Alla fine del corso fui assunto come allievo gerente a settantamila lire al mese nella Standa di Via Pattari, ma pochi mesi dopo trovai lavoro presso la Finarte (una nuova casa d’aste che oggi è un importante finanziaria e non solo per antiquari), con uno stipendio doppio e, oltre ad un incarico amministrativo interno divenni anche battitore delle commissioni di chi non voleva far sapere che partecipava agli acquisti. Da allora potei finalmente respirare una vita matrimoniale normale e guardare al futuro con Giovanna con maggior sicurezza. Si incominciava a pensare ad un figlio ma era troppo presto. Alla Finarte si battevano le aste di antiquariato all’Angelicum con la stessa serietà e ricchezza di valori di opere della Sotheby e potei avere tra le mani alcuni pezzi di grande importanza. Un caso per tutti: una sera andava all’asta un Morandi per il quale in sala un importante notaio di Milano mi aveva dato una commissione fino a otto milioni per poter arrivare a possedere il suo cinquantesimo Morandi! E proprio quella sera, la telefonata di un amico mi informò che Morandi era morto poche ore prima. Scesi in sala e avvisai il notaio, presente ma anonimo tra il pubblico, dicendogli che io mi sarei fermato alla sua commissione; poi avrebbe dovuto proseguire lui. Mi ringraziò e comprò il Morandi a oltre dodici milioni combattendo con qualcun altro che aveva saputo. Passò così il 1962 e nel 1963 e decidemmo di avere un figlio che nacque, col nome di Francesco il 20 luglio 1964 in casa, ostetrica la Giorgetti Brambilla, la stessa che aveva fatto nascere Giovanna. Per anni sperò di poter far nascere i figli di mio figlio ma morì in tarda età senza poter vedere soddisfatto il suo desiderio.- Ancora oggi, mio figlio a 48 anni, non ha figli, credo perché non li ha mai voluti, come del resto sua moglie, Catherine di origine svizzera tedesca da parte di padre, sposata nel 1992. Lo stesso dicembre del 1964, Francesco aveva cinque mesi, una tegola gigantesca si abbatté sulla mia vita e su Giovanna: mi costrinsero a partire per il sevizio militare. E questa volta feci ben tre traslochi: prima a Casale a fare il CAR (cioè il cretino che impara a tirare la bomba a mano e a marciare), poi alla Cecchignola ad imparare a manovrare i ponti radio ed infine a Mi65 lano, ma in Corso Italia dove c’è una caserma che allora ospitava il “Genio trasmissioni”. Isolato in una stanza dove gestivo un ponte radio tra Roma e Vercelli, studiavo l’odiato Diritto Amministrativo per completare il corso di laurea. Intanto Giovanna dovette rinunciare al suo lavoro per poter allevare nostro figlio. Così dal 7 gennaio al 13 ottobre 1965 ci partirono oltre sei milioni tra le liquidazioni per poter vivere, i viaggi e tutto il resto. Cinque tentativi per ottenere i tornare a casa andarono in fumo, perfino quello di un importante monsignore che conoscevo. E soprattutto persi il lavoro alla Finarte, posto prezioso di lavoro ma allora la giusta causa o l’art. 18 non funzionavano. All’inizio di ottobre avevo aiutato una commilitone a scappare di giorno per accudire all’azienda del padre che aveva avuto un infarto e solo allora trovai la strada giusta per le amicizie che aveva con il segretario di Andreotti, allora ministro della difesa. E fu così che lo stesso che mi aveva più volte rigettato la domanda basata sulla necessità di mantenere un famiglia, concesse al mio amico per me una “licenza straordinaria in attesa di congedo” che potei ritirare solo all’inizio del 1966. Ma già prima di Natale avevo trovato lavoro: fui assunto dalle stesse Messaggerie Italiane che avevano la filiale a Palermo dove avevo lavorato nel 1960 come commesso per quasi un anno con quel signore sopranumerario. E finalmente incominciò una carriera di lavoro, irta di tanti problemi ma decisamente più tranquilla delle avventure del mio passato. E la nostra vita iniziò un periodo sereno con un figlio e le materie che studiavo di notte per laurearmi mentre lavoravo di giorno. E venne la tesi di laurea: un vecchio cliente della Finarte, il professor Franceschelli di diritto commerciale era un appassionato collezionista di Madonne dell’ottocento e chiesi la tesi a lui. Voleva che la facessi sul Mercato comune ma io gli proposi un’idea un po’ stramba che accettò con entusiasmo: “Tipo di contratto in uso tra pittori e mercanti d’arte”. Il 6 luglio finalmente mi laureai con un voto abbastanza modesto: 98 centesimi, ma con il titolo in tasca e questo era quello che volevo. Il giorno dopo portai Giovanna da mio padre che dovette finalmente chiedere scusa a mia moglie. 66 Capitolo 22 Non metto in conto i tre trasferimenti da militare perché erano già troppi gli altri che avevo fatto. Iniziò finalmente un buon lavoro con un uomo che ancora oggi ho nella memoria come il migliore e intelligente imprenditore che io abbia mai avuto in 38 anni di lavoro. Aveva per me una grande stima e un giorno mi disse: “Lei è come i giocolieri cinesi: fanno degli esercizi che apparentemente sembrano facilissimi ma quando uno ci si mette, si rende conto quanto lavoro c’è dietro” Ancora oggi per me fu il miglior complimento nella mia carriera di impiegato e di dirigente. Dal 1965 restai alle Messaggerie fino al 1974. Credo sia stato il periodo più lungo della mia vita di lavoro. L’ufficio per giunta era vicino a casa (alla mattina dovevo fare sol duecento metri). Ma il destino era sempre in agguato con nuove sorprese spiacevoli. Al mio ritorno da militare rientrò anche mio fratello (assurdo che due fratelli dovessero fare lo stesso servizio militare) che però ricevette per errore la cartolina per un esame al posto di un altro per cui risultava avere la sifilide. Avendo frequentato per molto tempo una prostituta di Padova, sembrava logico ma la fidanzata che … ma lasciamo perdere … Rifece gli esami e risultò l’errore di Padova, ma i rapporti con la futura moglie incominciarono subito ad incrinarsi. Nel 1967, a tre anni Francesco, spinto da una bimba a terra si ruppe il femore all’asilo con la suora (un’incosciente!) che lo strattonò, trasformando così la frattura semplice in diagonale scomposta. Fu una lunga vicenda fino a che, dopo due mesi e passa, portato in riviera, riprese a camminare. Nel frattempo però Giovanna, costretta a sollevare 37 chili di bambino ingessato per fargli fare i suoi bisogni si beccò un distrofia alla colonna vertebrale che poi si riportò per tutta la vita. Riuscivamo ogni anno a fare delle vacanze dignitose: soprattutto a Sestri Levante dove avevamo come amici una ottima famiglia di ex pescatori. Nel 1969, su suggerimento di un amico decisi di presentarmi per l’esame di abilitazione all’insegnamento: la mia laurea in legge mi permetteva di partecipare all’abilitazione all’insegnamento di storia, filosofia, pedagogia e psicologia nei licei e negli istituti magistrali. Studiando al mattino dalle cinque alle otto, prima di andare in ufficio, mi preparai e superai lo scritto con un po’di fortuna. Ricordo ancora il titolo: “Il concetto dell’essere in Platone, Aristotele e Sartre” (una pazzia mettere insieme questi tre filosofi!). Passai l’orale e mi ritrovai il numero 49 nella lista del provveditorato di Milano, Potendo farlo, 67 mi iscrissi anche in un secondo provveditorato, Genova (non si sa mai, mi dissi, visto che mi piaceva la Liguria). Ricordo la mattina in cui andai al provveditorato a versare le diecimila lire obbligatorie: ero solo allo sportello e quanto l’impiegato mi disse: “Prego, professore” mi voltai per vedere chi c’era dietro di me: nessuno. E l’impiegato:”Guardi che parlo con lei!” “Con me?” gli chiesi e lui mi rispose: “Certo! Da oggi lei è professore!”. Non ci avevo pensato e allora mi feci stampare i biglietti da visita con il “dott. Prof.” E ne portai uno anche a mio padre per insegnargli che doveva avere più fiducia in suo figlio! Ne fu contento ma non si rese conto dello schiaffo morale e io lasciai perdere. Un professore di prima nomina prendeva allora meno di seicento mila lire al mese e io ne prendevo molti di più lavorando in Messaggerie. Purtroppo non insegnai mai(e mi sarebbe piaciuto, ma già tenevo famiglia da mantenere!) Ma nel 1970 io dovetti fare un giro per le filiali d’Italia ed approfittai per portarmi Giovanna: era un lavoro di rilevamento dei tempi ma fu quasi una vacanza, compresa un’avventura sull’Etna dove una sera, dopo un bellissimo tramonto e vedendo che c’era in corso una colata, decidemmo di salire sulla montagna. Ma all’improvviso si mise a nevicare con una forte tormenta e dopo due tornanti ci trovammo con la 124 Fiat della ditta davanti alla colata che ci stava per tagliare la strada su una doppia curva. Facemmo appena in tempo a evitarla con un rapido marcia indietro e un testa coda. Scendemmo dal monte e ci fermammo in una piazza: erano le due di notte ed eravamo nella piazza di Zafferana Etnea dove io, stanco del viaggio prima e dello spavento dopo, mi addormentai distrutto per un’ora. Quando mi risvegliai, Giovanna che aveva una pazienza infinita, mi indicò un gatto che attraversava la piazza passando sopra i “ballatuna” bagnati dalla pioggia che aveva smesso da poco. Nel 1972 mia sorella si sposò e la festa fu allietata dal fatto che ottenni per lei la cappella delle suore vicino a casa mia, dato che lei non voleva il matrimonio durante la messa nella sua parrocchia di Largo Boccioni. In quegli anni mio padre, non ostante la malattia, volle continuare a lavorare per aspettare che passasse la legge che equiparava la pensione allo stipendio (prima la pensione era di molto inferiore). Mia madre dovette a 55 anni prendere la patente e comprarsi una cinquecento a rate per portare mio padre in ufficio. 68 Ma poco tempo dopo scoprirono che mio padre aveva un tumore alla parte finale del’intestino; subì due interventi ma il 10 novembre 1974 come vi ho già raccontato, moriva tra le mie braccia alle quattro di notte. Nel 1972 invece era morto Toti, mio suocero, a causa del Parkinson che lo aveva colpito anche a causa della sua gioventù di pugile: in tre anni morì di una forma molto veloce. Nel 1973 invece Giovanna mentre leggeva il giornale al bagno, scoprì che vicino a noi affittavano un appartamento in via Pezzotti. Fu il nostro ventunesimo trasloco della mia vita. Il trasferimento in via Pezzotti sembrava definitivo. Avvenne nel 1973 ma durò solo fino al 1985. Avevamo un bell’appartamento con molte stanze, un bel balcone e in mezzo ad un grande giardino che ospitava otto palazzi in condominio. Erano appartamenti abitati per la maggior parte da insegnanti o da impiegati di banca, quindi di buon livello sociale. Francesco ebbe finalmente la sua stanza personale e io, mentre era in Inghilterra in vacanza da una mia cugina ad imparare la lingua, gli disegnai di blu cobalto il soffitto e poi gli aggiunsi le stelle nella loro vera dislocazione celeste con una vernice luminescente. In questo modo, quando alla sera si metteva a letto e spegneva la luce poteva sognare di dormire sotto un cielo notturno e gli piaceva molto. Nel 1973 aveva nove anni e cresceva bene; era la gioia e l’orgoglio mio e di Giovanna e non aveva più risentito della rottura del femore. Anzi fu allora che incominciò il primo anno di judo nella palestra che c’era in via Meda sotto la guida di una cintura nera, il vigile Zanoni. Ma si ruppe una clavicola e, dopo un anno di sospensione, riprese le arti marziali ma questa volta con Aikido. Ci andavamo anche Giovanna ed io ma poi io dovetti fermarmi a causa di un intervento alla cistifellea per calcoli. Allora l’amicizia di Giovanna con Mariella che abitava all’ultimo piano e che stava completando gli studi per diventare medico divenne più forte e fu lei che mi salvò da un’errata diagnosi del nostro medico di fiducia che aveva confuso i miei calcoli con un possibile fecaloma e mi costrinse a inutili e conseguenti terribili clisteri. Alla fine, grazie a Mariella fui ricoverato alla chirurgia d’urgenza in via Francesco Sforza ed operato da un’equipe di giovani chirurghi con a capo il figlio di Staudacher, il “mago” delle cistifellee. Il giovane chirurgo era balbuziente ma i suoi colleghi mi assicurarono che in sala operatoria parlava normalmente. L’ultima settimana prima dell’intervento i dolori erano saliti alle stelle e raccomandai a Giovanna di non lasciarmi mai solo in camera altri69 menti potevo anche buttarmi dalla finestra in un momento di massimo dolore. Francesco risentì molto per questo episodio, tanto che ebbe un improvviso calo di rendimento scolastico, ma poi si riprese. Io continuavo a lavorare alle Messaggerie ma alla fine del 1979, di fronte ad un ulteriore rifiuto di Mauri di farmi dirigente “altrimenti poi gli altri dirigenti se la prendono con lei e non con me come fanno oggi” (un ragionamento più che giusto ma che riduceva di molto le mie possibilità di carriera), decisi di cambiare azienda e divenni il Direttore amministrativo di un Cash & Carry di San Giuliano Milanese. Le consegne di chi se ne andava e di cui presi il posto mi furono fatte il 24 dicembre mattino in quattro ore ed io pur avendo qualche nozione di contabilità, avevo più esperienza in altri campi. Dovetti quindi fare una “full immersion” in casa sui libri per imparare quello che gli studenti imparano in cinque anni nelle scuole di ragioneria. Ne uscii quarantotto ore dopo abbastanza rincoglionito ma con qualche nozione in più, sufficiente per affrontare il mio nuovo lavoro: ero finalmente un dirigente con tutti i vantaggi che comportava allora la retribuzione ed il trattamento in relazione . Fu un’esperienza breve ma molto ricca di occasioni di vita. Ma mentre proseguivo per la mia carriera fui richiamato da Mauri ch mi riprese come dirigente a guidare la nuova azienda di distribuzione giornali, la Me. Pe., che per altro conoscevo già molto bene avendo lavorato anni prima nella stessa come Capo ufficio diffusione, un lavoro che mi piaceva molto. Nei tre anni dal 1971, sempre per una scelta sui giornali da parte di Giovanna decidemmo di andare a fare le vacanze estive a Lampedusa, allora veramente in fondo al mondo, senza alberghi (ne iniziavano a costruire nel 71 il primo, quello che diventò il “Baia Turchese”) Era una terra brulla, come un incolto aeroporto in mezzo al Mediterraneo, più vicina all’Africa (circa 100 chilometri) che alla Sicilia (240 chilometri). Ci arrivavamo in aereo e gli atterraggi erano abbastanza curiosi, su dei Focker che risentivano molto il vento trasversale. Ho un filmato in cui da terra una volta ripresi un atterraggio: il Focker atterrava sempre tutto di traverso a causa del vento mentre i gabbiani si levavano dalla pista per lasciarlo atterrare e per poi rimettersi sull’asfalto a godersi il caldo del sole. La prima volta dovemmo fare scalo a Palermo (dopo quello di Roma) per prendere il Focker che ci avrebbe portato a Lampedusa ma prima dovemmo fare sosta all’aeroporto di Trapani Birgi. Qui, mente aspettavamo in un hangar che fungeva da sala d’attesa, da bar, da rimessa di camionette dell’aviazione militare, da rimessa per 70 aerei leggeri, vidi il comandante del nostro Focker che si faceva un abbondante Whisky. Lo steward che aveva capito la mia meraviglia mi tranquillizzò: “Non si preoccupi, è il suo carburante, altrimenti non atterra bene. Guardi che è stato uno dei migliori piloti della RAF ed il primo che ha portato un Focker a Lampedusa. Aveva ragione e l’atterraggio a Lampedusa fu da manuale. Ma mentre aspettavamo non si sa cosa finalmente capimmo: si stava aspettando un altro aereo che arrivava sempre da Palermo ma stava portando un gruppo di Americani che arrivavano per un funerale di un parente in Sicilia, forse nella stessa Trapani. Così pensai, quando mi resi conto, oltre allo scorrere degli scarafaggi sul bancone del bar, di alcune decine di persone accatastate letteralmente su poche sedie, tutte vestite di nero per il lutto e che attendevano i loro parenti americani. Non vi descrivo l’incontro tra i due gruppi quando entrarono nell’hangar i parenti provenienti dall’America. Io e Giovanna non potevamo trattenere i sorrisi e lo steward che ci guardava con severità prima, poi rise anche lui. Finalmente molti anni dopo, misero la nave canguro che permetteva di caricare merci anche di grande peso e portare la macchina fino sull’isola. Ciò avvenne solo quando cambiò il sistema di raccolta del pesce nel canale di Sicilia. Prima il pescato veniva portato a Lampedusa dove ben tre scatolifici lavoravano il pesce che portavano i mazaresi. Ma un bel giorno questi decisero di farsi una nave frigo e di portare il pescato a casa. E Lampedusa, rimasta senza pesce da inscatolare dovette finalmente accettare di fare il molo d’attracco usando il cemento che da anni viaggiava nella stiva del traghetto senza mai che venisse sbarcato, a causa di un divieto dei locali mafiosi. E così alcuni anni dopo potemmo scendere da Milano in macchina, la nostra gloriosa 127 e raggiungere l’isola dopo un viaggio di 1600 chilometri da Milano a Porto Empedocle. Ma questo avvenne nel 1986. Prima accaddero altre cose che resero la nostra vita giornaliero a volte triste, a volte allegra. Nel 1978 andammo in Sardegna ma fu una vacanza ben strana, in un tugurio sulla riva del mare davanti a S. Giusta in provincia di Oristano. Era proprio una vacanza da poveri ma Giovanna si adattò per poter godere la bellezza dei vari posti che visitammo. Fu in una di queste incursioni che mi feci male: su un piccolo argine scivolai per tagliare dell’erica per Giovanna e, avendo in mano il tronchesino, caddi male. Morale: infrazione alla testa del perone, errore di 71 massaggi di una locale, ricovero e semivalva di gesso due giorni prima di ripartire per Milano, dove al Galeazzi mi chiesero chi era stato quel pazzo che mi aveva conciato in quel modo, avendo il gesso pieno di sabbia. In contemporanea avevamo quel giorno lasciato Francesco da solo, protetto dai nostri vicini ma lui si era inoltrato in uno stagno a fotografare le mucche con gli zoccoli a mollo. Preso per il figlio di un bracconiere, alcuni pescatori del luogo lo avevano menato e gli avevano rovinato la camicia, spaventandolo. Al mio rientro ci fu una litigata feroce in un capannone vicino dove gli autori erano a mangiare ed io dissi loro che se si sentivano orgogliosi perché sardi, io lo ero come loro perché figlio di siciliani. Ci fu una specie di pace armata che evitò loro le conseguenze di una mia denuncia ai locali carabinieri. Il viaggio di ritorno da Cabras a Porto Torres per l’imbarco ebbe come autista Giovanna e con il sottoscritto con una gamba fuori dal finestrino causa gesso. Poi al porto un camionista, mosso a pietà, aiutò Giovanna a farci imbarcare con la 127. Fu solo a Milano che scoprimmo che una gomma con una grossa bozza stava per scoppiare e ci rendemmo conto solo allora del rischio che avevamo corso da Genova a Milano se fosse avvenuto la scoppio. Capitolo 23 Nel 1980 maturò il momento di migliorare economicamente: lasciato il Cash & Carry, riuscii a farmi assumere dal gruppo Rusconi per diventare Controller di Italia 1, ma due anni dopo, mentre ero in vacanza a Trappeto, sotto Partinico …. Dovetti tornare a Milano, interrompendo le vacanze perché il dott. Rusconi aveva venduto Italia 1 a Berlusconi. Passai un’estate infernale a Milano per il caldo a discutere con gli uomini di Berlusconi i valori di tutte le apparecchiature di alta e bassa frequenza oltre che dei canali e del magazzino film al fine di raggiungere il valore finale di cessione della proprietà. Berlusconi, che nel frattempo possedeva Canale 5 e Rete 4, era stato informato dai suoi uomini sulle mie qualità di dirigente e mi arrivò tramite gli stessi la proposta di passare a loro. Sapevo da un mio amico quale fosse il suo modo di agire ed ero propenso ad un no. Per esempio regalava allora un appartamento a Milano 3 al venditore che gli portava un miliardo di fatturato pubblicitario. 72 Ma sapevo anche da un amico che ci abitava che le villette costruite nel villaggio che ora si chiamava Milano 3 mentre prima era un gruppetto di case con chiesetta che si chiamava Basiglio, che i muri erano di carta velina: il mio amico una sera scendendo nel garage sottostante casa non aveva frenato in tempo ed aveva sfondato il muro divisorio, entrando nel garage del dirimpettaio e sfondandogli involontariamente la macchina. A parte questo particolare, era proprio il tipo di imprenditore che non stimavo molto mentre con Rusconi i discorsi erano di lealtà e di reciproca stima sul lavoro. Decisi di parlarne con Rusconi ed egli mi fermò: aveva appena acquistato, facendosi aiutare da un piccolo azionista preesistente da Rizzoli la Edimoda che pubblicava Donna, Mondo Uomo e Donna e Bambino, ma soprattutto perché il piccolo azionista aveva il ruolo di editore delle testate giornalistiche, con alle spalle una lunga esperienza, insieme alla moglie, presso Vogue. Era la gallina dalle uova d’oro ed io, accettai di diventare il Controller dell’azienda ma con l’incarico di tenere d’occhio il socio di minoranza e la sua politica editoriale. Era un compito delicato ma ottenni aumento di stipendio e stima all’interno del gruppo. Così dal 1983 iniziai un nuovo incarico ed entrai indirettamente nel mondo della moda. Giovanna ed io sognavamo di poter un giorno diventare proprietari di un appartamento tutto nostro ma i prezzi erano proibitivi, finché, una volta stabilizzato il mio lavoro non si presentò la buona occasione. La casa di mia suocera era in vendita da parte degli antichi proprietari ad un prezzo accettabile ed io consigliai a mia suocera l’acquisto ma con l’intestazione a Giovanna. La malfidente accettò perché aveva da parte dei risparmi ma per l’intestazione pretese la separazione dei beni tra me e Giovanna. Accettammo ma ci vendicammo: feci fare una perizia del suo appartamento con la banca ed vi ottenni un mutuo intestato a Giovanna con il quale comprai un appartamento nella vicina via Bonghi, proprio di fronte a quella dove pagavamo fior d’affitto: la differenza tra affitto e rata del mutuo era poca e così ci trasferimmo nel nuovo appartamento, questa volta tutto nostro. Per capire il mio affare: lo comprammo nel 1985 a 78 milioni, io poi lo rivendetti nel 1994 a 240 milioni quando mio figlio decise di andarsene nel 1993 ad abitare a in affitto a Cremona ed oggi, se mio figlio Francesco se lo fosse tenuto, varrebbe più di 500 milioni delle vecchie lire! 73 Fu il ventiduesimo trasloco e ancora una volta sperai che fosse l’ultimo della mia vita. Mio figlio Francesco ebbe una stanza grande e bella, noi due una bella camera matrimoniale e io avevo finalmente il mio studio dove potevo scrivere e meditare. Giovanna, che nel frattempo frequentava l’Ismeo, si era diplomata in lingua e letteratura giapponese e Francesco coltivava assiduamente il mondo orientale. Avevo fatto appena in tempo a concludere l’affare che si stava presentando una situazione non troppo favorevole per il mio futuro: nel 1985 io avevo 47 anni e alla Rusconi il fondatore stava perdendo i colpi incalzato dal figlio che era un presuntuoso e incapace indegno di suo padre (a Firenze un giorno, parlando con un fornitore seppi che era riuscito ad imbrogliare il padre intascando i soldi pagati due volte per una fornitura; sembrò molto strana questa confidenza ma indicava i modi di comportamento del figlio). Ma il padre aveva ancora gli occhi aperti e aveva deciso di assumere come vicepresidente l’allora Amministratore Delegato del 24 Ore, dott. Lunati, che pensò bene di compiere il solito atto cretino riducendo il numero dei dipendenti e dei dirigenti. C’ero in mezzo anch’io e prima o dopo sarebbe toccata anche a me. Nel frattempo Giovanna ed io andavamo spesso in Umbria ad Assisi per passare una settimana di vacanza e incominciavamo già a pensare alla vita da pensionati: sarebbe stato bello poter vivere ad Assisi, nella pace non solo spirituale ma anche nella bella natura della terra umbra. Il problema era trovare un lavoro nelle vicinanze di Perugia dove poter vivere. Francesco era arrivato al primo anno del politecnico, poi, una sera in cui, dopo essersi ubriacato per trovare il coraggio per diremlo, mi confessò lungo il Naviglio che si era lasciato con Simona, una splendida ragazza e aveva intenzione di lavorare sui computer, per cui intendeva iscriversi a informatica, cosa che fece poco tempo dopo. Accettai la sua richiesta ma ormai avevo a che fare con uomo e gli dissi chiaramente che gli davo in tutto cinque anni, quattro per l’università e uno per il sevizio militare. E così feci. Lo corteggiavano molte donne che bazzicavano anche per casa e tra queste Catherine, figlia di una ligure e di uno svizzero tedesco, che la ebbe vinta sulle concorrenti. Nel frattempo, dopo essermi fatto anticipare dieci milioni della mia liquidazione incominciai a pensare seriamente all’Umbria. Feci una grossa inserzione sulla Nazione e ottenni tre chiamate. 74 Ricordo ancora il colloquio del 7 dicembre 1987 con i fratelli Bolletta, proprietari della Binova a Petrignano d’Assisi. Mi ero offerto come collaborazione in consulenza per portare il figlio di uno dei soci alla capacità di gestire l’azienda come Direttore Amministrativo e Finanziario, insegnandogli i trucchi le mestiere (che non è facile da quelle parti) e che non accettarono, forse perché erano troppo diffidenti verso un dirigente milanese. La mia soddisfazione fu che anni dopo fecero il passo più lungo della gamba con impianti enormi per entrare in America e fecero un buco nell’acqua con vistose perdite finanziarie. A proposito di finanza, mi ero fatto amico il gerente di un bar che aveva lavorato alla Spagnoli e dove mi portò a parlare con il direttore del personale per un’ipotesi di lavoro. Quando gli presentai la mia esperienza nel rapporto con tante banche mi gelò dicendo che loro si tenevano i soldi in tasca, che preferivano non usare i fidi delle banche e via dicendo. Un altro imprenditore a Perugia mi rispose per offrirmi un lavoro indegno delle mie possibilità: recupero di crediti che in realtà erano poco validi in quanto riguardavano la vendita di indirizzari non aggiornati che i clienti avevano dovuto constatare vecchi e spesso inutili. Non era Umbro ma non vi dico di quale mafia del sud fosse: era comunque il capo di una cricca di suoi compaesani che lo consideravano un dio mentre era solo un deficiente e presuntuoso. E finalmente arrivò l’incontro con Ginocchietti con il quale conclusi la mia assunzione ma in due tempi. Nel 1987 scendemmo in Umbria con la ferma intenzione di trovare dove andare ad abitare per gli anni della vecchiaia. E con l’aiuto di un giovane geometra, Antonello Sterlini, dopo una ricerca di quindici giorni in cui visitammo ventisei posti diversi, finalmente per una fortunata concomitanza di cose incontrammo quella che poi sarebbe diventata “Tenchi”. Vi risparmio la descrizione delle nostre ricerche e il pianto di Giovanna quando stavamo per rinunciare, delusi dei nostri incontri con persone superbe o buzzurre o con occasioni con prezzi sballati. Tornammo a Milano e chiedemmo a Francesco cosa preferiva fare: o con noi in Umbria o da solo a Milano nella casa che gli avremmo lasciato in affido. Scelse decisamente la seconda ipotesi (e gli amici gli dissero che aveva avuto un gran culo!) e noi ci demmo da fare per organizzare il nostro futuro trasferimento. Alla Rusconi, per una fortunata coincidenza la richiesta di Lunati di andarmene coincise con l’assunzione in Umbria da parte di Ginocchietti. Ma avvenne solo dopo un secondo colloquio nato in modo strano: dopo il primo colloquio in cui sembrava che tutto andasse in 75 porto mi resi conto che avevo contro il suo sottopancia, invidioso e che temeva che lo scalzassi, ma quando gli dissi apertamente che lui non mi interessava e che non avrei mai interferito con quello che faceva in azienda e con le banche, le cose cambiarono. Tutto questo però avvenne dopo che avevamo definitivamente cambiato casa, trasferendoci a Tenchi: il 9 marzo 1989 dormimmo per la prima volta nella nuova casa che ci sembrava una reggia con i suoi cinquemila metri di terra intorno alla casa e i suoi ulivi. Il nome Tenchi venne dalla lettura di Francesco dell’atto notarile: “da terra a cielo” diceva l’atto e lui lo tradusse in giapponese le parole, inventando il nome di “TEN CHI”. Avevo concluso il ventitreesimo trasloco. Capitolo 24 Ci sembrava troppo bello vivere a Tenchi e io pur andando avanti e indietro con Perugia dove lavoravo da Ginocchietti godevo di quella meravigliosa scelta fatta in onore di Giovanna: consideravo Tenchi il miglior regalo che avessi mai fatto a mia moglie e ne ero fiero. E nello stesso tempo io, che non credo, mi chiedevo che cosa volesse il padreterno in cambio! Poi lo seppi e fu triste. Con Ginocchietti era andata così: durante il 1989 ero ancora dipendente di Rusconi e solo a dicembre ne uscii con eleganza (e tanti quattrini di liquidazione che mi permisero di portar avanti i lavori che avevo in corso: al momento della liquidazione inoltre diedi uno schiaffo morale al capo del personale ricordandogli che mi stava liquidando il dovuto ma non aveva tenuto conto dei dieci milioni che mi erano stati a suo tempo anticipati. Ci rimase di stucco perché per una cosa del genere rischiava il posto ma io lo accontentai dicendogli che mi bastava che mi riconoscesse metà dell’importo come premio finale e così fu). Chiusi i debiti e coperto di contributi fino all’ottobre 1990, me ne andai definitivamente in Umbria dove però Ginocchietti, dopo il primo colloquio, forse imbeccato dal suo sottopancia, aveva delle perplessità. Ma nel febbraio 1990, mentre ero dal fornaio giù a valle, mi telefonò Giovanna: “Ha telefonato Ginocchietti; vuole che tu vada a parlargli”. E finalmente l’1 marzo 1990 entrai a far parte della sua azienda e incominciarono i guai: pretendeva che me ne andassi in America a recuperare i suoi crediti sparsi senza che io nemmeno sapessi come fosse fatta la sua attività di stilista (almeno lui si vantava di esserlo ma era ben lontano dagli stilisti noti come Armani o Ferré). 76 Comunque ribaltai l’archivio, scoprii perché il precedente direttore amministrativo era stato licenziato (aveva fatto in modo che le banche gli dessero dei fidi per aziende sue, altrimenti non le avrebbe usate per Ginocchietti) e riorganizzai il sistema dei crediti: aveva crediti per quattro miliardi solo in America su 10 miliardi di fatturato. E partii per New York a recuperare soldi : in circa una settimana riportai a casa due miliardi e finalmente il rapporto con Ginocchietti migliorò. Ma alcuni suoi modi di fare mi facevano impressione, come di un mezzo pazzo. Solo alcuni anni dopo scoprii che era ammalato di Alzheimer che alla fine lo portò su una sedia a rotelle. Ma i guai veri erano in agguato: nella primavera del 1991 scoprimmo che Giovanna aveva un tumore al seno. Non me la sento di raccontarvi tutto. Riassumo solamente: operata in primavera alla clinica Porta Sole a Perugia , rioperata per ragioni estetiche in novembre con me che fui operato insieme a lei per un’ernia inguinale, una ciste nello scroto e varicocele. Ricordo un episodio divertente: la sera del mio intervento (Giovanna era stata operata il giorno prima) fumavamo in camera come turchi (allora fumavo anch’io, poi smisi). Entrò il medico di guardia e chiese a Giovanna: “Ma signora, con quello che ha avuto fuma ancora?” E Giovanna rispose: “Tanto io fumerò anche dopo morta perché mi faccio cremare!”. E così la gioia di Tenchi visse solo due anni. I cinque controlli successivi furono negativi ma la paura era sempre nella mente di Giovanna ed anche in me. Ginocchietti nel frattempo aveva comprato la IGI che produce tuttora scarpe, soprattutto per bambini. Poco tempo dopo passai alla IGI I.F.T., ( una sotto IGI che si occupava di costruire stabilimenti all’estero per la fabbricazione di scarpe) e fui investito del piano finanziario per un grande calzaturificio a Mosca. Nel 1993 Ginocchietti mi aveva chiesto di andarmene perché proprio mentre stavamo per concludere un affare da 143 miliardi del calzaturificio in Russia arrivò l’era Garbaciov che mandò tutto all’aria. Furono mesi terribili tra un periodo mio di malattia, un altro che Ginocchietti mi obbligò a sfruttare come ferie ed infine con una visita fiscale di un medico che non avrebbe potuto far fare perché io ero un dirigente, Ma quel giorno ero in casa e questo aiutò a chiudere la partita a mio favore a fine del 93 davanti al pretore, prima di entrare dal giudice con un assegno che mi compensò largamente dei guai subiti. 77 Passai tutto il 1994 a cercare un altro lavoro mentre ero senza stipendio e in attesa che maturasse il momento per poter andare in pensione a dicembre. Nel frattempo conobbi Giampiero Bianconi, un vero imprenditore con il quale iniziai una consulenza ben retribuita e che consisteva nell’avviare i suoi dipendenti contabili a sfruttare al meglio le risorse finanziarie e simili. Gli aggiustai gli inventari di cinque anni di attività e nel frattempo gli preparai una brochure per il suo nuovo investimento: un centro alberghiero di lusso a sud di Assisi. Fu in quell’occasione che, pensando al nome, gli proposi “ Valle di Assisi”; gli piacque e me lo fece scrivere sulla copertina. Oggi posso dire di essere orgoglioso perché il suo Resort oggi si chiama proprio così:”Valle di Assisi”. Un giorno, andando a passaggio di Bettona a prendere il vino, ho scoperto il cartello pubblicitario di “Resort Valle di Assisi” e confesso che mi sono commosso. Ma stava per arrivare la botta finale. Nel frattempo Francesco nel 1992 si era sposato con Catherine e facemmo un gran rinfresco all’aperto a Tenchi la settimana dopo il suo matrimonio civile a Milano. Nel 1993 decise di andarsene a Cremona in affitto e io mi trovai con i mano un pugno di mosche perché la vendita della casa di Milano avvenne, come già ho detto, solo più di un anno dopo con spese arretrate di condominio e di mutuo non pagate alle quali dovetti aggiungere il pagamento del suo trasloco. Nel frattempo io avevo come giardiniere Guido fin dal 1989; lavorava molto e bene ed era un uomo di grande fiducia. Conoscemmo anche la sua famiglia e i figli, Francesco e Nicoletta; quest’ultima si sposò proprio nei primi anni di conoscenza della famiglia ma presto ci accorgemmo che le cose con suo marito non andavano bene. Ma questa sarà la prossima storia che racconterò. Capitolo 25 Dal 1991 ogni sei mesi Giovanna si faceva controllare e sembrava che le cose andassero bene. Nicoletta lavorava mattina e pomeriggio per l’edicola di suo marito che aveva in comproprietà col fratello. Lei serviva anche quotidianamente i giornali per l’ospedale di Assisi ed era ben voluta da tutti; anche oggi le vogliono molto bene: le antiche infermiere e i medici di allora la ricordano con amicizia sincera. 78 Tra Giovanna e Nicoletta era nato un bel rapporto di amicizia e Nicoletta la considerava una sorella maggiore. Arrivammo al punto che nel 1994 andammo in ferie a Gallipoli tutti e quattro. Fu in quell’occasione che scoprimmo che Nicoletta non sapeva nuotare ma mentre eravamo al largo: uno spavento cui Giovanna supplì prestandole le sue pinne per poter tornare a riva. Il giorno dopo aveva comperato le pinne. Il marito invece, che non sapeva nuotare, era ridicolo con i braccialetti per bambini e, mentre le due donne andavano al largo, io, rimasto sul bagnasciuga con Italo, lo rimproverai per come trattava male sua moglie, una ragazza che aveva tante belle qualità ed un buon carattere, una vera stakanovista nelle faccende domestiche. Seppi poi qual era stata la sua esperienza “amorosa”: in famiglia il padre, Guido, era geloso e ossessivo e il fratello, che credeva di agire bene spiandola, andava a raccontare al padre le sue piccole marachelle scolastiche. A quindici anni non aveva ancora avuto nemmeno un piccolo flirt quando apparve all’orizzonte Italo. Guido costrinse a farlo venire in casa altrimenti “ti proibisco di frequentarlo”: una mentalità che sarebbe stata più adatta ad Agrigento o a Catanzaro piuttosto che ad Assisi, ma Guido era così. Di conseguenza si fidanzarono e rimasero fidanzati per sei anni. Nel 1991 si sposarono e Nicoletta non aveva mai avuto alle sue spalle una vera esperienza alternativa nelle sua giovane vita di allora. Non ostante sei anni di fidanzamento non aveva ancora capito che caratterino avesse il futuro marito, ad incominciare dal fatto che non voleva figli. Inoltre, se avesse voluto separarsi ne sarebbe sorta una tragedia in famiglia perché l’abitudine corrente era “che cosa direbbe la gente!”; no “quale dispiacere avrebbe provato la ragazza”, ma “che cosa avrebbe detto la gente!” Ma la vita che conduceva era stressante: sveglia alle cinque di mattina, in edicola a preparare i giornali per l’ospedale dove si recava a fare il giro. Rientro in edicola a mezzogiorno, di corsa a casa a preparare il pranzo per il marito e poi tornare subito in edicola fino alla sera tardi. Il tutto sette giorni su sette. Inoltre il marito che faceva l’elettricista non era una cima nel suo lavoro e non era capace di incassare il dovuto. L’anno 1994 non solo segnò un momento importante tra noi e i due sposini: fu l’anno in cui non avevo né stipendio né pensione, che arrivò finalmente solo in dicembre. 79 Per fortuna aveva venduto la casa di Milano, lasciata vuota l’anno prima da mio figlio andandosene a Cremona. L’anno prima l’avventura con Ginocchietti era finita e, come già detto, eravamo arrivati in tribunale e la mia liquidazione costò cara a Ginocchietti ma soprattutto servì per coprire due anni senza stipendio e senza pensione. Nel frattempo avevo aiutato il dottor Lucentini a fondare l’associazione “Con noi”, una onlus per la terapia del dolore, organizzandogli tutta la parte burocratica. Ma un giorno sprofondai di vergogna quando Giovanna mi fece notare che non era piacevole sentir parlare di cancro ogni giorno in casa di una come lei che lo aveva avuto ed era continuamente sotto controllo. Mi resi conto del grande mio errore e lasciai tutti gli incarichi, rimanendo solo socio. Il 1995 passò abbastanza tranquillo ma improvvisamente il tumore si affacciò di nuovo nell’altro seno gettando Giovanna nello sconforto e avviando il periodo più triste della mia vita. A marzo del 1996 lasciai il lavoro con Giampiero per dedicarmi tutto a Giovanna; Nicoletta intanto soffriva di tachicardia a causa dello stress da lavoro e Giovanna la convinse a lasciare l’edicola al pomeriggio e a venire a casa nostra per farsi aiutare a tenere in ordine la nostra casa. Nacque così tra le due una grande amicizia, come tra due sorelle. Fu un anno di vari tentativi, il maggiore in Austria presso un certo dott. Pekar che ci accolse in albergo perché il giorno prima che arrivassimo a Bad Ischl il suo laboratorio era andato distrutto da un incendio. Con tre aghi sonda e uno strumento che emetteva delle vibrazioni bruciò il tumore nel seno di Giovanna e concluse” Tumore kaput!” Le preparò anche un vaccino col suo sangue che avrei dovuto poi inalare ogni giorno con iniezione per combattere eventuali ritorni del tumore. Non dovevamo fare alcuna radiografia finché non avessimo finito il vaccino e a fine agosto la radiologa confermò che il tumore era necrotizzato, ma nel frattempo la metastasi continuava: il tumore si era infilato nel polmone e tra le due pleure a destra. Su consiglio del dott. Pekar feci venire da Catania un suo allievo italiano, il dottor Gasso che mi costò un sacco di soldi dovendolo ospitare per più giorni in albergo a Ospedalicchio con il figlio e un assistente. Ma il suo intervento nel polmone destro di Giovanna non servì a nulla. E il tumore camminava. 80 Giovanna deperiva ogni giorno e Lucentini la aiutava con antidolorifici. Arrivammo al Natale del 1996 e Francesco e Catherine, dopo una discesa rapida da Cremona, il 26 dicembre ripartirono lasciandomi in merda: ero solo in casa con Giovanna che stava sempre peggio, la neve fuori, la Volvo senza catene pronta sul vialetto con bombola e coperte e l’ospedale a trecento metri ma in cima alla strada in salita. Per fortuna al telefono mi assicurarono tutta l’assistenza con ambulanza, se ne avessi avuto bisogno. Giovanna superò una forte crisi respiratoria mentre temevo che stesse per andarsene, Oggi ancora non so come feci a resistere alla situazione che stava precipitando. Dopo due torancentesi che Lucentini le aveva praticato nel gennaio del 1997, sembrava stesse un po’ meglio ma i liquidi si riformavano per combattere il male ma me la stavano soffocando. Una terza toracentesi non era possibile perché l’aspirazione del liquido sarebbe stata quasi impossibile a causa del fatto che il liquido stava diventando ormai troppo solido. Per fortuna, su indicazione di un’amica, feci venire a casa il dottor Frigerio, uno pneumologo molto bravo che lavorava a Montefalco in un distaccamento di pneumologia dell’ospedale di Foligno. Portai Giovanna in quel reparto e rimasi con lei dieci giorni mentre il dott. Frigerio tentava una terza toracentesi, ma soprattutto mi fece vedere in una ripresa con telecamera l’orrore delle pareti delle pleure di Giovanna. I due dolci signorini, Francesco e Catherine, arrivarono un giorno a trovare la mamma (che nel frattempo a causa degli oppiacei stava andando fuori di testa), ma solo perché avevano dovuto andare a Firenze per lavoro e io non perdonerò mai a mio figlio che nell’arco di otto mesi (fino a ottobre) sarebbe sceso a trovare sua madre solo quattro volte. Molto tempo dopo mi disse che glielo aveva chiesto Giovanna perché non voleva farsi vedere nel pieno della malattia. Ammesso che fosse vero, poteva promettere e non mantenere; oltre tutto a Tenchi c’era ance un padre, solo, che doveva supplire a tutto. Ma lasciamo perdere: la sua coscienza saprà cosa dirgli a suo tempo. Per fortuna invece il nostro caro amico Don Mario scese ben otto volte da Chiavari a trovare Giovanna: tre ore di viaggio andata, tre ore il ritorno e un’ora di sosta con Giovanna privatamente Solo molto tempo dopo seppi che Giovanna aveva accettato l’estrema unzione da Don Mario. 81 Di ritorno a casa, Giovanna, sotto le cure di Lucentini, prima con il coefferalgan e poi in maniera definitiva, con la morfina, poté andare avanti nella malattia con meno dolori ma con la certezza che sarebbe morta in poco tempo. Ci fu un colloquio a due molto sincero tra il dottor Frigerio e Giovanna: sei mesi al massimo. E fu così. Nicoletta lavorava da noi e da altri per guadagnare, mentre io cercavo di fare quasi tutto quello che era necessario. Passò l’estate; io avevo trovato un’ottima infermiera soprattutto per la notte: Liliana, una ragazza serba, un’infermiera molto in gamba, che mi alleviava le incombenze nel curare Giovanna. Con lei trovai aiuto anche con Debora e con un’altra bella infermiera della Val topina che mi faceva le notti. Non badavo a spese; mi interessava che Giovanna venisse seguita e curata bene. Veniva anche Isabella Tosti che era molto brava e aiutava Lucentini. Ma la notte del 26 settembre alle due la casa tremò svegliando tutti: era il terremoto che si aggiungeva ai guai che già dovevo sopportare. Io ebbi pochi danni, avendo la casa costruita con due strutture unite da un’intercapedine che fece il suo dovere di assorbire il colpo. Tanto spavento, controlli per casa e di nuovo a letto. Ma alle undici del mattino dopo arrivò la scossa più tremenda che ho mai dovuto subire in vita mia e, con Giovanna in quelle condizioni, fu una botta terribile fisica e psicologica. Il dottor Lunghi (sostituiva Lucentini che se ne era andato in barca in Grecia) stava compilando i moduli per la morfina nel salone quando, dopo un lungo e spaventoso boato, arrivò una scossa di terremoto di 6,2 della scala Richter che sconvolse tutto e tutti. La libreria del salone oscillò paurosamente e stava per cadere ma poi riprese il suo posto. Di sopra le ragazze presenti si gettarono generosamente d’istinto su Giovanna nel letto per coprirla e salvarla da eventuali crolli che, per fortuna, non ci furono. Lunghi si precipitò fuori sulla scala d’accesso mentre Guido saliva la stessa scala di corsa per venire a vedere che cosa avessimo subìto: fu uno scontro tra i due che rischiò di mettere in pericolo la loro salute fisica. E da quel momento incominciò una lunga serie di scosse: portammo giù su una sedia Giovanna e allestimmo un letto in salone. Inoltre mi portarono su da Bastia mia suocera perché avevano paura per la casa dove abitava. Alla sera il salone era un accampamento per Giovanna, sua madre, Liliana e io. 82 Chiesi scusa a Giovanna per come ci stavamo organizzando ma lei mi disse a proposito di sua madre che non voleva vedere: “non ci sono problemi; tanto ormai per me è tutto indifferente” Allora capii che si era arresa definitivamente. Quindici giorni dopo, alla sera alle dieci finì di vivere addormentandosi nel sogno infinito che segue alla morte. Venne subito Lucentini che ne constatò il decesso ed io iniziai la triste attività telefonica da mio figlio ai vari parenti. Poco dopo arrivarono Nicoletta e Italo mentre le infermiere la pulivano e le mettevano il bellissimo abito viola con decorazioni in oro che Lea Mechelli le aveva preparato mesi prima con degli spezzoni che le avevo regalato a Milano durante la fiera di Lacchiarella. Erano passati trentasei anni meno un settimana e la nostra vita finiva lì. Non avevo altro da pensare; non riuscivo a pensare. Era morto tutto per me. Nelle ore successive avvennero le cose che si fanno per un funerale. Rifiutai la proposta del parroco di San Rufino, quando venne a benedire la salma, di fare il funerale nella chiesa (c’erano continue scosse di terremoto e si poteva temere qualche altro guaio). La cerimonia funebre si svolse nel giardino di Tenchi, nella sua casa che lasciava per l’ultima volta. Nel pomeriggio, lasciati a casa i parenti con Nicoletta da custode, partì il carro funebre e io e Francesco lo seguimmo in macchina fino al cimitero di Perugia dove venne depositata la salma. Due giorni dopo mi diedero due urne: quella per il cimitero e una, abusiva, con un po’delle ceneri di Giovanna che misi in bella mostra sul mobile della sala tra le piante fiorite e la statua del Buddha che Giovanna mi aveva regalato tanti anni prima. Partirono tutti ma Francesco rimase altri tre giorni per farmi compagnia. Tre notti dopo feci uno strano sogno, tanto strano che scesi di corsa nello studio e riportai il racconto del sogno sul computer per poterlo ricordare. Oggi fa parte, senza alcun ritocco, delle mie cose più preziose per il suo strano contenuto che mi è sempre parso una specie di addio di Giovanna che ha voluto lasciarmi un segno di dove andò dopo morta. Se lo volete, potete leggerlo sul sito www.salottobiblioteca.it tra i racconti a pag. 2 col titolo “Diario di Giò dopo …” E finalmente rimasi solo con la mia solitudine. 83 Capitolo 26 Nei mesi successivi accaddero tante cose; cerco di raccontarle in ordine ma fu un turbinio di fatti. Il terremoto di Assisi a Colfiorito, che era l’epicentro, aveva distrutto tutto. Le scuole elementari funzionavano in tende. Con Nicoletta decisi in dicembre di raccogliere tutti gli animali di peluche di Giovanna (erano ben 79, più un grande orso che avevamo regalato a Francesco quando aveva tre anni) e, dopo averli fotografati per ricordo tutti distesi sul letto, organizzammo una spedizione a Colfiorito. D’accordo con i carabinieri di Foligno ( da loro dipendeva l’autorizzazione ad entrare nelle zone terremotate) salimmo con una Panda 4x4 che avevo comprato da poco, con Nicoletta vestita da Babbo Natale, e, confezionati da lei, tre sacchi rossi nei quali lei aveva suddiviso gli animali per grandezza. Col tutto, più un cestino pieno di caramelle e cioccolatini e, ovviamente, macchina fotografica, andammo a Colfiorito e distribuimmo i regali ai bambini che erano nelle tende (puzzolenti per il chiuso) a fare scuola. Grande e piacevole sorpresa per le maestre che alcuni mesi dopo ci spedirono una specie di diploma ricordo. Il grande orso fu regalato ad un ragazzo mezzo invalido e con un forte deficit mentale: gioiva come un matto. Decidemmo di fermarci nel vicino ristorante a pranzare perché lassù la vita era ricominciata, ma mentre mangiavamo un’altra scossa ci ricordò che la vita è sempre appesa ad un filo. Ma era la prima volta che pranzavamo assieme e questo aiutò molto la nostra decisione: ci mettemmo assieme promettendoci di sposarci appena possibile. Io le dissi chiaramente che a Lei, data la forte differenza d’età (29 anni!) non conveniva fare un passo del genere ma Nicoletta era ben determinata anche perché non aveva bisogno di conoscermi dopo tanto tempo che frequentava casa e Giovanna. Fu una splendida avventura ma creò i primi sospetti in Guido che non vedeva di buon occhio la confidenza che avevamo tra noi due. Il peggio arrivò quando Nicoletta ingenuamente informò la famiglia che aveva intenzione di separarsi dal marito. Un giorno Guido arrivò a casa mia dove Nicoletta stava facendo i mestieri di casa e davanti a me disse alla figlia: “Tu non puoi più venire a lavorare per il Beppe, perché è un vedovo e tu ti sputtaneresti e se decidi di separarti non troverai più un marito”. 84 Io stetti al gioco e dissi: “Tuo padre ha ragione: trovami un’altra persona che ti sostituisca e la istruisci perché in questa casa io so solo dove trovo le calze e le mutande”. Ma Nicoletta gli rispose che lei prendeva le sue decisioni senza il suo parere e aveva bisogno di lavorare. Infatti in quel periodo stava lavorando anche per altre due famiglie. Di fatto avviò la pratica di separazione; il problema era buttar fuori di casa Italo perché, dopo il terremoto ed un periodo di vita in una roulotte fuori dalla casa resa inagibile, Guido li aveva ospitati nel salone a pian terreno di casa sua dove si erano organizzati un loro ambiente. Nicoletta voleva usare la cugina che è avvocato ma cercai di dissuaderla perché se avessero usato un solo avocato (e avrebbero potuto farlo non avendo figli e beni al sole) avrebbe potuto risparmiare dimezzando le spese ma sarebbe nato un conflitto di interessi. Non ci credette ma alla fine dovette accettare il mio consiglio e decisi di affidarla ad una avvocatessa di Perugia che conoscevo. Non entro nei dettagli della vicenda. Accenno solo al tentativo di ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota perché lui non voleva figli ma la sua testimonianza ci sarebbe costata, grazie ad un amico comune, 20 milioni che Italo pretendeva come compenso. Rinunciammo e decidemmo di attendere la sentenza del divorzio per poterci sposare. La sentenza arrivò nel luglio del 2001 e noi ci sposammo civilmente il 27 ottobre dello stesso anno. Così le cose si svolsero in modo inverso: prima Nicoletta restò incinta, poi vendemmo Tenchi ed avemmo la fortuna di trovare gli acquirenti abbastanza in fretta. Di seguito Francesco e moglie scesero come lupi affamati sperando di avere soldi dalla vendita ma se ne andarono con la mascella caduta per la delusione quando seppero che Nicoletta era incinta e che avevamo comperato un appartamento a valle, a Santa Maria Degli Angeli che ci assorbiva, arredamento compreso, quasi tutto il ricavato della vendita di Tenchi. Mi dispiaceva vendere quello che avevo costruito con tanti sacrifici ma lo avevo fatto per Giovanna e non avrei potuto più vivere in quella casa piena di bellissimi ricordi. La notizia di Nicoletta incinta creò in loro solo la voglia di scappare e da allora le loro visite si fecero sempre più rare; anzi la gentil consorte di mio figlio da anni non ci parla più (dopo avermi anche insultato per lettera), mentre Francesco un giorno fece una tale sparata cretina che mi costrinse a prendere una drastica decisione: avevamo acquistato l’appartamento cointestandolo anche se ancora non sposati ma dopo la 85 sua cretinata vendetti a Nicoletta la mia metà con atto notarile, tenendo per me solo la mia parte di usufrutto. Ho lasciato in eredità, tra le altre cose, a Nicoletta precise istruzioni, anche se a Nicoletta (col suo dolce carattere) non piaceva questa soluzione ma alla fine si rese conto della stupidaggine di Francesco e della sua mancanza di rispetto per me ma soprattutto per Nicoletta e per Emanuele. E finalmente ci trasferimmo nella nuova casa nel maggio del 1999: era il ventiquattresimo trasloco che, per il momento, è anche l’ultimo. In settembre nacque Emanuele e da allora viviamo qui bene accettando nella gioia e nel dolore gli eventi che ci stanno cadendo addosso ogni giorno. In questi giorni purtroppo, tanto per ricordarci che siamo fatti di materia corruttibile, abbiamo dovuto scoprire che Guido, il papà di Nicoletta, ha un grosso guaio e dovremo andare incontro ad una nuova tremenda avventura di sofferenze per tutti. A casa il 7 giugno 2012. Giuseppe Amato FINE (speriamo) P.S. molte cose qui non ho ricordato e ne chiedo scusa Vorrà dire che quando avrò cento anni proverò a riprendere il discorso e completarlo dei ricordi che qui mi sono dimenticato di raccontare! 86
Scarica