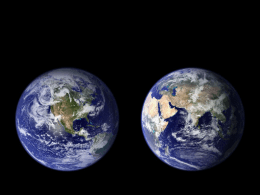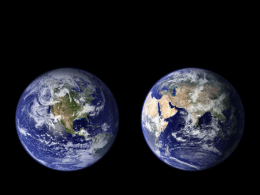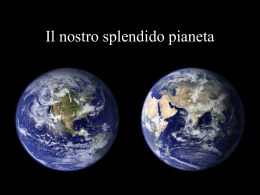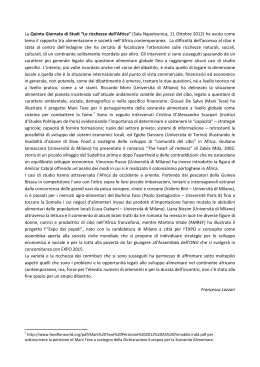3 I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea Giovana Omodeo Zorini Pozzi Fabei Magro Del Boca Ghezzi De Michele Pallotti Benardelli Germinario Loi Romandini Vecchia giugno 2006 EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO I Sentieri della Ricerca è una pubblicazione del Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo. Direttore Angelo Del Boca Condirettori Giorgio Rochat, Nicola Labanca Redattrice Severina Fontana Comitato scientifico Marina Addis Saba, Aldo Agosti, Mauro Begozzi, Shiferaw Bekele, Gian Mario Bravo, Marco Buttino, Giampaolo Calchi Novati, Vanni Clodomiro, Basil Davidson, Jacques Delarue, Angelo d’Orsi, Nuruddin Farah, Edgardo Ferrari, Mimmo Franzinelli, Sandro Gerbi, Mario Giovana, Claudio Gorlier, Mario Isnenghi, Lutz Klinkhammer, Nicola Labanca, Vittorio Lanternari, Marco Lenci, Aram Mattioli, Gilbert Meynier, Pierre Milza, Renato Monteleone, Marco Mozzati, Richard Pankhurst, Giorgio Rochat, Massimo Romandini, Alain Rouaud, Alberto Sbacchi, Gerhard Schreiber, Enrico Serra, Christopher Seton-Watson, Francesco Surdich, Nicola Tranfaglia, Bahru Zewde La rivista esce in fascicoli semestrali Direttore Angelo Del Boca Editrice: Centro Studi Piero Ginocchi Via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB) Stampa: Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli Via Jenghi, 10 - 28877 Ornavasso (VB) N. 3 - I° Sem. 2006 Numero di registrazione presso il Tribunale di Verbania: 8, in data 9 giugno 2005 Poste italiane spa Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Prezzo di copertina € 12,00 Abbonamento annuale € 20,00 Abbonamento sostenitore € 100,00 C.C.P. n. 14099287 intestato al Centro Studi Piero Ginocchi via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB) causale abbonamento: ISDR La pubblicazione di questa rivista è stata possibile grazie al contributo di: Provincia del Verbano Cusio Ossola Comune di Baceno Comune di Crodo ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA “PIERO FORNARA” NOVARA Sommario editoriale 7 Anomalie per un gioco, scale di valori e storia di una società contemporanea di Mario Giovana vivere la Resistenza 13 «Cammini dritto chi non è gobbo». Omaggio a «Iso» di Francesco Omodeo Zorini storia locale 25 Il linguaggio di Enrico Vezzalini di Giancarlo Pozzi storia nazionale 41 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano di Stefano Fabei 55 Idee e opinioni degli studenti d’oggi: indagine in un centro del Meridione di Alessandra Magro Africa e dintorni 73 La tragica fine della X armata e del suo comandante. Lettere della Libia del generale Tellera di Angelo Del Boca 91 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia di Carla Ghezzi 5 131 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia in uso nelle scuole superiori di Grazia De Michele 169 Ti scrivo dall’Abissinia. Lettere di Guerrino, camionista bolognese, alla moglie Derna dall’Africa Orientale Italiana di Vittorio Pallotti 219 L’Esercito del Signore di Mainardo Benardelli studi sull’Europa 227 Un testo inedito di Mécislas Golberg. Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle di Francesco Germinario rassegna bibliografica 247 L’operazione Ibis in Somalia: luci ed ombre in una missione di peace-keeping di Angelo Del Boca 253 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi 259 La riscoperta degli ascari eritrei di Angelo Del Boca 262 Schede di Matteo Vecchia e Massimo Romandini 283 Notizie sugli autori di questo numero 6 Anomalie per un gioco, scale di valori e storia di una società contemporanea di Mario Giovana La domenica 29 gennaio del 2006 l’anfiteatro dello stadio Olimpico di Roma ha offerto uno spettacolo inverecondo di razzismo, fascismo incallito, teppismo imbevuto di volgarità plebea. I suoi spalti hanno presentato, infatti, una rassegna senza precedenti di esaltazioni della bestialità nazista e di evocazioni della dittatura mussoliniana esibendo striscioni celebrativi del duce, della violenza all’insegna della svastica e dell’odio che ne impastava la natura; dietro le quinte di questa incivile manifestazione di massa era stato predisposto un attentato ai danni della squadra del Livorno a base di bombe incendiarie, sotto il proclamato auspicio che i suoi componenti facessero la fine delle vittime dei forni crematori di tristissima memoria. La preparazione dell’attentato è stata fortunatamente scoperta dalla polizia, ma nessuno è intervenuto ad interrompere il barbaro spettacolo: dietro quella oscena sfilza di rappresentazioni nostalgiche e di invocazioni da suburra, come documentavano gli schermi televisivi, stazionava una muraglia (non un velo) di rappresentanti dei cosidetti tifosi, impassibili e del tutto probabilmente consenzienti e compiaciuti di essere partecipi dell’incredibile dimostrazione del degrado civile e morale che può emergere da una società che vanta ad ogni pié sospinto la propria storia millenaria di elevatezza di pensiero e di culto delle conquiste più alte del vivere umano. Il giorno seguente le prime pagine dei quotidiani traboccavano di condanne e deplorazioni dell’accaduto, invocando una diversa attenzione al fenomeno dilagante di queste sconcezze; e, naturalmente, al coro si univano i redattori di quelle cronache sportive nelle quali il fenomeno calcistico è quotidianamente enfatizzato e sponsorizzato, quasi sempre in chiave scompostamente epica, facendo ricorso ai titoli più incongrui e rumorosi per esaltarne le imprese ed i protagonisti ed elevando la pedata al pallone agli altari delle supreme squisitezze delle capacità delle creature che popolano la penisola. 7 Mario Giovana Nelle pieghe di tanta indignazione si inserivano i contorcimenti verbali degli esponenti delle organizzazioni calcistiche, costretti a non dissociarsi in modo inverecondo dalle condanne ma attenti, in primo luogo, a circoscrivere il malanno a «non tifosi», ristrette cerchie di sciagurati infiltratisi fra il pubblico e non controllabili, in secondo luogo attenti a tenersi fuori da qualsivoglia responsabilità per la gestione di quel miserrimo guazzabuglio di speculazione finanziaria, avventurismo di trafficoni - sovente ammanigliati alla politica - e proconsolati inamovibili sui quali si basa la loro fortuna, cui è ridotto il gioco del calcio professionistico. Si sono subito annunciate misure drastiche di «tolleranza zero», cui non sono seguiti che una decina di fermi giudiziari (presumibilmente seguiti da rapide scarcerazioni) ed una ridicola interdizione del campo dell’Olimpico per una giornata di gioco da parte di una autorità sportiva che appare non meno incline a coprire gli sconquassi del settore dei vari Carraro e Galliani, per non citare che due dei massimi e sfacciatamente inamovibili esponenti del carrozzone calcistico. L’episodio romano non è che l’ultimo ed il più recente, mentre compiliamo queste note, scandalo che inabissa un gioco popolare relegandolo nelle pagine nere della storia nazionale. Perchè di storia nazionale si tratta. Giacché le statistiche ci informano che il calcio mobilita 32 milioni di italiani oltre i sei anni i quali si dichiarano appassionati di questo sport (secondo una ricerca della Customized research and analysis di Milano, riferita in Cronache di una partita dove tutti rischiano di perdere di Luca Fraioli, in «Il Venerdì di Repubblica» del 27 gennaio 2006), gli avvenimenti calcistici affollano all’inverosimile gli schermi televisivi (per lo più, le rubriche televisive dedicate allo sport danno quasi unicamente spazio al calcio, quasi sempre al limite dell’ignoranza totale delle altre discipline sportive, toccando livelli di autentica asfissia nella presentazione del prodotto), qualsiasi minima notizia inerente il mondo del pallone ed i suoi attori campeggia sulla stampa di ogni colore; e giornali quotidiani quali «La Gazzetta dello sport» e «Tuttosport» assorbono l’interesse quasi esclusivo di lettori che, evidentemente, snobbano ogni altra informazione per crogiolarsi in quei limbi dell’intelligenza critica. Storia nazionale, ormai. Perchè si ammette che il depresso livello culturale del Paese si nutre fino all’indigestione di questa forma di evasione dai problemi singoli e collettivi, se ne fa un costume di vita ed un referente ideale, assorbe lietamente il profluvio di vacuità che emergono da questo genere di informazione e 8 Anomalie per un gioco, scale di valori e storia di una società contemporanea di applicazione a fasulli temi di esercizio della ragione condotti da sussiegosi e perentori quanto inconsistenti «intellettuali» della specialità (si segua anche di passata una delle infinite «tavole rotonde» sul calcio che intasano TV di Stato e private con partecipanti che si azzuffano sulle prestazioni di un giocatore, esibendo la prosopopea di scienziati che spendono ogni energia in siffatte ricerche e male tollerano di essere contestati da altri «scienziati» della materia). Storia nazionale: perchè una società investita in forma così globale e torrentizia da problematiche - per impiegare con indulgenza un termine di questa portata al tema - del calcio finisce per esserne segnata profondamente nella propria storia collettiva del costume e della cultura, rivelando debolezze desolanti di fronte a fenomeni di ottundimento dell’intelligenza e anche della morale, nonchè della scala di valori cui fare riferimento nei propri comportamenti al cospetto di realtà che le incombono e che richiedono ben altra serietà di analisi, ben altri impegni di riflessione e disponibilità partecipi alle soluzioni da vagliare ed affrontare per il bene comune. Questa deformante e convulsa applicazione alle vicende di un gioco investe la sostanza di una sequenza di fattori che costituiscono appunto una scala, giusto quella dei valori formativi e di condotta; ai quali deve fare capo l’educazione del singolo in quanto tale ed in quanto cittadino e per cui senza una coscienza esatta delle loro portata ci si consegna, e si consegna la propria collettività, alle peggiori gestioni del presente e dell’avvenire. Quando, ad esempio, è consentito ad un grottesco personaggio (che pare prelevato da una sala di museo Gravin e si avvale per le proprie dissertazioni di un italiano claudicante - Stupisce, per inciso, che giornalisti non sportivi di tutt’altra levatura si assoggettino a simili riti sotto la direzione di un guitto supponente ed altezzoso) di tenere la tribuna di una trasmissione settimanale della TV - il «Processo del lunedì» del Canale Sette - non soltanto osservando un codice di personale autorità dichiaratoria a pieno orizzonte, ma emettendo sentenze sulla statura umana e civile di singoli; quando si fa questo, si ingenerano distorsioni di codici di valutazione e di comportamento suscettibili di riverberarsi su tutto l’orizzonte dell’educazione del cittadino. Affermare, come si è visto fare dal suddetto personaggio campeggiando in uno schermo televisivo, che l’ex calciatore Maradona, noto cocainomane, gradito alla camorra durante il suo soggiorno partenopeo, evasore fiscale ed inadempiente ad elementari obblighi verso figli naturali, è «un grande uomo» per rintuzzare giudizi di al9 Mario Giovana tro tenore senza essere minimamente in grado di opporvi argomenti validi fuori da eventuali apprezzamenti di carattere sportivo, affermare siffatto grado di elevatezza per il soggetto rappresenta un pubblico incitamento ad oscurare valori cardine per la personalità del singolo in quanto uomo ed in quanto membro del consorzio civile, e pertanto ad incentivare una visione priva di ancoraggi morali dell’agire umano nel privato e verso la società. Un «modello» di tale fatta offerto ad esempio della «grandezza» a milioni di persone - soprattutto a giovani - costituisce una spinta a fare piazza pulita di remore e di vincoli di fronte alle responsabilità di pensare il comportamento di un uomo e di un cittadino e ignorando qualsiasi parametro di decoro e di retto agire che ne dovrebbe improntare l’etica personale. Siamo allo stravolgimento di ogni misura anche dell’elementare senso comune, poichè si inneggia, in nome del passato di una abile pedata al pallone, alla marginalità delle sregolatezze e delle miserie intellettuali facendone termini di giudizio in sostanza positivi sulla consistenza complessiva di una personalità. Il fatto che la insulsa affermazione del conduttore del «Processo del lunedì» non abbia trovato alcuna replica fra i presenti alla trasmissione, né suscitato proteste fuori da quell’ambito, appare un oscuro segnale dello stato di grigia inerzia morale ed intellettuale, se non di complice approvazione, in cui vegeta la coscienza di non pochi settori importanti della società italiana. Per altro verso, ancora, la pratica, divenuta consueta, di ornare la bara di un disgraziato ragazzo perito in qualche infortunio della vita con la maglia della squadra di calcio amata, sta ad indicare che a quel poveretto nessuno aveva insegnato che altri devono e possono essere i simboli rispondenti ad ideali alti e sostanziosi dell’individuo e del membro della società; per cui, lo sfortunato giovane ha trascorso il breve tragitto della propria esistenza ancorato a quell’unico referente di un destino auspicabile e di ammirazioni da coltivare, nel quadro delle quali si collocava anche, magari, la decantata superiorità umana del Maradona come faro-guida delle aspirazioni di successo e dei traguardi morali della persona. Da tempo, sociologi, psicologi ed antropologi si studiano di penetrare i recessi della passione calcistica, soprattutto per spiegarne le pulsioni estreme, quel «tifo» che pare fagocitare mente e cuore del militante calciofilo e che mobilita masse rabbiose ed incontinenti di individui in apparenza normali, talora precipitandoli nella palude del teppismo o tenendo10 Anomalie per un gioco, scale di valori e storia di una società contemporanea li, comunque, ostaggi di una permanente tensione irrazionale che li trascina a concentrare i propri pensieri sull’esito di un confronto calcistico oppure sul grado delle prestazioni di un attore dei duelli negli stadi. Oltre venticinque anni fa, la sociologa ed antropologa Ida Magli, in un perspicuo saggio sul fenomeno giustappunto dell’attrazione di massa della disciplina, ne individuava alcune cause di fondo: la partita di calcio come simulazione della guerra, richiami impliciti a maschilismi a sfondo sessuale, addirittura esternazioni di reconditi impulsi omosessuali - gli abbracci dei calciatori sul campo per festeggiare una rete -, ecc. ecc.( Ida Magli, Alla scoperta di noi selvaggi. Simboli e storie: giornale di un’antropologa, Rizzoli, Milano 1981, pp. 50-53). A nostro avviso, parecchie delle considerazioni della Magli, opportunamente - e disgraziatamente - amplificate nelle conseguenze dagli anni che viviamo, sono di assoluta pertinenza ed attualità. Ma, in questa sede, non è la discussione sulle motivazioni, nascoste od esplicite, del fenomeno «tifo» di massa che ci deve interessare; è, viceversa, il discorso - che abbiamo cercato di impostare - sulla vastità e profondità di una piaga che sfigura l’immagine di una società (all’estero, siamo spesso giudicati un «popolo di tifosi», come ci è capitato di udire da uno studioso belga), che ne segna in qualche modo la storia ai livelli infimi del progresso mentale e culturale. Vale a dire, in sostanza, delle stigmate della società italiana del presente: il che significa, della sua storia, poichè la storia intima di una nazione, salvo errori, non è unicamente - e principalmente, crediamo - la storia delle lotte nelle sue istituzioni, delle sue produttività industriali e dei suoi avvenimenti nella sfera politica. Ora, accade che l’evento invasivo del calcio non risparmi alcun settore della società italiana, dalla televisione alla pubblicità, alla cronaca mondana; accade che sedute parlamentari vengano sospese per consentire ai deputati di seguire un incontro di calcio (poiché, in caso contrario, si sospetta che le aule andrebbero deserte); accade che intere mezze giornate di trasmissioni sugli schermi televisivi vengano assorbite da resoconti calcistici, con la chiamata di divi del cinema, della stessa televisione e delle più svariate attualità a farvi da corona, in caroselli interminabili di banalità pettegole e di enunciati da baraccone (dei «gallinai», direbbe, pensiamo, Michele Serra, che ha usato l’espressione per definire un degradante prodotto dell’inventiva di intrattenimento fatuo, l’«Isola dei famosi»). Accade che il «tifo» per una squadra assuma valore di identificazione con una realtà civica storica locale, con il suo profilo distintivo, senza alcun nesso razional11 Mario Giovana mente possibile fra quel complesso di gioco ed il contesto socio-culturale e storico nel quale opera. Qui si toccano i vertici dell’assurdo. Il leader della sinistra radicale italiana, l’on. Fausto Bertinotti, novarese di nascita, mai vissuto a Milano, si dichiara tifoso della squadra del Milan, composta, come tutte le compagini calcistiche professionali, di elementi che non hanno alcuna origine dal luogo e nessun legame con la sua storia anche sportiva (sono «mercenari» trattati sul mercato a colpi di milioni di euro e pronti a mutare sede se incontrano offerte più allettanti, al pari di ogni loro collega di qualsivoglia altra compagine calcistica), proprietà dell’acerrimo avversario on. Silvio Berlusconi e presieduta da un suo fedele ciambellano, il citato Galliani. Quali sentimenti e quali ragionamenti si celino dietro il «tifo» dell’on. Bertinotti per siffatta insegna rimane un mistero che forse lo stesso leader comunista-rivoluzionario stenterebbe a spiegare nei salotti nei quali è accolto e riverito (forse in ragione della presumibile innocuità della proclamata valenza eversiva dei suoi propositi, oltreché della ricercata eleganza del vestiario di cui fa solitamente sfoggio); non si conosce esponente politico dei vari fronti contrapposti che non riveli la sua passione per una squadra e sono rari quelli che non frequentano le tribune degli stadi, magari confusi con i loro avversari ma in eguale spirito devozionale verso l’evento al quale assistono (che, talora, è una farsa presieduta da lucrosi accordi sottobanco su chi deve vincere, come risulta periodicamente dagli scandali che emergono a valanga, non di rado settimanale, sul fronte delle indecenze nazionali). L’universo calcistico è, quindi, inquinato non soltanto da un affarismo non di rado di taglio bancarottiero che viene alla luce con sempre maggiore frequenza (il caso del Perugia calcio può fare testo), non soltanto da sottoboschi di transazioni al limite della furfanteria peggiore, ma da coperture di entusiasmi e venerazioni che stampa, televisione, e anche troppo di frequente politica, tendono a trasformare in suggelli di «verità» dell’immagine nazionale ed in immanenza di valori che la connoterebbero. Ad uno stadio del genere, il fenomeno segna tangibilmente la storia del Paese, e fa corpo con i dati più disarmanti della sua involuzione culturale e morale. Il «cammino del gambero» di cui tratta Umberto Eco in pagine di un suo recente libro, che sfuggirà certamente all’attenzione dei tifosi del già proclamato immortale «pibe de oro» signor Maradona. 12 vivere la Resistenza «Cammini dritto chi non è gobbo». Omaggio a «Iso» di Francesco Omodeo Zorini Con questo breve scritto, da me letto davanti all’assemblea consorziale dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel VCO «Piero Fornara» nel sessantesimo della liberazione, intendo commemorare «Iso». Intendo farlo in modo divenuto inusuale, ma consueto ai partigiani che ci hanno preceduto alla guida dell’istituzione da loro voluta quarant’anni fa. Dai cattolici, ai comunisti, ai socialisti, agli azionisti, ai repubblicani, ai liberali, ai libertari e senza partito. Prima di tutto l’imprescindibile dovere di ricordare i nostri «maggiori», come li chiama Bobbio, che ci hanno di recente lasciato. Mi riferisco a colui che è stato tra i più importanti e meritevoli protagonisti, non soltanto della Resistenza della provincia di Novara (non l’antica né l’attuale, bensì quella per così dire «di mezzo» col Novarese, il Verbano, il Cusio e l’Ossola), ma della Resistenza italiana. Ogni giorno è un bollettino di guerra che il nostro foglio Resistenza Unita non può che riflettere con fedeltà. Dolorosi necrologi ne infittiscono le pagine. Le fanno nere di lutti. Per ineluttabile legge di Kronos molti amici e compagni meno noti, ma non meno degni della nostra ammirazione e riconoscenza, si stanno spegnendo e ci lasciano più soli. Reclamano da noi l’inarrestabile dovere di «rimettere continuamente al mondo la libertà». Parole di Hannah Arendt. Libertà: dono che essi ci hanno elargito non una volta per tutte. Ci consegnano un lascito da passare avanti, un legato ineludibile di inestimabile valore cui siamo tenuti. Ci chiedono di custodire le loro carte, documenti, testimonianze, memorie, fotografie. Di studiarle, farle conoscere, renderle scientificamente attuali. Scrivere libri e riviste. Di mettere in piedi biblioteche, emeroteche, strumenti multimediali: un laboratorio prepolitico di cultura, educazione, moralità. Non agiografia, né propaganda. Ci interpellano per far vivere le loro idee incarnate nella Costituzione della Repubblica, per continuare in democrazia la loro battaglia. Ci domandano di farci «testimo13 Francesco Omodeo Zorini ni dei testimoni», come dice Simon Wiesenthal, sopravvissuto al lager di Mauthausen e per mezzo secolo implacabile cacciatore di nazisti da consegnare alla giustizia. Anche lui scomparso da poco. Ricordare «Iso» è rileggere nella sua emblematica vita sessant’anni di storia del nostro paese. Nel romanzo della vita di ciascuno è racchiuso un pezzo di mondo, e il pezzo di storia incastonato nella vita di «Iso» è pesante. Tocca i passaggi cruciali di quella storia e vi entra imperiosamente da protagonista. «Iso» Danali, anagramma di Aldo Aniasi, adottato come nome di battaglia. Nasce a Palmanova di Udine nel 1921, dove il padre, di origine valsesiana, è procuratore dell’ufficio del registro. La madre è modenese e lui è il maggiore di quattro maschi: Guido, Mario e Ugo. I continui trasferimenti dovuti alla professione del padre lo portano a Rapallo, dove frequenta le elementari, a Mirandola nel Modenese, Rho (le scuole medie a Legnano), a Desio, Codogno, Magenta. Nel 1938 la famiglia si stabilisce a Milano in via Villoresi e si iscrive all’Istituto tecnico «Cattaneo» a Milano-San Cristoforo, in piazza della Vetra, uno dei quartieri più suggestivi della città che ha ispirato artisti e cantastorie. Reso celebre da Giovanni Raboni nella silloge di poesie Le case della Vetra: «Eh sì. Il Naviglio/è a due passi, la nebbia era più forte/prima che lo coprissero, la piazza/piena di bancarelle con le luci/a acetilene, le padelle nere/delle castagne arrosto, i mangiatori/di chiodi e di stoviglie […] in quelle scale, in certi portoncini/con la spia, nei cortili soffocati/dai ballatoi; lì semmai c’era umido/da prendersi un malanno». La Milano sottopopolare «risanata» per pressione della speculazione e del securitismo piccolo-borghese impaurito dalla lingera: «la gente/di qui, di piazza della Vetra, dietro/a San Lorenzo, era/gente da uscir di casa col coltello/alle sette di sera». E la vecchia canzone: «E fin che fiocca/a ‘sta manera/e la lingera, e la lingera/trionferà». Temi che si imprimono nella mente del milanese d’adozione che avrà la ventura di divenire «il Sindaco» per antonomasia della città. Al «Cattaneo» la professoressa di italiano e storia, di formazione crociana, dà a «Iso» e ai suoi compagni di classe i primi imput di educazione antifascista in parte già anticipata dal padre, socialista anteguerra. «I suoi discorsi appassionati mi convinsero che il fascismo era la prigione delle idee, io sceglievo la parte che allora sembrava non avere speranza: erano i tempi dopo la guerra d’Etiopia, i tempi più bui per chi non credeva nel fascismo, 14 «Cammini dritto chi non è gobbo» anni neri e disperati in cui molti intellettuali che fino allora avevano fatto la fronda, anche se inoffensiva, si erano convertiti al fascismo«. «Iso» partecipa a riunioni di discussione in casa di compagni di scuola e inizia la lettura di libri e pubblicazioni proibite dal regime. «La professoressa Romano fu denunciata al preside per antifascismo, ci fu un’inchiesta del Provveditore agli Studi, fu incolpata di averci parlato in classe di Marx e di Lenin. Qualcuno di noi la difese, disse che l’accusa era falsa, che la professoressa non ci aveva mai parlato di problemi politici. Ma era vero il contrario, e per me fu molto importante l’esempio di una persona che aveva avuto il coraggio e ci aveva detto la verità in un momento difficile». Scartato alla visita militare per daltonismo, nel 1940 si diploma geometra e trova lavoro all’impresa di costruzioni Radio, poi all’Anas fino al 1943. Nel 1941 consegue come privatista la maturità scientifica e si iscrive alla facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano. L’ingresso di «Iso» nella Resistenza non è quindi casuale come per altri giovani ma frutto della maturazione di una scelta consapevole controcorrente. L’8 settembre è sfollato con la famiglia a Codogno e sta lavorando a Lodi per l’Anas. Con amici socialisti, comunisti e azionisti organizza «assalti di massa» ai treni tedeschi in transito per la stazione ferroviaria, carichi di vettovaglie, vestiario, utensilerie. La popolazione è al loro fianco e agisce allo scoperto, senza doversi preoccupare di muoversi in clandestinità. Con una ventina di coetanei lodigiani e codognesi decide di salire in Valsesia da Moscatelli. Già vi andava in vacanza dai cugini. Raggiunge la valle su consiglio del capitano Coggi, ufficiale di cavalleria, monarchico, il quale si dice in grado di organizzare una banda di ribelli (poi passato coi repubblichini). Loro riferimento e punto d’appoggio è don Angelo, parroco di Campertogno, il paesino dell’alta Valsesia teatro sei secoli prima dell’eresia apostolica catara di fra’ Dolcino e della sua compagna Margherita da Trento, stroncata nel sangue e sul rogo dalla soldataglia del vescovo di Novara. L’avvocato Zacquini di Monza li ha segnalati a Bartolomeo Chiodo - il futuro capo di stato maggiore dei garibaldini di Moscatelli - che li ha guidati lassù. Si definiscono comunisti «rivoluzionari» scandalizzando i benpensanti. Si procurano armi disarmando nuclei della Guardia Forestale e della GNR. Entrano in collegamento con altre bande dislocate nella zona e con queste si aggregano a Camasco. Fanno il loro ingresso in formazione ragazzi del 15 Francesco Omodeo Zorini posto che non vogliono arruolarsi coi fascisti, operai che rifiutano di andare a lavorare per i tedeschi. Tra loro Martin Valanga, Pietro Rastelli, Celso Ranghini, Attilio Musati, i cui nomi diventeranno famosi. È guerra davanti alla porta di casa e qui si riforniscono di viveri e indumenti. L’aiuto dei valligiani è vitale. Arrivano anche ex-ufficiali, alpini e soldati sbandati che portano nel gruppo la loro esperienza militare. La guerriglia, flessibile, elastica, il contrario della guerra di posizione, un mordi e fuggi in perenne movimento, imparano a farla cammin facendo, mettendo a frutto il sapere dei montanari che conoscono il territorio e l’a-bi-ci della sopravvivenza. Non ci sono manuali. I partigiani il comandante se lo scelgono da soli in base al suo prestigio e al coraggio, alla prudenza e all’intelligenza. Il potere viene dal basso e il rapporto gerarchico non poggia sull’autoritarismo ma sul consenso costantemente verificato nella pratica quotidiana. Vige egualitarismo tra comandanti e partigiani: nessun privilegio, mangiano insieme condividendo lo scarso cibo, patiscono insieme il freddo e il disagio della precarietà assoluta, le estenuanti marce, i turni di guardia. Accanto al comandante opera con pari dignità il commissario politico. Suo compito è di parlare agli uomini, di dare sostegno spirituale e un senso alla strana guerra che stanno conducendo, di «educare» alla libertà, all’onestà intellettuale e alla democrazia con l’esempio. Spiegare le finalità della lotta: cacciata degli occupanti tedeschi e abbattimento del regime fascista nella versione sanguinaria della RSI, per porre fine alla guerra. Prefigurazione di un ordinamento statuale libero e democratico. Di conquistare il rispetto e la collaborazione della popolazione. Rendere fluida ed efficace la comunicazione e salda la comprensione reciproca all’interno della piccola comunità guerrigliera. Armonizzare e coagulare gli umori e i sentimenti individuali in spirito collettivo. In seguito a un primo scontro coi militi della «Tagliamento» sono costretti a salire a 1.200 metri all’Alpe Sacchi. In quei giorni del dicembre 1943 a Borgosesia vengono fucilati dieci partigiani; con loro è stato ucciso un industriale, l’ex podestà fascista Giuseppe Osella che sosteneva la lotta armata. A lui sarà intitolata l’81a brigata Garibaldi. Raggiungono Valduggia dove c’è il comando di Moscatelli che li aiuta a riorganizzarsi come formazione autonoma, sistemata a Cavaglia sopra Roccapietra, in collegamento operativo con i garibaldini di «Cino» e «Ciro». Non è sufficiente l’apporto dalla Valstrona della formazione del capitano Beltrami a Moscatelli per fronteggiare il rastrellamento della «Tagliamento». Il gruppo di «Iso» ripiega a Rimella e da lì è costretto a stanziar16 «Cammini dritto chi non è gobbo». si temporaneamente in dislocazione difensiva all’Alpe Baranca, a duemila metri a cavallo tra la Valsesia e la Valle Anzasca. Il comando militare è affidato al Attilio Musati e «Iso» assume l’incarico di commissario. Dopo incursioni a fondovalle l’inverno impone loro di ripiegare alla base operativa dei garibaldini di Moscatelli a Rimella. La riorganizzazione e la nuova dislocazione dei reparti li obbliga allo sconfinamento in Ossola. Il distaccamento chiamato «Fanfulla», perché costituito prevalentemente dai lodigiani saliti in montagna con «Iso», è comandato da lui, affiancato in qualità di commissario da Pippo Coppo, classe 1908, operaio falegname della Cobianchi di Omegna, comunista fin dalla seconda metà degli anni trenta e collettore del partito nell’Alto Novarese. Da lì il trasferimento del «Fanfulla» nella Bassa Ossola al Monte Massone, Alpe Fieno Secco, sopra Ornavasso, a far capo dall’aprile 1944. Il distaccamento «Camasco» comandato da Dino Vicario «Barbis» va in Valle Antrona e il «Torino» al comando di Renato Zametti «Boris» si stanzia in Valle Anzasca. 150 uomini in tutto, oltre ad alcune decine disarmati e in abiti civili. Nel luglio del 1944 le forze garibaldine in loco raggiungono le 400 unità cui vanno ad aggiungersi 250 disarmati. L’afflusso alle formazioni di nuovi patrioti - i cosiddetti «sfollati» - è in parte la risposta al bando mussoliniano che fissa al 25 maggio il termine ultimo di presentazione per l’arruolamento nelle milizie di Salò per «fuori-legge», sbandati e renitenti, pena l’eliminazione. Si rende necessaria la costituzione all’Alpe Previano, sopra Cesara, di un apposito centro reclutamento. Dalla fusione dei distaccamenti «Fanfulla», «Carletti», «Redi», «Monte Massone», «De Micheli», «Eliot», «Romolo», «Bariselli» e «Godio» nasce la 15a brigata Garibaldi, non più dipendente dalla 1a divisione della Valsesia. Commissario è «Pippo», comandante «Iso». Vice-commissario (senza vicecomandante) è Gino Vermicelli «Edoardo». La base è il Massone, sulle cui pendici, all’alpe di Corte Vecchio è stanziata parte della divisione azzurra «Valtoce» comandata da Alfredo Di Dio «Marco» che i garibaldini hanno soprannominato «Opera Pia». I rapporti fra le formazioni di differente ispirazione ideale non sempre sono facili e talvolta sfociano in aperto dissenso e contrasti che influiscono negativamente sulla collaborazione, come nel caso delle operazioni militari per liberazione dell’Ossola: accaparramento di aviolanci destinati alla formazione concorrente, divergenza di scelta di indirizzo della guerriglia, come nel caso della battaglia di Gravellona, polemiche sull’attesismo, diversi e perfino antitetici rapporti col ne17 Francesco Omodeo Zorini mico, come nel caso della costituzione della Zona Neutra di Omegna patrocinata dal prevosto don Annichini. Sempre in luglio, il 18 per l’esattezza, viene costituita la 2a divisione d’assalto Garibaldi, intitolata a Gianni Citterio «Redi» di Monza, uno dei tredici caduti di Megolo, e strutturata su due brigate, la 15a e la 83a «Valle Antrona». «Pippo» è commissario, «Iso» vice-comandante, «Edoardo» vicecommissario e «Boris» capo di stato maggiore. Ai primi di settembre alla vigilia della liberazione dell’Ossola la divisione «Redi» è strutturata su quattro brigate per complessivi 1.300 garibaldini operanti in tutte le valli dell’Ossola. Sede del comando è Villadossola. «Pippo» è il commissario e «Iso» il comandante della più consistente formazione partigiana della Zona liberata nel settembre-ottobre 1944. La mitica Repubblica partigiana assurta agli onori della cronaca della stessa coeva stampa fascista e tedesca, come di quella svizzera e americana. Significativa nell’enclave partigiana in particolar modo la consegna dell’autogoverno da parte delle forze militari partigiane a pubbliche istituzione democratiche. Riprova della consapevolezza dei partigiani che non stanno combattendo una guerra tradizionale secondo criteri di opportunità militare ma che l’obiettivo è un modo nuovo di governare dando senza indugio la sovranità ai cittadini. «E così si opera su due piani. Il primo - fondamentale -, come osserva Giovanni Cerutti, è quello dell’opinione pubblica, che viene ricostruita attivando luoghi di confronto delle idee, con assemblee in ogni comune e una straordinaria fioritura di testate giornalistiche. […] Il secondo è la ripresa dell’attività politica», del conflitto regolato come motore di progresso con l’accesso al sistema politico di tutte le istanze sociali. Sono i principi sui quali si innerva il Costituzionalismo europeo del dopoguerra, esplicitati specificamente nella distinzione dei poteri, di cui è esempio l’azione di Ezio Vigorelli incaricato dalla Giunta provvisoria di Governo di ricoprire il ruolo di giudice straordinario per le istruttorie penali di carattere politico. «Una scelta, secondo Cerutti, di grande respiro, che afferma, in chiara polemica col fascismo, l’indipendenza del potere giudiziario dal potere politico come condizione per garantire le libertà dei cittadini e tutelare i diritti umani. Una lezione di civiltà che continua a parlarci». Infine si ha la consapevolezza che l’istruzione è «la precondizione per l’esercizio dei diritti di cittadinanza, che la democrazia può crescere solo se le società si impegnano a formare individui in 18 «Cammini dritto chi non è gobbo» grado di leggere se stessi e il mondo senza condizionamenti, senza doversi uniformare a precetti e dottrine. Idea che si tradusse in una riforma della scuola e dei testi scolastici ancora oggi all’avanguardia e nell’istituzione di una scuola superiore popolare, curata da Mario Bonfantini». Mi preme sottolineare inoltre che nelle file della «Redi», specie nella 10a brigata «Rocco», prende corpo il bisogno di cultura e di educazione democratica che si concretizzerà - Luciano Raimondi «Nicola» ne è forse l’assertore più sagace - nell’istituzione a guerra finita dei dodici Convitti scuola della Rinascita sparsi nelle città del Nord Italia. È in gran parte l’esito dell’azione dei commissari o delegati politici nelle lezioni e dibattiti dell’«ora politica» nelle scuole alla macchia, persino con temi da svolgere, nella creazione di piccole biblioteche itineranti in quella «guerra di corsa» che è la guerriglia, nella redazione dei giornali murali di formazione. Uno degli esemplari ed emblematici commissari (non solo cappellano, ma commissario a tutti gli effetti in una formazione di ispirazione comunista) è don Sisto Bighiani di Ornavasso. La figura del commissario ha peraltro un’antica storia. Nasce impensabilmente tra vele, ancor prima che nell’armata puritana di Cromwell, primo regicida moderno, ancor prima che tra i sanculotti della Rivoluzione francese, che nelle armate napoleoniche, che tra i volontari di Garibaldi, che tra i bolscevichi della rivoluzione d’Ottobre, che tra le Brigate Internazionali della guerra di Spagna, nell’Armata rossa, nell’Armata proletaria di Tito, tra i barbudos di Fidel. È il quartermaster, una sorta di nostromo mediatore di conflitti, armonizzatore degli umori della ciurma, affiancato al capitano eletto dall’equipaggio tra i gentiluomini di ventura della filibusta. Avevano osato ribellarsi a catene, frusta, gerarchia della marina di Sua Maestà. Osato immaginare e vivere una vita diversa da egualitari tra spinnakers e solings. Alla caduta della Repubblica dell’Ossola «Iso» e i suoi rifiutano lo sconfinamento in Svizzera e a marce forzate si portano sul Lago d’Orta con incessanti spostamenti strategici attorno alla zona di Cesara per continuare la lotta. Nella fase insurrezionale apparecchiano il piano difensivo delle installazioni produttive dell’Ossola, Cusio e Verbano che i tedeschi per far terra bruciata vogliono danneggiare e distruggere. Particolarmente importante il salvataggio con sminamento notturno da parte di suoi partigiani della Galleria del Sempione che i tedeschi hanno disposto di far saltare. Il magnificente tripudio della liberazione «Iso» non può assaporarlo nella sua Milano esultante, perché sta combattendo contro gli ultimi mici19 Francesco Omodeo Zorini diali colpi di coda dell’armatissima colonna tedesca in ritirata comandata dal capitano Stamm della «Kriegsmarine» e del repubblichino tenente Finestra tra Stresa e Arona. Dopo il 25 aprile è insignito di Medaglia d’argento al V. M. Riprende la vita civile cimentandosi nell’esperienza dell’attività privata con l’apertura dello Studio tecnico-commerciale ABC. Poi il sodalizio con Ezio Vigorelli, già commissario alla giustizia nella giunta provvisoria di governo dell’Ossola, sindaco di Milano, e poi ministro del Lavoro, cui i nazifascisti hanno ammazzato i due figli nel rastrellamento nella Valgrande (giustamente ribattezzata Martire) nel giugno 1944. Al suo fianco «Iso» svolge il delicato e essenziale compito, nella desolazione umana, sociale ed economica del primo dopoguerra, di guidare con efficienza e razionalità l’Ente comunale di assistenza. In questo ambito unifica nell’ANEA le varie associazioni ed enti di assistenza e fonda il periodico «Solidarietà umana». Lascia il Partito comunista nel 1945 per aderire al PSIUP e poi nel 1947 alla scissione di Palazzo Barberini allo PSLI di Saragat insieme ai giovani di «Iniziativa socialista»: Italo Pietra, Mario Zagari, Giuliano Vassalli, Leo Solari, Ezio Vigorelli, Antonio Greppi. Nel 1959 ritorna al PSI di Nenni, Lombardi, De Martino quando questo spezza i legami col comunismo sovietico. Dopo la rottura dell’unità resistenziale aderisce alla FIAP, l’associazione terzaforzista liberal-socialista fondata da «Maurizio» Ferruccio Parri nel 1949, che raccoglie partigiani giellisti, laici e parte dei socialisti delle brigate «Matteotti». «Iso» la presiede per 18 anni dal 1987 alla morte e si adopera con passione verso l’ANPI e la FIVL per il ritorno all’unità. Non possiamo dimenticare il suo foglio «Lettera ai compagni» che fa proprio il motto di Parri: «Cammini dritto chi non è gobbo», accompagnandoci per decenni. Consigliere comunale nel 1951 come Gisella Floreanini, primo ministro donna nella Giunta di governo della Repubblica dell’Ossola, e Mario Venanzi «Michele» commissario della 1a divisione Garibaldi-Valsesia. Poi assessore all’Economato dal 1954 al 1959 e ai Lavori Pubblici dal 1961 al 1967. Deputato per cinque legislature, nel 1976, 1979, 1983, 1987 e 1992, due volte vicepresidente della Camera per complessivi dieci anni dal 1982 al 1992 e due ministro, prima della Sanità, poi degli Affari regionali. Nominato responsabile nazionale per il PSI degli enti locali. Ma la persona di «Iso» si sublima e identifica con il Sindaco di Milano per eccellenza, 20 «Cammini dritto chi non è gobbo» nella scia dei grandi predecessori di matrice socialista come Caldara, Vigorelli, Greppi, Ferrari. È sindaco dal 1967 al 1976, periodo definito da alcuni «decennio del diavolo». Periodo difficile e convulso del grande movimento dell’insorgenza giovanile antistituzionale e antiautoritario operaio, sindacale, studentesco, femminile, civile cui l’establishment reagisce con la strategia della tensione, lo stragismo di Stato, nell’intreccio di repressione poliziesca e provocazione tra corpi separati, servizi segreti nazionali (cosiddetti «deviati») e statunitensi, neofascismo e mafia, società segrete e criminalità comune, con ben quattro tentativi di colpo di stato, per affossare la democrazia come nella Grecia dei colonnelli e, più tardi, nel Cile di Allende e di Neruda. Sono i terribili «anni di piombo» del terrorismo brigatista e di quello neofascista che insanguinano soprattutto Milano. L’attentato alla Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 acquista la rappresentazione simbolica di «perdita dell’innocenza» della capitale morale della Resistenza e segna il punto saliente della parabola di «Iso» sindaco di Milano, del suo rapporto con la città e con la memoria. Lo ricordiamo affranto, avvolto nella nebbia sul sagrato del Duomo, ai funerali delle vittime straripanti di folla ammutolita. Lo ricordiamo sconcertato per la definitiva archiviazione del processo dopo quasi quarant’anni, senza colpevoli, né complici, né mandanti. «Comunque - diceva, con spirito pasoliniano - la verità storica è scritta: strage fascista coperta dallo Stato». «Iso» riesce tuttavia in quei drammatici frangenti con un dialogo fermo e pacato a tenere unita la città contro la destabilizzazione imperversante. Durante il mandato di primo cittadino traghetta l’amministrazione milanese da una maggioranza di centro-sinistra ad una di sinistra. Sono gli anni della seconda ondata dell’immigrazione «incessante e speranzosa» dal Sud di centinaia di migliaia di italiani, seicentomila nel decennio precedente. Come ricorda Rossana Rossanda hanno bisogno di case, di strade che non siano fosse di fango, di elettricità e fognature, di un salario meno miserabile dal padrone, e dal Comune di servizi e allacciamenti. Quel che più manca è dove alloggiare, «nemmeno nei seminterrati, troppo cari, e per cominciare ci si infila in qualche buco in provincia, fin nelle scuderie dismesse delle vecchie ville». «La città scoppiava, esplodevano le scuole pur pensate con lungimiranza a inizio del secolo dalla giunta socialista Caldara». Si va affermando una concezione della metropoli con quartieri «a misura d’uomo» per cui necessitano case popolari e recupero abitativo. «Iso» 21 Francesco Omodeo Zorini - ultimo sindaco degno della tradizione del socialismo milanese - e la sua giunta cercano di far fronte ai problemi con lo strumento della programmazione, con dinamismo democratico-riformista, grandi doti organizzative e pragmatismo attento prioritariamente ai bisogni delle classi subalterne, soprattutto potenziando i servizi: bene pubblico, spazi pubblici, proprietà pubblica. Il verde a Milano, povera di piazze, è venti volte inferiore che a Los Angeles o a Stoccolma e sette volte meno che a Londra. C’è il problema del crescente inquinamento atmosferico aggravato dalla nebbia meneghina e l’amministrazione progetta la trasformazione delle caldaie e la creazione di zone pedonali nel centro storico. I trasporti non sono sufficienti ed è opera della sua amministrazione la costruzione della linea 2 della Metropolitana. Si comincia ad affrontare la piaga dell’evasione fiscale, mentre si percepiscono avvisaglie di una sotterranea pratica corruttiva di «bustarelle». Ma è anche l’epoca dell’incipiente declino economico e sociale di Milano caratterizzato dal disinvestimento produttivo specie dall’epoca della crisi energetica. Si è alla fine del virtuoso ciclo economico del «paradigma fordista» in cui capitale e forza lavoro, secondo un modello conflittivo/negoziale, hanno stretto sulle macerie della guerra un tacito patto per la crescita e lo sviluppo. Milano, indurita dalla perdita della propria identità, fatta di intraprendenza nel rispetto e decoro, senza vanto e vanità, sembra andare verso una sindrome autodistruttiva. È «il crollo delle aspettative» - come titola il pamphlet di Luca Doninelli -, profonda crisi morale degli «anni dei lupi», gli anni ottanta, in cui dominano edonismo autoreferenziale, magnificazione dell’effimero, affarismo spregiudicato, secessione dei vincenti che le farà meritare l’appellativo di «Milano da bere». Più tardi - allorché Milan dal coeur in man diventa suo malgrado laboratorio nazionale di collusione tra criminalità e politica, cinico neoconservatorismo, autismo particolaristico e xenofobo - tra i giovani si diffonderà addirittura quello ancor più spregiativo di «Milano da vomito». Quando Craxi con metodi autoritari diventa padrone del PSI, Aniasi in sordina si defila ed è da notare come sia forse l’unica personalità di spicco del socialismo milanese ad uscire a testa alta dal terremoto di tangentopoli e dintorni. Gli si addicono le parole di Claudio Magris dell’ultimo romanzo Alla cieca: «Finché te le danno gli altri, i nemici, i farabutti, è una cosa che se hai fegato, puoi sopportare. Il peggio viene quando a metterti nella fossa dei serpenti sono i tuoi, e dopo un po’ non sai più se quelli so22 «Cammini dritto chi non è gobbo» no i tuoi o se sono le carogne che con i tuoi hai sempre cercato di spazzar via. E dopo ancora un po’ non sai nemmeno più se anche tu sei dei nostri o sei diventato uno dei loro». «Iso» si spende con tenace passione a coltivare i nobili ideali del socialismo originario nel Circolo milanese De Amicis, sua creazione, inaugurato da Pietro Nenni nel 1968. L’associazione è intitolata a «quel personaggio come osserva Guido Bersellini -, accantonato, o rammentato con fatica e con la consueta presuntuosa sufficienza tanto di moda ai giorni nostri, ma che resta tra i precursori di quel primo socialismo umanitario e democratico italiano, che ha poi avuto Filippo Turati e i turatiani, Giuseppe Saragat e anche Carlo e Nello Rosselli, tra i suoi interpreti migliori». Il circolo aggrega socialisti e giellisti e si pone l’obiettivo di ricondurre a una casa comune i dispersi della diaspora del garofano. È aperta a tutte le componenti dell’antifascismo e tesa a rintuzzare con le residue forze l’offensiva del revisionismo storico e politico. Vi passano a centinaia le più importanti personalità della politica, della cultura e dell’arte in dimensione internazionale. «Iso» giudica ambigua, tendenziosa e fuorviante la formula storiografica della «guerra civile» appartenente all’armamentario ideologico della destra nostalgica: «Come è noto, - scrive - il primo a definirla tale fu Giorgio Pisanò, l’esaltatore della RSI e delle sue bande. Perché la definì tale? Non mi pare dubbio che l’obiettivo che egli si proponeva era di sostenere il diritto che i vinti avessero la stessa dignità dei vincitori». Altrettanto ritiene sia da respingere senza esitazione l’incauto omaggio reso ai «ragazzi di Salò». All’uscita del libro Il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa - ricorda Angelo Del Boca - manifesta sconcerto e indignazione. Non riesce a capacitarsi di come lo stimato giornalista dell’«Espresso», apripista nelle monografie resistenziali col saggio giovanile Guerra partigiana tra Genova e il Po, abbia potuto, col pretesto di squarciare «il silenzio sull’altra faccia della guerra che divise in due l’Italia», pervenire nelle sue pagine ad un’adesione così smaccata alla memorialistica della RSI e scivolare in errori e forzature che potevano essere evitati con un lavoro di scavo metodologicamente rigoroso. Nel 1994 «Iso» riflette con amarezza: «Quale mortificazione è stata quella di assistere al corteo di giovani che, subito dopo l’annuncio della vittoria elettorale, cantando inni fascisti entrarono, bandiere al vento, a Palazzo Marino [sede del Comune di Milano, n.d.a.] guidati da un loro dirigente, già segretario del MSI noto negli anni settanta per aver guidato gli 23 Francesco Omodeo Zorini scontri nelle piazze contro i democratici e che quel giorno dichiarò: “Finalmente ritorniamo dopo 50 anni”, confermando così la continuità con il regime fascista». Nel 1998 aderisce ai Democratici di sinistra ed è membro del consiglio nazionale della Quercia. Concludo ricordandolo, con esile voce consumata dal tumore ai polmoni già diagnosticato ma abrasiva e tagliente come non mai, al suo epilogo, alla sua vera apoteosi: il festeggiamento dello speciale 25 aprile del Sessantesimo della Liberazione, in piazza Duomo affollata da 200 mila persone. Dà il benvenuto, «a nome della cittadinanza milanese» al Presidente Ciampi «garante della Costituzione» e protagonista della manifestazione. Muto nell’angolo, il sindaco ufficiale Albertini, «invisibile» per timore dei fischi del popolo antifascista. «Iso» gli rifila un metaforico ceffone quando stigmatizza «tutti quelli che in modo petulante propongono l’abolizione del 25 aprile», quelli che - «doppia provocazione» - miagolano l’equiparazione tra i caduti per la libertà e quelli della Repubblica di Salò, intonando il ritornello «i morti sono tutti uguali» e fanno in parlamento l’equivalenza giuridica tra i partigiani e le camicie nere al soldo di Hitler, visto che hanno perso per sempre la speranza di poterla fare sul piano storico e soprattutto su quello etico-civile. A lui premeva più dell’uguaglianza nella morte la disuguaglianza nella vita. Migliaia di cittadini, lavoratori con le famiglie gli rendono omaggio sfilando nella camera ardente allestita nella sala Alessi di Palazzo Marino. Le sue ceneri sono tumulate nel famedio dei milanesi illustri al Cimitero Monumentale e la grande partecipazione popolare alle sue esequie assurge a valenza simbolica di unità della sinistra e dell’antifascismo nel suo nome. Bibliografia P. SECCHIA - C. MOSCATELLI, Il Monte Rosa è sceso a Milano, Einaudi, Torino 1958; A. ANIASI, Sindaco a Milano, Palazzi, Milano1970; Guerriglia nell’Ossola. Diari, documenti, testimonianze garibaldini, a cura di M. Fini, F. Giannantoni, R. Pesenti, M. Punzo, Feltrinelli, Milano 1975; B. FRANCIA, I garibaldini nell’Ossola, Saccardo, Ornavasso 1977; C. BERMANI, Pagine di guerriglia. L’esperienza dei garibaldini della Valsesia, voll. I-IV, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli «Cino Moscatelli», Borgosesia1995-2000; Ne valeva la pena. Dalla Repubblica dell’Ossola alla Costituzione italiana, a cura di A. Aniasi con la collaborazione di G. Vermicelli ed E. Carinelli, F.I.A.P.-MB Publishing, Milano 1997; Ciao, Iso, «Lettera ai compagni», Milano, a. 34, n. 5, settembre-ottobre 2005; A. ANIASI «ISO», Un uomo autorevole, in Pippo Coppo partigiano e sindaco della Liberazione, Comune di Omegna, 2005, pp. 21-27. 24 storia locale Il linguaggio di Enrico Vezzalini di Giancarlo Pozzi Le ordinanze prefettizie contro «la canaglia banditesca» Dell’autodifesa di Enrico Vezzalini, uno dei più fanatici esponenti del fascismo «mai morto» e il più determinato animatore dell’operazione Ossola nel ruolo di capo della Provincia di Novara, sopravvive l’immagine che l’imputato caparbiamente ha dato di sé nell’interrogatorio in Corte d’Assise, imperterrito nella parte che recita di anonimo e ininfluente gregario che non sa, non vede, non sente nulla, non dispone di agenti, non ordina rappresaglie, non tollera illegalità, non porta uniforme militare, semmai una mise di caccia verdina. In una litania che non ha fine, di repliche a discarico delle sue responsabilità e di rivendicazioni a difesa dell’integrità dell’animo e della vita, l’autostima che esibisce si focalizza sull’immagine di soldato della propria Fede, che tiene a sdegno la taccia di sgherro dello straniero e sicario di partito. L’impettita rivendicazione dell’esercizio burocratico della sua reggenza prefettizia, estranea a mansioni fuori d’ordine, mira a sottrarlo ai riscontri oggettivi e alle irrecusabili testimonianze del dibattimento per riconoscergli il profilo dell’uomo d’ordine e di fede patriottica, che esercita le funzioni di controllo e di assistenza «per tenere la provincia in tranquillità», attenuando i poteri dei comandi germanici. Ma è l’andamento del processo che comprova la diretta responsabilità dell’imputato per i fatti tragici che costellano il suo percorso di gerarca fascista a partire dall’eccidio di Ferrara del 15 novembre 1943, d’una durezza vestita di false parole e gonfia d’odio e di protervia in tutte le occasioni, che si vale di mezzi estremi. Il suo stato di servizio sciorina la vera identità di sicario e di volgare mestatore che ha deciso di ferrarizzare l’Italia. Un riscontro particolare lo può fornire l’inveterata aggressività del suo linguaggio a bocca e in scritto, consentaneo al sentire che lo innesca e l’indirizza. Ma in questo ambito un modello, chiamiamolo così, normativo che pre25 Giancarlo Pozzi scrive modalità espressive nella lotta antibande è rinvenibile in una circolare interna, datata Vercelli 8 maggio 1944, che reca la firma del ten. col. Merico Zuccari, comandante della famigerata Legione d’Assalto Tagliamento: «Prescrivo che la parola partigiano sia bandita dal nostro linguaggio comune ed ufficiale. La denominazione di tali schifosi e spregevoli individui dovrà essere esclusivamente quella che più a loro si addice, e cioè banditi. È necessario non dar tregua a questo nemico, che è più nemico degli anglo-americani»1. Da simile fonte non sorprende l’idea meschina della prescrizione che impone di sopprimere l’appellativo con un pedigree storico nel parlare quotidiano, che deve essere sostenuto da un tessuto verbale carico d’odio e di tracotanza. È su questo versante negativo che si può riconoscere nel linguaggio del Vezzalini il rispecchiarsi del suo connaturato fanatismo mediante uno spoglio del lessico e dei modi espressivi impiegati negli interventi pubblici in provincia di Novara che restano accessibili, fino a quando non si avrà la disponibilità anche del ventilato fondo di quaderni del carcere compilati nei cento giorni trascorsi in attesa dell’esecuzione. Nella sequela di bandi, appelli, comunicati e pezzi di cronaca, quanto a pregnanza di retorica orecchiata si distingue l’irrituale messaggio dell’insediamento in prefettura alla data 10 agosto 1944, che merita d’essere riportato: «Mi assumo di reggere la provincia di Novara con lo spirito del combattente che non vuole e non può vedere frustrato il sacrificio dei Migliori, con la fede del fascista che si batte per il trionfo dei principi ideali che sono all’avanguardia nei campi dello spirito, dell’audacia e dell’umanità. Conosco la situazione. Non mi spaventa. E se anche ore ancora più gravi sono riservate, ho la certezza che giungerò allo scopo, insieme a coloro che avranno tenacia ed audacia, […]. I disonesti, gli incapaci, gli abulici, gli inetti, gli ignavi e gli anti-italiani disertino prima che la loro attività criminosa e la loro inattività colpevole provochino misure durissime»2. Il tono infuocato del discorso, consono alla mistica fascista di comando e di obbedienza, che accompagna un elenco inzeppato delle categorie di non allineati «anti-italiani» è finalizzato ad innescare un’eco patriottarda con un di più di pressione psicologica. In una circolare di rito «Ai Podestà e Commissari Prefettizi» del 22 settembre 1944–XXII, che ordina drastiche misure repressive a carico dei congiunti di renitenti, disertori e banditi, il capo della Provincia fa fronte con uguale dovizia d’enfasi «all’attività dei fuori-legge esercitata con be26 Il linguaggio di Enrico Vezzalini stiale, inumana ed odiata violenza in evidente ossequio e con volgare servilismo agli ordini del nemico della patria». Con maggiore evidenza spicca il tono didattico del manifesto del 24 agosto 1944-XXII ai Podestà di una provincia addormentata, che adotta parole marcate da supponenza autoritaria: «Sembra che non riusciamo a comprenderci. Allora sarò ancora più chiaro. […] Per difendere i paesi non sono necessarie Grandi Unità: basta che gli uomini di turno si armino con fucili da caccia e qualcuno stia pronto alle campane da suonare a stormo, appena si profilino minacce. Se la popolazione accorre basta una fucilata, perché i banditi usino prudenza. […] Dove vedrò che la popolazione si sveglia dall’invigliacchimento, manderò aiuti anche armati. […] Avvicinare gli onesti per convincerli che è tempo che la popolazione si svegli dal letargo e si vergogni della omertà. Che cosa riservi loro la canaglia banditesca lo sanno già»3. È la popolazione incurante dei propri doveri il bersaglio privilegiato di una rosa d’ingiurie e di minacce ai capi famiglia, ai paesani, ai familiari di assenti ingiustificati, ai renitenti e disertori, a chi dà i propri figli alle bande, a chi aiuta i fuorilegge e a chi non li avversa. Le ordinanze prefettizie travalicano il linguaggio burocratico, intendono piuttosto mobilitare la piazza con un ultimatum psicologico di due alternative perentorie tra l’acquiescenza al potere e la compiacente collaborazione nella lotta alla canaglia banditesca. Il lemma «invigliacchimento», sostantivato dal suffisso a una base verbale, è coniato dallo stesso Vezzalini per rendere meglio percepibile la febbre persecutoria che lo spinge a un’offensiva di male parole, che gli ritornano spesso alla bocca per la scarsa estensione del suo vocabolario. Dopo la rioccupazione dell’Ossola viene indirizzato alla «Gente Novarese» il primo manifesto datato Ottobre XXII, cinquanta righe firmate E. Vezzalini squadrista, a scapito del precedente professionale Avv. E. Vezzalini meno leggibile quando all’emergenza occorre presentarsi con una più forte identità. Il testo tocca l’apice dello sfascio retorico con una infilata di parole vuote e d’ingiurie nella cornice di una sguaiata prosopopea squadristica. I cosiddetti patrioti vengono qualificati ad abundantiam come banditi, sicari, traditori, briganti, fuorilegge, marionette e in locuzione di maniera come «eroi per i bastardi, che hanno insegnato l’assassinio, la rapina, l’imboscata, l’omertà» e anche con un sarcasmo di seconda mano, «i cavalieri della vergogna», paralleli al noto titolo su «La Stampa» del 29 dicembre 1943: I cavalieri della macchia a firma del direttore Concetto Pettinato, che a sua volta mostra un debole per l’accumulazione di sinonimi e anto27 Giancarlo Pozzi nimi: «C’è chi li chiama ribelli, c’è chi li chiama partigiani, c’è chi li chiama addirittura patrioti. Il nome poco importa. La cosa però è grave e importa moltissimo. […] Urge sfatare l’aureola che si è creata intorno ai latitanti della montagna […]. Sono taglieggiatori, banditi, delinquenti, malandrini camuffati». La frenesia classificatoria non mira a scansare ambiguità, è piuttosto un segno di debolezza dinanzi ad una situazione percepita come piena di minacce e di nemici, che spinge a cercare un compenso in mosse d’effetto come la ripetizione di termini comuni, che servono a ripigliare le smagliature del discorso. La retorica del Vezzalini è farcita di rimpasti di una povera fraseologia propagandistica: «la tragica carnevalata dei banditi sta per finire» oppure «l’ubriacatura di tutto un popolo poteva essere guarita soltanto dal duro schiaffo della realtà», fino a mollare la presa nel marasma di parole guastate dall’uso. Mentre il miraggio trionfalistico che inganna i mestatori di Salò, rimasto brullo di lusinghe, si limita a reclamare spazio sopra le righe, che ottiene in termini di goffa ampollosità: «Non è vero che tutto intorno sia buio; è vero che non si vuole vedere la luce. Ma per mirarla bisogna guardare più in alto. Molto più in alto della pancia, del portafoglio, della nostra carcassa umana. […] Niente ci verrà regalato. E l’avvenire non si acquista. Si conquista»4. La chiusa del manifesto poggia su un’asserzione che scarica in una massima da caserma la retorica di un reboante vaniloquio, tra pancia, portafoglio e povere carcasse umane. Resta da mettere a confronto il fulgore dell’avvenire «che non si acquista. Si conquista», che è un calco imperfetto estratto dal comunicato ai Podestà del 10 agosto 1944, con il diritto alla vita che «dobbiamo meritarcelo; non acquistandolo ma conquistandolo», con una prosa che riformula i modi plateali della propaganda e appioppa ai cittadini l’accusa di vigliaccheria e ai ribelli la nomea di «ladri volgari truccati da elementi sabotatori al soldo del nemico» e di banditi5. Il repressore minaccioso non è persuasore efficace, ammoniva a suo luogo e tempo il Tommaseo. A dare il primo annuncio dell’ingresso in Domodossola della colonna Noweck con i legionari SS italiani e i paracadutisti del «Folgore» - e dietro, l’Aprilia grigia con il Vezzalini in tenuta di caccia, autista l’agente della Squadraccia Ermanno De Gregari di Trecate - è l’edizione ossolana in zona d’impiego di «Ardimento» del 15 ottobre, entro il riquadro Arrivano gli italiani, vergato dal brigatista pennaiolo Malanotte: «Col Battaglione so28 Il linguaggio di Enrico Vezzalini no anche i sempre presenti Tupin, c’è il segretario politico di Domo Maffi col gagliardetto del Fascio, c’è un tipo brutto, con una strana tenuta che dicono si chiami Vezzalini, ma soprattutto c’è il Battaglione Debiza. Ragazzi magnifici». Muta per ora convento il capo della Provincia, stendendo un avvertimento che si rivolge in tono più cauto al popolo dell’Ossola dalle pagine di «Ardimento» (17 ottobre), un testo dello stesso tenore, ma ricamato d’enfasi, dell’annuncio al duce del suo ingresso nella capitale ribelle alla testa delle avanguardie: «In nome vostro e dei nostri Caduti portiamo bontà e clemenza. Vogliamo, dopo avere rioccupato questo lembo d’Italia, conquistare gli animi». Ora, la vibrata esortazione, a malapena tenuta a freno, ad accomodarsi alle circostanze che viene rivolta agli indocili abitanti è una mossa per tranquillizzare l’ambiente con l’artificio della verbalità più curata, anche se l’effetto trascinante che ci si propone resta scalfito dallo strombazzamento della propaganda, che d’obbligo chiama banditi i ribelli, intralciando la partecipazione emotiva degli ossolani: «Popolo dell’Ossola, i soldati che non hanno tradito ti riportano l’Italia. Non chiedono applausi, fiori, bandiere: gli applausi non sarebbero sinceri; i fiori troppi Caduti li aspettano soltanto dalla primavera ed i combattenti soltanto dalla Vittoria; di bandiere ne adorano una sola e quella l’hanno in cuore e Volantino della Propaganda-Abteilung Italien, ottobre 1944 29 Giancarlo Pozzi dal cuore non si ammaina. Non ti chiedono pane: te lo vengono a portare quando la fame era già un incubo che non ti permetteva più di sorridere ai banditi. E non ti chiedono neppure se lo meriti. Te lo offrono a nome di chi è caduto perché ti giungesse il dono. Attento, però, popolo dell’Ossola: portano armi che non cederanno. Tu fa, come essi vogliono, che servano soltanto a dar serenità al lavoro». Sin dalle prime si avverte il mutamento di tono nella scrittura meno avariata, e la non simulata attenzione all’uditorio maldisposto da coinvolgere tatticamente. Più ordinaria la cronaca Da Domo all’Ossola che ambisce a dare notizia della «ripresa totale di una vita che si era spenta» con la fedele registrazione degli interventi politici del primo gerarca nei suoi spostamenti in centri da pochi giorni liberati dall’oppressione dei banditi «venduti al soldo dell’ebraismo internazionale», secondo lo stereotipo antisemita trasmesso dall’alto. In «Ardimento» il 31 ottobre si reca notizia dell’adunata al Teatro Corso di fascisti e lavoratori ossolani per la ricorrenza del 28 ottobre, «anniversario miracoloso, così stupendamente persuasivo», recita tronfio il brigatista d’età Ezio Maria Gray, classe 1885. In linea con i criteri della guerra psicologica, si ricorre all’escalation retorica in chiave dispregiativa con interventi che si vogliono più mirati, come «i sanguinosi seguaci di Londra e Mosca», e più frontalmente «la fobia distruttrice dei garibaldini predatori e fuggiaschi»6, e il viraggio della fraseologia dal dispregio al più pungente sarcasmo per «la libertaria benemerenza dei governaioli dei 34 giorni di generale ubriacatura» (il suffisso iolo appartiene al bagaglio sarcastico di Mussolini: antiguerraiolo, ventraiolo) e in prospettiva «la buffonesca carnevalata dei banditi datisi alla fuga» o «il gabinetto degli uomini senza macchia e senza paura… che si sono salvati in tempo in Svizzera». Ma la mediocrità dell’eloquio e la meccanica ripetizione di termini e locuzioni chiave tradiscono una situazione emotiva bloccata, che toglie midollo al discorso. Per superare l’impasse la pagina della cronaca si affida ai ritagli della politica, come le magagne della Croce Rossa Svizzera per la «triste avventura» dei bambini ossolani sottratti ai genitori, e la malafede del clero locale a cui va data «una metaforica spolverata per avere predicato un Verbo non eccessivamente divino». La tracotanza verbale a giro d’orizzonte del Vezzalini mira a veicolare verso un consenso forzato la popolazione nuovamente esposta a coercizioni, ricatti e rappresaglie, della quale egli ben conosce e soppesa l’ostilità latente. In sostanza, si vuole giungere alla sopraffazione emotiva che elimina ambiguità e dissidenze, al fine di 30 Il linguaggio di Enrico Vezzalini Volantino della Propaganda-Abteilung Italien, novembre 1944 31 Giancarlo Pozzi conquistare comunque gli animi7. La suggestione di un’Ossola «tranquilla e repubblicana» convince il capo della Provincia a scendere in campo e sulle colonne di «Ardimento» il 7 novembre allignano brandelli di discorsi pervasi di zelo bellico, con «i banditi fuggiaschi che all’ombra delle insegne garibaldine 1944 avevano terrorizzato la pur plaudente popolazione ossolana» (non è la prima volta che il Vezzalini aggiusta il tiro sui più temibili «banditi comunisti»), fino al fumetto dei «bestiali dinamitardi al soldo del nemico», tutti mercenari i cosiddetti «patrioti». Quanto alla riconta dei trentaquattro giorni di governo dei fuorilegge non si perde occasione di attaccare i governaioli di una falsa democrazia «largitrice di fame, terrore e miseria», dove l’endiadi fame-terrore ricalca quella del contestuale volantino della Propaganda-Abteilung Italien: La lotta partigiana è questione comunista! dell’ottobre 1944, che condanna il bolscevismo partigiano e i suoi commissari politici «con la stella sovietica sul berretto ed all’occhiello», rovesciando contumelie marchiate da una dozzina di esclamativi, come molla emotiva sotto carico, e con un’interrogazione retorica che dà un giudizio al centro del discorso: «I banditi combattono per la libertà di Stalin! Patrioti? Ribelli? Partigiani? No! Precursori del comunismo sanguinario! E nel paese regnerà la fame ed il terrore!», sentenza estrema di un fanatismo ribollente che trova alimento nel conclamato accanimento antibolscevico contro «i briganti d’assalto di Stalin». Per il Vezzalini, tra i più feroci esponenti della Rsi, che si dichiara fascista anche quando il partito non esisteva, il fascismo è la giusta fede a grande altezza ideale, è «la poesia del ventesimo secolo», come reclamava la fede granitica di Robert Brasillach, l’intellettuale francese condannato a morte per collaborazionismo con l’invasore. In vent’anni di dittatura il fascismo ci ha mostrato fin dalle origini il volto brutale della violenza e dell’oppressione, messe al servizio di un’ideologia che ha soppresso le libertà democratiche, ha accomodato la realtà alle sue pretese e imposto di fatto e di diritto il più spietato asservimento al potere, traendo fino alla rovina la nazione. Ma Enrico Vezzalini, fedele fino all’ultimo al partito, in carcere, il giorno stesso dell’esecuzione s’infervora «a cercar la bella morte» con un grido d’esultanza virile e la sublima con la maiuscola reverenziale messa in carta di suo pugno: «Sarebbe bello cantare la nostra canzone di fede e finire urlando: per l’Italia e per il fascismo, viva la Morte!». Ma era già da un decennio il motto lugubre e provocatorio della Falange Española: Viva la Muerte! 32 Il linguaggio di Enrico Vezzalini Ritratto del vicecomandante della Brigata Nera di Novara. Vezzalini giudica Dongo «capace di tutte le colpe» Lo squadrista Giuseppe Dongo di Casale Monferrato, corrispondente di «Il Popolo d’Italia», passato all’Ufficio Stampa del partito fascista, poi funzionario a Roma, è conosciuto più che per gli incarichi pubblici ricoperti negli anni del regime, per le malefatte inemendabili che hanno segnato la sua carriera politica: nel 1921 si appropria di un piccolo fondo del Fascio locale, in seguito si presta a macchiare la reputazione di uno squadrista non meno sui generis, Amedeo Belloni di Codogno, che verrà espulso dal partito in virtù della fraudolenta invenzione di sue avances omosessuali. Una figura, questa del Dongo, di assai dubbia moralità. E di primo acchito sorprende che il suo nome di squadrista ormai emarginato dal partito figuri tra i ventidue nominativi selezionati in tutta fretta il 16 settembre 1943 in una riunione nella sede dell’Ambasciata germanica di Roma per impiantare un governo provvisorio dell’Italia occupata8. Nella Rsi il Dongo viene ripescato con la nomina a commissario federale di Novara e a direttore di «Il popolo novarese», organo della ricostituita Federazione dei Fasci della provincia, che inizia le pubblicazioni il 14 ottobre 1943. Tutto Dongo in una sola lettera è il titolo che «La Squilla Alpina» il 10 febbraio 1948 impiega per guidare alla lettura del rapporto del 9 febbraio 1944 indirizzato al Segretario nazionale del fascio republicano Alessandro Pavolini, dove si legge - oltre lo sfogo in lamenti e vanti personali enfatizzati - che la Brigata Garibaldi della Valsesia comandata dal famigerato Moscatelli contava il mese prima cinquecento uomini «vestiti alla foggia russa e con la stella rossa sul cappello», e ora una trentina di elementi: «i comunisti sono paradossali […], non sono altro che una fantasia ammalata di un megalomane e sanguinario». Più avanti, il Dongo afferma con risolutezza di opporsi alle trattative in corso per la creazione di una zona neutra nell’Alto Novarese, proposta dal Beltrami, il capo dei «cosiddetti patrioti», assegnando al suo controllo in forza di una specie di «statu [sic] vivendi» più della metà della provincia fino alla frontiera svizzera: «Siamo caduti nel ridicolo». Da parte sua sostiene di aver continuato la lotta con i suoi fidi Zurlo, Martino e altri «fino alla distruzione ed allo sfacelo totalitario di questa banda di sanguinari che si fanno chiamare patrioti», calcando senza ripensamenti le frasi fatte della stolida propaganda fascista. Per un breve periodo, dal 22 febbraio al 10 aprile del 1944, è ispettore regionale del Partito fascista re33 Giancarlo Pozzi pubblicano e in luglio lo troviamo al comando della VI Brigata Nera «Augusto Cristina». Ma già il mese successivo è revocato dall’incarico e fermato in seguito all’inchiesta aperta a suo carico, con altri sette brigatisti e civili, in quanto come dirigenti della Commissione approvvigionamenti per il corpo delle Brigate Nere i sette risultano collusi con la ditta Doppieri di Novara nella fornitura di calze militari9. Si prende adesso conoscenza di un rapporto in tre fogli stilato da un confidente anonimo in data 10 settembre 1944-XXII (col segno a penna R per «riservato» e il timbro «Visto dal Duce»), che fornisce un identikit in negativo con notizie di fatti e misfatti del Dongo che meritano attenzione (a parte il silenzio inspiegabile sulla revoca dell’incarico nella Brigata Nera avvenuto dodici giorni prima). La figura morale che ne affiora - più che appannata, avvilita senza rimedio è informata a millanteria, impostura, velleità improprie e parassitismo: in sostanza, l’ambizione sbagliata del tentativo di suicidio, a cui si accenna, ha piuttosto il significato di frustrazione sofferta, non soltanto tecnica, per così dire. Tra gli addebiti riesce particolarmente odiosa l’appropriazione di beni a danno di vittime della persecuzione razziale. Ecco il rapporto uscito dagli Archivi Nazionali di Washington (Sezione Ministero dell’Interno fascista repubblicano). 10 settembre 1944-XXII DONGO GIUSEPPE, già commissario federale di Novara, in atto vicecomandante di una Brigata Nera, che pur vanta precedenti politici, verrebbe descritto in modo che la sua figura morale risulta fortemente menomata. Millantatore, vanitoso, non avrebbe mai avuto grandi simpatie per il lavoro ordinato e metodico preferendo vivere di espedienti. Fin dagli albori del Fascismo ebbe ad asportare un piccolo fondo di pertinenza del Fascio Provinciale di combattimento allora presieduto da Vittorino CACCIA. Successivamente, vantando ipotetiche conseguenze, riusciva a carpire piccole somme di denaro ai suoi camerati con il pretesto di portare loro degli autografi di personalità allora altolocate. Al Console BRUNACCI, già comandante la 29ª Legione M.V.S.N., con la lusinga di farlo nominare Federale di Alessandria, carpiva un avallo su di una cambiale di lire quindicimila, cambiale che rimase insoluta e che il Brunacci dovette pagare. Fu inviato poi quale propagandista in provincia di Pavia dove continuò le sue malefatte. Pentito forse di una vita dissoluta e non certamente corretta, tentò il suicidio. Un colpo di rivoltella sopra il cuore, pochi giorni di degenza in ospedale. Fu successivamente alla direzione del Partito addetto all’Ufficio Stampa, ma fu allontanato dopo breve volgere di tempo. A Novara avrebbe sfruttato l’amicizia di due donne, una delle quali avrebbe perciò dovuto vendere un palazzo. A Roma, dove visse a lungo in pessime 34 Il linguaggio di Enrico Vezzalini condizioni finanziarie, si sarebbe trovato implicato in un losco affare di falsari, di cui dovrebbe trovarsi traccia negli atti di qualche questura. Prima dell’8 settembre si aggirava nelle anticamere dei Ministeri per sbrigare delle pratiche che gli procuravano di che sbarcare il lunario, e spesso riceveva delle somme da una certa Baggio la quale, in via Gioberti, gestiva una casa di appuntamento frequentata da «pezzi grossi», si vuole anche qualche ministro. Ora la Baggio è a Novara ed alloggia all’albergo Principe, amante ufficiale del Dongo. Una delle camere occupate dalla signora è a disposizione di un cane e non servirebbe ad altro. Per questo vengono pagate 40 lire al giorno. Le spese della signora sono molte, e solo quelle di ristorante ed albergo si aggirerebbero sulle 12-14 lire mensili. Il proprietario del Principe ha dichiarato che una parte viene pagata dalla signora ed il resto dalla Federazione dei Fasci Repubblicani. La Baggio afferma che nella sua abitazione romana si sono gettate le basi per la ricostruzione del Fascismo. La Baggio, dato che il Dongo avrebbe ora perduto molto del suo entusiasmo nel soddisfarla, lo ricatterebbe spesso e lo avvertirebbe di stare bene attento se non vuole essere da lei denunciato. È così che nell’abitazione di costei continuano a pervenire numerosi e costosi regali: persino scarponi da montagna. La voce pubblica addebita al Dongo l’allontanamento di taluni capi provinciali che gli si erano opposti. Si vuole anche che il Dongo nasconda in casa della moglie, in una località della provincia di Novara, numerosi oggetti sequestrati ad ebrei10. Il rapporto è accompagnato dalla comunicazione della Prefettura di Novara-Repubblica Sociale Italiana in data 25 novembre 1944-XXII a firma del capo della Provincia E. Vezzalini, indirizzata al Ministero InternoGabinetto, oggetto: Dongo Giuseppe - V.Comandante della Brigata Nera di Novara. Sul foglio con i timbri «Visto dal Duce» e «2 DIC. 1944» figura l’annotazione a penna «6 dicembre 1944-Tab.241.Prot.600.R.». Non che sia meno aspra e risentita l’opinione del Vezzalini, che anzi conferma seccamente la diagnosi del rapporto riservato quanto alla condotta immorale del Dongo, da ritenersi ormai di dominio pubblico, ma soprattutto censura duramente l’indegno sfruttamento della tessera e della divisa, simboli del partito-milizia e della connessa tensione ideale. Ma l’addebito più pesante che gli muove il Vezzalini è quello di un criminale doppiogiochismo per i contatti con capibanda e per una perniciosa attività spionistica. Accuse di collaborazione col nemico, indotte a fomentare l’auspicio della fucilazione del «vigliacco assassino», con il Vezzalini nel ruolo di killer in pectore per il cieco fanatismo che lo distingue. E con questo ritratto ai raggi X del Dongo, il caso è chiuso (ma meriterebbe di accompagnarsi, sulla scia del grottesco, alla realtà quotidiana del fascismo, come la descrive in Le rose del ventennio un narratore implacabile come Gian Carlo Fusco). 35 Giancarlo Pozzi OGGETTO: DONGO GIUSEPPE V. Comandante della Brigata Nera di Novara AL MINISTERO INTERNO-Gabinetto POSTA CIVILE 721 La segnalazione trascritta nel foglio al quale si risponde, descrive esattamente quello che purtroppo è il Dongo. Si può «grosso modo» descrivere questo uomo con l’affermazione che, con una leggerezza che significa assoluta mancanza di senso morale, è capace di tutte le colpe: vita immorale, sempre e, quel che è peggio, sempre sfruttando la divisa e la tessera del Partito. Infine come comandante di reparto, recentemente, per una documentazione schiacciante raccolta tra le carte di una banda distrutta, si è rivelato anche un traditore, sia per i suoi contatti con i capibanda, ai quali intendeva fare patti per tradire Fascismo ed Alleato, sia col fornire indicazioni per mezzo di suoi uomini di fiducia sul movimento di nostri reparti, così che molti dei nostri Morti e noi vivi non possiamo che accusarlo di vigliacco assassinio. Attualmente il Segretario del Partito è stato costretto ad arrestarlo. Speriamo che il Tribunale delle Brigate Nere sia costretto a fucilarlo. Ritengo che ogni ulteriore notizia, che ogni particolare, ogni dettaglio della sua vita non meritino di essere ulteriormente esaminati. IL CAPO DELLA PROVINCIA (E. Vezzalini)11 Ma il Dongo non sarà fucilato. Settantaquattro giorni dopo, da una nuova comunicazione della Prefettura di Novara al Ministero dell’Interno e per conoscenza al capo della Polizia e al prefetto capo della Provincia di Torino, in data 7 febbraio 1945-XXIII, a firma del subentrante capo della Provincia Alberto Zaccherini proveniente da Ravenna il 2 gennaio 1945 (avente per oggetto un’ambigua vicenda di ricatti a danno di un facoltoso industriale di Galliate) si apprende che l’ex commissario federale Giuseppe Dongo «risiede attualmente a Milano presso il Gruppo Rionale Fascista Oberdan»12. Sulla scorta di questa notizia si può desumere che, se dei connotati morali del Dongo è facile figurarsi che nell’ambiente si tenga piena memoria, della sconcertante accusa di aver pugnalato alle spalle il partito, mossa dal Vezzalini13, la presumibile irrilevanza penale dei riscontri oggettivi e delle prove raccolte porti piuttosto sulla via di rotture tra autorità e di scontri tra frazioni di partito negli ordinari garbugli del momento, tra servilismi, attriti, falsità, malefatte e crimini che non si conoscono abbastanza. 36 Il linguaggio di Enrico Vezzalini Note al testo 1 Quando bastava un bicchiere d’acqua, Istituto per la Storia della Resistenza in provincia di Vercelli, Borgosesia 1979, p.36. Dell’oratoria mussoliniana, che converte il bellicismo del partito in sopraffazione emotiva di massa con un’abile tecnica di contatto con il pubblico, Enzo Golino mette a nudo la finalità: «L’arma della parola esalta la parola delle armi» e in un discorso di Firenze del 17 maggio 1930 lo stesso Mussolini aveva tagliato corto: «Le parole sono bellissima cosa, ma moschetti, mitragliatrici, navi, aeroplani e cannoni sono cose ancora più belle» (cfr. ENZO GOLINO, Parola di Duce, Rizzoli, Milano 1994, p.15). Da un diligente spoglio del quotidiano «Cronaca Prealpina» di Varese risulta che, sulla falsariga del linguaggio politico imposto ai giornali, il termine partigiano non compare, si ricorre invece a fuorilegge, ai cosiddetti patrioti oppure a locuzioni dispregiative come «sicari al soldo della barbarie», «traditori badoglieschi», «mani fratricide», ecc. La soppressione del termine partigiano mira a condizionare in qualche modo la percezione degli eventi e al tempo stesso a favorire l’adesione emotiva al rituale retorico del linguaggio ufficiale come del parlare quotidiano (vd. la rilettura del quotidiano varesino in: FRANCO GIANNANTONI, Fascismo, guerra e società nella Repubblica Sociale Italiana (Varese 1943-1945), Franco Angeli, Milano 1984, p.687). Merita attenzione la chiosa di Carlo Calcaterra, critico e storico della letteratura italiana, che fece parte della Commissione didattica per la riforma della scuola nell’Ossola liberata: «A quella guisa che il popolo aveva innalzato le parole patrioti, fuorilegge e partigiani a significar “combattenti per la libertà d’Italia”, così l’Ossola riguardò l’essere stata messa fuori legge come un segno d’onore, perché uscir fuori delle leggi mussoliniane significa esser per l’Italia e per la libertà» (cfr. «Ossola insorta», numero unico del Comitato Promotore di Domodossola, 23 settembre 1945, p.2). 2 Cfr. LAZZERO RICCIOTTI, Le Brigate Nere, Rizzoli, Milano 1983, p.102. In altro momento, nella comunicazione al Podestà di Arona del 18 settembre 1944 il Vezzalini definiva «quattro pezzenti» gli organizzatori degli scioperi operai, affibbiando loro i connotati di un’insolita iperbole dispregiativa della miseria d’animo. Questa ossessione di dare rinomanza negativa al nemico, nel quale s’impersona il male, tracima l’ambito del lessico e punta piuttosto all’espressione di un accanimento verbale, che va visto come un latente sintomo di debolezza per il senso d’inferiorità che esterna, di cui non si ha coscienza. 3 Cfr. «Ossola insorta», cit., p.15. 4 Cfr. ENRICO MASSARA, Antologia dell’antifascismo e della Resistenza novarese, Novara 1984, pp.649-50. «Vezzalini, un tempestoso capo», riconosce Bruno Spampanato, giornalista e capitano della Decima Mas (Contromemoriale, C.E.N., Roma 1974, vol.IV, p.996). «La Repubblica di Salò sembrava essere fatta apposta per dare effimeri privilegi, effimeri soldi ed effimere carriere ai personaggi […] che fino a quel momento non avevano combinato niente di buono e che tutti, a ragione o a torto, consideravano dei falliti»: a distanza di sessant’anni cominciano così le memorie da Novara, «grigia e intatta come un quadro di Sironi», sul quarto d’ora storico di un fanatico gerarca di Salò, uscite dalla penna dello scrittore Sebastiano Vassalli, che coltiva il suo giardino a Biandrate nella campagna novarese: «Un altro personaggio che mi piacerebbe raccontare e che, forse, un giorno racconterò, è un certo Enrico Vezzalini, che fu prefetto a Novara dal luglio 1944 al gennaio 1945, e poi fu condannato a morte (“mediante fucilazione alla schiena”) dalla Corte d’Assise straordinaria di quella città (sentenza eseguita il 23 settembre 1945). Vezzalini, nato nel 1904, era un avvocaticchio di Rovigo, senza cause e senza clienti, a cui la Repubblica di Salò regalò una carriera straordinaria e fulminea. Come membro del Tribunale straordinario di Verona gli diede la possibilità di giudicare e di condannare i grand’uomini del Fascismo, quelli che il 25 luglio avevano voltato le spalle a Mussolini. Come capo di un distaccamento delle milizie e poi come prefetto di Ferrara, gli permise di compiere ogni genere di violenze e di abusi e di avere tutto ciò che l’avvocato non aveva mai avuto: abiti di 37 Giancarlo Pozzi grande sartoria, automobili, denaro, donne facili. Da Ferrara, nell’estate del 1944, Vezzalini arrivò a Novara con un’amante di diciannove anni, tale Fede Greco, e con diciannove bauli (così, almeno, dicono gli atti del processo) pieni di argenteria e di preziosi sottratti alle sue vittime, sia ariane che ebree. A Novara, il mio personaggio pronunciò alcune frasi memorabili (per esempio: “Io ai novaresi vado in c… Bisogna ammazzarne il più possibile col mitra, così il pane aumenterà anche senza la tessera”) e fece anche in tempo a compiere alcuni delitti e ad autorizzare quella strage di piazza Cavour, di cui io stesso sono stato un testimone. Nel gennaio 1945, avvicinandosi gli Alleati, la Repubblica lo sostituì con una persona più presentabile e lui allora si spostò nel Modenese, con il suo seguito di bauli, di amanti e di fedelissimi armati fino ai denti, detti tupin. Le sue ultime gesta si compirono tra l’Appennino e Cernobbio presso Como: dove venne arrestato dai partigiani mentre cercava di arrivare in Svizzera insieme ad altri gerarchi e allo stesso Mussolini (i bauli e le donne, nel frattempo, si erano persi per strada)» (Memorie di paure e di sospetti mentre esplodeva la Liberazione, «Corriere della Sera», 1° agosto 1999). Chiusa nella legalità la vicenda Vezzalini, il prefetto di ferro giudicato responsabile di feroci rastrellamenti, omicidi, estorsioni, rapine, sequestri di persone e sevizie, è Giampaolo Pansa che rivanga senza ragione la faccenda nelle pagine di Il sangue dei vinti (Sperling & Kupfer, Milano 2003, pp.86-9) destinate a raccontare le storie delle esecuzioni sommarie di fascisti eliminati dopo il 25 aprile «per vendetta e per odio politico o di classe». Confessa il Pansa: «Ho scritto da dilettante assoluto raffigurando a modo mio la cosiddetta guerra interna italiana» (cfr. DARIO FERTILIO, Vincitori e vinti, la verità di Pansa, «Corriere della Sera», 7 novembre 2004). È per questo che di un criminale alla sbarra con la sua Squadraccia, legalmente processato secondo il diritto e la legislazione vigente, esce un falso profilo, scontornato del suo contesto storico, come quello di un individuo «integerrimo sul piano personale», vittima innocente di una vendetta giudiziaria. Nella prefazione di Angelo Del Boca al volume su La «Repubblica» dell’Ossola (Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo 2004, pp.86-9) si replica appunto: «Pansa presenta il Vezzalini con malcelata simpatia quasi fosse un eroe del Risorgimento. Ma per la storia - quella vera - Vezzalini fu soltanto un criminale assetato di sangue». Seicento sono le tombe aperte in provincia di Novara durante la reggenza di Vezzalini, una sola la faccia della storia. Di due fedelissimi di Vezzalini, «la tigre dell’Ossolano», il cap. Carlo Tortonesi (n.1916), comandante della cosiddetta «Compagnia Giorgi»-GNR di Ferrara (con 160 elementi, tutti giovanissimi, che si fanno chiamare Tupin), e il cap. Umberto De Sisti dei Paracadutisti GNR, ex ufficiale della Milizia fascista e a Ferrara nel marzo 1944 segretario particolare del capo della Provincia Vezzalini (cfr. Almanacco Storico Ossolano 2003, Grossi, Domodossola 2002, pp.210-11, p.241), è illuminante la trafila giudiziaria. Il De Sisti, responsabile dell’eccidio di Goro del 28 marzo 1944 e di altri crimini, fu condannato a trent’anni di reclusione, di cui dieci condonati con sentenza dell’11 ottobre 1946; il famigerato Tortonesi, che del Vezzalini fu il braccio destro, venne condannato a morte dalla Corte d’Assise di Ferrara il 17 aprile 1947, pena tramutata in ergastolo il 19 novembre 1948, ridotta a diciannove anni di detenzione nel 1950 e ulteriormente ridotta a dieci anni nel 1953. Il 23 luglio 1954 gli fu concessa la libertà vigilata. Infine, con sentenza della Corte d’Appello di Bologna in data 8 settembre 1967 il Tortonesi, che nel frattempo si era trasferito a Milano, ottenne la riabilitazione per buona condotta, dopo avere scontato nove anni e sei mesi di reclusione. Dettagliate informazioni sui crimini dei Tupin, del Tortonesi e del De Sisti e sulle vicende giudiziarie che ne seguirono in : ROLANDO BALUGANI, La scia di sangue lasciata dai «tupin» (1943-1945), Edizioni Sigem, s.l.s.d. (ma Modena 1999). 5 Cfr. Verbania 1943-1945, Comune di Verbania, ottobre 1984, p.61. 6 Nel volantino Bologna! della Propaganda-Abteilung Italien (siglato Ø II/189, novembre 1944) lanciato nelle vie della città, che reca la fotografia, scattata l’8 novembre, di un sacerdote che prega per dei cadaveri rinvenuti in una fossa tra le macerie dell’Ospedale Maggiore in via Riva Reno, la didascalia accusa i garibaldini, che nei sotterranei dell’Ospedale avevano una base 38 Il linguaggio di Enrico Vezzalini operativa, di aver compiuto esecuzioni sommarie, mandando a morte vittime innocenti e occultandone i corpi in fosse comuni: «I vostri fratelli affossatori gappisti sono stati chiamati dal popolo di Bologna teppisti. Questa è la decorazione che il popolo italiano ha dato ai vostri eroici fratelli di Bologna! Altro che garibaldini, altro che cavalieri dell’ideale! […] Un centinaio erano questi eroi che voi, o ribelli, continuate a chiamare garibaldini e che io chiamerei sanguinari, omicidi, briganti da strada». Non è così. All’ingannevole giudizio sulle «fosse di Katyn» di Bologna, appoggiato da una virulenta campagna di stampa del quotidiano «Il Resto del Carlino», diretto da Giorgio Pini, con lugubri articoli sulle centinaia di vittime innocenti trucidate dai fuorilegge - «uomini divenuti corvi e iene allo stesso tempo» -, il Comando della 7ª Brigata GAP replicò con un manifesto indirizzato alla popolazione per renderla edotta dell’esatto contrario, smentendo recisamente la versione fascista dell’accaduto. Il reparto Gap accantonato nell’Ospedale aveva catturato spie e agenti delle forze nazifasciste, che erano stati sottoposti al giudizio del Tribunale militare di brigata, condannati a morte e giustiziati, perché rei confessi. La loro sepoltura nel recinto dell’Ospedale fu decisa per esigenze belliche. A maggiore conferma, dei colpevoli erano forniti nominativi: cap. Senese, agente del Comando tedesco, promotore dei rastrellamenti; s.ten. Gilardini, agente delle S.S. e delle Brigate Nere, esecutore di rastrellamenti; Panaro, padre e figlio, spie delle Brigate Nere; Antemi, brigadiere di P.S. e spia personale del questore; Lattuga, spia dell’U.P.I. fascista. Il manifesto del Comando Gap trova giusta risposta alle domande retoriche della parte avversa sul «terrore gappista», che, come dimostrano i fatti, raggiunge soltanto i colpevoli: «Chi sono gli assassini degli innocenti? Chi sono i banditi? Chi sono i fuorilegge? Sono i briganti neri con i loro dirigenti: Pagliani, Torri, Fabriani, Fortunati» (cfr. MARIO DE MICHELI, 7ª Gap, Editori Riuniti, Roma 1971 seconda ediz., pp.266-9). 7 Della virulenza del linguaggio fascista nella stampa quotidiana ha lasciato esempio senza confronto il quotidiano romano «L’Impero», direttori Mario Carli, ex capitano degli Arditi, ed Emilio Settimelli, scrittore futurista. Con il governo in mani fasciste dal 31 ottobre 1922, il 13 maggio 1923 la testata sbatte in prima pagina un titolo su nove colonne che rinnova l’imperativo delle squadre d’azione: «Chi non è nella sensibilità fascista non è un dissidente, è un morto», e cinque mesi dopo, ad Argenta don Giovanni Minzoni, parroco ferrarese medaglia d’argento al v.m., attivo nell’organizzazione cattolica dei lavoratori, viene assassinato il 23 agosto dai fascisti a manganellate. Se non ci conoscete / guardateci all’occhiello, / noi siamo i fascisti / del santo manganello, è il ritornello di un canto dei picchiatori. 8 Del tentativo di mettere in piedi un governo fascista si fa promotore un gruppo attorno a Gino Bardi, primo reggente del Fascio repubblicano di Roma, con l’appoggio di elementi tedeschi, prima dell’arrivo dalla Germania di Alessandro Pavolini, che figura a capolista di ventuno nominativi, con Renzo Montagna, Fernando Mezzasoma, Giovanni Battista Riggio, Bardi, Pollastrini, Caruso, Franquinet. Tra i nomi privi di notorietà, oltre Giuseppe Dongo, compare quello di Nello Carducci, futuro commissario federale di Novara, che sostituirà dal 29 agosto 1944 il Dongo al comando della B.N. «Cristina». Nell’aprile 1945 il Carducci riparerà a Venezia, alla XVII B.N. «Azara», scortato dal fratello Giosuè e dal Malanotte della Propaganda (cfr. RENZO DE FELICE, Mussolini l’alleato. II La guerra civile 1943-1945, Einaudi, Torino 1998, p.121). 9 A Mussolini arriva notizia delle malversazioni da una relazione del 6 dicembre 1944, che esige l’apertura di una severa inchiesta. Si accusano componenti della Commissione Approvvigionamenti e Collaudi per le Brigate Nere: con Giuseppe Dongo, il maggiore Guido Baffigo, il tenente colonnello Gritti, Li Calzi ex federale di Enna, il capitano Ruggeri, il colonnello Franco Matranga, il tenente colonnello Gildo Simini, il perito Pugnetti (cfr. DIANELLA GAGLIANI, Brigate Nere, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p.36). 10 The National Archives, Washington, T 586/Roll 1295, n.112714-112716. 39 Giancarlo Pozzi 11 Ibidem, n.112713. 12 Ibidem, n.112707. Il Gruppo Rionale Oberdan ha sede in Porta Venezia. Il Dongo ricompare in tutt’altra veste l’anno successivo nel processo davanti alla Corte d’Assise di Novara del 16 maggio 1946 contro il giornalista Giuseppe Rolandi (Pallanza, cl. 1915), che fu direttore di «Il popolo novarese» e di «Ardimento», con l’accusa di collaborazionismo con l’invasore e concorso in rapina alla Banca d’Italia di Novara il 25 aprile 1945, complice Salvatore Zurlo sottufficiale della GNR. L’imputato ha come testi a discarico il Dongo e il Malanotte, gli verrà irrogata una condanna a tredici anni di reclusione, sentenza annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione di Roma il 4 dicembre 1946 per amnistia. Il Rolandi era accusato di articoli di propaganda repubblicana fascista «non molto pregevoli dal punto di vista letterario, che oggi muovono più al riso che allo sdegno», secondo la sentenza di Novara. Aveva scribacchiato in «Ardimento» (7 novembre 1944): «I banditi, pagati con l’oro nemico, guidati da ufficiali nemici, forti di un reclutamento fatto tra i rifiuti della società, i criminali, i grassatori, i disertori, hanno potuto mettere a ferro e fuoco quella zona (di Domodossola) e portare il terrore fra quelle popolazioni, affamarle, angariarle, uccidere e seviziare in nome di una libertà straniera e di un diritto da strada». Era solo un giro di discorso «l’incitamento continuo, astioso, insistente, a compiere le azioni di repressione e di strage tante volte ripetutesi»? 13 Vero è che il 23 settembre 1944 il federale Dongo, in un incontro a Milano con i garibaldini della Volante azzurra di Taras fuori della linea di condotta fissata dal CLN, ebbe a deplorare l’alleanza con i tedeschi e si scagliò contro l’ibrida figura del Vezzalini, capo della Provincia e comandante dei Tupin, esprimendo il suo sdegno per l’incrudimento della lotta contro i patrioti voluto dal Vezzalini stesso, impegnandosi a contattare il Quartiere Generale delle Brigate Nere per arrivare all’eliminazione del Vezzalini e dei Tupin dalla provincia di Novara. Ciò consentirebbe di riunire fascisti e patrioti nella lotta comune contro tutti gli stranieri perché l’Italia ritorni libera: fiato sprecato di un personaggio in cerca dell’idea vincente. Successivamente, il Dongo offrì di passare con i suoi uomini dalla parte dei patrioti. Ma tutti i suoi tentativi al Quartiere Generale si erano arenati: «Purtroppo dobbiamo ritornare nemici». Ogni forma d’intesa veniva respinta da Pietro Secchia, che tuttavia esortava, con lucida visione delle opportunità, a continuare nell’azione difficile ma in sé vantaggiosa di dividere i fascisti (cfr. CESARE BERMANI, L’oro di Pestarena: zone d’ombra della Resistenza, Sapere Edizioni, Milano 1973, pp.124, 127, 139-40). 40 storia nazionale I volontari cosacchi nell’Esercito italiano di Stefano Fabei Durante l’ultimo conflitto mondiale al fianco dell’esercito italiano combatterono alcune centinaia di cosacchi che accettarono di collaborare con le nostre forze armate non per simpatia nei confronti del fascismo o della causa dell’Asse, bensì per combattere il regime di Stalin. Popolazione nomade d’origine tatara (dal turco kazak: nomade) i cosacchi, nel corso del XV secolo, si erano stabiliti nelle steppe della Russia meridionale, lungo il corso dei fiumi Dnepr e Don; gruppi minori si erano stanziati nel Kuban, a sud dell’Ural e ad est della Siberia, al confine con la Cina. Organizzati in comunità militari, i cosacchi eleggevano il proprio capo (atamano) e vivevano di caccia, pesca e scorrerie ai danni delle popolazioni seminomadi, russe ma non solo, cui frequentemente si mescolavano. Nel XVIII secolo la politica di accentramento portata avanti dagli zar determinò per i cosacchi la perdita della propria autonomia; tuttavia essi riuscirono a garantirsi alcuni privilegi in cambio del servizio militare obbligatorio di durata ventennale. Scoppiata la Rivoluzione d’Ottobre si erano schierati con l’Armata Rossa ma quando vennero soppressi i loro privilegi passarono in parte alle forze controrivoluzionarie. Durante la Seconda guerra mondiale i tedeschi, e in misura molto minore gli italiani, non incontrarono pertanto grosse difficoltà nell’organizzare formazioni militari facendo leva soprattutto sui sentimenti di autonomia e sulle grandi qualità militari dei cosacchi. In merito a quest’ultimo aspetto riteniamo significativo quanto affermava lo storico S. Andolenko nella sua Storia dell’Esercito Russo: «Un combattente della grande Armée, il generale Brack, esprime la sua ammirazione per i cosacchi: “I cosacchi sono la migliore cavalleria leggera d’Europa, quella che raggiunge in modo più completo i suoi fini istituzionali. Alcuni ufficiali che hanno fatto la guerra si sono permessi di parlare con disprezzo di questi cavalieri: non credeteli. Domandate l’opinione che hanno dei cosacchi i nostri militari più illustri, i veri ufficiali. Es41 Stefano Fabei si vi diranno che i cavalieri leggeri, come i cosacchi, circondano l’esercito di una rete di vigilanza e di difesa impenetrabile, che molestano il nemico, che danno quasi sempre colpi e ne ricevono ben pochi, raggiungendo completamente e perfettamente lo scopo che deve proporsi tutta la cavalleria leggera”»1. Non è un caso che delle gesta dei cosacchi abbiano parlato molti grandi scrittori della letteratura russa, da Puškin a Tolstoj, da Gogol a Checow, a Babel. Volontari cosacchi e ufficiali dell’Esercito italiano. Foto del Museo Storico dell’Arma di Cavalleria Gli squadroni cosacchi di Ranieri di Campello Regista iniziale e protagonista, insieme a circa trecento di questi quasi leggendari cavalieri, dell’episodio poco noto della collaborazione cosacco-italiana che ci accingiamo qui a ricostruire fu un maggiore che prestava servizio nel Savoia Cavalleria, il conte Ranieri di Campello. Conoscendo l’indubbio coraggio di cui i cosacchi avevano dato dimostrazione e il loro viscerale anticomunismo, che aveva portato già nell’agosto del 1941 un reggimento a disertare dall’Armata Rossa e a passare dalla parte dei tedeschi2, l’aristocratico ufficiale propose ai propri superiori la formazione di 42 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano un gruppo di squadroni che, al suo comando, sarebbero stati inquadrati nell’esercito italiano come «Banda irregolare cosacca». A determinare l’ammirazione che Ranieri di Campello nutriva nei confronti dei cosacchi, al di là delle necessità militari italiane e delle motivazioni politiche, era la passione per i cavalli e l’ippica che l’avevano già portato, giovanissimo, a distinguersi come uno dei nostri migliori cavalieri, tanto che nel 1936 aveva partecipato alle Olimpiadi di Berlino per il completo e cioè per il concorso comprendente le diverse specialità dell’equitazione. Figlio del conte Pompeo, senatore del Regno, e della principessa Guglielmina Boncompagni Ludovisi, dama di corte della regina Elena, Ranieri era nato a Spoleto nel 1908. Trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra Roma - dove i genitori prestavano per sei mesi all’anno servizio al Quirinale - e Campello sul Clitumno, era entrato all’accademia militare di Modena per passare poi, in qualità di ufficiale in servizio permanete, alla scuola di Pinerolo, nel Savoia Cavalleria. Dopo essere stato addetto militare a Bucarest, scoppiata la guerra, fu destinato dal Servizio Informazioni Militari ad Algeciras, di fronte a Gibilterra, presso un osservatorio che il SIM aveva impiantato su una nave semiaffondata da cui erano trasmesse informazioni operative utili ai sommergibili italiani. Nella primavera del 1942, dietro sua richiesta, gli fu permesso di raggiungere il Savoia Cavalleria sul fronte russo; qui venne a contatto con centinaia di cosacchi che, arruolati a forza nell’Armata Rossa, avevano disertato o erano stati fatti prigionieri dagli italo-tedeschi. Alcuni di questi uomini si dichiararono disponibili a combattere al fianco delle forze dell’Asse e Ranieri di Campello, consapevole del loro coraggio e della loro abilità (molti di loro, ripetiamo, avevano dato del filo da torcere ai bolscevichi durante la guerra civile), propose ai suoi superiori la costituzione, con dei volontari, di un gruppo di squadroni di cui egli avrebbe assunto la responsabilità. A metà luglio 1942 nacque così il «Gruppo Squadroni Cosacchi Maggiore Campello», dipendente dal Comando dell’VIII Armata, per la precisione dall’Ufficio Informazioni di questa unità3. Il materiale documentario a riguardo è pressoché inesistente e utile sarebbe certamente la relazione compilata a suo tempo dal maggiore Campello, relazione di cui parlano alcuni documenti e appunti conservati presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore ma che non figura tra le carte riguardanti i volontari cosacchi qui conservate. Sappiamo tuttavia che il gruppo un’autentica formazione i cui membri indossavano le uniformi, i colbacchi 43 Stefano Fabei e le sciabole tipici di quel popolo - comprendeva tre sotnie4 e una fanfara a cavallo. I quadri agli ordini di Ranieri, che indossava il pastrano cosacco sopra la divisa grigioverde, erano costituiti da ufficiali e sottufficiali cui era stato riconosciuto il grado già ricoperto nell’Armata Rossa. Questi volontari alternavano le missioni esplorative a vere e proprie incursioni nelle linee sovietiche. Nel corso di un’azione di questo tipo il comandante fu ferito dai russi e salvato dai suoi uomini che lo caricarono su una slitta e ripiegarono sotto il fuoco nemico verso le linee italiane. I sentimenti di fiducia e stima che legavano i volontari cosacchi alla loro guida ebbero un’ulteriore conferma allorché il capitano Vladimir Ostrowski salvò Ranieri all’ultimo istante da un uomo che gli si era avvicinato per ucciderlo a bruciapelo. L’ammirazione di cui Campello godette presso i suoi cosacchi è spiegabile con le motivazioni per le quali gli fu concessa la medaglia d’argento nel gennaio del 1943: «in ogni incarico era primo nell’offerta e nell’esempio. Guidava il gruppo in situazione difficile per insidie nemiche, clima e disagi, in modo esemplare. In ogni occasione ha dato di più di quanto richiesto. Ferito, continuava a guidare il gruppo dando sagge disposizioni per sfuggire all’accerchiamento»5. Accanto a questi uomini in quel momento, sul Don, combatteva, anche lui al comando di un gruppo di squadroni cosacchi, il colonnello tedesco Helmut von Pannwitz, che certo con ben altri mezzi a disposizione, nella tarda estate di quell’anno sarebbe giunto a disporre di una divisione organizzata su tre reggimenti di cavalleria cosacca. In seguito al ferimento, nel febbraio 1943 Ranieri di Campello fu riportato in Italia; al momento dell’armistizio fuggì dall’ospedale del Celio, dove era stato ricoverato, e si diresse, traversate le linee, verso sud. Tornato al fronte con il Regio esercito fu ancora ferito a Montecassino. Scudetti dei militari cosacchi arruolati con gli italiani 44 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano Terminato il conflitto si rifiutò di giurare fedeltà alla Repubblica; venne pertanto radiato dall’esercito e morì nel 1959. I volontari cosacchi in Italia Tra il febbraio e il marzo del 1943, in seguito alle numerose perdite, quanto rimaneva della «Banda Campello», insieme ai superstiti di altre formazioni simili provenienti da Millerovo e a nuovi volontari arruolati sia nei campi di concentramento tedeschi sia fra la popolazione civile, si costituì il «Gruppo Cosacchi Savoia» (in seguito denominato «Banda irregolare cosacca»). Questo reparto, forte di oltre trecento effettivi, fu affidato alla guida del capitano di Cavalleria Giorgio Stavro Santarosa che lo comandò dal marzo all’8 settembre 1943, quando fu sciolto. I quadri erano formati, come nel caso della banda Campello, da ufficiali e sottufficiali russi cui era stato riconosciuto il grado ricoperto nei ranghi dell’Armata rossa. Affiancavano il comandante il tenente Copetzki, un russo naturalizzato italiano ufficiale di complemento di Artiglieria che svolgeva anche il ruolo di interprete e, in qualità di «aiutante maggiore», il sottotenente Pietro Leonar(…), un esule russo arruolato come volontario nel Regio esercito, nonché un certo numero di sottufficiali e militari italiani addetti al funzionamento dei servizi. Il gruppo fu alle dirette dipendenze del comando dell’ARMIR. Dopo Stalingrado i cosacchi, insieme alle armate italiane e tedesche, stavano ripiegando e la ritirata li condusse, ai primi di giugno, al seguito del II Corpo d’Armata, in Italia. Nell’estate dell’anno dopo tra la Carnia e la Carinzia sarebbero affluiti altri 70.000 cosacchi (oltre a 30.000 caucasici, turkestani, georgiani, ucraini e bielorussi) che si erano schierati con la Wehrmacht6. Posto alle dipendenze del comando dell’VIII Armata, il Gruppo Cosacchi Savoia fu accasermato a Macaccari, in provincia di Verona, per essere riorganizzato. Appoggiato amministrativamente al deposito del Reggimento Lancieri Novara, il gruppo fu visitato dal generale Marazzani, ispettore dell’arma di Cavalleria, che in quell’occasione consegnò le ricompense al valor militare ai cosacchi che ne erano stati insigniti7. Lo Stato Maggiore dell’esercito aveva disposto che, a riordinamento e completamento avvenuti, la Banda irregolare cosacca sarebbe stata inviata in Albania alle dipendenze del comando della IX Armata8. L’ufficio ordi45 Stefano Fabei namento si fece pertanto carico di provvedere all’assegnazione del personale italiano occorrente e di esaminare «la possibilità di reclutare altro personale […] traendolo dalle colonie cosacche dislocate in Albania o dal personale russo giunto in Italia al seguito delle nostre truppe»9. Per quanto riguarda la formazione e gli organici della banda, questa al 22 luglio 1943 comprendeva un comando italiano (tre ufficiali, cinque sottufficiali, quattro autieri e 10 soldati), un comando cosacco (quattro ufficiali: un capitano comandante, un ufficiale medico, uno veterinario e un tenente cappellano ortodosso; due sottufficiali e 30 soldati) e due sotnie di cosacchi, ciascuna delle quali era formata dal comandante (capitano o tenente), una squadra comando (un sottufficiale e 11 uomini di truppa) e tre plotoni. Ognuno di questi era, a sua volta, costituito dal comandante e da tre squadre di cavalieri, agli ordini di un sergente maggiore o di un sergente, e composte da un sottufficiale e da 10 uomini di truppa. Il numero totale di cosacchi in forza alla banda era di 266 uomini, di cui 10 ufficiali e 24 sottufficiali. Quanto ai mezzi di trasporto la formazione era dotata soprattutto di quadrupedi e di carri a due ruote, ma disponeva anche di un autocarro, di un autofurgoncino e due motocicli. L’armamento in dotazione, ufficiali a parte, era costituito dal moschetto automatico Beretta e, soprattutto, dal moschetto modello 1891; il personale cosacco aveva inoltre la sciabola se originario dal Don, il pugnale se proveniente dal Kuban10. A metà agosto, quando il comando dell’VIII Armata dovette comunicare allo Stato Maggiore la consistenza della banda, il personale cosacco era leggermente aumentato di numero e comprendeva 13 ufficiali, 23 sottufficiali e 243 uomini, ripartiti adesso in tre sotnie o squadroni.11 Ai primi di luglio lo Stato Maggiore dell’esercito aveva comunicato la futura destinazione della banda e chiesto ai comandi della VIII e della IX Armata di suggerire proposte circa il trattamento economico da riservare ai cosacchi, in Italia e in Albania. Il 23 dello stesso mese lo Stato Maggiore informava il ministero della Guerra della proposta del comando dell’VIII Armata per questi «uomini che, dopo aver combattuto al nostro servizio, si trovano impossibilitati a rientrare nelle proprie terre restate in mano sovietica»12: doveva venire loro riservato lo stesso trattamento previsto per l’esercito mobilitato in Patria, più 10 sigarette al giorno. Fino ad allora, del resto, questi uomini avevano fruito della sola razione di viveri e attinto ai propri risparmi portati dalla Russia, ormai in via di esaurimento. Di 46 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano fronte alla lentezza - tanto più disdicevole perché «non in relazione con la situazione di disagio in cui versano i cosacchi che hanno perduto terra, tetto e famiglia, per combattere con noi e che hanno dato contributo di sangue per la nostra stessa causa»13 - con cui la questione era esaminata, non volendo rinviare oltre la soluzione del problema, il ministero della Guerra proponeva di autorizzare la corresponsione del trattamento economico suggerito, senza tener conto delle difficoltà sollevate dalla direzione generale dei servizi amministrativi, ritenute prive di fondamento. Pertanto il 1° settembre il comando dell’VIII Armata veniva autorizzato a corrispondere subito il soldo ai cosacchi14. Antonio Sorice, informando di questa sua autorizzazione la suddetta direzione, affermava di non concordare con quanto da essa prospettato circa la necessità di ulteriori e preliminari indagini sul modo in cui la predetta banda era stata, a suo tempo, reclutata e organizzata, ribadendo che «si tratta di elementi superstiti di formazioni cosacche da noi reclutate sul posto durante la campagna di Russia, che hanno combattuto alle nostre dipendenze dando largo contributo di sangue, che hanno per tale motivo perduto patria, famiglia e beni restati in possesso delle armate sovietiche e che sono destinati - infine - a combattere per noi in Albania»15. Per Sorice, infine, non esisteva alcun serio motivo «per procrastinare oltre l’adozione di un trattamento economico praticato, tra l’altro, ad altre formazioni straniere - quali, ad esempio, la 2ª legione croata - che non vantano nei nostri confronti le stesse benemerenze»16. In quegli stessi giorni il ministero della Guerra non si occupava solo delle necessità materiali dei volontari cosacchi, bensì anche delle loro esigenze spirituali. Alla proposta formulata il 31 agosto dallo Stato Maggiore di assegnare alla banda l’arciprete ortodosso principe Kurakin, reduce dalla Russia dove aveva operato con l’ARMIR - il quale «per i suoi molteplici incarichi, tra cui quello della cura delle anime per tutta l’alta Italia devolutogli dal Ministero dell’Interno, […] potrebbe disimpegnare le mansioni di cappellano della banda recandosi presso il reparto ogni quindici giorni» - il ministero dava il suo consenso due giorni prima che la banda fosse sciolta per i drammatici fatti dell’8 settembre17. Per quanto riguarda le vicende successive della maggior parte di questi uomini non siamo riusciti a trovare documenti, tuttavia sembra alquanto probabile che un certo numero abbia raggiunto le file dei connazionali che operavano al fianco dei tedeschi e avrebbero presto raggiunto l’Ita47 Stefano Fabei lia nord-orientale. Altri, per idealismo o per interesse - tenendo conto dell’andamento della guerra, era allora prevedibile una sconfitta dei tedeschi che avrebbe, inevitabilmente, travolto anche quanti avevano con essi collaborato e comportato il forzato rimpatrio in Unione Sovietica - fecero scelte diverse arruolandosi nelle formazioni partigiane. È il caso, ad esempio, di Vladimir Ponomarov, il quale - nonostante il servizio prestato in qualità di tenente veterinario prima presso il Gruppo Cosacchi Savoia quindi, dopo l’armistizio, presso le formazioni partigiane operanti nell’area attorno a Macaccari, come attestato anche dall’ANPI di Verona - deciso a non tornare in patria e a rimanere nel nostro Paese, riuscì a ottenere la cittadinanza italiana solo l’8 novembre 1966, dopo molteplici tentativi miranti anche a garantirsi il diritto, fino allora non riconosciutogli, a una sistemazione professionale stabile in grado di assicurargli un decoroso tenore di vita. Grazie ai documenti conservati in archivio all’interno di una sua particolare cartella ripercorriamo brevemente le tappe fondamentali della sua vita che fu una continua lotta, anche e soprattutto dopo la fine della guerra, per una dignitosa esistenza. Vicissitudini di un cosacco in esilio Nato il 17 luglio 1910 a Serafinovic (Stalingrado), dopo aver conseguito nell’ottobre del 1937 la laurea in Medicina veterinaria all’università di Kasan, dal 1938 al 1941 aveva prestato servizio nel distretto di Nicolajev come veterinario provinciale. Reclutato nel 1941 dalle autorità militari sovietiche con il grado di capo veterinario di un reggimento di artiglieria, nell’agosto del 1942, trovandosi nel suo paese natale a causa della carenza di personale sanitario, era stato inquadrato dagli italiani nel reparto di cavalleria cosacca con il grado di sottotenente. Nel 1943, seguendo l’ARMIR che si ritirava dai territori occupati, raggiunse l’Italia «per evitare possibili rappresaglie da parte delle forze belligeranti ed in considerazione anche che mi era stato assicurato che, una volta in Italia, potevo restare inquadrato nelle Forze Armate o presso altre Pubbliche Amministrazioni»18. Rimase quindi a Gazzo Veronese fino all’8 settembre 1943, quando il suo squadrone fu sciolto, per passare poi nelle file della resistenza e partecipare fino al 1945 alla lotta di liberazione nazionale collaborando con il Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Verona e con la mis48 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano sione militare RYE. Finita la guerra, sicuro delle promesse fattegli dalle autorità militari italiane, si rivolse all’Ufficio veterinario provinciale di Verona per l’assegnazione di un posto di lavoro, ma con grande sorpresa la sua istanza non fu tenuta in considerazione in quanto la laurea conseguita in Russia non era considerata «titolo valido» in Italia. Per ovviare a tale ostacolo Ponomarov intraprese nuovamente gli studi e con enormi sacrifici economici riuscì nel 1952 a conseguire la laurea in Veterinaria presso l’Università degli Studi di Camerino. Dotato del nuovo diploma fece istanza all’Ordine dei veterinari della provincia di Verona per l’iscrizione all’albo, ma anche questa volta le sue speranze furono infrante da una nuova e più amara delusione: adesso l’iscrizione non era possibile a causa della mancanza di un requisito fondamentale, la cittadinanza italiana. Tutto ciò senza tenere conto né della Convenzione di Ginevra, né delle leggi 1366 (del 17 ottobre 1932) e 722 (del 24 luglio 1954). Stando così le cose fino al 1961 Ponomarov fu costretto a esercitare furtivamente la professione per procacciarsi da vivere e ciò con il tacito consenso delle autorità competenti che compresero la sua non facile situazione e ne apprezzarono le capacità professionali. Nel febbraio del 1961 ottenne finalmente l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei veterinari di Roma che, contrariamente all’operato dell’Ordine di Verona, aveva tenuto nella debita considerazione la Convenzione di Ginevra e le leggi sopra citate. Nonostante l’iscrizione Ponomarov non poté partecipare, per superati limiti di età, ad alcun concorso, cosa che gli avrebbe consentito, dopo anni di disagi e privazioni, di trovare una definitiva sistemazione. Le cose non cambiarono nemmeno con il conseguimento della cittadinanza italiana, l’8 novembre 1966. Nel 1971, dopo aver prestato servizio in qualità di veterinario comunale ad interim a Vallarsa, faceva parte, come coadiutore, dell’Ufficio veterinario di confine a Fortezza; si trattava tuttavia di un posto provvisorio e senza alcuna assicurazione previdenziale e contro le malattie. Il 22 marzo 1971, tenendo conto dell’esistenza di provvedimenti governativi per la categoria dei veterinari che permettevano di partecipare ai concorsi, senza alcun limite di età, a quanti erano già in pianta stabile, presentava un’istanza al ministero dell’Interno affinché questo intervenisse in suo favore. Non desiderava riconoscimenti ufficiali o medaglie ma solo di poter esercitare la sua professione «in un posto di ruolo, senza dover continuare a fare lo zingaro quale alla mia età non è più possibile condurre»19. Chie49 Stefano Fabei deva, pertanto, che il suo caso fosse considerato «eccezionale» e che ad esso fosse trovata una soluzione, magari con l’assegnazione di un posto stabile nell’Ufficio veterinario di Fortezza. In caso contrario chiedeva al ministero l’adozione di un provvedimento legislativo di concerto con la presidenza del Consiglio dei ministri per la concessione di un assegno vitalizio come ex combattente e partigiano. Due anni dopo, era il 1973, il caso Ponomarov costituiva ancora l’argomento di uno scambio di lettere tra i gabinetti della Presidenza del Consiglio e del ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito. Questo il 21 agosto, rispondendo al suddetto dicastero, esprimeva il parere che il caso potesse «trovare soluzione soprattutto sotto il profilo umano inquadrandolo nella particolare situazione dell’epoca comune non al solo Ponomarov ma anche ad altri ex cittadini sovietici e di territori occupati dai sovietici»20, non potendo disconoscere che lo stesso aveva coscientemente affrontato gravi rischi militando volontariamente sotto la bandiera italiana sia nell’esercito sia nelle formazioni partigiane21. Era menzionato a riguardo il caso degli ex appartenenti all’Armata polacca Anders che al termine della guerra avevano potuto fruire di una pensione a vita concessa del governo britannico. Dopo essersi trasferito - probabilmente alla ricerca di un’occupazione per l’ennesima volta, dal 21 settembre 1971 al 14 ottobre 1982 Ponomarov risiedette a Casaleone (PD), quindi si trasferì a Lignago dove morì il 26 giugno del 1984. Da nostre indagini non risulta che il Ponomarov sia stato mai percettore di alcunché da parte dell’Inps né dell’Inpdap, nemmeno per il periodo in cui lavorò come veterinario presso il comune di Pieve di Sacco (PD). Un destino tuttavia peggiore toccò certamente a quanti, cosacchi o «mongoli», dopo aver combattuto al fianco delle forze dell’Asse (per la quasi totalità al fianco dei tedeschi) furono costretti al rimpatrio o lo decisero di loro spontanea iniziativa. Possiamo, per quanto riguarda quest’ultimo caso, avvalerci della testimonianza che ci ha reso il professor Angelo Del Boca, il quale nel 1944 era comandante partigiano di un distaccamento della VII Brigata alpini comandata dal tenente Londei. Verso la fine di novembre con alcuni dei suoi partigiani, sulla strada 45 che unisce Piacenza a Genova, in località Passo di Barberino, all’incrocio del fiume Trebbia con la statale, si imbatté in un gruppo di cinque uomini dagli inconfondibili tratti somatici orientali, membri della divisione Turkestan, diretti 50 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano con uno dei loro caratteristici carriaggi a Bobbio dove si trovava il comando della grande unità22. Il gruppo era agli ordini di un sergente maggiore di nome Elia: un uomo di circa 23 anni - ricorda Del Boca - che parlava abbastanza bene il francese e masticava qualche parola di italiano. Originario di Tiflis, nella cui scuola media aveva insegnato, era stato catturato dai tedeschi, insieme ad altre migliaia di soldati sovietici, a Melitopol nel 1941. Accettata la proposta di collaborare con il Terzo Reich, al seguito della Turkestan era infine giunto in Italia. Elia dichiarò subito al comandante partigiano di essere disposto a passare, insieme agli altri quattro commilitoni, nelle file della resistenza, aggiungendo che avrebbe potuto indurre altri a disertare dalla Turkestan. Per metterlo alla prova Del Boca lo accompagnò nei pressi dell’accampamento della divisione in cui doveva entrare per indurre altri a disertare. Elia, volendo, avrebbe potuto colpire Del Boca che gli stava davanti, ma non lo fece confermando con ciò i suoi buoni propositi; entrò quindi nel campo e lo disseminò di biglietti scritti in cirillico, in cui si invitavano i soldati alla diserzione. Venne quindi costituito un plotone di circa 50 «mongoli» che a fine guerra, nonostante il consiglio di Del Boca di non tornare in Russia, perché grande era il rischio che fossero considerati traditori, vollero rimpatriare. Furono pertanto dotati di documenti in cui era attestata la loro militanza nelle file partigiane. Raccolti a Vienna in un campo di concentramento, come tanti altri cittadini sovietici che avevano collaborato con i tedeschi, vennero dagli inglesi rinviati in Russia, dove li attendeva la vendetta di Stalin. Note al testo 1 S. ANDOLENKO, Storia dell’Esercito Russo, Sansoni, Firenze 1969, p. 98. 2 Il reggimento, alla cui guida era il maggiore Kononow, fu designato dai tedeschi inizialmente «Kosaken Abteilung 102», quindi «Ost.Kos.Abt. 600» nella sequenza dei battaglioni orientali (Ostabataillonen), infine 5° Reggimento Cosacchi del Don. Oltre a questo le autorità militari germaniche iniziarono ad organizzare, seppur in modo semi-ufficiale, altre bande cosacche di varia consistenza numerica. Già prima del dicembre 1941 le divisioni di sicurezza tedesche furono autorizzate ad arruolare i primi squadroni cosacchi, finché nell’aprile del 1942 lo stesso Hitler autorizzò personalmente ulteriori reclutamenti. 3 Cfr. Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, (AUSSME), Diario Storico, 1551, Carteggio e relazioni relative alla Banda Cosacca e sua formazione, «Rapporto del Sottotenente Alessio di Fontani al Tenente Colonnello S.M. Guido Rampini, Capo Ufficio I - 8ª Armata», senza data ma dell’agosto-settembre 1943. 51 Stefano Fabei 4 Sotnia: termine cosacco indicante una formazione di cavalleria comprendente tra i 120 e i 160 uomini. 5 R. DE MATTEI, La Vandea russa, in «Il Secolo d’Italia», 2 aprile 1996, p. 17. 6 Sull’argomento vedi i libri di P. A. CARNIER, L’armata cosacca in Italia 1944-1945, Mursia, Milano 1990, e Lo sterminio mancato. La dominazione nazista nel Veneto orientale 1943-1945, Mursia, Milano 1982, nonché E. FOLISI, La liberazione del Friuli 1943-1945. Una guerra per la democrazia, Paolo Gaspari Editore, Udine 2005. 7 AUSSME, Diario Storico, 1551 cit. , «Rapporto del Capitano Giorgio Stavo Santarosa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito -Ufficio Storico», 8 giugno 1952. 8 Ibidem, «Lo Stato Maggiore del Regio Esercito al Comando dell’8ª Armata - Ufficio servizi e al Comando della 9ª Armata, oggetto: trattamento banda cosacchi», 11 luglio 1943, prot. n. 353557. 9 Ibidem, «Lo Stato Maggiore del Regio Esercito - Ufficio ordinamento - 2ª Sezione al Comando dell’8ª Armata, all’Ufficio Mobilitazione e all’Ufficio Servizi I, oggetto: riordinamento e completamento della Banda irregolare cosacca», 22 luglio 1943, prot. n. 0079150/2. 10 Cfr. «Formazione ed organici della Banda irregolare cosacca», allegato al foglio dello SMRE - Ufficio ordinamento 2ª Sezione, in data 22 luglio 1943, prot. n. 0079150/2. 11 Ibidem, «Lo Stato Maggiore del Regio Esercito - Ufficio ordinamento - 2ª Sezione al Comando dell’8ª Armata, oggetto: prima serie di aggiunte e varianti alle formazioni e agli organici della Banda irregolare cosacca», 16 agosto 1943, prot. n. 20/82670/2 e allegato. 12 Ibidem, «Ministero della Guerra - Gabinetto - Trattamento economico banda cosacchi», 28 agosto 1943, senza prot. 13 Ibidem. 14 Ibidem, «Il Ministero della Guerra - Gabinetto - al Comando dell’8ª Armata, oggetto: trattamento economico banda cosacchi», 1° settembre 1943, prot. n. 154571/130.7.1/7. 15 Ibidem, «Il Ministero della Guerra - Gabinetto - alla Direzione generale servizi amministrativi - UTEPM, oggetto: trattamento economico banda cosacchi», 1° settembre 1943, prot. n. 155844/130.7.1/7. 16 Ibidem. 17 Ibidem, «Il Ministero della Guerra - Gabinetto - Tenente cappellano ortodosso per la Banda irregolare cosacca», 31 agosto 1943, senza prot.; «Il Ministero della Guerra - Gabinetto - allo Stato Maggiore R Esercito - Ufficio mobilitazione, al comando 8ª Armata e al comando II Corpo d’Armata, oggetto: Tenente cappellano ortodosso per la Banda irregolare cosacca», 6 settembre 1943, prot. n. 155399. 18 Ibidem, «V. Ponomarov. Appartenente alle Bande Cosacche Savoia: esposto al Ministero dell’Interno - Direzione Generale Assistenza Pubblica - Roma», senza data ma presumibilmente del novembre 1971. 19 Ibidem, «V. Ponomarov. Appartenente alle Bande Cosacche Savoia: esposto al Ministero dell’Interno - Direzione Generale Assistenza Pubblica - Roma», 22 marzo 1971. 20 Ibidem, «Al Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro, oggetto: Dr. V. Ponomarov, veterinario presso il Comune di Pieve di Sacco (Padova) - Richiesta assegno vitalizio per benemerenze acquisite durante il periodo bellico», 21 agosto 1973, prot. n. 5726/064. 21 Vedansi in merito la dichiarazione del Comitato provinciale dell’ANPI di Verona del 16 agosto 52 I volontari cosacchi nell’Esercito italiano 1949 (prot. n. 651) che riconosce al Ponomarov la qualifica di «partigiano combattente», e la lettera del generale di Corpo d’Armata Italo Gariboldi all’Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità Pubblica - Palazzo Vicinale - Roma e, p. c., al Prefetto della Provincia di Verona, del 22 ottobre 1949, in cui sono menzionati i meriti e i servigi resi durante il suo servizio di ufficiale nell’esercito italiano. 22 Sulla divisione Turkestan vedi S. FABEI, Il fascio, la svastica e la mezzaluna, Mursia, Milano 2002, pp. 342 sgg. e A. BALZARRO, Inverno 1944: il flagello dei«mongoli», in «Studi piacentini», n. 8, 1990, pp. 43-72. 53 Idee e opinioni degli studenti d’oggi: indagine in un centro del Meridione di Alessandra Magro Gli attuali dibattiti sociali non possono non interessare i giovani e la società in genere. Immancabilmente, quando si manifestano tensioni a proposito di problemi aventi una dimensione socio-demografica, viene sollecitato il sistema educativo, come quello più idoneo a fornire un contributo permanente e durevole alla loro soluzione. La formazione delle opinioni, delle immagini, delle attitudini e dei comportamenti individuali e collettivi chiamano necessariamente in causa l’interazione fra il sistema educativo - sia familiare che scolastico - e l’informazione, così come, anche, il fondamentale ruolo dei mass-media. Eppure, le opinioni, gli stereotipi e gli ideali espressi dagli adolescenti a proposito dei problemi della popolazione, generalmente, vengono trascurati e marginalmente studiati, mentre a noi sembra quanto mai necessario conoscere le nuove tendenze: è importante chiedersi pertanto quale sia la posizione dei ragazzi di fronte ai temi della famiglia, della donna, dell’immigrazione, della droga ecc. Ci si dovrebbe quindi interrogare sui luoghi dove nascono i pregiudizi; sul modo in cui si consolidano gli stereotipi intorno a fenomeni vecchi e nuovi, quali i ruoli di genere, la famiglia o la convivenza multi-etnica; sul persistere, nell’immaginario collettivo, di uno stereotipo sociale, spesso il primo segnale di comportamenti negativi, difficili da sradicare. E soprattutto, chiedersi di quali valori siano portatrici le giovani generazioni, che stanno costruendo la propria identità e stanno crescendo in una realtà in rapido mutamento. Nell’era dei media omnipervasivi, è più che mai importante avere uno spirito particolarmente vigile, in grado di distinguere sofismi venduti a buon mercato e imposture. Alla base del nostro studio, c’è dunque la convinzione che la conoscenza delle modalità con le quali i giovani e gli adolescenti si pongono nei con55 Alessandra Magro fronti di queste dinamiche sia una premessa indispensabile alla costruzione di una società capace di aprirsi a nuovi stili di vita, di valorizzare il nuovo ruolo delle donne dentro e fuori la famiglia, di saper accogliere l’immigrazione, riducendo la conflittualità, di essere sensibile ad ogni tipo di diversità. Difatti, come recenti indagini dimostrano1, persistono ancora non pochi pregiudizi in merito a tali tematiche. Tra le ultime indagini effettuate sul campo2, ci ha interessato in modo particolare quella relativa agli studenti della città di Catanzaro, per la sua validità ed attendibilità, dato il vasto campione di riferimento. Per selezionare il campione degli studenti, si è scelto un campionamento casuale a grappoli con stratificazione delle unità primarie. Questa definizione, che potrebbe risultare poco chiara, si riferisce ad un tipo di campionamento particolarmente adatto al caso delle scuole. Infatti, le unità intervistate - gli alunni delle classi terminali - sono già raggruppate in classi e non è sensato, né possibile, per il fatto che non si ha a disposizione un elenco di tutti gli alunni da intervistare, pensare di estrarre in modo casuale i singoli intervistati. É invece più facile estrarre l’intera classe, cioè, detto in termini tecnici, il grappolo. Le scuole coinvolte nell’indagine sono state, inoltre, scelte in base ad esigenze di stratificazione, tenendo conto di diverse caratteristiche sociali presenti nel campione: sono stati inseriti diversi tipi di scuola, dai licei agli istituti tecnici. Questo garantisce un campione variegato in relazione all’estrazione socio-culturale degli studenti. La casualità, infine, garantisce una migliore attendibilità dell’analisi dei risultati: infatti, solo un campionamento probabilistico ci mette in condizioni di stimare l’errore che commettiamo, estendendo il nostro risultato a tutta (o quasi) la popolazione scolastica di riferimento. Il disegno campionario teorico e i vincoli economici, spesso presenti in un’indagine campionaria, hanno consentito di stabilire quali e quante scuole estrarre nel complesso. Il numero di classi di volta in volta scelto è proporzionale al numero di alunni delle singole scuole, perciò in alcune sono state intervistate più classi rispetto ad altre. Anche la scelta delle sezioni è stata del tutto casuale. Il numero degli intervistati - 555 studenti, di cui 229 ragazzi e 326 ragazze - ha ampiamente coperto le esigenze del disegno campionario, fornendo risultati che possiamo ritenere validi e attendibili. Per quanto riguarda poi la fase di indagine sul campo, non è stato difficile il coinvolgimento delle scuole, grazie alla collaborazione di insegnan56 Idee e opinioni degli studenti d’oggi ti e presidi, che hanno dimostrato sensibilità e interesse verso iniziative di questo genere. Molti di essi, infatti, hanno sacrificato parte della loro lezione in classe per favorire la somministrazione di un questionario, garantendo in tal modo una maggiore attendibilità dell’indagine: è stato così possibile limitare influenze e condizionamenti esterni nella scelta delle risposte, sia da parte dei compagni, che, soprattutto, da parte dei genitori (qualora il questionario fosse stato portato a casa). L’indagine, che aveva diversi obiettivi conoscitivi, è stata orientata a: - raccogliere le opinioni e gli atteggiamenti degli studenti che mettano in luce l’esistenza di alcuni stereotipi (ancora purtroppo esistenti nella nostra «società adulta»); - valutare la percezione di alcuni fenomeni sociali del tutto attuali; - analizzare diverse aspettative di vita. L’indagine ha riguardato tematiche ben precise, quali la famiglia, con riferimento alla scelta della migliore forma di unione nella nostra società; le differenze di genere, con riferimento alle specificità legate ai compiti di cura familiare; l’immigrazione, relativamente all’aumento della criminalità; la disabilità, e in particolar modo la presenza delle barriere architettoniche; la tossicodipendenza, soprattutto in merito alla legalizzazione delle droghe leggere. Molto interessante e significativo potrebbe essere il tentativo di analizzare le diverse tematiche affrontate e poter leggere la contemporaneità del pensiero giovanile, interpretandone tendenze e mutamenti. L’indagine condotta - per la varietà e l’ampiezza delle informazioni - potrebbe fornire un importante spaccato del pensiero adolescienziale, contribuendo a far luce sui meccanismi sociali delle rappresentazioni mentali. Interessante, poi, sarebbe la possibilità di far leggere i dati agli studenti stessi all’interno della scuola, quale luogo di riflessione aperta, la cui finalità è di costruire capacità critica, consapevolezza, scelte autonome e responsabili. Per quanto riguarda una delle prime tematiche trattate, matrimonio o convivenza, sembra interessante notare come all’istituzione del matrimonio gli italiani abbiano dato sempre grande importanza, (sia alla famiglia che all’istituzione in sè), ma di recente sono stati rilevati dei cambiamenti in questo settore e sembra esserci una tendenza accentuata a dare meno importanza al matrimonio, mentre emerge un atteggiamento più tollerante verso quelle forme di vita familiare alternative alla famiglia coniugale. In questo quadro, è molto importante conoscere l’atteggiamento del57 Alessandra Magro le giovani generazioni. Anche se ancora i giovani del nostro campione non hanno un’esperienza diretta di una vita indipendente, sicuramente si trovano con idee, atteggiamenti e opinioni verso la loro vita futura già in buona parte elaborate. Il dibattito sulle trasformazioni della famiglia sta prendendo sempre più spazio sia nei media che nell’opinione pubblica; il declino delle nascite e la progressiva diffusione di comportamenti «nuovi» rispetto al modello tradizionale dell’Italia (divorzi, matrimoni misti ecc. ) sono temi che trovano riscontro anche tra le generazioni più giovani, non solo come frutto di riflessione, ma anche sotto forma di esperienze vissute direttamente. Nel complesso, gli studenti hanno dimostrato, con le loro risposte, un atteggiamento aperto riguardo ai cambiamenti in atto. Dando uno sguardo ai dati [Fig. 1], si può notare come l’orientamento verso le forme di unione cambi notevolmente secondo il tipo di scuola frequentata. Anche quando la graduatoria complessiva non cambia, le posizioni a favore del matrimonio e della convivenza si polarizzano: optano massicciamente per il primo gli studenti degli istituti tecnici, mentre quelli dei licei propendono più nettamente per la seconda: la prefererenza per il matrimonio passa dal 54 per cento di un istituto professionale al 37 per cento di un liceo classico, mentre preferiscono la convivenza il 7 per cento di un istituto tecnico commerciale e il 16 per cento di un liceo scientifico. La convivenza seguita dal matrimonio resta, comunque, la forma d’unione maggiormente preferita dagli studenti (dal 30 per cento al 45 per cento). Altra tematica molto attuale riguarda la scelta del partner: si tratta di un tema che suscita posizioni molto articolate. Le caratteristiche del potenziale compagno sono, infatti, in alcuni casi, molto chiare, definite e condivise; in altri, invece, l’incertezza gioca un ruolo dominante [Fig. 2]. Per i ragazzi, le differenze socio-culturali non rappresentano più un ostacolo all’unione, soprattutto se si tratta di livello d’istruzione o di ceto sociale, ma anche di orientamento politico. Più complesso appare gestire il diverso atteggiamento verso la religione, per la quale sale anche il livello d’indecisione: molti non si sentono in grado di operare una scelta. Molti giovani esprimono difficoltà ad accettare un compagno con un diverso atteggiamento religioso o ancora con un notevole dislivello di età: si tratta, evidentemente, di una situazione fortemente stigmatizzata dal58 Idee e opinioni degli studenti d’oggi Fig. 1. Nella nostra società quale forma d’unione ti sembra migliore? Fig. 2. Accetteresti come partner una persona diversa per. . . 59 Alessandra Magro l’opinione comune. Una persona diversa per religione è rifiutata da circa ail 20 per cento della popolazione studentesca, mentre una di diversa età per oltre il 35 per cento. Oltre l’80 per cento, invece, accetterebbe come partner una persona diversa per ideali politici. Passando ad analizzare la famiglia, un fenomeno ormai diffuso è la lunga permanenza nella casa dei genitori (sindrome di Peter Pan), che caratterizza la società italiana rispetto alle altre realtà europee ed occidentali: si tratta di quello già molto conosciuto, per l’ampissimo spazio con cui è stato recentemente trattato e diffuso dai media italiani. Abbiamo chiesto agli studenti - non ancora protagonisti, ma molto vicini alla soglia di età in cui in altri paesi i loro coetanei lasciano la casa dei genitori - di individuare le cause di questo comportamento. La graduatoria complessiva non sorprende: la lista delle ragioni addotte, infatti, ripropone uno schema consueto, in cui il lavoro e la casa sono in cima alle preoccupazioni dei giovani che si affacciano all’esperienza della vita autonoma. Tuttavia - anche se solo in terza battuta - l’ammissione del ruolo protettivo della famiglia è un indizio della consapevolezza di un elemento specifico «endogeno» delle relazioni genitori-figli, tipico della la nostra società. La vera novità, che emerge dalla lettura dei dati, compare nell’analisi delle altre cause indicate al primo posto: infatti, la consapevolezza del protrarsi di una fase protetta della vita e di riluttanza verso l’assunzione di responsabilità è pienamente sentita e condivisa dai nostri intervistati. Ancora un sintomo della diffusione di consapevolezza è fornito dal fatto che tra le possibili spiegazioni del fenomeno sia la circostanza che la famiglia italiana - rispetto alle altre società occidentali - offre ai figli più protezione e assistenza. La dimensione affettiva primaria rappresentata dalla famiglia è invece la causa principale della permanenza solo per una minoranza di maschi rispetto alle femmine, mentre la diminuita conflittualità tra genitori e figli non è considerata come un aspetto importante o comunque determinante. Da un’analisi più attenta dei dati si è rilevata una differenza d’approccio al problema tra maschi e femmine: i primi tendono a privileggiare le motivazioni «strutturali» (lavoro, casa ecc. ), mentre le seconde interpretano il problema con una maggiore attenzione alla dimensione relazionale specifica della famiglia italiana, evidenziando gli aspetti di consapevolezza della sindrome del ritardo, della propensione protettiva della famiglia, del ruolo affettivo e di sostegno emotivo esercitato dalla stessa. 60 Idee e opinioni degli studenti d’oggi I giovani, indipendentemente dalla differenza sessuale e di istituto, ritengono che il fenomeno della permanenza in casa dei genitori per un periodo di tempo più lungo rispetto ai loro coetanei europei sia da attribuire principalmente ai seguenti motivi, in ordine di importanza: 1) maggiore difficoltà a trovare un lavoro soddisfacente; 2) rinvio del momento dell’assunzione di responsabilità (matrimonio, convivenza, figli ecc. ); 3) possibilità che i genitori risolvano molti problemi pratici (i pasti, il bucato, le bollette ecc. ). Qualche problema legato alla convivenza tra genitori e figli, ovviamente, esiste, pur in un clima di maggiore tolleranza e sintonia tra le generazioni. Il problema più sentito relativo alla condivisione dei compiti è quello dell’insofferenza verso le regole basilari della convivenza, come, ad esempio, la collaborazione domestica. Non sembra che le altre regole di convivenza (rispetto dell’orario dei pasti, organizzazione di feste, ospitalità ecc. ) siano vissute con difficoltà, mentre affiora con una certa forza il tema della conflittualità con la mentalità rigida dei genitori. Aiuto e sostegno nei lavori domestici, e persino l’ordine delle proprie cose, sono generalmente vissuti come maggiore «limite» anche rispetto a quello della privacy: i ragazzi soprattutto, ma anche le ragazze, vivono dunque come primo vincolo la preoccupazione di aiutare in casa! Le tre scelte prioritarie che sui nostri studenti pesano maggiormante risultano: 1. dover tener in ordine le proprie cose; 2. dover aiutare in casa; 3. rispettare l’orario dei pasti. C’è da sottolineare, comunque, che decine sono state le schede lasciate in bianco o sbarrate, dandosi come motivazione il fatto che non esistono limiti o regole non condivise: ciò lascia pensare che ormai il rapporto genitori-figli sia molto più «libero» e meno condizionante rispetto al passato. Dunque, meno vincoli e meno conflitti coi genitori? Certamente i genitori di oggi sono molto più permissivi rispetto al passato, e ciò lascia troppa libertà ai figli: i ragazzi, spesso responsabilizzati prematuramente, rischiano di non sapersi gestire autonomamente e soprattutto di non saper riconoscere il valore delle conquiste. Un aspetto molto importante nell’analisi dei cambiamenti avvenuti all’interno della famiglia è rappresentato dall’evoluzione delle strutture familiari e dalla crescente presenza delle madri sul mercato del lavoro. 61 Alessandra Magro In generale, l’aumento del numero delle donne lavoratrici è collegato all’aumentata scolarizzazione femminile, un fattore che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione all’interno delle mura domestiche. Dall’indagine risulta che le ragazze sono in generale molto più orientate, rispetto ai ragazzi, verso un modello di donna lavoratrice [Fig. 3]. È da sottolineare poi che anche il titolo di studio della madre risulta condizionante la scelta della risposta: il titolo di studio superiore della madre influenza fortemente l’atteggiamento dei figli, aumentando il loro favore riguardo all’idea che la donna possa raggiungere l’indipendenza soltanto attraverso il lavoro. L’istruzione dei genitori e la partecipazione delle madri al lavoro retribuito non solo sono indice di un cambiamento nei comportamenti e nei ruoli sociali degli adulti, ma condizionano, anche, la vita quotidiana della famiglia: ciò si traduce in un modo diverso di rapportarsi con i figli e può implicare la trasmissione di valori e di atteggiamenti più aperti e più tolleranti verso nuove forme di vita familiare e di comportamento sociale. Inoltre, la parità formativa dei genitori e la spinta verso la parità lavorativa dovrebbero tradursi, a livello di ideali e di immaginario familiare, in un atteggiamento più aperto e favorevole verso la famiglia simmetrica, nel senso di una maggiore condivisione delle responsabilità e lavoro familiari con conseguente influenza sugli atteggiamenti dei figli. Se guardiamo all’indirizzo scolastico, gli studenti che frequentano i licei, sia di indirizzo classico che scientifico, risultano essere portatori di atteggiamenti molto più aperti rispetto a coloro che frequentano scuole di indirizzo tecnico e in particolar modo professionale. Le aspettative lavorative, il tipo e la qualità delle gratificazioni derivanti dal lavoro sono probabilmente diverse: si presuppone evidentemente un contesto familiare diverso. Fig. 3. La donna dovrebbe occuparsi solo della casa? 62 Idee e opinioni degli studenti d’oggi Dalle indagini effettuate, si può dedurre che attualmente nella famiglia, soprattutto quella meridionale, il peso del lavoro domestico sia ancora oggi più gravoso per la madre rispetto al padre e anche al resto dei componenti la famiglia. La madre, che spesso lavora anche fuori casa, deve saper conciliare i tempi, dal momento che la collaborazione risulta tanto difficile anche da parte del marito e dei figli stessi! La distribuzione diseguale del lavoro di cura in famiglia è un fenomeno significativo soprattutto in Italia, che risulta essere il Paese europeo con il maggior numero di ore di cura familiare a carico della donna: gli ultimi dati ISTAT3 rilevano che oltre la metà delle donne occupate con figli lavora (tra lavoro retribuito e lavoro di cura) 60 ore la settimana o più, e oltre un terzo lavora dalle 70 ore in su, mentre fra gli uomini sono solo il 15 per cento quelli che raggiungono o superano la soglia delle 60 ore. Non pare trascurabile come il doppio lavoro della donna, assieme alla carenza di servzi sociali, possa ostacolare la realizzazione del desiderio di maternità (in Italia il numero di figli per donna è tra i più bassi del mondo: 1,21). L’atteggiamento verso i ruoli di genere, sia in famiglia che nella società, è stato misurato attraverso batterie di domande, che consentono di discriminare atteggiamenti di tipo più liberale e altri più tradizionali. Alla domanda «gli uomini dovrebbero collaborare maggiormente nei lavori domestici?», circa un quarto degli studenti risponde negativamente, indipendentemente dall’istituto di appartenenza. La famiglia, le sue modificazioni e l’atteggiamento verso queste modificazioni sono una buona lente, attraverso la quale leggere e interpretare gli stereotipi ed i processi mediante i quali gli individui definiscono le proprie identità. Quest’aspetto è molto rilevante, quando si parla di adolescenti che stanno formando il proprio essere uomo o essere donna attraverso comportamenti caratteristici del proprio sesso. Se proviamo a confrontare i dati relativi alla domanda «Una donna sa fare le stesse cose che sa fare un uomo?», certamente le differenze per sesso sono più significative rispetto alle differenze per istituto. I ragazzi non si sbilanciano troppo, collocando le loro risposte in una fascia intermedia, mentre le ragazze sono molto più decise nell’affermare le loro pari capacità di fare. Analizzando la provenienza scolastica, sembra che gli istituti tecnici sia63 Alessandra Magro no inclini a «riconoscere» una certa supremazia delle capacità maschili rispetto ai licei: tra tutti gli studenti, quelli degli istituti professionali sono probabilmente i meno convinti del fatto che donne e uomini sappiano fare le stesse cose. Sull’affermazione «è soprattutto l’uomo che deve mantenere la famiglia» è d’accordo almeno il 24 per cento degli studenti di un istituto tecnico, mentre la percentuale scende al 5 per cento in un liceo. Per quanto poi riguarda il fenomeno della rappresentanza politica femminile, non sono pochi gli studenti che lo ignorano. Come rivelano i dati, essi presentano anche alti livelli d’incertezza: in Italia, attualmente, le donne che governano sono meno del 10 per cento: una rappresentanza certamemente scarsa della popolazione femminile, che è il 52 per cento dell’intera popolazione!4 Al di là dell’atteggiamento verso il ruolo sociale e lavorativo della donna, esiste un atteggiamento culturale nei giovani che attribuisce delle diversità a ciascuno dei due sessi, così come qualità specifiche e «ruoli di potere» diversi. Inoltre, dalla nostra indagine emerge un orientamento più libero rispetto ai costumi sessuali tradizionali: i ragazzi e le ragazze ritengono ormai che non sia necessario aspettare il matrimonio per avere rapporti sessuali completi e che ormai una donna non debba arrivare vergine al matrimonio. Le diversità tra maschi e femmine sono minime, ma va, comunque, segnalato che sono le ragazze ad avere atteggiamenti più liberi verso la sessualità rispetto ai loro coetanei [Fig. 4]. Risultano culturalmente più liberi e aperti gli studenti dei licei e più orientati verso comportamenti tradizionali gli studenti di istituti professionali e tecnici. Fig. 4. L’infedeltà di una donna è molto più grave di quella di un uomo? 64 Idee e opinioni degli studenti d’oggi Diversità di atteggiamenti si possono notare in relazione all’infedeltà: per i ragazzi l’infedeltà sessuale di una donna è molto più grave di quella dell’uomo. Queste diversità esistono in qualche modo anche quando si parla di esperienze sessuali: il livello di consenso espresso alla domanda «è preferibile sposare una donna che non abbia avuto rapporti sessuali con altri» è sicuramente maggiore rispetto alla domanda «è preferibile sposare un uomo che non abbia avuto rapporti sessuali con altre». Tra i vari possibili stereotipi legati all’identità di genere, uno molto importante è quello relativo alle norme di comportamento sessuale, anche perché detta regole non scritte sulla scelta del partner e predetermina parametri di giudizio diversi in relazione alla considerazione della «brava ragazza» o del «bravo ragazzo». Chi sono in sostanza i «bravi ragazzi», cioè quelli che si comportano in modo conforme a regole morali condivise dai più? La verginità è ancora un valore? Sono in certa misura giustificati comportamenti violenti verso le donne? L’ISTAT5 ha rilevato che il 3,6 per cento delle donne italiane, nel corso della loro vita, ha subito una tentata violenza. Anche la violenza domestica continua ad essere un fenomeno sottovalutato (si pensi che la legge antiviolenza è solo del 1996!). Diversità di atteggiamento sono molto evidenti, quando si parla di violenza di genere: l’idea che «se una ragazza viene violentata è perché se l’è cercata» provoca maggiore disaccordo tra le ragazze [Fig. 5]. Il fatto che circa la metà dei giovani giustifichi in fondo la violenza, poiché la mette in relazione con una certa tipologia di ragazze, quelle più vistose, attraenti, provocatorie o che vivono in condizioni di disagio e povertà, è un indicatore preoccupante, che andrebbe affrontato a scuola e nelle sedi più opportune, quali, ad esempio, la famiglia. Fig. 5. Se una ragazza viene violentata è perchè se l’è cercata? 65 Alessandra Magro Queste indicazioni sulla possibile giustificazione di atteggiamenti e comportamenti violenti dei ragazzi dovrebbero essere approfondite: spesso, la violenza giovanile ha un’origine «sociale», da intendersi in quei contesti diversi da quelli familiari, in cui i ragazzi vivono e si confrontano con i loro coetanei. Le scuole d’indirizzo tecnico-professionale sembrano svolgere un’azione educativa più debole nel campo degli orientamenti d’opinione su temi simili: sembrerebbe necessario dedicare una maggiore attenzione a tali stereotipi, affinchè non si annidino legittimazioni di violenza. Oggetto della terza area tematica sono gli atteggiamenti verso i principali aspetti della questione dell’impatto degli immigrati sul sistema sociale, economico e normativo del nostro Paese. La percezione dell’immigrazione, com’è noto, è quanto mai attuale negli scenari contemporanei. L’interpretazione dei nostri dati evidenzia non pochi atteggiamenti di chiusura e diffidenza nei riguardi del fenomeno. L’affermazione che maggiormente contribuisce a caratterizzare l’indagine è relativa all’associazione tra immigrazione e aumento della criminalità. Al fenomeno migratorio vengono accostati poi i livelli di tolleranza culturale (arrichimento della diversità) e gli aspetti normativi (estensione dei diritti ai cittadini immigrati). Non poche sono le differenze tra le risposte dei ragazzi rispetto alle ragazze, come del resto quelle tra istituti professionali e licei: in questi ultimi è più facile riscontrare livelli maggiori d’apertura e tolleranza. Spesso un basso status sociale della famiglia di appartenenza può determinare poca disponibilità nei riguardi del fenomeno migratorio. Un’analisi di genere permette di rilevare (relativamente alla dimensione pubblica più che a quella privata) che le ragazze sono più pronte ad accogliere la diversità, e perciò favorevoli ad una più ampia integrazione. La progressiva integrazione con culture diverse dalla nostra è purtroppo ancora un processo lento. Alcuni studenti, soprattutto degli istituti tecnico-professionali, interpretano il fenomeno come un pericolo per le nostre tradizioni nazionali: elemento di disturbo e alterazione della nostra cultura! Gli immigrati contribuiscono ad un arricchimento culturale per il 36 per cento degli studenti di istituti professionali, fino al 60 per cento dei liceali. Al contrario, atteggiamenti negativi interessano il 7 per cento di un liceo classico ed il 27 per cento di un istituto tecnico. Altra questione connessa all’immigrazione è quella della criminalità e della sicurezza nelle società occidentali. Questo legame, pur sostanziato da alcune evidenze come le attività illegali «specializzate» di alcune minoranze etniche (prostituzio66 Idee e opinioni degli studenti d’oggi ne, traffico di droga ecc. ), a causa del suo fortissimo impatto emotivo, dà adito all’amplificazione della reale portata del fenomeno e determina un senso di panico collettivo da invasione «criminale», ma soprattutto genera un automatismo nell’identificazione tra immigrazione e attività illegale. A tal proposito, se analizziamo le opinioni dei nostri ragazzi, riscontriamo una prima differenza di approccio tra i due sessi: tra i ragazzi sono, infatti, più rappresentate le posizioni estreme, mentre l’atteggiamento femminile è più concentrato sulle affermazioni intermedie [Fig. 6]. Anche il tipo di scuola seleziona e differenzia profondamente le posizioni: le divergenze sono molto acute fra gli istituti professionali, che si allineano su un netto consenso del binomio immigrazione-criminalità, rispetto ai licei, che hanno posizioni più articolate, e in cui le risposte si distribuiscono con maggiore equilibrio. Fig. 6. Un aumento d’immigrati comporta un aumento della criminalità? Anche in relazione alla dimensione economica, gli immigrati appaiono potenziali concorrenti della forza lavoro: non sono pochi coloro che li considerano responsabili dell’aumento della disoccupazione nel nostro Paese. Le giovani generazioni si sentono, dunque, minacciate, facendo così registrare una sorta di sensazione di «competizione» con il lavoratore straniero. Una delle caratteristiche dell’inserimento dei lavoratori immigrati consiste nella sostituzione dei lavoratori italiani, sia per il nostro declino demografico, ormai consolidato, che per l’esistenza di meccanismi legati all’aspirazione professionale, fenomeno che interessa soprattutto i lavoratori delle giovani generazioni. Va tenuto presente, comunque, che le ultime indagini dell’Isfol6 rilevano come il livello d’istruzione dei lavoratori immigrati risulti superiore a 67 Alessandra Magro quello che l’opinione pubblica generalmente ritiene. Esiste un serio dislivello tra il grado d’istruzione realmente posseduto dai cittadini stranieri e il lavoro da essi svolto: tale situazione resta comunque un fenomeno di discriminazione, in evidente contrasto con le indicazioni e gli orientamenti della Comunità Europea. La valutazione del fenomeno migratorio da parte degli studenti rileva profonde incertezze [Fig. 7]: se da un lato essi evidenziano aspetti solidaristici, dall’altro nascondono atteggiamenti per noi preoccupanti. Oltre la metà degli studenti asserisce che gli immigrati dovrebbero ritornare al Paese d’origine. Fig. 7. Gli immigrati contribuiscono ad un arricchimento culturale? Altro tema della nostra indagine riguarda la disabilità. Secondo l’ISTAT7, solo il 16,5 per cento delle persone diversamente abili in Italia ha un’occupazione e solo il 6,5 per cento va al cinema o a teatro: sono dati che riflettono un’allarmante forma di discriminazione. Spesso, la disabilità è qualcosa di «nascosto», di cui non parlare, da vivere in famiglia, con dolore e difficoltà. Relativamente a tale tematica, i nostri giovani si esprimono abbastanza uniformemente: certamente «le persone disabili meritano tanta attenzione». Non si può non rammentare come siano stati numerosi gli studenti che hanno chiesto - durante la somministarzione del questionario - cosa fossero le barriere architettoniche! Per essere ragazzi delle ultime classi, il fenomeno non può lasciare indifferente il mondo degli adulti e in particolar modo quello degli educatori e delle istituzioni. Si rileva, pertanto, una notevole disinformazione sugli ostacoli fisici e gli «impedi68 Idee e opinioni degli studenti d’oggi menti» che ancora oggi sono diffusi sul nostro territorio. Senza riscontrare nelle risposte differenze significative di genere, si può notare, invece, qualche contrastante tendenza fra i diversi istituti: ancora quelli tecnici e professionali dimostrano una minore sensibilità rispetto ai licei, che mostrano, al contrario, minor incertezza nell’asserire la persistenza di difficoltà che i disabili trovano nella nostra società, sia dal punto di vista fisico che mentale. Alla domanda «sono ancora molte le barriere architettoniche presenti sul nostro territorio?» rispondono «molto» appena il 25 per cento di un istituto professionale ed il 65 per cento di un liceo [Fig. 8]. Se il grado di civiltà di una società moderna si misura attraverso la sua capacità di adoperarsi per la tutela dei diritti della persona nella sua specifica identità, non è giusto che la categoria sfortunata delle persone diversamente abili, purtroppo numerosa, debba subire l’indifferenza e la scarsa considerazione da parte della società stessa. Se osserviamo l’urbanistica cittadina, essa è ricca di barriere architettoniche: sono molti gli edifici commerciali e le strutture pubbliche inacessibili, per non parlare di quelle sportive (si tratta spesso di strutture considerate «a norma»). Tra l’altro, nell’immaginario collettivo, è vista come lo stereotipo del disabile la persona sulla sedia a rotelle, mentre è da considerare tale almeno il 20 per cento della popolazione: anziani, donne in gravidanza o con un passeggino, convalescenti a seguito di un intervento chirurgico o con ingessatura agli arti inferiori sono persone - momentaneamente -«svantaggiate». Come si vede, pertanto, i giovani danno spesso risposte poco coerenti, dimostrando scarsa consapevolezza della realtà. Fig. 8. Sono ancora molte le barriere architettoniche sul nostro territorio? 69 Alessandra Magro Affrontiamo ora uno dei temi che più interessano le nuove generazioni: la tossicodipendenza e la liberalizzazione delle droghe leggere. Possiamo facilmente osservare, indipendentemente dal tipo di istituto frequentato, che significative sono le differenze di genere: oltre la metà dei ragazzi si dichiara favorevole alla legalizzazione, molto più rispetto alle ragazze, le quali dimostrano non poche perplessità nei riguardi del fenomeno [Fig. 9]. Il fatto che le ragazze siano generalmente contrarie alla legalizzazione delle droghe leggere fa pensare, magari, che l’uso di queste sia anche limitato tra loro, mentre fra i maschi potrebbe essere molto più diffuso. Fig. 9. È giusto legalizzare le droghe leggere? Se poi analizziamo le risposte relative alla maggiore integrazione sociale dei tossicodipendenti, si rileva un atteggiamento d’incertezza generalizzata, che attesta come il fenomeno sia, comunque, ancora poco considerato: quasi il 20 per cento sul totale delle risposte - indipendentemente dalle differenze sessuali - non sa esprimere un’opinione sulla necessità d’integrazione del tossicodipendente. Ciò denota una scarsa informazione in merito al fenomeno sociale, una certa indifferenza sulle relative conseguenze e, soprattutto, una scarsa percezione di ciò che il problema comporta all’interno del tessuto sociale. In tema di droga, il ministero del Welfare rileva un aumento costante del suo uso, soprattutto di quella leggera. Secondo l’Eurispess, oltre alla diffusione di massa di hascisc e marijuana, vi è un continuo abbassamento dell’età dell’assunzione. Sono veramente tanti i ragazzi che si considerano consumatori occasionali, che provano per curiosità o divertimento, per sentirsi uguali agli altri o riempire un vuoto8. All’affermazione «i tossicodipendenti dovrebbero essere maggiormente 70 Idee e opinioni degli studenti d’oggi integrati» si trova molto d’accordo il 25 per cento degli studenti dei licei e appena il 15 per cento di quelli degli istituti professionali. Traendo qui a conclusione tutto il nostro discorso, ci sembra che emerga la nessità di una ricaduta didattica nella diffusione di indagini di questo tipo. Tenuto conto dell’accelerazione degli scambi tra società diverse e del fatto che, attualmente, un numero crescente di persone entra in rapporto con più di una cultura, oggi si può parlare di «spirito cosmopolitico» e di «cultura transnazionale». Il dibattito sul multiculturalismo, rispetto al quale nessuna forma culturale è legittimata a costituirsi come cultura dominante, rende necessaria l’educazione al reciproco riconoscimento. L’intento di realizzare i principi dell’uguaglianza e delle pari opportunità (in senso ampio), senza discriminazioni legate al sesso, alla razza, alla provenienza etnica, alla religione ecc., impone l’educazione alla convivenza. Dal momento che non esiste una cultura che, in assoluto, sia migliore delle altre, interventi che diano la consapevolezza del carattere relativo e limitato della propria «proposta culturale» sarebbero garanzia di apertura al dialogo. È solo su questa base che sembra si possano oggi concordare regole generali di solidarietà, evitando posizioni rigide ed estreme, che derivano da un eccesso d’identificazione. Se la cultura si configura come un patrimonio di sedimentazione delle esperienze, delle rappresentazioni e dei valori (tramandato attraverso il linguaggio, i testi scritti, i monumenti ecc. ), che fonda la memoria individuale e collettiva9, l’aumento della percezione del carattere relativo ad ogni forma culturale dà la possibilità di parlare d’integrazione socio-culturale. Se è estremamente difficile isolare una fonte d’influenza (come ad esempio la televisione e altri mezzi di comunicazione di massa), da altri tipi d’influenza culturale e sociale, è comunque necessario considerare le influenze interpersonali. I processi di socializzazione, sia primari che secondari, costituiscono punti di ancoraggio per le opinioni, gli atteggiamenti e i valori, che vengono appunto trasmessi attraverso reti di comunicazione interpersonale: famiglia, scuola, gruppo dei pari, centri di aggregazione ecc. costituiscono indiscutibili influenze capillari. La scuola deve quindi configurarsi come laboratorio socio-culturale, con l’attenzione rivolta alla cultura del territorio e non solo a quella disciplinare10. Se s’intende contribuire realmente alla costruzione di un mondo migliore, il mondo degli adulti deve, quindi, 71 Alessandra Magro necessariamente interessarsi alle opinioni dei giovani, cercando di interpretarle, e magari poterle orientare. Prendendo in debita considerazione il pluralismo dei punti di vista, è quanto mai necessario per i giovani d’oggi assumere con più matura consapevolezza il proprio posto e le proprie responsabilità nel mondo. Note al testo 1 Cittadinanza delle donne e culture delle differenze, Under 18, Venezia 2003. 2 A. MAGRO, Under 18, Numeri, idee, ideali degli studenti di Catanzaro, Catanzaro 2004. 3 ISTAT, Le trasformazioni del vivere: il lavoro delle donne, 2000. 4 Quaderni internazionali di vita italiana, Donne 2000, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2000, p. 115. 5 Indagine multiscolpo Istat sulla sicurezza dei cittadini, 1997/98. 6 ISFOL, Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento, Milano 2001, p. 129 7 «Disabilità e Arte», n. 4, novembre 2003, p. 4. 8 G. C. BRUNELLO - E. ARCARI, Ragazzi normali, Fondazione CESAR, 2002, p. 46. 9 F. CRESPI, Manuale di sociologia della culura. Bari 1998, p. 267. 10 M. PUGLIESE, La formazione del personale nella scuola dell’autonomia, 1999, Cirò (KR), pag. 66. Cenni bibliografici G. SFORZA, La funzione didattica. Roma 1976; G. BALLANTI, Il comportamento insegnante, Roma 1975; MCLUHAN, La cultura come business, Roma 1998; F. CRESPI - F. FORNARI, Introduzione alla Sociologia della conoscenza, Roma 1998; V. BURR, Psicologia delle differenze di genere, Bologna 1998; M. MAPELLI - G. BOZZI TORIZZO - D. DE MARCHI, Orientameno e identità di genere, Milano 2001; C. ADAMI - A. BASAGLIA - V. TOLA, Dentro la violenza: cultura, pregiudizi, stereotipi. Rapporto nazionale Progetto Urban, Milano 2002; G. BARONIO E. CARBONE, Il lavoro degli immigrati: programmazione dei flussi e politiche di inserimento, Isfol, Milano 2001. 72 Africa e dintorni La tragica fine della X armata e del suo comandante. Lettere dalla Libia del generale Tellera di Angelo Del Boca 1. Alle 10.30 del 6 febbraio 1941, il grosso delle forze italiane che cercava di raggiungere Agedabia abbandonando la Cirenaica ormai quasi completamente occupata dagli inglesi, veniva irrimediabilmente bloccato da reparti corazzati nemici all’altezza della Bottega Araba, a 39 chilometri da Agedabia. L’immensa colonna in ripiegamento era investita sul fianco dal fuoco delle artiglierie mentre decine di carri armati e di autoblindo avvolgevano la testa della formazione impedendole ogni movimento. Il piano strategico elaborato dal generale Archibald Percival Wavell era perfettamente riuscito. Mentre la 6a divisione australiana occupava Bengasi e in seguito tallonava le retroguardie della X armata italiana, che si ritiravano lungo la strada costiera, la 7a divisione corazzata britannica, al comando del generale O’Connor, si spingeva da Derna nel deserto, aggirava il Gebel Achdar, occupava el-Mechili e proseguiva la sua difficile marcia su piste infami raggiungendo Msus il 4 febbraio, Antelat il 5 e la costa del Mediterraneo il giorno seguente, chiudendo le forze italiane in una sacca senza scampo. Come racconta l’inviato del «The Times», «nessun esercito aveva mai attraversato prima una landa così vasta. Per poter realizzare l’impresa era stato necessario ridurre la razione dell’acqua ad un solo bicchiere al giorno, ed ogni cosa era stata sacrificata alla velocità, persino le soste per i pasti e per il riposo notturno»1. Per completare l’accerchiamento delle forze italiane i genieri britannici avevano cosparso la via Balbia di mine, rendendola impraticabile. Va anche detto che mentre i reparti inglesi motorizzati e corazzati potevano manovrare liberamente su tutto il terreno circostante la strada, quelli italiani, montati su automezzi, erano legati alla rotabile ed erano facili obiettivi. Si aggiunga, come riferisce uno studio dello Stato Maggiore dell’Esercito, «che una moltitudine disordinata di militari di enti diversi e di civili si era 73 Angelo Del Boca Il generale Tellera al tavolo di lavoro frammischiata alla colonna in marcia, provocando confusione e difficoltà; erano militari di truppa appartenenti alle più svariate unità, alle compagnie lavoratori e ai servizi d’intendenza; era personale dell’aviazione e della marina; erano uomini, donne e bambini provenienti da Bengasi su torpedoni e automezzi di ogni genere»2. Nella grande sacca lungo la via Balbia era rimasto rinchiuso anche il comandante della X armata, generale Giuseppe Tellera, secondo, in ordine di grado, soltanto al governatore della Libia, maresciallo Rodolfo Graziani. Ma mentre quest’ultimo aveva già abbandonato la Cirenaica nella notte del 2 febbraio per trasferire il comando tattico nella Sirtica3, il generale Tellera, che aveva ricevuto da Graziani il comando di tutte le forze dislocate nella Libia Orientale, era costretto a condividere il destino dei suoi uomini, che si annunciava catastrofico. Mentre parte dei militari italiani si rifugiava nella Casa cantoniera al chilometro 39 da Agedabia e vi abbozzava una difesa, una trentina di carri armati M 13 del VI battaglione cercava di aprirsi un varco nello schieramento nemico, ma l’operazione non aveva alcun successo. A uno ad uno i carri M 13 venivano distrutti dal fuoco concentrico dei mezzi controcar74 La tragica fine della X armata e del suo comandante ro, delle artiglierie e dei cannoni dei carri pesanti inglesi. A questo punto il generale Tellera abbandonava il riparo della Casa cantoniera e, noncurante del fittissimo fuoco, saliva su uno dei carri superstiti4 e cercava di risalire la colonna per andare incontro alla brigata corazzata del generale Bergonzoli e con questa compiere l’ultimo tentativo per rompere l’accerchiamento. Ma mentre risaliva lo schieramento si scontrava con una formazione corazzata nemica e veniva ferito gravemente a un polmone. In una lettera del 31 maggio 1941, il tenente medico Mauro Sabiani così descriveva alla moglie le ultime ore del generale: «Sua Eccellenza presentava diverse ferite da scheggia di granata in più parti del corpo, delle quali la più grave era una penetrata al polmone al terzo spazio intercostale di destra. Era stato colpito da una scheggia di granata scoppiatagli a qualche metro di distanza. […] Soffriva, respirava male, e stentava a parlare. […] Il Generale morì nelle mie braccia alle ore due del 7 febbraio nel deserto Cirenaico, nei pressi di Solluch. Vi sia di conforto, signora, il sapere che il vostro caro marito non fu mai toccato da una mano che non fosse italiana: per un mio orgoglio e per un mio dovere. […] Intanto gli alti comandi inglesi, che evidentemente erano stati messi al corrente del fatto, mi dettero personalmente l’autorizzazione di accompagnare la salma a Bengasi e mi fecero accompagnare da un capitano cappellano anglicano». Il «Daily Telegraph» così commentava l’accaduto: «Martedì mattina, al culmine della più grande battaglia fra carri armati della campagna, il generale Tellera veniva catturato mortalmente ferito»5. Il «The Times», dal canto suo, precisava che il funerale del generale Tellera si era svolto nella cattedrale di Bengasi «with full military honours»6. Ma nessuno metteva in evidenza, come invece farà più tardi il genero di Tellera, Giacomo Bondoni, che si trattava dell’ufficiale «più alto in grado, caduto in combattimento nelle guerre moderne, che vedono i comandi in posizione strategica, alle spalle delle prime linee»7. Un incidente del genere, ad esempio, non sarebbe mai potuto accadere al maresciallo Graziani, che aveva scelto come sede del proprio comando una tomba greca di Cirene, scavata in profondità nella roccia e lontana centinaia di chilometri dal fronte. A Mussolini, che aveva criticato questa scelta, rispondeva che «le tombe greche potevano anche servire giustamente da rifugio antiaereo, e per meglio dormire qualche volta allo scopo di ritemprare le forze che mi erano necessarie per sostenere la titanica fatica impostami»8. I combattimenti lungo la via Balbia cessavano del tutto nella giornata 75 Angelo Del Boca del 7 febbraio con la resa del generale Bergonzoli. La X armata aveva così cessato di esistere. Si erano salvati alla cattura soltanto 7 mila italiani e 1.300 libici. Restavano nelle mani degli inglesi 130 mila soldati, 400 carri armati e 1.200 cannoni. Anche l’aviazione aveva subito perdite gravissime nel corso dell’offensiva di Wavell: 564 apparecchi, di cui 200 abbattuti in volo o distrutti a terra, gli altri abbandonati durante il ripiegamento per la loro inefficienza9. 2. Nell’assumere, il 22 dicembre 1940, il comando della X armata, già logorata nei combattimenti di Sidi el Barrani e nella precipitosa ritirata sulla piazzaforte di Bardia, il generale Tellera così confidava ad un collega: «So di andare a morire, ma avrei almeno gradito di guidare un’armata da me addestrata»10. Essendo in Libia dal settembre del 1937, in qualità di capo di Stato Maggiore del Comando Superiore delle forze armate dell’Africa Settentrionale, Tellera conosceva perfettamente la situazione in Libia, la consistenza degli armamenti, il grado di preparazione delle truppe nazionali ed indigene. Sugli armamenti presenti in colonia avrebbe sicuramente potuto sottoscrivere ciò che il generale Erwin Rommel il 5 marzo 1941 scriveva nel suo primo rapporto a Berlino: «L’antiaerea è costituita da vecchissimi Skoda da 75 mm. che risalgono alla guerra 1914-18. Ho visto perfino dei mortai di bronzo, antiquati già nell’esercito austro-ungarico. Gli aerei italiani sono logori e non vengono sostituiti; i piloti debbono fare miracoli. Gli apparecchi da ricognizione sono vecchi Caproni, inermi e lenti, micidiali solo per chi ci vola… Gli aerosiluranti sono empirici e rudimentali. L’unica cosa viva è il valore e il coraggio dei piloti; un nostro aviatore rifiuterebbe di volare con certi apparecchi che qui, a ragione, chiamano “casse da morto”. [...] I fucili italiani si chiamano “modello 91” perché rimontano all’anno 1891. Gli italiani non possiedono mitra; i carri armati da 3 tonnellate sono semplicemente ridicoli»11. Con questi arsenali di ferraglie si poteva a malapena mantenere l’ordine pubblico in colonia, non combattere una guerra moderna. «Nel generale Tellera, ufficiale di vecchio stampo - ha scritto Giacomo Bondoni - era preminente lo spirito militare, gli ordini non si discutevano, ma non ha mai rinunciato a dire la propria opinione, non si è mai accodato ai tanti opportunisti che facevano sfoggio di faciloneria. La verità la disse a tutti: che eravamo impreparati a fare una guerra, e specie nel deserto, e che la guerra agli inglesi era un autentico suicidio. Balbo, che stimava profondamente la sua 76 La tragica fine della X armata e del suo comandante competenza e la sua onestà, andò quattro volte - si disse - a Roma per dissuadere Mussolini dall’entrare nel conflitto. Ma tutto fu inutile»12. Che Tellera fosse contrario alla guerra e che si fosse più volte adoperato per scongiurarla, è confermato anche dalla figlia Gianna in una breve memoria indirizzata alla figlia Simonetta nel luglio 1969: «Tuo nonno - recita il documento - per la sua posizione preminente, potrebbe essere considerato uno tra i responsabili di quella pazza partecipazione alla guerra, ma invece è positivo che il suo pensiero si concentrò tutto nel dimostrare, dati alla mano, che affrontare la guerra, da parte dell’Italia, sarebbe stata pura follia. Sua idea dominante, infatti, era che il nemico avrebbe svolto la sua prima azione contro di noi, proprio incominciando dall’Africa, dove eravamo particolarmente impreparati a riceverlo. Naturalmente, a Roma, tale tesi veniva tenuta allora in nessun conto, ma io ricordo benissimo quanto egli la sostenesse, anche perché, pur senza entrare nel più piccolo dettaglio militare, lo diceva a tutti, a chi voleva e a chi non voleva sentirlo!»13. 3. Dal giorno del suo arrivo in Libia, il 21 settembre 1937, al 31 gennaio 1941, sette giorni prima dello scontro mortale sulla via Balbia, il generale Tellera ha mantenuto con la moglie Zete una fitta corrispondenza. Si tratta di 150 fra lettere e cartoline postali per le Forze Armate, nelle quali il generale racconta la sua vita quotidiana, abbondando nei dettagli, e rivelando un carattere particolarmente affettuoso. Per la moglie Zete, che amorevolmente chiama Cetty o Cettina, nutre un’autentica adorazione, esaltata ancor più dalla lontananza. A lei confida ogni suo riposto pensiero, ogni suo piccolo vezzo, quasi volesse continuare, attraverso il Mediterraneo, quell’intimo colloquio che durava dal 1919, dal giorno delle nozze. Così le rivela di aver acquistato a Napoli, prima di imbarcarsi, una cappelliera per riporvi il casco coloniale14; di riuscire «ad applicare rigorosamente la teoria del quarto di vino [...]; qui bisogna essere moderatissimi nel cibo: non sovraccaricare lo stomaco, bere poco vino e resistere alla tentazione di bere molta acqua»15; e di essere riuscito persino a superare la tragedia della vestizione della grande uniforme: «Durante il Congresso Eucaristico ho cambiato più di 7 uniformi al giorno»16. Ma nelle lettere del generale Tellera compaiono spesso notizie e commenti che possono interessare anche allo storico. Notizie sulla preparazione bellica e poi, più tardi, sulla guerra che non aveva voluto. Tellera è prudente, sulle questioni militari misura le parole, anche perché sa che la cen77 Angelo Del Boca sura si applica anche alla corrispondenza dei generali. Quando, invece, affronta temi meno scottanti, allora si lascia andare, il suo linguaggio appare colorito, a volte addirittura lirico. Ecco, ad esempio, come descrive la Tripoli di Balbo: «Alle 17.30 sono andato a visitare il museo archeologico al Castello, dove sono gli uffici di S.E. il Governatore. Marmi, statue, mosaici antichi, una bellezza vera e propria, e tutto disposto con un buon gusto raro. È tutta opera di Balbo, che sta rinnovando Tripoli.[...] Dappertutto sorgono palazzi, parchi, viali: è veramente una bella città. Gli italiani pullulano; in certi momenti pare di essere in una delle belle strade di Palermo»17. Comandante della 60a divisione «Sabrata», Tellera è particolarmente fiero per come è riuscito ad istruirla in poche settimane. Il giorno in cui Balbo e Rudolf Hess, il vice di Hitler, la passano in rivista, scrive alla moglie: «Schieramento a massa imponente; passaggio dallo schieramento alla formazione per sfilare rapidissimo (12’) [...]. È ormai veramente una robusta Divisione, come mi ha detto Hess, due volte» 18. Qualche giorno dopo torna a parlare della divisione: «Ma la cerimonia più suggestiva, di più alto sentimento, cui ho assistito, è stata la messa della mia Divisione, schierata in un grande piano presso il mare. [...] Seimila uomini in quadrato, con un lato aperto verso il mare, l’altare improvvisato, preparato con grande amore. Hanno fatto la comunione sul campo 2.500 soldati. [...] Officiante il vescovo castrense mons. Bertolamasi»19. Ufficiale dal lontano 1902, comandante di imponenti formazioni, come le divisioni «Isonzo» e «Sabrata», direttore delle Scuole centrali militari, Tellera ama molto stare con i propri soldati ed è risaputo che si cura personalmente delle loro condizioni. Quando, nell’agosto del 1938, viene promosso generale di corpo d’armata e poco dopo diventa il collaboratore diretto di Italo Balbo nella qualità di capo di Stato Maggiore del Comando Superiore delle forze armate dell’Africa Settentrionale, avverte che i suoi impegni e le sue responsabilità sono notevolmente aumentate e che è suo stretto dovere provvedere ai bisogni dei suoi uomini in qualsiasi località essi siano. Così, spesso, al mattino si alza in volo e pilota lui stesso l’aereo che lo porterà nelle oasi più lontane. Il 2 novembre del 1938 il generale Tellera assiste ad un avvenimento storico. Quindici navi compaiono all’orizzonte e poco dopo sbarcano a Tripoli 1.800 famiglie di coloni. La cerimonia più suggestiva è quella che si svolge nella piazza del Castello, sotto lo sguardo di Mussolini, che appare, 78 La tragica fine della X armata e del suo comandante in dimensioni colossali, dipinto su di un muro. Dopo un breve saluto rivolto da Balbo alla folla, essa si inginocchia e in coro recita il Pater Noster. Tutti hanno le lacrime agli occhi, compreso Balbo. Due giorni dopo, mentre 800 famiglie si imbarcano di nuovo dirette in Cirenaica, Tellera scrive alla moglie: «Stamane si è fatto il carico dei coloni (1.000 famiglie) sugli autocarri che li hanno portati a destinazione. Operazione complicatissima, ma riuscita semplicemente in modo perfetto. Famiglie con 6,7,10 bambini! E che belli i piccini! E nessuno piangeva: ti assicuro che era una cosa commovente vederli. E venivano taluni dalle terre più lontane d’Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, ecc. Ed erano in viaggio da una settimana! [...] I coloni avranno un duro lavoro, ed è stato loro detto, perché non si facciano illusioni; ma finiranno col divenire piccoli proprietari terrieri. Se pioverà, come pare avviato, faranno presto bellissime colture»20. Intanto si profila, con sempre maggior insistenza, la minaccia di un’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania nazista. Nel maggio del 1940 Balbo invia Tellera a Roma per ricordare ancora una volta, agli alti comandi, che la Libia è impreparata. Su questa missione disponiamo della testimonianza della moglie del generale: «Eravamo alla fine di maggio del 1940: papà era arrivato dall’Africa stanco e molto preoccupato per la minaccia della guerra incombente sull’Italia, quella che egli sapeva eravamo assolutamente impreparati ad affrontare. Lo vidi, per alcuni giorni, andare e venire dal Ministero della Guerra, ove, a quanto pareva, non otteneva notizie rassicuranti. Poi, l’ultimo giorno del suo soggiorno romano, finalmente ci apparve più sereno e sorridente. Ci raccontò, a tavola: “Questa mattina al Ministero ho parlato col Maresciallo Badoglio, il quale ha affermato di avere, appena allora, lasciato S.M. il Re, il quale lo ha formalmente assicurato che mai firmerà una dichiarazione di guerra. La parola del Re è garanzia di pace. Siamo salvi!” Dopo pochi giorni il Re firmava la dichiarazione di guerra contro le potenze alleate e, con essa, la nostra rovina. Non so chi mentì, quella mattina, se Badoglio o Vittorio Emanuele, e non voglio fare commenti, perché i commenti li farà la storia»21. Ma ancora prima che giunga il 10 giugno, giorno della dichiarazione di guerra, Tellera si rende conto che la sua ultima missione è fallita e che a Roma gli hanno raccontato soltanto delle frottole. Alla moglie Zete scrive che, a causa della minaccia di guerra e al relativo panico che si è diffuso in colonia, è costretto a respingere con fermezza i tentativi di imboscamento: «Tutti ardenti patrioti, tutti prodi a chiacchiere! Ma tutti (o molti, alme79 Angelo Del Boca no) cercano l’ufficio, il boschetto qualunque, la licenza! Sentendo rumor di polvere, cessa il chiacchiericcio guerrafondaio ed emerge… la fifa»22. L’8 giugno, due giorni prima che Mussolini annunci la fine della non belligeranza e l’entrata in guerra dell’Italia, Tellera scrive a Zete: «Qualunque cosa succeda, state calmi. [...Domattina parto per la Cirenaica, salvo imprevisti, e tornerò lunedì. Se, nel periodo della guerra, tarderà la posta, non ti angustiare, di tanto in tanto cercherò di mandarti un telegramma e di darti mie notizie con qualche ripiego»23. Il 17 giugno Tellera lascia Tripoli «per poter seguire meglio le vicende della punta orientale»24. Il 18 è a Tobruch, il 21 a Cirene. L’indomani è di ritorno a Tripoli, dove è colto da una forte arrabbiatura. Scrive a Zete: «A Tripoli, la notte del bombardamento, mi hanno molto scocciato con falsi allarmi, tiri serrati d’artiglieria, ecc. Ma io li ho fatti smettere subito ordinando, la mattina seguente, che si diano il massimo degli arresti di rigore, e pagamento delle munizioni, ai colpevoli dei falsi allarmi e dei tiri ingiustificati»25. 4. Il 23 giugno il generale Tellera riparte per la Cirenaica. Il 26 è a Derna, con Balbo, per ispezionare le retrovie del fronte. Il 28 raggiunge in aereo Tobruch e dall’alto assiste all’abbattimento dell’apparecchio di Balbo. Alla moglie scrive, il 29 giugno: «Sei già al corrente dell’orrenda sciagura che ci ha tolto il Maresciallo Balbo: con lui sono periti Cino Florio, il nipote Lino, Brunetti, Fraylich e altri suoi vecchi amici. Io ero in altro apparecchio al seguito e ho assistito a tutto! A me stamane è toccato il duro, amaro compito di informare la Signora, che è a Cirene con i bambini. Uno strazio da non dire»26. L’indomani il generale scrive una lunga lettera a Zete fornendo ulteriori particolari della tragedia: «Avevamo avuto due giorni di ghibli violentissimo, che ci aveva impedito di volare. Il 28 il tempo si era fatto bello ed il Maresciallo decise di recarsi al pomeriggio a visitare certe truppe che avevano occupato quella mattina una nuova posizione. Partenza alle 17 dal campo d’aviazione qui vicino. Io dovevo andare sull’apparecchio del Maresciallo, come al solito; ma proprio nel momento in cui stavo per montare la scaletta del suo apparecchio, il Maresciallo mi disse di passare nell’altro apparecchio del gen. Porro, perché lì c’era da sedere. E con me mandò il ten.col. Sorrentino. Così noi due abbiamo avuta salva la vita. [...] Quando ci siamo avvicinati a Tobruch si è visto che gli inglesi stavano bombar80 La tragica fine della X armata e del suo comandante La moglie Zete 81 Angelo Del Boca dando il campo d’aviazione e noi abbiamo proseguito. Giunti al campo per atterrare (gli inglesi si erano allontanati) siamo stati investiti da raffiche di mitragliatrice della difesa contraerea, il nostro pilota si è buttato violentemente a sinistra e in basso verso il mare, e ci siamo salvati pure con qualche pallottola nell’apparecchio; l’aereo del Maresciallo è stato colpito nel serbatoio ed è precipitato in fiamme. Noi abbiamo atterrato in un altro campo, abbiamo atteso il Maresciallo; il dubbio è diventato certezza; siamo corsi a Tobruch e siamo giunti sull’imbrunire, quando l’apparecchio finiva di bruciare. Non ci pareva vero. Quell’uomo intelligente, pieno di vita, sicuro di sé, di salire ancora, non era più! E sembrava il figlio prediletto della fortuna. Ho chiamato Gariboldi, perché assuma il comando interinale delle truppe della Libia ed è giunto stamane; ma ora un telegramma comunica che prenderà il Governo e il Comando Superiore il Maresciallo Graziani»27. Per alcuni giorni il ricordo della tragedia nel cielo di Tobruch tormenta Tellera. Alla moglie, il 12 luglio confida: «Certo che la fine di Balbo ha qualche cosa di mistero. Mandò via me e Sorrentino, contro il solito, fece scendere dal suo aereo un fotografo (certo Goldoni, che non fa che ringraziare il Padre Eterno!) e chiamò su Carretti, suo intimissimo: insomma ha voluto portar con sé i parenti e i suoi più intimi amici. C’è qualche cosa di più del caso, in tutto questo»28. Qualche giorno dopo Tellera ritorna a parlare di Balbo alla moglie: «Col povero Maresciallo Balbo avevo avuto dall’inizio delle ostilità due grosse discussioni (di questo non dir niente a nessuno): appunto per quel suo andare in giro di continuo, spesso lontano da tutto lo stato maggiore, il che portava gravi inconvenienti nel funzionamento del Comando. Ma dopo le discussioni eravamo più amici di prima, e negli ultimi giorni, poi, egli era stato con me di una gentilezza e finezza da non si dire. Mi aveva fatto anche un rapporto magnifico, che però non fece a tempo a firmare»29. Il nuovo governatore della Libia, maresciallo Rodolfo Graziani, conferma Tellera nel suo incarico di capo di Stato Maggiore del Comando Superiore e qualche mese dopo, quando è già in atto l’offensiva britannica ed è già cominciato l’investimento della piazzaforte di Bardia, nomina Tellera comandante della X armata, precisando, nel suo memoriale difensivo, che si tratta di «soldato di grande mente e di grande cuore, perfettamente orientato sulla situazione ed all’unisono con me»30. Tellera dà notizia della promozione alla moglie Zete con una lettera del 26 dicembre 1940: 82 La tragica fine della X armata e del suo comandante «II gen. Berti ha dovuto lasciare il comando dell’armata per ragioni di salute e altro, e il Maresciallo dandomi la più alta prova di fiducia e di stima lo ha affidato a me. Assumo il duro compito, in sostanza la difesa della Cirenaica, con animo calmo e sereno, risoluto, come sempre, a fare tutto il mio dovere e ad esigerlo dai miei dipendenti, del resto ben disposti e di morale elevato. Come tu comprendi, il comando affidatomi ha il valore di una promozione: state quindi calme e tranquille e non preoccupatevi di nulla»31. Ben diversa di tono e di contenuto è la lunghissima lettera che il generale Tellera spedisce alla moglie l’ultimo giorno dell’anno. Una lettera che i famigliari giudicano, ed a ragione, una sorta di testamento spirituale. Affidata al tenente colonnello Celotti, che rientra in Italia, essa sfugge quindi all’ufficio censura di Roma, e contiene, per la prima volta, una ricostruzione degli avvenimenti assolutamente fedele ed obiettiva, quasi il generale volesse porre la famiglia al corrente della verità dei fatti. «Come sai, per avertene parlato - esordisce Tellera - noi siamo entrati in guerra (10 giugno) con una integrale e totale impreparazione. Fu detto, scritto, ripetuto - fu strepitato - lettere scottanti, telegrammi offensivi, tanto che Badoglio ebbe ad assicurare che non saremmo entrati in guerra prima del ’42 o ’43 (lo disse a me personalmente). Mancavano totalmente o quasi: mezzi corazzati, anticarro, contraerei - scarsi gli aeroplani, artiglierie vecchie, ecc. La morte di Balbo fu dovuta alle terribili preoccupazioni ed allo sforzo di sollevare il morale delle truppe - avvilitesi per l’inanità della lotta contro i mezzi blindati nemici - mediante la sua presenza, e del suo Stato Maggiore, sui campi di battaglia. Venuto Graziani, egli accettò tutti i provvedimenti in corso approvati dal povero Balbo e rinnovò le richieste di questi: fra l’altro quella di 1.000 autocarri (ne sarebbero occorsi più di 5.000), i quali 1.000 non avevano ancora finito di giungere ai primi di dicembre. Graziani mi confermò nella carica di capo di Stato Maggiore; ma non mi diede confidenza - mi sorvegliava (me lo disse lui stesso) - in un mese e mezzo non mi parlò più di tre volte. A Roma mi avevano ben calunniato, vilmente, e mio nemico fu proprio colui che più io avevo beneficato, colui del quale avevo fatto la fortuna32. Conosciuto che mi ebbe, mi diede tutta la sua stima e dopo la fortunata azione di Sidi el Barrani (settembre, prima quindicina), rimasto di me contentissimo, per la mia opera in certi duri momenti, mi elogiò e, recatosi a Roma, prese le mie difese e ristabilì le cose»33. Tellera continua la sua missiva sostenendo che la conquista di Sidi el 83 Angelo Del Boca Altre due immagini del generale 84 La tragica fine della X armata e del suo comandante Barrani era stata imposta da Mussolini; che Graziani era contrario all’operazione per l’assoluta povertà dei mezzi. Per lo stesso motivo si era opposto alla ripresa dell’offensiva con l’obiettivo di Marsa Matruh. Ma gli inglesi non gli avevano lasciato il tempo di preparare il balzo in avanti di ben 150 chilometri. «E così - racconta il generale - il 9 di questo mese si scatenò l’attacco degli inglesi. Nessuna sorpresa! Sapevamo tutto! E Roma sapeva tutto! Gli inglesi avevano concentrato in Egitto 15 divisioni. [...] In due mesi erano stati scaricati nei porti egiziani 300 piroscafi ed in un certo momento erano in Alessandria in scarico 42 mila tonnellate di materiale. Gli inglesi avevano un’aviazione potentissima (600-700 apparecchi); noi, il secondo giorno della battaglia, 46 apparecchi da bombardamento e 58 da caccia. Gli inglesi un migliaio tra carri armati ed autoblinde; noi zero autoblinde e una sessantina di carri armati efficienti (le parti di ricambio per mettere in efficienza una quarantina di carri armati stanno arrivando ora!). A soli 58 anni ho l’onore di comandare un’armata, affidatami dalla stima che ha di me il Maresciallo. Il nemico è formidabile per i mezzi. Le truppe nemiche in parte eccellenti (gli inglesi), in parte scadenti (indiani, neozelandesi, ecc.). Sono calmo, tranquillo, sereno, deciso.[...] Quello che ti scrivo è un minimo...ci sarebbero da scrivere molti libri... ma io ho voluto che mia moglie e la mia famiglia sappiano come sono andate le cose»34. Dopo la lettera-testamento il generale Tellera invia ancora alla moglie una dozzina di lettere, ma con pochissime informazioni di carattere politico-militare. Si intravede anche che queste missive sono state scritte di notte e soprattutto in condizioni di estremo disagio. In una, del 9 gennaio 1941, Tellera ritorna sulla «notevole sproporzione di mezzi fra noi e il nemico»35. Il 25 gennaio scrive: «E così anche il destino di Tobruch si è compiuto! Era inevitabile e nulla si poteva fare, per mancanza di mezzi. Questi verranno (vengono un po’ lentamente) ed allora vedremo di capovolgere la situazione. Questo è nel nostro animo»36. Con questa ultima frase Tellera cerca evidentemente di tranquillizzare la famiglia, ma lui sa perfettamente che la situazione è disperata. Dopo la perdita della piazzaforte di Tobruch, si sta tentando un’estrema difesa sulla linea Derna-Berta-el Mechili, ma il destino della Cirenaica è ormai segnato. L’ultima lettera del generale porta la data del 31 gennaio 1941: «Vorrei scriverti a lungo, ma non è possibile perché siamo in piena guerra di movimento, e ti assicuro che ho il mio da fare. Per ora, come vedrai dai bol85 Angelo Del Boca lettini, dobbiamo cedere e ripiegare, ma abbiamo inflitte al nemico molte perdite e verrà la rivincita»37. Mentre Tellera verga queste parole, ancora venate da un patetico ottimismo, il maresciallo Graziani ha già impartito l’ordine per la «ritirata totalitaria» di tutte le truppe del Gebel. Al Comando Supremo così spiega la sua decisione: «È ineluttabilmente dettata dalla configurazione del teatro operativo e dal criterio che, dovendo perdere prima o poi territorio e truppe, preferisco salvare queste ultime per adoperarle a sbarramento della via per la Tripolitania schierandole nella Sirtica»38. Ma, come abbiamo visto, la ritirata generale non si svolge nell’ordine preconizzato da Graziani, ma diventa presto caotica e disastrosa, e soltanto 8 mila uomini riescono a rompere l’accerchiamento messo in atto dal generale O’Connor. E mentre il generale Tellera si spegne in un’assurda, disperata lotta contro i mostri d’acciaio britannici, Rodolfo Graziani invia a Mussolini questo telegramma, che denuncia il crollo fisico e morale del Maresciallo ed insieme l’incapacità del duce di gestire una guerra già perduta in partenza: «Duce, gli ultimi avvenimenti hanno fortemente depresso i miei nervi e le mie forze, tanto da non consentirmi di tenere più il comando nella pienezza delle mie facoltà. Se per falso sentimento di amor proprio lo facessi, mi sentirei grandemente colpevole. Ho cercato in tutti i modi di far comprendere la verità. Non sono stato ascoltato. Sono sicuro che una nuova energia potrà rendere assai più di me nella fase risolutiva delle operazioni, che qui si preparano»39. L’11 febbraio è già in volo per Roma ed esce - purtroppo non definitivamente - dalla scena. Se avesse il coraggio di analizzare la batosta ricevuta, capirebbe che un conto è mietere vittorie contro partigiani libici ed etiopici, male armati, come ha fatto nel passato, ed un altro è affrontare eserciti europei modernamente armati e guidati. Ma Graziani è troppo vanaglorioso per imparare la lezione. 5. Anche se la morte sul campo di un comandante di armata era piuttosto imbarazzante per un regime che si vantava di tener testa ai più forti eserciti del mondo, il generale Tellera meritava comunque una ricompensa, vale a dire una medaglia d’oro al valor militare. Essa fu perciò consegnata con una solenne cerimonia a Roma, all’altare della patria. Ma la moglie Zete, prostrata dal dolore, negò la sua presenza alla cerimonia, e Vittorio Emanuele III appuntò la medaglia d’oro al petto della figlia Gianna, ventenne. Nella «nota conclusiva» alle lettere del generale Tellera è registrato un 86 La tragica fine della X armata e del suo comandante episodio, quasi incredibile, che documenta quanto fosse poco serio e rispettoso il regime nei confronti di chi aveva dato la vita per la nazione. Scrive Simonetta, la nipote del generale: «II Duce tentò a quel punto di sfruttare in qualche modo, a favore del regime, quella morte scomoda. Fece sapere alla vedova che le avrebbe “donato” un milione di lire (di allora) se si fosse prestata (lei, o almeno la figlia) alla seguente scenetta, che avrebbe dovuto essere filmata e poi usata per propagandarla in tutto il Paese. La vedova sarebbe entrata nella stanza del Duce, esclamando: “Vinceremo!”, affinché egli potesse battere il pugno sul tavolo, e replicare: “Abbiamo vinto!”. Forse basta aver letto le lettere di mio nonno per sapere come reagì la famiglia. Il denaro scarseggiava, la pensione del generale tardava ad essere pagata (lo fu solo alla fine della guerra), la “tribù” era numerosa, e la somma offerta dal Duce, molto alta: ma nessuno ebbe il minimo dubbio. La proposta fu definita una “buffonata indecorosa”, e il “no” fu secco e deciso»40. Note al testo 1 «The Times», 12 febbraio 1941: The battle of Benghazi. Italian struggles to escape. 2 Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, La prima offensiva britannica in Africa Settentrionale (ottobre 1940-febbraio 1941), vol. 1, Tipografia Regionale, Roma s.i.d., p. 272. 3 RODOLFO GRAZIANI, Africa Settentrionale (1940-1941), Danesi editore, Roma 1948, p. 222. 4 Questo episodio è riferito dal cappellano militare Francesco Donati, nel suo rapporto al Comando Superiore Africa Settentrionale dell’11 aprile 1941. 5 «The Daily Telegraph», 12 febbraio 1941. 6 «The Times», 12 febbraio 1941. 7 Archivio Famiglia Bondoni Pastorio. D’ora innanzi: AFBP. Ritratto del generale Tellera del genero Giacomo Bondoni. 8 RODOLFO GRAZIANI, Africa Settentrionale cit., p. 46. 9 Stato Maggiore dell’Esercito Ufficio Storico, La prima offensiva britannica cit., p. 281. 10 «L’Espresso», 12 gennaio 1958. 11 Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, La prima controffensiva italo-tedesca in Africa Settentrionale (15 febbraio-18 novembre 1941), Tipografia Regionale, Roma 1974, p. 20. 12 AFBP, Ritratto del generale Tellera cit. 13 AFBP, Lettere dalla Libia scritte dal generale Giuseppe Tellera alla moglie Zete, trascritte e annotate dalla nipote Simonetta M. Bondoni Pastorio, p. 85. 14 Ivi, p. 5, in data 17 settembre 1937, da Napoli. 87 Angelo Del Boca 15 Ivi, p. 6, in data 21 settembre 1937, da Tripoli. 16 Ivi, p. 11, in data 14 novembre 1937, da Tripoli. 17 Ivi, pp. 10 - 11, 4 ottobre 1937, da Tripoli. 18 Ivi, p. 9, 6 novembre 1937, da Tripoli. 19 Ivi, p. 12, 14 novembre 1937, da Tripoli. 20 Ivi, pp. 18 - 19, 4 novembre 1938, da Tripoli. 21 Ivi, p. 85. 22 Ivi. p. 29, 27 maggio 1940, da Tripoli. 23 Ivi, p. 32, 8 giugno 1940, da Tripoli. 24 Ivi, p. 35, 17 giugno 1940, da Tripoli. 25 Ivi, p. 36, 22 giugno 1940, da Tripoli. 26 Ivi, p. 37, 29 giugno, da Cirene. 27 Ivi, pp.37-38, 30 giugno 1940, da Cirene. 28 Ivi, p. 41, 12 luglio 1940, la località non è indicata. 29 Ivi, p. 43, 18 luglio 1940, la località non è indicata. Il rapporto di Balbo così recitava: «Ho alle mie dipendenze dirette il Gen. Tellera, quale capo di S.M. delle Forze Armate A.S. dal [...] e non ho che a lodarmi di lui e della sua opera. Io stesso, del resto, che lo conoscevo quale Comandante della Divisione Sabratha e che lo avevo seguito nel campo disciplinare, addestrativo e tattico, durante le grandi manovre dell’anno XVI in Gefara, l’ho designato a Capo di Stato Maggiore perché gli avevo riconosciute qualità eccezionali. Dichiaro subito che non mi sono certo ricreduto conoscendolo a fondo. Il Gen. Tellera è dotato d’una vastissima cultura militare, ma la sua cultura non lo rende né un arido teorico, né un pedante. Aderente com’è alla realtà della vita militare, è un comandante dal cervello elastico, giovanile, che forma i dipendenti e che possiede assoluta la conoscenza del servizio. Non rifugge dalle più moderne concezioni della guerra, che lo trovano attento indagatore ed entusiasta seguace. Proveniente dalla fanteria conosce molto bene l’impiego dell’artiglieria, come ho potuto constatare io stesso ad un’esercitazione di artiglieria sul Gebel». Balbo, che sapeva che Tellera non godeva di grandi simpatie a Roma, accompagnava il rapporto con una lettera al generale Ubaldo Soddu, sottosegretario di Stato per la Guerra: «Caro Soddu, vedo che Geloso è stato incaricato del comando d’armata. Non so se questo incarico abbia influenza nella carriera, comunque ti avverto che dovrei altamente protestare se un meno anziano saltasse Tellera, che fa onore all’Esercito per la sua cultura, per la sua intelligenza e per le sue alte qualità professionali. A scanso di equivoci ti unisco un rapporto sull’opera da Tellera prestata alle mie dirette dipendenze». (Segreteria di S.E. il Maresciallo dell’Aria, 25 luglio 1940, in AFBP). 30 RODOLFO GRAZIANI, Africa Settentrionale cit., p. 174. 31 AFBP, Lettere dalla Libia scritte dal generale Tellera cit., p. 74. 32 I famigliari del generale Tellera tendono a credere che si trattasse del generale Ubaldo Soddu, all’epoca sottosegretario alla Guerra e in seguito comandante delle truppe in Albania. 33 AFBP, Lettere dalla Libia del generale Tellera cit., p. 75, in data 31 dicembre 1940. 34 Ivi, p. 76, in data 31 dicembre 1940. 35 Ivi, p. 79. 88 La tragica fine della X armata e del suo comandante 36 Ivi, pp. 81-82. 37 Ivi, p. 83. 38 Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, La prima offensiva britannica in Africa Settentrionale cit. p. 232. 39 RODOLFO GRAZIANI, Africa Settentrionale cit., pp. 236 - 37. 40 AFBP, Lettere dalla Libia del generale Tellera cit., p. 84. 89 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia di Carla Ghezzi Nel luglio 1911 «La Tribuna», l’autorevole quotidiano d’opinione e di cultura diretto da Olindo Malagodi - che gli aveva impresso un indirizzo fiancheggiatore della politica giolittiana - concesse un rilievo inusuale all’impero etiopico, pubblicando una serie di articoli dedicati alla successione a Menelik, messo fuori gioco da un colpo apoplettico1. Uno di questi, abbastanza disomogeneo con gli altri, era intitolato Una donna bianca attraverso l’Abissinia ed era a firma di Ida Locatelli2. L’impresa di cui l’autrice dava conto era in realtà stata effettuata nei mesi di gennaio e febbraio di quello stesso anno, ma la redazione decise di congelare la pubblicazione dell’articolo in attesa che le vicende abissine avessero una qualche ricaduta interna italiana: la missione etiopica nel nostro paese, guidata dal deggiac Cassha, figlio di un ras del Tigrai, svoltasi dal 16 al 31 luglio successivo, sembrò dunque l’occasione opportuna3. Difficile tratteggiare una biografia puntuale della «viaggiatrice africana […] che, a scopo di studio, sta attraversando l’Abissinia da un capo all’altro»: così «La Tribuna» presenta Ida ai propri lettori, precisando che la signora non ha scorta di soldati, ma soltanto alcuni servi, a conferma della sicurezza garantita agli europei entro i confini etiopici. Originaria di Romanshorn, una località sul lago di Costanza, Ida Schroop (un cognome che nei documenti depositati presso l’Archivio del soppresso ministero dell’Africa Italiana viene di frequente storpiato in Schop, Schoop, Schoose)4, diviene suddita del regno in virtù del matrimonio contratto a Novara con il veronese Guglielmo Locatelli. In quella città è per un certo periodo ispettrice scolastica. La sua vicenda africana, con l’eccezione del viaggio in terra abissina, il prosieguo nella capitale etiopica nell’arco del 1911 e un lungo soggiorno ad Alessandria d’Egitto nel 1897, si svolge interamente in Eritrea. Un dies a quo documentato è il 23 giugno 1893, quando la Real Casa riceve da Ida un’istanza per l’autorizzazione a recarsi a Massaua come 91 Carla Ghezzi sorella della Croce Rossa. Dalla lettera prende l’avvio un fitto scambio di corrispondenza tra l’amministrazione centrale e il governo dell’Eritrea, che si conclude il 16 agosto dello stesso anno con un nulla di fatto: il ministero dellaGuerra, che ha ricevuto per competenza dalla Real Casa l’istanza, la inoltra a sua volta al ministero degli Esteri. «Debbo ritenere da tale trasmissione fattami dell’istanza che i servigi della predetta signora non siano richiesti né presso le R.R. Truppe né presso cotesti ospedali militari». Sbrigativamente, Giacomo Malvano, segretario generale del ministero, chiede a Oreste Baratieri, governatore militare dell’Eritrea, se Ida possa essere impiegata nell’ospedale civile «Umberto I» o presso qualche altra istituzione della Colonia. Con rammarico, il governatore esclude la possibilità di iscrivere nel bilancio dell’ospedale lo stipendio per un’altra persona, in aggiunta a quello già previsto per l’infermiera interna alla struttura. Ed è in questi termini che il Ministro degli esteri, Benedetto Brin, motiva la chiusura del caso alla Real Casa5. Maria José crocerossina in A.O. 92 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia Passano poco più di quattro anni: da Alessandria d’Egitto, Ida si rivolge di nuovo al Re per ottenere il nullaosta al rilascio del passaporto necessario per recarsi in Eritrea a insegnare nelle scuole elementari. È il reggente il ministero della Real Casa, Emilio Ponzio Vaglia, a trasmettere l’istanza al ministero degli Esteri che, memore del precedente, invita Cesare Romano, console ad Alessandria, a far presente a Ida che senza mezzi propri non potrà mantenersi in Colonia, né essere rimpatriata gratuitamente, non essendo previsti, nel bilancio coloniale, fondi per facilitazioni di viaggio. La persona, evidentemente, suscita diffidenza. In effetti, il contenuto della lettera, datata 14 dicembre 1897, indirizzata al ministero degli Esteri dal console, può indurre qualche perplessità. Nel rivolgersi al Re Ida aveva affermato di trovarsi ad Alessandria d’Egitto da alcuni giorni: giusto il tempo per ottenere il passaporto e imbarcarsi per l’Eritrea. Il cav. Romano sostiene, al contrario, che la donna è in terra egiziana dal gennaio precedente, priva di documenti, presumibilmente di denaro e di notizie da parte del marito, «d’ignota dimora da 5 anni» per condanna in contumacia del Tribunale di Novara. Può soltanto esibire una lettera di raccomandazione per padre Michele da Carbonara, capo della missione dei Cappuccini in Eritrea, redatta dal parroco cattolico di Alessandria e un certificato di lodevole condotta e di raccomandazione a firma del conte Giorgio Calvi di Bergolo, consigliere di legazione presso l’Ambasciata di Berlino, rilasciato poco più di due anni prima. Alla richiesta per il nullaosta si aggiunge quella della riduzione della metà del prezzo del passaggio per Massaua, avendo Ida già ottenuto dal direttore della Compagnia di Navigazione Generale la riduzione dell’altra metà del biglietto. Com’era prevedibile, il ministero autorizza soltanto il nullaosta alla concessione del passaporto. È il 9 marzo 1899 quando Emilio Ponzio Vaglia scrive nuovamente al ministro degli Esteri, Felice Napoleone Canevaro, a proposito di una richiesta pervenuta da Asmara da parte di Ida per la concessione gratuita del terreno occorrente alla fabbricazione – questa volta a proprie spese – di un tucul, in una zona dichiarata di servitù militare. Invitato a esprimere un parere, il commissario civile straordinario della Colonia, Ferdinando Martini, risponde negativamente, argomentando il suo diniego con due ordini di motivi: Ida si era già rivolta al governo della Colonia chiedendo non soltanto il terreno su cui avrebbe dovuto sorgere la nuova casa, ma anche che questa venisse costruita gratuitamente. In secondo luogo, la località prescelta - tra il forte Baldissera e gli edifici governativi - era ovviamente gra93 Carla Ghezzi vata da servitù militare. Anche la destinazione d’uso dell’edificio - l’istituzione di una scuola per bambini bianchi - non convince il governatore, dal momento che il loro numero è limitatissimo. «Non saprei se realmente la Signora Locatelli, la quale fu anche ispettrice scolastica, abbia le qualità didattiche e le altre doti richieste per un regolare e proficuo insegnamento, non risultando che essa abbia fatto studii o almeno ottenuto un diploma magistrale: ma in ogni caso sulla idoneità di quella signora al compito, che ella vorrebbe assumersi, mi parrebbe lecito per lo meno di dubitare, per le speciali condizioni sue, anche di temperamento e di salute»6. La nuova istanza di Ida, indirizzata al re, si riferisce a un terreno diverso, per il quale si chiede comunque la concessione gratuita. Secondo Martini il prezzo dei terreni edificabili ad Asmara è talmente irrisorio da non potere costituire un aggravio; la soddisfazione della richiesta rappresenterebbe, al contrario, un «precedente pericoloso» per le finanze della Colonia. Anche questa volta l’esito, negativo, è scontato. Trascorre un anno e al governatore viene offerta l’opportunità di spendere una parola in favore di Ida presso il presidente della Croce Rossa italiana, conte Rinaldo Taverna, cui lei si era rivolta per essere ammessa come assistente infermiera volontaria in caso di guerra. Cosa che Martini prontamente fa, definendola «sotto ogni aspetto meritevole dell’accoglimento della sua generosa domanda». E, sconfessando il giudizio espresso qualche mese prima sulle attitudini della Locatelli all’insegnamento, in una lettera al Ministro degli esteri, Emilio Visconti Venosta, il governatore afferma che per la fondazione ad Asmara dell’istituto «Savoia» a Ida non sono mancati «né gli appoggi né l’approvazione di questo Governo, e se esso è oggi poco frequentato ciò è indipendente dalle cure che la predetta signora vi dedica e dalle sue qualità intellettuali e morali»7. Ma Ida è instancabile nelle sue richieste al re, che inevitabilmente coinvolgono Giacomo Malvano e Giulio Prinetti - rispettivamente segretario generale e responsabile del ministero degli Esteri nella primavera del 1901 - Emilio Ponzio Vaglia e Ferdinando Martini, dal cui giudizio dipende, come sempre, la soluzione del caso. Ida deve avere, nel frattempo, commesso qualcosa di grave o che il governatore ha giudicato tale se, a distanza di qualche mese dalla lettera indirizzata a Visconti Venosta, in quella diretta al suo successore, Prinetti, lui fa riferimento non al precedente rapporto - in cui esprimeva un giudizio lusinghiero delle qualità didattiche di Ida - ma a quello del 1899, sopra riportato, che è di condanna. In esame è la 94 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia L’Istituto Savoia fondato dalla Locatelli nel 1899. Foto di Ida Locatelli, Asmara 1904. Fonte: ASMAE, ASMAI, Persone operanti in Africa (1879-1925), posiz.35, pacco L-3, busta 1 95 Carla Ghezzi richiesta di un sussidio inoltrata al Re: ebbene, Martini taglia corto affermando che l’istituto «Savoia», fondato «nominalmente» da un anno e mezzo, esiste più di nome che di fatto; pochissimi sono i bambini iscritti, nonostante che l’istituzione di una scuola sia stata più volte perorata dai coloni e dallo stesso governo di Asmara. Questo, che per la concessione di un sussidio si era mantenuto in una posizione di benevola aspettativa, ha alla fine deciso di non accordare alcuna sovvenzione. La lettera di Prinetti a Ponzio Vaglia, che cita testualmente le parole di Martini, costituisce l’ennesimo epilogo negativo delle istanze di Ida. Il rapporto travagliato di Ida con il governo della colonia è testimoniato dall’esito di un’altra sua istanza, mirante a ottenere l’alto patronato di S.A.R. il principe di Piemonte per la sua scuola-asilo. La risposta negativa ha una giustificazione formale - la richiesta è stata inoltrata nel dicembre 1904, quando il principe Umberto ha ancora pochi mesi di vita - e una di merito, ovviamente non esplicitata alla richiedente. In una lettera datata 5 febbraio 1905, indirizzata al Ministro degli esteri, Tommaso Tittoni, Guglielmo Pecori Giraldi, comandante delle RR. Truppe di stanza in Eritrea nonché facente funzioni di Commissario civile in occasione delle frequenti assenze di Ferdinando Martini dalla colonia, afferma che «non basteranno la buona volontà e l’operosità della fondatrice» […] «per altri rispetti colta e intelligente gentildonna» […] «a farle conseguire la lodevole ambizione di veder prospero l’istituto». Una prosa elegante che mal dissimula il giudizio espresso dal governatore sulle attitudini didattiche della direttrice e che Pecori Giraldi ha fatto proprio8. Incautamente, Ida decide di prendersi una rivincita contro Martini, nel quale vede ormai un avversario. L’occasione sembra essere offerta dal congresso coloniale promosso nel settembre-ottobre 1905 ad Asmara dal governatore con intenti palesemente autocelebrativi e anche in vista di un rilancio della politica coloniale nel suo complesso. Dal capoluogo della colonia invia una corrispondenza al periodico romano «Italia Militare e Marina» in cui definisce la mostra dei prodotti della colonia, ordinata ai margini del congresso, un’«esposizione di campioni fatti venire da tutte le parti del mondo, in specie dallo Egitto»9. Il dottor Isaia Baldrati, direttore dell’Ufficio agrario sperimentale della colonia e curatore della mostra, ritenendosi personalmente offeso e diffamato, sporge formale querela davanti al tribunale di Roma contro l’autrice della corrispondenza. In realtà non è tanto lui a essere chiamato in causa quanto lo stesso Martini, che in Il dia96 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia rio eritreo dà sfogo a una rabbia che ha tutta l’aria di voler chiedere soddisfazione. Il governatore la otterrà: Ida ritratta le affermazioni ritenute ingiuriose in una lettera di scuse e di stima per il dottor Baldrati, pubblicata sia nell’ «Italia Militare e Marina» che nel «Bullettino Ufficiale della Colonia Eritrea»10. Lo scontro era impari e Ida ha dovuto soccombere. Dal Chi è? dell’Eritrea di Giuseppe Puglisi, che dedica alla donna una trentina di righe, si possono trarre informazioni a corollario dell’impresa di viaggio attraverso l’Abissinia piuttosto che elementi utili per la biografia. Del viaggio da Asmara ad Addis Abeba attraverso il Tigrai e il Wollo, di cui l’articolo pubblicato in «La Tribuna» costituisce il resoconto, il Chi è? offre una sorta di continuazione da dietro le quinte: apprendiamo così che Ida si ferma nella capitale etiopica fino alla fine del 1911, animata dal proposito, rivelatosi irrealizzabile, di fondare una scuola di lingua italiana e un comitato della «Dante Alighieri». Ad Addis Abeba viene introdotta alla corte dell’erede al trono Ligg Iyasu, dove riesce a conquistarsi la fiducia di due cugine del reggente: fatto senza precedenti per una donna europea, anche se appartenente al corpo diplomatico. Di questa esperienza Ida compila degli appunti da utilizzare per la stesura di un libro. Incoraggiata dall’ambiente favorevole, progetta un viaggio fino al lago Margherita e un ritorno nella colonia Eritrea attraverso il Goggiam. Da Puglisi si apprende anche che la sua storia africana si conclude con il ritorno in Italia, a seguito di un provvedimento di espulsione11. Forte dell’esperienza acquisita nel corso di precedenti escursioni in colonia e oltre confine a nord, fino a Kassala, Ida reagisce con impazienza agli avvertimenti di quanti, amministratori e viaggiatori, intendono dissuaderla dal proposito di raggiungere la capitale etiopica per altra via che quella attraverso Gibuti e Dire Daua. Le pressioni arrivano al punto da lasciar presagire gli inevitabili «grattacapi per raccogliere le sue ossa laggiù»12; per tagliar corto, lascia intendere a qualcuno che da Asmara sarebbe partita alla volta di Massaua e di lì si sarebbe imbarcata per Gibuti. Ottenuto il consenso al viaggio da parte del governatore della colonia, il marchese Giuseppe Salvago Raggi, che le rilascia lettere di richiesta di protezione dei capi etiopici, delle agenzie commerciali di Adua e di Dessié e delle stazioni telegrafiche italiane oltre il Mareb dipendenti dal governo della colonia, Ida lascia la riva italiana del fiume, nei pressi di Addi Quala, il 7 gennaio 1911. Dichiara di voler «compiere anzitutto un pellegrinaggio patriottico in tre luoghi sacri per l’Italia: Adua, Macallè e Amba Alagi». Ma subito la co97 Carla Ghezzi scienza dell’eccezionalità della vicenda che la vede protagonista le fa mettere in subordine l’amor di patria per dare conto al lettore di un «viaggio durante il quale vissi come in un sogno stupendo» per «il fascino che questa terra incantatrice esercita su tutto l’essere del viaggiatore civile». E più oltre: «La sublime bellezza della natura […] mi allietava l’anima al punto di renderla inaccessibile alla paura dell’ignoto e sempre più vaga dell’imprevisto»13. Più volte, nell’articolo, si fa ricorso all’aggettivo «civile», anche associato al sostantivo «donna»: Ida è una «solitaria viaggiatrice bianca» – così si autodefinisce – che percorre gli oltre mille chilometri esistenti fra il Mareb e Addis Abeba in ventisei giorni di marcia e quattordici di sosta forzata con una scorta di tre muletti - uno da sella e due da basto - e di quattro indigeni. Fra questi primeggia il tigrino Redda Chidamì, divenuto noto ai suoi connazionali per aver servito da interprete ad Arnaldo Cipolla, inviato nel 1910 nella capitale etiopica dal «Corriere della Sera» per verificare le condizioni di salute di Menelik, affetto da una paralisi irreversibile che, secondo alcuni, poteva averne già causato la morte, avvenuta, secondo le fonti ufficiali, il 12 dicembre 1913. Redda disimpegna con tale abilità le mansioni di guida, interprete, capo-carovana, staffiere e cuoco che a missione conclusa Ida lo mantiene al proprio servizio. Da Adua si erano aggregati come scorta volontaria due uomini e un ragazzo, che le rimangono fedeli fino all’arrivo nella capitale dell’impero. La singolarità dell’impresa e l’intelligenza di chi la realizza si manifestano anche nella descrizione degli incontri con le autorità e i notabili dei luoghi-tappa del viaggio: Ida non rifiuta l’ospitalità che le viene offerta, accetta di dedicare tempo ai suoi ospiti e, mentre cerca di soddisfare le domande su ferrovie, aeroplani e i «supposti miracoli che si verificano nel mondo civile», lascia che la moglie del capofamiglia, timidamente, accarezzi con garbo i suoi vestiti14. Lo scambio dei doni privilegia il versante femminile: uno spillone in filigrana d’argento per la padrona di casa e gingilli di ogni genere per le dame di compagnia; nulla per gli uomini. Un sotto-capo di ras Olié dichiara di condividere la scelta della prima visitatrice italiana dell’Abissinia di fare doni soltanto alle donne, dal momento che i primi viaggiatori offrivano, ai capi, soltanto fucili e cartucce. Con sensibilità tutta femminile Ida risponde che i piccoli doni conquistano i cuori, mentre le armi possono alimentare l’odio, anche nei confronti di chi le ha donate. Il carico dei muletti della carovana comprende anche una rudimentale, quanto provvidenziale cassetta dei medicinali, di cui la viaggiatrice si serve per curare un’affezio98 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia ne oculare di alcuni sotto-capi membri della missione politica del governo della Reggenza, diretta a ras Mikael, padre dell’erede al trono Ligg Iyasu15. L’incontro con il capo-missione, il deggiac Imenié, avviene nella sua tenda, a Demebà, a tre giornate di marcia dalla capitale etiopica. Il generale la invita a pranzo, la pone sotto la sua protezione e al momento del congedo un trombettiere del campo non le risparmia una maldestra esecuzione della marcia reale italiana. Nel territorio di ras Mikael la piccola carovana è accompagnata fino al confine da una scorta d’onore, incaricata di provvedere al sostentamento delle persone e degli animali. Alla generosa ospitalità dei notabili abissini Ida contrappone l’inefficienza del personale italiano: cinque giorni di sosta forzata a Makallè sono la conseguenza della mancata comprensione della sua richiesta, inoltrata telegraficamente alla legazione italiana in Addis Abeba, di farle ottenere il nullaosta di Menelik, necessario per varcare i confini del Tigrai. L’arrivo di Ida ad Addis Abeba desta grande stupore, «per il fatto inaudito che io avevo attraversato le regioni meno sicure dell’impero sola, con pochi uomini indigeni e senza un fucile…»16. La scorta armata di due guardafili della linea telegrafica Asmara-Addis Abeba, accordatale dal governo della colonia, si era infatti ridotta a un certo momento del viaggio a due indigeni armati di bastoni per l’incompetenza del personale delle stazioni telegrafiche dislocate lungo il percorso. Ma Ida non fa valere i suoi diritti per sperimentare appieno l’umanità del governo imperiale e dei sudditi, «che davvero non sono barbari». Il successo del suo «esperimento» servirà dunque a eliminare i pregiudizi che costituiscono un serio ostacolo alla soluzione del problema della penetrazione pacifica in quei territori. Ma c’è un altro obiettivo tenacemente perseguito: l’attraversamento di un «continente» fino ad allora riservato all’eroismo maschile, come le fa notare un giovane esploratore italiano. Nell’incipit Ida ammette che la sua marcia attraverso l’impero abissino è stato sì, lungo e disagevole, ma niente affatto pericoloso, che «non costituisce un gesto eroico a glorificazione del femminismo, ma semplicemente e casualmente un record femminile, essendo io la prima donna civile che giunse in questa metropoli [Addis Abeba] per la via dello interno». Nel simbolo femminino così abilmente creato si fatica a riconoscere la maestra che si ingegna per la sopravvivenza nella colonia primigenia. Il viaggio solitario, meno che mai quello in terre considerate - a torto o a ragione - selvagge, non è da annoverare fra le aspirazioni delle donne ita99 Carla Ghezzi liane dei due primi decenni del Novecento: l’unica eccezione è rappresentata da Annie Vivanti, che a metà degli anni venti percorre l’Egitto animata da una buona dose di curiosità, più che da passione o da coraggio, pubblicando poi un romanzo di viaggio in terra africana destinato a rimanere un episodio isolato nella produzione letteraria italiana17. Il viaggio, come anche l’emigrazione nei nostri possedimenti coloniali, resta un appannaggio esclusivo delle donne sposate: a poco valgono gli appelli, l’impegno profuso dai fasci femminili e dall’Istituto fascista dell’Africa italiana nella promozione di corsi di formazione coloniale, gli ammiccamenti per presentare come familiari nomi e paesaggi dell’impero alle donne comuni, soprattutto nubili. A partire dall’ottobre 1940 il mensile dell’Ifai, «Africa Italiana», apre una rubrica dal titolo La donna e l’Africa, nella quale compaiono resoconti delle attività svolte nei campi coloniali femminili, poesie, racconti di ambientazione africana sviluppati in chiave domestica e patriottica. Una firma ricorrente è quella di Jolanda Giacomelli Galofaro, portavoce di quante - dattilografe, maestre, sarte, telefoniste - furono sul punto di aderire alla chiamata, ma ne saranno poi di fatto impedite dall’esito rovinoso della guerra in colonia. Eppure l’Etiopia fascista può ben vantare le sue pioniere dell’avventura solitaria le quali, dopo avere percorso l’impero, anche se non più in maniera avventurosa, ne esaltano la missione civilizzatrice descrivendo i popoli assoggettati e le ricchezze del suolo in maniera quasi sempre funzionale al progetto di espansione della metropoli coloniale. Agli abitanti del luogo non si presta attenzione se non per avvalorare la tesi della superiorità della razza bianca, che ha come corollario lo sfruttamento da parte di questa ai danni dell’altra elevato a forma di governo. Per rimanere in tema di primati, la tedesca Louise Diel proclama il proprio orgoglio per essere stata «la prima scrittrice del mondo che abbia visto […] l’Abissinia pacificata»18. Prima della partenza, nell’ottobre 1937, la Diel è ricevuta a Palazzo Venezia dal duce, che le indica su una carta dell’Aoi l’itinerario che si appresta a compiere, lungo più di 10.000 chilometri. A viaggio concluso il maresciallo Badoglio, cui la donna riferisce di avere effettuato la missione in nove mesi, si prende bonariamente gioco della sua interlocutrice ricordando di avere portato a termine la campagna d’Etiopia in soli cinque mesi e cinque giorni. Nonostante tale asserita inferiorità, ad Addis Abeba la Diel viene soprannominata «il vulcano volan100 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia te». Per tutto il libro cercherà di mantenere fede all’esortazione scritta in tedesco da Mussolini sulla prima pagina del suo nuovo diario: «Vedi la nostra nuova terra con occhi aperti». Un compito fin troppo facile - scoprire quello che di buono ha realizzato il colonialismo - per chi ha già tutte le risposte ai propri interrogativi e non ha bisogno di verifiche per alimentare un credo già sufficientemente corroborato. E allora decide di andare oltre e di assumersi un ruolo di imbonitrice per le ragazze in età da marito, per le quali «non vi sono prospettive migliori di matrimonio che nelle colonie, dove scarseggiano le donne»19. Il Manifesto della razza sarà pubblicato nel luglio del 1938; la promulgazione della legislazione razziale è del novembre successivo; ma tutta una serie di provvedimenti legislativi emanati in precedenza avevano provveduto a regolare pervasivamente la materia. Perché la struttura normativa, ormai definita, non resti puramente teorica, è necessaria una massiccia emigrazione femminile in Aoi: politica della razza e politica coloniale si compenetrano, dal momento che soltanto il nucleo familiare può arginare la mescolanza della razza e, così facendo, proteggere l’edificazione dell’impero20. Vengono in mente gli scritti di Martino Mario Moreno e di Angelo Piccioli sul tema della razza e della colonizzazione demografica: probabilmente Louise, prima di dare alle stampe il suo libro, ha cercato conferme autorevoli delle proprie affermazioni21. Il suo libro è così profondamente impregnato di razzismo da lasciare presagire vasti consensi anche in patria; in Etiopia, al momento, appare comunque eccessiva la messinscena del «trasporto del caffè di Harar, dono del duce alla Signora Louise Diel per l’Opera di assistenza invernale tedesca», da lei architettata per ottenere dal suo governo il consenso alla missione africana. Anche la natura le appare simbolicamente assoggettata ai ritmi convulsi della vita in colonia: così il passaggio repentino dal giorno alla notte e viceversa è percepito come un’assenza di tempi intermedi e di vicende che evolvono lentamente. La vita è «grandiosa e insieme primitiva, stracittadina e nello stesso tempo strapaesana»22. Rimane sorpresa della propria noncuranza per tutto ciò che è autenticamente africano - atteggiamento che non stupisce il lettore, ormai abituato alle espressioni di disprezzo disseminate nel libro galvanizzata com’è dai lavori di costruzione dell’impero, che esercitano su di lei un fascino irresistibile. Il primato della lunghezza del viaggio, anche se non della durata, di Louise, è offuscato da un altro viaggio solitario: a bordo di una Dodge coupé, con un equipaggiamento di sole apparecchiature fotografiche, la 101 Carla Ghezzi giornalista e fotografa Ruth Ricci Eltse, che conosce il territorio per esservi stata crocerossina nella guerra italo-etiopica, percorre 13.000 miglia nell’Etiopia conquistata: «Five glorious months of vagabonding from the Red Sea to the Blue Nile, from the Kenya Colony to the Sudan, from Lake Tana to the Indian Ocean»23. Nelle due sole pagine di premessa al libro fotografico Ruth, come Louise, esalta i contrasti di questa parte del continente, «glamorous and terrifying at one and the same time … lovely yet desolate, wealthy yet barren» per potere a sua volta intonare l’inno incensatore dell’opera italiana, che ne ha fatto un paese in pieno rigoglìo. Con due differenze: qui le immagini, lì le parole, qui un’attenzione per la gente comune - quella che l’impero lo costruisce sotto il sole, talora al fianco degli indigeni - lì la riverenza, scontata, per il Duce, associata alla piaggeria per le autorità coloniali (Lessona e Badoglio) che si trasformano in esaltazione per il maresciallo Graziani. Anche la moglie dell’ex-viceré viene lodata per gli abbellimenti apportati agli arredi di Villa Italia, dei quali beneficia l’attuale viceré, il duca d’Aosta, che vi risiede «senza la sua Augusta Consorte»24. Il viaggio solitario, anche se non più l’avventura, accomuna Louise e Ruth a una donna che attraversa l’impero lasciandosi precedere dalla fama del proprio padre, Pietro Felter25. Alba Felter Sartori è una fascista di provata fede, che compie il viaggio per rendere omaggio alla memoria paterna e per recuperarne gli oggetti che gli erano appartenuti, ma soprattutto per testimoniare l’epopea dell’Italia nella terra africana da poco assoggettata26. Il suo amor di patria è tale che si duole persino per il suo aspetto fisico, non all’altezza delle aspettative dei connazionali che, relegati da molti mesi ai confini dell’impero, avrebbero tratto grande beneficio dall’incontro con una donna avvenente. Il registro intimistico è il meno consentaneo alla cifra del regime, che ha sempre privilegiato i toni alti, ritenendoli più persuasivi. Con la perdita delle colonie, in molti italiani d’Africa l’intento elogiativo del fascismo perdura, ma si acquisisce una sensibilità diversa: vi è quindi, almeno nella forma, un rifiuto della veemenza e un ripiegamento sul rimpianto. I brevi scritti di Laura Nicoli, moglie del residente di Addi Quala Fabio Roversi Monaco, sono significativi di questa inversione di tendenza27. Laura non manifesta direttamente il rancore per gli inglesi invasori: preferisce piuttosto attribuirlo a Seium Cassa, interprete di ruolo presso la residenza di Addi Quala, rimasto fedele al governo italiano e per questo inviso ai successori, che gli comminano una pena di tre anni di prigione; e a un ufficia102 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia le piemontese, amico della famiglia Roversi Monaco, che optò per alcuni mesi di cella di punizione in un campo di prigionia inglese per non essersi sottomesso all’ordine di non salutare con il saluto romano. Né accenna alle traversie seguite alla caduta dell’Aoi, al ritorno nella patria devastata dalla guerra: solo in uno scritto intitolato Appello (A Carlo), datato Monferrato, autunno 1944, allude a «quattro anni di dolore [ quattro? Non sappiamo…]»28. In La casa in Africa, che possiede una nitida eleganza intellettuale e di scrittura, lo sguardo indugia su cose, luoghi, paesaggi e l’udito percepisce i rumori, soprattutto quelli notturni. Tutto viene recuperato sul filo della memoria, delle cui attenuanti gode il passato, rispetto alle asprezze del presente: la dolcezza del vivere, la nostalgia di grandi ideali, l’inno alla vita separata dal resto del mondo, l’attenzione ai sentimenti e alle cose piccole e tenere, le semplificazioni aneddotiche riproducenti la dimensione quotidiana. La casa di Addis Abeba, «sempre aperta al vento e alla luce», dove «tutto è leggero, […] crepitante in un immaginario incendio di luce»29, più che un’immagine reale appare una creazione dell’anima, un luogo mitico della geografia poetica e sentimentale di Laura. L’Etiopia è nel cuore di chi vi ha vissuto e poi, costretto al rimpatrio, la rievoca come un dove incantato di esilio della memoria; è stata altresì, per tutta la durata della campagna di conquista, un tirocinio patriottico per i ragazzi che dall’Italia ne seguivano le sorti attraverso i comunicati dell’Eiar e una crescente campagna d’informazione. Una quinta classe elementare femminile di Genova annota su un diario, sotto l’occhio vigile della maestra, le operazioni di guerra, dalla rivincita di Adua (6 ottobre 1935) fino alla proclamazione dell’ «impero di civiltà che il popolo italiano feconderà con il suo lavoro e difenderà contro chiunque con le sue armi» (9 maggio 1936)30. Il quaderno di Sandra, depositato presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, presenta elementi di interesse diversi fra loro anche per il lettore comune: la grafia regolare - che risente dell’insegnamento di calligrafia impartito all’epoca - è poco più che infantile, come la prosa, ancora un po’ impacciata in alcuni passaggi sintattici. Ma è impressionante vedere come una bambina di dieci anni abbia completamente assorbito lo stile della retorica di regime. C’è un richiamo quasi ossessivo alla civiltà, contrapposta alla «barbaria», alla missione civilizzatrice dell’Italia nel mondo - che ha dato origine alle «inique» sanzioni impostele da molti paesi - all’eroismo dei soldati, ai più valorosi dei quali Sandra dedica paginette vibranti di amor patrio. Anche l’apertura della sorpresa dell’uovo pa103 Carla Ghezzi squale, con la scoperta di un soldatino di latta, si risolve in chiave patriottica: «Allora come in una nebbia mi apparvero i soldati che combattevano e spargevano il loro sangue nelle arse e barbare terre d’Abissinia per la gloria della mia Patria» (13 aprile). In una pagina (18 aprile) in cui è evidente il ricorso ad aiuti familiari la penna zelante della maestra annota «Lavora da te»: ma è un contributo di poco conto, si parla della distribuzione di certificati di pensione a lavoratori e a invalidi e si annuncia l’ottavo censimento della popolazione. Sandra non ha bisogno di essere guidata, ha bene assorbito i principî sottesi alla campagna di conquista e li esprime come certamente ha sentito e letto, in famiglia, a scuola, nelle adunate delle piccole italiane: «le forze armate dell’Italia Fascista animate da incontenibile volontà di vittoria […]», a proposito della battaglia dell’Amba Aradam (tra il 14 e il 20 febbraio); «Grandi ore corrono per i cieli della patria» (2 marzo) [seconda battaglia del Tembien]; e finalmente, in un tripudio di bandierine, di «W il Re! W il Duce! W Badoglio! W Graziani!», la vittoria: «Pare un sogno, invece è una smagliante realtà» (5 maggio 1936). Passano sei anni, la bambina è diventata una ragazza di diciassette anni, iscritta all’Istituto magistrale «R. Lambruschini» di via Bertani. È l’ottobre 1942 e Genova, «dissacrata fino in fondo, giace sconvolta in macerie sotto una serie di notturni bombardamenti a tappeto»31. Per la famiglia di Sandra, il cui negozio è andato completamente distrutto, incombe un trasferimento a Parma, necessario per ricominciare a vivere, e urgente per lei, per potere iscriversi all’anno scolastico 1942-43. Ma prima della partenza, sente di dover compiere un rito: il recupero, nella scuola bombardata, del grembiule, che ritrova, miracolosamente intatto, insieme con gli altri «tutti in fila, impolverati e beffardi […]. Sembrano sull’attenti, avanzi di fantocci neri in un mondo che sta per crollare»32. Sgomenta, Sandra intuisce, ancora non adulta ma non più bambina, di avere fino ad allora amato la patria soltanto a parole. La guerra immaginata come una parentesi breve da combattersi in luoghi lontani è sotto i suoi occhi, con il suo carico di devastazione, e quando, meno di un anno dopo, ogni adulto sarà chiamato a operare una scelta di campo la sofferenza diventerà tragedia. «Sembra che la terra si sia aperta per incanto a dare un senso di bellezza e di pace a questo covo di briganti»33. Di nuovo la contrapposizione razza/natura è funzionale alla giustificazione dell’aggressione dell’Etiopia, perché era iniquo il godimento di tante risorse da parte di un popolo barbaro. L’assunto, non nuovo nella pubblicistica di regime, si inserisce in 104 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia un’alternanza di descrizioni e di affermazioni contrapposte in cui dispiace vedere una bella capacità di scrittura appiattita sulle equazioni eroismo bianco/indolenza nera, pulizia bianca /sudiciume nero, lealtà bianca/ disonestà nera. Maria José, all’epoca principessa di Piemonte, è la dedicataria del diario di Maria Giaconìa Landi, che prende le mosse dal servizio prestato dall’autrice in qualità di crocerossina presso l’ospedale militare di Caserta a partire dal 1° febbraio 1936, seguito da quello presso l’ospedale coloniale «Regina Elena» di Asmara e nell’ospedale «Vittorio Emanuele III» (ex-svedese) di Addis Abeba e si conclude il 29 ottobre con il rientro in Italia. Al di là di alcune iperboli stilistiche - «militari nell’animo, donne nel cuore!» oppure «la veste bianca, che ci avvolge nella sua purezza ideale […]» - il libro testimonia un grande impegno nell’adempimento del dovere e una sincera partecipazione alla sorte degli ammalati, la cui riconoscenza è il «saldo» di una giornata di lavoro, che ripaga della fatica e dà l’illusione del «grande amore di una grande comunità»34. Maria Giaconìa si sente una piccola parte di un grande progetto di «giustizia» e di «civiltà» e, in occasione dell’ingresso delle truppe italiane in Addis Abeba, dichiara di non avere perduto mai «la fede di vera italiana»35. Con il trasferimento da Asmara alla capitale etiopica il registro narrativo si fa più serrato, elogiativo della nostra presenza nel territorio non ancora completamente assoggettato; il percorso Dire Daua-Addis Abeba si delinea pieno di emozioni: la linea ferroviaria, resa inagibile dai ribelli abissini, è stata riattivata da poco e la divisione «Tevere» è dislocata lungo tutto il percorso a difesa dagli attacchi dei nemici, il cui numero è stimato in circa 4.000-5.000 uomini. Tra i passeggeri del treno c’è il giornalista Mario Appelius, che godette di una grande fama durante il ventennio36; a fare gli onori di casa all’ospedale italiano della capitale, in funzione dal 1935, c’è il dottor Edoardo Borra, che per nove anni ha svolto in Etiopia le funzioni di medico del negus, godendone la fiducia anche dopo l’inizio delle ostilità37. Gli eventi si susseguono: la fucilazione dell’abuna Petros, «che fomentava disordini», la sottomissione di ras Sejum, la «battaglia di Addis Abeba», con 35.000 uomini guidati da ras Immirù schierati a cinque giornate di cammino dalla capitale, mentre all’interno dell’ospedale si prosegue «la battaglia contro le ferite e le malattie»38. L’abnegazione di Maria Giaconìa, «fulgido esempio di nobile virtù femminile», è premiata con la croce di guerra per avere continuato per due giorni e due notti «nella alta nobile missione», nel corso di un attacco sfer105 Carla Ghezzi rato da ribelli sulla capitale, «noncurante delle raffiche di fucileria e di mitragliatrici che si abbattevano vicino»39. L’«eroismo in divisa» al femminile dell’apogeo del fascismo ha lasciato scritti di memoria con cifre stilistiche sostanzialmente omogenee, in cui l’amor di patria, confuso con l’esaltazione per il regime, spinge a contrabbandare per missione di civiltà una guerra di aggressione condotta con tutti i mezzi40. A guerra in Africa conclusa, alcune crocerossine danno voce ai passeggeri delle navi bianche e, nel farlo, ne esaltano «la compattezza di un livello spirituale forte, cosciente»41. La gente comune, già pronta a far ritorno in Africa per farvi valere i propri diritti, è convinta del fatto che all’inizio della campagna etiopica, «il [suo] diritto era ideologia espansionistica, l’affermazione di una necessità economica; era un diritto umano di volontà ed audacia. Oggi, è un diritto dello spirito, conquistato dalla sublimazione della sofferenza»42. Nel 1937 la marchesa Irene di Targiani Hermann Giunti, succeduta nel 1921 alla dimissionaria duchessa Elena d’Aosta nella carica di delegata generale della Croce rossa italiana, dà alle stampe un libro elogiativo della «sorella» Maria di Piemonte, che due anni dopo, dalla stessa duchessa d’Aosta, avrebbe ricevuto le consegne della carica di ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Cri43. La «bianca milizia» si fregia della presenza continuata tra le sue file della bella principessa per un lungo periodo - dal 26 marzo all’11 maggio 1936 - al termine di un corso per «lo studio e l’assistenza alle malattie tropicali», promosso dalla clinica per le malattie tropicali e subtropicali dell’Università di Roma, diretta dal prof. Aldo Castellani, benemerito di quel settore disciplinare44. Abolito ogni protocollo, senza seguito, con la sola compagnia delle altre volontarie, Maria José si imbarca a Napoli sulla nave-ospedale «Cesarea», che la condurrà in visita agli ospedali di Massaua, Asmara, Mogadiscio e Chisimaio. Alla principessa, che vanta una speciale preparazione per l’assistenza in camera operatoria, viene affidato a bordo il reparto di chirurgia settica, all’interno del quale esplica tutte le mansioni affidate alle infermiere. Quando sulla nave si diffonde la notizia della presa di Addis Abeba anche la marchesa si lascia contagiare dall’empito patriottico e immagina che per i soldati d’Italia avere vissuto questo momento accanto alla loro principessa, che un giorno sarà imperatrice, «è aver vissuto una vita!»45. Al termine dell’esperienza africana Maria José segue un corso di specializzazione in sala operatoria presso l’ospedale militare di Napoli, conseguendo il diploma 106 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia di grado superiore46. Dunque neanche la nobiltà, che per educazione dovrebbe praticare la virtù dell’antiretorica, riesce a non essere contagiata dal delirio per il trionfo della civiltà contro la barbarie. In realtà ancora negli anni Trenta per la donna – nobile o borghese – la scrittura autobiografica è ancora essenzialmente uno strumento di ricerca e di affermazione identitaria: l’esaltazione del destino di Roma imperiale è per alcune soltanto un’occasione per testimoniare la propria esperienza oltremare, e quando, come nei casi illustrati fin qui, questa si è realizzata non al riparo di una presenza maschile, l’intento autocelebrativo è inevitabile. Come inevitabile è il ricorso a una prosa ridondante, in cui c’è un continuo rinvio dalla figura umanizzata di Roma alla vestale che ne tutela i valori e li divulga attraverso la scrittura. C’è anche chi assurge a «fulgido esempio di romana virtù delle donne d’Italia» - per cui viene insignita di una medaglia di bronzo al valor militare alla memoria - senza averne la consapevolezza e, meno che mai, avuta l’aspirazione47: la consacrazione viene in questo caso dalla morte - che di eroico a dire il vero non ha molto - e che invece verrà spesso accostata dalla pubblicistica di regime a quella di Maria Boni Brighenti, la prima donna decorata con la medaglia d’oro al valor militare alla memoria per il ruolo svolto nel ripiegamento di Tarhuna, nel territorio tripolitano, nel giugno 191548. Lydia Maffioli, moglie dell’ingegner Cesare Rocca, direttore del cantiere della Gondrand di Mai Lahla, nei pressi di Adua, dedicataria del volume della crocerossina in Africa orientale Maria Corazza, da semplice vittima di un eccidio in zona di operazioni di guerra viene trasfigurata in simbolo dell’amore votato al martirio della donna bianca, italiana soprattutto. La sua biografia ufficiale probabilmente ad arte è rimasta povera di dettagli per essere traghettata nell’Olimpo degli eroi circonfusa di leggenda: era nativa della val Formazza, nell’alta val d’Ossola, viveva a Novara, non aveva figli, ricopriva un ruolo di prestigio in una delle organizzazioni femminili del partito, aveva raggiunto da un mese in Etiopia il marito. Questi, brevemente, i fatti: all’alba del 13 febbraio 1936 un reparto di un centinaio di abissini dà l’assalto al cantiere all’interno del quale riposano un’ottantina di operai (il numero delle presenze e, quindi, quello delle vittime, non sarà mai indicato ufficialmente dalle autorità italiane) insieme con Cesare Rocca, sua moglie e l’ingegner Roberto Colloredo Mels. Alberto Pollera, capo dell’Ufficio politico del II Corpo d’armata, giunto per primo sul luogo dell’eccidio, indica in settantaquattro il numero delle vittime 107 Carla Ghezzi italiane e in quaranta quello delle etiopiche. Si apprenderà successivamente che Lydia Maffioli è stata uccisa dal marito, il quale intendeva salvarla dall’oltraggio degli assalitori e che, a sua volta, lui si è subito dopo tolta la vita. Angelo Del Boca, che ha dedicato alla vicenda pagine dense di argomentazioni, rileva come, nonostante il frastuono provocato dallo scoppio di un deposito munizioni e dei colpi d’arma da fuoco esplosi da ambedue le parti, i soldati di stanza nei dintorni, che certamente hanno udito il boato, arrivano sul luogo a strage ultimata 49. La mancanza è imputabile soprattutto al comando militare di zona, che non ha saputo valutare i rischi e predisporre una difesa adeguata degli operai, assimilati dagli abissini a soldati che costruivano strade sulle quali venivano trasportati i rifornimenti bellici necessari all’aggressione50; ovviamente l’impegno non viene profuso nella ricerca e nell’addebito delle responsabilità, quanto in una ricostruzione scritta dei fatti che, inoltrata alla Società delle nazioni, convalidi l’assunto fascista dell’impresa d’Abissinia come di una missione di civiltà contro la barbarie. Con grande rigore viene quindi effettuata la repressione nei villaggi sospettati di collusione con gli autori dell’eccidio: Ennio Flaiano - che con il suo primo romanzo, Tempo di uccidere, in un contesto storico diverso, si addentra nel travaglio interiore del soldato italiano coinvolto in un incontrollabile esercizio omicida51 - riporta nel suo diario un episodio di violenza agghiacciante, che non ha nulla da invidiare a quella di Mai Lahla, avvenuto ad Adi Onfitò, nello Scirè; questa volta il casus belli è fornito dal ritrovamento di alcuni oggetti appartenuti al marito di Lydia52. Le rappresaglie sono rievocate in chiave eroica da Mario Gazzini, volontario in Africa Orientale, che in un testo scritto immediatamente dopo le stragi ammonisce: «i malfattori, i razziatori, i traditori hanno scontato con la vita la luttuosa, dolorosissima aggressione ai nostri avanzati pionieri di civiltà che, come i soldati, vivevano “pericolosamente”, coerenti ai tempi eroici»53. La costruzione del mito procede speditamente: in un altro testo, dal titolo Rielaborazioni fantastiche, lo stesso Gazzini immagina di intervistare M., un operaio del cantiere, scampato all’eccidio grazie allo scoppio del deposito munizioni che lo proietta, con lo spostamento d’aria, a una trentina di metri lontano dal luogo dove ancora infuria lo scontro. Le pause, le reticenze nella narrazione, un registro poco incline all’iperbole, rendono il brano singolarmente efficace, anche se non si sa quanto veridico54. Una narrazione sapiente nelle allusioni e nella creazione di un’atmosfera rarefatta, quasi misteriosa, si ha nel volume di Franco Dani AOI. Rac108 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia conti e disegni, in cui un intero capitolo è dedicato all’eccidio55. E come in Rievocazioni fantastiche il cantiere dopo l’assalto appariva all’operaio sopravvissuto come «un cimitero con le tombe scoperchiate»56, così nel capitolo dedicato a Mai Lahla Franco Dani riferisce di una certa aria insolita, «quasi d’inebetimento» finché «tutto il mio corpo fu come attraversato da una fortissima scossa: voltandomi bruscamente dalla parte che non avevo ancora osservata […] vidi la distesa terrificante di una lunga e doppia fila di cadaveri seminudi e sanguinolenti, appena coperti, in qualche parte, da pezzi di stuoia, da stracci, da vecchie camicie»57. La narrazione, di sicuro meno efficace quando da allusiva diventa descrittiva, e in maniera truculenta, è però una tessera importante del mosaico che si va componendo in onore di Lydia. In tempi più vicini a noi G.T., originario di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, operaio marcatempo nel cantiere, rende a Irma Taddia la sua testimonianza dell’accaduto, confermando la circostanza della morte della donna per mano del marito, dal momento che i ribelli avevano solo fucili e i due coniugi morirono invece con proiettili di rivoltella, avvalorando la versione fornita da Franco Dani quarant’anni prima58. Una vittima muta offerta all’imperialismo coloniale fascista, il quale sapientemente ne manipola la vicenda negli ingranaggi della propaganda, che dovrebbe renderla immortale. Ma ci sono anche drammi femminili che si consumano in silenzio all’interno di una struttura familiare, ai quali il regime non dà voce, ormai spazzato via in Africa dall’avanzata delle forze alleate, nel corso della seconda guerra mondiale. Ferrero Bigiarini, che con fervore di combattente aveva partecipato alla guerra d’Etiopia, rievoca il proprio dramma familiare nelle memorie depositate presso l’Archivio di Pieve Santo Stefano59. La cifra narrativa del suo scritto autobiografico deriva da una sintesi fra la necessità di ripercorrere vicende legate al proprio vissuto e quella di inserire queste vicende in un contesto storico non completamente rinnegato. «Sono passati oltre 30 anni. Io penso, scrivo, narro il mio dolore ma non ne parlo mai con mia moglie. Parlarne in due significherebbe ancora piangere»60. Alla rievocazione del dolore da parte dell’uomo fanno da contraltare il silenzio e la fissità dello sguardo della moglie, che non sa trovare conforto nelle parole. Questo l’antefatto: dopo la campagna vittoriosa del 1935-36 Ferrero si stabilisce con la famiglia ad Addis Abeba; nel giugno 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia, rinuncia all’esonero previsto per i combatten109 Carla Ghezzi ti della guerra d’Etiopia e parte volontario. Ecco allora il ricordo del commiato, del sorriso inconsapevole delle due figlie piccole, di «un abbraccio intenso di mia moglie, sempre ansiosa: ansia rassegnata»61. In un soprassalto di orgoglio lui vede confermate nel comportamento della moglie le virtù della sopportazione e del sacrificio che la accomunano a tutte le spose e madri italiane. Il viso di lei si contrae, gli occhi si arrossano, non una parola viene pronunciata; ma il marito legge nel suo sguardo sentimenti ed emozioni. Nel novembre 1940 Ferrero viene fatto prigioniero dagli inglesi: «Una gioventù sacrificata inutilmente, io prigioniero da una parte, mia moglie con due bambine: di due anni la prima, di pochi mesi la seconda, sbattute in un altro campo di concentramento. Trasferimenti, privazioni, viaggi, addossati come animali, primi mesi: duri, duri di prigionia»62. In un campo di internamento scorge la moglie e le piccole, di nuovo i loro sguardi si incrociano «dicendosi tutto in un fissarsi di pupille». Un soldato inglese solleva la figlioletta più grande, di tre anni, perché lui possa baciarla; con la mano manda un bacio alla moglie e all’altra bambina, di diciotto mesi. «E via. Era l’ultimo saluto. Non l’avrei rivista più. La rivedrò nel mondo dell’aldilà»63. È il 20 gennaio 1942: il convoglio dei prigionieri parte per Dire Daua; di lì, nell’aprile seguente, prosegue per il porto di Berbera, dove viene imbarcato per il Kenya. Una sosta nel campo di Mandera, nel Somaliland britannico, avviene soltanto qualche giorno prima dell’arrivo della moglie e delle figlie. Le lettere della moglie a Ferrero testimoniano la sua odissea con le due bambine: dona il sangue alla figlia minore, spossata dai trasferimenti e indebolita dalla febbre; il 7 maggio 1942, dal porto di Berbera, annuncia l’imbarco sulla nave bianca «Vulcania». Infine, dal «Vulcania», 15 maggio 1942: «due righe sole ti mando perché di più non si può. Due righe terribili perché ho da darti una notizia che non vorresti avere. Non abbiamo più che Silvana. Titti è in Paradiso che pregherà per noi. Baci da Silvana che sta bene»64. Il dolore ha spezzato il silenzio e ha saputo trovare parole di fede e di conforto per il marito, che ha già perduto ogni illusione. La tragedia muta della moglie di Bigiarini propone una storia delle italiane d’Africa da una prospettiva diversa da quella ufficiale; così, attraverso le memorie di un italiano d’Egitto, emigrato da bambino con la famiglia ad Asmara, quindi, nell’ottobre 1939, ad Addis Abeba, emerge un ritratto di donna, Maria Ciucussich, la madre, rappresentata nella quotidianità che si interseca con le vicende della storia d’Italia in Africa: la dichiara110 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia zione di guerra, l’occupazione inglese, l’internamento, l’imbarco sulla nave bianca65. Di nazionalità austro-ungarica come i genitori, nati a Zagabria, Maria si impiega come dattilografa nella natia Port Said presso la succursale del Banco di Roma, dove lavora anche Amedeo Amato. Lo sposa, gli dà due figli. L’autore delle memorie, il primogenito, ricorda il baule bombato, contenente il ricco corredo di nozze non ancora usato, che faceva bella mostra di sé in salotto. La coppia viveva in armonia, pur nella diversità dei caratteri e degli interessi: «Mamy intellettuale, controllata, riservata, incline alla poesia, Papà pragmatico, estroverso, facondo, negato alle arti»66. Maria porta i figli al mare coprendo il viso con cappelli a larghe tese, legge «Mani di fata», cuce da sé i vestiti, lavora a maglia e ricama, suscitando l’ammirazione delle amiche. Ascolta le poesie che il figlio impara a memoria; lei stessa ama recitare poesie, in La cavallina storna dà il meglio di sé. Il 18 dicembre 1935 - «Giornata della Fede» - con il marito offre la propria fede nuziale e una catena d’oro alla patria, a testimonianza di uno spirito nazionale fortemente radicato nella comunità, nonostante che il primo insediamento italiano in Egitto risalga ormai a un secolo prima. Amedeo dalla fine degli anni venti è tenente di complemento dell’esercito e capo-manipolo della Milizia; Maria, al contrario, non si lascia contagiare dal fervore per il fascismo. La serenità familiare è bruscamente interrotta dal fallimento di un’impresa finanziaria del padre il quale, assunto dalla ditta Gondrand, viene destinato con mansioni di capoufficio spedizioni, trasporti e turismo ad Asmara. Dopo un anno e mezzo avviene il trasferimento ad Addis Abeba, dove Maria riprende sapientemente l’ordito della vita familiare, perché tutto si ricomponga senza lacerazioni. Anche il pasticcio di maccheroni con il ragù di carne e i piselli, reminiscenza di Port Said, torna a essere una consuetudine. Lo scenario cambia bruscamente con l’entrata degli inglesi nella capitale, il 6 aprile 1941: Maria con i figli si trasferisce per un anno al vecchio campo della Gondrand, mentre Amedeo il 1° gennaio 1942 lascia Addis Abeba per Dire Daua, da cui verrà trasferito per essere imbarcato alla volta di un campo di prigionia in Kenya. La loro casa al campo nuovo della Gondrand è saccheggiata dagli etiopici, che vi si insediano definitivamente67. Il 9 maggio, dalla stazione di Addis Abeba, comincia per Maria e i figli il difficile viaggio - di ritorno, o non piuttosto di andata? - verso l’Italia; 111 Carla Ghezzi con sé hanno poche cose, ma lei non se ne dà cura. Quando la motonave «Giulio Cesare» approda a Napoli il 28 giugno, dopo trentacinque giorni di traversata, Maria decide di proseguire per Genova: lo Stato italiano, infatti, garantisce l’albergo nel porto di sbarco, più tre mesi di vitto e alloggio ai rimpatriati che in Italia non hanno nessuno. La scelta del capoluogo ligure non è casuale: è la città più vicina a Milano, dove ha sede la Gondrand e dove la vita può forse ricominciare. Anche nel contesto migratorio la vita della moglie di Ferrero Bigiarini e di Maria Amato, come quella di molte donne maritate, si risolve all’interno delle mura domestiche, intorno al lavoro di casa, all’amore coniugale e materno; all’uomo spetta un ruolo dominante che soltanto eventi straordinari - la guerra, il rimpatrio per le donne e i bambini, la prigionia per gli uomini - annullano temporaneamente. Nel rapporto di coppia si assiste a una specie di livellamento sociale per il quale la borghese, la contadina, la nobile, sono equiparate in un ruolo di subalternità. Marta Majone Padovani rappresenta un’eccezione nel quadro accennato fino a qui: il suo volume di ricordi, pubblicato a più di venticinque anni di distanza dal rimpatrio in Italia, è la storia di una famiglia italiana emigrata in Etiopia, ma è soprattutto la testimonianza di una donna forte, che ha consapevolezza del ruolo svolto in una congiuntura politica tumultuosa - nella colonia appena conquistata - del quale vuole lasciare un’impronta68. La scrittura autobiografica rende conto di uno spaesamento che dopo tanti anni pesa ancora sull’anima e che il velo della finzione narrativa e dello pseudonimo attenua solo parzialmente. Nel romanzo la protagonista, Magda, madre di cinque figli, sul finire del 1937 raggiunge ad Addis Abeba il marito, che intende impiantare un mulino e un pastificio nella nuova colonia. Nella coppia esiste un’ intesa affettiva che non ha riscontro sul piano professionale: Ruggiero tende ad accontentarsi di risultati mediocri, mentre Magda ha come obiettivo la creazione di una vera e propria industria molitoria che garantisca il futuro dei figli. È inflessibile con la manodopera indigena, con la quale non ha difficoltà a lavorare, pur avvertendo un acuto disagio a causa «di quei selvaggi che svelavano, anche nel lavoro, quanto la loro razza fosse primitiva»69. La sensazione degenera in terrore in occasione di un attacco degli shifta, in cui gli operai dell’azienda «ridiventano i combattenti della conquista dell’Impero» per soccorrere i militari e gli avanguardisti rimasti a fronteggiare i ribelli70. 112 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia L’orgoglio imperiale è ben radicato nella coscienza di Magda/Marta, che ovunque osserva compiaciuta «il segno tangibile dell’opera italiana»: nella «febbrile attività pubblica» della capitale, nell’architettura moderna e razionale, nelle vetrine «ricche, belle ed eleganti come quelle dei negozi delle grandi città italiane»71. Quando la minaccia della guerra si fa più insistente, all’azienda affluiscono migliaia di quintali di grano, che Ruggiero e Magda giorno e notte sottopongono a pesatura prima dell’immagazzinamento. Un colonnello della Finanza, in visita all’azienda, indaga sulla disponibilità della donna a fare esperimenti di miscele di cereali, allo scopo di ridurre il consumo del grano da parte della popolazione bianca. Un altro colonnello, che guida una rappresentanza di funzionari del governo generale al pastificio, la fa oggetto delle sue galanterie, per nulla disturbato dalla novità che a illustrare le potenzialità dell’azienda sia una donna. La dichiarazione di guerra dell’Italia, il 10 giugno 1940, ha fra le prime conseguenze il contingentamento della benzina e della nafta e il timore del blocco del trasporto marittimo. Per l’azienda, che attende dall’Italia l’arrivo dei macchinari e che, per funzionare a pieno ritmo, deve contare su approvvigionamenti regolari di forza motrice, è un colpo duro: «Avevamo speso, per mettere su quell’industria, tutto il capitale portato dall’Italia e tutto il guadagno di tre anni di lavoro in Africa»72. Il pastificio non gode purtroppo degli appoggi del Governo generale, necessari per ottenere assegnazioni di carburante; incombe anzi la minaccia della restituzione del terreno, su cui sorgono gli edifici dell’azienda, al legittimo proprietario etiopico cui fu confiscato all’epoca della conquista. Magda tenta allora di far pervenire un pro-memoria sull’azienda al viceré, interponendo i buoni uffici di una crocerossina, la baronessa Maria Teresa Motta d’Albonia, amica della duchessa d’Aosta, Anna d’Orléans. Gli eventi precipitano: il terreno su cui è impiantata l’azienda, a circa dieci chilometri dalla capitale, è giudicato indifendibile dagli attacchi dei ribelli e come tale è abbandonato da molti operai italiani, che riparano ad Addis Abeba. Per i pochi superstiti lei appresta il pranzo del Capodanno con la «tovaglia delle grandi occasioni quasi come un rito propiziatorio»73. Attorno alla tavola è riunita la famiglia, insieme con la domestica e gli operai rimasti fedeli: ma a occupare la mente di Magda non è il momentaneo livellamento sociale, quanto il numero dei commensali - tredici - che la sua superstizione giudica intollerabile. Un avvicendamento alla tavola fra lei e la domestica, inavvertito dagli altri, solleva le sorti di una serata che deve 113 Carla Ghezzi comunque riuscire, anche se fuori rimbomba un colpo di fucile. La disfatta si percepisce ormai come inevitabile e sempre più evidente si manifesta la disorganizzazione dell’esercito, il contrasto di questo con la Milizia, il disagio dei «valorosi ufficiali che soffrivano già l’umiliazione dei vinti»74. Obbedendo a un disperato istinto di difesa Ruggiero e Magda si ritrovano, soli, a presidiare di notte l’azienda. A un ufficiale inglese che, dopo averne ispezionato i locali e le apparecchiature, propone di avviare di nuovo la lavorazione del grano per le truppe sudafricane, la coppia oppone un rifiuto. Identica risposta ottiene subito dopo la moglie dell’etiopico già proprietario del terreno confiscato dagli italiani, che si è presentata allo stabilimento affermando di avere preso accordi con le autorità britanniche per la ripresa dell’attività, offrendo a Ruggiero di lavorare alle sue dipendenze. La situazione si è spinta a un punto tale che lui decide di lasciare Addis Abeba con gli «indesiderabili», definiti tali dagli inglesi. Senza lasciare trasparire l’emozione, Magda prende commiato da un sogno realizzato giorno per giorno, assecondando un’esigenza creativa, e assumendosi al contempo la piena responsabilità di ogni iniziativa. Queste considerazioni sono indotte anche dalla vicinanza, il giorno della partenza alla volta di Gibuti, con coloro che Ruggiero identifica come «i veri artefici della nostra disfatta: alti gerarchi, elevati funzionari statali che, sistematicamente, intralciarono l’iniziativa privata, la casta chiusa che, giorno per giorno, inesorabilmente, fece opera disfattista […]. Per costoro l’Africa aveva rappresentato soltanto il trampolino di lancio per raggiungere più presto scalini gerarchici più alti […]. Niente li legava a quella terra!»75. Per Magda e Ruggiero, invece, l’Etiopia avrebbe dovuto essere la nuova patria. Nel tragitto da Dire Daua a Hargeisa Magda ha un nuovo sussulto di amore patrio nel vedere la strada asfaltata, frutto del «tenace lavoro italiano», quindi, giunta nella piana della città del Somaliland, prorompe orgogliosamente: «Questa zona è rimasta selvaggia e abbandonata come quando apparteneva agli indigeni. Invece gli italiani, in meno di cinque anni, erano già riusciti a trasformare l’Etiopia!»76. Dopo oltre un anno di stenti per l’internamento e di disagi per i trasferimenti attraverso l’Etiopia e il Somaliland, finalmente una bella nave italiana, la«Giulio Cesare», accoglie la famiglia per ricondurla a casa. A bordo Magda guarda l’Africa allontanarsi e prova sentimenti contrastanti: felicità, per avere con sé il marito e il figlio maggiore, scampati alla prigionia inglese; dolore, per essere stati costretti ad abbandonare il frutto del loro la114 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia voro; vergogna, per essere stati cacciati da quelle terre strappate alla «barbarie»; ira nei confronti dei vincitori, che dal tradimento di pochi vili hanno tratto la loro vittoria. Compiuto il periplo del continente, doppiato lo stretto di Gibilterra, gli inglesi lasciano la nave che fa rotta verso l’Italia: il piccolo battello che si allontana rapidamente appare a Magda e a Ruggiero un presagio di libertà. Anche se proteggendosi con uno pseudonimo e optando per il genere del componimento narrativo piuttosto che per la formula più esplicita del racconto autobiografico, Marta Majone Padovani manifesta l’urgenza di lasciare una traccia di sé, al di fuori dell’ambito familiare, in un contesto che è singolare anche per il fatto di averla posta su un piano di assoluta parità con il marito. Come lei, Olga Corsini Olsoufiev e Anna Maria Mòglie testimoniano, specularmente, il versante intimo e quello pubblico o semipubblico della sconfitta, affrontata perlopiù in solitudine, senza l’appoggio dei rispettivi mariti, prigionieri degli inglesi in Etiopia e poi in Kenya77. Già nella presentazione che Leonida Fazi fa del diario di Anna Maria c’è la consueta mistificazione del ruolo femminile; un lascito del regime, caduto ormai trentacinque anni prima, evidentemente duro a morire: «la donna che del soldato fu ombra e angelo». La figura che emerge dallo scritto di memoria è piuttosto quella di una «borghese […] eroica senza fanfare né medaglie»78, che ha lasciato sì il cuore in Italia, ma che vive con l’eccitazione dei vent’anni il primo mese di matrimonio, la prima separazione dai genitori, la scoperta di «un paesaggio mai immaginato» - all’ingresso nel canale di Suez - con l’illusione che il bel sogno africano avrà una durata breve: diciotto mesi, quanti ne prevede il contratto di permanenza in colonia sottoscritto dal marito, impiegato di banca. La visita di Asmara, «con aspetto coloniale», «tutta bianca, pulita, gradevole», la rassicura, rammentandole certi paesaggi della provincia italiana, mentre a Gibuti il «primo impatto con i neri è disastroso»: «I neri mi intimoriscono […] la mia ripugnanza è invincibile»79. Lo stesso orrore suscitano in lei le donne, che le appaiono più sporche degli uomini; soltanto i bambini le ispirano compassione, perché nel loro sguardo intravede tutte le avversità della vita. Eretto rapidamente uno steccato fra sé e gli indigeni, che si vede costretta ad assumere al proprio servizio, anche perché capaci, premurosi e di scarse pretese, tanto da meritare poi il suo rispetto e la sua stima, la «ragazza di famiglia sempre vicina ai genitori, studio e casa»80 può finalmente immergersi nella vita della società coloniale di Dire Daua; la città le appare «delizio115 Carla Ghezzi sa, bianca, pulita»; la villetta di cui lei e il marito occupano il piano terra ha una veranda e un giardino che, sottoposto a cure sollecite, potrà diventare degno del suo nome; i mobili sono semplici e gradevoli. «Non vedo l’ora che arrivino i bagagli con tutte le mie belle cose e la renderò una reggia. Ci siamo portati tutto, corredo, materassi, regali di nozze, persino le posate d’argento»81. Non si può che convenire con Angelo Del Boca che, nel suo Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’impero, vede nel diario di Anna Maria uno strumento di comprensione dell’«ascesa sociale della donna italiana in Aoi»82. Pochi anni dopo, quando l’epopea italiana in Etiopia è ormai conclusa, quegli stessi materassi, arrotolati, diventano il simbolo della disfatta: «20 febbraio 1942. Vedo portare via le mie casse, i miei bauli, le valigie, il mio corredo, i miei regali di nozze. Mi impongo di essere forte, di non farmi prendere da sentimentalismi, ma ecco ritornare due neri, cercare ancora. Vedono i miei materassi celesti, ancora nuovi: li arrotolano, se li mettono sulle spalle e se ne vanno soddisfatti. Non so perché, ma il vedermi portare via i nostri materassi mi ha fatto crollare: sono scoppiata in un pianto irrefrenabile, sconsolato e disperato. Ho perso proprio tutto»83. Ma tra la fine del 1938 e i primi mesi del 1939, quando lo scoppio della seconda guerra mondiale è ancora soltanto uno spettro per i due genitori in ansia per la sorte della figlia, Anna Maria vuole vivere intensamente la sua avventura «esotica»: tennis, scambi di inviti, serate, battute di caccia, gite, partite a carte. «Qui si fa una vita tipo villeggiatura; si esce, si combinano pranzi, si fanno gite»; e ancora: «Alcune volte penso che una vita così varia, divertente e particolare forse in Italia non si farà più». È quindi consapevole dei privilegi che la vita in colonia offre - difficilmente riproponibili nella madrepatria - e risoluta a non rinunciarvi84. All’annuncio della mobilitazione generale, nel maggio 1940, il marito viene richiamato; la dichiarazione di guerra dell’Italia, il 10 giugno successivo, vede Anna Maria ancora bisognosa della presenza del marito, al punto di rifiutare il rimpatrio predisposto dal governo della colonia per le donne e i bambini. A sorreggerla è l’amore per lui, la certezza della breve durata della guerra e della possibilità del ritorno congiunto in Italia, ma dispera della propria capacità di fronteggiare «cose più grandi di me»85. Separata dal marito, costretta a riparare a Harar insieme con altre sfollate, trova nell’attaccamento e nella difesa strenua della «roba» una sorta di antidoto allo sconforto. L’angoscia e le miserie di pochi mesi di guerra la inaspriscono 116 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia senza corromperla: così, al colonnello che, dopo averle assicurato una licenza natalizia per il marito, con un sorriso ammiccante la invita a casa sua per un tè, risponde seccamente di rinunciare alla licenza. Con la caduta di Harar, Addis Abeba e Asmara in mano inglese, all’incertezza subentra il sentimento di ammirazione per le sacche di resistenza che ancora vengono opposte al nemico, prima fra tutte quella del duca d’Aosta sull’Amba Alagi, che si conclude l’8 maggio 1941. Il 27 novembre, con la caduta di Gondar, ha termine la guerra in Etiopia. Alla paura dei bombardamenti subentra quella più sottile e pervasiva dei neri, dai quali si paventa ogni sorta di violenze, soprattutto dopo la partenza della polizia italiana, che avrebbe dovuto difendere la popolazione bianca da eventuali aggressioni (21 aprile). Contemporaneamente ha fatto il suo ingresso trionfale a Harar il figlio del negus; l’incubo è diventato realtà: «Ora sono i neri che ci comandano»86. «Dall’occupazione di Addis Abeba al mio ritorno in Italia. Aprile 1941. Addis Abeba è stata dichiarata città aperta. Le truppe hanno lasciato frettolosamente la città in questi ultimi giorni. […] 3 aprile. Alle 1,40 nasce mia figlia Caterina»87. Già nell’incipit il diario di Olga testimonia non la necessità di derogare al potere dell’angoscia, come avviene per Anna Maria, o quella di lasciare un segno del proprio passaggio in colonia, come è per Marta: per la nobildonna russa la scrittura autobiografica, anche in situazioni di pericolo o di grande disagio, si risolve in una registrazione contabile di vicende personali inserite in quelle drammatiche dell’Etiopia sottoposta all’amministrazione militare britannica. Nel suo diario sono assenti le descrizioni di sentimenti e di stati d’animo: Olga sceglie di affidare la caratterizzazione delle persone a pochi tratti essenziali, senza attardarsi nella descrizione di quello che sentono, ma mostrandolo attraverso le azioni. Fa così anche con se stessa, e con suo marito, cui dedica non molte righe, dalle quali non traspare una grande emozione, come tanto di frequente avviene nel diario di Anna Maria. Con uno stile spoglio, innervato di una buona dose di ironia leggera che la tiene lontana dai rischi dell’autocommiserazione e grazie a una sottile sensibilità nel raccontare i drammi minimi in cui si riflettono le massime tragedie, ogni dettaglio, anche il più irrilevante, porta il sigillo dei grandi eventi pubblici. Anna Maria e Olga sono protagoniste degli stessi universi geografici, ma i loro universi narrativi sono molto lontani, proprio perché a Olga sembra mancare il «movente» della scrittura: scrive e basta, dosando sobrietà e rigore, senza drammatizzare, 117 Carla Ghezzi evitando le trappole della banalità o dell’esibizionismo. Il racconto dell’oltraggio alla bandiera italiana ammainata davanti al Ghebì da parte del capo del Political Office, colonnello Dallas che, mutilato di una gamba, l’ha calpestata con la sua stampella, suscitando la reazione del capitano di fregata Mario Zambon, che chiede e ottiene che la bandiera venga issata di nuovo e poi ammainata con i dovuti onori, appare a Olga un deviamento dalla cifra dell’understatement a lei più consentaneo; puntualmente l’indomani, 7 aprile, annota: «Esco dall’ospedale con la neonata, sul mio calesse. Il cocciuto vecchio cavallo Pallino è felice di poter finalmente tenere la sinistra»88. Nata a Firenze nel 1912 da una famiglia insignita del titolo comitale dallo zar Alessandro II soltanto nel 1856 - i cosiddetti «nuovi conti» - Olga Vassilievna Olsoufiev sposa nel 1937 il marchese Giovanni Corsini dei principi di Sismano, discendente sia per parte di padre che di madre da due fra le più insigni famiglie toscane di antica nobiltà; sul finire di quello stesso anno il marito emigra in Etiopia, per dirigere un’azienda di legname, progettata in società con un ex-collega d’Università. Nel febbraio 1938 Olga dà alla luce a Mentone il primogenito Giovanni, ma raggiunge Vanni, il marito, ad Addis Abeba soltanto un anno e mezzo dopo. Nel frattempo la Saile - Società anonima italiana legnami Etiopia - si consolida ed espande la propria attività con la costruzione di nuove segherie, l’apertura di piste per l’esbosco e tagli di bosco, che occupano circa 2.000 operai indigeni. Alla dichiarazione di guerra le segherie vengono decretate «ausiliarie» dopo la revoca dell’ordine di mobilitazione generale che aveva provocato la paralisi del paese - e il marito può riprendere l’attività. Ma le segherie, che avevano intensificato la produzione per far fronte alle esigenze militari, sono ubicate in zone in mano ai ribelli, fatte segno, quindi, ad atti di violenza, anche omicida. A fine marzo giunge l’ordine di abbandonarle perché dichiarate indifendibili e Vanni fa in tempo ad assistere all’occupazione di Addis Abeba: «E lì, insieme con altri 10.000 seminquadrati e semiarmati, fui spettatore della tragica farsa dei pochi baldanzosi nemici che entrarono la mattina del 6 aprile ad occupare la città. Tre giorni prima […] mia moglie aveva dato alla luce una bambina tutta oro, rosa ed azzurro: cominciava il calvario dei vinti»89. Il racconto dell’occupazione inglese dell’Etiopia nel diario di Vanni Corsini, pur se anteposto nel libro a quello di Olga, si legge di riflesso: per i suoi empiti retorici, i suoi intenti autoreferenziali e la sua proclamata fe118 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia deltà a ideali che gli orrori della seconda guerra mondiale non ha scalfito, e che sono ancora vivi nel 1956, data della redazione della premessa alle memorie. Per cinque mesi Vanni presta servizio, in qualità di interprete e segretario, nel Comitato centrale italiano incaricato di tenere il collegamento con il Comando di occupazione, dove anche Olga viene impiegata per la traduzione in inglese di alcune sentenze del Tribunale militare e delle numerose segnalazioni alla Military Police di furti, delitti e reati di ogni genere90; quindi, nel mese di settembre, nell’ippodromo di Addis Abeba, comincia la sua prigionia, che avrà come tappe Dire Daua, Harar, Hargeisa, La Farouk, Mandera. Dal campo di prigionia di Eldoret, in Kenya, progetterà e realizzerà con altri quattro compagni una fuga rocambolesca attraverso il Tanganyika, la Rhodesia del Nord e il Nyassaland fino al Mozambico, cominciata il 10 febbraio e conclusasi il 13 marzo 1943, dopo 2.800 chilometri. Il libro in realtà è stato pubblicato proprio per rendere omaggio a quest’impresa audace - tentata inutilmente da molti prigionieri prima di allora - che all’epoca suscitò anche l’ammirazione e l’ilarità degli inglesi non implicati nella vicenda. Soltanto il protagonista definisce quel successo «una sequenza di banali episodi», percependolo anzi come il preludio di una sconfitta; con amarezza avverte di avere «sognato e complottato invano»91. Rientra in Italia soltanto nel gennaio del 1946, ma già l’anno successivo torna in Mozambico, ove avvia un’attività commerciale, industriale e immobiliare. L’indipendenza del paese lo convince, nel 1976, al rimpatrio. Due donne che affidano al loro diario il racconto dell’incontro con il proprio uomo, da cui sono state separate l’una, Anna Maria, per trentasei giorni, l’altra, Olga, per sei mesi. Il diario di Vanni, che riporta lo stesso episodio del quale è protagonista con la moglie, è un interessante termine di paragone fra i due scritti, perché sembra il prolungamento di quello di Anna Maria, tanto è traboccante di stupore e di ammirazione per le circostanze dell’incontro, e di mal dissimulato desiderio per la moglie; ma c’è anche l’encomio per la donna che ha lasciato due figli piccoli ad Addis Abeba e si è fatta destinare al campo somalo di Mandera come interprete: «Restò un mese ispezionando, brigando, lavorando. Fece valere i suoi privilegi di donna e di crocerossina, la perfetta conoscenza dell’inglese e la sua classe sociale, per affrontare ed avviare a soluzione molti cruciali problemi. Senza curarsene passò fra rivalità, sospetti, simpatie, invidie e calunnie, mi119 Carla Ghezzi rando solo ai risultati»92. Dal canto suo, Olga annota: «Siamo molto felici di ritrovarci dopo 6 mesi […]. Gli do il numero sequestrato dell’ «Ethiopian Star» che tratta dell’accordo fra il Negus e gli inglesi»93. D’altra parte, alla data del 30 settembre 1941, quella della partenza di Vanni e di altri compagni militari e civili da Addis Abeba per la prigionia, ha scritto: »Andiamo a salutarli alla stazione. Molto commovente»94. Alla scrittura controllata, intessuta di reticenze, di Olga, si contrappone il registro narrativo del viaggio di Anna Maria da Harar al campo di Dire Daua, dove il marito è internato. Al volante della camionetta che la accoglie a bordo c’è un ufficiale sudafricano bianco, sui sedili posteriori tre soldati neri. Quando si accorge che la strada che stanno percorrendo non è quella per Dire Daua è troppo tardi: arrivano in un attendamento di «soldati e tanti, tanti neri col cappellaccio» dove Anna Maria, «impietrita», rimane «in attesa di affrontare il mio destino ed invocando la Madonna». L’ufficiale, mosso a compassione da tanto sconforto, la fa risalire sul camioncino e la conduce a destinazione. La scena dell’incontro sembra quella di un film americano degli anni cinquanta: sotto una pioggia battente, il marito fa per correrle incontro, ma ne è impedito da un jambo sudafricano che gli punta contro il mitra. A una distanza di cinquanta metri provano a scambiare qualche parola ma il rumore della pioggia copre le loro voci; all’unica domanda di Carlo, su come sia riuscita ad arrivare fino a lì, lei, per tranquillizzarlo, riesce a rispondere con una bella bugia. Lo stesso ufficiale, senza dire nulla, la riaccompagna a Harar, e al momento del commiato le mostra la fotografia della moglie e dei suoi due bambini. Amaramente, Anna Maria commenta: «Possibile che questi fossero i nostri nemici? Ma che orrore è la guerra!»95. L’incontro casuale con l’altro versante della guerra, impersonato da un nemico che è impossibile odiare, dopo il turbinio di emozioni provocate da un ingenuo impulso d’amore, le fa ritrovare il vigore della donna che riesce a sublimare l’odio nell’amore. La parola «amore» è presente ogni volta che Carlo viene nominato e ha una forte capacità evocativa. Con una saggezza tutta nuova si impegna, senza macchina da cucire, in un lavoro di cucito, ricavando, da un lenzuolo e da una tovaglia, un abitino, una gonna e una camicetta: «sono indaffaratissima» annota il 25 ottobre 1941, probabilmente mentendo anche a se stessa96. Il diario di Vanni Corsini, nella parte relativa alla prigionia in Etiopia e 120 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia nel Somaliland, è utile per comprendere il ruolo svolto nel campo di Mandera da Olga, e le ritorsioni cui è fatta segno da parte del comando militare britannico, che non le perdona l’accusa di mental cruelty a danno dei civili evacuati, contenuta in un rapporto pervenuto a Londra attraverso i servizi segreti. Olga, maestra nell’arte del togliere, si astiene da commenti riguardanti la sua sfera privata: è dal marito pertanto, non da lei, che il lettore apprende che la secondogenita di tredici mesi, partita in perfetta salute da Addis Abeba, è stata imbarcata, già ammalata, a Berbera, sul «Vulcania», ed è arrivata completamente stremata, al limite delle forze, a Livorno. In Olga è ben radicata l’avversione per gli invasori, ma altrettanto lo è per le comunità greca e armena della capitale e per gli appartenenti all’Associazione della Libera Italia97, sospettati di delazione alla polizia britannica, e per «i giudaici negozi Hendel e Zingone [che] vendono solamente agli inglesi»98. Questo sentimento le fa sembrare del tutto normali le vicende di cui si rende protagonista e che riporta con una precisione chirurgica: l’incontro, dopo ventitré anni, con il tenente del Field Security, George Hartmann, appartenente a una famiglia russa amica degli Olsoufiev, che risulta decisivo per la sorte del maggiore dei carabinieri Domenico Lucchetti, in attesa dell’esecuzione della condanna a morte comminata dagli inglesi per attività sovversive.«Bisogna salvarlo e vado da H.». L’esito dell’intervento è scontato: l’ufficiale riuscirà a fuggire99. I due figli di Olga fanno la loro apparizione soltanto in scene di «vita tranquilla», in cui risalta l’intelligenza del primogenito, di tre anni e mezzo che, inconsapevolmente, si prende gioco degli inglesi oppure la bellezza di Caterina, che suscita l’ammirazione anche dei patrioti etiopici venuti dalla boscaglia. Pressappoco alla stessa data Anna Maria denuncia casi di mortalità infantile, dovuta alla scarsità di medicinali a Harar e, condividendo l’ansia delle madri, conclude: «Guai se si ammalano»100. Eppure Olga si dibatte in problemi economici, che la costringono ad accettare una parte dello stipendio di George Hartmann fino alla fine della guerra, a tradurre arringhe e appelli per il Tribunale, a vendere gioielli e vestiti suoi e del marito, a eseguire lavori a maglia per un negozio della capitale. Per i poveri e per i patrioti italiani effettua le traduzioni gratuitamente. Dal capitano Peter Rodd, figlio dell’ambasciatore inglese a Roma, ottiene un lavoro volontario come interprete al campo alloggio di Addis Abeba, al fine di procrastinare per sé e per i suoi figli l’internamento in un campo inglese. Giunta sul posto, le condizioni delle donne e dei bambini 121 Carla Ghezzi evacuati fanno passare in second’ordine il servizio per il quale è stata chiamata e si prodiga nel conforto delle internate e nel disbrigo dei preliminari delle operazioni di partenza. Quando protesta presso Rodd perché un convoglio di donne e bambini proveniente dal Gimma ha effettuato il percorso in diciassette ore senza cibo né acqua, il lavoro volontario ha bruscamente fine. Finalmente, nel febbraio 1942, dopo un viaggio attraverso Dire Daua, Giggiga e Hargeisa, arriva a destinazione al campo di Mandera, dove è internato il marito e dove ha ottenuto di svolgere mansioni di interprete, di nuovo senza uno stipendio, che ha rifiutato. Fa valere il suo status con il responsabile del campo, il maggiore Drummond, fratello di sir Eric101, dal quale a poco a poco ottiene una serie di concessioni che il colonnello italiano di collegamento prima di lei ha giudicato improponibili: l’integrazione della dieta alimentare dei bambini di età inferiore ai due anni e mezzo con pane e verdura, quindi anche con frutta; il recupero della trippa, del fegato e del cervello degli ovini scartati dal macellaio musulmano di La Faruk, a dodici chilometri da Mandera, dove si reca regolarmente; l’estensione a tutte le coppie regolari internate del permesso, attualmente concesso a quelle dei soli ufficiali, di incontrarsi in luoghi appartati e in orari prestabiliti per arginare l’immoralità di convegni alla luce del sole; l’allestimento di un campo giochi per i bambini. Convince, inoltre, una giovane donna vittima del ricatto di un tenente inglese, che le promette denaro in cambio di prestazioni sessuali - a firmare una denuncia, redatta da Olga, da inoltrare al maggiore Drummond; indaga con successo, infine, per incarico dello stesso maggiore, sui furti delle razioni al campo. Si muove naturalmente, fungendo da liaison tra il comando nemico e le internate, che «hanno perso ogni senso di decenza e di ritegno» e per le quali ha comunque parole di comprensione e di condiscendenza102. Viene alla mente, per converso, l’incapacità di adattamento alla promiscuità sociale, proclamata da Anna Maria come un vessillo: «È un vero inferno. Siamo tutte lì, signore, prostitute, mogli di ufficiali, e donne abituate a vivere nei “tucul”: bambini che urlano, mamme che urlano ancora di più, litigi, nervosismi, isterismi, parolacce. In alcune sembra di notare un godimento sadico nel vederci tutte lì, tutte uguali, schiacciate dal peso degli eventi»103. Olga trascorre a Mandera quattro settimane, il tempo sufficiente per disporre degli elementi per un rapporto sul campo richiestole ad Addis Abeba da Roberto Maltini, membro del Fronte di resistenza antibritan122 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia nico, creato dal maggiore Domenico Lucchetti. Il capitano è un amico di vecchia data, e Olga ne fiancheggia l’attività clandestina, affliggendosi per le frequenti pene detentive che ne bloccano lo svolgimento. Giunta ad Addis Abeba in precarie condizioni di salute, stende il rapporto in tre copie, contravvenendo alla pratica di non lasciare mai copie dei lavori destinati a Roberto: una, firmata, la consegna a lui in persona; la seconda, dietro sua richiesta, la nasconde in casa Maltini; la terza l’affiderà ad amici russi prima di imbarcarsi per l’Italia. Il rapporto, nucleo del diario, è una testimonianza, nel significato più alto della parola: Olga denuncia la «forzata convivenza di 80-90 donne per baraccone in brande quadruple; […] i baracconi in cui piove […]; l’insufficienza di acqua per un campo di oltre 4.000 persone […]. Dubbia potabilità di quell’acqua non esaminata. Insufficienza del vitto. Pericolo di maggiori epidemie. […] Insufficienza di medicinali e di impianti sanitari. […] La dolorosa impressione delle donne che vedono trattare male i prigionieri di guerra in stracci, ridotti a pochissimo pane ed a 1 scatoletta di carne in 4 persone»104. L’aspra requisitoria del maggiore Rodd, che è venuto a conoscenza del rapporto da Londra - ove è giunto attraverso i servizi segreti - le fa temere ritorsioni che non tardano a venire. Ricevuto il foglio di via per l’Evacuation per se stessa, i figli e la governante, il 12 maggio 1942, «dopo una sera e una notte in treno, che diverte molto Giovanni - benché sia un lurido vagone bestiame - arriviamo a Dire Daua»105. Alcuni giorni dopo proseguono alla volta di Berbera. Nel mese di maggio, pressappoco negli stessi giorni, Anna Maria compie su camion militari il percorso Harar-Gyggiga-Hargeisa- Mandera -Berbera: al disagio del viaggio e al clima soffocante si aggiunge l’incertezza per la destinazione, che le solite voci tendenziose dicono essere non l’Italia, ma il Sud Africa. Tradita dalla stanchezza e dalla trepidazione, Anna Maria sviene non appena viene imbarcata sulla nave bianca. Olga, al contrario, non lascia trapelare alcuna emozione; si limita alla pura registrazione degli eventi che la vedono protagonista: l’interdizione della partenza, comminatale, senza alcuna spiegazione, dalle autorità inglesi a un passo dall’imbarco; il consenso ottenuto per i figli, che partono sotto la protezione di una crocerossina e della governante; l’internamento nel campo di Dire Daua come prigioniera politica. Tale status le dà «l’enorme vantaggio di abitare da sola una camera e di non stare in un lurido ca123 Carla Ghezzi merone con donne e bambini». «In due spiacevoli interrogatori» un capitano del Field Security cerca di patteggiare il suo rimpatrio con la rivelazione del rifugio di Roberto Maltini dopo l’ennesima fuga; il rifiuto le costa l’internamento al campo Incis dove sembra non avvertire l’eterogeneità del gruppo degli internati. Il 28 novembre viene finalmente imbarcata sul «Vulcania»; queste le parole con cui conclude il racconto dei venti mesi della sua guerra privata contro le forze di occupazione inglesi: «Che voglia di scendere a metà scaletta e tornare indietro! Tornerò»106. Note al testo 1 L’Abissinia fa parlare di sé, 11 luglio 1911, p. 3; Combattimento in Abissinia fra ras Micael e ras Guxa, 14 luglio 1911, p. 5; I travagli della successione in Etiopia, 15 luglio 1911, p. 1; G.P., Il guazzabuglio della successione etiopica, 18 luglio 1911, pp. 1-2; La missione etiopica ricevuta dal Re, 19 luglio 1911, pp. 1-2; G. P., La missione etiopica. L’arrivo a Roma. Una intervista impossibile, 24 luglio 1911, p. 1. 2 15 luglio 1911, pp. 1-2. 3 La missione ebbe come tappe la Gran Bretagna e la Francia; in Italia visitò Torino, Racconigi - ove fu ricevuta da Vittorio Emanuele III - Milano e Roma; proseguì quindi alla volta di Gerusalemme. Vedi LUCIANO MONZALI, L’Etiopia nella politica estera italiana, 1896-1915, Università degli Studi di Parma, Parma 1996, pp. 367-368 e, per le referenze archivistiche, la nota 30 a p. 368. 4 Sono grata a Massimo Zaccaria, che mi ha indicato l’esistenza del faldone dedicato a Ida Locatelli presso l’Archivio storico del ministero dell’Africa Italiana e a Claudio Cerreti, che ha identificato il luogo di nascita di Ida citato in ASMAE, ASMAI, Persone operanti in Africa (18791925), posiz. 35, pacco L-3, busta 1. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 «Italia Militare e Marina», 17-18 ottobre 1905, n. 210. 10 FERDINANDO MARTINI, Il diario eritreo, Vallecchi, Firenze [1942-1943] vol. IV, 10 novembre 1905, p. 56; «Italia Militare e Marina»,10-11 luglio 1906, n. 76; «Bullettino Ufficiale della Colonia Eritrea», XV, 46, 17 dicembre 1906, p. 370. 11 Agenzia Regina, Asmara 1952, pp. 183-184. 12 IDA LOCATELLI, Una donna bianca attraverso l’Abissinia, in «La Tribuna», 15 luglio 1911, p. 1. 13 Ibidem. 14 Ivi, p. 2. 15 Ras Olié dello Jeggiù, fratellastro di Taitu, governatore del Tigrai, era uno degli uomini più 124 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia potenti dell’impero. Vedi ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. Dall’Unità alla marcia su Roma, Mondadori, Milano 1992 [1a ediz. Laterza, Roma-Bari 1982], passim; ras Mikael del Wollo, di religione musulmana, era stato obbligato dal negus Yohannes alla conversione al cristianesimo; dalle sue nozze con Shoa Rega, figlia di Menelik, nacque Ligg Iyasu. Vedi GIAMPAOLO CALCHI NOVATI, Il Corno d’Africa nella storia e nella politica. Etiopa, Somaliae Eritrea fra nazionalismi, sottosviluppo e guerra, Società Editrice Internazionale, Torino 1994, alle pp. 55, 109, 110. 16 IDA LOCATELLI, Una donna bianca cit., p. 2. 17 ANNIE VIVANTI, Terra di Cleopatra, Mondadori, Milano 1925. Non dimentico Maddalena Cisotti Ferrara, Amalia Sola Nizzoli, Rosalia Pianavia Vivaldi Bossiner, le cui opere rientrano nel genere della scrittura di memoria piuttosto che in quello della letteratura di viaggio. Si veda il mio Colonie, coloniali. Storie di donne, uomini e istituti fra Italia e Africa, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Roma, 2003, rispettivamente alle pp. 118-120, 120-121 e 115-118, a loro dedicate. 18 A.O.I. Cantiere d’Italia, Edizioni Roma, Roma 1939, p. 14. 19 Ivi, rispettivamente alle pp. 134 e 119. 20 Ivi, p. 82. In un articolo dal titolo La donna e la colonia, apparso in un periodico pubblicato ad Addis Abeba, una voce influente della macchina del consenso fascista, Augusta Perricone Violà, ricordava come il duce, nell’indicare alla donna italiana la missione cui il regime l’aveva consacrata, avesse proclamato di averle affidato la propaganda della bontà ( «Etiopia», anno III, n. 4, aprile 1939, p. 37 ). 21 MARTINO MARIO MORENO, Politica di razza e politica coloniale italiana, in «Gli Annali dell’Africa Italiana», anno II, vol. II, 1939, pp. 453-467; ID., Il problema della razza con particolare riferimento al meticciato nell’Africa italiana, in Atti del I Congresso regionale di studi coloniali, Napoli 13-18 novembre 1938, Istituto fascista dell’Africa Italiana- sez. di Napoli, Napoli 1939, pp. 201-208; ANGELO PICCIOLI, La razza e l’Impero, in «Gli Annali dell’Africa Italiana», anno I, vol. II, 1938, pp. 417-422. 22 LUISA DIEL, A.O.I. cit., rispettivamente alle pp. 198 e 136. 23 RUTH RICCI, Three years after, 1936-1939, Società editrice di Novissima, Roma [1940] s.i.p.. Dal 1936 al 1939 Ruth effettuò reportages fotografici anche in Africa settentrionale. 24 LUISA DIEL, A.O.I. cit., p. 249. Il corsivo è dell’Autore. 25 Per la figura di Pietro Felter si veda il Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1996, pp. 98-100; Enciclopedia biografico-bibliografica. Precursori pionieri e combattenti italiani d’Africa, Istituto editoriale italiano, Milano 1941 (bozze di stampa); ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. Dall’Unità alla marcia cit., p. 138; NICOLA LABANCA, In marcia verso Adua, Einaudi, Torino 1993, p. 366. 26 ALBA FELTER SARTORI, Vagabondaggi soste avventure negli albori di un impero, F.lli Geroldi, Brescia 1940. Per l’esperienza africana della Felter si veda il mio Colonie, coloniali. Storie di donne cit., pp. 134-135. 27 Africa come un mattino, a cura di Fabio Roversi Monaco, Tamari, Bologna 1969. 28 Ivi, p. 241. 29 Ivi, p. 248. SANDRA CIRANI, Giorni di scuola giorni di guerra, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefano DG/86, s.i.p. 31 SANDRA CIRANI, Il grembiule, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefa30 125 Carla Ghezzi no MG/T, p. 1. 32 Ivi, p. 3. 33 MARIA GIACONÌA LANDI, Crocerossina in A.O., Treves, Milano 1938, p. 120. 34 Ivi, pp. 2, 3 e 25. 35 Ivi, pp. 60 e 64. 36 Mario Appelius (Arezzo, 1892 - Roma, 1946). Redattore di «Il Popolo d’Italia», quindi, fino al 1933, direttore del «Mattino d’Italia» di Buenos Aires. Autore di libri di viaggio di grande successo. Processato alla caduta del fascismo. 37 Divenuto il medico personale del duca d’Aosta, lo seguì in prigionia in Kenya, assistendolo fino alla morte, avvenuta a Nairobi il 3 marzo 1942. 38 MARIA GIACONÌA LANDI, Crocerossina in A.O. cit., p. 160. 39 Ivi, p. 227. 40 Un altro esempio di scritto agiografico è rappresentato da MARIA CORAZZA, La guerra in A.O. veduta da una donna, S.A.Tipografica Editrice Trevigiana, Treviso 1940, analizzata nel mio Colonie, coloniali. Storie di donne cit., alle pp. 135-136. 41 FERRUCCIA CAPPI BENTIVEGNA, Quelli che ritornano, in «Gli Annali dell’Africa Italiana», anno VI, vol. I, 1943, p. 43. Della Cappi Bentivegna mi sono occupata nel mio Colonie, coloniali. Storie di donne cit., alla p. 218. 42 FERRUCCIA CAPPI BENTIVEGNA, Quelli che ritornano cit., p. 44. 43 Maria di Piemonte infermiera volontaria in Africa Orientale. Pagine di diario, Mondadori, Milano 1937. Per la vicenda della designazione della Targiani all’alta carica si veda STEFANIA BARTOLONI, Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918, Marsilio, Venezia 2003, alle pp. 221222 e, per una breve nota biografica, la nota 12 di p. 221. 44 Aldo Castellani (Firenze, 1874 – Lisbona, 1971). Conte di Chisimaio. Clinico, patologo e batteriologo. Membro di una spedizione della Royal Society di Londra in Uganda, scoprì l’agente etiologico della malattia del sonno. Insignito del titolo di cavaliere in Gran Bretagna (1928), nominato senatore in Italia, accademico dei Lincei e direttore della cattedra di malattie tropicali e subtropicali istituita per lui all’Università di Roma. Durante la guerra d’Etiopia fu ispettore superiore generale dei servizi sanitari militari e civili per l’Africa orientale; prese quindi parte al secondo conflitto mondiale presso l’Alto comando delle Forze sanitarie dislocate in Africa, poi presso il Comando supremo. Ottenne due medaglie d’argento e due di bronzo al valor militare. Vedi il Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1978, pp. 605-609 e l’Enciclopedia biografico-bibliografica. Precursori pionieri e combattenti italiani d’Africa, Istituto editoriale italiano, Milano 1941 (bozze di stampa). 45 Maria di Piemonte infermiera volontaria cit., p. 124. 46 M.C., Sorella Maria di Piemonte nella campagna etiopica, in «Africa Italiana», anno III, febbraio-marzo 1940, n. 2-3, pp. 5-6. 47 La frase conclude la motivazione della medaglia concessa alla memoria a Lydia Maffioli Rocca. Il testo completo è riportato in RACHELE FERRARI DEL LATTE, Italiane eroiche in terra d’Africa, in «Africa Italiana», anno III, febbraio-marzo 1940, n. 2-3, pp. 9-12. La motivazione è a p. 11. 48 Per l’eroica morte di Maria Boni Brighenti si veda il mio Colonie, coloniali. Storie di donne cit., alle pp. 121-123. Si veda anche l’Enciclopedia biografico-bibliografica cit.; MARIZ REVELLI, L’ombra che torna. Maria Brighenti, in «Rivista delle colonie», anno XVI, maggio 1942, n. 5, pp. 434-439; CESARE CESARI, Episodi eroici di guerra coloniale. Tarhuna, in «Rivista delle colonie 126 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia italiane», anno II, gennaio-febbraio 1928, n. 1, pp. 241-245. 49 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell’impero, Mondadori, Milano 1992 [1a ediz. Laterza, Roma - Bari 1979] pp. 585-587. 50 La tesi è contenuta in La verité sur la guerre italo-éthiopienne. Une victoire de la civilisation par le Negus, supplemento di «Vu», luglio 1936, p. 37, riportata in ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell’ impero cit., p. 586. 51 Rizzoli, Milano 1947. L’opera si aggiudicò la prima edizione del premio Strega (1947). 52 ENNIO FLAIANO, Un bel giorno di libertà, Rizzoli, Milano 1979. Il brano del diario, pubblicato postumo, è alla p. 156 ed è riportato da ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La conquista dell’impero cit., alla n. 10 di p. 587. 53 MARIO GAZZINI, Schiacciare gli ostacoli alla civiltà, 1936, riportato in NICOLA LABANCA, Posti al sole. Diari e memorie di vita e di lavoro dalle colonie d’Africa, Museo storico italiano della guerra, Rovereto (Tn) 2001, p. 75. 54 Ivi, pp. 301-306. 55 Parenti, Firenze 1938. Il capitolo, intitolato «Un permesso per Asmara», è alle pp. 15-27. 56 Riportato in NICOLA LABANCA, Posti al sole. Diari e memorie di vita cit., p. 305. 57 FRANCO DANI, AOI. Racconti e disegni cit., pp. 19-20. 58 IRMA TADDIA, La memoria dell’Impero. Autobiografie d’Africa Orientale, Lacaita, Manduria – Bari – Roma 1988, pp. 92-93 e FRANCO DANI, AOI. Racconti e disegni cit., p. 22. 59 FERRERO BIGIARINI, Ricordi inutili, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefano, MG/Adn. 60 Ivi, p. 6. 61 Ivi, p. 9. 62 Ivi, p. 5. 63 Ivi, p. 44. 64 Ivi, p. 48. 65 MANLIO AMATO, Lo spessore del ricordo, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefano, MP/90. 66 Ivi, p. 67. 67 Ivi, p. 100. 68 NELUSKY BRANA [pseudonimo di Marta Majone Padovani], Avventura in Africa Orientale Italiana, Tipomeccanica, Napoli 1968. Ringrazio sentitamente il dottor Gian Carlo Stella per avermi segnalato il volume e rivelato il nome dell’Autrice. 69 Ivi, p. 88. 70 Ivi, p. 84. 71 Ivi, pp. 117 e 118. 72 Ivi, p. 93. 73 Ivi, p. 137. 74 Ivi, p. 151. Ivi, p. 195. 75 127 Carla Ghezzi 76 Ivi, rispettivamente alla p. 225 e alla p. 232. 77 Diario di Olga Corsini Olsoufieff, appendice a GIOVANNI CORSINI, Lunga fuga verso il sud. L’incredibile evasione di cinque P.O.W. italiani, Mursia, Milano 1979; ANNA MARIA MÒGLIE, Africa come amore, Trevi, Roma 1978. Di Anna Maria Mòglie mi sono già occupata nel mio più volte citato Colonie, coloniali. Storie di donne…, pp.123-125. Una rilettura di Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’ impero di Angelo Del Boca mi ha suggerito il raffronto fra i diari di Anna Maria e di Olga, oltre che offrire il riscontro delle situazioni adombrate e dei personaggi citati da Olga. 78 Ivi, pp. 8 e 7. 79 Ivi, pp. 13 e 14. 80 Ivi, p. 11. 81 Ivi, pp. 19 e 15. 82 Mondadori, Milano 1992 [1a ediz. Laterza, Roma-Bari 1982] p. 557. 83 ANNA MARIA MÒGLIE, Africa come amore cit., p. 70. 84 Ivi, pp. 23 e 30. 85 Ivi, p. 37. 86 Ivi, p. 59. 87 Diario di Olga Corsini Olsoufieff cit., p. 179. 88 Ivi, p. 180. 89 GIOVANNI CORSINI, Lunga fuga verso il sud cit., rispettivamente alle pp. 33 e 36. 90 Ne erano membri il comandante della Pai, generale Renzo Mambrini; l’ex-ministro plenipotenziario ad Addis Abeba, Renato Piacentini; il vice-podestà della città, dottor Giuseppe Tavazza; il capitano di fregata Zambon. Vedi ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’impero cit., la nota 53 di p. 461. 91 GIOVANNI CORSINI, Lunga fuga verso il sud cit., rispettivamente alle pp. 15 e 11. 92 Ivi, p. 57. 93 Diario di Olga Corsini Olsoufieff cit., p. 190. Si allude all’accordo biennale, firmato il 31 gennaio 1942 tra le forze di occupazione inglesi e il governo etiopico, che ridimensionava pesantemente le prerogative di Haile Selassie, pur riconoscendo formalmente la sovranità dell’Etiopia. Vedi ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’impero cit., p. 545. 94 Diario di Olga Corsini Olsoufieff cit., p. 185. 95 ANNA MARIA MÒGLIE, Africa come amore cit., pp. 60-61. 96 Ivi, p. 66. 97 Secondo Angelo Del Boca l’Associazione è il primo nucleo antifascista nato dopo la caduta dell’Africa orientale italiana. Venne creata nel marzo 1941 a Mogadiscio da Ferruccio Nicoloso, un ex-ufficiale condannato nel 1927 a dieci anni di reclusione per avere attentato alla vita del Duce. Sezioni dell’Associazione nascono anche a Dessié e, dopo l’occupazione inglese, anche ad Addis Abeba. Vedi ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’impero cit., alle pp. 547-548. 98 Diario di Olga Corsini Olsoufieff cit., pp. 182-183. 99 Ivi, pp. 183-184. Secondo Olga, la consuetudine di Hartmann con Lucchetti risale all’epo- 128 Famiglia, patria e impero: essere donna in colonia ca precedente l’occupazione italiana dell’Etiopia, quando ambedue vi «facevano reciprocamente il controspionaggio» (p. 184). A Lucchetti si deve, nell’autunno 1941, la creazione ad Addis Abeba del Fronte di resistenza - un’organizzazione segreta i cui primi membri sono soprattutto militari – che intende fungere da organo di collegamento fra i vari gruppi che, dalla caduta dell’impero, effettuano azioni di guerriglia contro le forze di occupazione. Vedi ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’impero cit., p. 550. 100 ANNA MARIA MÒGLIE, Africa come amore cit., p. 65. Eric Drummond, conte di Perth (1876 - Rogate,1951). Dal 1919 al 1933 fu segretario generale della Società delle Nazioni, quindi, fino al 1939, ambasciatore in Italia. 101 102 Diario di Olga Corsini Olsoufieff cit., p. 194. 103 ANNA MARIA MÒGLIE, Africa come amore cit., p. 71. 104 Diario di Olga Corsini Olsoufieff cit., pp. 200-201. 105 Ivi, p. 202. 106 Ivi, rispettivamente alla p. 203 e alla p. 205. Il corsivo è dell’Autore. 129 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia in uso nelle scuole superiori di Grazia De Michele Sopravvivenze e mutamenti nell’approccio storiografico Tracciare una panoramica dei mutamenti occorsi alla trattazione del tema del colonialismo italiano nei manuali di storia destinati alle scuole superiori è abbastanza complesso. Il colonialismo italiano si è sviluppato, volendo seguire il percorso cronologico e geografico tradizionale, in tre fasi: la prima, iniziata ufficialmente nel 1885 con lo sbarco a Massaua e arrestata nel 1896 dalla sconfitta di Adua; la seconda, con la guerra d’occupazione della Libia nel 191112; la terza, caratterizzata dall’aggressione fascista all’Etiopia nel 1935-36. Si tratta di tre fasi molto diverse tra loro dal punto di vista politico, sociale e culturale e che hanno subìto, in sede di rielaborazione storiografica, una serie di interpolazioni che ne hanno alterato la sostanza e spesso mistificato il senso anche dopo la fine della parentesi espansionista. Molteplici sono dunque i punti di vista che i manuali di storia del dopoguerra hanno espresso sull’argomento sebbene sia possibile riassumerli per aree tematiche: ad esempio la rappresentazione delle popolazioni indigene e quella dell’esercito occupante, le cause dell’impresa e le sue ripercussioni. Si può, inoltre, tentare l’analisi delle categorie di valutazione dell’esperienza coloniale italiana e dei nuclei concettuali cui fa riferimento ciascun manuale e metterli a confronto. Ciò che risulta difficile è trarne delle conclusioni di carattere generale: i testi, e il loro approccio alla vicenda coloniale, non si evolvono nello stesso tempo né nello stesso modo e tanto meno sugli stessi temi. Se uno di essi, pubblicato in un certo periodo, propone una visione «di rottura», diversa dalle precedenti, ad esempio sulla battaglia di Adua, non è detto che gli altri, pubblicati o riediti contemporaneamente facciano altrettanto, e, soprattutto non è detto che esso si riveli innovativo anche nella trattazione delle altre vicende coloniali. La complessità, dunque, sta 131 Grazia De Michele sia nel considerare singolarmente i testi, che, appunto, possono presentare differenze anche marcate nell’analisi delle varie fasi del colonialismo italiano e sia nel cercare d’individuare delle comuni variabili, storico-culturali e politiche, che potrebbero sovrintendere ad un’evoluzione dei testi che appare, al contrario, estremamente composita e difforme. Il mito dei precursori Tra le caratteristiche che accomunano i testi esaminati, va segnalata innanzitutto la sopravvivenza degli stereotipi e delle mitologie che hanno nutrito la propaganda coloniale di epoca liberale e fascista. Un fenomeno ravvisabile in misura maggiore nei testi pubblicati negli anni cinquanta e sessanta ma la cui persistenza, nei manuali più recenti, è il segnale di come il dibattito sulla storia e la storiografia del colonialismo italiano, che pure ha coinvolto negli ultimi anni un nutrito gruppo di studiosi, non abbia ancora prodotto risultati significativi, tali da informare di sé la manualistica scolastica. Ne è un esempio quello che potremmo chiamare «il mito delle origini», che propone una ricostruzione epica dei prodromi del colonialismo italiano in Africa, stabilendo tra questi e le vicende successive dei nessi causali che rendono verosimili l’ineluttabilità e la necessità della nostra avventura africana: l’Italia di Giuseppe Sapeto, di padre Stella, di Guglielmo Massaia, di Orazio Antinori, di Gustavo Bianchi, di Antonio Cecchi, di Pellegrino Matteucci, di Daniele Comboni non poteva non proseguire l’opera di penetrazione nei misteri d’Africa cui questi suoi coraggiosi figli avevano dedicato e spesso sacrificato la propria vita. In quest’ottica missionari, esploratori, o semplici avventurieri - che si erano recati in Africa con gli obiettivi più disparati, e spesso non proprio leciti, emissari della Chiesa o delle Società Geografiche di cui il governo si serviva, maldestramente delegando loro delicate questioni diplomatiche - giustificano e rendono nobile con il loro contributo un’impresa che altrimenti non avrebbe avuto molte buoni ragioni di essere1. Va detto che la retorica, la propaganda, i toni da epopea hanno fatto da cassa di risonanza per tutti i colonialismi ottocenteschi, consentendo di mettere in ombra le vere, realistiche ragioni della conquista coloniale e di raccogliere il consenso di un’opinione pubblica spesso abilmente conquistata da racconti di leggende esotiche e gesta d’eroi. Un tipo di operazione 132 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia che nell’Italia post-unitaria è risultata più complessa per le profonde spaccature che l’argomento coloniale sollevava nella classe politica e anche nella fascia di popolazione che aveva accesso all’informazione, almeno nella prima fase del colonialismo italiano e fino alla sconfitta di Adua, i cui esiti provocarono infatti un’ondata di proteste tale da far cadere il governo di Francesco Crispi, fervido espansionista, e da indurre i gruppi d’interesse e di opinione che avevano spinto in quella direzione a battere momentaneamente in ritirata. È con la guerra di Libia e poi soprattutto con l’imperialismo fascista che vengono recuperate e rielaborate le mitologie dell’epoca liberale, aggiungendovene di nuove, utili ad alimentare e fornire solidi appigli al sentimento di revanche che, dopo Adua, avrebbe alimentato la politica e la propaganda colonialista del paese. Ma sarà il fascismo, maestro nell’arte di «fabbricare il consenso», a fare dell’impresa africana un capolavoro propagandistico per il vivo senso di partecipazione e di plauso nei confronti di una guerra scatenata per motivi di prestigio ben lontani dagli interessi del paese, che pure l’approvò con entusiasmo. Così come per la campagna di «fascistizzazione» del paese, la manualistica scolastica rivestì un ruolo di grande efficacia tra i mezzi di aggregazione intorno all’impresa etiopica, rivelatore di quali fossero i temi salienti della propaganda attraverso cui il regime perpetrava e rinsaldava se stesso2. La lettura dei testi di storia pubblicati a ridosso del 1935 sottopone chi oggi la intraprenda ad un vero e proprio bombardamento di mistificazioni, falsità e forzature capaci di confondere anche il lettore più critico. La storia d’Italia, protagonista pressoché assoluta, vi è ricostruita col solo scopo di legittimare teleologicamente il fascismo, la cui missione è riportare l’Italia ai fasti della romanità, alla grandiosità dell’impero, espressione del «primato della discendenza classica»3 che ha fatto dell’Italia «la culla della civiltà universale»4. L’obiettivo di tale impostazione è «annettere la gente comune all’opinione che il fascismo non rappresenti un fortunato colpo di mano contrattato e sanzionato al vertice, ma lo sbocco genuino e necessario di una storia nazionale»5, nella quale avrebbe segnato una svolta. Così anche, il diritto di invadere l’Etiopia è sanzionato dalla storia e dal passato glorioso dell’Italia di cui, secondo la manualistica scolastica della seconda metà degli anni trenta, le imprese di esploratori e missionari nel Corno d’Africa - regione che gli ignavi governi liberali non erano stati capaci di accaparrarsi - facevano parte a pieno titolo: 133 Grazia De Michele Vergognoso poi il disinteresse per le grandi iniziative coloniali, che pur facevano vibrare i maggiori stati europei e li spingevano verso nuove e non pensate fortune. Veri apostoli furono in quei tempi i pochi ma audaci esploratori italiani, come l’Antinori, l’Antonelli, il Cecchi, il Giulietti, il Bianchi, che perlustrarono la regione etiopica; [...] valorosi missionari come il Massaia e lo Stella, per parecchi decenni evangelizzarono le barbare tribù dell’interno, spesso invocando l’intervento della patria su queste terre abbandonate al disordine e all’anarchia6. Ciò su cui ci preme focalizzare l’attenzione è che l’insistenza su questi personaggi e soprattutto la loro strumentalizzazione non si esaurirono con la caduta del fascismo né con l’avvento della decolonizzazione, giacché i testi degli anni cinquanta e sessanta continuano ad esaltarli in modo retorico e acritico con sorprendenti tracce anche nella manualistica più recente: Da tempo audaci italiani si erano diretti frequentemente verso i mari africani del Mar Rosso, dell’Alto Nilo e dell’Abissinia, ora come missionari, come Monsignor Sapeto e il Cardinale Massaia, ora come funzionari del governo egiziano, quale Romolo Gessi, intrepido combattente contro i mercanti di schiavi dell’Alto Sudan, ora infine come esploratori, quali Orazio Antinori, Carlo Piaggia, Pellegrino Matteucci, ecc.7 Nell’entroterra abissino, inoltre, e nella zona dell’alto Nilo esploratori e missionari italiani, come Romolo Gessi, Carlo Piaggia, il cardinale Massaia e il marchese Orazio Antinori erano già penetrati negli anni precedenti, combattendo la tratta degli schiavi e svolgendo opera di apostolato.8 Nel frattempo audaci esploratori italiani, come Guglielmo Massaia (1809-1886), Antonio Cecchi (1849-1896), Giuseppe Giulietti (1847-1881), Gustavo Bianchi (18451884), si erano spinti all’interno della regione etiopica, dove però trovarono quasi tutti una tragica morte nel corso di sanguinosi conflitti con gli indigeni9. La rappresentazione dell’Altro La trattazione agiografica della vicenda di esploratori e missionari rappresenta solo una piccola parte di quel più vasto «romanzo coloniale» che nel periodo liberale e ancor più in quello fascista appassionò milioni di italiani, conquistati dai racconti, spesso palesemente fantastici, di coloro che avevano visitato il «continente nero», ne avevano esplorato i misteri, sperimentato le avversità e apprezzato le bellezze. Un nostrano «mito della frontiera» che faceva leva anche sul bisogno, molto sentito all’epoca, di venire in contatto in qualche modo con mondi inesplorati, lontani dalle proprie contingenze e miserie, colmi di ricchezze da conquistare, di battaglie 134 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia da combattere, di barbari da «civilizzare»10 e i cui stilemi confluirono anche nei testi scolastici del dopoguerra. Non a caso sino alla fine degli anni sessanta gli aggettivi maggiormente ricorrenti nei manuali e riferiti alle genti e ai luoghi incontrati dagli italiani sul loro cammino d’oltremare sono: barbaro, selvaggio, misterioso, fanatico, ostile, sospettoso, infido, primitivo, inesplorato. È a partire dagli anni settanta che si fa strada un approccio più neutro: l’aggettivazione immaginosa lascia il posto ad un timbro più pacato nella presentazione dei luoghi e delle popolazioni assoggettate, una presentazione che, tuttavia, non riesce ad andare oltre la citazione di qualche personalità e vaghi accenni a qualche istituzione locale; spesso viziati dal paragone con i loro omologhi, o presunti tali, europei: Questa terra [l’Abissinia] era allora retta da un negus (imperatore) Giovanni, il quale esercitava la propria autorità sui capi (i ras) a lui legati da un ordinamento politico pressoché feudale11. L’Etiopia - o Abissinia - come era comunemente chiamata in Italia - era un paese economicamente molto arretrato, con una popolazione di fede cristiana e di confessione copta, dedita in prevalenza alla pastorizia, con un’organizzazione di tipo feudale, in cui l’autorità dell’imperatore (negus) era fortemente limitata rispetto a quella dei signori locali (ras), che disponevano di propri eserciti12. Era questo [l’Etiopia] un isolato e arretrato paese di agricoltori e pastori che aveva conservato nei secoli la fede cristiana di rito copto e la sua identità statale, ed era governato da un re (negus), le cui prerogative erano però fortemente limitate dall’autonomia dei ras (capi), una sorta di signori feudali che governavano le province e avevano milizie proprie13. L’eurocentrismo che caratterizza, in misura più o meno evidente, questi testi è rilevabile anche da un rapido esame della loro impaginazione: pochissimi offrono una trattazione del colonialismo italiano che prescinda da limiti strettamente cronologici, ponendo nel giusto risalto la complessità e lo sviluppo del fenomeno attraverso una presentazione sistemica . Nemmeno le recenti innovazioni metodologiche apportate ai manuali scolastici, che propongono una scansione modulare, sono riuscite a trarre il colonialismo fuori dal mare magnum della storia nazionale in cui sembra inserito a mò di appendice. Sotto questo profilo gli ultimi venticinque anni hanno segnato un peggioramento, man mano che i segni lasciati dall’impaginazione fascista sono andati scomparendo. I testi del regime infatti erano strutturati in modo da presentare le imprese coloniali - punto di forza del135 Grazia De Michele la propaganda fascista - come il compimento del destino dell’Italia «dominatrice», ragione per cui ne veniva riservata la trattazione al capitolo conclusivo della storia nazionale14, in cui, accanto ai successi fascisti in Etiopia veniva passata in rassegna tutta la storia dell’espansione italiana in Africa, in aggiunta ai paragrafi che già le erano stati dedicati all’interno delle sezioni sulla politica estera di Crispi e di Giolitti. I testi editi nei primi quindici anni del dopoguerra ancora riservano al colonialismo interi paragrafi intitolati, ad esempio: «L’espansione coloniale italiana. La questione di Tunisi.», «La Colonia Eritrea», «La Somalia», «La guerra d’Etiopia e le sue conseguenze»15; e ancora «La prima impresa coloniale: Massaua», «Il massacro di Dogali», «La ripresa africana e il disastro di Adua», «L’impresa libica»16. Tra la metà degli anni sessanta e i primi settanta titoli e trattazioni di questo genere scompaiono e le vicende coloniali finiscono confinate in poche, sbrigative righe, a margine della trattazione della politica dei governi Crispi, Giolitti e Mussolini. I caratteri dell’espansione coloniale italiana In questi stessi anni, i manuali cominciano a rendere ragione degli studi e delle riletture sull’età dell’imperialismo, conclusasi da poco e dunque terreno di coltura assai fecondo per la ricerca storica: l’argomento è infatti affrontato quasi sempre in maniera abbastanza esauriente, rinnovata e critica nei confronti delle imprese europee. Gli imperialismi inglese, francese, tedesco, belga vengono analizzati secondo le peculiarità proprie di ciascuno ma anche, comparativamente, nei punti di contatto con gli altri, mettendone bene in evidenza la portata storica. Nell’ampio spazio guadagnato dalla trattazione del fenomeno imperialista, non trova posto una più ampia e critica analisi del colonialismo italiano che, collocato separatamente e privato di un’analisi delle sue specificità, viene fatto apparire come diverso e meno importante. C’è chi sottolinea tale diversità esplicitamente: La politica coloniale dei paesi come la Gran Bretagna, la Francia e poi anche della Germania era espressione di uno sviluppo capitalistico finanziario e industriale presente: flotte ed eserciti potenti la sostenevano. Ma l’Italia non era affatto in simili condizioni. Il capitalismo italiano non fu il prodotto di un forte capitalismo bensì di un insieme di elementi il cui centro era negli interessi settoriali di alcuni strati della classe dirigente17. 136 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia Alcuni autori sostengono la diversità del colonialismo italiano facendo riferimento alla definizione data da Lenin quando, riferendosi all’impresa italiana, parlò di «colonialismo straccione»: L’imperialismo italiano assomigliava a quello che, più tardi, Lenin avrebbe definito «l’imperialismo degli straccioni»18. Il colonialismo italiano è, dunque, anomalo e marginale anche per gli autori che ne offrono una visione critica. Se ne analizziamo le caratteristiche economiche e politiche, da un punto di vista strettamente europeo, non si può che assentire: l’espansionismo italiano è stato tardivo, povero di risorse, per certi versi dilettantesco e per niente remunerativo rispetto a quello degli altri paesi ma la prospettiva su cui queste considerazioni poggiano è, tuttavia, parziale in quanto non tiene conto della caratteristica fondamentale che accomuna tutte le dominazioni coloniali: il rapporto di sudditanza, sfruttamento e violenza del colonizzatore nei confronti del colonizzato19 che non solo ha provocato danni incalcolabili in termini di vite umane, perdita della libertà e depauperamento delle risorse dei territori che ne sono stati oggetto, ma ha condizionato anche la storia successiva alla fine della colonizzazione. Un elemento, i cui effetti non sembrano adeguatamente «pesati» dai manuali nel bilancio della penetrazione europea in quei continenti che oggi rappresentano il cosiddetto sud del mondo. Una valutazione sostanzialmente assolutoria del colonialismo trapela anche dal testo curato nel 1988 da Giardina, Sabatucci e Vidotto dove si legge che le conquiste coloniali, pur «segnate dall’uso sistematico e indiscriminato della forza contro le popolazioni indigene», avrebbero sortito «alcuni effetti positivi sui paesi che ne furono investiti» in termini di sviluppo delle tecniche agricole, di industrializzazione e introduzione di «migliori ordinamenti amministrativi e finanziari»: sarebbe stato, dunque, messo in moto «un processo di sviluppo», anche se in funzione degli interessi dei colonizzatori.20 Nella sfera delle attenuanti, che impediscono di condannare il fenomeno del colonialismo, si inserisce per quanto riguarda quello italiano anche la considerazione che, essendo stato di entità minore rispetto agli altri, avrebbe prodotto meno danni. Una interpretazione che contribuisce ancora oggi a mantenere in vita un altro dei «refrain» classici della propaganda coloniale di epoca liberale e fascista, quello del «colonialismo diverso»: un presunto carattere distintivo che veniva fatto discendere, da un la137 Grazia De Michele to, dal mito del «bono italiano» e, dall’altro, da un presunto diritto italiano all’espansione derivante dall’eccedenza di popolazione e dalla scarsità di risorse del paese. Un’argomentazione utilizzata dai governi liberali prima e dal fascismo poi se non altro per spiegare perché, invece di concentrare energie e risorse sul Mezzogiorno d’Italia ci si imbarcava in avventure d’oltremare nemmeno troppo fortunate. È sorprendente come la «giustificazione demografica», secondo la definizione di Nicola Labanca21, sopravviva alla fine del colonialismo e alla disponibilità dei dati relativi all’emigrazione, che mostrano chiaramente come i nostri connazionali si siano spostati prevalentemente verso le Americhe e l’Europa e solo in misura infinitamente minore verso l’Africa dove, fra l’altro le mete preferite non erano la Libia, l’Eritrea e la Somalia e ancor meno l’Etiopia, che non fu mai completamente soggiogata e quindi idonea ad accogliere nuovi insediamenti. Eppure fino alla metà degli anni settanta le motivazioni addotte nei manuali scolastici per spiegare la politica coloniale sono sempre le stesse: Certamente, se c’era nazione in Europa che avesse diritto all’espansione coloniale era l’Italia, paese povero, in cui la popolazione in rapido aumento non trovava risorse sufficienti per la vita, né le nascenti industrie le materie prime necessarie22. La portata del fenomeno migratorio e la conseguente necessità di protezione delle comunità italiane obbligarono il governo a dedicare attenzione al problema coloniale, in quanto l’acquisto di possedimenti d’oltremare avrebbe potuto dischiudere agli Italiani in patria esuberanti, vie nuove di espansione. L’avvento del Crispi segna, infatti, una decisa ripresa della politica di penetrazione nell’Africa23. All’azione militare seguì quella politica nel proposito di rendere colonie di popolamento quei possessi coloniali, dando terra e lavoro alle migliaia e migliaia di italiani, che, costretti ad emigrare, trovavano chiuse le porte in colonie di altri paesi. Era ciò possibile? La Libia e la Somalia avrebbero potuto risolvere del tutto il problema dell’emigrazione italiana? Non forse le spese militari occorrenti sarebbero pesate gravemente sul bilancio dello stato? Le bonifiche costosissime, dei terreni coloniali non sarebbero state nuovo e grave peso al bilancio? Tutte queste domande hanno pure il loro valore per pesare la gravità dei sacrifici che la politica coloniale importava; ma si deve pur convenire che tanti sacrifici valevano ad assicurare all’Italia, potenza mediterranea, un suo posto nell’Africa mediterranea, procurando a molti italiani terra e lavoro quando le porte di paesi ricchi erano appena socchiuse all’emigrazione italiana. L’Europa era chiamata a fare opera di civiltà nell’Africa. E a questa opera l’Italia partecipava. Ragioni dunque non mancarono a giustificazione di un’attiva politica coloniale24. 138 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia In alcuni casi l’emigrazione non viene presentata solo come una spinta verso l’opzione espansionista o come un proposito dei nostri governanti al momento di lanciarsi nella gara di spartizione coloniale ma come addirittura un fatto verificatosi realmente: La colonia, [la Libia] pur non essendo ricca, costituì un importante sbocco per il lavoro italiano, che trovò in quelle terre assai vicine una comoda risorsa25. Quei territori [libici] o meglio quelle popolazioni erano in condizioni di arretrato incivilimento e di povere risorse economiche; comunque ora al lavoro indigeno e al lavoro italiano era aperto un grande campo di attività; quelle province potevano dare all’Italia frutta, agrumi, grani, animali, fosfati, sale; l’Italia poteva là importare i suoi manufatti e soprattutto risolvere, in parte almeno, il problema dell’emigrazione per molti nostri disoccupati e nullabbienti26. Solo nei primi anni settanta cominciano ad affacciarsi nei manuali di storia motivazioni più realistiche, che almeno mostrano d’essere il frutto di una riflessione più attentamente critica sui fatti esposti: Crispi e quegli intellettuali e uomini politici specialmente meridionali che allora si fecero fautori di una simile prospettiva imperialistica, intendevano così orientare verso l’esterno la grave tensione sociale esistente nelle campagne27. [Il fascismo] fu indotto a ricercare nelle conquiste coloniali un rimedio alla depressione e alla stagnazione economica e un motivo di prestigio e di consolidamento interno e internazionale28. L’espansionismo coloniale era ormai una necessità per il nuovo capitalismo italiano che aveva bisogno di nuovi mercati e nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime. L’Italia si inserì quindi in quel vasto processo di spartizione dell’Africa tra le grandi potenze che portò alla formazione dei grandi imperi coloniali29. Negli anni novanta è possibile rintracciare in qualche manuale un’interpretazione complessiva del colonialismo italiano demistificata e coerente. Il testo di Capra, Chittolini e Della Peruta, ad esempio, segnala le «ragioni di prestigio internazionale» che spinsero l’Italia a lanciarsi nella gara imperialistica, nonostante «[le] ambizioni non [fossero] sorrette da un adeguato potenziale economico». Una caratteristica che, a giudizio degli autori, si accompagna all’assunzione di «un aspetto letterario e demagogico con la retorica rivendicazione dell’eredità imperiale romana e della missione italiana nel mondo», il cui acme è rappresentato dall’adesione di poeti e intellet139 Grazia De Michele tuali, come Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio, alla campagna di Libia. In questo quadro generale, l’impresa etiopica viene ricordata nelle sue vesti di operazione propagandistica, ideata dal regime allo scopo di assicurarsi il consenso «delle classi popolari, specie del Mezzogiorno, dove aveva fatto presa l’idea che «l’impero avrebbe potuto appagare la fame di terra dei contadini», e destinata a segnare «il culmine dell’adesione al regime»30. E sono sempre i manuali più recenti a denunciare le responsabilità del colonialismo, non solo italiano, sia per quanto riguarda le violenze e le privazioni cui furono sottoposte le popolazioni autoctone sia per quanto riguarda le conseguenze economiche, sociali e politiche che ancora oggi gravano sul continente africano. Tuttavia spesso i tentativi di ricercare le ragioni dell’attuale sottosviluppo anche nella storia precoloniale dell’Africa svelano la povertà di conoscenze degli autori sulla storia e la realtà del continente di cui sembrano loro sconosciute le peculiarità e al quale applicano coordinate interpretative che se possono attagliarsi perfettamente alla storia del continente europeo con quella dell’Africa hanno poco a che vedere. Se da una parte, infatti, viene denunciato il volto del colonialismo, anche italiano, forse ben più crudele e disumano di altri, dall’altra è l’approccio con le storie «altre» che continua a non convincere, proprio perché non riesce a liberarsi dal peso dell’eurocentrismo - che certo la tardiva decolonizzazione dei nostri studi sull’Africa non ha contribuito a corrodere - e di una visione ancora evoluzionistica e unilineare della storia, in virtù della quale le cosiddette «società senza stato» sono necessariamente più deboli, insanguinate da lotte intestine, «tribali» e accecate da «pseudoreligioni»: Nel «continente nero» l’allargamento del dominio diretto degli europei fu facilitato dalla debolezza delle strutture politiche e sociali preesistenti nelle regioni centro-meridionali. In queste zone la caratteristica dominante era infatti l’esistenza di società rurali senza ben definiti apparati statali, dominate da capi tribù e caste di sacerdoti che celebravano i riti di religioni primitive animiste e feticiste. E la maggior parte dei gruppi dominanti di queste genti accettò la sudditanza dai bianchi in cambio della conservazione di una parte dei propri privilegi sul resto delle popolazioni. Il dominio coloniale in Africa mirò prevalentemente a mettere le risorse economiche africane al servizio degli interessi degli europei, spesso con metodi duri e brutali come l’appropriazione di terre destinate alle piantagioni (caffè, palma, ecc.), il lavoro forzato degli indigeni, l’imposizione di alte tasse. Tali pratiche ebbero effetti distruttivi sulle società africane, costrette a distorcere le loro povere agricolture verso produzioni indirizzate ad altri mercati, con gravi ripercussioni sulle popolazioni: queste furono così condannate a una condizione di sottosviluppo e di miseria appesantita dal fatto 140 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia che venne a lungo trascurata l’attività industriale. [...] In conclusione si può affermare che il colonialismo alterò l’identità culturale delle genti africane, che furono inserite in formazioni statali artificiose che non rispettavano le tradizioni e i caratteri etnici delle varie popolazioni. [...] Le operazioni [in Etiopia] furono condotte dal comando italiano con 400.000 militari (dotati di aerei, carri armati e aggressivi chimici largamente impiegati)31. La resistenza dei ribelli [libici] fu vinta con le armi, in una lotta che soprattutto in Cirenaica, fu condotta con metodi molto violenti: il maresciallo Rodolfo Graziani (1882-1955) fece ricorso a rappresaglie, deportazioni di popolazioni, esecuzioni sommarie, provocando decine di migliaia di vittime. Vennero quindi confiscati e assegnati ai contadini italiani 65.000 ettari di terre incolte o scarsamente coltivate. In Somalia il dominio italiano, limitato inizialmente a un’area piuttosto ristretta, venne ampliato, anche in questo caso piegando con la forza la resistenza delle popolazioni e dei vari capi locali. Furono avviate imprese di colonizzazione, affidate a società private con il sostegno del governo e con l’impiego di lavoro coatto indigeno. [L’Eritrea] forniva gran parte delle truppe indigene (ascari) utilizzate dall’Italia nelle sue operazioni militari in Africa. [...] [La campagna militare per la conquista dell’Etiopia fu] condotta con grande abbondanza di uomini e mezzi e con l’uso di gas tossici. [...] Il processo di decolonizzazione dell’Africa subsahariana e australe fu rapido e impetuoso, ma risenti di alcuni fattori negativi: [ad esempio] la mancanza di una tradizione politica autonoma e quindi la dipendenza dai modelli e dai valori imposti dai colonizzatori. [...] A differenza dei popoli asiatici, spesso eredi di civiltà millenarie, e di quelli arabi, [in Africa] non esistevano concetti quali nazione o patria a guidare i movimenti indipendentisti32. La «missione civilizzatrice» Va riconosciuto, dunque, ai testi pubblicati negli ultimi quindici anni il merito di non aver occultato la ferocia e le pesanti responsabilità degli europei. Tuttavia molta è la strada da fare ancora per portare sui banchi di scuola la conoscenza e lo studio della storia del colonialismo italiano e quella dell’Africa - anche antecedente alla seconda metà dell’Ottocento - secondo più appropriate coordinate storico-antropologiche che sono ormai considerate parte integrante del metodo storico. Indubbiamente si tratta di analisi molto diverse da quelle risalenti a trenta o quarant’anni fa, quando non era nemmeno immaginabile la possibilità di muovere critiche all’imperialismo, di cui si continuavano a tessere le lodi per il suo contributo alla diffusione della «civiltà»: [L’espansione coloniale] era giusta in se stessa, le popolazioni arretrate degli altri continenti non avendo il diritto d’impedire che le risorse dei loro paesi fossero messe in va141 Grazia De Michele lore dalla superiore civiltà occidentale33. Un esempio significativo del senso di confusione e disarticolazione che possono dare solo i giudizi espressi su questioni di cui si ignora forse anche l’esistenza è il testo di A. Rossi, del 1967: Il fenomeno dell’espansione coloniale appartiene soprattutto alla storia europea, perché, anche se si svolse in terre geograficamente lontane dalla sede dei popoli che lo promossero, fu intimamente connesso con la civiltà del nostro continente. Le conquiste che diedero luogo alla formazione degli imperi coloniali, pur avendo avuto inizio nell’epoca dei grandi viaggi e delle grandi scoperte, si sono politicamente consolidate nel XIX secolo, seguendo di pari passo l’evoluzione politica ed economica delle grandi potenze. A queste infatti si rese sempre più necessario reperire fuori dal territorio metropolitano un’area destinata a dar sfogo all’industria e ai traffici e ad incrementare la reputazione nazionale. È d’altronde vero che le suddette potenze non mancarono di compiere un’opera civilizzatrice a favore dei popoli arretrati, ma appare altrettanto palese che esse hanno in pari tempo curato preminenti interessi economici e di prestigio, che avevano ben poco a che fare con lo spirito umanitario. Purtroppo le colonie sono sempre state causa di gelosie, di rivalità e di guerre: ciò rende evidente che la missione civilizzatrice non ha mai operato come movente predominante. La verità è che ciascuna potenza politica ha sempre cercato di accaparrarsi più terre che ha potuto senza badare ai bisogni e alle altrui aspirazioni, e soprattutto ha posto le popolazioni assoggettate ad un livello di inferiorità. Sono state svolte opere animate da un autentico spirito umanitario, quali quelle dei pionieri, dei missionari e dei medici, ma esse meglio si prestano a venir considerate al di fuori e al di sopra degli stretti interessi politici, perché, più che essere delle singole nazioni, appartengono a quelle della civiltà umana essendo state animate dagli ideali della libertà e della carità e non dai moventi della conquista. Ciononostante i domini coloniali ricevettero un impulso evolutivo rispondente all’importanza civilizzatrice lasciata dai conquistatori, perché questi ultimi trasportarono nelle terre occupate la cultura, le costumanze, la lingua, le istituzioni e le leggi delle loro patrie, trasformando le preesistenti condizioni di vita. Così, ad esempio, dalla colonizzazione inglese e francese nacquero nazioni ormai pienamente emancipate, entrate nel novero dei paesi liberi con un’impronta indelebile di civiltà lasciata loro dagli antichi dominatori. Bisogna però aggiungere che il sistema coloniale ha ricevuto una decisiva condanna dall’attuale civiltà. Pertanto, il processo di liberazione che ne è scaturito si manifesta come un fenomeno irreversibile, anche se contrasta, almeno in parte, gli interessi europei34. Le argomentazioni addotte dall’autore - ammesso che tali si possano definire - per rendere ragione di un fenomeno storico estremamente com142 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia plesso e dibattuto quale quello coloniale sono improntate ad un banale pietismo lontano anni luce da qualsiasi criterio di scientificità. Dietro l’apparente intenzione di fornire un bilancio obbiettivo, l’autore mostra di ignorare nel 1967, anno di pubblicazione del manuale, la guerra di liberazione che aveva messo a ferro e fuoco l’Algeria; la secessione del Katanga, che aveva insanguinato il Congo e avviato la dittatura, quella del Biafra che era alle porte e il Ghana, il primo stato africano a vedersi riconosciuta l’indipendenza, che aveva già concluso la sua fragile esperienza democratica: in quegli anni la parola «neocolonialismo» era già stata coniata per dare nome alla perpretazione dei soprusi e dello sfruttamento dei potenti ai danni dei più deboli, ma l’autore del manuale definisce le nazioni nate dalle macerie del colonialismo pienamente emancipate e libere grazie all’opera di civilizzazione dei dominatori. Il dato sconcertante è che tali tesi non compaiono in un articolo di giornale, un pamphlet o un libro qualsiasi ma in un manuale scolastico, uno degli strumenti didattici e pedagogici di fatto più importanti, cui è affidata la formazione anche civile - ancor più quando si tratta di manuali di storia - delle giovani generazioni. Coerenti con una visione così assolutoria sono i bilanci sull’operato italiano proposti in altri manuali, pubblicati sul finire degli anni sessanta; che spesso ricalcano il taglio spiccatamente autocelebrativo, tipico delle formulazioni dei decenni precedenti: Dando atto all’Italia degli ottimi precedenti della sua amministrazione coloniale, l’ONU le affidò nel 1950 l’amministrazione fiduciaria della Somalia con l’incarico di condurre il paese all’indipendenza al termine di un decennio. Il governo italiano attenne con scrupolo al ciclo evolutivo stabilito dalla massima organizzazione internazionale e nel 1960 è sorto il nuovo stato della Somalia ingrandito dall’assorbimento della Somalia Britannica cui Londra alla stessa data ha concesso l’indipendenza35. L’analisi sin qui esposta dimostra che le rappresentazioni artificiose, le omissioni, le falsità sull’Italia in Africa sono rimaste in fondo le stesse: sia pure in forme diverse, i manuali continuano a proporre un messaggio intrinsecamente razzista e discriminatorio in forza del quale, ad esempio, le forze militari di ras Alula rimangono sempre «orde»36 e i gas sull’Etiopia non sempre appaiono degni di essere ricordati. Singolare è il caso dell’ultima edizione del testo di Rosario Villari che, dopo aver liquidato la guerra italo-etiopica nello spazio di sei righe senza spendere una parola sui mezzi con cui essa fu condotta, riporta tra i riferimenti bibliografici Le guerre 143 Grazia De Michele coloniali del fascismo e I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, di Angelo Del Boca37. È anche per via di queste pratiche omissive che a quasi settant’anni dalla fine dell’epopea coloniale nel nostro Paese, ne sopravvivono i miti e le ideologie. Edizioni a confronto: due casi esemplari Fino alla fine degli anni sessanta, i manuali non subiscono sostanziali rinnovamenti nell’impaginazione e nei contenuti rispetto all’epoca fascista. Il fenomeno non riguarda soltanto la trattazione del colonialismo italiano ma dell’intera storia contemporanea: l’aggiunta di capitoli e appendici sul fascismo, la II guerra mondiale, la Resistenza, l’avvento della democrazia nel nostro paese, non aiuta a bilanciare la mancata riflessione sugli avvenimenti precedenti. Così l’aggiornamento dei testi risulta svuotato di significato sia perché non promuove alcun cambiamento di prospettiva da cui guardare al passato sia perché esso sembra guidato dal proposito di riproporre vecchie categorie di pensiero e di giudizio, mistificando la realtà storica invece che aderirvi il più possibile. Un fenomeno che sembra dettato dal clima generale di rimozione della dittatura fascista e dalle molteplici spaccature - sul piano politico, sociale, culturale, individuale - che avevano segnato gli anni della seconda guerra mondiale. In realtà, una seria riflessione su questioni così delicate e strettamente connesse ai mutamenti epocali verificatisi in Italia a partire dal 1945, per quanto difficile, avrebbe potuto aprire la strada ad un nuovo modo di percepire l’appartenenza alla comunità nazionale, i cui valori fondamentali vengono trasmessi anche attraverso l’insegnamento della storia. Pur non mancando, negli anni cinquanta e sessanta, accesi dibattiti, questi restano circoscritti al mondo intellettuale, alla sfera ristretta della cultura «alta». Manca nel Paese un progetto politico finalizzato al coinvolgimento delle masse nell’opera di ricostruzione dell’identità italiana, declinata nelle nuove istituzioni repubblicane38. L’obiettivo principale da perseguire appare il superamento dei traumi causati dal fascismo, dalla guerra disastrosa in cui aveva trascinato il paese, dalla sconfitta e dalla lotta di liberazione che sembrava aver lacerato le coscienza collettiva degli italiani. Il desiderio di normalizzare la vita della nazione e di guardare al futuro condiziona la ricostruzione del passato, resa pacifica, rassicurante, capace «di allineare in soporifera convivenza gli elementi più opposti», come sot144 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia tolineano, nel 1964, i curatori dell’indagine sui manuali di storia pubblicata sulla rivista dell’Insmli39. Il taglio con cui viene affrontato il colonialismo non è migliore. Il razzismo, le distorsioni propagandistiche della realtà storica, la retorica e gli stereotipi di epoca liberale e fascista sono più nascosti, più subdoli ma contribuiscono ancora a giustificare l’operato italiano in Africa e ad impedirne una più corretta rilettura. Per meglio chiarire quanto si sta dicendo, è utile confrontare due o più edizioni di uno stesso testo, l’una pubblicata durante il fascismo e le altre apparse nei primi due decenni del dopoguerra. I manuali di Alfonso Manaresi. Il mito di Dogali e la guerra italo-turca Un caso esemplare è quello rappresentato dai testi di Alfonso Manaresi, tra i più diffusi, longevi ed esemplificativi della manualistica scolastica relativa alla storia, almeno fino alla seconda metà degli anni sessanta. Particolarmente significativa è la ricostruzione della battaglia di Dogali che offrono. Nell’edizione del 1951 si legge: [Ras Alula] il 26 gennaio 1887 attaccava con cinquemila uomini una colonna di nostri soldati, che procedeva verso l’altopiano, agli ordini del colonnello De Cristoforis, e barbaramente la massacrava presso Dogali40. Pur riproponendo la versione del «barbaro massacro», la presentazione della vicenda è sicuramente più edulcorata rispetto all’edizione del 1936, immediatamente a ridosso dell’aggressione fascista all’Etiopia: [Ras Alula] il 26 gennaio 1887 attaccava con 5.000 uomini una colonna di nostri soldati, che procedeva verso l’altopiano, agli ordini del colonnello De Cristoforis, e barbaramente la massacrava presso Dogali: il colonnello rimasto con pochi in mezzo al campo di battaglia, ordinò ai superstiti di presentare le armi ai caduti, e morì coi suoi, crivellato di ferite, gridando: «Viva l’Italia!». La notizia di questa sventura suscitò nella fiacca Italia di quei tempi assai più dolore che sdegno; il governo, responsabile del modo con cui si compievano queste spedizioni coloniali allestite spesso con un’inesperienza indecorosa, non fece che dimettersi, per poi rimanere al potere quando, tra crisi e crisette, non si trovò chi voleva sobbarcarsi alle responsabilità di quel momento. Così l’Inghilterra poté interporsi tra l’Italia e l’Abissinia, dandosi l’aria di salvare la situazione, e in realtà tentando di stabilire un controllo sulla nostra attività coloniale41. La battaglia di Dogali rappresenta uno dei capisaldi della propaganda colonialista italiana liberale e fascista: Angelo Del Boca, che ha cercato di 145 Grazia De Michele ricostruirne il reale svolgimento, sostiene che «con Dogali siamo all’eroismo di massa. Con Dogali tocchiamo le più alte vette della retorica, dell’invenzione e del delirio patriottardo42. La notizia dell’inattesa sconfitta africana giunge in Italia proprio quando comincia a diffondersi nel paese l’idea che gli intenti della spedizione in Africa erano assolutamente pacifici e di natura commerciale. Il malcontento si diffonde nelle piazze di molte città italiane dove la folla chiede l’immediato ritiro delle truppe, mentre alla Camera il deputato socialista Andrea Costa pronuncia il famoso discorso in cui dichiara di non essere più disposto a dare «né un uomo né un soldo»43 per l’Africa. Tuttavia il ritorno in patria dei superstiti e dei feriti fornisce al governo e alla lobby colonialista dell’epoca un ottimo pretesto per infondere, attraverso la strumentalizzazione del dolore della popolazione, quello spirito di vendetta e di amor patrio ferito che costituirà la base di rilancio dell’iniziativa coloniale. Con manifestazioni che si susseguono in tutta la penisola, il mito di Dogali, dei coraggiosi soldati presi alla sprovvista dalle «orde di ras Alula», del colonnello De Cristoforis che pur morente trova la forza di presentare ai caduti l’onore delle armi e inneggiare all’Italia, dei corpi massacrati barbaramente ma allineati come fossero sull’attenti, si va modellando fino a sostituire alla concretezza dei fatti la fantasia e la retorica. L’edizione del 1936 del manuale di Manaresi ripropone due dei topoi classici della mitologia liberale e poi fascista su Dogali: i corpi straziati dei caduti e De Cristoforis patriota sino all’ultimo. Nel definire «fiacca» l’Italia liberale e «indecorosa» l’inesperienza del governo Depretis, ridicolizzato per via di «crisi e crisette», Manaresi dà voce al «rifiuto [tipico della propaganda fascista] dell’ordine liberaldemocratico degli anni successivi all’unità d’Italia, come deviazione rispetto alla vera vocazione del paese»44, quella imperiale, cui le classi dirigenti pre-fasciste «rinunciatarie» e «agnostiche» non avevano saputo dare corpo. Al modello di stato liberale, indebolito dalle macchinazioni delle sue stesse correnti, «fiacco» in quanto incapace di comporre i conflitti sociali, di tenere unita la nazione e di sospingerla verso il compimento della sua missione civilizzatrice nei confronti del mondo, si contrappone - secondo la propaganda di regime - quello fascista, unito, autorevole, delegato dal destino a riportare l’Italia ai fasti della «romanità». L’edizione del testo successiva alla seconda guerra mondiale se risulta emendata degli eccessi della propaganda di regime in realtà non rielabora la presentazione dei fatti su Dogali alla luce della riacquistata libertà di 146 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia espressione e delle esperienze e riflessioni maturate nel frattempo. Se gli slogan e le parole del Duce vengono cancellati, la valutazione storica di sessant’anni di espansionismo non cambia, infarcita ancora dagli stessi stereotipi e preconcetti e impregnata del razzismo e dell’ideologia coloniale di marca sia liberale che fascista. Così nell’edizione del 1948 e in quella del 1951 è possibile leggere: Il Crispi fu tratto a ideare un vasto piano coloniale, che se non fosse stato frustrato dall’incapacità di chi doveva porlo ad effetto, avrebbe aperto all’emigrazione italiana un promettente avvenire45. Anche in Italia alcuni uomini chiaroveggenti si erano dimostrati favorevoli ad una nostra partecipazione al movimento europeo di espansione coloniale; [tuttavia] indecoroso [era] il disinteresse [delle classi dirigenti italiane nella seconda metà del XIX secolo] per le iniziative coloniali, che pur facevano vibrare i maggiori Stati europei e li sospingevano verso nuove fortune. Veri apostoli furono in quei tempi i pochi ma audaci esploratori italiani, come l’Antinori, l’Antonelli, il Cecchi, il Giulietti, il Bianchi, che perlustrarono la regione etiopica; qualcuno fra essi, come il Giulietti (1881) e il Bianchi (1884) vi perdette la vita; valorosi missionari, come il Massaia e lo Stella, per parecchi decenni evangelizzarono le barbare tribù dell’interno, spesso invocando l’intervento della patria su queste terre abbandonate al disordine e all’anarchia46. E ancora: Vittorio Bòttego fra il 1892 e il 1893 visitò le zone misteriose dell’alto Giuba [...] purtroppo una tragica fine, per mano dei selvaggi, attendeva il nostro coraggioso pioniere47. [Ad Amba Alagi] il negus marciò con le sue orde [contro l’esercito italiano]48. Così finiva questa guerra d’Africa, che costò all’Italia tanto sangue, ed ebbe purtroppo una trista influenza nell’animo del popolo italiano, rimasto poi per molti anni assai ostile ad ogni impresa coloniale49. [Il problema coloniale] aveva per noi un’importanza grande, poiché una fertile colonia africana avrebbe potuto accogliere una parte della nostra emigrazione, che andava invece disperdendosi per il continente americano50. La riproposizione di giudizi acriticamente ereditati da un’edizione all’altra e la scelta di una terminologia particolarmente denigratoria soprattutto nei riguardi dell’Altro (barbare tribù, disordine e anarchia, orde, ecc.) contribuiscono efficacemente a perpetrare ricostruzioni ancora fortemente colonialiste e di parte, che sfiorano palesemente il falso nella presentazione della campagna di Libia del 1911, il cui iniziale ed eroico successo sarebbe 147 Grazia De Michele stato funestato dalla fiducia riposta nell’arabo «infido» e traditore: Giungevano del resto dalla Libia notizie esasperanti: i Turchi, prevedendo le imminenti ostilità, avevano cominciato a maltrattare gli italiani residenti a Tripoli; eccitando il cieco fanatismo degli Arabi, avevano provocato l’assassinio di alcuni nostri coraggiosi missionari, mentre il valì di Tripoli, a noi avverso, intralciava l’opera della succursale tripolina del Banco di Roma e l’attività dei nostri commercianti51. Alcuni nostri reparti, incoraggiati dalle apparenti cortesie degli Arabi, avanzarono troppo nell’oasi di Tripoli e furono barbaramente trucidati. La nostra reazione fu immediata: catturati i colpevoli del tradimento, giustiziati subito i capi, imponemmo a tutti il rispetto della nostra bandiera, e sbaragliammo la successiva avanzata turco-araba. Anche in Cirenaica gloriosi fatti d’armi allargarono la cerchia delle nostre conquiste; tuttavia la resistenza del nemico, organizzato da un valente ufficiale turco, Enver bey, non ci permise di giungere a risultati definitivi52. L’aggressione fascista all’Etiopia Se per la prima guerra d’Africa e per l’impresa libica, l’impaginazione e i contenuti del testo di Manaresi nelle edizioni del dopoguerra sono, dunque, sostanzialmente immutati rispetto a quelli del 1936, le differenze nella trattazione della campagna d’Etiopia sono vistose. Interi capitoli, infatti, scompaiono; come nel caso del capitolo XIX, intitolato «L’impresa etiopica e l’assedio economico. Fondazione dell’Impero»53 e costituito, oltre che da una fitta narrazione degli eventi del 1935-36, da una minuziosa digressione sul colonialismo crispino e sugli sviluppi della politica interna ed estera dell’Etiopia dalla battaglia di Adua alle soglie della conquista italiana. In esso, l’azione di Crispi viene esaltata in quanto precorritrice di quella di Mussolini mentre la ricostruzione della storia etiopica appare manifestamente denigratoria: L’impero etiopico [alla morte di Menelik] rimaneva un caotico ammasso di genti, diversissime per razza, per religione, per costumi, sul quale la minoranza etiopica, feroce e guerriera dominava col terrore. I ras, potenti feudatari taglieggiavano orrendamente le popolazioni soggiogate, impoverendole con periodiche razzie, rubando raccolti e bestiame, traendo in schiavitù intere tribù, spaventando tutti con la loro crudeltà. Così l’Etiopia si affacciava al secolo ventesimo come un paese ancora selvaggio, dove era impossibile ogni progresso civile, dove la schiavitù era sfacciatamente praticata, la barbarie trionfava nelle sue forme più ripugnanti. [...]Il nuovo negus [Hailè Selassiè] si accinse al riordinamento dell’Etiopia [e] annunciò un vastissimo programma di riforme, destinato poi a fallire in buona parte per l’impreparazione dei dirigenti e per le re- 148 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia sistenze di un popolo, barbaro da millenni. Accorsero da ogni parte d’Europa sedicenti consiglieri, diplomatici falliti, tecnici di dubbia origine, ai quali vennero affidati posti nelle amministrazioni, negli uffici, nell’esercito, negli ospedali, nelle scuole. E l’Etiopia pullulò di cosiddetti «esperti» inglesi e americani, di ex ufficiali svedesi, belgi e turchi, di affaristi greci, di fuoriusciti turchi, di commercianti giapponesi, di avventurieri levantini. Addis Abeba e i principali centri dell’Etiopia presentarono la più caotica mescolanza di bianchi, di abissini, di negri: il più stridente contrasto fra i barbari usi tradizionali, le ingenue pretese di modernità e di civiltà, mentre i pochi giovani etiopici che avevano visitato l’Europa, si univano in associazioni patriottiche, assumendo atteggiamenti nazionalistici e grottesche pose imperiali. E ciò in un paese che aveva due milioni di schiavi, che ancora per punizione le più barbare mutilazioni, che non aveva scuole, strade, ospedali, nulla! In mezzo a tanta confusione di idee e di cose, il negus era riuscito a creare una sola soluzione seria: l’esercito54. Al di là di questa ricostruzione palesemente giustificazionista nei riguardi dell’intervento «civilizzatore» italiano, le vicende di politica interna relative all’Etiopia - ossia di quella non strettamente legata all’espansionismo europeo - dopo di allora non avranno più alcun posto nei manuali scolastici italiani: delle colonie africane - e non solo di quelle italiane verrà soltanto citato il nome senza fornire agli studenti alcuno spunto per approfondire la conoscenza dei territori e delle popolazioni assoggettate, e così privandoli della possibilità di comprendere quale influenza vi abbia esercitato il colonialismo e quanto complessa sia stata, successivamente, la decolonizzazione. La narrazione degli avvenimenti riguardanti la spartizione coloniale risulterà ridotta ad una cronistoria priva di qualsiasi forma di problematizzazione. Un’impostazione che indurrà ulteriormente nel lettore la sensazione di «immobilità» della storia dei popoli africani, storia che sembra iniziare solo quando interseca quella dei colonizzatori, emergendo allora da un abisso di presunta astoricità unicamente per l’intervento di forze esterne. La storia del popolo etiopico è stata oggetto, dunque, solo di una trattazione a scopo propagandistico la cui omissione nelle edizioni di epoca repubblicana non è stata compensata da alcun rinnovamento rispetto all’epoca fascista; le venti pagine del capitolo XIX vengono sintetizzate nel 1948 in un paragrafo di circa due pagine, depurate dalla descrizione dettagliata delle operazioni militari, dall’esaltazione del sostegno della nazione all’impresa, dall’aggressività esplicita nei confronti degli stati sanzionisti e dai proclami del Duce, ma perfettamente in linea con la precedente impo- 149 Grazia De Michele stazione: l’autore, infatti, riconduce l’iniziativa del governo italiano di aggredire uno stato africano indipendente, sovrano e membro della Società delle Nazioni alla presunta necessità di «aprire alla esuberante popolazione italiana uno sfogo per l’emigrazione»55 e di «riscattare l’umiliazione della vittoria mutilata»56. Il testo ripropone inoltre inalterate le rivendicazioni di epoca fascista nei confronti dell’Inghilterra e della Società delle Nazioni: Nel dicembre 1934 alcuni incidenti di frontiera tra l’Eritrea e l’Etiopia servirono di occasione a Mussolini per tentare la conquista dell’Etiopia, antico sogno di Crispi e dei nazionalisti italiani. Invero delle diverse azioni belliche del fascismo fu questa l’unica che, assistita da un’abile propaganda e favorita dalla perpetua incomprensione inglese per le necessità emigratorie dell’Italia, riuscì a raccogliere una notevole simpatia fra il popolo italiano. La Gran Bretagna, che non voleva gi italiani in Etiopia, portò la questione a Ginevra dove, difendendo tenacemente le ragioni del negus e del suo governo schiavista, riuscì a ottenere dalla Società delle Nazioni un voto contrario all’Italia (settembre). Ma Mussolini non recedette dal suo proposito e intensificò i preparativi militari, mentre l’Inghilterra inviava ostentatamente, in appoggio alla sua flotta nel Mediterraneo, l’intera flotta nazionale (Home Fleet) la tensione anglo-italiana divenne in quel momento gravissima. Tentativi di conciliazione fallirono, e Mussolini, lanciato ormai nel rischioso gioco, il 3 ottobre 1935 dichiarava guerra all’Etiopia, facendo varcare il confine eritreo dalle divisioni del generale De Bono e quello somalo dalle truppe del generale Graziani57. L’edizione del 1951 precisa: Le delusioni provocate in Italia dagli irrisori compensi coloniali concessi all’Italia dalla Francia e dalla Gran Bretagna, sospinsero Mussolini a tentare un’azione energica per aprire alla esuberante popolazione italiana uno sfogo per l’emigrazione. Nel dicembre 1934 alcuni incidenti di frontiera fra la Somalia e l’Etiopia servirono di occasione al dittatore per intraprendere la conquista dell’Etiopia, antico sogno di Crispi e dei colonialisti italiani58. «Una modesta guerra coloniale» L’ambiguità del giudizio di Manaresi sull’impresa del 1935-36 - e più in generale sull’intero espansionismo italiano - rispecchia la forte influenza che le consolidate giustificazioni propagandistiche esercitano ancora sull’opinione pubblica e l’atteggiamento della classe dirigente repubblicana che continua ad alimentarla. In sintonia con il clima dell’epoca l’autore non prende le distanze da quella che definisce riduttivamente «una mode150 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia sta guerra coloniale»59 la cui responsabilità viene fatta ricadere sull’Etiopia e sul «suo governo schiavista». Il riferimento alla categoria a-valutativa, come l’ha definita Luciano Canfora, di guerra coloniale sottintende «una sorta di fatalità della repressione, la cui responsabilità ricadrebbe in fondo, almeno in parte, sugli stessi colonizzati, rei di provocarla, in qualche modo, con la loro inquietudine e il loro ribellismo60. Canfora sottolinea come il riduzionismo da parte degli storici del dopoguerra nei confronti di quello che definisce «il genocidio dimenticato», compiuto «ai danni della popolazione etiopica durante e dopo l’aggressione italiana» e declassato a guerra coloniale, abbia attenuato il giudizio sul regime fascista, presentato come antidemocratico e autoritario ma meno efferato di altri. In quest’ottica e sulla scorta di un pregiudizio più o meno consapevolmente razzista, la guerra d’Etiopia - che racchiude invece per Canfora l’essenza stessa del fascismo - è considerata un episodio, un accidente della politica estera che ha reso visibile il declino della Società delle Nazioni e avvicinato l’Italia alla Germania hitleriana. Il testo di Manaresi appare perfettamente allineato su queste posizioni quando afferma che: Mai forse una modesta guerra coloniale ebbe così gravi conseguenze per la pace del mondo. Il modo maldestro col quale la controversia italo-etiopica fu trattata a Ginevra condusse al crollo del prestigio della società delle Nazioni, cioè al tramonto dell’unica idea, ancora superstite, della collaborazione pacifica trai popoli. [...] Quanto all’Italia [...] si apprestava a pagare il successo ad un prezzo assai elevato con l’asservimento alla Germania61. L’analisi storica si appiattisce, dunque, sulla conta dei danni politicodiplomatici, priva di spessore e profondità: le migliaia di vittime etiopiche e l’aver privato un intero popolo, dotato di un’organizzazione statuale millenaria, dell’indipendenza non rientrano, per Manaresi, nel bilancio complessivo dell’accaduto. I manuali di Pietro Silva Se Manaresi, seppure nel modo che abbiamo appena visto, non si sottrae al compito - sancito dai programmi ministeriali solo a partire dal 1960 - di occuparsi della storia più recente, altri autori scelgono, all’opposto, di chiudere le loro trattazioni con il primo dopoguerra omettendo temi come il fascismo, il nazismo, la seconda guerra mondiale, l’antifascismo, la Resi151 Grazia De Michele stenza e rendendo dunque manifesta, anche solo scorrendo l’indice dei capitoli, l’assenza di una qualsiasi rilettura, che la riflessione su tali argomenti avrebbe potuto ispirare, anche delle parti precedenti. Il testo di Pietro Silva destinato all’ultima classe dei licei e pubblicato nel 1952 ne costituisce un valido esempio. II capitolo XXII, l’ultimo, intitolato «L’Europa di Versailles e i suoi problemi politici ed economici» fornisce un excursus sulle conseguenze della I guerra mondiale e sui trattati di pace con qualche riferimento sporadico anche agli anni trenta: Nell’atmosfera di crisi che gravò sulla Germania nell’immediato dopo guerra, si preparò un movimento di risollevamento che dovrà poi portare il paese nel tragico caos della seconda guerra mondiale. Il movimento ebbe come esponente Adolfo Hitler, fondatore del partito nazional-socialista, la cui azione, iniziata con un tentativo di sollevamento a Monaco nel 1923, doveva in un decennio prima portare Hitler alla testa del governo e poi, con la morte di Hindenburg, a capo dello Stato (febbraio 1933). L’avvento di Hitler segnò in Germania la formazione di un regime totalitario, sul modello di quello creato dal fascismo in Italia. In politica estera Hitler si staccò dall’orientamento verso la Russia per avvicinarsi all’Italia, in cui, come vedremo, in quel periodo trionfava il fascismo62. In realtà nel prosieguo del capitolo non c’è alcun riferimento al fascismo, salvo un richiamo piuttosto vago al patto di Monaco del 1938 riguardo al quale viene data la semplice notizia della partecipazione di Mussolini insieme a Hitler e ai rappresentanti dei governi francese e inglese. Nella panoramica sui mutamenti dell’assetto economico mondiale all’indomani della Grande Guerra viene spiegato perché alcuni «Paesi meno favoriti, ma risoluti a difendere la loro autonomia e la loro libertà d’azione63 ricorsero all’autarchia senza, però, precisare che tale «espediente»64 era stato adottato anche dall’Italia fascista. Nell’escludere la storia contemporanea successiva al 1918, il manuale di Silva risponde ai programmi ministeriali dell’epoca i quali avallano, fino al 1960, una disposizione «provvisoria» del governo Badoglio, che prescriveva l’eliminazione di qualsiasi celebrazione del fascismo dai manuali65. A monte di questa decisione sembra esserci stata la preoccupazione da parte dei primi governi repubblicani di placare gli animi e costruire per il paese, appena uscito dalla guerra civile, un clima di operosa collaborazione. Tuttavia il silenzio su anni cruciali, che avevano così profondamente condizionato e trasformato la coscienza civile degli italiani, finiva col negare alla storia una delle funzioni sociali che le è universalmente riconosciuta, quel152 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia la della formazione dei cittadini, nel caso italiano ispirata agli ideali di democrazia e libertà che avevano sovvertito l’assetto statuale precedente. Nella relazione presentata al «Convegno sull’insegnamento della storia», organizzato nel 1952 dall’Associazione per la Difesa della Scuola Nazionale, Ernesto Ragionieri denuncia non solo che «in questa omissione dei programmi, nel non aver saputo cioè con una concreta spiegazione degli avvenimenti dell’ultimo trentennio rendere noti i fatti che erano stati artificialmente tenuti nascosti e combattere le false affermazioni che il fascismo aveva fatto penetrare nel bagaglio culturale, e fin nel senso comune di numerosi settori della piccola e media borghesia, debba essere rintracciato uno dei motivi che hanno consentito quella rapida diffusione del neofascismo tra i giovanissimi studenti che oggi constatiamo e deprechiamo» ma anche che tra gli autori dei manuali «non manca chi si avvale del silenzio dei programmi per compiere opera di falsificazione e di aperta propaganda politica»66. Tra questi spiccano i nomi di Alfonso Manaresi67 e Pietro Silva. Quest’ultimo, come rileva Ragionieri, pur nel pressapochismo con cui passa in rassegna le clausule del Trattato di pace riguardanti l’Italia non manca di definire la spedizione di Fiume del 1919 un «provvidenziale e trionfale» sussulto della «coscienza della Nazione», il «primo movimento di protesta contro le iniquità dei Trattati di pace»68. La raccomandazione a chiusa dei programmi ministeriali allora vigenti riguardo alla «ripresa di coscienza generale dei fondamentali progressi umani nel corso storico, e presa di coscienza dei più gravi problemi ancora insoluti e delle nuove aspirazioni di collaborazione sociale e internazionale»69 resta evidentemente disattesa se Silva può permettersi di presentare così la politica colonialista di Francesco Crispi: Il sogno di Crispi era quello di un grande Impero coloniale italiano dal Mar Rosso all’Oceano Indiano, che avviluppasse tutta l’Abissinia70. Anche l’occasione di promuovere la cooperazione pacifica tra i popoli viene disattesa dal nostro autore anche quando commenta, più in generale, il fenomeno coloniale: Fra i caratteri più importanti e più ricchi di conseguenze nella storia del XIX secolo [dobbiamo annoverare] l’allargamento della penetrazione della colonizzazione europea a tutte le parti del globo, anche le più remote, impervie e selvagge: quali l’interno dell’Africa misteriosa, l’interno dell’Asia centrale, le terre polari: dovuto ad esplorazioni audaci ed importanti tanto quanto erano state quelle del sec. XVI e del sec. XVIl71. 153 Grazia De Michele Dieci anni dopo la coloritura razzista e stereotipata, con l’eliminazione di qualche aggettivo, si affina ulteriormente: Uno dei fatti salienti del secolo XIX è l’allargamento del campo della storia a paesi e continenti che fino ad allora erano rimasti piuttosto ai margini della civiltà, perlomeno della grande politica. E questo fenomeno è dovuto a due ordini di ragioni: 1. La formazione di organismi politici extra-europei in grado di rivaleggiare con le vecchie potenze tradizionali, formazione avvenuta ad opera (stati americani) o ad imitazione (Giappone) degli stessi europei; 2. L’allargamento della colonizzazione europea e la sua penetrazione in tutte le contrade del globo anche le più remote e le più selvagge72. Il periodo sopra riportato apre il paragrafo intitolato «L’espansione bianca nel mondo», quasi a voler sottolineare l’importanza e il valore strategico, ai fini dell’espansione, del colore della pelle dei conquistatori, i «bianchi», categoria da cui evidentemente vengono esclusi, ad esempio, i giapponesi, sebbene protagonisti della spartizione dell’Asia tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del secolo successivo. Il titolo del paragrafo, subdolamente, riconduce la questione dell’espansione europea a determinanti razziali facendo leva sull’antinomia stereotipa bianco-nero, per cui se l’espansione è bianca e si dirige verso i «selvaggi» questi ultimi saranno necessariamente neri. Ma è soprattutto l’immediato riferimento all’apertura del canale di Suez «mezzo prezioso» per l’espansione europea, grazie al quale si «rese più intensa l’esplorazione e la colonizzazione africana» - a suggerire a quale parte del mondo debbano riferirsi gli aggettivi «remoto» e «selvaggio». La conclusione del paragrafo è la stessa in entrambe le edizioni e precisa ulteriormente la caratterizzazione spiccatamente razzista dell’eurocentrismo di Silva: In questo periodo le questioni extra-europee assumono un’importanza sempre maggiore, anche come determinanti di avvenimenti europei; e se la vecchia Europa rimane pur sempre il centro più fulgido e più possente di storia e di civiltà, cessa di essere il centro unico, come per tanti secoli, anzi per millenni, era stata73. L’approccio generale al colonialismo da parte dell’autore è perfettamente coerente con quello più specificamente dedicato all’esperienza italiana, cui il testo del 1962 fornisce qualche illuminante accenno già nel paragrafo che abbiamo preso in esame poc’anzi, quando afferma che: Con l’apertura del Canale di Suez il Mediterraneo riacquistò l’importanza di via essen154 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia ziale per il traffico e per la vita mondiale; ciò doveva avere vantaggiose ripercussioni soprattutto per il paese più mediterraneo: l’Italia74. La retorica del «mare nostrum» ispira anche l’edizione del 1952 che non manca di ricordare, a proposito delle prime fasi dell’attività coloniale italiana come: L’insediamento sulle coste del Mar Rosso si presentava consigliabile anche come compenso, almeno parziale, alla grave delusione mediterranea subita dall’Italia nella questione di Tunisi; perché dopo l’apertura del canale di Suez, il Mar Rosso era diventato importantissima, essenziale via d’accesso al Mediterraneo. Il ministro Mancini affermò alla Camera al momento della spedizione di Massaua, che «nel Mar Rosso, il più vicino al Mediterraneo, si potevano trovare le chiavi di quest’ultimo75. Alla cosiddetta «delusione di Tunisi» viene dedicato un intero paragrafo che illustra, legittimandoli, i motivi che avevano spinto l’Italia a reclamare il possesso di quel territorio: La Tunisia, governata da un Bey nominalmente vassallo del Sultano, si presentava nella seconda metà del secolo XIX come una delle più floride e feconde regioni del Nord-Africa. Ciò non solo per le condizioni singolarmente favorevoli della sua posizione geografica, del suo clima e del suo suolo; ma anche per virtù del tenace lavoro fecondatore dei coloni italiani, provenienti soprattutto dalla Sicilia, che a decine e decine di migliaia si erano insediati su quella terra tanto contigua all’Italia, così da presentarsi come un prolungamento della Sicilia, dalla quale era separata da un piccolo braccio di mare e con la quale aveva comuni singolari affinità di clima e di configurazione e costituzione del suolo. Perciò verso la Tunisia erano naturalmente tese le aspirazioni italiane a quell’espansione mediterranea che per l’Italia, risorta a unità e grandezza di Nazione, costituiva insieme una necessità e un diritto76. Una cartina della Tunisia, allegata al paragrafo, in cui sono indicati «i nomi delle antiche province romane»77 è il segno evidente che i temi e gli strumenti della propaganda fascista e coloniale non abbiano esaurito il proprio corso, come dimostrano, del resto, anche le pagine successive con le agiografie sugli «audaci e benemeriti esploratori italiani dei misteri d’Africa»78, la lettura leggendaria della sconfitta di Dogali, la rappresentazione bozzettistica degli etiopici79 e la ricostruzione della battaglia di Adua: Il comandante supremo, generale Baratieri, rivelò in quel momento una mancanza di energia e di iniziativa, che compromisero la nostra situazione. Poi, assillato dai rimproveri di Crispi e preoccupato dal possibile esaurimento di viveri, tentò di giocare la car155 Grazia De Michele ta suprema in una battaglia decisiva. L’azione improvvisata, in una località scarsamente conosciuta, finì in una .sconfitta (battaglia di Adua, 1° marzo 1896). Era un insuccesso non più grave di altri che tutte le Potenze coloniali, cominciando dall’Inghilterra, hanno incontrato nella loro espansione coloniale, e perfettamente riparabile con misure di prontezza e di energia; tanto più che anche ad Adua il mirabile valore del soldato italiano aveva dato fulgide prove, pur nella sventura. Invece, le sue conseguenze furono gravissime per lo Stato di depressione in cui cadde la Nazione. Crispi, che avrebbe voluto la continuazione della lotta e la rivincita, venne travolto, e il suo successore, marchese Di Rudinì, si affrettò a concludere la pace di Addis Abeba (ottobre 1896), che implicava la rinuncia al trattato di Uccialli, e la riduzione della Colonia Eritrea entro limiti più ristretti. Così tristemente finì la prima prova di attività coloniale italiana, mentre anche le condizioni interne si aggravavano80 . Anche a proposito della battaglia di Caporetto viene fatta la stessa precisazione: Si trattava di un rovescio inizialmente non superiore, né più grave di tanti rovesci subiti da tutti gli eserciti combattenti81. Il bilancio di Adua, come oggi sappiamo, fu molto pesante: dei sedicimila soldati combattenti circa cinquemila italiani e mille ascari rimasero sul campo e tra 1.600 e 1.900 italiani e circa un migliaio d’indigeni furono fatti prigionieri82. Si trattò della più grave sconfitta che un esercito europeo avesse subito in Africa dai tempi di Annibale, come ha fatto rilevare, tra molti, Richard Pankhurst83, secondo il quale la data del 1° marzo 1896 rappresenta simbolicamente l’inizio della «riscossa» africana nei confronti del dominio dei «bianchi». Adua resta un punto molto dolente per la coscienza nazionale degli italiani soprattutto per via delle reazioni e dei sentimenti contrastanti che ha suscitato: si è parlato in proposito del «complesso di Adua» o, come ha sostenuto Nicola Labanca84, dei «complessi di Adua» proprio per mettere bene in evidenza l’estrema eterogeneità delle risposte emotive e politiche, provenienti sia dagli strati più umili della popolazione che dai ceti dirigenti, di fronte all’evento in sé e, in seguito, ai fantasmi che evocava. Per anni il ricordo di quello scontro dagli esiti così disastrosi da far cadere un governo, mettere in crisi la monarchia sabauda e spingere gli italiani a radunarsi nelle piazze principali del paese urlando «Viva Menelik!» ha popolato gli incubi dei governanti liberali, divisi tra la paura che una circostanza si156 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia mile potesse ripetersi e la necessità della rivincita, per ridare slancio al moto di espansione coloniale che di fatto dopo Adua si era arrestato. Dal canto suo Mussolini, alimentò e strumentalizzò il revanchismo presentando la campagna d’Etiopia come la vendetta per l’ umiliazione subita quarant’anni prima, pur non pronunciando mai in nessuno dei suoi discorsi il nome di «Adua». Nel dopoguerra né gli storici né l’opinione pubblica né tantomeno i politici ritennero opportuno soffermarsi sulla questione, come accadde, del resto, per l’intera problematica coloniale. La rimozione è stata tale che nel 1996, in occasione delle celebrazioni per il centenario della battaglia, nonostante gli inviti e gli auspici del governo etiopico, nessuna delegazione italiana è stata inviata ad Addis Abeba: solo l’allora presidente della Commissione Esteri del Senato, Giangiacomo Migone, ha sentito il dovere prima di fornire all’Etiopia una risposta e poi, resosi conto che nessuno agli Esteri era intenzionato ad andare a «celebrare una Caporetto», di rappresentare l’Italia alla cerimonia. Adua continua ad essere un boccone amaro anche quando i punti di riferimento, i valori, le prospettive della nazione sono profondamente cambiati; continua a suscitare lo stesso imbarazzo e confusione che traspare, come si è visto, dalle poche righe che Silva dedica all’argomento e che sono identiche a quelle presenti nell’edizione fascista del suo manuale. Immutata è nei testi di Silva anche l’esaltazione dell’entusiasmo diffusosi al tempo della guerra di Libia, presentata dalla propaganda nazionalista come la rivincita di Adua: Codesta accorta e paziente preparazione della spedizione di Libia, contrastò felicemente con l’improvvisazione dell’altra spedizione africana, quella Eritrea, del 1885, decisa, si può dire, da un giorno all’altro, senza obbiettivi chiari e precisi e senza adeguata conoscenza dei luoghi e delle difficoltà. Altro felice e significativo contrasto, tra la situazione in cui si svolse l’impresa di Eritrea e quella in cui si svolse l’impresa di Libia, si rilevò nelle condizioni dello spirito pubblico. Al tempo della prima impresa, conchiusasi tristemente con Adua, l’Italia fu purtroppo teatro di manifestazioni e di proteste violente contro l’avventura africana, che giunsero a provocare gravi disordini; al momento dell’impresa libica, la grande maggioranza della Nazione fu presa da un sano e vibrante entusiasmo, che avvolse l’impresa in una atmosfera fervida85. L’edizione del 1962 sembrerebbe a prima vista meno «partigiana»: lo scarto con la campagna d’Eritrea si riduce ad una più accorta preparazione, da parte del governo, dell’opinione pubblica« evitando qualunque con- 157 Grazia De Michele fronto sul piano militare tra le due spedizioni; tuttavia «l’entusiasmo di larghi strati popolari» viene nuovamente definito trionfalisticamente come «vibrante»86. Quanto alla sconfitta di Adua, le cause vengono attribuite, non alla sorte, ma alla cattiva impostazione della politica espansionistica in Africa Orientale «poiché si era voluta fare una politica di forza e di guerra a oltranza contro il negus, senza aver apprestato i mezzi necessari in uomini e in armamenti87. Non si può certo dire che tali argomentazioni siano esaustive, ma sicuramente denotano il tentativo di spiegare storicamente la disfatta piuttosto che riproporre la tesi consolatrice della guerra sfortunata. Si tratta tuttavia di uno dei pochi esempi in questo senso. La maggior parte dei testi addossa le responsabilità a Baratieri o all’opinione pubblica ostile alla politica di Crispi, statista incompreso, banalizzando la complessità e la molteplicità dei fattori in gioco e, talvolta, fornendo ricostruzioni che dietro un’apparente obbiettività nascondono la riproposizione degli artifici propagandistici utilizzati dai governi liberali e da quello fascista. Così nel manuale di Raffaello Morghen, ad esempio, «la sconfitta [di Adua] non era irreparabile [ma trasformata in catastrofe nazionale travolse] Crispi mentre ancora fiammeggiavano le passioni che la sua opera aveva suscitato»88. L’autore, inoltre, fa risalire l’esaltazione fascista di Crispi all’epoca liberale affermando che dopo la sua caduta «da molti egli fu, infatti, esaltato come un grande uomo di stato, precorritore dei tempi»89 nonostante avesse voluto imporre «una politica di grandezza e di espansione a un popolo [...] al quale solo il numero, la posizione strategica nel Mediterraneo e l’estensione del territorio avevano attribuito il ruolo di grande potenza»90. La lettura dell’episodio di Adua, tuttavia, non è univoca in quegli anni. Alcuni testi, infatti, come lo Spini o il Saitta forniscono, sin dalle edizioni degli anni cinquanta e sessanta, un resoconto demistificato della sconfitta in cui non vengono taciute le pressioni di Crispi che «lamentava come una “tubercolosi militare” la prudente condotta [di Baratieri] davanti alle forze abissine e gli ingiungeva [in un telegramma] di passare immediatamente all’offensiva e nemmeno il «fatale errore di topografia che fece perdere il collegamento fra le varie colonne»91. Spini considera, inoltre, la caduta di Crispi una conseguenza naturale del disastro africano e della sua «avventata politica»92, mentre Saitta definisce coraggiosa la decisione con cui Baldissera «rinunziò ad ogni chimera etiopica e si limitò a salvare il territorio della Colonia Eritrea»93. 158 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia Questi fatti [le sconfitte di Amba Alagi e Makallè] destarono una sensazione di malessere nel paese, cui il Crispi credette di ovviare inviando al Baratieri un severo telegramma, in cui si lamentava come una «tubercolosi militare» la sua prudente condotta davanti alle forze abissine e gli si ingiungeva di passare immediatamente all’offensiva. Il primo marzo 1896 ad Abba Garima, presso Adua, 18000 italiani si trovarono così davanti ad oltre 80.000 abissini. Aggravò la loro sorte un fatale errore di topografia che fece perdere il collegamento fra le varie colonne, che finirono sopraffatte le une dopo le altre dal numero soverchiante degli avversari. Il disastro di Adua travolse naturalmente il Crispi. La pesante eredità della sua avventata politica fu raccolta dal Di Rudinì, il quale cercò di attenuarne le conseguenze. Il generale Baldissera ristabilì la situazione in Eritrea, liberò il presidio di Adigrat, assediato dagli abissini e colse altri successi locali. Fu firmata allora la pace di Addis Abeba (1896), per la quale il confine italo-abissino era portato al corso del Mareb ed erano liberati i prigionieri italiani di Adua94. La caduta definitiva del governo Crispi fu però una conseguenza della megalomane politica estera del suo presidente. I precedenti gabinetti Di Rudinì e Giolitti avevano segnato una battuta d’arresto nell’espansione coloniale. Questa venne nuovamente intensificata dal Crispi, dopo il suo ritorno al governo. [...] Il Crispi era stato messo fuori strada dai rapporti ottimisti del generale Oreste Baratieri, capo delle truppe italiane in Africa; alla notizia dei primi insuccessi, provvide ad inviare dei notevoli rinforzi insieme col generale Baldissera, destinato a sostituire il Baratieri. Ma ancora una volta non seppe attendere l’effetto dei provvedimenti presi: con un imperioso telegramma, in cui definiva la campagna del Baratieri una «tisi militare», ingiunse al responsabile dell’azione militare l’immediato passaggio all’offensiva. Il risultato dell’insano telegramma fu che, quando i rinforzi del Baldissera giunsero a Massaia, il precedente corpo di spedizione italiano non esisteva più: il I° marzo 1896, ad Abba Garima, presso Adua, le truppe italiane, prive persino del semplice sussidio di una carta topografica, erano state sopraffatte dalle soverchianti forze nemiche. Coraggiosamente raccogliendo l’eredità della sconfitta, il Baldissera rinunziò ad ogni chimera etiopica e si limitò a salvare il territorio della Colonia Eritrea. Una violenta crisi scosse l’opinione pubblica italiana all’annunzio del disastro di Adua e ad essa non resistette il Crispi che dovette abbandonare, e per sempre, il governo 95. La trattazione della vicenda di Adua proposta nei manuali di Spini e Saitta rappresenta, dunque, un’eccezione in un panorama di testi fedeli ancora all’approccio retorico della propaganda colonialista. Conclusioni «Un motore di automobile può essere spento, può essere in folle, può andare a 5.000 giri - scrive Paola Tabet -. Ma anche spento è un insieme 159 Grazia De Michele coordinato, gli elementi messi a punto e collegati tra loro e, con un’opportuna manutenzione, pronti ad entrare in movimento quando la macchina viene accesa. Il sistema di pensiero razzista che fa parte della cultura della nostra società è come questo motore. [...] Il suo ronzio può essere quasi impercettibile, come quello di un buon motore in folle. Può al momento buono, in un momento di crisi partire. [...] Con l’arrivo in Italia degli immigrati dai paesi del ’terzo mondo’, in particolare dalla metà degli anni ’80, questo sistema viene registrato e messo in moto, subisce un’accelerazione e si pone in modo più scoperto. [...] Questo sistema non nasce a un tratto quando arrivano in Italia degli immigrati. [...] No, questo sistema si è formato ben prima, è un sistema di lunga costruzione»96. L’immigrazione cosiddetta di «massa» rappresenta in Italia un fenomeno recente e insolito. Le vicende socio-economiche del paese hanno costretto milioni di italiani, tra la fine dell’Ottocento e i primi sessant’anni del secolo successivo, a cercare fortuna nelle Americhe, nell’Europa centrosettentrionale, in Australia. Gli stessi governi, prima quello liberale e in seguito quello fascista, sembravano considerare l’emigrazione una necessità per l’Italia e un beneficio per i paesi ospitanti, che sarebbero stati arricchiti dal «fecondo lavoro italiano», ed esortavano perciò gli emigranti a dirigersi verso le colonie italiane in Africa, sia pure con scarsi risultati. Quando, all’incirca vent’anni fa, il nostro paese si è trasformato in una delle tappe obbligate per il transito degli immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo e diretti in Europa, a fronte dell’incapacità delle istituzioni di provvedere ad un adeguamento dell’apparato legislativo in materia, si è fatto strada in buona parte dell’opinione pubblica un sentimento diffuso di disorientamento e insofferenza. Una reazione sicuramente amplificata dai media, le cui cause remote, tuttavia, sarebbero individuabili, secondo la Tabet ed altri, nella «rimozione, nella cultura del nostro paese, del fenomeno del colonialismo»97 e nella sopravvivenza, anche sotto il regime repubblicano, dei miti e delle leggende diffusi dalla propaganda colonialista. Le conclusioni che possono trarsi dall’analisi dei manuali scolastici, presentata in questo lavoro di tesi, confermano l’ipotesi avanzata dalla Tabet. Tra i testi esaminati, quelli risalenti al periodo che va dall’immediato dopoguerra alla metà degli anni settanta, hanno riproposto fedelmente buona parte dei luoghi comuni, delle mistificazioni e delle omissioni caratteristici dell’ideologia coloniale attraverso i quali le classi dirigenti liberali e fasciste, promotrici dell’espansionismo italiano in Africa, hanno legittima160 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia to velleità di potenza e prestigio. Gli stilemi caratteristici dell’epopea coloniale italiana - la giustificazione demografica, l’eroismo e l’operosità del soldato-colono, la missione civilizzatrice, la bonomia degli italiani in colonia, le ricostruzioni arbitrarie degli avvenimenti - hanno continuato ad essere presenti nei manuali dell’Italia repubblicana e democratica, contribuendo a diffondere tra le giovani generazioni, oltre che una versione adulterata dei fatti, una mentalità spiccatamente razzista. La mancata decolonizzazione della cultura e delle coscienze degli italiani si inserisce nel panorama più vasto di «continuità» delle istituzioni e della struttura economica e socio-culturale del paese. La caduta del regime, la Resistenza, la nascita della Repubblica non sono bastate da sole a recidere il legame con i tradizionali assetti del potere costituito. Una serie di motivazioni contingenti e storicamente determinabili hanno impedito che gli ideali dell’antifascismo, della libertà e della giustizia sociale ispirassero un processo di radicale rinnovamento della società italiana. Anche quando, dalla metà degli anni settanta, i manuali hanno cominciato a riportare una lettura finalmente demistificata del colonialismo italiano, l’assenza di una radicata ed autentica sensibilità alle questioni riguardanti il continente africano ha fatto sì che lo spazio dedicato alla trattazione della presenza italiana in Africa si andasse riducendo progressivamente e che anche le tematiche più recenti, come la decolonizzazione, la crisi del modello dello stato-nazione, le guerre civili, venissero affrontati in modo quasi sempre generico e superficiale. È inevitabile allora che milioni di italiani, formatisi come cittadini soprattutto a scuola, attraverso la lettura e lo studio di quanto proposto dai manuali, possano rimanere sgomenti di fronte ai tanti «extracomunitari» con cui si trovano fianco a fianco a fare la spesa o a prendere l’autobus. Privi di informazioni corrette sui rapporti passati tra i propri connazionali e le popolazioni africane, tanti italiani sembrano temere di vivere nuove «invasioni barbariche», ignari che l’origine dell’attuale crisi del continente risieda anche in quegli avvenimenti lontani. Uno spiraglio di cambiamento sembra provenire, tuttavia, dall’opera di diffusione dei valori della solidarietà e del rispetto per l’altro che gli insegnanti - di cui sono un esempio alcuni tra quelli intervistati per questo lavoro - spesso svolgono tra gli studenti. Se ne può concludere che le possibilità di progresso morale e civile degli italiani di domani sono, in assenza di altri referenti, più che mai nelle loro mani. 161 Grazia De Michele Note al testo 1 Sull’argomento si veda: L’esplorazione italiana dell’Africa, a cura di Francesco Surdich, Il Saggiatore, Milano 1982. 2 Sull’argomento si vedano: M. OSTENC, La scuola italiana durante il fascismo, Laterza, Roma-Bari 1980; L. AMBROSOLI, Propaganda e proselitismo nei programmi e nei libri di testo della scuola durante il periodo fascista, in Motivi pedagogici. In memoria di A. Leonarduzzi, a cura di P. Roveda, Università degli studi di Udine, Udine 1992, pp. 93-113; Dalla scuola all’impero: i libri scolastici del fondo della Braidense, 1924-1944, a cura di R. Coarelli, presentazione di F. De Giorgi, Viennepierre, Milano2001. 3 G. BOLLATI., L’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi, Torino1983, p. 40. 4 Idem, p. 45. Occorre precisare che il fascismo eredita e reinterpreta a proprio sostegno temi caratteristici dell’«italianità» propri del periodo post-unitario. Il rimpianto per la grandezza perduta e il desiderio di riconquistarla, l’esaltazione dell’operosità contadina e la rincorsa della modernità sono parte integrante dell’ideologia nazionale, espressione e instrumentum regni della borghesia risorgimentale impegnata a trasformarsi da forza di rinnovamento in apparato di governo e conservazione dello stato monarchico. Il desiderio di perseguire lo sviluppo industriale senza prestare ascolto alle accresciute istanze delle masse lavoratrici, di eguagliare il progresso economico e lo status internazionale delle grandi potenze europee senza fronteggiarne i contraccolpi a livello istituzionale si traduce nel sentimentalismo idealista e patriottico che mette tutti d’accordo. 5 M.ISNENGHI, L’Italia del fascio, Giunti, Firenze 1996, p. 150. 6 A. MANARESI, Storia contemporanea. Per i licei classici scientifici e gli istituti magistrali. Edizione interamente rifatta secondo i programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV. Casa Editrice Luigi Trevisini, Milano 1936, p.272. 7 G. SPINI, Corso di storia civile ed economica per gli istituti tecnici di ogni tipo. Volume Il per la terza classe: dal congresso di Vienna al primo conflitto mondiale, Perrella, Roma 1951, p. 188. 8 A CAMERA, R. FABIETTI, Elementi di storia per i licei e gli istituti magistrali. Volume III. L’età contemporanea, Zanichelli, Bologna 1967, p. 256. 9 A. BRANCATI, Il cammino della storia. Volumi 2 e 3: Nuova edizione La Nuova Italia, Firenze 1998. 10 Sull’argomento si veda: A. TRIULZI, L’Africa come icona. Rappresentazioni dell’alterità nell’immaginario coloniale italiano di fine Ottocento, in Adua: le ragioni di una sconfitta, a cura di Angelo Del Boca, Roma-Bari Roma-Bari 1997; M. ISNENGHI, Il sogno africano, in Le guerre coloniali del fascismo,a cura di Angelo Del Boca, Laterza; S. PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, in particolare il capitolo La frontiera africana. 11 A. ROSSI, La società umana. Corso di storia civile ed economica per il triennio degli istituti tecnici dal Risorgimento ai giorni nostri. Nuova edizione riveduta e ampliata. Principato Editore, 1967, p. 128. 12 A. GIARDINA, G. SABATUCCI, V. VIDOTTO, Uomini e storia 3. Dall’Ottocento al Duemila, RomaBari, Editori Laterza, 1988, p. 212. Nell’edizione del 1993 questa breve digressione sull’Etiopia viene eliminata, probabilmente per guadagnare le poche righe ad altri argomenti considerati più importanti. Ancora più grave, tuttavia, è la mancanza di qualsiasi riferimento all’episodio della battaglia di Dogali. 162 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia 13 C. CAPRA, G.CHITTOLINI, F. DELLA PERUTA, Corso di storia. Volume III. Storia contemporanea, 9a edizione, Le Monnier, Firenze 1996, p. 467. 14 A. MANARESI, Storia contemporanea. Per i licei classici scientifici e gli istituti magistrali. Edizione interamente rifatta secondo i programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV, Casa editrice Luigi Trevisini, Milano 1936, capitolo XIV «La politica italiana nell’ultimo trentennio del secolo diciannovesimo. Le prime colonie»; capitolo XV «Il primo quindicennio di regno di Vittorio Emanuele III. La brillante conquista della Libia. Il risveglio nazionale»; capitolo XIX «L’impresa etiopica e l’assedio economico. Fondazione dell’Impero». P. SILVA, P. (Ordinario nella Università di Roma), Corso di storia ad uso dei licei e degli istituti magistrali. Volume III, casa editrice Giuseppe Principato, Messina-Milano 1938-XVI: capitolo XVII «La politica interna e de estera italiana dal 1870 al 1900. Le prime colonie»; capitolo XVIII «L’Italia dal 1900 al 1914. La conquista della Libia. Il risveglio nazionale»; capitolo XXV «L’impresa etiopica e l’assedio economico. Il Mediterraneo e l’Italia». 15 A. VALORI, Corso di storia per il licei. Volume III: l’età contemporanea, SEI, Torino 1950. I. BARBADORO, G. FERRARA, Corso di storia per gli istituti tecnici con particolare riguardo alla storia economica, Vol. II: L’età contemporanea (1815-1959). Quarta edizione riveduta e ampliata con un capitolo sulla resistenza, Le Monnier, Firenze 1961. 17 M. SALVADORI, Storia. Volume III: dal 1848 ai giorni nostri, Loescher, Torino, 1987, p. 100. 16 18 A. DESIDERI, M. THEMELLY, Storia e storiografia. Dall’Illuminismo all’età dell’imperialismo. Secondo tomo, Casa editrice G. D’Anna, Messina-Firenze, 1996, p. 1176. 19 G. BALANDIER, Sociologie actuelle de l’Afrique noir. Dynamique social en Afrique central, Presses universitaires de France, Paris 1963. 20 A. GIARDINA, G. SABATUCCI, V. VIDOTTO, Uomini e storia. 3. Dall’Ottocento al Duemila, Editori Laterza, Roma-Bari 1988, p. 182. 21 N. LABANCA, Italiani d’Africa in Adua. Le ragioni di una sconfitta, a cura di A. Del Boca, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 193-230. Secondo Labanca la «giustificazione demografica» ha sempre giocato un ruolo strumentale sia da parte dell’ideologia espansionistica liberale, per la quale «svolse una funzione di supporto dei programmi coloniali della classe dirigente», poi da parte dei nazionalisti che se ne servirono per smuovere quello che loro consideravano l’eccessivo moderatismo del governo, soprattutto quello giolittiano in concomitanza con la campagna di Libia, sino ad arrivare a Mussolini che proclamò la «colonizzazione demografica». Tuttavia «la giustificazione demografica parve operare sul campo delle intenzioni più che su quello della realtà, fu più ideologia di propaganda che fatto concreto, come pure un’attenta verifica quantitativa dei dati già allora pubblicamente disponibili avrebbe potuto facilmente rilevare. La ripetizione dei canoni di questa propaganda persino a livello storiografico, se al fondo non stupisce per gli “storici coloniali”, colpisce invece in studi più recenti» (p. 198). 22 F. LANDOGNA, Storia e civiltà. Testo di storia per i licei classici. Volume III: i problemi del mondo moderno. Seconda edizione, Petrini, Torino 1950, p. 399. 23 G. B. PICOTTI, G.ROSSI-SABATINI, Lineamenti di storia, La Scuola Editrice, Brescia 1957, p. 206. 24 N. RODOLICO, Emerito della Università di Firenze, Sommario storico. Ad uso dei licei e degli istituti magistrali con letture di documenti contemporanei. Volume III. XII edizione secondo il programma del 1960, Felice Le Monnier, Firenze 1967, pp. 338-339. Si riferisce alla politica coloniale del fascismo antecedente l’aggressione all’Etiopia. È interessante anche il nesso piuttosto fumoso tra l’emigrazione verso le colonie e l’opera di civilizzazione dell’Africa che l’Italia, in quanto paese europeo, era chiamata a compiere: l’autore infatti prima descrive l’Italia come 163 Grazia De Michele bisognosa di terra e di lavoro per i suoi emigranti che vedevano spesso sbattersi la porta in faccia dagli altri paesi, - quindi di fatto fornisce l’immagine di un paese arretrato - per poi aggiungere subito dopo che la stessa Italia partecipava alla missione di civilizzazione dell’Africa intrapresa dal resto d’Europa, dunque da paesi più avanzati se non altro economicamente. 25 A. ROSSI, La società umana. Corso di storia civile ed economica per il triennio degli istituti tecnici dal Risorgimento ai giorni nostri. Nuova edizione riveduta e ampliata, Principato Editore, Torino 1967, p. 141. 26 SORANZO, Storia per i licei e per gli istituti magistrali. Volume III: età contemporanea. III edizione riveduta, corretta e aumentata, Minerva Italica, 1960, p. 397. 27 R. VILLARI, Storia contemporanea per le scuole medie superiori, Laterza, Roma-Bari 1970, p. 403. 28 F. TRANIELLO, G. CRACCO, A.PRANDI, Corso di storia per i licei e gli istituti magistrali, SEI, Torino 1980 p. 433. 29 A. DE BERNARDI, S. GUARRACINO, I tempi della storia. Terzo volume. Dall’affermazione della società industriale al mondo attuale, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1989, p. 158. 30 C. CAPRA, G. CHITTOLINI, F. DELLA PERUTA, Corso di storia. Volume III. Storia contemporanea, 9a edizione, Le Monnier, Firenze 1996, pp. 466, 495, 612. Il testo, a differenza degli altri coevi, dedica spazio e visibilità al colonialismo italiano alla cui trattazione, sebbene sempre nell’ambito dei capitoli dedicati alla storia italiana, vengono riservati paragrafi specifici. 31 F. DELLA PERUTA, Storia del Novecento. Dalla «grande guerra» ai giorni nostri, vol. 2, Le Monnier, Firenze 1991, pp. 552, 554, vol. 3 pp. 161. Il capitolo 51 del volume 2 si intitola «Il mondo extraeuropeo: America e Asia sino alla Grande Guerra». Dell’Africa non viene fatta alcuna menzione, nonostante faccia anch’essa parte del mondo extraeuropeo: quanto riportato sopra si trova infatti nel capitolo 50, «Imperialismo e colonialismo», e quanto vi si dice sull’Africa precoloniale è solo una breve digressione nell’ambito di un discorso più generale sul colonialismo e sulla spartizione del continente. 32 M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, Studiare storia 3. Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2001, pp. 150, 151, 326. 33 F. LANDOGNA, Storia e civiltà. Testo di storia per i licei classici. Volume III. I problemi del mondo moderno. II edizione, Petrini, Torino 1950, p. 352. 34 A. ROSSI, La società umana. Corso di storia civile ed economica per il triennio degli istituti tecnici dal Risorgimento ai giorni nostri. Nuova edizione riveduta e ampliata, Principato Editore, Torino 1967, pp. 310-311. 35 36 37 38 N. RODOLICO, Emerito della Università di Firenze, Sommario storico cit., p. 405. G. SPINI, Disegno storico della civiltà. Per i licei classici, scientifici e gli istituti magistrali. Volume III, XI edizione, Edizioni Cremonese, 1980, p. 311. R. VILLARI, R., Sommario di storia. 1900-2000, Laterza, Roma-Bari, 2002. Lo storico Claudio Pavone segnala il progresso degli studi, reso possibile dall’opera degli istituti legati all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e di studiosi, scrittori e cineasti che si sono appassionati al tema. Tuttavia «la cronica incapacità della scuola italiana di insegnare la storia contemporanea [ha generato] indifferenza, più che ripulsa, noia più che contestazione nei confronti della Resistenza». Contemporaneamente si sarebbe verificata, negli anni dell’immediato dopoguerra, la creazione del «mito della Resistenza. Evento che coinvolse una pur cospicua minoranza, [ma utilizzato] come alibi per tutti». Ogni elemento 164 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia che potesse costituire «un vulnus senza rimedio allora inferto alla identità nazionale del nostro paese» venne espunto dalla ricostruzione di uno dei periodi più complessi della storia d’Italia: la guerra fascista, la sconfitta, i dilemmi morali che agitarono chi scelse di schierarsi dall’uno o dall’altra parte, i rapporti e le influenze tra chi preferì attendere gli esiti degli eventi e chi volle invece scendere in campo non hanno costituito, secondo Pavone, per molto, troppo tempo oggetto di indagine, di interesse, di discussione. Si tratta, tuttavia, di questioni che avrebbero potuto e potrebbero indurre ulteriori riflessioni, sino a portare ad un ripensamento complessivo della storia nazionale. Cfr. C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1994, pp. IX-XVI. 39 La storia contemporanea nella scuola. Note sui libri di testo, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», aprile-giugno 1964, 2, n. 75, p. 69. 40 A. MANARESI, Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Volume II, Editore Trevisini, Milano 1951, p. 127. 41 A. MANARESI, Storia contemporanea. Per i licei classici, scientifici e gli istituti magistrali. Edizione interamente rifatta secondo i programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV, Editore Trevisini, Milano 1936, p. 273. A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale. Dall’Unità alla marcia su Roma, Mondadori, Milano 1992, p. 239. 43 Idem, p. 247. 42 44 G. BIONDI, F. IMBERCIADORI, Voi siete la primavera d’Italia. L’ideologia fascista nel mondo della scuola 1925-1943, Paravia, Torino 1982, p. 171. 45 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 127. La stessa frase è presente anche nell’edizione successiva del testo, risalente al 1951, nonché in quella per i licei del 1936 a pagina 272: «II Crispi, afferrando energicamente il potere, ideò un vasto piano coloniale, che, se non fosse distrutto dall’incapacità di chi doveva condurlo ad effetto, avrebbe aperto all’Italia un ben diverso avvenire nell’Africa Orientale.» 46 Idem,, p. 128; gli stessi periodi si trovano anche nell’edizione del 1951 a pagina 127. La versione fascista, identica anch’essa, definisce il disinteresse delle classi dirigenti italiane «vergognoso» piuttosto che «indecoroso». Cfr. A.MANARESI, Storia contemporanea pere i licei classici, scientifici e gli istituti magistrali, Edizione Interamente rifatta secondo i programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV, Casa editrice Luigi Trevisini, Milano 1936, p. 272. 47 Idem, p. 130; A. MANARESI, A., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1951, p. 129; A. MANARESI, Storia contemporanea pere i licei classici, scientifici e gli istituti magistrali, Edizione Interamente rifatta secondo i programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV, Casa editrice Luigi Trevisini, Milano 1936, p. 274: in questo caso i «selvaggi» vengono anche apostrofati come «feroci». 48 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 130; 1951, p. 129; 1936, p. 275. 49 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 131; 1951, p. 130; 1936, p. 276. 50 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 140; 1951, p. 139. 51 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 142; 1951, p. 141. 52 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 142; 1951, p. 141. 165 Grazia De Michele 53 A. MANARESI, Storia contemporanea. Per i licei classici, scientifici e gli istituti magistrali. Edizione interamente rifatta secondo i programmi ministeriali del 7 maggio 1936-XIV, Editore Trevisini, Milano 1936, p. 380. 54 Idem, pp. 382-384. 55 A. MANARESI, Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 292. 56 Il riferimento è all’esito della Prima guerra mondiale. 57 A. MANARESI, Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 292; «Un vasto impero coloniale italiano, che dal porto di Massaua si distendesse, attraverso l’Eritrea e l’Etiopia fino alle coste della Somalia, era stato il sogno di un nostro grande ministro, Francesco Crispi (1888-1896)». Cfr. l’edizione del 1936, p. 380. 58 A. MANARESI, Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Volume II, Editore Trevisini, Milano 1951, p. 282. 59 A. MANARESI., Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 293; 1951, p. 283. 60 L. CANFORA, L’olocausto dimenticato in J.JACOBELLI, Il fascismo e gli storici oggi, Laterza, RomaBari 1988, p. 36. Secondo Canfora il fascismo andrebbe identificato oggi, a cinquant’anni dalla caduta del regime e dall’avvio del tormentato e non ancora concluso processo di decolonizzazione, essenzialmente come l’artefice del «genocidio coloniale in Etiopia, dell’olocausto dimenticato ma non per questo meno assiduo, distruttivo e consapevolmente perseguito». Il fascismo è stato considerato in passato, tanto dagli avversari che dai sostenitori, come autoritario, repressivo ma in fin dei conti «moderato», specie se paragonato al nazismo, responsabile del genocidio degli ebrei, mentre quello compiuto ai danni degli etiopici veniva iscritto nella generica e autoassolutoria categoria della «guerra coloniale». Tale distinzione, osserva Canfora, non è più storicamente fondata adesso che «è caduto il diaframma più o meno consapevolmente razzista» che ne aveva resa possibile la formulazione e che stava a monte della «insensibilità diffusa, all’epoca, intorno ai crimini contro l’umanità perpetrati in Etiopia da generali fascisti» come Graziani e Badoglio che, dopo il 25 luglio 1943 «si sono trovati [emblematicamente] al vertice dei due stati italiani contrapposti, il «regno del Sud» e la «repubblica sociale». 61 A. MANARESI, Corso di storia per gli istituti tecnici superiori, Editore Trevisini, Milano 1948, p. 293; 1951, p. 283. 62 P. SILVA, Corso di storia. Ad uso dei licei classici e scientifici. Volume III. Undicesima edizione Nuova ristampa. Casa editrice Giuseppe Principato, Milano - Messina 1952, p. 371. 63 Idem, p. 381. 64 Ibidem. 65 G. DI PIETRO, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’Italia contemporanea, Bruno Mondadori, Milano 1991, p. 98. 66 E. RAGIONIERI, I manuali di storia nelle scuole italiane, in «Società», a. VIII, n. 2, 1952, pp. 325-338. 67 Ragionieri si esprime negativamente su Manaresi annoverandolo tra gli autori dei manuali, insieme a Silva e Rodolico, che hanno dato «adeguata realizzazione pratica» a «quell’insegnamento della storia [affermatosi a pieno titolo sotto il ministero De Vecchi] che ebbe per proprie caratteristiche il dogmatismo del metodo, la falsità del contenuto, il fine educativo antidemocratico». Anche dopo la caduta del fascismo e la guerra di liberazione nazionale «lo spirito e la sostanza dell’educazione fascista sono rimasti intatti in questi libri», come Ragionieri dimostra 166 La storia dell’Africa e del colonialismo italiano nei manuali di storia riportandone alcune citazioni significative. 68 P. SILVA, Corso di storia cit., p. 360. 69 E. RAGIONIERI, I manuali di storia cit., p. 328. 70 P. SILVA, Corso di storia cit., p. 292. La stessa frase: «Il sogno di Crispi, veramente precorritore della gloriosa situazione attuale, era quello di un grande impero coloniale italiano dal Mar Rosso all’Oceano Indiano, che avviluppasse tutta l’Abissinia» si trova anche nell’edizione del 1938 e in quella degli anni quaranta. Cfr. P. SILVA, Corso di storia ad uso dei licei e degli istituti magistrali, Casa editrice Giuseppe Principato, Milano-Messina 1938-XVI, p. 292; P. SILVA, Corso di storia, Casa editrice Giuseppe Principato, Milano-Messina [anni quaranta], p. 291.Nell’edizione del 1962 ne risulta modificata la struttura sintattica ma non il senso: «Crispi volle anche riprendere quella politica di espansione coloniale che era il suo più caro sogno; e lì mirava a costituire un grande impero coloniale italiano dal Mar Rosso all’Oceano Indiano, che avviluppasse tutta l’Abissinia». Cfr. P. SILVA, Lezioni di storia civile ed economica ad uso degli istituti tecnici. Volume III. Nuova edizione rifatta da V. Silva Pugliese, Casa Editrice Giuseppe Principato, Milano-Messina 1962, p. 114. 71 P. SILVA, Corso di storia. Ad uso dei licei classici e scientifici. Volume III. Undicesima edizione Nuova ristampa. Casa editrice Giuseppe Principato, Milano - Messina 1952, p. 240. 72 P. SILVA Lezioni di storia civile ed economica ad uso degli istituti tecnici. Volume III. Nuova edizione rifatta da V. Silva Pugliese, Casa Editrice Giuseppe Principato, Milano-Messina 1962, p. 122. 73 P. SILVA, Corso di storia. Ad uso dei licei classici e scientifici. Volume III. Undicesima edizione - Nuova ristampa. Casa editrice Giuseppe Principato, Milano - Messina 1952, p. 239; 1962, p. 123. 74 P. SILVA Lezioni di storia civile ed economica ad uso degli istituti tecnici. Volume III. Nuova edizione rifatta da V. Silva Pugliese, Casa Editrice Giuseppe Principato, Milano-Messina 1962, p. 122. 75 P. SILVA, Corso di storia. Ad uso dei licei classici e scientifici. Volume III. Undicesima edizione Nuova ristampa. Casa editrice Giuseppe Principato, Milano - Messina 1952, p. 290. 76 Idem, pp. 284-285. 77 Idem, p. 285. 78 Idem, p. 290. 79 «Menelik [... ] era per sua natura sospettosissimo e gelosissimo della sua indipendenza». Idem, p. 292. 80 Idem, pp. 292-293. 81 Idem, p. 344. 82 N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Laterza, Roma 2002, p. 82. 83 R. PANKHURST, Special issue on the battle of Adowa, in «Ethiopia Observer», vol. 1, n. 1, december 1957, p. 357. 84 N. LABANCA, In marcia verso Adua, Laterza, Roma-Bari 1997. 85 P. SILVA, Corso di storia. Ad uso dei licei classici e scientifici. Volume III. Undicesima edizione Nuova ristampa. Casa editrice Giuseppe Principato, Milano - Messina 1952, pp. 302-303. 86 P. SILVA Lezioni di storia civile ed economica ad uso degli istituti tecnici. Volume III. Nuova edizione rifatta da V. Silva Pugliese, Casa Editrice Giuseppe Principato, Milano-Messina 1962, 167 Grazia De Michele pp. 167-168. 87 Idem, p. 115. 88 R. MORGHEN, I.IMBERCIADORI, Corso di storia civile ed economica per gli istituti tecnici, Palumbo, Torino 1957, p. 246. 89 Ibidem. 90 Ibidem. 91 G. SPINI, Corso di storia civile ed economica per gli istituti tecnici di ogni tipo. Volume II per la terza classe. Dal congresso di Vienna al primo conflitto mondiale, Perrella, Roma 1951, pp. 192-193. 92 Ibidem. 93 A. SAITTA, Il cammino umano. Corso di storia ad uso dei licei, La Nuova Italia, Firenze 1960, p. 542. 94 G. SPINI, Corso di storia civile ed economica per gli istituti tecnici di ogni tipo. Volume II per la terza classe: dal congresso di Vienna al primo conflitto mondiale, Perrella, Roma 1951, pp. 192-193. 95 A. SAITTA, Il cammino umano. Corso di storia ad uso dei licei, La Nuova Italia, Firenze 1960, pp. 541-542. 96 P. TABET, La pelle giusta, Einaudi, Torino 1997, pp. V-VI. 97 A. DEL BOCA, Le conseguenze per l’Italia del mancato dibattito sul colonialismo, in «Studi piacentini», a. 1989, n. 5, p. 115. 168 Ti scrivo dall’Abissinia. Lettere di Guerrino, camionista bolognese, alla moglie Derna dall’Africa Orientale Italiana di Vittorio Pallotti Introduzione Sono ormai trascorsi molti anni da quando, rovistando tra le vecchie carte di famiglia, ho trovato le lettere che mio padre Guerrino scriveva a mia madre Derna dall’Africa Orientale tra l’aprile 1937 e il settembre 1938. Sulla busta arancione che le conteneva mia madre aveva scritto: «Posta personale - preziosa - Parte della Corrispondenza di Guerrino dall’Africa». In tutte, oltre ai complimenti e alle frasi di circostanza (saluti ad amici, parenti e conoscenti, «sto bene di salute come spero di tutti voi», …) si trovano, ove più ove meno, diverse notizie sulla vita e sul lavoro di mio padre in quelle terre che, a quell’epoca, erano molto più lontane di quanto lo siano oggi. Notizie che, direttamente o indirettamente, fornivano un quadro della situazione in cui venivano a trovarsi i camionisti italiani nelle colonie dell’Etiopia e dell’Eritrea, nei pochi anni compresi fra la conquista dell’Etiopia e l’entrata in guerra dell’Italia. La figura del camionista aveva un’importanza primaria per il regime fascista nel processo di colonizzazione dell’Africa. Infatti, era necessario costruire tutta una serie di infrastrutture (dalle strade alle ferrovie, dalle comunicazioni alle costruzioni edilizie) per poter portare un grande numero di coloni in quelle terre (di cui si aveva ancora una scarsissima conoscenza)1, per sfruttarne le risorse2 e per rafforzare il controllo del territorio. Il numero dei camionisti pertanto doveva essere particolarmente alto, come si intuisce da diversi brani dell’epistolario, come viene evidenziato da alcuni dati statistici riportati dalla Guida dell’Africa Orientale Italiana nella descrizione di alcuni itinerari stradali e, soprattutto, dall’analisi storica di Angelo Del Boca3. Ho pensato quindi che, forse, valeva la pena di trascrivere queste notizie (sulla cui importanza, o irrilevanza, ai fini della ricerca storica deci169 Vittorio Pallotti deranno eventualmente gli specialisti del settore) prima che le lettere e gli altri documenti utilizzati andassero dispersi o la loro lettura, con il passare del tempo, diventasse sempre più problematica. Ritengo comunque che l’epistolario, al di là della sua effettiva importanza storica, possa rivestire una certa importanza dal punto di vista umano. Esso rappresenta infatti un ritratto, immediato ed evidente, non solo del suo autore, ma anche, sia pure con meno evidenza, del suo destinatario, la moglie Derna, maestra elementare alle prese con problematiche del tutto diverse, ovviamente, da quelle del marito: dalla gravidanza ai trasferimenti di sede. Il carattere e le apprensioni quotidiane di Derna traspaiono dalle risposte che Guerrino dà alla sua «Ucia» o «Uciona», come affettuosamente la chiamava. Un rapporto familiare che, pur nella sua originalità e individualità, doveva avere molti tratti in comune con altri tipi di rapporti familiari in situazioni analoghe: mariti (o fidanzati o figli), camionisti in Africa Orientale, e mogli (o fidanzate o madri) che, a casa, aspettavano con ansia il loro ritorno. I motivi della partenza Perché mio padre decise di partire da Bologna per l’Eritrea e l’Etiopia (o Abissinia, come spesso allora veniva chiamata) nell’aprile del 1937, nonostante fosse sposato da appena 10 mesi e sua moglie fosse incinta? Certamente non per motivi ideologici e/o politici, come evidenzia chiaramente e ripetutamente il contenuto delle lettere. Le motivazioni erano di due tipi diversi: il desiderio di guadagno e la sua personalità. Guerrino proveniva da una numerosa famiglia rurale (due genitori e nove fratelli, di cui, all’epoca, ne sopravvivevano sette). Anche la famiglia Pallotti, come (quasi) tutte le altre famiglie nei primi due decenni del secolo scorso, aveva dovuto misurarsi con difficoltà economiche quotidiane e spesso gravi. Negli anni trenta, un’attività di commercio, prima solo ambulante poi misto (ambulante più negozio), esercitata dal capofamiglia Gaetano con l’aiuto dei figli, aveva sensibilmente migliorato la situazione. Ma, come capita spesso in questi casi, il ricordo dei tempi delle «vacche magre» e la necessità di «mettere da parte» per la vecchiaia manteneva comunque alto nei giovani dell’epoca, e soprattutto nella società rurale, l’obiettivo del miglioramento economico. Particolarmente in chi, come Guerrino, non si era limitato a conseguire la licenza di terza elementare ma aveva continuato gli studi per 2 o 3 anni dopo la quinta. 170 Ti scrivo dall’Abissinia Guerrino e il suo autocarro Fiat 634 Colonna di autocarri sulla strada di Uolchefit 171 Vittorio Pallotti Probabilmente, anche mio padre, come moltissimi altri giovani di allora, non sapevano e non potevano resistere al «canto delle sirene» della propaganda di regime. Le illustrazioni di Beltrame sulle copertine della «Domenica del Corriere» n.3 e n.5 del 1937 riproducevano scene di convinta adesione dei popoli sottomessi alla supremazia e alla generosità dell’oppressore. Sulla prima pagina del n.12 si leggeva: «L’IMPERO RICHIEDE uomini forti, decisi, capaci: uomini che debbono dare ai nostri nuovi sudditi la loro saggia guida ». Vari articoli, riccamente illustrati, dedicati all’Africa Orientale, comparivano quasi in ogni numero dello stesso settimanale e di altre riviste come «Le vie d’Italia» andando ad amplificare gli effetti prodotti dai numerosi discorsi propagandistici di Mussolini e dagli scritti dei suoi numerosi cantori4. Inoltre, non poteva non essersi diffusa in Italia, fra il 1936 e i primi mesi del 1937, la voce che i proprietari di automezzi, i cosiddetti «padroncini», guadagnavano cifre altissime per trasportare merci da un luogo all’altro dell’Africa Orientale, arricchendosi rapidamente: il guadagno giornaliero netto di un padroncino era di 600 lire, a fronte delle 350 lire mensili di un impiegato in Italia5. Ma, come sempre accade in questi casi, dopo poco i profitti cominciano a diminuire rapidamente, sia per l’aumento della concorrenza, dal momento che, ovviamente, il numero dei padroncini aumentava rapidamente, sia per le restrizioni imposte dal governatore dell’Etiopia, scandalizzato da questo eccesso di guadagno che, fra l’altro, avveniva a spese dello Stato. Il guadagno dei padroncini venne dimezzato dal maresciallo Graziani nell’aprile 1937, proprio il mese di arrivo di Guerrino. Per di più, a fine agosto 1938 un altro decreto stabiliva un’ulteriore riduzione delle tariffe degli autotrasportatori6. In effetti, come si legge in molte lettere di Guerrino, dalla seconda metà del 1937 a tutto il 1939 le prospettive erano molto meno rosee. L’aleatorietà del lavoro, la sua precarietà nel rapporto con le ditte appaltatrici del lavoro, le enormi spese che il padroncino doveva affrontare per la manutenzione e l’uso del suo automezzo, dal carburante ai mezzi di ricambio (il prezzo di una sola gomma era di 2.500 lire, più di sette volte lo stipendio mensile di un impiegato in Italia!) e la necessità di pagare i debiti contratti per l’acquisto dell’autocarro (pur acquistato in società con altri), per le spese di viaggio e per l’inizio dell’attività erano tutti elementi che non dovevano far dormire sonni tranquilli a mio padre. E che l’Etiopia non fosse proprio un Eldorado viene anche confermato da un altro camionista in 172 Ti scrivo dall’Abissinia Il ribaltamento del camion 173 Vittorio Pallotti una sua autobiografia7. Al momento della decisione di partire per l’Africa, Guerrino era impiegato presso lo zuccherificio di Bologna, ove lavorava anche il fratello della moglie, Bruno Barbieri. Un lavoro che, per quanto gli potesse garantire una relativa tranquillità economica, non era per nulla congeniale alla sua forte personalità, caratterizzata (per quanto mi è stato possibile conoscere mio padre e per quanto traspare, più volte, da diversi brani in varie lettere) dai seguenti elementi: carattere estroverso e socievole, spirito di intraprendenza e di indipendenza, insofferenza all’esecuzione acritica di ordini, desiderio di affermazione sociale, avversione al lavoro sedentario e di routine, determinazione a conseguire un obiettivo prefissato, grande fiducia nel prossimo, fino a sfiorare (e a volte sorpassare) il limite dell’ingenuità. Elementi caratteriali, questi, che rappresentavano un fertile terreno di coltura per la propaganda colonialista del regime8. E a nulla valsero gli inviti della moglie a preferire il posto sicuro di impiegato nello zuccherificio rispetto ai rischi e alle incertezze dell’avventura africana. I destinatari delle lettere Dovevano essere veramente tanti, oltre alla moglie Derna. Infatti, oltre i sei fratelli con relativi cognati, cognate e nipoti, c’era il fratello di Derna, Bruno, i suoceri, gli ex-colleghi dello zuccherificio e, infine, una lunga serie di amici e conoscenti. Le cinquanta cartoline di cui parla in una lettera ne sono l’esempio più evidente. La corrispondenza Fra lettere (34), cartoline postali (6), cartoline illustrate (5) e biglietti postali (3) sono riuscito a recuperare 47 pezzi di corrispondenza, tutti indirizzati alla moglie Derna Barbieri, in via Gorizia a Bologna, dove abitava con i genitori e il fratello Bruno. E dove io sono nato il 25 luglio 1937, esattamente 101 giorni dopo la partenza di mio padre. A questi 47 pezzi va aggiunta una lettera indirizzata al cognato Bruno. Un numero imprecisabile di lettere e cartoline è sicuramente andato perso, in particolare per il periodo compreso fra l’ottobre 1938 e il ritorno in Italia, nel marzo del 1940. 174 Ti scrivo dall’Abissinia La scrittura Per quanto Guerrino avesse seguito uno o due anni di studi post-elementari e un corso per corrispondenza «preparatorio per l’ammissione agli esami di licenza dell’Istituto tecnico superiore di ragioneria», il suo italiano scritto non era perfetto dal punto di vista sintattico e, più raramente, grammaticale. Evidente appare, qua e là, l’influenza della sua lingua madre (il dialetto bolognese). Per rispetto alla realtà storico-letteraria e all’efficacia espressiva del testo originale, ho ritenuto di non apportare alcuna correzione formale al testo stesso. Come pure ho preferito scrivere il presente del verbo «avere» anziché nella forma attualmente usata (ho, ha, hai, hanno) in quella preferita da mio padre (ò, à, ài, ànno) che, allora, nell’uso quotidiano conviveva senza drammi con la prima. Lo stile della scrittura risente molto della moda dell’epoca. Uno stile spesso ridondante di retorica, di frasi ad effetto, di iperboli. Questo stile viene usato quasi esclusivamente e in modo quasi ripetitivo solo all’inizio e alla fine di ogni lettera: nelle frasi di circostanza relative alle condizioni di salute, al tempo atmosferico, al clima e nei saluti. Ogni lettera si conclude, inevitabilmente, con i bacioni o gli abbracci, i saluti ai parenti, rassicurazioni varie. Una volta che Guerrino venne meno a questo vero e proprio adempimento, formale e morale, di fine lettera, ne nacque un piccolo dramma (v. la lettera n. 14). All’interno delle parentesi quadre sono contenute le note di redazione e alcuni commenti e precisazioni dello scrivente. Ove non compare il tipo di documento (cartolina, biglietto postale, ecc.), subito dopo il numero progressivo, si deve intendere che si tratta di semplice lettera. I temi La partenza dei coloni. Da alcune frasi contenute in diverse lettere si può intuire quanto fosse alto il numero di italiani che in quel periodo partivano o tentavano di partire per l’Africa Orientale Italiana9. Inoltre, a giudicare dalla frase: «Ò visitato ufficialmente e bene tutta la città [di Littoria] accompagnato anche in macchina» (lettera n.2), sembra che chi decideva di partire (se non tutti, molti di loro) fosse trattato con molti riguardi dal regime che, prima che il colono lasciasse l’Italia, lo portava a visitare una delle nuovissime «città-simbolo» del fascismo: Aprilia, 175 Vittorio Pallotti Littoria (l’attuale Latina costruita fra il 1932 e il 1933), Pontinia o Sabaudia. Quasi per lenire, in anticipo, quella che sarebbe divenuta la ferita psicologica di quasi tutti i coloni: la nostalgia. Lenimento che continuava nel viaggio sul piroscafo, che durava mediamente 6-7 giorni e durante il quale i coloni, che già cominciavano a sentire questo dolore della lontananza dai propri cari e dal proprio ambiente, erano trattati particolarmente bene (lettere n.3 e n.4). Anche se, poi, le spese del viaggio venivano loro addebitate dalle ditte che li assumevano (lettera n.6). La nostalgia. Anche Guerrino fu ferito da questo sentimento, come si può intravvedere dai brani di alcune lettere, a cominciare dalla lettera n.2, dove viene evidenziato il suo grande desiderio di essere raggiunto il più presto possibile da un cugino di Derna, Antonio(«Tonino») Sangiorgi di Faenza. Evidentemente, nonostante la sua grande socievolezza, che doveva consentirgli di fare rapidamente amicizia con i compagni di viaggio e di lavoro, egli sentiva una grande nostalgia del suo ambiente, quello familiare soprattutto. La gelosia. Nella lettera n.6 si legge «Qui donne bianche ce ne sono poche». E queste poche «credo stiano meglio in Italia». Frasi che sembrano rappresentare risposte a probabili domande di Derna e, contemporaneamente, sembrano evidenziare il tentativo di Guerrino di neutralizzare eventuali velleità della moglie di raggiungere il marito10. Altre domande di Derna riguardavano il divertimento, il vitto (lettera n.6), il clima (lettera n.8 e altre) e, naturalmente, la salute. Il rimpianto. Da alcune lettere e cartoline pare di capire che Guerrino era a volte assalito dal dubbio di non avere fatto la scelta giusta. Anche la frequente corrispondenza epistolare che intratteneva con i suoi ex-colleghi e superiori dello zuccherificio sta a indicare, forse, il rimpianto per un ambiente di lavoro situato decisamente, dal punto di vista sia fisico che esistenziale, agli antipodi di quello che aveva scelto e nel quale ora si trovava inesorabilmente immerso. Un ambiente, quello dello zuccherificio, nel quale aveva esercitato un’attività lavorativa breve ma comunque fortemente partecipata. I rischi e i pericoli. Pur avendo già maturato, nonostante la giovane età 176 Ti scrivo dall’Abissinia (28 anni), una certa esperienza di guida - aveva conseguito la patente nel 1931, all’età di 22 anni -, Guerrino si trovò a dover guidare un autocarro su strade in buona parte non asfaltate e in condizioni nemmeno paragonabili a quelle italiane dell’epoca, in zone quasi sempre di montagna, probabilmente con scarsa o nessuna segnaletica. Strade strette e piene di curve, spesso con forti pendenze. Forare una gomma (in un solo viaggio ne forò ben 8!) o avere un qualunque tipo di guasto meccanico poteva significare uscire di strada e finire in un precipizio. E una volta Guerrino ci andò vicino (lettera n.14). Si intuisce a volte che c’era il pericolo reale di essere assaliti da bande di guerriglieri. Infatti, le colonne di autocarri erano scortate da mezzi militari (lettera n.36 e altre) e i posti di blocco non mancavano. Una guerriglia che continuò ininterrottamente dalla fine della guerra allo scoppio della seconda guerra mondiale11. Altro rischio era rappresentato dalla possibilità che i militari requisissero l’autocarro, probabilmente anche per esigenze militari in funzione anti-guerriglia (lettera n.8). Ancora. La possibilità di contrarre malattie. Guerrino contrasse l’infezione malarica alla fine di febbraio 1940 e rimase sotto sorveglianza sanitaria fino al 19 marzo dello stesso anno. Con ogni probabilità tuttavia i rischi e i pericoli affrontati, per numero e tipologia, devono essere stati superiori a quelli che nelle lettere descrive o lascia intuire. L’ansia di Derna era troppo forte perché Guerrino ne potesse parlare. Il «camionista-centauro». Nella lettera n.33 c’è una frase che rileva, in modo chiarissimo, la perfetta identificazione del camionista coloniale con la sua «macchina»: «Ora qui ci sono molte macchine che vorrebbero andare a lavorare in cantiere perchè più conveniente e vita migliore, certo più sacrificata». Anche in altre lettere si possono trovare espressioni simili. Ad esempio, nella lettera n.46: «Le altre macchine del cantiere sono già tutte licenziate». E nella lettera n.48: «Non solo le macchine ma anche gli operai sono stati licenziati». D’altra parte, viaggiare per giorni e settimane sullo stesso automezzo, dormirci sopra per intere notti e doverci spesso litigare per frequenti forature, balestre che si spezzavano, pezzi di motore che si rompevano e altro ancora (lettera n.9) erano tutti elementi che finivano per trasformare un essere umano in una specie di moderno centauro. Anziché mezzo uomo e mezzo cavallo il camionista finiva per trasformarsi in mezzo uomo e 177 Vittorio Pallotti mezzo autocarro. Grazie alla Guida dell’Africa Orientale Italiana della Consociazione Turistica Italiana - il fascismo obbligava, com’è noto, a italianizzare tutte le parole di origine straniera, come, in questo caso, il nome del vecchio Touring Club Italiano - sono riuscito a ricostruire in gran parte i viaggi effettuati da mio padre e il relativo chilometraggio. I chilometri percorsi dal 24 aprile 1937 al 31 dicembre 1937 sono stati 12.594 - con una media mensile di circa 1.500 chilometri -, dal marzo 1938 al marzo 1940 15.517 con una media mensile di 647 chilometri. In considerazione del fatto che un certo numero di viaggi non sono stati menzionati nelle lettere e che di alcuni viaggi non sono riuscito a ricostruire il percorso, i medesimi dati sono da considerarsi approssimati per largo difetto. La forte differenza delle medie chilometriche mensili fra i primi otto mesi e gli ultimi due anni si spiega col fatto che Guerrino nel 1938 e nel 1939 aveva lavorato a lungo all’interno di cantieri stradali o edili facendo di solito percorsi brevi o brevissimi. Nel 1937 invece trasportava merci spesso su lunghe distanze a velocità medie che, quando si viaggiava incolonnati, non superavano i 25-30 chilometri orari. Le merci e i passeggeri trasportati. Le merci trasportate erano le più varie: dalle uova al cemento. Avendo l’autocarro una portata massima di 80 quintali, il carico massimo trasportato non superava i 70 quintali. Anche la tipologia dei passeggeri, trasportati a volte assieme alle merci, era abbastanza varia: indigeni, militari, singole persone. Di queste ultime nel «libretto di viaggio» viene riportato nome e cognome. Probabilmente si trattava di altri lavoratori. Ma poteva anche trattarsi, a volte, perfino di qualche raro turista italiano che, in alternativa agli scarsi mezzi pubblici, si affidava ai molto più diffusi autocarri privati. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, un autocarro impiegava quattro giorni per coprire la distanza fra il porto eritreo di Massaua e Addis Abeba (1.278 chilometri)12. Calcolando una media di 9 ore di guida giornaliere, la velocità media era di 35-40 chilometri orari. I rapporti con le ditte. A giudicare dalla frequenza con cui Guerrino raccontava, spesso lamentandosi, dei suoi rapporti con le ditte con cui lavorava o sperava di lavorare se ne deduce che questi rapporti dovevano avere un certo grado di conflittualità. I motivi erano di natura prevalentemente 178 Ti scrivo dall’Abissinia La moglie Derna con il bambino 179 Vittorio Pallotti economica: ditte che pagavano in ritardo o addirittura non pagavano (lettera n.16). Oppure motivi di carattere etico: promesse che non venivano mantenute (lettera n.36). Il risultato era un morale che, come si legge in molte lettere, spesso rischiava di andare a pezzi o quasi. Fortunatamente, mio padre aveva un carattere abbastanza forte da non lasciarsi prendere dallo scoramento e dalla stanchezza, come invece avveniva ad altri suoi colleghi (lettera n.30). Gli venivano in aiuto la tenacia, la speranza (lettera n.44) e una buona salute fisica, che lo ha abbandonato solo verso la fine del 1939, quando contrasse una forma di malaria. La malaria e il ritorno in Italia. «Infezione malarica perniciosa» era la diagnosi riportata nel «Biglietto di uscita» rilasciato dall’Ospedale Principessa di Piemonte di Addis Abeba in data 20 dicembre 1939, XVIII [anno dell’era fascista] e relativa al «Sig. Pallotti Guerrino, dipendente della ditta Biondi». Purtroppo, della data di dimissioni dall’ospedale si riesce a leggere solo l’anno: 1939. Come si deduce da questo documento e da un certificato rilasciato dal Regio Governo dell’Eritrea - Direzione Affari Civili - Ispettorato di Sanità Civile mio padre decise di iniziare le pratiche per il rientro in Italia nel dicembre 1939 anche, e forse soprattutto, a causa di questa malattia. Da questo certificato risulta anche che Guerrino dovette sottostare, prima di imbarcarsi per l’Italia, a un regime di quarantena dal 28 febbraio al 19 marzo 1940. La partenza per l’Italia dovette avvenire, con ogni probabilità, prima della fine del marzo 1940. Una partenza che, forse, non doveva né poteva essere definitiva. Infatti, da un documento ritrovato fra le vecchie carte, mio padre dovette dichiarare alle autorità locali, il 18 marzo 1940, che si sarebbe allontanato temporaneamente dall’Eritrea, per un massimo di 90 giorni (che sarebbero scaduti il 17 giugno 1940, una settimana esatta dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Inghilterra). Due sono le possibilità: o questa dichiarazione rappresentava un semplice escamotage (favorito dalla malaria), in quanto una partenza definitiva non era consentita ai civili militarizzati (come era mio padre), oppure Guerrino era veramente intenzionato a tornare in Africa Orientale. Ma anche considerando questa seconda possibilità, il rientro in Eritrea nella prima metà di giugno doveva essere impossibile, o quasi, per la drammatica situazione, sia politica che 180 Ti scrivo dall’Abissinia militare, in cui l’Italia era coinvolta. Ho sentito più volte ripetere da mio padre, e confermare da mia madre, che la malattia è stata l’occasione per ottenere l’autorizzazione al rientro in Italia e che il piroscafo che riportò in patria Guerrino fu l’ultimo (ma molto più probabilmente uno degli ultimi) prima che gli inglesi, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, chiudessero ogni collegamento con l’Africa Orientale. Una versione, questa, che contrasta in parte con quanto riportato da Angelo Del Boca, secondo cui, nei primi mesi del 1940, il movimento di navi da e per l’Italia era più che normale13. Infatti, anche se la tensione politico-militare fra Italia e Inghilterra era in continuo aumento, le prime operazioni belliche dell’esercito coloniale italiano contro le colonie inglesi confinanti del Sudan e del Kenia hanno luogo solo nel luglio 1940, un mese circa dopo l’entrata in guerra dell’Italia14. Comunque, i lavoratori italiani cui non toccò la sorte di ammalarsi e di tornare in patria divennero prigionieri di guerra degli inglesi e poterono rientrare in Italia solo dopo la fine del conflitto, nel 1946 o 1947. Cinquantotto anni dopo Guerrino morì a Bologna il 22 dicembre 1972, trentadue anni dopo il suo rientro dall’Africa, senza riuscire a soddisfare il suo desiderio di tornare in quei luoghi. Cinquantotto anni dopo il fatidico 1940, nel 1998, sua moglie Derna, all’età di 86 anni, non più in grado di vivere da sola, per uno strano gioco del destino (che, quando non è fatale o crudele, è spesso un gran giocherellone), trova come aiutante una giovane ragazza etiope, appena arrivata da…Addis Abeba. La ragazza si chiama Emebet, ha due fratelli e quattro sorelle (anche Guerrino aveva due fratelli e quattro sorelle) e ha esattamente la stessa età di Guerrino quando arrivò ad Addis Abeba: 28 anni. A differenza di Guerrino, Emebet è arrivata in Italia nubile e senza figli. Solo nel 2003 si è sposata con un ragazzo di Addis Abeba che l’ha raggiunta a Bologna dove ha partorito Jafet, il suo primo figlio. Emebet è stata al servizio di Derna per 6 anni e due mesi, fino alla morte di mia madre avvenuta il 3 dicembre 2004, quando aveva la rispettabile età di 92 anni. Dalla morte di mio padre erano trascorsi 32 anni: esattamente lo stesso arco di tempo intercorso tra il rientro di Guerrino dall’Africa e la sua morte. 181 Vittorio Pallotti L’Italia fascista, nei due anni di guerra - in realtà la guerra durò solo sette mesi, dal 3 ottobre 1935 all’aprile 1936 - e nei quattro di occupazione15, come ogni regime di tipo coloniale ha sfruttato e provocato danni materiali e morali ai popoli etiope ed eritreo. E mio padre, presente in quei territori in quello stesso periodo, con la sua attività lavorativa, prestata anche al servizio del Genio Militare, a ciò ha contribuito, indirettamente e certo inconsapevolmente. Ma ora la presenza, nella mia famiglia, di una giovane etiope ha fatto sì che il debito morale e materiale contratto da mio padre con quei popoli sia stato, almeno in parte e idealmente, saldato. Infatti, l’offerta di un lavoro a Emebet ha permesso l’instaurarsi non solo di un rapporto economico, ma anche di un rapporto affettuoso che, con l’arrivo di Jafet - che ha vissuto con sua madre i suoi primi quattordici mesi nella stessa abitazione di Derna, almeno limitatamente all’arco della settimana lavorativa - si è ulteriormente rafforzato. 182 Ti scrivo dall’Abissinia 1. Roma, 16 aprile1937 Carissima Derna, come già ti ò avvertito con telegramma, parto domani sabato alle ore 14 da Napoli sul Biancamano. Dato il piroscafo molto buono ò creduto bene prendere la terza [classe] non solo per risparmiare, ma anche perché si sta come in seconda degli altri piroscafi. Senz’altro sarò a Massaua la mattina del 23. A dormire sono in una cabina a 4 letti. Domani assieme alla presente riceverai molte fotografie del Biancamano e vedrai che è il primo viaggio per l’oriente perché prima faceva i viaggi per l’America. Ò fatto il viaggio fino a Roma molto bene, ò dormito da Firenze fino vicino a Roma, perciò oggi sto bene. Subito sono andato dalla Ditta [Ing. Ceraso] dove mi ànno ricevuto benissimo. Mi ànno consegnato il lasciapassare e poi in macchina (una 1500) siamo andati a prendere il biglietto per Massaua. Dato il piroscafo molto buono, ò dovuto sborsare io in più un supplemento di lire 130. A mangiare sono in Via Frattina dove si mangiava con te circa 10 mesi orsono [in viaggio di nozze, effettuato nella prima metà di giugno 1936]. Mi ànno conosciuto subito, anzi il proprietario desidera venire anche lui in Africa, perché molti clienti sono già partiti ed ora lavora poco, e proprio ora mi diceva che io faccio molto bene andare giù con un camion. Alla ditta ò parlato molto di Tonino ed ànno fatto subito una sollecitazione al Ministero; in proposito ò dato al ragioniere di Ceraso 20 lire di mancia perché non si dimentichi. Quindi io spero che presto avrà anche lui il passaporto. Oggi pomeriggio volevo andare in S. Pietro, ma forse non faccio in tempo perché alle 15,20 parto per Napoli e mi fermerò a Littoria a trovare quello di Padova che mi deve dare dei soldi. Forse pernotterò e domattina alle 10 circa sarò a Napoli. Cara Derna, Bruno può salutare tutti, digli, ed in modo particolare Iperbole, ricordandogli Evaristo [uno dei cognati]. Uciona [da Dernuccia], mi raccomando di non pensare a me, perché ti assicuro che sto molto bene. Pensa a stare bene tu ed Ucino. Molti saluti ai tuoi. A te aff.mi baci e tante cose. Appena arrivo a Decamerè [città eritrea], spero leggerti e sapere che tu, Ucino ed i tuoi state come me benissimo. Tuo aff.mo [affezionatissimo] Ucio [Guerrino] 2. Napoli, 17 aprile1937 Carissima Ucia, pensa sono le 13 ed ò appena finito di mangiare quindi ò poco tempo. Stamattina sono arrivato a Napoli alle 10 e alle ore 11 e mezza circa avevo già sbrigato tutte le operazioni relative alla partenza. Stanotte ò dormito a Littoria, dove sono stato ospite del cognato di Zini, cugino di quello che già è partito. Ò visitato ufficialmente e bene tutta la città accompagnato anche in macchina. Ò tro183 Vittorio Pallotti vato alla sera quello di Padova e mi à assicurato che appena può mi manderà qualche 50 lire, se poi sarà vero…!! A Littoria Zini [di Anzola E., suo collega di lavoro in territorio africano] mi à riferito cose importanti, sapute al Ministero a Roma e che mi serviranno molto in Africa quando dopo 4 mesi dovrò rinnovare il contratto con l’ing. Ceraso. Io spero che Tonino avrà presto il lasciapassare ed appena in possesso partirà subito. Da Littoria a Napoli ò trovato già diversi che conosco coi quali faremo il viaggio assieme fino a Massaua. Spero avrai ricevuto anche le fotografie del Biancamano spedite da Roma come stampe. Sempre a Roma ò trovato un signore che mi à fatto una raccomandazione per il capo della Mensa del Biancamano, quindi spero di mangiare anche bene in mare. Cara Uciona, mi raccomando sempre di stare molto bene, anche Ucino il quale immagino che ti darà qualche calcino, non è vero? Ti assicuro di stare molto bene per ora e così spero per sempre. Salutami tanto i tuoi e tutti coloro che non ò potuto salutare. Moltissimi e aff.mi bacioni Tuo Guerrino 3. Da bordo, ore 21 del 17 aprile 1937 Carissima Derna Invece di partire alle ore 14 siamo partiti alle 15,10 e come da mia promessa ti scrivo il diario da Napoli. Appena lasciato il porto, abbiamo trovato il mare piuttosto cattivo e molti passeggeri che si trovavano in coperta, sono scesi giù nelle loro rispettive cabine, parecchi dei quali con i sintomi del mal di mare. Io sono rimasto in coperta per più di un’ora e poi sono entrato nella mia cabina dove dormiamo in 4, io e 3 romani che vanno a Gibuti con macchine. Mi sono sdraiato un po’ per riposarmi, ò letto il giornale e poi mi sono cambiato vestito e alle 19 siamo andati a cena. Francamente ò mangiato bene, siamo in 8 per tavola con tovaglie pulitissime; 3 piatti, uno per la minestra, poi bistecche con molto contorno, frutta, caffè, dolce, vino e di tutto a volontà. Per ora, cara Ucia, sto molto, ma molto bene, il mare è più calmo e si dondola meno. Fra poco andrò a letto e voglio sperare di continuare a stare così. Ciao cara Ucia e Ucino, buona notte e spero starete pure voi due bene. Domenica 18. Sto ancora molto e veramente bene, ti assicuro cara Ucia: ò dormito proprio senza neppur svegliarmi una sola volta durante la notte. Ora sono già sicuro di non soffrire per nulla il mare e sono contento. Stamattina appena preso il caffè sono andato a Messa celebrata non dal cappellano di bordo, ma da un frate che si recava nelle Indie spiegando anche il Vangelo. Dopo la messa, coi miei amici e colleghi ci siamo fatti diverse fotografie e passeggiato in coperta, parlando dei nostri famigliari e di quello che faremo in Africa. Anche a mezzogiorno si è mangiato molto bene e nel pomeriggio ànno distribuito a gratis, un piccolo giornaletto con le più importanti notizie dall’Italia e dall’Estero. Cara Ucia senz’altro non pensare a me perché ti assicuro e ti giuro che sto tanto bene, non credevo proprio di fare un viaggio così buono, non mi sembra neppure di essere in alto mare. La maggior parte della giornata ce la passiamo pensa in prima e seconda classe a leggere libri e raccontare barzellette e fumare certe sigarette leggerissime che assolutamente non fan- 184 Ti scrivo dall’Abissinia no male. Io fumo le Balcana e le pago 2,40 di 20. In Italia costano, credo, 9 lire - i cerini li danno a gratis. Anche a cena si è mangiato bene tutto a volontà. Ora vado ancora in 1.a o 2.a a trovare qualcuno per passare un’oretta e poi verso le 10 andrò a letto.. In questo momento ànno cambiato orario, anticipandolo di 24 h. Ciao Uciona desidero che tu stia bene proprio come sto io ed arrivederci a domani. Lunedì 19. Anche stanotte ò dormito molto bene e causa allo spostamento di orario ò dovuto alzarmi prima per non rimanere senza caffè-latte. Per ora tutto procede benissimo e stanotte saremo a Porto Said [Egitto]. 1.a fermata, la seconda sarà la nostra, il tempo è sempre ottimo e il mare calmo. Si dice a bordo che domani cominceremo a sentire di più il caldo. Cara Ucia, avverti Bruno che oggi ò saputo che uno dei migliori amici di viaggio è il socio di Zaniboni dello zuccherificio. Non so ancora come spedirò la presente e se da Porto Said oppure da Massaua per via aerea. La vita a bordo è sempre la solita, si gioca a carte, di nulla però, neppure la consumazione, si parla delle solite cose più o meno, tanto perché venga l’ora di colazione e cena indi in cabina si va. Allora cara Uciona ài capito, mi raccomando in modo speciale di stare bene tu ed Ucino perché io di salute stò molto bene. Salutami tanto tanto i tuoi genitori, Bruno, e quanti chiedessero di me. Stasera a cena dovrei vedere due ragazzi di Faenza e voglio chiederci se conoscono Tonino e se sanno pressappoco quando verrà via, ad ogni modo appena sapete voi qualcosa scrivetemi subito. Ciao cara Derna vogliamo sperare che tutto proceda come fino ad ora e nell’attesa di leggerti a Decamerè ti accludo molti aff.mi baci anche ad Ucino, ed alla tua famiglia cordiali saluti. Tuo molto aff.mo e per sempre Guerrino 4. Da bordo del Biancamano, martedì 20 aprile 1937 Cara Dernuccia Anzitutto desidero avvisarti che continuo a stare ottimamente bene. Proprio per nulla nulla mi sono accorto di aver già fatto tante ore di mare. Stamattina alle ore 4 locali siamo entrati a Porto Said (a Bologna saranno state le 3 circa) e subito mi sono alzato. Solo verso le 8 il commissario di bordo ci à permesso di scendere a terra onde visitare la città. Tù vedessi cara Derna quanto è caratteristica tale cittadina, è tutto un negozio, ma belli e anche molto movimentati; ò avuto subito e proprio l’impressione di vedere qualche cosa di diverso. Ò comperato il casco [il classico copricapo tipo coloniale], due canottiere, un termo e altre cosettine. Da Porto Said siamo ripartiti alle 10 imboccando subito il Canale di Suez. Ò imbucato anche a P.to Said una lettera e una cartolina, per via normale però, ma spero ti arriverà prima della presente che imbucherò appena arrivo a Massaua. Molto bello è anche il Canale di Suez ed ogni tanto si vedono piccoli paesaggi sulla sponda, tanto belli e caratteristici. 185 Vittorio Pallotti Stanotte alle 23 saremo a Suez. Ora suona il gong e bisogna andare a mangiare. Ciao Uciona arrivederci a domani e tanti bacioni a te ed Ucino. Mercoledì 21. Stamattina alle 7 sono stato svegliato dai compagni tanto dormivo bene. La giornata di oggi è trascorsa sempre ottimamente in pieno Mar Rosso. Tempo bellissimo, mare calmo calmo e verso le 10 abbiamo incontrato il veloce e anche bello «Vittoria» diretto in Italia e proveniente da Massaua. Anche a bordo abbiamo festeggiato il 21 aprile con la musica dei marinai. Oggi nel pomeriggio ò avuto occasione di parlare con diversi ragazzi di Faenza i quali conoscono Tonino, ma non sapevano nulla della sua partenza. Cara Dernuccia, ti scrivo ora prima di andare a letto, sono le 23,30 e fino ad ora siamo stati in coperta assieme al socio Zaniboni, al mio amico di Calcara e ad un altro signore di circa 50 anni di Firenze. Questi è sempre con noi, è molto colto, conosce benissimo mezzo mondo, soprattutto l’Africa e tutta la sera ci à parlato delle più remote civiltà ed in particolare di quella Egiziana. Ora vado a letto, augurando a te, ad Ucino ed anche ai tuoi una felicissima notte, con la certezza che tutti tutti starete bene come sto io. Giovedì 22. Mi continua una ottima salute ed anche l’appetito. Mare calmissimo e tempo bello: stamattina ci accompagnavano squadre di delfini per lunghi tratti e pesci rondini e anche qualche pescecane. Domattina venerdì alle ore 5 saremo a Massaua quando tu dormirai perché corrisponde alle 3 circa di Bologna. Ora vado un po’ a riposare e stasera preparerò la mia valigia. Anche nel mar Rosso non ò sofferto molto caldo come dicevano. Cara Ucia come vedi ò fatto un viaggio ottimo e domattina, appena posso, ti scriverò ancora da Massaua per dirti qualche cosa della macchina [l’autocarro Fiat 634, che sarebbe stato il suo strumento di lavoro]. Ciao cara Dernuccia mi raccomando sempre di stare tanto e sempre bene come nel modo più assoluto ti assicuro di me, e con ciò arrivederci da Massaua . Salutami Ucino ed i tuoi. Venerdì 23. Ecco giunto a Massaua stamattina alle 5,30, terminando il viaggio ottimamente. Appena sbarcato ò trovato Zini e Peli [altro collega di lavoro di Anzola E.] coi quali sono ora a mangiare. Ò già visto la macchina e forse nel pomeriggio la sbarcano e domattina carico per Decamerè. In piroscafo ò trovato un ottimo ragazzo sposato di Taranto vecchio autista d’Africa, il quale starà con me fino all’arrivo di Tonino. Avrete letto la diminuzione dei prezzi ma è conseguenza delle strade migliorate, quindi dicono che si guadagna ancora. Spero avrete già saputo qualche cosa di Tonino ad ogni modo scrivimi in proposito. Cara Derna, pensami, ma non dubitare come starò io perché ti giuro che la mia salute è ottima ed anche il morale. Cerca di curarti te ed Ucino nostro, mi raccomando di non cadere quando cammini e [parola incomprensibile] di Ucio. Ora ò saputo da uno di Faenza che i Geminiani sono in Italia, ma ritorneranno in Africa. Ciao cara Ucia stai pure bene, anche i tuoi spero staranno così. Tanti lunghi baci a te e Ucino ed aff.me [affettuosissime] cose. Salutami tutti tutti dicendo che sto bene. Tuo aff.mo per sempre Guerrino 5. Dessiè, 6 maggio 1937 Molto aff.ma Derna, approfitto di un po’ di tempo libero per assicurarti che la mia salute è proprio sempre 186 Ti scrivo dall’Abissinia ottima. Ora sono a Dessiè e il viaggio prosegue bene salvo qualche gomma bucata. Però ànno già cominciato le piogge e quindi io preferisco andare molto cauto anche impiegarci più giorni, ma pur di ritornare bene a Decamerè. Spero di arrivare ad Addis Abeba sabato sera se tutto andrà bene, quindi dovrei essere ancora a Decamerè verso il 20, ma di preciso non lo so. L’importante è di arrivarci bene come senz’altro speriamo perché come ti ò detto andiamo molto adagio e l’autista [molto probabilmente etiope o eritreo] è molto prudente ed ottimo conoscitore delle strade, guida la macchina sempre lui. Stanotte ò pernottato a Dessiè dove ò fatto montare due gomme nuove. Prima di partire ò comperato una cassa di vino, una di birra e molte scatolette di carne, latte e marmellata ed una [cassa] di acqua minerale, perché qui su [sull’altopiano etiopico] il vitto è carissimo soprattutto il bere, un fiasco di vino costa 20 lire. Cara Ucia stai pure più che tranquilla perché io ò di tutto per mangiare e bene ed anche di stomaco sto bene molto. Ò comperato la magnesia, le purghe, il chinino, ecc. ecc. Ma per ora non ò avuto bisogno di nulla nulla. Mi dispiace solo di stare parecchi giorni senza sapere tue sempre molto gradite notizie. Cara Uciona non dubitare che tu ed Ucino, vi ricordo sempre sempre e penso che starete bene come me. Cara Uciona mi raccomando quando cammini di non cadere di stare molto in riguardo e di prenderti tutto quello che ài bisogno. Penso anche ad Ucino quando ti darà dei calcioni poverino. Scrivimi e dimmi sempre tutto tutto sai Uciona. Al ritorno spero di trovare a Decamerè Tonino. E tua zia come starà? Scrivimi anche in proposito. Appena c’è Ucino od Ucina, scriverò sulla macchina [probabilmente il nome del nascituro/a]. 6. Decamerè, 17 maggio 1937 Carissima Uciona sto benissimo di salute e di morale, quindi stai tranquillissima cara Uciona riguardo a me. Spero e voglio credere che anche tu ed Ucino starete molto bene. Sono arrivato domenica mattina dopo un viaggio ottimo salvo qualche piccola pioggia. Ò ricevuto tutte le tue lettere anche quella che cambiò l’indirizzo tuo padre. Cara Uciona scusami se non rispondo eventualmente a tutte le tue domande dato il poco tempo che ò qui. Con molto piacere ò saputo che Tonino à già il lasciapassare e aspetta il biglietto, perciò spero che presto arriverà e mi avviserai per telegramma così se mi sarà possibile cercherò di andarlo a prenderlo a Massaua. Ora se possibile vorrei lavorare con la macchina da Massaua a Decamerè, Asmara, ecc. e non andare più ad Addis Abeba perché le strade sono ancora pessime, soprattutto da Dessiè. Cara Uciona il clima lo sopporto molto bene ò molto appetito e non faccio economia per il mangiare e per il bere. Per il divertimento neanche a parlarne potevo benissimo lasciare a casa il vestito blu e il cappello nero, qui c’è solo da lavorare e sperare che la macchina vada bene. Qui fa molto piacere quando si trovano amici, come tanto spesso mi capita. Decamerè è un centro importante perché ci sono molte officine e ditte come la Ceraso, 187 Vittorio Pallotti ma quasi tutte baracche di legno e poche case in muratura. C’è il cinema, anzi ieri sera davano [proiettavano] «Vivere» con Tito Schipa, ma io sono andato a letto presto perché stanco. Con me dormono Zini, Peli e altri due uno di Forlì e l’altro di Bologna arrivato pochi giorni fa e che à fatto il viaggio con Manzoni che stava qui da voi [forse in via Gorizia 7, dove Derna abitava con i genitori]. Oggi ò la macchina in officina per fare guardare il cambio e accomodare una balestra, il motore va però molto bene e domani martedì vado giù a Massaua a caricare cemento e scaricarlo a circa 200 chilometri. da Decamerè. Cara Uciona qui donne bianche ce ne sono poche e credo stiano meglio in Italia soprattutto si dice per le mestruazioni le quali non sono regolari, così mi raccontava uno. Cara Ucia ò sentito anche che il sig.Arrigo è venuto due volte da te, ma io gli ò scritto già 4 volte e anche oggi scriverò a lui e a casa mia, ma tante volte non mi [è] possibile scrivere sempre 3 lettere e le medesime notizie assieme, certo che faccio sempre del mio meglio dato che in Africa le comodità non sono come [in] Italia. Aff.ma e cara Uciona ti ò letto per il trasferimento e mi sembra che tu abbia scelto molto bene; ti faccio infiniti e sinceri auguri perché tu venga esaudita e nel miglior modo dato il diritto che ài. Ad ogni modo sono sempre ansioso di sapere notizie in proposito e alla peggiore delle ipotesi, chiedi l’aspettattiva Cara Uciona il primo viaggio di A.ba.[Addis Abeba] mi à reso 14.400 lire lorde, ma nette incasserò poco perché ò preso già dalla ditta 5.000 lire per due gomme, 2.000 lire in contanti, 1.500 lire per il bollo della macchina, un copertone nuovo, circa 1.000 lire di carburante e poi le trattenute per il viaggio mio e della macchina e l’11 per cento quale diritto di Ceraso, ecc. Di queste spese le avrò solo questo mese e poi più. Nel ritorno ò caricato a Dessiè 20 militari fino a Decamerè e spero mi pagheranno qualche cosa, circa lire 1.500, ma non sono ancora sicuro. E di tua zia perché non mi rispondi? come starà? spero bene. Contraccambio i saluti dei tuoi e di tuo fratello il quale lo ringrazio per l’interessamento presso Iperbole. Oggi volevo scrivere cartoline agli amici, parenti e conoscenti; ma non so se avrò tempo, dato che debbo lavorare nella macchina [probabilmente per fare controlli, messe a punto, riparazioni]. Cara Uciona vorrei pure stare ancora con te, ma il tempo è poco ora mangio qui con Zini la pastasciutta che abbiamo fatto noi e poi scriverò a casa mia e a Tosi. Ciao cara Uciona bella e brava anch’io ti assicuro e ti giuro su Ucino nostro che sarò sempre tutto tutto solo tuo, stai certa e tranquilla perché voglio troppo bene a te a me e ad Ucino. Ti ringrazio della notizia di Pietro. Ciao Uciona tanti veri aff.mi baci ed abbracci dal tuo tutto tuo Ucione. 7. Cartolina illustrata da Decamerè, 20 maggio 1937 Carissima Derna, parto ora per Dessiè e sarò di ritorno il 25. Stamattina ò ricevuto la tua del 13 graditissima. Sto sempre ottimamente come senz’altro starete voi. Ciao Uciona tanti aff.mi baci ed auguri tuo Ucio 8. Decamerè, 28 maggio 1937 Carissima Uciona e Ucino, 188 Ti scrivo dall’Abissinia ancora la mia salute è veramente ottima come pure il morale è altissimo e la macchina risponde alle esigenze dell’Africa. Come già ti ò scritto con cartolina sono già stato a Dessiè e ritornato benissimo. Ieri pomeriggio ò caricato ancora a Decamerè e oggi parto per Addis Abeba con casse di latte condensato e se tutto va bene, come speriamo, sarò di ritorno verso il 10, soprattutto se nel viaggio di ritorno non mi requisiscono [la macchina; molto probabilmente per esigenze militari] per qualche giorno nel viaggio di ritorno. Ieri ò ricevuto anche la tua graditissima del 16, ma soprattutto speravo anche di trovare Tonino o almeno il telegramma. L’autista va sempre bene è un ottimo ragazzo serio e volonteroso, ma con me ci potrà stare ancora per pochi giorni, dovendo ritornare col suo vecchio padroncino [così erano, e ancor oggi sono chiamati i proprietari di un unico autocarro]. Io spero che Tonino sarà già partito e trovarlo senz’altro al ritorno da Addis Abeba. Per il biglietto del viaggio dite al rag. Caramitti che faccia assoluta pressione a Roma perché lo mandino altrimenti a Roma dormono. Cara Uciona per il caldo non dubitare perché si sta come in Italia, anzi io credo che sia più fresco in Africa, a Massaua invece sì che fa molto caldo. Io vado vestito sempre all’autista [alla maniera dell’autista] tanto in viaggio come pure quando sono fermo. Cara Uciona sono contento anzi contentissimo quando leggo che tanto tu ed Ucino state bene e sempre vi penso vi vedo e spero che continuerete a stare ottimamente come vi assicura il vostro aff.mo Ucio. Cara Uciona ti vedo già grossa grossa e chi sa come starai bene e ti prego nel modo più assoluto di stare tanto in riguardo in tutto e per tutto. Per la visita ài fatto bene e vedrai che tutto sarà come deve essere, ad ogni modo non vedo l’ora di saperlo. Cara Uciona, il 2 giugno [compleanno di Derna e primo anniversario di nozze] penso che sarò ad Addis Abeba molto probabilmente e fin d’ora ti faccio tanti auguri e pensieri aff.mi. Cara Uciona la strada per Addis Abeba non è troppo buona soprattutto gli ultimi 140 km e la montagna [è] altissima; pensa che il Passo Mussolini, a circa 200 chilometri dalla capitale fra Dessiè e Addis Abeba, è alto circa 4.800 metri. Io appunto ò preferito andare ancora una volta ad Addis Abeba prima che comincino le vere piogge le quali dureranno circa due mesi e mezzo. Ora ci sono le piccole piogge fino alla fine di giugno. L’autista è sposato con due bambine, una di 13 anni e l’altra credo di 9. Con piacere ò saputo che tua zia sta meglio e speriamo che continui. Grazie molto della fotografia che mi manderai e sarà graditissima presto te ne manderò anch’io. A dormire nella cabina si sta proprio bene e stai tranquilla che non soffro freddo. Anche per il mangiare cerchiamo di fare del nostro meglio senza risparmiare nulla. Ora non si viaggia più in colonna perché pericoli non ve ne sono. Ad ogni modo il traffico è grande come da Bologna a Milano, forse maggiore. Ecco l’indirizzo di Elio Maccaferri - via Palmieri 1 Porta Ticinese - Milano, salutalo tanto per me. Con piacere ò sentito anche che vi siete accomodati discretamente in casa. Addio sempre più aff.ma Uciona, stai tranquilla perché io sto proprio tanto bene e ti faccio i migliori i più cari auguri perché tu stia altrettanto bene e che anche Ucino sarà bravo. Saluta tutti soprattutto i tuoi tuo fratello ed i parenti. A te ed Ucino milioni di bacioni abbracci lunghi ed i più cari pensieri ed aff.mi cose ed auguri. 189 Vittorio Pallotti Tuo veramente tutto tuo e per sempre Ucio [ P.S.]: Cara Uciona ò ricevuto ora la tua graditissima ultima, ma dovendo partire subito per Addis Abeba, con altre due macchine, non ò tempo di risponderti in proposito. Ti scriverò ancora in viaggio. Ciao Uciona tanto cara tanti lunghi baci anche ad Ucino o ad Ucina ed infiniti e sinceri auguri . Tuo sempre aff.mo Ucio 9. Decamerè, 12 giugno 37 Aff.ma Uciona, salute e morale sempre ottima. Cara Uciona avrai atteso mie notizie immagino con ansia anche da Addis Abeba, ma inutilmente. Spero però avrai ricevuto il telegramma fatto il giorno 1 da Dessiè. Dopo Dessiè circa 50 chilometri la Regia Intendenza mi à fermato perché in quella località erano rimasti sprovvisti di latte condensato e solo dopo due giorni ò potuto scaricare. E tu cara Uciona grossa grossa, come starai? Scrivimi, magari se non puoi, fai scrivere da tuo padre, anche in semplice cartolina pur di tenermi informato circa le tue condizioni. Anzi io per qualche giorno rimango fermo a Decamerè perché causa guasti alla cabina ed un po’ al cassone ò messo la macchina in carrozzeria. In questi giorni mi riposerò molto e ti scriverò a lungo anche a te. Con molto piacere ò letto di Tonino e oggi proverò d’informarmi circa l’arrivo a Massaua così se mi sarà possibile andrei a prenderlo allo sbarco. Ò letto quanto à detto la levatrice per l’orina e spero che il responso del professore sarà buono. Avverti Bruno che in questi giorni scriverò a tutti quelli del zuccherificio (per via normale) e che intanto saluti Bernardi Riva ecc. ecc. ecc. Cara Uciona il giorno 2 ero fermo in attesa di scaricare la macchina [dal suo carico] minuto per minuto invece ò dovuto attendere più di 2 giorni. Rammentavo pure i giorni seguenti [successivi] a Roma e Napoli ecc.ecc. Cara Uciona oggi pomeriggio vado all’Asmara dall’ing. Ceraso ma i soldi credo me li dia solo lunedì. Oggi all’ Asmara andrò a trovare Goffredo di Bazzano e li saluterò da parte tua. Ciao cara Uciona. Quando mi manderai quel telegramma tanto atteso? Mi raccomando, curati stai molto in riguardo e sii brava. Tanti aff.mi auguri i più belli e sinceri dal tuo tutto e sempre più aff.mo Ucione 10. Cartolina postale da Asmara, 18 giugno 1937 Carissima Uciona, Anche stamane ò ricevuto un’altra tua e te ne ringrazio. Anch’io sto molto bene come con infinito piacere ò sempre letto di te e dei tuoi. Tonino è arrivato all’improvviso a Decamerè perché a noi ci avevano assicurato che l’Ogaden [nome di un piroscafo] arrivava a Massaua due giorni dopo. Ora sono più contento e presto cominceremo a lavorare assieme. Domani scriverò anche a te con lettera da Decamerè. Ciao Uciona stai sempre tranquilla e bene perché il tuo Ucione ti pensa ognora. Aff.mo Guerrino 190 Ti scrivo dall’Abissinia 11. Decamerè, 19 giugno 1937 Carissima Uciona, Come ti ò promesso ieri oggi ti scrivo la presente per assicurarti sempre della mia ottima salute ed anche quella di Tonino Ò detto subito a Tonino che la mamma sua sta meglio come mi ài scritto tu. Cara Uciona con moltissimo piacere ò letto quanto à detto il professore e sono davvero tranquillo e contento. Non solo spero cara Uciona, ma voglio essere sicuro che tu sarai tanto brava ed anche Ucino od Ucina faranno pure i bravi perché tutto vada bene. Non vedo l’ora di ricevere il telegramma [che avrebbe annunciato la nascita di Ucino]. Mi raccomando sempre Uciona di stare tranquilla per me perché io godo ottima salute il clima credo sia meglio che in Italia, escluso Massaua, e l’appetito mi continua formidabile. Cara Uciona, di essere venuto in Africa non sono certo pentito, per quanto la ditta Ceraso non sia troppo puntuale a pagare e questo fatto potrebbe anche influire sul morale. L’unico pensiero è la distanza enorme che mi separa da te Uciona cara ed anche dai miei genitori, per tutto il resto faccio qualunque sacrificio. Cara Uciona appena pronta la macchina spero poter andare a lavorare con un’altra ditta verso Dessiè o Addis Abeba e sarebbe un lavoro molto buono e più sicuro per riscuotere. Cara Uciona ieri pomeriggio ò proprio visto subito Vecchietti il marito di quella signora di Via Podgora 7 [una traversa di via Gorizia] il quale sta bene ed à avuto molto piacere di conoscerci. Cara Uciona io altre novità importanti non saprei, ora c’è Tonino e presto speriamo cominciare a lavorare assieme. Oggi ò scritto più di 50 cartoline ma per via normale altrimenti mi ci vorrebbe un patrimonio. Ora spero scriverti più spesso anche poco, ma almeno dirti e sempre sinceramente come sto di salute. Ciao cara Uciona tanti cari e belli auguri i più sinceri ed i saluti più aff.si [affettuosi]. Tanti saluti ai tuoi anche da parte di Tonino. Tuo aff.mo e per sempre Guerrino 12. Cartolina illustrata da Decamerè, 26 giugno 1937 Io e Tonino stiamo molto bene. Vi ricordiamo ed affettuosamente vi salutiamo. Già avevo scritto al zuccherificio ma per via normale. Ciao Uciona tanti bacioni ed auguri tuo aff.mo Guerrino 13. Decamerè, 29 giugno 1937 Carissima Uciona Come ti ò promesso rispondo alla tua ultima del 20. Anzitutto ti assicuro che tanto io quanto Tonino stiamo molto bene. Ti scrivo la presente subito dopo aver mangiato giù alla mensa di Ceraso con Tonino. Stasera non abbiamo luce elettrica causa guasto al motore e ti scrivo alla luce di candela ed in baracca siamo solo io, Tonino ed il morettino [l’aiutante eritreo] e gli altri sono usciti a fare due passi. L’altro giorno ò trovato all’Asmara Goffredo nella sua officina composta di una piccola baracca, ma non ò visto sua moglie poiché di casa abitano un po’ più lontano. Anche loro stanno bene e ti salutano. Cara Uciona appena la levatrice ti avrà nuovamente visitata fammi sapere subi- 191 Vittorio Pallotti to l’esito il quale senz’altro sarà buono. Cara Uciona anch’io spesso ti sogno, ma ci vuole pazienza ancora per qualche mese e poi speriamo che finalmente staremo assieme. Cara Uciona ò sentito anche che 3 o 4 volte la settimana devi fare una piccola passeggiatina e fai molto bene ad uscire sempre con tuo padre e tua madre. Cara Uciona anche a te desidero farti conoscere l’estratto conto del lavoro fatto. Totale incasso lordo lire 31.691. Spesa totale compreso 5.000 lire delle due gomme circa 4.500 lire dell’autista 1.000 lire del copertone l’11 per cento alla ditta mangiare nafta, olio, ecc. ecc. 19.063 lire. Utile netto 12.628 lire. Da questa cifra però la ditta deve trattenersi una parte delle spese sostenute per il trasporto della macchina ed il nostro viaggio, per ora non si sa di preciso quanto sia. Come già ti ò scritto Ceraso mi à dato un acconto di lire 8.000 dopo aver tanto insistito. Oggi dovevano darmi la macchina ma poiché anche qui si festeggia S.Pietro e Paolo, me la daranno domani oppure giovedì. Ora cara Uciona voglio scrivere due righe anche a Bruno. Quindi anche a te accludo infiniti sinceri, ma proprio sinceri ed aff.mi bacioni abbracci strettissimi sempre assieme ad Ucino od Ucina s’intende; uniti a tanti e belli auguri. Tuo sempre più aff.mo Ucio 13. Cartolina postale da Decamerè, 3 luglio 1937 Carissima Derna Oggi posso scriverti solo con la presente e domani ti scriverò a lungo in risposta alla tua ultima. Per quanto riguarda il sig. Tosi, già avevo scritto col rendiconto prima di ricevere la tua, proprio con la data in cui ò fatto presente anche a te i conti. Per Zini e Peli mi spiegherò bene nella lettera dato che i medesimi lavorano vicino ad Addis Abeba di nascosto a Ceraso. Anche per la cabina [dell’autocarro] mi spiegherò di più, ma sta tranquilla poiché è stato un vero caso, non un incidente vero e proprio [l’autocarro era uscito di strada e si era ribaltato]. La macchina è già pronta. Attendiamo solo ordini per andare a caricare. Ciao Ucia. Molti bacioni aff.mi tuo Ucio 14. Decamerè, 4 luglio 1937 Carissima Uciona, come ti ò promesso ieri sera con semplice cartolina postale, ti scrivo stamattina subito appena alzato, avvertendoti subito che la mia salute e quella di Tonino sono veramente ottime e senz’altro penso che anche la tua e quella dei tuoi siano altrettanto. Cara Uciona, mi devi perdonare molto, ma molto se proprio senza volere, stupidamente, non ò accluso in qualche mia ultima i bacioni che doverosamente dovevo mandarti. Credi però cara Uciona che alle volte qui in Africa certe cosette care e piacevoli, passano momentaneamente per la testa e per quanto uno cerchi di ricordarsele non ci riesce. Infatti sovente si vorrebbe ricordare nomi di persone, strade di Bologna e qualche volta ci dimentichiamo pure i giorni e le date. Cara Uciona, mi raccomando e non credere che mi sia successo qualche cosa di grave per cui io sia preoccupato di dover essere stato fermo molti giorni a Decamerè, poiché la causa è stata perché Ceraso non aveva sol192 Ti scrivo dall’Abissinia di in contanti per comperarmi una cabina nuova già pronta, così ò dovuto trovare una carrozzeria la quale mi à fatto una cabina nuova, robusta proprio adatta all’Africa pagandola a mio comodo. Causa poi le piogge giornaliere e la macchina, come tutte le altre, è allo scoperto, ànno dovuto impiegarci più giorni. La causa poi della rottura della cabina, anzi io credevo di avertelo detto, è stato così: vicino alla strada vecchia si trova un tratto di strada nuova rialzata e nel prendere la curva a passo d’uomo sono andato troppo vicino alla strada rialzata, causa i freni che non tenevano abbastanza, quindi la macchina è stata costretta a ribaltarsi piano piano sulla strada vecchia. Quindi se noi fossimo andati forte, oppure fossi andato contro qualche ostacolo si sarebbe certamente danneggiato il motore, lo chàssis, ecc.ecc. Perciò cara Uciona puoi proprio stare completamente sicura e tranquilla perché l’incidente è piccolo. Per quanto poi riguarda al sig. Tosi e come già ti ò scritto, io appena ò potuto avere da Ceraso i conti mi sono subito interessato per farglieli sapere. Cara Ucia proprio ora è ritornato Zini, da solo però, lasciando su la macchina e il suo socio. Subito gli ò detto che il sig. Tosi aveva saputo da sua moglie che già avevano spedito a casa 23.000 lire. Il sig. Zini senz’altro mi assicura e mi à pure fatto vedere, presente Tonino, che lui à spedito a casa 10.000 lire in tutto e solo il 28 circa del mese scorso à fatto un altro vaglia da Dessiè (credo di altre 10.000) riscosse dalla ditta per la quale lavora attualmente. Anzi Zini stesso mi à detto che vorrebbe accludere alla prossima lettera che scriverò a Tosi due righe per smentire appunto quanto à detto a te, ed anche in merito alla poco buona situazione finanziaria in cui si trova Ceraso. Cara Uciona ài fatto benissimo a scrivermi il colloquio col sig.Tosi, poiché come vedi io sono sempre a posto in tutto e per tutto, anzi mi raccomando scrivimi pure sempre tutto tutto. Cara Uciona io non sono affatto e per nulla angustiato te lo giuro sulla tomba dei miei cari perché la mia coscienza è tranquilla e faccio solo il mio dovere da onesto. Zini e Peli carichi extra non ne ànno fatti e poi se ora mandano a casa soldi, bisogna tenere presente che loro attualmente lavorano sotto un’altra ditta di nascosto a Ceraso e vengono pagati anche ogni settimana, Ceraso invece paga solo quando dispone. Cara Uciona, altro che coraggio mi faccio io, anzi io e Tonino abbiamo un morale altissimo e solo attendiamo l’ordine per poter andare a caricare forse giù a Massaua. Cara Uciona ài fatto bene a farti dare l’indirizzo del mio amico così gli scriverò subito. Anche per il Provveditore ò sentito, ma oltre che dalle carte, le tue condizioni le dovrebbe avere notate e bene soprattutto con la tua presenza, è vero cara Uciona? Quindi senz’altro vedrai che ti favorirà. Con infinito piacere ò sentito che Ucino od Ucina sta nella tua pancina proprio come deve stare e che si farà vedere verso il 15 o 20. Cara Uciona dal 15 in poi andrò sempre in ufficio da Ceraso con la speranza di trovare il tanto desiderato telegramma. Anzi il telegramma indirizzatelo così: Pallotti - Campo Ceraso - Decamerè. A.O.I. [Africa Orientale Italiana]. Vedremo se la levatrice ci indovinerà. Cara Uciona mi devi proprio perdonare se non sarò presente, ma tu sai che non sono venuto in Africa per diporto od altro, quindi Uciona perdona la mia assenza e pensa solo che tutto, tutto, andrà bene; avremo il frutto della nostra eterna sacra unione e gli vorremo tanto bene. Stai certa Uciona, che se anche non vedrò nascere il nostro primo amore già mi sento l’orgoglio di essere padre e di volergli infinitamente bene, anzi non vedrò 193 Vittorio Pallotti l’ora ed il momento per porgergli il primo bacio [invece del bacio, quando mi vide per la prima volta circa tre anni dopo, mi porse … un sonoro ceffone. Forse non preparato a sufficienza dai parenti per questo incontro spasmodicamente atteso dal padre, il figlio Ucino accolse questo sconosciuto con una frase che suonava più o meno così: «Vai via, io non ti conosco, tu non sei mio padre»]. Aff.ma Uciona, mi raccomando non parlarmi più di certe cose mi ài compreso? Stai tranquilla Dernuccia, perché il mio pensiero è proprio sempre a te rivolto e più i giorni passano maggiormente attendo la lieta notizia. Immagino sì cara Ucia che soffrirai, ma tu sarai forte pensando soprattutto che il tuo Ucio ti ama veramente ti vuole infinitamente bene. Cara Uciona qualora dovessi cambiare ditta te lo farei sapere subito. Il nostro morettino ci serve per fare pulizia nella baracca, va a prendere l’acqua da bere e da lavarci, ci pulisce, qualche volta, le scarpe, alla mattina ci porta il caffè in branda, lo mandiamo a fare qualche spesuccia, ecc.ecc. Per il lavare invece, qualche volta laviamo noi, come i fazzoletti, calze, ecc. altrimenti portiamo alla lavanderia. Per ora rimango con la Ceraso, ma però potrei anche fare qualche viaggio per altre ditte che pagano subito. Cara Uciona, mi raccomando se ora cominci a disturbarti a scrivermi, preferisco che tu mi scriva meno, oppure fai scrivere magari un po’ a tuo padre. Ài capito Uciona, penso ed immagino come sarai bella grossa grossa e tonda tonda è vero Uciona. Ed ora Dernuccia ti accludo subito tanti bacioni proprio anche quelli stupidamente dimenticati le altre volte. Unisco abbracci aff.mi; sempre i migliori auguri, sicuro che tutto andrà benissimo. Saluta sempre anche i tuoi, dicendogli che anche Tonino sta bene e li saluta. Ciao Uciona bacioni, abbracci pensieri ed auguri. Tuo sempre e più aff.mo Ucio 15. Biglietto postale da Massaua, 8 luglio 1937 (via normale: partito il 9 luglio, arrivato a Bologna il 14) Carissima Uciona, Come vedi ci troviamo a Massaua avendo già cominciato a lavorare e caricheremo circa 50 quintali di uova da portare a Decamerè. Mi dispiace che mi manca il tempo per scriverti più a lungo. Ad ogni modo novità nessuna, noi siamo sempre in ottima salute, la macchina va bene e molto. Anche te spero starai come il tuo Ucione il quale più che mai ti pensa con la sicurezza assoluta che tutto andrà bene. Appena posso ti scriverò di più. 16. Decamerè, 11 luglio 1937 Molto carissima e aff.ma Uciona Ò letto con piacere come ti trovi ed anch’io posso assicurarti e giurarti che la mia salute è ottima ed anche il morale è alto. Come già ti ò detto ò già fatto un viaggio da Massaua a Decamerè e tutto è andato benissimo. Domattina lunedì presto ritorneremo giù a Massaua e caricheremo catrame per Decamerè oppure per Amba Lagi ad ogni modo ora posso assicurarti di fare sempre viaggi non lunghi e su strade asfaltate. Questo perché cara Uciona sono passato, in regola, col permesso delle autorità, sotto un’altra ditta, la quale mi à anticipato tutte le spese per saldare i lavori fatti alla macchina. Ora so194 Ti scrivo dall’Abissinia no proprio contento, soprattutto perché facendo viaggi corti starò assente da Decamerè massimo due giorni, quindi appena arriverà il tanto atteso e desiderato telegramma lo leggerò subito. E poi con le piogge posso lavorare lo stesso dato le strade asfaltate. La ditta Ceraso molti dicono che potrebbe anche fallire, per fortuna che io mi sono fatto dare quelle 8.000 lire più riparazioni ecc. Ora le macchine di Ceraso lavorano per altre ditte perché temono di non essere poi pagati. Per l’indirizzo scrivi ancora col solito e presto ti manderò il nuovo, il quale dovrebbe essere così: presso Limiti anziché Ceraso. Cara Uciona, tanto cara; che sia Ucino od Ucina gli vorremo lo stesso tanto bene e faremo tutti i sacrifici anche per loro, certo che eventualmente avrei piacere che il mio cognome continuasse è vero Ucina? Pensa Ucina che fra giorni sarai mamma ed il tuo Ucio papà. Domani 12, perciò la mia attesa si fa sempre più grande. Come starai ora Ucia? sarai già a letto? potresti anche già esserti liberata è vero? Ò letto per la stufa economica e per l’assicurazione. Se Bruno eventualmente dovrà interessarsi per Evaristo [Molinari, un cognato di Guerrino] ringrazialo tanto fin d’ora. Cara Uciona, ora per vederci non posso dirti nulla per quanto il desiderio sia grande, immenso e solo a costo di sacrifici rimango qui, perché spero proprio che i sacrifici verranno appagati dopo rimanere per sempre vicino alla mia cara ed aff.ma Ucia ed Ucina o Ucino. Ciao cara e sempre aff.ma Ucia, mi raccomando di farti tanto coraggio, pensando che Ucio ti ama proprio con tutto il più grande affetto e ti assicura che è e sarà sempre tutto tuo. Bacioni lunghi cari a te ed all’erede. Tuo Ucione 17. Biglietto postale da Massaua, 16 luglio 1937 Carissima Uciona Mi dispiace non poterti rispondere in proposito alla tua graditissima ultima perché come vedi ti scrivo ancora da Massaua in attesa di caricare. Poiché mi trovo a Massaua da due giorni non vedo l’ora di arrivare a Decamerè perché potrei anche leggere il telegramma che attendo sempre con infinita ansia. Uciona mi raccomando di farti coraggio, poiché tutto andrà bene, o meglio sarà già andato forse anche bene. Anch’io sto proprio ottimamente di salute e di morale come pure Tonino. Ciao Uciona tanti, ma tanti sinceri aff.mi auguri e bacioni infiniti anche all’erede caro. Tuo molto e sempre aff.mo Ucio. 18. Cartolina postale da Addis Abeba, 18 agosto 1937 Carissima Ucia ed Ucino, siamo arrivati ieri sera martedì ad A. Abeba dopo un viaggio ottimo. Solo venerdì potremo ritornare a Decamerè e speriamo che tutto andrà bene. Noi di salute stiamo sempre molto bene ed anche di morale. Anche voi due spero starete altrettanto bene. Ed Ucino come sta? È buono? Ti lascia dormire? È sempre così grosso? Non vedo l’ora di arrivare a Decamerè per leggerti e sentire che soprattutto starete bene. Anche la macchina va bene e speriamo continui. Ti scriverò ancora e più a lungo da Decamerè. Per ora aff.mi e molti cari bacioni a te ed Ucino qui vicino a me in foto. Ciao auguri. Tuo aff. Ucio 195 Vittorio Pallotti 19. Cartolina postale (via aerea) da Asmara, 24 agosto 1937 Carissima Derna Siamo arrivati stanotte a Decamerè ed anche il ritorno è stato ottimo. Ora mi trovo all’Asmara per il cambio della targa ed il collaudo della macchina. Con grande piacere ò letto tutte le tue ultime graditissime. Se domani avrò tempo ti scriverò più a lungo. Ò ricevuto anche la partecipazione [della nascita di Ucino, molto probabilmente] e ti ringrazio molto. Ero molto in ansia per la lunga assenza da Decamerè, ma avendo letto che tu migliori continuamente, Ucino sta benissimo, ora sono contento. Anche la nostra salute è ottima. Sono felice perché Ucino è già battezzato ed à ricevuto molti regali. Tanti bacioni cara Ucina e sempre anche a Vittorio aff.mo. Saluta i tuoi. Vostro aff.mo Guerrino 20. Cartolina postale (via aerea) da Asmara, 30 agosto 1937 (arrivata a Bologna il 3 settembre) Carissimi Poiché proprio stasera parte l’aereo, desidero con la presente assicurarti ancora che la nostra salute continua ottima. E tu ed Ucino come starete? Voglio e spero starete bene anzi già completamente bene. È birichino oppure ti lascia in pace? Se vedi i miei salutali tanto [i genitori di Guerrino abitavano al Martignone, sulla via Emilia a 800 metri da Anzola E. e a 12 chilometri da Bologna, per cui Derna non li vedeva certo di frequente], come sempre desidero che tu faccia anche ai tuoi genitori ed a Bruno molti cordiali saluti. Ti prego voler gradire assieme ad Ucino molti sinceri ed aff.mi bacioni. Stasera spero leggerti. Baci. Tuo aff. Ucio 21. Foglio brevettato per posta aerea A.O.I. di peso inferiore a gr. 5, Asmara, 9 settembre 1937 (arrivata a Bologna il 14 luglio) Carissimi ed aff.mi Alla tua graditissima del 2 rispondo appena tornato dal rag. Pirzio Biroli. Ò potuto andarci solo oggi e mi à ricevuto molto gentilmente nella sua villetta in via Godaif 22, Asmara, presentandomi la sua signora, la quale mi à fatto vedere il bambino e facendo a te molti auguri. […] ad ogni modo quando tu me lo dirai io scriverò lo stesso personalmente al sig. Provveditore, senza però dirgli da quanto tempo mi trovo in Africa. Da Decamerè all’Asmara alle volte ci vado con la nostra macchina quando porta sabbia, qualche volta con amici oppure fa servizio anche la corriera tre volte al giorno a. e r. e molte volte approfitto della macchina della ditta poiché tutte le mattine vanno ad Asmara. Asmara Decamerè ci sono circa 45 chilometri tutta salita e discesa, con strada bella ed asfaltata. Asmara credo sia a circa 2.500 metri s.m. e Decamerè a circa 2.000. Ti ringrazio cara Uciona delle fotografie che mi manderai appena possibile di Vittorio assieme a te. La fotografia che à mandato a casa Passerini ricordo che l’abbiamo fatta qualche giorno prima di festeggiare Vittorio e dato che la negativa credo l’abbia Zini di Anzola, sarà difficile averla poiché Zini e Peli, come tutti gli altri, ànno lasciato la ditta Ceraso 196 Ti scrivo dall’Abissinia ed ora sono con una ditta ad Asmara. Cara Uciona ò sentito che tu stai benino ed Ucio benissimo, ma io voglio sperare che fra breve anche tu ti rimetterai completamente. Ò letto anche che Ucino mangia molto e si ingrossa quel birichino che l’altra notte ti à tenuta desta per tre ore. Presto spero andare su ad Addis Abeba e ti scriverò subito se rimarrò in cantiere. Il Gimma è molto bello e vi sono terre fertili, esistono solo piccole colline e molta pianura. Certo, cara Ucia, che in cantiere la vita è molto migliore ed anche la macchina sta meglio, la posta potrebbe impiegare magari due giorni di più. Ora attendo Tonino da Decamerè carico di sabbia e stasera ritorniamo giù. Domani non so se caricheremo ancora sabbia oppure andremo giù a Massaua a sentire [qualcosa] come 43 gradi all’ombra od anche più. Ciao tanto cara Uciona anche ad Ucino molti aff.mi bacioni e tanti auguri a tutti e due. Saluti da Tonino anche per i tuoi e da parte mia. Tuo aff. Ucio 22. Foglio per posta aerea, Asmara, 13 settembre 1937 (arrivato a Bologna il 19 settembre) Carissima Ucia ed Ucino Ò ricevuto la tua graditissima ultima e ti ringrazio anzitutto sono rimasto sorpreso e contentissimo del regalo che Bruno à fatto a Vittorio carissimo. Ti prego con la presente ringraziare molto Bruno per il regalone e poi lo farò anch’io personalmente rispondendo alla sua pure molto gradita. Dalla spesa e dove la comperata immagino senz’altro che sarà molto bella ed elegante [la carrozzina, probabilmente]. Ò letto pure che Ucino capisce già che sta bene nella carrozzina e si arrabbia poverino quando non lo fate camminare, mi scrivi anche che sempre più assomiglia a me in molti particolari e che continua ad ingrossarsi. Con piacere ò letto che è venuto a trovarvi anche Evaristo [Molinari, il cognato del Martignone di Anzola E.] e per quanto riguarda Romeo [Masina, altro cognato di Anzola E.], io gli ò scritto che faccia lui come crede meglio fare poiché ora l’Africa non è più quella di un anno fa, per quanto ci sia da guadagnare di più che stando in Italia. Con un ritardo di venti giorni ài ricevuto la cartolina da A. A. Per ora non credo necessario che tuo padre vada a Roma al Ministero [della Pubblica Istruzione], ad ogni modo se avesse i biglietti gratuiti [il padre era un ferroviere] potrebbe anche fare una scappata pagando noi le spese. Anzi cara Ucia se tuo padre andasse a Roma, sarebbe bene che prima si recasse da quel signore col quale siamo stati già in corrispondenza e se tu non trovi più l’indirizzo, lo potrebbe avere Bruno, chiedendolo alla guardia del zuccherificio, Asioli, suo zio. Così dato che quel signore è impiegato al Ministero, potrebbe essere più facile ad avere colloqui. Io poi scriverò al Provveditore come mi ài consigliato tu. Circa poi al regalo [per Vittorio: una piccola collana d’oro con medaglietta riproducente la Madonnina del Tenbien, una località etiopica], cara Ucia ò ricevuto la misura ed appena mi sarà possibile farò senz’altro del mio meglio sperando di accontentarvi. Ucino già comincia a ridere? ma chissà quanto sarà carino. Bacialo tanto sai e digli pure che il suo papà lontano gli vuole tanto tanto bene e farà per lui tutti i più grandi sacrifici. Ciao cara Uciona anche tu come me fatti corag- 197 Vittorio Pallotti gio e prega tutte le sere come fa il tuo tanto amato e caro marito più che sincero. Ti bacio sempre e ti dico di essere sempre tutto tutto e solo per voi. Baci ancora per Ucino ed abbracci aff.mi a te. Saluta i tuoi. Tuo per sempre Ucio 23. Foglio per posta aerea da Asmara, lunedì 20 settembre 1937 (arr. a BO il 24 settembre) Carissima Ucina ed Ucino. Innanzitutto ti assicuro che la mia salute continua ottima. Stamattina subito la ditta Limiti mi à consegnato la tua ultima graditissima e con molto piacere ò letto che tu stai bene ed Ucino sempre benissimo, non solo, ma mi assicuri che Vittorio ogni giorno diventa sempre più carino. Cara Uciona puoi ben immaginare quanto desideri vedervi, ma ci vuole pazienza, è vero cara Ucia? passeranno ancora questi mesi e speriamo con maggiori profitti di quelli già passati. Ad ogni modo cara Uciona noi due sappiamo il bene che ci vogliamo e nessuna distanza può diminuire il nostro affetto. Cara Ucia, da due giorni il lavoro in Africa è aumentato per noi di molto e quindi spero di guadagnare di più. Come già ti ò scritto con cartolina, ò caricato a Massaua per Macallè a 30 lire al quintale ma oggi si prenderebbe anche 40 e più lire quindi caricando 70 quintali si potrebbe realizzare circa 700 e più lire, ed in 3 giorni o 4 si può fare il viaggio di a. e r. L’intendenza invece paga al solito. Noi siamo partiti da Macallè ieri domenica alle ore 13 circa e stanotte all’una eravamo a Decamerè, circa 320 chilometri. Sono sempre in attesa di caricare per Addis Abeba ed intanto stanotte andremo ancora giù a Massaua. Oggi mi trovo all’Asmara sempre per definire i conti con Ceraso, il quale cara Uciona ò l’impressione che si sia sbagliato di qualche migliaia di lire a suo danno in seguito alla cattiva amministrazione […]. Con molto piacere ò letto le piccole passeggiate verso S. Luca che fai con Ucino e fai molto bene, guarda però di non strapazzarti Uciona. Anche la visita che ti à fatto la mamma [di Guerrino, Augusta Vanzini] mi à fatto molto piacere e soprattutto perché mi assicuri che sta bene. Se ti sarà possibile andare ad Anzola farai piacere anche a me, ma però vacci se ti senti proprio bene. Voglio sperare che tu abbia anche già ricevuto la lettera in cui ti parlavo del colloquio avuto col figlio del gen.[generale?]. Cara Ucia ò appreso la risposta del giornalino [scolastico, probabilmente] io però volevo scrivere al provveditore da A. Abeba ed appena scritto te lo farò presente. A proposito della C.(…) ò sentito che continua ad essere sempre lei la medesima, poverina! ma anche quel marito?! Cara Uciona, l’altro giorno ò mandato a casa 2.500 lire a mio fratello e 2.500 al s.[signor] Arrigo [forse un creditore], ma stai certa cara Uciona che io penso sempre anche a te e non dubitare che appena posso avere qualche cosa di più e spero presto, te lo mando anche a te ed Ucino. Tu sei troppo buona e gentile, lo so, ma io voglio e desidero mandare anche a voi quanto posso. L’altro giorno avevo detto a Tonino che mi ricordasse per mandare a Faenza qualche cartolina, ma poi ci siamo dimenticati. Ti accludo una foto fatta nel ritorno da Addis Abeba mentre guardo un magnifico panorama. Addio Uciona, mandami pure sempre notizie anche di Ucino e appena puoi la fotografia. Molti lunghi cari sinceri aff.mi bacioni a te ed Ucino. Grazie per i saluti gra- 198 Ti scrivo dall’Abissinia diti dei tuoi e di Bruno al quale appena posso scriverò, intanto salutali tutti. Di nuovo molti baci ed abbracci. Vostro aff.mo Ucio 24. Foglio per posta aerea da Asmara, 24 settembre 1937 (arrivata a Bologna il 28 settembre) Carissima Ucia ed Ucino Grazie infinite per le fotografie di Ucino tanto gradite. Non importa se è venuto tutto serio e con gli occhi un po’ socchiusi poiché interessante è che io vi veda. Mi sono piaciute molto molto e tutte tre. Vedo anche che Ucio [Ucino] è molto grosso ed ò constatato che pure tu stai rimettendoti discretamente. Cara Uciona e alla notte come va Ucino? Ti disturba poverino? e di giorno piange spesso? sai io ci penso a tutte queste cose ed immagino che spesso dovrai fare qualche sacrificio. Ò letto che sono venuti a trovarti i Vianelli [amici della famiglia di Derna] e se mi manderai l’indirizzo scriverò anche a loro una cartolina, come pure scriverei volentieri a tutti gli altri tuoi parenti più prossimi sempre se mi darai gli indirizi loro. Il bambino di Pirzio Biroli, mi è sembrato bellino per quanto avesse pochi giorni, ma non ricordo più come si chiami. La ditta Ceraso non è ancora fallita, ma una gran parte di padroncini ànno cambiato ditta, fra i quali anche Zini e Peli. Cara Uciona stai pure sempre tranquilla perché tanto io quanto Tonino stiamo ottimamente. Mi dici di Ucino [che] dorme con te nel mio posto e penso anch’io quanto sarà carino. Mi dispiace di non aver ancora potuto scrivere personalmente a Bruno, ma assicuralo che lo farò appena possibile e spero presto. A proposito Bruno à saputo poi se allo zuccherificio ànno ricevuto tutte le mie cartoline? Incaricalo di ringraziare Amedeo [forse Amedeo Malverdi, titolare dell’omonima impresa edile, che raggiunse Guerrino in Africa e col quale strinse un amicizia che si protrasse nel dopoguerra e che sfociò in un rapporto di collaborazione professionale protrattosi, con grande stima reciproca, per molti anni] della sua cartolina ricevuta molti giorni fa. Ora il lavoro qui à ripreso, infatti l’altro giorno, appena arrivato giù a Massaua ò subito caricato per l’Asmara reti per brande, ma io preferisco andare a [caricare] sabbia perché appena arriva l’ordine di caricare per Addis Abeba desidero trovarmi in sede, non solo, ma anche il prezzo della sabbia è aumentato. Addio cara Uciona e ciao caro Ucino. Ti ringrazio per gli auguri graditissimi. Saluta Bruno ed i tuoi genitori. A te ed Ucino sempre più cari aff.mi sinceri bacioni ed abbracci. Vostro tutto e sempre aff.mo Ucio 25. Cartolina illustrata (via aerea), Asmara, 2 ottobre 1937 Carissimi, domani domenica spero potervi rispondere più a lungo. Per ora ti posso assicurare che stò sempre molto bene, come pure Tonino. Ciao tanti saluti i più aff.si [affettuosi], tuo Guerrino 199 Vittorio Pallotti 26. Foglio per posta aerea, Asmara, 4 ottobre 1937 Carissima Ieri domenica spero avrai potuto andare a casa mia. Infatti mentre voi stavate mangiando (circa alle ore 13 io alle ore 15 di Decamerè incominciavo a scrivere a casa mia) ma non avevo ancora finito la lettera che gli impiegati della [ditta] Limiti (un Dr.[dottore] in scienze, un Ing. un rag.) mi sono venuti a prendere in baracca per andare a spasso con loro. Quindi non ò potuto scrivere neanche a te, però sapevo che anche a scriverti oggi era lo stesso poiché l’aereo parte da Asmara il martedì mattina, giovedì sabato e domenica mattina. Cara Uciona se ieri come già ti ò detto ài potuto andare con Ucino ad Anzola spero che tutto sarà andato bene soprattutto per Ucino, poverino: ma come ci sarai andata? Cara Uciona volevo rispondere proprio in proposito alla tua ultima graditissima, ma ora mi accorgo di avere preso in tasca un’altra tua del 29 agosto. Cara Uciona mi ricordo però per quanto riguarda la visita che ài fatto fare ad Ucino e sono contentissimo perché anche il dott. ti à assicurato che è sano e molto. Ài fatto benissimo Uciona a farlo visitare, così si è sempre più tranquilli, non è vero? Ad Anzola è venuto anche qualcuno dei tuoi? Spero di sì. Cara Ucia proprio l’altro giorno, trovandomi come ti ò scritto dai Savini ò conosciuto e bene Manzoni quello che stava qui da voi e ti posso assicurare che tutte quelle fortune non esistono, anzi la famosa villa che sta costruendo per la sua famiglia è solo una bella, ma semplice casina ad un piano terreno solo e non sanno, lui e il suo socio, come fare per finirla per mancanza di Filus [denaro ?]. […] Ti scriverò ancora presto. Tanti bacioni al nostro amatissimo Ucino ed a te anche abbracci. Saluta molto tuo padre, tua madre e Bruno. Anche Tonino vi saluta tutti. Ciao baci infiniti e sinceri. Vostro tutto e sempre aff. Ucio 27. Cartolina illustrata da Asmara (via aerea), 6 ottobre 1937 Carissima Ucia Anche oggi sono ad Asmara ma tutte le sere ritorno a Decamerè. Rarissime volte Tonino fa piccoli viaggi solo. Domani risponderò anch’io a lungo alla tua ultima. Noi stiamo sempre molto bene. Molti cari aff.mi baci a te ed Ucino. Cordialità anche ai tuoi. Guerrino 28. Foglio per posta aerea, Decamerè, 17 ottobre 1937 Caro Bruno Anzitutto ti chiedo perdono se ò ritardato a rispondere alla tua molto gradita. Ti ringrazio anche e nel modo più sincero del graditissimo regalo a Vittorio il quale immagino che qualche volta disturberà anche te. Pure gradite mi sono giunte le notizie dello zuccherificio e quella che più mi à sorpreso è stata quella del sig. Ristori. Ti sarò sempre grato se vorrai contraccambiare i saluti a tutti gli amici dello zuccherificio ed anche alla Margherita alla Fantini Riva Ramini, il sig. Bernardi ecc.ecc. Per quanto riguarda al richiamo [alle armi] sapevamo già anche noi ma speriamo che qui ci lasceranno sta- 200 Ti scrivo dall’Abissinia re. Per quello che ti à detto Ansaloni di Dessiè, non è vero, però qualche cosa è successo in altri posti, però di poca importanza ed ora tutto è a posto [si trattava forse di qualche azione di guerriglia contro gli italiani]. Sì, Bruno, il Gimma è un bellisssimo posto e presto, anzi in settimana, spero andarci anch’io. Ti ringrazio anche per le notizie ottime vostre e di Vittorio. Caro Bruno ora è ritornato dall’Italia il presidente della nostra ditta il quale ci à assicurato che presto ci sarà di nuovo molto lavoro, ma io se in settimana caricherò per Addis Abeba, come proprio spero, rimango su a lavorare in cantiere con la ditta Parisi la quale fa la strada da A. Abeba al Kenia attraverso il Gimma. Quindi io spero presto di sistemarmi bene e definitivamente. Caro Bruno la vita qui in Africa è molto diversa da quella di Bologna, qui bisogna dimenticarsi i caffè, i divertimenti ecc. però io spero che i sacrifici verranno presto pagati. Salutami tutti allo zuccherificio e soprattutto i tuoi baci a Vittorio e avverti la Derna che forse oggi non posso scriverle perché debbo rispondere ad altre quattro lettere. Ciao Bruno saluti anche da Tonino, da me aff.mi cari saluti, ringraziandoti per gli auguri. Guerrino 29. Cartolina illustrata (via aerea) da Asmara, 23 ottobre 1937 A tutti molti cari aff.mi saluti. Baci a te ed Ucino Guerrino 30. Foglio per posta aerea, Decamerè, 27 ottobre 1937 (arrivato a Bologna il 31 ottobre) Carissima Uciona ed Ucino, ò voluto ritardare [nell’utilizzare] un altro aereo a risponderti con la presente alla tua sempre graditissima ultima del 14, poiché sembrava che si dovesse partire per A. Abeba giorno per giorno, invece il piroscafo che arriva dall’Italia col cemento da portare poi ad Addis Abeba à ritardato. Quindi anche noi partiremo con tutta probabilità solo lunedì o martedì prossimo. Il cemento dovremmo portarlo alla ditta Parisi quella stessa che mi à promesso di tenermi a lavorare in cantiere. Cara Ucia, come ò detto anche a mio fratello [Aldo] e cioè che fino ad ora, non solo io, ma tutti, si è lavorato poco, anzi pochissimo, ma io ò la massima fiducia, anzi direi la certezza che da ora in poi dovrei sistemarmi bene e per qualche mese sicuro. Cara Ucia ti dirò subito anche che la mia salute è come sempre ti ò detto ed assicurato. Anche te mi scrivi di stare benino assai e Vittorio invece ottimamente, non solo, ma diventa sempre più bello, e certamente anche più biricchino. Ti fa tanto arrabbiare? è cattivo? no vero, almeno spero. Cara Ucia nella tua prossima, ti prego, spiegati meglio per quanto riguarda la tua salute, la quale vorrei e spero migliori sempre. Cara Uciona, credilo, e te lo giuro sulla salute di Vittorio, che io non vedo l’ora per poterti mandare anche a te, qualche discreto aiuto. Per quanto poi riguarda la fotografia della macchina, io non ne ò nessuna, e neppure sono io quello che tu dici con i capelli diritti. Non è il caso davvero di impressionarti per tale incidente, poiché sai bene che la fotografia fa sempre vedere, soprattutto in questi casi, peggio di quello che è proprio avvenuto. Per la assicurazione, se proprio insistono, 201 Vittorio Pallotti paga pure onde evitare noie. Ò saputo di quel tale mandato dal Distretto [Militare?] ed anche del permesso ottenuto fino al 30 novembre. Ài fatto benissimo a farti visitare e curarti come dice il D.r [dottore]. Le notizie di Vittorio mi giungono sempre tanto tanto gradite cara Uciona. Te ne sarò proprio e sempre grato se continuerai a dirmi molte cose di lui. Quando puoi mandami pure fotografie tue e sue sai Uciona? Tuo padre, tua madre e Bruno stanno pure bene? Penso sempre che spesso saranno disturbati da quel biricchino di Ucino non è vero? Per ora cara Uciona altre notizie che possono interessarti, nessuna. Sento sempre più il vostro affetto e mio, sincero, leale, eterno. Forse verrà a salutarti un mio amico, il quale faceva vita troppo bella in Italia e venuto in Africa, dove bisogna fare molti sacrifici, dimenticarsi i divertimenti, le fidanzate, ecc. si è stancato ed è ritornato in Italia. Addio Uciona ed Ucino a voi sempre tanti cari aff.mi baci e cari pensieri. Ucio 31. Decamerè, 5 novembre 1937 Carissima Uciona ed Ucino, con la presente per avvertire pure te che domani sabato partiamo per Addis Abeba con circa 65 q.li di sale. Ò caricato due giorni fa qui a Decamerè e stasera dovrebbero essere pronti i documenti onde poter partire domattina. Prendo su con me tutto poiché spero molto poter rimanere in cantiere e guadagnare maggiormente con minor spese. Uciona cara, ricordo sempre la mia promessa per te e per Ucino tanto caro e non mi dimentico sai. Ieri speravo leggerti, invece nulla, ad ogni modo se parto domani e dovessi rimanere in cantiere, sono già d’accordo che mi mandino su la posta. Io, se tutto andrà bene come spero conto di arrivare ad Addis Abeba giovedì sera o venerdì prossimo perché preferisco impiegarci un giorno di più, ma arrivare bene. Appena arrivato sarà mio dovere avvertirti come il solito, sperando che non succedano altri disguidi postali. Cara Uciona tanto tu quanto Ucino voglio bene sperare che starete ottimamente come vi assicura che sta il vostro Ucione. Novità altre nessuna. L’altro giorno sono stato da Ceraso a ritirare l’effetto delle 12.000 lire che noi rilasciammo per le spese di trasporto della macchina e viaggio nostro dicendomi anche che la partita fra noi e Ceraso era chiusa e bene perché i conti erano stati controllati. Addio cara Uciona, ed Ucino bello è sempre tanto caro e simpatico? Salutalo, bacialo ed abbraccialo dicendogli che il suo papà lontano lo ricorda con tutto il più grande affetto. Anche te Uciona ricevi infiniti baci pregando per me come io prego per voi sicuri che un giorno ritornerò fra di voi vincitore. Saluta sempre i tuoi genitori e Bruno. Ciao molti baci ancora e pensieri aff.mi. Vostro aff.mo Ucio 32. Biglietto postale (via aerea), Addis Abeba, 16 novembre 1937 Carissimi, Solo col presente per assicurarti che siamo arrivati ieri sera lunedì. Il viaggio è andato bene, per noi e per la macchina, solo ben 8 gomme abbiamo forato. Oggi abbiamo tro202 Ti scrivo dall’Abissinia vato il proprietario del sale e domani scaricheremo. Appena scaricato andrò subito dalla ditta Parisi a sentire per il cantiere. Domani spero scriverti più a lungo. Ad ogni modo cara Uciona, puoi stare molto tranquilla perché io e Tonino stiamo proprio bene. E voi come starete? Vi ricordo sempre, tu ed Ucino proprio assieme e spero senz’altro starete come il vostro tanto e poi tanto aff.mo Ucio. Sempre anche molti baci per te ed Ucino caro e aff.mi saluti ai tuoi. Tuo aff.mo Ucio 33. Addis Abeba, 20 novembre 1937. Carissima Ucia ed Ucino, senza accusare tua gradita, la quale sarà giù a Decamerè certamente. Cara Uciona solo ieri venerdì abbiamo scaricato una parte di sale ed oggi abbiamo terminato. Come già ti ò detto il viaggio è andato bene salvo le gomme. Ò già parlato con la ditta Parisi, la quale mi à quasi assicurato di farmi lavorare in cantiere e lunedì prossimo spero di sapere l’esito preciso in proposito il quale spero sarà senz’altro buono. Ora qui ci sono molte macchine che vorrebbero andare a lavorare in cantiere perché più conveniente e vita migliore, certo più sacrificata. La ditta Parisi mi à detto che dovrei lavorare a contratto. Quindi non so ancora quanto si prenderà e forse andremo nel Gimma a circa 200 o 300 chilimetri oltre A. Abeba. Oggi ò parlato con dei padroncini della Parisi e mi dicevano che se riesco ad andarci sarò contento. Cara Uciona se tutto andrà bene come molto spero ò ancora pochi giorni e poi sarò sistemato e bene. Cara Ucia mi sembra un secolo di non aver ricevuto tue notizie ma voglio proprio sperare che tanto tu quanto Ucino caro starete sempre ottimamente, come il vostro amato Ucio. Cara Ucia io tutte le sere prima di addormentarmi prego per voi perché Iddio vi conservi sempre in ottima salute, così come sono sicuro che farai tu. Cara Ucia, ed Ucino come va? ti farà arrabbiare soprattutto alla notte? Presto spero di vederlo almeno in fotografia. Appena mi sarà possibile ti manderò il nuovo eventuale indirizzo. Anche i tuoi spero staranno bene, anzi devi dire a Bruno che ieri notte à dormito sulla mia macchina il socio di Zaniboni, i quali ànno sempre la macchina in cantiere a circa 60 km da Addis Abeba e sono contenti. Cara Ucia, domani domenica oppure lunedì ò già visto quello che prenderò per il nostro caro Ucino e poi lo farò spedire. Anche per te mi sono interessato, ma desiderando una cosa che certamente ti piacerà, credo che non mi rimarrà sufficiente denaro. Mi dispiace cara Ucia, ma tu cara Uciona, sai benissimo la mia intenzione quindi se anche dovessi ritardare spero mi perdonerai. Terminerò la presente domani perché l’aereo parte lunedì. Domenica 21 - ore 14 ò appena finito di mangiare e ritorno a te. Novità fino a quest’ora nessuna. Stamattina insieme ad un mio amico il quale dovrebbe rimanere in cantiere con me, sono andato nel centro di Aba (A. Abeba) ed ò comperato una catenina con la Madonnina del Tembien che accludo alla presente. Spero di aver preso una cosettina che ti piacerà, è oro tanto la catenina come la Madonnina. Potevo prendere anche qualche altra cosa, ma non sapevo se indovinavo. Per te ca- 203 Vittorio Pallotti ra Uciona ò guardato ancora, ma la mia disponibilità per ora non era sufficiente poiché se andrò in cantiere dovrò fare molte altre spese. Appena potrò penserò anche per te, senz’altro. Cara Uciona devi dire a Ucino che papà lontano lo ricorda sempre sempre e che assieme alla Madonna manda anche molti e sinceri auguri assieme alla mamma. Se Uciona vorrai potrai anche farla benedire e farci scrivere la data di nascita 25 luglio 1937 qui a Bologna. Cara Uciona prima di imbucare attendo stasera poiché nel pomeriggio potrei avere notizie per il cantiere, ma le avrò solo domani. Ora scrivo anche a casa mia [al Martignone di Anzola E.] ed al sig. Tosi e poi se sarà presto andremo a fare un giro per il centro di Aba. Ciao cara Uciona appena saprò qualche cosa di preciso scriverò a Decamerè perché mi mandino su la posta. Molti aff.mi bacioni e tanti cari pensieri per te ed Ucino con la speranza che starete proprio bene come il vostro amatissimo Ucione 34. Cartolina postale (via aerea) da Aba [Addis Abeba], 23 novembre 1937 Carissima Derna, Solo con la presente onde avvertire anche te, che oggi ò parlato con l’Ispettore della Parisi, il quale mi à assicurato che io rimango a lavorare con loro. Incominceremo forse lunedì pross. 29 perché qui abbiamo avuto qualche giorno di pioggia. Sabato debbo ritornarci ancora. Ad ogni modo in settimana ti scriverò ancora e più a lungo. Spero che fra giorni potrò leggere la posta di Decamerè [dove continuava ad arrivare la corrispondenza a lui indirizzata]. Voglio ben sperare che starete sempre bene proprio come il vostro Ucio. Per te e per Ucino molti cari aff.mi baci. Vostro Ucio 35. Addis Abeba, 12 dicembre 1937 Aff.ma Ucia e carissimo Ucino, subito ti chiedo molto perdono del mio abbastanza lungo silenzio. Non credere cara Uciona che io vi avessi dimenticato, proprio no te lo giuro, ma tutti i giorni sembrava che dovessi avere qualche risposta veramente positiva da parte di Ditta. Desidero anche dirti subito che la macchina è partita ieri sera sabato con 60 q.li di sale diretta al Gimma. Io ò creduto bene rimanere poiché è in vista qualche lavoro per la macchina e poi Tonino è andato via con altre due macchine e poi la distanza fra Aba ed il Gimma sono solo 360 chilometri. I giorni che Tonino potrà stare via non saprei poiché dipende dai posti di blocco liberi, ad ogni modo dovrebbe ritornare fra 6 giorni circa. Ora del lavoro qui ad Addis Abeba ce n’è anzi sembra che anche in tutto l’impero si riprenda a lavorare. Con la ditta Parisi non abbiamo fatto nulla, poiché quando già eravamo sicuri, l’ispettore che ci raccomandava è stato mandato via dalla ditta Parisi; non solo, ma dato le numerose offerte di macchine per i cantieri nei giorni scorsi, le ditte se ne approfittavano e davano i lavori a contratto. Dato che ora il lavoro non manca si può benissimo fare il servizio di linea. Cara ed aff.ma Uciona, ò ricevuto venerdì 10 la tua molto gradita del 26 u.s. con ac204 Ti scrivo dall’Abissinia clusa la bellissima fotografia. Uciona tanto cara non puoi proprio credere con quanto e quale piacere abbia visto la cartolina e spessissimo continuo a guardarla. Non potevi farmi un regalo più bello. Ò l’impressione vera di vedere Ucino in carne ed ossa ed anche tu sei venuta proprio come spessissimo ti vedo. Cara Uciona non so se mi avrai scritto altre lettere, poiché da quando sono ad Aba ne ò ricevuto una sola. Dato che certamente mi fermerò qui in Addis Abeba ti prego volermi scrivere d’ora in poi così: Fermo Posta Addis Abeba, A.O.I. È vero che mi sono allontanato ancora, ma tu non puoi avere una piccola idea come si stia bene qui ad Addis Abeba, tanto più se si pensa che a Bologna ora farà freddo, ci sarà la neve e penso anche alla vita che farai con Ucino. Per dirti poi come sto di salute ti basti sapere che mi sono pesato in due posti e sono quasi 72 chilogrammi. Quindi spero starai tranquilla. Ora a mangiare sono presso un mio amico che abitava vicino ad Anzola e che à qui la moglie e due bambine piccole. La più grandina fa la seconda classe. Qui ad Aba sono come in pensione e pago circa 20 lire al giorno. Ora che la macchina è via dormo in una branda proprio assieme ad altri amici fra i quali il cognato di mia sorella Maria cioè il marito della sorella di Romeo [Masina, marito di Maria]. Dato la distanza dal centro di A. A. circa 3 chilometri veniamo in piazza solo di giorno, e alla sera dopo cena si fa una partitina [a carte] e poi andiamo a dormillo [a dormire]. Stasera forse andremo a sentire il discorso del Duce, ma non sono sicuro. Per la fotografia mi va molto bene quella che mi ài mandato e che guardo, ripeto, tanto spesso e volentieri. Ò letto che ài ricevuto la catenina di Vittorio. Presto spero sapere se avrai ottenuto altri sei mesi di aspettativa, speriamo senz’altro. Voglio poi scrivere al Provveditore per il trasferimento e nella tua prossima mi dirai eventualmente qualche consiglio. Cara Uciona ed Ucino bello spero, voglio che la vostra salute sia soltanto buona come la mia soprattutto che ora costì fa cattiva stagione. Saluti molto cari a Bruno ai tuoi genitori. Molti cari lunghi bacioni, abbracci forti forti a te ed Ucino e tutti i più sinceri auguri. Aff.mo Ucio 36. Aba, 29 dicembre 1937 Carissima Uciona ed Ucino Sono ritornato ieri sera ed il viaggio è andato bene tanto l’andare come il ritorno. Noi si poteva fare il viaggio in due giorni di meno ma abbiamo dovuto sostare il 25 e il 26 a Ghedò poiché nei giorni festivi non si effettuano le colonne [di autocarri]. Quindi io, il giorno di Natale di S.Stefano e la vigilia di Natale (siamo arrivati nel pomeriggio a Ghedò) l’ò trascorso a 200 chilometri da Aba in un piccolo paese formato esclusivamente di tucul [la capanna indigena di fango e paglia]. Dato che a Ghedò non esistono trattorie alla sera del 24 ci siamo fatti da mangiare noi, invece il giorno di Natale siamo stati invitati a mangiare alla mensa dei sottufficiali del fortino di Ghedò, così pure la sera stessa ed il giorno di S.Stefano. In quei due giorni ò comperato da portare alla mensa tre galline pagandole solo 3 lire l’una circa e 20 uova a 30 centesimi l’una. Cara Uciona ecco come ò passato io pressappoco il Natale. Uciona cara ò ricevuto stamane due tue lettere e ne sono molto contento soprattutto in 205 Vittorio Pallotti quanto riguarda la vostra salute identica alla mia e te lo giuro proprio. Ò letto anche di Ucino tanto simpatico e sempre più birichino, ma sempre in ottima salute. Alla fine di gennaio senz’altro speriamo che tu abbia altri due mesi di aspettativa. Con molto piacere ò ricevuto pure il biglietto di Bruno e ti prego volerlo ringraziare. Ò letto anche che sei stata come i miei molti giorni senza leggermi e ti assicuro che sarà successo qualche disguido poiché massimo io ò ritardato 8 o 10 giorni. Anche dall’Italia è successo qualche inconveniente poiché pure da casa mia mi doveva arrivare una lettera dalla mia sorella [Olga] invece non ò avuto ancora nulla. Ora io potrei caricare di nuovo ma poiché ci sono di mezzo altre feste, aspetto poiché, come ò detto, di domenica i posti di blocco sono chiusi. Carissima Uciona non dubitare, vi penso troppo, troppo ti amo e grande è l’affetto per Ucino e poi non credo che ci sia ragione di offenderti quando tu fai identici sacrifici ai miei. Quando poi mi parli di Ucino ti giuro che sto male, ma sono tanto contento sai, e ti prego darmi spesso sue notizie. Cara Uciona con la presente potrei dirti che fra giorni dovrei avere buone notizie da comunicarti relative al lavoro, ma per ora credo bene non dirti di più, poiché ò notato che tutte le volte che ti ò assicurato, garantito in seguito a promesse fattemi, queste non si sono mai avverate. Perciò cara Uciona fra pochi giorni potrei scriverti dandoti buone notizie. Per la fotografia colorata di Ucino se non ti disturbi, puoi mandarmela e mi giungerà sempre graditissima. Anzi cara Uciona voglio dirti che a Ghedò ò fatto vedere la fotografia tua e di Ucino agli abissini a molti e questi contenti come matti, facevano esclamazioni, baciavano la cartolina con inchini, poi dicevano «bono belo ligg» (buono bello piccolo). Io temevo che la rompessero perché tutti volevano guardarla per primi. Voglio ben sperare che anche voi avrete passato bene il Natale e pure bene passerete l’anno nuovo, di nuovo vi faccio tanti auguri. Sono anche contento poiché ò saputo che i miei ànno fatto anche quest’anno una discreta campagna con le pelli [con il commercio delle pelli grezze]. Cara Uciona in questi giorni farò qualche lavoro alla macchina, poiché c’è sempre qualche cosa da farci e presto ripeto spero darti buone notizie. Addio cara e buona Uciona bacia sempre Ucino. A te oltre che infiniti bacioni sinceri ed aff.mi anche abbracci lunghi come da Aba a via Gorizia 7. Saluta i tuoi. Anch’io per Natale ò assistito alla S. Messa al campo a Ghedò. Baci baci baci baci baci… Ucio 37. Addis Abeba, 10 gennaio 1938 Carissima Uciona ed Ucino, Oggi ò ricevuto la tua del 15 u.s. e mi dispiace assai che tu sia stata nientemeno che 17 giorni senza mie notizie. Immagino anch’io cara Uciona quanto tu sia stata in pensiero in quei giorni ma io non solo ti ripeto ancora, ma ti giuro che quando mi è possibile, non sto mai più di 6 o 7 giorni senza scriverti. Quindi Uciona come già altre volte ti ò detto se ti capita di stare qualche giorno di più senza mie notizie non pensare a male, ma pensa solo a disguidi; oppure a qualunque altra cosa. La tua ricevuta oggi mi è arrivata da Decamerè credo per via normale, poiché l’aereo dall’Italia che doveva arrivare ieri domenica, non è giunto e nemmeno oggi lunedì è 206 Ti scrivo dall’Abissinia arrivato. Oggi io imbuco la presente, ma partirà solo il giorno dopo che arriva l’aereo. Vittorio poverino anche lui durante quei diciassette giorni mi dice che aveva cambiato nel vedere la sua mamma in pensiero. Ora digli pure che papà lontano sta sempre ottimamente e sempre vi ricorda pregando anche il Signore affinché vi mantenga in buona salute, soprattutto voi che ora avete una stagione brutta. Immagino quanto sarà carino bello grasso e qualche volta anche birichino però. Verrà sì Uciona il giorno in cui ritornerò fra di voi non solo in ottima salute, ma spero anche con qualche cosa. Ed ora ti parlerò della macchina. Come già ti ò detto ero in trattative per darla in affitto a lire 7.000 mensili nette con lavoro in cantiere ed ora posso dirti che l’affare è fatto e la macchina partirà mercoledì mattina e dovrebbe cominciare a lavorare entro la corrente settimana. In questi giorni abbiamo sempre lavorato attorno alla macchina e questi voglio sperare siano gli ultimi soldi che spendo, poiché d’ora in poi tutte le spese relative alla macchina sono a carico di chi l’à presa, cioè del rag. della ditta di autotrasporti Giusberti. Cara Uciona se ài la possibilità di vedere qualcuno dei miei mi farai un piacerone di dirgli il contenuto della presente, poiché a loro scriverò fra 2 o 3 giorni. Ora sto cercando qualche cosa da fare poiché non è mia intenzione di stare ad Aba senza fare nulla, anzi ti dirò che ò in vista un lavoro di quattro mesi circa e se riesco dovrei guadagnare proprio benino e questi, cara Uciona, sarebbero tutti soldi miei. E poi già mi sono interessato per le pelli [Guerrino, assieme al fratello Aldo, aveva già fatto esperienza in Italia nel commercio delle pelli grezze] ed ò visto che si potrebbe guadagnare mandando a casa le pelli di gattopardo e leopardo dato che in Italia sono apprezzate molto. Ad ogni modo si vedrà fra 10 giorni circa. Ieri sera è venuto a trovarmi Zaniboni ed ò approfittato per inviare ad Amedeo i miei saluti. Tonino è ancora giù a Decamerè … Ciao cara ed aff.ma Uciona ed Ucino bello. Bacioni proprio molto cari sinceri ed affettuosi a te ed Ucino ed anche tutti i pensieri più belli. Ai tuoi pure sinceri saluti. Tuo aff.mo Ucio 38. Cartolina illustrata (via aerea) da Addis Abeba, 16 febbraio 1938 Sto sempre benissimo. Appena novità ti scriverò. Molti ed aff.mi baci a te ed Ucino. Saluti cari anche ai tuoi. Guerrino 39. Addis Abeba, 1 marzo 1938 Cara Uciona, domattina mercoledì parto per Soddu. Però ti faccio presente che ritornerò ad Addis Abeba fra 5 giorni circa perchè vado su a Soddu con del materiale della ditta Prato e La Spina e non con la nostra macchina perché ancora senza bollo. Faccio questo viaggio volentieri perché so di fare il piacere al titolare della ditta il quale oggi mi à pregato di portargli su il materiale. Io intanto attendo il bollo della nostra macchina dall’Asmara, così quando ritorno in Addis Abeba troverò il libretto già bollato e poi ritornerò a Soddu in cantiere. Cara Uciona ò ricevuto la tua ultima, ma non posso risponderti in proposito perché la 207 Vittorio Pallotti tengo a casa nella valigia. L’importante è che io desidero sempre la vostra ottima salute tanto tua quanto quella di Ucino il quale penso e lo vedo tanto carino e simpatico. Lo faccio vedere a tutti i miei amici e tutte le sere bacio la fotografia dove ci sei anche tu. Cara Uciona ò trascorso questi giorni assieme ai titolari della ditta Prato e La Spina e ne ò avuto una impressione proprio ottima. Se mi era giunto il libretto bollato dall’Asmara potevo andare su con la nostra macchina, invece così andrò su fra 5 o 6 giorni; intanto vado a vedere il posto, il quale so già come è pressappoco e dista da Aba circa 450 [chilometri]. La maggior parte della strada è pista, ma montagne pochissime. E Tonino non so se sia ancora a Decamerè oppure sia venuto in Italia. Cara Uciona ricordati e ti giuro che la mia salute ed il mio morale sono ottimi. Solo spero che anche la vostra salute sia proprio come la mia. Ò ricevuto solo ieri gli auguri dal sig. Bernardi e prego Bruno di ringraziarlo. Baciami tanto tanto tanto Ucione caro e bello e simpatico. A tu Uciona voglio poi infinitamente bene e ti giuro sempre di essere sempre tuo e solo tutto tuo. Quando ritorno ti scriverò proprio a lungo. Scrivimi sempre Fermo Posta Aba. Infiniti bacioni a te i più sinceri e cari saluta i tuoi molto cordialmente. Tuo Ucione 40. Addis Abeba, 27 marzo 1938 Aff.ma Uciona ed Ucino Ò ricevuto in questo momento la tua ultima del 22 e 23 corr. e come vedi ti rispondo subito. Ti giuro che in principio sono rimasto un po’ maluccio e poi in seguito meglio. Cara Uciona senti e voglio sperare che mi crederai. Io qualche volta sono costretto a ritardare, anche qualche volta obbligato, di risponderti, ma di 3 o 4 giorni, e non 18 giorni ad ogni modo ci vuole proprio pazienza come dici tu e dico anch’io. Cara Uciona non dubitare che quando posso è sempre mio piacere darti notizie, anzi volevo scriverti anche durante questo ultimo viaggio, ma non c’era la possibilità di imbucare, oppure ti sarebbe giunta chissà con quale ritardo, tanto è vero che molti operai ànno dato a me lettere da imbucare ad Aba. Quando rispondo proprio in proposito alla tua cerco sempre di rispondere a tutte le tue domande. Quindi continua pure te ne prego a farmi domande. Ò letto con dispiacere dell’indisposizione di Ucino e ti assicuro che sono ancora un po’ preoccupato, ma voglio proprio sperare che ora stia completamente bene. Ài fatto fatto proprio bene a farlo visitare dal prof. Stefanini e domani lunedì guarderò se posso mandarti qualche cosa … Se potessi ti manderei anche più, ma non voglio più rimanere completamente sprovvisto come già mi è successo. Ò poi sentito come e quanto mangia Ucino, mi piacerebbe proprio vederlo voglio sperare che continui con tale appetito. Per il certificato dichiarante che io mi trovo in Africa, io credo che te lo potrà benissimo rilasciare anche il Comune di Bologna oppure questi saprà dirti dove andare. Appena me lo dirai scriverò al Provveditore [agli Studi] dandomi tu qualche appunto. Pure ò letto di Tarcisio [un cugino di Derna] e soprattutto le notizie di Bruno mi ànno interessato, poiché penso che ora sarete più contenti e tranquilli. Saluta sempre i tuoi e Bruno e molto cordialmente, non mi ricordo bene la fisionomia della signorina Castrignano. Se vuoi Derna cara presenta a Bruno e alla futura cognata 208 Ti scrivo dall’Abissinia [Giglia Martinelli] le mie vivissime congratulazioni ed i migliori auguri. Però ò piacere di essere presente al matrimonio.Sembra, ma non sono sicuro, che siano molte le macchine che ritornano in Italia. Cara Uciona ed ora ti dirò qualche cosa circa il mio viaggio ultimo. Ò avuto solo qualche noia al cambio e alla frizione ed ò bucato una sola gomma. Ò dovuto impiegarci quasi nove giorni causa la colonna che ritornava da Lechemti, ò fatto il viaggio da solo senza nulla stancarmi. Oggi ò voluto fare festa, mi sono alzato alle 11 ed ora ti scrivo la presente stando nel caffè Romano mentre fuori in piazza suona la musica militare. Domattina subito farò vari lavoretti alla macchina e martedì ò molte probabilità di partire per Diredaua a lavorare in cantiere sotto il Genio Militare, ad ogni modo avrai in proposito altre precise notizie col prossimo aereo. Ò letto purtroppo cara Uciona che il Provveditore ti à concesso solo aprile cosa vuoi fare siamo sempre al punto di prima e cioè bisogna sempre non arrabbiarsi e farsi coraggio, ma tanto, soprattutto per Ucino poverino e per te finanziariamente e fisicamente e poi quale unione fra marito moglie e figlio è proprio vero quello che dici tu, ma il nostro amore il nostro affetto non diminuirà mai e poi mai te lo giuro pure io. Cara Uciona se avessi la fortuna di poter lavorare benino qualche mese vedrai tu come farei presto a raggiungervi !! Addio cara Uciona ed Ucino termino perché ò molto ancora da scrivere. Ti faccio presente che la mia salute è sempre ottima, il mio pensiero per voi due è costante e soprattutto non dimentico il mio dovere di marito e padre te lo giuro. Addio Uciona cara tanti aff.mi bacioni i più sinceri e belli anche ad Ucino. Abbracci lunghi e stretti ed auguri infiniti. Saluti molti e cari anche ai tuoi ed a Bruno. Ciao ciao e sempre baci più cari e sinceri. Aff.mo e per sempre Ucio 41. Diredaua, 12 aprile 1938 Aff.ma Uciona e carissimo Ucino Come da mia promessa ci tengo a scriverti la presente, anche breve, onde avvertirti che oggi lunedì pomeriggio ò ripreso a lavorare col Genio Militare. Infatti ò caricato un po’ di cemento, copertoni, tende ed una balilla di un tenente da portare ad Addis Abeba. Il carico è buono poiché non raggiunge i 30 q.li e sono pagato a giornata, cioè 530 lire al giorno. Essendo pagato a giornata è meglio così - posso fare il viaggio con la massima comodità. La strada è buona e si potrebbe farla in 2 giorni, ma io la farò in 3 giorni. Arrivato ad Addis Abeba mi fermerò due o tre giorni per lo scarico e poi ritornerò con tutta probabilità a Dire Daua: carico sempre per conto del Genio. Cara Uciona io spero che tu avrai ricevuto la mia ultima di giovedì sempre da D. [Dire] Daua. La mia salute cara Uciona è ottima anche qui per quanto faccia un po’ caldo ed altrettanto voglio proprio sperare di te di Ucino e dei tuoi. Ti rinnovo molti sinceri aff.mi auguri assieme ad Ucino ed alla tua famiglia. Cara Uciona ti prego di scrivermi ancora come prima in Fermo Posta ad A. Abeba poiché avrò modo di leggerti magari con un po’ di ritardo. Ora scrivo anche ai miei ed a Tosi e desidero andare a letto prestino. 209 Vittorio Pallotti Cosa farete voi costì ora? Vi penso sempre sempre, ma soprattutto spero nella vostra salute e faccio voti perché essa sia tale quale la mia. Addio Uciona ed Ucino. Molti lunghi bacioni sinceri ed abbracci aff.mi dal vostro non meno aff.to Ucio 42. Località non indicata [un cantiere stradale lontano da centri abitati], 15 maggio 1938 Molto aff.ma Uciona e caro Ucino L’altro giorno ò consegnato una semplice cartolina ad un autista di passaggio perché la imbucasse, ma temo che non ti sia giunta, poiché in seguito ò saputo che questo tale si è fermato a lavorare in cantiere a circa 70 chilometri dal nostro cantiere. Ad ogni modo aff.ma Uciona ti scrivo ancora la presente e domani dovrebbe passare Tonino oppure il suo principale onde consegnerò la presente così sarò più sicuro che la imbucheranno a Dire Daua. Cara Uciona tu capirai benissimo ora la ragione per cui qualche volta attenderai invano mie notizie. Però ti prego sempre di volermi bene lo stesso di stare sempre tranquilla riguardo alla mia salute la quale grazie Dio è sempre veramente ottima. Cara Uciona ti giuro di volerti sempre tanto bene non solo, ma tutte le sere prego il Signore perché vi mantenga con la stessa salute che ò io. E tu come stai? Ora ti vedo a Runzi [frazione del Comune di Bagnolo di Po (Rovigo), ove Derna insegnava alla scuola elementare] pensando ad Ucino ed a Ucio come io penso alla mia Ucia ed al nostro caro Ucino. Pazienza Uciona, le cose per me si sono cambiate un po’ in ritardo, era sufficiente che io fossi venuto in cantiere qualche mese prima. Infatti ora con la ditta nuova mi trovo a credito ed in più ò due gomme nuove e mi costeranno circa 2.600 lire l’una. Ad ogni modo sono contento e se dovessi terminare presto in questo cantiere ne troverei un altro il più presto possibile poiché in queste zone non è molto difficile. Qui in questo cantiere bisogna fare solo un po’ di sacrificio perché si è lontano da tutto, ma però non c’è pericolo di malattie di strade ecc. Dobbiamo lavarci tutto da soli e qualche volta farci da mangiare. Alla domenica qualche volta si lavora fino a mezzogiorno e ci pagano [la] giornata intera. Nel pomeriggio, si lavora per la macchina e per noi e niente cinema, caffè musica e neppure c’è la Santa Messa. Cara Uciona ora ti scrivo la presente mentre sono in casa e gli operai caricano la macchina di terra e sassi da portare lungo la strada fra poco andremo a scaricare a circa 10 chilometri. Per la verità come lavoro non è da paragonare alla linea [il collegamento stradale fra due città], ma però non tutti si adattano al cantiere perché la vita è troppo monotona. Aff.ma Uciona è da molti giorni che non posso leggerti perché come ti ò detto non ò avuto ancora modo di farmi avere la posta di A. Abeba e quella di D. Daua non solo per sapere notizie circa la vostra salute, ma anche per sapere se dovrò scrivere al Provveditore il quale quest’anno deve trasferirti non ti pare cara Uciona? E poi ci tengo sempre alle notizie di Ucino il quale presto camminerà i primi passi. Sempre aff.ma Uciona si avvicina anche il 2 giugno [compleanno di Derna e secondo anniversario di matrimonio] e fin d’ora ti ricordo questa data inviandoti sinceri auguri, molto sinceri ed affettuosi, con la massima speranza che l’anno prossimo festeggeremo assieme io te ed Ucino più grandicello e più biricchino. Ucino durante la tua assen- 210 Ti scrivo dall’Abissinia za sarà cattivo? quando ti rivede dopo una settimana come ti guarderà? Sarà certamente un sacrificio per i tuoi non è vero? lo immagino benissimo. Mi raccomando Uciona quando vai su e giù in treno [per raggiungere Pontelagoscuro] e soprattutto in bicicletta [Pontelagoscuro-Runzi: circa 15 chilometri] guarda bene di stare molto attenta sai. Ed i tuoi come stanno? spero pure loro sempre ottimamente, e Bruno come va con la sua fidanzata? Darà quest’anno degli esami? [Bruno Barbieri, fratello di Derna, lavorava come geometra allo zuccherificio e, contemporaneamente, era iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio]. Cara Uciona spero accludere alla presente qualche fotografia che ci siamo fatti in cantiere e sviluppata da un mio collega perciò venuta alla meglio. Per ora cara Uciona non saprei che altro dirti. Ti ripeto ancora tutto il mio più grande affetto per te e per Ucino. Vi ricodo sempre con infinito sincero amore sicuro di essere contraccambiato al 1000 per cento; ecco perché preferisco sacrificarmi ancora per qualche mese qui in Africa. Addio Uciona ed Ucino state sempre in ottima salute come il vostro aff.mo Ucio. Vi accludo tutti i più sinceri aff.si e lunghi baci abbracci forti ed i migliori auguri. Vostro aff.mo Ucio 43. Aba [Addis Abeba], 11 luglio 1938 Aff.ma Uciona e caro Ucino ò gradito moltissimo la fotografia di Ucino e la tua ultima. Mi ài fatto un regalo dei più belli cara Uciona te lo giuro. Ucino è sempre con me e sarà sempre con me. Anche tu Uciona mi sei sempre vicina in qualunque posto ed in qualunque momento. Ucino è veuto tanto bene e lo guardo spesso e ti ringrazio se potrai inviarmi una [foto] formato cartolina. Rimango sempre in attesa per le novità del trasferimento ed i primi di agosto voglio sperare mi darai in proposito buone notizie, anche riguardo la vostra salute. Cara Uciona, tu sei buona e sono certo che vorrai perdonare il tuo Ucio se anche con la presente sono breve. Noi si doveva ripartire domattina o stasera tardi per Dire Daua invece si partirà fra mezz’ora. Sono venuto ad Aba assieme ad un certo Roncaglia di Anzola il quale lavora da Gibuti ad Aba ed assieme [a lui] ritorno giù. Lo scopo della mia venuta ad Aba è stato quello di fare i conti con la ditta e farmi dare soldi. Nei conti ò trovato solo circa 800 lire in più per 4 fusti di nafta. A conti fatti dovrei avere a tuttoggi dalla ditta 13.900 lire più la differenza di cui sopra. E pensa cara Uciona che lunedì u.s. ò dovuto prendere dalla ditta 3 batterie nuove e due cuscinetti per semiasse per un importo totale di 2.200 lire quindi fino a domenica ero creditore di circa 17.000 lire. Appena arrivo a D.Daua ti scriverò ancora. Arrivando a Dire Daua spero di trovare ancora un buon acconto e spedire a casa qualche cosa Addio Uciona sto benissimo salutami i tuoi. Bacioni aff.mi tanto a te quanto ad Ucino augurandovi tante belle cose, Sono un po’ preoccupato riguardo a mia madre, poveretta, e non vorrei …mi ài compreso? Ciao Uciona auguri baci abbracci sinceri cari lunghi ed aff,mi Ucio 211 Vittorio Pallotti 44. 6° cantiere [stradale], 16 agosto 1938 Cara Derna Rispondo subito alle tue ultime del 2 e del 9 u.s. e particolarmente rispondo alla tua del 9. Con vero sincero ed infinito dispiacere leggo la tua disperazione [per avere ottenuto il trasferimento in una sede scolastica particolarmente disagiata] e non ài torto, però cara Ucia io ti consiglio di prendere la cosa con più calma e soprattutto nell’interesse per la tua salute. Infatti pensa al caso mio; se io non avessi resistito in Africa contro a mille difficoltà di ogni specie, ora mi troverei in altre condizioni, invece insistendo, sopportando sono riuscito a portarmi nelle attuali discrete condizioni. Capugnano, la tua nuova sede, mi sembra di averlo presente anche perché conosco bene la zona di Riola e Porretta e so pure che è scomodo molto. Ad ogni modo se deciderai di andarci o non ti sarà concesso un altro posto migliore io ti dico subito di non guardare a cinque o dieci lire di spesa in più al giorno purché tu non ti strapazzi. Ti consiglio pure di farti accompagnare in auto da Porretta a Capugnano e ritorno perché tre quarti d’ora a piedi in montagna sono molti, con l’autista però cercate di fare un buon contratto perché diventereste clienti fisse e deve farvi uno sconto. Se poi la tua collega non fosse tanto disposta a prendere la macchina anche per venire giù, tu le devi dire che preferisci anche pagare qualche cosa in più della metà. Per quanto poi riguarda alle spese, ripeto, tu non preoccuparti poiché io ti assicuro, ti giuro sulla cara Tomba di mia madre che penserò io. Per non mantenere questa promessa, dovrebbe proprio succedermi un disastro.E poi se voglio questo, non è solo nel tuo interesse, ma anche nel mio poiché non vorrei mai pensare che ti dovessi ammalare in seguito a strapazzi. Cara Uciona quando riceverai la presente, spero avrai ricevuto un vaglia di circa 400 lire che ti manderò fra due o tre giorni, dato che la macchina a disposizione del capitano andrà su a D. Daua appunto verso la metà della corrente settimana. Proprio ieri sera la ditta mi à mandato altre 2.000 lire onde comperarmi la nafta, quindi avendo ora i soldi in tasca sono ben sicuro di poterteli mandare. Riprendo a scriverti stasera stessa subito dopo mangiato. Stasera sono stato a mangiare come molte altre volte al ristorante «Continental» il proprietario è un greco, mangio il primo il secondo frutta e caffè [per] 10 lire più 2 lire per un quarto di vino, molte volte vado anche a mangiare in una mensa però fuori di D. Daua, dove ci sono dei modenesi ed è appunto là che mangio le tagliatelle ed i tortellini alla bolognese, ma certo non come quelle famose che mi facevi tu, Uciona. Per quanto riguarda la macchina va ancora proprio bene però devo tenerla ed adoperarla con molto riguardo. E la faccenda del provveditore come andrà? Chissà se mi risponderà oppure manderà a chiamare te. ad ogni modo cosa vuoi bisogna sempre essere calmi, avere fiducia e poi verrà anche per te l’ora buona in tutto e per tutto. Ed Ucino sarà già ritornato a Bologna? [dalla Celle di Faenza, ospite di una famiglia di agricoltori parenti di Derna]. Io penso sempre alla prima volta che avrò il grande piacere di vederlo credilo cara Uciona. Uciona ti scrivo la presente da un caffè ove c’è la radio e qualche volta sento le notizie dall’Italia, non pensare però che sia come il Caffè Modernissimo di Bologna, per cari- 212 Ti scrivo dall’Abissinia tà e tanto meno non pensare che tutte le sere vada al caffè a divertirmi oppure a giocare [a carte] mi raccomando. Le mie uniche e sole preoccupazioni sono: la vostra salute, la mia e quella di curare bene la macchina onde averla sempre in efficienza, lavorare e raggiungere il mio scopo. Ecco quello che penso cara Uciona. Ed ora vado ad imbucare alla Regia Dogana perché alla Posta Centrale sono già terminate le levate. Addio Uciona cara, tanti auguri sinceri aff.si e tanto cari anche ad Ucino. Infiniti baci lunghi e belli. Vostro aff.mo Ucio Ti accludo pure due foto fatte in cantiere, venute però troppo scure, una la darai a casa mia per piacere. Grazie La raccomandata fu fatta in errore dai miei amici, come anche quella fatta [inviata] a casa mia. 45. Dire Daua, 26 agosto 1938 Aff.ma Ucia Rispondo proprio a grande velocità alla tua ultima tanto gradita con accluse le foto di Ucino di tua madre e di tua zia. Ti giuro che per me le foto di Ucino sono di grande sollievo, vedendolo bello grosso e sempre col suo sguardo speciale. Cara Uciona ora ti faccio subito presente di averti scritto ancora circa in data 18 u.s. ma partita da Dire Daua i primi della corr. setimana. Anzi assieme alla tua ò pure mandato una racc.ta al Provveditore ed ò la ricevuta in tasca. Era mia intenzione mandarti la copia ma non mi è stato possibile, causa il lavoro. Ti ho pure fatto un vaglia telegrafico però di solo lire 300 in data 18 u.s. e spero lo avrai ricevuto, per questa volta non mi è stato possibile inviarti di più. Con molto piacere ò pure letto che il 15 u.s. sei stata a casa mia ti ringrazio Ucia cara. Desidero anche farti presente che ora lavoro al Comando della 2.a Sezione Strade qui in D. Daua trasportando materiale da un magazzino all’altro. Se questo lavoro potesse continuare qualche giorno sarei un signore. Al nostro cantiere sono state licenziate sabato altre 2 macchine. Anzi, il padroncino di una è un Bolognese e l’altro è quel toscano di cui ti ò parlato. Cara Uciona spero d’aver più tempo da scriverti col prossimo aereo. Io sono venuto a D. D. il 24 e dovevo ritornare giù, invece il Maggiore mi à trattenuto a lavorare in sezione, quindi tutta la mia roba è rimasta giù spero solo non mi mancherà nulla. Per ora tanti aff.mi bacioni abbracci a te ed a Ucino e sempre saluti ai tuoi. Addio Ucia ti scriverò ancora presto e con meno fretta. 46. Dire Daua, 1° settembre 1938 Molto aff.ma Uciona ed Ucino caro Oggi scrivo ancora a te dicendoti subito della mia sempre ottima e grande salute. Voglio e spero che anche la tua quella di Ucino dei tuoi e dei miei sia solo altrettanto. Anche per quanto riguarda al lavoro sono arcicontento e se continuasse ancora così per qualche giorno sarei proprio un signore. Lavoro sempre qui al Comando della 2.a Sezione con la medesima paga di quando ero in cantiere. Comincio alle 7 fino alle 12 e dalle 15 al213 Vittorio Pallotti le 18 circa trasportando sempre materiale da un magazzino all’altro in Dire Daua, carico pochissimi quintali e faccio pure pochi chilometri. Le altre macchine del nostro cantiere sono già tutte licenziate, quindi io sono stato fortunato, ma però ò sempre cercato di fare il mio dovere, ò sempre tenuto la macchina in efficienza e mi ero attirato la simpatia degli ufficiali. Anche il maggiore qui della sezione, mi à chiamato proprio stamattina dicendomi che ci sarebbero ancora circa 700 q.li di cemento, circa 500 poutrelles (q.li 3.500) poi legname, 1.200 paia di scarpe, ecc. ecc. Quindi se mi farà fare questo lavoro ne avrei per quasi tutto il corrente mese. Però da un giorno all’altro possono anche cambiare idea. Desidero anche farti presente che a tutto il 31agosto sono creditore della ditta di circa 20.000 lire e poi se continuo questo lavoro ò la nafta pagata sufficiente fino al 15 circa di questo mese. Ieri sera il mio amico Roncaglia di Anzola mi à portato su tutta la mia roba dal cantiere e fortunatamente mi è mancato solo circa 20 scatolette di frutta, carne, burro marmellata, un po’ di the e pasta, questo però lo prevedevo e non fa nulla. Roncaglia è stato molto gentile e mi à fatto proprio un vero favore, sempre ieri sera gli ò consegnato una lettera e te la porterà lui stesso, partirà da Gibuti il 10 corr. Essendo Roncaglia stato con me sempre più che gentile sono certo che lo riceverai con la stessa tua gentilezza, ringraziandolo di tutto. La tua ultima lettera del 21 agosto cara Uciona mi è piaciuta proprio molto e vorrei che tu mi scrivessi sempre così, poiché quando io ricevo lettere buone da te dai miei e da Tosi, sono tanto contento che tu non puoi averne una minima idea. Io qui ora ò bisogno solo di essere tranquillo, avere da voi possibilmente sempre buone notizie, anche Tosi ora mi scrive tanto gentile sai. Anche per il mangiare qui a Dire Daua stò benissimo certo che spendo molto di più di quando ero in cantiere io preferisco spendere qualche cosa di più, ma desidero mangiare quello che mi sento, qualche volta mangio pure le tagliatelle ed anche i tortellini però questi [solo] alla domenica, per il dormire invece dormo sempre in cabina [dell’autocarro]. Però cara Uciona desidero che tu non dica nulla a nessuno in proposito. Per quei pochi soldi che ti posso mandare, ricordati di adoperarli come e dove ne ài bisogno, tanto per te come per Ucino, ài capito? e sono sicuro che tu li spenderai più che bene. Per quanto riguarda alle chiacchiere che si fanno ad Anzola …la prossima volta che scrivo a casa mia, domanderò ad Aldo se mi sa dire con precisione i nomi di coloro i quali si permettono di chiacchierare e poi questi signori dovranno fare i conti con me. Ò letto anche che Bruno à scritto all’ing. Terzi ed à fatto bene come pure bene credo farai te a scrivere personalmente a S.E. Bottai. Da parte mia ti assicuro che scriverò subito personalmente al Provveditore [agli Studi] con raccomandata dicendogli che tu dovevi avere un’altra [sede] tenuto conto della tua condizione di madre, dei tuoi precedenti svariati e diversi anni di servizio ed in più io mi trovo in A.O. [Africa Orientale] da oltre 20 mesi quale legionario alle dipendenze del Genio Militare di Dire Daua, in mezzo alla boscaglia ed al confine con il deserto Dancalo, quindi ritengo che al mio ritorno in patria, d’aver diritto di avere la moglie più vicina. Se il provveditore ti dovesse domandare cosa io faccio in A.O. rispondigli che sono col Genio Militare di DireDaua e facciamo le strade. Voglio sperare che la mia lettera avrà qualche risultato, ad ogni modo tu procedi per conto tuo anzi, scrivendo al Ministero [della P.I.] potresti, se credi, accennare che io mi trovo attualmen214 Ti scrivo dall’Abissinia te in A.O.I. alle dipendenze del Genio Militare di Dire Daua, 2a Sezione Strade, 6° cantiere e che quanto prima ritornerò in Patria in seguito allo scioglimento del suddetto Genio Militare. Per ora nessuna altra novità stò sempre bene e continuo a lavorare, anzi abbiamo fatto festa solo domenica 14 e lavorato il 15. Mi raccomando di non avvilirti e di non demoralizzarti nell’interesse tuo, di Ucino e mio. Ti prego di porgere ad Ucino lunghi aff.mi e sinceri bacioni ed altrettanto accludo per te. Saluta i tuoi molto cordialmente. Aff.mo Ucio 47. Dire Daua, 6 settembre 1938 Carissima Derna ed aff.mo Ucino Domenica ò ricevuto la tua ultima del 28 u.s. Fino a detta data tu sei stata 20 giorni senza mia posta. E lo credi cara Uciona che io ti ò sempre scritto? Almeno una volta la settimana, ma anche più e te lo giuro sulla Tomba della Buona Anima di mia Madre quindi lo devi credere. Per quanto riguarda al silenzioso vaglia di 300 lire devi sapere che i vaglia telegrafici debbono essere brevi perché [se] lunghi la spesa relativa diventerebbe sonora. Cara Ucia dovevo mandarti 400 lire ed era proprio mia intenzione, ma il giorno stesso che ò consegnato i soldi ad un mio amico per farti il vaglia ò creduto necessario comperare un pezzo di ricambio per la macchina (un iniettore) pagandolo 110 lire non solo l’ò comperato da un autista del cantiere quale occasione, ma soprattutto prevedevo di averne bisogno da un momento all’altro. Stai tranquilla cara Uciona che ora difficilmente rimango proprio in bolletta, magari potrò avere poco in tasca, ma qualche cosa sempre e poi con la somma che devo avere a tutt’oggi (oltre 20.000 lire) ci mancherebbe altro a non avere i soldi per mangiare. Ò letto pure che oggi ritornerai da Faenza con Ucino bello, chissà se ti riconoscerà ancora? e poi anche per te sarà cambiato vedrai Uciona per me invece nulla di cambiato avrà poverino. Ancora pazienza, da parte mia poi hai fatto benissimo ad andarci pure te a prenderlo. Cara Uciona continuo a scriverti con la matita perché ò finito l’inchiostro nella stilografica. Mi raccomando Ucia se non ti senti tanto bene guarda pure di curarti e di non fare soprattutto strapazzi. Sto sempre molto bene io cara Derna ed ancora non so fino a quanto tempo rimarrò a lavorare qui al Comando della 2.a Sezione. Aff.ma Ucia per quanto riguarda la mia venuta in Italia ti dico subito che il mio desiderio è grandissimo te lo giuro anche su Ucino, però tu devi ben capire che se posso lavorare ancora per qualche mese sono costretto obbligato a rimanere. Riguardo alle fotografie te ne ho inviate due accluse alla mia ultima riuscite molto scure però. A te Uciona non dubitare che ti penso non sovente solo, ma sempre, come pure penso ad Ucino ed a casa mia. Come già ti dissi nella mia precedente io penso qui e cerco di stare bene di salute, curare la macchina e fare il mio vero e completo dovere di marito e di padre per il bene e l’affetto verso te ed Ucino. Ò letto poi che ài ricevuto la mia del 16 u.s. ma ti assicuro di averti scritto anche dopo tale data. Aff.ma Uciona, sempre con la presente voglio anche dirti che proprio oggi (7 settembre 1938) ò ricevuto posta da Tosi il quale (io sono arcicontento) mi dice di avere venduto 215 Vittorio Pallotti metà della sua parte e cioè un quarto della macchina a Zini di Anzola. Ripeto che sono molto contento perché ora avrò a che fare con uno che conosce gli autotrasporti in Africa ed è presente, non solo ma sarà Zini che penserà a tenere al corrente Tosi per quanto riguarda il lavoro, le spese e gli utili. Questo è per me un sollievo enorme e una grande preoccupazione di meno te lo giuro. Per ora cara ed aff.ma Uciona ti bacio e ribacio con tutto il mio più grande e sincero affetto, bacia pure e sempre Vittorio bello e saluta cordialmente i tuoi. Nell’indirizzo mio ora metti solo: 2a sezione strade Genio Militare Dire Daua perché il 6° cantiere non esiste più. Addio cara Ucia altri baci sempre sinceri lunghi e carissimi. Aff.mo per sempre Ucio 48. Harar, 18 settembre 1938 Carissimi Ucia ed Ucino Come vedi rispondo alla tua dalla Celle [frazione del comune di Faenza] da Harar. Ò letto con piacere quello che faceva Vittorio [cioè Ucino] in campagna e quello che diceva secondo la sua lingua poverino. Anche la mia salute Uciona cara ti giuro sulla Tomba ultima ed amata di mia madre che è ottima ed altrettanto spero continui la vostra. E sì cara Ucia con quale e quanto piacere vedrei Ucino anche per pochi minuti, ma ritengo sia meglio soffrire ancora qualche mese di più, ma quando avrò il piacere di vederlo e rivederti rimanere per sempre con voi non ti pare Ucia cara. Ò saputo che ànno cambiato provveditore a Bologna e speriamo che il nuovo sia più umano e soprattutto per chi à diritto. Dunque cara Ucia io ora sono venuto su ad Harar (Dire Daua - Harar sono 50 chilometri) per vedere se posso occuparmi con la macchina, con qualche impresa privata di costruzioni e soprattutto ci terrei perché lavorando con questa ditta riscuoterei io stesso i soldi e non la mia ditta. Cara Ucia voglio anche farti presente che prima di venire su ad Harar ò guardato i conti con la ditta e risultavo creditore di 24.800 lire, ma poi ieri ò dovuto farmi dare 1.000 lire per prendere il bollo per la macchina per 4 mesi ed un fusto di nafta, così oggi il mio credito è rimasto di 23.300 lire salvo qualche piccola differenza in più od in meno. Quindi io credo che non sia neanche poco pensando poi alle 6.000 lire mandate a casa, ò preso dalla ditta per circa 9.000 lire di gomme, 1.500 per 3 batterie, circa 1.000 lire per 2 cuscinetti, mangiare e bere per me, olio nafta e manutenzione della macchina provvigione alla ditta l’11 per cento. Se avessi sempre guadagnato così da quando sono in Africa a quest’ora ero già a Bologna. Cara Ucia io ò finito di lavorare col Genio Militare il 15 poiché con tale data la 2a Sezione Strade si è sciolta completamente e non solo le macchine, ma anche tutti gli operai sono stati licenziati. Ora io rimango qui ad Harar qualche giorno anche perché debbo sbrigare pratiche relative alla macchina, perché essa sia in regola e poi se non troverò lavoro ritorno giù a Dire Daua e secondo gli accordi che prenderò con Zini, vedrò se ritorno in Eritrea, oppure rimango qui. Cara Uciona per ora altre novità nessuna ti terrò sempre informata e presto cosa farò e dove andrò. Ò sempre e maggior desiderio di vedervi abbracciarvi per assicurarti e far- 216 Ti scrivo dall’Abissinia ti vedere il bene che vi ò sempre voluto e che vi vorrò ancora. Addio cara Uciona ancora infiniti bacioni proprio come quelli di una volta ed abbracci strettissimi e lunghi sempre anche ad Ucino bello caro e buono. Vostro aff.mo e per sempre Ucio Note al testo 1 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III: La caduta dell’Impero, Mondadori, Milano 1992, pp. 154-55. 2 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., pp. 173-78. 3 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., p.166: «Poiché tutte le ditte automobilistiche di una certa importanza hanno qui [a Decamerè] succursali e magazzini con parti di ricambio, tutto il paese è un’unica, grande autorimessa». Così scriveva la giornalista tedesca Luisa Diel, sul finire del 1937, nel suo viaggio in Etiopia. 4 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., pp.32-37. 5 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., pp. 184-85. 6 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., pp. 185-86 7 ANGELO DEL BOCA, L’ Africa nella coscienza degli italiani, Mondadori, Milano 2002, p. 39. 8 Ne è un esempio il poeta ligure Adriano Grande, le cui motivazioni per la partecipazione alla guerra etiopica nella Legione Parini sono descritte in ANGELO DEL BOCA, L’Africa nella coscienza degli italiani cit., pp. 95-109. 9 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale cit., p. 155: tra il 1936 e il 1938 dei 600.000 italiani che chiedono di andare a lavorare in Africa Orientale, solo 120.000 vi si potranno trasferire. 10 Sulla presenza delle donne italiane in Africa orientale cfr.: A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol.III cit., pp. 221 ss. 11 ANGELO DEL BOCA, L’ Africa nella coscienza degli italiani cit., p. 38. 12 CIRO POGGIALI, Aspetti sereni di vita etiopica, in «La Domenica del Corriere», n.12, 1937. 13 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., pp. 343-44. 14 ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, vol. III cit., pp. 355-56. 15 Ampiamente descritti e documentati da Angelo del Boca nei tre volumi sopra citati. Cfr., in particolare, L’ Africa nella coscienza degli italiani cit., pp. 111-125. 217 L’Esercito del Signore di Mainardo Benardelli Chi ricorda in Italia gli spettacolari attentati islamici del dicembre 2002 a Mombasa, che seguirono quelli di Nairobi e Dar es Salaam del 1998? Anche questi sono stati attribuiti all’audacia di al-Qaida. L’Africa orientale è considerata un’ottima base per le cellule dell’estremismo islamico: è noto a tutti che Sudan e Somalia in gestione diretta e Kenya e Tanzania quali santuari di organizzazioni terroristiche, sono ben posizionati geograficamente per avere tale ruolo, ma al grande pubblico probabilmente sfugge che anche nella cattolicissima Uganda non mancano organizzazioni terroristiche, islamiche e non. In questo senso, appare opportuno sottolineare l’esistenza da circa una dozzina di anni del Lord’s Resistance Army di Joseph Kony, operante nell’Uganda settentrionale, abitata da etnie di ceppo nilotico, estremamente ricche in tradizione profetica e messianica: risulta interessante rilevare che all’inizio il LRA di Kony si proponeva l’instaurazione, tramite la coercizione, dei dieci comandamenti mosaici, e che per tale ragione la stampa lo definiva un movimento di ispirazione cristiana radicale, quando in realtà si è sempre trattato di un movimento di sovversione armata - con una sua struttura militare ben definita - al governo di Kampala. Il precedente Movimento dello Spirito Santo della profetessa Alice Lakwena (cugina di Kony), pur essendo anch’esso un movimento di ribellione armata al governo centrale, ricorreva ad una serie di pratiche tradizionali, come l’invocazione degli spiriti degli antenati e l’uso di unguenti corporali prima dei combattimenti con le unità militari governative. L’Esercito del Signore è in realtà un movimento di guerriglia classica, che opera dal 1992 nell’Uganda settentrionale e che ufficialmente ha come obiettivo l’instaurazione di uno Stato fondamentalista-cristiano; in realtà, secondo testimonianze dei missionari Comboniani (che operano da circa 70 anni nel Paese) si tratta di pochi leader spregiudicati che, con la for219 Mainardo Benardelli za, reclutano ragazzi dai 10 ai 16 anni per combattere il governo centrale di Kampala, con una strategia dichiarata del terrore (saccheggi, stupri, rapimenti di donne e specialmente bambini, reclutamento forzato di combattenti minorenni). La zona di operazione è l’Uganda settentrionale, specialmente i distretti di Kitgum, Gulu e Lira, area che ha dato i natali a vari uomini politici (fra cui Milton Obote ed Okello) che gestirono il potere a Kampala prima di Museveni, innescando tutte le lotte civili che dissanguarono il Paese fino alla presa del potere nel 1986 da parte dell’attuale presidente Yoweri Kaguta Museveni. Le etnie ugandesi del Nord, di stirpe nilotica (assimilabili ai Masai, Nuba e BaTutsi) sono sempre state in conflitto con Museveni: Acholi, Lango, Iteso e Karamajong (questi ultimi considerati banditi che si rendono colpevoli di abigeato, tradizione consuetudinaria di questo popolo da centinaia di anni), da un lato non nutrono simpatie verso un governo che non ha mai fatto mistero della propria politica di disinteresse (sia in termini di sicurezza che di crescita socio-economica) e dall’altro sono le prime vittime dei crimini dei guerriglieri del LRA. Joseph Kony nasce ad Odek (distretto di Gulu) nel 1961 e viene educato nella religione cattolica, avendo anche un breve passato di catechista, da cui mutuerà alcuni termini per il suo movimento: aderisce al Movimento dello Spirito Santo di sua cugina Alice Lakwena, che viene sconfitto nel 1987 e che continua con il padre di Alice, Severino Likoya Kiberu, per qualche anno. Nel 1990 Kony fonda il Lord’s Salvation Army, che successivamente si trasforma in UDCF (United Democratic Christian Force) e finalmente in LRA nel 1992, utilizzando già i metodi che lo renderanno tristemente celebre, un misto di tradizioni animistiche e pseudo-cristiane, una profonda brutalità, un’autorità mistica, una cultura della disciplina e dell’esaltazione della propria carismatica persona. A questi fattori va aggiunto il sostegno del Sudan, che ha fornito fino a pochi mesi fa armi e santuari al movimento (specialmente nelle montagne del Juba). Il trio Alice-Severino-Kony si era arrogato ad un certo punto il blasfemo titolo di «Trinità» (Kony il Figlio - Won - , Severino il Padre - Wod - e Alice lo Spirito Santo - Tipu Maleng - ), ma, dopo la sconfitta di Alice e di suo padre, i rancori emersero fra il gruppo, con mutue accuse. In realtà Kony (al pari di Alice) ha sempre sostenuto di essere la reincarnazione di uno spirito Acholi, cioè un «ladit» gli avrebbe soffiato il suo spirito («laa»). Questo fattore animistico-tribale è forse uno di quelli che maggiormente caratterizza la tipologia del LRA, che potrebbe essere definito di tipo apocalittico (seguendo le dot220 L’Esercito del Signore trine di Kaplan nel libro The coming Anarchy del 1994, che, al pari di tutte le guerriglie africane, combinerebbe «passione, ignoranza, trialismo» e non avrebbe alcun futuro, essendo il Continente Nero «inguaribile»), con la conseguenza che Kony sarebbe una reductio ad insanitatem (parafrasando Hans Magnus Enzenberger), ma in realtà il LRA è anche connotato da caratteri etnici, storici, rurali (è importante il confronto fra periferia e centro, in questo caso, e particolarmente se si considera che il distretto abitato dagli Acholi è molto depauperata e marginale al resto della vita dell’Uganda) e «neopatrimonialisti», per adottare il modello sistemico di Michael Bratton e Nicholas van de Walle. Ma il connotato che maggiormente caratterizza il LRA, oltre a quello messianico, è forse quello classico del banditismo e del «warlordismo», per usare un termine anglosassone difficile da tradurre all’italiano: l’Africa e l’Asia sono ancora pieni di episodi di banditismo e di pirateria, rispettivamente, talvolta (come è il caso del LRA) ammantati da ideologie parapolitiche. I primi atti di Kony seguirono questa logica, e intendevano creare una «nuova razza» di Acholi, purificati dai peccati precedenti. Per raggiungere questo fine, si adottarono una serie di riti di «purificazione», alcuni ereditati dalle tradizioni etniche, altri inventati di sana pianta: stregoneria e riti animistici si univano all’invocazione degli angeli e dei malaika (spiriti potenti), con l’ausilio di rosari e strumenti di magia classica del posto. Ad esempio, Kony è convinto che, grazie alle sue arti ed alla sua personalità ultraterrena, è posseduto da una serie di potenti spiriti: il sudanese Silly Silindi, il cinese Ing Chu, l’americano Maggiore Bianca e l’ugandese Juma Oris (vecchio guerrigliero, già ministro di Idi Amin e successivamente leader del movimento West Nile Bank Front, ormai debellato). Dopo questi riti purificatrici, le reclute erano pronte ad operare nel LRA coloro che invece si opponevano a Kony, subivano torture e mutilazioni orrende, ma altamente simboliche nella primitiva regione di Gulu (il taglio di naso ed orecchie doveva essere una lezione per chi collaborava con il Governo centrale, mentre l’amputazione degli arti - specialmente gambe - era un chiaro segnale per una popolazione che usa unicamente la bicicletta per i propri spostamenti). Gli stupri e il rapimento di fanciulli di entrambi i sessi, spesso oggetto di brutale violenza, aveva questi stessi connotati. Il terrore che ne è conseguito ha cominciato ad impensierire il governo di Kampala, che ha adottato fin dall’inizio una politica di bastone e carota, anche se questo secondo fattore sembra essere perseguito con poca 221 Mainardo Benardelli 222 L’Esercito del Signore convinzione da parte ugandese. Sono molti coloro che si chiedono, infatti, fra cui l’Autore di questo scritto (che ha vissuto a Kampala dal 1993 al 1996) sulle ragioni occulte che stanno dietro alla continuazione della guerriglia contro il LRA e dai blandi negoziati tuttora in corso: da un lato, l’esercito ugandese (UPDF Uganda People’s Defense Forces) è considerato uno dei più disciplinati e meglio addestrati del continente africano (e quest’affermazione era certamente condivisibile fino al 1993, prima dell’inizio delle ostilità a vasta scala che portarono i guerriglieri del Fronte Patriottico Rwandese alla conquista di Kigali nel luglio del 1994, in quanto la maggiore parte di essi proveniva dai ranghi dell’esercito regolare ugandese), che ha addirittura posto le proprie basi nella RDC, convertendo intere regioni ex-zairesi in protettorati, a seguito della dissoluzione dell’impero di Mobutu. Dall’altro, i guerriglieri «di Dio» non superano il numero di 2.000 e sono per lo più minorenni demotivati e poco addestrati (in questo senso, tutte le organizzazioni internazionali umanitarie - Amnesty International, Human Rights Watch, UNICEF, CICR - hanno sottolineato la violenza ed i modi del LRA e gli abusi dei diritti del fanciullo: fino ad ora si parla di circa 8.000 minorenni rapiti). All’esercito ugandese vanno sommati anche i circa 11.000 arrow boys di Mosa Echuaru e Sam Otai, ex ribelli del UPA (Uganda’s People Army), di etnia Iteso, che hanno una funzione di vigilanza contro i guerriglieri del LRA. L’attuale struttura del LRA è organizzata su 4 Brigate, con la seguente gerarchia: Joseph Kony quale Comandante supremo del movimento, con il grado di Tenente Generale; Vincent Otti, quale Vice Comandante e Tenente Generale di grado; Okot Odhiambo Comandante militare del movimento e Maggiore Generale di grado; Raska Lukwiya incaricato dell’intendenza, con il grado di Maggiore Generale; ed i responsabili delle 4 Brigate, con il grado di brigadiere: Ocan Bunia, Dominic Ongwen, Bosco Gogi e Kenneth Banya, che riveste anche il ruolo di Consigliere politico di Kony. In realtà il LRA è stato parte di un complesso scacchiere in cui gli attori principali erano Khartoum-Kampala-Kinshasa, che appoggiavano questo o quel gruppo guerrigliero, spalleggiati, ma non sempre, da potenze occidentali: il dato certo, da testimonianze di chi in queste regioni ci vive - sacerdoti e volontari, per lo più italiani provenienti dal Triveneto -, è che il LRA non solo non adotta comportamenti cristiani, ma addirittura praticano riti animistici (e talvolta musulmani, dopo la conversione di Kony al223 Mainardo Benardelli l’Islam) tipici della zona, e che, in un modo e nell’altro, si collegano proprio ai movimenti settari e millenaristici tipici di quest’area, sfruttando i sentimenti di impotenza e frustrazione delle popolazioni ugandesi settentrionali. Il Sudan ha sostenuto la guerriglia del LRA durante vari anni, ma negli ultimi mesi sembra che quest’appoggio sia notevolmente diminuito e il flusso di armi si sia addirittura interrotto, a seguito specialmente del processo di riconciliazione nazionale sudanese, che ha visto recentemente la fine di un conflitto civile interno fra l’Esercito regolare e lo SPLA di John Garang, al Sud del paese (anche se sino aperti altri fronti, come quello del Darfour). Negli ultimi mesi la comunità internazionale, dopo più di dieci anni di gravi crimini, ha denunciato tali atrocità ed una risoluzione è stata approvata il 22 aprile 2002 alla Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, condannando le parti coinvolte «nel rapimento, tortura, uccisioni, stupri, schiavitù e reclutamento forzato di minorenni nel Nord Uganda, particolarmente da parte dell’esercito del Signore», chiedendo altresì una cessazione immediata di tali pratiche e delle violenze ed il rilascio immediato dei minorenni. Anche la Corte Penale Internazionale dell’Aja ha spiccato i suoi primi mandati d’arresto contro Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya e Kenneth Banya, con l’accusa di omicidio, violenza contro le donne, sistematico rapimento di bambini ridotti a schiavi e costretti a combattere. L’incriminazione risale al maggio 2005, ma è stata resa pubblica solo nell’ottobre scorso. Alcuni osservatori hanno giudicato inopportuna la mossa della Corte, perché metterebbe fine a qualsiasi possibilità per un accordo di pace tra governo e ribelli, che i negoziatori stanno faticosamente costruendo (da parte ugandese Betty Bigombe, già ministro per il Nord Uganda negli anni novanta, ed essa stessa di etnia Acholi; da parte LRA, prima Sam Kolo - che successivamente si è rifugiato all’estero - poi Vincent Otti ed ultimamente Kony stesso). Aldilà dei risultati che questa mediazione (sostenuta da tutta la comunità internazionale) produrrà, risulta interessante capire le motivazioni ultime della guerriglia del LRA Christopher Clapham sosteneva che le guerriglie derivano principalmente da aspirazioni politiche bloccate, che non trovavano altro sbocco se non con mezzi belluini, e che talvolta erano casi al limite della disperazione. L’Uganda, sin dalla propria indipendenza avvenuta nel 1962, è stata lacerata da conflitti civili ed intestini (al momento, oltre al movimento di Kony, vi sono ancora i movimenti insorgenti del 224 L’Esercito del Signore NALU - National Army for Liberation of Uganda - del col. Dusman Sabuni che conta con circa 3.000 persone ed il ADF - Allied Democratic Front - del Col. Kisuule con 5.000 uomini): la percezione che si ha nell’Uganda settentrionale (dominata dalle etnie Acholi, Langi e Iteso) è di essere emarginata dal resto del Paese, e particolarmente di essere «punita» dal governo centrale. Di conseguenza, oltre a proseguire gli sforzi negoziali per una cessazione del conflitto ed una riconciliazione nazionale (anche con la concessione di parziali, o totali, amnistie), risulta fondamentale effettuare una serie politica di ricostruzione dell’Uganda settentrionale, tramite un aumento degli aiuti internazionali. In caso contrario, seppur le brutalità del LRA finissero, sicuramente Kony troverà eredi che proseguiranno la sua lotta. 225 studi sull’Europa Un testo inedito di Mécislas Golberg. Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle* di Francesco Germinario Il testo inedito sull’omicidio rituale è dovuto a Mécislas Golberg, figura straordinaria e commovente di intellettuale e militante degli ambienti libertari francesi fin de siècle. Ebreo di origine polacca nato nel 1869, (il suo vero nome era Goldberg, ma preferiva firmarsi sempre Golberg), Mécislas Golberg, dopo un periodo di studi a Ginevra, si trasferì a Parigi poco più che ventiduenne, alla fine del 1891, per proseguire i suoi studi di medicina. In realtà, a Parigi Golberg abbandonerà quasi subito gli studi accademici, iniziando a scrivere su periodici e riviste letterarie e, su invito del sociologo René Worms, collaborò alla «Revue Internationale de Sociologie». Nel giro di poco più di un quindicennio (morirà di tubercolosi alla fine del 1907), malgrado le ricorrenti difficoltà economiche che lo costringeranno quasi sempre a una vita di pura sopravvivenza materiale, per di più errabonda, tanto che lo porterà in Inghilterra, Svizzera e Italia, a causa anche delle espulsioni decretategli dalle autorità francesi per la sua militanza, Golberg poteva vantare una produzione pubblicistica sterminata, sparsa in pamphlets e riviste, alcune delle quali da lui fondate e dirette. Era una produzione che si estendeva dalla sociologia alla poesia, dalla narrativa ai resoconti di viaggio, dai numerosi saggi di critica letteraria e filosofica all’economia politica. Oltre a costeggiare gli ambienti del sionismo libertario, Golberg fu molto attivo nel periodo dell’Affaire Dreyfus. Il suo impegno politico e culturale gli valsero anche gli attacchi dell’agguerrita stampa antisemita parigina. Alla fine del 1898, su «L’Antijuif», il settimanale diretto da Jules Guérin, uno dei leader più rappresentativi dell’antisemitismo francese, era pubblicato un articolo velenoso sulla figura di Golberg. Riferendosi alla sua produzione teorica, in particolare alle analisi sul fenomeno della disoccupazio227 Francesco Germinario ne, Golberg era definito un «neo-anarco-nichilista» influenzato dal marxismo; ossia, in riferimento ai suoi continui spostamenti in Europa, un «interprete di una legione di criminali cosmopoliti», un «ebreo errante, dedito alle scrocconerie (maître-tapeur), vagabondo (sillonant) da anni in Europa in cerca di sovvenzioni», in conclusione un «ebreo extra-scimmiesco»1. Dopo avere allacciato rapporti con gli ambienti dell’avanguardia letteraria parigina e con intellettuali della statura di Gide, Golberg ebbe anche rapporti personali ed epistolari con Bernard Lazare e Zadoc Kahn, all’epoca rabbino capo di Francia e figura tra le più prestigiose dell’ebraismo europeo. Morì di tisi nel 1907; due suoi fratelli nel 1917 ricopriranno incarichi nella diplomazia sovietica fin dai mesi immediatamente successivi allo scoppio della rivoluzione bolscevica. In questa sede, più che fornire ulteriori delucidazioni su una figura così affascinante, sulla quale, del resto, non mancano monografie e studi approfonditi2, è preferibile qualche contestualizzazione storiografica del contenuto del testo di Golberg, ossia l’accusa di omicidio rituale, una questione a dir poco fondamentale nella storia dell’antisemitismo europeo. Come si potrà facilmente notare, le pagine di Golberg oscillano fra accenni di analisi storica, con riferimenti ai documenti vaticani dei secoli precedenti che giudicavano falsa quest’accusa, e un taglio giornalistico, attento alle notizie emerse nel corso dei processi. Probabilmente Golberg aveva attinto le notizie proprio dai resoconti giornalistici dei processi; ed è altrettanto probabile che, considerati i diversi errori ortografici (che in sede di trascrizione si è preferito naturalmente mantenere, per aderenza al testo), i riferimenti a fonti giornalistiche alquanto generiche, se non errate quale il riferimento a una testata, «L’Osservatore catholico», che quasi sicuramente è «L’Osservatore cattolico» di don Davide Albertario -, egli avesse scritto il testo molto velocemente, in attesa di rivederlo e di arricchirlo per una pubblicazione su rivista, che comunque non avvenne mai, se non per darlo alle stampe come un vero e proprio pamphlet per replicare alle accuse degli antisemiti. È da osservare che un intellettuale libertario come Golberg, peraltro testimone dal vivo della condizione miserabile in cui vivevano le masse ebraiche nella zona di residenza dell’impero zarista, era quasi destinato necessariamente a incrociare il tema dell’omicidio rituale. A indirizzarlo verso questo tema contribuivano, a nostro avviso, diversi motivi, fra i quali le origini ebraiche dell’autore e la sua attiva militanza dreyfusarda. 228 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle E tuttavia, questi ci sembrano motivi nel complesso secondari, rispetto alla constatazione storiografica che le accuse di omicidio rituale erano fiorite nell’Europa nel corso dell’ultimo ventennio dell’Ottocento, trovando naturalmente eco nella propaganda e nella pubblicistica antisemita nel anni dell’Affaire Dreyfus. A ben guardare, l’epoca d’oro dell’accusa di omicidio rituale è compresa fra l’ultimo ventenio dell’Ottocento e lo scoppio della prima guerra mondiale, ossia proprio il periodo in cui sono più evidenti i segni del costituirsi di un antisemitismo di tipo nuovo, sostanzialmente «laico», a forte connotazione biologica e razziale. Del resto, il testo di Golberg è del 1901, quando l’Affaire, dopo avere toccato il suo punto più alto (1896-1899), comincia a decantarsi, avendo già disegnato l’emergere di una destra rivoluzionaria e antisemita. Non meraviglia che l’accusa di omicidio rituale, che rimonta al Medioevo e alla cultura cattolica antigiudaica, celebri probabilmente i suoi fasti proprio nell’Europa di fine secolo3, per poi tramontare definitivamente nel primo dopoguerra, quando l’antisemitismo laicizza definitivamente il proprio immaginario, abbandonando tutte le accuse di provenienza religiosa. L’ultimo processo per omicidio rituale, il famoso processo a Mendel Beilis, si svolse a Kiev nel 1913. L’antisemitismo ne uscì sconfitto su tutta la linea, non solo perché Beilis fu trionfalmente assolto; ma soprattutto perché, in sede di dibattimento, fu seccamente smentito, fino ad essere ridicolizzato, il parere di uno dei testimoni dell’accusa, il prete Panaitis, spacciatosi per un profondo conoscitore delle usanze religiose ebraiche4. Epoca d’oro delle accuse di omicidio rituale, dicevamo a proposito dell’ultimo ventennio dell’Ottocento; ma questo è anche il periodo d’oro dei teorici antisemiti dell’omicidio rituale. La fine del secolo vede la contemporanea presenza sulla scena dell’antisemitismo di alcuni tra i maggiori esponenti della tesi sull’omicidio rituale, quali Rohling, Desportes, Martinez e Monniot, questi ultimi tre - il secondo dei quali un frate - pubblicisti antisemiti di area drumontiana, nonché di un autore come l’abate Louis Vial, che non manca, in una specie di breviario popolare sull’antisemitismo, di discutere il problema5. Nell’antisemitismo di area tedesca è poi Berg a sostenere una specifica vampirizzazione dell’ebreo, «assetato di sangue (blutgierigen)»6. Soprattutto Rohling, un teologo dell’università di Praga, è presentato dalla pubblicistica antisemita come la maggiore autorità sull’argomento; e il suo libro, il Talmudjude, godette di numerose traduzioni, fra le quali una 229 Francesco Germinario italiana e una francese. Malgrado Rohling sparisse di scena alcuni anni dopo, in seguito a un processo perso, e il suo libro fosse poco più di una rimasticatura di testi antisemiti già apparsi in precedenza7, il Talmudjude era destinato a un successo travolgente e a essere presentato dalla cultura politica antisemita europea come un testo che delineava un aspetto fondamentale della pratica rerligiosa ebraica. Nella Francia alla vigilia dell’Affaire Dreyfus, non solo ci furono diverse traduzioni del libro, ma una ottenne una Préface di Drumont il quale, avendo pubblicato qualche anno prima la France juive, passava già per uno dei maestri riconosciuti dell’antisemitismo europeo8. Nella sua Préface Drumont non poteva che stilare le lodi del libro di Rohling, presentandolo come un «documento […] inestimabile», uno studio che forniva un contributo determinante a chiarire «le oscurità dell’epoca attuale»9. Quanto agli allievi francesi di Rohling, spiccano proprio i casi di Desportes, Martinez e Monniot. Il primo era un frate autore di due libri, pubblicati a distanza di pochi mesi uno dall’altro, e dal titolo quanto mai emblematico, Le Mystère du sang chez les Juifs e Tué par les Juifs - avril 1890 Histoire d’une meutre rituel, il secondo dei quali con la consueta Préface di Drumont10. Mentre il primo libro, non senza chiudersi con l’esaltazione di Drumont, celebrato come un condottiero in lotta contro la menzogna e la finanza ebraiche11, metteva soprattutto in guardia i cristiani dalla lettura del Talmud, un testo pieno di oscenità soprattutto per quanto riguardava il comportamento sessuale degli ebrei, in particolare delle ebree, («il nostro senso cristiano - sosteneva Desportes - vieta di affliggere l’animo dei nostri lettori»)12, una vera e propria anticipazione dello stereotipo dell’«etnia puttana», su cui avrebbe insistito l’antisemitismo novecentesco, il secondo testo costituiva invece una storia dell’accusa di omicidio rituale, attraverso la ricostruzione dei casi più risaputi. Desportes ricostruiva, insomma, alcuni casi passati di omicidio rituale - ovviamente tutti dati per certi - per giustificare le accuse ricorrenti. Stando al frontespizio del suo libro, uscito per la collana di testi antisemiti pubblicati dall’editore Savine, anche Martinez era un teologo. A differenza comunque di Desportes e Monniot, il testo di Martinez costituiva una puntualizzazione dell’atteggiamento che i cattolici avrebbero dovuto tenere nei confronti degli ebrei13. All’argomento dell’omicidio rituale Martinez dedicava poche e anodine pagine in cui, dopo avere elencato i pretesi omicidi rituali più importanti consumati dagli ebrei, sosteneva che 230 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle «l’ebreo ha sempre provato per il sangue un’irresistibile voluttà […] Innumerevoli sono gli assassinii di cristiani, specie tra i bambini, compiuti dagli ebrei con lo scopo di procurarsi il loro sangue»14. Rispetto agli altri pubblicisti e teorici antisemiti, la specificità delle pagine di Martinez consisteva nel fatto che egli cercava di dilatare l’accusa anche all’ebraismo dell’Europa occidentale: se era un’usanza religiosa quella di rapire e ammazzare i bambini cristiani, utilizzando il loro sangue per impastare il pane azzimo da consumare la sera nel rito del Seder, allora non solo gli ebrei dei ghetti orientali erano sospettabili di omicidio rituale, ma anche quelli dell’Europa occidentale, malgrado, da Berlino a Parigi, da Vienna a Londra e Roma, fossero emancipati e si fossero sottoposti al processo di Bildung15. Ciò che Martinez proponeva, insomma, era l’estensione all’occidente liberale del clima di persecuzione e di discriminazione imperante nella Russia zarista, considerato che proponeva un’ipotesi a dir poco pericolosa, almeno per gli ebrei francesi: «si registrano da tempo, specie a Parigi, dei rapimenti di bambini, dei quali non si trovano mai le tracce, e la stampa non manca in queste circostanze di accusare gli zingari. Non si potrebbe pensare che questi sono atti di ebrei? È certo che una città come Parigi, dove pullulano tanti piccoli vagabondi, deve offrire loro una preziosa risorsa per alimentare il loro bisogno di sangue cristiano, senza che nessuno se ne accorga»16. Quanto al testo di Monniot, la Préface di Drumont non poteva non mancare, soprattutto perché Monniot, oltre a essere autore di altri testi antisemiti17, figurava anche quale firma de «La Libre Parole», il quotidiano fondato da Drumont18. E tuttavia, se il testo di Monniot - il quale scriveva proprio mentre a Kiev si stava svolgendo il processo Beilis19 - dal punto di vista antisemita era da considerarsi pressoché esaustivo rimontando alla Bibbia e citando ampiamente dalla letteratura antisemita precedente, è anche da rilevare che esso costituiva il canto del cigno dell’accusa di omicidio rituale. Da quel momento, infatti, non ci è dato di rintracciare, neanche nella letteratura antisemita degli anni trenta, pressoché nessun altro testo di teorico antisemita dedicato all’omicidio rituale: l’antisemitismo, proprio a partire dall’Affaire Dreyfus, aveva imboccato un’altra strada che non quella dell’armamentario proveniente dalla tradizione antigiudaica cattolica, e un Monniot alla data del 1913-14 si presentava poco più che nella veste di un astuto quanto attardato replicante. E tuttavia, l’alto numero di processi e la presenza sulla scena di diversi teorici antisemiti presenta anche un’altra faccia della medaglia. Volendo 231 Francesco Germinario stilare un quadro sommario dell’accusa, almeno nel periodo che in questa sede c’interessa, potremmo osservare che quello che per secoli era stato uno dei temi forti dell’ostilità contro gli ebrei - un tema probabilmente inferiore solo a quello del deicidio -, e che proprio in quei decenni trovava occasione per svilupparsi, mostra nell’antisemitismo fin de siècle anche alcuni significativi segnali di crisi. Sembra quasi che alcuni ambienti dell’antisemitismo, almeno quello populista e socialisteggiante che si sviluppa nei paesi dell’Europa occidentale, esitino a ricorrere a quest’accusa e rivelino qualche difficoltà ad agitarla. È alla fine del secolo che viene a formarsi un immaginario antisemita totalmente rinnovato e tale da potere essere utilizzato nei decenni successivi dagli antisemitismi europei, in particolare da quello nazista e fascista. Alla data del 1914, in altri termini, sull’ebreo era stato già detto tutto. Sotto l’aspetto storiografico, in questa sede è appena il caso di notare che al moltiplicarsi delle accuse e dei processi corrisponde un atteggiamento talvolta più distaccato dell’antisemitismo teorico, quasi a tradire che si tratta di un’accusa che progressivamente cede il passo ad altre ritenute «laiche» e ben più attuali. L’accusa è assente in esponenti dell’antisemitismo «laico» (Chamberlain ecc.); è poi assolutamente assente anche in un sociologo delle razze materialista e socialista, come Vacher de Lapouge. Essa è inoltre scarsamente presente nell’antisemitismo più virulento. Pochi sono, ad esempio, gli articoli sull’argomento dedicatigli proprio da un periodico come «L’antijuif», così rappresentativo dei settori socialisteggianti e plebei dell’antisemitismo francese. Nell’articolo più significativo ci si limita a osservare che «l’esistenza dell’omicio rituale presso gli ebrei è incontestabile. Che quest’usanza provenga da un insegnamento scritto oppure dalla tradizione orale poco importa»20. Dalla funzione centrale che l’accusa aveva svolto nella tradizione antigiudaica, essa arriva, dunque, a svolgere un ruolo periferico e di supporto, poco più che un tema aggiuntivo da associare ad accuse ritenute ben più cogenti e attuali. A complicare il quadro storico, è da notare che, assente in diversi autori antisemiti, l’accusa di omicidio rituale è comunque presente nell’armamentario di autori laici e addirittura vicini al movimento socialista, come Paolo Orano e Sorel, i quali, anzi, scrivendo alla vigilia della prima guerra mondiale, sono probabilmente, assieme a un Monniot, gli ultimi esponenti dell’antisemitismo europeo a problematizzare quest’accusa21. E tuttavia, sia in Orano che in Sorel l’accusa di omicidio rituale svolgeva un ruo232 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle lo nel complesso marginale, rispetto a un antisemitismo che si sostanziava di altre accuse, fra le quali - almeno nel caso di Sorel - quella del ruolo dominante che, ad avviso dello scrittore francese, svolgevano gli ebrei nel movimento socialista, soprattutto in quello italiano22. È probabile, inoltre, che in queste posizioni dell’antisemitismo di sinistra echeggiassero posizioni polemiche contro un ebraismo giudicato una religione dotata di costumi barbarici e arretrati. È significativo, ad esempio, che il tema dell’omicidio rituale lo si ritrovi in uno dei maestri dell’antisemitismo di sinistra ottocentesco, l’ateo e socialista Tridon, collocato in un panorama di denuncia della religione ebraica, presentata quale rito sanguinario che sfociava nel cannibalismo. Il caso di Tridon è emblematico per verificare come l’accusa di omicidio rituale, per quanto sfaccettata, presente in maniera irregolare nella pubblicistica antisemita, alla fine del secolo trovi talvolta dei riscontri anche nell’antisemitismo estraneo alla cultura cattolica. L’ebreo ha sempre tradito una frequentazione particolare col sacrificio umano: «Davide - sostiene sempre l’ateo Tridon - ballava davanti all’area [del tempio] piena di ossa carbonizzate di bambini. Salomone, Roboamo, tutti i re di Giudea e d’Israele, adoravano Baal-Jéhovah e lo nutrivano di neonati del popolo»23. Quanto alle ebree, esse già in epoca antica rivelavano «preferenze cannibalesche»24. L’inclinazione dell’ebreo all’omicidio efferato aveva dunque per Tridon una motivazione religiosa, attinente, cioè, la glorificazione di un Dio severo e sanguinario: proprio nei giorni della Pesah, scriveva sempre Tridon, «si immolavano gli uomini, si mangiava la loro carne, si beveva il loro sangue in una commistione di crimini e orrore; ed è questo che rende tale festa così cara al popolo ebraico»25. Considerato che Tridon era un socialista e ateo dichiarato, è lecito ipotizzare che le sue granguignolesche descrizioni dell’omicidio rituale perpetrato dall’ebreo per celebrare i suoi misteriosi riti religiosi attengano più che altro alla critica dell’ebraismo quale momento d’irradiazione del detestato monoteismo. Mentre i vari Rohling e Martinez, sulla scia della tradizione antigiudaica cattolica, avevano contrapposto la Torah al Talmud, accusando quest’ultimo testo di avere creato la figura storica dell’«ebreo talmudista» dotato di una morale degenerata e di costumi religiosi sanguinosi, Tridon non esitava a chiamare sul banco degli imputati proprio l’ebraismo in quanto religione monoteista. Infatti, la polemica di Tridon sembra volgersi contro l’ebraismo, giudicato una religione fondata su una 233 Francesco Germinario visione del Dio biblico quale soggetto dispotico che misura la fedeltà degli uomini in funzione della loro disponibilità a commettere anche sacrifici umani. Ciò che comunque conviene problematizzare (anche in questo il caso di Tridon è emblematico) è come un’accusa formulata all’interno della tradizione antigiudaica cattolica riesca agevolmente a collocarsi in un panorama antisemita ormai segnato da altre istanze culturali, filosofiche e teorico-politiche. L’impressione è che quest’accusa non è più interpretata, come nella tradizione antigiudaica cattolica, quale ricorso a una pratica che snaturava l’ebraismo, rendendolo una religione legata al rito del sangue, con tutto ciò che questo comportava in riferimento al sacrificio di Gesù ecc.; bensì come un rito che tradiva palesemente il carattere atavico, barbarico e selvaggio dell’ebreo, in questo molto simile ai popoli ancora al di fuori del perimetro della civiltà. A guardar bene, il rapporto ebreo-rito del sangue risultava esattamente invertito: non erano più, come nella tradizione antigiudaica, i riti religiosi bestiali e sanguinari talmudici a rendere barbaro l’ebreo, ma era ormai quest’ultimo che, essendo appunto un soggetto selvaggio e bestiale, non poteva che dare vita a una pratica religiosa altrettanto bestiale e selvaggia. Nei decenni successivi, almeno per limitarci alle vicende dell’antisemitismo italiano, quest’accusa sarà assente in un autore come Preziosi, e in uno dei più significativi esponenti dell’antisemitismo paganeggiante europeo, come Evola. Ma in genere, in quasi tutta la cultura politica antisemita europea degli anni trenta, sia in quella che si sostanzia negli stati totalitari, che in quella in cui l’antisemitismo rimane all’opposizione, non ci è dato di riscontrare voci significative dell’accusa. Collocata all’interno del panorama dell’antisemitismo contemporaneo, l’accusa di omicidio rituale è una situazione, dunque, molto variegata e articolata. Non è questa la sede per discutere in modo approfondito i rapporti esistenti fra l’antigiudaismo tradizionale, alimentato quasi sempre da motivi religiosi, e l’antisemitismo novecentesco. La nostra ipotesi teorico-politica è che le origini dell’antisemitismo novecentesco siano da rintracciare nelle poche ma storiograficamente decisive pagine introduttive dei Juifs, rois de l’èpoque di Alphonse Toussenel26. In ogni caso, l’antisemitismo novecentesco provvede a rielaborare numerosi stereotipi antigiudaici, tanto che si potrebbe sostenere che quasi tutti gli stereotipi dell’immaginario antisemita costituiscono una metafora di quelli antigiudaici. L’accusa di omicidio ri234 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle tuale non sempre è presente nella pubblicistica antisemita; ma essa lo è talvolta presente in modo sotterraneo e appunto metaforico. Siccome il testo di Golberg è scritto quando l’Affaire Dreyfus è ancora lontano dall’esaurirsi, conviene approfondire particolarmente le posizioni dell’antisemitismo francese. Drumont accetta la veridicità dell’omicidio rituale, in base alla convinzione che il carattere dell’ebreo non è cambiato nei secoli. La differenza, ad avviso del direttore de «La Libre Parole», è che al presente l’omicidio rituale avviene in modi diversi: «irridere il crocefisso il Venerdì santo, profanare le ostie, sporcare le immagini sacre, - aveva sostenuto Drumont nel suo “classico” del 1886, La France juive - tale è la grande gioia dell’ebreo nel Medioevo; tale è la sua grande gioia oggi. Un tempo egli si attaccava al corpo dei fanciulli, oggi si attacca alla loro anima con l’insegnamento laico; un tempo sgozzava, oggi avvelena: cos’è meglio?»27. Non solo Drumont, per non dire della numerosa cerchia degli autori a lui vicini28, accetta l’esistenza dell’omicidio rituale, sia pure declinandola in modo diverso; ma rilancia addirittura l’accusa, polemizzando con la cultura del suo tempo, compreso Renan, imputato di avere assolto l’ebraismo da quell’accusa, costruendo un’immagine falsata dell’ebreo medesimo, assolutamente non corrispondente a quella dell’ebreo reale ed effettivo29. E siccome Drumont pretende di fare scienza positiva e di ragionare da storico, sociologo e psicologo, si trova costretto a giustificare quest’accusa, operando una distinzione, a nostro avviso storiograficamente decisiva, all’interno dell’ebraismo medesimo. Certo, non la ricca famiglia dei Rothschild può essere sospettata di essere dedita a questa pratica barbarica e disumana: i Rothschild sono ebrei sottopostisi al bagno di Bildung, frequentano gli ambienti dell’aristocrazia e dell’alta politica, di conseguenza, evitano di praticare costumi religiosi così sanguinari e barbarici. I Rothschild, come tutti gli ebrei europei, urbanizzati, colti, capaci di affettare le buone maniere, succhiano denaro e ricchezza, non sangue. Epperò non v’è dubbio che questa pratica «molochista» risulta molto diffusa in quei settori dell’ebraismo, in genere dell’Est Europa, ancora arretrati sotto l’aspetto culturale ed economico, chiusi nei loro Shtetlek. Dunque, per Drumont alla pratica dell’omicidio rituale ricorrono soprattutto quei settori dell’ebraismo rinchiusi ancora nei ghetti, giuridicamente discriminati e non ancora inseriti nel processo di civilizzazione. Infatti, l’opinione di Drumont è che «i sacrifici umani sono stati una delle fasi della vi235 Francesco Germinario ta di tutti i popoli»30. Gli ebrei avevano abbandonato questa pratica sanguinaria crudele, tipica del tempo in cui adoravano Moloch, in seguito ai divieti di Mosè e alla predicazione dei profeti, per poi farvi ritorno nel Medioevo. È in quest’epoca che gli ebrei abbandonano nuovamente il Dio biblico per fare ritorno al molochismo paganeggiane talmudico, perché vivevano «nella degradazione dei ghetti in mezzo a terrori perpetui»31. Quella di Drumont è una spiegazione «storica» che, se per un verso, sembra molto vicina allo spirito dell’antigiudaismo tradizionale, legittimando la propria posizione nel nome dell’avvenuta regressione degli ebrei dal monoteismo al paganesimo più crudele, per l’altro, addossa all’ebraismo ortodosso l’accusa di omicidio rituale, escludendo il settore degli ebrei laici e di quelli sottopostisi al processo di Bildung. È negli arretrati Shtetlek che bisogna cercare gli autori degli omicidi rituali, perché l’ebreo occidentale della Bildung ha altri modi, dall’usura alle speculazioni borsistiche e finanziarie, per ammazzare lentamente l’ariano. E infatti, «noi - osserva un altro autore antisemita, il drumontiano de Pascal, proprio in riferimento alle accuse di omicidio rituale - non riteniamo i Péreire e Rothschild … responsabili dei crimini mostruosi commessi in Siria e in Ungheria; siamo persuasi che gli ebrei civilizzati li detestano […] che degli assassini e dei sacrifici umani si siano prodotti e si producano ancora […] tra le classi basse dell’ebraismo ortodosso, e che si producano sotto l’influenza di un fanatismo ispirato alle dottrine del Talmud, è per noi una convinzione che trova appoggi nei documenti più sicuri della storia»32 . In altri termini, sotto i panni dell’ebreo civilizzato e arricchitosi, dedito alle speculazioni finanziarie di giorno e alle serate mondane all’Opéra, si nasconde sempre l’ebreo sanguinario e arretrato, l’ebreo indotto a perpetrare omicidi così efferati perché schiavo della sua tradizione religiosa. E comunque non bisogna illudersi che l’ebreo sia radicalmente cambiato nel tempo; che fra le due figure sociali di ebrei (quello del ghetto e dello Shtetl e quello della Borsa e della Bildung) ci siano differenze; che, insomma, l’ebreo possa fare a meno di ricorrere all’omicidio rituale. Cediamo ancora una volta la parola al teorico dell’antisemitismo contemporaneo: nell’ebreo molto vecchio e la cui razza si è conservata pressoché intatta, voi trovate simultaneamente, cambiando solamente paese, degli stati differenti. A fianco dell’Israelita lustrato di letteratura, che per certi aspetti, d’altronde più superficiali che reali, sembra personificare l’estrema raffinatezza della civilizzazione, voi potere vedere ancora agire il Semita molochista. […] Da un altro punto di vista, la teoria dell’evoluzione 236 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle delle nevrosi spiega perfettamente la permanenza di questa follia molochista in alcuni paesi e la sua sparizione in altri. Il cambiamento di ambiente è il grande guaritore della nevrosi; così presso gli Ebrei d’America, che vivono in condizioni del tutto rinnovate, non s’intende mai parlare di atti di questo genere. In Oriente, al contrario, in Romania, in Galizia, dove gli Ebrei vivono ammucchiati da secoli, in cui i fermenti ereditari, i germi di questa spaventosa monomania sono allo stato di incubazione costante, questi atti si producono in ogni istante33. Cerchiamo di interpretare questa posizione drumontiana. La questione riguarda il giudizio, a nostro avviso decisivo, dell’immaginario antisemita sulla modernità. Con la modernizzazione, l’ebreo riesce a mascherare e controllare le proprie pulsioni di razza, semmai assumendo comportamenti sociali deviati e criminali. L’ebreo orientale, abbrutito dalle malattie contagiose, dalla sovrappopolazione degli Shtetlek, dall’ignoranza, rimasto ancora allo stadio in cui la sua ebraicità si presenta allo stato puro, senza quelle coperture e autocensure imposte dalla civilizzazione, può dare libero sfogo alle pulsioni di razza: «negli Ebrei illetterati questo odio del cristiano si traduce nella forma del movimento brutale, è l’impulso irresistibile di cui parlano gli alienisti»34. Nella pratica dell’omicidio rituale, è il caso di dire, l’ebreo manifesta tutta la propria efferatezza, senza alcuna mediazione di natura psicologica e sociale. Differente si presenta la questione con gli ebrei integratisi. L’ebreo occidentale, che ha saputo conseguire livelli elevati di Bildung, che domina la Borsa, dirige o è proprietario di giornali, ed è onnipresente nei salotti culturali e letterari, ha imparato a dominare gli impulsi sanguinari, ovvero a indirizzarli verso altri obiettivi: l’ebreo civilizzato preferisce invece succhiare il denaro e le ricchezze della nazione, piuttosto che il sangue degli innocenti bambini cristiani. Il vampirismo razziale nell’ebreo della Bildung non è più tanto di natura fisiologica, non necessita più di nutrirsi del sangue dei bambini cristiani, ma è orientato in senso economico e politico. L’ebreo della Bildung mantiene, insomma, il suo vampirismo razziale, dirottandolo tuttavia su tutto il corpo sociale: è quest’ultimo, e non più il corpo dei bambini cristiani, ad essere salassato. Per l’antisemitismo l’omicidio rituale rimane; solo che, in epoca borghese, esso ha ormai assunto una dimensione economico-sociale: a Berlino come a Parigi, l’ebreo della Bildung continua imperterrito a salassare i cristiani, epperò non più attraverso il suo rito religioso, ma col ricorso alle strategie speculative e parassitarie. Ma proprio per questo, l’ebreo civilizzato, «mascherato», risulta più pe237 Francesco Germinario ricoloso dell’ebreo che esibisce con orgoglio la propria ebraicità, ossia dell’ebreo galiziano e romeno, per riprendere il paragone di Drumont: nell’ebreo occidentale, civilizzato e integrato, la tendenza ad assumere atteggiamenti «molochisti» è sempre in agguato, pronta a esplodere, lacerando i deboli panni di cui la falsa e ipocrita Bildung si era finora rivestita. E comunque il «molochismo» non assume più vittime individuali (i bambini), ma un intero sistema sociale: a essere sacrificata in questo caso è la vita di tutta l’umanità. La distinzione antisemita fra l’ebreo della Bildung, finanziere, politico, giornalista, intellettuale ecc., e l’ebreo del ghetto, legato ancora alle tradizioni religiose, e dunque incline a praticare l’omicidio rituale alla vigilia della Pesah, a ben vedere gioca a tutto vantaggio della prima figura, nel senso che quest’ultima è imputata di avere esteso alla società tutta un vampirismo razziale che in precedenza, fino a quando l’ebreo era stato rinchiuso nel ghetto, era limitato ai bambini. E allora, è più pericoloso l’ebreo dello Shtetl, intento a rapire e sgozzare bambini solo in occasione della Pesah, oppure l’ebreo della Bildung, che ha fatto della speculazione finanziaria una vera e propria professione, un omicidio rituale praticato quotidianamente in tutto il corpo sociale? Non v’è dubbio che l’immaginario antisemita associ decisamente la figura dell’ebreo a quella del vampiro35. Per rafforzare quest’associazione, quasi sempre nella pubblicistica antisemita le riunioni dei rabbini intenti a cospirare per il potere ebraico sul mondo sono spesso convocate di notte nei cimiteri, come nel caso di Discorso del rabbino nel romanzo Biarritz36. Si può effettivamente parlare di una particolare sensibilità dell’immaginario antisemita per il romanzo gotico, quale struttura e trame narrative maggiormente rispondenti alle esigenze antisemite di «oscurare» e vampirizzare la figura dell’ebreo: come tutti i parassiti, l’ebreo non riesce a produrre mai niente di proprio, a cominciare dal livello economico; può solo succhiare la ricchezza o il sangue prodotti da terzi. D’altro canto, qualora volessimo stabilire una graduatoria fra l’accusa di omicidio rituale e il cospirazionismo storico37, è appena il caso di osservare come l’accusa di omicidio rituale, connessa al bisogno dell’ebreo di usufruire di sangue cristiano prevalentemente «giovane» e ancora incontaminato costituisca una conferma della visione cospirazionista della storia, nel senso che entrambe le convinzioni condividono quanto meno l’oscurità dell’ambiente d’azione. Anzi, malgrado l’accusa di omicidio rituale anticipi cronologicamente di diversi secoli la diffusione delle teorie cospirazio238 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle niste antisemite, è la prima a collocarsi nella seconda; è il cospirazionismo a sollecitare l’accusa di omicidio rituale. Questo spiega la perfetta coincidenza temporale, alla fine dell’Ottocento, fra la diffusione delle teorie cospirazioniste in ambito antisemita e la fioritura delle accuse di omicidio rituale. Entrambe le accuse condividono infatti sia la funzione vampiristica dell’ebreo sia la conseguente necessità di quest’ultimo di agire in un ambiente oscuro e del tutto privo di luce: vampiro in politica e in economia, nel senso che agisce sempre in situazioni di scarsa o del tutto assente visibilità all’ombra semmai delle logge o del Kahal, l’ebreo lo è anche per quanto concerne il suo bisogno naturale di alimentazione. La luce e la visibilità sono le sue due più acerrime nemiche, dalle quali egli deve assolutamente rifuggire, pena l’azzeramento della sua potenza, se non la distruzione delle possibilità medesime di potersi alimentare e riprodurre. D’altro canto, l’accusa di omicidio rituale, proprio perché riattualizzata, viene ad assumere una specifica collocazione nell’universo generale della critica della modernità che l’antisemita intende sviluppare. In apparenza, l’accusa sembra stridere in un quadro in cui anche l’antisemita di provenienza cattolica, come nel caso di un Drumont, risulta affidarsi a sistemi culturali e discipline «laiche» quali la criminologia, la medicina ecc., sol che si pensi al riferimento drumontiano alla psichiatria. Parassita in economia, l’ebreo lo è perché ha sviluppato nei secoli un costume criminale o omicida che lo induceva a uccidere in modo efferato le sue vittime sacrificali, bevendone il sangue, per celebrare i riti religiosi del proprio Dio. Il parassitismo dell’ebreo, prima che trovare una realizzazione in economia, si è realizzato proprio nell’ambito della sfera religiosa, preferendo offrire a Dio il sangue di terzi, piuttosto che il proprio. Come a dire che quello dell’ebreo risulta essere un parassitismo ontologico e congenito, il quale nell’epoca moderna ha finalmente rintracciato l’occasione storica di defluire dalla religione all’economia, permeando di sé un intero sistema sociale. Un comportamento che quindi trovava in passato motivazioni religiose, nell’epoca moderna e borghese si è tradotto in una dimensione economica: se nell’antichità l’ebreo uccideva e succhiava il sangue delle vittime in nome del proprio Dio sanguinario, nell’epoca della modernità dispiega le ali del suo vampirismo, salassando economicamente i popoli con cui entra in contatto; se prima dissanguava le vittime, ora col sistema capitalista 239 Francesco Germinario succhia la ricchezza prodotta onestamente dai popoli con i quali entra in contatto. L’epoca storica della modernità diviene, insomma, una costante ed estenuante celebrazione religiosa dei riti del sanguinario Dio ebraico. Le crime rituel Les troubles antisemites en Autriche. La propagande antisemite. Quelques crimes rituels. L’agence du crime juif, Le crime rituel et la papauté. Histoire de Saint Simon. Crime rituel à Rome et en Chine L’antisemitisme a trouvé un terain d’action bien inattendu. En France, en Italie, en Pologne et en Autriche les organes antijuifs font ressorter les anciennes histoires sur l’emploi par les juifs du sang chretien. Le procès d’assassinat qui fut jujé cette été à Polna, en Bohème est le point de depart de cette nouvelle propagande antisémite. A Polna, en Bohème, un juif Helsner, chemineau de son metier, ivrogne par état, fut accusé d’avoir assassiné une jeune fill chretienne, Agnès Gruskha. Le parti antisémites’en emparé du procès. Les reporters ont organisé l’instruction. L’avocat chargé de defendre la famille de la victime a prononcé une veritable requisitoire contre les juifs - assassins des chretiens. Le procès fut terminé par la condamnation de l’accusé, sans proves suffisantes. L’arrêt aussitot prononcé, les troubles antisemites éclaitairent en Bohème, en Hongrie, en Galice. Les débats parlamentaires furent même envhais par les histoires des crimes juives et [on a] assisté, pendant plusrieurs séances, aux controverses sur la nature criminelle et sanguinairedes juifs. Le mouvement a pris de l’extension. On se repelait differents procès dirigés contre les juifs accusés d’assassinat sous pretexe rituel: le procès de Saratoff et de Kutais en Russie, le procès de Tica-Esslar en Hongrie, celui de Ksanten en Allemagne. Tout le parti libéral en l’Autriche a tenu de manifester son indignation et sur parmi eux, le professeur Massarik de Prague ayant publié la refutation des requisitoires du procureur de Polsa, a eu les honneurs qui rappellent ceux que les bandes antisemites ont menagés a M. Emile Zola, à propos de la lettre j’accuse. En France les journaux nationalistes et antisemites ont repris l’accusation. Des travaux furent publiés sur la question dans la revue de Sacréstie «La Quinzaine». A Rome, le journal subventionné par la cassette papale «Osservatore catholico» a declaré: «il est de notre devoir de donner un avis fraternel àcertains juifs de ne pas aggraver leus cas. Que ce peuple insatiable se contente de l’argent chretien, mais qu’il cesse de verser et de boir le sang chretien». Le cléricalisme a cru enfin tenir une arme suffisant epour jeter la population contre les juifs et inaugurer…38 Saint-Barthelémy. Pour y arriver plus vite, on ne recule devant rien on tient à l’honneur de la Croix de Jesus de trouver des crimes rituels, de les machiner aux besoin, pourvu que les fidéles croient et qu’[excuseres] par la vision sanglante ils organisent des represailles contre… les juifs. 240 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle Quelques exemples vont prouver par quels images on arrive à créer des troubles, à jeter des malheureux en prison, à faire peser sur tout un groupe des accusations les plus viles et le plus abominables. Le journaliste viennois, M. Fleischer a reçu (par erreur) une fiale remplie de liqueur rouge. Une lettre jointe à l’envoi explique qu’il de l’echantillon du «sang chrétien», versé par les juifs et que ceux qui voudraient organiser le crime n’auraient qu’à s’adresser à l’acence, Le sang chrétien; cette fais-ci, n’est que de l’eau colorée par le carman. Le fait existe donc! Des agents speciaux travaillentpour créer des crimes rituels. Il y a des officiers du sang versé; il y a des hommes chargés tout particulièrement d’exploiter les crimes dont les auteurs son inconnus, pour jeter la suspicion sur la population juive, pour exicetr à «debarbouiller avec du sang» les portes des demeures juives, comme onl’a fait à Prague. Ainsi à Podgorj près de Cracovie, un mineur qui a pris part dans les derniers troublesantisémites fut surpris en flagrant deli de la machination du crime… des juifs. Le procedé était simple. Son enfant est mort à l’hopital. Le brave propagandiste a retiré le petit cadavre, l’a enveloppé et ficelé soignueusement et a essaye de le glisses (exemplede le glisses) sous le banquet du cabaret tenu par les juifs. Le cabaretien…39 en eveil par les allures louches du client ne le perdait pas de vue et le surprenait en flagrant delit, au moment où allait glisser la preuve sous la banquette du [pre crime. Notre homme fut arrété au grand desagrement des journaux antisémites. En Bohéme l’année dernière, il y a eu trois cas de ces tentatives avortées grace au hasard. En Hongrie il s’est produit un cas analogue: au mois d’août de l’année dernière on a trouvé à Krentebin le cadavre d’une jeune fille originaire de Vienne. Comme pour Polna, le journal antisémite «Deutsch Volksblatt» a delegué, sur les lieux, un specialiste…40 procès des crimes rituels qui immediatement a trouvé des preuves irrefutables que laq jeune fille a succombé comme victime des juifs. Grace à son zèle, il y a eu la chance de rencontrer un temoin oculaire du crime. Un témoin qui de ses propres yeux a vu le sacristan de la synagogue égorger la victime et tirer son sang. Le sacristain fu arrété et malgré ses dénegations, il était sûr d’être condamné à mort. Hereusement pour lui, le gouvernement s’est mêlé de l’affair et bientôt non seulement on s’est aperçu que le malheureux pouvait fournir un alibi, mais aussi que le veritable assassin n’appartenait pas à la religion juive. Un cas analogue vient de se produire à Namiest. Dans la cave d’un paysan on a trouvé le cadavre d’un garçon de douze ans. Le journal cité plus haut a saisi l’occasion pour declarer que l’enfant était assassiné par les juifs «par la simple raison que le sang manquait» (textuel!). Déjà l’ agitation a commencé et les juifs se voyaent menacés de toutes les represailles, lorsque l’institution a demontré que l’enfat qui a vecu de l’aumone ayant été condamné pou vol ne pouvait plus exceter la pitié des paysans et a préféré le suicide à la mort par la faim. Un fait tout recent enfin jette une lumière toute particuliere sur ces crimes «rituels». La chose, cette fois-ci, se passe en Russie. Il y a deux ans, on a trouvé dans la forêt, pres Pereaslad le cadavre d’une fillette de 4 ans, mort étranglée. Les soupçons se sont portés bientôt sr une jeune fille de dix sept ans Yvanoff qui fu arrêté. L’accusé pour echapper au chatiment a evoqué le spectre du crime rituel juif. Elle a declaré avoir vendu aux juifs l’enfant que ces diernièrs ont amené dans la forêt et l’ont tuée pour…41 du sang necessaire pour le pan azyme. Elle a donné des dectails, indiqué l’endroit où on a enterré le cadavre. 241 Francesco Germinario En suivant ses indications on a trouvé le cadavre de la fillette, toute nue, avec un lacet au con. Pour bien conduire l’instruction pendant deux ans de suite on a fait defilé devant Yvanoff tous les juifs du pays. Elle a fini par choisir parmi eux une victime. Malheuresement encore pour elle, le juif a pu prouver qu’il était absent du pays au moment du crime. Enfin, dernierément fatiguée pour la detenction, Yvanoff a fait les aveux complets. Ella a declaré qu’elle a voulu aller à Moscou pour rejouire son amant. Pour faire cette partie de plaisir il lui manquait deux roubles. C’est alors qu’elle a entrainé dans la forêt la fillette, l’a depouillée de ses vetements qu’elle avait l’intention de vendre pour combler le pecule du voyage. L’enfant, toute nue et voyant la femme partireu peur, s’est mise à crier. Yvanoff l’a étranglée pour la faire taire et l’a enterrée dans l’endroit qu’elle a indiqué ulterieurement. Après ces aveux, les juifs ont pu respirer. La femme vient être condamnée a 8 ans de prison. Ces faits sont probants! Pourtant cela n’empêche pas les accusations des juornaux antisemites vont même puiser des preuves dans l’histoire du moyen âge proces [sic] à établir que les juifs «de tous les temps» emploient le sang chretien. Or, malgré la note de le Osservatore Catholico il existe toute une serie des bulles papales qu’interdisent ces accusations, les stigmatisent, ou les traitent aux femmes [sic] et aux criminells. Les papes Innocent IV, Gregoire X, Martin V, Michel V, Paul III ont interdit aux chretiens de pareilles accusations contre les juifs sous peine des chatements de l’Eglise. Les rois de Pologne et les rois de Bohèmie ont promulgué des ordonnances analogues et menageaient les calumniateurs pour la «poena talioni» trld étaient les decrets de Sigismonde (1514) de Stephane Batory (1576 et 1580) Ladislas IV (1636) de Stanislas August (1765) de Ottocar II (1254 et 1268) Venceslas II (1400). Il y a eu même à ce propos un procès bien interessant que les antisemites autrichiens ont deterré en le deformant. L’Histoire vaut la peine d’être contée d’autan plus que nous pouvons attendre que les antisemites de la Quinzaine la citent, selon la version des leurs frères d’Autriche. En 1415 à Trente e…42a jété dans le jardin d’un juif le cadavre d’un enfant. Le juif est allé, immediatement faire sa declaration à l’êveque. Malgré cela, la nouvelle du crime rituel fut mise en circulation. Tous les juifs de laville, avec leurs femmes et leurs enfants, furent arrétés et, chiane au pied, jetés en prison. La torture appliqué à chacun d’eux à tour de rôle a bientôt arraché des aveux que les juges derisaient…43 s’accusaient mutuellement, se denonçaient même pour éviter les souffrances. La chose fut jugée! L’enfant assassiné, de nom de Simon, fut declaré solennement victime des juifs et consacré comme saint. Quant aux juifs, après le chatiment des coupables, ils furent chassés de la ville. Les malheureux sont allés à Rome pour demander justice au pape qui sur leurs supplications a chargé l’evêque Vintimille d’instruire l’affaire. Bientôt on a trouvé le veritable auteur du crime. Un certain Canesus s’est declaré meurtrier de l’enfant Simon. Malgré cet aveu, la curie romaine avait à juger l’affaire de Trente, trois fois de suite et ce n’est qu’en 1478 qu’elle a rendu l’arrét suivant lequel les juifs n’étaient pas coupables du crime et la victime fu decanonisé. Le Saint Simon est redevenu un simple Simon! Mais le bravade fut donné! Des émeutes ont éclaté, un peu partout, dans…44 italien- 242 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle nes. On multipliait les accusations; on arrêtait les juifs dans leur ghetto… Pour mettre fin à ces troubles, le pape et le doge de Venise qui ont donné l’hospitalité aux exiles de Trente ont publié des acts dans lequels il annonçaient au monde chretien qu’ils ne croyaient pas à l’existence du meurtre rituel chez les juifs et qu’ils consideraient que l’affaire de l’enfat Simon est une machination ourdié par les malveillants. Ces faits son suffisament probants! On pourrait les corroborer en citant les accusations de même nature que les Romains dirigeaient contre les chretiens, que les Chinois et les Arabes dirigent contre les missionaires catholiques et protestants. Peu importe! On n’arrivera pas à persuader La Libre Parole, l’Osservatore Catholico et le «Deutsches Volksblatt» que ces accusations ne sont que des pretestes des rapines et des haines, que demain les hommes de mauvaise volonté les retourneraient contre eux, que des millions de Chinois sont certains que les missions de l’Osservatore Catholico et de nos Croix boivent du sang chinois et que les prouvent par ces mots de l’Evangile «manges ceci est ma chair, buvez-ceci est mon sang». Le lacryma Christ et le bordeaux suffisent aux Chinois pour créer la legende. Les auteurs de pareilles insinuations ne demandent pas des preuves et des faits. Ils ne comptent que sur l’ignorance de leur clientèle qui a avale tant de…45 et qui avalera encore celle-là! Mecislas Golberg Note al testo *Il lavoro costituisce un’anticipazione di un volume appena ultimato su Costruire l’ebreo. Saggio sull’immaginario antisemita, e di prossima pubblicazione. In questa sede, per comodità si forniranno solo i riferimenti bibliografici ritenuti necessari. 1 Tutte le citazioni in RAOUL MAYENCE,Un Juif anarchiste, in «L’Antijuif», n. 13, 18 novembre 1898. Sul ruolo di Guérin e della sua rivista, informazioni in Z. STERNHELL, La destra rivoluzionaria. Le origini francesi del fascismo 1885-1914, ed. or. 1978, trad. it., Corbaccio, Milano 1997, passim. 2 Cfr. la bibliografia citata in Mécislas Golberg (1869-1907). Une anthropologie politique et poétique au debut du siècle, sous la dir. de C. Coquio, Maisonneuve et Larose, Paris 1994, in particolare pp.487-489, nonché le pagine introduttive di ID., MécislasGolberg, écrivain trimardeur, in M. GOLBERG, Morituri - Textes, Au Fourneau, Paris 1994, pp.7-19. 3 Vedi la tabella delle accuse in D. TOLLET, Dalla condanna del giudaismo all’odio per l’ebreo. Storia del passaggio dall’intolleranza religiosa alla persecuzione politica e sociale, trad. it., Christian Marinotti editore, Milano 2002, pp. 106-7; nonché le cifre riportate da M.-F. ROUART, Le crime rituel. Ou le sang de l’autre, Berg International, Paris 1997, p.122. Per una ricostruzione dell’accusa, vedi, per tutti, R. TARADEL, L’accusa del sangue. Storia politica di un mito antisemita, Editori Riuniti, Roma 2002 (per l’antisemitismo fin de siècle, vedi pp. 214 ss.). Oltre agli autori analizzati in questa sede, per la presenza del tema anche negli ambienti dell’antisemitismo inglese, vedi, per tutti, C. HOLMES, Anti-Semitism in British society 1876-1939, Edward Arnold, 243 Francesco Germinario London 1979, pp. 52 ss. 4 Sulla figura di I. I. Panaitis, autore di una specie di «classico» dell’antisemitismo, I cristiani e il Talmud, ed. or. 1892 col titolo Christianus in Talmude iudaeorum sive rabbinicae doctrinae de Christianis, ma cit. dall’ed. it., a cura di M. de’ Bagni, Biblioteca della «Difesa della razza», Milano-Roma 1939, eletto a esperto in talmudistica in chiave di polemica antisemita, nonché perito dell’accusa nel processo di Kiev del 1913, conclusosi con l’assoluzione dall’accusa, anche per la mobilitazione di un vasto settore della cultura e della politica in Europa, notizie in R. TARADEL e B. RAGGI, La segregazione amichevole. «La Civiltà Cattolica» e la questione ebraica 18501945, Editori Riuniti Roma 2002, pp. 33, 45-6, 179 nota 126,186 nota 52; R. TARADEL, L’accusa del sangue. Storia politica di un mito antisemita, Roma, Editori Riuniti 2002, p. 231-2. Sul ruolo da lui svolto nel processo di Kiev ivi, pp. 247 ss., in particolare, pp. 252-3, nonché D. I. KERTZER, I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell’ascesa dell’antisemitismo moderno, Rizzoli, Milano 2002, p. 244, 249; G. M. CROCE, L’affaire Beilis vue de Rome, in «Nuova Rivista Storica», 2002, settembre-dicembre, n. 3, pp. 570-1. Immancabile, comunque, il riferimento sia alle memorie dell’accusato, M. BEILIS, L’Affaire Beilis, ed. or. 1992, trad. fr., Raphaë1, Paris 1994; nonché alla struggente forma romanzata della vicenda fornita da B. MALAMUD In L’uomo di Kiev, ed. or. 1966, trad. it., Einaudi, Torino 1968, 5 Su Vial vedi quanto scrive in Pourquoi il faut être antisémites, L’Union Antijuive de Propagande, Paris s.d. (ma 1902), pp. 10-13. 6 A. BERG, Judenbordelle. Enthüllungenaus dunkeln, Paul Heichen’s Verlag, Berlin 1894, p. 6; ma così anche p. 7. 7 Cfr., in proposito, frai tanti, L. POLIAKOV, Storia dell’antsemitismo, v. IV, L’Europa suicida 18701933,ed. or. 1977, trad. it., La Nuova Italia, Firenze 1990, p. 17. 8 A. ROHLING, Talmudjude. Zur Beheizigung für Juden und Christen aller Stände, Adolph Russell’s Verlag, Münster 1871, ma cit. dall’ed. francese col titolo Le Juif selon le Talmud, Savine, Paris 1889. 9 Entrambe le citazioni in É. DRUMONT, Préface ad A. Rohling, Le juif selon le Talmud, cit., rispettivamente p. I, p. II. 10 Rispettivamente, Savine, Paris 1889; Savine, Paris 1890, (la Préface di Drumont è a pp.6-12). Per qualche informazione su Desportes, v. R. F. BYRNES, Antisemitism in modern France. The Prologue to the Dreyfus Affair Howard Fertig, New York 1969, pp. 188 ss. 11 V. quanto scrive in Le Mystère du sang cit., pp. 359-360. 12 Ibidem, pp. 23-24. 13 DOCTEUR MARTINEZ, Le Juif, voilà l’ennemi.Appelaux catholiques, Savine, Paris 1890. 14 Ibidem, pp. 143-4. 15 Sul concetto di Bildung così come lo utilizzeremo in questa sede, vedi G. L. MOSSE, L’emancipazione ebraica fra Bildung e rispettabilità, in ID., Ebrei in Germania fra assimilazione e antisemitismo, Giuntina, Firenze 1991, pp.45-63. 16 DOCTEUR MARTINEZ, Le Juif cit., pp. 156-157. 17 A. MONNIOT, Le Crime rituel chez les Juifs, Pierre Téqui, Paris 1914 (la Préface di Drumont è alle pp. V-X). Tra gli altri testi di Monniot, vedi almeno Que faire?… Réponse d’un Antisémite, Librairie Antisémite, Paris s.d. (ma posteriore al 1900). Sulla figura di questo pubblicista, vedi la voce omonima in B. JOLY, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français (1880-1900), Honoré Champion, Paris 2005, p.291. 19 V. quanto scrive in ibidem, p. 19. 18 244 Appunti sull’accusa di omicidio rituale nell’antisemitismo fin de siècle 20 Così nell’articolo anonimo Le Meutre rituel chez les Juifs, in «L’antijuif», n. 61, 18 Juin 1899. 21 Almeno per quanto riguarda Sorel, vedi quanto scrive in Quelques prétentions juives, in «L’Indépendance», 1912, mai, XXX, pp. 217-236. Per un’analisi dei temi antisemiti presenti in Sorel, vedi F. GERMINARIO, Elementi per una biografia politico-intellettuale del «Tertullien du socialisme», in «Cher Camarade»...Georges Sorel ad Agostino Lanzillo 1909-1921, a cura dello stesso A., Annali della fondazione «Luigi Micheletti», Brescia 1993-94, n. 7, pp. 16-18. Per quanto concerne l’antisemitismo giovanile di Paolo Orano, militante sindacalista rivoluzionario italiano e destinato a svolgere il ruolo di esponente fra i più rappresentativi dell’antisemitismo fascista, vedi F. GERMINARIO, Latinità, antimeridionalismo e antisemitismo negli scritti giovanili di Paolo Orano (1895-1911), in Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945, a cura di A. Burgio, il Mulino, Bologna 1999, pp. 105-114. 22 «Bisognerà certo che prossimamente [Arturo] Labriola si decida a scriver un saggio sul socialismo ebraico; dappertutto gli ebrei giocano un grande ruolo nel socialismo, ma in Italia mi sembra che sono sul punto di costituire un sistema economico nuovo che può avere un grande avvenire davanti a sé» (Così Sorel in una lettera a Lanzillo del 30 Mai 1910, in «Cher Camarade» cit., p.141). 23 G. TRIDON, Du molochisme juif, E. Mahen, Bruxelles 1884, p. 11. 24 Ibidem, p. 13. 25 Ibidem, p. 128. 26 A. TOUSSENEL, Les Juifs, rois de l’époque. Histiore de la féodalité financière, ed. or. 1847, 3a ed. Marpon & Flammarion, Paris 1886. 27 La France juive , Marpon & Flammarion, Paris 1886, v. II, p. 381. Ma fra i tanti interventi drumontiani in materia di omicidio rituale, vedi, a titolo di puro esempio, quanto scrive in Crispi, in «La Libre Parole», 12 Août 1901. 28 Vedi, a titolo di puro es., quanto scrivono sull’omicidio rituale, G. VITOUX, L’Agonie d’Israel, Chamuel Éditeur, Paris, n. ed. 1898, p.178; J. de LIGNEAU (pseud. di F. BOURNAND), Juifs et antisémites en Europe, Tolra, Librairie-Éditeur, Paris 1891, pp. 139 ss. ; THÉO-DOEDALUS, L’Angleterre juive. Israël chez John Bull, Vve Ferdinand Larcier-Fontemoing & Cie, Bruxelles-Paris 1913, pp. 127 ss. ; R. LACAN, Histoire des Juifs. Leurs Trahisons de Judas à Dreyfus, A. Pierret, Paris 1898, p. 23 ; L. VIAL, Pourquoi il faut être Antisémite, A L’Union Antijuive de Propagande, Paris, s.d. (ma 1902), pp. 10 ss. 29 «Lo studio fisiologico non sarebbe certo meno interessante di quello storico, [… ] se gli specialisti, per delle buone ragioni, non si ostinassero a evitare tutte queste questioni e a presentarci, nel passato come nel presente, un Ebreo di convenzione che non ha alcun rapporto con l’Ebreo reale» (La France juive cit., v. II, p. 412. Per la critica a Renan, vedi ibidem, p.381). 30 ID., Les Juifs et l’Histoire, in «La Libre Parole», 30 Septembre 1909. 31 Ibid. 32 G. DE PASCAL, La Juiverie, Librairie Blériot - Henri Gautier, successeur, Paris 1887, p. 20. 33 É. DRUMONT, Le Testament d’un Antisémite cit., pp. 324-325. Per un approccio psicoanalitico a questo aspetto dell’immaginario antisemita, vedi BÉLA GRUNBERG et PIERRE DESSUART, Narcissisme, christianisme, antisémitisme. Etude psychanalitique, Hébraïca-Actes Sud, Paris 1997, pp. 302-315, una trad. it. vedila in La psicanalisi e l’antisemitismo, a cura di M. Bertani e M. Ranchetti , Einaudi , Torino 1999, pp. 120-132. 34 É. DRUMONT, La France juive cit., vedi II, pp. 414-415. 245 Francesco Germinario 35 Vedi, F. JESI, L’accusa del sangue, Morcelliana, Brescia 1993. 36 Su questo, vedi N. COHN, Licenza per un genocidio. I «Protocolli degli anziani di Sion»: storia di un falso, ed. or. 1967, trad. it., Einaudi, Torino 1969 (vedi il testo del Discorso del rabbino a pp. 221-224). 37 Vedi, F. GERMINARIO, Visione cospirazionista della storia e immaginario antisemita, in «Teoria politica», n. 3, pp. 55-85. 38 Una parola illeggibile 39 Una parola illeggibile. 40 Una parola illeggibile. 41 Una parola illeggibile 42 Una parola illeggibile. 43 Una parola illeggibile. 44 Una parola illeggibile 45 Una parola illeggibile. 246 rassegna bibliografica L’operazione Ibis in Somalia: luci ed ombre in una missione di peace-keeping di Angelo Del Boca Di tutte le operazioni di peace-keeping, coordinate dalle Nazioni Unite negli ultimi vent’anni, quella condotta in Somalia è stata sicuramente la più cruenta e fallimentare. A fronte di un modesto aiuto alimentare a popolazioni stremate da anni di guerra civile, sta infatti una serie di gravi insuccessi, come l’incapacità di operare il disarmo dei «signori della guerra» e di avviare un serio processo di pacificazione. Nel marzo del 1995, dopo sedici mesi di infruttuosi tentativi per salvare la Somalia dal caos, gli ultimi caschi blu abbandonavano Mogadiscio. Da allora il paese, nonostante tredici conferenze di pace, è in preda all’anarchia più assoluta e, per quanto vanti la costituzione di un governo provvisorio, in realtà è come se fosse scomparso dalle carte geografiche. All’operazione «Restore hope» partecipò, sin dall’inizio, un forte contingente di truppe italiane, secondo soltanto a quello statunitense. Negli ambienti della Farnesina e delle Forze Armate era infatti maturata la convinzione che nessun paese, meglio dell’Italia, era in grado di capire i somali, di comporre le loro vertenze, di portarli al tavolo della pace. Ragion per cui, si pensava in quegli ambienti, l’intervento umanitario dell’Italia era, più che utile, indispensabile. Eppure non era un segreto per nessuno che l’Italia, in Somalia, aveva molte colpe da farsi perdonare. Cinquant’anni di duro dominio coloniale; un mediocre decennio di mandato fiduciario; un sostegno immorale e senza riserve alla dittatura di Siad Barre; e, per finire, un pessimo impiego dei fondi della Cooperazione allo sviluppo, che ha arricchito partiti e imprenditori italiani senza migliorare per nulla le condizioni disperate delle popolazioni somale. Conoscendo i torti e gli errori del nostro paese, ritenevamo, alla vigilia della partenza per il Corno d’Africa del nostro contingente di truppe, che fosse auspicabile «che l’Italia tornasse in Somalia in sordina e senza prota247 Angelo Del Boca gonismi, con grande umiltà e discrezione. Possibilmente, come avevamo ingenuamente chiesto da un canale della televisione di Stato, con più genieri e meno guastatori, con più medici e meno paracadutisti, con più caterpillar e meno carri armati. Per quanto sollievo l’Italia avrebbe potuto portare a quelle infelici popolazioni, non sarebbe comunque mai riuscita a riparare i danni e a lenire le sofferenze causati in mezzo secolo di dominazione coloniale e in quarant’anni di rapporti viziati da indegne complicità»1. E invece si andò in Somalia sfoggiando i gioielli di famiglia: i parà del battaglione Tuscania e del Col Moschin, gli incursori del Comsubin e i fucilieri di marina del San Marco, una compagnia di carri M60 della brigata corazzata Ariete e due plotoni di blindo della Centauro. «Si trattava - riconosceva il generale Bruno Loi - di un vero e proprio corpo di spedizione, superiore per dimensioni e per quantità di armamenti e di equipaggiamenti a tutti gli altri contingenti nazionali presenti in Somalia, fatta eccezione, naturalmente, per quello americano»2 . Il generale Loi precisava inoltre che questo «strumento di alta valenza operativa [...] riduceva implicitamente la nostra dipendenza dalla forza multinazionale, valorizzando, nel contempo, la nostra autonomia intellettuale e decisionale»3. La consapevolezza di poter godere di una larga autonomia e la presunzione di conoscere i somali (e di saperli trattare) meglio degli altri caschi blu, ponevano presto il contingente italiano in grosse difficoltà. Per cominciare veniva accusato di non saper fare il gioco di squadra; di rivelare costantemente un comportamento «anomalo»; e addirittura «di aver minato la coesione della coalizione» consentendo al generale Aidid «di crearsi un santuario nel quartiere di Haliwa»4. Si trattava, ovviamente, di accuse in gran parte infondate o perlomeno esagerate, ma qualcosa di «anomalo» nella condotta del contingente italiano c’era, tanto è vero che dopo la condanna dell’Unosom-2, che sembrava inappellabile, i reparti italiani abbandonavano Mogadiscio e si attestavano più a nord, lungo l’Uebi Scebeli. Questa pretesa di possedere sempre, in qualsiasi epoca e in qualsiasi circostanza, la soluzione ottimale, è una iattura che ci accompagna sin dall’inizio delle nostre avventure coloniali, come la pretesa di essere «diversi» dagli altri, cioè più tolleranti, più rispettosi, più generosi, più capaci «di interpretare meglio la sensibilità del popolo somalo»5 . In omaggio al mito, duro a morire, degli «italiani brava gente»6. In realtà la storia della nostra presenza in Africa è costellata da episodi poco edificanti, da fallimenti, 248 L’operazione Ibis in Somalia da precipitose ritirate. A conclusione di un’operazione largamente all’insegna del dilettantismo e del velleitarismo, come quella in Somalia, il ministro della Difesa Fabio Fabbri pronunciava queste memorabili parole: «È un po’ il gioco del cerino. L’ultimo che lo prende si brucia le dita ed è per questo che ce ne andremo insieme agli americani»7. A confermare, infine, l’infondatezza di una presunta «diversità» dei nostri reparti in armi, nella primavera del 1997 esplodeva in Italia lo scandalo delle torture praticate in Somalia da alcuni soldati della missione Ibis. Dopo alcuni pietosi tentativi, da parte delle autorità militari, di depistare le indagini, di negare o di minimizzare gli episodi di violenza, il governo Prodi era costretto a nominare alcune commissioni d’inchiesta, le cui conclusioni confermavano l’attendibilità di alcuni episodi, anche se veniva sottolineato, da parte della commissione Difesa del Senato, che «sono assai più le luci che le ombre per il nostro contingente»8. Sull’operazione Ibis in Somalia disponiamo oggi di un importante documento, che pone in evidenza, cifre alla mano, le «luci» della missione. Lo firma il generale Bruno Loi, che comandò dapprima i reparti paracadutisti della Folgore e poi, dal 4 maggio al 6 settembre 1993, l’intero contingente. Va detto, innanzitutto, che il libro di Loi, Peace-keeping, pace o guerra? Una risposta italiana: l’operazione Ibis in Somalia, è un resoconto fedele, obiettivo della missione, così diverso dai libri che portano la firma di Graziani, Badoglio, De Bono, Bastico, Frusci, Starace, nei quali si rileva la più stucchevole autoesaltazione e l’assenza totale di autocritiche. Il generale Loi fa invece un bilancio preciso, onesto, attendibile dei successi ottenuti (1.300 missioni di scorta ai convogli dell’ONU e delle Ong; 100 mila prestazioni sanitarie; 3.350 armi da fuoco e 24 tonnellate di munizioni sequestrate; la ricostituzione della polizia somala; l’apertura di scuole ed orfanotrofi; il reclutamento di personale medico e paramedico), ma non esita a riconoscere le manchevolezze italiane, come l’assenza di «un’accurata preparazione politica e diplomatica»; un’organizzazione di comando «alquanto complessa e farraginosa»9; gli strumenti giuridico-legislativi inadeguati al tipo di missione10, e soprattutto l’incertezza della politica estera e della politica della sicurezza11. II generale Loi precisa inoltre che il fallimento della missione umanitaria in Somalia è da imputare anche alle «decisioni discutibili» delle Nazioni Unite: come lo schieramento dei caschi blu soltanto nelle regioni meridionali del paese; una politica del disarmo dominata dall’incertezza e dal249 Angelo Del Boca la confusione; la troppo vaga definizione dei limiti posti all’uso della forza, che portò alle tremende rappresaglie del giugno 199312. Su quest’ultimo punto Loi prende posizione in maniera assai netta: «Non siamo mai stati pregiudizialmente contrari all’uso della forza; abbiamo però sempre cercato di privilegiare, rispetto alle maniere forti, il dialogo con la gente, sia perché consideravamo precipuo dovere delle forze di pace ricercare l’accordo fra le parti contendenti [...] sia, infine, perché non volevamo assolutamente essere considerati come una forza di occupazione prepotente ed arrogante»13. Proprio perchè il generale Loi e il governo italiano dissentivano fortemente sull’uso della forza impiegato dagli alleati in maniera disordinata e controproducente, l’Italfor aveva abbandonato Mogadiscio e si era autoesiliata a Balad. «Forse, però - precisa Loi - si poteva negoziare per rimanere a Mogadiscio [...] e non vanificare i risultati ottenuti in nove mesi di battaglie vinte e perdute, di sofferenze materiali e morali, di speranze esaudite e frustrate. Essere andati via da Mogadiscio, infatti, ha cancellato tutto ciò»14. È chiaro, infatti, che dopo la «battaglia del pastificio» del 2 luglio 1993, il generale Loi fu lasciato solo, con un appoggio politico scarso e fluttuante. Del resto Loi non ne fa mistero e precisa: «I due governi che ebbero a occuparsi dell’operazione (Amato e Ciampi) sono stati totalmente assorbiti e anche coinvolti nelle turbolente vicende di “tangentopoli” ai suoi esordi»15. In altre parole, le vicende italiane avevano di colpo messo in secondo piano il dramma somalo, e restava in campo il solo ministro Fabbri con la sua incredibile storia del cerino. Il solo appunto che si può fare al generale Loi e alla sua lodevole ricostruzione dell’operazione Ibis è di aver minimizzato, probabilmente per spirito di corpo, le accuse di torture (incaprettamento di prigionieri, applicazione di elettrodi ai testicoli) rivolte ad alcuni reparti della Folgore. È vero che, dalle inchieste della magistratura, è emerso che soltanto tre episodi sono da considerarsi di rilevanza penale e che «gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa coinvolti sono stati poco più di una dozzina»16, ma ciò non autorizza nessuno, prima a coprire gli episodi e poi, divenuti questi di dominio pubblico, a liquidarli quasi con fastidio, quasi fossero di nessuna importanza. Scrivevamo in quei giorni: «Credo sia giusto non generalizzare. È probabile che si sia veramente trattato di episodi isolati, indipendentemente dal fatto che i soldati fossero i parà della Folgore, forse un pò suggestionati dall’epica militarista. Il punto è che qualcuno considera ancora i somali e le popolazioni subsahariane come inferiori»17. 250 L’operazione Ibis in Somalia Note al testo 1 ANGELO DEL BOCA, La trappola somala, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 4. 2 BRUNO LOI, Peace-keeping, pace o guerra? Una risposta italiana: l’operazione Ibis in Somalia, Vallecchi, Firenze 2004, p. 40. 3 Ibidem. 4 BRUNO LOI, Peace-keeping, pace o guerra? cit., p. 135. 5 Ivi, p. 92. 6 Si veda: ANGELO DEL BOCA, Italiani, brava gente?, Neri Pozza, Vicenza 2005. 7 «la Repubblica», 23 dicembre 1993. Cit. nell’articolo di VLADIMIRO ODINZOV: Via dalla Somalia fra cento giorni. 8 BRUNO LOI, Peace-keeping, pace o guerra? cit., p. 190. 9 Ivi, p. 174. 10 Ivi, p. 176. 11 Ivi, p. 180. 12 Ivi, pp. 164-73. 13 Ivi, p. 154. 14 Ivi, p. 178. 15 Ivi, p. 179. 16 Ivi, p. 14. 17 «Liberazione», 7 giugno 1997. 251 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi Lusingato dai giudizi sul mio libro, formulati da Angelo Del Boca, e dal suo invito a commentare il suo articolo sull’operazione Ibis in Somalia, farò su alcuni aspetti della vicenda alcune osservazioni suffragate da riscontri «sul campo». Della «consapevolezza di poter godere di una larga autonomia» L’Italia doveva partecipare con un contingente militare a un intervento umanitario della comunità internazionale in Somalia, a 6.000 chilometri dalla madrepatria, in un Paese privo di ogni risorsa e ridotto alla fame, dove quindici spregiudicati e irriducibili «signori della guerra» infrangevano quotidianamente i traballanti accordi sul «cessate il fuoco». Secondo la nuova dottrina ONU («Un’agenda per la pace»), il peace-keeper deve sapere e potere assolvere compiti di poliziotto, di operatore umanitario, di mediatore diplomatico e, sia pure eccezionalmente, anche compiti di combattimento. In questo contesto inedito, difficile e rischioso era necessario dotare il nostro contingente di tutto ciò che avrebbe potuto essergli utile per garantire l’assolvimento del mandato anche nelle condizioni-limite del combattimento (peace-enforcing). L’aver conferito al nostro contingente piena capacità operativa e larga autonomia, ricorrendo per lo più ai «gioielli di famiglia»(che, peraltro, nel 1992 non erano molti), è stata una decisione coerente e lungimirante; come mi pare che gli eventi abbiano ampiamente dimostrato. Non posso, dunque, condividere con l’Autore l’auspicio «che l’Italia tornasse in Somalia... con più genieri e meno guastatori, con più medici e meno paracadutisti, con più caterpillar e meno carri armati». Almeno non in una situazione come quella che caratterizzava lo scenario somalo. I genieri, i medici e i caterpillar nonché l’intero «sistema Italia» avrebbero dovuto semmai seguire il contingente militare e, usufruendo della cornice di sicurezza da questi garantita, attuare, d’intesa con l’ONU, un organico progetto di ricostruzione (peace-building), che non è mai stato neanche concepito e che i militari hanno cercato di surrogare come meglio hanno saputo e potuto fare. Né riesco a capire come presso il Comando UNOSOM questa nostra 253 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi autonomia possa essere stata percepita negativamente: sia perché non è mai stata da noi «usata» per sostenere, in contrapposizione, un progetto italiano autonomo (mai nemmeno pensato) sia perché UNOSOM, a più riprese, si è avvalso proprio di tale larga autonomia del nostro contingente per risolvere svariate situazioni critiche per la coalizione. Penso, piuttosto, che, al profilarsi del fallimento della politica della rappresaglia, sia stato molto comodo indicare questa autonomia degli italiani (prima di tutto, intellettuale) come causa della incrinatura nella coesione della coalizione. Della «presunzione di conoscere i somali (e di saperli trattare) meglio degli altri caschi blu» Senza voler mettere in discussione la conoscenza della Somalia e dei somali da parte dell’Autore, ribadisco che, pur essendo stati accolti inizialmente con diffidenza, nel giro di un mese i soldati italiani sono riusciti a conquistare il rispetto e la considerazione di tutta la popolazione e soprattutto a incoraggiare i non pochi nostalgici della pregressa familiarità con il nostro Paese a proporsi quali collaboratori e intermediari nei rapporti con le varie fazioni. Merito certo del nostro buon comportamento ma anche del sostanziale superamento da parte somala di ogni pregiudizio, se proprio non si vuole ammettere una predisposizione empatica nei confronti del popolo italiano. Di questa preferenza abbiamo avuto dimostrazioni piccole e grandi: dalle manifestazioni di cordialità nel tratto quotidiano alle richieste di mediazione con la dirigenza ONU nei giorni della rappresaglia; dagli innumerevoli attestati di soddisfazione per il nostro operato alle tacite garanzie riservate al nostro personale, che ha sempre goduto, diversamente da tutti gli altri contingenti, di una relativa sicurezza (se si esclude l’incidente del 2 luglio, dovuto verosimilmente alla fatalità); dalla partecipazione fiduciosa allo sforzo di pacificazione (consegna spontanea di molte armi) alla conclamata contrarietà alla nostra partenza da Mogadiscio (tristemente provata dal massacro dei nigeriani che dovevano sostituirci sul check-point «Pasta»). Con riguardo alla «presunzione» mi sento, quindi, di confermare quanto ho scritto a p.164 del mio libro: «Nella gestione della crisi somala, sarebbe stato molto utile, se non addirittura vincente per le Nazioni Unite, puntare sui quasi cento anni di frequentazioni italo-somale. Per il fatto stesso che molti somali erano stati abituati a pensare, parlare e agire in italiano, 254 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi i nostri militari si sono proposti subito come il miglior veicolo di penetrazione nelle loro complicate realtà politiche, sociali e claniche». Invece, reiteratamente abbiamo offerto al Comando UNOSOM questa nostra («presunta») migliore capacità di comprensione del contesto somalo, senza mai riuscire a vincere l’irriducibile, preconcetta e ingiustificata sua diffidenza nei nostri confronti. Della «solitudine del generale Loi» In effetti, io mi sono sentito molto spesso solo. Come ogni comandante che non può condividere con nessuno la responsabilità delle decisioni più gravi. Non credo, però, che l’Autore intenda riferirsi a questo tipo di solitudine quando dice: «È chiaro, infatti, che, dopo la battaglia del pastificio del 2 luglio 1993, il generale Loi fu lasciato solo, con un appoggio politico scarso e fluttuante». Questo tipo di solitudine sembra, infatti, riferirsi piuttosto alla prassi abbastanza frequente dello «scaricabarile». lo, però, non mi sono mai sentito «scaricato». II ministro della Difesa e i capi di SM della Difesa e dell’esercito hanno costantemente seguito l’evolversi della situazione reagendo prontamente alle mie richieste e proposte, dando sostegno ai miei comportamenti sul campo. Nei momenti degli scontri al pastificio e ancor più nei giorni successivi alla riconquista pacifica del check-point, hanno dimostrato fiducia al contingente che ha recuperato il morale provato dalle perdite subite (nel primo combattimento dell’esercito italiano dopo la seconda guerra mondiale) continuando ad assolvere il suo mandato con senso di responsabilità. Non altrettanto posso dire del ministero degli Esteri, come ho scritto nel libro (p. 177), meno solidale nel periodo più delicato (dal 20 giugno al 16 luglio) dell’inasprimento delle divergenze tra il Comando di UNOSOM e il Comando di ITALFOR. II suo comportamento, di cui non mi è nota la causa, credo che si possa addebitare al quadro generale del problematico funzionamento del «sistema Italia» che ha caratterizzato tutto il nostro intervento in Corno d’Africa. Della «minimizzazione, probabilmente per spirito di corpo, delle accuse di torture rivolte ad alcuni reparti della Folgore» lo non ho affatto minimizzato le accuse mosse al contingente (e non so255 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi lo ad alcuni reparti della Folgore), nell’estate del 1997, da una campagna di stampa di incredibile superficialità (vedasi il credito accordato, senza la benché minima verifica, alle innumerevoli «bufale» smascherate) e di inusitata virulenza (vedasi la richiesta a gran voce di scioglimento della Folgore). Semmai, a ridimensionarle, sono state le tre Commissioni (di inchiesta, governativa e amministrativa, e di indagine, parlamentare), tutt’altro che benevole e accomodanti, che dopo aver ripassato al microscopio tutta l’operazione rivoltandola come un guanto durante undici interminabili mesi hanno accertato che in diciotto mesi di operazioni difficili e rischiose, che hanno impegnato, a seimila chilometri dalla madrepatria, dodicimila soldati italiani, si sono verificati solo quattro episodi censurabili ad opera di una dozzina di componenti del contingente. Di tutto questo riferisco ampiamente sia nell’introduzione sia nell’epilogo del libro, con dovizia di citazioni e testimonianze significative. Mi sono anche soffermato (pp. 155 ss.) sui problemi dell’azione di comando e del mantenimento della disciplina in una situazione di massima responsabilizzazione individuale e di amplissima autonomia decisionale dei comandanti, mettendo in evidenza il rischio, che a mio parere vale la pena di accettare, che qualcuno potesse tradire la fiducia accordatagli. Ho anche raccontato (pp. 160 ss.), avvalendomi della testimonianza diretta di uno dei protagonisti, uno degli episodi che aveva turbato l’opinione pubblica nostrana e le reazioni che aveva provocato sul personale e sulla catena di comando. E non ho fatto mistero della profonda amarezza provata da me e da tutti i partecipanti all’operazione per aver visto screditare il lavoro compiuto. Cos’altro avrei dovuto dire? Che i prigionieri, mostrati da un settimanale legati e incappucciati, non erano stati crudelmente incaprettati, come denunciato con indignazione nello scoop, ma erano stati semplicemente messi in condizione di non nuocere e di non fuggire, esattamente come prevedeva la normativa NATO e ONU (p.177), usando i mezzi che avevamo a disposizione nella savana: corda e sacchetti a terra? Che gli «elettrodi» (come sono stati definiti i fili di un obsoleto telefono da campo EE-8), branditi dal «torturatore», immortalato nella prima delle fotografie-choc, potevano condurre una scarica elettrica di intensità massima pari a 24 volt, appena avvertibile e del tutto innocua, come dimostrato dalla perizia medica effettuata sul malcapitato ladro di cammelli? Che la ragazza «legata» al veicolo meccanizzato e in procinto di subire lo «stupro» del «branco» 256 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi era consenziente a partecipare al gioco osceno, come sostenuto nella perizia delle foto effettuata da un notissimo professionista romano? Che sono rimasti inascoltati i molti benpensanti (militari e civili) che hanno tentato di far capire che il verificarsi di episodi di abusi e di violenze in situazioni di conflittualità diffusa doveva considerarsi del tutto fisiologico e che era assurdo gridare al vulnus all’onore militare se a compierli erano stati singoli individui, al di fuori di ogni direttiva, ordine e controllo della catena gerarchica? Che, nel clima di «caccia alle streghe», creato dalla bufera mediatica e che ha coinvolto financo le più alte sfere istituzionali (riunione dei Consiglio Supremo di Difesa dei 18 giugno 1997), quei pochi che, intimiditi dal vento giustizialista, si sono chiusi in difensiva hanno finito per avvalorare la sensazione di reticenza sottolineata dall’Autore? Che nessuno, magari partendo dalla quantomeno «strana» contemporaneità della pubblicazione delle prime foto (6 giugno) con il lancio di alcune agenzie (5 giugno) che informavano della richiesta di non meglio identificati «intellettuali» somali di processare i tre comandanti dell’operazione per delitti contro il popolo somalo, ha seriamente cercato di capire quali suggeritori, più o meno «sotterranei», avessero ispirato e guidato chi ha dato la stura al linciaggio morale dei contingente e in particolare della Folgore? Se mi fossi addentrato in queste argomentazioni, avrei sicuramente offerto ai «soliti noti» ulteriori spunti per riaccendere sterili polemiche, convinto come sono che «non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire», e, con ogni probabilità, avrebbe anche finito per soffrirne la serenità dei mio racconto e la sua credibilità. Così, ho preferito non diffondermi sui singoli episodi che, per giunta, riguardando una infinitesima minoranza di appartenenti al contingente (uno per mille!), non hanno avuto alcuna incidenza sull’andamento generale dell’operazione. Questo non esclude la mia riprovazione come comandante e come uomo per i comportamenti aberranti dei quali si sono resi responsabili uomini in uniforme posti sotto il mio comando. Non mi pare, dunque, di aver «minimizzato». È semmai vero che, come precisato nell’introduzione, non avrei scritto il libro se non ci fossero state quelle accuse infamanti. Se, infatti, ho preso la penna in mano è per chiarire a chi era stato con me in Somalia ( in primis, i paracadutisti della Folgore), cosa era realmente accaduto. Obbligo che sentivo in particolare verso i caduti e i feriti, da onorare per il loro comportamento, e i loro familiari, che dovevano sapere che i loro Cari si erano sacrificati per un 257 Alcune osservazioni del generale Bruno Loi ideale. Le malefatte di alcuni erano solo brutti, sporadici e isolati episodi, e poco o nulla avevano a che fare con l’immagine del contingente. Volevo infine offrire agli Italiani una versione sobria e documentata dei fatti, alternativa a quella dominante, offerta all’opinione pubblica da una faziosa campagna d’informazione. Grazie ad essa, prima del mio libro, dominava il campo incontrastata l’immagine di un soldato italiano ottuso, volgare, razzista e violento. Ora, in controcanto, c’è anche la mia. Chi è in buona fede, giudichi. 258 La riscoperta degli ascari eritrei di Angelo Del Boca Dopo un silenzio durato più di sessant’anni, gli italiani hanno riscoperto gli ascari eritrei, i più coraggiosi e fedeli tra i sudditi coloniali. Ha dato il via una mostra di fotografie e di cimeli a Roma. Il tema è stato poi ripreso da quotidiani e da settimanali, mentre il governo della Repubblica decideva di erogare, alle poche decine di ascari superstiti, anziché la pensione mensile, una sorta di liquidazione. Alessandro Volterra, uno studioso che da dieci anni si occupa dell’Eritrea, in particolare dell’impatto delle strutture amministrative e giudiziarie italiane sulla società indigena, ha dedicato infine un libro all’argomento dal titolo Sudditi coloniali. Ascari eritrei 1935-1941 (Franco Angeli, Milano 2005, pp. 240) con una prefazione di Luigi Goglia. Anche il lungo silenzio sul contributo determinante degli ascari nelle guerre coloniali e nella difesa dell’impero dell’AOI fa parte della totale rimozione di quel periodo storico. Eppure le cifre parlano chiaro. Si prenda, ad esempio, la battaglia di Cheren, che lo stesso Churchill annovera fra le più difficili e sanguinose dell’intera seconda guerra mondiale. Le perdite degli italo-eritrei, in 56 giorni di combattimenti, ammontano a 12.147 morti e a 21.700 feriti, ma il contributo di sangue degli eritrei supera di gran lunga quello degli italiani. Si pensi che il solo 4° battaglione Toselli perde, in meno di un’ora, sulla sommità del Falestoh, 12 ufficiali e circa 500 fra graduati ed ascari. Eppure la propaganda britannica aveva usato tutti i mezzi per scoraggiare gli indigeni e per farli disertare. In un volantino lanciato dagli aerei, in 80 mila esemplari, sulle difese di Cheren si poteva leggere : «Il nostro vile nemico italiano vi deruba della vostra fertile terra e vi impedisce di allevare il bestiame. Esso stermina i vostri giovani nelle sue interminabili guerre. Voi pagate agli italiani un alto tributo di sangue ed essi, in compenso, vi insultano chiamandovi carne venduta. Attraversate le linee prima che inizi 259 Angelo Del Boca il terribile assalto finale». Soltanto 1.500 ascari accoglieranno l’invito a disertare, ma la maggioranza di essi non erano eritrei, ma amhara e tigrini. Come spiegare questa fedeltà alla bandiera italiana mantenuta sino all’estremo quando ormai era chiaro che l’Italia avrebbe perso il suo impero coloniale sotto l’urto degli eserciti britannici? Alessandro Volterra, che ha condotto una preziosa ricerca sul campo intervistando 26 ex ascari, affaccia questa ipotesi: «Molti ascari, ancora oggi, percepiscono la loro come una partecipazione attiva e collettiva all’edificazione dell’AOI. […] Emerge dalle interviste che molti, probabilmente la maggioranza, degli ascari vedevano il Governo italiano come il “loro” Governo e che quello bisognava servire. Soltanto con l’occupazione britannica e la prospettiva di una federazione con l’Etiopia si cominciarono ad affacciare i primi dubbi e le prime riflessioni» Dichiara, infatti, uno degli intervistati, Ghebregherghis Enrabie Tesfa: «Eravamo giovani, eravamo soldati, non avevamo studiato, e non davamo peso alle leggi razziali. Per noi il Governo italiano era tutto. Pensavamo di essere una parte del Governo italiano. Noi ci sentivamo parte dell’Italia, non conoscevamo altro». C’erano, ovviamente, altre motivazioni che spingevano i giovani eritrei ad arruolarsi: per cominciare la paga, modesta ma sicura; il prestigio sociale; il sentirsi partecipi di eventi di una grande rilevanza. Si pensi, soltanto, che l’intero peso della riconquista della Libia, tra il 1920 e il 1932, gravò sui battaglioni di ascari eritrei. Il colonnello Antonio Miani, che con un pugno di ascari aveva conquistato il Fezzan, attribuiva la catastrofe di Gars bu Hadi e la perdita di quasi tutta la Tripolitania nel 1915, al fatto che il ministro delle Colonie Martini gli aveva negato l’invio di altri battaglioni dall’Eritrea. Tanto sangue in cambio di poco, quasi di nulla. «Noi eravamo sempre davanti - ha dichiarato a Volterra Isaac Hagos Godofa - e i soldati italiani arrivavano sempre quando il terreno era libero». Accadde a Mai Ceu, alla conquista di Gondar e della stessa Addis Abeba. Gli ascari erano sempre in testa ai reparti nazionali, spesso marciando a piedi nudi. «Noi combattevamo senza scarpe - ha raccontato Tekeste Tewuoldeberhan Ghebremariam - ci arrangiavamo con quelle portate da casa o quelle tolte ai morti, ma ci davano soltanto i vestiti, quelli kaki, e le scarpe le davano ai graduati, ma a noi no». Ma ciò che umiliava maggiormente gli ascari eritrei, ancor più delle punizioni a base di «curbash» (da 20 a 70 frustate a seconda dei reati), era la 260 La riscoperta degli ascari eritrei legislazione razzista, che separava drasticamente gli italiani dagli indigeni nei cinema, nei bar, sugli autobus, in tutti gli uffici pubblici. Il centro di Asmara, ad esempio, era precluso agli eritrei e veniva chiamato dagli italiani «campo cintato». La separazione era totale. Ha dichiarato Berhane Ghebregherghis: «Anche noi ascari eravamo separati dai soldati italiani. Loro bevevano con il bicchiere e noi con un recipiente di metallo, la “cubaja”». E Tesfamichael Beyu ha aggiunto: «I fascisti di Mussolini erano cattivi e ci dicevano “sporchi negri”. Invece nel combattimento ci dicevano siete bravi. Alcuni ufficiali erano bravi, ci davano coraggio e combattevano al nostro fianco, alcuni invece non erano assolutamente bravi». Nel solo periodo preso in esame da Alessandro Volterra, tra il 1935 e il 1941, hanno combattuto per la bandiera italiana da un minimo di 55 mila ad un massimo di 70 mila ascari eritrei. Nessuno ha mai tentato di quantificare le perdite subite dagli indigeni. Ai superstiti, infine, è stata accordata una pensione ridicola, quasi un’elemosina. Del resto che cosa potevano pretendere degli analfabeti, usati soltanto come carne da cannone? «Portare gli indigeni a livello degli europei - aveva sentenziato nel 1938 Andrea Festa, il direttore di tutte le scuole dell’Eritrea - creerebbe soltanto degli spostati e degli ambiziosi». 261 Le schede Le schede A NGELO D’ORSI, I chierici della guerra. La seduzione bellica sugli intellettuali da Adua a Baghdad, Bollati Boringhieri, Torino 2005, pp. 331 «Mi ha sempre stupito imbattermi in intellettuali - sacerdoti della verità secondo ragione [...] - che delle guerre - trionfo della menzogna - si fanno corifei»: così scrive nella premessa al proprio testo Angelo d’Orsi, docente universitario e acuto indagatore della storia degli intellettuali. Non c’è frase più indicata di questa per entrare in nuce nell’interrogativo centrale de I chierici della guerra. La seduzione bellica sugli intellettuali da Adua a Baghdad e indagare sul perché gli intellettuali italiani, dal 1986 ad oggi, si siano spesso trasformati in guerrafondai abiurando al proprio ruolo. Si comprende quale possa essere l’ampiezza di questo totale stravolgimento delle funzioni se si citano le parole scritte da Giovanni Papini nel 1913 sulla rivista futurista «Lacerba» da lui fondata nello stesso anno con Ardengo Soffici: «finalmente è arrivato il giorno del262 l’ira dopo i lunghi crepuscoli della paura [...]. Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero dopo tanti umiducci e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne [...].È finita la siesta della vigliaccheria, della diplomazia, dell’ipocrisia e della pacioseria. I fratelli son sempre buoni ad ammazzare i fratelli; i civili son sempre pronti a tornare selvaggi; gli uomini non rinnegano le madri belve». Angelo d’Orsi ha optato nel proprio saggio per la felicissima scelta di lasciar parlare i testi senza darne a priori un’interpretazione, e così il «delirio» degli intellettuali è percepito dal lettore con una incredibile intensità, valore che si sarebbe perso se fosse stata presentata semplicemente una versione rielaborata dei discorsi pro-bellici in questione. Leggendo con passione le pagine dell’opera si rincorrono nomi di uomini di scienza, di letterati, di giornalisti e di pedagoghi, uniti l’uno all’altro nell’esaltazione della violenza bellica. Si ricava così l’idea di un valore taumaturgico ed espiatorio attribuito da questi - parafrasando il titolo del celebre testo di Julien Le schede Benda - «chierici della guerra» agli scontri d’armi: per loro l’antagonista, sia interno che esterno, diventa il nemico da annientare e disumanizzare. L’abiura dal ruolo che per definizione l’intellettuale si attribuisce e si vede attribuito dalla comunità in cui vive si esterna quindi in tutta la sua adamantina ampiezza. La rinuncia all’uso critico della ragione a favore di interpretazioni faziose, l’implicita abdicazione alla volontà di essere la «voce della verità» ed il «consiglio dei potenti» sono caratteri essenziali di ciò che Daniel Lindeberg e Sandra Laugier hanno definito come «la scomparsa dell’intellettuale critico», processo che d’Orsi ha saputo felicemente analizzare nel proprio testo. Lo studioso torinese riesce infatti a fornire un esaustivo ed affascinante quadro di questo «malessere» in tutta la portata che esso ha avuto in riferimento all’intellettualità italiana: dalle esaltazioni del colonialismo italiano, alla fine del sogno italiano di divenire una grande potenza materializzatosi con la sconfitta di Adua nel 1896; dalla campagna per l’occupazione della Libia, all’esaltazione bellicista che porterà, sotto la spinta delle ali nazionaliste della politica, all’intervento nella prima guerra mondiale; e poi ancora il cammino del fasci- smo che portò al secondo conflitto globale, ed infine gli «interventismi democratici» degli anni novanta e le contraddizioni dell’operazione «Iraqi freedom». Tutto ciò nella cornice di un testo che, come si può evincere da quanto detto sopra, possiede un apparato incredibile di riferimenti alla filosofia, alla storia e alla letteratura. Ed è forse in ciò che si deve, paradossalmente, rintracciare la «particolarità» di questo saggio, che per questa eccezionale esaustività di informazioni risulta forse più adatto ad un pubblico di specialisti che a semplici appassionati della lettura (Matteo Vecchia). SERGIO ROMANO, Libera Chiesa. Libero Stato? Il Vaticano e l’Italia da Pio IX a Benedetto XVI, Longanesi, Milano 2005, pp. 155 In un paese ben ordinato c’è un posto per la Chiesa e un posto per lo Stato. In Italia invece, dal 1870 in avanti, il rapporto tra queste due istituzioni è parso più essere una convivenza basata sulle diffidenze e sulle convenienze che un modello di reciproca e armoniosa collaborazione. È questo l’assunto, rimarcato nella quarta di copertina, che sta alla base del testo Libera Chiesa. Li263 Le schede bero Stato? Il Vaticano e l’Italia da Pio IX a Benedetto XVI scritto per i tipi di Longanesi da Sergio Romano, ex diplomatico ora editorialista del «Corriere della Sera» e di «Panorama». Il titolo, rielaborazione di un assunto di Cavour, già presuppone che la frammistione realizzatasi a fasi alterne negli ultimi centocinquant’anni di storia nazionale tra i due poteri abbia portato ad un bilanciamento solo fittizio, in cui è lo Stato a perdere alcune delle proprie prerogative di autonomia politica a beneficio della governabilità del Paese. È in particolare negli ultimi decenni del XX secolo che questo fenomeno si è andato accentuando. Sono infatti progressivamente venuti meno quegli «anticorpi» che l’autore identifica in coloro che, «fedeli servitori della cosa pubblica», contribuivano a salvaguardare la distinzione tra i due campi. Ma perché ciò è accaduto e accade oggi? «Vi sono» scrive Sergio Romano «elettori di destra o di sinistra per scelta ideologica, tradizione familiare e spirito di parte. Sono tifoserie, convinte che i mali siano colpa dell’“altro” e che basti rovesciare il governo per curare il paese. […] Tuttavia esiste accanto ad essi una parte sempre più numerosa della società italiana in cui è straordi264 nariamente cresciuto in questi anni un sentimento di insoddisfazione, delusione e rabbia, alimentato e moltiplicato dalla stagnazione economica, dalla concorrenza internazionale e dalla paura dell’immigrazione islamica». Ed allora «come in tutte le fasi della storia italiana in cui la politica è incapace di affrontare i problemi del paese, la Chiesa appare a molti un fattore di stabilità, continuità, saggezza e coerenza. Gli uomini politici se ne sono accorti e hanno deciso di trarne vantaggio». Oltre alla peculiarità della nostra storia, ad accrescere il prestigio della Chiesa cattolica in Italia contribuisce poi, a detta dell’autore, il fatto che non esista oggi in Europa «un’altra democrazia […] in cui la politica sia altrettanto screditata e disprezzata». Così, dopo avere a lungo attraversato un secolo e mezzo di storia dei rapporti tra Chiesa e Stato italiano, è proprio nelle ultime pagine del suo libro che Romano con più decisione tralascia le vesti di storico indossando quelle del saggista e del critico, in un evidente parallelismo tra quanto premesso nell’introduzione alla sua analisi e l’affermazione con cui essa si conclude. Si legge in apertura: «contrariamente alle mie intenzioni iniziali, ho finito così per scrivere un breve Le schede saggio storico (più saggio che storia) sui rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa dalla fine del potere temporale a oggi. Ho le mie convinzioni e preferenze. Ma spero che anche i lettori di diverso avviso vi troveranno materia di riflessione». E nelle ultime righe: «Non posso offrire al lettore né conclusioni né prospettive. Mi limito a constatare che è nata in questi ultimi anni un’Italia molto diversa da quella delle generazioni postunitarie. Non la riconoscerebbero come propria i cattolici liberali […]. Non la riconoscerebbe Benito Mussolini […]. Non la riconoscerebbero Sturzo e De Gasperi […]. Non la riconoscerebbe Bettino Craxi […]. E non la riconosce come sua, per quel che vale, neppure l’autore di questo libro». Quanto allo stile, si tratta di un testo di agevole lettura, che forse, proprio a beneficio della comprensione del lettore, limita un po’ troppo l’ispezione dei fatti storici e si arresta, come accade nella parte relativa agli eventi a partire dal secondo dopoguerra, in una eccessiva superficialità (Matteo Vecchia). Giacomo Naretti alla corte del negus Johannes IV d’Etiopia (Diari 18561881), a cura di Alberto Sbacchi e Gino Vernetto, Associazione di Storia e Arte Canavesana. Ivrea 2004, pp. 495. Figura interessante e, per molti riguardi, anche emblematica quella del canavesano Giacomo Naretti, che percorse a metà del XX secolo l’Etiopia di Johannes IV, lasciandoci una testimonianza che merita oggi di essere approfondita e soprattutto rivalutata. Di questa originale figura di italiano al servizio di un negus in un’epoca in cui l’Etiopia si apriva sempre più al mondo e attirava a sé diverse tipologie di visitatori (dai viaggiatori ai puri avventurieri) si sono occupati con lodevole impegno Alberto Sbacchi e Gino Vernetto. Il primo è stato professore di Storia all’Atlantic Union College di Lancaster nel Massachusetts; discepolo di Robert L. Hess, ha insegnato anche in Etiopia e pubblicato alcuni volumi sulla presenza italiana nel Corno d’Africa; oggi è professore emerito di Storia. Gino Vernetto vanta tra le sue passioni anche quella di riordinare archivi storici e di fare ricerca sulla storia locale, canavesana e valdostana in particolare. Ha al suo attivo alcuni interessanti lavori pubblicati dall’ASAC (Associazione di Storia ed Arte Canavesana) a cui si deve questo importante volume. Vernetto, peraltro, è compaesano del Naretti ed in grado di comprendere il 265 Le schede dialetto delle sue parti: elemento, questo, decisamente fondamentale nella storia del corposo volume. In alcune righe introduttive Sbacchi ha ringraziato quanti, oltre a Vernetto, lo hanno sostenuto nel difficile lavoro progettato addirittura quattro decenni addietro: da Hess a Vernetto, da Cerreti a Giampaolo Calchi-Novati, da Triulzi a Silvana Palma e Del Boca. Questi studiosi hanno contribuito, ciascuno per la loro parte, ad arricchire la storia del personaggio con ricerche di archivio e altre forme di collaborazione (articoli, saggi, ecc.). Il risultato è di pregevole fattura, di sicuro interesse per lo studioso di quel periodo e dei primordi del colonialismo italiano e per di più arricchito da belle immagini sparse qua e là nel testo: alcune di esse, a prima vista, ci sono sembrate inedite. La storia dei diari resta confusa. Si deve la loro scoperta a Robert L. Hess che acquistò da un libraio specializzato di Roma il manoscritto ancora non pubblicato e già parte della biblioteca specializzata del conte Pietro Ginori-Conti che aveva venduto prima del secondo conflitto mondiale alcuni pezzi pregiati della sua raccolta libraria. Non si può discutere l’importanza dei diari nel contesto storico in cui furono scritti per cui essi meritano ogni attenzione, a parte al266 cune inesattezze imputabili alla genesi del testo. Naretti era uomo di grande abilità professionale, ma di modestissima cultura, come molti degli italiani che in quei decenni si avventurarono sull’acrocoro etiopico. I diari sono la storia dell’uomo, dei suoi pregi e dei suoi difetti, della sua capacità di inserirsi in un mondo difficile e a volte estraneo, del suo trovarsi tra vicende di rilievo prima e dopo il peggiorare dei rapporti italo-etiopici causato dall’espansione italiana in Africa. Condensare in poche righe la lunga permanenza in Africa, e la vicenda umana nel suo insieme, di Giacomo Naretti non è facile per ovvie ragioni. Nativo di Parella (1831), nel 1856 lasciò le terre del Canavese per emigrare in Francia. Quindi raggiunse l’Africa e, al seguito di artigiani e commercianti italiani e francesi, si stabilì in Etiopia dove fu al servizio del negus Johannes IV che ne aveva intuito le grandi capacità: qui Naretti restò, tranne alcuni rientri in Italia, fino alla morte, nel 1899, ad Asmara dove era regio commissario civile straordinario della Colonia Eritrea Ferdinando Martini che così, nel suo puntuale diario, ne ricorda la fine sotto la data del 9 maggio: «È morto stamani improvvisamente Giacomo Naretti. Aveva oltre 70 anni, era da più di 40 in Abissinia. Tutte le au- Le schede torità, tutti gli italiani, può dirsi, dimoranti in Asmara lo hanno accompagnato al cimitero». Naretti aveva lavorato in Etiopia come falegname specializzato (un «bajerod», cioè un capomastro per gli etiopici) e si era comportato da lavoratore, onesto, schivo, forte della sua saggezza e professionalità (aveva studiato poco e male in Italia, se si escludono alcuni anni alle scuole elementari del suo paese). Era stato anche un buon osservatore del mondo che gli ruotava attorno, più propenso a scriverne (in quel suo particolare e poco comprensibile italiano) che a parlarne. Aveva avuto nemici ed ammiratori, era stato a volte capito e a volte no. Era stato accusato, come ricorda Sbacchi, di non aver protetto né i suoi interessi né quelli dell’Etiopia che gli aveva dato lavoro, ospitalità, onore e rispetto. Era stato giudicato di volta in volta un diplomatico, un ministro dei lavori pubblici, un architetto e un ingegnere, ma anche un avventuriero (pur mancandogliene la stoffa), uno qualunque, uno dei tanti che dalla metà del XX secolo erano riusciti a racimolare denaro, cioè talleri di Maria Teresa, in Etiopia. Naretti aveva goduto della fiducia di Johannes IV (cosa certamente non facile in quell’ambiente tipicamente feudale e con un uomo a sua volta non fa- cile, come concordano le testimonianze) e aveva svolto mansioni che gli avevano garantito un’ampia reputazione, ma non si era mai inorgoglito. Si era trovato molto spesso, e come altri prima e dopo di lui, nella scomoda, malvissuta condizione di intermediario tra i viaggiatori diretti in Etiopia e la corte dell’imperatore, meritandosi, secondo il momento, elogi o critiche, se non attacchi più pesanti. Sotto questo aspetto, Naretti era stato davvero uno dei tanti. Il fratello Giuseppe, più giovane di lui, era morto a Macallè nel 1881. La giovane moglie, Abözönesc (Teresa) Zander, figlia del tedesco Edoardo Zander, architetto e studioso accreditato presso il negus Teodoro e di madre etiopica, divenne, alla morte del marito, l’interprete di fiducia del Comando superiore italiano a Massaua e fu assunta nei ruoli eritrei nel gennaio 1903. Alla morte del marito, che aveva sposato quattordicenne, era ancora molto giovane. Fu destinataria di ripetuti, pesanti pettegolezzi nel piccolo mondo coloniale italiano dell’Eritrea prossimo alla disfatta di Adua (e fortemente penalizzato e condizionato subito dopo l’evento), al punto che si malignava sulla simpatia che Baratieri (di cui Teresa era l’interprete ufficiale) nutriva per lei e dopo il 1° 267 Le schede marzo 1896 si mormorò che avesse tradito la causa italiana schierandosi con gli etiopici e fornendo loro informazioni riservate. Era molto esperta di usi e consuetudini locali e morì ad Asmara nel 1948, dopo aver lavorato per il governo italiano fino al 1924, quando aveva 62 anni. Giacomo Naretti aveva realizzato numerose costruzioni e sculture sull’altopiano etiopico. A Debra Tabor, ad Adua, ad Aksum, a Macallè aveva lasciato ampie tracce del suo status di apprezzato «falegname reale». La chiesa di Heruy Giyorghis a Debra Tabor, la capitale di Johannes IV, la chiesa di Dabra Berhan Sellassie, il palazzo imperiale di Adua, il palazzo reale e il celebre trono di Macallè (a imitazione di quello di Salomone) sono le sue opere più importanti. Il trono pare sia ancora conservato. I diari di Naretti (che egli chiamò anche Memorie d’Affrica) abbracciano gli anni 1856-1881 e sono scritti a mano in quattro taccuini di 21 x 14 centimetri, per un totale di 742 pagine. Forse a questi quattro taccuini ne seguiva un altro che Naretti annuncia alla fine del quarto. Può darsi sia andato perduto, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi che Naretti non l’abbia mai cominciato. Il viaggiatore scrisse i suoi diari al rientro a Pa268 rella nel 1886 basandosi sulla memoria ancora ben salda. Gli appunti e i documenti che aveva raccolto in tanti anni d’Africa erano andati distrutti in uno strano, forse doloso incendio della sua abitazione a Macallè subito dopo l’occupazione italiana di Massaua (1885). Le mosse italiane in Mar Rosso avevano determinato la fine della permanenza di Naretti e Teresa Zander in Etiopia. Il negus «doveva» licenziarlo, seppure a malincuore: ormai lo trattava male ed evitava di avere contatti con lui. Naretti capì che era tempo di lasciare Debra Tabor e chiese un anno e mezzo di permesso. Era solo una scusa per non tornare più. Quando Tancredi Saletta sbarcò a Massaua, Naretti stava per ottenere in proprietà da Johannes IV un intero villaggio. Perso questo, al suo rientro si ritrovò in tasca solo il denaro messo insieme in tanti anni alla corte imperiale. A leggere bene tra le pagine dei diari si acquisisce la certezza che il falegname di Parella non aveva messo su quella che solitamente si definisce una fortuna. Dal paese natale chiese pertanto al re di essere indennizzato per le perdite finanziarie subìte in Etiopia a causa dell’occupazione di Massaua, ma sull’esito della richiesta si nutrono dubbi fondati. Sbacchi pensa ad una pensione concessagli per i servizi resi Le schede al Paese. Dopo un soggiorno di oltre un anno a Parella, Naretti e signora rientrarono in Eritrea (era il dicembre 1887) e, lo si è accennato, furono assunti entrambi come interpreti dall’amministrazione di Massaua, ma non si hanno notizie precise sulla vita di Naretti fino alla morte nel 1899. Visse l’atmosfera della sconfitta di Adua dall’osservatorio privilegiato di Asmara, ma si ignorano le sue reazioni. I diari sono della massima importanza. Scritti da un falegname consapevole dei suoi limiti linguistici (nel testo si mescolano incredibilmente italiano, francese, arabo, amarico e dialetto parellese) che rendevano anche la sua corrispondenza quotidiana di difficilissima decifrazione e fecero dire a Zaghi che «la lingua usata da Naretti era simile all’Ostrogoto», con nomi geografici e personali approssimativi, totale assenza di punteggiatura e capoversi, errori di date, essi hanno, comunque, un valore documentario notevole: una miniera di informazioni su quell’Etiopia ottocentesca, frazionata, dominata dalle contese feudali interne e tesa ad una istintiva autoconservazione, che il Naretti potè sperimentare di persona. Era l’epoca in cui le spinte imperialiste si affermavano in Etiopia, diversi viaggiatori italiani e stranieri la percorrevano e vi sog- giornavano compresi i missionari come Massaja, i rapporti tra Egitto ed Etiopia erano problematici e prossimi alla guerra (come di fatto avvenne), gli italiani si apprestavano a metter piede definitivo in Eritrea, ad Assab e Massaua. Il volume dà al lettore un senso di completezza. Alle premesse dei due curatori segue un’introduzione storica di Alberto Sbacchi (pp. 19203), in sostanza la storia di Giacomo Naretti attraverso le molteplici vicende della sua vita, suddivisa in capitoli ampiamente annotati. La storia del falegname reale e quella molto più complessa del tempo si intrecciano e Sbacchi ha il merito di farcele leggere entrambe con interesse. Seguono alcune genealogie delle famiglie Naretti e Zander e la riproduzione di alcune pagine del diario originale con relativa trascrizione a cura di Gino Vernetto. Sono proprio queste riproduzioni a darci la misura del lavoro di rara pazienza ed efficacia portato a termine. Seguono, quindi, i diari, in versione italiana corretta con note a piè pagina di Sbacchi e dello stesso Vernetto. In conclusione, un lavoro di gran mole che Vernetto definisce interessante e piacevole, nonostante la gran fatica. Nella trascrizione generale dei diari, il curatore concittadino di Naretti ha voluto lasciare inalterato lo «stile narettiano, ru269 Le schede spante e naif», al punto di bloccare al posto loro alcune espressioni inusitate certamente per la lingua italiana, ma comprensibili dal contesto: il tutto rigorosamente virgolettato. I diari riscritti occupano le pp. 227-410 del volume. Seguono le biografie (a cura di Sbacchi, Vernetto, Vicentini) dei personaggi ripetutamente citati da Naretti, da ras Alula a Pippo Vigoni, passando per i vari Antinori, Cecchi, Martini, Massaja, Menelik. Interessante appare anche il capitolo intitolato «Hanno scritto» (curato da Vernetto) in cui sono riportati i giudizi su Naretti e sulla moglie Teresa Zander tratti da pubblicazioni più o meno note, da viaggiatori come Bianchi e Matteucci, Vigoni e Rohlfs; da personaggi autorevoli come Ferdinando Martini e studiosi come Zaghi; dallo stesso Johannes IV; da giornali coevi, soprattutto quelli che parlarono di Naretti all’indomani del suo rientro in Italia per l’occupazione italiana di Massaua «Corriere della Sera», «Gazzetta Piemontese», «La Gazzetta del Popolo», «Il Canavesano» e altri). Alle pp. 481-494 sono presenti una copiosa bibliografia suddivisa in Archivi e altre raccolte di documenti, Fonti primarie, Volumi, Articoli, Giornali, Guide. Le illustrazioni, come già sottolineato, sono numerose e interessan270 ti (Massimo Romandini). M ANLIO BONATI, Vittorio Bottego (Coraggio e determinazione in Africa Orientale), Il Tucano Edizioni, Torino 2005, pp. 146 (Gli Esploratori, 1, Collana diretta da Manlio Bonati) Non è certo il primo lavoro che Manlio Bonati, ideatore e curatore della collana «Gli Esploratori» del Tucano Edizioni di Milano, dedica al parmense Bottego che fu presente in Africa Orientale nelle diverse vesti del militare, del geografo, dell’esploratore e zoologo. Di Bonati, infatti, oltre a contributi per così dire «minori» se confrontati con i lavori più impegnativi, ricordiamo la bella edizione della biografia dell’esploratore parmense, edita nel 1997 dall’Editore Silva (Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa), corredata di una serie di documenti inediti. Questo volume dà il via ad una collana che si arricchirà col tempo di numerose biografie dedicate agli italiani che percorsero l’Africa Orientale, e non solo, in un momento particolare della storia dell’Ottocento, quando le potenze si contendevano gli ultimi spazi «vitali» del continente africano: Orazio Antinori, ad esempio, e Giuseppe Maria Giulietti, Enrico Baudi Le schede di Vesme, Antonio Cecchi, Pietro Savorgnan di Brazzà, Luigi Amedeo di Savoia, Augusto Franzoj, Giovanni Miani, ma anche Guido Baggiani, Umberto Cagni, Giacomo Bove che esplorarono con alterna fortuna altre parti del pianeta. Questa nuova biografia di Bonati, preceduta da alcune righe di Willy Fassio sul «Perché (di) una collana sugli esploratori italiani» e da una breve Introduzione dello stesso curatore, è suddivisa in nove capitoli (dai primi anni di Bottego nella nativa Parma alla morte sulla collina di Daga Roba in Etiopia meridionale, nel marzo 1897, un anno dopo il disastro di Adua); è poi completata da una Cronologia con i fatti salienti della vita dell’esploratore parmense e da una ricca Bibliografia. Bottego resta, e probabilmente resterà sempre, un personaggio particolare nel panorama della travagliata, spesso contraddittoria, presenza italiana in Africa Orientale. Bonati nella citata Introduzione ricorda che l’esploratore parmense è come sospeso tra giudizi diametralmente opposti: «eroe» per alcuni grazie alla perizia dimostrata nei suoi viaggi e alla tenacia mai venutagli meno; da classificare «tra i criminali e gli avventurieri della peggior specie» per altri studiosi a causa del sangue sparso tra Etiopia e Somalia e di taluni discutibili comportamenti (è, quello virgolettato, il giudizio di Angelo Del Boca). Difficile, quindi, un esame univoco del personaggio, tanto più che alcuni eventi «negativi» collegati a Bottego parlano chiaro. Non ebbe un carattere semplice: fu piuttosto un uomo coraggioso, sprezzante del pericolo fino all’incoscienza, che chiuse la sua vicenda terrena a soli 37 anni nel corso dell’ultimo viaggio nel Sud dell’Etiopia: uno di quegli uomini, insomma, che non potevano non colpire l’immaginario popolare del tempo e si meritarono l’intestazione di vie e piazze in Italia e all’estero dove tuttora Bottego è uno degli esploratori italiani più noti. Bonati ripercorre la vita di Bottego con l’ausilio, anche, di belle fotografie e di alcune illustrazioni che danno pregio al suo lavoro. Dimostra, ancora una volta, di conoscere a fondo il «suo» personaggio a cui ha dedicato in questi dieci anni numerosi contributi, rivelandone aspetti particolari del carattere e portando alla luce testimonianze scritte inedite o poco note. La vita di Bottego presenta alcune tappe fondamentali. A 17 anni (1877) salva un coetaneo che sta annegando nelle acque in piena del torrente Parma. A 18 anni (1878) è allievo ufficiale della Scuola Mi271 Le schede litare di Modena, a 19 anni passa all’Accademia Militare di Torino. A 27 anni (1887, più esattamente il 13 novembre) Bottego sbarca in Africa Orientale all’indomani della sconfitta di Dogali e dopo che l’Italia si è stabilita a Beilul, Archico, Arafali e soprattutto Massaua (gennaio-aprile 1885). A 28 anni (1888), rimpatriata senza colpo ferire la spedizione di San Marzano e rimasto lui in Eritrea, comincia l’attività di raccoglitore di animali per il Museo di Storia Naturale di Parma. A 29 anni (1889) Bottego è promosso capitano. A 30 anni (1890, l’anno della nascita della Colonia Eritrea), medita una prima esplorazione con il consenso dei superiori Gandolfi e Baratieri e le sollecitazioni della Società Geografica Italiana di cui è diventato socio. A 31 anni (1891) percorre il litorale eritreo tra Massaua ed Assab e pensa concretamente ad una spedizione al Giuba con Matteo Grixoni. A 32 anni (1892) Bottego parte da Berbera per l’avventuroso viaggio verso il Giuba che esplora e dal quale rientra esattamente un anno dopo (settembre 1893). A 34 anni (1894) il capitano, che intanto ha ricevuto la gran medaglia d’oro della Società Geografica Italiana, è ormai conosciuto ed ammirato per i suoi viaggi, nonostante qualche pesante polemica, come quella 272 con Grixoni che lo ha abbandonato nel corso della spedizione al Giuba. A 35 anni (1895) comincia a parlare di un viaggio a Lugh, avamposto al confine somalo-etiopico, per poi procedere con l’esplorazione dell’Omo, del Sobat e del Lago Rodolfo. È un progetto ambizioso ma rischioso, tenuto conto della confusa situazione politica locale e del momento difficile che le relazioni italo-etiopiche attraversano. Si è alla vigilia della prima guerra d’Africa e il conflitto con Menelik è imminente. Ai primi di luglio Bottego parte da Napoli per la sua seconda, fatale spedizione in Africa. Lo seguono Vannutelli, Citerni, Sacchi e un vecchio servitore senza mano (il Monchino). A Brava la spedizione raccoglie Ugo Ferrandi, in novembre è a Lugh che lascia il giorno dopo Natale. Intanto nel Tigrè ci sono stati l’Amba Alagi e Macallè e lo scontro frontale tra Baratieri e Menelik è sempre più vicino. A 36 anni (1896) Bottego continua la sua cavalcata in regioni inospitali ricorrendo a metodi non sempre ortodossi. In maggio raggiunge il Lago Ciamò, il suo Lago gemello Pagadè ribattezzato Regina Margherita, quindi in giugno l’Omo fino alla confluenza nel Lago Rodolfo. Ai primi di dicembre (a poco più di un mese della pace tra Italia ed Etiopia nell’ottobre 1896) Le schede il capitano termina la ricognizione del Rodolfo e parte per i territori etiopici popolati dai Galla. A 37 anni (1897) si avvicina a tappe forzate alla sua fine, dopo la morte di Sacchi nei pressi del Pagadè. È il 17 marzo 1897 e Bottego muore sul colle di Daga Roba. Vannutelli e Citerni, sopravvissuti al massacro, sono fatti prigionieri dai Galla della zona e, in giugno, liberati e ricevuti da Menelik ad Addis Abeba. Al momento della morte Bottego non sapeva nulla di Adua, anche se aveva intuito qualcosa negli ultimi giorni della sua spedizione. Trentasette anni, una vita avventurosa, una fine «eroica»: ce n’era a sufficienza per avviare il mito (Massimo Romandini). FRANCESCO SURDICH, L’attività missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto (Dall’evangelizzazione dell’Abissinia all’acquisto della baia di Assab), Millesimo, Comunità Montana «Alta Val Bormida», 2005, pp. 299 (I libri dell’olmo - «Collana di studi valbormidesi», diretta da Giannino Balbis, 9) Giuseppe Sapeto è un personaggio che non può non interessare chi si occupa di storia del primo colonialismo italiano. Esaltato in epoca fa- scista e per motivazioni ben comprensibili, il missionario lazzarista (poi non più tale) fu uomo del suo tempo, operò quindi in un contesto storico ben preciso, si rivelò a suo modo un protagonista: merita che se ne ripercorra compiutamente la vita con le numerose attività svolte, soprattutto quelle africane o «affricane» come avrebbe scritto. La revisione ormai trentennale dei fatti e dei personaggi che agirono agli esordi del colonialismo italiano in mar Rosso (come ben ricorda Surdich nella Premessa) ci consente di guardare agli uni e agli altri con occhio più critico e con la certezza di conclusioni più vicine alla realtà. Di Sapeto gli studiosi ricordano la voluminosa monografia di Giacchero e Bisogni del lontano 1942, peraltro da sempre l’unico vero studio approfondito sul missionario. Ora il volume di Surdich ha rimesso mano alla materia e fornito a tutti una nuova biografia: nuova sia per i dati che contiene sia per l’impostazione critica che contraddistingue il lavoro. Nella già citata Premessa Surdich fa alcune importanti precisazioni. La prima è che il volume è nato dal suo studio approfondito, tuttora in corso, sui rapporti tra l’iniziativa del Sapeto e quell’avvio stentato di colonialismo italiano in Africa 273 Le schede Orientale. La seconda è l’attenzione da lui dedicata all’attività missionaria di Sapeto che era, prima di tutto, uomo di chiesa, ma non era stata adeguatamente approfondita nel volume di Giacchero-Bisogni, anche se fino ad oggi gli studiosi avevano potuto trarre utili informazioni da altre opere dedicate all’operato religioso di Sapeto. La terza motivazione è data dall’attività scientifico-didattica del missionario che fu un attento studioso dell’Etiopia e ci ha lasciato numerosi lavori, in gran parte dimenticati, ma ancora degni di essere studiati e, per così dire, ricomposti in un lavoro complessivo che rivelerebbe certamente altre caratteristiche di una personalità decisamente multiforme. Su questo specifico argomento Surdich ha speso un intero capitolo, pur nella consapevolezza che l’attività culturale del missionario meriterebbe ben altra attenzione. Dette le motivazioni che sono alla base del volume di Surdich, resta la certezza che Giuseppe Sapeto fu un uomo poliedrico. Lo stesso titolo del volume è una dichiarazione corretta della vita del missionario, proprio perché ne mette in rilievo l’intensa, a volte frenetica attività. Missionario dunque in primis, poi non più missionario, dotato di discrete doti diplomatiche, fu 274 il protagonista della prima espansione coloniale italiana, ora autonomo ora utilizzato (o sfruttato) a sua insaputa («un’utile pedina» per usare una significativa definizione di Battaglia). I capitoli che Surdich dedica sia all’acquisto di Assab sia alle polemiche che ne seguirono ripercorrono compiutamente le molteplici, e non sempre chiare, vicende che accompagnarono l’esordio dell’Italia in terra africana e mettono in rilievo le contraddizioni e le difficoltà, e spesso anche la complessiva mancanza di chiarezza, che si rivelarono una caratteristica dell’espansione italiana in Africa Orientale. L’operato di Sapeto, che più volte aveva manifestato al governo italiano l’opportunità di insediarsi in mar Rosso, è abbastanza noto almeno nelle sue linee generali. Varie le motivazioni da lui addotte per giustificare la scelta di Assab (un territorio di sei chilometri di base e sei d’altezza) quale insediamento per la Compagnia Rubattino mandata in avanscoperta dal governo italiano in questa intricata e confusa questione. Esse si possono riassumere con le stesse parole di Sapeto: «1. La sua vicinanza allo stretto di Bab el-Mandeb e il suo facile approdo indicato dall’isola elevata di Sennabiar e dai monti tagliati a sella, che additano da lontano il Le schede capo Lumah. 2. La sua posizione rispetto a Mokha e Hodeida, empori dello Jemen, con i quali può comunicare con tutti e due i monsoni. 3. L’attitudine sua a diventare, come già fu nell’alta antichità, l’emporio dell’Arabia e dell’Abissinia, potendovi far capo le carovane che ora vengono a Massaua, Ras Bailul, Raheita, Tagerrah e a Zeila». Tanto ottimismo non avrebbe risparmiato a colui che si trovò trasformato in «agente del signor Rubattino» una lunga serie di polemiche. Ricorda il Battaglia che nessuna potenza europea aveva messo ancora piede su quel litorale e che almeno al momento non si prospettavano incresciose controversie internazionali. Il luogo era nelle mani di «sultanelli» locali, che dipendevano solo formalmente dal Sultano Anfari dell’Aussa (regione ad alcune giornate di marcia da Assab), ritenuto capo nominale di tutte le tribù Danakil della costa eritrea, geograficamente appartenente all’Abissinia. Ma l’Egitto - non lo si dimentichi avanzava pretese su tutto il litorale eritreo fino al Capo Guardafui in Somalia. La data più importante da ricordare in questa vicenda è il 15 novembre 1869, quando a bordo di una modesta imbarcazione locale, il Nasser Megid, Sapeto stipulò con i fratelli Hassan e Ibrahim ben Ahmad una sorta di compromesso-con- tratto col quale i due arabi dichiaravano che «hanno venduto e vendono al signor Giuseppe Sapeto il territorio compreso tra il monte Ganga, il capo Lumah e i due suoi lati». Il costo dell’operazione, la prima della storia coloniale italiana, fu di «seimila talleri, lasciando [...] duecentocinquanta talleri di caparra ai venditori, obbligandosi [Sapeto] a pagare i rimanenti cinquemila settecento cinquanta talleri fra cento giorni» (a decorrere dal 9 dicembre, primo giorno della festa musulmana del Ramadàn). La caparra sarebbe stata considerata perduta se Sapeto non avesse rispettato i patti e intanto i fratelli Hassan e Ibrahim «non potranno vendere ad altri il detto luogo, avendolo già venduto al signor Giuseppe Sapeto, ed accordatogli cento giorni al pagamento del prezzo suo». L’ acquisto definitivo fu sottoscritto l’11 marzo 1870 e festeggiato a bordo del piroscafo «Affrica» dell’armatore Rubattino, ma prima della fine del mese alcuni soldati egiziani provvidero ad abbattere i cartelli e i pali che delimitavano il primo possedimento coloniale italiano. Tutte le altre vicende legate all’ormai ex missionario lazzarista sono debitamente descritte nel volume di Surdich (Massimo Romandini). SALVATORE BONO, Tripoli bel suol d’amore Testimonianze sulla guer275 Le schede ra italo-libica, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, Roma 2005, pp. 189 («Fonti e Studi per la storia della Libia», 3) A monte di questo volume di Salvatore Bono, già professore nell’Università degli Studi di Perugia ed attualmente presidente della SIHMED (Société internationale des Historiens de la Méditerranée), ci sono i rinnovati rapporti italo-libici che testimoniano un nuovo e motivato interesse per le vicende che finora hanno diviso, più che unito, i due paesi nel tentativo di una migliore e più corretta, reciproca comprensione in campo storico. Dalla metà degli anni novanta studiosi italiani e libici tentano questa via che ha già dato buoni risultati in tutti i campi, comprese le relazioni diplomatiche certamente più distese, seppure non prive di alti e bassi. Da un quindicennio si tenta, insomma, di porre fine al contenzioso che risale alla dominazione coloniale italiana in Libia, che non fu l’occupazione priva di soprusi e di violenze (come ancora una parte degli studiosi ritiene), ma fu propriamente (e, per certi versi, inevitabilmente) carica di tutte quelle ingiustizie e mostruosità che costellarono il cammino delle potenze in Africa e Asia. Il «comunicato congiunto» del 4 276 luglio 1998 fra Italia e Libia può a ragione essere considerato il punto di partenza di quest’azione di recupero che vede gli studiosi libici, in accordo con quelli italiani, cercare la ricostruzione più fedele delle vicende che hanno come estremi cronologici l’attacco italiano del 1911 e la completa risoluzione del vincolo coloniale con le incomprensioni degli anni seguenti. Dal 1998 alcuni convegni sugli esiliati libici nelle prigioni italiane e diverse pubblicazioni mirate a raccontare le cose con il loro vero nome hanno accompagnato questo tardivo, ma necessario, percorso verso la verità storica. Salvatore Bono, di cui ricordiamo numerosi lavori sulla Libia coloniale (Bono, tra l’altro, è nato in Libia e il nonno materno, il medico Sebastiano Zaccaria, ebbe parte nelle vicende del tempo legate ai rapporti tra l’Italia e la Quarta Sponda), è pienamente consapevole che i risultati delle ricerche in questo delicato settore debbano circolare non solo tra gli studiosi che sono gli artefici degli approfondimenti attuali, ma anche tra un pubblico più vasto, soprattutto tra quanti ignorano, o volutamente o per mancata coscienza critica, il peso della dominazione italiana in Libia. Il volume, edito dall’IsIAO di Roma con il Centro di Studi Libici di Tri- Le schede poli, diretto dal professor Mohammed T. Jerary, ha i connotati della «storia» di quella presenza forte, e spesso violenta, verso le popolazioni locali. Oggi a ragione, i loro storici chiedono una volta per tutte che la guerra del 1911-1912, continuata poi con epiche forme di resistenza all’invasore, sia etichettata non più comodamente come guerra «italo-turca», ma a giusta ragione come guerra «italo-libica», essendo stati i libici i veri avversari degli aggressori giunti dall’Italia. Lo stesso titolo del volume, che ricorda i versi di una nota canzone popolare, è a suo modo provocatorio per evidenti motivi, ma Bono non ha inteso favorire con questo volume, pur nel dichiarato intento che lo ha guidato, un «atteggiamento accusatorio» o il «tono scandalistico» che spesso è proprio di questi lavori storici, al di là delle giuste ragioni che ne determinano la nascita. Siamo di fronte a un quadro di testimonianze sulla vicenda italo-libica, segnato da un percorso quadripartito le cui tracce equivalgono ad altrettanti capitoli del volume: «1. Speranze ed illusioni di una terra promessa», «2. Ultimatum e invasione», «3. Insurrezione e repressione», «4. Il volto della guerra». A completare il percorso alcune tracce bibliografiche nelle due pagine finali. Per ciascun percorso Bono ha operato una scelta ben motivata e, se vogliamo, accattivante che consente di avere a portata di mano passi scelti da autori noti e giornalisti di grido al tempo degli avvenimenti. La guerra italo-libica si presenta a noi in tutte le sue sfaccettature crudeli e irriverenti e tutti i personaggi che le attraversano hanno qualcosa da confessarci. Alcune testimonianze di parte italiana sono agghiaccianti: a volte distaccate, a volte partecipi del dolore dei libici, delle loro sofferenze. Affiora, qua e là, la consapevolezza che si fa del male a un popolo che avrebbe desiderato vivere la sua vita e non essere toccato nei valori sociali, religiosi, storici. Emergono spesso particolari meno noti delle vicende trattate, alcuni inaspettati, altri tipici di ogni guerra e perciò carichi del loro corredo di brutture ed ingiustizie. Sono pagine di giornali o di libri del tempo, frammenti di lettere di militari italiani, stralci di scrittori stranieri al seguito dei patrioti libici: tutte comunque di estremo interesse per il contenuto che estrae la guerra italo-libica dalla solita retorica e ce la presenta nelle vera realtà di guerra d’invasione respinta da un popolo di coraggiosi, uomini, donne, ragazzi, tenacemente attaccati alla loro terra e pronti a vendere cara la pelle, co277 Le schede me fecero in tante occasioni, anche a costo di crudeltà verso gli invasori. Si pensi alle giornate di Sciara Sciat all’indomani dell’attacco a Tripoli di fine ottobre 1911, quando la caccia agli italiani si concluse con la distruzione di interi reparti appena giunti dall’Italia, accompagnata da crudeltà di cui resta viva traccia nei ricordi degli scampati all’eccidio. A questa ferocia gli italiani risposero con le forche e le deportazioni di massa, con la distruzione dei villaggi e l’erezione del filo spinato, come è stato ampiamente dimostrato nelle ricerche degli ultimi trent’anni da parte di storici che hanno sfidato l’omertà e diffuso informazioni ed immagini. Le pagine scelte da Bono, come si diceva, sono le migliori per un’antologia che deve essere alla portata di tutti, suscitare emozione e partecipazione: quegli stessi sentimenti che il curatore afferma di aver provato nello svolgimento del suo lavoro «verso i tanti umili, e perlopiù anonimi, attori di quegli eventi: verso i combattenti italiani, che il dovere e la speranza - ma ai nostri occhi la retorica illusoria della ideologia colonialista - aveva condotto a “morire per questi deserti”, come scrisse uno di loro; verso i libici, soprattutto, che con mezzi impari ma con tenace fierezza cercarono disperatamente di resiste278 re all’aggressione coloniale in nome della loro tradizione religiosa e di civiltà, della loro identità araboislamica». Questo produsse la presenza italiana in Libia, pur con qualche eccezione che fortunatamente non mancò (Massimo Romandini). «Non Mollare» (1925), a cura di Mimmo Franzinelli, Bollati Boringhieri, Torino 2005, pp. 173. «Ora che la libertà di stampa è abolita, vedremo comparire la stampa clandestina»: sono queste parole, pronunciate in una sera del gennaio 1925 che segnano l’avvio del primo esperimento di giornalismo anti-regime attuato in epoca fascista. Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e Dino Vannucci diedero ad esso il titolo di «Non mollare», un chiaro incitamento alla resistenza contro le sempre più vaste limitazioni alla libertà di espressione, un segnale forte per «resistere malgrado le armi della milizia, malgrado l’impunità assicurata ai delinquenti, malgrado tutti decreti che possono venire firmati dal Re». L’epopea di «Non mollare» durò 22 numeri, ovvero il volgere di meno di un anno: nacque nel gennaio 1925 come reazione al discor- Le schede so parlamentare con il quale il capo del PNF sferrava l’offensiva decisiva contro le opposizioni e terminò nell’ottobre, quando le persecuzioni fasciste stroncarono le vite di alcuni dei più importanti sostenitori del periodico e costrinsero i «redattori» all’esilio. Seppur breve, la vita di questo foglio voluto dal gruppo di giovani intellettuali fiorentini di orientamento social-riformista e liberaldemocratico fece da faro per successive pubblicazioni clandestine avverse al regime quale, sopra tutte, la napoletana «L’ Antifascista» promossa da Enrico Sereni. Il percorso storico del «Non mollare», le vicende pubbliche e personali che ne hanno segnato il nascere e il forzoso scomparire, sono state oggi, a ottant’anni dal periodo della prima pubblicazione e a cinquanta dalla seconda, ripercorse da Mimmo Franzinelli che ha curato per i tipi di Bollati Boringhieri una ottima pubblicazione che include un esauriente saggio del curatore, tre interventi dei principali animatori del periodico toscano (Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi e Pietro Calamandrei) e la riproduzione fotografica di tutti i numeri dello stesso. L’opera di Franzinelli ha saputo coniugare la dovizia di particolari alle esigenze della lettura di tutti colo- ro che non hanno vissuto nell’epoca in questione, ed ha avuto successo nel riproporre la carica di pathos connessa alle vicende. Tra le pagine di storia vividamente narrate spiccano, in questo testo, quelle dedicate alla nascita del «Non mollare». La pubblicazione affonda infatti le proprie radici in due esperienze culturali diverse ma entrambe localizzate a Firenze: quella del «Circolo di Cultura», un simposio formatosi nel 1920-21 senza collegamenti con schieramenti partitici, nel cui direttivo figuravano i nomi di Pietro Calamandrei e Ettore Lo Gatto; e le attività della sezione del capoluogo toscano dell’Associazione «Italia Libera», nata a Roma nel 1923 per volontà di Randolfo Pacciardi e Raffaele Rossetti, e considerata il primo movimento antifascista clandestino. Altrettanto intensi sono gli interventi dei principali protagonisti della vita di questo foglio di informazione che fece epoca: il saggio di Gaetano Salvemini è ricco di richiami a fatti privati, di confronti sul modo in cui venivano presentate le vicende pubbliche dagli organi di informazione fascista e da quelli di ispirazione antifascista. Altrettanto chiaramente lo storico e docente universitario delinea il filo di continuità che lega le esperienze resistenziali. Scrive infatti Sal279 Le schede vemini: «molti, che nel 1925 furono i distributori del “Non Mollare”, entrarono dopo il 1929, nelle file di Giustizia e Libertà, il movimento diretto da Carlo Rosselli. E li ritroveremo, poi, nella Resistenza del 1943-1944. Dall’Italia Libera al “Non mollare”, dal “Non mollare” a Giustizia e Libertà, e da Giustizia e Libertà alla Resistenza, il filo non si spezzò mai». Sul primo passaggio di questa «catena» di resistenza al fascismo si concentra invece il contributo di Ernesto Rossi. Una frase, riportata al termine del testo dell’antifascista campano, riassume idea e finalità della sezione fiorentina di Italia Libera: «la funzione dell’Italia Libera in Firenze fu quella di rompere l’isolamento, in cui si trovava ogni antifascista innanzi alla bestialità trionfante; dare agli antifascisti qualcosa da fare come antifascisti, e quindi metterli a contatto fra loro e rincuorarli». Affreschi di vita clandestina ed aneddoti sulle vicende di resistenza al regime costituiscono il cardine narrativo di questo interessante saggio. Ed infine, Pietro Calamandrei, docente universitario al pari di Salvemini, tratteggia nel proprio scritto i rapporti tra il «manganello», la cultura e la giustizia. Quello stesso manganello, cioè la repressione violenta attuata dalle squadre fasciste, 280 il cui utilizzo era stato considerato lecito ai fini della persuasione dal filosofo di orientamento fascista Giovanni Gentile (Matteo Vecchia). Arti e Resistenza, a cura di Emilio Pozzi, M&B Publishing, Milano 2005, pp. 216. «Arti e Resistenza» è un’opera composita. Ideato da Emilio Pozzi, il volume si pone l’obiettivo di riflettere, nel sessantesimo anniversario della Liberazione, su cosa la Resistenza abbia dato alle arti e cosa le Arti abbiano dato alla Resistenza. Diversi e molteplici, di conseguenza, i contributi che compongono il saggio e che rappresentano unità di lettura autonome non vincolate a prestabilite impostazioni narrative: memoria, narrativa, poesia, cinema, teatro, pittura e scultura, televisione, musica, giornalismo, radio e satira. Nella sentita ma concisa premessa Emilio Pozzi cita quella che a suo parere dovrebbe essere interpretata come la definizione più appropriata di Resistenza: sono le parole pronunciate all’Università di Padova nel 1975 dal filosofo Dino Formaggio, il quale disse che «la Resistenza è un atto di vita, una scelta etica ed un rifiuto opposto alla distruzione dell’uomo, infine un’of- Le schede ferta di liberazione che l’uomo offre, a costo anche della propria vita, all’altro uomo. Un atto di questo genere non si commemora né si celebra, si può viverlo insieme, come può insieme essere vissuta l’indicibile essenza stessa dell’uomo». Nella vastità delle sfaccettature in cui è suddivisa l’opera, tre saggi hanno colto particolarmente la nostra attenzione: L’arte povera della scrittura di sé. Autobiografie oltre tempo della Resistenza di Duccio Demetrio; Nel cinema, storia di una rappresentazione di genere dell’accademica Cristina Bragaglia e del critico cinematografico Fernaldo di Giammatteo; ed infine Sempre difficile la vita della satira scritto dall’esperto di comunicazione Walter Marossi. Il primo scritto, saggio di apertura dell’opera, vuole essere un tributo alla memorialistica resistenziale e post-resistenziale, genere spesso ritenuto un patrimonio minore e meno autorevole della più conosciuta letteratura della lotta antifascista. Lo sguardo di Demetrio si rivolge all’esempio dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) nel quale sono custodite circa 5.000 testimonianze di coloro che hanno lottato contro il fascismo. Ulteriore intervento di rilievo è quello di Bragaglia e Di Giammat- teo. È nel 1942 che i due autori pongono l’inizio della storia della rappresentazione resistenziale nella cinematografia: partendo da Hollywood, sempre più le industrie cinematografiche tratteranno delle vicende della lotta al nazifascismo, e produrranno agli occhi degli spettatori una «apologia di quel “fronte interno” su cui la propaganda alleata punterà con insistenza sempre maggiore». In Italia, per ovvi motivi di contingenza storica, sarà prevalentemente negli anni successivi alla guerra mondiale che il cinema nostrano si dedicherà alla tematica del cinema resistenziale: lo farà con «Roma città aperta» (1945) e «Paisà» (1946) di Rossellini, e poi ancora con Mario Camerini, Alessandro Blasetti, Carmine Gallone e Luigi Zampa che sapranno rendere in immagini le risonanze emotive della lotta antifascista. Emotività, questa, che si esaurirà con i decenni successivi, a fronte di un cinema più analitico, che «fa più storia (o tentativo di storia) e meno testimonianza». Il saggio di chiusura - Sempre difficile la vita della satira - è forse il più interessante dell’intera raccolta, dal momento che narra in maniera diacronica la storia della stampa satirica italiana: dai torinesi «Il fischietto» e «Don Pirlone» si giunge al mantovano «Mer281 Le schede lin Cocai»; e poi ancora al socialista e anticlericale «L’asino», che più volte denunciò gli scandali giolittiani. Con l’avvento del fascismo, come riporta Marossi, l’esistenza di tale tipo di riviste venne messa a dura prova: molte di esse, come «L’asino» già citato, furono chiuse a forza, ma nel frattempo nacquero «nelle maggiori città italiane spericolati giornali satirici che presero l’iniziativa di mettere in caricatura il nuovo regime attraverso il disegno, soprattutto, ma anche con testi brevi, spesso efficaci, filastrocche, flash fulminanti». Dopo la guerra, invece, la stampa umoristica è nettamente di destra e l’obiettivo viene ad essere la demolizione dei valori della Resistenza; la situazione cambia a partire dal 1968, quando si forma una nuova generazione di vignettisti di sinistra destinata ad avere sempre 282 maggiore notorietà nazionale ed internazionale. A rendere composita e interessante la stesura dell’opera contribuiscono, oltre ai tre già citati, i saggi di tutti gli altri autori: da Letteratura italiana del secondo Novecento tra fascismo e antifascismo di Raffaele Crovi, a Il lascito morale della poesia di Gualtiero de Santi; e poi, gli scritti sul teatro di Gigi Livio, Donatella Orecchia e Armando Petrini, e i contributi Per Romagnola e Io c’ero di Luigi Squarzina e Umberto Ceriani; ed infine i testi di Raffaele De Grada, Leandro Castellani, Mario Pasi, Vittorio Franchini, Paolo Murialdi, Vittorio Paolucci, Giovanni Cordoni e Peppino Ottoleva, cui si aggiungono le riproposizioni di precedenti lavori di Italo Calvino, Alessandro Galante Garrone, Mario de Micheli e Adolfo Mignemi (Matteo Vecchia). notizie sugli autori di questo numero MAINARDO BENARDELLI - Diplomatico di carriera, ha prestato servizio in Uganda, Paesi Bassi e Sri Lanka. Attualmente è Primo consigliere all’Ambasciata Italiana di Baghdad. Autore di un libro, da lui pubblicato usando lo pseudonimo Umwantisi, su La guerra civile in Rwanda, edito dalla Franco Angeli nel 1997, ha scritto numerosi articoli in riviste specializzate di politica estera. ANGELO DEL BOCA - Da quarant’anni si occupa di storia del colonialismo e dei problemi dell’Africa d’oggi. Fra i suoi ultimi libri: Gheddafi. Una sfida dal deserto, Laterza, 1998; Un testimone scomodo, Grossi, 2000; La disfatta di Gasr bu Hàdi, Mondadori, 2004; Italiani, brava gente?, Neri Pozza, 2005. GRAZIA DE MICHELE - Giovane laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Napoli «l’Orientale». Seguita da Silvana Palma, sua relatrice, ha di recente discusso una tesi di laurea in Storia dell’Africa Subsahariana. STEFANO FABEI - Insegna all’Istituto tecnico per le attività sociali di Perugia. Tra i suoi libri citiamo Guerra e proletariato, Società Editrice Barbarossa, 1996 e Una vita per la Palestina. Storia del Gran Mufti di Gerusalemme, Mursia, 2003. FRANCESCO GERMINARIO - Ricercatore della Fondazione Micheletti di Brescia, diversi suoi saggi sul sindacalismo rivoluzionario, su Pareto, sulla storia dell’antisemitismo e sulla destra italiana e francese sono apparsi in varie riviste italiane e straniere. Con la Bollati Boringhieri ha stampato i volumi Da Salò al governo. Immaginario e cultura politica della destra italiana; La destra degli dei. Alain de Benoist e la cultura politica della nouvelle droite; Razza del sangue, razza dello spirito. Julius Evola, l’antisemitismo e il nazionalsocialismo (1930-43). CARLA GHEZZI - Per anni responsabile della biblioteca e dell’ufficio studi dell’Istituto italo-africano, divenuto, nel 1995, Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, studia la letteratura delle migrazioni, gli organismi geografici e coloniali e la memorialistica femminile nelle ex-colonie italiane. Su questi due ultimi temi ha pubblicato saggi raccolti nel volume Colonie, coloniali. Storie di donne, uomini e istituti fra Italia e Africa, Roma 2003. MARIO GIOVANA - Per lunghi anni giornalista, è autore di numerosi saggi, fra cui Algeria anno settimo, Milano 1961; La Resistenza in Piemonte. Storia del CLN Piemontese, Milano 1962; Storia di una formazione partigiana, Torino 1964; Guerriglia e mondo contadino, Bologna 1988. Collabora a riviste italiane e straniere di storia contemporanea. BRUNO LOI - Generale ora in pensione, nel 1992 ha guidato l’intervento italiano nell’operazione Restore Hope in Somalia e lo scorso anno ha pubblicato il volume Peace-keeping, pace o guerra?, con la casa editrice Vallecchi. ALESSANDRA MAGRO - Insegnante a contratto presso l’Università «Magna Graecia» di Catanzaro, si occupa di studi antropologici e sociali. FRANCESCO OMODEO ZORINI - Dirigente scolastico, dal 1998 presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola «P. Fornara». Ha pubblicato tra l’altro: Conoscere la Resistenza novarese. Bibliografia ragionata, prefazione di A. Jacometti, Novara 1978; La formazione del partigiano. Politica, cultura, educazione nelle brigate Garibaldi, prefazione di Guido Quazza, Borgosesia 1990; Una scrittura morale. Antologia di giornali della Resistenza del Piemonte orientale, Borgosesia 1996; Piero Fornara il pediatra delle libertà, Novara 2005. GIANCARLO POZZI - Ex partigiano dell’Ossola e studioso di temi legati all’uso della propaganda negli anni del fascismo e della Repubblica sociale italiana. MASSIMO ROMANDINI - Dirigente scolastico, dal 1969 al 1975 ha insegnato in Etiopia alle dipendenze del ministero degli Esteri. Si occupa di storia del colonialismo italiano in Africa Orientale. MATTEO VECCHIA - Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste, è oggi dottorando di ricerca in Storia Contemporanea presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (Firenze-Napoli). Sta conducendo studi sul terrorismo arabo e islamico, e scrive articoli di politica internazionale su quotidiani e riviste italiane. Quaderni di storia locale Associazione riconosciuta CENTRO STUDI PIERO GINOCCHI EDITORIA Via Pellanda, 15 - 28862 CRODO (VB) - Tel. 0324.61655 C.F. 92003940035 - P. IVA 01793430032 e-mail: [email protected] Libreria GROSSI s.n.c. 28845 DOMODOSSOLA (VB) Piazza Mercato, 37 Tel. 0324 242743 - Fax 0324 482356 - e-mail: [email protected] SEMPIONE Cento anni del traforo COMUNE DI BACENO Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero Il bilancio di quti primi quindici anni di gtione dell’area protetta denominata Zona di Salvaguardia dell’Alpe Devero non può che ere positivo per l’amministrazione comunale di Baceno, constatando l’arezzamento sempre crcente rivolto dalle svariate tipologie di frequentatori del parco. L’intervento fondamentale sull’accibilità dell’area tramite la realizzazione del parcheio interrato ed il consolidamento del servizio di gtione delle aree a parcheio intermedie ed in particolare del servizio navetta potrà costituire un punto di partenza fondamentale per le scelte amministrative future. Il rupero dell’Albergo Cervandone ed il miglioramento dell’offerta alberghiera istente potranno garantire maior fruibilità turistica e soprattutto garantiranno una poibilità di prolungamento della “stagionalità” ancora troo concentrata in pochi mi. L’utilizzo di mezzi elettrici volti al trasporto pubblico all’interno dell’area protetta potrà rarentare una realtà nel proimo futuro grazie alla sensibilità di Enti Pubblici ed operatori privati. Di certo l’attività amministrativa dovrà, anche in futuro, tenere sempre prenti le finalità della lee istitutiva, nell’ottica di un turismo ambientale cosciente e rponsabile, nella consapevolezza che ogni scelta operativa può incidere in bene o in male su una delle aree di maior pregio ambientale dell’intero arco alpino. Prof. Stefano Costa Sindaco di Baceno Finito di stampare nel mese di giugno 2006 presso la Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli snc - Ornavasso (VB) e-mail: info@saccardotipografia.191.it ISSN 1826-7920 3 I SENTIERI DELLA RICERCA � 12,00 3 I SENTIERI DELLA RICERCA rivista di storia contemporanea Giovana Omodeo Zorini Pozzi Fabei Magro Del Boca Ghezzi De Michele Pallotti Benardelli Germinario Loi Romandini Vecchia giugno 2006 EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO
Scarica