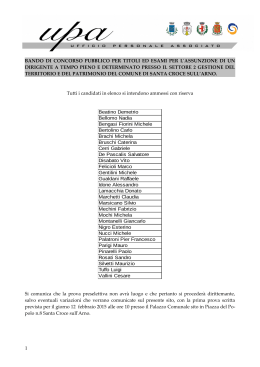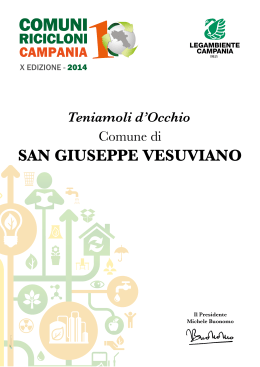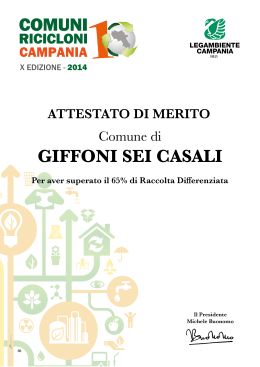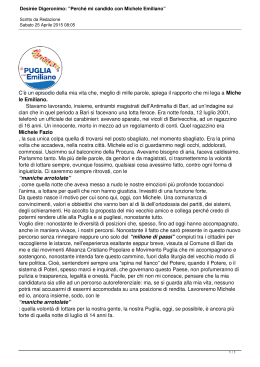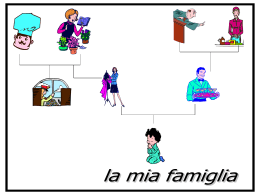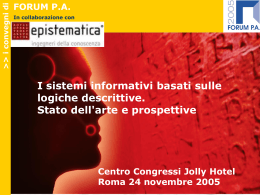La storia ricomincia dall’est Sette dialoghi su migrazioni e scenari demografici, su Cina e leadership mondiale e su molto altro ancora Michele Bruni Centro per l’Analisi delle Politiche Pubbliche Dipartimento di Economia Marco Biagi Immagine di copertina: Salvador Dalì “Mercato di schiavi con busto invisibile di Voltaire”, 1940. Dalì descrisse il suo lavoro dicendo che: “… rendeva normale l’anormale e anormale il normale”. 2 Il termine dialogo (dal greco dià, "attraverso" e logos, "discorso") indica il confronto verbale tra due o più persone. «La scrittura ha una strana qualità, simile veramente a quella della pittura. I prodotti della pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se domandi loro qualcosa, tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano i discorsi. [...] Una volta che sia messo per iscritto, ogni discorso si rivolge a tutti, tanto a chi l'intende quanto a chi non se ne fa nulla [...]; esso da solo non può difendersi né aiutarsi» Platone, Fedro Personaggi e interpreti in ordine alfabetico John: E’ americano, repubblicano e liberista; insegna storia in un liceo di Austin, Texas. Divorziato, i figli già grandi e sposati, viene spesso in Italia, un paese che conosce bene e di cui apprezza la cultura, soprattutto quella gastronomica. Li: E’ arrivato in Italia all’inizio degli anni ’80. Apprezza il suo nuovo paese di residenza nel quale ha avuto un discreto successo economico, ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza cinese. Negli ultimi anni il suo orgoglio nazionale è cresciuto a un ritmo analogo a quello del Prodotto Interno Lordo del suo paese. Lavora presso una società che si occupa di import export. Mario: Ha lavorato in un Centro di ricerca sindacale; adesso insegna all’università e opera nel campo della formazione. I suoi principali interessi culturali sono rivolti alla psicologia, ma lettore curioso e onnivoro cerca di mantenersi al corrente dei progressi di quasi tutte le discipline scientifiche. Michele: Professore di economia in pensione, si è sempre occupato di mercato del lavoro e di demografia e delle loro interrelazioni. E’ vissuto per parecchi anni in Cina e ha lavorato come economista del lavoro in progetti internazionali in numerosi paesi dei Balcani, in Estremo Oriente e in Africa. 3 Table of Contents Personaggi e interpreti in ordine alfabetico............................................................. 3 Indice analitico .................................................................................................................... 8 Frammenti dal futuro ..................................................................................................... 10 Primo dialogo - Riuscirà la Cina a conquistare la leadership mondiale? .... 13 Mentre l’oriente sorge, l’occidente tramonta ........................................................ 13 Il dibattito sul sorpasso: alcune tesi a confronto ...........................................................14 Crescita della produzione e sorpasso economico ..........................................................19 Misure alternative della produzione: il PIL a prezzi correnti e il PIL a prezzi costanti .................................................................................................................................................... 21 Il PIL a Parità di Potere d’Acquisto .............................................................................................. 22 Alcuni confronti internazionali ..................................................................................................... 22 Indicatori e tempi di sorpasso ....................................................................................................... 24 Le misure del benessere .........................................................................................................27 Il PIL pro capite .................................................................................................................................... 28 Che cosa misura il PIL ....................................................................................................................... 29 L’Indice di Sviluppo Umano ............................................................................................................. 31 L’Indice Lordo di Felicità ........................................................................................................34 Secondo dialogo - Le sfide demografiche della Cina: passato e futuro ................. 39 Stessa spiaggia, stesso mare ........................................................................................ 39 Carenza di lavoro e mobilità interna in Cina.............................................................. 39 Il crollo della popolazione in età lavorativa, le conseguenze sull’offerta di lavoro e la proposta della Banca Mondiale ............................................................ 40 Le sfide demografiche del passato............................................................................. 43 La sfida al sistema educativo ....................................................................................................43 La sfida occupazionale................................................................................................................44 Il sistema dell’Hukou ......................................................................................................................... 45 Deng e il nuovo corso dell’economia cinese............................................................................. 46 Modello di sviluppo di Lewis e offerta illimitata di lavoro ................................................ 48 La politica del figlio unico ................................................................................................................ 51 La popolazione fluttuante ................................................................................................ 55 Le dimensioni del fenomeno .................................................................................................55 Province di arrivo e province di partenza ........................................................................57 L’impatto delle migrazioni interne sull’economia e sull’offerta illimitata di lavoro .............................................................................................................................................59 Una prima valutazione della proposta della Banca Mondiale ......................... 61 Terzo dialogo - Le lontane origini del declino demografico .................................... 64 Elezioni, sistemi elettorali e informazione ................................................................... 64 Tasso di fecondità, benessere economico e andamento demografico..................... 66 La complessa relazione tra fecondità e sviluppo ...........................................................67 4 La transizione demografica ...................................................................................................70 Il Malthus pensiero ...................................................................................................................70 Benessere economico e fecondità .......................................................................................72 La rivoluzione demografica: dalla crescita alla contrazione della popolazione .. 73 L’invenzione dell’agricoltura ................................................................................................74 L’apologo delle formiche tagliafoglie .................................................................................74 Il grande decollo ........................................................................................................................75 Introduzione dell’agricoltura e prima transizione demografica .............................76 Speciazione e problem solving .............................................................................................77 Crescita delle disponibilità energetica e crescita demografica ................................78 Transizione o rivoluzione demografica?...........................................................................80 Le fasi della “Transizione demografica” ............................................................................81 Dal regime naturale al regime della consapevolezza e della scelta ........................83 Quarto dialogo - Il futuro demografico del pianeta secondo le Nazioni Unite: realismo delle ipotesi e affidabilità delle proiezioni demografiche ........................ 86 Il capodanno cinese ........................................................................................................... 86 La dinamica della transizione demografica ................................................................. 88 Transizione demografica e livello di sviluppo ............................................................. 89 I paesi sottosviluppati ..............................................................................................................89 I paesi in via di sviluppo ..........................................................................................................91 I paesi sviluppati ........................................................................................................................92 La transizione demografica a livello globale ...................................................................93 Le proiezioni demografiche della Population Division...................................... 95 Il futuro demografico della Cina...........................................................................................97 Cina e Nigeria: due paesi agli estremi del percorso della transizione demografica. ................................................................................................................................98 La polarizzazione dello sviluppo demografico ...............................................................99 La procedura di proiezione demografica utilizzata dalle Nazioni Unite. ..............99 Le ipotesi delle Nazioni Unite ............................................................................................. 100 Le ipotesi sulla mortalità ..................................................................................................................100 Una digressione su transizione demografica e “ordine demografico” ............................... 102 Le ipotesi sulla fecondità ...............................................................................................................103 Le ipotesi sulla migratorietà ............................................................................................................105 Le grandi tendenze dei flussi migratori.................................................................106 Modelli economici e modelli demografici dei flussi migratori ......................108 Quinto dialogo Un modello stock flussi del mercato del lavoro. ..................113 A proposito di tortelloni, ricotta e governo delle larghe intese ....................113 Il modello stock-flussi ..................................................................................................115 Le fasi della vita ....................................................................................................................... 116 Popolazione, condizioni socio - economiche e passaggi di condizione. .............. 118 Flussi generazionali e flussi temporanei ....................................................................... 119 Il modello di breve periodo e il modello generazionale ........................................... 121 Paradigmi, peyote e piselli ............................................................................................................121 Il modello microeconomico del mercato del lavoro ........................................................... 123 Il lavoro: fattore variabile o fattore fisso?...............................................................................125 Una digressione su realismo delle ipotesi e capacita previsiva ..................................... 126 Il modello stock flussi: seconda parte ............................................................................. 128 5 L’apologo del Cinema Italia ...........................................................................................................128 Le determinanti della partecipazione al mercato del lavoro .......................................... 131 Perché ai giovani non bisogna far sapere in quali mestieri potrebbero trovare lavoro più facilmente. ......................................................................................................................133 Il ruolo della domanda sostitutiva e della domanda aggiuntiva .................................... 133 Fonte: Elaborazione su Dati ISTAT ......................................................................................... 134 La definizione di crisi economica ..................................................................................... 134 Un modello per spiegare e prevedere i flussi migratori in ingresso ...........136 Sesto Dialogo – Il futuro demografico della Cina: Ipotesi, modelli e procedure per la costruzione di scenari demografici e del mercato del lavoro. ................................................................................................................................139 Notizie provenienti dall’interno e dall’estero .....................................................139 John fa il punto................................................................................................................141 Le ipotesi sulla migratorietà della Population Division...........................................141 Ciò che non convince Michele ................................................................................................ 141 Il caso italiano .......................................................................................................................... 141 Il rapporto Chamie e l’immigrazione sostitutiva ........................................................ 142 La verifica della tesi da domanda ............................................................................145 La verifica storica ................................................................................................................... 145 Le migrazioni che anche il più convinto dei neoclassici farebbe fatica a spiegare dal lato dell’offerta: schiavi e lavoratori a contratto. .............................................................. 145 La grande migrazione intercontinentale .................................................................................148 La verifica empirica ............................................................................................................... 149 Paesi di partenza e paesi di arrivo .............................................................................................149 Carenza d’offerta e saldo migratorio.........................................................................................150 Una procedura alternativa per la costruzione congiunta di scenari demografici e del mercato del lavoro .....................................................................153 Dalla teoria alla pratica: il futuro demografico della Cina ..............................156 Popolazione in età lavorativa e forze di lavoro ........................................................... 156 Domanda di lavoro e fabbisogno di occupati ............................................................... 158 Scenari migratori e di popolazione in età lavorativa in un mercato del lavoro aperto. ......................................................................................................................................... 159 L’impatto dei flussi migratori sulla natalità ................................................................. 161 Invecchiamento e carico sociale ....................................................................................... 163 Il futuro demografico della Cina nel medio periodo .................................................. 166 Uno sguardo a un futuro più lontano .............................................................................. 166 Settimo dialogo - Il secolo della grande migrazione ................................................168 Le riforme del Plenum cinese........................................................................................168 La presenza straniera nei paesi di arrivo .............................................................169 Proiezioni, percezioni e politiche: il caso della Cina .........................................171 Le politiche per ridurre il fabbisogno di manodopera straniera .......................... 172 Le politiche dal lato della domanda: aumentare la produttività e delocalizzare la produzione ...........................................................................................................................................172 Le politiche dal lato dell’offerta: età di pensionamento, mobilità interna, fecondità ...................................................................................................................................................................173 Il contesto demografico mondiale ...........................................................................176 6 Transizione demografica e polarizzazione demografica ......................................... 176 Tutti insieme appassionatamente verso la terza fase della transizione ............ 176 Popolazione in età lavorativa e offerta di lavoro: dove cresce (troppo) e dove cala (dopo) ................................................................................................................................ 178 I saldi migratori internazionali: previsioni a confronto .......................................... 179 Le migrazione internazionali: calamità o opportunità? .................................181 Il Fondo Migrazione Educazione ....................................................................................... 183 Da idea a progetto: ci vorrebbe un miracolo .......................................................186 7 Indice analitico Nella prima giornata i nostri amici cominciano a discutere se e quando l’economia cinese sorpasserà quella degli Stati Uniti e conquisterà la leadership del mondo, ma finiscono poi con l’approfondire il significato e i limiti dei diversi indicatori utilizzati per valutare produzione e benessere. Nella seconda giornata si prospetta l’incredibile calo demografico che attende la Cina nel corso del XXI secolo. Si ricordano le grandi sfide demografiche in campo scolastico e occupazionale che il paese ha già affrontato e le politiche adottate. La conversazione si chiude su un dubbio inquietante: la Cina dovrà rinunciare alla propria omogeneità etnica per conquistare la leadership mondiale? Nella terza giornata i nostri amici partono dalla considerazione che la Cina è solo uno dei tanti paesi che sono o saranno interessati da un calo della popolazione in età lavorativa. Dopo aver parlato di tassi di fecondità e del rapporto tra natalità e benessere economico, spuntano Malthus e la teoria della transizione demografica. E’ l’occasione per ripercorrere la storia demografica dell’umanità e discuterne gli aspetti più salienti. Nella quarta giornata si traccia il percorso della transizione demografica analizzandone le conseguenze in tre gruppi di paesi a diverso livello di sviluppo economico. Si affronta poi il tema delle proiezioni demografiche delle Nazioni Unite e si considerano alcuni degli elementi estremamente preoccupanti che ne emergono, per passare poi a valutare le ipotesi su mortalità, fertilità e migratorietà che sono alla base di tali risultati. La discussione finisce col concentrarsi sui limiti delle ipotesi in tema di migrazioni. Nella quinta giornata si prende in considerazione un modello stock-flussi del mercato del lavoro le cui variabili sono delle popolazioni che si muovono nel tempo reale. In tale prospettiva, l’andamento del mercato del lavoro è determinato dall’interazione tra la sfera demografica, che influenza l’offerta di lavoro, e la sfera economica, che condiziona la domanda. Da questo si deduce il perché i flussi migratori stiano progressivamente aumentando e cambiando la loro direzione. Nella sesta giornata vengono proposti elementi storici e statistici che danno supporto al modello dei flussi migratori proposto nella chiacchierata precedente. Michele illustra poi la procedura da lui elaborata per costruire in maniera congiunta scenari demografici e del mercato del lavoro e che incorpora il modello da lui proposto. Sulla base dei recenti dati censuari, questa procedura mostra che la Cina sta per essere colpita da una carenza strutturale di offerta di lavoro senza precedenti storici e che la stessa cosa sta per accadere in oltre cinquanta paesi che hanno nel loro insieme una dimensione demografica analoga a quella della Cina. Nella settima giornata le decisione prese dal recente Plenum cinese forniscono lo spunto per analizzare le politiche che possono ridurre il fabbisogno di immigrati agendo o sulla domanda o sull’offerta di lavoro. La conclusione è però che tali politiche possono solo alleviare, ma non risolvere il problema. Allargando l’analisi al contesto internazionale, Michele evidenzia che nei prossimi anni la transizione demografica provocherà una crescente polarizzazione tra paesi caratterizzati da una violenta contrazione della popolazione in età lavorativa e un numero decrescente di paesi dell’Africa sub-sahariana e dei paesi più poveri dell’Asia nei quali la popolazione in età lavorative esploderà con una velocità senza precedenti storici. Ciò consente di valutare che nel corso dei prossimi 50 anni oltre 700 milioni di persone si sposteranno dai paesi ad alta fertilità nei paesi a bassa fertilità, attratti dalla loro carenza strutturale di lavoro. Secondo Michele questa è la grande occasione che la transizione demografica offre agli abitanti del pianeta per ridurre diseguaglianze economiche e razzismo. Perché ciò non rimanga un sogno, ma un progetto servirebbe la creazione di una apposita Organizzazione Mondiale che gestisca i flussi migratori, una proposta che però ha qualche 8 probabilità di vedere la luce solo se troverà il supporto di uno sponsor con la necessaria autorità morale. 9 Frammenti dal futuro Notlim Namdeirf chiuse gli occhi e staccò il contatto mentale dalla memoria universale dopo essersi assicurato di aver alzato tutte le barriere protettive che un amico hacker aveva predisposto per lui. Da quando i suoi colleghi avevano saputo che l’opera fondamentale alla quale stava lavorando da oltre venti anni era quasi terminata, gli attacchi si erano ripetuti sempre più frequenti. I Sentimentalisti avrebbero fatto di tutto per cercare di leggere il suo lavoro e poter così mettere a punto le loro velenose critiche. La visione globale della sua opera gli aveva dato un piacere quasi sensuale. Si presentava perfetta in tutte le sue parti, armoniosa nella costruzione, irrefutabile nelle conclusioni. Certo non era stato facile costruirla partendo da un materiale così limitato, ma erano ormai cinque anni che i suoi assistenti non erano più riusciti a ripescare alcun frammento. Era stato il caso che l’aveva portato sulle tracce di quel mondo perduto subito dopo aver iniziato la sua carriera universitaria. Ma gli era bastato decodificare i primi frammenti che aveva recuperato dal cyberspazio di quel lontano pianeta per decidere che ne avrebbe fatto il suo campo di studio. Di quel mondo non era rimasto nulla, tutto ciò che copriva la sua superficie era stato fuso in una compatta ed omogenea materia di color viola che esalava ancora miasmi mortali. Ma lui, partendo da quei frammenti, aveva saputo ricostruire non solo la psicologia di quei lontani progenitori, ma anche i loro comportamenti di vita quotidiana. Ciò che lo aveva affascinato di quella civiltà perduta era che essa presentava caratteristiche che non si erano più ripresentate nei successivi mille anni. Il principio che guidava l’operare di quegli uomini era la più pura razionalità. Ogni loro azione era mirata all’ottenimento del massimo vantaggio, alla massimizzazione del risultato perseguito. Quegli antichi saggi avevano una tale perfetta conoscenza della propria psiche da poterla rappresentare attraverso delle funzioni matematiche che erano visualizzate da curve di livello la cui pendenza misurava il trade off tra le alternative disponibili. Si trattava, e su questo tutti i testi concordavano, di curve convesse verso l’origine perché essi amavano un consumo bilanciato e non avrebbero mai e poi mai preferito quattro banane e due mele o quattro mele e due banane a tre banane e tre mele. Sulla base del loro reddito, essi potevano così distribuirlo esattamente e senza alcuna incertezza fra i vari “panieri di consumo”. Una strana terminologia questa che gli aveva suggerito, anche se su questo punto non se l’era sentito di essere categorico, la visione di una vita agreste ancora a diretto contatto con la natura. Anche le loro attività produttive avevano luogo in una situazione di massima efficienza, senza sprechi, minimizzando i costi e massimizzando i profitti. Ciò che l’aveva colpito era la loro capacità di misurare le variazioni al margine di tutte le variabili coinvolte, un approccio che da allora era sempre stato scartato perché ritenuto matematicamente interessante, ma irrealistico. Così quel mondo era vissuto in una situazione di equilibrio economico generale in cui vi era una massima equità sociale dato che tutte le risorse erano retribuite in base al loro contributo alla produzione. La povertà di alcuni, comunque relativa, dipendeva solo da una scarsa dotazione di capitale umano. L’inquinamento veniva tenuto al livello ottimale e il sentiero di sviluppo economico e sociale veniva tracciato con precisione matematica da una serie di equazioni macroeconomiche che catturavano le immutabili leggi dell’economia. Ma il capitolo di cui era più orgoglioso, quello in cui la sua opera aveva raggiunto il massimo di accuratezza e d’interesse, era quello dedicato al mondo del lavoro. Questa società era stata capace di una totale mancanza di superbia. Le modalità attraverso le quali la forza lavoro era venduta ed acquistata erano del tutto identiche a quelle di qualunque altro bene, si trattasse di zucche, di aragoste del Maine o di widget, qualunque cosa fossero. I lavoratori, 10 perfettamente razionali e i cui processi decisionali erano tra di loro completamente indipendenti, in ogni data unità di tempo potevano decidere sulla base del livello salariale se lavorare o meno e, nel caso in cui il salario offerto fosse sufficiente a controbilanciare la disutilità che sarebbe venuta loro dal rinunciare al proprio tempo libero, per quante ore farlo. Era chiaro quindi che in quella felice società se qualcuno non lavorava era per sua libera scelta. Come non concludere che si doveva essere trattato di una società opulenta, in cui nessuno era schiavo delle necessità materiali e i cui membri potevano in qualunque momento concedersi anche lunghi periodi di disoccupazione, ovviamente volontaria, per recarsi in qualche amena località turistica. Tutto questo non sarebbe bastato a far funzionare il sistema se gli straordinari abitanti di quel pianeta non avessero usufruito di altre due capacità. Era stato questo che lo aveva convinto che si trattasse di una popolazione che aveva raggiunto un livello evolutivo mai più raggiunto: perfetta conoscenza e istantanea mobilità. La perfetta conoscenza -che doveva consistere in qualche cosa di simile, anche se molto più perfezionato alla possibilità di connettersi alla memoria universale- consentiva loro di visualizzare in tempo reale tutte le schede di domanda e di offerta, mentre la perfetta mobilità permetteva loro di raggiungere immediatamente il luogo di lavoro. Inizialmente Notlim aveva avuto paura di sostenere che la popolazione che aveva abitato quel pianeta avesse avuto simili doti. Poi un giorno aveva trovato la prova decisiva. Si trattava di pochissimi fotogrammi che erano stati girati su di una immensa nave stellare, l’Enterprise , in cui si vedeva un umano, di nome Spock, che si comportava con la razionalità che egli già sapeva essere tipica di quel popolo e che usava una macchina che gli permetteva di trasferirsi da un luogo ad un altro in maniera istantanea, una macchina che evidentemente era stata poi perfezionata. Quei pochi fotogrammi gli avevano anche permesso di scoprire che quel popolo aveva lunghe orecchie appuntite. La capacità di allocare istantaneamente il lavoro nei vari processi produttivi, sulla base dello loro caratteristiche tecnologiche e del livello della domanda, rendeva tale fattore perfettamente variabile, nei fatti qualcosa di simile all’energia, attivabile e disattivabile spingendo un pulsante. Ciò eliminava ogni necessità di pianificare il parco uomini necessario per far fronte a variazioni della produzione. Un mondo che gli industriali di Arret avevano sempre sognato, ma ovviamente mai ottenuto. La sua tesi avrebbe incontrato - Notlim ne era perfettamente consapevole- le critiche sarcastiche dei Sentimentalisti che avevano delineato un’immagine totalmente diversa. La loro tesi era che ciò che lui aveva preso per realtà fosse invece un modello che quel popolo arcaico aveva prodotto per analizzare, spiegare e prevedere i comportamenti socio-economici. Notlim non poteva credere che un gruppo di scienziati capaci di utilizzare strumenti logico-matematici avanzati come quelli di cui aveva trovata traccia sul pianeta forse chiamato Terra potessero ignorare il semplice e fondamentale principio che le ipotesi di un modello debbono riflettere gli elementi essenziali di quella fetta di realtà che si vuole rappresentare. Anche su Arret vi erano stati periodi oscuri durante i quali gli scienziati avevano dovuto affermare che i loro modelli non erano rappresentazioni fedeli della realtà, ma meri strumenti di calcolo. Essi lo avevano fatto non perché abbracciassero tale posizione, ma per evitare le persecuzioni della classe sacerdotale, in quel momento al potere, e i cui sacri testi sostenevano posizioni diverse. Era rimasta famosa l’introduzione che un sacerdote aveva scritto per poter pubblicare un fondamentale testo di astronomia che aveva sconvolto la precedente visione dell’universo. In essa si leggeva: “non vi è alcuna necessità che queste ipotesi siano vere o in qualche modo vicine alla realtà; è sufficiente che esse forniscano calcoli che siano coerenti con le osservazioni”. Ma poi la superstizione era stata sconfitta e gli scienziati di Arret avevano potuto continuare nella loro ricerca della “verità”, pur nella consapevolezza che si sarebbe sempre trattato di una verità relativa, condizionata dalla loro struttura sensoriale e dalla posizione ideologica implicita nella scelta delle ipotesi e dei termini non definiti posti alla base dei vari modelli. 11 Certo era successo che qualche altro scienziato avesse in seguito provato di portare avanti la cosiddetta tesi strumentalista, secondo la quale un modello non deve essere giudicato sulla base della veridicità delle sue ipotesi, ma sulla sua capacità di prevedere il futuro corso dei fenomeni. Questa posizione aveva sempre trovato ferma opposizione. In primo luogo come si poteva ritenere che fosse più importante prevedere che spiegare? La capacità previsiva di un modello è di fatto la conseguenza della sua capacità esplicativa che a sua volta dipende dalla capacità delle sue ipotesi di cogliere gli aspetti fondamentali del fenomeno analizzati dal modello. Rifiutare una tale posizione significava mettere sullo stesso piano gli scienziati con astrologi e cartomanti. Cosa sarebbe successo se le previsioni relative all’andamento del PIL o dell’occupazione fatte da un mago fossero risultate migliori di quelle degli economisti? Avrebbero essi deciso di abbandonare i loro modelli a favore dei tarocchi, o dei meridiani ? E poi se si fosse anche deciso di giudicare un modello sulla base della sua capacità previsiva si sarebbero dovute stabilire le regole del gioco. Chi avrebbe deciso quali margini di errore fossero accettabili? A chi sarebbe stato affidato il compito di effettuare le verifiche? Come fare ad evitare che giudici e giudicati finissero col coincidere? E come evitare che la mancata capacità previsiva del modello non venisse giustificata con motivi ad hoc del tutto contingenti e tale visione imposta in maniera autoritaria da chi nel mondo accademico deteneva il potere? Notlim non poteva accettare che studiosi così raffinati non fossero consapevoli di questi problemi e avessero accettato posizioni strumentaliste. Quindi ciò che gli scienziati di quel mondo avevano descritto non poteva essere che una rappresentazione veritiera della loro realtà. Certo anche Notlim aveva visto parte dei frammenti che i Sentimentalisti avevano utilizzato per fornire una visione diametralmente diversa di quel mondo. Violenza, miseria, corruzione, sfruttamento erano rappresentati a vive tinte. Sembrava di capire che la stragrande maggioranza degli abitanti di quel mondo vivesse sotto il limite della povertà; che i paesi ricchi avessero fatto ogni sforzo per rendere egemone la loro cultura e che avessero utilizzato senza troppi scrupoli il loro potere militare per farlo, giustificando le guerre da loro intraprese come strumento per portare la democrazia e diffondere quel rispetto dei diritti umani che essi erano i primi a violare. Le scene più drammatiche riguardavano però gli eventi che avevano determinato la fine di quel mondo. La popolazione dei paesi più poveri aveva cominciato a crescere in maniera smisurata e fuori controllo. A quel punto i paesi ricchi, terrorizzati dall’idea di essere invasi da bande di straccioni affamati, avevano iniziato a far pattugliare i propri confini dall’esercito e dalla marina, con l’aiuto dell’aviazione e dei satelliti. L’ordine era quello di respingere con qualunque mezzo chiunque si avvicinasse. Però l’unico risultato era stato quello di far lievitare i profitti delle organizzazioni che gestivano l’immigrazione clandestina e ancora di più il numero dei morti. Ben presto fu evidente che azioni puramente difensive erano insufficienti. Fu allora che, con la connivenza di alcuni gruppi di potere, i servizi segreti presero in mano la situazione e cominciarono a fomentare scontri e guerre fra fazioni avversarie dei paesi poveri, fornendo contemporaneamente armi a tutti i contendenti. Anche questo risultò insufficiente a disinnescare la bomba demografica e allora si decise di diffondere alcuni virus letali che erano però sfuggiti al controllo e si erano diffusi anche nei paesi ricchi. Pensando di essere sotto attacco batteriologico, uno di questi aveva rispolverato alcune bombe nucleari che aveva inavvertitamente dimenticato di distruggere. Purtroppo, anche altri paesi erano incorsi nello stesso sbaglio e in 24 ore tutta la vita del pianeta era stata annientata. Notlim però non si era fatto confondere da quelle immagini. Egli sapeva quanto la fiction fosse popolare su quel pianeta: i suoi collegati avevano semplicemente preso una telenovela per la realtà. 12 Ramòn: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, l’uomo con la pistola è un uomo morto. Joe: Vediamo se è vero. Dal film di Segio Leone “ Per un pugno di dollari”, 1964 Primo dialogo - Riuscirà la Cina a conquistare la leadership mondiale? Cesenatico, una delle località più note e simpatiche della riviera romagnola. E' una mattina di fine primavera che sembra preannunciare un’estate più calda del solito. Mario e Michele si sono alzati presto e hanno deciso di andare a prendere un cappuccino nel loro bar preferito. Appena arrivati, si uniscono a John che sta facendo colazione a un tavolino da cui s’intravvede, tra pini e capanni, un po’ di mare. Dopo poco arriva anche Li sventolando l’ultimo numero del China Daily 1 che scarica regolarmente da Internet e traduce (in maniera un po’ creativa) il titolo dell’articolo di fondo: “La Cina ha messo la freccia, pochi anni ancora e il sorpasso sarà cosa fatta”. Mentre l’oriente sorge, l’occidente tramonta John, assaporando la sua colazione all’inglese: Mio caro Li, la vostra voglia di sorpasso è pericolosa soprattutto se chi guida tirava la carretta fino a pochi anni fa; il vostro è un motore ancora in rodaggio e potrebbe surriscaldarsi. E poi non si possono certo escludere errori di manovra. Nessun economista cinese ha ancora vinto il premio Nobel. Insomma, se fossi in voi, starei attento a non andare a sbattere. Che vi piaccia o no, il futuro è ancora a stelle e strisce. Mario: Ha parlato John Wayne. Guarda John che l’attuale crisi mondiale è partita dal tuo paese ed è stata provocata dalle politiche liberiste che tanto ti piacciono e dalla deregolamentazione dei mercati finanziari. D’altra parte non mi sembra che la presenza di tanti premi Nobel nelle vostre Università sia servita a molto. E poi il problema è più generale. Il merito non è tutto della Cina: mentre l’oriente sorge, l’occidente tramonta. John: L’unico modo per essere efficienti e competitivi è quello di affidarsi al mercato e di minimizzare il ruolo dello Stato. Mario: Senti, perché non vai a fare due chiacchiere con i milioni di americani 2 che hanno perso la casa a seguito della crisi finanziaria? Sta solo attento perché i tuoi connazionali continuano ad avere il grilletto facile e nessuno è ancora riuscito non dico a eliminare, ma neppure a ridurre l’arsenale che si nasconde nelle vostre case. Tu come sei messo ad artiglieria? John: Sarò di destra come dite voi, ma non sono a favore del possesso indiscriminato di armi. 1 Con oltre mezzo milione di copie; un terzo delle quali diffuse all’esteero via satellite, il China Daily è il giornale cinese in lingua inglese con la circolazione piu ampia. 2 Tra il 2007 e il 2012 i pignoramenti effettuati negli Stati Uniti furono quasi 16 milioni e le banche si sono riprese oltre 5 milioni di case. 13 Michele: Lo sappiamo John, Mario scherzava; comunque, una fede cieca nella “mano invisibile” è fuori luogo. I limiti del libero mercato non sono pochi. Perfino Adam Smith li vide con grande chiarezza e uno dei risultati più importanti della ricerca economica del XX secolo è stato quello di aver dimostrato che i mercati sono efficienti solo nella misura in cui siano rispettate tutta una serie di condizioni, molto difficili da riscontrare nella realtà, come ad esempio l’assenza di poteri monopolistici e la presenza di perfetta informazione 3. Quando queste condizioni non sono presenti, si registrano, come ben sai, i cosiddetti fallimenti del mercato. Mario: Sì, che tutti noi conosciamo anche di persona! Michele: I fallimenti di mercato sono situazione nelle quali il mercato non produce esiti efficienti 4. Ma torniamo alla crisi. Stiglitz, che non è proprio l’ultimo arrivato dato che ha vinto il premio Nobel ed è stato Direttore della Banca Mondiale, ha detto che non è rimasto per niente sorpreso dal fatto che la crisi finanziaria non fosse stata prevista, dato che il modello utilizzato dalla Banca Centrale americana rappresenta un mondo caratterizzato da perfetta informazione e nel quale la bolla non poteva scoppiare perché non poteva esserci 5. Ma forse la miglior testimonianza del fallimento di tutto un modo di ragionare, che dimentica i limiti del mercato, fu offerta proprio dalla testimonianza data da Greenspan, allora Governatore della Banca Centrale, davanti al Congresso americano e che io stesso ricordo di aver seguito in diretta sulla CNN 6. Fu un momento sorprendente quando il Governatore riconobbe di aver commesso un errore nel ritenere che i mercati sarebbero stati capaci di gestire meglio i rischi e dichiarò di essere rimasto molto sorpreso. D’altra parte il mondo non è ancora uscito dalla crisi. Si deve tuttavia riconoscere che Stati Uniti e Cina si sono mossi in maniera più intelligente dell’Europa: hanno capito che per uscire dalla crisi non serve l’austerità, ma è necessario rilanciare l’economia. Il dibattito sul sorpasso: alcune tesi a confronto Mario: (che è alla seconda brioche, una chiara indicazione che i fallimenti del mercato lo lasciano al momento abbastanza indifferente) Ragazzi non cominciamo con le discussioni di principio e torniamo al problema del sorpasso. Forse a John è sfuggito il dibattito sulla caduta dell’Impero Americano e l’atteso passaggio del testimone dalla cultura occidentale a quella orientale. C’è ad esempio un recente articolo del Prof. McCoy 7 che non è cinese, non fa parte dell’equipaggio dell’Enterprise 8, ma insegna storia del Sud est asiatico all’Università di Wisconsin - Madison. Secondo lui, il crollo dell’America è dietro l’angolo. La sua tesi è che, malgrado l’aura di onnipotenza che li circonda, gli Imperi siano organismi fragili e il loro collasso è stato spesso improvviso e veloce. Ad esempio, a suo dire, il crollo dell’Impero Portoghese si compì in un anno, quello dell’Unione Sovietica in due, quello dell’Impero 3 Tra I lavori fondamentali vi sono l’articolo di Gerard Debreu e Kenneth Arrow: “Exixtence of a competitive equilibrium for a competitive economy del 1954 e la monografia di Debreu: Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, del 1959. Entrambi i lavori sono fortemente sconsigliati ai non matematici. 4 Tra i maggiori fallimenti del mercato vi sono quelli collegati all’inquinamento. 5 Joseph Stiglitz, “The Failure of Macroeconomics in America”, China & World Economy, pp. 17 – 30, Vol. 19, No. 5, 2011. 6 Si veda anche, Felsenthal, Mark (September 13, 2007). "Greenspan says didn't see subprime storm brewing". Reuters. Retrieved June 22, 2009. 7 Alfred W. McCoy, “The Decline and Fall of the American Empire. Four Scenarios for the End of the American Century by 2025”, affisso su Tom Dispatch il 5 dicembre 2010; http://www.tomdispatch.com/archive/175327/alfred_mccoy_the_decline_and_fall_of_the_American_empire 8 Ovviamente Michele si riferisce al popolare Dottor McCoy della serie Star Trek, noto anche come Bones (Ossa), un appellativo che, viste le tesi che sostiene, potrebbe essere utilizzato anche per l’omonimo professore universitario. 14 Ottomano in undici, quello della Gran Bretagna in diciassette. Sempre secondo McCoy, il crollo dell’Impero Americano si compirà in ventidue anni a contare dal 2003, l’anno fatidico in cui Bush decise di invadere l’Iraq. John: Mi sembra che questo McCoy dia i numeri e poi bella riconoscenza per il Presidente che ha guidato la guerra contro il terrorismo e gli stati canaglia 9. Mario: Guarda caso, i terroristi vivono sempre in paesi pieni di petrolio o di altri minerali interessanti, mentre nessuno se l’è mai presa con tutti quei sanguinari dittatori che hanno o stanno ancora sfruttando in maniera ignobile le popolazioni di paesi poveri di risorse naturali. Come diceva Agatha Christie, se una cosa capita una volta sola può essere una coincidenza, ma se capita più volte diventa un indizio. Ti ricordo anche che gli Stati Uniti sono l’unico paese che è stato condannato per terrorismo internazionale dalla Corte Mondiale e che ha respinto una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che richiamava i paesi a rispettare il diritto internazionale 10. Eravamo negli anni ’80 e Reagan, sconfitti gli indiani, aveva deciso di sradicare il comunismo dovunque si annidasse. Tutti gli strumenti erano buoni, incluse le squadre della morte. Michele: Mario, adesso ti ci metti anche tu! Torniamo al crollo del potere americano, un fatto che la maggior parte degli studiosi ritiene ormai assodato. Perfino lo US National Intelligence Council 11 ha ammesso che il potere globale degli Stati Uniti sia in fase discendente, anche se ritiene che il processo sarà lungo e si concluderà con un atterraggio morbido. Secondo McCoy, invece, l’Impero Americano sarà un ricordo del passato già prima del 2030 e la cosa non sarà piacevole per i suoi cittadini. La caduta degli imperi, secondo lui, ha effetti demoralizzanti, determina prolungate crisi economiche e spesso disordini politici. A dire la verità, vi è anche chi come Joseph Nye, il guru neoliberale della politica estera americana, non crede che gli Stati Uniti stiano declinando e tanto meno che la Cina possa assurgere al ruolo di leader mondiale 12. John (attaccando il secondo uovo all’occhio di bue): Questo è parlare! E non si tratta di un’opinione isolata. Guardate che anch’io ho letto un po’ di roba su questo tema -anche se mi sembra tempo perso- e che anche il vostro amico Obama ha dichiarato che non avrebbe mai accettato che gli Stati Uniti scendessero al secondo posto 13 . Mario: Beh, che cosa ti aspetti dal Presidente degli Stati Uniti, che faccia il tifo per la Cina? Il punto è che sono proprio gli studiosi occidentali a sostenere che la leadership mondiale stia per passare all’Oriente e a discutere le possibili caratteristiche di questo nuovo ordine mondiale. 9 E’ la traduzione creativa del temine inglese rogue state che letteralmente significa stato isolato dalla comunità internazionale. Nella visione originaria dell’Amministrazione Clinton, per essere canaglia uno stato doveva: i) essere diretto da un regime autoritario, ii) non rispettare i diritti umani, iii) sponsorizzare organizzazione terroriste, iv) prdurre armi di sterminio di massa e, ovviamente, v) essere critico nei confronti degli Stati Uniti. Corea del Nord, Libia, Iraq e Iran avevano tutte le caratteristiche richieste per essere degli stati canaglia. L’Amministrazione Bush passò alla dizione Asse del male, un appellativo che fu usato per la prima volta da G. B. Bush durante il Discorso dell’Unione tenuto nel gennaio del 2002. Nella visione di Bush il comportamento di questi paesi non poteva cambiare perché era implicito nella loro natura malvagia. Nel 2010 Obama ha definito l’Iran e la Corea del Nord “outliers”, suggerendo così che questi paesi possono adottare comportamenti accettabili, anche mantenendo gli attuali regimi. Si veda Robert S. Litwak, From “Rogues” to “Outliers”, the Globalist, 4/5/2010 http://www.theglobalist.com/storyid.aspx?StoryId=8438 10 The United States is a Leading Terrorist State”; Una intervista con Noam Chomsky di David Barsamian; monthlyreview.org/2001/.../the-united-states-is-a-leading-terroriststate. 11 US Intelligence Council (2010), Global Trends 2025. 12 Joseph S. Nye, The Future of Power, Public affairs, New York, 2010. 13 Discorso sullo Stato dell’Unione tenuto da Obama nel gennaio del 2010. 15 Michele: A chi ti riferisci? A Martin Jacques e Ian Morris? 14 Mario: Sì, anche se a dire la verità di Jacques mi sono limitato a guardare il video su Youtube 15 e il libro do Morris non l’ho letto tutto: settecento pagine sono molte anche per uno come me che ama i libri di storia. Comunque, se ho ben capito, Jacques sottolinea che il sorpasso della Cina presenta elementi totalmente nuovi: per la prima volta la leadership mondiale sarebbe presa da un paese in via di sviluppo e che appartiene geograficamente all’oriente. Sul primo punto non ci sono dubbi. Sul secondo, invece, Ian Morris, anche lui Professore di storia, ma presso l‘Università di Stanford in California, ha sostenuto che negli ultimi 15.000 anni l’Occidente ha mantenuto la leadership fino al 550 d.C. quando il testimone passò alla Cina per i successivi 1.200 anni. A quel punto, siamo all’inizio della rivoluzione industriale, l’Occidente tornò in testa e ci dovrebbe rimanere fino al 2103. John: Quindi, stiamo vincendo per quattordici millenni a uno. Ma c’era bisogno di risalire a 11.000 anni prima di Adamo, di Eva, e del serpente 16 per capire quello che sta succedendo adesso? Mario: Morris sostiene che per cogliere “la forma della storia” bisogna cominciare dall’inizio. John: E la straordinaria precisione nel fissare la data del prossimo sorpasso? Tarocchi o sfera di cristallo? Mario: Morris insegna a Stanford non a Hogwarts 17. La “precisione” delle sue previsioni dipende dalla trovata fondamentale del libro: utilizzare un indice di sviluppo che misuri la capacità delle varie società di padroneggiare l’ambiente fisico e intellettuale che le circonda. Michele: Si tratta di una scelta che consente di raccontare la storia del mondo come una gara fra Ovest ed Est sul filo di una sola variabile, un fantomatico indicatore di sviluppo. A me sembra però che il concetto di sviluppo utilizzato da Morris sia poco convincente. Il suo indice –che si basa su quattro indicatori che riguardano l’energia, l’organizzazione sociale, la tecnologia dell’informazione e la capacità di fare la guerra- misura forse la capacità o la potenzialità di dominare in campo economico e militare il mondo circostante, ma ciò non coincide con quello che normalmente intendiamo per sviluppo. Sarà pure vero, come dice Morris, che gli uomini sono tutti uguali da sempre, ma le società alle quali hanno dato vita, no. Esse sono cambiate nel tempo e sono sempre state diverse fra loro anche nello stesso periodo. Pretendere di catturare tale varietà di livelli e tipologie di sviluppo (sociale, economico, culturale, educativo, psicologico, ecc.) con un solo numero è, a dir poco, superficiale. Se la comprensione di tutto ciò che è complesso (e io credo che la complessità non sia una novità del nostro tempo, l’uomo e le sue società lo sono sempre stati) richiede un processo di semplificazione, è anche vero che oltre un certo punto la semplificazione falsa e 14 Martin Jacques (2012), When China rules the World. The end of the Western World and the Birth of a New Global Order; seconda edizione; Penguin books, (prima edizione 2009); Ian Morris (2010), Why the west rules – for now, Profile Books. 15 http://www.youtube.com/watch?v=Og8zBhDDkEQ 16 Come Ian Morris, anche l’Arcivescovo James Ussher amava adottare metodologie quantitative e nel 1650 pubblicò gli Annales Veteris Testamenti, in cui certificò che Dio aveva creato l’Universo il 23 ottobre 4004 a.C. e, in questo facendo meglio di Morris, indicò anche l’ora esatta: le 12 in punto. Ovviamente non sono mancate le critiche e altri autori hanno fornito date alternative come il 5199 a.C. e del 3760 a.C. Comunque mi sembra rassicurante il fatto che l’intervallo tra le varie stime non sia molto ampio. 17 Per chi avesse perso l’occasione di leggersi la saga di Henry Potter, Hogwarts è la sede della più famosa facoltà di magia della Gran Bretagna. 16 tradisce la realtà che vuole catturare. Così ciò che io ho gradito di più nel libro di Morris è stata la ricchezza delle informazioni e l’interesse delle storie che racconta. Mario: Come direbbe Confucio, sic transit Morris 18. John: Ragazzi, a me tutta questa discussione sembra impostata male; credo che stiamo dimenticando un punto fondamentale. So anch’io che l’economia cinese sta crescendo più rapidamente di quelle occidentali, un fenomeno che d’altra parte si registra in molti paesi in via di sviluppo. E’ anche evidente che la Cina sta assumendo un ruolo e un peso sempre più rilevanti sulla scena internazionale. Ma c’è qualcos’altro che succede in quel paese e che è evidente a chiunque lo visiti anche per pochi giorni. I cinesi si stanno occidentalizzando; la crescita economica e lo sviluppo sociale li stanno rendendo sempre più simili a noi nel comportamento e nei valori. Perciò questa differenza tra occidente e oriente è del tutto fasulla. Noi, la nostra civiltà, abbiamo vinto per definizione perché alla fine saranno la nostra cultura, i nostri principi, i nostri valori a prevalere. Insomma, come si usa dire per gli abitanti di Hong Kong, anche i Cinesi dell’entroterra diventeranno come le banane: gialli fuori, bianchi dentro. Mario: Caro John, Jacques sostiene proprio l’opposto e a me pare che i suoi argomenti siano convincenti. Secondo lui, l'American way of life non è né il mito, né l’obiettivo dei Cinesi. Insomma la Cina non è occidente e non vuole diventarlo. A prima vista può sembrare che il consumismo, oggi imperante e strumentalizzato dal governo cinese per tenere alto il tasso di crescita della produzione in una fase in cui la domanda estera sta drammaticamente calando per effetto della crisi globale, sia portatore e indice di una omologazione alla cultura, o meglio ad un certo tipo di cultura, occidentale. Così non è. A sostegno di questa tesi, Jacques cita tre differenze fondamentali tra noi e la Cina. John: Che sono? Mario: La prima riguarda la natura dello stato. La nostra identità si basa su principi e valori piuttosto recenti introdotti dall'illuminismo nel XVIII secolo. I cinesi, invece, si definiscono e si sentono tali facendo riferimento a una civiltà che risale per lo meno al terzo secolo a.C., ma che affonda le proprie radici in un passato ben più lontano. Nel 221 a.C., Qin Shi Huang, per intenderci quello dei guerrieri di terracotta, della prima grande muraglia 19 e dell’ancora inviolato tumulo sepolcrale, diede vita all’Impero cinese sconfiggendo ed occupando gli stati confinanti. Pertanto, a differenza di noi, la Cina ha le proprie radici in un passato lontano, in una lunghissima tradizione culturale, è uno “Stato Civilizzazione”. In secondo luogo, gli stati europei sono il risultato di processi di disgregazione: in Europa si è passati da vasti imperi a stati relativamente piccoli. La Cina ha seguito il percorso opposto e le numerose dinastie che si sono succedute sul trono dell’Impero Celeste, pur con alti e bassi, hanno progressivamente ampliato il territorio da esse controllato. La terza differenza tra la Cina e i paesi occidentali riguarda il modo in cui guardiamo allo stato. Date un’occhiata ai giornali che abbiamo comperato questa mattina. Lo sport principale della stampa italiana, ma 18 L’espressone completa è “Sic transit gloria mundi” che letteralmente significa “Cosi passa la gloria del mondo”, una frase che viene spesso usata per indicare come siano effimere le cose di questo mondo. Per i più curiosi, l’espressione è tratta dalla Imitazione di Cristo, un’opera medioevale fortemente consigliata a chi voglia conoscere la via da percorrere per raggiungere la perfezione ascetica. Il testo, normalmente attribuito al monaco tedesco Thomas da Kempis, potrebbe aspirare a un Guinness per essere il libro più letto dopo la Bibbia. Presenta anche un’interessante analogia con il libro che state leggendo: anch’esso è scritto sotto forma di dialogo. Tornando all’espressione incriminata, essa è stata usata, invero con un’efficacia molto modesta, nelle cerimonie d’incoronazione dei papi tra il 1409 e il 1963. 19 La costruzione della Grande Muraglia fu proseguita da altre Dinastie e soprattutto dai Ming fin quasi alla fine del XV secolo. 17 forse anche una delle sue principali ragioni di esistere, è quello di analizzare criticamente le azioni del governo, di qualunque governo. In Cina, per la stragrande maggioranza dei cittadini, ciò non ha molta importanza. Per i cinesi lo Stato è il capo-famiglia delle ormai perdute tradizioni, il padre che ci ama e che, conoscendoci profondamente, sa qual è il nostro bene e lo persegue senza che noi ci si debba preoccupare. In sostanza, lo stato cinese gode di una legittimità molto maggiore e ciò da ben prima della comparsa del partito unico, ben prima di Mao. Michele: Mi ricordi un episodio che mi è successo ormai tanti anni fa quando studiavo in California. Un giorno un amico indiano che studiava per conseguire un dottorato in ingegneria mi disse che doveva tornare a casa per sposarsi. Gli chiesi chi era la promessa sposa e lui mi confessò candidamente che non la conosceva e che non l’aveva mai vista di persona; l’aveva scelta la sua mamma. Gli domandai se era matto a sposare una donna che non aveva mai visto e che non amava. Lui molto tranquillamente mi rispose che la sua mamma lo conosceva bene e che sicuramente aveva scelto la ragazza giusta; l’amore sarebbe venuto col tempo. Mario: Fatemi finire la tesi di Jacques. Un'altra differenza rilevante riguarda l’omogeneità etnica. Oltre il 90% della popolazione cinese appartiene all’etnia Han 20. Michele: A me pare che ciò abbia valenze sia positive, sia negative. Da un lato, l’omogeneità etnica è uno dei collanti fondamentali dello stato cinese; dall’altro, contribuisce a creare, diciamo così, un senso di superiorità che oggi è alimentato anche dai successi conseguiti negli ultimi trenta anni sul piano economico e politico e dal fatto che le sconfitte del passato non siano state ancora del tutto digerite 21. Per essere espliciti, il razzismo non è un problema solo dell’occidente. Li: Non è facile dimenticare ciò che hanno fatto i giapponesi, prima e durante la seconda guerra mondiale, quando anche adesso, dopo quasi 70 anni dalla fine del conflitto, i loro governi continuano a non mostrare la minima sensibilità su questi temi; senza parlare del fatto che non vi sia stato alcun gesto di pentimento rispetto agli orrori di cui le truppe giapponesi si sono macchiate. E non parlo solo delle stragi perpetrate a Nanchino e in altre città, ma dell’aver usato le nostre donne come confort women, per usare un eufemismo, e dell’aver condotto orrendi esperimenti medici e chimici su prigionieri cinesi 22. Michele: Li, su questo hai tutta la mia comprensione. Lascia, tuttavia, che ti confessi che io, da bianco normalmente non esposto al problema, ho capito cosa fosse il razzismo proprio in Cina, tanti anni fa, passeggiando per Guangzhou con una ragazza cinese. Fui circondato da 20 Vi sono solo due province nelle quali gli Han non sono la maggioranza: lo Xinjiang e il Tibet, entrambi al centro di gravi disordini negli ultimi anni. 21 Si pensi alla tensione fra i due paesi generata dalla disputa su alcune isole disabitate (le isole Senkaku per i giapponesi e Diaoyu per i Cinesi) del Mar Cinese Orientale, attualmente sotto l’amministrazione giapponese e i sensi di rivalsa riaccesi ogni anno dalle visite di uomini politici al tempio schintoista di Yasukuni dove si venerano i caduti di guerra giapponesi, fra i quali vi sono alcuni criminali di guerra. 22 Li si riferisce agli orrendi esperimenti (incluse vivisezioni) condotti da medici giapponesi su prigionieri cinesi, ma non solo, tra il 1937 ed il 1945 presso la Unità 731 che operava nella città di Harbin sotto il comando del generale Shiro Ishii. Alla maggior parte degli “scienziati” coinvolti gli Stati Uniti concessero l’immunità in cambio d’informazioni sugli strumenti di guerra biologica che erano stati sviluppati presso l’Unità 731. Come scrisse a Washington il generale Douglas MacArthur, comandante in capo delle Forze Alleate: “Forse potremo ottenere dati aggiuntivi, possibilmente dalle dichiarazioni di Ishii, informando i giapponesi coinvolti che le informazioni rimarranno nei canali dell’intelligence e non verranno utilizzate come prove di “Crimini di Guerra”. Un accordo in questo senso fu raggiunto l’anno seguente. Harris, Sheldon H. Factories of Death: Japanese Biological Warfare 1932-45 and the American Cover-Up, Routledge, 1994. ISBN 0-415-09105-5 ISBN 0-415-93214-9. 18 un gruppo di uomini che non gradivano che una loro compatriota andasse in giro in atteggiamento affettuoso con uno straniero e sembravano decisi a farmi passare la voglia di un matrimonio misto. Fu la mia amica a convincerli che non era il caso di mandarmi all’ospedale, ma non fu facile. So per esperienza personale che, per quanto riguarda i bianchi, le cose sono cambiate, almeno nelle grandi città. Tuttavia, anche stando a recenti articoli sul China Daily sono rimaste più o meno le stesse nei confronti dei neri. Li: Hai ragione; non c’è dubbio, in Cina c’è ancora molto razzismo. John: Vediamo di ricapitolare quello che ha raccontato Mario. Secondo Jacques, lo stato cinese è destinato a prendere la leadership del globo prima di aver raggiunto un elevato livello di sviluppo e mantenendo una propria diversa e specifica identità che non sarà modificata più di tanto dalla crescita economica e dallo sviluppo sociale. Infatti, essa affonda le proprie radici in un passato lontano. Inoltre, lo stato cinese è etnicamente omogeneo - o forse più realisticamente sta omogeneizzando senza fare troppo rumore i suoi diversi - e il suo governo gode di una legittimità sconosciuta nei nostri paesi. Sono però convinto che ci vorrà molto tempo perché gli occidentali si fidino dei cinesi come si sono fidati di noi. Michele: Bella forza! Siete stati capaci di fare il lavaggio del cervello a mezzo mondo. Voi e la vostra industria cinematografica siete riusciti a venderci una lunga serie di miti fasulli e razzisti a partire dall’epopea del Far West (oggi la si definirebbe una pulizia etnica), per continuare con le guerre contro i cosiddetti musi gialli, per finire, come dicevamo prima, con gli stati canaglia produttori di petrolio. Forse sarebbe ora che gli Stati Uniti si sdraiassero su di un lettino e cercassero di guardarsi dentro in maniera onesta, come suggerirono gli studenti nel lontano ‘68. E poi, a dire la verità, non so in quanti continuino a fidarsi degli Stati Uniti con le loro armi intelligenti, i loro droni, ma soprattutto con il loro perbenismo bigotto. John: Ah. Adesso capisco perché porti solo camicie a fiori … Li: Sentite, mi sembra che stiate facendo un dialogo sui massimi sistemi. Se la Cina prenderà o meno la leadership mondiale, che tipo di leader sarà e come governerà il mondo sono certo domande interessanti. Suppongo però che la leadership mondiale richieda la supremazia anche in campo tecnologico e militare e certamente coinvolga anche valori e aspetti culturali. A me sembra che la premessa fondamentale necessaria, anche se certamente non sufficiente, sia però rappresentata dal raggiungimento della leadership economica. Sono anche convinto che questo sorpasso avrà importanti implicazioni psicologiche sia per noi, sia per gli americani, sia per tutti gli altri paesi del mondo. Insomma, si tratta di qualcosa che potrebbe aprire una nuova fase della storia umana. Vi confesso, tuttavia, che non mi è del tutto chiaro se stiamo parlando di una previsione basata su fatti o sia noi cinesi, sia voi occidentali, stiamo semplicemente dando voce a speranze e timori. Crescita della produzione e sorpasso economico Michele: Supponiamo che vi siano due ciclisti e che quello più indietro stia cercando di raggiungere quello davanti. L’inseguimento sarà coronato da successo se l’inseguitore saprà mantenere una velocità più elevata. Il tempo che impiegherà per raggiungere il corridore in testa dipenderà dalla distanza e dalla velocità relativa. Ora, nel nostro caso, la distanza è data dalla differenza tra il Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti e della Cina, mentre la velocità dei due paesi è misurata dalla crescita percentuale dei rispettivi Prodotti Interni Lordi. Il problema è che l’economia non è come la fisica. I fisici sanno calcolare esattamente quanto tempo impieghi una sonda spaziale per raggiungere Marte perché possono prevedere con 19 grande precisione la distanza tra Marte e il centro di lancio del satellite in qualunque momento futuro, conoscono la traiettoria e la velocità con cui Marte si sposta nel cielo e possono programmare la traiettoria e la velocità della sonda. I modelli degli economisti non hanno certo capacità analoghe. Li: E allora? Michele: Lascia che ti racconti una barzelletta. Su un’isola deserta ci sono un fisico, un chimico e un economista. Un giorno un improvviso colpo di fortuna: i tre trovano una grossa scatola di tonno, ma non hanno nessuno strumento per aprirla. Il chimico dice: “Sono certo che su questa isola ci sono delle sostanze che mi possono consentire di costruire un solvente che sciolga il coperchio della scatoletta”. Il fisico dice: “Se metto questa pietra su quella roccia e la faccio cadere sulla scatoletta con la giusta inclinazione, penso di riuscire a far saltare il coperchio”. L’economista dice: “Supponiamo di avere un apriscatole”. Li guarda Michele con aria attonita e non ride. Michele: OK. Questo è un tipico problema culturale. Anch’io non ho mai trovato una barzelletta cinese che mi facesse ridere. Comunque, quello che volevo dire è che, in assenza di modelli capaci di predire la crescita del Prodotto Interno Lordo dei due paesi per i prossimi trenta anni, l’unica cosa che gli economisti possono fare è formulare delle ipotesi e quindi delle previsione sostanzialmente “naso metriche” basate sulle tendenze passate e le percezioni dello studioso che le effettua. Ovviamente quello che succede è che quasi ogni economista che si cimenta in questo gioco esce con delle ipotesi e quindi dei risultati diversi. C’è un ulteriore problema che è quello di scegliere quale Prodotto Interno Lordo utilizzare così da rendere confrontabile la produzione dei due paesi. Li: Suppongo che comunque si parta dal fatto che negli ultimi anni il Prodotto Interno Lordo della Cina sia cresciuto molto più rapidamente di quello degli Stati Uniti e la distanza si sia ridotta. Ad esempio abbiamo già raggiunto e superato il Giappone. Michele: Esatto. Però, tanto per darti un’idea del problema, secondo molte fonti il sorpasso del Giappone sarebbe avvenuto solo di recente. Secondo altri autorevoli esperti, il sorpasso si sarebbe invece verificato una ventina di anni fa. Sentite preferirei discutere questo tema avendo più informazioni fattuali. Non posso andare a memoria. Che ne direste di continuare questa sera davanti ad un aperitivo. Questo mi lascerebbe il tempo per documentarmi un po’ meglio. Stesso posto verso le sei di sera; i nostri quattro amici hanno ordinato prosecco e stuzzichini. Li: rivolgendosi a Michele e Mario: Vedo che siete venuti armati di computer. Da Michele me l’aspettavo, ma tu Mario ... Mario: Aspettati ben altro. Siamo solo all’inizio. Ti sorprenderò! Michele: Ho scaricato alcuni dati e preparato una simulazione che ci potrà aiutare a capire meglio il problema del sorpasso. In fondo, non c’è niente di male se anche noi proviamo a dare i numeri. 20 John: Se ho capito bene quello che hai detto stamattina, quando si affronta il problema del sorpasso, ci sono due problemi: il primo riguarda quale misura della produzione usare; il secondo le ipotesi sui tassi di crescita. Misure alternative della produzione: il PIL a prezzi correnti e il PIL a prezzi costanti Michele: Purtroppo alcuni aspetti tecnici non possono essere evitati. Se mi permettete di fare il professore di economia per qualche minuto, comincerei con una definizione di Prodotto Interno Lordo, per gli amici PIL. Anche il PIL è una di quelle parole che è entrata nel linguaggio comune, ma questo non significa che tutti sappiano che cosa voglia dire esattamente. Li: Hai perfettamente ragione, almeno per quanto mi riguarda. Michele: Non ti preoccupare, sei sicuramente in numerosa e qualificata compagnia. Comunque, il PIL misura il valore dei beni e dei servizi prodotti da un paese, all’interno dei suoi confini, nel corso di un determinato periodo, di solito un anno. Per evitare duplicazioni, nel calcolo del PIL si considerano solo i prodotti finali destinati al consumo, all’investimento o alle esportazioni. John: Puoi fare un esempio? Michele: Supponiamo che il paese di Fruttilandia produca due beni: pere e mele. Vi ricorderete che alle elementari ci hanno insegnato che non si possono sommare le mele con le pere? Per calcolare il PIL lo dobbiamo fare. Per risolvere il problema basta rendere i due beni omogenei e questo risultato si raggiunge utilizzando non le quantità dei due beni, ma il loro valore. In sostanza, il PIL sarà uguale alla somma del valore delle mele e delle pere, valore che si ottiene moltiplicando la quantità prodotta per il prezzo. Nel caso descritto nella parte sinistra della Tavola 1, il PIL di Fruttilandia è uguale a 25 nell’anno A. Supponiamo adesso che, come mostra la parte a destra della stessa Tavola, nell’anno successivo (anno B) si registri un aumento sia delle quantità prodotte, sia dei prezzi cosicché il PIL di Fruttilandia sale a 42. L’aumento è dovuto alla crescita sia delle quantità, sia dei prezzi, cioè all’inflazione. Tavola 1- Fruttilandia; Prodotto Interno Lordo a Prezzi correnti; anno A e anno B Anno A Anno B Quantità Prezzo Valore Quantità Prezzo Valore Mele 5 2 10 6 3 18 Pere 3 5 15 4 6 24 PIL 25 42 Mario: E’ possibile distinguere il contributo delle due componenti? Michele: Certo. In primo luogo ricalcoliamo il PIL dell’anno B utilizzando i prezzi dell’anno A, cosi da annullare l’effetto dell’aumento dei prezzi (Tavola 2). Il PIL (adesso a prezzi costanti) sale a 32 e ciò ci consente di concludere che la quantità di frutta prodotta in Fruttilandia è aumentata del 28 per cento. John: E l’inflazione? Michele: Per calcolare il tasso d’inflazione, vale a dire la crescita percentuale dei prezzi, basa calcolare la differenza percentuale tra il PIL a prezzi correnti dell’anno B e il PIL a prezzi costanti dello stesso anno: (42-32)/32 *100 = 31 per cento 21 Adesso sappiamo che la produzione è aumentata del 28 per cento e i prezzi del 31 per cento. Tavola 2 - Fruttilandia; Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti dell’anno B Mele Pere PIL Quantità 6 4 Prezzo 2 5 Valore 12 20 32 Li: Scusami Michele, non capisco perché ci dobbiamo sorbettare questa roba, anche se è meno complicata di quello che credevo, per discutere il problema del sorpasso. Il PIL a Parità di Potere d’Acquisto Michele: Il problema che abbiamo è quello di confrontare la produzione di paesi diversi nei quali non solo si producono quantità diverse degli stessi beni, ma anche i prezzi sono diversi. La soluzione consiste nel misurare la produzione di tutti i paesi con gli stessi prezzi, normalmente quelli degli Stati Uniti, ed esprimere il tutto in dollari. In questo caso si parla di Prodotto Interno Lordo a Parità di Potere d’Acquisto (PIL a PPA). Li: Mi hai dato un’idea. Un indicatore del passaggio della leadership globale alla Cina sarà l’adozione di prezzi cinesi e dello yuan per misurare il PIL, come hai detto che si chiama? Michele: A Parità di Potere d’Acquisto. Hai ragione. Se cominciassimo a guardarci intorno di questi esempi di “predominio culturale” ne troveremmo moltissimi. Potrebbe essere divertente farne una lista e poi spulciarla progressivamente, costruendo così un indice di Passaggio della Leadership Mondiale (il famoso IPLM); ma torniamo al nostro problema. Lo possiamo illustrare utilizzando i dati delle tavole precedenti. Supponiamo che i dati dell’anno A siano quelli della Cina e i dati dell’anno B quelli degli Stati Uniti. Pertanto il PIL della Cina è di 25 e quello degli Stati Uniti di 42. Supponiamo adesso di calcolare il PIL della Cina utilizzando i prezzi degli Stati Uniti. Il PIL della Cina sale a 33. Fa una bella differenza. Nel primo caso il PIL della Cina è il 59,5 per cento di quello statunitense, nel secondo il 78,6 per cento. In sostanza, la distanza da colmare è molto diversa a seconda della definizione di PIL che si utilizza, quella a prezzi correnti, cioè ai prezzi pagati dai consumatori nei loro paesi, o quella a Parità di Potere d’Acquisto in cui il valore dei beni è ottenuto usando i prezzi degli USA. Ovviamente, anche il tempo necessario per il sorpasso sarà molto diverso. John: Nella realtà le differenze sono così marcate come nell’esempio? Alcuni confronti internazionali Michele: Beh forse anche di più. Guardate queste tabelle. I valori si riferiscono al 2010. Nella prima (Tav. 3) ho riportato il PIL a prezzi correnti dei primi quindici paesi per livello di produzione. Come potete vedere gli Stati Uniti hanno un ruolo di assoluto predomino. Il loro PIL è pari a oltre il 23 per cento della produzione mondiale, il che è veramente impressionante dato che la popolazione americana rappresenta meno del 6 per cento della popolazione mondiale. Nessun altro paese ha una quota superiore al 10 per cento: al secondo posto vi è la Cina con il 9.3, al terzo il Giappone con 8,7 per cento e al quarto la Germania con il 5,2. Le quote di tutti i paesi dal quinto al quindicesimo posto sono comprese tra il 4,1 per cento della Francia e l’1,6 per cento di Messico e Corea del Sud. Inoltre, il PIL cinese è pari al 40,5% di quello statunitense, quelli di Giappone e Germania al 37,6 e al 22,6 per cento 22 rispettivamente. Passiamo alla tavola successiva dove ho riportato il PIL a Parità di Potere d’Acquisto. Lo scenario cambia in maniera sostanziale. Gli Stati Uniti rimangono naturalmente al primo posto, ma il loro “contributo” alla produzione mondiale scende sotto il 20 per cento. La cosa più interessante è però che il PIL della Cina è adesso pari a quasi il 70 per cento del PIL statunitense ed è 2,3 volte quello del Giappone. Notate poi che l’India sale dal nono al quarto posto, la Russia dall’undicesimo al sesto, il Messico dal quattordicesimo all’undicesimo. Insomma la classifica diventa molto più favorevole ai paesi in via di sviluppo. Mario: Colpisce vedere la Germania superata dall’India, il Regno Unito dalla Russia, la Francia e l’Italia dal Brasile. Si tratterebbe di un G8 ben diverso da quello attuale! Li: Mi sembra di aver capito, ma preferirei che me lo spiegassi ancora una volta, perché usando il PIL a Parità di Potere d’Acquisto la differenza tra la produzione cinese e quella statunitense si riduce in maniera così pronunciata. Tav. 3 – PIL nominale dei primi quindici paesi; valore assoluto e percentuale rispetto al PIL mondiale e al PIL degli Stati Uniti; 2010 Fonte: World Bank Michele: Sta tutto nel fatto che i prezzi degli Stati Uniti, ma anche del Giappone e degli altri paesi più sviluppati sono molto più alti di quelli cinesi e indiani e, in generale, di quelli dei paesi in via di sviluppo. Così, se prendiamo i beni prodotti in Cina e li moltiplichiamo per i prezzi ai quali sarebbero venduti negli Stati Uniti, otteniamo un valore molto più elevato di quello che si ottiene valutandoli a prezzi cinesi. Detto in altro modo, il PIL a valori correnti, cioè stimato ai prezzi di vendita in Cina, porta a sottostimare, e di molto, la produzione cinese rispetto a quella statunitense e lo stesso ragionamento vale per tutti i paesi meno sviluppati dove molti prezzi sono notevolmente inferiori. 23 Tav. 5 – PIL a PPA; primi quindici paesi; valore assoluto e percentuale rispetto al PIL mondiale e al PIL degli Stati Uniti; 2010. Fonte: World Bank Indicatori e tempi di sorpasso Li: Suppongo che ciò abbia serie conseguenze per i tempi del sorpasso. Michele: Cominciamo dal caso del Giappone. Se utilizziamo il PIL a valori correnti, la Cina ha sorpassato il Giappone nel 2009 e lo sopravanza di poco. Invece, se utilizziamo il PIL a PPA il sorpasso si è verificato nell’ormai lontano 1992 e nel 2010 la produzione del Giappone era pari a solo il 40% di quella cinese 23. Li: Insomma, abbiamo festeggiato con 17 anni di ritardo! John: Con il Giappone ce l’avete fatta, ma con noi è tutta un’altra storia e il sorpasso non mi sembra cosi scontato. Il passato è pieno di previsioni errate. Non so se vi ricordate che alla fine degli anni ’80 il Professor Paul Kennedy che insegnava a Yale 24 sostenne che il Giappone avrebbe superato gli Stati Uniti entro pochi anni. Mario: Me ne ricordo bene. Allora si faceva un sacco di formazione sulle modalità organizzative introdotte dalle imprese giapponesi. John: E poi, che cosa è successo? Il sogno è tramontato in pochi anni; l’economia giapponese è entrata in una lunga fase di stasi e invece di raggiungere gli Stati Uniti è stata superata dalla Cina. Non tutte le previsioni si avverano. Michele: John potrebbe avere ragione, ma prima di discutere questo punto proviamo anche noi a dare i numeri. Avevo pensato di preparare un gioco che volevo chiamare “Caccia agli USA”, in cui almeno per una volta John Wayne sarebbe stato la preda e non il predatore. 23 Angus Maddison and Harry X. Wu, 2008, “Measuring China Economic Performance”, World Economics, Vol. 9, n. 2, Aprile-Giugno, 2008. 24 John si riferisce a un libro di Paul Kennedy intitolato Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000, pubblicato nel 1987 dalla Random House. 24 Quello che avevo in mente era una specie di gioco dell’oca in cui un giocatore parte con un certo vantaggio e l’altro giocatore deve raggiungerlo. La particolarità di questa variante del gioco stava nel dare al giocatore in testa, alla preda, un dado con solo tre valori 1, 2, e 3, e all’inseguitore un dado con i numeri da 5 a 10. Fuori metafora, l’ipotesi è che il tasso di crescita del PIL degli Stati Uniti non superi il 3 per cento, mentre quello della Cina sia destinato a scendere progressivamente, ma a rimanere comunque sopra il 5 per cento. John: Con queste regole, la preda non ha alcuna speranza di sfuggire. L’unico dubbio è quanto tempo ci metterà l’inseguitore a raggiungerla. Michele: Proprio così. D’altra parte questo riflette la posizione della maggior parte degli esperti, incluso il tuo amico Nye. John: Sì, che però rimane molto dubbioso sulla possibilità del sorpasso visto che la Cina è ancora priva di quelli che lui definisce i soft powers, cose come Hollywood e università di livello mondiale. Michele: Forse ti sorprenderà, ma anch’io sono abbastanza scettico, anche se per un motivo al quale nessuno ha pensato finora; tuttavia di questo parleremo dopo. Alla fine il gioco può prendere una forma più semplice, quella di due grafici che servono per rappresentare l’andamento del PIL a prezzi correnti e a parità di potere d’acquisto per gli USA e per la Cina, in funzione dei rispettivi tassi di crescita, per il ventennio 2010-2030. Basta inserire il tasso medio di crescita della Cina e il tasso medio di crescita degli Stati Uniti per leggere sui grafici l’anno del sorpasso. Proviamo ad esempio con 2 per cento per gli Stati Uniti e 7,5 per cento per la Cina. Come potete vedere il sorpasso avverrebbe nel 2029 per il PIL a prezzi correnti e nel 2018 per il PIL a parità di potere d’acquisto. Cambiando i tassi di crescita troviamo immediatamente le nuove soluzioni. Per esempio, se il tasso di crescita degli USA salisse al 3 per cento e quello cinese scendesse al 5 per cento, il sorpasso del PIL a prezzi correnti sarebbe posticipato verso il 2050 e quello a PPA avverrebbe solo nel 2029. Com’è ovvio, la data del sorpasso si avvicina sia riducendo il tasso di crescita statunitense, sia alzando quello cinese. Li: Vuoi dire che le date del sorpasso che ci sono proposte non si basano su teorie e complicati modelli matematici, ma solo su ipotesi? Insomma, che è un vero gioco dell’oca? Michele: Mi dispiace deluderti, ma la cassetta degli attrezzi degli economisti è un po’ meno fornita di quella dei fisici e degli astronomi. Ovviamente ci sono numerose considerazioni che avvalorano, da un lato, il fatto che la crescita cinese sarà più alta di quella americana, per lo meno per i prossimi venti anni e, dall’altro, che i tassi di crescita cinesi tenderanno progressivamente a ridursi. Il primo fatto da tener presente è che la Cina è riuscita a mantenere per trenta anni un livello di crescita che nessun economista avrebbe ritenuto possibile: stiamo parlando di circa il 10 per cento, secondo l’Ufficio di statistica cinese. Tanto per fare un paragone, tra il 1990 e il 2011 il tasso medio di crescita del PIL statunitense è stato di circa il 2,5 per cento, in nessun anno la crescita ha superato il 5 per cento e in tre anni i valori sono stati negativi. John: Chi ci assicura che le stime cinesi non siano state gonfiate a scopi puramente politici? Gafici 1 e 2 – Cina e Stati Uniti; Prodotto Interno Lordo a prezzi correnti e a PPA; scenari alternativi di crescita 25 Fonte: Elaborazione su dati World Bank Michele: E’ certamente successo e ci sono casi clamorosi come quello relativo al periodo 1996-98 e, in particolare, al 1998. Secondo le stime ufficiali i tassi di crescita di quel triennio furono 10, 9,3 e 7,8 per cento, mentre stime indipendenti hanno ridimensionato quei valori a 2,1 per cento, 5,3 e a solo lo 0,3 per cento per il 1998. Comunque, anche secondo gli autori di questa drastica revisione 25, l’economia cinese avrebbe registrato tra il 1992 e il 2003 uno straordinario tasso medio di crescita del 8,7 per cento, cha ha portato a una crescita della produzione del 173 per cento in 12 anni. Notate che la straordinaria crescita economica ha consentito alla Cina di portare fuori dalla povertà circa 500 milioni di persone, cioè quasi la metà della sua popolazione. Ma la storia della Cina non è solo la storia di uno straordinario successo socio-economico. Malgrado rimanga un paese in via di sviluppo, la Cina si sta già muovendo come una grande potenza internazionale. Inoltre, il fatto che non abbia un passato coloniale e si attenga a una politica di non interferenza costituisce un grande vantaggio sul piano diplomatico, in particolare in Africa, dove la Cina cerca le materie prime di cui ha bisogno. Anche sul piano tecnologico ed organizzativo gli sviluppi sono stati impressionanti. Ormai nei lontani anni sessanta la Cina si dotò di armi nucleari, quinto paese a fare ciò dopo Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Francia. Oggi la Cina dispone di 16 impianti nucleari e ne sta costruendo altri 26 così da portare la percentuale di energia prodotta con impianti atomici da 1 a 6 per cento. Grafico 3 – Cina; Tassi di crescita del Prodotto Interno Lordo; 1992 2003 Fonte: Cina; National Bureau of Statistics; Maddison Wu Mario: Questo non mi sembra un dato positivo. Michele: Sono d’accordo con te; volevo solo sottolineare le conquiste tecnologiche. Scommetterei, ad esempio, che il prossimo uomo che poserà i piedi sul suolo lunare sarà cinese, dato che la Cina è l’unico paese che può permettersi di anteporre gli aspetti mediatici e di propaganda a quelli economici. E i fatti testimoniano che la Cina sta procedendo 25 Maddison e Wu, op. cit. 26 speditamente in questa direzione 26. Rimanendo nel campo aerospaziale, a Shangai è in costruzione un aereo di grandi dimensioni 27. L’esempio più impressionante della modernizzazione della Cina è però quello in campo ferroviario, a partire dalle nuove stazioni di Pechino e Shanghai e da treni che, viaggiando costantemente a 300 Km orari, uniscono le due città in meno di cinque ore. Inoltre la Cina ha in programma la costruzione di 14.000 km di ferrovie per l'alta velocità. Sempre in tema di trasporti, già ora la Cina ha la seconda rete autostradale al mondo e ha costruito i tre ponti sul mare più lunghi del mondo. Poi due banche cinesi sono fra le prime dieci del mondo, 61 imprese cinesi sono fra le prime 500 al mondo e nel 2010 un centro di ricerca cinese ha costruito il computer più veloce del mondo (noto come Tianhe-1°) levando il primato agli Stati Uniti. Li: Insomma non ci sono dubbi. Ci sono tutte le premesse perché prima della fine di questo decennio saremo al primo posto per livello di produzione e negli anni successivi distanzieremo gli Stati Uniti come abbiamo già fatto con il Giappone. Mario: Mettiamo pure che sia così. Però, se non vado errato, la popolazione cinese è più o meno tre volte e mezzo quella statunitense. Quindi, quando il PIL cinese supererà quello americano, il PIL pro capite dei cinesi sarà un po’ meno del 30 per cento di quello dei cittadini statunitensi. John: Bravo Mario. La strada è ancora lunga e credo che la Cina farà in tempo a cadere nel caos politico prima che quel giorno arrivi. Le misure del benessere Mario: Guarda John che le mie motivazioni nel sollevare questo argomento sono diverse e potrebbero coinvolgere anche una diversa valutazione della situazione nel tuo paese. Tutte queste disquisizioni sul PIL ci portano a dimenticare, da un lato, le modalità con le quali questo indicatore viene costruito e, dall’altro, i problemi di distribuzione del reddito. C’è sempre il rischio che un aumento della ricchezza sia accompagnato da un aumento dell’infelicità e che nel contempo milioni di bambini continuino a morire di fame. Li: Non in Cina John: Viva il capital-comunismo che darà a tutti una Ferrari o una Lamborghini, a scelta. A proposito avete già deciso se comprerete prima la Ferrari o la Lamborghini. Io vi consiglierei la Ferrari, per via del colore. Poi potreste suggerire ai figli dei vostri leader di guidare solo Ferrari per fare pubblicità ai prodotti cinesi nel mondo. Altro che ventaglietti per cocktail e t-shirt! Li: John, come diceva Confucio: “Non di solo pane vive l’uomo” 28. Per i cinesi sarebbe già una bella soddisfazione riuscire a produrre più degli Stati Uniti. Non ti devi dimenticare che trenta anni fa nessuno avrebbe scommesso neanche uno yuan su questo sorpasso, che adesso tutti danno per scontato. 26 Il riuscito attracco di una navicella a una stazione spaziale rimane un passo significativo nella storia della tecnologia cinese anche se americani e russi riuscirono in questa impresa oltre trenta anni fa. 27 Si tratta del C919 che dovrebbe poter ospitare 190 passeggeri e rivaleggiare con il Boeing 737 e l’Airbus A320. 28 Non mi è stato possibile verificare se Confucio l’abbia detto o solo pensato. La cosa è irrilevante in quanto credo che tutti gli uomini abbiano sempre provato il bisogno di qualche cibo ”spirituale”, anche se non necessariamente divino, come suggerito in modo molto limitativo dal Deuteronomia (Dt. 8.3) dove si legge: “(Dio) ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, \ per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore”» (Dt 8,3). Secondo Matteo e Luca (Matteo 4,4 e Luca 4,4) Gesù riprese questa frase per rispondere all’invito fattogli dal diavolo di trasformare in pane le pietre del deserto, per saziare la fame sopravvenutagli dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno. Personalmente penso che se qualcuno ha queste capacità e non le usa per sfamare i milioni di persone che muoiono di fame è privo del concetto di caritas. 27 Il PIL pro capite Michele: Ragazzi, ragazzi, un po’ di calma e di ordine. Propongo di cominciare con qualche dato sul PIL pro capite a PPA per vedere come sono messi i vari paesi e, in particolare, gli Stati Uniti e la Cina; poi ci chiederemo quali siano i limiti di questo indicatore. John: Suppongo che il PIL pro capite si ottenga dividendo il PIL totale per la popolazione. Michele: Sì; normalmente per una stima della popolazione a metà anno. Di fatto parecchie organizzazioni internazionali propongono una graduatoria dei paesi per PIL pro capite a PPA 29 . La figura che vedete (figura 1) è della Banca Mondiale e ci fornisce una visione d’insieme della situazione. La Tavola 5, che viene dalla stessa fonte, vi da invece l’ordinamento e gli ordini di grandezza. La classifica è guidata da piccoli paesi quali Lussemburgo (1), Macau (2), Singapore (5), Hong Kong (8) e da paesi produttori di petrolio [Qatar (3), Norvegia (4), Brunei (7) Kuwait (10)], ma include anche la Svizzera (6). Il gruppo successivo è guidato dagli Stati Uniti con un PIL pro capite di quasi 50.000 dollari. Nell’intervallo tra i 30.000 e i 50.000 dollari troviamo, oltre a Canada, Australia e Nuova Zelanda, la maggior parte dei paesi Europei. L’Italia occupa il 26esimo posto con 33.111 dollari; un valore in linea con la media dell’Unione europea (33.014). In questo gruppo vi sono anche gli Emirati Arabi, il Giappone, le Bahamas e la Corea del Sud. Figura 1 – Paesi del mondo per livello del PIL pro capita a PPA; 2011 Li: E la Cina? Michele: La Cina si trova circa a metà della classifica, al 93esimo posto (tra la Bosnia e le Maldive), con 9.233 dollari. Ciò significa che il PIL pro capite a PPA della Cina è uguale al 18,5 per cento di quello degli Stati Uniti, al 28 per cento di quello medio dell’Unione Europea e al 26,2 per cento di quello del Giappone. In fondo alla graduatoria, ben diciassette degli 29 In particolare, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la CIA. 28 ultimi venti paesi sono in Africa e gli ultimi otto hanno un PIL pro capite inferiore a 1.000 dollari 30. Li: Insomma, mi sembra di capire che se la strada per diventare la prima potenza economica del mondo non è molto lunga e potremmo dire che la cosa è a portata di mano, ben diversa è la situazione per quanto riguarda il benessere. A occhio e croce stiamo parlando di una trentina di anni, a essere ottimisti. Tavola 5 – Reddito pro capite a Parità di Potere d’Acquisto; primi trenta e ultimi trenta paesi; 2010 Fonte: Elaborazione su dati World Bank Che cosa misura il PIL Mario: Fermo lì, mio caro Li. Il PIL non misura il benessere. Nel marzo del 1968, in un intervento pieno di pathos e divenuto famosissimo, Robert F. Kennedy sostenne che il Prodotto Interno Lordo misura tutto, tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta 31. Michele: Me lo ricordo. Fu un intervento memorabile, in linea con i sentimenti liberal della California di quegli anni. Tuttavia, Kutnetz, uno dei padri della contabilità nazionale 32, 30 Mozambico, Madagascar, Malawi, Repubblica dell’Africa Centrale, Niger, Burundi, Eritrea, Liberia, Repubblica Democratica del Congo. 31 L’intervento fu tenuto presso l’Università del Kansas il 18 marzo del 1968. Robert F. Kennedy fu ucciso tre mesi dopo. Kennedy sostenne con forza che: “Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere Americani." 29 aveva già ricordato più volte che il PIL non è una misura del benessere. Pertanto, prima di sparare a zero sul PIL, vediamo quali sono gli obiettivi della contabilità nazionale: potremmo scoprire che il problema non è l’indicatore, ma l’uso che ne viene fatto. John: Ok professore, sentiamo la lezioncina. Michele: La contabilità nazionale fornisce una stima della quantità di beni e di servizi prodotti dall’economia. Consente di conoscere la quota di reddito che è stata risparmiata (e può quindi essere utilizzata per finanziare gli investimenti) e la quota che è stata spesa in beni di consumo. Una volta nota l’occupazione, si può valutare la produttività del lavoro. La raccolta sistematica di questi dati consente di valutare l’andamento nel tempo della produzione e verificare se e come cambi la sua struttura. E’ quindi evidente che si tratta di un sistema che fornisce valutazioni strettamente quantitative e limitate ai beni di mercato, cioè quei beni che hanno un prezzo, senza alcuna valutazione della loro utilità o della loro dannosità. Come osservò lo stesso Kennedy, il PIL include anche i beni che mettono a rischio la nostra vita e le nostre società, che distruggono l’ambiente in cui viviamo o lo rendono meno attraente, che danneggiano l’ecosistema, che depauperano il pianeta di risorse non riproducibili. Di contro, non include tutti quei beni e servizi che non sono venduti sul mercato, ma che contribuiscono in maniera sostanziale al nostro benessere come il lavoro domestico, il lavoro volontario e comunque tutte quelle produzioni generate da lavoro non retribuito. Inoltre, non può per definizione tenere conto della produzione del settore informale e quindi soprattutto di una larga quota di attività femminili. In conclusione il PIL misura solo una parte della produzione, mescola il buono con il cattivo e quindi non è una misura di benessere. Mario: Io aggiungerei che questo indicatore non tiene conto in alcun modo della distribuzione del reddito che, fra l’altro, sta diventando sempre più ineguale in quasi tutti i paesi del mondo. Li: In conclusione? Michele: In conclusione, il problema non è la contabilità nazionale, che credo svolga onestamente il compito di fornirci alcune importanti informazioni sul livello e l’andamento di produzione, produttività, investimenti, commercio internazionale, ecc., ma l’uso a dir poco estensivo, disinvolto e spesso inappropriato d’indicatori come PIL e PIL pro capite. Mario: Supponiamo che il governo italiano decida di erigere un mausoleo, o meglio un grande lingam a Berlusconi. Ciò aumenterebbe il PIL, ma qualcuno dei soliti comunisti prevenuti potrebbe pensare che il monumento distolga risorse da investimenti che avrebbero un impatto più costruttivo sullo sviluppo socio-economico del paese. Michele: Certo, il Pil non distingue il reddito prodotto scavando buche per terra e poi riempiendole, erigendo giganteschi lingam in onore del Presidente Berlusconi o mostruosi alberghi in località incontaminate, da un lato, e il reddito generato dalla costruzione di scuole, dal miglioramento del sistema dei trasporti, da investimenti in educazione e ricerca, o comunque da tutte quelle spese che contribuiscono a elevare lo sviluppo di un paese, dall’altro. Mario: Rimane da capire come mai questo indicatore, nato con obiettivi limitati e ben definiti, abbia finito con acquisire un ruolo così importante tanto da dominare i comunicati 32 E’ stato Simon Kutnetz a sviluppare, all’inizio degli anni trenta, il primo insieme di misure del reddito nazionale. 30 televisivi, gli articoli di giornale, i confronti internazionali e continui ad oscurare l’uso di indicatori che potrebbero fornire una visione più a tutto tondo della realtà socio-economica. Michele: Onestamente non so quale sia la risposta: posso solo speculare insieme a voi. La seconda metà del XX secolo è stata dominata da una cieca fede nel potere taumaturgico della crescita economica, vista come il toccasana di tutti i problemi. Il PIL e il PIL pro capite incarnano meglio di ogni altro indicatore questa ideologia. John: Perché non è forse vero che la crescita economica risolve tutti i problemi di una società? “La crescita economica ci rende più alti: sovrastiamo di circa sette pollici i nostri antenati preindustriali. Ci rende più sani: oggi la speranza di vita alla nascita non è di venti, ma di settant’anni. Ci consente una maggiore quantità di tempo libero: la giornata lavorativa è oggi di otto ore e non è più vero che “l’uomo lavora dall’alba al tramonto, mentre il lavoro della donna non è mai finito”. Ci fornisce abbastanza vestiti per non soffrire il freddo, abbastanza riparo da non bagnarci e abbastanza cibo da non soffrire la fame. Ci fornisce divertimento e svago cosicché di sera abbiamo possibilità diverse da quella di accalcarci attorno al fuoco del villaggio, per ascoltare ancora una volta quel poeta cieco che viene dall’altra parte dell’Egeo raccontare l’unica storia che conosce, quella su Achille e Agamennone. Col passare del tempo quelli che erano lussi, diventano cose utili e poi necessità e ciò che era inimmaginabile persino nelle fantasie più selvagge diventa un sogno e poi un lusso” 33. Michele: Bella citazione. Che memoria! Aggiungo che alla fede nella crescita economica si unisce quella nel progresso tecnologico al quale è affidato il compito di riparare i danni collaterali, comunque giudicati ampiamente giustificati dai vantaggi che si sono ottenuti. Il risultato di questo connubio è un cocktail ideologico al quale è difficile resistere anche perché quasi tutte le previsioni catastrofiche degli oppositori della crescita non si sono avverate o se si stanno avverando hanno un impatto diffuso e differenziato sul pianeta che non consente o rende molto difficile a chi ne soffre di fare un fronte comune. Li: Sentite io sono l’unico qui che ha visto il proprio paese immerso in una profonda miseria ed è consapevole che molti suoi compatrioti si trovano ancora in una situazione spesso disperata. Per me è evidente che se la crescita economica non porta necessariamente la felicità, però aiuta a vivere meglio. Penso anche che non si possa chiedere a chi non ha neppure il minimo necessario per sopravvivere di preoccuparsi per l’ambiente e per l’esaurimento delle risorse provocato da quelli che hanno i mezzi per consumarle. L’Indice di Sviluppo Umano Mario: Sono d’accordo con te. Come diceva Confucio: “E’ facile predicare quando si ha la pancia piena e i piedi al caldo”. Mi sembra evidente che per misurare il benessere di un paese si debba necessariamente ricorrere non a uno, ma a una batteria d’indicatori che prendano in considerazione non solo gli aspetti economici, ma anche altre dimensioni della vita umana. E’ questa la strada che fu intrapresa nel 1990 dell’economista pakistano Mahbub ul Haq che costruì l’Indice di Sviluppo Umano poi adottato dal Programma della Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 34. 33 La citazione viene da una recensione di J. B. Delong al libro di B. M. Friedman, The moral consequences of Economic Growth. dhttp://harvardmagazine.com/2006/01/growth-is-good.htm 34 Alla costruzione dell’Indice contribuirono anche i lavori del premio Nobel Amartya Sen. UNDP ha regolarmente pubblicato lo Human Development Report a partire dal 1990. I rapporti presentano una visione ampia e articolata della situazione economica mondiale, dei diversi sentieri di sviluppo in cui i vari paesi si sono incamminati e delle modalità di sviluppo adottate. L’ultimo rapporto (The Rise of the South. Human Progress in a 31 Li: Com’è costruito questo indicatore? Michele: Nella sua ultima formulazione, l’Indice di Sviluppo Umano, noto come Human Development Index (HDI) è ottenuto come media di tre indici: il primo è la vita attesa alla nascita; il secondo è un indicatore di scolarità; il terzo è il nostro vecchio amico, il Prodotto Nazionale Lordo pro capite in PPA. Sulla base dell’HDI le Nazioni Unite classificano i paesi del mondo 35 in quattro gruppi composti ognuno da 47 paesi, ad eccezione del primo che ne contiene 48, quelli ad Altissimo Sviluppo Umano. Nel rapporto che si riferisce al 2012 la classifica è guidata dalla Norvegia, seguita da Australia e Stati Uniti. L’Italia occupa il 25esimo posto preceduta non solo da numerosi paesi europei, dalla Nuova Zelanda e dal Canada, ma anche da quattro paesi asiatici: Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore. Tra i successivi 23 paesi del primo gruppo troviamo poi Brunei, Qatar, Barbados, Cile, Emirati Arabi, Argentina e Seychelles. Li: E la Cina? Michele: Di fatto la situazione è simile a quella del PIL pro capite a PPA. La Cina occupa il 101esimo posto con un valore dell’ISU (0,699) di poco superiore alla media mondiale (0,694). Degli altri paesi BRICS, due sono classificati peggio (L’India e il Sud Africa, rispettivamente al 136esimo e al 121esimo posto) e due meglio: il Brasile al 85esimo e la Russia al 55esimo. Li: Mi aspettavo qualcosa di più dal mio paese. Michele: Credo che l’aspetto più interessante di questo indicatore sia la storia che ci racconta. Prendendo come punto di partenza il 1990, la Cina presenta la performance di gran lunga migliore degli 8 paesi che ho considerato. Come mostra il Grafico 4, nel periodo 19902012 l’ISU mondiale è aumentato in media ogni anno dello 0,71 per cento. L’Indicatore cinese, di contro, è cresciuto di quasi 1,9 per cento. Fra gli altri paesi la performance migliore -e l’unica a essere più pronunciata della media mondiale- è stata quella dell’India con 1,6 per cento. Il Brasile è sulla media mondiale e precede i paesi sviluppati che registrano valori intorno alla metà della media mondiale. La Russia con 0,36 per cento registra un valore analogo a quello dell’Italia, mentre il Sud Africa è buon ultimo con un valore del tutto marginale (0,06 per cento). Ancora più interessante è la situazione che emerge analizzando i due sottoperiodi (1990-2000 e 2000-2012) che il Grafico 5 ordina rispetto ai valori del periodo più recente. Nella maggior parte delle situazioni considerate, inclusa la media mondiale, la performance del secondo periodo è stata migliore. Le due eccezioni più rilevanti sono fornite da Stati Uniti e Giappone. Tra il 2000 e il 2012 la crescita dell’HDI registrata dalla Cina è stata più che doppia rispetto a quella del periodo precedente (2,28 contro 1,09 per cento). In questa fase tutti i BRICS, ad eccezione del Sud Africa, (nell’ordine India, Russia e Brasile), hanno registrato valori superiori alla media mondiale. Sorprendentemente l’Italia ha fatto meglio di Giappone e Stati Uniti, mentre la performance del Sud Africa, pur essendo leggermente aumentata, rimane quasi nulla. Diverse World, 2013) sottolinea il fatto che la crescita economica non si traduce automaticamente in un aumento dello sviluppo umano e che il progresso richiede più di un semplice aumento del relativo Indice, ma anche una più pronunciata equità nella distribuzione del reddito, modalità di consumo sostenibili e una maggiore coesione sociale. Il rapporto sottolinea la necessità di allargare il concetto di sviluppo umano dato che i risultati raggiunti nei campi della sanità, dell’educazione e del reddito non garantiscono il progresso nello sviluppo umano se le condizioni sociali ostacolano i risultati individuali e se le percezioni di progresso sono diverse. 35 L’Indice è calcolato per 185 dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite, Hong Kong e i Territori Palestinesi. 32 Li: Quindi ce la faremo a raggiungere il livello di Sviluppo Umano degli Stati Uniti? Grafico 4 – Indice di Sviluppo Umano in alcuni paesi; crescita percentuale media annua; 1990-2012 Fonte: Elaborazione su Dati UNDP Grafico 5 - Indice di Sviluppo Umano in alcuni paesi; crescita percentuale media annua; 1990/2000 e 2000-2012 Fonte: Elaborazione su Dati UNDP Michele: Credo che la domanda rilevante sia piuttosto quella di sapere quanto tempo ci vorrà alla Cina per diventare un paese di serie A. Ora, il primo gruppo di merito è incluso tra un massimo di 0,955 e un minimo di 0,805. Se questi confini non saranno modificati, alla velocità attuale la Cina dovrebbe entrare in questo gruppo verso il 2020. Insomma è pensabile che in una decina di anni la Cina diventi un paese ad altissimo sviluppo umano anche se il suo reddito pro capita sarà ancora meno di un terzo di quello degli Stati Uniti e meno della metà di quello dell’Unione Europea. C’e però da chiedersi se questo indicatore ci dia una visione alternativa a quella del PIL. Come vedete dalla Tavola sei, i due ordinamenti sono molto simili. Per i nostri otto paesi, l’unica differenza riguarda Cina e Sud Africa. Il PIL pro capite premia il Sud Africa, l’ISU la Cina. Nel complesso mi sembra che l’ISU non costituisca un passo in avanti particolarmente rilevante, anche se penalizza i paesi produttori di petrolio i cui proventi non vanno certo ai più poveri. Cosi il Qatar passa dalla seconda al 36esima posizione, il Kuwait dalla quinta alla 54esima, il Brunei dalla sesta alla 30esima, gli Emirati dalla nona alla 41esima e la Guinea Equatoriale addirittura dalla 21esima alla 136esima. Comunque, anche con questo indice si rimane lontani dalla capacità di cogliere il benessere e la dizione “Indice di Sviluppo Umano” è certamente ottimistica e fuorviante. John: Tu cosa suggeriresti? 33 Michele: Come ho già detto, credo che la realtà sia complessa, che la complessità vada accettata e anzi si debba fare uno sforzo per educare alla complessità i non addetti ai lavori, e ciò in tutti i campi del sapere. L’idea di sintetizzare il livello di benessere in un solo numero può essere attraente a livello di comunicazione, ma il prezzo che si paga è quello di trascurare l’analisi dei punti deboli e di mantenere il dibattito a un livello superficiale. Tavola 7 – Posizione di alcuni paesi negli ordinamenti in base al Prodotto Interno Lordo a Parità di Potere d’Acquisto e Indice di Sviluppo Umano; 2012 Fonte:Elaborazione su dati World Bank e UNDP L’Indice Lordo di Felicità Mario: Arrivati a questo punto lasciate che vi racconti la storia di una grande intuizione culturale che, a mio avviso, si sta trasformando in una delle iniziative più innovative nel campo della valutazione del benessere e del modo di scegliere le politiche dello sviluppo. Nel 1972 il quarto re del Bhutan Jigme Singye Wangchuck introdusse il concetto di Indice Lordo di Felicità (ILF in inglese Gros National Happiness Index, GNHI). Per il Bhutan, paese impregnato di spiritualità Buddista, non era un’idea nuova dato che già un codice legale del 1729 dichiarava: “Niente giustifica l’esistenza di un governo che non sappia dare la felicità al proprio popolo”. Se i nostri politici prendessero sul serio questa scontata perla di saggezza Buddista non so quanti governi resterebbero in piedi. Michele: Fortunatamente per loro e sfortunatamente per noi credo che la maggioranza dei politici non ne abbia mai sentito parlare. La cosa interessante è che quella che poteva essere niente più di una boutade del re di un piccolissimo paese sperduto sulle montagne himalaiane, si è trasformata in uno sofisticato strumento statistico che non solo è ora utilizzato per misurare il benessere del piccolo regno e guidarne le politiche di sviluppo, ma ha anche attratto l’attenzione di economisti e statistici occidentali. John: Mi stai incuriosendo; che cosa s’intende per felicità nel lontano regno del Bhutan? Mario: Il primo Rapporto del Centro Studi del Bhutan, relativo al 2010, non ne fornisce una vera e propria definizione 36. Osserva però che la felicità è un concetto olistico e multidimensionale; che la felicità aumenta solo se si sviluppano contemporaneamente e in maniera complementare aspetti materiali e spirituali; che non si può essere felici quando i nostri vicini soffrono, e che la felicità deriva dal servire gli altri e vivere in armonia con la natura. Il rapporto specifica poi che l’indicatore deve non solo misurare la felicità e il benessere degli individui, ma essere in grado di cogliere l’impatto delle politiche, permettere 36 Karma Ura, Sabina Alkire e Tshoki Zangmo, Ura, “Gross National Happines and the GNH Index” in John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs (ed.) (2010), World Happiness Report. 34 confronti temporali fra aree caratterizzate da situazioni climatiche, culture, accesso a servizi e mezzi di sostentamento molto diversi fra loro, come è il caso del Bhutan. Infine, la sua struttura deve permettere di promuovere un concetto di sviluppo che trascenda il soddisfacimento materiale e dia indicazioni per l’allocazione territoriale e sociale delle risorse. John: Per raggiungere tutti questi obiettivi e soddisfare questi requisiti si deve trattare di un indicatore molto complesso. Mario: Sì, l’indicatore prende in considerazione molti aspetti materiali e spirituali della vita ed è difficile fornire una breve sintesi della sua struttura. Si va dagli ambiti usuali (standard di vita, scolarità e salute) ad altri che riguardano l’uso del tempo, la governance e l’ambiente, per finire con aspetti veramente innovativi come il benessere psicologico, la vitalità delle comunità, e le differenze culturali. Inoltre, tutti i nove ambiti considerati sono misurati in maniera innovativa. John: Ad esempio? Mario: Prendiamo il caso dell’istruzione. Di solito la valutazione del livello educativo si basa sui concetti di alfabetismo (il saper leggere e scrivere), sul titolo scolastico o universitario conseguito o sul numero di anni di presenza nel sistema educativo. L’indicatore del Bhutan prende in considerazione anche la conoscenza delle tradizioni locali (leggende, feste, canzoni), la conoscenza delle modalità di trasmissione dell’AIDS e della costituzione del paese. Considera poi i valori e lo fa chiedendo agli intervistati se uccidere, rubare, mentire, provocare disarmonia nelle relazioni con gli altri e comportamenti sessuali scorretti siano giustificabili. Ancora più interessante l’introduzione dell’ambito “benessere psicologico” che è definito da quattro dimensioni. La prima è la valutazione che gli intervistati danno del loro livello di soddisfazione per quanto riguarda salute, lavoro, famiglia, standard di vita, e il rapporto vita-lavoro. La seconda è data dal saldo tra emozioni positive (compassione, generosità, comprensione, appagamento, calma) e negative (egoismo, gelosia, rabbia, paura, preoccupazione). Infine vi è la dimensione spiritualità che è misurata da quattro variabili: la valutazione soggettiva della spiritualità, la frequenza con la quale l’intervistato riflette sul suo karma, prega e medita. John: Beh è certo che qui si stanno battendo strade nuove. Ma gli abitanti del Bhutan sono felici? Mario: Il rapporto non si propone di misurare il livello della felicità del paese e di esprimerlo con un numero. L’obiettivo è di individuare quelli che non raggiungono un livello minimo di felicità e capire quali siano le cause del loro malessere materiale ed emotivo. Questa è la premessa indispensabile per poter formulare delle politiche dello sviluppo che portino sopra la soglia minima della felicità quelli che non la raggiungono o per lo meno mitighino la sofferenza di quelli che non sono felici. John: OK; comunque dammi qualche indicazione. Sono curioso. Mario: Come abbiamo visto, l’indice di felicità si basa su nove domini. La scelta del Centro Studi del Bhutan è stata quella di considerare non felici quelli che non raggiungono la sufficienza in almeno 5 di essi e marginalmente felici quelli che la raggiungono in 5. Questi due gruppi includono circa il 59 per cento dei cittadini del Bhutan, mentre solo il 10,4 per cento rientra nel primo gruppo. In conclusione, secondo il Primo Rapporto sulla Felicità, 35 relativo alla rilevazione del 2010 in cui furono intervistate 7.000 persone, circa il 41 per cento degli abitanti del Bhutan ha un livello accettabile di felicità. Graf. 6 – Distribuzione della popolazione del Bhutan per livello di felicità; 2010 Fonte: Elaborazione su dati World Happiness Report. John: Non male. Sarebbe interessante avere valutazioni analoghe per i nostri paesi. Michele: Credo che ci arriveremo visto l’interesse che questa idea sta suscitando. Comunque lo GNHI è un’altra delle tante testimonianze del ruolo crescente che l’oriente sta assumendo sulla scena mondiale, anche se non ha ancora raggiunto il livello di popolarità del Gangnam style di PSY 37. Mario: Mi sembra che gli elementi di novità siano molti. L’indicatore del Bhutan rispetta la complessità della società umana, ne valuta gli aspetti materiali ed emotivi che misura affidandosi senza timore alle percezioni individuali (forse non confrontabili fra loro, ma certamente alla base delle nostre scelte), riconosce il ruolo della comunità, delle relazioni, delle tradizioni, dei valori, della natura; ma la cosa più importante è il messaggio di cui è portatore. Per fare politiche dello sviluppo bisogna individuare coloro che soffrono e capirne il perché; disegnare e implementare le politiche che consentano loro di uscire da tale condizione. I Bhutanesi sanno che non si può essere felici se coloro che ci stanno attorno soffrono. John: E gli occidentali? Michele: Anche gli economisti occidentali si stanno cimentando nel compito di sviluppare nuovi indicatori di benessere. Nel 2009 è stato pubblicato il cosiddetto rapporto Zarkosy 38, mentre l’anno scorso è uscito il primo World Happiness Report 39. John: Roba interessante? Michele: Essendo stati scritti da alcuni dei più famosi economisti del mondo, entrambi i rapporti sono ovviamente ben informati, saggi e pieni di osservazioni intelligenti. La loro analisi ci porterebbe però fuori strada. Il problema non sono gli indicatori, ma la concezione dello sviluppo e le politiche in funzione delle quali essi sono individuati. Fin tanto che lo sviluppo dei paesi più poveri sarà nelle mani dei burocrati degli organismi internazionali che come pastori abitudinari spingono i paesi più poveri, ai loro occhi pecore riluttanti e 37 Per chi l’avesse dimenticato, si tratta del primo e per il momento unico video a superare il miliardo di hit su YouTube. 38 Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean_Paul Fitoussi, 2010, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social progress. 39 John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs (ed.) (2010), World Happiness Report 36 scarsamente intelligenti, lungo il tratturo consunto della crescita economica a tappe scandite dai livelli di PIL con l’unico obiettivo di accatastarli attorno agli stessi parametri di reddito, le prospettive di un vero sviluppo umano sono ben poche. John: Non capisco che cosa vuoi, con queste critiche da figlio dei fiori. Michele: L’accettazione delle differenze, l’umiltà di ascoltare le idee e le emozioni degli altri, la fantasia di suggerire sentieri di sviluppo coerenti con la natura e la cultura dei singoli paesi. John: Spazio alla poesia! Li: Sentite, a me interesserebbe capire quali sono le conseguenze di tutte queste chiacchiere e tornare al problema del sorpasso. Questi americani, li prendiamo o no? Mario: Quello che sto cercando di dire è che per la Cina raggiungere lo stesso prodotto pro capite degli Stati Uniti o lo stesso HDI è un falso problema perché questi indicatori non misurano né il benessere né la felicità. Michele: Sono d’accordo. Anch’io penso che la Cina non debba preoccuparsi troppo degli indicatori standard, soprattutto di quelli sintetici. Gli obiettivi andrebbero elencati e per ognuno di essi dovrebbe essere stimato il valore di partenza ed enunciato quello di arrivo. Ciò aiuterebbe a individuare le politiche, consentirebbe di monitorarle e valutarne l’impatto. Gli obiettivi non mancano, primo fra tutti ridurre la crescente diseguaglianza economica e sociale tra città e campagna e tra le province, in particolare fra quelle dove si è concentrata fino ad ora la crescita economica e le altre. Li: Forse era questa l’idea di Hu Jintao quando propose la creazione di una società armoniosa. Michele: Le parole d’ordine mi fanno la stessa impressione degli indicatori sintetici. Vanno bene come mezzi di comunicazione di massa, ma poi vorrei capire che cosa vogliano veramente dire, soprattutto quando, come in questo caso, sono usate anche in contesti sospetti 40 . Li: Sì, credo anch’io che un po’ più di concretezza farebbe bene, visto che sono molti gli obiettivi sociali che molti cinesi vorrebbero veder raggiunti. Ad esempio, potremmo smettere di fare a gara con gli Stati Unti su chi controlla di più la sfera privata, incluse le comunicazioni telefoniche e Internet, abolire prima di loro la pena di morte, combattere l’omofobia, garantire il diritto ai servizi di base a chi lascia la propria residenza per motivi di lavoro, non intervenire nelle scelte riproduttive delle famiglie, accettare l’espressione di opinioni diverse. Michele: Aggiungerei che la Cina deve accelerare lo sviluppo del sistema educativo e formativo, un passaggio indispensabile per spostare il processo produttivo verso settori a più alta intensità di capitale e per sostenere la terziarizzazione in atto. E poi, ci sono le zone rurali che accusano ancora un notevole ritardo in quasi tutti i campi. 40 Il concetto di armonia è legato alla musica che, nella visione confuciana, ha il potere di creare equilibrio negli individui, nella natura e nella società. Il concetto di una “Armoniosa Società Socialista ” cominciò a essere diffuso nel 2006 come uno degli elementi fondanti della leaderdship di Hu Jintao che indicava nella lotta alle diseguaglianze economiche e alle ingiustizie sociali uno dei suoi obiettivi principali. Di fatto il concetto è stato spesso usato dal governo cinese per giustificare la soppressione del dissenso e un accentuato controllo dell’informazione. 37 John: Ragazzi è tardi comincio ad essere stanco. Li: Fermi tutti, prima di salutarci devo chiedere a Michele perché anche lui ha dei dubbi sulla capacità della Cina di sorpassare gli Stati Uniti. Michele: Per un motivo molto semplice: la Cina sta per rimanere senza lavoratori. Li, John e Mario a una voce: Stai scherzando, lo stato più popoloso del mondo senza manodopera? Michele: Tutto è relativo. Comunque è un discorso lungo. Perché non lo rimandiamo alla prossima cena? Li: Mi stai facendo preoccupare. Spero che riusciremo a parlarne presto. 38 Perché dovremmo controllare le nascite quando possiamo aumentare le morti? Pubblicità per la Grande Caccia, dal Film di Elio Petri “La decima vittima”, 1965. Secondo dialogo - Le sfide demografiche della Cina: passato e futuro Un ristorante in riva al mare. Sotto i pini l'atmosfera pre-serale è decisamente piacevole. I nostri quattro amici siedono a un tavolo un po’ in disparte, vicino alla spiaggia, per parlare senza essere disturbati dalle conversazioni degli altri clienti. Si potrebbe pensare che Cina e Stati Uniti siano molto lontani. Stessa spiaggia, stesso mare Li: Spaghetti allo scoglio per tutti? Ci facciamo preparare anche qualche grigliata mista? John: Io direi che un paio di grigliate siano indispensabili. Mario: Che vino prendiamo? John: Che ne direste di una bottiglia di Verdicchio? Il Verdicchio arriva e mentre aspettano gli spaghetti, i nostri amici cominciano a bere e a chiacchierare. Carenza di lavoro e mobilità interna in Cina Li: Michele, è da venerdì che sto pensando come ti possa essere venuta l’idea che alla Cina stia per mancare la manodopera. Mi sembra impossibile che una cosa del genere possa accadere al paese più popoloso del mondo. Mi sono però ricordato di aver visto parecchi articoli, anche sul China Daily, che raccontano di fabbriche che non riescono a trovare operai e altri sul fatto che nelle zone di confine ci siano immigrati clandestini provenienti dal Vietnam, che lavorano non solo nelle fabbriche, ma anche nei campi 41. Tuttavia, pensavo si trattasse di fenomeni isolati dovuti all’arrivo di poveretti che non riuscivano a trovare lavoro a casa loro. Michele: Credo invece che siano le prime avvisaglie di una vera e propria tempesta. Ci sono stati anche articoli relativi a rivendicazioni per ottenere migliori condizioni economiche e di lavoro e ai risultati, in alcuni casi positivi, che ne sono derivati. Non si tratta di fenomeni casuali, ma di segnali ben precisi inviati dal mercato. Quando le persone che cercano lavoro sono molto più numerose dei posti disponibili, quando cioè l’offerta di lavoro eccede largamente la domanda 42, com’è successo per lungo tempo in Cina, chi lavora è costretto ad accettare un salario appena sufficiente per sopravvivere 43 e le condizioni di lavoro che gli vengono imposte. Se la manodopera inizia a scarseggiare, la situazione cambia. I lavoratori 41 “ Working-age population set to decline”, China Daily, 1/9/2006; “Illegal immigration from Vietnam surges in China”, China Daily, 11/04, 2010; http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/11/content_9713105.htm 42 Nel linguaggio degli economisti la domanda di lavoro è espressa dalle imprese e l’offerta dalle famiglie. 43 In questo caso gli economisti parlano di salario di sussistenza. 39 cominciano ad avere un maggiore potere contrattuale, a pretendere salari più adeguati e condizioni di lavoro più umane. John: Ma saranno fenomeni locali dovuti al fatto che i cinesi non possono muoversi all’interno del loro paese. Michele: E’ un divieto che non ha mai avuto molto effetto. L’unica conseguenza è che gli “immigrati clandestini” non hanno diritto ai servizi forniti dalle amministrazioni locali. D’altra parte, nessun paese è mai riuscito a bloccare completamente i flussi migratori, né in uscita, né in entrata. Fra l’altro, un segno dei tempi che stiamo vivendo e dei cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi venti-trenta anni è che mentre prima numerosi paesi creavano barriere quasi insormontabili –muri, fili spinati, posti di blocco e che più ne ha più ne mettaper impedire l’uscita ai propri cittadini e richiedevano un visto di uscita difficilissimo da ottenere, adesso altri paesi pongono barriere ugualmente insormontabili, inclusi muri fortificati, reti metalliche, l’esercito e la marina per impedire l’ingresso ai cittadini di altri paesi 44. Inoltre, mentre prima le misure restrittive all’uscita erano condannate come barbare e contrarie ai più normali diritti umani e civili, adesso l’atteggiamento speculare passa sostanzialmente sotto silenzio. Tuttavia, le restrizioni non sono mai riuscite a fermare chi vuole costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, soprattutto quando è convinto, molto spesso a ragione, che la probabilità di trovare un lavoro nei paesi di arrivo sia elevata. Immaginiamoci se restrizioni prive di forti sanzioni potevano funzionare all’interno di un paese dalle dimensioni della Cina e che si trova in una fase ancora iniziale del proprio sviluppo socio-economico. E così negli ultimi trent’anni più di 250 milioni di cinesi hanno abbandonato il proprio luogo di nascita per andare a lavorare nei grandi centri urbani e nelle province lungo la costa, dove l’offerta locale di lavoro era divenuta insufficiente. Come hanno sottolineato gli stessi cinesi 45, si è trattato del più grande esodo nella storia dell’umanità. Li: Noi quando facciamo una cosa la facciamo in grande. Michele: D’altra parte, caro John, mi sembra che le vostre operazioni paramilitari contro gli immigrati messicani non abbiano molto successo e che anche nel vostro melting pot nuotino più di undici milioni di clandestini 46. Vi posso comunque assicurare che in Cina la mancanza di lavoro sta per diventare un problema nazionale e non lo dico io, ma lo si deduce dai dati della Population Division. Il crollo della popolazione in età lavorativa, le conseguenze sull’offerta di lavoro e la proposta della Banca Mondiale Li: Che cos’è la Population Division? Non ne ho mai sentito parlare. 44 A partire dal vallo di Adriano e dalla grande Muraglia fino ad arrivare al muro di Berlino, i tentativi di utilizzare il settore delle costruzioni per tenere lontani gli invasori o rinchiudere i propri cittadini non sono certo mancati. Dato che alcuni dei grandi esempi storici sono diventati delle attrazioni turistiche, in altri paesi si sta alacremente lavorando per il turismo del futuro. Le iniziative di maggior respiro sono certamente quelle in corso negli Stati Uniti e in Israele. 45 National Population and Family Planning, Report on the Development of China’s Floating Population, 2010 46 Nel 2012 l’amministrazione Obama ha speso 18 miliardi di dollari in programmi volti a combattere l’immigrazione illegale. 40 Michele: E’ uno dei più autorevoli istituti di analisi demografiche del pianeta che da oltre 60 anni pubblica proiezioni per oltre 200 paesi 47. Secondo questo istituto delle Nazioni Unite, la popolazione cinese dovrebbe raggiungere un massimo di un miliardo e quattrocento cinquantadue milioni nel 2030 per poi scendere a un miliardo e ottantasei milioni nel 2100, una diminuzione del 25 per cento 48. Cosa ancora più rilevante, la popolazione tra i 15 ed i 64 anni dovrebbe diminuire del 40 per cento, scendendo da un valore massimo di un miliardo e quindici milioni, raggiunto nel 2015, a uno di 615 milioni alla fine del secolo. John: E quindi anche l’offerta di lavoro diminuirebbe in maniera vertiginosa e devastante! Li: Ci giochiamo il sorpasso? Mario: Com’è che nessuno parla di un evento così straordinario? Sembrerebbe quasi un fenomeno di rimozione. Michele: E’ un fatto che tutti i politologi e gli storici che si sono occupati del futuro della Cina e, in particolare, dell’eventuale sorpasso -sia quelli che lo vedono come inevitabile, sia quelli che prevedono esiti completamente diversi- non abbiano preso in considerazione il problema demografico. Diverso il caso degli economisti che, pur essendo consapevoli degli scenari delle Nazioni Unite e di altri organismi, sembrano ritenere che il problema possa essere facilmente risolto. L’esempio più sorprendente è fornito da un recente, voluminoso rapporto redatto dalla Banca Mondiale e dal Centro di Ricerca sullo Sviluppo del Consiglio di Stato Cinese 49. Lo studio propone che tra il 2015 e il 2030 il livello dell'occupazione diminuisca, in parallelo con le forze di lavoro, del 4 per cento vale a dire di 30 milioni. Mario: Qual è la logica di questa proposta? Michele: Questa “soluzione” ha il pregio di salvare capre e cavoli, cioè di mantenere il mercato del lavoro cinese in una situazione di pieno impiego, scongiurando, allo stesso tempo le tensioni salariali che verrebbero create dalla mancanza di offerta di lavoro. John: Stai dicendo che la Banca Mondiale ha capito che alla Cina sta per mancare la manodopera e ha suggerito un percorso programmato di riduzione dell’occupazione? E alla produzione cosa succederebbe? Michele: Ah, qui sta la trovata. Affinché i conti tornino, lo studio ipotizza che la produttività del lavoro cresca in eccesso della produzione di un ammontare esattamente uguale al calo dell’occupazione. Li: Non capisco. Potresti fare un esempio. Michele: Supponiamo che la produzione aumenti del 6 per cento e l’occupazione diminuisca dello 0,2 per cento. Per rendere coerenti questi valori bisognerà che la produttività media del lavoro cresca del 6,2 per cento. In sostanza che gli occupati rimasti riescano non solo a far fronte all’aumento della produzione, ma si prendano anche carico di quello che avrebbero prodotto i lavoratori mancanti. In conclusione, la produzione può aumentare anche se l’occupazione diminuisce purché l’incremento della quantità prodotta in media da ogni lavoratore sia tale da coprire non solo la crescita della produzione, ma anche il calo dell'occupazione. 47 La Population Division pubblicò il primo insieme di stime e proiezioni demografiche nel 1951. A partire dal 1990 I World Population Prospects sono aggiornati ogni due anni. 48 Population Division, World Population Prospects: the 2012 Revision. Highlights, 2013 49 World Bank, 2012, China 2030; Building a modern harmonious and creative high-income society, New York, The World Bank. 41 Mario: Non essere sicuro di aver capito. Michele: Facciamo un esempio numerico. Supponiamo che 10 operai producano 1.000 spillini e abbiano quindi una produttività media, cioè producano ognuno, cento spillini. Otto operai potranno produrne 1,200 se la produzione media salirà a 150 spillini. Mario: Ci sono. Quindi, se capisco bene, il calo dell’occupazione non sarebbe il risultato di una crisi economica o comunque di un fenomeno fuori controllo, ma un intervento teleguidato commisurato all’andamento demografico. Michele: Proprio così, ma non è una soluzione senza problemi. In primo luogo, se anche l’economia fosse retta da leggi immutabili, cosa che non è, di certo gli economisti non le hanno ancora scoperte. I fisici possono inviare un SUV su Marte e farlo scendere dolcemente con una procedura programmata prima della partenza dalla terra; gli economisti non sono certo in grado di guidare il PIL a loro piacimento e tanto meno il livello dell’occupazione. Lo mostra chiaramente il fatto che non solo periodi di prosperità e di crisi si succedono gli uni agli altri senza che si riesca a fare molto per evitarlo, ma anche e soprattutto il fatto che gli economisti siano divisi su quale sia la ricetta giusta per uscire dalle crisi. L’attuale dibattito su austerità e misure espansive ne è la dimostrazione migliore. Inoltre, disegnare una soluzione è una cosa, metterla in pratica un’altra. Mario: Suppongo che il Rapporto prenda in considerazione anche le trasformazioni che si verificherebbero nella struttura del sistema produttivo cinese. Michele, facendo apparire quasi per incanto il suo computer dallo zaino arancione che non abbandona mai: Speravo di evitarlo, ma a questo punto mi sembra inevitabile dare un’occhiata ad alcune tavole statistiche. Li: Lo sapevo che ci saremmo ricaduti. Michele: La tavola riassume le principali tendenze dell’occupazione per settore ipotizzate dalla Banca Mondiale da qui al 2030. Nel 2010, con circa il 38 per cento dell’occupazione totale, l’agricoltura era il settore più rilevante, seguita da Servizi e Industria. Secondo la Banca Mondiale questa situazione è destinata a modificarsi drasticamente. La quota dell’Agricoltura si dovrebbe ridurre progressivamente di oltre 25 punti percentuali, mentre la quota dei Servizi ne dovrebbe guadagnare quasi altrettanti e quella dell’Industria rimanere stazionaria. Così nel 2030 il 59 per cento degli occupati cinesi dovrebbe lavorare nei Servizi, il 28,5 per cento nell’Industria e solo il 12,5 per cento nell’Agricoltura. Insomma, in venti anni la Cina si trasformerebbe da paese agricolo in paese post-industriale. Tavola 1 – Popolazione in età lavorativa, occupati totali e per settore; valori assoluti, variazioni assolute e composizione percentuale. 42 Fonte: World Bank, China 2030. 2012 Li: Si tratterebbe di cambiamenti straordinari, ma la Cina ha saputo fare ben altro. John: E’ vero, ma credo che ci si debba chiedere se si tratti di trasformazioni in linea con quelle del passato e coerenti con gli obiettivi del governo cinese. Ad esempio, credevo che nella “fabbrica del mondo” l’industria avrebbe continuato a dare un contributo fondamentale alla dinamica dell’occupazione. Michele: Per rispondere dobbiamo guardare a quello che è successo nel passato. Mario: Va bene, ma non farla troppo lunga. Le sfide demografiche del passato Michele: Ci proverò. Nel secolo scorso la Cina è stata oggetto di una vera e propria esplosione demografica. In sessanta anni, dal 1950 al 2010, la popolazione totale è aumentata di due volte e mezzo e la popolazione in età lavorativa è triplicata. Ciò ha posto alla Cina due grandi sfide: la prima, al suo sistema educativo e della formazione tecnico-professionale, la seconda al mercato del lavoro. Li: Bravo Michele, credo si parli troppo poco di questi aspetti. Il dibattito sulla Cina rimane molto spesso ancorato a pregiudizi ideologici e si dimenticano i problemi che la Cina ha dovuto affrontare e saputo risolvere. La sfida al sistema educativo Michele: Quando il primo Ottobre del 1949 Mao si affacciò su Tian An Men per annunciare l’inizio di una nuova fase storica, la Repubblica Popolare Cinese era un paese poverissimo, ma i suoi 544 milioni di abitanti, l’85 per cento dei quali era analfabeta, ne facevano lo stato più popoloso della terra. Essi rappresentavano il 21,5 per cento della popolazione mondiale e “producevano” più di un quarto dei bambini che vedevano la luce ogni anno sul pianeta. Il numero annuo dei nati rimase costantemente sopra i 20 milioni fino al 1995 e tra il 1965 e il 1970 la media fu addirittura di quasi 29 milioni. Ovviamente, ciò si tradusse in un enorme aumento dei ragazzi e delle ragazze in età scolare. Il numero di quelli tra i 5 e i 19 anni -che corrisponde più o meno al numero dei potenziali fruitori del sistema educativo- crebbe da 162 a 357 milioni, per scendere sotto i 300 milioni solo dopo il 2005 50. Malgrado ciò, la Cina ha conseguito risultati straordinari in campo educativo. In occasione del recente censimento demografico, il tasso di analfabetismo della popolazione con oltre 15 anni era già sceso sotto il 5 per cento e gli analfabeti erano soprattutto anziani che vivevano nelle zone rurali. Alla stessa data la percentuale della popolazione con almeno un diploma di scuola media superiore era del 22,9 per cento 51, con percentuali molto più elevate nelle grandi zone urbane come Pechino (52,7 per cento), Shanghai (42,8per cento) e Tianjin (38,1 per cento). Certo la situazione non era così rosea dappertutto. Per esempio in Tibet la percentuale dei diplomati era di poco superiore al 9,9 per cento. Li: Dite quello che volete, ma questi dati mi fanno sentire orgoglioso di essere cinese, soprattutto se penso ai fallimenti della maggior parte dei paesi che erano in una situazione simile alla nostra. Ho davanti agli occhi la mia scuola elementare all’inizio degli anni ‘70. 50 In occasione del censimento la popolazione tra 5 e 19 anni era di 246 milioni. Il tasso di analfabetismo è più elevato per le donne che per gli uomini, mentre la percentuale di coloro che hanno come minimo dodici anni di scolarità è più elevata per gli uomini che per le donne 51 43 Eravamo almeno cinquanta in ogni classe e ogni settimana pulivamo le aule, cosa di cui andavamo fieri. D’inverno portavamo da casa la legna per riscaldare la scuola. Anche se spesso faceva veramente freddo, ci impegnavamo al massimo per soddisfare le aspettative della nostra famiglia. Non era certo il paradiso ma, data la situazione, era già tanto che il sistema garantisse a tutti o quasi la possibilità di imparare a leggere e scrivere. Certo, pensando all’atmosfera politica di quel periodo viene un po’ da ridere. La sfida occupazionale Michele: Tornando alle sfide demografiche, secondo i dati ufficiali, che ovviamente vanno presi con grande cautela, la Cina è anche riuscita nel quasi incredibile compito di generare una crescita occupazionale in linea con quella della popolazione in età lavorativa. Tuttavia, si sono registrate diverse fasi. Nella prima, durata fino al 1978, la Cina fu governata da una rigida economia di piano; nella seconda, ancora in corso, si è avuta una progressiva evoluzione verso un sistema di mercato. Nella prima fase non si può parlare di mercato del lavoro così come normalmente lo definiamo. L’allocazione dei posti avveniva in maniera amministrativa e rispondeva agli obiettivi della produzione e delle politiche volte a ridurre la povertà, un obiettivo che fu perseguito col cosiddetto sistema della “ciotola di ferro per il riso” che tendeva a garantire a tutti un lavoro e quindi salario e pensione a vita. Li: In quel periodo la crescita economica fu piuttosto modesta. Michele: Mica tanto. Stando ai dati ufficiali, tra il 1953 e il 1978 il PIL crebbe in media del 6,2 per cento. Non male, visto che durante quel periodo ai disastri naturali si sommarono alcune politiche socio-economiche disastrose, a partire dall’introduzione delle comuni agricole. Inoltre, sul piano politico quella fu anche la fase del grande balzo in avanti, della rivoluzione culturale e di violente lotte di potere. Il risultato fu che ad anni di crescita molto elevata si alternarono anni di profonda crisi. John: Cosa ci si poteva aspettare da una politica imperniata su di una rigida collettivizzazione dell’agricoltura e che cercò di aumentare la produzione del ferro con le fornaci da cortile. Se non ricordo male, si ricorse anche, e con risultati terribili per le popolazioni rurali, alle tecniche di coltivazione suggerite da uno scienziato russo totalmente pazzo che sosteneva fra l’altro che si potevano abituare le piante a fare senz’acqua diminuendo progressivamente l’irrigazione 52. Michele: Sì di storielle su quel periodo ve ne sono molte, inclusi i record di nuoto di Mao, il Grande Timoniere. Comunque, al di là del folklore, la strategia economica seguì un duplice binario: da un lato, aumentare la produzione agricola per sostenere il consumo urbano e le esportazioni, dall’altro sviluppare l’industria pesante per rendere la Cina indipendente dalla Russia. 52 John si riferisce a Trofim Lysenko le cui tesi in campo agricolo dominarono lo scenario sovietico dalla fine degli anni 20 fino alla metà degli anni 60. Lysenko, uno “scienziato” scalzo nato in Ucraina alla fine del XIX secolo, riuscì in maniera rocambolesca ad acquisire un enorme potere nella Russia di Stalin, potere che mantenne fino agli anni 60. Durante questi trenta anni egli condizionò in maniera drammatica la ricerca scientifica del suo paese. L’idea che lo rese famoso emerse da un esperimento condotto nel 1928 e pubblicizzato in maniera del tutto acritica dalla Pravda. Secondo Lysenko, per rafforzare le seminagioni primaverili bisognava “vernalizzare” le sementi durante l’inverno, sottoponendole al freddo e all’umidità. In seguito sostenne anche che i semi prodotti da piante vernalizzate non richiedevano più la vernalizzazione. Lysenko riusci a fare disastri non solo la Russia, ma anche la Cina dove nel 1958 Mao, affascinato dalle sue idee, impose ai contadini di quadruplicare i semi per ettaro (per poi raddoppiarli ancora l’anno successivo), di non fertilizzare i campi, di arare i campi fino ad una profondità di 1,2, 1,5 metri per favorire lo sviluppo delle radici. Il risultato fu una delle peggiori carestie che abbiano colpito l’umanità. Sul’impatto delle idee di Lysenko in Cina, si veda Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao’s Secret Famine, An Owl Book, Henry Holt and Company, New York. 44 Il sistema dell’Hukou Li: Bisogna anche ricordare che in quella fase fu introdotto il permesso di residenza che però sarebbe più esatto definire il divieto di circolazione interna, tuttora in vigore. John: Da dove venne questa idea bislacca? Li: Secondo alcuni l’hukou, così si chiama in cinese, fu ispirato dai registri di famiglia utilizzati da sempre nel mio paese per raccogliere le tasse, per la leva militare e per il controllo sociale. Ma è più probabile che l’idea sia stata suggerita dal passaporto per spostamenti interni utilizzato in Russia 53. John: E quando fu introdotto esattamente? Michele: La legislazione complessiva su questo tema fu approvata nel 1958, anche a seguito dei consistenti flussi migratori dalla campagna alla città che si erano registrati nell’anno precedente e molto probabilmente, come ha già suggerito Li, sulla scorta dell’esempio russo. Il governo cinese voleva creare una propria industria pesante. Per finanziare l’operazione e assicurare il cibo agli operai, si diede vita a un sistema di scambio ineguale tra città e campagna che richiedeva un rigido controllo dei movimenti migratori interni. D’altra parte, è evidente che il sistema del hukou forniva al governo anche i mezzi e le informazioni necessari per assicurare l’ordine sociale e il controllo politico. Li: La conseguenza peggiore del hukou fu la divisione dei cinesi in due gruppi. Il primo, largamente maggioritario, era costituito da coloro che vivevano nelle zone rurali; il secondo da coloro che vivevano in città. I membri del primo gruppo erano in buona sostanza cittadini di seconda classe: solo chi viveva nei centri urbani riceveva un lavoro dal governo, aveva accesso ai servizi sociali e, in questa prima fase, razioni alimentari. Inoltre, per spostare la propria residenza in un centro urbano, gli abitanti delle campagne dovevano chiedere una autorizzazione che veniva concessa molto raramente. I bambini erano registrati nel luogo di residenza della madre al momento della nascita e ciò predeterminava quali scuole avrebbero potuto seguire e di quali benefici sociali (assistenza medica, pensione, ecc.) avrebbero potuto usufruire. Il punto è che questi benefici erano -e in buona parte sono ancora- assenti nelle zone rurali. Mario: ma oggi è possibile cambiare la propria residenza? Li: Rimane molto difficile e le modalità variano da zona a zona. Il modo più classico è quello di sposarsi, ma anche in questo caso ci sono talvolta restrizioni relative alla durata del matrimonio. Vi è poi la possibilità di ottenere una residenza urbana competendo per uno degli hukou (pochi) messi a bando ogni anno dalle principali Università tra i propri laureati o ottenendo lavori di solito molto qualificati. E poi, per chi può permetterselo, c’è sempre la via del guanxi 54 e delle bustarelle. Insomma, anche l’hukou può essere comprato in certi casi regolarmente, più spesso sul mercato nero. 53 Si tratta della propiska, o registrazione del luogo di residenza, che fu introdotta da Stalin per controllare gli spostamenti delle persone all’interno dei vasti confini dell’Unione Sovietica. Ancora oggi, la propiska continua a complicare la vita dei cittadini russi. Per trasferirsi da una città all’altra occorre, infatti, iscriversi ad una nuova anagrafe e la procedura può trasformarsi in vero e proprio incubo burocratico. Il governo ha però annunciato che le pratiche di iscrizione anagrafica saranno presto drasticamente semplificate e il direttore del Servizio federale per le migrazioni, Konstantin Poltoranin, ha addirittura lasciato intendere che la pratica potrebbe essere abolita e che i russi potranno cambiare residenza per posta o via Internet. 54 La parola guanxi significa letteralmente relazioni, rapporti; in pratica si riferisce alla rete di relazioni che lega fra loro vari attori e si sostanzia nel reciproco aiuto. Insomma anche in Cina, una mano lava l‘altra. 45 John: Il divieto di muoversi sul territorio cinese è stata sempre applicato in maniera rigida? Li: Solo fino alla fine degli anni 70. Michele: D’altra parte i dati mostrano chiaramente che fino all’inizio degli anni ‘90 i flussi migratori furono modesti e che solo negli anni successivi le migrazioni interne divennero un fenomeno di massa. La Cina stava cominciando a cambiare! Deng e il nuovo corso dell’economia cinese Li: Beh nel frattempo era arrivato Bottiglietta Deng 55, ed era cominciato il nuovo corso dell’economia Cinese. Le sue massime hanno fatto storia e riassumono bene il suo pensiero. Mario: Com’era quella dei gatti? Li: Diceva più o meno così: non importa se un gatto sia bianco o nero, ciò che conta è che acchiappi i topi. Michele: Il 1979 segna l’inizio della trasformazione della Cina da economia pianificata a economia di mercato. In questa fase, tuttora in corso, il governo ha introdotto progressivamente una serie di misure volte a combinare pianificazione e mercato allo scopo di favorire un più elevato progresso tecnologico, aumentare la produttività e innalzare il tenore di vita. E, come abbiamo visto, i risultati non sono mancati. Ovviamente questo comportò l’introduzione del mercato anche nel mondo del lavoro. Mario: In pratica? Michele: All’inizio degli anni ’80 il governo cinese cominciò a concedere alle imprese di stato la possibilità di assumere e licenziare i propri dipendenti in maniera autonoma e di commisurare il salario alla produttività. Nel 1986 stabilì poi non solo che le nuove assunzioni avvenissero sulla base di contratti individuali, ma che tale principio fosse esteso anche ai lavoratori già presenti nelle imprese. Fu in quegli anni che la ciotola per il riso pur essendo di ferro cominciò a incrinarsi e i lavoratori cinesi dovettero cominciare a cercarsi un lavoro e a preoccuparsi di poterlo perdere. Tuttavia, nel corso degli anni ’80 il governo chiese alle imprese di stato di evitare i licenziamenti e così l’occupazione aumentò in misura notevole, malgrado il rallentamento nella crescita del PIL che si registrò alla fine di quel decennio. John: E nelle campagne? Michele: I primi interventi innovativi furono attuati proprio nelle campagne con l’introduzione dei “contratti di responsabilità”. Con questo sistema le famiglie potevano affittare un appezzamento di terra per un periodo fino a trenta anni in cambio del versamento allo stato di una data quota della produzione. La principale novità consisteva nel fatto che le famiglie contadine potevano vendere sul libero mercato, o eventualmente allo stato, la quota di prodotto che non consumavano. 55 In cinese il nome di questo straordinario leader (Xiaoping) suona simile a bottiglietta. Deng nacque nel 1905 nel Sichuan da una famiglia benestante che gli fornì un’educazione tradizionale. Visse in Francia dal 1920 al 1926 dove lavorò come operaio, conobbe il marxismo e si iscrisse al Partito Comunista Cinese che era stato fondato nel 1921. Si trasferì poi a Mosca dove continuò a studiare il marxismo e fu testimone diretto della rivoluzione. Tornato in Cina partecipò alla lunga Marcia. Piccolo di statura, oratore non certo entusiasmante, rifuggì dalla notorietà e arrivò al massimo ad essere il numero tre del partito. Nel 1976 successe a Zhou Enlai che lo aveva protetto nei complicati anni precedenti. Accusato di pragmatismo da un morente Mao, rimase nell’ombra fin al 1980. La vittoria della sua linea di pensiero fu sancita dal XII Congresso del partito comunista che si tenne nel settembre del 1982. 46 Li: I contratti di solidarietà apparvero per la prima volta nel 1981 in un piccolo villaggio dell’Ánhui per poi diffondersi con grande rapidità in tutte le province della Cina. Deng Xiaoping li definì una grande invenzione dei contadini cinesi. Michele: L’introduzione dei contratti di solidarietà determinò un aumento sia della produttività, sia della produzione. Inoltre, la possibilità di commercializzare parte della produzione, e quindi di utilizzare il denaro ricavato per fare acquisti, introdusse le famiglie contadine nel circuito monetario sia come venditori, sia come acquirenti. Tornando al processo di modernizzazione, nel corso degli anni 90 le imprese pubbliche, che all’inizio del decennio davano ancora lavoro all’80 per cento dei lavoratori dell’industria, cominciarono a essere sempre più esposte alla concorrenza del settore privato e tra il 1998 e il 2002 l’industria pubblica attraversò una fase di drastica ristrutturazione. Li: Dovevamo prepararci per entrare nell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Michele: Proprio così. Nel 2002 la Cina entra nell’Organizzazione Mondiale del Commercio e comincia una fase caratterizzata da un’ulteriore progressiva contrazione del settore pubblico, da uno straordinario aumento degli investimenti stranieri 56 e da una elevatissima crescita economica, tirata soprattutto dalle esportazione. Questa fase dura fino a quando anche la Cina comincia a risentire della crisi globale in cui ci troviamo in questo momento. Mario: Ma questo processo di modernizzazione, questa transizione da piano a mercato avrà avuto effetti negativi sul mercato del lavoro, così come è successo nei paesi dell’Est? Michele: Di fatto gli anni ‘80 sono stati uno dei periodi nei quali l’occupazione ha registrato una crescita maggiore. A ciò contribuirono sia l’industria, malgrado le imprese pubbliche cambiassero le relazioni contrattuali con i propri dipendenti, sia il settore dei servizi. Secondo le fonti statistiche ufficiali, i due settori crearono rispettivamente 5,5 e 5,8 milioni di posti di lavoro all’anno. Tuttavia, la crescita della popolazione in età lavorativa fu molto sostenuta e l’agricoltura, il mondo contadino, continuarono ad assorbire tutti coloro (e furono oltre 8 milioni l’anno) che non riuscivano a trovare lavoro nei settori moderni. Così, quando si arriva al 1991, l’occupazione in agricoltura raggiunge il proprio massimo storico con oltre 390 milioni di addetti, circa il 60 per cento dell’occupazione totale. Di certo molti di quei contadini non davano alcun contributo effettivo, nel senso che la produzione non sarebbe diminuita se essi avessero trovato un lavoro altrove. In pratica erano dei disoccupati nascosti. Tavola 2 – Occupati totali e per settore; valori assoluti (in milioni) e composizione percentuale; 1952 - 2008 Fonte: Ufficio Statistico Nazionale della Cina, Annuario statistico, anni diversi 56 Nel 2003 gli investimenti stranieri in Cina furono uguali a quasi 50 miliardi di dollari. Negli anni successivi essi sono progressivamente aumentati e, dopo una leggera flessione nel 2012, hanno raggiunto un massimo di 347 miliardi nel 2013, a dimostrazione che la fiducia nel futuro della Cina rimane, se non immutata, certamente molto alta. 47 Modello di sviluppo di Lewis e offerta illimitata di lavoro John: Quello che dici mi ricorda un modello che studiai all’Università in un corso di economia dello sviluppo, ma non riesco a ricordarne il nome. Michele: Penso che tu ti riferisca al modello di Lewis che fu pubblicato nel lontano 1954 e prese il nome dal suo ideatore, un economista giamaicano che a quel tempo insegnava all’Università di Manchester e proprio per quel lavoro vinse il premio Nobel nel 1979 57. Mario: Credevo che la Giamaica fosse specializzata solo nella produzione di velocisti! John: Si, adesso mi ricordo. Se non sbaglio l’idea di Lewis -che comunque aveva un nome reso poi famoso da un velocista- era che in molti paesi sottosviluppati la popolazione è così numerosa che i capitali e le risorse naturali del paese non sono sufficienti a dare lavoro a tutti. Allora, gli imprenditori che fanno investimenti possono pagare salari di sussistenza, fintanto che nelle campagne o nei settori informali dell’economia vi è quella che Lewis definì un’offerta illimitata di lavoro. Ciò genera un grosso vantaggio competitivo e consente all’economia di svilupparsi. Michele: John, spero che tu non sia un caso isolato. Ho sempre pensato che i miei studenti dimenticassero tutto quello di cui avevo parlato nel giro di pochi mesi. Tu mi rincuori. John: Non essere così pessimista. Ognuno di noi ricorda i propri docenti, nel bene e nel male e, se sapevano insegnare, anche un po’ di quello che ci hanno raccontato. Michele: Mi fai venire in mente che un paio di anni fa mentre camminavo in Via Indipendenza 58 vidi un signore completamente calvo, e che a me parve molto anziano, virare velocemente verso di me. Arrivatomi vicino, cominciò a stringermi calorosamente la mano. Mi disse che era stato un mio studente e che non si sarebbe mai dimenticato una cosa che avevo detto in classe. Ora, a parte il fatto che la vista di quello “studente” mi diede la sensazione concreta e spiacevole di quanto fossi invecchiato, la cosa buffa fu che io non solo non mi ricordavo assolutamente di aver mai pronunciato quelle parole (che a lui parevano così sagge e che io mi sono di nuovo dimenticato), ma mi sembrò anche impossibile averle dette. Comunque hai ragione. Anch’io sono stato molto influenzato da alcuni dei miei insegnanti e alcuni li ricordo ancora con affetto e moltissimo rispetto. La mia maestra della seconda elementare, la Signora Donnini, e il maestro Maestri che ebbi dalla terza alla quinta elementare; al Liceo la professoressa Goretti che insegnava filosofia e che faceva sembrare ciascun filosofo come qualcuno che aveva scoperto la verità assoluta per poi distruggerlo completamente nella lezione successiva; e il professor Patrizi che non insegnava arte, ma la rappresentava e mi fece capire più di ogni altro l’importanza di un approccio multidisciplinare. E poi, all’università a Firenze, il prof. Tosi con cui feci la tesi e il prof. Sartori; e negli Stati Uniti, a Berkeley, George Akerlof senza il cui aiuto non sarei mai riuscito a completare il mio dottorato; Carlo Cipolla non solo un grande storico, ma anche un vero signore italiano che faceva lezione davanti al camino della sua bella villa sulle colline di Berkeley offrendoci dei vini dell’Oltre Po pavese; e infine Benjamin Ward, che mi diceva sempre di chiamarlo Ben, ma che io non riuscii mai a chiamare se non Professore perché rappresentava ai miei occhi il Professore con la P maiuscola, colui che non ti insegna delle cose, ma come guardare alle cose. John: Ehi mi stai diventando sentimentale, al limite del patetico. 57 A.W. Lewis, 1954, Economic development with Unlimited spploies of labor”, The Manchester School of Economics and Social Studies, n. 22, pagg. 139-191. 58 Via Indipendenza è una delle strade principali di Bologna; collega il centro con la stazione ferroviaria. 48 Michele: OK. Allora lasciate che racconti una storiellina che definisce l’intelligenza che il Prof Ward cercava di sviluppare nei suoi allievi. La maestra dice alla classe:” Disegnate una testa”. Tutti i bambini cominciano a disegnare, ad eccezione di Pierino che dopo un po’ si alza e chiede: “Dal di dentro o dal di fuori?” Li: E’ finita? John: Li, non ti preoccupare, si tratta solo del solito caso di differenza culturale in campo umoristico. Ricordati che hai promesso di raccontarci delle barzellette cinesi per fare una prova contro-fattuale. Ma torniamo al modello di Lewis; è così che viene spiegato il miracolo cinese? Michele: Sì, questa è l’ipotesi prevalente e adesso la discussione verte sul fatto se questa offerta illimitata di lavoro esista ancora o se il mercato del lavoro cinese stia entrando in una situazione nella quale i salari non potranno più essere di sussistenza e finiranno con l’essere collegati alla produttività del lavoro. Insomma si discute se il mercato cinese abbia raggiunto il cosiddetto punto di svolta di Lewis, vale a dire la situazione in cui un aumento della domanda di lavoro genera un aumento dei salari 59. Li: Insomma, gli articoli sui giornali farebbero vedere che la nostra riserva di lavoro è agli sgoccioli. Comunque da qui a dire che alla Cina manca il lavoro ce ne corre. Michele: Hai ragione, ma vedrai che saprò giustificare questa affermazione. Torniamo alla nostra storia. La prospettiva introdotta dal modello di Lewis ci perrmette di dividere i sessanta anni di storia cinese che stiamo esaminando in due periodi. Nel primo, che arriva fino all’inizio degli anni 90, si assiste alla grande accumulazione di forza lavoro nelle zone rurali. Il secondo, che sta terminando in questi anni, è quello della grande de-accumulazione prodotta dalla domanda di lavoro generata dagli ingenti investimenti, effettuati soprattutto nelle regioni costiere, e dal progressivo calo delle entrate nella popolazione in età lavorativa. Mario: Spiegati meglio. Michele: Nel primo periodo la crescita occupazionale fu elevatissima, oltre 11 milioni all’anno. Quasi la metà fu però dovuta al settore agricolo e quindi soprattutto al processo di accumulazione nelle campagne dell’eccesso di offerta di origine demografica. A partire dal 1991, lo scenario cambia totalmente. La crescita occupazionale media annua scende a 7 milioni, che sono però il risultato di una crescita dell’occupazione nell’industria di 8 milioni e nei servizi di 10,5 a cui si contrappone un calo in agricoltura di 11,5 milioni. Entrando più nel dettaglio, tra il 1991 e il 1998 solo l’industria e i servizi creano posti di lavoro aggiuntivi dato che l’occupazione in agricoltura comincia a contrarsi. La crescita dell’occupazione industriale è, tutto sommato, modesta rispetto ai periodi precedenti, in media meno di 4 milioni l’anno, ed è quindi il terziario con oltre 9 milioni di posti di lavoro aggiuntivi a 59 Si veda, ad esempio, Cai Fang and Wang Dewen (2005), “Demographic transition: implications for growth”, Institute of Population and Labor Economics, CASS, Working Paper Series No.47; Cai Fang (2007), “How to deal with the future labour shortage?” China Daily; Cai Fang (2008), ”Approaching a triumphal span: How far is China towards its Lewisian turning point?”, Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 2008/09; Cai Fang (2008), ”Lewis turning point: a Coming new stage of China’s economic development”, Social Sciences Academic Press; Bruni, Michele (2011), “China’s new demographic challenge: From unlimited supply of labour to structural lack of labour supply. Labour market and demographic scenarios: 2008–2048,” Department of Political Economy, University of Modena and Reggio, Working Paper No. 643: www.dep.unimore.it/materiali_discussione/ 0643.pdf.; Bruni, Michele and Claudio Tabacchi (2011), “Present and future of the Chinese labour market. Dualism, migration and demographic transition,” Department of Political Economy, University of Modena and Reggio, Working paper No. 647. 49 mantenere alta la dinamica occupazionale. Vengono poi quattro anni nei quali la ristrutturazione delle imprese pubbliche porta a un calo dell’occupazione industriale di circa 17 milioni. Allora l’agricoltura torna ad agire come una spugna, assorbendo l’eccesso di offerta di lavoro. Superata anche questa fase e con l’ingresso della Cina nella Associazione Mondiale del Commercio, entriamo nel periodo durante il quale la Cina diventa la grande fabbrica del mondo. In dieci anni l’occupazione industriale aumenta di 76 milioni, quella nei servizi di 67, ma l’occupazione agricola perse 109 milioni. Tavola 1 – Occupati Totali e per settore; 1952-2012 Fonte: Ufficio Statistico Nazionale della Cina, Annuari statistici, anni diversi Grafico 1 – Occupazione totale e per settore; variazione media annua in milioni; valori medi annui; 1952-91 e 1991-2012. Fonte: Ufficio Statistico Nazionale della Cina, Annuari statistici, anni diversi Mario: Insomma si registra un trasferimento in massa di lavoratori dall’agricoltura ai settori moderni. Michele: Questa è l’interpretazione normale, ma le cose sono più complesse. Ciò che normalmente succede è che vi sono dei lavoratori anziani che escono dall’agricoltura per invecchiamento o morte, mentre i loro figli entrano direttamente nei settori moderni. Tornando all’esaurimento di quella che era un’offerta illimitata di lavoro, la sua causa 50 principale è certamente rappresentata dal calo delle entrate nella popolazione in età lavorativa dovuta al crollo delle nascite. La politica del figlio unico Li: Suppongo che sia il risultato della politica del figlio unico. Michele: Credo che sia difficile valutare quanti bambini sarebbero nati se la politica del figlio unico non fosse stata introdotta e io penso che i suoi effetti siano stati sovrastimati. John: Comunque, converrete con me che si tratta di una politica disumana e inaccettabile. Michele: Io credo invece che ci si debba chiedere se in certe situazioni un paese non abbia il diritto d’imporre restrizioni anche gravose ai propri cittadini quando esse siano indispensabili per costruire un mondo migliore. Insomma, a mio avviso, si trattò di una mossa coraggiosa e intelligente anche se non vi sono dubbi che in moltissimi casi fu attuata in maniera violenta e incivile, causando enormi sofferenze. John: Michele, come fai a dire queste cose? Lo sai che moltissime donne sono state costrette ad abortire con la forza e che casi di questo genere si registrano ancora? Michele: Nel tuo paese li chiamereste danni collaterali 60. Personalmente penso che si sia trattato di comportamenti inaccettabili, ma sono anche dolorosamente consapevole della situazione in cui si trovano tanti bambini che vivono in paesi la cui crescita demografica è così elevata che nessuna politica di sviluppo ne può tenere il passo e che se dovessero sopravvivere alla mancanza di cibo e di affetto dovrebbero poi affrontare una vita senza un lavoro decente e produttivo. Quando vedo bambini che vivono sui campi di rifiuti di tante megalopoli o che sono costretti ad accettare con gratitudine il lavoro a salari di fame loro offerto da grandi corporation e piccole imprese locali, la loro denutrizione, le loro malattie, la loro disperazione, credo che i cinesi abbiano dimostrato più umanità di tanti che si battono per il cosiddetto diritto alla vita, ma accettano e sostengono sistemi economici e politici che tali diritti negano a coloro che nascono e quindi non si assumono la responsabilità delle conseguenze della loro ideologia. Senza contare che in questo modo si creano generazioni di ragazzi disperati che non possono che dare poco o nessun valore alla propria vita ed essere facili vittime non solo della criminalità organizzata, spesso l’unico datore di lavoro presente sul mercato, ma anche di qualunque forma di fanatismo religioso e ideologico. Comunque, si tratta di un tema complesso la cui analisi richiederebbe molto tempo. Mario: Io vorrei invece andare un po’ più a fondo su questo tema cosi controverso. Prima di tutto pensavo che il Marxismo fosse contrario al controllo delle nascite e che originariamente la Cina si fosse schierata con forza contro questo idea. Michele: Hai ragione; all’inizio il partito comunista condannò il controllo delle nascite e giunse a vietare l’importazione di preservativi e l’aborto. Lo stesso Mao nel 1949 sostenne che la popolazione avrebbe potuto moltiplicarsi di molte volte e che la Cina avrebbe fatto fronte al problema aumentando la produzione. Nel 1965 reiterò che la crescita demografica è una cosa buona e nel 1974 denunciò le politiche della popolazione come misure imperialiste. Mario: Posizioni tutto sommato in linea con quelle di Papa Benedetto XVI. Quindi, 60 Un eufemismo che probabilmente fu usato per la prima volta durante la guerra del Vietnam per indicare il “fuoco amico”, l’uccisione di civili e la distruzione delle loro proprietà durante operazioni militari. L’espressione divenne popolare a partire dalla prima Guerra del Golfo ed è stata usata anche dalla Nato nel contesto della Guerra del Kosovo. Svolge l’importante ruolo di nascondere la drammatica e sanguinosa realtà delle operazioni militari dietro una terminologia neutra e difficile da decodificare. 51 all’inizio la popolazione cinese crebbe moltissimo. Michele: Tra il 1950 e il 1980 la popolazione cinese crebbe dell’80 per cento. Superò il traguardo del miliardo nel 1982, mentre la percentuale di bambini tra 0 e 14 anni sorpassò il 40 per cento nel corso degli anni 80. Tuttavia, alla fine degli anni 70 la crescita media annua della popolazione era scesa da un valore massimo di 2,7 per cento a meno di 1,5 per cento. Nello stesso periodo la vita attesa alla nascita era cresciuta di quasi il 50 per cento salendo a 66 anni 61, anche grazie al fatto che la mortalità infantile si era ridotta drammaticamente, scendendo dal 122 al 42 per mille. Ancora più sorprendente è il calo della fecondità totale che passa da oltre sei a circa tre bambini per donna con una velocità che non ha uguali in nessun paese del mondo. Ad esempio, nei paesi dell’Europa occidentale per ottenere questo risultato ci sono voluti 75 anni. Mario: E queste trasformazioni epocali avvennero senza alcun intervento? Michele: Non proprio. Gli interventi furono numerosi, ma contraddittori e altalenanti. A partire dal 1953, la Cina cominciò a fornire servizi di pianificazione familiare nell’ambito di un programma volto a migliorare la salute delle madri e dei bambini. Questa politica fu però bloccata nel 1958 al tempo del Grande Balzo in Avanti. In tale occasione, Hu Yaobang, segretario della Lega dei Giovani Comunisti, osservò: “Una popolazione numerosa significa una maggiore Forza lavoro”. E, preso dalla foga, aggiunse: “La forza di 600 milioni di persone liberate è decine di volte più forte di un’esplosione nucleare”. Non sorprende quindi che nel 1960 il governo cinese rimuovesse dalla sua posizione di Presidente dell’Università di Pechino il Professor Ma che aveva ricoperto tale carica dal 1951 e che nel 1914 aveva conseguito un Dottorato in Economia presso la Columbia University di New York. Il Professor Ma era responsabile di aver sostenuto, nel giugno del 1957, che un’ulteriore crescita della popolazione sarebbe stata dannosa per la Cina, una tesi che gli causò anche l’allontanamento dalla vita pubblica fino al 1979, quando fu riabilitato. Dopo la grande carestia del 1962, indotta proprio dal Grande Balzo non proprio in Avanti, il programma di pianificazione famigliare fu silenziosamente riattivato per essere nuovamente sospeso durante la Rivoluzione culturale. Il quarto piano quinquennale lanciato nel 1970 conteneva però tra i propri obiettivi un rallentamento della crescita demografica. Nel corso degli anni 70 le famiglie cinesi furono sollecitate a ritardare la nascita del primo figlio, ad allungare gli intervalli fra un figlio e l’altro e a ridurre il loro numero. 62 John: Visto il calo della fertilità che era già stato ottenuto, c’era veramente bisogno di una politica cosi violenta e in contrasto con quello che pensavano molti membri del partito? Michele: L’andamento era incoraggiante, ma non devi dimenticare che i trend demografici hanno una grande inerzia, che il numero delle donne in età fertile era aumentato quasi in parallelo con la popolazione e che il numero dei giovani in età riproduttiva sarebbe continuato a crescere in maniera impressionante ancora per molti anni. Sono anche convinto che la dirigenza cinese credesse veramente che questa politica fosse indispensabile per assicurare la crescita socio-economica della Cina. 61 In Cina all’inizio degli anni 1950 La vita attesa era più o meno uguale a quella dei paesi più sviluppati (Inghilterra, Francia, USA) nel 1850. Va sottolineato che in soli 60 anni la vita attesa della Cina ha quasi raggiunto quella di questi paesi; anche se il livello di reddito pro capite è ancora molto più basso. 62 Le citazioni sono tratte da Laura Fitzpatrick, “China’s one child policy”, Time, 27 luglio, 2009 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1912861,00.html 52 Mario: Comunque fu certamente un “salto di qualità” nelle politiche demografiche. A chi venne la brillante idea? Michele: La storia è curiosa. Dietro questa pensata ci sarebbero un certo Song Jian e un gruppo di matematici cinesi che si occupavano dei sistemi di controllo dei missili; vi furono anche alcune coincidenze abbastanza sorprendenti. Tavola 3 – Cina; Principali Indicatori demografici; 1950/55-2005/10 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision. Li: E chi è questo Song Jian? Non ne ho mai sentito parlare. Michele: Secondo la biografia ufficiale, Song è stato presidente dell’Accademia Cinese di Ingegneria e dovrebbe essere ancora membro dell’Accademia Cinese delle Scienze, anche se non sono riuscito a trovare sue notizie successive al 2000. Song studiò a Mosca dove ottenne un dottorato in cibernetica nel 1960. Tornato in Cina lavorò come ricercatore della China Aviation Industry Corporation e divenne direttore dello State Science and Technology Committee. Negli anni 70 lavora alla progettazione dei sistemi di controllo di numerosi missili, ma fonda anche una nuova disciplina che chiama teoria del Controllo della Popolazione. Fin qui la biografia ufficiale 63. Li: Non si sa nient’altro? Michele: In una recente intervista un matematico olandese, Geert Jan Olsder, ha raccontato che alla metà degli anni ‘70 fu attratto dal problema del controllo della crescita demografica. In quel periodo Olsder si trovò a bere una birra con un matematico cinese che faceva parte di un gruppo di scienziati in visita alla sua università. Il discorso finì col cadere, con grande interesse dell’ospite, su come il controllo delle nascite potesse servire per guidare la crescita demografica. Lo scienziato cinese era Song e Olsder ritiene che quella conversazione e il paper che egli spedì al collega cinese abbiano contribuito alla “nascita” della politica del figlio unico 64. Mario: Una birra densa di conseguenze. Michele: Di fatto, come ha magistralmente raccontato Susan Greenhalgh 65 in un recente volume, le cose furono molto più complicate. La tesi dell’antropologa americana -che è stata per 10 anni membro del Population Council degli Stati Uniti e che ha potuto giovarsi della conoscenza diretta di molti dei decisori politici del tempo per intervistarli personalmente- è che l’adozione della politica del figlio unico da parte dei massimi leader politici del tempo, fra cui Deng Xiaoping, segnò una svolta nel modo di fare politica. Essa si appoggiò, infatti, 63 http://www.chinavitae.com/biography/Song_Jian http://freakonomics.com/2011/11/04/the-academic-origins-of-chinas-one-child-policy/ 65 Susan Greenhalgh, 2008, Just One Child: Science and Policy in Deng’s China, Berkeley, UC Press 64 53 come abbiamo già visto, sui modelli e sulle proiezioni “scientifiche” di un gruppo di esperti missilistici che sostenevano che il problema demografico era biologico e non sociale, che era estremamente urgente, e che poteva essere controllato con strumenti simili a quelli usati per dare alla Cina una capacità missilistica. Inoltre, la Greenhalgh afferma che le radici di questa politica non affondano solo nel suolo cinese, ma anche nelle drammatiche previsioni formulate dal Club di Roma, note ai matematici cinesi a seguito della loro frequentazione di conferenze internazionali 66. John: Tuttavia, secondo i tuoi dati, all’inizio la politica del figlio unico non fu molto efficace. Michele: Proprio così. Nel corso degli anni 80 il tasso di fecondità rimase sostanzialmente costante. Il fatto è che nel 1981 entrò in vigore una legge che abbassava l’età minima per sposarsi a venti anni per le donne e a ventidue per gli uomini. Secondo la legislazione precedente, l’età minima era di 23 e 25 anni nelle zone rurali e di 25 e 28 in quelle urbane. Questa norma provocò un notevole aumento dei matrimoni e un temporaneo aumento del tasso di fertilità che, essendo però basato su di un più elevato numero di coorti in grado di riprodursi, è certamente sovrastimato rispetto ai precedenti. Quindi, è solo a partire dall’inizio degli anni ‘90, una volta che fu assorbito l’impatto di questa norma, che il tasso di fertilità registra la seconda forte contrazione e scende rapidamente sotto il livello di rimpiazzo, ponendo le premesse per il drastico calo demografico di cui abbiamo parlato. John: Tutti bei discorsi, ma cosa mi dici dei comportamenti disumani che hanno accompagnato l’applicazione di questa legge? Michele: Non ho alcuna intenzione di evitare l’argomento. Anzi, t’invito a leggere il drammatico quadro che ne ha fatto di recente il demografo Wang Feng, direttore di un importante centro di ricerca di Pechino 67. Wang Feng comincia con il sottolineare che la politica del figlio unico è stata probabilmente l’esempio più draconiano d’ingegneria sociale messo in essere da un governo; ricorda poi che essa si è tradotta in una diffusa pratica di aborti forzati, di sterilizzazioni e inserzione di spirali contraccettive effettuate contro la volontà delle donne che le hanno subite; che ha portato a privare numerose famiglie contadine delle loro case, dei loro animali e della loro terra e si è anche tradotta in lunghe detenzione. D’altra parte, i sostenitori dell’efficacia di questa norma citano il fatto che negli ultimi quaranta anni gli aborti siano stati oltre 300 milioni e ne misurano cosi l’impatto sulla crescita demografica. Li: Fatemi aggiungere che c’erano anche inaccettabili intromissioni nella vita privata come quando si esponevano i grafici dei periodi mestruali delle donne del vicinato in modo da generare un controllo sociale su situazioni “sospette”. Ho letto da poco un libro di Zhang Lijia 68 che racconta come lei dovesse mostrare i propri assorbenti bagnati di sangue alla funzionaria dell’Ufficio di Pianificazione per averne un’altra confezione. 66 Il Club di Roma fu fondato nel 1968 a Roma, presso la sede dell’Accademia dei Lincei, da un imprenditore italiano Aurelio Peccei e da uno scienziato scozzese Alexander King insieme a numerosi premi Nobel e leader politici e intellettuali. Il Club attrasse l’attenzione mondiale pubblicando nel 1972 il Rapporto sui Limiti dello Sviluppo. La tesi era che la crescita economica non poteva continuare indefinitivamente a causa della limitata disponibilità delle risorse naturale, in particolare del petrolio, e della limitata capacità del pianeta di assorbire inquinanti. I prossimi decenni permetteranno di verificare la correttezza delle previsioni del rapporto che riguardavano il periodo successivo al 2020. 67 Dopo aver insegnato all’Universita di Califofnia a Irvine e di Fudan a Shanghai; Wang Feng è ora il direttore del Brookings-Tsinghua Center for Public Policy in Beijing. Si veda “The Future of a Demographic Overachiever: Long-Term Implications of the Demographic Transition in China” 68 Zhanh Lijia (2008), Il socialismo è grande, l’esperienza del lavoro in fabbrica negl ianni ’80, Cooper. 54 Mario: Ma insomma, questa norma è servita o no? Michele: Se vuoi la mia opinione è stata importante per lo sviluppo socio economico della Cina, ma una corretta lettura dei dati demografici avrebbe dovuto portare alla sua abolizione alla fine del secolo scorso. Mario: A questo punto mi sembra indispensabile entrare nel merito di questa legge. Michele: La prima cosa da dire è che dagli anni 90 la politica del figlio unico è evoluta in un sistema complesso, estremamente articolato e diversificato, che si basa sempre meno sulla coercizione e sempre più su di un pianificazione famigliare consapevole e, di fatto, è diventata la politica del figlio e mezzo 69. Inoltre i cambiamenti socio economici intervenuti nel frattempo hanno portato il tasso di fertilità di moltissime regioni ben al di sotto del limite “di legge”, soprattutto nelle aree urbane, come a Shanghai, dove le stime locali parlano di un indice di fertilità inferiore a 1. Le ragioni sono, come in altri paesi sviluppati, ricollegabili a problemi di reddito, mancanza di tempo libero, di uso alternativo delle risorse, ma anche a ragioni specifiche come i problemi burocratici che le coppie cinesi incontrano nel chiedere l’autorizzazione per avere il secondo figlio. Li: Ovviamente chi ha dei soldi se ne frega. L’ultimo caso riportato dalla stampa è quello di Zhang Yimou, il regista di Lanterne rosse, che avrebbe avuto sette figli da quattro donne diverse 70. John: Comunque continuo a non capire come mai questa legge non venga abolita. Michele: A dirti la verità me lo chiedo anch’io, visto che tutte le recenti analisi 71 indicano che una sua abolizione non causerebbe grosse conseguenze sulle nascite, mentre continuano a inasprirsi i problemi dell’invecchiamento e della carenza di donne. Di questo però vorrei parlarne solo dopo che vi avrò esposto le mie previsioni sul futuro demografico della Cina. Adesso tornerei al fatto che la crescita della domanda di lavoro si è concentrata in alcune aree e che è stato qui che si sono diretti i flussi migratori interni. La popolazione fluttuante Le dimensioni del fenomeno Li: In Cina non si è mai parlato di migrazioni interne, ma solo di popolazione fluttuante; una terminologia che fornisce un’immagine del tutto distorta del fenomeno. Negli ultimi trenta anni si è registrato un esodo senza precedenti storici di persone che lasciavano le zone rurali e le province a basso livello di sviluppo per cercare un lavoro in maniera permanente nelle zone in cui la crescita economica era così elevata da rendere insufficiente l’offerta locale di lavoro. In sostanza, si è verificata una migrazione di massa di carattere economico. E il punto fondamentale è che proprio facendo ciò questi migranti “irregolari” hanno dato un contributo fondamentale al miracolo economico del paese. Sono loro che hanno fornito e 69 Wang, Feng (2005), “Can China afford to continue its one-child policy?,” Asia Pacific Issues, No.17, Honolulu: East-West Center. 70 Secondo notizie dell’ultima ora, dopo aver negato di aver avuto sette figli da varie donne, Zhang Yimou ha però pagato una multa di 1,23 milioni di dollari per avere avuto ed allevato due figli “eccedentari “ con la moglie Chen Ting. 71 Gu Baochang, and Wang Feng (2009), “An Experiment of Eight Million People: Reports from Areas with Twochild Policy”, Beijing, China Social Sciences Academic Press; Gu Baochang and Yong Cai (2011), “Fertility Prospects In China”, UN DESA Population Division, Expert Paper, No. 2011.4. 55 stanno ancora fornendo il carburante umano per alimentare la locomotiva cinese. Mario: Ma di quanta gente stiamo parlando? Michele: Fino al 1978 i fenomeni d’inurbamento furono modesti sia perché il divieto di lasciare la propria residenza era imposto in modo più rigoroso, sia perché le occasioni di lavoro nei centri urbani erano molto più ridotte. Secondo valutazioni ufficiali, nel 1978 la “popolazione fluttuante” era di 7 milioni che salgono a 22 nel 1990, a 79 nel 2000, a 147 nel 2005 e ad oltre 260 milioni in occasione del Censimento del 2010. John: Una cosa biblica! Credevo che la mobilità interna fosse una caratteristica americana e che facesse parte solo della nostra cultura l’idea che in qualunque momento si potesse saltare su di un cavallo o su di un carro per andare verso Ovest alla ricerca di un mondo migliore. Non avrei mai pensato che in Cina succedessero cose analoghe. Li: Beh, noi prendiamo o l’autobus o il treno. Comunque una differenza c’è: in Cina siamo andati verso est. Michele: I vecchi miti sono duri a morire e la Cina non ha ancora trovato uno Steinbeck e un Ford che facessero della violazione del hukou una dolorosa epopea 72. Non bisogna dimenticare che, come in tutti i paesi del mondo, l’immigrazione illegale fa comodo a molti. Non solo alle imprese che si trovano nella condizione di poter sfruttare una manodopera indifesa, ma anche alle famiglie più abbienti che possono avere servizi domestici a buon mercato. Comunque, gli Stati Uniti rimangono il paese con la maggiore mobilità interna, anche se il fenomeno è in progressiva contrazione, in particolare dopo l’inizio dell’attuale crisi finanziaria. Mario: Suppongo che la dimensione della popolazione fluttuante, così come quella della mobilità interna, dipenda dalla definizione adottata. Michele: Sì; i dati si riferiscono a persone che al momento della rilevazione si trovavano da almeno sei mesi in una località diversa da quella in cui sono registrate e classificano i migranti sulla base della lunghezza del percorso migratorio: persone che si sono mosse all’interno di una contea, all’interno di una provincia, o si sono spostate da una provincia a un’altra. Le analisi hanno mostrato che l’incidenza delle migrazioni “lunghe” è progressivamente aumentata a seguito degli ingenti flussi migratori verso le province della costa. John: Ci puoi dare qualche indicazione quantitativa? Michele: In occasione del censimento del 2010 le persone che si trovavano in un luogo diverso da quello di registrazione erano poco più di 260 milioni –quasi equamente divise nei tre gruppi che abbiamo appena indicato – e che rappresentano il 19,6 per cento della popolazione. I dati mostrano che vi sono immigrati in tutte le province e municipalità. Tuttavia oltre la metà è concentrata in otto province e municipalità, prima fra tutte il Guangdong con il 14,1 per cento, seguito dallo Zhejiang (7,6 per cento) e dallo Jangsu (7 per cento) 73. Se invece guardiamo dove gli immigrati hanno un’incidenza maggiore, troviamo al primo posto le due grandi “capitali” della Cina, Pechino e Shanghai dove ben oltre la metà degli abitanti è costituita da immigrati, seguite da Tianjin con il 38,5. Con valori sopra al 30 72 Michele si riferisce al capolavoro di John Steinbeck del 1939, The Grapes of Wrath, che John Ford portò quasi immediatamente sullo schermo: 73 Le altre province e municipalità sono Shandong, Shanghai, Sichuan, Fujian e Beijing. 56 per cento troviamo poi lo Zhejiang, il Guangdond e il Fujian. Precedenti analisi hanno mostrato che la motivazione principale dei flussi migratori è rappresentata dalla ricerca del lavoro, la seconda dai ricongiungimenti familiari. La prima riguarda soprattutto le persone nelle classi centrali di età, la seconda i giovani e gli anziani. Anch’io ho fatto alcune stime dei flussi migratori interni, ma utilizzando dati demografici 74. John: E cosa hai trovato? Michele: Prima di tutto tenete presente che i dati che vi ho appena fornito non contengono gli immigrati regolari, vale a dire coloro che sono riusciti a spostare il proprio hukou. Mario: Vuoi dire che nei paesi occidentali si conosce la consistenza dell’immigrazione regolare e si hanno solo valutazioni vaghe su quella irregolare, mentre in Cina è l’opposto? Michele: Esattamente. In secondo luogo le rilevazioni degli uffici statistici cinesi forniscono stime della presenza d’immigrati nelle zone di arrivo, ma nulla ci dicono sulla loro provenienza. Io ho cercato di verificare la consistenza complessiva (migrazione regolare e irregolare) dei flussi campagna-città e tra le varie province. Per quanto riguarda il primo aspetto, le mie stime mostrano che dal 1993 al 2008 almeno 217 milioni di cinesi hanno lasciato le zone rurali per le zone urbane e che quindi oltre 4/5 della crescita della popolazione urbana che si è registrata in quel periodo è da imputare all’immigrazione. I dati mostrano poi che anche i flussi campagna-città, molto elevati fino al 2008, sono in progressiva diminuzione. Forse ancora più interessanti per la nostra discussione sono i movimenti a lungo raggio, vale a dire le migrazioni da provincia a provincia. Province di arrivo e province di partenza Li: E’ un punto interessante. Io sento sempre parlare di Cina, ma la Cina è una realtà complessa e non solo per la concentrazione di minoranze etniche in alcune province. In Cina si parlano ancora molte lingue e vi sono norme e usanze molto diverse, per non parlare delle differenze relative alla cucina. Michele: In questo Cina e Italia sono molto simili. Li, prima o poi potresti farci apprezzare questo aspetto della Cina. Li: Che ne direste di venire a cena a casa mia? Michele: Credo che nessuno si opporrà a questa proposta. Se tu ti impegni a parlarci delle diverse cucine regionali, io posso concentrarmi sugli aspetti quantitativi. Tanto per cominciare lo sapevate che una provincia cinese (il Guangdong) ha più di 100 milioni di abitanti e due (lo Shandong e lo Henan) ne hanno più di 90, sono cioè più popolose della Germania? E che sette hanno tra i 50 ed i 90 milioni e che, di queste, quattro sono più popolose dell’Italia? Vi sono poi anche nove province cha hanno tra i trenta e i cinquanta milioni di abitanti. Sono anche sicuro che se chiedessimo in giro quali sono le province più popolose della Cina, ben pochi saprebbero rispondere. John: Io faccio parte del gruppo. Li: Molto male. Si vede che non hai letto l’Arte della Guerra di Sun Tzu 75. John: Perché? 74 Bruni Michele e Claudio Tabacchi, 2011, “Present and Future of the Chinese labour Market”, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, CAPaper., n. 83 www.capp.unimore.it/pubbl/cappapers/Capp_p83.pdf 75 Sun Tzu (2003), L’arte della Guerra, Mondadori. 57 Li: Avresti imparato che per vincere una battaglia senza subire perdite non è sufficiente conoscere se stessi, ma è anche indispensabile conoscere il nemico. John: Non ti preoccupare, ci pensa la CIA. Mario: A me sembra comunque molto curioso che anche le persone istruite dell’occidente, noi inclusi, sappiano così poco di un paese che non solo è la seconda potenza mondiale, ma possiede un terzo del debito pubblico americano. Li: Anche noi conosciamo ben poco dell’occidente. Michele: A nostra discolpa va detto che a tutt’oggi, o meglio fino alla recente pubblicazione dell’ultimo censimento, le informazioni statistiche sulle province cinesi erano molto limitate e che le differenze provinciali sugli aspetti demografici e del mercato del lavoro sono poco discusse anche dalla letteratura accademica. Vi immaginate se, come avviene attualmente in Cina, avessimo solo un’idea approssimativa dei tassi di occupazione e disoccupazione dell’Europa e non sapessimo quello della Germania o dell’Italia? Alcune cose però si sanno. Ad esempio, se è vero che nel complesso il tasso di crescita della popolazione cinese è molto basso e si sta avvicinando a zero, a livello provinciale i tassi di crescita naturale, vale a dire la differenza tra natalità e mortalità, vanno da valori inferiori all’uno per cento nella provincia del Liaoning e nelle tre municipalità di Shanghai, Tianjin e Pechino a valori prossimi al sei per cento nelle regioni autonome dello Xinjiang e del Tibet. E’ stato utilizzando queste informazioni e alcune semplici ipotesi che ho calcolato i saldi migratori delle singole province tra il 2003 e il 2008. Li: E che cosa è emerso? Michele: Che ci sono province di partenza e provincie di arrivo, come ci si poteva attendere in una situazione in cui la crescita economica è concentrata in alcune aree e la crescita demografica in altre. Quindi, non solo vi sono stati intensi flussi migratori dalle zone rurali alle zone urbane, ma tra il 2003 ed il 2008, ben 28 milioni di cinesi si sono spostati da 8 province dell’interno verso le province della costa e le tre grandi municipalità di Pechino, Shanghai e Tianjin. Mettendo insieme questi dati, ne esce un quadro notevolmente complesso. Vi è un gruppo di sei province che rappresentano il polo d’attrazione principale dei flussi migratori e in cui l’enorme crescita delle zone urbane è spiegata da notevoli fenomeni d’inurbamento, ma anche e soprattutto da immigrati provenienti da altre province. Di contro, vi sono cinque province che presentano un pronunciato saldo migratorio negativo dovuto al fatto che coloro che hanno abbandonato le zone rurali si sono diretti verso altre province. Per finire, vi sono province che sembra siano state interessate da veri e propri processi di ruralizzazione 76. A seguito di questa mobilità così pronunciata e della modesta dinamica delle nascite, non è poi sorprendente che siano soprattutto i flussi migratori a determinare l’andamento demografico. Se prendiamo, ad esempio, le otto principali province e municipalità di arrivo, ¾ della loro crescita demografica è dovuta all’immigrazione. D’altra parte, i flussi in uscita hanno reso negativo il saldo demografico delle principali regioni di partenza i cui saldi naturali erano largamente positivi 77. Mario: Insomma, mettendo insieme tutto quello che hai detto, mi sembra di capire che la straordinaria crescita economica cinese sia stata propiziata dalla presenza di un’offerta, come 76 Shandong, Fujian, Jilin, Tibet, Jiangxi. E’ tuttavia probabile che per alcune province questo risultato sia dovuto al fatto che zone definite rurali sono state infatti scelte come aree di insediamenti industriale, a seguito della loro vicinanza con le zone urbane. 77 Sichuan, Anhui, Henan, Hunan, Hubei, Chongqing, Guizhou e, sia pure marginalmente, Guangxi. 58 l’hai definita, illimitata di lavoratori disposti a lasciare le loro famiglie, accettare salari estremamente bassi e subire senza fiatare condizioni di lavoro spesso disumane. Li: Non pensate che sia più facile per i cinesi che per voi occidentali. Credo, anche per esperienza personale, che alla base vi sia stato e vi sia tuttora un forte senso della famiglia e una conseguente disponibilità a soffrire per il bene dei propri figli. Per quel po’ che capisco dell’Italia, credo che le motivazioni siano state simili a quelle di chi lasciò il vostro paese per cercare fortuna in terre lontane. Michele: Ben detto Li. Ogni tanto fa bene pensare non solo alle differenze, ma anche alle similarità. Tornando a quello che diceva Mario, penso proprio che propiziare sia la parola giusta. Tutti i fenomeni economici e sociali sono complessi, molto complessi, e non possono essere spiegati da una sola variabile. Io credo che la presenza di un eccesso strutturale di lavoro nelle zone rurali e in alcune aree più povere del paese non sia di per sé sufficiente a innescare lo sviluppo, come dimostrano tanti paesi poverissimi che si trovano in questa condizione. Ciò detto, credo che non si darà mai abbastanza merito ai milioni di cinesi che hanno sopportato incredibili disagi fisici e morali (non dimentichiamo che gli immigrati non godono mai di buona fama nelle città in cui arrivano e la Cina non fa certo eccezione) per migliorare anche solo marginalmente la vita dei loro famigliari rimasti nelle campagne e per far studiare i figli, la più grande aspirazioni di ogni famiglia cinese. Inoltre, con i loro sacrifici essi hanno dato un contributo essenziale alla crescita economica del paese. L’impatto delle migrazioni interne sull’economia e sull’offerta illimitata di lavoro John: Suppongo che la mobilità abbia portato a una maggiore uguaglianza economica tra le varie province. Michele: John, i risultati del modello di libera concorrenza riguardano una struttura economica ideale e aspettarsi che i mercati reali portino a tale risultati è totalmente utopistico. E’ notizia di questi giorni che negli Stati Uniti la diseguaglianza è cresciuta anche durante la presidenza Obama. La stessa cosa si sta verificando in Cina, malgrado tutte le dichiarazioni d’intenti della classe dirigente, cosicché quella che, secondo Deng, doveva essere soltanto una necessaria fase di passaggio sta diventando una costante del sistema. Si tratta di una sfida politica cruciale per il governo cinese, soprattutto se consideriamo che le disuguaglianze socio-economiche sono molto pronunciate non solo nelle aree urbane e che lo straordinario sviluppo economico dell’ultimo ventennio ha determinato una crescente diseguaglianza fra le province. Li: Malgrado tutto ciò, tu dici che siamo arrivati al punto in cui l’offerta illimitata di lavoro si è esaurita e la pacchia per gli investitori cinesi e stranieri è finita. Mi sembra però di aver letto che, secondo un qualche organismo internazionale, la Cina avrebbe avuto ancora un’enorme disponibilità di lavoro. Si parlava, mi sembra, di 150 milioni di persone. Qui qualcuno si sbaglia. Michele: Certo, non sono mancate e non mancano opinioni diverse da quelle che vi ho appena esposto. Nel 2009 un noto studioso cinese sostenne che l’offerta di lavoro sarebbe stata sufficiente per altri quaranta anni e che nel 2050 la popolazione in età lavorativa sarebbe stata ancora uguale a circa un miliardo, un dato in contrasto con tutte le proiezioni 59 demografiche disponibili 78. Debbo però dire che, già a partire dal 2006 quando la stampa cominciò a segnalare le prime carenze di offerta, numerosi studiosi fra cui esponenti di spicco dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali hanno ben documentato l’opinione opposta79. E’ stato, ad esempio, mostrato che i salari stavano aumentando rapidamente (come succede quando l’offerta di lavoro non è più illimitata) e che 3 su 4 dei 2.800 villaggi analizzati in una recente indagine non avevano più risorse umane in eccesso 80. Altre stime sostenevano che non vi erano più di 45 milioni di contadini disponibili a lavorare nei settori moderni. John: Suppongo che tu sia d’accordo con queste stime. Michele: Bisogna tener distinti due concetti. Il primo è l’ammontare di persone di cui un settore può fare a meno senza per questo diminuire la propria produzione. Si tratta di un valore che è determinato dall’innovazione tecnologica. In Cina la meccanizzazione dell’agricoltura è ai suoi inizi e la produttività del lavoro varia molto da provincia a provincia. Se tutte le province avessero la stessa produttività che si registra nel Jangsu, la provincia in cui si registra la più elevata produttività media del lavoro nel settore agricolo, circa la metà dei lavoratori del settore, vale a dire più o meno 150 milioni, risulterebbe ridondanti. A questo punto ci si deve però chiedere quanti di questi lavoratori rappresentino un’offerta potenziale per i settori moderni. Il primo elemento da considerare è l’età: oltre un terzo degli occupati in agricoltura ha più di cinquanta anni. Essi rappresentano ¾ di tutti gli occupati in quelle classi di età. Il secondo è il livello educativo: solo poco più del 6 per cento dei lavoratori agricoli ha un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo. Se si tengono presenti questi fatti si giunge alla conclusione che la disponibilità di lavoratori agricoli per i settori moderni è sostanzialmente esaurita 81. Mario: Quindi le zone rurali non rappresentano più un serbatoio di manodopera per i settori moderni e i flussi migratori da provincia a provincia si arresteranno? Michele: Non ho detto questo; infatti credo che sarà vero l’opposto. Se guardiamo alla dinamica occupazionale vediamo, ad esempio, che tra il 2003 ed il 2012 l’occupazione è aumentata di 119 milioni nelle zone urbane ed è diminuita di 85 in quelle rurali e la crescita netta di 34 milioni si è concentrata in poche province, in particolare nel Guangdong, nello Zhejiang, nello Jangsu. Se, com’è probabile, la crescita occupazionale continuerà a concentrarsi in poche province, i flussi migratori interni continueranno; il problema è che non saranno sufficienti a soddisfare la domanda. John: Mi sembra arrivato il momento di fare il punto. L’economia cinese si è sviluppata in modo geograficamente sbilanciato. La crescita si è concentrata nelle grandi città e nelle province costiere che offrivano condizioni migliori in termini d’infrastrutture. Quando l’offerta di lavoro presente in tali aree è stata completamente assorbita, la crescita è continuata indisturbata grazie alla presenza di un’offerta illimitata di lavoro nelle zone rurali e, più in generale, nelle province più povere, che ha alimentato elevatissimi flussi migratori. I 78 Questa tesi e stata sostenuta nel non lontano 2010 da Ma Li membro della National Population and Family Planning Commission, oggi National Health and family Planning Commission. Secondo Ma Li le forze di lavoro cinese sarebbero cresciute fino al 2026 ma si sarebbero poi mantenute sopra al livello attuale fino al 2050. Sono d’accordo con la conclusione, ma ritengo che ciò sarà possibile solo con massicci flussi migratori 79 Cai Fang (2006), “How to deal with the future labour shortage”, China Daily, March. 80 Cai Fang, Yang Du, Meyan Wang (2009), “Employment and inequality outcomes in China”, Institute of Population and Labour Economics, Chinese Academy of Social Sciences. 81 Bruni, Michele and Claudio Tabacchi (2011), “Present and future of the Chinese labour market. Dualism, migration and demographic transition,” Department of Political Economy, University of Modena and Reggio, Working paper No. 647. 60 flussi migratori hanno mantenuto il salario ai livelli si sussistenza, per altro senza gravare sui costi delle amministrazioni locali che erano “protette” dalla illegalità del fenomeno. E così la Cina, dove nel frattempo si stavano concentrando ingentissimi investimenti stranieri, si è trasformata nella “fabbrica del mondo”. Questa fase si sta concludendo perché la popolazione in età lavorativa è destinata a diminuire e ciò provocherà inevitabilmente un calo dell’offerta di lavoro. Di fronte a questa situazione la proposta della Banca Mondiale è che la Cina approfitti della caduta dell’occupazione agricola, ormai in corso senza interruzione dal 2002, punti sulla terziarizzazione della propria economia e mantenga inalterata l’occupazione nel settore industriale destinato ad abbandonare progressivamente le produzioni ad alta intensità di lavoro per spostarsi su clusters produttivi a più elevato contenuto tecnologico. Michele, mi sembra però di capire che tu non creda in questo scenario. Una prima valutazione della proposta della Banca Mondiale Michele: No, e per numerose ragioni di cui avremo occasione di parlare. Per il momento vi cito solo la terziarizzazione. In una fase di forte espansione dei servizi è difficile immaginare che la produttività possa aumentare più della produzione. John: Mi piacerebbe però sapere se esistono esempi in cui un’economia è cresciuta mentre il livello dell’occupazione diminuiva. Michele: Da un punto di vista teorico non ci sono motivi perché la produttività del lavoro non possa aumentare in misura tale da garantire l’incremento della produzione e permettere anche una diminuzione del numero degli occupati. Però, se esaminiamo cos’è successo fino ad ora l’occupazione è aumentata ovunque. John: Ad esempio? Michele: Gli Stati Uniti sono l’esempio più paradigmatico. Li: Paradigma che? Michele per piacere parla come mangi. Io sono un povero cinese del Fujian. Michele: Li, sei certamente del Fujan, ma permetti che io non sia d’accordo sul “povero”. Comunque, volevo dire rappresentativo di questa situazione. Prendiamo gli Stati Uniti. Tra il 1960 e il 2010 il livello dell’occupazione è passato da 60 ad oltre 160 milioni. In sostanza, l’occupazione è aumentata del 166 per cento. Nello stesso periodo il PIL è aumentato del 370 per cento. Dividendo la crescita percentuale dell’occupazione (166) per la crescita percentuale della produzione (370) otteniamo un numero che gli economisti chiamano elasticità occupazione prodotto. In questo caso 0,45, che ci dice quale è stato l’aumento percentuale dell’occupazione per ogni punto percentuale di crescita del PIL. John: E’ molto o poco? Michele: E’ molto. Nel lungo periodo gli Stati Uniti hanno creato un numero molto elevato di posti di lavoro e l’occupazione ha dato un contributo molto rilevante alla crescita della produzione. Negli ultimi 20 anni la dinamica occupazionale degli Stati Uniti non è stata tra le più elevate, come vedete nel grafico che mostra la crescita percentuale della occupazione tra il 1990 e il 2008 in una serie di paesi sviluppati. I valori sono compresi tra un massimo di 120 per cento in Lussemburgo e minimi inferiori al 10 per cento in paesi come la Danimarca, la Francia, il Giappone, l’Italia, la Svezia e la Finlandia. Anche in questo periodo gli Stati Uniti sono nella parte alta della classifica, pur essendo preceduti da Spagna, Corea, Olanda e 61 Australia. Il punto fondamentale è però che l’occupazione è aumentata in tutti i paesi industrializzati. Vi è anche un altro tipo di evidenza empirica che può aiutare a chiarire meglio la mia posizione. Numerosi paesi sono già stati interessati da una caduta tendenziale e sostenuta della loro popolazione in età lavorativa e quindi dell’offerta di lavoro autoctona. Grafico 2 – Tassi percentuali di crescita dell’occupazione in alcun paesi industrializzati, tra il 1980 e il 2008 Fonte: Elaborazione su dati ILOSTAT Nella tavola ho riportato alcuni esempi significativi: Germania, Italia, Spagna, Russia, e Giappone. Tra il 1990 e il 2010 nei quattro paesi europei il saldo naturale della popolazione in età lavorativa è stato fortemente negativo, ma in tutti e quattro esso è stato totalmente (Italia, Spagna, Russia) o largamente (Germania) coperto dal saldo migratorio. Nel caso del Giappone il calo della popolazione in età lavorativa è iniziato solo nell’ultimo quinquennio del secolo scorso, raggiungendo però molto rapidamente una dimensione notevole. Il saldo migratorio è stato positivo, ma ha coperto solo il 17 per cento del saldo naturale. Bisogna però tenere presente che il Giappone ha sperimentato una situazione di stagnazione economica, tanto che tra il 1995 e il 2011 il PIL del Giappone è cresciuto in media meno dell’1 per cento all’anno. La tabella riporta anche il caso di Singapore cha si trova alla soglia del punto di svolta di Lewis e il fenomeno migratorio ha già un ruolo molto rilevante, contribuendo per oltre il 90 per cento alla crescita della popolazione in età lavorativa. Tav. 5 – Saldo naturale. Saldo migratorio e saldo totale in alcuni paesi; 1990-2010 Fonte: Elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision 62 John: Non starai mica suggerendo che la Cina dovrà importare mano d’opera? Michele: Proprio così. Stando ai recenti dati censuari, nei prossimi venti anni la popolazione in età lavorativa della Cina diminuirà in maniera molto più pronunciata di quanto stimato dalla Banca Mondiale e anche dalle ultime proiezioni delle Nazioni Unite 82. Pertanto la Cina non potrà evitare d’importare manodopera e, viste le sue dimensioni, si tratterà di numeri senza precedenti storici. Li: Di nuovo la nostra mania di grandezza. E il sorpasso? Michele: Rimane possibile, ma la Cina dovrà mettere in gioco la sua omogeneità etnica. Li: E’ un’idea difficile da digerire. Come siamo arrivati a questa situazione? Michele: E’ una storia lunga, troppo lunga per questa sera. John: Non ci rimane che rinviare il tutto alla prossima occasione. 82 Bruni Michele (2014), “Dwindling labour supply in China: Scenarios for 2010-2060”, in Attané Isabelle, Gu Baochang (a cura di), Analyzing China’s Population, INEd Population Studies, n.3, Springer 63 La mente è come il paracadute: funziona solo quando è aperta. Frank Zappa Terzo dialogo - Le lontane origini del declino demografico E’ il 6 novembre del 2012, la sera delle elezioni americane. John ha invitato Li, Mario e Michele a casa sua per seguire l’evento alla televisione. Mario e Michele fanno il tifo per Obama, John per Romney. Li pensa che per la Cina non faccia alcuna differenza anche se, tutto sommato, ha l’impressione che sarebbe meglio Obama. Elezioni, sistemi elettorali e informazione John: Sarà una sfida all’ultimo voto, roba da OK Corral. Ragazzi cosa volete da bere? Sono abbastanza ben rifornito. Mario: Senti se cominciassimo con del vino e tenessimo la roba forte per il gran finale? John: OK, Prosecco per Michele per evitare che gli vengano le emorroidi e per noi un bel rosso: Amarone o Brunello? Mario: Wow… Fai sul serio. Io mi accontentavo di un Sangiovese. John: Ragazzi oggi è un giorno speciale. Gli Stati Uniti stanno per tornare ad avere un presidente come si deve che riporterà il paese ai suoi veri valori, farà scelte corrette in campo economico e i Cinesi dovranno dimenticare l’idea del sorpasso. Mario: Il tuo Romney non ha una probabilità su cento di farcela. Alla fine gli americani si renderanno conto che Obama è riuscito se non proprio a tirarli fuori dalla … crisi, a muovere il paese nella direzione giusta. Se non avesse trovato tanta opposizione, forse sarebbe riuscito a rendere gli Stati Uniti un paese un po’ più avanzato anche sul piano sociale. Li: Per noi, invece, non ci sará molta suspense. Sappiamo giá che il prossimo presidente sará Xi Jinping che è ormai “in formazione” da molti mesi. Quindi, non mi aspetto che stampa e televisioni mondiali seguano con attenzione il prossimo Congresso Nazionale del Partito Comunista che procederà alla sua nomina nella Grande Sala del Popolo di Pechino. John: Li, non credo che si tratti solo di questo. Devi ammettere che voi non siete molto folkloristici e che i vostri rituali politici sono noiosi e impaludati. Durante il capodanno cinese, i vostri leader vanno regolarmente a trovare le vecchiette, soprattutto quelle che vivono in capanne senza riscaldamento, per portare loro il calore del partito e ne approfittano per stringere la mano ai bambini di due anni che vivono in zona; e poi mai che nei vostri congressi di partito si veda un palloncino, che spunti una qualche amante segreta e appena qualcuno prova a dire che un leader si è arricchito, come è normale che sia in un paese con tanta corruzione come il vostro, apriti cielo: non si interviene sul leader ma sui social network. La conseguenza è che si parla ancora molto poco della vita politica cinese e lo si fa come se si trattasse di qualcosa di misterioso e difficile da capire. Sono curioso di vedere se il partito comunista farà qualche scelta innovativa quando ci saranno i processi di Bo Xilai e di sua moglie. Potrebbe essere l’occasione buona per sollevare un po’ il coperchio e dare una 64 sbirciatina a cosa bolle dentro la pentola del potere cinese. Comunque, anch’io non so quando inizierà il Congresso del Partito Comunista Cinese. Li: Beh, i lavori stanno per cominciare e di solito durano tra 5 e 10 giorni. John: Tanto i giochi sono già fatti sotto l’attento controllo dei vostri vegliardi. Li: sì, se vuoi la puoi mettere così. Tuttavia io non sono molto sicuro di vedere dei grossi vantaggi nel vostro metodo che porta all’elezione di un presidente scelto tra un piccolo numero di miliardari o comunque di persone sostenute da qualche lobby e che raccoglie il consenso di poco più di un quarto dei potenziali elettori, molti dei quali siamo onesti, sanno ben poco di quello che succede fuori dal loro paesino e votano sulla base di stereotipi e frasi fatte. Da noi c’è certamente un disinteresse diffuso per la politica. Molti sono convinti che i nostri leader s’impegnino a fare il bene del paese e del popolo, come dei buoni padri di famiglia. Altri non ci credono ma, come avviene anche nel Montana, se ne fregano totalmente della vita politica e i loro interessi si fermano alla famiglia e al lavoro. Però, c’è una concorrenza selvaggia tra i membri del partito. Per arrivare in cima non serve solo appartenere alla cordata giusta, ma anche essere in gamba, molto in gamba. Credo che questo non si possa dire di alcuni degli ultimi presidenti americani, uno per tutti il buon George Bush. Mario: Ragazzi non scadiamo nel qualunquismo. La democrazia è una cosa importante, anche se poi le forme con cui viene attuata possono essere ben lontane dai nostri desideri. John: Forse la soluzione è la rete che diffonde una quantità d’informazione senza precedenti e dà a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione. Michele: Io credo, invece, che si stia esagerando sul contributo che Internet può dare alla democrazia. Non ci sono dubbi che i nuovi strumenti informatici e telematici abbiano aumentato il flusso di dati, ma la disponibilità d’informazione rappresenta solo una premessa per l’aumento di consapevolezza, sapere e cultura, tutte cose che richiedono un grosso impegno e hanno quindi un prezzo elevato in termini di sforzo personale. Bisogna anche interrogarsi sulla qualità e comprensibilità dell’informazione, sulla sua origine e sul ruolo dei grandi interessi economici. E poi, questa idea che tutti usino Internet credo che vada ridimensionata. Mario: L’espansione dell’utenza di Internet è stata strabiliante. Si è passati dai 361 milioni del 2000 agli attuali 2,4 miliardi che, se rapportati alla popolazione mondiale, danno un tasso di penetrazione della rete del 34,4 per cento. In Asia vi sono 1,07 miliardi di utenti, ma il il tasso di penetrazione è del 27,5%. A livello di continenti la classifica del tasso di penetrazione è guidata dal Nord America con il 78,6 per cento, seguito dall’Oceania con il 67,6 per cento, dall’Europa con il 63,2 per cento, dall’America Latina con il 42,9 per cento. L’Africa chiude la classifica con il 15,6 per cento 83. John: Non ti sarai mica fatto applicare un chip collegato a Wikipedia. Comunque, tanto che ci siamo, puoi dirci anche qual’è la situazione a livello di paesi. Mario: Il tasso di penetrazione più elevato è quello del Principato di Monaco, dove vi sono più utenti che abitanti (100,6%). Sopra l’80 per cento troviamo numerosi paesi dell’Europa del Centro nord: Islanda (97,1%). Norvegia (96,9%), Olanda (92,9%), Lussemburgo (90,9%), Danimarca (90%), Liechtenstein (85%), Finlandia (89.4%), Germania 83 Le informazioni fornite da Mario sono tratte da: Internet World Stats - Usage and population statistics, http://www.internetworldstats.com/stats.htm 65 (83%), e Belgio (81,3%), nonchè il Canada (83%) e la Corea del Sud (82,5%). Seguono: Austria (79,8%) Francia (79,6), Giappone (79,5), Stati Uniti (78,1), Brunei (78%), Taiwan (75,4%), Singapore (75%) e Hong Kong (74,5%). Michele: E l’Italia? Mario: L’Italia con il 58,4 per cento non è certo ai primi posti. Michele: Hai anche qualche statistica sull’aumento del numero di cazzate apparse su twitter e sugli altri social networks? Mario: Non ancora, ma mi sto organizzando. John: La stampa ha certamente dato un notevole contributo alla diffusione della conoscenza e della democrazia. Perché non dovrebbe farlo anche la rete? Michele: Voi sapete che il libro di cui sono state stampate più copie è un vecchio libro di favole? John: I fratelli Grimm? Michele: No, la Bibbia che nella classifica dei libri più stampati è seguita dal Libretto Rosso di Mao e dal Corano; sopra i 100 milioni di copie vi è anche il libro dei Mormoni. Per fortuna tra i primi dieci troviamo anche il Piccolo Principe, Il Signore degli Anelli e Dieci Piccoli Indiani. Comunque, la buona notizia è che il numero delle copie stampate non è uguale al numero delle copie lette. E’ l’unico pensiero che mi da sollievo tutte le volte che in una camera di albergo trovo una delle bibbie distribuite dalla Bible Society. Li: Che cos’è? Un tour operator? Michele: No; un gruppo di persone convinte di contribuire a risolvere i problemi del mondo stampando e distribuendo Bibbie. John: Sentite, mi sembra che abbiamo già cazzeggiato abbastanza; perché non cerchiamo di colmare quest’attesa snervante parlando di cose serie? Tasso di fecondità, benessere economico e andamento demografico Li: Io riprenderei il discorso da dove l’abbiamo lasciato. Michele, prima ci ha detto che in Cina la popolazione in età lavorativa sta per cominciare a diminuire, poi hai sostenuto che ciò obbligherà la Cina a importare manodopera da altri paesi. Insomma, qual’è la situazione? Michele: Per dirla tutta, io credo che se la Cina vorrà continuare a crescere dovrà diventare il più grande importatore di manodopera nella storia della società umana. D’altra parte la Cina non sarebbe certo un caso isolato; numerosi paesi stanno già importando manodopera per far fronte ad una crescente carenza di offerta di lavoro e molti altri dovranno cominciare a farlo nei prossimi 50 anni. John: L’hai visto nella tua palla di vetro? Michele: No, mi sono limitato a guardare i valori del Tasso di Fecondità Totale in giro per il mondo. Li: Spiega 66 Michele: Il TFT, cosi lo chiamano quelli del mestiere, ci dice il numero medio di figli che ogni donna (o se per questo ogni uomo) produce nel corso della vita 84. Il trucco sta nel fatto che se ogni individuo ha due figli, la popolazione rimane invariata, dato che i due bambini sostituiscono uno la madre, l’altro il padre. Se il tasso di fecondità ha un valore superiore a quello di rimpiazzo, cioè due 85, la popolazione tenderà ad aumentare, se inferiore a diminuire. Li: Semplice; non ci avevo mai pensato in questi termini. Qual’è la situazione attuale? Michele, che non aspettava altro, estrae rapidamente il computer dallo zaino arancione. La complessa relazione tra fecondità e sviluppo Michele: A livello mondiale il tasso medio di fecondità è di 2,5 figli per donna e quindi la popolazione della terra sta ancora aumentando. Però i paesi più ricchi e sviluppati, hanno un tasso medio di fecondità di 1,7, ben al di sotto del livello di rimpiazzo; i paesi in via di sviluppo un tasso del 2,4, mentre i paesi più poveri con un tasso medio del 4,5 sono ancora ben lontani dalla stabilità demografica. Mario: Suppongo che questi dati siano il frutto di una lunga evoluzione storica. Tavola 1 – Mondo e regioni a diverso livello di sviluppo; Tasso di Fecondità Totale; 1970-75 e 2005-2010 Mondo Paesi sviluppati Paesi in via di sviluppo Paesi meno sviluppati 1970-75 4,4 2,2 5,2 6.8 2005-10 2,5 1,7 2,4 4,5 Diff. assoluta -2,1 -0,5 -2,8 -2,2 Diff. percentuale -43,0 -22,7 -53,6 -32,9 Fonte: Elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Michele: Sì, la situazione è in evoluzione da oltre duecento anni ed è cambiata drasticamente soprattutto negli ultimi quaranta. Dal 1970 a oggi il numero medio di figli per donna è sceso del 43 per cento. Il contributo maggiore è venuto dai paesi in via di sviluppo e la Cina ha certamente svolto un ruolo rilevante. Inoltre, quarant’anni fa i paesi con una fecondità sotto il livello di rimpiazzo erano meno di 20 e quasi tutti in Europa 86 , oggi sono una settantina. Jonh: Insomma c’è una relazione inversa tra livello di reddito e fecondità. Man mano che il reddito di un paese aumenta, il suo tasso di fecondità diminuisce e questo dovremmo poterlo vedere sia seguendo un paese nel tempo, sia confrontando la situazione dei vari paesi nello stesso momento. 84 La fertilità è la manifestazione concreta della capacità fisiologica potenziale di procreare. Il tasso di fertilità totale è il numero medio di figli che una coorte di donne genera nel corso della propria vita. Per ottenere tale dato bisogna quindi attendere che tutte le donne della coorte siano uscite dalla loro fase fertile. A quel punto l’indicatore ha un interesse di carattere puramente storico. Per ovviare a questo problema e avere un valore più attuale il tasso di fertilità totale viene stimato sommando i tassi specifici di fertilità registrati in un dato anno e che ci dicono il numero medio di figli che le donne di una data età hanno avuto nel corso di tale anno. Quindi il tasso di fertilità totale ci dice il numero medio di bambini che una donna immaginaria genererebbe se nel corso di un solo anno si muovesse attraverso il suo periodo fertile e fosse soggetta ai tassi di fertilità specifici registrati nel corso di quell’anno. Esso non va confuso con il tasso generico di natalità che è dato dal rapporto tra il numero di bambini nati in un determinato anno e la popolazione totale. Questo indicatore è fortemente influenzato dalla struttura per classe di età della popolazione, mentre il TFT e immune da questa distorsione in quanto tutte le classi di età hanno lo stesso peso e quindi lo stesso impatto sull’indicatore. 85 In pratica il valore é un po’ più di due dato che un certo numero di donne muore prima di aver concluso la propria fase fertile. 86 Si tratta di Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Malta, Croazia, Gran Bretagna, Svezia, Latvia, Finlandia, Danimarca, Ucraina, Russia, Ungheria, Stati Uniti, Canada, Macao. 67 Michele: In generale è vero, ma la situazione è molto articolata. Basti pensare che i tassi di fecondità sono compresi fra un massimo di 7,6 del Niger ed un minimo di 0,9 di Macao, una dispersione senza precedenti storici. Se poi entriamo un po’ più nel dettaglio, dei 203 paesi presi in considerazione dalle statistiche delle Nazioni Unite, come ho già detto 70 sono sotto la soglia di rimpiazzo ed altri 60 hanno un tasso di fertilità tra due e tre. Insomma, vi sono già 130 paesi in cui la popolazione totale, in assenza d’immigrazioni, sta diminuendo o diminuirà in un futuro non troppo lontano. Dall’altra parte, 32 paesi hanno un tasso di fecondità uguale o superiore a cinque. John: Suppongo che si tratti dei paesi piú poveri. Michele: Casualmente ho una cartina che ci può aiutare. I paesi con il TFT sotto il livello di rimpiazzo sono quelli colorati in giallo e quelli che, con tutta probabilità, entreranno in questo gruppo entro breve tempo, in verde. Come vedete ci sono ormai macchie di giallo in tutti i continenti, ma la loro distribuzione è ben lungi dall’essere omogenea. L’area del declino demografico è concentrata nell’emisfero nord. Essa copre tutta l’Europa e si estende anche su buona parte dell’Asia dove include la Cina, la Corea del Sud e il Giappone, ma anche Singapore, Tailandia e Vietnam; ed infine Armenia, Azerbaijan, Cipro, Georgia, Libano, Iran e Emirati Arabi. Sempre nella parte nord dell’emisfero troviamo Canada e Stati Uniti. Nell’emisfero Sud questa situazione è molto meno diffusa e riguarda solo Australia, Mauritius, Cile e numerosi paesi dei Caraibi fra i quali Cuba 87. I paesi ad alta fertilità sono quasi tutti concentrati nel continente africano, ma includono anche Afghanistan e TimorLeste, quasi tutta l’America Centrale alcuni stati dell’America Meridionale. Figura 1 – Paesi per livello di fertilità Fonte: Elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2010 Revision John: Insomma, miseria e alta fecondità vanno di pari passo. Michele: Se date un’occhiata al prossimo grafico potete vedere che quello che dice John è vero in linea di massima, ma che la situazione è molto articolata 88. Ogni punto del grafico si riferisce a un paese e ne indica i) il reddito pro capite a parità di potere d’acquisto e ii) il tasso di fecondità totale. Nel suo insieme il grafico mostra, come ha detto John, che la fecondità è alta in corrispondenza di redditi pro capite molto bassi e diminuisce all’aumentare del reddito; in sostanza che esiste una relazione inversa tra queste due variabili. Mostra però che la diminuzione è molto rapida per aumenti dei redditi più bassi, ma diventa progressivamente meno accentuata man mano che il reddito pro capite aumenta. Inoltre, vi è una notevole dispersione dei valori attorno al trend. In sostanza, se è vero che la fertilità tende a ridursi 87 I paesi interessati sono Cuba, Trinidad, Tobago, Barbados, Giamaica, Martinica, Antille Olandesi, Porto Rico e Santa Lucia. 88 Il grafico riporta i dati di 180 paesi. I valori del reddito pro capite a parità di potere d’acquisto sono quelli forniti dalla Banca Mondiale, mentre i tassi di fecondità sono della Population Division 68 all’aumentare del reddito pro capite, soprattutto in una fase iniziale del processo di sviluppo, è però anche vero che vi sono paesi in cui il reddito è molto basso e la fecondità relativamente alta e viceversa. Ad esempio, la Repubblica della Moldovia -che con un reddito procapite di circa 3.400 dollari occupa il 129esimo posto del ranking mondiale- per quanto riguarda questo indicatore, ha un tasso di fecondità totale di 1,25 che dovrebbe essere associato ad un reddito di circa 35,000 dollari. D’altra parte, gli Emirati con un reddito pro capite di oltre 48.000 dollari si trovano all’ottavo posto nell’ordinamento per PIL procapite, ma hanno un tasso di fecondità totale di 3,42. In sostanza, il livello di benessere economico influenza la fecondità, ma non ne è l’unica determinante. Inoltre, è del tutto possibile che la rilevanza del livello di reddito nello spiegare la fecondità dipenda dal fatto che esso è correlato con una serie di altre variabili quali il livello d’istruzione, in particolare delle donne, la presenza femminile nel mercato del lavoro, ecc., mentre altre variabili quali la religione e la cultura predominante o la diversa distribuzione del reddito possono spiegare l’ampia dispersione che osserviamo nel grafico. Figura 2 – PIL pro capite a PPA e Tasso di Fecondità totale, 2010 Fonte: Elaborazione su dati World Bank e UN DESA Li: Mi sbaglio o il tuo grafico potrebbe aiutarci a capire se e in che misura la legge sul figlio unico abbia avuto effetto? Mario: Buona idea. Potremmo vedere se il TFT della Cina sia coerente con il suo reddito pro capite e potremmo fare la stessa cosa anche con il Vietnam che ha adottato una legge che consente due figli per coppia. Michele: Lasciate che evidenzi la Cina colorando di rosso il suo “punto”. Come vedete la sua localizzazione indica una performance riproduttiva molto diversa da quella suggerita dal suo reddito pro capite. Infatti, la Cina ha un tasso di fecondità simile a quello dell’Italia, ma un reddito pro capite pari a un quarto. Prima che saltiate a delle conclusioni, vi faccio però notare che la Moldavia, l’Armenia e la Georgia, che hanno un reddito pro capite decisamente inferiore a quello cinese, e la Bosnia & Erzegovina, con un reddito pro capite leggermente superiore, hanno un TFT analogo a quello della Cina senza avere nessuna limitazione legislativa al numero delle nascite . John: E il Vietnam? Michele: Anche il Vietnam ha una fecondità inferiore a quella che sarebbe coerente con il suo livello di reddito pro capite, ma anche nel suo caso valgono le osservazioni precedenti. Insomma, sia nel caso della Cina, sia nel caso del Vietnam il tasso di fecondità è inferiore al valore atteso, ma questo tipo d’analisi non è sufficiente a dimostrare che la causa sia la legislazione adottata dai due paesi. 69 John: Comunque, guardando un grafico come questo è difficile sottrarsi all’idea che i comportamenti che esso riassume non rispondano a leggi ben precise e non siano la risultante di evoluzioni socio-economiche di lunghissimo periodo che spingono la specie umana lungo un sentiero comune. La transizione demografica Michele: Non sei il primo a pensarla così. Fu un demografo americano –mi sembra si chiamasse Warren Thompson 89 - a osservare per primo, verso il 1920, che negli ultimi 200 anni i paesi industrializzati erano stati caratterizzati da una tendenza demografica comune che li aveva condotti da una situazione iniziale di alta natalità e alta mortalità a una situazione di bassa natalità e bassa mortalità. Da qui si è poi sviluppato il modello, secondo alcuni la teoria, della transizione demografica. Certo il grafico precedente è, per dirla in inglese, impressive. A prima vista, esso sembra avere tutte le caratteristiche per giustificare il fatti che qualche demografo, invidioso della capacità dei colleghi fisici di scoprire le leggi eterne che Dio ha scritto nell’Universo, a quanto sembra usando una matematica abbastanza avanzata, abbia pensato che andamenti del tipo appena descritto rinchiudano gli elementi per una grande teoria della popolazione. Fra i più convinti c’é Chesnais; anzi secondo questo demografo francese la transizione demografica sarebbe l’unica teoria in possesso dei demografi, “una scienza nella quale le teorie generali sono rare” 90. La cosa interessante, e tutto sommato paradossale, è che si tratta di un fenomeno macroscopico che ha assunto dimensioni globali toccando ormai tutti i paesi del nostro pianeta, ma per il quale non disponiamo di una spiegazione condivisa. Li: Cosa vuoi dire? Michele: Voglio dire che non c’è accordo tra i demografi né sulle cause di questo fenomeno, né su quale sarà la sua evoluzione futura. Insomma, siamo di fronte ad una regolarità statistica per la quale abbiamo molte possibili spiegazioni, ma nessuna di esse soddisfa tutti gli studiosi della materia. D’altra parte, non è la prima volta che qualcuno prova a sviluppare una grande teoria della popolazione e fallisce. Il Malthus pensiero Mario: Ti riferisci a Malthus? Li: Ragazzi parlate di roba che non ho mai visto. Che cos’ha tutto ciò a che fare con la Cina? Michele: Scusa Li, hai ragione. Ricapitoliamo. Abbiamo visto che la Cina si trova sull’orlo di un disastro di origine demografica, per dirla con gli americani, di un demographic cliff, e che dovrà affrontare una situazione che, a prima vista, può apparire ridicola per il paese più popoloso del mondo: una contrazione paurosa della sua popolazione che porterà a una analoga contrazione della sue forze di lavoro e quindi a una significativa carenza di manodopera. Lo stesso fenomeno sta già interessando numerosi paesi europei e sta per interessarne numerosi altri sparsi in tutto il globo. Insomma, la Cina sará in buona compagnia. 89 Warren Thompson (1887–1973) pubblicò una prima versione della teoria della Transizione demografica in un articolo apparso nel 1929 quando era direttore della Scripps Foundation for Research in Population Problems, presso l’Università di Miami a Oxford, Ohio. Importanti contributi alla teoria della transizione demografica vennero poi dai lavori dei sociologi Dudley Kirk e Kingsley Davis, e dell’economista Frank Notenstein, tra il 1944 e il 1946. Nel 1943 Thompson pubblicò insieme a Whelpton degli scenari demografici per gli Stati Uniti che ponevano la popolazione americana al 2000 tra 129 e 198 milioni. Insomma, fin dall’inizio le proiezioni demografiche sono state dei fallimenti. Si veda: Warren Thompson (1929), ”Population”, American Journal of Sociology, 34 (6), pp. 959-975; Thompson, Warren S., and P. K. Whelpton (1943), Estimates of Future Population of the United States, 1940-2000, Washington, D.C. National Resources Planning Board. 90 Jean Claude Chesnais (1986), La transition demographique. Etapes, forms, implications economiques, PUF, Parigi, p. 3. 70 A questo punto stiamo cercando di capire cosa stia succedendo e quali siano le origini e le spiegazioni di questo fenomeno. Per questo abbiamo cominciato a parlare del modello della transizione demografica che è stato il primo a cogliere, sia pure parzialmente, le tendenze in atto. E in questo contesto è venuto fuori Malthus che circa due secoli fa propose una diversa teoria dell’evoluzione demografica. Li: Allora cominciate con lo spiegarmi meglio chi è questo Malthus e che cosa ha detto. Mario: Lasciate che sia io a stupirvi questa volta, perché Malthus mi ha sempre incuriosito e su di lui ho letto parecchio. La prima cosa da sapere è che si trattava di un pastore anglicano con la passione della matematica. Al tempo in cui pubblicò il suo “Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società” 91 si era in piena epoca illuminista, un periodo nel quale si aveva fiducia nelle capacità razionali dell’uomo. Pertanto, molti intellettuali, alcuni dei quali, come Rousseau, amici della sua famiglia, erano convinti che la società umana avesse delle ottime possibilità di migliorare la propria condizione. Malthus non condivideva questa visione ottimista del futuro. La sua era una visione cupa che non lasciava adito a molte speranze. Egli riteneva che crescita demografica e crescita del benessere non potessero coesistere. La società umana è inserita in un circolo vizioso che dipende, da un lato, dal fatto che le risorse naturali, e in particolare la terra da coltivare, siano limitate e, dall’altro, dal fatto che l’uomo sia inevitabilmente vittima della propria lussuria. La sua tesi era tutto sommato semplice. In una situazione di discreto benessere economico, e quindi di sufficiente disponibilità di cibo, la popolazione tende ad aumentare sotto la spinta degli irrefrenabili desideri sessuali di cui l’uomo è vittima. Tuttavia, poiché la terra fertile è limitata, ben presto diventa impossibile aumentare la produzione di beni alimentari al ritmo della crescita demografica e ciò finisce col provocare una carenza di risorse alimentari che finisce col provocare un calo della popolazione, il che apre la strada all’inizio di un nuovo ciclo. Malthus era convinto che si trattasse di una “trovata divina” per insegnare agli uomini un comportamento virtuoso. Li: Mi sembra che questo Malthus non l’abbia proprio azzeccata. Mario: Già. Le predizioni di Malthus non si sono avverate perché se è vero che la terra fertile è limitata, è anche vero che l’uomo è riuscito a trovare altri modi per aumentare il prodotto per unità di superficie coltivata. Ovviamente, soprattutto negli ultimi cinquanta anni, la capacità del pianeta di soddisfare un numero crescente di bocche è anche dovuta alle disperate condizioni di povertà -e quindi di sottoconsumo- di gran parte della popolazione umana. Mi chiedo se la produzione agricola sarebbe sufficiente qualora tutta la popolazione terrestre seguisse la “dieta americana”. John: Mario, non prendertela sempre e solo con gli Stati Uniti. Mi risulta che anche “Biggest Looser Asia” 92 sia un grande successo. Michele: Al di lá delle errate previsioni, vale però la pena riflettere su di una serie di cose. La prima è che, a mia conoscenza, Malthus è l’unico religioso che abbia messo in guardia l’umanità dal crescere e moltiplicarsi, spiegando che era uno sforzo inutile. Mario: Ovviamente Malthus vedeva in una virtuosa astinenza la cura del male, anche se era intimamente convinto che il suo consiglio non sarebbe stato seguito data la natura lussuriosa dell’uomo, particolarmente evidente nel comportamento delle classi inferiori. Aveva invece una fiducia totale e incondizionata nell’impatto della povertà che tali comportamenti avrebbero inevitabilmente generato e nell’eventuale sostegno di qualche 91 Di fatto Malthus ne pubblicò sei edizioni tra il 1798 e il 1826. Si tratta di un reality show televisivo che è andato in onda nel 2009 e nel 2010 sulle orme della celebre serie Americana nella quale un gruppo di obesi sono sottoposti a sevizie fisiologiche e psicologiche del tipo già ampiamente trattato in alcune opere fondamentali di Paolo Villaggio. Si veda ad esempio il suo incontro col famoso dottor Birkermeier: www.youtube.com/watch?v=vsQjAh8bFvg 92 71 misericordioso atto di Dio (epidemie, carestie, disastri naturali) che avrebbe contribuito a riportare più rapidamente la popolazione a una situazione, sia pure temporanea, di equilibrio. Michele: A Malthus va comunque riconosciuto il merito di aver sollevato il problema del rapporto tra popolazione e risorse disponibili sul pianeta, un dibattito che rimane vivo in un mondo la cui popolazione si appresta a essere dieci volte più numerosa di quella dei tempi di Malthus. John: Guardate che il problema non è la popolazione: la povertà non deriva dall’andamento demografico. I problemi nascono dall’adozione di politiche sbagliate, da strutture economiche inadeguate e da un’organizzazione sociale carente. Di fatto, una popolazione numerosa favorisce lo sviluppo economico aumentando la probabilità della comparsa di nuovi geni e rendendo più vivace la concorrenza tra individui. Mario: Bell’intervento John, ma credo che qui tu sia l’unico a credere in queste panzane. Fatemi anche ricordare che Malthus usò le sue tesi per opporsi a ogni riforma sociale (incluse le Poor Laws), essendo convinto che tali misure avrebbero consentito ai poveri di avere ancora più figli, annullando così i benefici di qualunque intervento volto ad aiutarli. Michele: Mente progressista e aperta, come quella di molti religiosi non solo del suo tempo! Comunque, su questi temi torneremo perché, non importa come uno la pensi, sarebbe opportuno che si discutesse di piú di demografia e del suo rapporto con l’economia. Tornando a Malthus, un altro punto fondamentale della sua tesi era che ci fosse una relazione positiva tra benessere e numero dei figli. Mario: Quindi l’opposto di quello che succede oggi. Jonh: Le motivazioni degli uomini rimangono le stesse sempre e ovunque, solo che situazioni diverse richiedono ricette diverse. In una società contadina la famiglia massimizza il proprio benessere producendo molti figli che forniscono braccia per i campi e sicurezza per la vecchiaia. Nelle società urbane il benessere delle famiglie richiede, invece, pochi bambini ben istruiti, coerentemente con un mondo che vuole persone ben preparate e famiglie non ostacolate da una prole eccessiva. Benessere economico e fecondità Michele: Mi fa piacere vedere che le ideologie non sono morte. Comunque, ciò che i dati mostrano, al di lá di ogni dubbio, è che le strategie riproduttive delle famiglie tendono a modificarsi all’aumentare del reddito e sono diverse in contesti con redditi diversi. D’altra parte, come abbiamo già visto, vi sono numerose variabili che si muovono insieme al reddito pro capite e che potrebbero avere un effetto diretto sul numero dei figli, prima fra tutte il livello educativo delle donne e, perché no, dei loro mariti. Mario: A me pare che il passaggio dalla società contadina alla società industriale e postindustriale abbia determinato, insieme all’aumento del reddito procapite, numerosi altri cambiamenti strutturali e valoriali dei quali dobbiamo tenere conto per comprendere le dinamiche demografiche. Tanto per citarne alcuni: l’affermarsi della famiglia mononucleare, il declino delle credenze religiose, una crescente libertà sessuale, la centralità dell’individuo, il diritto delle donne alle scelte riproduttive, i concetti stessi di consumo e tempo libero come importanti componenti della vita. Michele: Il problema è proprio questo. Le possibili spiegazioni del passaggio da una relazione diretta a una relazione inversa tra fecondità e livello di benessere sono tante che non vi è accordo su quali siano quelle fondamentali. Conviene, pertanto, tornare per il momento al modello, o meglio alla meccanica del modello della cosiddetta transizione demografica. 72 La rivoluzione demografica: dalla crescita alla contrazione della popolazione Li: Prima di tutto vorrei capire bene cos’è questa ”transizione demografica”. Michele: Una transizione è la fase intermedia tra due condizioni, il passaggio da una condizione a un’altra. Ad esempio, si parla di transizione scuola-lavoro. La transizione demografica indica il passaggio dal regime demografico tradizionale, caratterizzato da alta natalità e alta mortalità, al regime demografico moderno caratterizzato da bassa natalità e bassa mortalità. Li: Insomma, tra il regime demografico che caratterizza il mondo contadino e quello che caratterizza le società industriali e post-industriali. Michele: Esatto. Però uno degli aspetti fondamentali della teoria della transizione demografica è che entrambi i regimi sono descritti come regimi di equilibrio, vale a dire come situazioni in cui la popolazione è sostanzialmente stabile. John: E’ un aspetto che non ricordo. Michele: Una delle idee che domina l’analisi demografica è che fino all’inizio della rivoluzione industriale il tasso di crescita della popolazione mondiale sia stato molto modesto, con valori di lungo periodo vicini a zero. In sostanza, le società preindustriali sarebbero state in una situazione di quasi-equilibrio demografico nella quale il numero delle nascite era sostanzialmente uguale a quello delle morti. Mario: Mi sembra un’affermazione alquanto strana. Non so se lo sapete, ma tra il 69.000 e il 77.000 a.C. il supervulcano Toba che si trova nel nord dell’isola di Sumatra –un posto che mi piacerebbe tanto vedere – provocò una delle più grandi eruzioni che si siano mai registrate, precipitando tutto il pianeta in un inverno che durò tra i sei e i dieci anni e provocando un consistente abbassamento della temperatura che sembra sia durato qualcosa come 1.000 anni. Questo catastrofico evento avrebbe ridotto la popolazione umana a poche migliaia di unità il che spiegherebbe la scarsa variabilità genetica della nostra specie 93. Penso che abbia avuto effetti analoghi anche sui nostri cugini primati che quindi saranno partiti anche loro da una situazione numerica analoga alla nostra 94. Tuttavia, quando arriviamo verso il 1750 d.C. la popolazione umana ha toccato, correggetemi se sbaglio, quasi 800 milioni di unità, un valore che non credo fosse stato raggiunto da scimpanzé o gorilla. Insomma, la storia dell’umanità è la storia di uno straordinario successo demografico, soprattutto viste le mostruose carestie e pestilenze che l’hanno punteggiata e l’indole non proprio pacifica della nostra specie. John: Posso aggiungere una curiosità. Recenti ricerche hanno portato ad aumentare la stima del numero di persone che sono vissute fino ad ora. Mario: Dimmi, dimmi. Mi sono sempre chiesto quante persone siano nate prima di me. John: Verso il 1970 si riteneva che la popolazione di quel periodo rappresentasse circa 3/4 di tutti gli uomini che erano vissuti precedentemente. Dato che la popolazione mondiale era allora di quasi 4 miliardi, si giungeva alla conclusione che gli uomini vissuti fino al 1970 erano stati meno della popolazione attuale. Più recentemente è stata proposta una stima molto 93 E’ stata la giornalista Ann Gibbon a suggerire per prima nel 1993 l’esistenza di un possibile legame tra l’eruzione del supervulcano Toba e il collo di bottiglia nell’evoluzione umana. A livello accademico l’idea è stata ripresa prima da Michael R. Rampino della New York University e da Stephen Self della Universita delle Hawai a Manoa. Nel 1998, la teoria del collo di bottiglia fu ulteriormente sviluppata da Stanley H. Ambrose della Università dell’Illinois a Urbama-Champaign; Ambrose Stanley H. (1998), Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic winter, and differentiation of modern humans. Journal of Human Evolution 34 (6): 623–651. 94 Mario pensa di aver fatto una trovata, ma l’esistenza di un bottleneck anche in altri mammiferi è già stata studiata. Per quanto riguarda scimpanzé e orangutan si veda ad esempio Goldberg, T.L. (1996), Genetics and biogeography of East African chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii), Harvard University, unpublished PhD Thesis, and Steiper, M.E. (2006), "Population history, biogeography, and taxonomy of orangutans (Genus: Pongo) based on a population genetic meta-analysis of multiple loci", Journal of Human Evolution (50): 509–522. 73 diversa: 106 miliardi prima del 2002 il che ridurrebbe la percentuale della popolazione attuale sul totale dei nati a meno del 6 per cento 95. Mario: Insomma, l’andamento demografico precedente al 1800 non darebbe molto supporto alla tesi della stabilità demografica proposta da Malthus che, d’altra parte, non disponeva d’informazioni sull’andamento demografico dei secoli precedenti. Certamente non aveva cognizione che nel 10.000 a.C. la popolazione umana era di circa 10 milioni e che quindi era aumentata di oltre settanta volte tra il momento in cui fu scoperta l’agricoltura e il 1800. L’invenzione dell’agricoltura Michele: Quando facevo le elementari, nessuno dubitava del fatto che Cristoforo Colombo avesse “scoperto” l’America. Poi ci si è resi conto che l’America era stata scoperta almeno quattordicimila anni prima da una piccola pattuglia di nostri progenitori asiatici che riuscirono ad attraversare lo stretto di Bering. Più recentemente abbiamo capito che anche l’agricoltura e l’allevamento non furono delle scoperte, ma il b-product di una complessa serie di eventi e di scelte effettuate senza alcuna consapevolezza delle loro conseguenze e che ebbero luogo in maniera indipendente in diverse aree del pianeta. Se adottiamo una visione globale, ci accorgiamo che la comparsa dell’agricoltura è distribuita su di un arco temporale di circa 8.000 anni. Si va, infatti, da circa il 10.000 a.C., quando l’agricoltura compare nella cosiddetta mezzaluna fertile 96, al 2.500 a.C. quando compare nel Nord America. Il periodo diventa ancora piú lungo se includiamo il continente australe e le isole del Pacifico dove l’agricoltura fu portata dagli europei. Se poi prendiamo in considerazione il fatto che l’agricoltura fu introdotta indipendentemente in ecosistemi notevolmente diversi, mi pare molto difficile e comunque poco credibile cercare una causa unica della sua comparsa. Insomma, se non è esistito un Archimede Pitagorico che scoprì l’agricoltura una volta per tutte, dobbiamo concludere o che gli Archimede Pitagorici sono stati parecchi o, più probabilmente, che l’agricoltura non è stata scoperta, ma è stata il frutto di processi evolutivi. Mario: Michele, mi fai venire in mente la storia delle formiche tagliafoglie. Li: Cosa c’entrano le formiche? L’apologo delle formiche tagliafoglie Mario: Servono per confermare quello che ha appena detto Michele, che cioè l’agricoltura non è una scoperta. Dovete sapere che le formiche tagliafoglie, che sono diffuse su tutto il continente americano, circa 50 milioni di anni fa passarono da una fase guerriera e di caccia, che ancora contraddistingue molte altre specie di formiche, ad una fase basata sull’agricoltura e sull’allevamento. Le tagliafoglie adulte si cibano di linfa, ma le larve sono nutrite con un fungo, o meglio con dei corpuscoli rotondi chiamati gonglicidi prodotti dai funghi. I gonglicidi, da cui dipende la sopravvivenza della specie, sono il risultato di un complesso processo produttivo che inizia con la ricerca e la raccolta di foglie idonee, prosegue con il trasporto al formicaio e la distribuzione delle foglie in numerosi centri di coltivazione, dove sono lavorate e trasformate nell’humus per la cultura dei funghi; si conclude con la coltivazione vera e propria, la raccolta e la distribuzione del prodotto. L’ultimo aspetto di grande rilievo è che, per proteggere le loro colture, le formiche utilizzano degli antibiotici prodotti da dei batteri. Li: E’ una storia affascinante! Mario: L’introduzione dell’agricoltura ha avuto effetti profondi sulla vita delle 95 Haub, Carl (November/December 2002). "How Many People Have Ever Lived on Earth?". Population Today (Population Reference Bureau) 30 (8). 96 Come dice la parola stessa, è la fertile regione a forma di mezzaluna che include la Mesopotamia e il Levante ed è caratterizzata da estate calde, secche e lunghe, e da inverni piovosi e miti. 74 tagliafoglie. Esse vivono in centri urbani in grado di rivaleggiare per dimensione e complessità organizzativa con le nostre metropoli. Il loro sistema economico è centralizzato; il prodotto è accumulato e distribuito a tutti i membri della comunità e ciò ha reso possibile una divisione del lavoro molto articolata che, a sua volta, si è tradotta nell’evoluzione di formiche di forme e dimensioni differenti, coerenti con il lavoro svolto, ma anche nella comparsa di classi sociali. Vi sono gli scout che trovano le foglie, le tagliatrici, le trasportatrici, le distributrici -le cui dimensioni diminuiscono man mano che si scende nelle viscere del formicaio-, le soldatesse di grandi dimensioni, le spazzine e le addette alle discariche a cui è fatto divieto di entrare nel formicaio e vengono uccise se cercano di farlo. Insomma queste formiche hanno inventato anche gli intoccabili. Infine, il passaggio all’agricoltura ha fortemente ridotto il loro spirito guerriero, ma ció non toglie che le tagliafoglie siano le formiche dominanti ovunque si trovino. Li: Ma come hanno fatto le formiche a inventare l’agricoltura? Mario: Il punto è proprio questo: non l’hanno inventata. Si è trattato di un processo di coevoluzione, vale a dire di adattamento reciproco di tre specie (le formiche, i funghi e i batteri) che hanno originato uno dei più complessi esempi di mutualismo 97. John: Non sono sicuro di aver capito tutto, ma mi sembra una prospettiva molto interessante e che ci aiuta a capire cosa possa essere successo ai nostri antenati. Comunque, Mario, dove le impari queste cose? Mario: Hai presente la rubrica: “Lo sapevate che …” sulla Settimana Enigmistica. Un’altra rubrica fondamentale che vi consiglio è “Strano ma vero”. John: Non fare l’asino! Tu e Michele state dicendo che anche per gli uomini si è trattato di un processo di co-evoluzione dell’uomo con le piante che avrebbe poi coltivato e con gli animali che avrebbe poi allevato? Insomma, gli uomini avrebbero seguito un percorso analogo a quello delle tagliafoglie, ma con un ritardo di cinquanta milioni di anni? Il grande decollo Michele: Esattamente, e come ha detto Mario molte delle conseguenze socio-economiche sono state simili. Comunque, l’uomo aveva già fatto un lungo percorso che lo rendeva pronto a sfruttare quella co-evoluzione in direzioni sempre nuove, cosa che le formiche non hanno saputo fare rimanendo ferme allo stesso processo produttivo e alla stessa organizzazione sociale per decine di milioni di anni. In particolare c’è un momento speciale nella storia della nostra specie. Circa 40.000-50.000 anni fa –siamo nel periodo della cosiddetta cultura CroMagnon- apparvero in maniera improvvisa una serie d’innovazioni tecnologiche che si pongono su di un piano totalmente diverso da quelle introdotte fino ad allora. L’uomo di CroMagnon adotta nuovi materiali, quali l’osso e l’avorio, costruisce strumenti composti di più parti e mirati a scopi specifici tutt’ora facilmente riconoscibili; introduce armi più efficaci quali il lancia-dardi e l’arco; inizia a pescare e utilizza subito strumenti sofisticati quali ami ed arpioni, mentre inventa la corda con cui costruisce lenze e reti; cuce i propri vestiti e costruisce le prime case. Questa fase di grande esplosione creativa culmina nelle prime affascinanti produzioni artistiche nei campi della pittura, della scultura e della musica, mentre i gioielli rinvenuti in numerose tombe testimoniano non solo la presenza di un avanzato gusto estetico, ma evidenziano anche la presenza di una stratificazione sociale della quale i gioielli sono gli strumenti di comunicazione. Infine, questa data segna l’inizio dell’espansione a tutti i continenti di un uomo moderno sia da un punto di vista biologico, sia comportamentale 98. 97 Il mutualismo e la modalità con cui due o piu organismi di specie diverse esistono in una relazione da cui entrambi traggono beneficio. 98 Jarred Diamond (1997), Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies: W.W. Norton & Company, pag. 39 75 Mario: Diamond ha parlato di Grande balzo in avanti e Mithen di Big bang 99. Michele: Io credo, che si dovrebbe parlare di Grande decollo perché la razza umana non è mai atterrata e la sua velocità di crociera non è mai diminuita, ma semmai è aumentata. Credo poi che alla domanda quando inizi la nostra storia si debbano dare due risposte: la prima, da quando comparve la prima cellula vivente, il che stabilisce con chiarezza la nostra connessione con tutti gli organismi viventi, monocellulari e multicellulari presenti sul pianeta; la seconda, alla fase che abbiamo appena descritto. E’ da quel momento che l’uomo comincia a evidenziare in maniera chiara il suo aspetto più caratterizzante, la capacità di creare e innovare. Mario: Dawkins ha sostenuto che se qualcuno ci osservasse da un altro pianeta e potesse cogliere con un solo colpo d’occhio tutti i traguardi raggiunti dall’uomo nell’era moderna -e se ricordo bene vi include, oltre a quelli in campo informatico, la Cappella Sistina, la Relatività speciale, le Variazioni di Goldberg e la congettura di Goldback- le potrebbe tranquillamente considerare coeve della Venere di Willendorf e della grotta di Lascaux. Li: Continuate a dimenticarvi che i miei riferimenti culturali sono diversi! Michele: Scusa Li. Al di lá delle citazioni dotte di Mario –che ogni tanto si lascia prendere un po’ la mano- stiamo solo cercando di dire che la storia dell’uomo moderno comincia circa 40.000 anni fa e questo nel bene e nel male. Molti studiosi sono, infatti, convinti che la scomparsa dei Neandertal, l’altra specie umana con cui abbiamo condiviso una parte del pianeta per oltre 100.000 anni e della quale sembra esista qualche traccia nel nostro DNA, fu dovuta a quei nostri antenati così come appare sospetta la sparizione della megafauna in Australia e nelle Americhe non appena essi raggiunsero questi continenti. Li: Abbiamo cominciato bene. Mario: … e continuato meglio. La totale indifferenza per l’ambiente che ci circonda o meglio l’idea di poter sfruttare tutto ciò che si trova sulla terra senza alcuna considerazione del futuro sembra sia stata con noi sin dall’inizio. Introduzione dell’agricoltura e prima transizione demografica Michele: Ragazzi, torniamo alla “scoperta” dell’agricoltura. Essa ha certamente rappresentato una tappa fondamentale della storia umana e quindi non è sorprendente che alcuni demografi abbiano pensato di individuare anche una transizione demografica collegata alla transizione produttiva dalla fase della caccia e della raccolta a quella dell’agricoltura. Secondo Livi Bacci -cha ha introdotto questa tesi poi riproposta da Bocquet-Appel 100 - il passaggio all’agricoltura avrebbe generato un’accelerazione della crescita demografica. John: Suppongo che la causa sia individuata nella sedentarietà. Michele: Esatto. Secondo Livi Bacci, nel periodo in cui la vita era nomade, le nascite erano scandite dal periodo necessario ai nuovi nati per diventare autonomi. Comunque, il controllo della crescita demografica sarebbe stato affidato soprattutto a un tipico meccanismo malthusiano di aumento della mortalità a seguito di un aumento della popolazione101. Insomma, anche la fase della caccia e della raccolta sarebbe stata caratterizzata da una crescita demografica praticamente nulla. Mario: Questi demografi sono proprio fissati con l’idea di una popolazione stabile! 99 Jarred Diamond, op. cit.; Mithen, S. J. (1996), The Prehistory of the Mind, a search for the origins of art, religion, and science, London, Thames and Hudson. 100 M. Livi Bacci (2002), Storia Minima della Popolazione, Il Mulino, pag. 57; J.P. Bocquet-Appel (2002), Paleoanthropological Traces of Neolithic Demographic Transition, Current Anthropology, 43, pagg. 638–650. 101 Davis Kingsley (1986), “Below Replacement fertility in Industrial Societies. Causes, consequences, policies”; Population and development Review; A Supplement to Volume 12, Cambridge University, Cambridge, pag. 49 76 Michele: Il concetto di popolazione stazionaria è duro a morire perché è molto comodo da un punto di vista analitico. Questa idea di una prima transizione mi sembra, comunque, più che altro una curiosità intellettuale, difficile da verificare. Per farlo bisognerebbe avere dati relativi alla popolazione mondiale e alla sua distribuzione territoriale in tre momenti di tempo, ad esempio il 18.000 a.C., il 10.000 a.C. e l’anno 1, cosa ovviamente impossibile. Tenete inoltre presente che non c’è neppure accordo su come si sarebbe verificata. Mario: Cioé? Michele: Beh, ci sono due scuole di pensiero. La prima imputa l’accelerazione della crescita demografica a un calo della mortalità dovuto al miglioramento del livello nutritivo prodotto dall’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento. L’altra scuola di pensiero obietta che l’agricoltura avrebbe invece prodotto un’alimentazione più povera e meno variata, nonché l’insorgere e il diffondersi di malattie infettive. Di contro, la vita sedentaria avrebbe garantito un incremento della fecondità maggiore di quello della mortalità. Mario: Tu cosa ne pensi? Michele: Io sono un demografo dilettante. Però ho l’impressione che questa tesi di una prima transizione sia forzata e ispirata dall’idea che, come il passaggio dall’agricoltura all’industria è stato accompagnato da uno sconvolgimento demografico, lo stesso sia successo con il passaggio dalla fase di caccia e raccolta alla fase agricola. Ora, non solo si tratta di una tesi basata su indizi e prove indirette, ma ci sono altre considerazioni che creano seri dubbi. In primo luogo sappiamo che anche nel primo neolitico il numero di figli poteva essere elevato 102. Ma anche ammettendo che l’agricoltura porti a una dinamica demografica piú accentuata, non solo il suo inizio in aree diverse del mondo è distribuito su oltre 10.000 anni, ma la sua diffusione dai centri di partenza prese tempi molto lunghi. Nell’Europa del Nord, ad esempio, il passaggio all’agricoltura, avvenne tra il 5.000 e il 3.500 a.C., fu molto graduale e numerose comunità rimasero a lungo in una situazione intermedia. Infine, parlare di agricoltura tout court è una semplificazione eccessiva. Nella fertile mezzaluna, e di riflesso anche in Europa, la messa a coltura delle piante che dovevano poi costituire una delle fonti principali di nutrimento della popolazione avvenne su di un periodo di circa 6.000 anni. L’agricoltura mista, che accoppia coltivazione dei campi e allevamento di animali che forniscono sia proteine, sia forza motrice rendendo l’agricoltura più efficiente e produttiva, è rimasta del tutto assente in numerose aree del pianeta fino a tempi recenti per la mancanza di animali idonei. Altri contributi alla produttività del settore agricolo sono venuti dall’introduzione di utensili migliori, tecnologie sempre più raffinate per la conservazione dei prodotti agricoli e l’irrigazione dei campi, quali i mulini a vento e ad acqua, tutti eventi che si distribuiscono su tempi lunghi. La conclusione è che, a partire dal 10.000 a.C., il settore agricolo è stato caratterizzato dalla presenza di comunità a diversi livelli di sviluppo tecnologico e organizzativo. Insomma, fatte tutte queste premesse, anche ammettendo che un sistema agricolo consenta una maggiore fecondità o riduca la mortalità, è difficile individuare quando ciò sia successo nelle varie aree del mondo e quindi quale sia stato il suo contributo all’accelerazione della crescita demografica. Speciazione e problem solving Mario: Io vorrei tornare alla storia delle formiche. Li: Ma è una fissazione! 102 Mary Jackes and Chris Meiklejohn, “Building a method for the study of the mesolithic – neolithic transition in Portugal”. Documenta Praehistorica, XXXI. Lo studio riguarda alcuni siti portoghesi che coprono il periodo dal 6000 al 4000 A.C. e che permettono di analizzare il passaggio dal mesolitico al neolitico. L’analisi, basata su di una analisi estremamente accurata degli scheletri rinvenuti nei siti di Moita, Casa de Moura e Arruda, porta i due autori a sostenere che l’ultima fase del mesolitico fu caratterizzata da un progressivo incremento della fertilità riconducibile ad un cambiamento di stile di vita (maggiore sedentarietà) ed ottenuto tramite un riduzione degli intervalli fra i parti. 77 Mario: Si, sono colpito dalle conseguenze dell’introduzione dell’agricoltura. Nel caso delle formiche, l’agricoltura ha generato una sofisticata divisione del lavoro ed un’organizzazione sociale estremamente articolata. D’altra parte, anche le differenze con ciò che è successo nella nostra società sono ugualmente istruttive. L’agricoltura delle tagliafoglie è rimasta monoprodotto, l’articolazione dei mestieri non è stata accompagnata da innovazioni tecnologiche, ma da un’evoluzione biologica (non nuovi strumenti, ma formiche diverse). Infine, l’agricoltura non è stata imposta alle altre specie di formiche che per altro non l’hanno copiata e le formiche coltivatrici non hanno invaso il pianeta. John: Qual’è l’implicazione di tutto ciò? Mario: Che la caratteristica principale dell’uomo è la sua capacità di risolvere problemi attraverso soluzioni innovative e creative. Per tutti gli altri esseri viventi la necessità di far fronte a situazioni climatiche diverse, a una diversa disponibilità delle risorse opera nella direzione di privilegiare la selezione degli individui pi idonei, un processo che in presenza di limitato interscambio con altri territori o vincoli sessuali porta alla speciazione. Negli ultimi 200.000 anni l’uomo ha affrontato situazioni di questo genere inventando nuove tecnologie il che gli ha permesso, da un lato, di mantenere un’elevatissima omogeneità genetica, dall’altro, di espandere l’ammontare delle risorse disponibili. Michele: Sono d’açcordo anche perché non mi sembra di cogliere nell’evoluzione demografica delle società tradizionali molte evidenze di un equilibrio di lungo periodo come conseguenza di vincoli di carattere economico. Mario: Hai una proposta alternativa? Crescita delle disponibilità energetica e crescita demografica Michele: Io credo che l’agricoltura fornisca una prospettiva troppo limitata e convenga ipotizzare che il livello della popolazione dipenda dall’ammontare di energia che l’uomo riesce a estrarre dall’ambiente sotto forma di cibo e di combustibile e che la dinamica demografica di lungo periodo dipenda dalla capacità di aumentare tale livello. John: Va avanti. Michele: In questa prospettiva, l’estensione degli stanziamenti umani e la capacità di sfruttare le risorse naturali disponibili su tale territorio costituiscono sia le premesse della crescita demografica, sia i suoi vincoli. Ve lo faccio vedere con un grafico. Li: Sei sicuro che aiuti? Figura 3 – Popolazione e livello di utilizzo dell’energia 78 Michele: Certo. Sull’ordinata (l’asse verticale) mettiamo la popolazione e sull’ascissa (l’asse orizzontale) il livello di sfruttamento dell’energia disponibile. Ogni curva si riferisce a un periodo della storia umana. In ogni periodo la popolazione dispone di una combinazione – un paniere direbbe un economista- di risorse costituite dal territorio che occupa e dalle risorse naturali che esistono su tale territorio e quindi di un dato ammontare potenziale di energia. La popolazione iniziale può crescere aumentando il livello di sfruttamento delle risorse. Tuttavia, aumenti uguali della popolazione richiedono aumenti via via crescenti delle risorse disponibili utilizzate. Il caso più semplice è quello classico in cui le terre messe progressivamente a coltura hanno livelli di fertilità decrescenti. In generale, tuttavia, l’origine di questo fenomeno, di questi rendimenti decrescenti, può essere individuato nella crescente complessità del processo di sfruttamento delle risorse e/o nella presenza di una quantità fissa di qualche risorsa fondamentale. John: Suppongo che sia questo che determina la forma concava delle curve. Michele: Esatto. Mario: Quindi, se capisco bene, ogni curva è un caso malthusiano in cui la popolazione umana ha un limite superiore che raggiunge quando le risorse disponibili in tale fase storica siano completamente sfruttate. Michele: Sì, ma il punto è che nel corso della storia l’uomo ha saputo aumentare il paniere delle risorse disponibili, acquisendo nuovi territori, trovando nuovi prodotti agricoli e nuove risorse naturali, ma soprattutto mediante un progresso tecnologico che in certi momenti ha fatto compiere veri e propri balzi alla quantità di energia disponibile. Il grafico visualizza questo fenomeno con una serie di traslazione verso l’alto della relazione tra livello della popolazione e livello di utilizzo delle risorse. John: Vediamo se ho capito. Le singole curve rappresentano quello che possiamo chiamare il breve periodo in cui le risorse sono date. In questo caso la crescita della popolazione umana incontra crescenti difficoltà e ha un limite superiore. Tuttavia, gli uomini sono riusciti a traslare verso l’alto questa curva soprattutto tramite la capacita di innovare, d’introdurre nuove prodotti e nuove tecnologie. Michele: Esattamente e quindi possiamo utilizzare il grafico per “disegnare” la storia della popolazione umana tramite un sentiero di espansione, una linea che collega le varie curve di livello pur snodandosi in parte lungo di esse. Se nel lungo periodo il nostro sentiero presenta un andamento chiaramente ascendente, non sono però mancate fasi durante le quali la popolazione umana si è contratta, ridiscendendo lungo la curva su cui si trovava o scivolando su di una curva piú bassa. In genere arresti e regressi della crescita demografica sono stati provocati da pestilenze, carestie, guerre che non credo siano state provocate dalla crescita demografica. Mario: Ma qual’è stata l’effettiva evoluzione demografica? Michele: Secondo la stima più ottimistica, nel periodo in cui agricoltura e allevamento fecero la loro comparsa la popolazione umana ammontava a circa 10 milioni. Essa sarebbe poi raddoppiata nei successivi 5.000 anni, per aumentare di 20 volte nei 5.000 successivi. All’inizio dell’era cristiana, la popolazione umana sarebbe stata di 400 milioni, un valore che pur tra alti e bassi non sarebbe più stato raggiunto fino alla fine dell’undicesimo secolo. Nei secoli successivi l’andamento demografico fu positivo, ma altalenante a causa di una serie impressionante di epidemie, carestie e guerre. Mario: Fino a quando possiamo utilizzare il modello che ci hai presentato? 79 Figura 4 – L’andamento demografico di lungo periodo Michele: Direi che il rapporto tra popolazione ed energia che ho ipotizzato è tuttora valido, anche se l’interazione con l’ambiente è oggi cosà complessa che una semplificazione di questo genere può essere eccessiva e fuorviante. In sostanza, credo che il modello illustri bene quello che è successo fino alla seconda metà del XIX secolo, anche se non può rendere conto di singole situazioni che debbono essere analizzate non con il telescopio, ma con il microscopio. Figura 5 – La popolazione mondiale dal 10.000 a.C al 1950 d.C. Fonte: Census Bureau degli Stati Uniti Li: Perché fino alla seconda metà del diciannovesimo secolo? Michele: Perché è in quel periodo che in Europa si palesa in maniera rilevante la rivoluzione demografica che sta ormai interessando quasi tutti i paesi del mondo e che è all’origine della futura carenza di manodopera della Cina. Li: Quindi, è colpa vostra. Michele: Solo nel senso che il fenomeno è cominciato in questa parte del mondo. John: Perché hai detto rivoluzione e non transizione? Transizione o rivoluzione demografica? Michele: Come ho già detto, la teoria della transizione demografica prevede il passaggio da un regime demografico tradizionale, caratterizzato da alta natalità e alta fertilità, a un 80 regime demografico moderno, caratterizzato da bassa natalità e bassa mortalità. Essa prevede cioè che il calo del tasso di fecondità si arresti al valore di rimpiazzo di due figli per donna e ciò in base all’idea che la popolazione mondiale sia sempre stata caratterizzata da una sostanziale stabilità di lungo periodo. In sostanza, secondo la teoria della transizione demografica, ciò che è successo negli ultimi duecento anni e succederà nei prossimi cento sarebbe solo un’eccezione. Mario: Mi sembra che ci voglia un notevole coraggio per definire il casino demografico che ci circonda un’eccezione. Michele: Vi sono stati anche demografi che hanno sostenuto che non vi fosse alcuna ragione teorica o evidenza empirica per ritenere che il tasso di fecondità avrebbe frenato bruscamente una volta giunto in vista del magico valore di due e che l’esito più probabile delle attuali tendenze sarebbe un calo della popolazione 103. Comunque, il punto è che, se il fenomeno che stiamo vivendo non è il passaggio da una situazione di equilibrio a un’altra situazione di equilibrio, non vi è alcun motivo di parlare di transizione e sarebbe più opportuno parlare di rivoluzione demografica. Purtroppo la dizione transizione è ormai talmente radicata che dubito si riuscirebbe a cambiarla, anche se fosse chiaro che ci stiamo dirigendo verso una fase di disequilibrio demografico permanente. Mario: Di cosa parliamo quando diciamo alta natalità e alta mortalità? Michele: Nelle società tradizionali i tassi di natalità e mortalità si aggiravano tra il 40 e il 50 per mille. Quindi, in un villaggio con 1.000 abitanti vi erano un funerale e un battesimo quasi tutte le settimane. Mario: Ottima situazione per i preti. John: Magari è la transizione demografica che spiega la caduta delle vocazioni. Mario: Numeri impressionanti che dovevano generare una società molto diversa da quella in cui viviamo. Michele: Certo e molto diversa da quella che vediamo nei lindi villaggi dei film in costume, così piacevolmente rappresentata da Mel Brooks 104. Li: Adesso però vorrei poter vedere qualcosa che mi facesse capire meglio di cosa stiamo parlando. John: Ragazzi veloci però perché il mio Romney .., Mario: Non dovresti aver fretta di perdere. Le fasi della “Transizione demografica” Michele: Pochissimi paesi dispongono di serie storiche sufficientemente lunghe per visualizzare tutta la transizione demografica. Un’eccezione è rappresentata dalla Svezia che ha dati relativi ai tassi di natalità e mortalità a partire dal 1735. All’inizio della storia i tassi di natalità e di mortalità erano, come da copione, elevati e stazionari, con una leggera prevalenza del tasso di natalità. Verso l’inizio del XIX secolo il tasso di mortalità comincia a diminuire, mentre il tasso di natalità rimane sui valori tipici del regime tradizionale. Dopo circa 70 anni anche il tasso di natalità comincia a diminuire e lo fa ad una velocità superiore a quella del tasso di mortalità. Cosi dopo circa 100 anni i valori dei due indici convergono su di un valore 103 Nel 1992, ad esempio J.C. Caldwell aveva osservato che non vi era niente nelle ricerche da lui condotte che suggerisse qualche ragione per la quale il calo della fertilità, determinato dalla transizione demografica, dovesse arrestarsi al livello di rimpiazzo, come suggerito dalla teoria classica della transizione demografica. Egli sostenne che l’ipotesi piu probabile era che la popolazione dei paesi occidentale cominicasse a diminuire all’inizio del xxi secolo e quella del mondo alla fine del secolo. J.C. Caldwell, 1992, Theory of Fertility Decline, Academic Press, New York; pag. 264. 104 Il riferimento e al film del 1993, Robin Hood: Men in Tights. 81 di circa il 10 per cento. Arriviamo infine alla terza e ultima fase della transizione nella quale il valore del tasso di natalità scende sotto il valore del tasso di mortalità. Li: Credo di aver capito l’idea generale. Adesso mi piacerebbe sapere che cosa ci sia dietro a questa storia e che cosa l’abbia innescata Figura 6 – La transizione demografica in Svezia; tasso lordo di natalità e tasso lordo di mortatità; 1735-1995 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition Michele: Tra il 1750 e il 1850 la popolazione europea aumentò dell’88,3 per cento, passando da 111 a 209 milioni, una crescita record per il nostro continente che aveva registrato aumenti massimi del 51 per cento tra il 1200 e il 1340 e del 24,7 per cento tra il 1600 e il 1750. Secondo l’interpretazione prevalente, il fenomeno fu dovuto a un calo della mortalità riconducibile a due cause fondamentali: da un lato, la riduzione delle grandi crisi di mortalità dovute a carestie ed epidemie, dall’altro, il calo della mortalità normale da imputare essenzialmente alla diminuzione della mortalità infantile. Tuttavia, fino a oltre la metà del secolo, gli indicatori demografici non facevano certo presagire quello che stava per accadere. Ancora nel 1850 in tutti i maggiori paesi europei, ad eccezione della Francia, la fecondità era su livelli tipici del regime tradizionale e la stessa cosa vale anche per la mortalità, addirittura fino al 1880. Comunque, sempre secondo questa tesi, l’iniziale diminuzione della mortalità provocò un’accelerazione della crescita economica e l’aumento della pressione sulle risorse mise in moto dei meccanismi riequilibratori, in particolare una contrazione della fecondità che fu, a sua volta, il frutto di una rallentata nuzialità e di un controllo volontario delle nascite. Tavola 2 – Alcuni paesi europei; Tasso di Fecondità Totale (1850 e 1950) e Speranza di Vita (1880 e 1950) 1850 Inghilterra Francia Svezia Germania Italia Paesi Bassi 4.56 3.27 4.28 5.17 4.67 4.98 Tasso di Feconditá Totale 1950 Var. assoluta -2.38 2.18 2.73 -0.54 2.21 -2.07 2.16 -3.01 2.32 -2.35 2.85 -2.13 Var. % -52.2 -16.5 -48.4 -58.2 -50.3 -42.8 1880 43.3 42.1 48.5 37.9 45.4 41.7 Speranza di vita 1950 Var. assoluta Var. % 69.2 25.9 59.8 66.5 24.4 58.0 71.8 23.3 48.0 67.5 29.6 78.1 66 20.6 45.4 72.1 30.4 72.9 Fonte: Massimo Livi Bacci, Storia Minima della Popolazione, 2002 John: Il tutto mi sembra molto meccanico. 82 Michele: Lo é. E infatti non mancano analisi più articolate che fanno riferimento alle trasformazioni socio-economiche messe in moto dalla rivoluzione industriale e che Mario ha già in parte ricordato. Possiamo aggiungere anche le spiegazioni economicistiche secondo le quali in una società industriale il costo dei figli aumenta determinando una minore attività di shopping in questa direzione. Mario: Michele, tu come la vedi? Dal regime naturale al regime della consapevolezza e della scelta Michele: A me sembra che si tenda ad esagerare il ruolo dell’industrializzazione e della urbanizzazione. I dati della tavola che vi ho appena fatto vedere (tenete presente che non ve ne sono molti di più) mostrano che in Europa le trasformazioni più pronunciate degli indicatori demografici si verificarono nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX quando la popolazione era ancora prevalentemente contadina e l’impatto dell’industrializzazione riguardava una quota limitata della popolazione. D’altra parte le tesi economicistiche potrebbero eventualmente avere una qualche capacità esplicativa solo dopo la seconda guerra mondiale. Mario: E allora? Michele: Sono convinto che le cause della rivoluzione demografica siano state molto numerose e in mix diversi in paesi diversi. Tuttavia, il progresso economico, l’aumento del reddito, l’urbanizzazione non possono di per sé ridurre la fecondità e aumentare la durata della vita; ne sono premessa indispensabile, condizione necessaria, ma non sufficiente. Servono anche una discreta comprensione dei processi riproduttivi e adeguate conoscenze della fisiologia umana. In conclusione, anche se potrà sembrare una semplificazione eccessiva, sarei propenso a dividere la storia della popolazione in sole due fasi. John: Quali? Michele: La prima fase è quella che definirei del Regime Naturale nella quale la capacità degli uomini di controllare natalità e mortalità è praticamente nulla. Mario: Per quello che ne so io, sempre con il supporto della settimana enigmistica e di Wikipedia, il controllo volontario della fecondità è stato attuato in maniera cosciente in pochissime società: tra le élite romane nella fase di massimo fulgore dell’Impero, tra i borghesi ginevrini del XVII secolo e in Francia all’inizio del XIX secolo 105. Per il resto si è sempre trattato di meccanismi di controllo indiretti che si realizzavano attraverso prassi relative all’età al matrimonio o al prevalere di contesti socio-economici che consentivano solo ad una parte della popolazione di formarsi una famiglia. Credo, però, che sarebbe sbagliato attribuire il mancato controllo della fecondità solo alla mancanza di conoscenze. Un ruolo importante l’ha certamente avuto anche la visione fatalistica che pervadeva molte società africane e dell’Asia meridionale, ma anche quelle più vicine a noi per le quali i bambini rappresentavano un dono di Dio. Per quanto riguarda la morte, malgrado i documentari che cercano di stupirci illustrandoci la capacità di alcuni nostri progenitori di trapanare il cranio di poveri disgraziati affetti da emicrania, resto convinto che ne uccidessero più i medici delle malattie. Michele: Sono totalmente d’accordo. Credo che questa situazione sia durata ininterrottamente fino alla seconda metà del secolo XIX. E’ allora che inizia la seconda fase della storia della popolazione mondiale caratterizzata da un crescente controllo dell’uomo 105 Per una conferma si veda Massimo Livio Bacci, op. cit. 83 sulla procreazione e sulla morte. E’ questo controllo che a me pare l’elemento fondamentale della rivoluzione demografica alla quale stiamo assistendo e della sua diffusione. Insomma quello che si sta imponendo è il Regime della conoscenza, della consapevolezza e della scelta. Mario: Non c’è dubbio che è alla metà del secolo XIX che inizia uno straordinario processo di crescita delle conoscenze chimiche e biologiche. Cose che oggi sembrano scontate ebbero effetti importantissimi, a partire dall’indicazione che era opportuno che coloro che attendevano un parto si lavassero le mani 106 e dall’introduzione di pratiche operatorie antisettiche 107. La scoperta che certe malattie erano causate da specifici organismi aprì la strada allo sviluppo di vaccini per le malattie contagiose più diffuse 108. Nel 1899 fu scoperta l’aspirina, nel 1929 la penicillina e nel 1943 la streptomicina. La seconda metà del XX secolo si apre con la scoperta della struttura del DNA -che per il momento non ha certo prodotto i risultati che ci si attendeva, ma che potrebbe finire con il farlo nei prossimi anniseguita da una impressionante accelerazione dei progressi della medicina nel campo dei trapianti e dello sviluppo di nuovi medicinali. Michele: E’ sempre in questo periodo che si diffondono le conoscenze relative ai meccanismi riproduttivi e vengono introdotti sistemi anticoncezionali più sicuri e di facile uso (in particolare la spirale e la pillola) che permettono alle coppie di avere una fecondità controllata, cioè non di subire, ma di scegliere il numero di figli. John: Insomma, secondo te la popolazione umana sarebbe andata attraverso due sole fasi caratterizzate, la prima, da un Regime demografico naturale in cui gli uomini non avevano nessun controllo su fecondità e durata della vita e una seconda fase in cui tale controllo è divenuto sempre più completo. Michele: Esattamente. Allo stesso tempo l’aumento della durata della vita è stato perseguito “automaticamente” da tutte le popolazioni, man mano che le possibilità di cura aumentavano e divenivano utilizzabili a seguito dell’aumento del reddito. Gli strumenti per controllare la fecondità hanno reso possibile scelte riproduttive coscienti, ma la loro adozione ha richiesto e richiede trasformazioni socio-economiche che sono il portato dello sviluppo economico, a parità però anche di altri fattori, fra cui quello religioso. Infine, sono convinto che queste due fasi demografiche finiranno con avere esiti opposti. La prima è stata caratterizzata da un lento aumento della popolazione. La seconda, che inizia con una esplosione demografica che si è estesa e si sta estendendo da un paese all’altro come in una 106 Questa idea geniale e rivoluzionaria venne al medico austriaco Ignaz Semmelweis verso il 1848. Anche quella di Ignaz è una storia interessante. Ignaz, noto come il padre del controllo delle infezioni, nacque in Ungheria e si laureò in medicina a Vienna nel 1844. Nel 1847 ricevette un incarico biennale di assistente presso un reparto di ostetricia. Fu così che gli capito di osservare che le donne che erano assistite da medici e studenti in medicina registravano una mortalità più elevata delle donne assistite da ostetriche. Ignaz ipotizzò che la cosa fosse dovuta al fatto che medici e studenti maneggiavano cadaveri prima di assistere ai parti. Portò così avanti un esperimento che prevedeva l’obbligo di lavarsi le mani prima di andare in sala parto e poi il lavaggio degli strumenti medici. L’esperimento dimostrò la validità della sua tesi. Come da copione, il suo capo, il celebre Prof Klein, negò l’evidenza e sostenne -sulla base del paradigma condiviso che dava la colpa delle infezioni ai cosiddetti miasmiche la riduzione delle morti fosse dovuta al nuovo impianto di condizionamento. Ignaz perse il posto di lavoro, tornò in Ungheria e dopo una serie di esperienze di lavoro non troppo felici in cui cercò con poco successo di promuovere la propria tesi, mori in un manicomio, dopo cinque anni di degenza. 107 Joseph Lister procedendo lungo ls strada aperta da Ignaz Semmelweis, e sulla base dei suggerimenti di Pasteur, pubblicò nel 1867 un volume dal titolo: “Antispetic principles fo the practice of Surgery” 108 Dopo I primi esperimenti di vaccinazione contro il vaiolo fatti da Jenner alla fine del XVIII secolo, il vaccino contro il colera fu scoperto nel 1879, quello contro l’antrace nel 1881, contro la rabbia nel 1882, contro la febbre tifoide nel 1896, contro la plaque nel 1897, contro la difterite nel 1923, contro il tifo nel 1937, contro l’influenza nel 1945, contro la poliomelite nel 1955, contro il morbillo nel 1964, contro gli orecchioni nel 1967. 84 catena di fuochi d’artificio, porterà invece a un notevole calo della popolazione umana, forse tale da consentire una riduzione del consumo delle risorse naturali. Li: Prima di parlare dei grandi scenari, io vorrei capire bene come questa rivoluzione demografica possa produrre carenza di manodopera in Cina e in altri paesi e contemporaneamente condannare numerosi paesi africani ed asiatici ad una spaventosa esplosione demografica. Michele: Questo è il punto centrale di tutta la vicenda. John: Fermi tutti. Anche a me questa cosa interessa moltissimo, ma non possiamo parlarne adesso: stanno per arrivare i primi risultati. Lasciate che vi riempia i bicchieri per brindare alla vittoria di Romney. Ciò che successe quella notte che si chiuse con il grande coro al McCormick Place di Chicago è ormai storia. John rimase depresso per lungo tempo. Li fece notare che Obama era stato eletto con 65 milioni di voti che rappresentavano poco più di un quarto degli elettori. Mario e Michele brindarono a Obama augurandosi che riuscisse finalmente a fare alcune delle cose che aveva promesso, come ad esempio chiudere Guantanamo e trovare una soluzione più umana ai problemi dell’immigrazione. 85 Erronee credenze possono avere una sorprendente capacità di sopravvivere, … , sfidando l’evidenza e senza l’aiuto di cospirazioni. Karl R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica. Quarto dialogo - Il futuro demografico del pianeta secondo le Nazioni Unite: realismo delle ipotesi e affidabilità delle proiezioni demografiche E’ il 9 di febbraio del 2013 e, secondo il calendario lunare, è l’ultimo giorno del 2012 109. La moglie e i figli di Li sono andati in Cina per festeggiare con la famiglia la più importante festa del calendario cinese e torneranno in Italia solo dopo la festa delle lanterne che si celebra il quindicesimo giorno del nuovo anno. Li ha colto l’occasione per invitare gli amici a casa sua per il cenone dell’ultimo dell’anno. Il capodanno cinese Mario (suonando il campanello e guardando gli striscioni di carta rossa incollati sulla porta): Si vede subito che è festa. Li: Entrate amici; entrate. Guo nian hao! John: Suppongo che la risposta giusta sia: buon anno. Ho visto tante volte striscioni di carta rossa simili a quelli che hai messo sulla porta, ma non ho mai capito bene cosa fossero. Li: Sono dei Chuen lian. John: Questo chiarisce tutto! Li: Aspetta, è una vecchia storia. Si narra che nella notte dei tempi vi fosse un mostro, il Nian, che all’inizio della primavera usciva dal suo nascondiglio per distruggere le coltivazioni e uccidere i contadini. Questo mostro aveva però alcuni punti deboli: la luce, il rosso e i rumori molto forti. Dopo l’ennesimo attacco gli abitanti di un villaggio si riunirono e stabilirono un piano di azione: prima di tutto dipinsero di rosso le mura delle loro case; poi decisero di spaventare il mostro con fuochi di artificio, tamburi e altri strumenti a percussione che facevano un fracasso d’inferno, mentre ballerini vestiti di colori brillanti percorrevano le strade del villaggio 110. Michele: Dunque è questa l’origine della danza del leone? Li: Sì e anche degli striscioni di carta rossa che mettiamo all’ingresso delle nostre case. Il Nian è il simbolo di tutto ciò che è cattivo e da temere. Una volta era la 109 La numerazione del calendario cinese inizia dal regno dell’Imperatore Giallo, ma é univoca e vi sono almeno tre date per il 2013: 4650, 4710, 4711. 110 Per un cartone animato molto carino che racconta la storia del Nian si veda www.youtube.com/watch?v=0uJbp8d_d9c 86 distruzione del raccolto e la guerra. Oggi è la povertà. La leggenda del Nian suggerisce anche che di fronte al pericolo non bisogna rimanere passivi, ma agire. Così, all’arrivo dell’anno nuovo, ci attrezziamo per tenere lontano dalla nostra famiglia le cose che temiamo maggiormente. Mario: E le scritte? Li: Come vedete, sulla porta vi sono tre striscioni di carta, uno orizzontale e due verticali. In quelli verticali sono scritti dei versi: il primo a destra, è la testa; il secondo a sinistra, la coda. Mario: Un distico. Li: Se lo dici tu. La cosa interessante è che questi piccole poesie devono rispondere a regole ben precise. In primo luogo i due versi devono avere lo stesso numero di caratteri. Poi i singoli caratteri devono essere in qualche relazione con il corrispondente carattere dell’altro verso; infine, i toni del secondo verso debbono avere la sequenza opposta a quelli del primo. John: Quindi queste poesiole sono difficili da comporre. Li: Molto difficili. Quelli veramente belli sono pochi e di solito sono stati scritti da grandi poeti. Una volta le persone colte scrivevano i propri distici e li copiavano con la propria calligrafia. Adesso li si compra nei negozi, ma la qualità è molto bassa. Mario: Un’altra cosa che non ho mai capito, e che neppure la Settimana Enigmistica ha mai spiegato, è come mai la Festa della Primavera cada in pieno inverno. Li: Hai ragione e devo confessare che non ci avevo mai pensato neppure io. A volte non vediamo le cose che ci circondano e nel mezzo delle quali siamo cresciuti. E’ stato un mio amico italiano a farmelo notare e allora ho cercato la spiegazione … Mario: Ovviamente su Internet. Li: La cosa risale al 1913 quando la Nuova Repubblica Cinese fondata da Sun Yat Sen introdusse il calendario gregoriano. A quel punto c’era bisogno di un nome nuovo per il capodanno cinese che rimaneva comunque la festa più importante dell’anno e si decise per Festa della Primavera, anche se il nome era chiaramente in contrasto con la stagione, soprattutto nel Nord. Sedetevi, vado a prendere qualcosa da bere. Mario: Fammi indovinare: del vero maotai a 53 gradi 111. Michele: Ha parlato James Bond. Secondo me Mario ha fatto i compiti a casa prima di venire a cena. Li arriva con la bottiglia di maotai e la stappa mentre l’attenzione di John, Mario e Michele è attratta da una serie di paper cutting incollati alle finestre. Li riempie i bicchiere Li: Cambai John: Stasera il cinese è di rigore. Li: Come disse Confucio: “Quelli che comprano maotai non lo bevono; quelli che lo bevono non lo comprano”. Io sono un’eccezione: l’ho anche comprato. 111 Il Maotai è il liquore nazionale cinese e prende il nome dalla città dove viene prodotto. 87 John: Suppongo che abbiate numerose altre tradizioni per la Festa della Primavera. Li: Certamente, anche se arrivati a questo punto non so quanto dureranno. Molte prevedono la preparazione di cibi tradizionali già a partire da tre settimane prima dell’arrivo dell’anno nuovo. Poi, sei o sette giorni prima di capodanno, si pulisce la casa, ma anche gli abiti, le coperte e gli utensili di cucina. Il significato è chiaro: spazzare via la sfortuna. Questo è anche il periodo in cui si acquistano cose nuove con cui si da il benvenuto all’anno nuovo. Il primo giorno dell’anno i bambini ricevono una busta rossa con dentro del denaro, una tradizione che si è anche estesa ai dipendenti. Nei primi giorni dell’anno poi si visitano i parenti e gli amici e si scambiano regali. La festa di primavera si conclude con la festa delle lanterne che si celebra il quindicesimo giorno dell’anno nuovo. Sentite, proporrei di mangiare più tardi. Nel frattempo potremmo continuare la nostra chiacchierata sul futuro della Cina che mi sta appassionando. Prima però vi riempio i bicchieri. Cambai! La dinamica della transizione demografica Li: L’ultima volta che ci siamo visti, l’annuncio dei risultati delle elezioni americane interruppe la nostra chiacchierata sul più bello; così, sono rimasto con la curiosità di sapere come sia possibile che la transizione demografica provochi contemporaneamente in alcuni paesi il calo della popolazione, in altri un’esplosione demografica. John: Non fatemi ricordare quella serata! Mario: Coraggio John. Fidati, vi è andata fatta bene. John: Meglio parlare della transizione demografica. Michele: La transizione demografica è come una tempesta che all’inizio alza onde via via più alte che scorrono sulla superficie del mare; poi, quando si acqueta, le onde diventano via via più basse. Così, la transizione demografica, in una prima fase produce generazioni di nuovi nati sempre più imponenti e poi, in una seconda fase, generazioni di dimensioni decrescenti. Scorrendo lungo le età della vita, queste generazioni provocano prima un aumento dei giovani, poi della popolazione nella fase lavorativa e, infine, degli anziani. Cosi, in un primo momento la popolazione ringiovanisce, in una seconda fase invecchia. Li: Fin qui ti seguo. Michele: Quello che è successo è che la tempesta ha avuto inizio in momenti diversi nei vari oceani della terra. Fuori di metafora, la transizione demografica è iniziata in Svezia, Inghilterra e Francia alla fine del settecento, inizio dell’ottocento; nei paesi europei più arretrati, come Italia e Russia, nella seconda metà del XIX secolo. Si è poi diffusa negli altri paesi con tempi e modalità che sono stati ritmati dalla interazione di numerosi elementi economici, sociali e legislativi. Nei paesi più poveri e socialmente più arretrati la transizione sta iniziando solo ora. Il risultato è che paesi diversi si trovano in fasi diverse della transizione. In alcuni, siamo nella fase di crescita demografica accelerata; in altri, la popolazione cresce ancora, ma a tassi sempre più ridotti; in altri, siamo ormai nella fase finale durante la quale la popolazione diminuisce. Li: Continua però a sfuggirmi come il calo della fecondità possa andare di pari passo con l’aumento delle nascite e della popolazione. 88 Michele: Hai ragione; la cosa non è per niente intuitiva, anche se poi il meccanismo è abbastanza semplice. Come abbiano visto nel grafico della Svezia, la transizione demografica inizia con la caduta della mortalità, provocata soprattutto dalla diminuzione della mortalità infantile. Come conseguenza, le generazioni che, dopo una ventina di anni, raggiungono l’età della riproduzione sono più numerose delle precedenti, ma hanno lo stesso livello di fecondità. Ciò innesca la crescita del numero delle nascite che, a sua volta, provoca col tempo un ulteriore aumento della popolazione in età riproduttiva. Quando, dopo trenta o più anni, anche la fecondità comincia a diminuire, il numero delle donne in età fertile è così elevato che l’effetto numerosità prevale sulla contrazione della fecondità per un periodo che può essere anche molto lungo. A ciò si deve aggiungere che questa fase è stata quasi ovunque caratterizzata da un aumento della durata media della vita. John: Vorrei provare a ripetere con le mie parole per vedere se ho capito. A un certo momento in una società tradizionale l’adozione di norme igieniche, la disponibilità di medicinali, l’arrivo di missionari intenzionati a far aumentare i potenziali clienti per il paradiso o quant’altro determinano una riduzione della mortalità infantile e così, dopo venti, trenta anni, il numero di giovani coppie che si dedicano con impegno al piacevole compito della riproduzione aumenta. Poiché in questa fase la fecondità è ancora a livello tradizionale, ognuna di esse dà un sostanziale contributo alla popolazione che sta già aumentando per via della riduzione della mortalità. In questo modo si crea una differenza crescente tra nati e morti. Col tempo anche la fecondità comincia a diminuire e, prima o poi, lo fa ad un ritmo maggiore di quello della mortalità che, ad un certo punto, inizia ad aumentare perché la popolazione invecchia e il numero dei candidati a questo evento aumenta. Così, i tassi di natalità e mortalità convergono e la crescita della popolazione si riduce progressivamente e alla fine inizia a diminuire. Michele: Perfetto! John: I riassunti sono sempre stati il mio forte. Transizione demografica e livello di sviluppo Mario: Se ho capito bene, pochi paesi possiedono informazioni statistiche che consentano, come nel caso della Svezia, di documentare la loro transizione demografica. Quindi, non c’è modo di verificare direttamente quanto hai appena detto. Michele: E’ vero! Possiamo però aggirare l’ostacolo analizzando tre gruppi di paesi a un diverso livello di sviluppo (i paesi sviluppati, i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati) e porli in sequenza così da ricostruire l’intera storia. Lo faremo utilizzando i dati della Population Division. Mario: Sarei per tornare a chiamarli “paesi sottosviluppati”; capisco essere rispettosi, però cosi facendo non si denuncia la disperata situazione socio-economica in cui questi paesi si trovano e le insormontabili difficoltà che li aspettano, alla faccia dell’atteggiamento ottimistico di molte organizzazioni internazionali, a mio avviso del tutto ingiustificato. I paesi sottosviluppati Michele: Sono d’accordo con te. Cominciamo, quindi, con i paesi sottosviluppati che, essendo stati gli ultimi a iniziare il lungo percorso della transizione demografica, 89 permettono di documentarne la fase iniziale. Nel grafico ho riportato i tassi di natalità e di mortalità dei 47 paesi più poveri del mondo, nonché la differenza tra questi due tassi) che misura il tasso di crescita percentuale della popolazione totale ed è rappresenta con degli istogrammi. Come vedete, in questi paesi nel 1950 il tasso di natalità era di poco inferiore al 50 per mille, mentre il tasso di mortalità era sotto il 30 per mille 112. John: Dunque, la mortalità era già scesa sotto il livello “naturale”. Michele: Sì, e quindi la transizione demografica era già iniziata, sia pur da poco. Gli istogrammi mostrano che all’inizio degli anni ‘50 il tasso di crescita della popolazione era del 21 per mille, un valore molto al di sopra di quelli che si registrano durante il regime naturale. Negli anni successivi, il tasso di mortalità è diminuito più rapidamente del tasso di natalità e la differenza tra i due indicatori è aumentata fino a raggiungere un massimo di 28,4 per mille tra il 1980 e il 1985. A questo punto il tasso di natalità comincia a contrarsi più velocemente, cosicché nel 2010 il tasso di crescita della popolazione scende al 24,7 per mille. Secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere del 13,4 per mille nel 2060 e del 5,5 per mille alla fine del secolo. Grafico 1 – Paesi meno sviluppati; tasso di natalità, tasso di mortalità e tasso di crescita della popolazione; valori medi annui; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Quindi anche nei paesi meno sviluppati la situazione sta migliorando. Michele: E’ una conclusione ottimistica che non prende in considerazione i costi umani e sociali dell’esplosione demografica che è un inevitabile prodotto della transizione. Tanto per darvi un’idea del problema, con un tasso di crescita del 20 per mille (cioè del 2 per cento) la popolazione di un paese raddoppia in trentacinque anni 113. Il grafico 2 rappresenta il percorso della transizione demografica utilizzando 112 Il tasso di natalità lordo è dato dal rapporto tra il numero delle nascite e la popolazione totale. Nel caso del tasso di mortalità il numeratore è il numero dei decessi. Si noti che questi indicatori sono fortemente condizionati dalla struttura della popolazione per classe di età. Non deve, ad esempio, sorprendere che il tasso di mortalità dello Zambia, sia analogo a quello dell’Italia (10,4 per mille) malgrado la vita attesa alla nascita sia molto inferiore (51,6 anni contro 81,5); la spiegazione sta nell’età mediana (l’età che divide una popolazione in due gruppi della stessa dimensione) che è di 16,5 anni nello Zambia e di 43,3 in Italia. 113 Una semplice regoletta per capire l’effetto di lungo periodo di una crescita ad un dato tasso fisso é che la variabile interessata raddoppia in un tempo pari a 70 diviso per il tasso di crescita. Alternativamente se una grandezza aumenta ad un tasso di crescita percentuale costante, in 70 anni tale grandezza sarà raddoppiata un 90 il numero delle nascite e delle morti. Nel 1950 i paesi sottosviluppati avevano una popolazione complessiva di 195 milioni, che allora rappresentava il 7,7 per cento della popolazione mondiale. Ogni anno vi nascevano 10 milioni di bambini e vi erano 6 milioni di decessi: quindi la popolazione aumentava di 4 milioni all’anno. Adesso vi sono circa 28 milioni di nascite che dovrebbero superare i 42 milioni verso il 2065, per poi mantenersi su tale livello fino alla fine del secolo; le morti sono poco più di 8 milioni e raggiungeranno i 26 nel 2100. La conseguenza è che adesso la popolazione di questi paesi cresce a un ritmo di 21 milioni l’anno, che saliranno a oltre 27 verso il 2040, e starà ancora crescendo ad un ritmo di 16 milioni all’anno alla fine del secolo. Così la popolazione dei paesi più poveri del mondo, che é ora di 878 milioni, dovrebbe superare i 2,9 miliardi nel 2100 quando sarà pari al 27 per cento della popolazione mondiale. Grafico 2 – Paesi meno sviluppati; nascite, morti e crescita della popolazione; valori medi annui in milioni; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Più del doppio della popolazione cinese di oggi! Una cosa agghiacciante e difficile da immaginare pensando alla situazione in cui si trovano questi paesi. I paesi in via di sviluppo Michele: Non potrei essere più d’accordo. I paesi in via di sviluppo ci permettono di cogliere l’arrivo della seconda fase della transizione, quella in cui la crescita della popolazione rimane positiva, ma diminuisce progressivamente convergendo verso zero. Nel 1950 i paesi in via di sviluppo avevano una popolazione di 1,5 miliardi, pari al 60 per cento della popolazione mondiale. Ogni anno vi nascevano 69 milioni di bambini, mentre i decessi erano 36 milioni (Grafico 4). Quindi, la popolazione aumentava di 33 milioni all’anno. La transizione demografica era più avanzata che nei paesi sottosviluppati: il tasso di mortalità era sceso al 23 per mille, mentre il tasso di natalità era già entrato nella fase discendente (Grafico 3). La differenza massima fra nati e morti fu raggiunta, con 73 milioni, tra il 1985 e il 1990, sessanta anni prima dei paesi più poveri. Negli anni successivi natalità e mortalità cominciano a convergere e il calo del tasso di natalità diventa così pronunciato che anche il numero dei nati numero di volte pari al suo tasso di crescita. Si veda il video di Albert Bartlett al seguente sito: http://www.youtube.com/watch?v=umFnrvcS6AQ; si veda anche: http://www.lanxsatura.org/ 91 comincia a diminuire e converge verso il numero dei morti. La popolazione totale inizierà a diminuire a partire dal 2085 Grafico 3 – Paesi in via di sviluppo; tasso di natalità, tasso di mortalità e tasso di crescita della popolazione totale; valori medi annui; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Grafico 4 – Paesi in via di sviluppo; nascite, morti e variazione assoluta della popolazione; valori medi annui in milioni; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision I paesi sviluppati Michele: Veniamo infine ai paesi sviluppati, i paesi dove la transizione demografica è nella fase più avanzata. Già nel 1950 il tasso di mortalità di questi paesi era sceso a poco più del 10 per mille e quello di natalità, ormai in caduta libera, a circa il 22 per mille (Grafico 5). Il processo di convergenza dei due tassi è continuato negli anni successivi cosicché alla fine del secolo scorso la popolazione dei paesi sviluppati era sostanzialmente stazionaria. Secondo la Population Division, questa situazione dovrebbe continuare fino al 2020 quando la popolazione dei paesi sviluppati comincerà a diminuire. D’altra parte, come abbiamo già visto, numerosi paesi sviluppati registrano da tempo tassi di fertilità sotto il livello di rimpiazzo e se la popolazione dei paesi economicamente più progrediti non sta ancora diminuendo è 92 solo perché alcuni di essi, primo fra tutti gli Stati Uniti, mantengono una natalità elevata. Grafico 5 – Paesi sviluppati; tasso di natalità, tasso di mortalità e tasso di crescita della popolazione totale; valori medi annui; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Grafico 6 – Paesi sviluppati; nascite, morti e variazione assoluta della popolazione; valori medi annui in milioni; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Come mai? John: Devi tenere conto dei milioni d’immigrati che sono arrivati nella seconda metà del ventesimo secolo e che hanno mantenuto, almeno per un certo periodo, l’alta fecondità del paese di partenza. Il fenomeno è evidente anche in altri paesi d’immigrazione storica come Australia e Nuova Zelanda. La transizione demografica a livello globale Michele: Veniamo ora al livello globale che è il risultato delle tre diverse situazioni che abbiamo appena descritto. Nel 1950 il tasso di mortalità era di poco sotto il 20 per mille, mentre quello di natalità era ancora vicino al 37 per mille. La distanza massima fra i due indicatori fu raggiunta dopo una quindicina d’anni, con un dato di poco superiore al 20 per mille. L’aspetto più interessante che emerge dal Grafico 7 è però rappresentato dalla caduta tendenziale del tasso di natalità, caduta che decelera progressivamente; cosicché il tasso di natalità si assesta nell’ultima parte 93 del secolo intorno al 12, 13 per mille. In parallelo vediamo un crollo iniziale del tasso di mortalità che dimezza il suo valore tra il 1950 e il 1990. Rimane poi sostanzialmente stazionario fino a quasi la metà del secolo per aumentare leggermente nel periodo successivo. E’ comunque evidente che in questa prospettiva il progressivo annullamento della crescita demografica è da imputare alla natalità. Grafico 7 – Mondo; tasso di natalità, tasso di mortalità e tasso di crescita della popolazione totale; valori medi annui; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Come al solito, io preferirei vedere i valori assoluti. Grafico 8 – Mondo; nascite, morti e variazione assoluta della popolazione; valori medi annui in milioni; 1950-2100 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Michele: Ti accontento subito. In una prima fase, il numero dei nati aumenta, passando dai 98 milioni del 1950 ai 139 del 1990, e ciò perché il numero delle donne in età fertile è più che raddoppiato, mentre il numero dei figli per donna è calato solo del 31 per cento. Nella lunga fase successiva la fecondità cala leggermente, ma un po’ di più di quanto non aumenti il numero delle donne tra i 15 e i 49 anni che dovrebbe raggiungere il proprio massimo verso il 2090. Di conseguenza, il numero dei nati non dovrebbe mai scendere sotto i 120 milioni 114. L’aspetto forse più impressionante di questa storia è però rappresentato dal cambiamento della distribuzione geografica delle nascite. Alla fine del secolo, quasi un terzo dei bambini dovrebbe vedere la luce nei paesi più poveri della terra, e ciò rende difficile immaginare che la situazione economica e sociale di questi paesi possa migliorare. 114 A puro titolo di curiosità ciò corrisponde a una nascita ogni 4 secondi 94 John: Questi dati cominciano a preoccuparmi! Quali sono le principali tendenze demografiche che emergono dalle proiezioni? Dopo tutto non stiamo parlando di fantascienza, ma del mondo in cui vivranno i nostri figli e i nostri nipoti. Grafico 9 – Gruppi di paesi per livello di sviluppo economico; distribuzione percentuale delle nascite; 1950-55, 2005-10 e 2095-2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Le proiezioni demografiche della Population Division Michele: In primo luogo, nelle sue ultime stime la Population Division ha alzato il livello della popolazione mondiale previsto per il 2100 a 10,9 miliardi (la stima precedente era di 9,7 miliardi) a seguito di un aggiustamento verso l’alto della fecondità e della durata della vita, soprattutto nei paesi sub-sahariani. Come abbiamo già accennato, uno degli aspetti più drammatici è poi la concentrazione di una quota crescente della popolazione mondiale in Africa. Nel 1960 solo 9 persone su cento abitavano in questo continente; nel 2010 sono salite a 15 e nel 2100 dovrebbero arrivare a 39. Notate anche che l’Africa ha attualmente meno abitanti sia della Cina, sia dell’India, ma nel 2100 dovrebbe avere più abitanti di questi due paesi messi insieme. Questo risultato è ovviamente la conseguenza della drammatica crescita della popolazione dei paesi più poveri che abbiamo appena visto e che si trovano quasi tutti in Africa. Nel frattempo dovrebbero calare le quote degli altri continenti; in particolare, l’Asia dovrebbe scendere dal 60,3 al 43,4 per cento. Tuttavia, alla fine del secolo Africa e Asia dovrebbero ospitare l’82 per cento della popolazione mondiale. Ovviamente il peso degli altri continenti diventerebbe marginale con l’Europa al 5,9 per cento, a fronte del 21,7 del 1950, l’America all’11,5 contro un iniziale 13,4 per cento e l’Oceania allo 0,6 per cento. Tavola 1 – Popolazione totale dei continenti; valori assoluti in milioni e composizione percentuale; 1950, 2010 e 2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision 95 John: E a livello dei singoli paesi? Michele: Le trasformazioni sono ugualmente impressionanti. In primo luogo dovrebbe aumentare il numero e la dimensione dei grandi paesi. Nel 2010 i paesi con una popolazione tra i 50 e i 100 milioni erano quattordici e quelli con oltre 100 undici. Nel 2100 il numero dei primi dovrebbe salire a ventotto e quello dei secondi a ventiquattro. Dovrebbero poi sparire dalla lista dei venticinque paesi più popolosi della terra tutti i paesi europei: Russia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia. Il caso più impressionante è quello della Germania che dovrebbe perdere 25 milioni di abitanti e passare dal quindicesimo al quarantaduesimo posto in classifica. Mario: Secondo te l’hanno già detto alla Merkel? Tavola 2 – Popolazione nei venticinque paesi più popolosi; valori in milioni; 2010 e 2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Michele: Non lo so; comunque i politici non sono mai molto interessati a quello che succederà dopo di loro. Fra l’altro la Germania, scesa a 57 milioni, sarebbe largamente sopravanzata dalla Francia con 79 milioni e sarebbe appena più popolosa dell’Italia a 55 milioni. Dovrebbe sparire dalla lista dei venticinque paesi più popolosi del mondo anche il Giappone che dovrebbe perdere 43 milioni di abitanti e scendere dal decimo al ventinovesimo posto. Dovrebbero sparire anche Iran, Turchia, Tailandia, Myanmar e Sud Africa. Come vi aspetterete dopo quello che ho detto, a parte l’Iraq che sale al ventunesimo posto, le new entry sono tutte africane: Tanzania, Uganda, Niger, Kenia, Zambia, Sudan, Mozambico, Madagascar, Mali e Angola. Li: La popolazione tenderà ovviamente a invecchiare. Michele: Sì. Tanto per darvi un’idea del fenomeno, a livello globale la percentuale delle persone con 65 anni e più dovrebbe quasi triplicarsi, salendo da un valore attuale di 7,7 per cento a uno di 21,9 per cento nel 2100. Il processo dovrebbe essere particolarmente accentuato nei paesi più poveri, dove si dovrebbe passare dal 3,5 per 96 cento al 15,4 per cento e nei paesi in via di sviluppo, dal 6,2 al 23,4 per cento, un valore di poco inferiore al 28,7 per cento dei paesi sviluppati, che però sono già al 16,1 per cento. Mario: Mi stai dicendo che il mondo si trasformerebbe in un gigantesco ricovero per anziani e che la professione del futuro sarà quella del badante? Michele: E’ una possibilità che va presa in seria considerazione. Li: In tutto questo che cosa dovrebbe succedere alla Cina? Grafico 10 – Gruppi di paesi per livello di sviluppo economico; percentuale di persone con 65 anni e più; 1950, 2010 e 2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Il futuro demografico della Cina Michele: Ti accontento subito: sulla Cina sono organizzatissimo. Il grafico 11 rappresenta l’andamento del numero medio annuo di nati e di morti e il relativo saldo che, come ormai sappiamo, misura la crescita assoluta della popolazione totale. Il grafico sintetizza buona parte della storia della demografia cinese che abbiamo discusso durante la nostra ultima chiacchierata. Tra il 1950 e il 1990 il numero delle nascite oscilla attorno ai 25 milioni a seguito dell’effetto contrastante di riduzione della fecondità, aumento della popolazione in età riproduttiva, abbassamento del’età legale per il matrimonio, introduzione e applicazione molto dura della politica del figlio unico. A partire dal 1990, il numero medio dei nati comincia a diminuire e, secondo la Population Division, questo trend negativo dovrebbe continuare per tutto il secolo. D’altra parte, il miglioramento delle condizioni igieniche ed economiche nonché gli interventi specifici nel campo della salute ebbero subito un effetto positivo sulla mortalità, così che il numero dei morti diminuì dai circa 14 milioni del 1950-55 a meno di 5 milioni nel 1970-75. A partire da quel momento il numero dei morti ricomincia a salire e dovrebbe uguagliare il numero dei nati verso il 2030. La popolazione totale entrerebbe allora in una fase di progressivo e inarrestabile declino. Il grafico permette di vedere chiaramente le tre fasi della transizione demografica: la prima, caratterizzata da aumenti via via crescenti della popolazione, dura fino al 1970; la seconda, caratterizzata da aumenti decrescenti, dura i successivi 65 anni; la terza che inizia verso il 2030 dovrebbe vedere il progressivo calo della popolazione totale. 97 Li: Non so se ci vedo giusto, ma se l’area sotto l’ordinata rappresenta una diminuzione, la popolazione cinese rischia di sparire. Michele: Sparire no, ma si porrebbero le premesse perché ciò possa accadere nel secolo successivo. Grafico 11 – Cina; nati, morti e saldo naturale; valori medi annui in milioni; 1950-2060 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Ma ti sembra possibile? Michele: A dirti la verità, ritengo che queste proiezioni siano totalmente infondate e trovo incredibile che le Nazioni Unite le facciano circolare senza riflettere sulle potenziali conseguenze che questi dati potrebbero avere. John: Forse contano sul fatto che nessuno le prenda sul serio! Oppure la Cina rappresenta un caso speciale? Michele: Tutt’altro! Anzi ne approfitterei per raccontarvi la visione demografica del futuro del pianeta secondo le Nazioni Unite, cominciando da un confronto tra Cina e Nigeria. Li: Perché proprio la Nigeria? Cina e Nigeria: due paesi agli estremi del percorso della transizione demografica. Michele: In primo luogo perché se la Cina è il gigante dell’Asia, la Nigeria 115 è il gigante dell’Africa. Inoltre, mentre la Cina è il prototipo dei paesi che stanno per entrare nella terza fase della transizione demografica, quella in cui la popolazione diminuisce, la Nigeria è uno dei paesi in cui la transizione è appena agli inizi. Come vi ho già raccontato in una precedente chiacchierata, la popolazione cinese dovrebbe raggiungere un massimo di un miliardo e 453 milioni nel 2030 per poi calare progressivamente fino a un miliardo e 86 milioni alla fine del secolo. In sostanza, nel corso di 70 anni dovrebbe perdere 5 milioni di persone all’anno. Questo secondo la 115 Vale la pena ricordare che la Nigeria è stata anche la culla di alcune delle maggiori civiltà africane e ha prodotto le più belle sculture di questo continente: Purtroppo oggi rappresenta il miglior esempio di come le ricchezze minerarie non portino che la distruzione ambientale e l’ingiustizia social ai paesi produttori sottosviluppati. 98 Variante media, quella che Population Division considera la più probabile. Nella variante bassa -che prevede un livello di fecondità inferiore di mezzo figlio 116- la popolazione cinese riuscirebbe solo a sfiorare il miliardo e 400 milioni nel 2021, per poi scendere a 608 milioni nel 2100, con un calo medio annuo di 10 milioni di persone. Li: Quindi il livello della fecondità fa una differenza sostanziale. Michele: Certamente, tanto che nella variante alta la popolazione cinese continuerebbe a crescere per tutto il secolo fino a toccare, nel 2100, il traguardo di un miliardo e 778 milioni. Se le altre varianti sono irrealistiche, questa lo è ancora di più. Li: Comincio a capire l’importanza della pianificazione famigliare! Michele: I dati della Nigeria ti possono fornire ulteriore materiale di riflessione. In Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa, la transizione è appena agli inizi. Pensate che nel 2010 la popolazione totale di questo grande paese era di 160 milioni. Secondo le Nazioni Unite nel 2100 la popolazione della Nigeria sarà compresa tra un minimo di 644 milioni nell’ipotesi di natalità bassa e un massimo di un miliardo e 262 milioni nell’ipotesi di natalità alta, passando per il valore della variante intermedia di 914 milioni. John: Quindi, secondo la Population Division ci sono buone probabilità che la popolazione della Nigeria sorpassi quella della Cina nel corso del secolo e che la crescita demografica che la Cina ha dovuto fronteggiare nel secolo scorso sia roba da ridere, rispetto a quella che aspetta la Nigeria nel corso di questo secolo. La polarizzazione dello sviluppo demografico Michele: Sì: qui non si parla di una crescita di 2,5 volte com’è avvenuto in Cina, ma nell’ipotesi media di 4,7 volte, un dato tuttavia modesto se confrontato con la crescita di 11,8 volte prevista per il Niger e di 8,4 volte prevista per la Zambia. Li: Dati impressionanti anche per uno come me abituato al sovraffollamento! John: Anche a me sembrano numeri che avrebbero effetti socio-economici persino difficili da immaginare; ma queste proiezioni sconvolgenti, che tutto sommato stanno passando inosservate, sono realistiche? Michele: Come per tutte le proiezioni, la loro probabilità di avverarsi dipende dal realismo delle ipotesi. John: E quindi? La procedura di proiezione demografica utilizzata dalle Nazioni Unite. Michele: Partiamo dalla procedura. Il meccanismo è semplice. Si prende una popolazione iniziale della quale si conosce la struttura per sesso e classe di età. Nel caso di una popolazione chiusa, che cioè non è interessata da flussi migratori, sarà sufficiente stimare, da un lato, il numero dei nati e, dall’altro, il numero dei morti per ogni classe di età per il periodo successivo. I nati sono inseriti nella prima classe di età, mentre i morti sono dedotti dalle classi di età interessate. Li: Ti dispiacerebbe fare un esempio? 116 Se, ad esempio, nella variante media il tasso di fertilità ipotizzato e di due bambini per donna, in quella bassa sarà di 1,5 e in quella alta di 2,5. 99 Michele: Prendiamo una popolazione di 100 persone, composta da cinque classi di età, ognuna di cinque anni di ampiezza e consideriamo un intervallo temporale anch’esso di cinque anni. Formuliamo poi delle ipotesi sul livello e la tendenza della fecondità e della mortalità. Sulla base dei dati e delle ipotesi, possiamo stimare i nati nel corso dell’intervallo considerato. Supponiamo che siano quindici. Calcoliamo poi i morti di ogni classe di età e li sottraiamo dalle classi di appartenenza. Così, ad esempio, tra il tempo t e il tempo t+5, si dovrebbe registrare un solo decesso nella prima classe di età. Pertanto, al tempo t+5 la seconda classe di età, composta al tempo iniziale da venti individui, ne conterà 19. Effettuando questa operazione per tutte le classi di età successive, otteniamo il loro livello al tempo t+5. A questo punto ripetiamo il procedimento per quanti intervalli desideriamo. Tornando all’esempio, i nati sono meno dei morti e quindi la popolazione diminuisce. Potete anche vedere che la consistenza delle prime 4 quattro classi è diminuita, mentre quella dell’ultima è aumentata, provocando così un invecchiamento della popolazione. Tavola 3 – Popolazione per classi di età quinquennali al tempo t e al tempo t+5; nati, morti e saldo naturale. 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 Totale Pop (t) 20 25 25 20 10 100 Nati Morti Saldo 15 15 -1 -3 -7 -9 -10 -30 -15 Pop (t+5) 15 19 22 18 11 85 John: Vediamo le ipotesi adottate dalla Population Division. Le ipotesi delle Nazioni Unite Le ipotesi sulla mortalità Michele: Cominciamo dalla mortalità. La Population Division ipotizza che la durata media della vita continuerà ad aumentare, ma che gli aumenti saranno inversamente correlati ai valori attuali. Mario: Cioè? Michele: La vita attesa alla nascita è molto diversa da paese a paese. A fronte di un valore medio mondiale di 68,7 anni, nei paesi sviluppati la vita attesa è di 76,9 anni e nei paesi sottosviluppati di 58,4, con un dato dei paesi in via di sviluppo praticamente uguale alla media mondiale. Come vedete dalla Tavola 4, la situazione è decisamente migliore di quella del 1950, ma i progressi non sono stati uniformi. I risultati più consistenti sono quelli dei paesi in via di sviluppo; seguono i paesi più poveri che partivano da una situazione analoga a quella dei paesi europei all’inizio della rivoluzione industriale. Per ultimi vengono i paesi sviluppati nei quali la durata media della vita negli ultimi sessanta anni è aumentata di circa dodici anni. 100 Tavola 4– Mondo e gruppi di paesi per livello di sviluppo; vita attesa alla nascita; 1950-55, 2005-10, 2095-2100 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Quindi la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri è diminuita. Michele: Nella media sì, ma rimangono molti casi drammatici, soprattutto in Africa dove vi sono 11 paesi nei quali la vita attesa è tra i 40 ed i 50, mentre in altri 29 è tra i 50 e i 60. Malgrado ciò, le previsioni della Population Division sono abbastanza ottimistiche e prevedono sia un ulteriore aumento della vita attesa, sia un ulteriore riavvicinamento tra i tre gruppi di paesi. Così la vita attesa dovrebbe salire a 88,9 anni nei paesi avanzati, a 82,2 nei paesi in via di sviluppo e a 77,6 nei paesi meno sviluppati, un valore questo superiore al valore attuale dei paesi più ricchi. Per rendere confrontabile quanto è successo negli ultimi 60 anni con le previsioni relative ai prossimi novanta, ho riportato nel grafico la crescita media annua dei due periodi espressa in mesi. Come vedete, a livello mondiale la crescita della durata della vita dovrebbe più che dimezzarsi; scendendo da 4,8 a 1.7 mesi, soprattutto a causa del rallentamento “previsto” nei paesi in via di sviluppo che sono quelli nei quali l’allungamento della vita è stato più accentuato negli ultimi sessanta anni. Anche così il processo porta a risultati sorprendenti. Se ora la durata media della vita supera gli 80 anni in diciassette paesi, primo fra tutti il Giappone con circa 83 anni, nel 2100 essa dovrebbe superare i 95 anni in Corea, e i 90 in altri quarantadue paesi. Dopo la Corea troviamo Hong Kong e Giappone. L’Italia occupa il settimo posto, prima di tutti i grandi paesi occidentali. All’altra estremità, vi dovrebbero essere solo tre paesi sotto i settanta; un limite al quale oggi non arrivano ben ottantacinque paesi. Grafico 12 - Mondo e gruppi di paesi a diversi livelli di sviluppo; vita attesa alla nascita; crescita media in mesi tra il 1950-55 e il 2005-10 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Mario: Comunque la Population Division sembrerebbe accettare l’idea che vi siano limiti biologici alla durata della vita. 101 Michele: Credo che i dati che vi ho appena fornito riflettano semplicemente le tendenze in atto che mostrano come maggiore la durata della vita, minori i progressi che sono compiuti. Va però detto che anche in questo caso negli ultimi 150 anni la realtà ha largamente superato l’immaginazione ed è possibile che la cosa si ripeta. Mario: Il futurologo Ray Kurzweil 117 ha sostenuto che chi riuscirà ad essere ancora in vita verso il 2040 avrà buone probabilità di diventare immortale o quasi perché a quel tempo disporremo di nanorobots in grado di distruggere le cellule cancerogene, fare il backup delle nostre memorie e rallentare l’invecchiamento. Tuttavia, anche l’opinione opposta ha numerosi sostenitori che osservano come, malgrado tutti gli sviluppi della scienza, non siamo ancora riusciti a spingere verso l’alto il limite massimo di vita che rimane intorno ai 120 anni. Michele: Ciò che emerge dalle proiezioni delle Nazioni Unite è soprattutto una concentrazione della mortalità tra gli anziani. Li: Comunque, aver debellato o ridotto la mortalità infantile e dei bambini piccoli non è cosa da poco. Michele: Certo. A livello mondiale negli ultimi 60 anni la mortalità infantile si è ridotta di due terzi. Nei paesi ricchi il problema è stato quasi totalmente debellato, mentre rimane rilevante nei paesi in via di sviluppo e soprattutto nei paesi più poveri che hanno fatto grandi passi in avanti, ma sono ancora su livelli disastrosi tanto che 7 bambini su 100 muoiono durante il primo anno di vita. Secondo la Population Division, nel 2100 il problema dovrebbe essere sostanzialmente risolto anche in questi paesi. Una digressione su transizione demografica e “ordine demografico” Mario: Comincio a pensare che nessuno abbia guardato questi numeri nel loro insieme. Si prospetta che il problema della mortalità infantile venga quasi totalmente risolto, mentre la popolazione esplode. Non ha alcun senso. Michele: Totalmente d’accordo, ma c’è di peggio. Tavola 5 – Mortalità infantile in tre gruppi di paesi a diverso livello di sviluppo; 1950-55, 2005-0, 2095-00 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Comunque, mi sembra che questi dati mostrino che si muore sempre più al momento giusto. Michele: E’ stato già sostenuto che il passaggio dal sistema demografico tradizionale a quello moderno rappresenta il passaggio dal disordine e dall’inefficienza, all’ordine e all’efficienza. Nel regime tradizionale c’era bisogno di molte nascite per generare una crescita demografica modesta, mentre adesso ne bastano molte di meno per far crescere la popolazione. La macchina demografica riuscirebbe, quindi, ad andare più veloce utilizzando meno carburante. D’altra parte, il 117 Kurzweil Ray and Terry Grossman, 2004, Fantastic Voyage. Live Long Enough to Live Forever, Plume 102 sistema tradizionale era disordinato nel senso che la morte non dava la precedenza ai vecchi e falcidiava la popolazione in maniera casuale e imprevedibile. Insomma, nel regime tradizionale i figli spesso morivano prima dei genitori, nel regime moderno ciò avviene molto raramente. John: Mi sembra un’osservazione interessante, anche se per il momento questa non è certamente la situazione prevalente in moltissimi paesi. Michele: Livi Bacci, l’autore di queste osservazioni, parla in prospettiva, dando per scontato che la transizione demografica finirà con investire tutto il mondo 118. Però questa evoluzione non è stata e non è senza costi. Lo stesso Livi Bacci osserva che il regime demografico moderno comporta nuove vulnerabilità: le strutture familiari divengono più fragili e la perdita di un figlio unico, o la perdita dei genitori in giovane età, possono avere pesanti effetti sui sopravvissuti. A mio avviso gli effetti più devastanti della transizione demografica sono però quelli generati dai disequilibri che si creano nel mercato del lavoro e le conseguenze che essi generano. Lasciate però che passi alle ipotesi sulla fecondità perché ho ancora molte cose da dire sulla metodologia dalla Population Division. Per i demografi è la fecondità che gioca il ruolo fondamentale nel determinare le future tendenze demografiche. Pertanto, a fronte di un solo scenario sulla mortalità e di due scenari sull’immigrazione, la Population Division calcola e pubblica cinque scenari di fecondità: oltre ai tre che abbiamo già incontrato (con fecondità bassa, media e alta) vi sono quelli a fertilità costante e a rimpiazzo istantaneo, anche se questi ultimi rappresentano più che altro delle curiosità. Le ipotesi sulla fecondità Li: Quando abbiamo parlato dell’evoluzione della popolazione cinese e nigeriana, hai detto che la fecondità ha un grosso impatto sul livello della popolazione. Michele: Sì, molto maggiore della mortalità. Ad esempio, nel 2100 la popolazione mondiale raggiunge i 10,9 miliardi nella variante intermedia, mentre è di solo 6,8 miliardi nell’ipotesi bassa e di ben 16,6 nell’ipotesi alta. Se poi la fecondità rimanesse ai valori attuali, si supererebbero i 28 miliardi. John: Mi sembrano intervalli troppo ampi per dare qualche indicazione sul futuro, a parte il fatto che tutto può succedere. Michele: E’ vero, ma il punto di riferimento è la variante media e, a partire dalle proiezioni del 2010, la stima dei futuri livelli della fecondità in questa variante si basa su di una complessa procedura statistica che tiene conto non solo delle tendenze passate di ogni singolo paese, ma anche di quelle dei paesi che appartengono alla stessa regione e all’andamento globale. John: Comunque una procedura in cui il futuro è dedotto dal passato. Michele: Non proprio, perché queste proiezioni vengono poi “corrette” per tenere conto di un’ipotesi fondamentale, vale a dire che la popolazione dei singoli paesi -e quindi anche la popolazione globale- tenda verso una stabilità di lungo periodo. Mario: Vuoi dire che correggono le stime a mano? Michele: Più o meno. D’altra parte il mio professore di Politica economica, che non era l’ultimo arrivato, diceva che i modelli econometrici sono quella cosa che 118 Massimo Livi Bacci (2100), Storia Minima della Popolazione, Il Mulino, 103 produce delle previsioni che poi gli economisti aggiustano con il buon senso e l’esperienza. Mario: In questo caso cosa suggeriscono ai demografi buon senso ed esperienza? Michele: Non sono sicuro che in questo caso si possa parlare di buonsenso. L’idea è che in tutti i paesi del mondo il livello della fecondità converga, sia pure in tempi e con modalità diverse, verso il magico valore di 2, dall’alto se hanno una fecondità maggiore, dal basso se partono da un valore inferiore. Il grafico mostra le conseguenze di questa ipotesi di convergenza utilizzando i soliti tre gruppi di paesi. Grafico 13 – Tassi di fertilità totale in tre gruppi di paesi a diversa livello di sviluppo; 1910/15-2095/2100 - variante intermedia Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision John: Spiega meglio. Michele: S’ipotizza che nei paesi in cui il Tasso di fecondità totale sia superiore al livello di rimpiazzo, la fecondità diminuisca progressivamente e possa anche scendere sotto tale livello, ma poi, raggiunto un minimo, il trend s’inverta e la fecondità risalga verso il valore di equilibrio. Qualora invece tale valore minimo sia stato già raggiunto, la fecondità dovrebbe risalire verso due. Un esempio del primo caso è fornito dalla Libia, dove la fecondità totale raggiunse un massimo di quasi 8 figli per donna verso il 1980. E’ ora scesa a 2,38 e la Population Division ipotizza che scenda a un minimo di 1,62 verso la metà del secolo per poi risalire a 1,81 nel 2100. Un tipico caso del secondo tipo è quello della Cina che dal valore attuale di 1,66 119 dovrebbe progressivamente risalire a 1,88 verso la fine del secolo. Mario: L’idea di questo yoyo demografico è nuova? Michele: Direi di sì. Nella precedente revisione, quella del 2010, si era ipotizzato che la convergenza avvenisse sul valore di 1,85 il che, insieme alla progressiva omogeneizzazione dei comportamenti riproduttivi, portava a prevedere una progressiva riduzione della popolazione mondiale. Adesso siamo ritornati all’idea che la convergenza si realizzi su di un valore di equilibrio e che quindi nel futuro la popolazione mondiale si stabilizzerà attorno agli 11 miliardi. Mario: Tu come la vedi? 119 Secondo gli ultimi dati censuari si tratterebbe di un dato in eccesso; si veda Zhao, Z. (2011), China’s far below replacement fertility and its long-term impact. Demographic Research, 25, 819–836; Guo Zhigang e Gu Baochang (2010), “China’s Low Fertility: Evidence from the 2010 Census”, Springer. 104 Michele: A me pare che, se non ci mettessimo i paraocchi dell’equilibrio e guardassimo a quello che sta succedendo senza pregiudizi, emergerebbero tendenze molto diverse da quelle ipotizzate dalla Population Division e che non darebbero supporto all’ipotesi di una popolazione stabile. Demografi ben più preparati ed esperti di me hanno già da tempo sollevato seri dubbi su di un ritorno a tempi brevi ad una situazione di equilibrio demografico e sostenuto che ci troviamo in una situazione di transito verso una massiccio calo della popolazione mondiale 120. Comunque, questo equilibrio demografico mondiale, che dovrebbe essere raggiunto verso la fine del secolo, sarebbe il risultato di una generalizzata situazione di disequilibrio a livello dei singoli paesi e questo ci porta al punto più debole di tutta questa impalcatura previsiva: le ipotesi sul processo migratorio. D’altra parte i demografi sono da sempre consapevoli che le ipotesi sull’andamento delle migrazioni siano le più difficili da formulare e le più deboli del modello previsivo da essi adottato. John: E allora? Le ipotesi sulla migratorietà Michele: Negli ultimi quindici anni la Population Division ha esplorato e proposto diverse ipotesi. La soluzione standard, prescelta per lungo tempo e comunque fino a quando le proiezioni arrivavano al 2050, era che il livello dei flussi migratori rimanesse uguale al valore medio del decennio precedente l’anno d’inizio. In occasione delle proiezioni di lunghissimo periodo del 2004 –che si spingevano fino al 2300- s’ipotizzò che i saldi migratori fossero nulli a partire dal 2050. Nelle ultime due proiezioni, quelle del 2010 e del 2012, con orizzonte al 2100, si è invece ipotizzato che tra il 2050 e il 2100 i saldi migratori si riducano progressivamente fino ad annullarsi. John: Mi sembrano ipotesi caute e ragionevoli? Cos’è che non va? Michele: Quasi tutto. Le proiezioni partono dall’assunto che il livello futuro della popolazione dipenda dall’andamento di tre variabili: nati, morti e saldo migratorio. I demografi non si chiedono che cosa spieghi il livello e le tendenze di queste variabili, ma si limitano a utilizzare i dati storici per stimare i loro valori futuri. Inoltre, ognuna delle tre variabili è proiettata separatamente. In sostanza, s’ipotizza che non vi sia alcuna relazione tra di esse -ad esempio tra diminuzioni o aumenti della popolazione e flussi migratori o tra flussi migratori e fecondità- o che tali relazioni siano incorporate nei dati passati. Infine, mentre per nati e morti si tiene conto delle tendenze presenti nei dati storici, nel caso dei saldi migratori il valore utilizzato è mantenuto costante per una quarantina d’anni e poi portato progressivamente a zero per la fine del secolo. Mario: Insomma, stai dicendo che poiché non si sa da che cosa dipenda il numero dei nati e dei morti, si prendono i valori passati, si tira una riga in mezzo e la si prolunga? Michele: In sostanza sì, anche se per tirare quella riga si usano sistemi super complicati, resi possibili solo dalla potenza degli attuali computer. Tenete poi presente che nel caso della fecondità si usa il freno a mano per bloccare la decrescita demografica. Tuttavia, per quanto riguarda nati e morti non ho sostanziali obiezioni a una estrapolazione che arrivi a 30, 50 anni dato che si tratta in entrambi i casi di 120 Coale Ansley J. (1986), “Demographic effects of below-replacement fertility and their social implications in Kingley Davis e altri, Below Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies, Population and Development Review, Supplement to Vol. 12, New York, Population Council. 105 variabili lente e che, in assenza di eventi drammatici e comunque non prevedibili, non presentano particolari sussulti. E poi non esistono alternative. Mario: Tornando ai saldi migratori, tu pensi che in questo caso il passato non sia un buon indicatore del futuro. Michele: Sicuramente no. In secondo luogo credo che non sia realistico ipotizzare che i flussi migratori crolleranno durante la seconda metà del secolo. Infine, credo che le migrazioni dipendano anche dalle tendenze demografiche, mentre fecondità e mortalità sono certamente influenzate dal livello e dalla tipologia dei flussi migratori. In sostanza sono convinto che la spiegazione dei flussi migratori vada ricercata in un’analisi delle interrelazione tra variabili demografiche e variabili economiche. Li: Comunque, se tu ci raccontassi cosa è successo ai flussi migratori, anche noi potremmo confrontare le tendenze degli ultimi 50, 60 anni con quelle ipotizzate dalle Nazioni Unite. Le grandi tendenze dei flussi migratori Michele: I saldi migratori internazionali hanno subito grossi cambiamenti. Il primo è uno straordinario aumento del livello: si è passati da poco più di un milione d’immigrati all’anno, all’inizio degli anni 1950, a più di sei milioni nell’ultimo quinquennio così che, secondo le più recenti valutazioni, nel mondo vi sarebbero circa 233 milioni di emigrati. A parte il picco del 1990-95, dovuto alla caduta del muro di Berlino, l’aumento è stato regolare e progressivo. Quindi, ipotizzare che i saldi migratori rimangano costanti per i prossimi quaranta anni e poi diminuiscano è in totale contrasto con le tendenze degli ultimi sessanta anni. Mario: D’altra parte; se le migrazioni internazionali continuassero ad aumentare ai ritmi attuali si arriverebbe a trenta milioni di migranti all’anno verso la metà del secolo e questo mi sembra un risultato non politicamente corretto. Michele: Sembrano tanti, ma potrebbe essere il numero giusto. Il secondo fenomeno è stato un aumento più che proporzionale delle migrazioni intercontinentali che, nello stesso periodo, sono cresciute da 6,3 milioni nel decennio 1950-60 a 33,2 milioni nel decennio 2000-2010. L’incidenza delle migrazioni intercontinentali è così cresciuta dal 48 al 55 per cento. Infine, si è registrato un cambiamento molto pronunciato nella struttura geografica delle partenze e delle destinazioni. Tra il 1950 e il 1960 i flussi intercontinentali furono generati, in ordine d’importanza, da Europa, Africa e Sud America, mentre i principali paesi di arrivo furono i paesi del Nuovo Mondo (gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda) e l’Asia. Tra il 2000 e il 2010, le partenze sono state generate soprattutto dall’Asia, dall’America centrale e meridionale e dall’Africa, mentre l’Europa, i paesi del Nuovo Mondo e i paesi del Golfo sono stati le principali aree di arrivo. Pertanto, in sessanta anni, l’Europa è passata da essere il principale fornitore di manodopera del mondo a essere il principale importatore, mentre dal lato dell’offerta l’Asia ha preso il posto dell’Europa. Mario: Insomma, livello e direzione dei flussi migratori possono cambiare in maniera sostanziale anche in tempi brevi. Michele: Non vi è alcun dubbio. Gli esempi non mancano. Nel corso degli anni ‘70, il saldo migratorio d’Italia, Spagna, Portogallo e Grecia divenne negativo e questi paesi, che erano stati per oltre cento anni tra i principali esportatori di manodopera, 106 sono ora ai primi posti della classifica dei principali paesi importatori. Pensate che tra il 1950 e il 1970 gli stessi paesi esportarono 2 milioni e mezzo di persone, mentre tra il 1990 e il 2010 ne hanno importate quasi 12 milioni. Grafico 14 – Numero totale d’immigrati internazionali e d’immigrati intercontinentali; valori quinquennali in milioni dal 1950-55 al 2005-10 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Tavola 6 – Numero dei paesi di arrivo e di partenza; immigrati ed emigrati per continente in milioni; 1950-60 e 2000-10 Fonte: elaborazione su dati UNDESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Tavola 7 – Grecia, Italia, Portogallo e Spagna; saldi migratori in due periodi: 1950-1970 e 1990-2010 107 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Li: Forse si è trattato di un caso isolato e particolare. Michele: Assolutamente no. Negli anni successivi Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Slovenia, Malta e Cipro hanno registrato lo stesso fenomeno, mentre la Repubblica Moldova si è trasformata da paese importatore di manodopera in paese esportatore. John: A questo punto si deve dedurre che in tutti questi paesi è successo qualcosa di simile che ha causato questa radicale trasformazione. Una volta noto il meccanismo, lo potremmo usare per formulare delle ipotesi più realistiche sul futuro andamento dei flussi migratori. Michele: Stai dicendo che invece di fare proiezioni meccaniche delle serie storiche dei flussi migratori, immaginando che essi avvengano nel vuoto, dovremmo utilizzare un modello? John: Esattamente Michele: Vedo che i tuoi studi di economia hanno “plasmato” la tua mente. Ma c’è un problema: tale modello non è disponibile. Modelli economici e modelli demografici dei flussi migratori John: Stai scherzando. Anch’io ho studiato dei modelli economici dei flussi migratori. E poi, anche i demografi avranno le loro idee a proposito. Michele: Fammi riassumere brevemente la situazione, partendo da una breve rassegna della impostazione dei modelli economici. Le caratteristiche fondamentali del marginalismo -che rappresenta il pensiero economico prevalente- sono l’atomismo, il razionalismo e l’edonismo. Per dirla in maniera che non faccia subito arrabbiare Mario e Li, esso si basa sull’analisi del comportamento dei singoli attori economici, siano essi consumatori, imprenditori o lavoratori. Il marginalismo ipotizza che le loro scelte siano guidate dalla razionalità, siano cioè volte a massimizzare un qualche obiettivo, e che l’obiettivo che essi perseguono sia il “piacere”. Le teorie sull’immigrazione non fanno eccezione. Gli economisti scoprirono questo tema solo negli anni 50, proprio col lavoro di Lewis del quale abbiamo già parlato, nel quale le “migrazioni” dal settore arretrato verso il settore moderno costituiscono allo stesso tempo un meccanismo di sviluppo e di riequilibrio. Semplificando al massimo, la teoria economica immagina che il potenziale migrante faccia un confronto fra la situazione nella quale si troverebbe rimanendo nel proprio paese e quella nella quale si troverebbe emigrando. Affinché tale scelta possa attuarsi in maniera razionale, il modello ipotizza perfetta conoscenza. Il progetto migratorio verrà attuato nel caso in cui egli giunga alla conclusione che l’emigrazione produca un aumento del suo benessere. Il modello economico suggerisce, quindi, che gli emigranti tendano a spostarsi nei paesi nei quali i salari e i redditi sono più elevati, dove la probabilità di trovare lavoro è maggiore, dove le prospettive per il futuro delle loro famiglie sono migliori. Quindi, i differenziali di benessere, sviluppo e disoccupazione sono le determinanti principali della decisione di emigrare. John: Tutto ciò mi sembra molto ragionevole. 108 Michele: E’ proprio questo il problema. Il fatto che una cosa sia ragionevole non significa che sia giusta. Credo sia sempre opportuno guardarsi dalle cose troppo ovvie e, a dire il vero, molto banali come quelle che ho appena enunciato. John: Io non ho niente contro l'ovvietà. Michele: Purtroppo cose che sembrano ragionevoli e innocue hanno talvolta implicazioni e conseguenze non immediatamente evidenti. Se sono spiegate dal lato dell’offerta, le migrazioni non sono altro che una fuga dalla mancanza di lavoro e dalla miseria, dalla degradazione sociale, economica e politica generata dal sottosviluppo e la decisione di migrare risponde all’interesse dei migranti, non a quelle dei paesi di arrivo. Questa visione ha fortemente contribuito a presentare l’immigrazione come un’invasione di persone che, quando non sono dei criminali, come minimo rubano il lavoro ai cittadini dei paesi di arrivo; in sostanza, a dipingere l’immigrazione come un pericolo e come una minaccia. Pertanto, il pensiero economico prevalente ha condizionato in maniera negativa l’atteggiamento di molti nei confronti degli immigrati. Nella peggiore delle ipotesi, è alla base di posizione xenofobe e razziste; nei casi migliori, suggerisce atteggiamenti buonisti. Se in buona fede siamo convinti che gli immigrati siano dei poveretti che fuggono dalla fame e dalla miseria e siamo persone generose e di buon cuore cercheremo di aiutarli per quanto possiamo; ma è però normale che, prima o poi, specialmente se si creano situazioni particolari e di emergenza che ci danneggiano, stanchezza e rabbia finiscano con l’affiorare. E allora ci sarà sempre qualche politico che, interpretando il pensiero di buona parte di una popolazione disinformata e facendo ricorso al suo maggior buon gusto e alle sue superiori qualità linguistiche, esclami: “Fora di ball” 121. Per quanto riguarda le politiche poi, questa visione suggerisce che è giusto che un paese faccia tutto il necessario per fermare l’invasione. John: Questa tua lettura del modello è interessante. Tuttavia non basta per dimostrare che le cose non funzionino così. Mario: Questa impostazione non è di stampo liberista? Michele: Certamente. Essa si basa sull’idea che la società sia una somma d’individui e che i comportamenti globali (non solo migrazioni, ma anche consumi, produzione, investimenti) siano la somma di comportamenti individuali. In conclusione, ciò che spiega il comportamento del singolo, spiega anche il comportamento globale. Ovviamente, così facendo, questa tesi nega (o per lo meno nasconde) che i flussi migratori siano un fenomeno demografico, economico e sociale estremamente complesso. John: Ma il liberismo non è favorevole alla libera circolazione dei prodotti e dei fattori di produzione e considera questa una condizione necessaria e indispensabile per lo sviluppo e la crescita economica? Michele: E’ vero. Il modello neoclassico sostiene che i flussi migratori tendano a generare condizioni di equilibrio tra paesi di partenza e paesi di arrivo. Riducendo l’offerta di lavoro delle zone di partenza e aumentando l’offerta delle zone di arrivo, essi contribuiscono a livellare salari e costi del lavoro, mentre il trasferimento di rimesse favorisce la crescita economica dei paesi di partenza. Mario: Quindi i paesi capitalisti dovrebbero essere favorevoli ai flussi migratori, assicurarsi che il passaggio delle loro frontiere non presenti difficoltà e, qualora vi 121 La Repubblica, 29 marzo 2011 109 fossero ostacoli, rimuoverli. Gli imprenditori dovrebbero sostenere questa politica che renderebbe le loro imprese più competitive e contribuirebbe a creare mercati di sbocco per le loro merci. Michele: Cosa vuoi che ti dica. A volte la carne è debole e la paura di essere invasi dai diseredati della terra ha sempre prevalso, spingendo tutti i governi dei paesi di arrivo a stabilire quote ed elevare muri. Insomma, i dirigenti dei paesi di arrivo sono convinti che gli abitanti dei paesi poveri siano irrazionali, mentre nei loro paesi sia la razionalità a prevalere. Li: Ma tu credi veramente che se le frontiere fossero aperte non saremmo invasi? I poveri del mondo sono tanti. Michele: Credo che ci siano tutte le evidenze necessarie per sostenere che se le frontiere fossero aperte il numero degli immigrati sarebbe su per giù uguale a quello che si ha con tutti i divieti messi in essere dai vari paesi del mondo. John: Non mi convinci. Michele: In primo luogo è evidente, come sostiene anche il modello neoclassico, che gli emigranti economici vanno dove esiste una maggiore probabilità di trovare lavoro. In secondo luogo, se guardi il mercato del lavoro dei paesi d’arrivo, vedrai che il tasso di disoccupazione degli immigrati non è mai di molto superiore a quello dei residenti. In sostanza, i migranti vanno dove c’è lavoro e lo fanno in una misura corretta. Fra l’altro questa è la tesi sostenuta ormai da molto tempo da Nigel Harris, uno dei più interessanti studiosi inglesi d’immigrazione 122. John: Quindi il modello neoclassico potrebbe eventualmente spiegare le partenze. Michele: Eventualmente. Ma la domanda dirimente è se esso possa essere utilizzato per fare previsioni; vale a dire se esso consenta di stimare i flussi in uscita dai paesi di partenza e, cosa ancora più importante, la loro distribuzione tra i paesi di arrivo. In questo momento in Italia, ma anche in altri paesi europei, vi sono persone che provengono da circa 200 paesi. Anche volendoci limitare ai principali, si tratterebbe pur sempre di svolgere l’analisi presso una decina di paesi di partenza. Supponiamo, ad esempio, di voler studiare i flussi in uscita dalle Filippine. Per farlo in maniera corretta, dovremmo disporre di serie storiche delle partenze totali e per destinazione e poi metterle in relazione con gli indicatori dei paesi di arrivo, rapportati agli indicatori delle Filippine. Ti posso subito dire che queste informazioni statistiche non sono disponibili e che se lo fossero richiederebbero comunque un grossissimo lavoro di omogeneizzazione. D’altra parte, che la situazione sia questa lo dimostra il fatto che, a mia conoscenza, di studi di questo genere non ve ne sono. La conclusione è che se il modello non può essere stimato su dati retrospettivi, non è possibile utilizzarlo per fare previsioni. John: Stai dicendo che, al di là della sua validità teorica che sembra tu consideri se non proprio nulla comunque molto modesta, il modello neoclassico non consente di stimare il livello delle partenze e la distribuzione per paese di sbocco perché le informazioni statistiche necessarie non sono disponibili? Michele: Esattamente. E, prendendo sempre come esempio l'Italia, in assenza di stime che ci dicano come varia il numero di filippini, albanesi, ecuadoregni, ecc. che vogliono venire nel nostro paese al variare, ad esempio, dei relativi differenziali del 122 Nigel Harris (2000), I Nuovi Intoccabili, Il Saggiatore, Milano 110 tasso di disoccupazione o di reddito pro-capite, non potremo costruire non solo delle previsioni, ma neppure degli scenari degli arrivi. Va anche sottolineato che il numero di filippini che decidono di venire in Italia non dipende solo dal variare della condizioni relative dei due paesi, ma anche delle condizioni economiche degli altri paesi potenziali di sbocco. A questo punto, dovrebbe essere evidente che un modello, giusto o sbagliato che sia, che fornisce una spiegazione delle migrazione dal lato dell’offerta è comunque inutilizzabile per costruire scenari degli arrivi nei singoli paesi di destinazione. A mio avviso, l’unico risultato che questi modelli hanno raggiunto è stato quello di proporre una visione dei flussi migratori errata e dannosa sia per i paesi di partenza, sia per quelli di arrivo. John: E i demografi? Michele: Come abbiamo visto, le migrazioni fanno parte dell’agenda degli economisti da una sessantina anni; invece, esse sono da sempre uno dei temi centrali della demografia così che in tema di migrazioni la voce dei demografi è ancora la più autorevole e la più ascoltata dai politici. L’obiettivo principale della demografia è quello di descrivere e “spiegare” l’evoluzione delle popolazioni. Lo strumento di base è il cosiddetto bilancio demografico che “spiega” la variazione del livello di una popolazione come risultante di flussi di entrata e di uscita dovuti, da un lato, a fenomeni naturali (nascita e morte) e, dall’altro, ai movimenti delle persone da un’area geografica ad un’altra (emigrazione ed immigrazione). In sostanza, la variazione della popolazione in un dato intervallo temporale è “spiegata”, da un lato, dalla differenza tra nascite e morti (saldo naturale) e, dall’altro, dalla differenza tra immigrati ed emigrati (saldo migratorio). Mario: Questo è quello che ci hai già detto quando abbiamo parlato della metodologia previsiva, ma suppongo che si tratti solo del primo livello di “spiegazione”. Michele: I demografi spiegano l’andamento delle nascite con l’andamento della fecondità e del numero delle donne in età fertile e l’andamento delle morti con la struttura della popolazione per classi di età e coi tassi di mortalità. In sostanza, la demografia è una disciplina eminentemente descrittiva e non ha mai sviluppato modelli che spieghino i flussi migratori, ma si è da sempre limitata a descrivere il fenomeno dandone, per altro, interpretazioni diverse a seconda dei contesti e delle fasi storiche. Tuttavia, la “teoria” demografica delle migrazioni condivide, in maniera più o meno esplicita, numerosi elementi dell’impostazione economica. In primo luogo, il contesto liberista e quindi l’interesse prioritario per l’analisi delle decisioni individuali di partenza. Anche le analisi demografiche tendono poi a vedere i flussi migratori come elementi di riequilibrio delle situazioni demo-economiche dei vari paesi. La situazione tipica è quella in cui cause di ordine demografico ed economico portano alla costituzione di un eccesso di popolazione che non può trovare sbocco nel mercato locale del lavoro o che comunque non trova sostentamento nel processo economico dell’area di residenza. A questo punto s’ipotizza che, come in un sistema di vasi comunicanti, l’acqua si riversi dai bacini con un livello più elevato a quelli in cui il livello è più basso finché i livelli non si siano eguagliati. Così una parte delle persone che vivono in paesi caratterizzati da un eccesso relativo di popolazione è soggetta a una pressione che spinge una parte dei suoi componenti ad emigrare verso altri paesi dove la popolazione è relativamente carente. In sostanza, i demografi ritengono che i flussi migratori siano attivati da una crescita demografica non 111 accompagnata da un’adeguata crescita economica, cioè da un eccesso di offerta di lavoro. John: E’ cosi che sono state spiegate le grandi migrazioni del XIX secolo? Michele: Si. E’ stato sostenuto che le migrazioni intercontinentali del secolo scorso furono attivate dall’accumularsi nelle campagne Europee, tra il 1870 e l’inizio della prima guerra mondiale, di un’offerta di lavoro che eccedeva largamente il fabbisogno di lavoro generato dal processo d’industrializzazione che si stava attuando nelle città. Analogamente si è sostenuto che l’inizio del grande esodo migratorio dall’Italia fosse stato causato da una situazione di eccesso di offerta di lavoro provocato, da un lato, dalla crescita demografica e, dall’altro, dalla crisi agraria del 1880. Mario: Quindi, anche i demografi spiegano le migrazioni dal lato dell’offerta? Michele: Vi sono anche analisi attente alla situazione delle zone e dei paesi di arrivo e quindi al ruolo dell’attrazione dovuto alla carenza di lavoro. In generale, tuttavia, è il ruolo della sovrappopolazione e dell’eccesso di offerta a prevalere e la domanda di lavoro non svolge mai un ruolo paritetico a quello dell’eccesso di offerta. Va tuttavia riconosciuto che le analisi dei demografi sono più articolate di quelle degli economisti, anche se molto meno formalizzate e spesso inclini a spiegazioni ad hoc e contingenti. Mario: In conclusione ci stai dicendo che i demografi non dispongono di modelli che spieghino le migrazioni, mentre gli economisti hanno i modelli, ma questi modelli potrebbero eventualmente spiegare le partenze, ma non gli arrivi e comunque non vi sono i dati per stimarli. Michele: Proprio così. John: Senti, comunque vada la tua rimane una tesi anomala che credo tu ci debba provare partendo da quello che dicevamo prima e cioè mostrandoci che è la domanda che spiega le tendenze dei saldi migratori e le modifiche nella struttura delle partenze e degli arrivi. Michele: E’ quello che intendo fare anche perché è su questa impostazione che si basa la possibilità di formulare proiezioni realistiche dei flussi migratori e quindi creare scenari demografici credibili. Li: Ragazzi, io ne avrei abbastanza di demografia; è ora di cominciare il nostro cenone di capodanno. La tavola e pronta, manca solo il cibo. Mario: Ma quanta roba hai preparato! Li: Per noi il cenone di capodanno è una cosa seria, voi direste una grande abbuffata. Aiutatemi a portare tutto in tavola e intanto vi spiego. 112 Nonostante le certezze di molti autori che si occupano di questo argomento, non ho trovato alcun elemento convincente per asserire che sono le privazioni a spingere la massa dei lavoratori emigranti (distinti dai rifugiati) a lasciare i propri paesi, mentre abbondano i riscontri del fatto che il movimento e la sua composizione (per qualifiche, educazione, sesso, ecc.) sono fortemente sensibili alla domanda di lavoro nei paesi di destinazione. Nigel Harris, I nuovi intoccabili, pag. 11 Quinto dialogo Un modello stock flussi del mercato del lavoro. Una pizzeria nel centro di Bologna la città dove Michele vive ormai da un paio d’anni con la famiglia. A proposito di tortelloni, ricotta e governo delle larghe intese Li: Vada per la pizza, ma la prossima volta si torna a mangiare cinese. John: Il tuo cenone di capodanno è stato fantastico, ma per me una buona bistecca rimane il massimo. Mi hanno appena detto che a Bologna c’è un nuovo ristorante argentino e non mi dispiacerebbe provare le sue bistecche. Michele: Ma allora sarebbe meglio organizzare una gita in Valdichiana e farsi una bella fiorentina. Mario: Lo sapevate che Li: ci risiamo.. Mario: .. la Chianina è una delle razze bovine più antiche ed è stata descritta da Columella 123 già nel 55 a.C.? Li: No, e adesso che lo so mi sento veramente molto meglio. Mario: Comunque, io penso che dovremmo evitare la carne. Se mangiassimo le calorie corrispondenti in verdura, cereali e frutta risparmieremmo denaro, staremmo meglio, faremmo il bene delle mucche e, soprattutto, non devasteremmo l'ambiente. Michele: Risalire la scala alimentare è certamente una mossa intelligente, ma io sono un animale carnivoro. Comunque, questa sera sono disposto a venire incontro ai desideri di Mario e a sacrificarmi ordinando un piatto di tortelloni burro e oro. Qui la pasta è fatta a mano e la cuoca appartiene alla scuola di pensiero che per il ripieno usa gli spinaci e non il prezzemolo, proprio come faceva mia nonna. La ricotta, poi, la comprano direttamente da uno dei pochi pastori che vive ancora nei dintorni. Credo venga dal Marocco (il pastore, non la ricotta). Trent'anni fa, al massimo sarebbe venuto dalla Sardegna. Un altro esempio di come le tendenze demografiche ed economiche modifichino costantemente il livello e la direzione dei flussi migratori! 123 L. Iunius Moderatus Columella, c.55 a.C, De Re Rustica, Liber Sextus 113 Mario: Che palle con questi tortelloni. Non so quante volte ci hai parlato dei tortelloni che fanno in quel ristorante, vicino al tuo paese natale, dal nome un po’ enigmatico: Al Bivio. Michele: Niente di enigmatico o ambiguo; semplice descrizione del contesto stradale. Purtroppo la nuova gestione per quanto buona non è al livello della precedente. John che non si lascia facilmente distrarre da diatribe in tema di tortelloni, tortellini, ecc: Il problema sta tutto nell'esplosione demografica e nella crescente povertà di tanti paesi dell’Africa e dell’Asia. Mario: Vedo che siete “casualmente” ritornati al punto nel quale ci eravamo lasciati. Li: Prima di cominciare a bisticciare, ordiniamo. Come diceva Confucio, si discute meglio con la pancia piena. Avete scelto? Convinti da questa perla di saggezza orientale: Michele: Confermo i tortelloni burro e oro. John: Io mi faccio una pizza speciale gigante. Mario: Per me un’ortolana. Li: Per me spaghetti allo scoglio. John: Che cosa beviamo? Birra, prosecco o, meglio, ancora, un bianco di Napa Valley? Alla fine quelli che hanno scelto pizza ordinano birra, gli altri un buon prosecco che anche il resto della compagnia non disdegna come aperitivo. Mario: Dopo l’ultima chiacchierata mi è tornato in mente quello che ho letto sui giornali e ho visto negli ultimi anni in televisione in tema di migrazioni. Si tratta soprattutto d’immagini di disperati in fuga dalla miseria e dalla degradazione sociale, di gommoni e battelli sovraccarichi di uomini, donne e bambini, del villaggio vacanze a cinque stelle organizzato per loro a Lampedusa dal nostro Ministero degli Interni, di selvaggi assalti a ville venete e lombarde da parte di affiliati alle mafie albanesi e serbe, di accoltellamenti nella Chinatown milanese. Ben poche le analisi sulle ragioni della presenza in Italia di milioni d’immigrati che non siano basate sull’idea della fuga dalla miseria e facciano riferimento a un fabbisogno del nostro mercato del lavoro, a parte alcune denunce della mancanza di badanti e infermiere. Non ricordo di aver udito nessuno affermare che gli immigrati sono qui semplicemente perché il nostro sistema produttivo ne ha bisogno. John: A me questa tesi non convince e prima che io l’accetti deve argomentarla molto meglio, dati alla mano. Michele: Facciamo così. Vi proporrò la mia tesi e poi proverò di convincervi con un pizzico di storia, il tutto condito da statistiche quanto basta. L’unico rischio è che poi la pizza vi rimanga sullo stomaco. Li: Ok; minimizziamo il rischio; racconta la tua tesi prima che ci servano. Michele: Non so se c’è il tempo perché prima bisogna che vi racconti come funziona il mercato del lavoro. Comunque, diciamo al cameriere che aspetti un po’ a portarci i primi e, se proprio non ce la facciamo, sarà per la prossima volta. Li, vedendo Michele aprire il suo zaino arancione: Bisogna rassegnarsi. Mai che se lo dimentichi. Approfittiamone per brindare alla formazione del governo delle larghe intese. 114 Michele, tirando fuori il computer dallo zaino: Prepariamoci al peggio! Mario: Non vedo che cosa ci sia da festeggiare! Andare al governo con Berlusconi non può certo portarci ai cambiamenti radicali dei quali il nostro paese ha bisogno. Questo è, tutto sommato, un governo democristiano. Avrei preferito che i grillini facessero un atto di responsabilità e di realismo e si alleassero con la sinistra. John: Non sarebbe stato coerente con il loro programma elettorale. Inoltre anche la politica è un mestiere e, come tutti i mestieri, richiede professionalità. Mario: A volte rimpiango i democristiani di una volta. E’ morto anche Andreotti. C’è rimasto solo Cirino Pomicino che vedo spesso al mattino su la Sette: un grande. Michele mentre cerca una presa, attacca il computer e lo accende: Un pateracchio che ci consentirà di bordeggiare, ma non di uscire dalla crisi nella quale ci troviamo; che terrà i conti in ordine e ci farà sembrare dei bravi ragazzi all’occhio della Unione economica europea e della culona tedesca la quale vincerà le elezioni giocando sul doppio standard: guanto di velluto per i suoi elettori, guanto di ferro per gli sfaticati del sud. John: Un po’ di rispetto verso una statista di calibro che sta conducendo con mano salda il suo paese e l’Europa verso un futuro migliore. Mario: Sul calibro non ci sono dubbi! Sull’incapacità di comprendere i bisogni dell’economia europea solo certezze! Le economie del sud dell’Europa non possono rimettersi su di un solido sentiero di crescita se i consumatori sono obbligati a ridurre i consumi e le aziende non hanno liquidità per investire. Il modello stock-flussi Michele: Torniamo a noi. Sono pronto. La figura che vedete sullo schermo del mio computer ci può aiutare prima di tutto a capire come funzioni il mercato del lavoro e poi a spiegare i flussi migratori e costruire una metodologia per “prevederli”. Mario: Miracoloso! Un disegno molto carino, ma per il momento non ci vedo tutte le cose che hai detto. Michele: Fatemi spiegare. Anche se a prima vista può non essere del tutto evidente, quella che avete davanti a voi è una rappresentazione della vita umana. John: Non l’avrei mai detto! 115 Le fasi della vita Michele: Piantatela di fare gli spiritosi. Un po’ di rispetto per la scienza con la S maiuscola. Il rettangolo rappresenta la popolazione di un paese ed è diviso in tre parti che si riferiscono alle tre fasi fondamentali della vita umana vista da una prospettiva economica: la fase formativa, la fase lavorativa, la fase post lavorativa. Mario: Insomma se mentre andavi a Tebe, tu avessi incontrato la Sfinge, l’avresti sgamata. Li: State parlando per enigmi. Michele: Hai detto la parola giusta: enigma. Mario sta delicatamente insinuando che la mia non è una gran trovata, dato che anche la Sfinge e Edipo, che vissero su per giù 3.000 anni fa, lo sapevano. Li: Sapevano cosa? E chi erano la Sfinge e Edipo? Mario: La Sfinge era una leonessa alata con la testa umana. Se ne stava appollaiata su di una roccia che sovrastava la strada che conduceva a Tebe. Era un po’ come il vostro Nian, ma più intellettuale. La Sfinge poneva a tutti quelli che volevano entrare in Tebe il seguente indovinello: “Qual è l’animale che la mattina cammina a quattro zampe, a mezzogiorno con due e alla sera con tre?” Chi non sapeva la risposta non prendeva un brutto voto, ma veniva mangiato e ciò non aiutava le attività commerciali e turistiche di Tebe. Il re della città, Creonte, promise il trono e la mano della sorella Giocasta a chi avesse saputo rispondere al quesito della Sfinge. Ci riuscì un certo Edipo che così divenne re di Tebe e sposò Giocasta. Li: Tutto è bene ciò che finisce bene! Michele: In questo caso non fu proprio cosi perché Edipo -che senza saperlo aveva già fatto fuori suo padre- sposò Giocasta che era sua madre, cosa che fu poi fonte di altri terribili disastri, ma qualche millennio dopo offrì la possibilità prima a Freud e poi a Jung di parlare del complesso di Edipo. Li: Ragazzi, non state migliorando la situazione. Limitatevi a dirmi che rapporto c’è tra la Sfinge e il grafico di Michele. 116 Mario: Beh, la risposta all’enigma della Sfinge è l’uomo che da bambino gattona, quando è adulto, cammina su due piedi e quando è vecchio, si aiuta con un bastone. Il punto è che sia la Sfinge, sia Edipo avevano già chiaro che l’uomo nel corso della vita attraversa tre fasi. Michele: Posso continuare? Grazie. La vita umana fluisce continua al ritmo che il tempo ha sul nostro pianeta. Viviamo nel continuo 124, ma per capire e interpretare la storia abbiamo bisogno di tracciare barriere temporali, creare discontinuità. Così, fin dai tempi più antichi, la vita umana è stata percepita come una successione di fasi, ritmate da discontinuità biologiche e caratterizzate da diversi ambiti di attività, diritti e doveri, definiti e regolati da consuetudini, norme e prassi. Mario: Quasi poetico e un po’ aulico! Michele: E’ un argomento che m’ispira. A meno di spiacevoli incidenti di percorso, tutti gli uomini attraversano, sospinti dal trascorrere del tempo, le tre fasi. La fase formativa è la fase della socializzazione, della crescita fisica, della maturazione psicologica. John: Beh, è la fase in cui ognuno di noi costruisce il proprio capitale umano. Michele: Certamente, dopo aver preso carta e matita e aver eseguito un attento confronto 125 tra varie alternative per decidere razionalmente se prendere la terza asilo o un dottorato . La fase formativa dovrebbe essere dedicata ad apprendere le cose necessarie a divenire degli adulti psicologicamente maturi e dei buoni cittadini. Gli aspetti produttivi, l’apprendimento di competenze coerenti con le nostre capacità e aspirazioni hanno una grande importanza individuale e sociale solo se inserite in un contesto formativo che premi gli aspetti psicologici, sociali e culturali. Buttarla tutta sull’aspetto economico mi sembra a dir poco riduttivo e svilente vista la complessità della natura umana. Poi questa terminologia “capitale umano” non mi va giù. Mario: Sapete, l’altra settimana sono andato in banca a chiedere un prestito. Il direttore mi ha detto che c’era bisogno di garanzie; io gli ho detto che avevo un notevole capitale umano, un paio di lauree e molta esperienza. Mi ha guardato per un attimo e poi, forse sospettando un Alzheimer precoce, mi ha accompagnato gentilmente alla porta. Appena uscito, mi è sembrato di sentirlo sghignazzare in maniera scomposta insieme agli altri impiegati. Michele (trascurando l’interruzione): La fase lavorativa è la fase della maturità, durante la quale gli uomini si costruiscono una famiglia, si riproducono e danno vita ai più importanti giuochi di potere e d’interazione sociale. E’ agli individui in questa fase che è affidata la sopravvivenza e il miglioramento delle condizioni socio-economiche del loro paese. Nelle società tradizionali la fase post-lavorativa era la fase della saggezza e i pochi che la raggiungevano erano altamente rispettati. Le cose stanno cambiando rapidamente. Il numero degli anziani è in rapida crescita e le pantere grigie stanno perdendo il loro fascino in una società in cui l’anziano è sempre più uno scarto, magari per un po’ riciclato come babysitter e incaricato della manutenzione ordinaria della famiglia, ma poi da rottamare non appena la sua produttività si riduce. A livello sociale poi, gli anziani sono percepiti sempre più come un 124 Di fatto non sappiamo ancora se vi sia una quantità minima di tempo. Comunque sia, non è un problema di cui preoccuparci troppo. 125 Il concetto di capitale umano fu discusso per la prima volta da A. C. Pigou nell’ormai lontano 1928 per essere poi introdotto nel contesto neoclassico da Jacob Mincer (“Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”, Journal of Political Economy, 1958). Ma la sua consacrazione come uno dei capisaldi del pensiero neoclassico si ebbe con la pubblicazione nel 1964 del libro Human Capital da parte di Gary Becker. Becker vinse il premio Nobel nel 1992 per aver ampliato il campo della macroeconomia a un ampio spettro di comportamenti e interazioni umane anche al di fuori dell’ambito di mercato. 117 peso e un pericolo per i costi crescenti che la comunità deve sopportare per pagare loro pensioni e assistenza medica. John: Ehi mi sembri un po’ troppo coinvolto in questa discussione sugli anziani. Michele: Figurati. Ho appena fatto il primo tagliando. John: Forse hai perso il conto. Michele: Non mi disturbate che se no arrivano i tortelloni mentre siamo sul più bello. Notate che il rettangolo della fase lavorativa include delle ripartizioni ulteriori che mettono in evidenza le forze di lavoro e le non forze di lavoro e che le forze di lavoro sono ulteriormente divise in occupati, persone in cerca di prima occupazione e disoccupati. Mario: Insomma, le persone in età lavorativa possono o lavorare o cercare lavoro o essere fuori dal mercato del lavoro e dedicarsi allo studio, ai lavori domestici, e c’è sicuramente anche qualcuno che vive di rendita. Popolazione, condizioni socio - economiche e passaggi di condizione. Michele: I censimenti e altre rilevazioni misurano la dimensione della popolazione totale e delle sub-popolazioni nelle condizioni socio-economiche che ho appena elencato. Ci dicono quanti sono gli abitanti di un paese (l’area del rettangolo), quanti di loro sono studenti, occupati, persone in cerca di occupazione, oltre a fornircene la struttura per sesso e classe di età. Insomma, i censimenti fotografano il livello e la struttura della popolazione di un paese in un dato istante di tempo. Li: Fin qui ci sono. Adesso però m’incuriosiscono tutte quelle frecce che hai messo nel tuo grafico. Michele: Le frecce rappresentano i flussi che collegano le sub-popolazioni e che determinano il loro continuo divenire, i loro cambiamenti quantitativi e qualitativi. Mario: Suppongo che tu stia usando il termine popolazione nella sua accezione tecnica. Michele: Sì; una popolazione è un insieme d’individui che vivono su di un determinato territorio e condividono una qualche caratteristica. Si tratta, tuttavia, di un concetto molto generale che può essere utilizzato non solo per le persone che abitano in un dato paese, o per gli elefanti che vivono nel Parco Nazionale di Addo, ma anche per le stelle che formano la Via Lattea. Tuttavia, l’aspetto più caratterizzante di una popolazione è il suo continuo modificarsi, il suo continuo divenire. Un censimento fotografa una popolazione in un dato momento di tempo. Le fotografie scattate da censimenti successivi permettono non solo di cogliere i cambiamenti quantitativi della popolazione, ma anche di vedere come sia cambiata la sua struttura e quindi la sua composizione per sesso, classe di età, livello scolastico e educativo, peso delle varie condizioni socio-economiche. Ed è qui che entrano in gioco i flussi, i cambiamenti di condizione. Il modo in cui una popolazione cambia è, infatti, il risultato di entrate e di uscite e delle differenze quantitative e qualitative tra questi due flussi, nonché dei cambiamenti registrati dai sopravvissuti a causa del trascorrere del tempo, dei loro comportamenti e delle loro decisioni e dei comportamenti e delle decisioni degli individui con cui essi hanno interagito. Prima che Li mi chieda qualche esempio di come questa cosa funzioni, eccone alcuni. L’aumento della presenza femminile nelle forze di lavoro è dovuto al fatto che le donne che entrano sono più di quelle che escono. L’aumento del livello educativo degli occupati è dovuto all’ingresso di persone con una scolarità maggiore di quelli che escono. Il calo degli occupati in agricoltura, contrariamente a quanto normalmente si sostiene, 118 non è dovuto a fenomeni d’inurbamento, ma al fatto che sono pochi i figli di contadini che entrano nel settore, rispetto agli anziani che ne escono per cause naturali. Mario: Non condivido il fatto che la tua rappresentazione della vita non preveda l’eterno ricambio generato dalle rinascite Michele: Insomma vorresti che la freccia di uscita girasse intorno al rettangolo e si collegasse alla freccia d’ingresso, che cioè collegassi le uscite definitive con gli ingressi naturali, le morti con le nascite. Mi sembra un suggerimento interessante e che, per così dire, chiuderebbe il cerchio. Tuttavia, per il momento, lascia che mi limiti all’approccio demografico che, sia pure in maniera più prosaica e materialista, vede la variazione del livello di una popolazione come la conseguenza del saldo naturale, dato dalla differenza tra nati e morti, e del saldo migratorio, dato dalla differenza tra immigrati ed emigrati. Quello che a me interessa è utilizzare questo approccio per imputare le variazioni delle subpopolazioni nelle diverse condizioni socio-economiche (forze di lavoro, occupati, non forze di lavoro, ecc.) a entrate e uscite. Inoltre, intendo usare solo flussi definitivi. Li: Cosa vuol dire? Flussi generazionali e flussi temporanei Michele: I cambiamenti di condizione sono di due tipi: definitivi e temporanei. Il primo tipo, che preferisco chiamare generazionale, si riferisce agli eventi che i demografi definiscono non rinnovabili o fatali, nel senso che avvengono una volta sola e non consentono un ritorno alla situazione precedente. Li: Credevo che l’unico evento fatale fosse la morte. Michele: Beh, anche qui non si può essere categorici. Sembra, infatti, che 2000 anni fa in Palestina vi siano state almeno un paio di eccezioni. Anche a Berkeley, verso il 1970, comparvero dei manifesti che preannunciavano la resurrezione di un santone indiano che, prima della sua prematura dipartita, aveva promesso ai propri fedeli che sarebbe ritornato in vita. Tuttavia, pian piano, ci dovemmo convincere che qualcosa era andato storto e non saremmo riusciti ad assistere a questo interessante evento. Comunque, oltre alla morte, vi sono altri cambiamenti di condizione che normalmente non sono ripetibili e non consentono un ritorno alla condizione precedente. La nascita preclude il ritorno alla condizione di feto, l’ingresso nella scuola preclude il ritorno nella popolazione composta da coloro che non hanno mai frequentato la scuola, l’ingresso nell’occupazione preclude il ritorno tra coloro che non hanno mai lavorato e cosi via. Sono questi i passaggi di condizione che chiamo definitivi o generazionale. Inoltre, questi passaggi rappresentano le tappe fondamentali della vita delle persone e delle generazioni. Mario: E il secondo tipo? Michele: Sono i passaggi di condizione seguiti da un ritorno nella condizione di partenza; si tratta quindi di passaggi temporanei. Nel caso del mercato del lavoro, il caso più comune è quello del passaggio dalla condizione di occupato a quella di disoccupato, spesso seguito da un ritorno nella condizione di occupato. Ovviamente, nel caso in cui il passaggio alla disoccupazione non sia seguito da un ritorno nell’occupazione si tratterà di un passaggio definitivo. Li: Tanto per essere sicuro di aver capito: il matrimonio rappresenta un passaggio di condizione definitivo o temporaneo? 119 Michele: Dipende. Se uno rimane sposato tutta la vita, si tratta di un passaggio definitivo; in caso di divorzio o morte del coniuge il passaggio diventa temporaneo. Notate che un passaggio è temporaneo anche nel caso in cui sia l’inizio di una catena di passaggi che finisce, però, per riportare alla condizione di partenza. Di fatto, i flussi temporanei sono quelli che riportano alla condizione di partenza. Ad esempio: Occupato => Disoccupato => Non Forza di lavoro => Disoccupato => Occupato John: Quindi in molti casi la tipologia di un passaggio di condizione, se sia cioè definitivo o temporaneo, la si conosce solo ex post. Michele: Esatto, ma questo non inficia la validità di questa distinzione necessaria per comprendere il funzionamento del mercato del lavoro e spiegarne la dinamica. Sono i flussi generazionali che ritmano la vita degli individui e permettono di tracciare i percorsi di vita. Tutti noi con la nascita siamo entrati, in maniera del tutto inconsapevole, ma certamente traumatica, nella popolazione; abbiamo percorso una fase formativa, più o meno lunga, alla fine della quale abbiamo vissuto la seconda transizione, anche questa spesso traumatica, dal mondo della scuola al mondo del lavoro. I più fortunati hanno trovato un lavoro duraturo o sono passati con facilità da un lavoro a un altro. Altri hanno faticato a trovare un lavoro e a mantenerlo, trascorrendo molto tempo nella condizione di disoccupato. Altri, soprattutto altre, hanno trascorso la fase lavorativa della vita tra le non forze lavoro, ma lavorando ugualmente, se non di più, provvedendo alla manutenzione ordinaria delle forze di lavoro e alla cura dei giovani e degli anziani. Poi per tutti arriva il momento della terza grande transizione, quella dal mondo del lavoro alla fase post lavorativa. Questa transizione conduce nella sala d’aspetto dell’ultimo e definitivo cambio di condizione, una sala d’aspetto che può essere ancora vivacizzata da attività di supporto al proprio nucleo famigliare o alla frequentazione di Disneyland specializzate in anziani, ma che poi spesso conduce alla frequentazione di meno allegri luoghi di degenza. Se i flussi generazionali mostrano le tappe fondamentali del percorso di vita, i flussi temporanei ci fanno vedere le deviazioni che abbiamo scelto o a cui siamo stati costretti. Ad esempio, molte donne escono dal mercato del lavoro quando i figli sono piccoli per rientrare quando sono cresciuti. Il modello del mercato del lavoro che vi voglio presentare si concentra sulla fase lavorativa, ma la figura che vi ho fatto vedere permette di evidenziare la sua relazione con la fase precedente, quella formativa, e con la fase successiva, quella post lavorativa. Infine, esso non contiene meccanismi che generino automaticamente situazioni di equilibrio. Al contrario, consente di evidenziare eventuali situazioni di disequilibrio strutturale, analizzarne le cause e fornire cosi gli strumenti analitici necessari per disegnare e implementare politiche di medio lungo periodo. John: Mi fai riaffiorare lontani ricordi dei tempi dell’Università. Michele: Beh l’analisi di flusso del mercato del lavoro non l’ho inventata io. Il mio contributo è stato l’introduzione della distinzione tra flussi generazionali e flussi temporanei 126 126 La rappresentazione di flusso del mercato del lavoro ha una lunga storia che risale al dopoguerra e raggiunse la maturità a cavallo degli anni ’70 in una serie di studi del National Bureau of Economic Research; subito dopo l’attenzione degli economisti del lavoro si spostò però sul tema della durata della disoccupazione. Tuttavia, in tutti questi studi manca la distinzione tra flussi generazionali e flussi temporanei, fondamentale per comprendere la dinamica del mercato del lavoro. Franco Franciosi ed io la introducemmo in una serie di lavoro scritti a partire dalla fine degli anni ’70. Solo molto più tardi, lavorando sulla storia della letteratura sui flussi del mercato del lavoro, mi sono imbattuto in un articolo passato ignorato (I. Sobel and C Wilcock (19556), "Secondary labor force mobility in four mid-western shoe towns", Industrial and Labor Relations Review) in cui gli autori ponevano con chiarezza tale distinzione:” "Movement into and out of the labor force, or labor force mobility, can 120 John: E così importante? Il modello di breve periodo e il modello generazionale Michele: Questa distinzione permette di formulare due diversi modelli del mercato del lavoro e specificare diversi indicatori del mercato del lavoro. Un modello che consideri sia i flussi generazionali, sia quelli temporanei permette di apprezzare come il movimento e il cambiamento siano le caratteristiche dominanti del mercato del lavoro. Consente di analizzarne la flessibilità, di misurare la durata della disoccupazione e di verificare se e in che misura vari gruppi socio-economici ne siano affetti in modo diverso Il modello generazionale che rappresenta può, invece, rispondere a domande di carattere strutturale: farci capire, ad esempio, quale sia il meccanismo che permette alle generazioni che escono una dopo l’altra dal sistema formativo di trovare lavoro, come mai per alcune sia più difficile che per altre ottenere tale risultato, perché alcuni giovani risultino relativamente avvantaggiati, ma anche perché alcune generazioni possano essere numericamente insufficienti a fronteggiare la 127 domanda di lavoro . John: Belle domande! Non ricordo che durante il mio corso di economia del lavoro ci si sia interrogati su questi problemi. Paradigmi, peyote e piselli Michele: La parte difficile della ricerca scientifica non è rispondere alle domande sul 128 tappeto, prima o poi qualcuno ci riesce , ma formulare domande nuove. Studiare comporta l’apprendimento di modi di interpretare la realtà e questi modi di guardare al mondo sono attaccaticci. L’attaccamento tende spesso a diventare viscerale soprattutto nel caso dei ricercatori professionisti per i quali quelle rappresentazioni cessano di essere strumenti, ma diventano una bandiera e una fonte di reddito e di potere. Quello che voglio dire è che la maggior parte dei ricercatori svolge il proprio lavoro indossando dei paraocchi che limitano il campo visivo e rendono molto difficile, se non impossibile, porsi domande nuove e vedere problemi diversi, ma spesso più interessanti di quelli al centro delle loro analisi. be classified into two basic types. One is an inevitable function of the human aging process and is characterized by movements into the labor force upon the completion of schooling and movement out when a worker retires or is retired because of age. The other consists of the entrances and exits of those persons who are not regularly or consistently in the labor force during the usual span of working years but who move into and out of the labor force intermittently or are in the labor force only once or twice for relatively short periods of time". 127 Il modello generazionale fu introdotto alla fine degli anni ’70 (Bruni Michele e F.B. Franciosi (1979), “Domanda di lavoro e tassi di attività”, Rivista Trimestrale di Economia, Istruzione, e Formazione Professionale, n. 6), ma le prime esposizioni esaustive sono degli anni ’80, quando il modello fu utilizzato per formulare gli scenari che furono alla base del Piano Decennale dell’Occupazione: M. Bruni e F.B. Franciosi (1985), "Scenari alternativi di domanda e di offerta di lavoro: un'analisi in termini di flusso", in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, La politica occupazionale per il prossimo decennio, Roma; si veda anche M. Bruni e F.B. Franciosi (1985), "Il mercato del lavoro in Italia: un'analisi di flusso", in M. Schenkel, (a cura di.), L'offerta di lavoro in Italia. Problemi di rilevazione, valutazione, costruzione, di modelli di comportamento, Marsilio, Venezia; M. Bruni (1988), “A stock flow model to analyse and forecast labor market variables", Labour, n.1; M. Bruni (1993), "Per una economia delle fasi della vita", in Associazione Italiana di Statistica, Popolazione, tendenze demografiche e mercato del lavoro, Roma. La prima esposizione del modello congiunturale, sviluppato per analizzare il mercato del lavoro della Valle d’Aosta a supporto delle attività di programmazione delle politiche regionali del lavoro compare in M. Bruni e D. Ceccarelli, “I mercati locali del lavoro: un modello per l’analisi congiunturale”, Franco Angeli, Milano, 1995. 128 Uno dei casi più sensazionali è stata certamente la dimostrazione dell’ultimo teorema di Fermat presentata da Wiles nel 1995, dopo sette anni di lavoro condotto in assoluta segretezza. Il teorema era stato formulato nel lontano 1637. Fermat aveva altresì notato: “ Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina” e c’è da credergli dato che la dimostrazione di Wiles occupa circa 200 pagine. 121 Mario: Mi viene il dubbio che da giovane tu sia stato influenzato dal libriccino di quel fisico che, dovendo tenere un corso di storia della scienza in quel di Harvard, si era messo a leggere non i riassunti, ma i testi originali di Aristotele e si accorse che lo stagirita, come lo chiamava il mio professore di filosofia, poteva sembrare veramente ignorante se ci si dimenticava di inserirlo nel contesto culturale in cui si muoveva. Michele: La reading list del corso di sistemi economici comparati che seguii nel lontano 1970 conteneva due titoli che cambiarono il mio modo di vedere il mondo e di guardare alle interpretazioni che ne sono date. Il primo era il libriccino di Thomas Kuhn a cui Mario si è riferito in maniera cosi dotta e elegante; il secondo era “A Scuola dallo stregone” di Carlos 129 Castaneda . John: Per citare ancora una volta Confucio “Dalle stelle alle stalle”. Scusa Michele li ho letti anch’io, ma non vedo il nesso. Michele: Non pensi che Don Juan la pensasse un po’ come Kuhn quando sosteneva che il nostro modo di veder il mondo dipende da ciò che ci è stato insegnato da bambini, ed è per questo che non ci accorgiamo che siamo fatti come delle uova con tanti tentacoli? Mario: Non starai suggerendo che un giro di peyote farebbe accelerare il passo del progresso scientifico? Michele: Non è più aria e non vorrei apparire nostalgico. Malgrado l’inevitabile invecchiamento, le mie papille gustative trovano che l’uva di oggi non sia più cattiva di quella di una volta. Ho tuttavia l’impressione che fantasia, creatività e umorismo siano in calo, mentre si sta riaffacciando in molti la certezza che ciò che abbiamo capito sulla realtà che ci circonda sia sostanzialmente vero e che siamo sempre più vicini alla Verità con la V 130 maiuscola . Io rimango scettico e credo che solo il confronto con paradigmi scientifici sviluppati in altri pianeti potrebbe dirci qualcosa sul valore universale e definitivo del nostro sapere, inclusa la matematica. In attesa degli alieni, un evento che però anch’io credo vada 131 visto con molta preoccupazione , penso che non si debba sottostimare l’inerzia dei paradigmi e gli interessi costituiti che li reggono e quindi il freno che essi pongono a idee nuove. Gli esempi d’illustri vittime di conservatorismo scientifico non mancano. Mario: Un esempio su tutti, il povero Mendel! Li: Ci risiamo. Chi è il povero Mendel? Quello dei piselli? Mario: Sì proprio lui e la sua è una triste storia. John: Cosa gli è successo? Credevo che fosse nell’Olimpo della scienza come padre della genetica e per aver fornito l’anello mancante alla teoria evoluzionista di Darwin. Mario: Sì, il dramma è che lui non l’ha mai saputo. A un certo punto della sua vita, Gregor Mendel -che di professione non faceva l’orticultore, come si potrebbe pensare, ma il 129 Thomas Kuhn (1962), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University Press; Carlos Castaneda, (1968), The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge. 130 Si veda ad esempio Primack J.R e N.E. Abrams, 2006, The View from the Center of the Universe. Discovering our extraordinary Place in the Cosmos, Riverhead Books, New York. 131 Il Professore Simon Conway Morris dell’Università di Cambridge, sostenitore di una visione teistica dell’evoluzione, ha ipotizzato che se gli alieni esistono sono simili a noi. Questa conclusione si basa su due ipotesi: la prima che la vita sulla terra si è sviluppata tollerando limiti fisici e chimici estremi non solo sulla terra ma nell’universo; la seconda che l’evoluzione agisce in maniera prevedibile e produce quindi risultati prevedibili. Se cosi è, per Morris un incontro con gli alieni ci dovrebbe preoccupare parecchio. Una tesi analoga è stata sostenuta anche da Stephen Hawking. 122 monaco, scelta alla quale era stato obbligato per poter continuare i suoi studi- si diede a investigare i principi della ereditarietà e se ne uscì con le relative leggi. Come sapete ogni individuo presenta somiglianze e differenze rispetto ai suoi genitori. Mendel definì le regole statistiche con cui i tratti dei genitori si trasmettono ai figli. Si trattava di una teoria diversa da quella prevalente e gli accademici del suo tempo non lo presero sul serio, fornendo così un bell’esempio di resistenza e inerzia dei paradigmi anche di fronte all’evidenza empirica. Nel frattempo la teoria darwiniana dell’evoluzione rimaneva priva di una spiegazione di quali fossero i meccanismi attraverso i quali certe caratteristiche finiscono con l’imporsi. Solo 132 verso il 1930 fu riconosciuta l’importanza delle scoperte del monaco di Brno, anche se la sua città natale rimane più famosa per il circuito motociclistico che per i piselli. Michele: Lasciate che riprenda la mia storia proprio dalle domande che vi ho appena citato. Di fatto esse mi furono poste durante un incontro di orientamento da ragazzi che stavano terminando il liceo. Volevano sapere se per la loro generazione sarebbe stato facile o difficile trovare un lavoro e quali percorsi universitari o formativi li avrebbero avvantaggiati. Vi potrà sembrare strano, ma nello schema neoclassico del mercato del lavoro non vi è spazio per domande di questo genere. Li: Spiegati meglio. Il modello microeconomico del mercato del lavoro Michele: La microeconomia oggi insegnata da New York a Pechino, passando probabilmente anche per Pyongyang … Li: La micro cosa? Michele: Li, un po’ di greco è indispensabile per vivere nel mondo occidentale! Come dice la parola stessa, la microeconomia è la disciplina che spiega il comportamento economico degli individui e poi, per aggregazione, quello della società che è vista come una somma di individui. Insomma, come diceva il buon Ronald Reagan, una volta che hai visto una sequoia le hai viste tutte. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’obiettivo dell’analisi microeconomica è quello di spiegare la distribuzione del reddito definendo il salario e l’occupazione di equilibrio. Un’inevitabile conclusione del modello è che quelli che sono senza lavoro debbono rimproverare solo se stessi. Fra l’altro credo che anche noi siamo stati causa del nostro male quando abbiamo detto al cameriere di non aver fretta a portarci i primi. Lasciate almeno che ordini un’altra bottiglia di prosecco. John, mentre Michele parla con il cameriere: In un’economia di mercato esistono solo dei disoccupati “volontari”. Mario: Certo, ed è evidente che ci troviamo di fronte a una diffusa forma virale di masochismo che ultimamente si è venuta diffondendo in maniera molto veloce nei paesi dell’Europa del sud, in particolare tra i giovani. Michele: Funziona cosi. Le famiglie offrono lavoro e la quantità offerta aumenta all’aumentare del salario. Le imprese domandano lavoro e la quantità che sono disposte ad assumere è tanto maggiore quanto minore è il salario. Quindi, come mostra il grafico, 132 Fu in tale periodo che genetisti matematici (J.B.S. Haldane e Ronal Fisher nel Regno Unito e Sewall Wright negli Stati Uniti) unirono genetica e selezione naturale in un meccanismo evolutivo accettato da tutti che venne definito Sintesi moderna o Neodarwinismo. In questa impostazione sono i geni a trasmettere le variazioni di una specie da una generazione alla successiva. Si veda Rose Hilary e Steven Rose (2013), Geni Cellule e Cervelli. Speranze e Delusioni della Nuova Biologia, Le Scienze. 123 l’offerta di lavoro è crescente, mentre la domanda è decrescente. Pertanto, le due curve hanno una buonissima probabilità di incontrarsi. Il punto dove ciò avviene, è il punto di equilibrio 133 che individua il salario reale (W*) in corrispondenza del quale le famiglie piazzano esattamente l’ammontare di lavoro che sono disposte a cedere a quel salario e le imprese assumono esattamente la quantità di lavoro che sono disposte ad assumere a quel salario (SL*). Insomma, il migliore dei mondi che rende tutti felici in quanto realizza contemporaneamente i desideri delle famiglie e delle imprese. Figura 3 – Equilibrio del mercato del lavoro John: Piena occupazione e disoccupazione strettamente volontaria, ecco cosa produce il mercato. Michele: Come tutti voi potete chiaramente vedere guardandovi intorno! Tre, quattro euro all’ora è il salario al quale il mercato assicura il pieno impiego agli immigrati nel settore della raccolta della frutta in Puglia. Che poi uno con questa cifra debba vivere in una baraccopoli, in una situazione che definire di sussistenza è guardare al mondo con un ottimismo del tutto ingiustificato non interessa. Il concetto di sfruttamento non entra in questo schema che non considera la differenza di potere contrattuale degli individui che sono considerati tutti uguali, non importa su quale curva si trovino. Ma, all’interno della logica sulla quale il modello si basa, è innegabile che chi non lavora è perché pretende troppo e non può che biasimare se stesso e la sua mancanza di flessibilità. Mario: Un modo elegante per scaricare la colpa della disoccupazione sui lavoratori! Li: Mi piacerebbe sapere da dove esca una … trovata di questo genere e come possa essere che si perda tempo e denaro a insegnarla nelle università. John: La microeconomia è fondamentale per capire il funzionamento di un’economia di mercato. 133 Come recita correttamente il dizionario del cittadino: “Per salario nominale (o monetario) si intende la quantità di moneta che viene data al lavoratore dipendente, periodicamente, in cambio della sua prestazione. Per salario reale si intende, invece, il potere d'acquisto del salario nominale, cioè la quantità di beni e servizi che il lavoratore può ottenere con esso. Di conseguenza, il salario reale è pari al salario nominale diviso per un indice dei prezzi (infatti, a parità di salario nominale, il salario reale sarà alto se i prezzi dei beni e dei servizi sono bassi, e viceversa).” http://www.pbmstoria.it/dizionari/dizcittadino/lemmi/397.htm “ 124 Mario: O forse per giustificare l’attuale ordine sociale e politiche a favore di pochi, ricchi e potenti! Michele, io però vorrei sapere perché hai detto che questa conclusione era inevitabile. Michele: Perché essa è implicita nelle ipotesi del modello, ipotesi che, a loro volta, sono state scelte non perché rappresentino fedelmente il mondo che ci circonda, ma proprio perché 134 conducono inevitabilmente a un equilibrio stabile . In sostanza, per dimostrare che il libero mercato è il migliore dei mondi, il modello deve fare delle importanti concessioni alla realtà. John: Quali? Il lavoro: fattore variabile o fattore fisso? Michele: In primo luogo, quando il modello neoclassico parla di lavoro non intende lavoratori, ma servizi di lavoro; in secondo luogo esso ipotizza che vi sia una relazione diretta tra l’ammontare di lavoro che le famiglie sono disposte a cedere e il salario, e che vi sia invece una relazione inversa per le imprese. Mario: Cosa intendi per servizi di lavoro? Michele: Faccio un esempio. Supponiamo che tu abbia bisogno di risolvere un problema di trasporto per motivi di lavoro o di svago. Hai diverse possibilità. Puoi acquistare un’automobile, fare un leasing o decidere di chiamare un taxi tutte le volte che ti devi spostare. Se decidi di chiamare un taxi quello che fai è di acquistare un servizio dal proprietario del taxi. Il modello neoclassico rappresenta un mercato del lavoro che si ispira a questa immagine. Vi sono delle famiglie che posseggono della forza lavoro e sono disponibili ad affittarla alle imprese. Le imprese, dal canto loro, posseggono macchine e tecnologie e affittano servizi di lavoro nelle misura e alle condizioni compatibili con l’ammontare di produzione che desiderano effettuare e con le macchine di cui dispongono. In questo modo, dunque, il lavoro è perfettamente frazionabile e variabile cioè perfettamente aggiustabile ai bisogni degli imprenditori. Insomma è come se ogni mattina le imprese potessero decidere, come nel caso del taxi, di quante ore di lavoro abbiano bisogno e da chi “affittarlo”. John: Ma è proprio questa flessibilità che consente alle imprese di essere efficienti, di ridurre i prezzi al consumo favorendo così i consumatori, e di conquistare nuovi mercati. Michele: Forse in un mondo pre-capitalistico dove quasi tutte le imprese sono piccolissime, c’è poca varietà di prodotti e non sono richieste ai lavoratori particolari competenze: Nel nostro mondo la costituzione di un parco uomini competenti e affidabili è ugualmente importante, se non addirittura più importante, della creazione di un parco macchine con la giusta tecnologia. Insomma, la distinzione tra un fattore fisso, le macchine, e un fattore variabile, il lavoro, è una distinzione fasulla: per essere efficiente un’impresa deve investire non solo in macchine, ma anche in uomini. Quindi, nel mondo reale le imprese, sopratutto quelle di dimensioni medio grandi, non affittano servizi di lavoro, ma assumono uomini e donne in carne e ossa, li scelgono per le loro competenze, per la loro storia e per la loro esperienza; in molti casi, inutile negarlo, preferiranno uomini a donne, o donne a uomini. Infine tenderanno a investire in essi e a fidelizzarli. In sostanza, le aziende non mirano solo ad avere un determinato parco macchine, ma anche un ben definito “parco uomini” e a tenerlo in efficienza con una continua attività di manutenzione. In questo contesto, sempre più 134 Si ha una situazione di equilibrio quando nessuno degli attori ha interesse a cambiare in maniera unilaterale il proprio comportamento. Un equilibrio si dice poi stabile se tende a ritornare nella posizione iniziale qualora si siano verificate delle perturbazioni che l’abbiano disturbato. 125 importante in una società fortemente terziarizzata, la favola neoclassica non riflette più la realtà e ha ben poco da insegnarci. Mario: Hai detto che c’era un secondo problema. Michele: Sì; per raggiungere una situazione di pieno impiego il modello ipotizza anche che più elevato il salario, più elevata sia la quantità di lavoro che le famiglie sono disposte a cedere. Però, come potete vedere nella Figura seguente, nel caso in cui l’offerta di lavoro sia illimitata (il caso della Cina fino a pochi anni fa) l’offerta è piatta al livello del salario di sussistenza fino al Punto di Svolta di Lewis (PSL). In sostanza, fin tanto che la domanda non raggiunge quel livello, vale a dire non è sufficientemente elevata da assorbire tutti i lavoratori disposti a lavorare a un salario di sussistenza, le imprese possono espandere la propria occupazione senza dover pagare un salario più elevato. Nel grafico quella domanda è D2. Nel caso in cui la domanda sia D1, il lavoro assorbito sarà SL* e la distanza tra SL1 e PSL rappresenta un eccesso strutturale di offerta di lavoro. Li: Insomma tu dici che il mondo descritto dal modello neoclassico non ha niente a che vedere con il mondo in cui viviamo e che quindi quel modello ci serve ben poco. Figura 4 – Mercato del lavoro con offerta illimitata alla Lewis Una digressione su realismo delle ipotesi e capacita previsiva John: Un modello non va giudicato in base al realismo delle sue ipotesi, ma alla sua capacita di prevedere. Li: Chi l’ha detto: Confucio? Michele: No, Milton Friedman, che vinse il premio Nobel per l’economia nel 1976. All’inizio degli anni 50 Friedman ebbe il merito, si fa per dire, di porre un argine alle numerose critiche che venivano mosse, soprattutto dagli economisti di Cambridge, Gran Bretagna, alla mancanza di realismo delle ipotesi che erano alla base del modello neoclassico. Il buon Milton sostenne, come ha appena detto John, che un modello non va giudicato in base al realismo delle ipotesi, ma alla capacità di prevedere, una tesi che fu accolta con immediato favore dalla stragrande maggioranza degli economisti e permise loro di scrivere brillanti pagine di fantascienza senza doversi giustificare. John: Scusa, ma le riviste di economia sono piene di verifiche econometriche. Michele: Ne hai mai vista una che giunga alla conclusione che il modello testato è una vera e propria schifezza e deve essere buttato via? D’altra parte non mi sembra che ci sia bisogno di studi approfonditi per accorgersi che, contrariamente a quanto previsto dal modello neoclassico, nelle economie di mercato i ricchi stanno diventando più ricchi e i poveri più poveri, mentre la distanza tra paesi sviluppati e sottosviluppati è venuta 126 aumentando progressivamente, malgrado lo straordinario aumento degli scambi commerciali, dei flussi migratori internazionali e dei flussi finanziari. Però, il modello neoclassico è ancora lì. In fondo non è colpa del modello se il mondo non è perfetto! Mario: Tu cosa suggerisci? Michele: Prima di tutto a me sembra strano che un modello che si basa su ipotesi balzane possa fare previsioni corrette. A parte questo, credo che per studiare il mercato del lavoro dei nostri giorni e porsi domande rilevanti, ci sia bisogno di modelli che considerino uomini e donne in carne e ossa, con le loro storie di vita, la loro cultura, i loro vincoli; uomini e donne che si muovono nel tempo reale. Ciò è tanto più vero se si deve affrontare il problema dei flussi migratori. Li: Ragazzi, fortunatamente pizze e primi sono in arrivo. L’economia m’incuriosisce, ma sto cominciando a boccheggiare. Michele: Ti ho visto più silenzioso del solito! Mi sembrava tuttavia di leggere sul tuo volto intelligente una grande attenzione. Li: Si; a quello che succedeva in cucina! Michele: Uomo di poca fede, non riuscirai a scoraggiarmi. Ho ancora molte cose da raccontare per completare la presentazione del mio modello del mercato del lavoro senza il quale non potremmo capire il futuro della Cina e del pianeta nel suo complesso. John: Cala! Per oltre mezzora cibo e alcolici distolgono la mente dei nostri amici dal mercato del lavoro. John cerca di convincere Li a andarlo a trovare negli Stati Uniti promettendogli un 135 viaggio coast to coast, lungo Route 66 sulle orme di Saetta McQueen . Mario continua, invece, a parlare delle manchevolezze del modello neoclassico, anche se Michele lo ascolta con un orecchio solo e preferirebbe dedicarsi anima e corpo ai tortelloni. Mario sostiene di aver perso interesse in questo modello non appena si è accorto che esso pretendeva di spiegare i comportamenti sociali partendo da quelli dei singoli attori, per giunta tutti animati dagli stessi valori e con gli stessi obiettivi, e basando il successo del sistema sulla concorrenza. Lui è invece convinto che la società non possa essere ridotta a una somma d’individui, una tesi riduzionista che si è rivelata del tutto illusoria anche in altre discipline, prima fra tutte la genetica. Il sogno di capire che cosa sia l’uomo, una volta decodificato il genoma, un’idea che era stata portata avanti con convinzione da scienziati come Dawkins, si è rivelata del tutto infondata. D’altra parte, anche dalla settimana enigmistica vengono forti segnali volti a rivalutare le idee del Principe Kropotkin che compare sempre più spesso non solo nella classica domanda “le iniziali di”, ma più recentemente anche come “Celebre anarchico russo” e addirittura “Evoluzionista russo che credeva nell’importanza della cooperazione”. Come sosteneva il principe, le società che prevalgono sono quelle basate non su di una feroce concorrenza, ma quelle animate da spirito cooperativo. La storia delle formiche tagliafoglie è lì a dimostrare l’importanza della cooperazione che è stata più recentemente riproposta anche da Bateson 136. 135 Saetta Mcqueen, in inglese Lightning McQueen, è il protagonista di Car, il film di maggior successo della Pixar, fortemente consigliato a chi l’avesse mancato. 136 Gregory Bateson (1972), Steps to an Ecology of Mind; (1979), Mind and Nature – A necessary Unity. 127 Il modello stock flussi: seconda parte Li che ha colto le ultime parole di Mario ha un sussulto: Non tirerai fuori di nuovo le formiche. In questo caso preferisco tornare ai modelli del mercato del lavoro. E’ quasi un anno che aspetto di conoscere l’opinione di Michele sul futuro della Cina. John: Temo sempre più che sarete voi cinesi a vincere il peluche, anche se i dubbi che Michele ha espresso qua e là mi danno ancora qualche speranza. Comunque, prima di andare avanti, vorrei riassumere quello che è emerso dalla nostra chiacchierata, anche se oggi più che una chiacchierata è stato un monologo del professore. Li: Ti ringrazio. Non mi è del tutto chiaro dove stiamo andando e forse neanche da dove veniamo. Mario: Spero almeno che tu ti ricordi ancora chi siamo. John: Michele ha cominciato dicendoci che per affrontare in maniera corretta il problema delle migrazioni doveva farci vedere un suo modello stock-flussi del mercato del lavoro. Di fatto, per il momento, ha speso quasi tutto il tempo per far emergere i limiti del modello neoclassico suppongo per evidenziare quali debbano essere le caratteristiche di un buon modello. Secondo Michele, il problema del modello neoclassico sta nel fatto che esso non prende in considerazione uomini veri con le loro storie di vita e si muove al di fuori del tempo reale; trascura, infine, quella che lui dice essere la caratteristica fondamentale del mercato del lavoro, il suo continuo divenire. Il prof. ha cominciato facendoci vedere un rettangolo diviso in rettangoli più piccoli e ci ha informato che si trattava di una rappresentazione sintetica della vita umana, delle sue fasi fondamentali e delle principali condizioni socioeconomiche nelle quali gli uomini si possono trovare. In questa prospettiva la popolazione totale risulta articolata in una serie di sottopopolazioni la cui dimensione è regolarmente misurata dai censimenti e da altre rilevazioni campionarie. Se invece consideriamo un intervallo di tempo, prendono vita le frecce che collegano le varie condizioni, vale a dire i flussi di persone che passano da una condizione a un’altra. Michele ha concentrato la sua attenzione sul modello generazionale che si basa unicamente su flussi definitivi, vale a dire i cambiamenti di condizione irreversibili e senza ritorno, come la nascita e la morte, ma anche come l’uscita definitiva dalla fase formativa e l’entrata per la prima volta nell’occupazione o tra le persone in cerca di prima occupazione. A me sembra però che i flussi di entrata e di uscita forniscano solo una spiegazione meccanica delle variazioni del livello delle popolazioni e dei cambiamenti strutturali. Mi aspetto quindi che Michele trasformi questa rappresentazione descrittiva in un modello vero e proprio e ci faccia vedere qual è il meccanismo attraverso il quale le diverse generazioni si succedono nel mercato del lavoro, perché per alcune di esse sia più facile che per altre la transizione scuola-lavoro e infine perché alcuni paesi siano paesi d’immigrazione e altri d’emigrazione e cosa spieghi i saldi migratori. Michele: Come al solito un riassunto perfetto. Posso tornare alla mia storia? Li: Questa sera è come essere a scuola. John: Non proprio; qui si può bere. Lasciatemi offrire un giro di bourbon. L’apologo del Cinema Italia Incurante delle interruzioni, Michele riattacca la sua storia: Come vi ho già detto, tanti anni fa, credo fosse la meta degli anni 80, mi trovavo in un cinema pieno di ragazzi per un incontro di orientamento. Fu quella situazione a fornirmi lo spunto per un apologo, che avrei 128 137 poi chiamato la favola del Cinema Italia . Furono i ragazzi a darmi lo spunto chiedendomi se sarebbero riusciti a trovare lavoro, quanto tempo ci avrebbero messo, se andare all’università li avrebbe aiutati e infine a quali facoltà si dovevano iscrivere per essere avvantaggiati nel mercato del lavoro. All’improvviso mi resi conto che il mio bagaglio di strumenti neoclassici non mi permetteva di dare delle risposte valide a quelle domande e che serviva qualcos’altro. Ed ebbi un’ispirazione. Mario: Ti apparve San Giuseppe patrono dei lavoratori? Michele: No, me la cavai da solo. Cominciai ponendo ai ragazzi la seguente domanda. Supponiamo che vi sia una sala cinematografica nella quale si proietta un film di successo e che, a un certo momento del pomeriggio, tutti i posti siano occupati: quante persone potranno trovare posto nel cinema nelle due ore successive? Tenete presente che eravamo all’inizio degli anni 80 e che nei cinematografi non solo si poteva fumare, ma si poteva entrare in qualunque momento, anche durante la proiezione. I ragazzi ci pensarono un po’ e giunsero rapidamente alla soluzione del problema: poiché all’inizio tutte le sedie erano occupate, le entrate sarebbero state determinate unicamente dalle uscite; era anche evidente che più gente usciva, più gente sarebbe riuscita a entrare. A quel punto suggerii che per amore di completezza dovevamo considerare uno di quei cinema estivi, all’aperto, dove in caso di necessità il proprietario può aggiungere delle sedie, magari quelle pieghevoli di legno. I ragazzi osservarono subito che, in questo caso, gli ingressi sarebbero stati uguali alle sedie lasciate libere dagli spettatori che avevano finito di vedere lo spettacolo o erano dovuti uscire per l’arrivo di qualche emergenza (non temporanea), più le sedie aggiunte dal gestore del cinema. Mario: Voglio vedere se ho capito. La sala cinematografica rappresenta il mercato del lavoro, le sedie i posti di lavoro, il gestore del cinema gli imprenditori e il governo. I giovani che si presentano al botteghino per comprare i biglietti sono l’offerta di lavoro, quelli che riescono ad entrare sono i giovani che hanno trovato un lavoro e quindi misurano la domanda. Michele: Esatto; solo che in questo caso parleremo di offerta e di domanda di flusso. John: Carina questa storia, ma il mondo è molto più complicato. Michele: Di fatto, l’immagine che proposi ai ragazzi fu più articolata. Osservai che nel cinema Italia, come nel mercato del lavoro, vi sono posti di vario ordine: poltrone di prima fila, molto comode ma poco numerose; posti di seconda e terza fila, posti molto scomodi nella vecchia galleria che non è stata ancora ristrutturata. Si possono vedere persone che tengono occupati due posti; altre sedie sono occupate da due o più persone; alcuni spettatori siedono su sedie di fortuna e in ogni momento temono di essere fatti sloggiare dalle maschere. Avrete riconosciuto i doppio-lavoristi, i lavoratori part time, i lavoratori precari. Alcune sedie sono poste dietro a delle colonne e sono occupate da spettatori che, pur essendo nel cinema, non riescono a vedere lo spettacolo (sono i cassaintegrati). Inoltre, quelli che sono appena entrati siedono di solito nelle ultime file e hanno le sedie più scomode. Solo col tempo, man mano che gli spettatori seduti sulle comode poltrone delle prime file escono dal cinema, alcuni di essi riescono ad occupare poltrone più comode. John: Uscendo di metafora, da cosa dipendono gli ingressi nella occupazione e nelle forze di lavoro? 137 L’apologo del cinema Italia fu pubblicato per la prima volta in Isfol, 1984, Manuale delle Professioni, e poi in Michele Bruni, 1988, “A stock flow model to analyse and forecast labour market variables”, Labour, n. 1. 129 Michele: Cominciamo con gli ingressi nell’occupazione perché la mia ipotesi è che sia la domanda di lavoro a giocare il ruolo dominante. Seguendo l’analogia con il cinema, gli ingressi nell’occupazione sono uguali alla somma delle uscite definitive e dei posti di lavoro aggiuntivi creati dal sistema produttivo. Le uscite definitive sono imputabili a due cause: la morte e il pensionamento. Queste ultime dipendono dalla struttura degli occupati per classe di età: più alta l’età media degli occupati, maggiore il numero delle uscite definitive per pensionamento. Il numero dei posti aggiuntivi dipende invece dalla crescita economica e dalla tipologia dello sviluppo: maggiore la crescita economica e minore l’intensità di capitale delle nuove attività, maggiore l’incremento dei posti di lavoro generato dal sistema economico. In sostanza, il numero di giovani che riescono a trovare lavoro per la prima volta, in ogni dato intervallo di tempo, è uguale alla somma, da un lato, dei posti lasciati vacanti dai pensionati e da coloro che sono morti in età lavorativa e, dall’altra, dei posti aggiuntivi. Insomma le entrate generazionali nell’occupazione sono il risultato di due componenti: la domanda sostitutiva e la domanda aggiuntiva che, a loro volta, dipendono dalle tendenze demografiche, dalla crescita economica e dall’innovazione tecnologica. Quindi, mentre la domanda sostitutiva è sempre positiva, la domanda aggiuntiva può essere anche negativa. In questo caso le entrate generazionali - quella che chiamo domanda di flusso- saranno inferiori alle uscite definitive, il che significa che non tutti i posti lasciati liberi da quelli che hanno finito di vedere lo spettacolo o sono dovuti uscire per forza maggiore vengono ricoperti: una parte viene distrutta. John, Mario e Li fanno cenno di aver capito, anche se in maniera più o meno convinta. Michele: Veniamo all’offerta di flusso. Essa è rappresentata dalle entrate nelle forze di lavoro e la determinante principale è costituita dalle entrate nella popolazione in età lavorativa. Non dobbiamo però dimenticare che se tutti quelli che sono sopravvissuti per i primi quattordici anni della loro vita, o comunque fino alla fine della fase formativa, entrano automaticamente nella popolazione in età lavorativa, sul livello e la struttura delle entrate nelle forze di lavoro incidono pesantemente i sistemi valoriali del paese e la probabilità di trovare lavoro. John: E il salario e il reddito? Stai distruggendo tutte le mie certezze! Michele: Credimi, in questo caso non è una perdita grave. Pensi veramente che ci sia qualcuno che un giorno sì e un giorno no sceglie se lavorare o meno in base al livello del salario reale e del reddito, e che le imprese decidano tutte le mattine quante persone occupare? John: A me è sempre parsa un’idea geniale, compatta ed elegante. Dammi almeno una alternativa. Michele: Non sto mettendo in discussione la bellezza estetica del modello neoclassico, ma la sua capacità di spiegare cosa succede nel mercato del lavoro. In tutte le società occidentali, ma credo anche nella stragrande maggioranza delle altre, gli uomini non hanno scelta: per loro il lavoro è un diritto dovere che li accompagna per tutta la durata della vita lavorativa. Se un ragazzo non trova lavoro immediatamente al termine degli studi, tutti avranno la massima comprensione; famiglia e amici entreranno in azione per aiutarlo a trovare una soluzione utilizzando amicizie e conoscenze. Ma se la cosa dura un po’ troppo, il disoccupato si trasforma da vittima del sistema in un fannullone, uno sfaticato, un disoccupato volontario, e non nel senso neoclassico, ma in quello più prosaico della lingua comune. Mario: E le donne? 130 Michele: Vi sono donne che hanno un comportamento del tutto simile a quello degli uomini, vuoi per scelta, vuoi per necessità economica. E’ il caso di donne vedove o divorziate con bambini o altri carichi famigliari o quello delle donne sempre più numerose che vedono il lavoro come lo sbocco naturale della fase formativa. Vi è poi un secondo gruppo di persone composto soprattutto da donne, ma anche da giovani in età scolare e da anziani. Sono le forze di lavoro secondarie. Esse, scelgono se entrare o meno a far parte delle forze di lavoro, generalmente in maniera temporanea, in base alla situazione economica della loro famiglia: la decisione sarà influenzata dall’età, dal livello educativo, dal contesto sociale in cui vivono, dalla situazione economica del “capofamiglia”. E’ il caso, fra l’altro, delle donne che decidono di rimanere fuori dal mercato del lavoro quando i bambini sono piccoli e di lavorare quando i figli sono grandi. Infine, vi è un terzo gruppo, anche questo composto quasi unicamente da donne, che decide di restare fuori dal mercato del lavoro per tutta la fase lavorativa e dedicarsi alla cura della famiglia. Mario: Quindi, in ogni intervallo le entrate generazionali nel mercato del lavoro hanno un nucleo duro composto dagli uomini che hanno terminato la fase formativa e dalle donne che pure hanno finito il loro percorso formativo e che vedono nel mercato del lavoro lo sbocco naturale o necessario della loro vita. A questo si può aggiungere una quota, più o meno numerosa, a seconda della fase ciclica, di forze di lavoro secondarie composta da studenti, casalinghe e pensionati. Michele: Stai cominciando a parlare come un economista. John: Quindi, secondo te, anche per quanto riguarda l’offerta, salario e reddito famigliare hanno un ruolo del tutto marginale? Le determinanti della partecipazione al mercato del lavoro Michele: Il reddito famigliare è spesso una causa non secondaria del successo nel mercato del lavoro; credo invece che la partecipazione al mercato del lavoro sia spiegata da aspetti strutturali, storici e culturali, mentre salario e reddito famigliare abbiano un qualche ruolo 138 solo per le forze di lavoro secondarie. Ad esempio, secondo voi, il tasso di partecipazione (*) è più alto in Germania o in Cambogia? John: Ovviamente in Germania. Michele: Sbagliato, è più elevato in Cambogia per almeno un paio di ragioni. In primo luogo perché in Cambogia l’agricoltura è il settore dominante e la maggior parte della popolazione rurale comincia a lavorare non appena può dare un contributo, anche minimo, alla sussistenza della propria famiglia e continua a farlo finché si regge in piedi. Mia nonna Letizia ricordava di aver cominciato a fare calzini per tutta la famiglia all’età di quattro anni. John: Era cambogiana? Michele: Non fare il furbo. Era italiana, ma era nata in una famiglia di braccianti agricoli in un contesto rurale non certo più avanzato di quello della Cambogia di oggi. Il secondo motivo è che i giovani tedeschi frequentano la scuola in una percentuale e per un periodo più lungo dei loro coetanei cambogiani e ciò riduce il numero di persone presenti nel mercato del lavoro. Veniamo più vicino a noi: e tra Germania e Italia? John: Qui non ci sono dubbi: vince la Germania. 138 Il tasso di partecipazione è dato dal rapporto tra forze di lavoro e popolazione in età lavorativa. 131 Michele: Giusto, ma prima che tu mi offra una spiegazione basata sulla minore operosità di noi meridionali, lascia che ti dica che il motivo è un altro: in Germania vi è un maggior numero di occasioni di lavoro o, per essere più precisi, il rapporto tra occupati e popolazione in età lavorativa è più elevato e ciò trascina in alto anche il livello dell’offerta perché aumenta la probabilità di trovare lavoro per i lavoratori secondari. John: Ma come gestisci il problema della non omogeneità del lavoro? Michele: Immaginando che davanti al cinema ci siano tante file quante sono le professioni e che coloro che cercano lavoro si mettano in una fila coerente con il loro titolo di studio e le loro precedenti esperienze lavorative. Adesso abbiamo tutto ciò che serve per sapere se una generazione sarà più o meno avvantaggiata o svantaggiata rispetto alle generazioni precedenti e quali siano i percorsi formativi premianti. Mario: Se intuisco correttamente, le generazioni avvantaggiate sono quelle per le quali il rapporto tra domanda e offerta di flusso è più alto e lo stesso vale per le persone con percorsi educativi e formativi che risultino relativamente rari sul mercato. Michele: Risposta esatta. A parità di livello di domanda di flusso, generazioni in uscita dalla fase formativa relativamente piccole saranno avvantaggiate rispetto a generazioni più numerose. Risulteranno altresì relativamente avvantaggiati quelli che escono dal sistema formativo con titoli di studio “rari” rispetto alla domanda. Insomma, se il numero dei laureati in lettere è relativamente più alto rispetto alla domanda di laureati in lettere di quanto non lo sia il numero degli ingegneri rispetto alla domanda di ingeneri, gli ingegneri in media avranno una probabilità più elevata di trovare lavoro. Osservate anche che se, in un dato intervallo, il numero delle persone che vogliono entrare nel cinema (le persone in cerca di occupazione) è circa uguale al numero di posti che si rendono disponibili la lunghezza della fila rimarrà costante. Nel caso in cui il numero sia più elevato, la fila tenderà ad allungarsi, nel caso opposto ad accorciarsi. John: Perché tenderà? Michele: Perché il numero di persone che decide di andare al cinema non dipende solo dal numero delle entrate nella popolazione in età lavorativa, ma anche dalla lunghezza della loro specifica fila di attesa e dal suo trend. Mario: Spiega. Michele: La lunghezza della fila dà ai potenziali entranti un’idea di quanto tempo dovranno aspettare per entrare nel cinema, cioè il livello della disoccupazione e il suo andamento forniscono una indicazione della probabilità di trovare lavoro. Di solito accade che una disoccupazione alta e crescente generi fenomeni di scoraggiamento tra le forze di lavoro secondarie, mentre una fila breve e che sta diminuendo incoraggi il loro ingresso nel mercato del lavoro. Insomma, in periodi di crisi è molto probabile che il numero dei disoccupati sia inferiore a quello di coloro che vorrebbero trovare lavoro. Molte persone smettono, infatti, di cercare attivamente un’occupazione scoraggiate dalla bassa probabilità di trovarne una. Comunque vada, la probabilità di trovare lavoro non dipende solo dalla domanda, ma anche dell’offerta e questo è uno dei motivi per i quali bisogna stare attenti a sbandierare previsioni in tema di professioni. Mario: Quindi secondo te non bisogna dire ai giovani quali file saranno lunghe e quali saranno corte, quali file scorreranno velocemente e quali lentamente? 132 Perché ai giovani non bisogna far sapere in quali mestieri potrebbero trovare lavoro più facilmente. Michele: Lasciate che racconti un’altra favoletta. Li: Questa è una serata per bambini! Michele: In un paese di cui non vi dirò il nome, alle sei di sera tutti i bambini sono seduti davanti alla televisione a guardare l’ultimo episodio dei Pokemon e sia Ash, sia Pikachu li consigliano di studiare informatica se vogliono trovare un lavoro. C’è però un bambino che è andato in cortile a giocare a palla. Così, mentre tutti i piccoli teledipendenti studiano informatica, lui studia greco antico. Chi troverà lavoro più facilmente? Li: Il bambino che studia greco perché non avrà concorrenza. E allora? Michele: La conclusione è che l’unico consiglio che dobbiamo dare ai ragazzi è di non ascoltare i consigli dei propri genitori, dei propri insegnanti, dei propri amici, e neppure di Ash e Pikachu e soprattutto di guardarsi da tutte le previsioni sul mercato del lavoro. L’unica cosa seria è insegnare ai ragazzi a guardarsi dentro con onestà per capire che cosa amino fare, che cosa li appassioni di più e aiutarli a realizzare i loro sogni. Credo che questa sia la ricetta 139 se non per il successo, almeno per evitare rimpianti e frustrazioni . Credo anche che l’amore per una qualunque disciplina o attività sia la chiave per uscire dal sistema educativo e formativo con una buona preparazione ed entrare nel mercato del lavoro con l’entusiasmo e la determinazione necessari a convincere i datori di lavoro di essere la persona giusta per quel lavoro. Il ruolo della domanda sostitutiva e della domanda aggiuntiva Mario: C’è un’altra cosa che ti vorrei chiedere. Cosa conta di più nel determinare il numero di giovani che trovano lavoro: la domanda sostitutiva o quella aggiuntiva? Michele: In generale la domanda sostitutiva. Vi sono però paesi come la Cina e gli Stati Uniti nei quali il sistema economico ha creato un enorme numero di posti di lavoro e dove la domanda aggiuntiva ha svolto un ruolo molto rilevante. Mario: E l’Italia? Michele: L’Italia rientra nel gruppo dei paesi nel quale il contributo della domanda aggiuntiva è stato modesto. Se mi date un attimo, vi trovo dei dati. Ecco. In Italia, tra il 1966 e il 2006 tutti coloro che erano occupati all’inizio del periodo sono stati sostituti da giovani usciti dal sistema formativo, provocando così un totale ricambio generazionale. In questo periodo hanno, infatti, trovato lavoro quasi 24 milioni di persone. Quindi, ogni anno sono entrati per la prima volta nell’occupazione circa 600.000 giovani; però solo 4,2 milioni, pari a meno del 19 per cento, devono il loro ingresso alla crescita dell’occupazione. Gli altri 19,6 milioni sono entrati in sostituzione o di lavoratori che sono morti (2,8 milioni) o hanno raggiunto i 65 anni (16,8 milioni). Inoltre, mentre per gli uomini la domanda aggiuntiva è stata praticamente irrilevante (solo 1,5 per cento degli entrati lo deve all’aumento dei posti di lavoro), per le donne essa spiega quasi il 40 per cento delle entrate. 139 Nel dire queste cose non posso non ricordare chi me le ha insegnate, Luisa Pombeni una cara amica tragicamente scomparsa. 133 Tav. 1 – Entrati nell’area dell’occupazione per sesso e causa; 1966-2006 Fonte: Elaborazione su dati Istat John: Come si spiega questa differenza? Michele: I motivi principali sono due. Il primo è che per l’Italia questo è stato il periodo della terziarizzazione. Tra il 1966 e il 2006 la quota dei servizi è passata dal 35,1 al 65,6 per cento e l’occupazione del settore è aumentata di 8,5 milioni, mentre l’agricoltura ha distrutto 3,5 milioni posti di lavoro e l’industria oltre 500.000. I lavori nei servizi non solo erano culturalmente più compatibili con l’immagine della donna, ma anche più consoni, per la minore gravosità e durata media della settimana lavorativa, a chi deve quasi sempre cominciare un secondo lavoro appena ha finito il primo. Cosi le donne hanno occupato il 60 per cento dei posti aggiuntivi del settore dei servizi e i 3/4 della domanda di flusso da esso generato. Il secondo motivo è che all’inizio del periodo le donne occupate erano poche (l’occupazione femminile toccò un minimo storico all’inizio degli anni 70) e giovani. Quindi, negli anni successivi le uscite definitive non potevano che dare un contributo modesto all’assorbimento delle nuove generazioni di donne. Notate che questa situazione caratterizza anche le professioni nuove che non possono che generare un numero relativamente contenuto d’ingressi per sostituzione. Mario: Quindi, è la domanda sostitutiva che da il contributo maggiore all’assorbimento dei giovani, mentre l’andamento della domanda aggiuntiva riflette le oscillazioni cicliche. Michele: Vero; sempre nel caso italiano, si va da una situazione come quella del periodo 1991-96, quando il sistema economico distrusse in media 150mila posti all’anno, a quella degli anni successivi quando il sistema economico seppe creare oltre 250mila posti di lavoro all’anno e a quella degli ultimi cinque anni durante i quali almeno un milione di posti di lavoro è andato distrutto. Tav. 2 – Entrati nell’area del’occupazione per causa e quinquennio; 1966-2006 Fonte: Elaborazione su Dati ISTAT La definizione di crisi economica John: Comunque l’Italia sta finalmente per uscire dalla crisi. Michele: John tu ricordi sicuramente la definizione di crisi economica. John: Un paese si dice tecnicamente in crisi quando registra una variazione negativa del PIL per due trimestri consecutivi. 134 Michele: Perfetto! Non pensate che anche in questo caso ci troviamo di fronte a uno dei tanti esempi della disumanizzazione dell’economia? La crisi viene definita come una diminuzione della produzione dei beni e dei sevizi e ciò mette in primo piano non l’obiettivo della attività economica, il miglioramento delle condizioni degli uomini, ma lo strumento con il quale viene perseguito, la crescita economica. John: Per favore, non ritorniamo a discutere i limiti del concetto di prodotto interno lordo. Michele: Non è questo il punto, anche se è interessante notare che l’uscita dalla crisi viene definita dalla crescita del Pil e non del PIL pro capite. No, il punto è che l’aspetto fondamentale di una crisi economica è l’aumento del numero di persone che non hanno un lavoro o si trovano in condizioni lavorative precarie. Questo problema non viene necessariamente risolto dal fatto che il livello della produzione torni eventualmente a crescere. Mario: Cosa ci vuole? Michele: Supponiamo che nel corso del prossimo anno si registri una congiuntura astrologica favorevole e il PIL italiano registri una variazione positiva, diciamo del 1 per cento. Secondo la definizione che John ci ha ricordato l’Italia sarebbe “tecnicamente” uscita dalla crisi. Gli economisti applaudirebbero, ma i lavoratori italiani, e soprattutto i giovani alla ricerca di lavoro, potrebbero non accorgersene perché il livello dell’occupazione potrebbe continuare a diminuire. Infatti, vista la perdita di competitività registrata dal sistema economico italiano negli ultimi anni, è molto probabile che l’aumento della produttività risulti più elevato della crescita del PIL, diciamo ad esempio del 2 per cento. In questo caso l’occupazione diminuirebbe. Mario: Vuoi dire che l’occupazione può diminuire anche in periodi che non sono tecnicamente di crisi? Michele: Esattamente; basta che la produttività aumenti più della produzione. Se vi ricordate è quello che la Banca Mondiale auspica che avvenga in Cina nei prossimi 15 anni per risolvere il problema della carenza di offerta. Per quanto riguarda l’Italia, credo che l’occupazione avrà qualche possibilità di aumentare solo se la crescita del PIL toccherà almeno il due per cento, un miraggio con le attuali politiche di austerità richieste dall’Unione europea. Mario: In conclusione? Michele: Bisogna rimettere gli uomini al centro dell’economia, anche dando loro informazioni rilevanti. Io suggerirei, prima di tutto, che radio e televisione smettessero di comunicarci l’andamento della borsa di Tokio tutte le volte che ci sediamo a tavola. Anche la chiusura della borsa di New York non dovrebbe essere considerato uno show da prima serata: ha sicuramente effetti dannosi sui minori anche se accompagnati. Sarebbe molto meglio se i media ci fornissero analisi del mercato del lavoro e degli andamenti demografici. Sarebbe poi opportuno che si adottasse una definizione di crisi rilevante per coloro che ne pagano il costo e che si basasse sull’andamento non della produzione, ma dell’occupazione. Li: Sentite, il tema della crisi economica è certamente interessante, ma il tempo passa e dovremmo parlare delle cause dei flussi migratori. 135 Un modello per spiegare e prevedere i flussi migratori in ingresso Michele: Li ha ragione. E’ arrivato il momento di utilizzare l’approccio al mercato del lavoro che vi ho proposto per affrontare il tema centrale delle nostre chiacchierate: un modello che spieghi i flussi migratori in arrivo. Vi ricordo che i demografi non hanno mai sviluppato un modello delle migrazioni dato che ciò esula dagli obiettivi della disciplina, mentre gli economisti neoclassici si sono limitati a modellare le partenze John: Continuo ad avere molti dubbi che tu riesca a fare meglio dei tuoi colleghi neoclassici. Ma vediamo! 140 Michele: In termini molto sintetici il mio modello parte dall’idea che nel lungo periodo un paese registri un saldo migratorio positivo qualora abbia una carenza strutturale di offerta di lavoro; ipotizza inoltre che il livello del saldo migratorio sia commisurato al numero di posti di lavoro che l’offerta locale non riesce a ricoprire. Ovviamente, ciò presuppone la presenza di un eccesso strutturale di offerta di lavoro in altri paesi. Usando la metafora del cinema, sarebbe come se nel momento in cui i giovani del posto non riescono a riempire tutte le sedie del teatro, ciò attirasse spettatori di altri paesi dove, al contrario, la fila di attesa è lunghissima e la probabilità di riuscire a vedere modelli formalizzati delle migrazioni,. John: Potresti definire i concetti di carenza strutturale e eccesso strutturale di lavoro. Michele: Un paese presenta una carenza strutturale di offerta di lavoro quando il suo mercato del lavoro è caratterizzato da una differenza rilevante e duratura tra le entrate nelle forze di lavoro e le entrate nell’occupazione, vale a dire tra l’offerta di lavoro di flusso e la domanda di lavoro di flusso. Insomma, al gestore del cinema non basta proiettare un film più attraente, magari in 3D, o ridurre il prezzo del biglietto per riempire il cinema. Definiremo eccesso strutturale di offerta la situazione opposta. In questo caso coloro che desiderano vedere lo spettacolo sono così numerosi che è impossibile che il gestore riesca ad aumentare il numero di sedie tanto da poter accogliere tutti i potenziali spettatori. John: Adesso comincio a capire perché abbiamo parlato tanto di transizione demografica. La transizione demografica è iniziata in momenti diversi in paesi diversi e così vi sono paesi nella terza fase, durante la quale le entrate nella popolazione in età lavorativa diminuiscono, e paesi nella prima fase nella quale le entrate aumentano a tassi crescenti. I paesi del primo tipo sono i paesi che possono essere caratterizzati da una carenza strutturale di lavoro; i paesi del secondo tipo sono quasi certamente caratterizzati da un eccesso strutturale di offerta. E’ la carenza di lavoro dei primi che determina la direzione e l’ammontare delle migrazioni internazionali, mentre i secondi offrono i migranti. Michele: Perfetto. Non mi è rimasto quasi niente da dire. Li: Faccio fatica a crederlo. Michele: Aggiungo poche cose. Li: Così va meglio. Michele: Negli ultimi sessanta anni il numero di paesi nella terza fase della transizione demografica è progressivamente aumentato, mentre molti paesi in via di sviluppo vedevano la 140 Per una presentazione esaustiva del modello si veda Michele Bruni (2009), “The century of the great migration. Demographic forecast, migration and transition theory: A labor market perspective”, Papeles de Poblacion, Vol. 15. N. 62, pp. 9-73; Michele Bruni (2012), Migration and demographic projections: A new methodology to jointly build labor market and demographic scenarios”, Genus, Vol. 68, n. 3 pp. 1-26. 136 loro popolazione aumentare in maniera molto pronunciata. Ciò ha creato la premessa per il notevole aumento dei flussi migratori che si è registrato dal 1950 a oggi. Tuttavia, anche le variabili economiche hanno avuto un ruolo rilevante. Mario: Hai un’idea di quanto abbiano inciso? Michele: E’ una questione empirica e l’affronteremo verificando la capacità esplicativa del modello. Il secondo punto che voglio accennare è che l’avvicinarsi di una situazione di carenza strutturale di lavoro è spesso segnalato dalla mancanza di persone con specifiche professionalità. Solo in una seconda fase la carenza di offerta porta a una diminuzione del numero di persone in cerca di occupazione, provoca un aumento dei flussi migratori interni dalle zone con eccesso di lavoro alle zone in cui la carenza si è già manifestata e, infine, a un aumento della partecipazione di forze di lavoro secondarie. Ma se il paese si trova nella terza fase della transizione quasi inevitabilmente arriva il momento che l’immigrazione rappresenta l’unica soluzione possibile. Il problema è spesso aggravato dal fatto che si continua a negare o a sottovalutare l’esistenza del fabbisogno e quindi non si adottano neppure le politiche che potrebbero rendere il problema meno acuto. Mario: Credo che l’Italia fornisca un perfetto esempio di questo processo. Michele: Sono completamente d’accordo. Basti pensare che bisogna arrivare al 1998 perché il governo italiano riconosca l’esistenza, anche se limitatamente a certe professioni, di un fabbisogno strutturale di manodopera e introduca l’ovvia considerazione che nello stabilire i flussi si debba prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro. Tuttavia, né allora né in seguito venne fornita una definizione teorica e tantomeno empirica del concetto di fabbisogno o meglio le indicazioni che venivano fornite per stimarlo erano, volendo essere generosi, criptiche e non operative, ma a voler essere seri mostravano semplicemente che chi le aveva formulate non avevano alcuna idea di cosa volesse misurare Cosi, malgrado alcune illuminate proposte avanzate nel 2006 da Livi Bacci, che a quel tempo sedeva in Parlamento, 141 la situazione non è cambiata e le migrazioni sono ancora regolate dalla legge Bossi Fini . Mario: Parafrasando un vecchio Carosello “Bastano i nomi”. Michele: Un dato su tutti: dal 1995 al 2005, le quote hanno consentito l’ingresso regolare di 250mila lavoratori extra comunitari a tempo indeterminato; nello stesso periodo si ebbero tre sanatorie che portarono alla regolarizzazione di oltre 1,1 milioni di lavoratori già presenti in maniera irregolare sul territorio. Nel complesso ciò ha consentito a 1.350.000 lavoratori di risiedere regolarmente sul nostro territorio, ma ben 82 per cento deve questo a sanatorie. Dopo il breve intermezzo del governo Prodi che con i decreti flussi del 2006 e del 2007 consentì l’ingresso a quasi 700.000 lavoratori, le cose sono tornate come prima. Mario: Con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: lo sfruttamento da parte di imprese, non solo meridionali, di lavoratori clandestini, ma necessari al sistema produttivo come viene poi regolarmente riconosciuto dalle regolarizzazioni- e l’affidamento del lucroso business del trasporto dei migranti alla criminalità organizzata. John: A mio avviso, queste osservazioni non sono sufficienti per dimostrare che le migrazioni sono generate dalla domanda. Serve qualcosa di più. Michele: Sono d’accordo e vi porterò altri argomenti, ma adesso è troppo tardi. 141 Per una storia dettagliata degli interventi legislativi in tema di migrazione e delle relative analisi di appoggio, si veda Michele Bruni, 2008, “Il boom demografico prossimo venturo. Tendenze demografiche, mercato del lavoro ed immigrazione: scenari e politiche”, Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio, Materiali di Discussione; n. 607; www.dep.unimore.it/materiali_discussione/0607.pdf 137 Li: Spero che la prossima volta non parleremo solo di modelli, ma cercheremo anche di capire quale sarà il futuro dello Cina. Michele: Promesso, a costo di metterci tutto il giorno. 138 Da molti punti di vista, la transizione demografica che sta interessando la Cina è un evento da celebrare: riflette una riduzione della mortalità senza precedenti e uno straordinario sviluppo economico. Ha consentito alle donne di spogliarsi dalla loro tradizionale condizione di macchine da riproduzione e ha aiutato milioni di studenti a raggiungere il desiderato livello educativo. Ma la rapida riduzione dei tassi di fertilità si è spinta troppo oltre e la Cina dovrà implementare rilevanti riforme strutturali per annullarne l’impatto. Dopo anni di crescita demografica accelerata, il treno cinese ad alta velocità sta correndo verso un precipizio demografico. La sfida per coloro che sono incaricati di disegnare le politiche è di prevenire che superi il crinale 142. Wang Feng Sesto Dialogo – Il futuro demografico della Cina: Ipotesi, modelli e procedure per la costruzione di scenari demografici e del mercato del lavoro. I nostri amici si sono riuniti nell’appartamento di Mario a Cesenatico con l’intenzione di farsi una bella mangiata di pesce. Di ritorno dal mercato sono tutti in cucina impegnati a pulire frutti di mare, polipi e cefali. Ovviamente si stanno sostenendo con una bottiglia di albana locale. Notizie provenienti dall’interno e dall’estero Michele: Ragazzi nelle ultime settimane è successo un po’ di tutto a cominciare dalla piroetta parlamentare di Berlusconi, sorprendente e scenografica anche se non aveva la calzamaglia. Mario: A volte la vecchiaia toglie la grandezza. Avrei preferito vederlo combattere fin in fondo e non piangere come un vecchio leone che ha perso i denti 143. Michele: L’uomo ci riproverà. Non è di quelli che capiscono la bellezza di uscire di scena dopo aver ottenuto il più lungo applauso della propria carriera. John: Anche gli Stati Uniti hanno dato uno spettacolo penoso. Chiudere bottega per riaprire pochi minuti prima del disastro e per di più con una prospettiva a termine 144, dà una misura della crescente incapacità di gestire aspetti fondamentali della nostra politica. 142 Traduzione dell’autore. Era il 3 ottobre del 2013 quando Berlusconi, dopo aver dato il voto a Letta, scoppiò in lacrime. 144 Per una storia dei fallimenti del governo americano, passati e recentemente temuti, si veda http://www.politico.com/story/2013/10/debt-limit-government-default-98252.html 143 139 Comincio veramente a temere che questo secolo vedrà il progressivo tramonto del mio paese. I segnali non mancano. Li: Per non parlare delle attività di spionaggio 145. Dove è andato a finire il rispetto per i diritti umani che il vostro governo sbandiera continuamente sotto il naso di tutti se poi i vostri servizi segreti entrano, a loro insaputa, nella intimità di milioni di persone? Michele: Comunque l’evento più drammatico è stato la strage preannunciata nel mare di Lampedusa 146. John: Questi continui sbarchi sono la dimostrazione più chiara che l’emigrazione è spinta dalla drammatica situazione dei paesi di partenza. Michele: John, non bisogna confondere i rifugiati politici con gli emigrati economici. I primi fuggono effettivamente dai teatri di guerra del medio oriente e vengono in Europa alla ricerca di una vita normale, spesso con i propri famigliari. Gli immigrati economici sono invece attratti dalla mancanza di lavoro che caratterizza molti paesi europei. In entrambi i casi, l’Italia è spesso solo il paese di transito più vicino. Mario: Sarebbe quindi giusto che l’Italia non fosse lasciata sola a gestire questo problema e che l’Unione Europea gestisse in prima persona il problema dei rifugiati. Michele: …e anche le migrazioni economiche visto che tutti i paesi europei dovranno importare manodopera se vorranno continuare a crescere e che gli immigrati debbono spesso attraversare altri paesi europei per arrivare alla loro meta finale. John: La tua tesi è ancora tutta da dimostrare! Michele che sta mettendo sul fuoco un grosso tegame pieno di cozze che ha appena accuratamente pulito con uno spazzolino di ferro: Va bene, ma diamoci un obiettivo per la serata o meglio per questo week end, visto che resteremo tutti a Cesenatico fino a domani sera. Mario: In primo luogo una degustazione di prodotti del mare: spaghetti allo scoglio e grigliata mista. John: Poi, almeno una passeggiata sulla spiaggia. Li: A me piacerebbe che arrivassimo finalmente a capire cosa sta per succedere in Cina. John: .. e a me come funziona la procedura di Michele per effettuare proiezioni demografiche realistiche. Michele: Ok. Credo allora che io dovrei, prima di tutto, dimostrarvi che il mio modello dei flussi migratori trova sostegno nei fatti, poi farvi vedere come esso porti a modificare la procedura per effettuare proiezioni demografiche e, infine, applicare la procedura alla Cina. Mario: Stiamo per mettere molto pesce sul fuoco! Li: Però a me non dispiacerebbe che prima John ci ricordasse dove siamo arrivati. 145 Si tratta di un vizietto che testimonia soprattutto un atteggiamento mentale di superiorità morale che non trova certo sostegno nella storia degli Stati Uniti. 146 Il 3 ottobre del 2013 un barcone con oltre 500 rifugiati prende fuoco e s’inabissa nei pressi dell’isola di Lampedusa. E’ il peggior disastro registratosi fino ad allora, ma il primo di una lunga serie alla quale l’opinione pubblica si sta lentamente anestetizzando, mentre governi e istituzioni internazionali mostrano la loro totale impotenza. 140 John fa il punto John: Eccomi … Durante la penultima cena Michele ci ha raccontato che le proiezioni demografiche si basano su tre set di ipotesi. Il primo, che i demografi considerano il più importante, riguarda la fecondità. Esso consente di prevedere il numero dei nati che vengono inseriti alla base della piramide dell’età. Il secondo riguarda la mortalità. Esso consente di prevedere l’evoluzione quantitativa delle coorti successive. In un paese chiuso, senza immigrati, questi due insiemi d’ipotesi sono sufficienti per costruire scenari demografici. Mortalità e fertilità sono variabili lente che normalmente si modificano lungo il trend messo in evidenza dai valori precedenti. Pertanto, su orizzonti temporali di medio periodo queste proiezioni sono abbastanza affidabili. Quando si passa a un paese aperto, entra in gioco il terzo insieme d’ipotesi, quello relativo ai saldi migratori. E qui, come disse Confucio, casca l’asino, perché ne i demografi ne gli economisti sanno spiegare i saldi migratori. Cosi i demografi si limitano a ipotizzare che i saldi migratori futuri sia positivi, sia negativi saranno uguali a quelli passati. Secondo Michele, si tratta di un’ipotesi del tutto assurda perché l’attuale situazione demografica è caratterizzata da una continua evoluzione sia del livello, sia della direzione dei flussi migratori. Secondo il prof., il problema può essere risolto solo facendo ricorso a un modello che individui le cause del fenomeno e permetta quindi di fare previsioni. Michele: Perfetto. Posso cominciare. John: A costo di sembrarti un rompiballe, mi sembra impossibile che i demografi siano cosi poco astuti come ce li racconti e vorrei capire bene quali sono le tue critiche alle ipotesi in tema di migrazioni adottate dalla Population Division e dagli altri enti che si occupano di proiezioni demografiche. Le ipotesi sulla migratorietà della Population Division Ciò che non convince Michele Michele: La mia obiezione principale è molto semplice. I flussi migratori internazionali sono diventati un fenomeno sempre più rilevante tanto che in parecchi paesi sono essi che spiegano l’evoluzione demografica. Pertanto, cogliere in maniera corretta il loro andamento futuro è essenziale per produrre proiezioni demografiche realistiche. E’ evidente che, in un contesto demografico estremo come l’attuale, tale risultato non può essere raggiunto utilizzando semplici estrapolazioni dell’andamento passato. Sarebbe come qualcuno prevedesse che domani pioverà perché è piovuto ieri, pur sapendo che domani inizia la stagione secca. L’ovvia soluzione è di utilizzare un modello che colleghi i saldi migratori a variabili demografiche ed economiche, anche per evitare i continui fallimenti delle proiezioni e la necessità di modificarle sempre più spesso e in maniera sempre più pronunciata. John: Ad esempio? Il caso italiano Michele: Mi sembra di avervi già detto come, alla fine degli anni sessanta, i demografi non abbiano saputo prevedere un fenomeno macroscopico come l’inversione del segno dei saldi migratori che stava per verificarsi in numerosi paesi, a partire da quelli della sponda sud del Mediterraneo. Comunque, per capire rapidamente la situazione, lasciate che vi riassuma cosa è successo in Italia. Le prime proiezioni demografiche furono effettuate dall’IRP, 141 l’Istituto di Ricerca sulla Popolazione, nel 1984; a queste ne seguirono delle altre nel 1988 147. In entrambi i casi, furono ipotizzati saldi migratori nulli, malgrado fosse già evidente che la popolazione italiana stava per entrare in una fase di rapida decrescita, tanto che lo stesso IRP stimava che la popolazione del Centro-nord sarebbe diminuita di 5 milioni nei trenta anni successivi. In un esercizio fatto dallo stesso Istituto nel 1998, sulla falsariga di un precedente lavoro di Coale 148, si ipotizzarono due saldi migratori costanti di 50mila e 80mila unità per un periodo di cento anni. In entrambi i casi, i saldi migratori non sono collegati in nessun modo al diverso andamento demografico prodotto dai quattro tassi di fertilità ipotizzati nell’esercizio e che producono riduzioni della popolazione totale fino all’82 per cento 149. Questa impostazione si mantiene anche nelle proiezioni successive quando entra in azione l’ISTAT, l’Istituto italiano di statistica. Nelle proiezioni del 2001 il saldo migratorio ipotizzato viene posto, sotto l’incalzare degli eventi, a 125mila unita e poi a 200mila in quelle del 2008. Nelle ultime, quelle del 2011, il saldo migratorio è alzato ulteriormente a 325mila unita, ma in questo caso, in linea con le indicazioni della Population Division, si ipotizza che esso scenda a 175mila nel 2065 per poi annullarsi nei 35 anni successivi 150. Insomma, in 30 anni i demografi italiani hanno alzato l’ipotesi sul numero medio annuo di immigrati da 0 a 325.000, sono passati da una ipotesi di costanza nel tempo a una di progressivo declino, ma si sono mantenuti fedeli all’idea che il fenomeno sia indipendente dall’andamento economico e da quello demografico. John: Scusa, se le cose stanno come dici tu, cosa giustifica il perseverare nell’errore? Michele: Si è a lungo pensato che i flussi migratori giocassero un ruolo poco rilevante nella dinamica demografica e questa idea permane, dato che la percentuale dei migranti sulla popolazione totale non sta aumentando. Allo stesso tempo è opinione diffusa tra i demografi che le ipotesi sui saldi migratori siano le più difficili da formulare. Quindi, perché non affidarsi a metodi meccanici che hanno anche il vantaggio di non generare controversie su di un tema cosi sensibile politicamente? Non sarebbe facile per un demografo che lavora in un organismo nazionale o internazionale sostenere una tesi da domanda che porterebbe inevitabilmente a saldi migratori di dimensioni “politicamente scorrette”. John: Fermati un momento. Stai dicendo che il problema non è tecnico, ma politico? Il rapporto Chamie e l’immigrazione sostitutiva Michele: Per lo meno anche politico. Lasciate che vi racconti una storia. Nel marzo del 2000 Joseph Chamie, allora direttore della Population Division, presentò al meeting annuale della Population Association of America, tenutosi a Los Angeles, un Rapporto dal titolo molto suggestivo e controtendenza: “L’immigrazione sostitutiva rappresenta una soluzione al declino e all’invecchiamento di una popolazione?” 151. Lo studio presentava una serie di scenari demografici che arrivavano fino al 2050 per otto paesi (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Federazione Russa, Repubblica della Corea e Giappone) e due 147 CNR e IRP (1988), Secondo Rapporto sulla situazione demografica in Italia, Roma. Ansley J., Coale (1986), “Demographic effects of below-replacement fertility and their social implications”, in Kingley Davis e altri, Below Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies, Population and Development Review, Supplement to Vol. 12, New York, Population Council. 149 IRP (1994), Tendenze demografiche e politiche per la popolazione. Terzo rapporto IRP, Il Mulino, Bologn. 150 Istat (1997), Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione: Base 1.1.1996, Informazioni, N. 34; Istat (2001), Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione dal 1.1.2001 al 1.1.2051; Istat (2006), Previsioni demografiche nazionali, 1 gennaio 2005 – 1 gennaio 2050, Nota Informativa, 22 marzo; Istat (2009), Previsioni demografiche 1 gennaio 2007-2051. 151 UN DESA (2000), Replacement Migration, is it a solution to declining and ageing population? New York 148 142 regioni (Europa e Unione Europea). Il Rapporto Chamie “calcolava” il saldo migratorio in funzione di alcuni indici di “fabbisogno” dei paesi di arrivo. La sostituzione nel titolo è, infatti, quella necessaria per mantenere costanti alcuni indicatori demografici, il più interessante dei quali è certamente la popolazione in età lavorativa. John: I risultati? Michele: Secondo questo rapporto, per mantenere costante la popolazione in età lavorativa al livello massimo che sarebbe stato raggiunto tra il 2000 e il 2050, la Russia dovrebbe importare 36 milioni di immigrati, il Giappone 32, la Germania 24 e l’Italia 19. L’Europa nel suo complesso avrebbe bisogno di 161 milioni d’immigrati e gli Stati Uniti di 18 milioni. John: E allora Michele: Si trattava di una rivoluzione, come mostra un confronto tra i valori medi annui del Rapporto Chamie con quelli che la Population Division ha proposto nel 1998 e poi nel 2010 152. Ma ancora piu interessante è il confronto tra i dati delle poiezioni del 1998 e quelle del 2010, entrambe basate su una estrapolazione del passato. Il fabbisogno della Russia aumenta di 64 volte, quello dell’Italia di 22, quello della Francia di 15, quello della Gran Bretagna di 9, mentre quello della Germania si dimezza. Il dato del Giappone passa da 0 a 53mila unità, quello della Corea da negativo a +43mila. Il dato degli Stati Uniti, che registra un ritocco di “solo” il 32 per cento, è il più stabile. Non male per proiezioni che dovrebbero consentire di disegnare politiche di lungo periodo! Tavola 1 – Saldi migratori in tre scenari alternativi della Population DIvision; valori medi annui in migliaia Fonte: elaborazione su UN DESA, 1998, 2001, 2010 Li: Mi stai confondendo con tutti questi numeri. Cosa non va nello studio di Chamie? Michele: Niente. Anzi, dal mio punto di vista si tratta di uno studio molto importante perché rompe con la tradizione di “prevedere” le migrazioni solo sulla base dei valori passati e suggerisce che le migrazioni possono avere a che fare con i buchi demografici che si creano nei paesi di arrivo a seguito della transizione demografica. Mario: E poi che cosa è successo? Michele: La Population Division ha fatto marcia indietro. John: Perché? 152 UN DESA, World Population Prospects , the 2008 and the 2010 Revisions 143 Michele: Non appena il Rapporto Chamie fu presentato, fioccarono critiche di tutti i generi, molte anche ingiustamente sarcastiche 153. Si sostenne che dietro l’esercizio demografico si celava una ben precisa proposta politica che individuava nelle migrazioni di massa il toccasana per affrontare il problema del calo della popolazione totale, della popolazione in età lavorativa e dell’invecchiamento 154. Di fatto il Rapporto partiva dal presupposto, per me scontato, che nel medio periodo solo le migrazioni internazionali possono modificare la tendenza al declino demografico e all’invecchiamento. E questo perché se vi è qualche possibilità che nei paesi sviluppati la natalità aumenti nei prossimi decenni, è però del tutto improbabile che essa possa riportarsi a quel valore di circa 2,1 figli per donna che garantisce la stabilità del livello della popolazione. D’altra parte, tutti i paesi e tutte le istituzioni internazionali si pongono l’obiettivo di ridurre la mortalità e ciò comporta l’inevitabile accelerazione del processo d’invecchiamento della popolazione. Mario: Interessante. Michele: Venne anche sostenuto, da quelli che vedono la cultura come qualcosa di statico e da conservare come se si trattasse di carciofini, che migrazioni delle dimensioni indicate dal Rapporto avrebbero portato alla perdita d’identità delle comunità di arrivo 155. Vi furono poi i soliti struzzi che, alla faccia del footprint ecologico 156, sostennero che dopo tutto non è un grosso problema se la popolazione cresce e invecchia. Le critiche più ragionevoli, se interpretate al di fuori del contesto massimalista nel quale furono pronunciate, segnalavano che vi erano altri strumenti, altre politiche per fare fronte al declino demografico e all’invecchiamento, anche se poi si limitavano a suggerire le solite cose: aumenti della produttività e della partecipazione al mercato del lavoro. Non un solo demografo difese una visione del futuro del nostro pianeta caratterizzata da flussi migratori delle dimensioni previste da Chamie o espresse qualche interesse verso l’idea di considerare la situazione demografica dei paesi di arrivo per stimare i flussi. Poco dopo Chamie andò in pensione e le Nazioni Unite tornarono alle solite ipotesi. Mario: Ma tu cosa ne pensi? Michele: Quello di Chamie era certamente un esercizio, ma gettava un sasso nelle acque stagnanti delle previsioni demografiche. Non solo innovava rispetto alla metodologia standard, ma conteneva l’idea del tutto nuova per le Nazioni Unite di collegare le migrazioni alla situazione demografica dei paesi d’arrivo. Tuttavia, la metodologia proposta da Chamie presentava due grossi limiti: si basava su obiettivi demografici privi di qualunque significato economico e non prendeva in considerazione la domanda di lavoro. Li: Anche in questo caso se tu potessi fornire un esempio non guasterebbe. Michele: Te lo fornirò, ma più avanti. Veniamo adesso alla situazione attuale. Nelle proiezioni del 2012 la Population Division ipotizza non solo che fino al 2050 i saldi migratori rimangano sostanzialmente uguali al valore medio registrato negli ultimi dieci anni, ma 153 Scrisse Coleman: “Nel 2000 la possibilità di un salvataggio demografico dal problema dell’invecchiamento mediante flussi migratory fu risvegliato fra i creduli da un Rapporto della Population Division delle Nazioni Unite inn tema di “Migrazione di rimpiazzo” (traduzione dell’autore). D.A. Coleman (2002), “Replacement Migration, or why everyone is going to have to live in Korea: a fable for our times from the United Nations”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 357. 154 McNicoll G. (2000), “Reflection on replacement migration”, Place and People. Vol. 8, n. 4 155 D. Coleman op. cit.; molto più pacata la valutazione dell’australiano McNicoll, op. cit. 156 L’impronta ecologica è un indicatore utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della terra di rigenerarle. Il concetto è stato introdotto nel 1996 da Mathis Zackermagel e William Rees nel loro libro Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society Publishers. 144 anche, come ho già accennato, che la loro consistenza si riduca progressivamente fino ad annullarsi nei successivi cinquanta anni. Mario: A questo punto sono veramente curioso di vedere a quali risultati portino queste ipotesi. Michele: Credo che potremo fornire una valutazione più corretta confrontando le proiezioni della Population Division con quelle che si ottengono con la mia procedura. John: OK, allora torniamo al nostro programma iniziale. Prima di vedere. i risultati ci devi dare qualche valido motivo per comperare la tua tesi da domanda. La verifica della tesi da domanda Michele: Non aspetto altro e cercherò di farlo fornendovi prove sia storiche sia empiriche della mia tesi. John: Cosa intendi per prove storiche? Michele: Vorrei ripercorrere con voi la storia delle migrazioni e dei grandi spostamenti geografici che hanno caratterizzato la storia dell’uomo per cercare di capire che cosa le abbia determinate. Mario impegnato a pulire un notevole quantitativo di aglio: Scacciati dal paradiso terrestre e liberi finalmente di cedere alle tentazioni della carne, gli uomini e le donne si sparsero su tutta la terra in cerca di attraenti compagne e di non meno attraenti compagni. La verifica storica Le migrazioni che anche il più convinto dei neoclassici farebbe fatica a spiegare dal lato dell’offerta: schiavi e lavoratori a contratto. Michele: Il primo grande fenomeno di spostamento di forza lavoro 157 di cui abbiamo una buona documentazione si verificò nell'Antica Roma quando i contadini italici furono chiamati a formare le invincibili legioni che avrebbero conquistato il mondo occidentale e la coltivazione dei campi venne affidata a schiavi provenienti da tutti i paesi del Mediterraneo e non solo. L’idea piacque anche ai romani di Roma che cominciarono ad usare schiavi per svolgere tutte le faccende domestiche, incluso l’insegnamento, spesso affidato a colti schiavi della magna Grecia, una soluzione che riduceva le spese di manutenzione della casa e della città eterna. Così, all'inizio dell'era cristiana, circa il 40 per cento del milione di romani era costituito da schiavi. In sostanza, nella Roma dei Cesari c'erano più stranieri che nella Roma di Marino 158. John: Ma quelli erano schiavi. Non vedo il nesso tra schiavitù e migrazioni? Michele: La mia ipotesi è che sia sempre stata la carenza di lavoro e/o la ricerca di modi per ridurre i costi di produzione a provocare gli spostamenti di manodopera, non importa che si tratti di spostamenti volontari o involontari, di uomini liberi o di schiavi. La caduta dell'Impero romano e il declino economico che si registrò in tutta Europa, resero inutile l'importazione massiccia di manodopera straniera per moltissimi secoli, mentre gli arabi non 157 Va tenuta distinta la mobilità sul territorio -che risale a tempi molto precedenti alla comparsa di homo sapienscon lo spostamento di risorse mane a scopo produttivo. 158 Si veda Keith Hopkins (1981), Conquerors and Slaves, Cambridge University Press. 145 fecero mai un uso rilevante di schiavi. Poi “scopriamo” l'America e in nome della fede cristiana e a causa della ostinazione degli indios a non voler salvare la propria anima e a difendere le loro famiglie, le loro case e i loro modesti averi massacriamo quasi completamente la popolazione nativa. John: Le solite esagerazioni ideologiche. Gli indios morirono d’influenza e altre malattie. Mario: Il dibattito è ancora aperto su quanti milioni di indios morirono per le malattie 159 che comunque erano state portate dagli spagnoli- e quanti vennero torturati ed uccisi dagli invasori, pardon scopritori, anche in base al fatto che la chiesa ci mise un po’ di tempo a decidere se si trattasse di essere umani o di un nuovo tipo di scimmie, una incertezza sulla quale pesò certamente l’aspetto economico della vicenda 160 . Michele: Comunque sia andata, quando si arriva verso la metà del sedicesimo secolo, gli indios non erano più sufficienti per coltivare le piantagioni e sfruttare le miniere. Allora, per rispondere a una crescente domanda di lavoro e per unire l'utile al dilettevole, i portoghesi per primi, seguiti a ruota da inglesi, spagnoli, francesi e olandesi si dedicarono con crescente entusiasmo al cosiddetto “commercio triangolare”, un’invenzione fondamentale nella storia dell’uomo che contribuì notevolmente alla creazione degli imperi coloniale e alla costituzione di enormi fortune famigliari. Li: Interessante! Cos’è il commercio triangolare? Lo si può fare ancora? Michele: Forse sì, basta trovare le merci giuste e il triangolo giusto. L'idea è molto semplice. Si partiva dal paese di origine verso l’Africa con un carico di manufatti di poco valore con i quali si compravano dai locali mercanti di carne umana degli schiavi che venivano caricati su navi speciali. Ogni schiavo disponeva di circa due metri quadrati di spazio (servizi in comune) così che per la carenza di cibo e le pessime condizioni igieniche circa il 25% moriva durante la traversata. I superstiti erano venduti nelle colonie dell'America centrale e meridionale. Con il ricavato si acquistava a buon mercato il prodotto del lavoro di precedenti schiavi: cotone, zucchero, tabacco, melassa e rum che venivano poi portati sui mercati europei. Si chiudeva così il cerchio, o meglio il triangolo, con enormi profitti. John: Non dimenticare che se molti trassero guadagno dalla tratta degli schiavi, ci furono anche consistenti movimenti per la sua abolizione. Mario: La Repubblica Serenissima di Venezia abolì la schiavitù nel X secolo, con grande anticipo sugli altri stati europei. Michele: .. che vuoi per motivi ideali, ma soprattutto economici abolirono la tratta degli schiavi solo nella prima metà del XIX secolo. Cominciò l'Inghilterra, seguita da Spagna e Portogallo e, infine, dalla Francia. In Europa molti erano a favore della schiavitù che 159 Massimo Livi Bacci (2006), Conquista. La distruzione degli indios americani, Il Mulino, Bologna. Bisogna arrivare al 1537 perché la chiesa scopra che “Indios veros homines esse”. Questa straordinaria realizzazione, in gran parte dovuta all’azione di missionari come il Vescovo Bartolomé de Las Casas che avevano avuto occasione di assistere alle atrocità perpetrate dai conquistadores, si trova nella Bolla Veritas Ipsa di Paolo III che vietava di ridurre in schiavitù gli indigeni delle Americhe. La Bolla rovesciava la posizione che la Chiesa aveva assunto in due Bolle precedenti, la Dum diversas del 1452 e la Romanus Pontifex del 1455 che consentivano ai cristiani il diritto di ridurre in schiavitù i non cristiani. Come se questo non bastasse, dopo la scoperta delle Americhe c’erano stati i soliti zelanti servitore dei poteri finanziari che avevano prontamente argomentato che gli indios non potevano essere umani dato che il buon Dio aveva negato loro la conoscenza dei Vangeli per 1500 anni. Ovviamente la Veritas Ipsa non ebbe molto effetto su coloni e conquistadores. Le eccezioni non mancarono neanche nei pressi del Vaticano visto che nel 1545 Paolo III tornò a consentire la compravendita di schiavi a Roma dove sembra ci fosse carenza di questo essenziale fattore di produzione. 160 146 consentiva l’importazione di prodotti esotici sempre più ricercati anche per i loro prezzi molto contenuti. Insomma, in quel periodo l’America con i suoi schiavi svolgeva lo stesso ruolo svolto oggi dalla Cina e dagli altri paesi del sud est asiatico con la loro manodopera a buon mercato. L'abolizione della tratta non significò comunque né l'abolizione della schiavitù, né l'abolizione del commercio di uomini. Lì: Che differenza c'è? Michele: Si tratta di una differenza puramente formale. Quando la tratta degli schiavi fu abolita, rimase il problema di trovare manodopera a buon mercato non solo per le piantagioni e per le miniere, ma anche per le grandi opere infrastrutturali, prima fra tutte la ferrovia del Pacifico. Mario: Nel profondo sud si provò a risolvere il problema con la produzione in loco, ma le farms del posto non riuscirono a far fronte alla domanda 161. Poi, rivolto a Li: Anche in questo caso foste voi cinesi a trovare la soluzione. Non solo siete stati i primi a scoprire la polvere da sparo, la bussola, la stampa a caratteri mobili e la carta, ma avete anche inventato il commercio dei lavoratori a contratto. Ancora una volta furono però gli occidentali a trovare le applicazioni più redditizie. Le cose procedevano così. Uomini armati raccoglievano, in campi recintati e sorvegliati, persone raccolte nelle strade e che oggi definiremmo marginali (ubriachi, vagabondi, accattoni etc.), insieme ad altre catturate e imprigionate a forza. Veniva poi proposto loro un contratto con il quale essi si vendevano per un periodo variabile tra i 5 e i 7 anni. Probabilmente era una proposta che non si poteva rifiutare dato che mancano testimonianze di cosa accadesse a coloro che non firmavano. Lì: Non sapevo questa storia. Michele: I libri cinesi ne dovrebbero parlare perché se è vero che i “lavoratori a contratto” furono un’invenzione locale è anche vero che furono le popolazioni cinesi ed indiane della costa l'obiettivo principale di quelle prime agenzie private di collocamento a livello internazionali che, non a caso, si stanno riproponendo alla grande in questi ultimi anni in attesa di un futuro che potrebbe diventare per loro molto luminoso. Non solo, ma mentre si stima che gli schiavi africani arrivati in America siano stati meno di 15 milioni, per i lavoratori a contratto le stime parlano di 30-40 milioni tra cinesi e indiani. Ovviamente il numero così alto dipende dal fatto che, come per gli schiavi, la sopravvivenza media era molto ridotta (secondo alcune testimonianze nelle miniere del Perù non oltre sei mesi) e che quei pochi che riuscivano a giungere alla fine del contratto spesso ne firmavano uno nuovo, non perché fosse loro piaciuto il lavoro, ma per una totale mancanza di alternative. D’altra parte, come tu sai la grande ferrovia che collega l'Atlantico con il Pacifico fu in gran parte costruita dai tuoi antenati. Li: Sì, ho visto un ottimo film con Jakie Chang 162! John: Il nostro Li sta diventando sempre più spiritoso. Michele: Meglio di Xiao Ming 163. Ah! Mi sono dimenticato una cosa. C'era una grossa differenza tra gli schiavi e i lavoratori a contratto. Le navi erano le stesse e i servizi simili, ma 161 L’opinione espressa da Mario si basa soprattutto su racconti di diretti interessati e prove indirette. Anche secondo William Fogel e Stanley Engerman (Time on the Cross; The Economics of American Negro Slavery, W,W. Norton; 1995) le evidenze di attività sistematiche di riproduzione di schiavi negli stati del sud sono scarse. 162 Li si riferisce forse al film “Shanghai noon”. 147 i lavoratori a contratto pagavano il biglietto, solo andata. In conclusione la fine della tratta degli schiavi non determinò la fine del traffico di carne umana, ma fu sostituita da un traffico ugualmente crudele di cui però si parla molto meno anche perché nel frattempo l'Oceano Atlantico veniva attraversato dalle prime grandi ondate di emigranti europei: italiani, irlandesi, tedeschi, polacchi, ecc.. Mario: Prima che Michele continui con la sua storia, lasciate che aggiunga alcune cose sulla schiavitù. Fine della tratta e fine della schiavitù, non sono la stessa cosa. La dichiarazione d'indipendenza americana, promulgata nel 1776, asseriva che tutti gli uomini sono stati creati uguali e posseggono diritti inalienabili tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità, anche se poi, come abbiamo visto, gli Stati Uniti continuano a misurare il PIL e non l’Indice Lordo di Felicita proposto dal Bhutan. Nello stesso anno, un abolizionista inglese fece notare, riferendosi a Thomas Jefferson, come fosse ridicolo un patriota americano che con una mano firmava la dichiarazione d'indipendenza e con l'altra frustava i suoi schiavi. Pochi anni dopo, contrariamente a quanto avveniva negli Stati Uniti, la rivoluzione francese abolì la schiavitù che però fu reintrodotta, per motivi economici e politici, da Napoleone all'inizio del secolo successivo e, non a caso, fu proprio la Francia il paese che si oppose più a lungo all'abolizione della tratta. Infine, se è vero che tutti i paesi europei hanno abolito la schiavitù entro la metà del XIX secolo, ben diverso è stato il comportamento di alcuni dei loro alleati. A parte il caso disperato -e solo saltuariamente ricordato da qualche indagine giornalistica - della Mauritania dove la schiavitù è stata formalmente abolita nel 1980, ma è ancora ampiamente praticata, l'Arabia Saudita e lo Yemen hanno abolito la schiavitù solo nel 1962. Per non parlare dei bambini usati nei paesi dell’Africa occidentale dall’industria del cioccolato e di quello che sta succedendo nei paesi del golfo! La grande migrazione intercontinentale John: Arriviamo così all'era moderna nella quale i poveri, i diseredati e coloro che ritengono di non avere un futuro nel loro paese partono verso terre lontane per cercare un vita migliore per sé e per i propri figli. Michele: Ritengo che il mio modello si applichi anche a questa fase, una volta chiarito che i Padri Pellegrini erano dei rifugiati politici. Non sono il primo a notare che le grandi migrazioni intercontinentali dell’ottocento e dei primi del novecento ebbero luogo quando solo l’Europa si trovava nella prima fase della transizione demografica 164. A questo va aggiunto che i paesi di destinazione erano quelli che offrivano alte probabilità di trovare un lavoro dipendente o di inventarsi una qualche attività artigianale o imprenditoriale. In sostanza, anche per i milioni di emigranti europei che attraversarono l’Atlantico fino all’inizio della prima guerra mondiale non si trattò di una fuga dalla miseria e dalla mancanza di lavoro, ma dell’attuazione di progetti migratori rivolti ai paesi che offrivano potenzialità di lavoro. D’altra parte, il fenomeno si arrestò in occasione della grande depressione. Insomma anche in quel caso non possiamo trascurare il semplice fatto che si emigrò verso l’America e l’Australia, e non verso il centro dell’Africa, e limitatamente al periodo durante il quale quei 163 Anche i cinesi hanno il loro Pierino. Jean Claude Chesnais (1986), La transition démographique: Etapes, formes, implications économique, Paris, Puf. 164 148 paesi offrivano ottime occasioni di lavoro, una situazione che ritroviamo anche nel secondo dopoguerra 165. John: Tu appoggi la tua tesi da domanda sul fatto che nel tempo il lavoro sia stato una merce al centro di un fiorente commercio internazionale alimentato da una domanda che non poteva essere soddisfatta localmente -non diversamente da quanto avveniva per il cotone in Inghilterra e negli altri paesi europei- e sostieni che la stessa cosa sia vera anche per gli attuali migranti. A me pare che ci sia una sostanziale differenza tra le due situazioni. Insomma, prima di accettare la tua tesi vorrei avere un più robusto supporto empirico della tua tesi. Michele (scolando le cozze e passandole a Mario che ha già pronto un sughetto un po’ piccante in cui metterle): Nessun problema. Ribadisco il concetto. La mia tesi è che i migranti partono non perché spinti dalla povertà, dalla carenza di occasioni di lavoro, ma perché sono attratti colà dove tali probabilità esistono. Ciò implica, tra l’altro, che coloro che emigrano non sono i più poveri e i più disperati, ma i più preparati e intraprendenti. Se quello che sostengo è vero, i flussi migratori si dirigono verso i paesi caratterizzati da una carenza strutturale di offerta di lavoro e il loro livello è correlato alla dimensione di tale carenza o fabbisogno. Lasciate che vi proponga un test che ho preparato in attesa di questa chiacchierata. Mario: Quale periodo hai preso in considerazione? Michele, levandosi il grembiule: Scusate prima trasferiamoci in sala da pranzo. Vado a prendere il computer. John: Ci obblighi a prendere un’altra bottiglia di albana. Dopo cinque minuti i nostri amici sono seduti intorno al tavolo della sala da pranzo con i bicchieri pieni e Michele ha già acceso il computer. La verifica empirica Paesi di partenza e paesi di arrivo Michele: Per dimostrarvi la mia tesi ho scelto l’intervallo 1990-2010 perché i dati sono più affidabili di quelli dei periodi precedenti 166. Inoltre, si conoscono i livelli dell’occupazione di cui avevo bisogno per il mio esercizio. In questo periodo si sono registrati circa 94 milioni di migranti che si sono trasferiti da 119 paesi di partenza in 83 paesi di arrivo. Però, come vedete nella tavola, sia gli arrivi, sia le partenze sono concentrati in un piccolo numero di paesi. Nel caso degli arrivi, gli Stati Uniti con 23 milioni di immigrati pesano per un quarto del totale; i primi cinque paesi d’arrivo (che includono, oltre gli USA, Russia, Spagna, Emirati Arabi e Spagna) spiegano oltre il 50 per cento e i primi sedici l’80 per cento degli arrivi 167. La classifica dei paesi di partenza è guidata dal Messico con 7,6 milioni. I successivi sei paesi sono asiatici: nell’ordine Bangladesh (7,3), Cina (5.6), India (5,4), Pakistan (5,2), Filippine (3,8) e Kazakistan (2.8). Questi sette paesi spiegano quasi il 40 per cento delle 165 Michele Bruni (2008), “Il boom demografico prossimo venturo. Tendenze demografiche, mercato del lavoro ed immigrazione: scenari e politiche”, Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio, Materiali di Discussione; n. 607op. cit. 166 Per utilizzare dati omogenei ho usato per tutti i paesi i dati demografici della Population Division, mentre per l’occupazione e per il tasso di partecipazione ho fatto ricorso alla base dati dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, LABORSTA. 167 Fra i primi 16 vi sono anche Canada e Australia, Italia, Gran Bretagna e Francia, il Sud Africa e l’Arabia Saudita e tre paesi asiatici (Malesia Giappone e Singapore). 149 partenze. Per arrivare al 50 per cento bisogna aggiungere l’Egitto, i Paesi caraibici, il Marocco e il Vietnam. Osservate la lista dei paesi di partenza. Notate niente di strano? John: Sono tutti paesi in via di sviluppo. Michele: Vero, ma la cosa più sorprendente è che tra i paesi di partenza non vi sono i paesi più poveri. Se si è troppo poveri, non si riesce neppure a emigrare! Anche questa è una cosa da tenere presente quando si dice che l’emigrazione è motivata dalla miseria e si descrivono gli emigranti come dei diseredati della terra. Mario: Abbiamo il quadro. Torniamo al tuo modello e alla sua verifica. Tavola 2 - Paesi d’arrivo e di partenza; primi trenta per ordine d’importanza dei saldi migratori; valori in milioni 1990-2010 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision Carenza d’offerta e saldo migratorio. Michele: Il primo passaggio è stato quello di verificare se, come ipotizzato, i paesi di arrivo siano o meno caratterizzati da una carenza strutturale di offerta. Per fare ciò ho calcolato la differenza tra la variazione dell’offerta di lavoro e la variazione della domanda di lavoro, cioè tra la variazione delle forze di lavoro e quella della occupazione, al netto dell’emigrazione, tra il 2010 e il 1990. Se il saldo è negativo, possiamo dire che il paese è caratterizzato da una carenza di offerta, se positivo da un eccesso di offerta. Mario: Un esempio numerico non guasterebbe. Michele: Prendiamo il caso italiano. Come vedete nella Tavola 2, tra il 1990 e il 2010 in Italia la popolazione in età lavorativa è passata da 38,987 a 39,735 milioni registrando quindi un incremento di 748.000 unita. Nello stesso periodo, il saldo migratorio è stato di 4,1 milioni. Ne possiamo quindi dedurre che, in assenza di migrazioni, la popolazione in età lavorativa sarebbe diminuita di circa 3,4 milioni, il che mostra altresì che l’Italia era ormai da tempo nella terza fase della transizione demografica 168. Ho poi moltiplicato la variazione della popolazione in età lavorativa per il tasso di attività del 2010. Ciò mi ha consentito di 168 In Italia il tasso di fertilità totale è sotto il livello di sostituzione dal lontano 1977 e il saldo naturale della popolazione in età lavorativa è negativo dal 1991. Per una analisi dettagliata si veda Bruni Michele (1988), op. cit. 150 verificare l’impatto delle tendenze demografiche sulle forze di lavoro. Come potete notare, in assenza di migrazioni, le Forze di lavoro sarebbero diminuite di 2,2 milioni. Poiché nello stesso periodo l’occupazione è aumentata di 1,4 milioni, l’Italia ha registrato un fabbisogno di manodopera straniera pari a quasi 3,7 milioni che non sono nient’altro che la somma della crescita dell’occupazione e del calo delle forze di lavoro autoctone. John: Stai dicendo che senza gli immigrati, l’offerta di lavoro presente nel paese non sarebbe riuscita a coprire quasi 3,7 milioni di posti di lavoro? Tavola 3 - Italia; Popolazione in età lavorativa, variazione delle forze di lavoro e dell’occupazione; carenza di offerta e saldo migratorio. Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision; ILO, LABORSTA Michele: Esattamente. Infine, poiché il saldo migratorio è stato di 4,1 milioni, l’Italia ha registrato 1.130 immigrati per ogni 1.000 di fabbisogno, vale a dire una reattività immigrazione/occupazione di 1,13. Li: Mi sembra di aver intuito l’essenziale. Magari ti chiederò qualche precisazione quando ci farai vedere i risultati complessivi. Michele: Ho poi applicato questa procedura a tutti i paesi più importanti tra quelli che hanno avuto una saldo migratorio positivo e per i quali erano disponibili le informazioni statistiche necessarie. Le omissioni più rilevanti riguardano i paesi del golfo che sono stati tra i principali paesi d’arrivo nel corso di questo secolo, ma per i quali non erano disponibili i dati sull’occupazione. Ho così ottenuto per ogni paese una coppia di valori relativi rispettivamente al fabbisogno di manodopera straniera e al saldo migratorio. John: Il risultato? Michele: E’ emerso che tutti i venticinque paesi del campione hanno registrato una carenza di offerta di lavoro, il che costituisce una prima conferma della mia ipotesi. Vi sono tuttavia due situazioni diverse. In un primo gruppo di undici paesi, in assenza d’immigrati, le forze di lavoro sarebbero diminuite. In pratica, la crescita dell’occupazione ha esacerbato una carenza potenziale di offerta di lavoro di origine demografica 169. Negli altri quattordici il saldo della popolazione in età lavorativa, e quindi dell’offerta, è stato positivo 170. In questi paesi la crescita dell’occupazione è stata maggiore della crescita delle forze di lavoro, rendendo l’offerta locale insufficiente. John: Quindi, nel primo caso la mancanza di lavoro è di origine puramente demografica, nel secondo è stata causata dall’azione congiunta delle tendenze demografiche ed economiche. Michele: Il che dimostra che un approccio puramente demografico non è sufficiente per spiegare i flussi migratori. La situazione è riassunta da questo diagramma di dispersione. 169 Si tratta di dieci paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera) e del Giappone. 170 Questo gruppo include i quattro paesi del Nuovo Mondo (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda), sei paesi dell’Europa del centro nord (Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, e Svezia) e quattro paesi asiatici (Hong Kong Macau, Malesia, Singapore). 151 Ogni punto individua il fabbisogno di manodopera e il saldo migratorio di ciascuno dei paesi presi in considerazione. Li: Un altro disegnino interessante. Che cos’è quella retta che passa attraverso i punti? Michele: La retta mostra il comportamento medio dei ventiquattro paesi e conferma la mia ipotesi. Il fatto che la retta sia inclinata positivamente indica, infatti, che maggiore il fabbisogno, maggiore il livello del saldo migratorio. Inoltre, i dati si trovano abbastanza vicini alla retta e questo indica che la spiegazione è una buona spiegazione. Figura 1 - Fabbisogno occupazionale e saldo migratorio in 25 paesi; 1990-2010 Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision; Banca Mondiale Li: Però, non tutti i punti si trovano sulla retta. Michele: Chiedi un po’ troppo. A me sembra già straordinario che la relazione sia cosi forte. Vi sono tre paesi -Spagna, Svizzera e Australia - che registrano un saldo migratorio praticamente uguale al fabbisogno e i punti che li individuano sono molto vicini alla retta. Per quanto riguarda gli altri paesi ve ne sono alcuni il cui saldo migratorio è inferiore, talvolta largamente inferiore, al fabbisogno. I punti relativi a questi paesi si trovano sotto la retta. Altri registrano un saldo migratorio maggiore del fabbisogno e i loro punti si trovano sopra la retta. Li: E gli Stati Uniti te li sei dimenticati? Non sono il principale paese di arrivo? Michele: Mi hai scoperto! Però gli USA sono un caso particolare. Il fabbisogno e il saldo migratorio degli Stati Uniti sono almeno il triplo di quelli degli altri paesi. Inoltre, il rapporto tra saldo migratorio e fabbisogno è uguale a 2,8, un valore del tutto anomalo. John: Come lo spieghi? Michele: Da un punto di vista meccanico ciò è dovuto al fatto che, a seguito della crisi, dal 2007 al 2010 l’occupazione statunitense è diminuita di ben sette milioni, mentre i flussi migratori sono rimasti più o meno in linea con quelli del quinquennio precedente. Ciò non è sorprendente data la rilevanza delle catene migratorie che collegano gli Stati Uniti con gli altri paesi americani - in particolare con il Messico - e che avevano certamente già portato a definire molti progetti migratori prima dell’arrivo inaspettato della crisi. Ma il punto fondamentale è un altro. Gli immigrati sono funzionali all’occupazione irregolare, l’unica che 152 si espande durante le crisi. A mio avviso è stato questo a sfalsare completamente la relazione rappresentata nel grafico: mentre l’occupazione regolare diminuiva, la domanda di lavoro irregolare aumentava e ciò ha continuato ad attrarre i lavoratori dei paesi vicini. John: Esiste anche la possibilità che una parte degli immigrati che si recano negli Stati Uniti fuggano dalla miseria e dalla mancanza di lavoro dei loro paesi. Michele: E’ possible, ma ripeto vanno negli Stati Uniti perché pensano, a ragione, che la probabilità di trovare lavoro, un qualche tipo di lavoro; quasi sempre irregolare, sia maggiore negli Stati Uniti che nel loro paese. John: Quindi tu ne concludi che il saldo migratorio dipende dal fabbisogno dei paesi di arrivo ed è ad esso commisurato. Michele: Esattamente e questo mi permette di effettuare proiezioni demografiche e costruire scenari utilizzando una procedura diversa da quella delle Nazioni Unite e i cui risultati sono certamente più realistici. Li: Vediamo. Una procedura alternativa per la costruzione congiunta di scenari demografici e del mercato del lavoro Michele: La procedura che vi propongo si basa sul modello dei flussi migratori che vi ho esposto durante l’ultima cena. Partirei con un paio di figure che vi chiariranno tutto. Li: Sei sempre troppo fiducioso. Michele: I miei disegnini sono dei prototipi di chiarezza lapalissiana! La prima figura presenta la procedura in maniera sintetica. Il primo passaggio è la costruzione di scenari del saldo migratorio utilizzando il mio modello. Il procedimento si snoda su due percorsi paralleli. Nel primo, quello demografico, palla in alto, si proietta la popolazione in età lavorativa e si stimano scenari alternativi di offerta di lavoro utilizzando diversi valori dei tassi specifici di partecipazione per sesso e classe di età. Nel secondo, quello economico, palla in basso, si stimano scenari di domanda di lavoro formulando ipotesi alternative sul tasso di crescita della produzione e sulla tipologia di sviluppo socio-economico. I due percorsi confluiscono per fornirci delle stime degli scenari di fabbisogno occupazionale e del saldo migratorio. Questa fase produce anche una proiezione della popolazione in età lavorativa. A questo punto si passa alla seconda fase. In primo luogo si somma la Popolazione in età lavorativa con le diverse stime dal saldo migratorio. Ovviamente otterremo un numero di scenari della popolazione in età lavorativa in un mercato del lavoro aperto ai flussi migratori uguale a quello degli scenari dei saldi migratori. Ci siete fin qui? Li: La cosa continua a essere un po’ misteriosa, ma va pure avanti. Come disse Confucio: “La speranza è l’ultima a morire”! Michele: Entriamo nella terza fase. Ogni scenario della PEL con immigrati contiene anche una stima del numero delle donne in età fertile. La formulazione d’ipotesi standard su fecondità e mortalità consente di stimare, da un lato, i nati e, dall’altro, gli anziani. A questo punto abbiamo tutto l’occorrente per produrre scenari demografici completi. Disponiamo, infatti, per ciascun scenario della popolazione in età lavorativa, dei giovani e degli anziani, la cui somma ci fornisce la popolazione totale. 153 John: Credo di avere il quadro generale, ma mi piacerebbe avere qualche dettaglio in più sulla procedura di calcolo. Figura 2 – La costruzione di scenari demografici del mercato del lavoro e della popolazione Michele: La ricetta da seguire è abbastanza semplice. Passiamo alla Figura 3. Mario: Stai scherzando; mi sembra un percorso a ostacoli. Michele: Lasciati guidare per mano. Cominciamo dall’offerta (parte alta della Figura). Il primo passaggio consiste, come abbiamo già visto, nel proiettare la popolazione in età lavorativa in assenza di migrazioni. Prendiamo, a titolo di esempio, un orizzonte temporale di quindici anni sufficiente per programmare la maggior parte delle politiche strutturali. In questo caso i giovani che entreranno nella popolazione in età lavorativa sono già nati: sono i bambini che hanno tra 0 e 14 anni nell’anno di partenza delle proiezioni, supponiamo il 2015. Come vi ho fatto vedere in una precedente chiacchierata, basterà allora applicare alle singole classi di età quinquennali presenti nel 2015 i relativi tassi di sopravvivenza per il quindicennio successivo. E’ evidente che in questo caso i margini di errore saranno molto modesti. John: Quindi a questo punto, oltre al dato relativo al 2015, avremo anche stime della popolazione in età lavorativa (definita tra i 15 e i 64 anni) nel 2020, nel 2025 e nel 2030. Michele: Esattamente. Veniamo ora al secondo passaggio il cui obiettivo è quello di costruire degli scenari di offerta di lavoro. Per farlo dovremo formulare delle ipotesi sull’evoluzione della partecipazione al mercato del lavoro. Potremmo considerare, ad esempio, tre scenari che riflettano diverse evoluzioni della scolarità, del comportamento partecipativo della componente femminile e degli anziani. John: Fammi indovinare. A questo punto si moltiplica la stima della popolazione in età lavorativa per i tassi di partecipazione ipotizzati e si ottengono tre scenari delle forze di lavoro nel 2020, nel 2025 e nel 2030. 154 Michele: … e potremo calcolare per ogni intervallo quinquennale, a partire da quello tra il 2015 e il 2020, le variazioni delle forze di lavoro dovute alle tendenze demografiche e all’evoluzione dei comportamenti partecipativi. Figura 3 – Metodologia per la costruzione di scenari congiunti del mercato del lavoro e della popolazione Mario e Li fanno cenno di aver capito anche loro. Michele: Passiamo alla domanda di lavoro. Qui la cosa è più semplice. Basterà formulare delle ipotesi, ad esempio tre, sul tasso di crescita dell’occupazione per calcolarne il livello nel 2020, nel 2025 e nel 2030 e quindi le variazioni assolute nei singoli intervalli. A questo punto il gioco è fatto: intersecando gli scenari di domanda e di offerta, potremo calcolare per ognuno di essi il fabbisogno occupazionale, dato dalla differenza tra le variazioni della domanda e dell’offerta di lavoro, e poi il saldo migratorio. Mario: Quanti scenari avremmo in questo esempio? Michele: Incrociando i tre scenari di offerta con i tre scenari di domanda, avremmo nove scenari migratori che rappresentano l’obiettivo intermedio della procedura. John: Se ti ho seguito fin qui, questi nove scenari dei saldi migratori ci consentono di costruire altrettanti scenari di popolazione in età lavorativa in una economia aperta. Michele: … e quindi anche della popolazione femminile in età feconda. E’ vero, ma probabilmente a questo punto si potrebbero selezionare i tre scenari più significativi e utilizzarli per calcolare gli scenari demografici completi. Questo ultimo passaggio si baserà sull’utilizzo di due o tre ipotesi di fecondità con cui calcoleremo i nati da inserire nella parte inferiore della piramide delle età. Come ho già detto prima, a questo punto avremo degli scenari demografici completi, articolati per classi di età. Mario: Riassumendo, quali sono le variabili da cui dipendono i tuoi scenari? Michele: Gli scenari dipendono, da un lato, dall’evoluzione del comportamento partecipativo e, dall’altro, dall’andamento della produzione e dalla intensità di lavoro del modello di sviluppo -le variabili che determinano i saldi migratori- e poi ovviamente dai tassi di fecondità e mortalità. Il punto fondamentale è però rappresentato dall’introduzione di un 155 modello per stimare il saldo migratorio in funzione della carenza strutturale di offerta di lavoro al posto di una ipotesi meccanica sulla migratorietà. Mario: Prima che lo dica Li, lo dico io. Per capire bene la tua metodologia bisogna che tu ci faccia vedere come funziona in pratica. Michele: Va bene. Per prendere due piccioni con una fava vi farò vedere come funziona il modello utilizzandolo per costruire degli scenari per la Cina. Li: Ci avviciniamo alla conclusione della nostra lunga marcia! John: Li abbi pietà. Non ce le faccio più. E’ arrivato il momento di accendere la carbonella. Dato che questa sera ci fermiamo tutti a Cesenatico, consiglio di riprendere la cosa domani mattina. Dopo esserci bevuti un cappuccino, ripartiamo da dove siano arrivati. Li: Però stavolta non mi fregate. Non ci si alza dal tavolo se non so cosa sta per succedere in Cina. La cena fu un successo, ma i nostri amici andarono a letto piuttosto tardi e piuttosto allegri. Gli argomenti demografici furono attentamente evitati per non turbare il laborioso processo digestivo che li aspettava. Adesso sono circa le dieci del mattino. I nostri eroi sono seduti a un tavolino del loro caffè preferito nei pressi della spiaggia. Mario e Michele sorseggiano un cappuccino; John ha optato per una spremuta di arance rosse e Li si è fatto preparare un te verde che il barista tiene solo per lui. Dalla teoria alla pratica: il futuro demografico della Cina Michele: Come avevo promesso ieri sera, vi mostrerò come funziona la mia procedura applicandola ai dati del censimento demografico che la Cina ha effettuato nel 2010 171. Li: Finalmente saprò come va a finire! Michele: Come vi ricorderete il primo passaggio è quello di proiettare la popolazione in età lavorativa e stimare gli scenari dell’offerta di lavoro. Popolazione in età lavorativa e forze di lavoro Michele:. Secondo l’ultimo Censimento demografico, nel 2010 la popolazione cinese ammontava a 1,338 milioni, 22 in meno della stima proposta dalle Nazioni Unite. Li: Beh, tutto sommato si tratta di una differenza modesta. Michele: La cosa interessante è che la differenza è spiegata dalla minore consistenza delle prime classi di età (0-14): 221 milioni per il censimento e 247 milioni per la Population Division, mentre il dato sulla popolazione in età lavorativa è molto simile: 993 milioni contro 996. Li: E allora? Michele: La cosa è molto importante perché implica che nei prossimi 15, 20 anni gli ingressi nella popolazione in età lavorativa saranno inferiori a quelli già molto ridotti previsti dalle Nazione Unite e il numero delle donne in età fertile subirà un calo ancora più massiccio. Li: Potresti farci vedere un po’ di numeri. 171 Per essere precisi il primo novembre. L’Ufficio Nazionale Cinese di Statistica ha affermato che la qualità del censimento è stata molto alta. Il livello di copertura è stato molto elevato tanto che la percentuale di mancata copertura è stata solo dello 0,12 per cento, un valore molto inferiore a quello registrato nel censimento del 2000 (1,81 per cento) e di quelli osservati nei recenti censimenti di altri paesi molti dei quali hanno registrato valori di circa 1,5 per cento. 156 Michele: Ho proiettato la popolazione in età lavorativa usando i tassi di sopravvivenza delle classi di età quinquennali dedotti dalle proiezioni delle Nazioni Unite e ipotizzando costante il tasso di fecondità 172. Il grafico visualizza entrate, uscite e saldo relativi a ogni quinquennio tra il 2010 e il 2060. Figura 4 – Cina; Popolazione in età lavorativa; entrate, uscite e saldo; dal 2010-15 al 2055-60 Fonte: Elaborazione su dati del Censimento demografico cinese del 2010 Li: L’area verde misura il calo della popolazione in età lavorativa? Michele: Sì. Dopo un modesto incremento nel quinquennio in corso, tra il 2015 e il 2030 la popolazione in età lavorativa diminuirebbe di 66 milioni e tra il 2030 e il 2060 di 336 milioni, per un totale di oltre 400 milioni. In sostanza la popolazione in età lavorativa scenderebbe da 996 a 598 milioni, registrando una diminuzione di circa il 40 per cento. Li: Agghiacciante! Michele: Anche secondo le Nazioni Unite la popolazione in età lavorativa dovrebbe diminuire, ma “solo” del 25.9 per cento. Come mostra la tavola 4, la differenza è dovuta a un numero minore di ingressi riconducibili inizialmente solo alla minore consistenza delle classi più giovani e poi, in un secondo momento, anche a un minor numero di donne in età fertile. John: Se ricordo bene, da qui al 2030, secondo la World Bank la popolazione in età lavorativa dovrebbe diminuire in maniera molto meno pronunciata di quanto stimato da te. Michele: Esattamente e questo è molto importante perché i miei dati, o meglio i dati censuari, portano a stimare un calo molto più massiccio anche dell’offerta di lavoro, il che ha rilevanti implicazioni per il fabbisogno di manodopera. Mario: Quali sono gli ordini di grandezza? Michele: Ho considerato due ipotesi: tassi di partecipazione costanti 173 e tassi decrescenti. La seconda ipotesi è più realistica in quanto nei prossimi anni si registrerà sicuramente un aumento della scolarità e della partecipazione agli studi superiori. 172 173 L’ipotesi sulla fecondità ha effetto a partire dal 2025. Anche questi valori sono stati elaborati utilizzando i dati del Censimento del 2010. 157 Tavola 4 – Cina; Popolazione in età lavorativa; entrate uscite e saldo in alcuni periodi; valori totali e valori medi annui Fonte: Elaborazione su dati Censimento Demografico 2010 e UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision. Li: E in persone? Michele: Nel primo caso le forze di lavoro diminuirebbero di 73 milioni, nel secondo di 100. John: Stai dicendo che, bene che vada, in quindici anni la Cina dovrà gestire un calo delle forze lavoro uguale a quello che si registrerebbe in Europa se sparissero contemporaneamente la Francia e la Germania? Michele: Esattamente 174; nel secondo scenario sarebbe addirittura come se nel Sud America sparisse il Brasile, la cui popolazione in età lavorativa ammonta a 100 milioni. Li: Non mi sembra credibile! Michele: Se i dati censuari sono corretti 175, la cosa è più che probabile, dato che non si tratta di previsioni, ma di proiezioni basate sul numero di bambini che sono già nati o che stanno nascendo in questi anni. Comunque non dimenticatevi che, diversamente da quanto sostenuto dalla Population Division, questo non è quello che succederà, ma quello che succederebbe se non vi fossero immigrazioni. John: Andiamo avanti. Se ricordo il tuo disegnino, adesso tocca agli scenari di domanda. Domanda di lavoro e fabbisogno di occupati Michele: Ottima memoria. Nel caso della domanda, ho considerato tre ipotesi: occupazione costante (E2); un calo degli occupati uguale a quello suggerito dallo scenario della Banca Mondiale (E1); una occupazione che aumenta, ma in maniera decrescente (E3). Li: Come al solito io vorrei vedere i numeri. Michele: Secondo i dati censuari, nel 2010 gli occupati erano 715 mila che nello scenario E1 scenderebbero a 686,000, mentre salirebbero a 765 mila nello scenario E3. (Tav. 5). Nella Tavola 6 ho invece riportato il fabbisogno occupazionale, cioè i posti di lavoro che non possono essere coperti da lavoratori locali, nei sei scenari che si ottengono combinando i due scenari delle forze di lavoro (A e B) con i tre dell’occupazione (1,2, 3). Mario: Il fabbisogno è calcolato sottraendo dalla variazione delle forze di lavoro la variazione dell’occupazione? 174 Le forze di lavoro della Francia ammontano a 29 milioni, quelle della Germania a 42. Per una difesa della validità dei dati censuari e in particolare di quelli relativi ai bambini tra 0 e 14 anni si veda Zhao, Z. (2011), “China’s far below replacement fertility and its long-term impact”. Demographic Research, 25, 819–836; Guo Zhigang e Gu Baochang “China’s Low Fertility: Evidence from the 2010 Census”, Springer. 175 158 Michele: Esatto; quindi valori negativi indicano una carenza di manodopera, valori positivi segnalano il potenziale aumento della disoccupazione Tavola 5 - Proiezione della popolazione in età lavorativa, di forze di lavoro e occupazione in scenari alternativi di partecipazione e crescita e crescita economica; 2010-2030 Fonte: Elaborazione su dati Censimento demografico cinese, 2010 Li: Quindi, se prendo lo scenario B1, tra il 2010 e il 2015 avremmo una diminuzione delle Forze di lavoro di 6 milioni e un aumento dell’occupazione di 21 milioni e, in totale, mancherebbero 27 milioni di persone. Tavola 6 - Fabbisogno di occupati in sei scenari alternativi di partecipazione e occupazione; dal 2010-15 al 2025-30 Fonte: Elaborazione su dati del Censimento cinese della Popolazione del 2010. Michele: Esatto. Come vedete, già in questo quinquennio la Cina si troverebbe in carenza di forza lavoro in tutti gli scenari, a eccezione dello scenario nel quale sia il tasso di partecipazione, sia il livello dell’occupazione rimangono costanti. Nel complesso il fabbisogno del periodo 2010-2030 –vale a dire il numero di posti di lavoro che non possono essere coperti dall’offerta locale- è incluso tra un minimo di 35 milioni (scenario A1, il più “ottimistico” nel quale il tasso di partecipazione rimane costante e l’occupazione diminuisce) e un massimo di 149 milioni (scenario B3, il più pessimistico, nel quale il tasso di partecipazione diminuisce a l’occupazione aumenta). Li: A questo punto. Scenari migratori e di popolazione in età lavorativa in un mercato del lavoro aperto John: A questo punto il modello di Michele ipotizza che il fabbisogno sia coperto da immigrati. Michele: Per essere precisi ho ipotizzato che il saldo migratorio tenda a eccedere il fabbisogno. Nei paesi di lunga immigrazione, una quota del saldo è sempre imputabile a 159 congiunti e famigliari. Nel caso della Cina, che non ha precedenti esperienze di immigrazione, ho stimato il saldo migratorio ipotizzando che, al primo apparire del fabbisogno, il saldo sia uguale al fabbisogno e ho poi alzato progressivamente il rapporto saldo/fabbisogno così che nel quarto periodo di immigrazione esso fosse pari a 1.15. Li: Comunque i saldi migratori sono diversi da scenario a scenario? Michele: Certamente, dato che essi dipendono dal livello del fabbisogno. A questo punto, come da procedura, ho stimato gli scenari di popolazione in età lavorativa “aperta” sommando alla popolazione chiusa -quella che si avrebbe in assenza d’immigrati- con la stima del saldo migratorio. I dati sono riportati nella tavola 7. Mario: In sintesi. Michele: Il risultato più interessante è che la mia procedura provoca un aumento della popolazione in età lavorativa in tutti gli scenari, tranne nello scenarioA1 (Tavola 7). John: Interessante! Mentre la Population Division profetizza un drammatico crollo della popolazione cinese in età lavorativa, tu sostieni l’opposto. Mario: Se ci pensi è ovvio che sia così. Le Nazioni Unite sostengono non solo che la Popolazione in età lavorativa diminuirà per motivi naturali, ma che malgrado ciò i Cinesi continueranno a emigrare. Michele ritiene, invece, che il calo naturale delle PEL genererà una diminuzione dell’offerta di lavoro. Se -come è molto probabile- l’offerta non sarà sufficiente a soddisfare la domanda di lavoro si genererà un fabbisogno che attirerà inevitabilmente un’immigrazione più che sostitutiva. Tavola 7 - Livelli della popolazione in età lavorativa in uno senario senza immigrazione e in sei scenari di immigrazione; 2010-203 Fonte: Elaborazione su dati censuari 2010 Li: Di quanti immigrati stiamo parlando? Michele: Parecchi. La situazione è sintetizzata nella tavola 8 e nella Figura 5. Nella tavola ho riportato i saldi naturali della popolazione in età lavorativa unitamente ai saldi migratori e ai saldi totali relativi ai singoli periodi quinquennali nei sei scenari. Nei venti anni considerati, il saldo migratorio totale sarà compreso tra un minimo di 38 milioni (scenario A1) e un massimo di 162 milioni (scenario B3). Poiché il saldo naturale è negativo e pari a 63 milioni, il saldo totale risulta negativo solo nello scenario A1. In tutti gli altri scenari, la popolazione in età lavorativa aumenta e la crescita è massima nello scenario B3 (quasi 100 milioni). Infine, la dinamica migratoria risulta diversa a seconda delle ipotesi relative alle forze di lavoro. Negli scenari A, nei quali i tassi di partecipazione sono costanti, il saldo migratorio cresce progressivamente, mentre negli scenari B caratterizzati da tassi di partecipazione decrescenti, i valori massimi sono raggiunti in quinquenni diversi. 160 Li: Vorrei essere sicuro di aver capito bene. Stai dicendo che la Cina dovrà importare lavoro forse fin da subito, ma certamente tra il 2015 e il 2020 e che tra il 2015 e il 2030 il saldo migratorio si aggirerebbe sui 5, 6 milioni l’anno? Tavola 8 – Saldo naturale, saldo migratorio e saldo totale in scenari alternativi; 20102030 Figura 5 – Saldo migratorio e saldo totale della popolazione in età lavorativa in scenari alternativi-;2010-2030 Michele: Esatto e le sorprese non sono finite! John: Che bello! L’impatto dei flussi migratori sulla natalità Michele: La prima conseguenza è un aumento delle donne in età fertile. Nel caso della Cina si può ipotizzare che almeno la metà degli immigrati sarà costituita da donne, dato che una buona parte del fabbisogno sarà nel settore del lavoro domestico e negli altri comparti del terziario. 161 Li: Questo potrebbe aiutare a ridurre uno dei disequilibri demografici della Cina, la carenza di giovani donne, che è molto pronunciata in alcune zone 176. John: L’impatto principale dovrebbe però essere sul numero delle nascite. Michele: Credo che l’immigrazione non farà aumentare solo i nati, ma anche la fecondità, perché le immigrate mantengono, almeno per un certo periodo, la fecondità del paese di partenza John: Pensavo che su questo tema vi fossero opinioni contrastanti 177. Michele: Sì; ma credo che la mia ipotesi sia realistica. Essa è condivisa da numerosi istituti statistici. Ad esempio, nel 2004 le Nazioni Unite sostennero che l’ipotesi che le immigrate adottassero istantaneamente la fertilità del paese di arrivo era stata adottata non perché così fosse, ma per semplicità di calcolo. Le ultime proiezioni effettuate dall’Istituto Italiano di Statistica ipotizzano che le immigrate abbiano un tasso di fecondità uguale al valore di rimpiazzo, e quindi molto più elevato di quello delle donne italiane. Mario: Se non sbaglio, in Italia le donne straniere stanno dando un grosso contributo al numero delle nascite. Michele: Non c’è dubbio. Dovrei avere dei dati. Eccoli Li: Il tuo computer è una miniera. Michele: In Italia, dal 2002 al 2012 l’incidenza dei bambini nati da donne straniere è passato dal 6,2 a quasi il 15 per cento, ma si supera il 20 per cento se si considerano i bambini nati da coppie nelle quali almeno uno dei genitori è straniero. Mario: Quindi; l’immigrazione potrebbe frenare la caduta del numero dei nati! Michele: Ipotizzando che i tassi specifici di natalità rimanessero costanti ai valore del 2010, in assenza d’immigrazioni il numero dei bambini si ridurrebbe più o meno nella stessa misura delle donne in età fertile e scenderebbe quindi da 15,1 a 11,6 milioni. La cosa cambia in presenza di migrazioni. Ho considerato tre casi: i) senza immigrazione e fertilità costante: ii) con immigrazione e fertilità uguale a quella delle donne cinesi: iii) con immigrazione e immigrate con fertilità di rimpiazzo, per tutti e sei gli scenari. In tutti e tre la diminuzione sarebbe inferiore e nell’ipotesi più favorevole il numero dei nati rimarrebbe sostanzialmente costante. Si tratta di un fatto importante non solo nell’orizzonte temporale che stiamo analizzando, ma ancora di più nel lungo periodo. Li: Perché? Michele: Nella mia ottica le immigrazioni potrebbero essere necessarie fintanto che il disequilibrio demografico non sarà ricostituito. Ad esempio, tra il 2030 e il 2045 le uscite dalla popolazione in età lavorativa saranno uguali a 340 milioni (circa 23 milioni all’anno) un numero che non può essere modificato, dato che si tratta di coloro che sono adesso nelle classi di età centrali. Ora, se le nascite fossero quelle delineate nello scenario a fertilità costante e senza immigrazione la popolazione in età lavorativa diminuirebbe di 150 milioni e, 176 A livello nazionale, la percentuale di donne nella popolazione tra i 15 e i 49 anni è del 49,1 per cento. Il disequilibrio di genere è particolarmente pronunciato nelle grandi città (Shanghai 47,6, Pechino 47,5, Tianjin 45,1 per cent). 177 Per un’analisi della letteratura internazionale su questo tema e sulle evidenze empiriche si veda Anne Genereux (2007), “A review of migration and fertility theory through the lens of African immigrant fertility in France”, MPIDR, Working paper WP 2007-2008. 162 anche nel caso dello scenario B3 con immigrazione elevata e fertilità di rimpiazzo, il buco di offerta ci sarebbe, ma scenderebbe a 112 milioni. Tavola 9 – Cina; numero di nati in scenari alternativi; 2010-2030 Fonte: Elaborazione su dati del Censimento cinese del 2010 Li: Altre implicazioni? Invecchiamento e carico sociale Michele: Si, l’impatto sull’invecchiamento. E’ il problema che fino ad ora ha attratto maggiormente l’attenzione di economisti e demografi e l’unico di cui si discute ampiamente. Tutti sono convinti che le attuali tendenze demografiche provocheranno un carico sociale insostenibile. John: Non dirmi che non sei d’accordo neanche su questo! Michele: E per ottimi motivi. John: Quali Michele: Il fatto è che questa conclusione si basa sull’uso d’indicatori che non sono idonei né a capire il problema, né a indicare possibili soluzioni. Mario: Cosa c’è che non va? Michele: Quasi tutto. Gli indicatori di carico sociale sono ottenuti dividendo il numero di giovani, di anziani e la loro somma per la popolazione in età lavorativa 178 John: E allora? Michele: Le leggi della natura non sono soggette a cambiamenti per lo meno su tempi a scala umana; quindi i loro indicatori rimangono validi nel tempo. Lo stesso non si può dire della società e delle sue modalità di funzionamento. Nella fase storica in cui gli indicatori di carico sociale sono stati ideati, le società erano prevalentemente rurali e anche gli abitanti delle città erano tutti disponibili a lavorare (uomini, donne e bambini) a qualunque condizione. Quindi, identificare la popolazione in età lavorativa con coloro che mantengono era una buona approssimazione. Questo non è certamente vero oggi. Sono gli occupati che mantengono la restante popolazione ed essi rappresentano circa il 60 per cento della popolazione in età lavorativa che include anche numerosi studenti, casalinghe e altre persone che non mantengono, ma sono mantenuti. 178 Il tasso di dipendenza giovanile (TDG) si ottiene dividendo il numero dei giovani per la popolazione in età lavorativa; il tasso di dipendenza degli anziani (TDA) dividendo il numero degli anziani per la popolazione in età lavorativa. Il tasso di dipendenza totale (TDT) è la somma del tasso di dipendenza giovanile e del tasso di dipendenza degli anziani. 163 John: E quindi cosa suggerisci? Michele: Una cosa molto semplice: sostituire la popolazione in età lavorativa con gli occupati 179. Insomma, invece d’indicatori puramente demografici, la mia proposta è di costruire indicatori economici che oggigiorno sono possibili perché la maggioranza dei paesi dispone, quasi in tempo reale, di stime del livello e della struttura dell’occupazione, unitamente a dati su numerose altre condizioni socio-economiche. Mario: Ci sarebbero dei vantaggi? Michele: Numerosi. Il primo è disporre di una misura corretta del carico sociale, basato su di una imputazione dei “mantenuti” a coloro che effettivamente li mantengono. Il secondo è di poter articolare il carico totale non soltanto su giovani e anziani, ma su di un numero più numeroso di categorie dotate di un maggiore significato economico 180. Altra cosa molto importante è che questo indicatore permette di capire se i cambiamenti registrati in un dato periodo sono dovuti a cause demografiche o alla incapacità del sistema di creare posti di lavoro aggiuntivi. Infine, esso consente confronti tra paesi che utilizzano diverse definizioni della popolazione in età lavorativa e i suoi valori rimarranno validi anche quando la definizione di popolazione in età lavorativa verrà cambiata, cosa che succederà tra non molto visto il progressivo allungamento della vita umana e della fase formativa. Last but not least, l’indicatore economico permette di calcolare l’aumento dell’occupazione che permetterebbe di mantenere costante il livello totale del carico sociale. Insomma esso è anche uno strumento per disegnare le necessarie politiche dell’occupazione. Mario: Troppa grazia San Antonio. Cambi un denominatore e succede tutto questo! Li: Fermi! Non riesco neanche a ricordarmi tutti i punti che Michele ha elencato. Michele: Anche in questo caso la cosa migliore è fare ricorso a degli esempi. Partiamo dagli indicatori demografici. In Cina, secondo la Population Division, il tasso demografico di dipendenza totale ha raggiunto un massimo di 810 per mille nel 1965. E’ poi progressivamente diminuito ed ha toccato un minimo di 360 nel 2010. Nei successivi 90 anni dovrebbe aumentare progressivamente fino a toccare un valore di 770 nel 2100 181. Per mettere questi valori in una prospettiva internazionale, la tavola 10 confronta gli indicatori cinesi con quelli di Australia, Francia, Italia e Stati Uniti. Come potete vedere le tendenze sono sostanzialmente analoghe. Secondo l’indicatore demografico nei prossimi anni le persone a carico dovrebbero più che raddoppiare in Cina, che ha attualmente l’incidenza più bassa, e aumentare di una percentuale compresa tra il 57 e il 73 è per cento negli altri. John: Tutto il mondo invecchia! 179 Lo stesso suggerimento era già stato avanzato da George Tapinos (2001), “The role of migration in moderating the effect of population ageing, Migratio, 2. Tapinos non sottolineò però il cambiamento di prospettiva e le numerose implicazioni della proposta. 180 Ad esempio, minori in età di obbligo scolastico, altre persone nella fase formativa, persone in cerca di occupazione, casalinghi/e, altre non forze di lavoro in età lavorativa, non forze di lavoro in età post lavorativa. 181 Nell’intervallo considerato il ruolo relativo di giovani e anziani s’inverte. Nel 1965 i bambini rappresentavano il 91,4 per cento delle persone a carico, nel 2010 il 69,4 e nel 2100 dovrebbero rappresentare il 35,1 per cento. 164 Tavola 10 – Cina e altri paesi; Indicatore demografico di carico sociale totale; circa 1960, 2010 e 2100. Fonte: elaborazione su dati UN DESA, World Population Prospects, The 2012 Revision; ILO, LABORSTA Michele: Questo è evidente, ma io credo che si sbagli a rappresentare l’invecchiamento come un evento determinato unicamente da tendenze demografiche irreversibili e quindi da subire in maniera passiva. Per capirlo basta guardare al fenomeno da una prospettiva che tenga conto della crescita occupazionale, usando l’indicatore che vi ho appena proposto. In primo luogo esso evidenzia in maniera più realistica che mille occupati debbono mantenere 870 persone. Ho poi messo in evidenza che gli occupati non mantengono solo bambini e anziani, ma anche gli inattivi in età lavorativa (TDI) che includono studenti, disoccupati,. casalinghe, ammalati, ecc.. Di fatto con il 38,5 per cento dei dipendenti è questa la categoria più numerosa. Tra il 2010 e il 2030, il valore dell’indicatore economico supera le mille unità in tutti e tre gli scenari considerati. Tuttavia, la sua crescita è inversamente correlata alla dinamica dell’occupazione. Inoltre, maggiore è la crescita dell’occupazione, maggiore la crescita della percentuale dei giovani e minore quella degli anziani. Tavola 11 – Cina; indicatore economico di carico sociale in scenari alternativi; 2010 e 2030 Fonte: elaborazione su dati Censimento Cinese, 2010 Mario: Insomma, tu stai suggerendo che la riduzione delle pensioni non è ne l’unico ne il miglior modo per fare fonte all’invecchiamento. Michele: Infatti, io sono convinto che per affrontare il cosiddetto problema dell’invecchiamento si debba in primo luogo fare ricorso ad una ingegneria delle fasi della vita che colleghi l’età di uscita dal sistema formativo con l’età di uscita dall’occupazione, e questa non con l’età biologica; ma con la capacita lavorativa. La cosa più importante è però capire che, in attesa di un riequilibrio demografico, la soluzione sta nella crescita economica che aumentando il numero degli occupati riduce quello dei dipendenti per occupato. Li: Michele si sta facendo tardi; vorresti mettere insieme tutti i pezzi e farci capire cosa sta per succedere alla popolazione cinese. 165 Il futuro demografico della Cina nel medio periodo Michele: Cominciamo dal periodo 2010-2030. Come abbiamo visto, la mia procedura evidenzia come vi sia un’alta probabilità che un calo naturale della popolazione porti a una immigrazione più che sostitutiva e quindi a un aumento di questo aggregato. Ciò innescherà un aumento del numero delle donne in età fertile e quindi dei nati. Poiché gli anziani non possono che aumentare la conclusione è che anche la popolazione totale aumenterà. Se ciò ti consola credo quindi che si possa escludere che presto l’India divenga il paese più popoloso della terra, come suggerito dalla Population Division 182. Mario: In conclusione il tuo modello ribalta le conclusioni della Population Division. Michele: Si; secondo la Population Division, la fase finale della transizione demografica provoca necessariamente una diminuzione della popolazione totale, una ancora più pronunciata contrazione della popolazione in età lavorativa, un inarrestabile e irreversibile processo d’invecchiamento. Io ritengo, invece, che questa conclusione si basi sull’assurda e ideologica premessa che i sistemi economici non continueranno lungo il loro processo di crescita rinunciando ad attrarre da altri paesi le risorse umane necessarie per la loro crescita. E se lo faranno, ciò comporterà non solo un aumento della popolazione in età lavorativa e un aumento, sia pure meno pronunciato, della popolazione totale, ma porterà anche ad aumenti delle nascite e della fecondità e a un rallentamento del processo d’invecchiamento. Li: E dopo? Uno sguardo a un futuro più lontano Michele: Si, ma senza pretendere di leggere il futuro con precisione. Per la Cina, gli scenari che vi ho presentato suggeriscono che, a meno di una crisi economica di dimensioni tali da mettere in crisi anche il resto del mondo, la Cina dovrà importare 80, 90 milioni di lavoratori e che il problema tenderà ad accentuarsi col passare del tempo. Li: Cioè? Michele: Abbiamo già visto che tra il 2030 e il 2060, le uscite dalla popolazione in età lavorativa sono valutabili in circa 660 milioni, circa 22 milioni all’anno. Questo è quindi il numero di nascite che si dovrebbero verificare in media ogni anno tra il 2015 e il 2045 per mantenere inalterata la popolazione in età lavorativa. E’ difficile ipotizzare che ciò possa avvenire anche in presenza di sostenuti flussi migratori che al massimo potrebbero potare il numero delle nascita a 15, 16 milioni. Tuttavia ciò porterebbe la riduzione della popolazione in età lavorativa a soli 200 milioni a fronte dei 260 previsti dalle Nazioni Unite e dei 335 dello scenario basato sui dati censuari a fertilità costante. John: Quindi, se applicassimo il metodo Chamie gli immigrati sarebbero solo 200 milioni. Michele: Esatto. Ma come abbiamo visto dovremmo ipotizzare che la partecipazione al mercato del lavoro rimanesse costante e soprattutto che l’occupazione non aumentasse, o meglio che tutta la crescita del PIL fosse gestita con aumenti della produttività. In sostanza a questo numero dovremmo aggiungere la crescita occupazionale e l’impatto di una più che probabile diminuzione della partecipazione. Insomma a tenersi bassi, altri 100 milioni di persone. Li: Fammi fare un po’ di conti all’ingrosso. Tu stai dicendo che nei prossimi 15 anni la Cina dovrà importare almeno 80 milioni di persone e che nei trenta anni successivi il 182 Il sorpasso dovrebbe avvenire verso il 2035. 166 fabbisogno sarà di almeno 300. Siamo quindi a un totale di 380 milioni e questo mentre le Nazioni Unite dicono che ci potremo permettere di esportare 15 milioni di persone. Michele: Esatto. Aggiungerei che possiamo tranquillamente ipotizzare che un numero analogo d’immigrati sarà necessario agli altri paesi che sono già o stanno per entrare nella terza fase della transizione demografica. John: Quindi, stai dicendo che nei prossimi 45 anni i saldi migratori saranno dell’ordine di 750 milioni. Michele: Sì, questo è il risultato a cui porta l’ipotesi che i flussi migratori siano determinati dalla carenza strutturale di offerta di lavoro. Sono convinto che il ventunesimo secolo sarà ricordato come il secolo della grande migrazione. Li: Lo scenario che tu dipingi non include però possibili interventi del governo cinese e dei governi degli altri paesi. Si potranno pure fare politiche mirate a risolvere il problema della carenza di offerta di lavoro. Michele: Le politiche non mancano e la Cina avrebbe già dovuto attivarle. Il problema è che per farlo dovrebbe prima accettare che gli scenari che vi ho presentato sono affidabili, cosa che per il momento non mi sembra molto probabile. Comunque, vedremo cosa uscirà dal prossimo Plenum. Mario: Ragazzi è quasi mezzogiorno. Che ne direste di una passeggiatina sulla spiaggia come aperitivo? 167 Quella che il bruco chiama la fine del mondo, per il suo padrone è una farfalla. Richard Bach, “Illusions” Settimo dialogo - Il secolo della grande migrazione E’ la vigilia di Natale. I nostri amici sono a casa di Michele per tirare le somme delle loro lunghe chiacchierate e, cosa non secondaria, per il rituale cenone. E’ ancora pomeriggio: seduti sulle poltrone del soggiorno, le lucine dell’albero di Natale che si accendono e si spengono alle loro spalle, cercano la risposta a due domande di grande respiro. Vogliono sapere quale sarà il futuro demografico del mondo e se la Cina riuscirà a prenderne la leadership. Consapevoli che i grandi della terra attendono con ansia le loro conclusioni, si stanno sostenendo con una classica pinza di Natale alla bolognese, mentre dalla cucina arriva il profumo del brodo di cappone in cui verranno cucinati i tortellini 183. Le riforme del Plenum cinese Mario: Ragazzi, dall’ultima volta che ci siamo visti di cose ne sono successe parecchie. Tanto per citarne alcune, la vittoria di Renzi alle primarie, la morte di Mandela, i primi accordi con l’Iran, l’allunaggio di una sonda cinese, la vergognosa incapacità dei nostri centri di accoglienza di svolgere il proprio lavoro in maniera dignitosa e umana 184. Li: Ti stai dimenticando l’evento per noi più importante: le direttive emanate dal terzo Plenum del Partito Comunista Cinese 185. Mario: No, volevo lasciare a te l’onore. Tutti i media hanno annunciato la fine della politica del figlio unico, la chiusura dei campi di rieducazione, la riforma dell’hukou e l’innalzamento dell’età di pensionamento. Li: A dire la verità ci sono state molte inesattezze dovute anche al fatto che il governo cinese in quanto a capacità comunicativa fa ancora pena. Il primo comunicato, diffuso subito dopo la chiusura del Plenum, era infatti scritto in un cino-politichese noto a un ristretto circolo di esperti. Solo più tardi, è stata pubblicata una relazione più comprensibile che è però arrivata quando l’attenzione mondiale si era già spostata su altri eventi 186. Così, la stampa e le televisioni internazionali si sono concentrate sulle misure relative alle norme che da sempre fanno scandalo, non su quelle più rilevanti. Michele: Il tuo parere? 183 La ricetta dei tortellini è stata depositata il 7 dicembre 1974 con atto notarile presso la Camera di Commercio di Bologna dalla Dotta Confraternita del Tortellino, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina. Si veda http://www.confraternitadeltortellino.it/ita. 184 E’ il 5 dicembre quando Mandela lascia il mondo che lo ha visto lottare per tutta la vita contro razzismo e diseguaglianza; è l’8 dicembre quando con il 68 per cento di oltre tre milioni di voti, Renzi vince le primarie contro Cuperlo e Civati; è il 16 dicembre quando Chang’e 3 tocca il suolo del nostro pianeta nella Baia degli arcobaleni e fa sbarcare Yutu, un rover a sei ruote del peso di 140 chili; è il 18 dicembre quando viene divulgato un video sul vergognosop trattamento subito dagli immigranti in un centro di accoglienza di Lampedusa. 185 L’attuale leadership cinese fu nominata nel novembre del 2012. Di norma la leadership cinese tiene una sessione plenaria all’anno, ad eccezione del primo. La seconda sessione si è pertanto tenuta nel febbraio del 2013, poco prima del Congresso di Marzo, per preparare il cambio di leadership. La terza si tiene normalmente in ottobre o novembre ed è stata spesso usata per svelare i piani politici della nuova leadership, le sue priorità e lanciare riforme economiche e politiche. Nel 2013 la terza riunione del plenum è stata tenuta dal 9 al 12 novembre. 186 http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-01/15/content_31203056.htm 168 Li: Mi è piaciuto il grande slancio riformista del documento. Ad esempio il fatto che esso parli del grande sogno di ringiovanire la nazione cinese e che affidi al mercato un ruolo decisivo nell’allocazione delle risorse e nel promuovere uno sviluppo giusto e sostenibile. Su altri punti, mi è sembrato ancora troppo timoroso e reticente. Mario: Abbiate fede! Forse il vostro RenZi è già nato e sta vagendo in un qualche sperduto villaggio di campagna o nella periferia di una megalopoli. Se è cosi starà già chiedendosi cosa fare, sena interrogarsi troppo sul dove andare. Sarebbe interessante sapere se la sua nascita è stata annunciata dalla comparsa di una stella rosa nel cielo della Cina. John: Li, non fargli caso e parlaci delle singole misure. Li: Cominciamo da quelle che sono state prese in considerazione solo dagli addetti ai lavori. In primo luogo, il documento da molto spazio alla riforma delle imprese di stato e concede ai privati la possibilità di effettuare investimenti in quasi tutti i settori. Il governo si è poi impegnato a favorire gli investimenti stranieri in Cina e quelli cinesi all’estero; a portare avanti l’integrazione verticale del sistema giudiziario; a unificare i mercati urbani e rurali della terra edificabile. E’ stata poi prevista la costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di rendere più incisive le riforme e che risponderà direttamente alla leadeship del partito. John: Mio caro Li, la cosa difficile dei piani non è scriverli, ma attuarli. Non mi sembra un caso che manchi una chiara indicazione di quando i vari interventi saranno attuati.. Il tuo governo potrebbe decidere di implementare le cose facili e rinviare quelle difficile. Però, l’aspetto più preoccupante è che mentre si riduce il ruolo del governo e della burocrazia, quello del partito ne esce rafforzato. Li: Mio caro John, non è che sotto sotto cominci a soffrire dell’invidia del dittatore? Guarda che il governo cinese, proprio a causa di quella che tu chiami mancanza di democrazia, può portare avanti le riforme di cui il paese ha bisogno in maniera molto più rapida ed efficace di quanto non riesca a fare il vostro Obama che, malgrado tutta la buona volontà, non è ancora riuscito a riformare la sanità, a chiudere Guantanamo, a fare una legge umana sugli immigrati e ad evitare ogni pochi mesi un ridicolo tira e molla con il Senato per riuscire a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Dobbiamo smettere di pensare che ciascuno di noi abbia il diritto di esportare i propri valori e le proprie istituzioni e di criticare quelle degli altri. Michele, tu cosa ne pensi delle nuove Direttive? Michele: Io mi sono concentrato sulle misure relative ai temi che stiamo discutendo. Vorrei però che ripartissimo dal problema del fabbisogno di manodopera straniera anche perché questo ci permetterà di dare una prospettiva globale alla nostra chiacchierata. Mario: Insomma, da quei 350 milioni di immigrati di cui la Cina avrebbe bisogno nei prossimi 40, 50 anni, ma anche dai 350 di cui avrebbero bisogno gli altri paesi a bassa fertilità. La presenza straniera nei paesi di arrivo Michele: Cominciamo col mettere in prospettiva questi numeri che, a prima vista, possono sembrare incredibili. Come già sappiamo, negli ultimi sessanta anni il saldo migratorio dei paesi di arrivo è cresciuto in maniera molto pronunciata e tra il 2000 e il 2010 ogni anno oltre 5 milioni di persone hanno lasciato la loro patria per cercare lavoro in un altro paese. Così, a 169 metà del 2013 il numero complessivo d’immigrati internazionali era stimato in 231 milioni187. Quindi, se le migrazioni continuassero al ritmo attuale, alla fine del secolo la somma dei saldi migratori registrati in cento anni supererebbe il mezzo miliardo. Mario: Forse è proprio per evitare un numero così politicamente scorretto che la Population Division ipotizza che le migrazioni internazionali finiranno per scomparire. Michele: Come direbbe Confucio: “Honi soit qui mal y pense” 188. D’altra parte, sono già numerosi i paesi nei quali la percentuale d’immigrati sulla popolazione totale è estremamente elevata. Mario: Secondo gli ultimi dati, vi sono 27 paesi nei quali la percentuale d’immigrati e rifugiati è superiore al 10 per cento 189. I casi più eclatanti sono quelli di tre paesi del golfo: gli Emirati Arabi con l’83,7 per cento, il Qatar e il Kuwait con il 73,8 e il 60,2 per cento rispettivamente. Il gruppo successivo, con valori superiori al 30 per cento, include altri tre paesi arabi (Giordania, Arabia Saudita e Oman) insieme a due delle piccole tigri asiatiche: Singapore e Hong Kong. L’incidenza degli schiavi nella Roma imperiale era analoga, ma le loro condizioni di vita erano certamente migliori, una cosa che mi sembra particolarmente grave e ripugnante visto che questi paesi non hanno certo bisogno di sfruttare il lavoro altrui. Tra il 20 e il 30 per cento vi sono molti degli storici paesi d’immigrazione (Svizzera, Australia, Nuova Zelanda e Canada), ma anche Israele e Kazakistan. Gli Stati Uniti sono il paese che ha il maggior numero d’immigrati, quasi 46 milioni, pari a circa il 20 per cento di tutti gli emigrati internazionali. Tuttavia, con un’incidenza sulla popolazione totale del 14,3 per cento, gli Stati Uniti sono in un gruppo di 13 paesi, quasi tutti europei, con percentuali tra il 10 e il 20 per cento. John: E l’Italia? Mario: Malgrado le leggi poliziesche volte più al controllo delle frontiere che a regolamentare i flussi migratori in funzione dei fabbisogno del mercato del lavoro, a metà del 2013 gli immigrati presenti in Italia erano quasi 6 milioni e rappresentavano il 9,4 per cento della popolazione totale. Il dato diventa ancora più rilevante quando si consideri il mercato del lavoro dove gli immigrati rappresentano ormai più del 10 per cento delle forze di lavoro. Tabella 1 – Paesi con la più alta percentuale di stranieri 187 United Nations Department of Economic and Social Affair (2013), Trends in International Migrant Stock: The 2013 Revision; http://esa.un.org/unmigration/TIMSA2013/migrantstocks2013.htm?mhome 188 “Vergogna a chi ne pensa male”. Come il dotto lettore avrà realizzato, ancora una volta il povero Confucio è del tutto innocente. Si tratta, in effetti, del motto che sormonta la giarrettiera che contraddistingue il più antico ed elevato ordine cavalleresco inglese che da essa prende il nome. 189 I dati non sono omogenei in quanto, in alcuni casi, si riferiscono a nati all’estero, in altri a stranieri e possono includere o meno i rifugiati. 170 Fonte: UN DESA, Trends in International Migrant Stock. The 2013 Revision Proiezioni, percezioni e politiche: il caso della Cina Michele: Comunque ciò che mostra meglio di ogni altra cosa il realismo delle mie previsioni è proprio ciò che è successo in Cina dove, negli ultimi venti anni, si sono registrati circa 250 milioni di migranti, quaranta in più dei migranti internazionali degli ultimi sessanta anni. Essi sono la risposta al fabbisogno di manodopera generato nelle province costiere dalle tendenze demografiche e dalla crescita economica 190. Li: Nessuno può più negare che il mercato del lavoro cinese sia a corto di manodopera. Lo straordinario aumento dei salari (85 per cento in 4 anni) e la crescente conflittualità sui luoghi di lavoro sono lì a testimoniarlo 191. Io continuo però a pensare che la Cina non potrà mai accettare l’idea che tutti gli sforzi fatti per tenere gli “stranieri” fuori dal proprio territorio, Grande Muraglia inclusa, vengano nullificati dalla crescita economica. D’altra parte, le tue stime valgono in assenza di nuove politiche e il governo cinese si sta muovendo. Michele: Io non ci conterei troppo. Li: Perché? Michele: La carenza di lavoro non sarà un fenomeno marginale e temporaneo, ma strutturale e di lunghissimo periodo. Per affrontarlo in maniera efficace il governo cinese dovrebbe agire immediatamente, ma per farlo, come ho già detto l’altra volta, dovrebbe accettare l’idea che la Cina si trova sull’orlo di un baratro demografico senza precedenti e, a dirti la verità, non mi sembra che neanche questo Plenum abbia avvertito il pericolo o sia disposto a farlo 192. Mario: Mi sembra curioso che, mentre trentacinque anni fa i demografi cinesi seppero leggere con chiarezza le implicazioni socio-economiche delle loro proiezioni demografiche e i leader di quel tempo ebbero il coraggio di prendere il più estremo dei rimedi, per di più rompendo con una lunga e solida tradizione culturale, oggi nessuno veda le conseguenze del crollo demografico indicato dalle proiezioni delle Nazioni Unite e di altri Istituti Statistici nazionali. John: Eh non ci sono più i cinesi di una volta! E poi si vede che non vanno a farsi una birra con le persone giuste. Michele: Spiritoso! Per quello che mi riguarda io a Pechino ci sono andato e di birre ne ho bevute più di una e credo, tutto sommato, anche con le persone giuste, ma di risultati per il momento non ne ho visti. Comunque, i cinesi sono in buona e numerosa compagnia visto che 190 Michele Bruni e Claudio Tabacchi (2011), “Present and Future of the Chinese Labour Market”, CAPPaper n. 83 191 Secondo una ricerca del China Economic Bulletin, tra il giugno del 2011 e la fine del 2013, la stampa e i media cinesi hanno registrato oltre mille scioperi e proteste messe in essere soprattutto da parte di lavoratori delle province del Sud. Il 40 per cento degli scioperi si è verificato nel settore manifatturiero e il 26 per cento nei trasporti. Nella prima metà del 2014 il fenomeno, molto sottostimato da questa stima in quanto molti scioperi e proteste non sono registrati dai media, sta accelerando. Per un aggiornamento in tempo reale del numero degli scioperi e della loro localizzazione si veda la mappa defli scioperi; disponibile sul sito del China Economic Bulletin http://www.numble.com/PHP/mysql/clbmape.html 192 Va ricordato che anche la Cina dispone di previsioni demografiche (non pubblicate) che, malgrado il bassissimo numero di nati registrati dal censimento e e la ridotta consistenza delle prime classi di età (dati confermati anche dalla rilevazioni successive), sono ancora, a dir poco, molto ottimistiche. Ad esempio reagendo alle direttive del Plenum, la National Health and Family Planning Commission ha emesso una dichiarazione in cui sostiene che, malgrado la popolazione tra i 15 e 59 anni abbia già cominciato a diminuire, la Cina riuscirà a mantenere una forza lavoro di oltre 800 milioni fino al 2030. 171 nessuno degli altri paesi che si trovano nella stessa condizione ha il coraggio di riconoscere il proprio fabbisogno di immigrati. Mario: Un’ulteriore dimostrazione dell’incredibile inerzia dei paradigmi scientifici e della globalizzazione del sapere. Michele: … ma anche di una profondo e inconfessata avversione al diverso. Li: Comunque vada, a me piacerebbe sapere cosa si può fare. Le politiche per ridurre il fabbisogno di manodopera straniera Michele: Come sappiamo il fabbisogno di manodopera straniera è causato dalla carenza strutturale di offerta di lavoro, una situazione che si determina quando la domanda di lavoro eccede in maniera pronunciata e continuativa l’offerta di lavoro. Ne consegue che il fabbisogno di manodopera straniera può essere ridotto agendo sia sulla domanda, sia sull’offerta. E questo è vero non solo per la Cina, ma per tutti i paesi che si trovano nella stessa situazione. Le politiche dal lato della domanda: aumentare la produttività e delocalizzare la produzione John: Se ricordo bene, nel caso della Cina, la Banca Mondiale ha proposto di ridurre progressivamente il livello dell’occupazione. Michele: Niente di nuovo sotto il sole. Sono più di venti anni che economisti e demografi suggeriscono questa soluzione a tutti i paesi che si trovano a dover fronteggiare un calo della popolazione in età lavorativa, incitandoli ad aumentare la produttività e a delocalizzare la produzione. Tuttavia nessuno di questi paesi è riuscito ad evitare massicci flussi d’immigrati. Li: Ma insomma che cosa dobbiamo fare? Michele: Sul fatto che la Cina debba ricercare aumenti della produttività -che d’altra parte saranno imposti dagli aumenti salariali, inevitabili in un fase di carenza di offerta- e trasferire all’estero i comparti produttivi ad alta intensità di lavoro non ci piove. E’ anche evidente che la Cina ha ampi margini per aumentare la produttività, in particolare nel settore agricolo, ancora molto arretrato sul piano della meccanizzazione e caratterizzato da aziende di dimensioni troppo piccole per garantire uno sfruttamento ottimale del territorio. Allo stesso tempo, ci si può aspettare che la Cina sposti la propria produzione su clusters tecnologicamente più avanzati e ad alta intensità di capitale, generando quindi sensibili aumenti di produttività nel settore industriale. Li: Allora siamo a cavallo! Michele: Non proprio. Io rimango convinto che la Cina non riuscirà ad aumentare la produttività in maniera sufficiente a ridurre in maniera sostanziale la propria domanda di lavoro per un periodo così lungo come quello richiesto dalle tendenze demografiche. Li: Ci hai già detto che nessuno c’è mai riuscito. Ma, se permetti, la Cina è un’altra cosa. Michele: Sì, ma anche nel senso che dovrà affrontare problemi particolari e di dimensioni colossali. In primo luogo l’aumento della produttività dipenderà anche dalla capacità della Cina di alzare il livello educativo e la preparazione professionale dei ragazzi che usciranno da scuole, centri di formazione e università. Come ovunque, anche in Cina, la fertilità è molto più elevata nelle zone rurali e nelle province meno sviluppate così che la maggioranza dei 172 giovani sotto i 18 anni vive ancora in queste aree 193. Questi ragazzi stanno studiando in scuole il cui livello non è certamente comparabile a quello delle zone urbane. Li: Vero, ma sono certo, che il governo cinese saprà intervenire e risolvere il problema. Michele: Speriamo, ma tutto prende tempo e la Cina è ormai fuori tempo massimo. Un ulteriore problema è che nei prossimi anni l’economia cinese entrerà in una fase di terziarizzazione sempre più spinta e ciò non potrà che ridurre la crescita della produttività del lavoro. Li: Quindi tu escludi che riusciremo a ridurre la domanda di lavoro attraverso aumenti della produttività? Michele: Mi auguro che la Cina riesca dove tutti gli altri paesi hanno fallito, ma oggettivamente non riesco a immaginare che la Cina possa mantenere un tasso di crescita della produttività maggiore di quello della produzione per i prossimi cinquanta anni. Li: Ci resta sempre la possibilità di delocalizzare. Michele: Anche in questo caso se a livello teorico non c’è motivo che la cosa non funzioni, sul piano pratico non mancano limiti e problemi. Li: Ad esempio … Michele: La prima e più ovvia considerazione è che non tutto può essere prodotto all’estero e sarebbe quindi opportuno che la Cina cominciasse fin da subito a pianificare quali attività produttive delocalizzare e dove, anche perché si troverà a competere con paesi come Giappone, Corea e Taiwan che hanno ormai acquisito una lunga esperienza in questo settore e possono contare su agenzie di internazionalizzazione ben collaudate, mentre le imprese cinesi utilizzano la propria manodopera anche all’estero. Li: Insomma, stai dicendo che produttività e delocalizzazione possono aiutare, ma non risolvere il problema. Michele: Sì, d’altra parte è quanto emerge anche dall’esperienza dei paesi che si sono già trovati in una situazione di carenza strutturale di lavoro, un caso su tutti quello dell’Italia le cui aziende di settori ad alta intensità di lavoro, come calzature e tessile, già a partire dagli anni novanta, hanno delocalizzato la produzione in numerosi paesi, senza che ciò abbia influito in maniera sensibile sul fabbisogno di manodopera straniera. Li: Se non possiamo diminuire la domanda di lavoro, possiamo almeno aumentare l’offerta? Le politiche dal lato dell’offerta: età di pensionamento, mobilità interna, fecondità Michele: Di politiche che agiscono sull’offerta di lavoro vi è un’ampia scelta. Alcune hanno un impatto nel breve periodo, altre nel periodo medio lungo. Nel breve periodo il modo più semplice per aumentare l’offerta di lavoro è aumentare il numero di classi di età copresenti sul mercato del lavoro, innalzando l’età legale di pensionamento. Li: Secondo le norme in vigore ormai da una sessantina di anni, in Cina gli uomini vanno in pensione a 60 anni e le donne tra i 50 e i 60. Michele: Nel frattempo la durata media della vita è aumentata di una ventina di anni. Il Plenum ha pertanto ritenuto che fosse necessario aumentare l’età di pensionamento per 193 La popolazione delle zone rurali rappresenta il 49,7 per cento della popolazione totale; tuttavia i bambini con meno di un anno sono il 61 per cento, la popolazione tra 0 e 14 il 57,4 e quella tra 15 e 34 il 44 per cento. 173 ridurre il carico pensionistico. Non ho però trovato da nessuna parte l’idea che questa misura potrebbe anche portare a un aumento dell’offerta di lavoro. John: Perché dici potrebbe? Michele: In primo luogo perché la presenza degli anziani nel mercato del lavoro è già molto elevata: il tasso di occupazione degli uomini tra i 60 e i 64 anni è del 57,8 per cento, mentre i tassi di attività delle donne tra i 50 e i 64 vanno dal 61,5 per cento (50-54) (69-64) al 40,3 per cento 194. In secondo luogo perché i giovani studiano sempre più a lungo ed entrano sempre più tardi nella fase lavorativa della vita, il che può controbilanciare l’innalzamento dell’età media di uscita dal mercato del lavoro. Non è quindi chiaro quale sarebbe l’effetto finale di uno spostamento verso l’alto dell’età legale di pensionamento in questa specifica fase storica. Li: Un intervento che comunque non è stato ancora attuato perché, anche in Cina come altrove, non è certo ben visto dai lavoratori. Michele: Vero tanto che, da una parte, esso è stato criticato perché renderebbe più difficile l’ingresso nell’occupazione dei giovani, mentre coloro che la difendono sono comunque a favore di un’implementazione lenta, graduale e selettiva 195. Li: Quindi? Michele: Credo che lo slittamento dell’età pensionabile ridurrebbe il carico pensionistico, ma avrebbe un effetto molto limitato sull’offerta di lavoro. Mario: Passiamo alle altre politiche dal lato dell’offerta. Michele: E’ molto probabile che la carenza di lavoro continuerà a essere localizzata in alcune aree e l’eccesso di lavoro in altre. Li: Quindi la cosa giusta da fare sarebbe facilitare la mobilità interna, abolendo l’hukou. Michele: Certamente, anche se il vero problema non è l’abolizione del divieto di mobilità interna, fra l’altro già totalmente disatteso, quanto la concessione agli immigrati degli stessi diritti dei residenti in aree quali educazione e salute. E questo è soprattutto un problema finanziario che riguarda le città d’immigrazione che vedrebbero esplodere le loro spese. Li: D’altra parte se queste misure non fossero adottate, la Cina continuerebbe a far pagare ai più poveri il costo della crescita economica, come pure il benessere dei residenti nei centri urbani. E’ una vecchia e consolidata tradizione del mio paese, ma potrebbe non essere un atteggiamento intelligente in una fase in cui la carenza di lavoro sta facendo aumentare il potere contrattuale dei lavoratori, immigranti inclusi! John: Ma scusa, se le migrazioni interne continueranno, perché la Cina dovrebbe aver bisogno di lavoratori stranieri? Michele: Le migrazioni interne possono fare ben poco per ridurre il fabbisogno totale. Anzi, l’esodo dei contadini provocherà una carenza di manodopera anche nelle zone più povere che finirà per attrarre lavoratori stranieri, disposti a fare i più umili lavori delle 194 China Statistical Yearbook, 2013 E’ stato, infatti, suggerito l’innalzamento dell’eta legale di pensionamento sia attuata prima e più velocemente per le donne -che sono penalizzate dall’attuale sistema- e per le professioni impiegatizie, in particolare quelle del settore pubblico 195 174 campagne. E’ un fenomeno che in Italia è stato molto evidente e ha portato intere comunità straniere a stanziarsi in zone agricole marginali. Li: Quindi, non ci rimane che fare più figli! Michele: Esatto; nel lungo periodo l’unica alternativa all’immigrazione e alla contrazione della produzione è l’ingresso nella popolazione in età lavorativa di coorti più numerose e ciò si può ottenere solo con un aumento della natalità, visto che il numero delle donne in età fertile è destinato a diminuire progressivamente. Li: Mi sembra che anche in questo caso il Plenum si sia mosso con eccessiva prudenza. Michele: Con una prudenza che definirei colpevole. Di fatto, la politica del figlio unico non è stata abolita, ma ci si è limitati ad estendere la possibilità di avere due figli alle coppie nelle quali almeno uno dei coniugi è figlio unico. Come sapete, facevano già eccezione le minoranze etniche, le coppie rurali il cui primo figlio è una femmina, le coppie nelle quali entrambi i componenti sono figli unici. Li: La politica del figlio unico è ormai in vigore da oltre trenta anni. Quindi, con questa deroga le coppie che non possono avere due figli divengono più l’eccezione che la regola. Michele: Personalmente ritengo che l’impatto di questa misura sarà se non nullo, certamente molto modesto perché la storica preferenza dei cinesi per una famiglia numerosa è ormai tramontata e i giovani coniugi -spesso entrambi occupati a tempo pieno e sempre meno aiutati dalle rispettive famiglie- hanno ormai aderito al nuovo paradigma riproduttivo che caratterizza tutti i paesi sviluppati e quelli che si affacciano alla modernità196. Tenete presente che se per i prossimi quindici anni non c’e più modo di evitare un declino della PEL, per raggiungere tale risultato a patire dal 2030 bisognerebbe che il numero delle nascite salisse immediatamente dagli attuali 13, 14 milioni ad oltre 23 e non credo proprio che la nuova deroga alla politica del figlio unico possa produrre tale risultato. Li: C’è rimasta qualche altra politica dal lato dell’offerta? Michele: Si può facilitare il ritorno dei cinesi che vivono all’estero, ma soprattutto portare ragazzi dei paesi sottosviluppati a studiare nelle scuole e nelle università cinesi. Il primo intervento contribuirebbe a ridurre il provincialismo culturale della popolazione cinese, mentre giovani stranieri cresciuti ed educati in Cina rappresenterebbero un’ottima alternativa a immigrati che abbiano terminato il percorso formativo nei loro paesi e avrebbero quindi difficoltà ad adattarsi a un paese nuovo e alla sua lingua. In entrambi i casi non ci può però aspettare grandi numeri 197. Li: In conclusione, tu ritieni che le misure adottate dal governo cinese non solo potranno fare ben poco per ridurre il fabbisogno di lavoratori stranieri, ma che anche l’adozione di un insieme coordinato di politiche demografiche e del mercato del lavoro potrebbe forse ridurre, ma certo non eliminare il disequilibrio demografico. Michele: Hai detto bene! Bisogna tener presente che il vero problema dei paesi nell’ultima fase della transizione è quello di trovare una soluzione strutturale al disequilibrio demografico 196 Zheng Z, Cai Y, Wang F. & Gu B. (2009), “Below replacement fertilitty and childbearing intention in Jangsu provincre”, Asian Population Studies. 5(3), 329-347 197 Nel 2011 gli studenti stranieri in Cina erano quasi 300.000 a fronte dei 110.000 che si registravano nel 2004. Con il 21,3 per cento la Corea del sud dava il contributo maggiore, seguita da Stati Uniti e Giappone. E’ quindi evidente che per il momento la presenza straniera non risponde alla logica sostenuta da Michele. Sempre nel 2011 vi erano quasi 340.000 studenti cinesi all’estero. http://www.iie.org/Services/Project-Atlas/China 175 e alla conseguente carenza di forza lavoro. In assenza di tale soluzione, la popolazione locale continua a diminuire e il fabbisogno di manodopera straniera a perdurare 198. Li: Ma alla fine della favola, ce la farà la Cina a prendere la leadership mondiale! Michele: Mio caro Li, mi sembra di aver già espresso chiaramente il mio parere. Li: Sii più esplicito. Michele: Il futuro socio-economico della Cina, il suo livello di crescita economica e di sviluppo sociale, e quindi la sua capacità di assumere la leadership mondiale, dipenderanno in maniera cruciale dalla sua capacità di accogliere e integrare lavoratori stranieri, un gran numero di lavoratori stranieri. D’altra parte, credo anche che la forza del mercato sia tale che ciò avverrà, non importa quali saranno le posizioni del governo. Li: Insomma, ce la faremo. John: Se Michele ha ragione, il vostro sistema salterà, il paese si spezzerà tra zone ricche e zone povere e il sogno di un’egemonia mondiale della Cina tramonterà definitivamente. Michele: Si accettano scommesse. Comunque, la situazione della Cina non può essere discussa in isolamento e deve essere inquadrata nel contesto mondiale. Non dimenticatevi che saranno numerosi i paesi che si troveranno nelle stesse condizioni demografiche della Cina, dovranno affrontare gli stessi problemi e tutti competeranno per l’eccesso strutturale di forza lavoro presente nei paesi più poveri. John: Ce ne hai già parlato e a questo punto vorrei capire le dimensioni del fenomeno. Li: Temo che neanche il Santo Natale ci proteggerà da un pacco di statistiche. Il contesto demografico mondiale Transizione demografica e polarizzazione demografica Michele: Lasciate prima di tutto che vi ricordi alcuni dati che già conosciamo. Come conseguenza dell’inesorabile procedere della transizione demografica, la popolazione in età lavorativa (15-64) mondiale sta convergendo verso il proprio massimo storico, ma in un contesto demografico caratterizzato, da un lato, dalla presenza di un numero crescente di paesi interessati da un calo massiccio della popolazione in età lavorativa e, dall’altro, da un numero decrescente di paesi su cui incomberà una mostruosa esplosione demografica. In sostanza tra un gruppo di paesi nei quali l’offerta di lavoro diminuirà in maniera drammatica e un gruppo di paesi nei quali avverrà l’opposto. Li: A questo punto sono curioso anch’io di sapere qualcosa di più sui compagni di viaggio della Cina. Tutti insieme appassionatamente verso la terza fase della transizione Michele: Tra il 2015 e il 2020 i paesi del primo gruppo saranno 54, 37 dei quali Europei. Tra il 2050 e il 2055 i paesi in questa situazione saranno diventati la maggioranza (111 contro 90) 199. Notate che gli ingressi nel secondo gruppo di paesi saranno particolarmente numerosi 198 Le conseguenze di lungo periodo di una fertilita sotto il livello di rimpiazzo furono indicate già nel lontano 1988 in un esercizio previsivo proposto da J. Bourgeois-Pichat, “Du XX au XXI siècle: l’Europe et sa population après l’an 2000”, Population, 1, pp. 9-44. 199 Si è deciso di terminare l’analisi nel 2055 perché da tale anno le proiezioni della popolazione in età lavorativa risentono dell’ipotesi sulla convergenza della fecondità a livello di sostituzione, ipotesi che non ritengo fondata. 176 in Asia, dove il fenomeno interesserà ben 29 paesi. Di conseguenza, nel 2055 i paesi asiatici nella terza fase della transizione demografica saranno 39, come in Europa. Dei 90 paesi la cui popolazione in età lavorativa dovrebbe continuare ad aumentare, ben 50 sono in Africa; degli altri 40, 12 sono in Asia, 18 in America Latina, 9 in Oceania e solo 1 in Europa. Tavola 2 –Paesi con variazioni negative della popolazione in età lavorativa; 2015-2020 e 2050-55 Fonte: UN DESA – Word Population Prospects. The 2012 Revision Mario: Un cambiamento drammatico del panorama demografico mondiale. Michele: .. e che diventa ancora più drammatico se guardiamo i dati e in particolare i dati della popolazione in età lavorativa. Nella Tabella 3 ho riportato l’elenco dei venti paesi la cui popolazione in età lavorativa dovrebbe registrare la maggior crescita e dei venti la cui popolazione in età lavorativa dovrebbe registrare la maggior contrazione. I primi dieci paesi del primo gruppo sono tutti africani e dei secondi dieci, solo tre (Tagikistan, Kuwait e Honduras) non appartengono a questo continente. Notate anche che la popolazione in età lavorativa dell’ultimo paese di questa lista, la Costa d’Avorio, dovrebbe “solo” triplicare. Il secondo gruppo contiene invece paesi molto diversi fra loro e rispetto ai quali è difficile trovare un legame. Vi sono paesi africani, asiatici, europei e dell’America latina; paesi relativamente grandi e paesi piccoli; paesi cattolici, protestanti, mussulmani e buddisti; paesi da tempo tra i paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Ciò che li accomuna è un calo della popolazione in età lavorativa superiore al 31 per cento. Il valore massimo è quello della Mongolia che è seguita dal Bahrain, dall’Uruguay e dal Costarica, tutti paesi la cui popolazione totale dovrebbe più che dimezzarsi. Notate anche che questi dati sottostimano il fenomeno, poiché considerano la variazione tra il 2010 e il 2100 e non tra il valore massimo che molti di essi devono ancora raggiungere e la fine del secolo. Ad esempio, la Cina non è inclusa in questa tabella anche se, come abbiamo già visto, la sua popolazione in età lavorativa dovrebbe diminuire di circa il 40 per cento tra il 2030 e il 2100, anche ipotizzando un aumento della fertilità. Li: Continuo a pensare che queste proiezioni siano assurde e non riesco a capire come sia possibile che i grandi paesi del mondo non intervengano per dirlo, e quindi implicitamente le accettino, e nel contempo non facciano nulla per evitare che esse si realizzino. Mario: Forse il mondo spera che le teorie Malthusiane siano vere e che saranno fame e denutrizione, o magari qualche provvidenziale virus, a disinnescare la bomba demografica. Sarebbe meglio far sorvolare il paese da aerei che sganciassero preservativi a grappolo, che i bambini non li uccidono, ma li prevengono. 177 Tavola 3 – I primi venti paesi per crescita e contrazione demografica; scenario in assenza di migrazioni; 2010 - 2100 Fonte: Elaborazione su dati UN DESA, Word Population Prospects. The 2012 Revision Popolazione in età lavorativa e offerta di lavoro: dove cresce (troppo) e dove cala (dopo) Michele: Ma torniamo ai dati. Il modo migliore per capire cosa stia per succedere è tracciare le variazioni della popolazione in età lavorativa nei due gruppi di paesi. Nel grafico 1 sono riportati i valori medi annui: 1. Dell’incremento della popolazione in età lavorativa nel primo gruppo di paesi (area blu); 2. Del calo della popolazione in età lavorativa nel secondo gruppo di paesi (area rossa); 200 3. Del saldo tra variazioni positive e negative che corrisponde alla variazione assoluta della popolazione mondiale in età lavorativa (barre verdi). Grafico 1 – Popolazione in età lavorativa; saldi positivi, saldi negativi e saldi totali; 2015-2055 Fonte: Elaborazione su dati UN DESA Word Population Prospects. The 2012 Revision 200 In entrambi i gruppi, il numero di paesi cambia progressivamente a seguito del passaggio di alcuni di essi dal primo al secondo gruppo. 178 John: Quindi, tra il 2015 e il 2020, la popolazione mondiale in età lavorativa dovrebbe aumentare in media ogni anno di 45 milioni, come differenza tra una crescita di 52 milioni nei paesi in espansione demografica e un calo di 7 nei paesi in contrazione demografica. Dopo quaranta anni, la crescita si dovrebbe ridurre, come abbiamo già visto, a 13 milioni a causa del calo dei saldi positivi (a 34 milioni) e dell’aumento del valore assoluto dei saldi negativi (a 21 milioni). Michele: Guardate adesso la distribuzione dei saldi positivi e dei saldi negativi per continente e la loro evoluzione in questa prima metà del secolo. Tra il 2015 e il 2020 la crescita della popolazione mondiale in età lavorativa dovrebbe essere concentrata in Asia (53,7 per cent) e in Africa (35,4 per cent), mentre l’America latina dovrebbe contribuire con il 10,6 per cento. Tra il 2050 e il 2055 la quota dell’Africa dovrebbe salire all’86,7 per cento e quella dell’Asia scendere al 10,9 per cento, con l’America latina all’1,9 per cento. Venendo ai saldi negativi, nel 2015-20 l’Europa dovrebbe dare un contributo maggioritario (53.4 per cento), seguita dall’Asia (41,2 per cento) e al terzo posto dai paesi del nuovo mondo, (Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda). Tra il 2050 e il 2055 la situazione è totalmente cambiata. L’Asia è ora di gran lunga al primo posto con un peso del 75,7 per cento (la Cina da sola rappresenta il 55,9 per cento), seguita dall’Europa il cui peso si dovrebbe ridurre al 15,1 per cento e dall’America Latina con il 5,8 per cento. I paesi del Nuovo Mondo dovrebbero dare un contributo marginale (2,6 per cento). Tavola 4 – Saldi postivi e negativi; distribuzione per continente; 2015-20 e 2050-55 Fonte: Elaborazione su dati UN DESA Word Population Prospects. The 2012 Revision I saldi migratori internazionali: previsioni a confronto Michele: Notate che, in assenza di flussi migratori, all’inizio del periodo il mantenimento del tasso di occupazione imporrebbe al primo gruppo di paesi la creazione ogni anno di circa 30 milioni di posti di lavoro, che sarebbero scesi a circa venti alla fine. Di contro i secondi dovrebbero distruggerne 4 all’inizio e 12 alla fine. Incrociando le informazioni del grafico con quelle della tavola è evidente che la stragrande maggioranza dei posti di lavoro aggiuntivi dovrebbe essere creata in Africa e negli altri paesi più poveri, mentre la riduzione dell’occupazione dovrebbe concentrarsi in Europa e in alcuni paesi asiatici. Mario: Credo che non serva essere demografi o economisti raffinati per capire che un tale disequilibrio demografico non potrà che generare flussi migratori di dimensioni senza precedenti storici e questo sia che si creda in una tesi da domanda, sia che si creda in una tesi da offerta. Michele: Spiacente di deluderti, almeno per quanto riguarda i demografi. Ti ricordo che, secondo la Population Division, nei quaranta anni considerati i flussi migratori non solo dovrebbero ammontare ad appena 90 milioni, vale a dire meno di quelli registrati negli ultimi quaranta anni, ma i valori medi annui dovrebbero progressivamente diminuire. E infine, come 179 vi ricorderete, secondo questi dotti demografi non vi dovrebbe essere quasi nessuna relazione tra andamento demografico e saldi migratori. John: Il tuo modello porta ovviamente a conclusioni completamente diverse. Michele: Certo. La mia impostazione porta a visualizzare un futuro demografico antitetico a quello proposto dalle proiezioni della Population Division. La prima differenza fondamentale è che i flussi migratori internazionali non tenderanno a scomparire per lasciare posto solo a flussi turistici, ma aumenteranno progressivamente tanto da divenire la caratteristica principale del secolo in cui stiamo vivendo. Se guardiamo al problema nel suo complesso, la somma dei saldi negativi registrati dai singoli paesi tra il 2015 e il 2055 dovrebbe essere di quasi 500 milioni. Questo sarebbe dunque il saldo migratorio necessario per mantenere inalterata la popolazione in età lavorativa al valore iniziale. Tuttavia, come abbiamo già visto, questo valore sottostimerebbe il saldo migratorio per almeno due ragioni che vale la pena ricordare. Un’immigrazione che mantenga inalterata la Popolazione in età lavorativa può non essere sufficiente per fronteggiare un aumento dell’occupazione, come possiamo attenderci che avvenga in numerosi paesi di questo gruppo. Ve ne potranno poi essere altri che, pur non essendo inclusi nel gruppo di paesi nella terza fase della transizione e che registreranno quindi un’espansione della popolazione in età lavorativa, avranno bisogno d’immigrati a causa di aumenti dell’occupazione maggiori di quelli della popolazione in età lavorativa. E’ quanto si è verificato negli ultimi dieci anni nei paesi del golfo e che potrebbe ripetersi anche in futuro in questi o altri paesi a causa delle segmentazioni educative, occupazionali e di genere che caratterizzano sia la domanda, sia l’offerta di lavoro. A titolo puramente indicativo possiamo pertanto ipotizzare, anche sulla base di precedente analisi, che il numero d’immigrati sia pari a una volta e mezzo il calo della popolazione in età lavorativa. Il grafico riassume che cosa succederebbe in questo scenario nei prossimi quaranta anni. Li: Il solito grafico facile, facile. Grafico 2 - Saldo migratorio totale e dei principali continenti di sbocco; valori medi annui in milioni Fonte: Elaborazione su dati UN DESA – Word Population Prospects. The 2012 Revision. Michele: Gli istogrammi misurano il valore medio annuo dei flussi migratori globali, mentre le linee descrivono l‘andamento degli arrivi in Asia ed Europa, nonché il dato residuale relativo ai paesi del nuovo mondo e ad alcuni piccoli stati soprattutto dell’America 180 latina e caraibica 201. Nel primo quinquennio (2015-20) il saldo migratorio medio annuo dovrebbe essere di circa 10 milioni, un valore che è comunque il doppio di quello del periodo 2000-2010. In questo periodo gli arrivi dovrebbero essere divisi quasi equamente tra Asia ed Europa, con una leggera prevalenza di quest’ultima. Il numero dei migranti dovrebbe poi progressivamente aumentare fino al 2040, tirato dalla rapida progressione del dato asiatico, mentre quello europeo dovrebbe rimanere sostanzialmente costante. Dopo una breve fase di declino, il numero medio annuo dei migranti dovrebbe salire oltre i 30 milioni, ancora una volta sotto l’impulso dell’Asia e, in particolare, della Cina. John: Insomma, tu confermi le stime che ci avevi fornito l’altra volta di oltre 700 milioni di immigrati nei prossimi quarant’anni e che ovviamente crescerebbero oltre il miliardo prima della fine del secolo. Michele: E questo determina la seconda differenza fondamentale rispetto alle proiezioni delle Nazioni Unite. Nella mia impostazione i paesi caratterizzati da un calo naturale della popolazione in età lavorativa sarebbero interessati da saldi migratori più che compensativi e vedrebbero quindi aumentare tutti i segmenti della popolazione, come abbiamo già visto, analizzando gli scenari per la Cina . John: A dire la verità, non so se essere più scettico sulle proiezioni delle Nazioni Unite o sui tuoi scenari migratori. Comunque, anche tu prospetti un disastro planetario. Michele: Al contrario, se si facessero le cose giuste, nel modo giusto, al momento giusto questa situazione potrebbe rappresentare una grande opportunità. John: Non scherziamo, una grande opportunità per chi? Le migrazione internazionali: calamità o opportunità? Michele: Per i paesi ricchi; in quanto consentirebbe loro di continuare a crescere; per i pesi più poveri; in quanto contribuirebbe a innescare un processo di sviluppo e a levare milioni di persone da livelli di povertà persino difficili da immaginare. Le migrazioni attutirebbero il divario socioeconomico tra paesi ricchi e paesi poveri, anche frenando una crescita demografica insensata; promuoverebbero il progressivo avvicinamento a un mondo nel quale la popolazione del pianeta avrà tutte le possibili sfumature di colore, levando cosi al razzismo una delle sue ragioni di base; favorirebbero un più rapido, anche se più morbido ingresso in una fase storica in cui la popolazione in età lavorativa prima, e la popolazione totale poi, inizieranno a diminuire, ponendo così le premesse per una consistente riduzione dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili. John: Ma come fai a pensare che quattrocento milioni d’immigrati in Cina e altrettanti nei paesi con carenza di offerta possano essere una cosa positiva? Continuo a pensare che le conseguenze d’immigrazioni di massa come quelle che tu ipotizzi sarebbero devastanti. Michele: Sarebbe sciocco pensare che flussi migratori di questa portata non genererebbero seri problemi nei paesi d’arrivo. Tuttavia, le loro caratteristiche e dimensioni dipenderanno dal modo in cui il problema sarà gestito. Sono convinto che essi porterebbero anche una serie di vantaggi e che il saldo finale sarebbe positivo. 201 Il caso piu rilevante dei paesi caraibici è Cuba la cui popolazione in età lavorativa dovrebbe diminuire di quasi 2,5 milioni nei prossimi 40 anni. 181 LI: Michele, anch’io sono molto scettico. Basta guardarsi attorno per vedere che i flussi migratori sono accompagnati da drammi di tutti i generi. Michele: .. ma che sono però dovuti soprattutto alle politiche di tipo poliziesco adottate dai paesi d’arrivo e che, a loro volta, sono la conseguenza del radicato, ma non per questo meno errato, convincimento che i flussi migratori siano generati dal lato dell’offerta. Le cose cambierebbero radicalmente se si arrivasse a comprendere non solo con la mente, ma anche con la pancia che gli immigrati vengono nei nostri paesi per rispondere ai fabbisogni del nostro mercato del lavoro, che se non servissero non verrebbero e comunque non rimarrebbero. La prova controfattuale è che gli immigrati non vanno nei paesi che non hanno bisogno di manodopera straniera. Mario: Va bene, ma consideriamo con più attenzione le tue considerazioni. Nella tua ottica, il primo e fondamentale contributo dei flussi migratori -e quello che giustifica tutta la tua analisi- è che gli immigrati non sono un optional, ma rappresentano l’unica possibilità per i paesi nella terza fase della transizione demografica di continuare a crescere. Michele: Certo, questo è il pilastro su cui poggiano tutte le considerazioni successive e credo di aver mostrato che si tratta di una tesi del tutto giustificata sia dalle evidenze storiche, sia da quelle empiriche. Per avere un quadro completo dell’impatto delle migrazioni sulla situazione economica e sociale dei paesi di arrivo dobbiamo considerare altri aspetti dei flussi migratori ai quali abbiamo già accennato nel corso delle nostre chiacchierate e che adesso possiamo riassumere. Gli immigrati sono in media più giovani della popolazione dei paesi di arrivo e quindi rallentano il processo d’invecchiamento nel senso che frenano l’aumento della percentuale degli anziani. Vengono da paesi a più alta fecondità ed è possibile che, almeno per un certo periodo, producano più bambini della popolazione locale. La giovane età e una maggiore propensione al rischio, senza la quale essi non farebbero parte di quella minoranza che ha deciso di lasciare il proprio paese, ne porta una parte rilevante a divenire imprenditore. Infine, gli immigrati contribuiscono a rendere una società più cosmopolita e più aperta al mondo. John: Quindi, secondo te gli immigrati sarebbero il toccasana per quasi tutti i problemi delle nostre società. Forniscono ai paesi più sviluppati la manodopera necessaria per continuare lungo un sentiero di crescita economica, riducono l’invecchiamento, conducono il paese d’arrivo verso una situazione di equilibrio demografico di tipo naturale, aumentano il tasso d’imprenditorialità, rendono una società aperta al mondo e, suppongo, aiutino anche a superare i pregiudizi razziali. Non ti sembra eccessivo? Michele: No, credo che sia realistico. Anche se è evidente che coloro la cui sopravvivenza politica dipende in buona parte dal fornire una visione negativa dei flussi migratori insisteranno nella loro posizione, indipendentemente da tutte le prove fornite. Li: Come ha detto l’antico saggio cinese: non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere! Michele: D’altra parte l’alternativa, ammesso che sia praticabile, cosa di cui non sono affatto convinto, è quella di società che invecchiano inesorabilmente e imboccano una spirale di declino demografico, che si rinchiudono in abitudini prive della dinamica che solo il rinnovo generazionale può dare -e che quindi cessano di essere cultura per divenire un monumento alla memoria del tempo che fu- che perdono contatto con il mondo esterno, che imboccano la via della stagnazione se non addirittura della crisi economica. 182 Mario: Comunque, ho l’impressione che una migrazione delle dimensioni che tu indichi avrebbe effetti ancora più rilevanti sui paesi di partenza. Michele: Questo è forse il punto più interessante. Tra il 2015 e il 2055, in assenza di flussi migratori, la popolazione in età lavorativa dei paesi ancora in espansione demografica aumenterebbe di 1,7 miliardi, mentre quella dei paesi in contrazione diminuirebbe di 500 milioni. Se vi fossero 700 milioni di migranti, l’aumento della popolazione in età lavorativa del primo gruppo scenderebbe di gran lunga sotto il miliardo perché le migrazioni ridurrebbero il numero delle donne in età fertile e, molto probabilmente, anche la fecondità. Così, a occhio e croce, potremmo ipotizzare che la crescita della popolazione in età lavorativa dei paesi in espansione demografica sarà solo di 800 milioni. Quindi il fabbisogno di posti aggiuntivi, necessario per mantenere inalterato il tasso di occupazione si dimezzerebbe, scendendo attorno al mezzo miliardo. Si tratta sempre di un valore molto alto, ma non irraggiungibile, anche perché una migrazione così massiccia porterebbe certamente a una notevole quantità di rimesse che, se opportunamente gestite, potrebbero dare un contributo rilevante alla crescita economica e dell’occupazione. A sua volta, la crescita economica aumenterebbe il livello di benessere il che comporterebbe un aumento del livello di scolarità della componente femminile e accelererebbe ulteriormente il declino della fertilità. Senza dimenticare che la crescita economica dei paesi poveri comporterebbe la comparsa di nuovi mercati per i prodotti dei paesi più sviluppati. Il grafico riassume le cose che ho appena detto. Il Fondo Migrazione Educazione John: Aspetta, cos’è quel cerchio giallo in mezzo alla Figura con la scritta “Fondo Migrazione Educazione”. Michele: Se fosse qualcosa su cui scherzare, direi la ciliegina sulla torta. La tesi da offerta sostiene che i migranti con un basso livello educativo e privi di competenze sono persone che fuggono dalla miseria, mentre quelli con un alto livello educativo e competenze professionali elevate sono persone in cerca di un reddito più elevato e di una vita migliore. La tesi da domanda ci porta invece alla conclusione che un numero crescente di paesi non riesce a produrre internamente le risorse umane di cui ha bisogno per portare avanti ed eventualmente 183 accrescere la propria produzione. Si trovano quindi nella necessità di acquisire tali risorse da altri paesi così come numerosi paesi devono acquisire all’estero beni capitale necessari per la produzione. La differenza è che mentre le macchine vengono pagate, gli immigranti portano in dono i corpi e le competenze necessarie al processo produttivo. John: Stai suggerendo che i paesi di arrivo dovrebbero pagare per gli immigrati? Non ti basta che debbano pattugliare i mari per salvare le vite di migranti e rifugiati, sopportare i costi di accoglienza e gestire i difficile problemi dei loro inserimento sociale e economico? Michele: John, la conseguenza della tesi da domanda è che l’arrivo d’immigranti risponde al bisogno dei paesi di arrivo e quindi porta all’acquisizione gratuita di fattori di produzione indispensabili per mantenere o accrescere il livello produttivo. A questo punto è semplicemente giusto che i paesi d’arrivo rimborsino i paesi di partenza almeno dei costi di “produzione” che hanno dovuto sostenere. John: Ma scusa se gli immigrati lavorano vengono retribuiti. Michele: Il salario è la retribuzione per il lavoro svolto, necessario per la manutenzione ordinaria dei lavoratori e che permette loro di riprodursi. Il salario corrisponde alle spese che le imprese sostengono per assicurare il funzionamento delle macchine come energia e manutenzione. Qui stiamo parlando dell’investimento affrontato dal paese di partenza e che viene vanificato dall’emigrazione. Li: Puoi spiegarti meglio. Michele: Supponiamo che vi siano due paesi. Nel primo le nascite sono sufficienti per fornire la forza lavoro di cui il paese ha bisogno. Il paese deve ovviamente sostenere una parte dei costi, fissi e variabili, per l’educazione e la formazione. Questi costi si trasferiscono in parte sulle imprese tramite l’imposizione fiscale e quindi sui costi di produzione. Il secondo paese importa tutta la manodopera da altri paesi e quindi le sue imprese hanno minori costi e godono così di un vantaggio competitivo nei confronti dell’altro paese. John: OK; supponiamo che tu abbia ragione. In primo luogo si dovrebbe fare una valutazione di quanto valga ogni immigrato e poi di come gestire e utilizzare i fondi. Michele: Si tratta ovviamente di un processo molto complesso i cui passaggi principali dovrebbero essere la definizione del “valore” degli immigrati, e quindi dell’ammontare di denaro che ogni paese dovrebbe versare, la riscossione del denaro, la definizione insieme ai governi dei paesi di partenza dei processi educativi e formativi più idonei per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del paese, l’attivazione dei progetti, il loro monitoraggio e la loro valutazione. I fondi potrebbero poi essere usati per costruire nuove scuole e migliorare le condizioni igienico-sanitarie di quelle esistenti, assumere nuovi insegnanti e migliorarne le retribuzioni così da attrarre in questo settore nevralgico persone capaci e dedicate, dare uguali opportunità agli abitanti delle zone rurali, promuovere l’uguaglianza di genere. Mario: Come si fa a stabilire il valore di un immigrato? Michele: Beh si potrebbe semplicemente far versare il denaro necessario per educare in maniera analoga un'altra persona. Mario: Sarebbe un po’ come decidere che chi utilizza il legname di alberi cresciuti in altri paesi consegnasse a un ente per la riforestazione il denaro necessario per far crescere un numero uguale di alberi e l’ente s’impegnasse, insieme al paese di partenza a realizzare 184 questo obiettivo. In questo modo il paese di partenza risulterebbe depauperato delle risorse arboree solo temporaneamente. Senti come ti è venuta questa idea? Michele: In primo luogo c’è un problema di equità e la necessità di garantire il rispetto delle regole della concorrenza. Ma il punto fondamentale è un altro. I paesi sottosviluppati non riescono a innescare percorsi di crescita e di sviluppo anche perché le loro risorse vanno soprattutto a rimborsare i paesi ricchi e gli organismi internazionali dei prestiti ricevuti e dei relativi interessi. Il fondo Migrazione Educazione potrebbe ridurre i prestiti dei paesi ricchi ai paesi poveri e i corrispondenti interessi, consentire loro di costruire una forza lavoro più preparata, indispensabile non solo per spostare la produzione su cluster a più elevata tecnologia, ma anche per attrarre capitali stranieri. Mario: Mi sembra che una proposta analoga sia già stata avanzata, ma non si sia mai riusciti a metterla in pratica. Michele: Forse ti riferisci alla così detta Bagwati tax che fu sul punto di fruttare all’economista indiano che la propose negli anni 70 il premio Nobel, ma che, contrariamente alla mia proposta, affonda le proprie radici in una spiegazione dei flussi migratori dal lato dell’offerta. Bhagwati partiva, infatti, dall’idea che paesi come l’India registrano l’emigrazione di professionisti che “abbandonano” il loro paese per recarsi in altri paesi, attratti dalla possibilità di guadagni più elevati. Propose quindi che i paesi di partenza potessero tassare il reddito di questi professionisti che lavoravano all’estero, un’emigrazione di élite che oggi è numericamente del tutto marginale 202. Mario: Forse hai ragione, ma mi sembra veramente difficile che le tue proposte possano essere accettate; John: E chi farebbe tutto questo? Michele: Credo che si dovrebbe creare un organismo internazionale, una Organizzazione Mondiale delle Migrazioni (l’OMM), come è stato suggerito recentemente anche da Livi Bacci, sia pure per motivi diversi. 203 Mario: Cioè? Michele: Lasciatemi chiarire una cosa. Ho dedicato buona parte delle precedenti chiacchierate a sostenere che la causa dominante dei flussi migratori è la carenza strutturale di offerta di lavoro che caratterizza alcuni paesi, in presenza di una offerta illimitata in altre aree del mondo. Sono convinto che questa sia la prospettiva che consente di spiegare e prevedere gli aspetti fondamentali del fenomeno migratorio, la direzione e la consistenza dei flussi. Questo non significa che non sia consapevole dell’enorme complessità che caratterizza il fenomeno migratorio, “per il modo in cui i flussi si incontrano, si accavallano e si respingono in un mutevole movimento”, per gli interessi che coinvolgono sia nei paesi di partenza sia nei paesi di arrivo, per l’enorme diversità delle politiche migratorie esistenti, per il fatto che il mondo è “senza regole che contemperino e garantiscano i diritti e gli interessi delle parti in causa” 204. E’ partendo dalla constatazione di questa situazione che Livi Bacci ha proposto di 202 Bhagwati J. N., Dellafar (1973), “The Brain Drain and Income Taxation”, World Development, 1; Bhagwati J. N., Hamada K. (1974) “The Brain Drain International Integration of Markets for Professionals and Unemployment: A Theoretical Analysis”, Journal of Development Economics, 1, 19-24. 203 Massimo Livi Bacci (2012), Migrazioni. Vademecum di un Riformista, Associazione Neodemos, http://www.neodemos.it/doc_eventi/Vademecum_Migrazione.pdf 204 “Anzitutto quelli del protagonista più debole, il migrante, stretto tra le regole imposte dal paese di partenza e quelle proprie del paese di arrivo. Poi quelli delle società di origine che perdono risorse umane che depauperano le comunità, i gruppi, le famiglie. Infine i paesi di arrivo che accolgono migranti per sostenere il proprio equilibrio 185 dare vita a un organismo internazionale (l’Organizzazione Mondiale delle Migrazioni) che desse ordine alle migrazioni. Mario: Facendo cosa? Michele: Livi Bacci propone che questa Agenzia acquisisca progressivamente tre funzioni: funzioni di studio (analisi, informazione, formazione e raccordo); funzioni di più diretta rilevanza per le politiche migratorie; infine funzioni di coordinamento, orientamento, garanzia e governo dei flussi. John: E quello che vorreste anche tu? Michele: Senza negare la rilevanza di queste funzioni io proporrei altre priorità. L’Agenzia dovrebbe sì occuparsi di approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio, ma nella mia ottica questo implica sviluppare e mettere in essere metodologie per valutare il fabbisogno di manodopera dei paesi che ne hanno una carenza strutturale su orizzonti temporali intermedi (10, 15 anni) e, possibilmente, per livelli educativi e principali profili professionali. Allo stesso tempo l’OMM dovrebbe mappare l’eccesso di offerta. Dovrebbe poi coordinare il matching della domanda e dell’offerta di lavoro a livello internazionale occupandosi di gestire direttamente o indirettamente tutti gli aspetti connessi: formazione, trasporto degli emigrati, pratiche per l’avviamento al lavoro. Questa stessa Organizzazione dovrebbe poi essere incaricata di gestire il Fondo Migrazione Educazione con le modalità che ho indicato in precedenza . Mario: Mi sembra molto difficile che questa proposta possa avere un futuro. Iniziative ben più solide e sollecitate da persone ben più influenti di te sono già fallite. Ad esempio la Global Commisison on Migration and Development, creata da Kofi Annan nel 2003, ha concluso i propri lavori con una proposta non solo molto più modesta (una commissione di semplice coordinamento), ma che è rimasta lettera morta. Da idea a progetto: ci vorrebbe un miracolo Michele: Sono d’accordo con te. Dovrei sperare che le mie previsioni non attraessero solo l’attenzione delle Agenzie internazionali di collocamento, ma che le loro implicazioni economiche e sociali, ma soprattutto politiche venissero prese in considerazione o per lo meno riuscissero a spaventare i policy maker sia dei paesi di arrivo sia dei paesi di partenza. A dire la verità, l’ipotesi più probabile è che le mie tesi non incontrino ne il favore del mondo accademico, ne quello dei funzionari di organismi internazionali, ne tantomeno dei politici (nessuno dei quali ha un particolare interesse a corree dei rischi lasciando la strada vecchia per la nuova) e vengano semplicemente ignorate. 205 John: E allora? Hai qualche idea di come trasformare questa proposta in un progetto? Ci vorrebbe un miracolo. Michele: Hai ragione. Forse basterebbe trovare lo sponsor giusto. Qualcuno che creda come me che i flussi migratori possono costituire uno strumento fondamentale ''per contribuire alla costruzione di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese sociale ed economico esprimono potenti interessi che non sempre coincidono con quelli dei propri cittadini e che spesso confliggono con quelli dei migranti e dei paesi di origine” Ibidem p. 12. 205 A quanto mi risulta, gli articoli pubblicati da Michele non hanno fino ad ora ricevuto ne commenti positivi ne commenti negativi, ma sono stati semplicemente ignorati, come le tendenze demografiche in atto e l’incapacità degi organi preposti di prevederle. 186 più solidale, un mondo più fraterno” e che abbia la statura intellettuale e l’autorevolezza morale per convincere il mondo a discutere queste idee e a fare i passi necessari per attuarle. Mario: Non stari mica pensando a .. Michele: Certo. E’ il solo uomo che potrebbe portare avanti idee come queste e poi è uno che ha familiarità con i miracoli. Mario: Cosa fai, mi cambi bandiera? Michele: Le convergenze tra il mondo religioso e la sinistra laica in tema di migrazioni non sono nuove; il problema è che le armi usate da entrambi sono spuntate. Non basta sostenere che “è necessario un cambio di atteggiamento verso i migranti e rifugiati da parte di tutti; il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di emarginazione - che, alla fine, corrisponde proprio alla “cultura dello scarto” - ad un atteggiamento che abbia alla base la “cultura dell'incontro”, l'unica capace di costruire un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore.” Ne è sufficiente battersi per pari dignità e uguali diritti di tutte le persone del mondo. C’è bisogno di una proposta operativa che poggi su di una base teorica convincente, che coniughi i bisogni dei paesi ricchi e dei paesi poveri, che aiuti entrambi a muoversi verso un equilibrio demografico naturale con cui affrontare il momento in cui la popolazione mondiale comincerà a diminuire e bisognerà imparare a guidare l’economia in discesa. Mario: Come pensi di fare a coinvolgerlo? Michele: Sono convinto che se potessimo farci una chiacchierata, magari davanti a un piatto di tortelloni burro e oro ci capiremmo. Tutti ebbero l’impressione che nella mangiatoia il bue e l’asinello ammiccassero divertiti. 187 Bibliography Stanley H. Ambrose (1998), “Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic winter, and differentiation of modern humans”, Journal of Human Evolution, 34 (6), 623– 651 Gregory Bateson (1972), Steps to an Ecology of Mind, Chandler Publishing Company Gregory Bateson (1979), Mind and Nature – A necessary Unity. J. N Bhagwati., Dellafar (1973), “The Brain Drain and Income Taxation”, World Development, 1 J. N., Bhagwati Hamada K. (1974) “The Brain Drain International Integration of Markets for Professionals and Unemployment: A Theoretical Analysis”, Journal of Development Economics, 1, 19-24 Gary Becker (1964, 1993, 3rd ed.), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Chicago, University of Chicago Press. Jasper Becker (1998), Hungry Ghosts: Mao’s Secret Famine, An Owl Book, Henry Holt and Company, New York. J.P. Bocquet-Appel (2002,) “Paleoanthropological Traces of Neolithic Demographic Transition“, Current Anthropology, 43 Michele Bruni (2014), “Dwindling labour supply in China: Scenarios for 2010-2060”. In Attané Isabelle, Gu Baochang, Analyzing China’s Population, INED Population Studies, n.3, Springer, forthcoming. Michele Bruni (2012a), Migration and demographic projections: A new methodology to jointly build labor market and demographic scenarios”, Genus, Vol. 68, n. 3 pp. 1-26. Bruni Michele (2012b), Labor market and demographic scenarios for ASEAN countries (2010-35) Education, skill development, manpower needs, migration flows and economic growth, DEMB Working Paper Series, N. 6. Michele Bruni (2011), “China’s new demographic challenge: From unlimited supply of labour to structural lack of labour supply. Labour market and demographic scenarios: 2008– 2048,” Department of Political Economy, University of Modena and Reggio Working Paper No. 643, www.dep.unimore.it/materiali_discussione/ 0643.pdf. Michele Bruni, (2009), “The century of the great migration. Demographic forecast, migration and transition theory: A labor market perspective”, Papeles de Poblacion, Vol. 15. N. 62, pp. 9-73 Michele Bruni (2008), “Il boom demografico prossimo venturo. Tendenze demografiche, mercato del lavoro ed immigrazione: scenari e politiche”, Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio, Materiali di Discussione; n. 607; www.dep.unimore.it/materiali_discussione/0607.pdf Michele Bruni (1993), "Per una economia delle fasi della vita", in Associazione Italiana di Statistica, Popolazione, tendenze demografiche e mercato del lavoro, Roma Michele Bruni (1988), “A stock flow model to analyse and forecast labour market variables”, Labour, n. 1. Michele Bruni e Dario Ceccarelli (1995), “I mercati locali del lavoro: un modello per l’analisi congiunturale”, Franco Angeli, Milano. M. Bruni e F.B. Franciosi (1985), "Scenari alternativi di domanda e di offerta di lavoro: un'analisi in termini di flusso", in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, La politica occupazionale per il prossimo decennio, Roma, 1985. 188 Michele Bruni e Franco B. Franciosi (1985), "Il mercato del lavoro in Italia: un'analisi di flusso", in M. Schenkel, (a cura di.), L'offerta di lavoro in Italia. Problemi di rilevazione, valutazione, costruzione, di modelli di comportamento, Marsilio, Venezia. Bruni Michele e Franco B. Franciosi, 1979, “Domanda di lavoro e tassi di attività”, Rivista Trimestrale di Economia, Istruzione, e Formazione Professionale, n. 6. Bruni Michele e Claudio Tabacchi (2011), “Present and future of the Chinese labour market. Dualism, migration and demographic transition,” Department of Political Economy, University of Modena and Reggio, Working paper No. 647, www.dep.unimore.it/materiali_discussione/ 0647.pdf. Cai Fang (2008), ”Lewis turning point: “A coming new stage of China’s economic development”, Social Sciences Academic Press. Cai Fang (2008), ”Approaching a triumphal span: How far is China towards its Lewisian turning point?” Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU), No. 2008/09 Cai Fang (2006), “How to deal with the future labour shortage?” China Daily, marzo Cai Fang and Wang Dewen, (2005), “Demographic transition: implications for growth”, Institute of Population and Labor Economics, CASS, Working Paper Series No.47 Cai Fang, Yang Du, Meyan Wang (2009), “Employment and inequality outcomes in China”, Institute of Population and Labour Economics, Chinese Academy of Social Sciences. Caldwell J.C. (1992), Theory of Fertility Decline, Academic Press, New York Carlos Castaneda, 1968, The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge. Chesnais Jean Claude (1986), La transition demographique. Etapes, forms, implications economiques, PUF, Parigi Coale Ansley J. (1986), “Demographic effects of below-replacement fertility and their social implications in Kingley Davis e altri, Below Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies, Population and Development Review to Vol. 12, New York, Population Council, Supplement CNR e IRP (1988), Secondo Rapporto sulla situazione demografica in Italia. D.A. Coleman (2002), “Replacement Migration, or why everyone is going to have to live in Korea: a fable for our times from the United Nations”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 357. L. Iunius Moderatus Columella, c.55 a.C, De Re Rustica, Liber Sextus Debreu Gerard e Kenneth Arrow (1954): “Exixtence of a competitive equilibrium for a competitive economy” Debreu Gerard (1959), Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Diamond Jarred (1997), Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, W.W. Norton & Company Felsenthal, Mark (September 13, 2007). "Greenspan says didn't see subprime storm brewing". Reuters. Fitzpatrick Laura (2009), “China’s one child policy”, Time, 27 luglio, http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1912861,00.html William Fogel e Stanley Engerman (1995), Time on the Cross; The Economics of American Negro Slavery, W,W. Norton. 189 Benjamin M. Friedman (2005), The moral consequences of Economic Growth, New York: Alfred A. Knopf, 2005, 570 pp. Anne Genereux (2007), “A review of migration and fertility theory through the lens of African immigrant fertility in France”, MPIDR, Working paper WP 2007-2008. Goldberg, T.L. (1996), Genetics and biogeography of East African chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii), Harvard University, unpublished PhD Thesis Greenhalgh Susan (2008), Just One Child: Science and Policy in Deng’s China, Berkeley, UC Press Gu Baochang, and Wang Feng (2009), “An Experiment of Eight Million People: Reports from Areas with Two-child Policy”, Beijing, China Social Sciences Academic Press Gu Baochang and Yong Cai (2011), “Fertility Prospects In China”, UN DESA Population Division, Expert Paper, No. 2011.4. Guo Zhigang e Gu Baochang “China’s Low Fertility: Evidence from the 2010 Census”, Springer. Harris, Sheldon H. (1994), Factories of Death: Japanese Biological Warfare 1932-45 and the American Cover-Up, Routledge,. ISBN 0-415-09105-5 ISBN 0-415-93214-9 Haub, Carl (November/December 2002). "How Many People Have Ever Lived on Earth?". Helliwell John, Richard Layard and Jeffrey Sachs (a cura di) (2010), World Happiness Report. Keith Hopkins (1981), Conquerors and Slaves, Cambridge University Press. Jackes Mary and Chris Meiklejohn (), “Building a method for the study of the mesolithic – neolithic transition in Portugal”. Documenta Praehistorica, XXXI. Internet World Stats - Usage and population statistics, http://www.internetworldstats.com/stats.htm IRP (1994), Tendenze demografiche e politiche per la popolazione. Terzo rapporto IRP, Il Mulino. Isfol (1984), Manuale delle Professioni, Roma Istat, (1997), Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione: Base 1.1.1996, Informazioni, N. 34; Istat (2001), Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione dal 1.1.2001 al 1.1.2051; Istat (2006), Previsioni demografiche nazionali, 1 gennaio2005 – 1 gennaio 2050, Nota Informativa, 22 marzo; Istat (2009), Previsioni demografiche 1 gennaio 2007-2051 Lister Joseph (1867), Antiseptic principles for the practice of Surgery Massimo Livi Bacci (2012), Migrazioni. Vademecum di un Riformista, Associazione Neodemos, http://www.neodemos.it/doc_eventi/Vademecum_Migrazione.pdf Massimo Livi Bacci (2006), Conquista. La distruzione degli indios americani, Il Mulino. Massimo. Livi Bacci (2002), Storia Minima della Popolazione, Il Mulino Kennedy Paul (1987), Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000, Random House 190 Kingsley Davis (1986), “Below Replacement fertility in Industrial Societies. Causes, consequences, policies”; Population and development Review; A Supplement to Volume 12, Cambridge University, Cambridge Thomas Kuhn (1962), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University Press Kurzweil Ray and Terry Grossman (2004), Fantastic Voyage. Live Long Enough to Live Forever, Plume Lewis A.W. (1954), “Economic development with Unlimited supplies of labor”, The Manchester School of Economics and Social Studies, n. 22, pagg. 139-191. Litwak, Robert S. (4/5/2010), From “Rogues” http://www.theglobalist.com/storyid.aspx?StoryId=8438 to “Outliers”, the Globalist, Maddison Angus and Harry X. Wu (2008), “Measuring China Economic Performance”, World Economics, Vol. 9, n. 2, Aprile Giugno, 2008. Malthus … Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società Martin Jacques (2009), When China rules the World. The end of the Western World and the Birth of a New Global Order, Penguin books McCoy Alfred W., “The Decline and Fall of the American Empire. Four Scenarios for the End of the American Century by 2025” McNicoll G. (2000), “Reflection on replacement migration”, Place and People. Vol. 8, n. 4 Mithen, S. J. (1996), The Prehistory of the Mind, a search for the origins of art, religion, and science, London, Thames and Hudson. Morris Ian, (2010), Why the west rules – for now, Profile Books. Jacob Mincer (1958),“Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”, Journal of Political Economy Isfol, 1984, Manuale delle Professioni, Nye Joseph S. (2010, The Future of Power, Public affairs, New York. Primack J.R e N.E. Abrams, 2006, The View from the Center of the Universe. Discovering our extraordinary Place in the Cosmos, Riverhead Books, New York Rose Hilary e Steven Rose, 2013, Geni Cellule e Cervelli. Speranze e Delusioni della Nuova Biologia, Le Scienze. I. Sobel and C Wilcock (1956), "Secondary labor force mobility in four midwestern shoe towns", Industrial and Labor Relations Review Steinbeck John (1939), The Grapes of Wrath Stiglitz Joseph (2011), “The Failure of Macroeconomics in America”, China & World Economy, pp. 17 – 30, Vol. 19, No. 5. Steiper, M.E. (2006). "Population history, biogeography, and taxonomy of orangutans (Genus: Pongo) based on a population genetic meta-analysis of multiple loci", Journal of Human Evolution (50): 509–522. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean_Paul Fitoussi (2010,) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social progress. Sun Tzu (2003), L’arte della Guerra, Mondadori George Tapinos (2001), “The role of migration in moderating the effect of population ageing, Migratio, 2. 191 Thompson Warren (1929), ”Population”, American Journal of Sociology, 34 (6), pp. 959975 Thompson, Warren S., and P. K. Whelpton (1943), Estimates of Future Population of the United States, 1940-2000, Washington, D.C. National Resources Planning Board. Ufficio Nazionale Cinese di Statistica, Censimento, 2010 UNDP, Human Development Report UN DESA (2013), Population Division, World Population Prospects: the 2012 Revision. Highlights, UN DESA (2009), World Population Prospects , The 2008 Revisions UN DESA (2011), World Population Prospects , The 2010 Revisions UN DESA (2000), Replacement Migration, is it a solution to declining and ageing population? New York US Intelligence Council (2010), Global Trends 2025. Ussher James (1650), Annales Veteris Testamenti, Karma Ura, Sabina Alkire e Tshoki Zangmo, Ura, “Gross National Happines and the GNH Index”, in John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs (ed.) (2010), World Happiness Report. Wang, Feng (2005), “Can China afford to continue its one-child policy?,” Asia Pacific Issues No.17, Honolulu: East-West Center. Wang Feng (),“The Future of a Demographic Overachiever: Long-Term Implications of the Demographic Transition in China”, World Bank (2012), China 2030; Building a modern harmonious and creative highincome society, New York, The World Bank Mathis Zackermagel e William Rees (1996), Our Ecological Footprint, Gabriola Island, New Society Publishers. Zhanh Lijia (2008), Il socialismo è grande, l’esperienza del lavoro in fabbrica negli anni ’80, Cooper. Zhao, Z. (2011), China’s far below replacement fertility and its long-term impact. Demographic Research, 25 192
Scarica