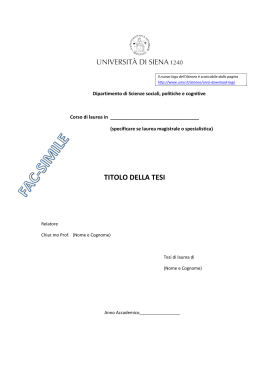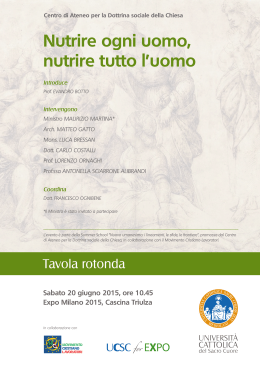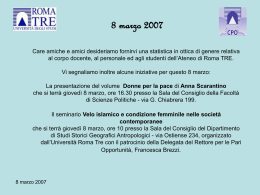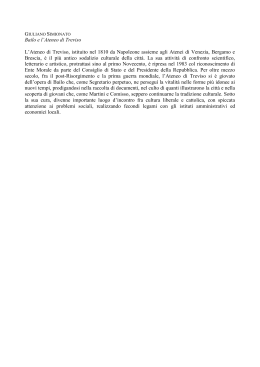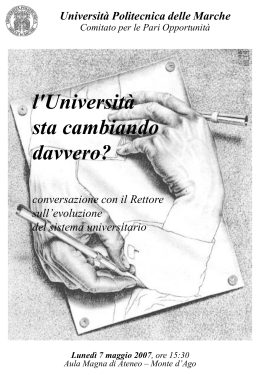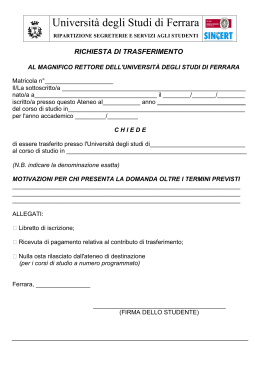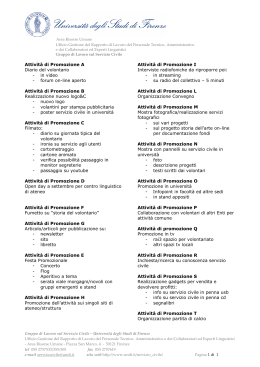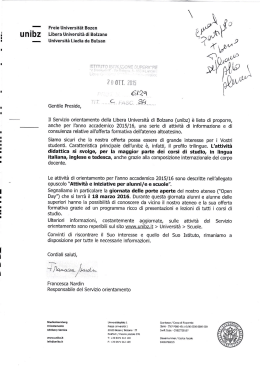Linee programmatiche presentate da Elisabetta Cerbai Candidatura a Rettore dell’Università degli Studi di Firenze Sessennio 2015-2021 www.elisabettacerbairettore.it Università pubblica: forte, libera, aperta Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai a scelta di candidarmi a Rettore dell’Università di Firenze per il periodo 2015-2021 è maturata in un arco di tempo breve, se confrontato all’esperienza di anni di ricerca, di didattica e infine di governo come Prorettore. Le motivazioni e il percorso che hanno portato a questo passo, nella piena consapevolezza della responsabilità che la candidatura pone, sono stati delineati in una lettera del 21 Gennaio inviata ai Direttori di Dipartimento e ai membri degli Organi di Ateneo, a un insieme di colleghi di tutte le aree disciplinari che mi avevano già esortato a riflettere sulla possibilità di una candidatura, e agli organi di stampa. Richiamando in sintesi, la delega di Prorettore alla ricerca mi ha permesso di conoscere più approfonditamente le tante realtà e la grande vitalità presenti in tutte le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, a partire da quella biomedica con cui avevo già maggiore familiarità. L Tale conoscenza ha rafforzato in me la convinzione del valore culturale e sociale dell'Università di Firenze, consentendomi di esplorare e sostenere i rapporti vitali fra le varie aree della ricerca e di questa con la formazione; di comprendere e incentivare l’impegno internazionale dell’Ateneo nelle sue diverse espressioni; di partecipare al dialogo con le differenti realtà presenti sul territorio - enti locali, imprese, organismi di categoria, associazioni professionali - e di apprezzare il loro crescente interesse per quanto l'Ateneo negli ultimi anni è riuscito a realizzare. A marzo, inaugurando il sito web della mia candidatura e i social network, tale decisione si era già rivelata straordinaria per impegno intellettuale ed emotivo, e mi ha consentito di aprire finestre di ascolto di altrettanta straordinaria ricchezza grazie all’interesse per il destino e le missioni dell'università, all’impegno istituzionale, alla professionalità e profondità culturale delle persone incontrate, in tutte le aree dell'Ateneo. L’ultimo mese, insieme all'allargamento dei confronti, ha visto lo sviluppo delle linee programmatiche, che ora vado a presentare complete, ma mai chiuse ad apporti costruttivi. Ricorderò sempre con gratitudine questa esperienza di incontri, qualunque sia l’esito elettorale. Le linee programmatiche si compongono di tre parti principali: - visione: l’Università che vogliamo e le sfide che ci attendono; - obiettivi: dove si può arrivare, quali risultati ottenere nel sessennio; - strategie: come arrivarci, con quali percorsi condivisi. Il documento si conclude con un breve curriculum vitae. Vi aspetto negli incontri di maggio, nelle aule di dibattito, ma ancora sul web e sui social network. Con cordialità, Elisabetta Cerbai http://www.elisabettacerbairettore.it/ https://www.facebook.com/ElisabettaCerbaiperUniFi https://twitter.com/ProfCerbai UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 1 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Sommario VISIONE......................................................................................................................................................... 3 L’Università di Firenze che vogliamo ......................................................................................................... 3 Il punto di partenza ................................................................................................................................... 3 Le sfide che ci attendono........................................................................................................................... 4 OBIETTIVI ...................................................................................................................................................... 5 Attrarre e competere ................................................................................................................................ 5 Vivere e diffondere innovazione e cultura ................................................................................................ 6 Riconoscere e integrare le diversità .......................................................................................................... 6 Consolidare sostenibilità e autorevolezza ................................................................................................. 7 Governare la complessità .......................................................................................................................... 7 STRATEGIE .................................................................................................................................................... 9 Indirizzo ....................................................................................................................................................... 12 Assetto federale e metodi partecipati e trasparenti per strategie di ateneo .......................................... 12 Professionalità e cultura di progetto nell’amministrazione .................................................................... 15 Controllo di bilancio per sostenibilità delle strategie .............................................................................. 17 Dialogo inter-istituzionale e rapporti col sistema territoriale ................................................................. 19 Sistema sanitario, integrazione e salvaguardia della specificità universitaria........................................ 21 Cantieri ........................................................................................................................................................ 26 Formazione, innovazione didattica, costi standard e diritto allo studio ................................................. 26 Ricerca per l’eccellenza del sapere, la diffusione culturale, l’innovazione .............................................. 31 III Missione come valorizzazione continua e sostenibile di formazione e ricerca .................................... 34 Internazionalizzazione per il confronto, la cooperazione, l’accoglienza ................................................. 37 Smart Hub .................................................................................................................................................... 40 Accelerazione dell’innovatività e della qualità con servizi digitali personalizzati e aperti ...................... 40 Comunicazione costruttiva e reti sociali .................................................................................................. 44 Strategie normative per processi amministrativi snelli e sicuri ............................................................... 46 Un Ateneo metropolitano multi-campus: progetto da completare......................................................... 48 CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA CERBAI – 04/05/2015 ....................................................................... 51 UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 2 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai VISIONE L’Università di Firenze è un grande ateneo pubblico immerso nel cambiamento, che L’Università affronta le difficoltà e le incertezze del contesto facendo leva sul valore della ricerca, di Firenze dell’alta formazione, dell’innovazione nelle società contemporanee, a livello locale, che vogliamo nazionale e internazionale. Affrontare le difficoltà e cogliere le opportunità è possibile se chi “vive” l’Università si sente parte di una comunità accademica forte, libera, aperta. Nella sezione sulla “visione”, viene proposta la prima chiave di lettura, un’enunciazione sintetica del punto di partenza e delle sfide che ci attendono se vogliamo che l’Università di Firenze sia capace di attrarre e competere forte, libera, aperta. Le sezioni dedicate a “obiettivi” e a “strategie” propongono le altre due chiavi di lettura: nell’orizzonte concreto dei prossimi sei anni quali caratteristiche di funzionamento e di prestazione dobbiamo acquisire o consolidare; quali progetti e strumenti possiamo utilizzare per arrivarci. Presento questo programma con la misura che i tempi richiedono, ma anche con la consapevolezza della grande capacità, dell’energia, del senso di responsabilità individuale e collettiva che sono parte integrante della vita della nostra comunità accademica, quella parte che più di tutte deve essere protagonista. Queste qualità non sono generiche né casuali ma scaturiscono dalla lezione della ricerca rigorosa e della curiosità creativa, della formazione critica centrata su una didattica connessa alla ricerca, dell’innovazione responsabile e del confronto culturale fondato e rispettoso, dell’impegno in strutture e servizi con forti ricadute sociali. Il punto di partenza L’Università di Firenze, muovendosi nella mutevole e incerta realtà contemporanea, ha mostrato negli ultimi anni capacità di reazione e sostenibilità, accompagnata dalla guida di Alberto Tesi. La base di un programma di governo partecipato è una conoscenza fondata e articolata dei tanti aspetti di questa università in movimento, cioè: • un Ateneo generalista con una grande articolazione di specificità nelle tradizioni e nei processi di formazione e ricerca; per molti parametri è nei primi 5 posti delle graduatorie delle università italiane; nelle graduatorie internazionali si colloca spesso nel primo decile; • un luogo di studio, lavoro, vita e relazioni sociali cui contribuiscono circa 60.000 persone; • una delle maggiori organizzazioni operanti in Toscana con rilevante impatto economico e urbano sul territorio; • un ponte da e verso il mondo, grazie a centinaia di accordi internazionali e migliaia di studenti stranieri; • uscita da un periodo di forte debolezza finanziaria con perdite estese di risorse umane e di capacità di investimento, condizioni in cui ha anche affrontato il difficile adeguamento normativo e organizzativo voluto dalla legge 240/2010. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 3 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Ognuno di questi aspetti potrebbe essere oggetto di illustrazioni statistiche e fattuali. L’Ateneo negli ultimi anni ha incrementato la capacità di introspezione e comprensione. Una raccolta esaustiva si trova nel documento “Linee di programma per la redazione del Piano Strategico 2013-2015” varato. Le analisi che portano alla proposta di obiettivi e strategie nelle sezioni seguenti hanno anche tali fondamenti. Le sfide che ci attendono − − − − I principi ispiratori dell’agire dell’Università di Firenze, nell’ambito delle tre missioni universitarie, devono essere l’alta qualità della Formazione e della Ricerca e la promozione di effetti positivi nei Contesti socio-economici di riferimento. La realtà contemporanea ci presenta: concorrenza fra università a livello nazionale e internazionale, con l’emersione di nuovi metodi formativi, la necessità di servizi innovativi nella didattica e nel diritto allo studio, il confronto con organizzazioni della ricerca sempre più articolate e dinamiche; profondi cambiamenti di respiro globale e locale in ambito socio-economico, politico, tecnologico, e domande sempre più pressanti in termini di innovazione, imprenditorialità, professionalità e lavoro, mobilità e coesione sociale, confronti di genere, sostenibilità ambientale; complessità del dialogo tra culture e identità, insieme rischio e opportunità per l’esercizio del pensiero rigoroso e critico e per l’accesso libero ai risultati della ricerca e ai contenuti della didattica; progressiva e costante rarefazione, nel sistema universitario italiano, delle risorse interne, umane, strumentali, insieme a limitazioni e incertezze del finanziamento pubblico e della normativa di riferimento. Tutto ciò si traduce in sfide che l’Ateneo dovrà affrontare negli anni futuri, per consolidare le posizioni raggiunte e da queste progredire lungo i principi ispiratori sopra enunciati. L’Università che vogliamo, per garantire questa progressione, deve essere: forte presidio di civiltà e motore di progresso sociale ed economico per l’intera Nazione e per il territorio di riferimento, cioè la città metropolitana fiorentina e la Toscana centrale; per i valori inalienabili della persona e per la responsabilità individuale e collettiva nella ricerca rigorosa, nella formazione critica, e nell’innovazione responsabile, che difende e diffonde; libera sede di produzione scientifica e formazione pubblica, autonoma nei propri ordinamenti e da condizionamenti esterni; aperta arena di confronto culturale rigoroso, creativo e rispettoso, di incontro per gli investimenti anche internazionali sulla formazione di competenze critiche e alte professionalità, di impegno della ricerca in tutte le aree del sapere. Nelle altre sezioni si propone l’articolazione dei principi ispiratori e della risposta alle sfide nei termini di un percorso fatto di obiettivi e strategie identificabili. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 4 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai OBIETTIVI L’Università “che vogliamo” è in primo luogo il risultato delle azioni quotidiane di tanti docenti e ricercatori, personale tecnico amministrativo e collaboratori, studenti e borsisti. Identificare gli obiettivi generali dei prossimi sei anni significa dotarsi di uno strumento che indichi con chiarezza la rotta da seguire in termini di caratteristiche funzionali e tipo di risultati che devono essere consolidati o acquisiti per un’università forte, libera, aperta che garantisca e diffonda i suoi principi ispiratori. Essere forte come presidio di civiltà e motore di progresso, significa che l’Università è in grado di attrarre e trattenere studenti, ricercatori e docenti di qualità, coinvolgere enti esterni in collaborazioni impegnative, guidare il confronto culturale in molti campi collegati alle proprie attività, in concorrenza con le alternative proposte da istituzioni accademiche più dinamiche, a livello nazionale e internazionale. Funzioni e risultati di alto livello, per essere duraturi, devono essere fondati su due ulteriori capisaldi. Il primo è fatti di sostenibilità economica e finanziaria, e dall’autorevolezza nel proporre l’Ateneo, coi suoi principi fondanti, difendendoli da sfide e incomprensioni. L’altro è interno e riguarda la capacità di governare un sistema complesso contrastando possibili tendenze alla dispersione delle risorse, ai conflitti di posizione, all’indebolimento delle capacità. L’università pubblica e autonoma è connessa ai principi costituzionali (art. 33) della libertà di arte, scienza e insegnamento. Un’università libera concilia i principi dell’interesse pubblico e dell’autonomia degli ordinamenti con la capacità di superare inerzie inutili e vincoli imposti da interessi particolari e modelli invecchiati, quindi vivendo e proponendo costantemente innovazione responsabile e avanzamento culturale al suo interno e con parti esterne interessate. Un’università che è arena aperta ai confronti culturali, nella formazione e nella ricerca. È aperta in primo luogo al suo interno valorizzando la grande varietà di competenze e conoscenze che la compone, trovando vie di integrazione e selezione efficaci. Un laboratorio che permetta di essere arena credibile, ma anche di accettare le sfide di punti di vista differenti, di domande nuove, di soluzioni competitive che vengono dall’esterno. Le tessere di questa sezione esplicitano dunque gli obiettivi generali inclusi nell’idea dell’Università che vogliamo, articolandoli anche in termini di prospettive da realizzare. L’Università di Firenze, anche grazie alla sua posizione geografica, contiene in sé enormi potenzialità di attrazione ed è chiamata a far fronte alle sempre più alte aspettative dei Attrarre e suoi studenti. Nei prossimi anni, infatti, è lecito aspettarsi un progressivo cambiamento competere nella modalità della formazione: il nostro Ateneo dovrà essere in grado di assicurare ai propri iscritti un’offerta didattica capace di conciliare innovazione (corsi in lingua straniera, utilizzo di nuovi media e tecnologie all’avanguardia) e tradizione, di garantire livelli formativi elevati e competitivi. Occorre rafforzare gli strumenti del Diritto allo studio e dell’accoglienza degli studenti anche fuori sede e stranieri offrendo un outplacement coerente con le richieste e le caratteristiche del mondo del lavoro. Occorre innalzare gli standard della nostra ricerca, ampliarne gli orizzonti e accrescerne le risorse, consolidare e potenziare la capacità di “educare attraverso la ricerca”. In questo ambito può realizzarsi quella “didattica di prossimità” che rende la formazione – in particolare magistrale e di terzo livello – un’esperienza unica per lo studente e il docente. Un’esperienza che si fonda anche su laboratori, infrastrutture e soprattutto risorse umane (docenti e personale tecnico amministrativo) adeguati. Tale UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 5 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai obiettivo si realizza anche attraverso il potenziamento delle relazioni di collaborazione e di scambio con le migliori Università europee ed extraeuropee di eccellenza e delle opportunità di accoglienza e offerta di studenti e docenti. Prospettive da realizzare - aumentare il numero e la qualità di studenti in ingresso, in particolare di secondo e terzo livello, e la capacità di attrarre studenti e dottorandi dall’estero; - costruire solide opportunità di progressione di carriera; allargare il reclutamento di giovani ricercatori, anche dall’estero, su progetti di eccellenza; - facilitare la presenza di ricercatori e docenti stranieri per una didattica plurilinguistica e multiculturale; - mappare e razionalizzare le infrastrutture didattiche e di ricerca come basi per l’eccellenza, l’innovazione, il confronto culturale. L’Università, nel suo ruolo di massima istituzione culturale, assume su di sé un compito di grande responsabilità. Nei prossimi decisivi anni, la sfida non è riaffermare una rendita di posizione; al contrario, si tratta di creare, consolidare, ampliare reti relazionali capaci di portare innovazione dentro e fuori l’Ateneo. Un’azione innovatrice volta all’inserimento lavorativo dei laureati, alla formazione di studenti e professionisti anche nei Paesi emergenti, all’avvio di percorsi di imprenditorialità, all’avanzamento della conoscenza anche tramite invenzioni, restituendo così alla comunità i benefici delle risorse derivanti da fondi pubblici in termini di conoscenza e crescita socio-culturale. Vivere e diffondere innovazione e cultura Prospettive da realizzare - promuovere un ambiente di studio creativo e innovativo che stimoli negli studenti capacità progettuali e critiche e faciliti il confronto con società e impresa; - sostenere avvii rapidi a lavoro di qualità per laureati e dottori di ricerca; aumentare il numero e il valore di invenzioni riconosciute e di imprese innovative e dinamiche dalla ricerca e dalla formazione accademica; - aiutare chi lavora nell'Università, in ogni settore, ad affrontare il cambiamento e l'innovazione in modo sostenibile; - far emergere e diffondere i risultati di Ateneo e di Dipartimento in termini di ricerca, di innovazione e di diffusione culturale, anche attraverso politiche coerenti con il principio dell’accesso aperto alla letteratura e dati scientifici. Essere un Ateneo generalista è una ricchezza ma implica saper affrontare la sfida quotidiana della conciliazione tra esigenze didattiche, scientifiche, logistiche, professionali e di risorse differenti per qualità e quantità. Gli strumenti di valutazione devono tener conto di tale diversità e il Rettore e il governo di Ateneo hanno il compito di trovare una sintesi che non lasci indietro nessuno. Esistono le premesse per uno slancio costruttivo: il superamento dei confini della ricerca disciplinare, specialmente tra i colleghi più giovani, una formazione che integri in modo più armonico saperi diversi perché questa è la realtà in cui gli studenti vivono e in cui si troveranno a operare. L’Ateneo deve quindi valorizzare la qualità delle nostre Riconoscere e integrare le diversità UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 6 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai tradizioni e consolidare i punti di forza, promuovendo con decisione incroci fertili sia nella ricerca sia nella didattica come spunti per idee innovative. Prospettive da realizzare - potenziare le sfere di formazione e ricerca interdisciplinari sulle grandi sfide sociali; - consolidare, aggiustare e snellire i sistemi di valutazione e di distribuzione delle risorse integrando metodologie per decisioni strategiche qualitative; - promuovere la ricerca curiosity-driven anche in aree scientifiche di nicchia. Negli ultimi anni l’Università di Firenze ha affrontato e risolto importanti difficoltà Consolidare sostenibilità e finanziarie e, al tempo stesso, ha acquisito una credibilità crescente come centro di irradiazione culturale e di progresso. Ora più che mai è necessario perseverare, autorevolezza migliorare la gestione delle risorse e affermare un ruolo di interlocutore privilegiato come sistema ben organizzato della ricerca, dell’alta formazione, dell’innovazione e del confronto culturale, del contributo a strutture sociali e sanitarie, con cui istituzioni, organizzazioni e privati possano confrontarsi. Una comunicazione efficace e trasparente è ovviamente strumento fondamentale di costruzione dell’identità interna ed esterna. Prospettive da realizzare - mantenere le quote di finanziamento statale ordinario; espandere i finanziamenti e le entrate su progetti di alta formazione, ricerca e innovazione a livello nazionale e internazionale; - rafforzare la riconoscibilità locale e internazionale di forti aree di ricerca e innovazione in tutti i dipartimenti, il valore del senso di appartenenza della comunità studentesca, la comunicazione dell’identità dell’Ateneo entro la varietà delle sue attività e delle sue anime; - utilizzare coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale. L’Università di Firenze è un sistema complesso che necessita una gestione efficiente, trasparente e sostenibile. Per affrontare le sfide che si prospettano, il nostro Ateneo deve proiettarsi oltre i risultati raggiunti e la semplice amministrazione dell’esistente grazie a una decisa politica di indirizzo e di governo. Il Rettore e il governo di Ateneo hanno il compito di offrire, all’interno di un disegno strategico complessivo, una guida politica chiara e condivisa, capace di riconoscere specificità e necessità delle singole realtà. I Dipartimenti devono essere strutture forti e largamente autonome nell’operatività quotidiana, ma anche in grado di rispondere a strategie di rete e di sistema entro l’Ateneo. È necessario sviluppare approcci e metodi di valutazione – non solo misurazione – responsabile e condivisa dei risultati, conoscenza delle specificità, capacità di seguire processi decisionali e attuativi snelli ed efficaci e rivedere la regolamentazione ispirandola a principi di ragionevolezza e proporzionalità, efficienza ed efficacia. Fulcro dell’azione è la sinergia, la sincronia tra piano strategico di Ateneo, programmazione delle risorse e obiettivi operativi assegnati all’Amministrazione. Governare la complessità UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 7 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Prospettive da realizzare - definire il piano strategico dell’Ateneo 2016-2018 mediante il confronto tra organi di indirizzo politico e Dipartimenti e il conseguente mandato a livello gestionale; - promuovere aggiustamenti mirati dello Statuto di Ateneo sulla base di un riscontro puntuale con le esigenze di efficienza ed efficacia nell’azione politica e nelle attività di strutture e personale; - rivedere i regolamenti specifici a favore di linee guida adattabili e monitorabili e di un responsabile esercizio delle prerogative dell’autonomia; - potenziare formazione e qualificazione professionale del personale; adattare gli strumenti operativi per rendere sostenibile, proficuo e gratificante il lavoro quotidiano; - estendere e approfondire il supporto informatico e alla comunicazione per didattica, ricerca, valutazione e per attività gestionali-amministrative; - promuovere confronto per obiettivi con le rappresentanze del personale. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 8 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai STRATEGIE Gli obiettivi comunicano dove vogliamo arrivare; se e come ci arriveremo dipende dal contesto mutevole in cui si muove l’Università di Firenze e dalla convergenza delle azioni delle migliaia di soggetti che la compongono. Quella di Firenze è una grande Università pubblica in movimento capace di adattarsi a una realtà, come quella contemporanea, incerta e mutevole. È un Ateneo generalista fortemente qualificato nei processi di formazione e ricerca. È un luogo di studio, di lavoro, di relazioni sociali che coinvolge 60.000 persone. È un ponte da e per il mondo capace di accogliere migliaia di studenti stranieri. È una realtà dinamica che ha dimostrato di sapere reagire superando un periodo di forte debolezza finanziaria, di perdita di risorse umane e di capacità di investimento. L’attuale assetto dell’Università degli Studi di Firenze costituisce un buon punto di partenza per un cammino culturale e di investimenti capace di farci progredire secondo gli obiettivi generali illustrati nella sezione per un’Università pubblica, forte, libera, aperta. Le strategie e i progetti che intendo porre in essere coinvolgono tutti i protagonisti della vita universitaria: studenti, personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, socio-sanitario, collaboratori, ricercatori e professori. I PROTAGONISTI Per gli studenti l’Università, oltre che luogo della loro formazione, deve essere anche centro di cultura, di aggregazione e di incontro. Centrali saranno la qualità e la varietà dell’offerta formativa, i percorsi parttime per chi lavora, le maggiori opportunità di formazione innovativa, interdisciplinare e internazionale. Il Diritto alla Studio significa anche qualità ed efficienza delle prestazioni: servizi di mensa in tutti i campus, spazi per socializzazione e studio in tutte le sedi, infrastrutture ricreative e sportive, uno sportello unico per tutte le necessità amministrative, servizi innovativi per il welfare e l’accoglienza anche internazionale, efficace orientamento e avviamento al lavoro e all’intraprendenza, servizi web chiari, semplici e immediati, miglioramento dei servizi di assistenza e tutoraggio con particolare attenzione alle disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento. Dobbiamo individuare, con il contributo fattivo degli studenti, azioni efficaci per la piena sostenibilità della formazione, basate sul principio che nessuno deve rimanere indietro. I percorsi formativi devono essere chiari, stabili e sostenibili. Il continuo riformismo imposto alle Università negli ultimi anni ha determinato troppa confusione e incertezza nell’offerta formativa e, soprattutto, ne ha causato un drastico e ingiustificato ridimensionamento. È necessario invertire la tendenza e ristabilire un’offerta formativa di qualità e varietà adeguata a una grande Università statale qual è quella di Firenze. Per il personale tecnico e amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario l’Università, oltre che luogo di lavoro, deve essere anche centro di confronto, partecipazione e discussione. Centrali saranno il miglioramento dell’organizzazione dei servizi, il rapporto federale fra amministrazione centrale e strutture decentrate, la valorizzazione delle competenze e l’aggiornamento professionale continuo, il miglioramento e la sostenibilità delle condizioni di lavoro. Il principio chiave che deve guidare l’azione di governo deve essere la salvaguardia delle competenze e il benessere sul luogo di lavoro, per far sì che mai più in futuro norme confuse, regolamenti troppo complessi e sistemi informatici inadeguati siano fonte di frustrazione e stress nel normale svolgimento dei compiti istituzionali. Ciascun lavoratore, nel suo specifico ruolo e per le sue specifiche competenze, deve essere messo in grado di operare con serenità e con obiettivi chiari, sostenibili e verificabili. La specificità del lavoro tecnico a supporto dei progetti di ricerca deve essere riconosciuta anche in termini di visibilità della produzione scientifica. La formazione deve essere UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 9 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai strettamente finalizzata al miglioramento delle competenze, dell’efficienza, dell’efficacia, della tempestività. Stretto e continuo deve essere il rapporto con docenti e ricercatori per l’ottimale espletamento delle funzioni istituzionali dell’Università in campo didattico, di ricerca e di terza missione. Deve essere messo a punto un piano di nuove assunzioni e di sviluppo di carriera, per ristabilire condizioni di sviluppo e sostenibilità del lavoro e per porre rapidamente rimedio alla drastica riduzione di personale e all’eccessiva restrizione delle opportunità di progressione, determinate dalle politiche governative degli ultimi anni. Nella nostra Università operano migliaia di collaboratori inquadrati in varie forme contrattuali che forniscono un effettivo e insostituibile supporto alle attività istituzionali di Ateneo nella didattica, nella ricerca, nella terza missione e nei servizi. Il loro ruolo deve essere prima di tutto pienamente riconosciuto e opportunamente valorizzato. Per essi l’Università deve essere anche fonte di concreta speranza di un adeguato futuro professionale pur entro il continuo cambiamento delle “regole del gioco” che ci viene imposto dalla confusa normativa nazionale. Collaborare alle attività istituzionali dell’Università di Firenze deve essere semplice e sostenibile. La spinta innovativa nella ricerca, la formazione sul campo di studenti magistrali e dottorandi, la capacità di trasferire rapidamente idee in progetti di lavoro, di crescita sociale e culturale passa sempre più attraverso ricercatori non strutturati o a tempo determinato. In un quadro normativo soggetto a mutamenti e interpretazioni, l’impegno del Rettore deve essere quello di adoperarsi affinché si giunga a livello nazionale a regole chiare, che stabiliscano condizioni di partecipazione ai bandi per il reclutamento di ricercatori a TD di tipo B rispettose di professionalità ed esperienza. Per il personale docente e ricercatore l’Università, come luogo di lavoro, deve essere centro di diffusione di cultura, rapporti inter-culturali, ricerca di qualità e innovazione continua. La massiccia riduzione di personale docente e ricercatore subita a seguito dei tagli nei finanziamenti ministeriali negli ultimi anni deve essere bilanciata da un nuovo programma di assunzioni e di progressioni di carriera. I Dipartimenti svolgeranno un ruolo cruciale nelle scelte relative al reclutamento e agli avanzamenti di carriera, entro una prospettiva federale che vuol dire fare sistema fra strutture diverse che devono essere in stretta interazione ed operare sinergicamente per il bene comune e per la crescita dell’Ateneo nel suo insieme. Non deve essere trascurato il bilanciamento delle numerosissime aree tematiche alle quali afferiscono ricercatori e docenti; sarà indispensabile definire modalità di perequazione e anche di investimento in nodi di competenza identificati come strategici, mantenendo i principi cardine della trasparenza, della partecipazione e della valutazione nei processi di distribuzione delle risorse. L’attenzione verso le componente precaria dei ricercatori deve essere massima, come per i ricercatori a tempo indeterminato improvvidamente messi ad esaurimento dall’ultima riforma. L’ingresso stabile nella fascia dei professori associati deve essere un obiettivo sostenibile e accessibile per i capaci e meritevoli, anche dopo la cessazione delle politiche di incentivazione governative. Anche la progressione di carriera verso la prima fascia dovrà tornare a essere una meta raggiungibile e non chimerica come è adesso un po’ in tutto il Paese. A tutti coloro che hanno conseguito un’abilitazione nazionale devono essere date risposte chiare e non casuali, per indirizzare il loro futuro nella maniera più opportuna e utile anche per la crescita e il progresso complessivo dell’Ateneo. I GRAPPOLI DI LINEE STRATEGICHE Le strategie di Ateneo indicano percorsi di scelte e realizzazioni, volte a una traduzione in sequenze di progetti operativi che influenzino e facilitino, da subito e oltre il 2015, il movimento del sistema complesso verso gli obiettivi. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 10 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai La definizione di strategie specifiche è un processo di costruzione in divenire a cui sono chiamati a contribuire tutti coloro che condividono questa visione dell’Università pubblica in movimento. Le strategie specifiche prendono la forma di progetti concreti entro le appropriate sedi di governo e amministrazione dell’Ateneo. Ciò che può essere ragionevolmente illustrato in un documento programmatico è l’architettura strategica, fatta di grandi grappoli di linee strategiche. L’architettura che propongo è basata su tre grandi grappoli che investono i settori prioritari di intervento: Indirizzo, Cantieri, Smart Hub. Il lettore potrà trovare nelle schede di approfondimento che seguono, gli elementi che più lo riguardano o lo interessano. Anticipiamo i titoli e gli incroci con gli obiettivi. INDIRIZZO Assetto federale e metodi partecipati e trasparenti per strategie di ateneo Professionalità e cultura di progetto nell’amministrazione Controllo di bilancio per sostenibilità delle strategie e supporto legale dell’università Dialogo inter-istituzionale Sistema sanitario, integrazione e salvaguardia della specificità universitaria CANTIERE Formazione, innovazione didattica, costi standard e diritto allo studio Ricerca per l’eccellenza del sapere, la diffusione culturale, l’innovazione III Missione come valorizzazione continua e sostenibile di formazione e ricerca Internazionalizzazione per il confronto, la cooperazione, l’accoglienza SMART HUB Accelerazione dell’innovatività e della qualità con servizi digitali personalizzati e aperti Comunicazione costruttiva e reti sociali Strategie normative per processi amministrativi snelli e sicuri Un Ateneo metropolitano multi-campus: progetto da completare Le schede che seguono hanno in premessa, ognuna, il riferimento a una o più delle prospettive da realizzare che traducono in termini concreti gli obiettivi generali proposti nella sezione precedente. La tabella qui riportata anticipa in termini sintetici gli incroci fra linee strategiche e obiettivi. Contributi strategici agli obiettivi generali Attrarre e competere Innovazione & cultura Riconoscere e integrare diversità Sostenibilità e autorevolezza Governare la complessità INDIRIZZO CANTIERE SMART HUB UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 11 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Indirizzo Assetto federale e metodi partecipati e trasparenti per strategie di ateneo Prospettive da realizzare da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - aiutare chi lavora nell'Università, in ogni settore, ad affrontare il cambiamento e l'innovazione in modo sostenibile da RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIVERSITÀ - aggiustare e snellire i sistemi di valutazione e di distribuzione delle risorse integrando nel sistema metodologie che consentano decisioni strategiche qualitative. da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - definire il piano strategico dell’Ateneo 2016-2018 mediante il confronto tra organi di indirizzo politico e Dipartimenti e il conseguente mandato a livello gestionale; - promuovere aggiustamenti mirati dello Statuto di Ateneo sulla base di un riscontro puntuale delle esigenze di efficienza ed efficacia nell’azione politica e nelle attività di strutture e personale - rivedere i regolamenti specifici a favore di linee guida adattabili e monitorabili e di un responsabile esercizio delle prerogative dell’autonomia - promuovere confronto per obiettivi con le rappresentanze del personale UNIFI è un sistema complesso che deve poter contare sull’autonomo contributo dei suoi docenti e ricercatori; sulla collaborazione del personale tecnico-amministrativo coinvolto anche in termini di sviluppo professionale e progettualità; sul confronto e la partecipazione dei suoi principali interlocutori, cioè gli studenti che nell’Università vivono e cercano non solo la loro formazione curricolare ma anche reti sociali, culturali, politiche; sul confronto con altri portatori di interessi specifici cioè le famiglie, le imprese, gli enti terzi, istituzioni e comunità scientifiche esterne. Questa è l’Università in cui sono stata studentessa prima e ricercatrice poi; questo è il modo in cui intendo la “governance”: un sentiero di confronti, consensi, indirizzi e scelte, fra organi centrali, unità operative di docenti e ricercatori, tecnostrutture, popolazioni studentesche, altri partner. La “governance” può essere interpretata con vari stili; occorre dunque definire indirizzi strategici su tre livelli di architettura: a) Rapporti fra strutture centrali e strutture dipartimentali. I dipartimenti devono essere rafforzati ed aiutati a sviluppare in pieno propri obiettivi e strategie, oltre a presidiare l’identità e l’alto livello delle loro specifiche aree formative, scientifiche, culturali e dell’innovazione, nonché le capacità di rete a livello nazionale e internazionale. Tali strategie e identità vanno federate nell’ambito delle strategie e dell’identità UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 12 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai di Ateneo che, presentandosi come una “squadra di campioni”, acquista forza e capacità di movimento che non avrebbe con un’organizzazione di puro servizio a strutture indipendenti. A livello operativo, oltre ai servizi generali quali bilancio, patrimonio, risorse umane, affari legali, vi sono funzioni specialistiche che possono essere più utilmente collocate a livello centrale, sia per favorire il coordinamento progettuale delle iniziative dipartimentali su grandi tematiche trasversali, sia perché l’ambito dei singoli dipartimenti può essere troppo piccolo per assicurare livelli di servizio professionale senza costi eccessivi. D’altra parte, è possibile prevedere l’estensione di alcune aree di delega ai Dipartimenti su contratti e progetti che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Università. Le funzioni di sistema devono essere delimitate secondo criteri di efficienza ed efficacia, adeguatamente collegate alle attività dei Dipartimenti, non condizionate dalle logiche inerziali delle burocrazie, e sottoposte a valutazione di qualità su risultati e produttività. La recente riorganizzazione delle aree dirigenziali e la funzionalizzazione di centri e strutture di servizio di ateneo sono un primo passo in questa direzione. Rimane cruciale un’attenta valutazione strategica e operativa del bilanciamento e del collegamento delle attività, professionalità e responsabilità (comprese le deleghe) fra strutture centrali e dipartimentali nei servizi per formazione, ricerca, terza missione, internazionalizzazione. Competenze specialistiche presenti in ambiti scientifici e culturali di singoli dipartimenti possono essere opportunamente valorizzate anche in prospettiva sistemica e collegate all’attività di strutture di servizio di ateneo. La redistribuzione di risorse finanziarie e tecniche a beneficio di aree economicamente deboli, entro e fra i dipartimenti, deve essere oggetto di valutazioni esplicite e agganciata a risultati condivisi e monitorabili. Occorre costruire un presidio centrale di governo dell’ateneo per guidare l’insieme di questi processi, che operi in collaborazione con l’Amministrazione e il Nucleo di Valutazione e includa il coordinamento delle politiche per l'ottimizzazione dei finanziamenti ministeriali. Tale presidio dovrà occuparsi pertanto della progettazione strategica e delle metodologie partecipative e farsi carico dell’elaborazione di scenari e proposte di scelte strategiche su aree di competizione nodali per l’Ateneo. Oggetto primario di tale presidio, nell’ambito degli obiettivi generali di questo Programma, sarà il supporto agli Organi di Ateneo per la costruzione e la realizzazione dei Piani Strategici 2016-2018 e 2019-2021. b) Dipartimenti e Scuole. Occorre procedere a una valutazione della configurazione dei Dipartimenti e dei rapporti con le Scuole alla luce dell’esperienza triennale, senza stravolgimenti, ma con apertura ad alcuni aggiustamenti. Variazioni nella composizione dei Dipartimenti (fusioni, redistribuzione di SSD, ecc.) dovranno avere chiare basi scientifiche e prospettive formative e culturali. Al Collegio dei Direttori di Dipartimento spetterà predisporre un parere obbligatorio sulle modalità di ripartizione delle risorse e della programmazione per il reclutamento del personale docente. Le Scuole dovranno consolidare la funzione di coordinamento dell’offerta formativa dei Corsi di studio, nell’ambito delle prospettive strategiche, delle funzioni gestionali e della programmazione delle risorse per la didattica deliberate dai Dipartimenti. c) Organi di governo di Ateneo. Occorre una valutazione sugli assetti raggiunti con la riorganizzazione che ha fatto seguito alla L. 240/2010, considerando la possibilità di aumentare la rappresentanza dei Dipartimenti entro il Senato Accademico; di distinguere più estesamente gli ambiti deliberativi di Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione pur mantenendo un forte collegamento conoscitivo fra gli Organi; di vedere nel Senato Accademico l’organo fondamentale di promozione dell’assetto federale dell’Ateneo; di dare spazio al Consiglio di Amministrazione per svolgere le sue funzioni di discussione e approvazione degli indirizzi strategici dell’Ateneo; di definire ruoli di indirizzo di membri di SA e CDA entro comitati accademici o inter-istituzionali. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 13 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Il Rettore si doterà di un governo basato su incarichi di prorettore e delegati conferiti a colleghi di alto profilo scientifico che aderiscano al Programma e siano dotati di adeguate competenze specifiche, forte senso istituzionale, capacità di impegno intenso e duraturo. L’articolazione fondamentale di deleghe distinte prevede (pur con possibilità di aggiustamenti): 1) Formazione (studenti, innovazione didattica e diritto allo studio) 2) Ricerca (per l’eccellenza del sapere, la diffusione culturale, l’innovazione) 3) III Missione (valorizzazione continua e sostenibile di formazione e ricerca) 4) Internazionalizzazione (per il confronto, la cooperazione, l’accoglienza) 5) Realizzazione del Programma e progettazione strategica (metodologie valutative e partecipative) 6) Promozione della cultura di progetto e relazioni con il personale tecnico-amministrativo 7) Controllo di bilancio e finanziamenti per sostenibilità delle strategie 8) Rapporti con i sistemi territoriali e dialogo inter-istituzionale 9) Accelerazione dell’innovazione e università digitale 10) Comunicazione e reti sociali 11) Strategie normative (per processi amministrativi snelli e sicuri) e contenzioso 12) Strategie del patrimonio per l’Ateneo metropolitano multi-campus. L’incarico primario dei prorettori è la traduzione delle linee strategiche connesse alle loro deleghe. I Direttori di Dipartimento dell’Area Biomedica, tutti rappresentati nel Comitato della Scuola della Salute Umana (COSSUM), devono sostenere il Rettore nelle strategie su sistema sanitario, integrazione e salvaguardia della specificità universitaria, in collaborazione con una commissione del CdA. Altre deleghe distinte, ma informate da principi analoghi di competenza, responsabilità e impegno, riguarderanno le responsabilità accademiche presso i Centri di servizi di Ateneo, le partecipate quali Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e PIN, il DIPINT, altri comitati e commissioni rilevanti per le strategie di Ateneo. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 14 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Professionalità e cultura di progetto nell’amministrazione Prospettive da realizzare da ATTRARRE e COMPETERE - costruire solide opportunità di progressione di carriera; allargare il reclutamento di giovani ricercatori, anche dall’estero, su progetti di eccellenza da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - aiutare chi lavora nell'Università, in ogni settore, ad affrontare il cambiamento e l'innovazione in modo sostenibile; da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - promuovere aggiustamenti mirati dello Statuto di Ateneo sulla base di un riscontro puntuale con le esigenze di efficienza ed efficacia nell’azione politica e nelle attività di strutture e personale; - potenziare formazione e qualificazione professionale del personale; adattare gli strumenti operativi per rendere sostenibile, proficuo e gratificante il lavoro quotidiano; - estendere e approfondire il supporto informatico e alla comunicazione per didattica, ricerca, valutazione e per attività gestionali-amministrative; - promuovere confronto per obiettivi con le rappresentanze del personale. La prossimità, in qualità di ricercatore e docente prima e di prorettore dopo, con il mondo del personale tecnico-amministrativo, mi ha permesso di acquisire consapevolezza di una realtà ricca anche se spesso in difficoltà. Occorre quindi prestarvi grande attenzione secondo pochi ma fondamentali principi: - dare voce ed evidenza alle professionalità presenti in Ateneo; valorizzare le competenze anche in vista della crescita professionale; realizzare pari opportunità; coinvolgere il personale e le rappresentanze in progetti di miglioramento e innovazione nelle funzioni di servizio dell’ateneo; in definitiva, promuovere e mantenere un sistema di relazione con il personale che consenta di monitorare i bisogni legati all’organizzazione della struttura tecnico-amministrativa, parte essenziale e strategica del buon funzionamento dell’Ateneo. In questo senso, non si può prescindere da un’organizzazione del lavoro costruita per progetto, inteso come declinazione operativa delle linee strategiche e quindi progettuali di Ateneo. Tutto il personale infatti è chiamato a far parte, ognuno sulla base delle proprie competenze, della filiera amministrativa che di fatto realizza, trasformandola in prodotto e servizio all’utenza interna ed esterna, la missione strategica di Ateneo. Lungi quindi dall’essere parte del meccanismo impersonale di una sterile catena di montaggio, il collega tecnico-amministrativo diventa così parte attiva e creativa dei processi strategici dell’Ateneo. Un processo di cambiamento culturale è in atto: l’emergere, fra tante inerzie e contraddizioni, della consapevolezza del ruolo chiave del personale che si occupa della gestione dell’attività amministrativa, contabile e finanziaria, nonché delle competenze tecnico-scientifiche indispensabili al funzionamento di infrastrutture e laboratori di ricerca e didattici e di servizi assistenziali in stretto contatto con studenti, ricercatori in formazione, docenti e pazienti. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 15 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Le nuove assunzioni e le promozioni di carriera dovranno essere articolate in un progetto per la gestione del pregresso (graduatorie aperte, contratti a termine) e uno per la programmazione futura, in condivisione con la Direzione Generale e le Rappresentanze sindacali. Sul piano della valorizzazione della professionalità va oramai considerata come attuabile l’ipotesi di una partecipazione attiva da parte del personale tecnico alla attività scientifica all’interno dei progetti di ricerca e/o di trasferimento delle conoscenze, anche con ruoli di responsabilità. La produzione scientifica di tecnici e tecnologi, introdotti dalla legge 240/2010, e dei collaboratori linguistici troverà spazio nel repository di Ateneo, IRIS, e nella sua interfaccia pubblica, FLORE. Ho raccolto in questi giorni segnali di una grande apertura a un confronto pacato e ordinato. Ho ricevuto e dato la disponibilità a lavorare insieme al Direttore Generale e alle Rappresentanze sindacali per giungere a soluzioni condivise su alcuni punti che mi sono stati sollevati: conoscenza e compartecipazione al lavoro degli organi di governo; continuità delle varie forme di progressione economica; posizioni di responsabilità che valorizzino le professionalità esistenti in particolare su funzioni chiave per le missioni fondamentali di formazione, ricerca, terza missione, internazionalizzazione. Una particolare attenzione va dedicata ai servizi di supporto e sociali (asili nido, benefit socio-sanitari e assicurativi), alle esigenze e alla valorizzazione del personale diversamente abile, al benessere e alla sicurezza lavorativa del personale di front office dell’Ateneo. Infine, va analizzata con attenzione la situazione complessa e le esigenze derivanti dalla missione specifica del personale tecnico-amministrativo funzionalmente assegnato alle Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer. Fra i tanti ruoli presenti in Ateneo, che meritano attenzione, richiamo per esemplificazione quello del personale Bibliotecario. La premessa è che le Biblioteche, insieme ad altri centri quali il Museo di Storia Naturale e la FUP, sedi di patrimonio culturale e di specifiche funzioni di servizio alla didattica e alla ricerca, costituiscono una fondamentale infrastruttura di confronto culturale e divulgazione dell’Ateneo, e questo carattere dovrà essere potenziato con progetti che coinvolgano insieme responsabili accademici e personale tecnico amministrativo. Il personale Bibliotecario ha competenza e attitudine, ma necessita di essere reintegrato per mantenere ed ampliare l’orario di apertura, con la copertura dei vuoti di organico determinati dai pensionamenti, incentivazione delle turnazioni del personale delle biblioteche per estendere l’orario di apertura e di erogazione dei servizi. I provvedimenti per rendere effettivi gli accorpamenti delle biblioteche devono avere priorità al fine di ottimizzare risorse e umane e qualità del lavoro eventualmente diversificando le regole di frequenza fra biblioteche con testi di grande valore (specifiche ad esempio dell’area umanistica e delle scienze sociali), da quelle fruibili in modo meno controllato. In generale i risultati dei processi e dei progetti, il cui valore dipende anche dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva e creativa da parte del personale tecnico amministrativo, devono essere misurati e valutati con metodologie adeguate e, in caso di raggiungimento degli obiettivi, premiati. Il mio essere donna e madre, prima di essere ricercatore, mi consente di comprendere quanto sia preziosa la capacità di fronteggiare difficoltà ed emergenze propria dell’approccio femminile. È un valore su cui punto fermamente; in particolare pensando a forme alternative di lavoro e di supporto sociale finora nemmeno prese in considerazione, quali il telelavoro, voucher per baby-sitter, orari differenti che consentano di conciliare i ritmi familiari con quelli lavorativi, e che permettano di contribuire attivamente all’attività quotidiana dell’ateneo in momenti di difficoltà di spostamento casa-lavoro. Anche questa è cultura di processo e di progetto. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 16 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Controllo di bilancio per sostenibilità delle strategie Prospettive da realizzare da ATTRARRE e COMPETERE - costruire solide opportunità di progressione di carriera; allargare il reclutamento di giovani ricercatori, anche dall’estero, su progetti di eccellenza; da CONSOLIDARE SOSTENIBILITÀ E AUTOREVOLEZZA - mantenere le quote di finanziamento statale ordinario; espandere i finanziamenti e le entrate su progetti di alta formazione, ricerca e innovazione a livello nazionale e internazionale; - utilizzare coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale. La politica di bilancio prudenziale degli ultimi anni ha consentito di costruire una prospettiva solida, volàno per iniziative del sessennio 2015-2021 mirate a innalzare gli standard della ricerca e didattica, ampliarne gli orizzonti e accrescerne le risorse. Il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio e la presenza di risorse disponibili per realizzare quanto sopra derivano da dismissioni e razionalizzazioni patrimoniali, tra le quali si ricorda la drastica riduzione degli affitti, e soprattutto la significativa riduzione delle risorse umane – docenti, ricercatori e personale TA – che da un livello percentualmente maggiore paragonato ad atenei di dimensioni simili, rispetto al numero di studenti, si è gradualmente assestato. Da alcuni anni a questa parte, il rapporto studenti/docenti è pressoché stabile intorno a 28; ulteriori diminuzioni delle risorse umane rischierebbero di innescare una spirale di regresso con riduzioni delle quote di finanziamento ministeriale e dei finanziamenti da altri progetti. Al contrario, una politica di rilancio è parte integrante dei motivi della mia candidatura. Il blocco del turnover è terminato per l’Ateneo e una meditata, armonizzata ma decisa azione di reclutamento, in particolare di Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B e di progressione in ruolo va attuata di concerto con la realizzazione del piano strategico di Ateneo e con una costante attenzione ai criteri premiali del FFO, migliorando l’esperienza maturata negli ultimi anni. Questo è ancor più vero in considerazione della disomogenea diminuzione delle risorse umane, che è risultata spesso non correlata con le necessità didattiche, per il ruolo docente e ricercatore, e alle esigenze di funzionamento dei servizi per il personale amministrativo e tecnico. La politica di investimenti va estesa alla definizione del patrimonio edilizio, in termini di acquisizioni, dismissioni e manutenzione, un politica attenta che renda l’Ateneo proprietario degli edifici di cui ha necessità permanente e imprescindibile, che limiti la dispersione sul territorio in particolare nell’ambito dello stesso Dipartimento e preveda/programmi le necessità didattiche dei prossimi anni, per numero e dimensioni del CdS. Su questo punto si rimanda anche alla scheda “Un Ateneo metropolitano multi-campus: progetto da completare”. È necessario migliorare la capacità di monitoraggio del progressivo formarsi del risultato di bilancio; l’incertezza sull’entità del FFO porta inevitabilmente a stimare al ribasso ricavi e in rialzo i costi, in via prudenziale. Il monitoraggio può consentire sia ulteriori economie basate su innovazione nei processi e più efficace controllo di gestione, sia forme di assestamento per impiegare gli avanzi emergenti, in contabilità economica, limitando l’incremento del patrimonio netto. Gli avanzi potranno essere destinati a UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 17 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai investimenti su snodi essenziali quali valorizzazione del personale (professionalità, incentivazione, trattamento accessorio), politiche di sostenibilità ambientale (risparmio energetico, acquisti, mobilità e rifiuti), e in generale implementazione della strategia “Smart Hub”, che contiene una forte spinta innovativa nell’ambito dei servizi agli studenti. Il supporto al reperimento di entrate extra-FFO sia pubbliche (bandi competitivi nazionali e comunitari, dal sistema sanitario) sia private (ricerca convenzionata, entrate dalla didattica extra-curriculare) è mirato ad aumentare le risorse per ricerca e formazione per i Dipartimenti. Il prelievo di Ateneo è stato ridotto per queste voci nel 2014-15 e l’obiettivo è dare continuità a una politica di basso prelievo. Il prelievo, soprattutto se sostenuto in assoluto da un aumento delle attività svolte contribuirà insieme ad altre fonti interne ed esterne allo sviluppo dei servizi stessi, al finanziamento dei bandi di ateneo (ex-60%, cofinanziamento assegni, dottorato), a progetti speciali nel campo della didattica (tutor, borse di merito) e della ricerca (bandi su progetti strategici per ricerca di base; scavi archeologici), sulla scorta di quanto attuato nel 2014-15. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 18 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Dialogo inter-istituzionale e rapporti col sistema territoriale Prospettive da realizzare collegate da CONSOLIDARE SOSTENIBILITÀ E AUTOREVOLEZZA - rafforzare la riconoscibilità locale e internazionale di forti aree di ricerca e innovazione in tutti i dipartimenti, il valore del senso di appartenenza della comunità studentesca, la comunicazione dell’identità dell’Ateneo entro la varietà delle sue attività e delle sue anime - utilizzare coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - estendere e approfondire il supporto informatico e alla comunicazione per didattica, ricerca, valutazione e per attività gestionali-amministrative L’Università di Firenze contribuisce ai processi della società come presidio di civiltà e motore di progresso sociale ed economico. Questo ruolo si associa a quello di grande nodo di reti sociali aperte e dinamiche, l’attivazione di moltiplicatori economici nei territori di insediamento con la sua grande comunità di personale, studenti, collaboratori, colleghi e visitatori per convegni e altro, e anche coi suoi rilevanti patrimoni tecnici - edilizi e culturali. Gli effetti si estendono a distanza, sono continui e intensi nei territori di insediamento, cioè in Toscana e in particolare nella città metropolitana fiorentina e nelle province vicine. Qui l’Università deve trovare anche la conciliazione con le proprie esigenze logistiche, di servizi di diritto alla studio, accoglienza e mobilità degli studenti, di facilitazione o cofinanziamento per investimenti infrastrutturali. Infine l’Università può e deve giocare un ruolo di attore fondamentale, col sistema delle proprie competenze di formazione, ricerca e innovazione, nel contributo alle istituzioni ed enti del territorio impegnati in progetti e politiche di sviluppo e sostenibilità di tipo economico, socio-culturale, giudiziario, sanitario, ambientale, energetico, della mobilità, ecc. Ruoli ed esigenze come sopra richiamati richiedono di rafforzare entro il governo di Ateneo forme e strumenti di approccio al Dialogo inter-istituzionale. Le forme devono essere caratterizzate da: - approccio alle collaborazione negli ambiti sopra richiamati (vedi anche scheda III missione), fuori da pratiche spartitorie localistiche o individuali; ascolto di consigli e sollecitazioni da soggetti esterni per migliorare pratiche e performance, ma ferma e costante richiesta di disponibilità a interlocutori esterni di rivolgersi a UNIFI come sistema; costanti rapporti con Enti locali e Pubblica sicurezza su temi di ordine e prevenzione di illegalità; rafforzamento della rete con altre università toscane e nazionali ed organismi della ricerca pubblica, rifuggendo da soluzioni semplicistiche (es. Università della Toscana); apertura di un confronto più ampio con altre accademie italiane e straniere presenti nel territorio; attenzione specifica ai temi del sistema sanitario regionale (vedi scheda sanità); UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 19 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai - supporto a infrastrutture di ricerca europee a guida toscana (vedi scheda ricerca); gestione sistematica di criticità in rapporti territoriali (come es. aeroporto) e di opportunità legate alla visione multi-campus (vedi scheda), col solido fondamento della tutela di investimenti pubblici. Gli strumenti vanno sviluppati a partire dall’azione di un prorettore con delega specifica, che si avvarrà in un primo momento di competenze e risorse presenti in alcuni Centri di ateneo e Dipartimenti. Il ruolo del Rettore direttamente e tramite la CRUI dovrà essere visibile nei rapporti con MiUR e ANVUR sugli aspetti che hanno ricadute in termini di finanziamento e funzionamento dell’Ateneo e in generale su tutto ciò che incide sull’autonomia dell’Università. Specifica attenzione riserverò al tema della valutazione, anche in virtù dell’esperienza internazionale e di Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Roma La Sapienza. La prolissa procedura di misurazione dell’attività dei dipartimenti nella SUA-RD e l’iter ripetitivo di accreditamento dei dottorati, solo per fare due esempi recenti, devono essere rivisti alla luce delle migliori pratiche internazionali. Particolare preoccupazione destano, infine, ulteriori recenti disposizioni in merito a vincoli concernenti il turnover del personale tecnico-amministrativo, segnale di una disattenzione politica al crescente disagio dell’Università anche su fronti diversi da quello pur gravissimo della riduzione del finanziamento statale al funzionamento e alla ricerca. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 20 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Sistema sanitario, integrazione e salvaguardia della specificità universitaria Prospettive da realizzare da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - aiutare chi lavora nell'Università, in ogni settore, ad affrontare il cambiamento e l'innovazione in modo sostenibile; da RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIVERSITÀ - aggiustare e snellire i sistemi di valutazione e di distribuzione delle risorse integrando nel sistema metodologie che consentano decisioni strategiche qualitative. da CONSOLIDARE SOSTENIBILITA’ E AUTOREVOLEZZA - mantenere le quote di finanziamento statale ordinario; espandere i finanziamenti e le entrate su progetti di alta formazione, ricerca e innovazione a livello nazionale e internazionale; - utilizzare coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale. da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - definire il piano strategico dell’Ateneo 2016-2018 mediante il confronto tra organi di indirizzo politico e Dipartimenti e definire di conseguenza il mandato a livello gestionale; - promuovere aggiustamenti mirati dello Statuto di Ateneo sulla base di un riscontro puntuale delle esigenze di efficienza ed efficacia nell’azione politica e nelle attività di strutture e personale; - promuovere confronto per obiettivi con le rappresentanze del personale. L’attività clinica e preclinica dell’area biomedica è una risorsa per l’Università di Firenze, per il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per il territorio di riferimento. L’importanza di tale risorsa anche nel contesto italiano è stata dimostrata anche dalla VQR nazionale, che ha evidenziato l’alto e diffuso livello qualitativo che caratterizza la ricerca clinica e biomedica svolta in UNIFI. L’attività di ricerca di UNIFI e il suo alto livello qualificano le attività assistenziali e didattiche svolte nella Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU) fiorentine, contribuendo in maniera determinante alla loro alta attrattività e competitività dimostrata negli ultimi anni. Come Rettore, avrò tra i miei compiti quello di sostenere e tutelare tali risorse, indicandone modalità di sviluppo e necessità per garantirne crescita culturale scientifica e tecnologica, di concerto con la Regione Toscana. Tuttavia affinché UNIFI possa svolgere pienamente la sua missione anche in ambito assistenziale, sarà fondamentale un supporto adeguato da parte del SSR e del territorio di riferimento. Ritengo che compito del Rettore e del governo dell’Ateneo sia quello di sviluppare e mantenere nel tempo accordi con le Istituzioni sanitarie locali adeguati a tal fine. La missione delle Università in campo sanitario è stata definita da decenni dalla legislazione nazionale. Questa consiste in un’attività assistenziale da perseguirsi insieme a quella di didattica e di ricerca. La normativa esistente inoltre stabilisce che il principio caratterizzante dell’attività del personale universitario interessato è l’inscindibilità delle tre funzioni e la persistenza della dipendenza del docente/ricercatore UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 21 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai universitario dal proprio ordinamento anche quando impegnato nelle attività assistenziali, per cui nello svolgimento di queste attività il rapporto con l’ordinamento ospedaliero è esclusivamente funzionale. I compiti assistenziali dell’Università possono essere modernamente declinati come segue: • ricerca clinica, rafforzata dalla collaborazione con la ricerca preclinica, caratteristica esclusiva dell’Università; • formazione pre- e post-laurea di personale medico, infermieristico e delle professioni sanitarie; • trasferimento rapido dell’innovazione biomedica all’assistenza, alla formazione e allo sviluppo industriale; • diffusione e trasmissione di una cultura che incoraggi e sostenga capacità di critica e indipendenza di pensiero, necessarie per interpretare senza condizionamenti i risultati della ricerca, per una rapida selezione e trasferimento all’attività assistenziale delle innovazioni, e per gestire appropriatamente i conflitti di interesse potenziali intrinseci nella ricerca clinica “profit”. L’Università ha quindi il compito di fungere da catalizzatore, promotore e guida della ricerca, formazione e innovazione anche per il sistema sanitario, che di per sé non possiede strumenti organizzativi e culturali finalizzati a tali obiettivi (a Firenze, solo una parte minima della produzione scientifica in campo biomedico proviene da gruppi di ricerca non universitari). Questi invece possono naturalmente essere perseguiti al meglio grazie alla sinergia, all’integrazione e alla collaborazione tra SSR e l’Università che vogliamo. Ritengo pertanto necessaria anche una decisa azione informativa e formativa sull’attività assistenziale di UNIFI verso i cittadini e le loro rappresentanze politiche e sindacali, nella consapevolezza che la missione assistenziale svolta da UNIFI assume anche un importante valore sociale. Infatti è interesse primario dei cittadini, specialmente quelli appartenenti alle fasce più deboli, la prossimità con una sanità moderna e aperta all’innovazione, come solo il rapporto con l’Università garantisce. La storia recente insegna che il perseguimento di un’integrazione virtuosa tra l’ordinamento universitario e quello del SSR non è stato e non è privo di criticità, conseguenti ai numerosi vuoti normativi e in parte attenuate dai Protocolli d’Intesa regionali e dalla predisposizione di Statuti Aziendali delle AOU (gli Atti) condivisi a tutti i livelli di governo dell’Università e dalle rappresentanze sindacali universitarie mediche. Tali criticità tuttavia sono riemerse dopo l’introduzione della nuova governance universitaria prevista dalla legge 240 del 2010, che ha abolito le vecchie Facoltà e con queste anche il ruolo che di fatto la Facoltà di Medicina svolgeva nei rapporti con il SSR. A Firenze, la Facoltà è stata sostituita da cinque Dipartimenti i cui compiti assistenziali sono ambiguamente definiti dalla nuova normativa e il cui stesso numero ne ha frammentato l’unità di fini e l’efficacia di indirizzo strategico. Negli ultimi anni si è assistito, infatti, a un indebolimento a livello nazionale dell’iniziativa e della forza negoziale dell’Università italiana nel sostenere le proprie missioni istituzionali legate all’assistenza e quelle dei propri docenti/ricercatori nei confronti di interessi – spesso contrastanti - presenti nel SSN-SSR. A Firenze l’attività clinica universitaria è resa ancor più complessa dall’interfacciamento con due Aziende Ospedaliero Universitarie, Careggi e Meyer, diverse per dimensioni e missione. La perdita di risorse umane, potere di indirizzo e spazi in tali AOU sta delineando un ridimensionamento drastico delle capacità di UNIFI di svolgere adeguatamente le proprie missioni e quindi anche della possibilità dei docenti/ricercatori universitari, in particolare i più giovani, di costruirsi la propria carriera con gli strumenti della produzione scientifica di alto livello. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 22 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai In tale contesto già critico, gli iscritti ai Corsi di Studio a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria sono aumentati, le risorse per la didattica e per le ricerca clinica sono state ridotte e Corsi e scuole di specializzazione riorganizzati. Si aggiungano alcune circostanze che richiedono un’adeguata e condivisa riflessione: - il ruolo assunto nei rapporti con le AOU da parte di un Comitato Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana (COSSUM), deputato a esprimere pareri e proposte in ordine alle attività e agli atti di competenza del Rettore relativi al concerto con la Regione Toscana, rivelatosi insufficiente rispetto al complesso compito che deve svolgere; - una modifica dell’Atto Aziendale di AOU Careggi, maturato in una fase di riorganizzazione dell’Ateneo, che ha acuito le difficoltà preesistenti e ne ha create di nuove (ad esempio introducendo la previsione che il Dipartimento Inter-istituzionale, che per anni ha svolto compiti amministrativi essenziali per l’area biomedica, possa diventare un Dipartimento ad attività Integrata dell’Azienda Careggi, DAI, sotto il diretto controllo della Direzione Generale aziendale); - l’interpretazione della dipendenza funzionale dall’AOU dei docenti/ricercatori con attività assistenziale come premessa all’assoggettamento a norme proprie dell’ordinamento ospedaliero, che possono costituire un potenziale vulnus allo svolgimento di attività di ricerca e trasferimento proprie dei docenti/ricercatori universitari; - la normativa nazionale sulle scuole di specializzazione di area medica, che con l’introduzione del cosiddetto “doppio binario” di formazione rischia di svuotarne finalità e contenuti. In conclusione nell’Università di Firenze si è venuta a creare una “questione medica e assistenziale” che richiede una proposta specifica e incisiva. Il modello toscano di integrazione tra Università e SSR non è in discussione, ma almeno a Firenze è necessaria una messa a punto delle sue modalità, soprattutto nel contesto di una normativa sanitaria regionale recentemente rinnovata con la Legge del Marzo 2015. Nella volontà e necessità di una stretta collaborazione con le AOU di riferimento, Careggi e Meyer, e nel rispetto della sostenibilità economica del sistema, va riaffermata la centralità dell’Università nella formazione e nella ricerca e la loro inscindibilità dall’assistenza, impedendo che prevalga una logica aziendalista puramente ospedaliera. Per un aggiornamento del modello organizzativo assistenziale delle AOU di riferimento dell’Università di Firenze, la mia attenzione si focalizzerà prioritariamente: • sulla valutazione congiunta delle tre missioni universitarie, anche in relazione alle risorse disponibili, e la conseguente valorizzazione dei più brillanti fra i docenti e ricercatori che svolgono le attività assistenziali, attraverso il reclutamento e la progressione nei ruoli universitari; • su un’organizzazione assistenziale che sia funzionale anche alle missioni universitarie e che permetta di ampliare gli spazi per l’innovazione (sperimentazioni cliniche) e l’internazionalizzazione (nella didattica multilinguistica; in percorsi innovativi di MD/PhD, nell’attrazione di studenti stranieri; nella cooperazione; negli scambi di studenti e docenti; nella collaborazione a iniziative come Meyer Health campus). Come Rettore, mi impegnerò quindi affinché nelle AOU di riferimento sia garantita un’attività assistenziale che: UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 23 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai • permetta uno stretto legame con l’attività di ricerca creando le condizioni per un suo rapido trasferimento all’assistenza e alla formazione; questo attraverso spazi e carichi di lavoro adeguati e un accesso alla casistica appropriata alla missione didattica e alle competenze di ricerca di ciascuno; • rispetti e valorizzi le articolazioni specialistiche delle conoscenze mediche (definite in campo internazionale su basi culturali e dalla pratica clinica, per organi/apparati o per metodi), attraverso articolazioni organizzative adatte a realizzare obiettivi di ricerca clinica anche focalizzati all’interno di ogni disciplina/specializzazione; • consenta a docenti e ricercatori condizioni per una produzione scientifica quali-quantitativamente adeguata alla propria progressione di carriera; • sia dimensionata adeguatamente in termini di spazi e risorse umane assegnati alle articolazioni specialistiche; in particolare, la rimodulazione degli spazi deve preservare le potenzialità di ricerca e didattiche. A questo fine è necessario pensare anche a forme di collaborazione innovative tra Università ed AOU, come in particolare attraverso: • istituzione di Laboratori Congiunti, per esempio per l’utilizzazione anche per fini scientifici delle grandi attrezzature e delle competenze presenti nelle AOU; • istituzione di un Clinical Trial Center che fornisca supporto organizzativo e culturale a tutti i trial clinici e favorisca l’attrattività di AOU per tali attività ; • sviluppo di attività di ricerca e formazione comuni tra Università e AOU; • aggiornamento del ruolo e delle funzioni del DIPINT; • promozione delle politiche sinergiche tra AOU e UNIFI in tema di reclutamento su posizioni universitarie con profilo assistenziale; • riconoscimento dei costi delle attività assistenziali universitarie: aggiuntivi, legati alla complessità anche in termini culturali della casistica afferente nelle AOU, alla dilatazione dei tempi dell’attività assistenziale associata a didattica e ricerca; minori, legati al costo orario dell’attività assistenziale dei docenti/ricercatori universitari, riconosciuto finora al DIPINT; • interpretazione condivisa delle norme che regolano i rapporti dei docenti universitari con il SSR, al fine di raggiungere regole condivise fra i due ordinamenti; • internazionalizzazione dell’offerta assistenziale: la qualità dell’assistenza offerta dalle AOU fiorentine è – in generale - di livello europeo e svolta a costi assai competitivi: un’organizzazione che sia capace di attrarre a ricevere pazienti stranieri entrando in competizione con altri Centri universitari europei che hanno fatto di tale attività uno strumento di sviluppo del paese, è possibile ed auspicabile; • potenziamento dell’attrattività dei Corsi di Studio dell’Area biomedica anche verso studenti fuori sede e stranieri, mediante corsi in lingua inglese, sperimentazione di percorsi di eccellenza come MD/PhD, produzione di corsi erogati in modalità e-learning capaci di migliorare e ottimizzare i processi di apprendimento, nella consapevolezza della difficoltà di tali sfide nella formazione professionalizzante e nei tirocini di materie cliniche; • di Master e Corsi di Dottorato di ricerca, di Corsi di perfezionamento e per l’Educazione Continua: si ritiene il supporto di corsi di questo tipo una priorità dell’Università di Firenze per le grandi potenzialità di sviluppo di collaborazioni internazionali e per le ricadute sul territorio che essi offrono. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 24 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Gli strumenti di tale recupero saranno la revisione/aggiornamento di: • protocolli d’intesa Università Regione Toscana, per recuperare i principi fondanti più virtuosi del rapporto tra i due ordinamenti; • modalità di valutazione e remunerazione delle attività assistenziali svolte nelle AOU fiorentine, con particolare attenzione a quelle di maggiore interesse universitario; • Atto Aziendale delle AOU fiorentine, anche per adeguarlo alla nuova Organizzazione sanitaria toscana; • interpretazione delle norme che regolano i rapporti con il SSR del personale docente e ricercatore universitario; • modalità di interfacciamento di UNIFI con le AOU fiorentine, che includa una revisione di compiti, composizione e procedure del COSSUM; con l’occasione della fine della fase di sperimentazione dello Statuto di UNIFI, parte integrante di tale revisione sarà anche il ripensamento delle funzioni dei Dipartimenti universitari dell’area Biomedica e, se sostenuto da chiare basi scientifiche e prospettive formative e culturali, della loro composizione; • ruolo del DIPINT in funzione di un supporto reale alle attività di ricerca delle AOU fiorentine; • ruolo delle rappresentanze sindacali universitarie nella negoziazione con AOU Careggi, per la quantificazione dell’orario e del costo del lavoro dei medici universitari. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 25 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Cantieri Formazione, innovazione didattica, costi standard e diritto allo studio Prospettive da realizzare da ATTRARRE E COMPETERE - aumentare il numero e la qualità di studenti in ingresso, in particolare di secondo e terzo livello, e la capacità di attrarre studenti e dottorandi dall’estero; - costruire solide opportunità di progressione di carriera; allargare il reclutamento di giovani ricercatori, anche dall’estero, su progetti di eccellenza; - facilitare la presenza di ricercatori e docenti stranieri per una didattica plurilinguistica e multiculturale; - mappare e razionalizzare le infrastrutture didattiche e di ricerca come basi per l’eccellenza, l’innovazione, il confronto culturale. da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - promuovere un ambiente di studio creativo e innovativo che stimoli negli studenti capacità progettuali e critiche e faciliti il confronto con società e impresa; - sostenere avvii rapidi a lavoro di qualità per laureati e dottori di ricerca; aumentare il numero e il valore di invenzioni riconosciute e di imprese innovative e dinamiche che escono dalla ricerca e dalla formazione accademica. da RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIVERSITÀ - potenziare le sfere di formazione e ricerca interdisciplinari sulle grandi sfide sociali. Nell’indagine Censis 2014/2015 l’ateneo di Firenze si è ben collocato. Per servizi, borse, strutture, web e internazionalizzazione si è posizionato al terzo posto tra i mega atenei dopo Bologna e Padova (Classifica Censis, http://www.censismaster.it/document/it/Mega_Atenei_La_classifica_Censis_delle_universita_2014-2015/news). L’offerta formativa di Firenze, pubblica e privata, nazionale e internazionale si confronta con i grandi Atenei vicini come quelli di Pisa, Siena e di Bologna. In questo ambito è necessario utilizzare la positiva esperienza maturata per affrontare le prossime sfide nella formazione e nella ricerca con l’obiettivo di attrarre e trattenere studenti, ricercatori e docenti di alto livello. Importante premessa è il superamento dell’apparente dicotomia tra ricerca e didattica, tradotta spesso nella distinzione tra research e teaching-university; essa trova oggi più che mai una sintesi nel maggiore coinvolgimento dei Dipartimenti nella programmazione didattica istituzionale oltre che nella ricerca. Dunque la sfida dell’Ateneo nei prossimi anni si riassume nel mantenimento di un’offerta generalista sui CdS triennali e l’ampliamento ragionato e sostenibile delle offerte di secondo e terzo livello. Per le lauree triennali, si deve alleggerire l’estensione (ma non la qualità) dell’impegno didattico mediante l’adozione di metodi innovativi di insegnamento, l’utilizzazione di e-learning e blended-learning, l’introduzione mirata di soluzioni innovative (per esempio, Massive Open Online Courses, MOOCs). Al UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 26 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai tempo stesso, occorre rafforzare le abilità di base (informatiche, linguistiche) acquisite dagli studenti, anche per le aree umanistiche e delle scienze sociali. Per le lauree magistrali (LM) l’offerta formativa deve essere potenziata attraverso progetti didattici che intercettino (i) nuove professionalità, (ii) percorsi di ricerca interdisciplinari, (iii) aree “di nicchia” (qualità nella tradizione legate alla storia e al territorio di riferimento; ricostruzione dell’immagine UNIFI), e il potenziamento dei percorsi formativi con maggiore attrattività e capacità di rapporto con il settore produttivo. Questo è indispensabile nella competizione nazionale/internazionale per un Ateneo di grandi dimensioni. La maggiore attrattività dovrebbe infine realizzarsi attraverso una minore rigidità nella scelta del percorso formativo per le LM; l’individuazione di percorsi di eccellenza (anche per laureati triennali e a ciclo unico); il rafforzamento del concetto di campus o “didattica di prossimità” grazie a interventi su infrastrutture didattiche (laboratori, biblioteche); un deciso investimento nella sperimentazione e nell’estensione di servizi innovativi per la didattica e per l’accoglienza degli studenti. Le nuove tecnologie: l’uso delle nuove tecnologie nella didattica deve essere finalizzato al dialogo costruttivo docenti/studenti che consenta la partecipazione più attiva alle lezioni, nonché all’impiego del materiale didattico prodotto anche come veicolo promozionale e di presentazione del nostro ateneo. La creazione di una didattica on line, anche solo integrativa, può inoltre consentire di ripensare il rapporto studio/lavoro permettendo anche ai lavoratori di fruire delle lezioni nel pieno rispetto dell’autonomia del singolo docente e della libertà di insegnamento. La didattica on line è già un’esperienza presente, si tratta di diffonderne l’uso positivo anche con supporti ad hoc ai corsi di laurea e con meccanismi incentivanti. Rapporto con il mondo del lavoro: Questo è un obiettivo sottolineato più volte dagli studenti, a ragione. Per incrementare il positivo collegamento tra didattica e mondo del lavoro occorre agire su più fronti: (i) integrare ore di didattica frontale con seminari tenuti da qualificati operatori e professionisti; (ii) presentare, anche nell’orientamento in ingresso, figure che ricoprono determinati ruoli professionali nella vita e sul mercato; (iii) ottenere feedback relativamente ai contenuti dei nostri corsi al fine di trarre possibili suggerimenti; (iv) creare contatti con il mondo del lavoro realizzando ed estendendo l’esperienza del Cantiere del lavoro e dell’intraprendenza (http://www.unifi.it/vp-7470-orientamento-al-lavoro-e-jobplacement.html); (v) offrire concrete opportunità formative ai nostri studenti e dottorandi per progettare la propria carriera. È da ricercare e guidare - nel pieno rispetto dell’autonomia - il dialogo con il mondo delle imprese anche nella prospettiva di dar vita a corsi o moduli che possano loro interessare. Internazionalizzazione. Particolare rilevanza ha assunto in questi anni la didattica in inglese o in altra lingua veicolare. È importante perseguire questa strada tramite corsi di laurea in lingua straniera o che prevedano insegnamenti in lingua straniera. I corsi impartiti in lingua straniera non solo rappresentano un canale di attrattività dall’estero ma consentono ai nostri studenti di interagire in un ambiente internazionale. Il tutto va realizzato nella consapevolezza che la presenza di una buona didattica in lingua italiana veicola la nostra cultura ed è particolarmente ricercata anche in quelle lauree, sanitarie ad esempio, per le quali il contatto con l’utente-paziente è parte integrante nella formazione dello studente straniero. Studenti e diritto allo studio. La didattica rimane un diritto fondamentale dello studente e del docente. In questa prospettiva è auspicabile la previsione di un governo della didattica più flessibile, soprattutto nelle LM, che consenta al docente di perseguire logiche di efficacia e ragionevolezza in relazione alle caratteristiche (per contenuti della materia, numero degli studenti, livello degli studenti) del singolo insegnamento. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 27 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai L’attrazione degli studenti, locali e fuori sede, richiede anche di individuare strumenti di migliore dialogo interistituzionale: assegnazione delle borse di studio per i più capaci e meritevoli, un più attivo supporto nel reperimento degli alloggi, una maggiore offerta di servizi di mensa, una migliore comunicazione sia attraverso strumenti web sia attraverso la valorizzazione del servizio delle segreterie volto anche all’attrazione e all’accoglienza degli studenti stranieri, una migliore manifestazione del valore del nostro ateneo all’esterno. In questo quadro risulta indispensabile il rafforzamento della concertazione con MIUR, Regione e Comuni perché tutti collaborino, in quanto parti interessate, per migliorare il diritto allo studio e alla formazione. Terzo livello di formazione. Non mancheremo di riservare uno spazio adeguato alla didattica post laurea che consenta elevati livelli di aggiornamento professionale attraverso Master e Corsi competitivi nel mercato internazionale. Appare particolarmente importante investire per qualificare il III livello della formazione con corsi in lingua, l’utilizzo di new media e tecnologie all’avanguardia; l’inserimento nell’offerta didattica di moduli con impronta industriale; l’acquisizione di crediti da corsi al di fuori della specifica area di ricerca dello studente. Il dialogo tra didattica e ricerca dovrebbe inoltre riflettersi nelle politiche di reclutamento e progressione orientate alla selezione di giovani ricercatori che presentino alti profili di curriculum nella ricerca e di docenti che oltre all’eccellenza nella ricerca abbiano maturato adeguata esperienza nella didattica e nel servizio alle istituzioni. Rimane centrale il ruolo delle scuole di dottorato come incubatore privilegiato per la formazione di giovani ricercatori. Anche sotto questo profilo il dottorato di ricerca occupa uno spazio importante nel III livello della formazione. Esso deve offrire un percorso di studio avanzato che coniughi profili teorici e pratici dei diversi campi che interessano la comunità nazionale e internazionale. Per questo gli studi dottorali dovranno essere il più possibile inter e pluridisciplinari. In questo quadro appare importante aumentare il grado di internazionalizzazione dei nostri dottorati attraverso l’estensione dello svolgimento di lezioni in lingua straniera, l’organizzazione di cicli seminariali in collaborazione con dottorati stranieri gemellati con UNIFI, l’organizzazione e finanziamento di periodi di ricerca o di corso all’estero, la promozione di gemellaggi con dottorati internazionali affini, gli scambi paritetici con studenti (sull’esempio dell’attuale Erasmus). Altrettanto utile sarà la collaborazione con Enti, Onlus e Associazioni per il cofinanziamento di borse di dottorato destinate a studenti di paesi emergenti. Un fronte pure da promuovere è quello dei dottorati di ricerca che sviluppano le prospettive di trasferimento delle conoscenze e di job placement tramite convenzioni e collaborazioni con imprese, enti pubblici, federazioni, locali, nazionali ed esteri che mettano a disposizione sedi per lo svolgimento di stage o periodi di alto apprendistato, dottorato industriale. Alla fine del percorso formativo i dottorandi devono dimostrare autonoma capacità di ricerca, adeguate capacità critiche e di analisi valutabili attraverso la stesura della tesi di dottorato. La capacità di presentazione della tesi o di sue parti per pubblicazioni di livello nazionale e soprattutto internazionale dovrà essere sostenuta e considerata parte del percorso e degli obiettivi formativi. La formazione professionale garantita dalle Scuole di Specializzazione di area medica deve rimanere profondamente e culturalmente ancorata alla ricerca Universitaria, difendendola da tentativi di trasferimento in strutture del SSR. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 28 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Qualità e valutazione della didattica. La ricerca di qualità ha la capacità di proiettare l’ateneo fuori dai suoi confini, il trasferimento tecnologico la rende compartecipe e stimolatrice del progresso economico e sociale, la didattica ha il fondamentale compito della formazione dei nuovi gruppi dirigenti. Inoltre, con l’anno accademico 2014-2015, la buona didattica è entrata nel novero degli indicatori che pesano nella distribuzione delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). A differenza della buona ricerca, che pesa e peserà soprattutto nella quota premiale, la buona didattica deciderà le sorti della quota base del FFO. I parametri di riferimento con cui dovremo fare i conti saranno essenzialmente quelli dei costi standard e del numero di studenti in corso. Questo significa che il nostro ateneo dovrà dotarsi di una strategia competitiva rispetto agli altri atenei, per sviluppare un’offerta didattica efficace (cioè in grado di attrarre studenti di qualità in numero adeguato a un mega-ateneo e che possano compiere il percorso di studio nei tempi previsti) ed efficiente (cioè con il migliore utilizzo delle risorse esistenti e la migliore allocazione delle risorse future). Per questo è necessaria dotarsi anche di sistemi di valutazione che rispondano a obiettivi da declinare secondo i principi dell’autonomia universitaria. La qualità e l’efficacia della didattica non deriva soltanto dalla capacità del docente ma, come sopra accennato, anche da nuovi strumenti tecnologici e informatici. L’esperienza di e-learning in teleconferenza avviata negli ultimi anni (per esempio, con Teleskill, e altre piattaforme di videoconferenza), affiancate da un uso estensivo di piattaforme di gestione e distribuzione di contenuti (come Moodle), comunque da testare e migliorare. Un maggior ricorso a modalità di e-learning o blended-learning deve garantire un efficiente collegamento di rete in tutte le sedi dell’Ateneo, e la disponibilità di tecnici informatici capaci e attivi in ogni centro di erogazione della didattica. Per i docenti e i dipartimenti che più si impegnano nella sperimentazione devono essere previsti meccanismi incentivanti. Una didattica di qualità è anche garantita da un equilibrato rapporto docenti/studenti, indispensabile per consentire ai primi di seguire e stimolare più da vicino i secondi. Il confronto continuo e personale non può che facilitare la formazione e lo sviluppo della capacità critica degli studenti. Buona formazione significa anche introdurre strumenti che riducano drasticamente abbandoni e lauree tardive; strumenti capaci di aiutare gli studenti a individuare il percorso di studio più rispondente ai loro profili e alle loro aspettative. Risulta inoltre necessario attivare sistemi efficaci di monitoraggio e valutazione della didattica ai quali collegare incentivi per i docenti e i dipartimenti migliori. Razionalizzazione dell’amministrazione della didattica Appare indispensabile una razionalizzazione dei flussi informatici per rendere più agevoli e semplici le procedure amministrative e i processi di documentazione. Tutto ciò per superare alcune criticità, come per esempio: • gestione dei test di autovalutazione (assenza di coordinamento tra segreterie studenti e SIAF); • complicato uso della piattaforma da parte degli studenti per l’immatricolazione (mancanza di coordinamento tra SIAF e segreterie studenti); • inefficienza dell’attuale applicativo per la gestione on line delle tesi che ha complicato la procedura. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 29 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Oltre a ciò occorre un piano generale di migrazione verso il “paperless office” che eviti la frammentazione dei processi e la duplicazione delle attività. Un esempio tipico è quello della verbalizzazione elettronica degli esami che ancora non ha eliminato la firma sul libretto. Si sottolinea la necessità di creare piattaforme partecipative in cui gli utenti possano indicare criticità relative alla didattica, alla governance e alla ricerca. La partecipazione e il confronto costruttivo e continuo fra i diversi attori del processo formativo con gli studenti sono le strategia migliore per il perseguimento dell’obiettivo generale di qualità. La valorizzazione della didattica passa attraverso indicatori di riferimento primo fra tutti l’impegno didattico che deve essere richiesto a ciascun docente che deve svolgere un minimo ore/anno di didattica frontale. Il riferimento di base deve essere integrato con una valutazione del carico didattico effettivamente erogato (es. numero esami, numero tesi, impegno nella didattica di terzo livello, impegno nei laboratori o nelle esercitazioni fuori sede). Si dovrà tener conto per il carico didattico anche di attività di ricerca che richiedano, transitoriamente, attività particolarmente onerose come, ad esempio, il coordinamento di grandi progetti europei. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 30 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Ricerca per l’eccellenza del sapere, la diffusione culturale, l’innovazione Prospettive da realizzare da ATTRARRE e COMPETERE - costruire solide opportunità di progressione di carriera; allargare il reclutamento di giovani ricercatori, anche dall’estero, su progetti di eccellenza; - mappare e razionalizzare le infrastrutture didattiche e di ricerca come basi per l’eccellenza, l’innovazione, il confronto culturale. da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - far emergere e diffondere i risultati di Ateneo e di Dipartimento in termini di ricerca, di innovazione e di diffusione culturale, anche attraverso politiche coerenti con il principio dell’accesso aperto alla letteratura e dati scientifici da RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIVERSITÀ - potenziare le sfere di formazione e ricerca interdisciplinari sulle grandi sfide sociali - aggiustare e snellire i sistemi di valutazione e di distribuzione delle risorse integrando metodologie per decisioni strategiche qualitative - promuovere la ricerca curiosity-driven anche in aree scientifiche di nicchia La ricerca è stata la mia attività principale da trenta anni a questa parte e dal 2009 come Prorettore ho avuto il privilegio di conoscere più da vicino la ricchezza della produzione scientifica dell’Università di Firenze. Nel corso di questi anni abbiamo creato un’area ricerca con una forte impronta internazionale, prima tutt’uno con l’area della didattica. E’ stato un lavoro non facile e si è realizzato grazie anche alla professionalità del personale tecnico amministrativo che ha creduto con determinazione a questo progetto. Questo è insieme un punto di arrivo e partenza per una strategia improntata a: 1. coadiuvare il compito dei dipartimenti, sede primaria della ricerca, vero motore della crescita e dell’innovazione dell’ateneo; 2. attrarre finanziamenti su bandi competitivi, nazionali e internazionali; 3. favorire politiche di integrazione di ambiti disciplinari diversi, con attenzione anche ai centri di ricerca; 4. creare un’interfaccia dinamica con i servizi alla didattica e alla terza missione, per azioni sinergiche su bandi internazionali e nazionali con contenuti formativi e/o reti con imprese ed enti pubblici. La messa a regime e il rafforzamento dei servizi di ateneo con funzioni di acquisizione, monitoraggio e rendicontazione per i progetti a elevata complessità; supporto ai temi di proprietà intellettuale; tutela contrattuale; reclutamento; sfruttamento dei risultati; rapporti con revisori nazionali, europei e di altre istituzioni sono leva di tale strategia nell’ambito della nuova area della ricerca e del trasferimento tecnologico. Ne rappresento qualche ulteriore aspetto nelle altre strategie illustrate di seguito. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 31 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Attrarre risorse, investire nei ricercatori. La maggior parte delle risorse per la ricerca proviene sempre più da fondi esterni, nazionali e più spesso internazionali. Ferma restando l’intenzione di proseguire con bandi di ateneo su aree di ricerca di base come quelli 2014-15, occorre che tutte le aree disciplinari e in particolare i ricercatori più giovani trovino in ateneo un supporto competente e attento. La prospettiva è quella di un servizio che funzioni come una “stampante 3D” dell’idea progettuale del ricercatore, con personale qualificato in grado di ricercare i bandi adatti, aiutare nella formulazione della proposta finale direttamente e attraverso un opportuno supporto ai dipartimenti sulla gestione, la rendicontazione con un monitoraggio attento, interfacciandosi se necessario con la commissione europea o le agenzie regionali. Di tutto questo sono già state gettate le basi, anche grazie a uno sforzo di reclutamento di personale a tempo indeterminato. Le risorse umane e finanziarie attualmente impiegate sono tuttavia insufficienti se rapportate alle dimensioni dell’attività di ricerca e a quelle presenti in altri atenei. Serve uno scatto ulteriore: è necessario coinvolgere i numerosi e riconosciuti esperti presenti nel nostro ateneo, con alle spalle anni di ricerca internazionale, quali advisor del Prorettore alla ricerca, al fine di suggerire strategie e aggiustamenti regolamentari mirati a migliorare la competitività dell’ateneo, anche grazie ai loro contatti continui con le agenzie di finanziamento come la Commissione europea. Le strategie di reclutamento di ricercatori a TD di tipo B e di professore associato, vero polmone per il rafforzamento delle potenzialità di ricerca dell’ateneo per i prossimi sei anni, dovranno considerare la possibilità di attrarre vincitori di progetti ERC o altri progetti di “eccellenza scientifica” con politiche mirate a integrarne le competenze e ampliarne l’operatività nel contesto dei dipartimenti. Dare opportunità di progressioni degli abilitati verso la prima fascia è pure un elemento cruciale, tanto più considerando la limitatezza delle risorse a disposizione; l’Ateneo dovrà sostenere i Dipartimenti e monitorare i risultati in modo da garantire che i nuovi ordinari, oltre all’indubbio merito scientifico e didattico, abbiano profili di capacità di coordinamento della ricerca e della formazione nei propri ambiti, di guida all’internazionalizzazione, e di impegno istituzionale. Rendere efficiente ed efficace l’investimento in ricerca. Contemporaneamente, occorre mettere in atto strumenti operativi, informatici e in rete, per aumentare la capacità di gestione presso i Dipartimenti (missioni, reclutamento di personale per la ricerca, acquisti), attraverso il rafforzamento degli strumenti informatici (vedi Smart Hub), senza rinunciare all’azione politica mirata a ridare significato all’autonomia universitaria in merito alla gestione amministrativa dei fondi di ricerca. La visibilità dei risultati della ricerca, tramite una comunicazione efficace, passa anche dal consolidamento della politica di accesso aperto ai risultati della ricerca, cioè attraverso il sostegno alle pubblicazioni ad accesso aperto per la produzione scientifica di eccellenza (Premio Open Access), anche attraverso i rapporti con FUP e la diffusione dell’uso di FLORE. Le infrastrutture di ricerca devono essere mappate, così come le competenze tecniche che le rendono capaci di aumentare la qualità della produzione scientifica; una strategia specifica su tali infrastrutture, sui centri di servizio, con una valutazione dei punti di forza e dell’adeguatezza del patrimonio strumentale è una piattaforma indispensabile a renderle disponibili ad ampi domini scientifico/culturali e garantirne il mantenimento. Tra queste, le Biblioteche e il Museo, i Centri di Servizio e Beni Culturali, i Centri di Ricerca interdipartimentali e interuniversitari, come infrastrutture di ricerca di importanza strategica per l’Ateneo. Valutare, controllare e premiare. Occorre ribadire anche qui che scopo precipuo della ricerca universitaria è l’espansione della frontiera delle conoscenze pubbliche e la diffusione culturale. Questa funzione si combina strettamente con l’educazione delle nuove generazioni allo sviluppo di capacità critiche cruciali, che comprendono ma trascendono gli strumenti conoscitivi e professionali specialistici. Gli esercizi di valutazione, o misurazione più propriamente, forniscono utili indicatori che vanno poi tradotti in politiche di incentivazione, o premiali, sui Dipartimenti. I modelli adottati hanno garantito piena UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 32 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai trasparenza e condivisione delle politiche. Tuttavia, una più decisa azione strategica dovrà prendere in considerazione settori in cui la ricerca è funzionale anche al potenziamento della didattica di II e III livello, alla formazione in ricerca, alla promozione della ricerca curiosity-driven anche in aree scientifiche di nicchia, alla ricerca interdisciplinare, alla salvaguardia di nodi di eccellenza internazionale a rischio di depauperamento. Il supporto alle infrastrutture di ricerca europee a guida toscana va mantenuto e rafforzato proprio perché funzionale alla creazione di reti e all’attrattività, così come la condivisione di risorse rappresenta un valore aggiunto nelle collaborazioni con LENS, CNR, INFN e altre Università a partire dall’Istituto Universitario Europeo. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 33 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai III Missione come valorizzazione continua e sostenibile di formazione e ricerca Prospettive da realizzare da ATTRARRE E COMPETERE • mappare e razionalizzare le infrastrutture didattiche e di ricerca come basi per l’eccellenza, l’innovazione, il confronto culturale. da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA • • • promuovere un ambiente di studio creativo e innovativo che stimoli negli studenti capacità progettuali e critiche e faciliti il confronto con società e impresa; sostenere avvii rapidi a lavoro di qualità per laureati e dottori di ricerca; aumentare il numero e il valore di invenzioni riconosciute e di imprese innovative e dinamiche che escono dalla ricerca e dalla formazione accademica; far emergere e diffondere i risultati di Ateneo e di Dipartimento in termini di ricerca, di innovazione e di diffusione culturale, anche attraverso politiche coerenti con il principio dell’accesso aperto alla letteratura e dati scientifici. La terza missione universitaria comprende gli ambiti tradizionali del trasferimento tecnologico (brevetti universitari, imprese innovative che nascono dalla ricerca, rapporti di committenza di ricerca da parte di enti terzi compresi i laboratori congiunti) ma si allarga anche ad altri ambiti caratterizzati da rapporti diretti fra ricerca, formazione universitaria e sistemi territoriali e produttivi - quando tali rapporti siano volti al rafforzamento di processi di innovazione di mercato e sociale, avviamento al lavoro e imprenditorialità, confronti culturali e fra comunità professionali. COSA E’ STATO FATTO NEL RECENTE PASSATO è una base solida per impostare la strategia di Ateneo per il prossimo sessennio. COSA SI PROPONE DI FARE NEL FUTURO. UNIFI oltre il 2015 deve assumere la terza missione come un insieme di processi che caratterizzano diffusamente la vita dei Dipartimenti insieme a servizi di “agenzie di sistema” ad alta specializzazione e professionalizzazione. Nella mia esperienza di Prorettore ho maturato la convinzione che la ricerca ma anche la formazione debbano essere viste come attività che fra i risultati normali hanno anche applicazioni più o meno dirette in forme utili per innovazione, lavoro, confronto culturale; e che dai rapporti conseguenti con sistemi territoriali e produttivi e reti sociali traggono stimoli e risorse. A livello di strategie di Ateneo si tratta di coordinare il movimento in modo che questi processi siano sostenibili e improntati sia a responsabilità sociale sia ad autonomia e autorevolezza dell’accademia. Ma anche in modo che l’Università accresca la sua visibilità nazionale e internazionale in questi campi; e che a livello locale sia considerata un motore fondamentale per lo stabilirsi, nella Città metropolitana fiorentina e nella Toscana centrale, di logiche endogene di ricerca, innovazione, cultura, nuovo lavoro e impresa, per il progresso sociale ed economico (cosiddetti ecosistemi territoriali dell’innovazione e della cultura). In particolare propongo una serie di linee strategiche, distinguendo fra quelle in continuità e quelle che prevedono una variazione più accentuata rispetto alla base di partenza. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 34 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai IN CONTINUITA’ - Consolidamento di CsaVRI: supporto strategico a Organi di Ateneo e Dipartimenti; gestione e progettualità collegate a Incubatore Universitario Fiorentino e Cantiere del Lavoro e dell’Intraprendenza e loro collegamento a iniziative di livello regionale, nazionale e internazionale; strumento di coordinamento e consulenza per estensione, efficacia e sostenibilità dei rapporti dei dipartimenti con enti esterni ed imprese, anche in collaborazione con partecipate di UNIFI quali Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, PIN, spin-off; e nell’ambito dell’area dirigenziale della ricerca e trasferimento tecnologico consolidamento dei processi di accompagnamento dei Dipartimenti a progetti su bandi ricerca e innovazione (es. in H2020). - Diffusione, anche con moduli formativi riconosciuti entro Corsi di studi, della cultura e delle pratiche della proprietà intellettuale e dell’università imprenditoriale; progresso nella protezione della proprietà intellettuale dell’università, anche con strumenti innovativi, nel confronto con enti esterni, applicando metodologie e professionalità adeguate. - Aggiornamento e semplificazione di normativa e linee guida su brevetti, spin-off, laboratori congiunti, conto terzi, progetti di ricerca e innovazione, tirocini e apprendistato, tenendo conto dell’esperienza recente e delle opportunità offerte da un assetto federale dell’Ateneo; estensione di alcune aree di delega ai Dipartimenti su contratti e progetti che richiedono la firma del legale rappresentante dell’Università. - Completamento della mappatura dei gruppi di ricerca nei Dipartimenti e delle infrastrutture con capacità di servizio sui fronti della III missione; utilizzo del database sia per monitoraggio dei risultati ed eventuali interventi di investimento o razionalizzazione, sia per comunicazione via web a livello di ateneo e nei Dipartimenti, per favorire la collaborazione con imprese ed enti esterni, tra Dipartimenti e con altre università ed enti di ricerca italiani e stranieri. ACCELERAZIONE - Attivazione e riconoscimento di funzioni di terza missione entro i progetti dei Grandi Laboratori scientifici, tecnologici e culturali e delle Infrastrutture del confronto inter-culturale, del patrimonio culturale e della divulgazione scientifica (es. grandi Biblioteche e Musei come centri culturali del territorio a risonanza nazionale e internazionale) entro strategie di Ateneo Multi-campus; - Estensione decisiva della comunicazione costruttiva della terza missione di UNIFI integrando l’ambito di ricerca, lavoro e innovazione presidiato da CsaVRI e dalla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, con quello delle iniziative nei campi dell’innovazione sociale e del confronto culturale presidiato da Dipartimenti e Centri delle Scienze Umane e Sociali, Museo, Centri di servizi e Beni culturali, Biblioteche, FUP, Istituto Confucio, ecc. - Estensione delle funzioni operative della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, con convenzione generale su attività istituzionali e risorse affidate dall’Università, in modo da facilitare rapporti snelli con Dipartimenti e CsaVRI, in particolare nel sostegno all’elaborazione di grandi progetti territoriali con enti esterni (Comune di Firenze, Città metropolitana fiorentina, area metropolitana vasta, Regione Toscana), in attività gestionali in ambito terza missione, e nel fundraising a beneficio anche dei Dipartimenti. - Bilanciamento dei rapporti con la Regione Toscana, ponendosi come attore che assieme all’ente Regionale e alle altre università toscane e organismi di ricerca, concorda le modalità di coinvolgimento della ricerca e della formazione universitaria entro le politiche regionali; funzionalizzazione e semplificazione drastica dell’accesso a bandi regionali e della gestione amministrativa degli stessi. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 35 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai - Adesione dell’Ateneo a strutture con specializzazioni elevatissime di terza missione (es. negoziazione con finanziatori per brevetti e spin-off ad alto potenziale) a livello regionale o nazionale; promozione di integrazione con AOU per innovazioni di prodotto e servizi in ambito bio-medico e clinico. - Presenza attiva di UNIFI entro tavoli e gruppi di lavoro nazionali e internazionali sui temi della Terza missione; monitoraggio delle performance di UNIFI in ambito nazionale e internazionale e realizzare un bilancio sociale della terza missione, con attenzione specifica anche al contributo a beni pubblici in ambito sociale e culturale. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 36 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Internazionalizzazione per il confronto, la cooperazione, l’accoglienza Prospettive da realizzare da ATTRARRE E COMPETERE - aumentare il numero e la qualità di studenti in ingresso, in particolare di secondo e terzo livello, e la capacità di attrarre studenti e dottorandi dall’estero; - facilitare la presenza di ricercatori e docenti stranieri per una didattica plurilinguistica e multiculturale. da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - far emergere e diffondere i risultati di Ateneo e di Dipartimento in termini di ricerca, di innovazione e di diffusione culturale, anche attraverso politiche coerenti con il principio dell’accesso aperto alla letteratura e dati scientifici. da RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIVERSITÀ - promuovere la ricerca curiosity-driven anche in aree scientifiche di nicchia. L’esperienza sull’internazionalizzazione della ricerca e della didattica è forse uno dei tratti distintivi della mia personalità accademica come ricercatore, docente e prorettore. In quest’ultimo ruolo, infatti, mi sono occupata sia della costituzione e consolidamento del “Grant office” dell’Area ricerca, sia del coordinamento della Commissione per l’internazionalizzazione, sia infine delle strategie Open Access. Vari punti di queste linee programmatiche hanno diretta corrispondenza con decisioni strategiche e sulle reti internazionali, sulla comunicazione, la ricerca e la formazione già descritte; non ripeto quindi argomenti e proposte già evidenziati altrove, in particolare nella scheda sulla ricerca. Il consolidamento e lo sfruttamento strategico della rete di relazioni internazionali, di cui l’Ateneo è ricco, non può prescindere da finanziamenti dedicati che favoriscano la presenza in Ateneo di visiting professor e scientist per la didattica in particolare nella formazione di secondo e terzo livello, per progetti di ricerca congiunti comunitari e internazionali in genere. Un piano per 400 mila euro è stato appena varato e finanziato per il triennio 2014-2016. Tale azione andrà riproposta, potenziata, e focalizzata negli anni a venire sempre lasciando autonomia ai Dipartimenti di individuare nell’ambito di linee strategiche dell’ateneo, proposte atte a valorizzare vocazioni specifiche didattiche, di ricerca e cooperazione. Le risorse avranno la forma anche di “benefit”, come la disponibilità di sedi foresteria anche in strutture presenti sul territorio (ad es. il Paradisino per l’ambito forestale). Analogamente, la sinergia con l’AOU Meyer sul Health Campus può dare una prospettiva di residenzialità per progetti di formazione e ricerca e terza missione in ambiti non solo clinici ma anche multidisciplinari (tecnologico, sociale). All’accoglienza di studenti stranieri per brevi periodi, o in attesa di alloggio definitivo, occorre pensare in un’ottica di sistema con DSU ed enti locali , anche in relazione al programmato sviluppo di strutture di accoglienza (ostelli) a Firenze, a Prato e in altre città vicine. Firenze non è ad oggi una città universitaria; in questa constatazione si riassume la difficoltà di accoglienza di studenti fuori sede anche stranieri. Tuttavia, i molteplici progetti messi in campo dall’amministrazione comunale, anche in collaborazione con UNIFI suggeriscono una crescente consapevolezza della ricchezza non solo economica che la componente studentesca rappresenta per il territorio. Occorre poi considerare la dimensione metropolitana che già hanno gli insediamenti didattici dell’Università e la possibilità di collaborazione a livello regionale, rafforzando l’esperienza di TUNE (Tuscany University Network) fra le UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 37 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Università Toscane per l’internazionalizzazione. Su questi fronti l’impegno del Rettore e quello sinergico dei Prorettori alla Formazione, al Dialogo inter-istituzionale e all’Internazionalizzazione sarà determinante. Il potenziamento dell’attrattività prevede la costituzione di un Welcome Office, esperienza in parte già presente in alcune aree dell’Ateneo, e quindi da sistematizzare. Il supporto agli ospiti internazionali del Welcome Office si esplica in processi di orientamento e informazione prima dell’arrivo, con documenti multi-lingue disponibili anche sul Web e scadenze segnalate col maggiore anticipo possibile (considerando le pratiche degli Atenei internazionalizzati); nell’accoglienza; nella predisposizione di apposite convenzioni con strutture ricettive dell’area fiorentina; nell’indicazione agli ospiti in arrivo di un apposito info point centrale; nella revisione della normativa allo scopo di agevolare prepagamento e rimborso delle spese di mobilità a carico dell’Ateneo; nel supporto alla consulenza offerta da personale con competenze specifiche in materia di immigrazione (visto, permesso di soggiorno, adempimenti amministrativi). Fanno infine parte di una politica di accoglienza l’organizzazione di eventi di socializzazione (welcome meeting, aperiErasmus) e di apposito programma sociale in accordo con la Città metropolitana fiorentina, ma anche a Prato e Pistoia, anche col supporto della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Insieme all’accoglienza, il rafforzamento dell’internazionalizzazione deve dispiegarsi in varie direzioni. Internazionalizzazione della didattica: il nostro Ateneo non ha sfruttato appieno negli anni i benefici della mobilità studentesca, ad esempio in termini di crediti ottenuti all’estero in Erasmus/placement. Scontiamo una inadeguatezza o incompleta consapevolezza di alcuni aspetti tecnico/gestionali nell’integrazione nelle carriere dello studente di tali crediti. Questo limite va superato con decisione mettendo in campo strumenti informatici adeguati e soprattutto una più diffusa cultura a livello degli studenti, docenti e personale amministrativo coinvolto nel processo. Tuttavia esistono altre esperienze, oltre l’Erasmus, in cui l’Ateneo si è impegnato fortemente: con il Sudamerica, la Cina, il Medio Oriente e il Maghreb. Il significato di questi veri e propri progetti di didattica internazionale si è modificato anche per le mutazioni del contesto economico che caratterizza oggi il rapporto Europa-resto del mondo. In generale, esiste una diffusa insoddisfazione per lo squilibrio tra impegno richiesto, sia dei docenti sia del personale, adeguatezza dei servizi e ricadute per l’Università; è importante il ricircolo di parte dei fondi ottenuti da tali progetti sui Dipartimenti e CdS e sui servizi necessari a garantirne la qualità. La progettazione sulla didattica internazionale (ad es. Erasmus plus) condividerà la disponibilità di un servizio “Grant office” di ateneo per il supporto alla progettazione, monitoraggio e rendicontazione; per le pratiche relative ai dottorandi stranieri da progetti comunitari come per i progetti di ricerca; per l’orientamento alla formazione degli studenti che favorisca la mobilità internazionale pre- e post-laurea, anche tramite la partecipazione a bandi a valere sul Fondo Sociale Europeo FSE, e Horizon 2020. Doppi titoli e titoli congiunti rappresentano insieme ai CdS interamente o parzialmente in inglese, un’esperienza positiva da perseguire e potenziare, estendendola anche ad altre Scuole in modo sostenibile e ragionato. In particolare, occorre valutare e sperimentare la possibilità che i CdS in inglese non siano repliche dell’esistente in italiano, ma terreno di sperimentazione di percorsi di eccellenza o innovativi (ad es., MD/PhD) e quindi di un’offerta alternativa a quella presente in Atenei vicini. Oltre all’inglese altre lingue straniere vanno considerate nella definizione di offerte alternative. Un ruolo chiave è svolto dal Centro Linguistico di Ateneo e dal Dipartimento di Lingue e Studi interculturali. Il CLA può essere il partner per potenziare l’attrattività dell’Ateneo nei confronti di studenti stranieri che necessitano di una preparazione in italiano anche con declinazione specialistica. Può inoltre contribuire allo sviluppo di nuove metodologie didattiche nel settore linguistico insieme al DILSI e SCIFOPSI: la lingua come ambito di integrazione culturale è un terreno di ricerca e formazione ben oltre il servizio, come ben sanno i docenti impegnati nella didattica con studenti di aree linguistiche e culturali lontane. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 38 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Ricerca e cooperazione internazionale: La ricerca universitaria ha una dimensione naturalmente europea e internazionale, per il cui rafforzamento si rinvia alla scheda sulle strategie della Ricerca. Va però sottolineato come la grande rete degli accordi internazionali di collaborazione scientifica oltre che didattica dell’Università di Firenze possa essere sfruttata non solo per progetti di ricerca di singoli gruppi, ma anche come fattore di attrazione di ricercatori internazionali e studenti, e come traccia per azioni di sistema a più ampio raggio, che coinvolgano infrastrutture di ricerca internazionali e la cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è prima di tutto uno strumento di dialogo inter-culturale. Gli esempi a questo riguardo sono numerosi ed eccellenti in tutti le aree scientifiche dell’Ateneo – ho avuto modo di farne conoscenza diretta - e non è possibile citarli. La maggiore difficoltà è nella disponibilità di strumenti adeguati di gestione di tali progetti che spesso gravano eccessivamente sul ricercatore. Anche in questo caso occorre potenziare il servizio di Ateneo per la progettazione internazionale per coadiuvare i dipartimenti che potranno accrescere la loro competenza e capacità di relazione ed azione. Terza missione e internazionalizzazione: La stessa rete di accordi internazionali deve essere utilizzata più incisivamente per attuare modelli di supporto all’innovazione produttiva e sociale a livello internazionale. I rapporti fra la nostra Università e quelle straniere costituiscono un ponte di cooperazione fra territori e sistemi produttivi anche lontani. Si pensi per esempio alla possibilità di fare ospitare nostre imprese spin-off o start-up innovative di giovani universitari presso incubatori di Università partner in paesi stranieri; e viceversa. Infine l’estensione sostenibile della formazione continua/non-curriculare per innovazione e internazionalizzazione attraverso il rapporto con università straniere è un altro campo in crescita, come dimostrato dalla recente apertura dell’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze. L’Istituto è inoltre catalizzatore di progetti di terza missione sul territorio con le comunità cinesi o di altre etnie. Il nostro territorio è infatti esso stesso un interlocutore privilegiato, eccezionale laboratorio di applicazione di esperienze multiculturali, di studi socio-economici, socio-sanitari, statistico-epidemiologici; delle ricadute delle attività dell’Ateneo occorre dare maggiore visibilità. Questo può avvenire certamente grazie al confronto con la performance di atenei esteri e con una comunicazione – descritta altrove- che contribuisca alla diffusione dell’immagine accademica, sociale e culturale dell’Ateneo a livello internazionale; con la partecipazione dell’Università di Firenze ai principali eventi internazionali (meeting, forum, fiere, matchmaking...) e l’organizzazione di eventi promozionali (international week). Anche la grande presenza di studenti di università straniere, nella Accademie e nell’Istituto Universitario Europeo a Firenze e nelle città vicine è una grande opportunità di dialogo inter-culturale e di collaborazione inter-universitaria internazionale, ma anche di offerta di servizi formativi extra-curriculari. Su questo fronte la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione insieme a Centri specializzati di Ateneo dovranno giocare un ruolo incisivo anche per le connesse opportunità di acquisizione di risorse per l’Ateneo, come indicato da alcune prime sperimentazioni recenti. Il Prorettore all’Internazionalizzazione dovrà avere la collaborazione un gruppo di lavoro di colleghi esperti delegati per le grandi aree geografiche e/o applicative dell’internazionalizzazione. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 39 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Smart Hub Accelerazione dell’innovatività e della qualità con servizi digitali personalizzati e aperti Prospettive da realizzare da ATTRARRE E COMPETERE - mappare e razionalizzare le infrastrutture didattiche e di ricerca come basi per l’eccellenza, l’innovazione, il confronto culturale. da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - aiutare chi lavora nell'Università, in ogni settore, ad affrontare il cambiamento e l'innovazione in modo sostenibile - far emergere e diffondere i risultati di Ateneo e di Dipartimento in termini di ricerca, di innovazione e di diffusione culturale, anche attraverso politiche coerenti con il principio dell’accesso aperto alla letteratura e dati scientifici da CONSOLIDARE SOSTENIBILITA’ E AUTOREVOLEZZA - utilizzare coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - potenziare formazione e qualificazione professionale del personale; adattare gli strumenti operativi per rendere sostenibile, proficuo e gratificante il lavoro quotidiano - estendere e approfondire il supporto informatico e alla comunicazione per didattica, ricerca, valutazione e per attività gestionali-amministrative Questa scheda ha un carattere fortemente innovativo; raggruppa alcune linee di azione e funzioni evolute rispetto ai modelli tradizionali adottati nelle università e nelle grandi amministrazioni, in particolare quelle degli enti locali. Fanno riferimento a quest’area l’adeguamento funzionale degli attuali processi e la creazione/integrazione di nuovi processi con l’uso di tecnologie informatiche e organizzative caratterizzate dalla personalizzazione e dalla gestione di grandi basi di dati (big data). Come nelle città si parla della prospettiva di “Smart city”, volendo intendere l’erogazione di servizi intelligenti e personalizzati sulla base di un’integrazione di dati e servizi, supporto allo sviluppo di nuove professionalità, sostenibilità ambientale e sociale; così si deve pensare allo sviluppo di una prospettiva di università “Smart Hub”. Peraltro tanti nostri gruppi di ricerca contribuiscono a progetti di “Smart city”; UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 40 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai queste competenze vanno coinvolte in progetti dove la nostra Università è non solo campo di applicazione ma anche laboratorio privilegiato. Lo Smart Hub è un contesto che predispone, raccoglie e gestisce soluzioni Smart e Big Data con principi di tutela di dati privati e trasparenza su dati pubblici. Dà accesso a informazioni integrate, e facilita strategie di diffusione di consapevolezza e partecipazione delle persone e delle istituzioni; di sinergia e trasversalità fra ricerca, didattica, e III missione; di valutazione predittiva; di sostegno personalizzato ad attività e adempimenti di studenti, ricercatori e docenti, personale tecnico amministrativo, ma anche collaboratori, famiglie, cittadini ed enti esterni; promozionali e di marketing. Le soluzioni dello Smart Hub sono abilitate da informazioni che si possono collezionare per esempio sulla carriera ed il profilo degli studenti (evoluzione, competenze, arricchimenti, connessioni, interessi, ecc.), sui corsi (contenuti, orari, location, materiale didattico, statistiche, ecc.), sul personale universitario (azioni, curriculum, competenze, ecc.), sulla ricerca (risultati, ranking, progetti, relazioni, infrastrutture, ecc.), i ricercatori in formazione, e nell’area della III missione (conto terzi, spin-off, brevetti, laboratori e progetti congiunti formazione e placement, ricerca e innovazione), su eventi in ateneo, sulle competenze amministrative e tecniche, le relazioni internazionali, monitoraggio Wi-Fi, ecc. Dati e/o servizi dello Smart Hub sono accessibili tramite soluzioni mobili (social media e matchmaking, siti web ex alunni UNIFI), applicazioni web, etc. Si pensi agli Atenei che forniscono indicazioni in tempo reale agli studenti in relazione ai corsi ai quali sono inscritti, a quelli che fornisco delle APP per la didattica completamente digitale, a quelli che permettono azioni di formazione a distanza ... per arrivare in un futuro non molto distante ad Atenei che forniscono suggerimenti su quali esami preparare prima, suggerire percorsi formativi personalizzati sulla base di obiettivi e interessi, stimolare la creazione di gruppi di ricerca interdisciplinari e la creazione di master e corsi specialistici, fornire suggerimenti su percorsi di stage, mettere in contatto studenti, ricercatori e aziende in base al loro profilo (si veda per esempio il lavoro di matchmaking di ApreToscana e le recenti esperienze della Settimana UNIFI), accelerare i processi di internazionalizzazione, promuovere in automatico le attività emergenti o con grande potenziale, rendere l’università una cosa viva che segue risponde alle esigenze degli studenti e dei ricercatori. Questi strumenti di analisi forniranno informazioni importanti per valutare l’interesse, l’uso dei servizi, la loro necessità e apprezzamento, la qualità per il loro adeguamento ed eventuali altre attivazioni. Lo Smart Hub sarà in grado di fornire informazioni importanti, un ritorno diretto verso gli organi dell’università, ma anche verso i singoli ricercatori in completa trasparenza, come succede in molti Atenei internazionali. Le azioni di “Smart City” e “Smart Hub” trovano forti sinergie e riscontri con la città metropolitana, si veda per esempio l’accordo fra Comune di Firenze e UNIFI per Firenze Digitale, l’integrazione degli Open Data del Comune con quelli di Regione Toscana ad opera di UNIFI, e le molte altre iniziative congiunte. Soluzioni sempre più integrate andranno a fornire servizi aggiuntivi, precedendo e soddisfacendo necessità di cittadini e studenti. Connessioni analoghe possono essere sviluppate fra UNIFI e sistema sanitario, a partire da AOUC e AOUM, svariati musei ed infrastrutture, il CNR e molti altri enti sul territorio. Con questi e con altri dovranno essere stabiliti accordi di scambio e integrazioni, anche in prospettiva metropolitana. Servizi specifici dello Smart Hub, consentiranno accesso ed erogazione di servizi integrati relativi a: • conoscenze e competenze dei ricercatori, dipartimenti, corsi di laurea, master, anche in relazione alle pubblicazioni, progetti e relazioni fra ricercatori, informazioni relative a ricerca, didattica e III missione; • operazioni di interfaccia ed integrazione fra le competenze dei nostri ricercatori e imprese interessate a sviluppare progetti di innovazione, studenti e mondo del lavoro, studenti e corsi di laurea, centri di ricerca internazionali e laboratori, ecc.; UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 41 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai • • • • • integrazione con i servizi del territorio e di altre istituzioni e amministrazioni nell’area vasta metropolitana; accesso e valutazione di andamenti e nuovi trend nel nostro ateneo, con operazioni di trasparenza; nuove applicazioni web e mobile per ricerca, didattica, III missione, promozione e comunicazione; strumenti di confronto e partecipazione degli studenti che nell’università vivono e cercano non solo servizi di insegnamento curricolare ma anche reti sociali, culturali, politiche; confronto con altri portatori di interessi specifici, a volte come partner, o come clienti o come fornitori: famiglie, imprese ed enti terzi, istituzioni e comunità scientifiche esterne. La caratterizzazione dell’Università come Smart Hub è un processo complesso che impegna risorse multidisciplinari, tecniche, politiche ed economiche. Riguardo alle infrastrutture ICT di ateneo, ci si riferisce in questa sezione ai servizi ICT che sono erogati verso le nostre strutture interne e verso l’esterno. Come tutte le soluzioni ICT, anche le nostre devono essere rinnovate, visto che negli anni passati queste azioni sono state parzialmente svolte. Ci troviamo pertanto a dover operare un significativo adeguamento per riuscire a rimanere al passo con i tempi e andare oltre. E’ altresì necessario presentarsi all’esterno con strumenti adeguati per la comunicazione, la didattica, l’internazionalizzazione, la promozione della ricerca, etc.; si pensi al catalogo unico delle pubblicazioni (accesso aperto o meno), dei progetti di ricerca, delle competenze di Ateneo, e molte altri strumenti relative ai processi interni di gestione: stage, tesi, dottorati, dipartimenti, conto-terzi, brevetti, spin-off, stage, didattica dei corsi di laurea, master e specializzazione, biblioteche, ecc. Alcune di queste necessità sono al momento non soddisfatte in modo adeguato per essere utilizzate per un uso interno verso i nostri ricercatori e studenti, ma anche, e specialmente, per la promozione e la presentazione di UNIFI a livello nazionale ed internazionale. Oramai, il materiale didattico (slide, video, etc.), e ovviamente le pubblicazioni sono un veicolo importante per la promozione e la valorizzazione di UNIFI. Una buona ed efficace comunicazione e promozione, con strumenti adeguati, può portare a un aumento delle citazioni per i nostri ricercatori e del numero di studenti. Oggi, i centri di ricerca internazionali, come le potenziali matricole non sono in grado di arrivare in modo semplice alle nostre pubblicazioni né al nostro materiale didattico. Questa documentazione non è accessibile dai siti web dei dipartimenti che la demandano ai singoli laboratori o ai singoli ricercatori; mentre non viene portata in evidenza a livello centrale. Similmente, non è possibile accedere al materiale didattico dei corsi se non dalle pagine web autoprodotte dei singoli docenti, oppure dal Moodle di ateneo che presenta varie barriere. Oramai siamo nell’era dell’iper-connettività, i nostri figli trovano a scuola le lavagne interattive LIM e i tablet, gli studenti dei licei scelgono l’università facendo delle ricerche su Internet delle parole chiave di loro interesse. UNIFI, nonostante il buon rango di UNIFI.IT non presenta il suo materiale e potenziale nel modo corretto, e pertanto è poco visibile. Il nostro Ateneo dovrebbe anche pensare a facilitare l’uso delle soluzioni e di servizi diffusi di riunioni telematiche, “net-meeting”, Webinar, sia per facilitare le sinergie fra gruppi di ricerca nel nostro ateneo che con gruppi esterni, sia per permettere al personale amministrativo di partecipare in maggior misura a opportunità di formazione e scambio con colleghi di altri atenei. Con le tecnologie attuali, le video conferenze sono superate da soluzioni diffuse che permettono ai singoli ricercatori e al personale di lavorare in team con i loro colleghi direttamente dai laboratori e dagli uffici, aprendo così anche a soluzioni di telelavoro su cui il nostro Ateneo è in ritardo. Anche in relazione al supporto per i processi amministrativi delle strutture centrali e dipartimentali sono necessari adeguamenti sostanziali per passare a modelli più orientati ai processi che possano fornire un recupero di efficienza. Senza trascurare il fatto che alcuni dei servizi ICT relativi alla gestione o agli aspetti UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 42 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai non primari sono oramai diffusi e standardizzati, così da poter essere ben gestiti con strumenti di commercio anche forniti in ottica di servizio su cloud. I modelli di fornitura a servizio su cloud permettono di poter abbattere i costi di infrastruttura e pagare solo per l’effettivo consumo delle risorse. Operazioni simili sono state intraprese da tempo in altri Atenei risparmiando utili risorse che possono essere utilizzate per rinnovare e potenziare i servizi attuali ed erogarne di nuovi. Lo SIAF e la dotazione di competenze e tecnologie informatiche dei Dipartimenti e delle altre strutture di Ateneo dovranno essere pensati in modo distribuito ed integrato secondo le prospettive della digitalizzazione Smart Hub. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 43 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Comunicazione costruttiva e reti sociali Prospettive da realizzare da CONSOLIDARE SOSTENIBILITA’ E AUTOREVOLEZZA - rafforzare la riconoscibilità locale e internazionale di forti aree di ricerca e innovazione in tutti i dipartimenti, il valore del senso di appartenenza della comunità studentesca, la comunicazione dell’identità dell’Ateneo entro la varietà delle sue attività e delle sue anime; - utilizzare la capacità di coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale; da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - estendere e approfondire il supporto informatico e alla comunicazione per didattica, ricerca, valutazione e per attività gestionali-amministrative Un ateneo generalista come UNIFI presenta evidenti punti di forza che derivano dalle competenze, dalla storia, e dal territorio, che devono essere comunicati in modo efficace anche alla luce del crescente attivismo comunicativo di università pubbliche e private. Competere a livello nazionale e internazionale implica anche adottare strategie innovative per aumentare la visibilità e la comunicazione. Il nome dell’Università di Firenze deve essere valorizzato e proposto con orgoglio da ogni area disciplinare e da ogni dipartimento, dal personale tecnico amministrativo, dai ricercatori, dai docenti e dai collaboratori. Mentre gli studenti sono i principali veicoli di informazione e diffusione per altri potenziali studenti, le famiglie, il territorio in genere, su come sono percepiti vita e studio presso l’Università di Firenze. L’immagine coordinata dell’Ateneo - dai loghi al rinnovamento dei siti web - ha contributo a rafforzare questo processo. L’Amministrazione uscente ha infatti svolto un importante lavoro in un momento difficile quale quello dell’applicazione della Legge 240/2010, operando nel ridisegno dell’identità complessiva d’Ateneo e nella comunicazione dei cambiamenti intervenuti. Bisogna ora consolidare, grazie alle tante esperienze condivise, alle tradizioni e ai valori comuni, il senso di appartenenza e l’identità dell’Ateneo, non rinunciando a far emergere anche le critiche, come è nello spirito del luogo. E’ necessario rafforzare la comunicazione dei nostri risultati, il valore prodotto dal nostro ateneo, anche discutendo in modo aperto e costruttivo limiti e criticità, ma difendendo l’Università pubblica da posizioni svalutative preconcette. Metodologie corrette ed efficaci di comunicazione devono diventare un patrimonio diffuso fra le strutture e il personale dell’Ateneo, ed essere usate consapevolmente anche come strumento di costruzione di confronto culturale e di basi di collaborazione, combinandosi coi social media che sono diventati abituali strumenti di comunicazione e di confronto per gli studenti. La progettazione della comunicazione dell’Ateneo sarà dunque componente centrale nel Governo di Ateneo, e potrà essere sviluppata indirizzando, valorizzando e consolidando, strutture e competenze presenti in Ateneo, come già suggerito dall’attuale Piano strategico di Ateneo. Tale progettazione seguirà alcune direttive strategiche principali: • I dati e la conoscenza prodotti della ricerca, didattica, III missione, internazionalizzazione, elaborati UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 44 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai • • • • • • coi processo dello Smart Hub (vedi scheda su “Accelerazione dell’innovatività”), costituiranno una base conoscitiva in continua evoluzione ma affidabile per gli interventi di comunicazione (anche con esempi molto concreti - quanto guadagna in media un nostro laureato, che tipo di lavoro è andato a svolgere, quante e quali aziende usano i nostri servizi e come, quali sono i nostri progetti di ricerca migliori secondo indici di successo, quali sono i nostri ricercatori e studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti e anche eccezionali). Sarà proseguito quanto è stato fatto per l’apertura al territorio, con eventi quali gli Incontri con la città, la cerimonia di conferimento del titolo di Dottorato, la notte dei ricercatori, il Career Day di Ateneo, fino ad arrivare alla recente Settimana dell’Università, e si investirà in adeguati strumenti comunicativi, quali una rinnovata newsletter e il rafforzamento dei social media di Ateneo. Tali iniziative si combineranno con varie altre, anche a vasto raggio con gli enti del territorio e con nodi di eventi globali, curando in particolare la valorizzazione dei risultati delle tre missioni dell’Università, per esempio con il lancio di campagne di promozione o comunicazione dei migliori progetti e laboratori di ricerca, delle pubblicazioni con maggiori citazioni, dei migliori spin-off, brevetti e centri di competenza, dei premi di eccellenza ricevuti da personale e studenti, premiando e gratificando a nostra volta, delle testimonianze di Alumni del nostro Ateneo, della partecipazione del nostro Ateneo o di suoi membri a competizioni internazionali di vario tipo. Il rafforzamento della comunicazione on-line – siti internet di Ateneo, Dipartimenti e Scuole, social media e radio web (anche sulla scorta di iniziative come RadioSpin al Polo di Prato) - richiede l’individuazione di apposite figure (come web editor, social media manager e altri) che, all’interno dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture, siano in grado di gestire efficacemente e con continuità i contenuti dei relativi siti, coordinandosi con la redazione centrale e in stretto collegamento con SIAF, nonché dialogando con iniziative che nascono nel mondo studentesco: dalle start-up innovative al giornalismo partecipativo (che si avvale di contenuti generati dagli utilizzatori). Occorre aumentare la capacità della FUP di sostenere le pubblicazioni scientifiche dei dipartimenti e di attrarre pubblicazioni da altri Atenei, diffondere l’uso di FLORE, integrare le iniziative comunicative del Polo museale, delle Biblioteche, e di altre sedi di divulgazione scientifica molto vitali entro l’Ateneo. L’Ateneo, attraverso le specifiche strutture centrali dell’Area Comunicazione, si farà carico di coordinare gli sforzi dei Dipartimenti di monitoraggio e valutazione degli eventi di divulgazione e di confronto culturale che, specie nelle aree umanistiche e delle scienze sociali, sono parte importante, quanto poco percepita nel suo complesso, della terza missione di tipo sociale e pubblico svolta dall’Ateneo e dalle sue strutture. Mi adopererò per il perseguimento del piano integrato di rinnovamento della segnaletica di Ateneo, realtà complessa per numero di siti e persone coinvolte, con supporti sia fisici sia di natura informatica (app), e per la realizzazione il progetto relativo al nuovo merchandising anche il relazione al Polo Museale. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 45 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Strategie normative per processi amministrativi snelli e sicuri Prospettive da realizzare da GOVERNARE LA COMPLESSITÀ - promuovere aggiustamenti mirati dello Statuto di Ateneo sulla base di un riscontro puntuale con le esigenze di efficienza ed efficacia nell’azione politica e nelle attività di strutture e personale - rivedere i regolamenti specifici a favore di linee guida adattabili e monitorabili e di un responsabile esercizio delle prerogative dell’autonomia Il carico burocratico e l’eccessiva produzione normativa riducono l’efficacia delle energie spese per formazione, ricerca e trasferimento delle conoscenze universitarie, intesi come reali fattori di sviluppo e di crescita dell’Ateneo e del Paese. Gli investimenti nelle missioni dell’Università devono aumentare ma avranno risultati limitati se non si procede a miglioramenti su tale fronte. La semplificazione normativa e amministrativa è una promessa tanto ripetuta quanto disattesa, a tutti i livelli nel nostro Paese ed entro il sistema universitario in particolare. Pur essendo necessario rivendicare dal governo nazionale un cambio decisivo di approccio alla regolamentazione statale dei processi universitari, come hanno cominciato a chiedere la CRUI e il CUN negli ultimi anni; e pur essendo necessario richiamare al confronto pure gli altri enti pubblici con cui l’università ha collaborazioni e contributi (es. sui bandi regionali su alta formazione, ricerca e innovazione) per una semplificazione efficace degli stessi; pur concesso quanto precede, rimane molto da fare anche al nostro interno. Occorrono in particolare strategie normative interne che sostengano processi amministrativi snelli e sicuri, nella consapevolezza che i livelli di governo sopra-ordinati e le esigenze regolamentari dei sistemi sociali e tecnologici contemporanei impongono comunque di affrontare aspetti normativi complessi. Si tratta in primo luogo di rendere più fruibile il quadro regolamentare attraverso una revisione quantitativa e qualitativa delle norme interne esistenti. Non vuol dire soltanto ridurre il numero delle norme, ma anche incrementarne la reciproca coerenza, la comprensibilità e l’efficienza; snellire le procedure riducendo gli oneri amministrativi “inutili” richiesti ai soggetti che vi intervengono, agevolando l’adempimento di quelli necessari a garantire un livello di controllo adeguato e lo svolgimento della funzione pubblica dell’Ateneo; rivedere l’organizzazione in funzione di procedure più celeri e più efficaci. Si tratta dunque di promuovere, con la collaborazione fra Organi e Amministrazione di Ateneo, una serie di progetti basati sulle competenze di ricerca e professionali presenti al nostro interno e sul confronto con le migliori buone pratiche comparabili a livello nazionale e internazionale, che portino a: • riorganizzare la produzione normativa dell’Ateneo muovendo da un’analisi che metta in luce eccessi regolamentari e disomogeneità; • utilizzare in maniera sistematica forme di valutazione preventiva dell’impatto che le norme possono avere sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ateneo; • ottimizzare le prestazioni amministrative attraverso un più efficace impiego delle tecnologie e dei sistemi informativi nonché il collegamento col rafforzamento delle competenze del personale; UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 46 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai • ridefinire i processi decisionali migliorando la comunicazione tra organi, eliminando eventuali sovrapposizioni di competenze, snellendo le procedure rispetto ad oneri che non rispondano a principi di ragionevolezza e proporzionalità; • valutare ex post l’efficacia degli interventi compiuti analizzando eventuali carenze persistenti e proponendo soluzioni efficienti; • dare vita a linee guida che sostengano l’attività dell’Ateneo senza ingessarla e consentendo di volta in volta soluzioni adeguate.Si reputa necessario anche istituire a stretto contatto con il Rettore un gruppo di supporto giuridico per la difesa dell’Autonomia universitaria dalle troppe norme improprie che vengono imposte a livello nazionale e regionale in palese violazione dall’autonomia dell’Università, della sua specificità, della libertà di ricerca e di insegnamento, del diritto allo studio e dell’accesso alla formazione superiore, della tutela del patrimonio culturale, storico e artistico. Trattandosi in molti di casi di principi fondamentali garantiti dalla Costituzione della Repubblica, il Rettore coadiuvato dal gruppo di supporto si farà parte attiva in ogni sede per la tempestiva prevenzione e la intransigente difesa dei diritti dell’Università, del patrimonio, dei lavoratori, degli studenti e dei cittadini tutti. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 47 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Un Ateneo metropolitano multi-campus: progetto da completare Prospettive da realizzare da ATTRARRE E COMPETERE - aumentare il numero e la qualità di studenti in ingresso, in particolare di secondo e terzo livello, e la capacità di attrarre studenti e dottorandi dall’estero - mappare e razionalizzare le infrastrutture didattiche e di ricerca come basi per l’eccellenza, l’innovazione, il confronto culturale da VIVERE E DIFFONDERE INNOVAZIONE E CULTURA - promuovere un ambiente di studio creativo e innovativo che stimoli negli studenti capacità progettuali e critiche e faciliti il confronto con società e impresa da RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIVERSITÀ - potenziare le sfere di formazione e ricerca interdisciplinari sulle grandi sfide sociali da CONSOLIDARE SOSTENIBILITÀ E AUTOREVOLEZZA - utilizzare coordinamento e comunicazione di sistema per rafforzare la capacità dell’Ateneo di confrontarsi autorevolmente con enti esterni in merito a grandi progetti di ordine sociale, sanitario, culturale, economico e territoriale L’Ateneo si è da tempo configurato con un profilo metropolitano, grazie ad insediamenti che dal centro città si irradiano alla periferia (Novoli, San Salvi, Careggi, Santa Marta, Cascine e Quaracchi) e nelle sedi didattiche decentrate di Sesto Fiorentino, Pistoia, Empoli, Prato, San Casciano in Val di Pesa, Vinci, Calenzano, Figline Valdarno, San Giovanni Valdarno, Borgo San Lorenzo. Recentemente la situazione del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino è stata delineata nel CdA; il piano prende in esame il contenzioso su valutazione economica dei terreni, presenza di amianto sul terreno da cedere per la costruzione del nuovo liceo Agnoletti e naturalmente i due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (contro la variante al PIT e contro il provvedimento dell'Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAC, sul Master Plan presentato da Aeroporto di Firenze) tuttora pendenti. Per ciò che attiene il programma, vale la pena sottolineare l’intesa con la Regione e la città metropolitana in merito al trasferimento nel Polo del Liceo Agnoletti; il progetto prevede la realizzazione di 4-6 grandi aule da 200 posti, indispensabili a far fronte alle incrementate esigenze didattiche e che possano anche alleggerire le richieste sul Plesso didattico Morgagni. La cessione in comodato all’ADSU del Faculty Club permetterà la realizzazione di una mensa universitaria, di cui il Polo assolutamente necessita. Per l’impatto della nuova pista aeroportuale, occorre attendere l’esito dei ricorsi; è al lavoro una commissione che sta elaborando i rilievi in merito alla funzionalità delle strutture esistenti e al rischio idraulico, acustico, da incidenti, ecc.. legate alla presenza eventuale della nuova pista. Ognuno di questi punti prevede problemi, prospettive e soluzioni diverse, certo accentuate dall’area aeroportuale. Le soluzioni vanno e andranno sempre affrontate in un’ottica di sistema: la divisione in Poli è UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 48 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai superata per volontà dell’Ateneo e rimarcare interessi specifici e contrapposti significa ripercorrere vecchie logiche che non appartengono a questo programma né alla Visione. La situazione più critica attualmente riguarda la Scuola e i due Dipartimenti di Agraria: per la frammentazione in cinque sedi, per lo stato di degrado di alcune di esse, per la crescente (fortunatamente) domanda di formazione in un’area scientifica strategica per l’ateneo e il territorio. Basti pensare, nell’ambito ricerca che ho seguito in questi anni, la selezione quale tematica meritevole di finanziamento infrastrutturale da parte della CE di SACE (Sustainable Agricolture in Changing Environment); il seminario regionale in vista delle proposte tematiche per i bandi Horizon, l’inserimento dell’Agricoltura nell’ambito delle strategie di SMART specialization. L’accordo di programma tra Demanio, Comune e UNIFI sulle Cascine ancora vigente deve trovare una soluzione con l’impegno del Rettore e del Prorettore competente a riunire un tavolo urgente. La ristrutturazione dell’edificio delle Cascine, su cui sono stati già stanziati alcuni fondi, è una possibilità concreta; edifici attigui per i quali esistono già ipotesi di accordo (ex Manifattura tabacchi, Istituto tecnico) e relative offerte possono offrire - transitoriamente o meno - una soluzione per l’adeguamento “a blocchi” senza trasferimenti massivi. Laboratori pesanti condivisi tra Agraria, Ingegneria Industriale e Architettura, anche nella zona di Calenzano, sono un progetto che l’ateneo ha già considerato vincente; oltre al valore aggiunto dell’interdisciplinarietà, essi rappresentano l’humus ideale per il trasferimento tecnologico, la formazione di secondo e terzo livello e continua. In alternativa all’affitto, l’acquisto a costi contenuti - stante la situazione economica generale e l’elevata disponibilità sul territorio - consente una patrimonializzazione sostenibile e responsabile. Il quadro va completato con i laboratori (Biotecnologie, tecnologie alimentari, arboricoltura) già presenti o da completare a Sesto, , e con le scelte successive sulle altre sedi (Via Maragliano, via Donizetti, Quaracchi), con il destino dell’Azienda Montepaldi, la valorizzazione del Paradisino a Vallombrosa per il CdS in scienze forestali: su ognuna di queste il Rettore si impegna a creare un tavolo permanente di confronto con l’Area di Agraria. Una situazione critica si registra anche per il Dipartimento e la Scuola di Architettura, in particolare per l’area fiorentina, tuttora dispersa in diverse sedi, nonostante le dismissioni delle sedi di Viale Gramsci e Accademia. Il progetto in corso di realizzazione conferma la scelta di individuare nell’area di Sant’Ambrogio il futuro del Dipartimento di Architettura e dei corsi di studio in architettura e paesaggio e della formazione di terzo livello e continua. L’impegno dei prossimi anni sarà dedicato, anche con un intesa con gli enti territoriali, a valorizzarne nella città e nel territorio il ruolo completando il progetto, avviato già negli anni 80, di trasformazione di santa Verdiana e santa Teresa, purtroppo solo in parte finora realizzato. La concentrazione di tutte le attività del Dipartimento e della Scuola di Architettura, oltre alle sedi nell’area metropolitana di Empoli e Calenzano, nell’area di sant’Ambrogio è l’obiettivo primario che l’Ateneo potrà perseguire nei prossimi anni, anche con la collaborazione della città metropolitana, valorizzandolo anche per le sue potenzialità di qualificazione urbana. Il terzo punto è rappresentato dalla grande Biblioteca umanistica, su cui esiste un progetto complessivo di circa 30 M€, da sostenere e accelerare. Alle biblioteche saranno dedicati approfondimenti sul sito aperti alla discussione nelle prossime settimane, non limitati ai soli interventi edilizi ma al significato che esse hanno come testimonianza visibile e tangibile del presidio culturale dell’Ateneo, della capacitò di aggregazione, dell’attrattività e accoglienza a studenti e studiosi per i quali biblioteca è luogo di studio, incontri, ricerca; è aperta ma protetta, è “casa”. La grande Biblioteca umanistica, che per il suo patrimonio costituisce una risorsa di primaria importanza europea, e accanto ad essa i grandi spazi del complesso di Piazza Brunelleschi, progressivamente lasciati liberi dai Dipartimenti e dalle Facoltà, risultano sottoutilizzati e le strutture, peraltro valide dal punto di vista murario, appaiono nel complesso non più funzionalmente UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 49 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai adeguate a una università contemporanea. L’idea di dedicare l’intero spazio del complesso di Piazza Brunelleschi a una moderna biblioteca umanistica e ai suoi servizi nel centro della città di Firenze, uno spazio che costituisca un cuore pulsante per lo studio, la ricerca e l’incontro tra protagonisti del sapere umanistico, è oggi un obiettivo che può essere perseguito. Intorno a questo obiettivo, che coinvolge e valorizza la Città e un patrimonio culturale di enorme rilievo nazionale, l’Università di Firenze deve ricercare il consenso e la collaborazione delle istituzioni a tutti i livelli: Comune, Regione, Città metropolitana, Governo e a strategie di fundraising in particolare sui fondi per infrastrutture di ricerca, di cui la Biblioteca un esempio tangibile. Altri interventi di minore impatto (Torretta per psicologia) sono urgenti e rientrano nella manutenzione straordinaria. Infine, la situazione delle Scuole e CdS che insistono nel centro città dovrà essere affrontata valutando la risoluzione di alcuni affitti (Lettere e Filosofia) e la dismissione di altri edifici parzialmente utilizzati. Un discorso a parte riguarda l’edilizia sull’area Careggi: l’atto aziendale rimanda la definizione del patrimonio ad atti successivi, ancora mancanti, mentre per il NIC e Cubo3 esiste un diritto di superficie che necessita anch’esso una definizione precisa delle quote di edificio spettanti a UNIFI. In generale, l’Ateneo deve perseguire una corretta e ragionata patrimonializzazione, soprattutto con la riqualificazione di edifici esistenti rispetto alla costruzione di nuovi, per dare continuità e stabilità alle esigenze di didattica e ricerca: è questo uno dei punti qualificanti dell’attrazione. L’ufficio tecnico deve essere in grado di seguire con competenza le operazioni, anche grazie a un responsabile/dirigente professionale. Su altri temi, che richiedono una trattazione specifica ma che sono certamente altrettanto rilevanti, si rimanda ad approfondimenti sulla pagina web: il progetto Grande Specola, ad esempio, che mira alla valorizzazione di uno dei più prestigiosi Musei di Storia Naturale a livello internazionale. Più in generale, per attrarre e competere l’Ateneo dovrà confrontarsi con esigenze strutturali legate alla disponibilità, razionalizzazione, ammodernamento di aule, laboratori didattici e biblioteche che – insieme ai servizi – sono il biglietto da visita verso gli studenti e le loro famiglie. Le criticità emergenti dovute alla frammentazione dei dipartimenti in più sedi dovranno essere affrontate con soluzioni razionali e sostenibili, anche caratterizzate anche da supporti informatici che consentano di ridurre i tempi di spostamento per riunioni, facilitino gli scambi di buone pratiche, rafforzino l’idea di appartenenza a una comunità che è dislocata ma non disunita. UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 50 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA CERBAI – 04/05/2015 INFORMAZIONI PERSONALI Nome CERBAI ELISABETTA Indirizzo Via del Pozzino 87 50143 Firenze Telefono 055 2758274 (ufficio) Fax E-mail Nazionalità Data di nascita 055 2758181 [email protected] italiana 30 luglio 1961 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro 1990-1996 Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Farmacia Istituto di Farmacologia Università Ricercatore Universitario 1996-oggi Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Farmacologia “Mario Aiazzi Mancini” dal 2013 Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NeuroFarBa) • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego Università Ricercatore Universitario (1996- 2000) Professore Associato (2000-2005) • Principali mansioni e responsabilità Professore Straordinario (2005-2008) Professore Ordinario (2008-oggi) Prorettore alla Ricerca Scientifica, Università degli Studi di Firenze (20092015) UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 51 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI Direttore del Centro Interuniversitario di Medicina Molecolare e Biofisica Applicata (2005-2011) Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia (2007-2011) Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ricerca e Innovazione, Firenze (2010 –2014) Chairperson del European WG on Cardiac Cellular Electrophysiology, European Society of Cardiology (2010-2012; past-Chair 2012-2014) Fellow di European Society of Cardiology (2009-) Fellow dell’European Heart Rhythm Association e Membro dell’Educational Committee, (2009-2013) Membro del Comitato di Indirizzo del Polo Tecnologico / Distretto Toscano Scienze della Vita (Comitato di Indirizzo) (2011 -) Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, Università “La Sapienza”, Roma (2013 -) ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date (da – a) 1984 Laurea in Scienze Biologiche, Università di Firenze (110/110 e lode) 1986-1990 Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia, Università di Firenze 1986-1987 Visiting scientist Institut für Physiologie Universitat Koeln (Germania) • Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 52 Linee programmatiche di Elisabetta Cerbai Docente di Saggi e Dosaggi farmacologici, Farmacologia II per CTF (Ferrara) DIDATTICA Docente di Farmacologia in vari Corsi di Studio triennali, magistrali e a Ciclo unico (Medicina e Chirurgia; Infermieristica, Ostetricia, Biotecnologie); di Terapie rigenerative nelle malattie cardiovascolari Commissione Erasmus e International Student Counseling per il CdL Medicina e Chirurgia (fino al 2008) Membro della Scuola di Specializzazione in Pediatria e Nefrologia Membro del Collegio del Dottorato in “Area del Farmaco e Trattamenti Innovativi” CAPACITÀ E COMPETENZE SCIENTIFICHE Elettrofisiologia cellulare cardiaca; biofisica dei canali ionici; meccanismi aritmogeni; farmacologia cardiovascolare; differenziamento cardiomiocitario (cellule staminali embrionali); cardiomiopatie. 2006-2009 LSHM-CT-2006-018676 Normal Cardiac Excitation Propagation and Coupling To Contraction (Coordinator) 2010-2013 EU-FP7-Health-2009-BIG-Heart: Bench-to-bedside Integrated approach to familial hypertrophic cardiomyopathy: to the heart of the disease (Coord. C. Redwood, Oxford; PI C. Poggesi) 2013 - Associate Editor, Cardiovascular Research 2013 - Valutatore AERES (FR) MADRELINGUA ITALIANA ALTRE LINGUA INGLESE • Capacità di lettura [ottimo ] • Capacità di scrittura [ottimo ] • Capacità di espressione orale [ottimo ] ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATI Autore di 115 pubblicazioni peer-reviewed (PubMed), h-index WoS 30 Pubblicazioni http://www.unifi.it/p-doc2-2013-200009-C-3f2a3d2f3527310.html Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. Data: 4 Maggio 2015 Firma: UNIVERSITÀ PUBBLICA: FORTE, LIBERA, APERTA pag. 53
Scarica