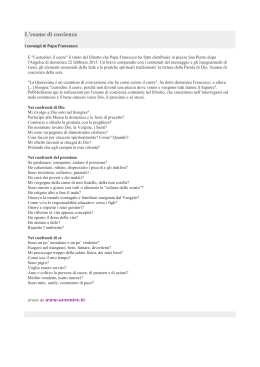Domenica il fatto Le nuove imprese della Banda del Buco La di DOMENICA 2 MARZO 2008 PIERO COLAPRICO e GIANCARLO DE CATALDO i luoghi Repubblica Alessandria, nel Forte della lentezza DANIELE DEL GIUDICE e MASSIMO NOVELLI Reduci d’Italia Un ritorno segnato dalla sofferenza JENNER MELETTI L SAVONA a stretta di mano è forte. «Brigadiere Piero Follesa, 13° reggimento carabinieri Gorizia, compagnia Alpha. Ecco, se mi avesse incontrato prima della strage di Nassirya, mi sarei presentato così. Ora invece devo dire: Piero Follesa, brigadiere a congedo per stato ansioso — cronicizzato — di grave entità. Non più idoneo al servizio militare e alla pubblica amministrazione. Ho quarantacinque anni e devo prendere almeno nove pastiglie al giorno per mandare via l’angoscia che ho dentro. Quando ero giovane, i carabinieri anziani mi dicevano: anche quando sarai in pensione non ti dimetterai mai dall’Arma perché gli alamari sono attaccati alla pelle e non solo alla divisa. È vero. Io mi sento sempre carabiniere e l’Arma ce l’ho dentro. La “mia” Arma, però. Quella che ho servito per ventisette anni, non quella che dopo Nassirya ha dimenticato me e i miei compagni». (segue nelle pagine successive) FOTO CRISTIANO LARUFFA / AGF E dal silenzio delle Forze armate e dell’opinione pubblica FABIO MINI cultura S Vigorelli, l’archivio delle lettere appiamo, noi militari, che per capire la guerra e i soldati di oggi bisogna capire i reduci: quelli che hanno fatto la guerra ieri e che hanno qualcosa da raccontare. Perciò, sentire e ricordare i loro racconti è un modo di addestrarsi al comando e alla psicologia di guerra. E così noi militari abbiamo coltivato e sviluppato la cultura del Reduce. Lo abbiamo onorato ed abbiamo ascoltato decine di volte la sua storia sempre uguale e sempre diversa. Perché c’era sempre un particolare nuovo o una contraddizione. I primi reduci da ascoltare erano quelli di famiglia, i nonni, gli zii, i padri e poi i vecchi del paese che si rivolgevano sempre ai giovani. Paradossalmente i più restii a parlare erano quelli con la memoria più fresca, che non avevano ancora rimosso i traumi della guerra. La storia del Reduce formava e univa le generazioni ed era un patrimonio comune da conservare e tramandare come Epos del nostro popolo, della nostra famiglia. (segue nelle pagine successive) PAOLO MAURI e GIAN PAOLO SERINO la lettura Quelli che ci rubano l’identità TOMMASO PINCIO spettacoli I formidabili settanta di Bruno Bozzetto ANNA BANDETTINI e BRUNO BOZZETTO Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Reduci d’Italia DOMENICA 2 MARZO 2008 “Tutto è iniziato la mattina del 12 novembre 2003 a Nassiriya”, racconta il brigadiere Follesa, ex carabiniere, in cura per disordine da stress post traumatico. Depressione, incubi, eccessi di rabbia, crisi dei rapporti familiari. Il pensiero costante dei compagni che non sono tornati. E il silenzio dell’Arma La guerra di Piero non è finita JENNER MELETTI (segue dalla copertina) ppuntamento in un bar di piazza Galilei, e non certo per caso. «Qui ogni giorno alle sei di sera suona la campana che ricorda i Caduti. I vigili bloccano le auto, anche i pedoni si fermano. Per un attimo, almeno qui, si ricorda chi è morto per l’Italia». Il brigadiere in congedo Piero Follesa è diagnosticato come Ptsd, Post-traumatic stress disorder, vittima di stress post traumatico, sindrome che ha colpito migliaia di soldati americani e inglesi tornati dalla guerra dell’Iraq. In America il Ptsd era studiato già dopo la guerra del Vietnam, ma in Italia — dice l’Ufficio comunicazione pubblica dello Stato Maggiore dell’Esercito — «sul fenomeno non esistono studi e dati statistici». Anche la storia del brigadiere Follesa è diventata pubblica per caso. Un’auto che corre troppo veloce, chi è alla guida viene multato. Fa ricorso al giudice di pace di Savona. «Sono un ex carabiniere, in cura presso il Centro di salute mentale di Finale Ligure. Ci sono altri cinque colleghi che hanno disturbi seri come me. Quando uno di noi è in crisi, chiama gli altri, che corrono per stargli vicino. Per questo andavo forte ed ero al telefono per dire all’amico: stai calmo, sto arrivando». Non è facile chiedere a un uomo quali siano le paure che sente dentro. «Tutto è iniziato la mattina del 12 novembre 2003 a Nassirya. Ero un veterano, avevo già fatto una missione in Albania, due in Bosnia ed ero in Iraq per la seconda volta. Ho sentito lo scoppio del camion bomba, mi sono preso delle schegge nella schiena. Tre della mia compagnia, Daniele Ghione, Andrea Filippa e Ivan Ghitti sono morti da eroi. Erano nella prima postazione, potevano scappare ma hanno bloccato il camion sparando con tutte le armi che avevano. E non hanno la medaglia d’oro perché c’è chi sostiene che non c’è stato conflitto a fuoco. Se il camion fosse entra- A MARÒ Un marò del reggimento San Marco in una postazione di controllo nel corso della missione Antica Babilonia AVAMPOSTO Il reggimento lagunari durante un’operazione di controllo nell’avamposto dell’ex base Libeccio a Nassiriya to nella base, i morti sarebbero stati almeno cento. Ecco, mi rivedo mentre salgo sanguinante su un Vm, assieme al sottotenente di complemento Ballerini. Voglio proteggere il lato sud della base perché temo altri attacchi. Poi corro all’ospedale dai feriti. Ricordo che ad un certo momento entra un iracheno, quasi mi getta fra le braccia una bambina che avrà avuto un mese o due, una ferita devastante nella schiena. Due occhioni neri, una meraviglia. Muore dopo poche ore». Un caffè ristretto, gli occhi che sembrano vedere solo la sabbia e il sangue dell’Iraq. «Mi mandano a casa per curare le ferite, ma non voglio il rimpatrio definitivo. Dopo cinque mesi chiedo di tornare nella Nuova Babilonia. I miei amici sono morti e non voglio che il loro martirio sia inutile. Troppe volte, nelle missioni, sembriamo chirurghi che aprono il paziente e poi vanno via. Ancora quarantasette giorni di Iraq poi il mal di schiena, causato dalle schegge, riesce a vincere. Il 31 luglio 2004 vengo rimpatriato». Il trasferimento da Gorizia alla Liguria, al radiomobile di Cairo Montenotte. «Non stavo bene ma rifiutavo di essere malato. Ho ripreso a fare il carabiniere, in pattuglia come altri. Nel marzo 2005 ho chiesto però il supporto psicologico. Non dormivo, ero teso, nervoso, bastava un nulla per farmi arrabbiare. Il comando regionale mi ha mandato dalla dottoressa Mortara che mi ha prescritto gli psicofarmaci. A fine anno la dottoressa non era più a disposizione dei carabinieri e allora, per fortuna, ho saputo che a Finale Ligure ci si poteva rivolgere al Centro di salute mentale della Asl 2 savonese, per un aiuto medico e psicologico. Già nei primi colloqui mi hanno spiegato che per me, e anche per gli altri, sarebbe stata opportuna una lunga convalescenza». Ptsd è una sigla che racconta un dramma. «Mi sveglio di notte con uno scatto improvviso, colpisco chi sta al mio fianco, mi metto a correre al buio nella stanza e grido chiamando i miei compagni di Nassirya. Per questo da tre anni non dormo più nella stanza con mia moglie. A causa della tensione puoi arrivare a mettere le mani addosso a un figlio. TIRATORI SCELTI Tiratori scelti in addestramento nella base di White Horse a Nassiriya durante la missione italiana in Iraq ALZABANDIERA Militari italiani assistono all’alzabandiera nella base di Nassirya. La foto è stata scattata nel 2004 Per questo l’8 gennaio 2006 sono tornato in caserma e ho consegnato la pistola e tutte le munizioni. Per questo ho accettato il congedo, cinque ricoveri in psichiatria e tre in neuropsichiatria, l’ultimo la settimana scorsa. Lo scriva pure, non me ne vergogno. Devi riconoscere la tua malattia, se vuoi tirartene fuori. Adesso ingoio pillole tutto il giorno, vado ai colloqui con la psicologa e ho una speranza: arrivare ad essere il Piero di prima almeno al cinquanta per cento. Per fortuna i commilitoni in cura come me stanno meglio. Tre vengono a Finale, gli altri due sono seguiti da altri medici delle Asl. Ma la cura principale ce la siamo inventata noi: siamo diventati fratelli. Se uno ha un problema, gli altri arrivano subito. A volte senti la crisi che arriva e pensi: ecco, telefono e fra dieci minuti avrò un amico al mio fianco. Non gli dovrò spiegare nulla, anche lui ha visto Nassirya». Le stanze del centro salute mentale di Finale Ligure sono in un vecchio palazzo con i soffitti affrescati. Ci sono anche gli uffici della Coldiretti e della comunità montana, così chi entra nel portone non viene marchiato. «Nei casi di Ptsd», dice il dottor Daniele Moretti, lo psichiatra che dirige il centro dove lavora anche Sabrina Bonino, psicoterapeuta, «i pazienti cercano innanzitutto qualcuno che li stia ad ascoltare. I reduci della Seconda guerra mondiale raccontavano una guerra che aveva coinvolto tutti: “Ho fatto la fame in un campo di concentramento”, “e noi a casa siamo stati bombardati dagli Alleati”. Questi militari, e parlo non dei casi che abbiamo in cura ma in generale di chiunque soffra di Ptsd, hanno vissuto episodi di guerra in missioni di peace keeping, hanno subito traumi pesantissimi e in un attimo si ritrovano in una società dove la vita è continuata esattamente come prima. È un contrasto che si vive anche durante la missione. Sei lì in Iraq, vedi i bambini dilaniati dalle bombe, e poi con la mail o il videotelefonino parli con la moglie che ti dice che c’è il mutuo da pagare e che il figlio ha una brutta pagella. Troppi contatti possono diventare un’arma a doppio taglio». Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 AFGHANISTAN 2002-? Missione segnata da forti dissensi tra il comando Usa e quello italiano, poi passata sotto comando Onu Oltre 2.100 militari italiani sono impegnati, in ambito Nato, nella ricostruzione del Paese. Nove i caduti IRAQ 2003-2006 LIBANO 1978-? La più impegnativa missione italiana. Diciassette militari uccisi nell’attacco alla base di Nassiriya il 12.11.2003 Missione Onu sotto comando italiano, rafforzata nel 2006 Oltre duemila i nostri soldati, quattro i caduti FOTO BRUNO MURIALDO SOMALIA 1992-95 I reduci dell’Iraq si sentono isolati. «Si sentono dire: in fondo eravate volontari, fatti vostri. E allora si chiudono. C’è chi sta troppo a letto. Gli tocchi una spalla e scattano impauriti. Un petardo di carnevale a loro sembra una bomba. Tanti soffrono di insonnia, depressione, eccessi di rabbia, incubi. C’è chi non riesce più ad andare a trovare l’amico carabiniere in caserma ma solo quando è a casa, senza divisa. In tutti, la domanda angosciante: perché lui è morto e io sono ancora vivo? Succede anche nelle grandi calamità, come le alluvioni o gli attentati ai treni. E quelli di Nassirya non erano casuali compagni di viaggio: erano colleghi dei nostri pazienti, con loro avevano vissuto in caserma, mangiato la pizza assieme a mogli e figli». Il lavoro del medico non è semplice. «I ricordi dolorosi vanno rielaborati. Nel Ptsd invece il ricordo è una cosa ferma, atemporale. E ogni stimolo fa rientrare in testa i pensieri intrusivi. Per fortuna in questi anni di assistenza soprattutto psicologica abbiamo registrato netti miglioramenti. Non va però dimenticato il peso della separazione dall’Arma, che non era solo un mestiere ma una scelta di vita». Il maresciallo dei carabinieri Giantullio Maniero, seguito dagli psicologi del San Martino di Genova, dice che, «nonostante tutto, l’Arma è sacra». «Io devo, voglio continuare a crederlo. Il colonnello Garau e il tenente Valvano mi sono stati vicini e li ringrazio ma l’istituzione in questi anni è stata troppo lontana. Dal novembre 2003 noi viviamo un’odissea. Abbiamo dovuto cercare noi gli esperti che ci prendessero in cura. E siamo soli anche quando chiediamo quella medaglia d’oro al valor militare per chi non è più tornato da Nassirya. Noi li abbiamo visti, i nostri colleghi, mentre sparavano contro i terroristi. E un ex ministro come Martino si è permesso di dire: “Non si può dare la medaglia a tutti”». L’Ufficio comunicazione pubblica dello Stato Maggiore dice che, anche se non ci sono studi o statistiche, «l’insorgere di tali disturbi in operazioni è comunque noto nella letteratura militare». «Le tecniche di preven- STATI UNITI REGNO UNITO Secondo uno studio pubblicato l’anno scorso dagli Archives of Internal Medecine, un terzo dei 103.788 reduci assistiti dai servizi sanitari dei Veteran Affairs nel periodo 2001-2005 soffre di disturbi psichici. Oltre la metà di essi (13.205 casi) sono stati diagnosticati come casi di stress post traumatico Sono oltre duemila, riferisce la Bbc, i soldati britannici rientrati dall’Iraq (su un totale di circa 100mila) ad aver richiesto cure psicologiche L’ong Combat Stress ne assiste 700 all’anno I ministeri della Salute e della Difesa hanno lanciato un programma pilota per l’assistenza ai reduci che soffrono di disturbi mentali Il racconto del soldato patrimonio di tutti FABIO MINI (segue dalla copertina) bbiamo rigettato, noi militari, il reducismo, perché come tutti gli “ismi” distorce il concetto di base. Non ne sopportavamo la petulanza, l’autoesaltazione, l’esclusività di ciò che il narratore diceva di aver fatto, visto o sentito. E quando dalla storia raccontata si passava alla lettura dei documenti matricolari, asciutti ma veri, ci si rendeva conto che il reducismo era la caratteristica di chi non aveva fatto niente di eccezionale o che si era addirittura imboscato. Ho avuto la fortuna d’incontrare reduci in ogni parte del mondo e di non essere traviato da mitomani o affabulatori. Un nonno fante nella Grande guerra era già paralizzato e muto quando nacqui. Insegnava con lo sguardo. Il nonno bersagliere e cavaliere di Vittorio Veneto non mi ha mai parlato del suo passato militare. Era riservato e lavorava tanto. Insegnava con l’esempio. Mio padre, da buon toscano, tendeva a dissacrare tutto. Delle esperienze di guerra parlava soltanto per riderci su. Insegnava con l’ironia. Ho quindi preso coscienza dei Reduci e del reducismo quando da bersagliere mi sono trovato immerso nel mondo del valore e del folklore. E poi quando ho collaborato con un capo di Stato maggiore Reduce e prigioniero di guerra che con serenità mi ha insegnato cosa significa stare da una parte o dall’altra di un reticolato. In America ho incontrato il primo ammalato di reducismo cronico. Era un colonnello di origine cubana reduce della Baia dei Porci. Non nascondeva di dovere a quell’impresa (fallita) la propria carriera folgorante. Diceva cose probabilmente vere, ma che apparivano come fanfaronate. Dopo una settimana dall’assunzione del comando di battaglione fu destituito. Fine della carriera. Il reduce era inciampato in una spacconata di troppo. Ma c’erano in servizio con me i reduci del Vietnam che avevano vissuto la gloria e l’abiezione del fango, delle conquiste a suon di massacri e delle ritirate ordinate dall’alto. Come i nonni. Anche loro parlavano A poco e cercavano sempre di capire chi e perché sbagliava. In Cina, ai piedi della Montagna Bianca, ho trovato i reduci della guerra di Corea. I volontari di Lin Piao che buttarono quasi a mare gli americani. Gente modesta che parlava del forzamento notturno del fiume Yalu come di un viaggio in cielo. Non erano più tornati a casa perché trattenuti al confine con la Corea del nord. A far ricordare. Ho incontrato i reduci cinesi della guerra contro il Vietnam. Avevano raggiunto i vertici dell’esercito e trasformavano la guerra persa in una lezione per l’ammodernamento: la loro vittoria. In Argentina è un reduce delle Falkland che mi elenca i novanta cognomi italiani tra i seicento caduti. E il suo Epos diventa il mio. A El Alamein e a Montelungo ho incontrato i reduci di tutte le nazioni belligeranti e le loro storie coincidono sempre, come la commozione di un cameratismo tardivo ma non inutile. In Kosovo ho trattato con eguale rispetto i reduci serbi e dell’Uck. Quelli che si erano combattuti come soldati e non i criminali di guerra. Le loro storie non coincidevano mai. Tutti volevano apparire come vittime innocenti. I serbi cercavano ancora i compagni scomparsi e quelli dell’Uck dopo quattro anni dalla guerra tentavano disperatamente di estrarre le poche migliaia di veri combattenti da una lista di circa trentamila pretendenti. Penso che si capisca che sto parlando da reduce. Guardando al passato come ad una realtà estinta. Senza recriminazione ma con rimpianto. Oggi abbiamo i reduci delle operazioni di peace keeping e fatichiamo a considerarli veri reduci costringendoli al reducismo. Con il mito del soldato di pace nessuno vuole ammettere che i nostri soldati sono stati in guerra: a tutti gli effetti. La cultura del Reduce rischia di finire per non riconoscere che anche il sacrificio dei soldati di oggi fa parte dell’Epos nazionale. E non ci rendiamo conto che senza il loro patrimonio rimane solo la responsabilità di averli esposti a rischi inutili. Come spesso accade in guerra. zione fanno parte del normale addestramento del soldato. È in fase di completamento un manuale di prevenzione dei disturbi da stress in zone di operazione». Non si sa quanti siano in cura per Ptsd ma si assicura che «il supporto ai militari colpiti è fornito dai medici psicologi delle nostre strutture ospedaliere». Domenico Leggiero, ex maresciallo pilota che a Firenze ha fondato l’Osservatorio militare, centro studi che segue soprattutto i soldati vittime dell’uranio impoverito, dice che «il Ptsd è una realtà che solo lo Stato Maggiore finge di ignorare». «Solo noi abbiamo ricevuto quasi centocinquanta segnalazioni. Ci mandano mail soprattutto le mogli dei soldati, dicendo che il marito picchia i figli, ha reazioni violente o sta separandosi dalla famiglia. Bisogna affrontare il problema a viso aperto, perché solo studiando chi è rimasto vittima di stress da guerra si può preparare la formazione di chi deve partire per le nuove missioni». Uomini come Pietro Follesa, brigadiere, per l’Arma sono diventati dei fantasmi. «Per più di due anni nessun comandante si è fatto vivo con me. Solo l’altro giorno, il 21 febbraio, un colonnello del Comando generale ha chiamato me e gli altri carabinieri in cura e ha detto: «Come state? Cosa possiamo fare per voi?». Lei non può capire, per un attimo ci è sembrato di rinascere. Spero che l’Arma torni a farsi sentire, vivere nell’oblio è terribile. Noi non siamo nemmeno stati invitati alle cerimonie dei carabinieri per Nassirya. Ma bisogna resistere, anche se è dura. Quando leggo sui giornali che qualcuno ancora oggi grida «dieci, cento, mille Nassirye», sento dentro di me una rabbia totale. E spesso nei cortei ci sono dei parlamentari, che si dissociano, ma solo dopo. La mia strada è in salita ma, quando sarò al cinquanta per cento il Piero di una volta, tornerò a fare il soccorritore volontario della Croce rossa. Non può immaginare che soddisfazione c’è quando una persona, magari solo con gli occhi, ti dice grazie». Suona, nel silenzio della piazza, la campana dei Caduti. Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA il fatto Cronaca nera PIERO COLAPRICO onli conosce nessuno. Preferiscono impugnare il trapano e non la ballerina, la pistola, che quando spari ti balla in mano. I “bucanieri”, come si chiamano gli uomini della banda del buco, costituiscono una specie di segretissima setta criminale. Ci sono stati assalti ai caveau clamorosi e miliardari, ma arresti altrettanto clamorosi mai, o quasi mai. Secondo “Radiomala”, sono napoletani, romani e milanesi i migliori di questo settore. E forse al top restano i milanesi, come confermerebbe l’ultimo colpo, quello della settimana scorsa a Casa Damiani, la gioielleria quotata in Borsa che ha visto la sua sede di corso Magenta svuotata da sette uomini d’oro. Un colpo da «svariati milioni», forse addirittura quindici. Un precedente che fa scuola c’è. Maggio 1984, piazza Diaz. Nella città dove tutti corrono, dove si lavora e si produce, c’è una banca che esalta l’uso delle rampe, per permettere ai clienti più affezionati alle quattro ruote una serie di operazioni senza nemmeno mettere il freno a mano, il tutto a duecento metri dal Duomo. La Banca provinciale lombarda sembra perfetta per la Milano rampante di quel periodo, ma sotto la pioggia del penultimo weekend di quel mese, accanto al muro, non posteggia una Ferrari. Appare uno strano, gigantesco cubo nero. Nasconde una “carotatrice”, e cioè una macchina da oltre una tonnellata capace di succhiare una carota di cemento larga quaranta centimetri e alta quarantadue. Il materiale impiegato dai ladri-ingegneri per quel cubo è un misto di truciolato e gommapiuma, coperto di catrame. Funziona come il silenziatore della pistola. E anche come il sipario di un teatro. Il cubo attutisce il rumore dei denti della carotatrice e impedisce agli estranei di vedere la tempesta di scintille che sarebbe scoppiata da lì a poco. “Svitato” il tappo di cemento, i muratori cedono il passo a chi sa usare la lancia termica per fondere come burro in padella l’ultima protezione d’acciaio del muro di cinta della banca. Si può accedere al caveau. Il lavoro di attacco dura alcune ore, c’è chi dice tredici o quattordici. Su mille cassette di sicurezza, ne vengono svuota- N DOMENICA 2 MARZO 2008 Il recente colpo a Casa Damiani, nel cuore di Milano, riporta alla ribalta l’arte criminale dei “bucanieri”, quella élite di ladri che confeziona pochi, ricchissimi furti senza armi e senza violenza ma con sperpero di carotatrici, lance termiche, tecnologia elettronica Una mala leggendaria e popolata soltanto di fantasmi che nelle indagini sull’assalto della carotatrice insonorizzata di piazza Diaz, spuntò infatti Ugo Ciappina. Esattamente lui. E cioè uno dei “cervelli” della famosissima rapina delle tute blu di via Osoppo, di cui ricorreva il cinquantenario pochi giorni fa. Condannato per l’assalto al furgone che segnò l’epoca storica del boom, finita la lunga detenzione, Ciappina era rimasto fedele alle regole della vecchia “ligera”, la mala milanese. Aveva girato alla larga dalle grandi bande dei Turatello e degli Epaminonda. Si faceva gli affari suoi. Appena venne sbattuto in cella come inventore della carotatrice silenziata, proclamò la sua innocenza. In appello venne prosciolto per insufficienza di prove. E se l’è sempre cavata in tutti questi anni, anche se è stato notato in banche e uffici poi razziati dai “bucanieri”, anche se è stato arrestato un’altra volta, nel marzo di cinque anni fa, a settantaquattro anni. Era in viale Piave, non lontano da un negozio di moda, che stava per essere svuotato dalla “banda del buco”. I ladri erano entrati nel vicino palazzo, in ristrutturazione, e avevano fatto un buco nelle cantine. Che ci fai qua, Ciappina?, gli chiesero i poliziotti. «Cercavo una farmacia», rispose. Confidò un suo conoscente al cronista: «In casa non ha un romanzo. Ho visto la sua biblioteca, ci sono decine e decine di manuali di elettronica, sui metalli, sulle chiavi…». Oggi Ciappina ha quasi ottant’anni. Non ha mai dato un’intervista. Non ha mai cambiato casa, a Porta Vittoria. Al telefono, quelle rare volte che hanno provato a metterlo sotto intercettazione, non gli hanno sentito dire più di qualche parola ai parenti. «Un caffè insieme? Lo bevo da solo», risponde a chi va a cercarlo. Dice che non sta bene, ma gli occhi sono quelli di sempre: attenti, fiammeggianti. E forse anche per colpa dei suoi occhi, per colpa della sua storia e — diciamolo — perché è tra i pochi ancora in grado di saper fare qualsiasi “lavoro”, il nome di questo decano delle bande sconosciute dei “bucanieri” è stato rilanciato dall’anticrimine anche per ragionare su quest’ultimo assalto, quello a Casa Damiani. La Banda del Buco il ritorno te duecento: per un bottino sui cinquanta miliardi di lire di allora. Agli investigatori, basiti, rimasero in mano un bel po’ di bottigliette vuote di Enervit e sette paia di stivali usati dai sette uomini d’oro e lasciati lì, per andarsene carichi di soldi e, si immagina, con le scarpe perfettamente pulite. Una carotatrice era stata usata anche per fare razzia, sei anni prima, in un’altra banca, in via Moscova. E circa sedici anni dopo ecco che tocca alla Cariplo di piazza della Scala subire l’assalto. Nei giorni delle vacanze del Natale del 2001 la filiale è in ristrutturazione interna e ha spostato il locale dove sono custodite le cassette di sicurezza: ai ladri, in possesso di ottime informazioni, basta bucare con la lancia termica la porta blindata di un cortile, sfondare un muro a picconate e poi, invece di usare di nuovo la lancia termica per la pesante porta d’accesso al caveau, picconano e trapanano il muro tutt’intorno. L’incasso è di poco più di un milione di euro in contanti e altre centocinquanta cassette di sicurezza vengono aperte. Chi si nasconde dietro questi blitz? Chi ha le “dritte” per arrivare al caveau? La speciale qualità umana dei “bucanieri” aiuta a spiegare il fallimento di tante indagini. Questi banditi non-violenti hanno un rapporto con il tempo, con il sudore della fronte e con l’adrenalina molto più sano rispetto ai “duristi”: gli esperti della “dura”, e cioè della rapina, vivono infatti con il cronometro nel cervello, sanno che devono stare in banca per pochi minuti e poi l’imperativo è scappare, scappare, tutto sul filo della velocità, delle pulsazioni, dei nervi tesi. Se molti rapinatori, per via delle telecamere difensive, delle impronte che lasciano, dei “pentiti” che parlano, vengono prima o poi catturati, gli uomini della “banda del buco” sono quasi tutti rimasti dei signori nessuno. Ricchi quanto basta e inafferrabili. In più, come dicono, «tra noi non ci sono rifarditi», mancano cioè i traditori al loro interno. Per due ragioni. Un po’ perché quel loro mondo di tecnologia ed elettronica è un mondo di amicizie decennali (anche politiche), chiuso, molto speciale, dove se si sbaglia, si sbaglia da professionisti. E perché spesso le grandi organizzazioni mafiose hanno tentato di “rubare” a loro volta il bottino a chi, grazie ai buchi nel sottosuolo, ai cunicoli delle fogne, alle ristrutturazioni, penetrava dove i loro picciotti non erano riusciti a entrare. Insomma, si sono cementati rapporti privilegiati che nessuna carotatrice potrebbe bucare e nessuno spione sporcare. Una persona è — anche se lui non vuole e protesta quando lo si cita — l’incarnazione di questo universo. Bisogna ricordare Come si ricorderà, una settimana fa è comparso in una cantina di corso Magenta 80 un foro nel muro di sessanta centimetri per ottanta. I lavori, notturni e misteriosi, erano cominciati per lo meno a Natale. Alcuni inquilini s’erano lamentati per i rumori: «Sentivamo lo zzz zzz del trapano». Un paio di custodi avevano dato un’occhiata. Non avevano notato nulla. E nulla era successo per mesi, sino alle prime ore di domenica scorsa, quando da quel buco spuntano sette persone, quattro con la pettorina della Guardia di Finanza. Si materializzano nel caveau del palazzo al numero 82, sede della famosa gioielleria e svuotano un armadio blindato di due metri per tre, pieno di cassetti carichi di preziosi. Questo colpo rappresenta un “ibrido”. E cioè alla tecnica del buco, si è sommata la rapina con travestimento. È risuonato il «fermi tutti e non vi succederà niente». In un’epoca di rapinatori cocainomani, i sette uomini di Casa Damiani sono sembrati dei signori perché non c’è stato l’uso di armi, a parte le manette per immobilizzare i dipendenti. Ma mentre i “bucanieri” classici non entrano quasi mai in contatto con i “dannati”, i derubati, in questo caso è successo. Proprio come succedeva negli anni Ottanta e Novanta, quando non erano rari colpi simili, soprattutto ai danni di grossisti di gioielli, con bottini record di decine e decine di chili di preziosi portati via, soprattutto a Napoli, Roma e Milano. Uno di questi colpi, a Napoli, ebbe come vittima Diego Armando Maradona. I ladri-rapinatori, passando dalle fogne e sfondando una parete, erano riusciti a immobilizzare i dipendenti di una banca vicino piazza del Mercato. Avevano svuotato centinaia di cassette di sicurezza, nella fuga in via Orefici avevano anche perso gioielli per settecento milioni di lire, ma non il pallone d’oro consegnato al campione argentino da France Football. E a Roma, nel novembre del 2000, una banda sbucata da un muro che si sbriciola tenne in ostaggio settanta tra clienti e dipendenti, in una filiale della Banca di Roma al quartiere Magliana. Decine e decine di colpi ci sono stati in Italia, a banche, poste, gioiellerie, tutti praticamente senza colpevoli. Gli investigatori pensano di avere a che fare con persone che hanno superato gli “anta”, persone abili e mature. Con gli eredi di quel ladro celebrato in un noir francese degli anni Cinquanta, dove si diceva che quando occorreva un esperto in casseforti, si chiamava «l’italiano, uno di Milano». La realtà investigativa, negli anni, ha solo confermato quell’intuizione letteraria. Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 SCASSINATORI IN SMOKING L’illustrazione di Walter Molino pubblicata il 17 aprile 1960 descrive un furto in banca a Benevento eseguito da scassinatori in smoking I SOLITI IGNOTI Mario Monicelli, 1958. Il debutto della commedia all’italiana: il furto fallimentare di cinque balordi della periferia romana SETTE UOMINI D’ORO Marco Vicario, 1965. A Ginevra una sofisticata banda internazionale svaligia la Banca Nazionale Svizzera OCEAN’S ELEVEN Steven Soderbergh, 2001. Ocean (George Clooney) recluta dieci superspecialisti per un colpo a Las Vegas INSIDE MAN Spike Lee, 2006 Un ladro filosofo a capo di una banda di finti imbianchini realizza la “rapina perfetta” a Manhattan Il triste tramonto del Buon Bandito GIANCARLO DE CATALDO enza denaro è triste il destino/ ma il coraggio non ci è mai mancato/ se sei la mala passi dappertutto/ se sei la mala ti puoi pagare tutto/ evviva il vino e la bella vita/ viva le donne e la ladreria!». Fu il vezzo di mettere in versi le scorribande del suo terzetto di scassinatori che condannò monsieur Clement: un poliziotto in borghese orecchiò il ritornello della ballata in argot che spopolava nelle bettole lungo la Senna e dal prezioso indizio fu agevole risalire all’inafferrabile rapinatore che aveva fatto razzia di casseforti nella Parigi di fine secolo. Inevitabilmente processato e condannato, Clement venne tuttavia osannato come un eroe popolare. Stesso destino sarebbe occorso, anni dopo, al rapinatore anarchico Jacob, la cui destinazione al bagno penale fu accolta dai francesi con la morte nel cuore. Maurice Leblanc, il padre di Arsenio Lupin, s’ispirò tanto a Clement che a Jacob. Gran seduttore, fascinoso conversatore, elegante commensale, inafferrabile e gentile spirito libero, Lupin è l’archetipo del Buon Bandito moderno, il degno figlio della rivoluzione industriale, del modernismo, dell’incalzare del pensiero scientifico. Legioni di lettori spasimano per le sue imprese, le donne sognano di incontrare dal vivo uno come lui, i giovani godono della disfatta degli sbirri che invano gli danno la caccia. Eppure, il Buon Bandito non ha niente a che vedere con il pio Robin Hood. Il quale non si limitava a derubare i ricchi, ma usava reinvestire ben più dell’“otto per mille” in beneficenza sociale. E nemmeno con il brigante della tradizione (l’Angiolillo, il Vardarelli) che raddrizza i torti e conforta le vedove. I vari Clement, Jacob, Lupin non sono dei filantropi, rubano per vivere alla grande, in quanto a coscienza sociale risultano alquanto primitivi anche all’osservatore più benevolo. Tuttavia, il processo di identificazione scatta immediato. Tratti precisi delineano la figura del Buon Bandito: detesta la violenza, per giocarsi la partita sul terreno delle idee e di geniali, arditissimi piani. Punisce l’avidità, rispetta i deboli, ogni impresa è per lui una sfida da condurre nel rispetto di regole comuni e condivise. E, soprattutto, rischia in prima persona: se preso, non piagnucola, non si “butta a Santa Nega”, semmai, orgogliosamente, rivendica, ritorcendo le accuse contro i “borghesi” e la loro mentalità gretta e utilitaristica. Flessibile, come ogni mito che si rispetti, quello del Buon Bandito si adegua al mutare dei tempi. Già pochi anni dopo Lupin al “padrone delle ferriere” si sostituiscono gli anonimi consigli d’amministrazione delle società finanziarie. Il Buon Bandito legge Brecht e fa tesoro del celebre aforisma sulla natura ontologicamente “criminale” delle banche. Legge Horkheimer e Adorno, capisce che gangster e statisti tendono ad assimilarsi sotto il profilo morale e anche antropologico, che hanno non solo le stesse abitudini, ma persino la stessa faccia, e allarga l’orizzonte dei suoi interessi. È il “cassettaro” che ripulisce il caveau senza nemmeno degnarsi di comperare un’arma sul mercato clandestino. L’hacker che, con un colpetto del dito indice, dirotta sul suo conto cifrato il patrimonio di una multinazionale. È George Clooney che svuota le casse del casinò dove le mafie vanno a candeggiare i proventi dei loro sporchi traffici. Ma è proprio quel contesto che il Buon Bandito sa così bene leggere e interpretare che sta decretando, a rapidi passi, la fine del suo mito. Fine che avverrà, forse tra breve, per colpa dell’Auditel: perché le sue gesta ci lasceranno indifferenti, sedotti, come siamo, da ben altri stimoli. Il pregio del Buon Bandito è di restare fedele a se stesso, ai suoi “ideali” non violenti e sottilmente provocatori. Siamo noi a essere cambiati. È cambiata, forse irrimediabilmente, la nostra percezione del rapporto fra il crimine e la normalità. Da molto, ormai, abbiamo smesso di provare interesse per genesi e prassi di qualunque impresa, sportiva come criminale. Ciò che ci sta a cuore è unicamente il risultato finale. Il “come va a finire”, assolutamente svincolato da modi, tecniche, percorsi. Che sia gentiluomo o feroce, un bandito è tale soltanto se viene catturato, processato e — a volte persino accade — condannato. Altrimenti, è uno che ce l’ha fatta, e buon per lui. A noi, magari, toccherà la prossima. Questo confine fra “noi” e “loro” che rendeva così unici gli Jacob e i Lupin oggi lo avvertiamo sempre più vago e scontornato. Segni inequivocabili di criminofilia ci circondano. Vediamo uomini d’affari vestiti all’ultima moda come pusher dei ghetti. Respiriamo tutti, consapevolmente o meno, nelle notti elettriche delle metropoli come nei viottoli della “sana” provincia italiana, la coca, allegra compagna di scorribande. La ricchezza è un valore che affratella, se si porta appresso la violenza, nessun problema. È la regola del gioco. Il Buon Bandito passa il testimone a Superciuk. Quel personaggio inventato dal genio dei fumettari Magnus & Bunker: lui che ruba ai poveri per dare ai ricchi, ecco uno che ha capito come vanno le cose. «S ILLUSTRAZIONE DI WALTER MOLINO DAL LIBRO “LA DOMENICA DEL CORRIERE” © 2007 FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA / © 2007 SKIRA EDITORE Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 2 MARZO 2008 il viaggio Imprese dimenticate Per novecento giorni, dal 1872 al 1874, prima di Nansen e di Peary, il tenente di vascello Carl Weyprecht esplorò il Mare Artico, scoprì la Terra di Francesco Giuseppe, poi tornò a casa con una eroica marcia sul pack La sua ciurma, sotto bandiera austro-ungarica, era composta di marinai dalmati e cacciatori sudtirolesi La nave dei triestini nell’inferno di ghiaccio PAOLO RUMIZ enivano dalle terre della bora — si chiamavano Marola, Zaninovich, Scarpa, Lusina o Catarinich — e stupirono il mondo tornando vivi dall’inferno bianco che li aveva inghiottiti per novecento giorni. Una ciurma di quattordici marinai dalmati, fiumani e triestini che, dopo aver abbandonato la nave, rientrarono a casa dal mare artico con una terribile traversata a piedi tra i ghiacci, dopo due inverni di tenebra a meno cinquanta. Era il 1874 e quegli uomini, con i loro ufficiali, si erano spinti alla massima latitudine Nord mai raggiunta, gli 82’ 51” gradi del desolato arcipelago da loro battezzato Terra di Francesco Giuseppe, punto più settentrionale d’Europa. Al ritorno in Norvegia, poi in Germania e a Vienna, furono accolti come eroi, ma ancora oggi il nome del loro comandante, Carl Weyprecht, triestino, dice poco o niente agli italiani. Che strano. Il 2008 è ormai il quarto anno polare mondiale, e il Belpaese sembra ignorare ancora questa favolosa storia. Eppure la prima grande spedizione scientifica verso il Polo non fu quella del norvegese Nansen o dell’americano Peary, ma venne compiuta da questo indomito triestino nato in Germania e della sua ciurma adriatica. Inglesi e tedeschi gli riconoscono tale primato; il suo nome figura nel sito della Nasa — l’agenzia spaziale americana — come padre della ricerca scientifica internazionale; Vienna gli tributa onori e l’Accademia delle scienze austriaca pubblica proprio in questi giorni il suo epistolario; ma in Italia solo pochi specialisti ne hanno sentito parlare e persino a Trie- V ste manca una via con il suo nome. Erano gli anni della febbre geografica mondiale e i mappamondi contenevano grandi spazi bianchi inesplorati. Il Polo Nord era il più grande di tutti e Weyprecht, tenente di vascello poco più che trentenne, pieno di ardore scientifico, contagiò del suo entusiasmo sponsor e istituzioni, raccogliendo quanto bastava. Fece costruire un piroscafo adatto ai ghiacci, lo foderò di ferro, caricò a bordo ventitré uomini scelti, e il 13 giugno del 1872 fece rotta sul Polo col compito di cercare anche il passaggio a Nordest per il Pacifico. Incappò in un’estate freddissima e fu subito intrappolato dalla banchisa senza avere alcun aiuto dalla corrente del Golfo che in condizioni normali avrebbe dovuto aprirgli la strada dagli iceberg per un migliaio di chilometri almeno. Quando il 28 ottobre il sole sparì e rimase sotto l’orizzonte, la pressione del gelo sulla chiglia era già così spaventosa che la nave si sollevò fra cigolii e tonfi terrificanti. Il buio era tale che per vincere la depressione dei suoi uomini il comandante inventò lavori di ogni tipo e lui stesso tenne lezioni all’equipaggio, come su una nave scuola. A mezzanotte di capodanno tutti uscirono con fiaccole attorno alla nave e bevvero pezzi di champagne gelato, mentre qualche orso bianco tentava di arrampicarsi in coperta. L’estate dopo fu avvistata la nuova terra, ma i ghiacci si strinsero di nuovo e arrivò la notte del secondo inverno. Bisognò aspettare altri sei mesi per esplorare la Franz Josef Land, in tempo per iniziare la traversata a piedi verso la salvezza, la Novaja Zemlja. Una fatica di Sisifo, con i ghiacci che andavano alla deriva nella direzione opposta. Certo. Weyprecht compì l’impresa A bordo della “Tegetthoff” si parlavano nove lingue diverse: una vera spedizione “internazionale” LE IMMAGINI Nelle pagine sono riprodotti i disegni di Julius Payer, comandante delle operazioni di terra della spedizione L’uomo del ritratto è Carl Weyprecht La mappa riporta la marcia sul ghiaccio tra Terra di Francesco Giuseppe, Novaja Zemlja e Norvegia sotto bandiera austriaca. Ma crebbe a Trieste e ne fu fino all’ultimo cittadino entusiasta. Lì ebbe la sua formazione scientifica e marinara, e lì iniziò ad apprezzare i figli delle ventose montagne a picco sul mare. Narrano che quando rivelò ai tedeschi di voler affrontare il Mare Artico con marinai mediterranei, quelli sorrisero con sufficienza, ma lui non si lasciò smontare e ricordò che nella ritirata di Russia i reparti napoleonici che avevano subìto meno perdite erano quelli delle province illiriche, fra Trieste e la Dalmazia. Anche sulle navi austriache i marinai che si ammalavano meno erano i figli della costa illirica, temprati da estati torride e inverni durissimi. Gli stessi uomini che avevano difeso Vienna e Venezia dai Turchi. A Bremerhaven si può vedere ancora oggi un obelisco dedicato a loro: i giuliani, istriani e dalmati che batterono l’Italia nelle acque di Lissa — correva l’anno 1866 — agli ordini dell’ammiraglio austriaco Wilhelm von Tegetthoff, cui sarebbe stata dedicata post mortem la nave polare di Weyprecht. A Pola, oggi Croazia, c’è un’altra lapide che con vanagloria non infondata esalta gli «uomini di ferro su navi di legno» che allora sconfissero «uomini di legno su navi di ferro». Gli “iron-men” erano il nostro nemico: ma in manovra parlavano veneto e a ogni bersaglio colpito gridavano «viva San Marco», in onore della grande Venezia per la quale avevano navigato per secoli. «Demoghe drento!» urlò letteralmente Tegetthoff al suo timoniere prima di speronare l’ammiraglia piemontese, zeppa di marinai napoletani. A Lissa Weyprecht affondò pure lui la sua nave, e c’è da capire perché sia finito nel vasto arcipelago delle amnesie nazionali. Trieste — l’italianissima — è luogo di memoria strabica, concentrata sull’epica irredentista e disattenta sul resto: soprattutto alle storie della lunga stagione asburgica, quando Trieste fu porta di un impero e toccò la sua massima fioritura. Così, gli italiani non sanno che qui fu inventata l’elica e la prima corazzata con i cannoni girevoli; che la scommessa dello scavo di Suez partì non a Parigi ma nella città di San Giusto; non sanno che a Gorizia furono progettati i primi aerei da combattimento oppure che nella vicina Pola vennero messi a punto i primi siluri e i primi overcraft sperimentali. L’Italia sabauda e quella fascista erano tirreno-centriche, e poiché l’Austria era stata erede di Venezia, anche la leggenda serenissima passò in second’ordine. E con essa i capitani coraggiosi dell’Adriatico. L’odissea del ritorno in un mare gelato a metà sfiancò gli uomini, già distrutti dalla diarrea, dal vento e dagli sbalzi di temperatura. Scrive Weyprecht: «Il lavoro consisteva nel mettere alternativamente i battelli sul ghiaccio e poi rimetterli in acqua. I campi di ghiaccio erano piccolissimi, giacevano l’uno in stretta vicinanza dell’altro ed erano divisi per lo più da canali angusti. Qualche giorno, per ben venti volte si ripeteva il lavoro di mettere i battelli sopra le slitte e quindi le slitte sopra i battelli, e la maggior parte delle nostre fatiche andava perduta senza profitto alcuno». Testimonianze straordinarie, mai tradotte in italiano su pubblicazioni scientifiche, e semi-ignorate dal mondo accademico, nonostante il bel romanzo sull’epopea artica scritto più di vent’anni fa dallo scrittore viennese Christoph Ransmayr. Un silenzio rotto solamente da un dilettante triestino — Enrico Mazzoli — che ha Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 I LIBRI Sulla spedizione polare Weyprecht-Payer, Enrico Mazzoli ha scritto due libri: Dall'Adriatico ai Ghiacci. Ufficiali dell'Austria-Ungheria con i loro marinai istriani, fiumani e dalmati alla conquista dell'Artico (Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2003, 25 euro, disponibile su ordinazione) e Viaggio ai Confini del Mondo La spedizione polare Weyprecht-Payer, alle origini dell'Anno Polare Internazionale (Biblion Edizioni, Milano 2007, 18 euro). Una versione parzialmente romanzata della storia è contenuta nel libro dello scrittore austriaco Christoph Ransmayr Gli orrori dei ghiacci pubblicato in Italia da Leonardo (1991) e da Il Mandarino (1989), ma ormai per entrambi fuori catalogo dedicato anni a raccogliere scritti e immagini sulla grande avventura, anche per saldare il debito di memoria della sua città. Maggiore della polizia municipale e assiduo viaggiatore tra i poli e l’equatore, ha raccontato la storia in due libri ricchi di curiosità e iconografie: Dall’Adriatico ai ghiacci e Viaggio ai confini del mondo. Julius Payer, ufficiale dei Kaiserjaeger, comandante delle operazioni di terra e straordinario illustratore dell’avventura, ricorda in un libro sulla scoperta della Terra di Francesco Giuseppe che a bordo la confusione delle lingue rasentava il comico. «Tra loro i marinai parlano per lo più in slavo, ma in servizio usano l’italiano. In cabina si parla tedesco, e norvegese col ramponiere Carlsen... il quale conversa in inglese con l’ufficiale di coperta Lusina... Il dottor Kepes dialoga con gli uomini usando il suo latino professionale o l’ungherese, ma con Lusina parla in francese. Infine abbiamo a bordo una strana lingua, quella dei due tirolesi, che all’inizio riuscivo a comprendere io solo». Nove lingue a bordo: quella della “Tegetthoff” non fu una spedizione austriaca ma europea. La prima spedizione internazionale della storia. Il fascismo liquidò Weyprecht come tedesco dimenticando che, quando la stampa d’Oltralpe lo definiva tale, egli stesso si ribellava. Si offendeva, anzi. E ribadiva la triestinità di adozione, perché nel porto dell’impero egli aveva scoperto non solo il mare ma anche una visione internazionalista della scienza. La prova fu proprio quel piroscafo plurilingue che vinse una sfida inaudita e mai divenne Babele. Nelle sue ultime lettere il comandante dichiarò di non aver niente da spartire col nazionalismo crescente che già allora spingeva l’Europa verso il gran burrone. «Voglio tu sappia — scrive Weyprecht poco dopo essere tornato in terraferma all’amico scienziato Heinrich von Littrow — quanto sono stati bravi gli ufficiali e l’equipaggio durante tutto il periodo. Quale contrasto con l’indisciplinata accozzaglia della spedizione americana di Hall! Lì contrasti, mancanza di coraggio, ammutinamenti, meschinità. Da noi armonia, pronta ubbidienza, subordinazione fino alla fine, in quelle situazioni così difficili, talvolta senza speranza; mai un accenno di mancanza di coraggio, nonostante le sconfortanti prospettive e i duri strapazzi. Questo è il mio più bel trionfo, che io festeggio e tu con me, perché tu eri uno dei pochi che era d’accordo con me sulla scelta dell’equipaggio». Appena tornato dalle terre del Nord, Weyprecht il triestino spese tutte le sue energie per spiegare che lo studio del pianeta Terra richiedeva uno sforzo internazionale i poli dovevano essere il baricentro di questa esplorazione. Tanto fece, che nel 1882 fu istituito il primo anno polare mondiale e dieci paesi costruirono quattordici basi tra Artide e Antartide, e altre trentacinque nel resto del mondo. Weyprecht morì poco dopo per una fulminante malattia, ma la sua opera rimase scolpita negli annali della scienza, al punto che nel 1907 — quando Amundsen, Scott, Shackleton e il Duca degli Abruzzi si riunirono per istituire la Commissione polare internazionale — il nome fu solennemente evocato per dire che la spinta determinante era partita da lui. L’ultimo a morire, di quel favoloso equipaggio, fu il dalmata Antonio Zaninovich, nel 1937 a Trieste, pochi mesi prima che vi fossero proclamate le leggi razziali e il mondo ripiombasse nella barbarie. Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 2 MARZO 2008 i luoghi Genio militare La Cittadella di Alessandria è stata per due secoli una delle basi più importanti dell’esercito Resistette a francesi ed austriaci, ad assedi e rivolte, tenne imprigionati La fortezza dove è nata l’Italia MASSIMO NOVELLI L ALESSANDRIA uigi XIV non doveva avere una buona opinione dei suoi “cugini” piemontesi, se un giorno esclamò che «i Savoia non terminano mai una guerra sotto la stessa bandiera con cui l’hanno iniziata». Il Re Sole ce l’aveva con Vittorio Amedeo II, il futuro Re di Sicilia e di Sardegna, che proprio i francesi aveva sconfitto nel settembre del 1706 durante la battaglia di Torino. I repentini cambi di alleanze non deposero certamente a favore del duca sabaudo, detto la Volpe savoiarda, ma nessuno osò mai mettere in discussione la sua spiccata vocazione per le arti militari. Se non bastassero gli avvenimenti storici raccontati nei libri, a testimoniarlo sopravvive ancora adesso un monumento eloquente, addirittura straordinario: il grandioso complesso della Cittadella di Alessandria, a forma di mazziniani e partigiani Un anno fa è stata abbandonata e chiusa per sempre Siamo andati a esplorare, tra silenzi irreali, quei bastioni segreti esagono stellare schiacciato, che è un esempio raro e unico in Europa di architettura difensiva. Vittorio Amedeo ne ordinò la costruzione nel 1728 a Ignazio Giuseppe Bertola, tortonese, «Primo Ingegnere di Sua Maestà», nominato conte d’Exilles nel 1742. Già nel 1745 ebbe il battesimo del fuoco. I soliti francesi strinsero in una morsa la città allungata nella pianura piemontese, ponendo il blocco all’enorme fortezza edificata lungo la sponda sinistra del fiume Tanaro. Ma gli assediati resistettero. Concepita massiccia e pressoché invisibile, dietro ai bastioni, per essere al riparo dal tiro del cannone, la Cittadella non fu espugnata e l’esercito di Carlo Emanuele III poté attendere l’arrivo dell’armata di soccorso. Da allora ai giorni nostri, in più di due secoli di assedi, rivoluzioni, occupazioni, imprigionamenti e fucilazioni di patrioti mazziniani e poi di partigiani, passando dalla battaglia napoleonica di Marengo ai moti risorgimentali del 1821, dalle guerre d’In- dipendenza alla Resistenza, la Cittadella e i suoi 478.340 metri quadrati di superficie, una vera città nella città, inaccessibile, è stato un teatro della storia, la base principale dell’esercito piemontese e in seguito una delle più importanti dello Stato unitario. Oggi, invece, tra il fossato, i sei bastioni possenti, i rivellini, le controguardie, i lunghi viali, le caserme, i magazzini che rifornivano di vestiario e di viveri l’intera regione militare del Nord-ovest, il palazzo del governatore e il piazzale di trentamila metri quadrati, a dominare è il silenzio. Un silenzio irreale, quasi uno smisurato silenzio metafisico di un dipinto di Giorgio de Chirico o di una sequenza di un film di Michelangelo Antonioni, rotto soltanto dall’irrompere del vento, dall’apparire su un bastione di un fenicottero, dal crepitio delle foglie secche nei mulinelli di polvere. E il silenzio colma, nel freddo, le ampie sale vuote, desolatamente nude, delle caserme Giletti e Beleno, dove prima riecheggiavano le voci dei soldati, i comandi impartiti seccamente, il battere dei tacchi, lo sferragliare delle sciabole. Lasciata libera dall’esercito nel 2007, quando l’ultimo militare chiuse dietro di sé a doppia mandata il portone d’ingresso e l’abbandonò per sempre, la Cittadella è passata all’Agenzia del Demanio, cioè allo Stato, che nel frattempo ha firmato un protocollo d’intesa con il comune di Alessandria per la gestione e la valorizzazione di un bene architettonico e artistico che rappresenta, senza alcun dubbio, uno dei più notevoli monumenti europei nell’ambito delle fortificazioni. Il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, nel 2011, potrebbe essere il volano ideale per eseguire i lavori di restauro e cominciare a progettare in concreto la rinascita dell’ex complesso militare, che all’epoca d’oro arrivò a ospitare trentamila uomini e negli anni Cinquanta del Novecento fu ancora sede del Cinquantaduesimo reggimento di artiglieria pesante. È però difficile che si Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 È stata una culla del Risorgimento: qui nel 1821, innalzando il tricolore, insorse una guarnigione di patrioti. Prima della battaglia di Montebello FOTO FOTOTECA GILARDI la “Gazzetta del Popolo” indisse una sottoscrizione per munirla di cento cannoni da puntare contro i soldati di Francesco Giuseppe A STELLA A sinistra, un’antica pianta della Cittadella di Alessandria Nelle foto, particolari di esterni e di interni della fortezza riesca a sfruttare l’opportunità. A causa dei tagli ai fondi pubblici destinati alla ricorrenza unitaria e per la priorità data alle opere in fase già esecutiva, con ogni probabilità la Cittadella non avrà reali benefici. A meno che non venga accolta l’ipotesi di realizzazione di un parco urbano nel fossato e nelle aree fortificate esterne, il cui costo è stato calcolato in oltre quattro milioni di euro e che è stato progettato da un gruppo di architetti torinesi: da Aimaro Isola a Paolo Pejrone, allo Studio Deferrari, a Giovanni Durbiano, a Luca Reinerio, all’Icis srl. La Cittadella alessandrina è stata realmente una culla del Risorgimento, dato che qui, nella notte fra il 9 e 10 marzo 1821, innalzando il tricolore e proclamando la Costituzione di Spagna, insorse la guarnigione agli ordini di patrioti come Ansaldi, Baronis, Bianco di Saint Jorioz, Palma, mentre a Torino e nel resto del Piemonte agivano Santorre di Santa Rosa, Asinari di San Marzano, Moffa di Lisio, i protagonisti della prima rivoluzione liberale d’Italia, insieme a quella napoletana del 1820. Sempre in Cittadella, nel 1833, vennero messi ai ferri e quindi uccisi l’avvocato Andrea Vochieri e altri aderenti e simpatizzanti della Giovine Italia. Nel suo celeberrimo libro I martiri della libertà italiana, Atto Vannucci narra che «all’avvocato Vochieri, uomo venerabile per onestà e dottrina e fermo contro ogni tormento, usò trattamenti bestiali il general Galateri governatore di Alessandria». Lo sgherro di re Carlo Alberto, prima di procedere con la fucilazione, lo fece incatenare per le mani e per i piedi, oltre che con un collare di ferro. La terribile cella in cui agonizzò è rimasta come allora. È in un sottotetto della caserma Beleno. Sulla porta c’è il suo nome, accanto una targa che rammenta il sacrificio dell’avvocato mazziniano. Dentro, in uno spazio esiguo, nella luce avara che filtra malamente da una finestrella, sono conservati il tavolaccio di legno, le catene, il collare. Fuori, sul piazzale, si ritrovano il silenzio di un mattino di febbraio, un sole che carezza le facciate delle vecchie caserme dalle tinte marroni e rosse corrose dagli anni e le lapidi a ricordo di atti eroici e valorosi, come quelli compiuti dai fanti della Brigata Ravenna nella disastrosa campagna di Russia dell’Armir. Camminando per i viali, svoltando in piazzale Gorizia, scorrono idealmente i giorni di Napoleone, che diede impulso al completamento delle fortificazioni, e quelli della mobilitazione per le guerre risorgimentali; i giorni dei francesi, accasermati tra queste mura prima della battaglia di Montebello, e della sottoscrizione della Gazzetta del Popolo, che la indisse per munire la fortezza di cento cannoni da puntare contro gli austriaci di Francesco Giuseppe. Fantasmi, echi, memorie, oblio. La nuova battaglia, ingaggiata ora dell’esercito delle ombre dei soldati che vissero e combatterono tra questi bastioni, ha un scopo preciso: impedire che la Cittadella muoia in tempo di pace. Una macchina del tempo per fabbricare lentezza DANIELE DEL GIUDICE uasi ogni città italiana ha in sé o nei dintorni una fortezza, un sistema di mura e torri da avvistamento, opere belliche e difensive che sono diventate con il tempo opere d’arte e d’architettura. C’è un profondo intreccio di rapporti tra l’architettura militare e quella civile; le opere militari talvolta anticipano i temi di quelle civili o li riprendono immediatamente, e, all’epoca di Michelangelo o Francesco di Giorgio Martini o Leonardo, l’“artista” edificava sia i palazzi sia le fortezze, riassumeva in sé le due attività. Le fortezze sono in qualche modo templi di una scienza, la scienza militare. Anche le chiese sono templi di un sapere, cantato e magnificato dall’edificio che lo ospita, perennemente sicuro di sé. Ben diverso è il caso della fortificazione; non ci sono dogmi sedimentati e per sempre validi e la scienza di cui è tempio è destinata a diventare velocemente obsoleta. La caduta, l’espugnazione di un forte e del territorio che esso presidia implica la caduta della concezione architettonica e conoscitiva che ne è l’anima, come mostra il rapido evolversi e mutare delle teorie della fortificazione e della loro pratica attraverso i secoli. Una retta o un angolo mal progettati si trasformano prima o poi in un tracollo militare. Le fortificazioni come le vediamo oggi nelle città italiane sono opere d’arte e sono anche dei musei, vuoti o prevalentemente vuoti di arredi: non espongono immagini della propria dottrina ma solo se stesse, racchiudono un’idea speciale di tempo, un’idea dello sguardo, e un’idea complessiva del rapporto tra dentro e fuori, relazione, questa, di cui la fortezza è l’emblema più caparbiamente e istituzionalmente significativo. La fortezza è un tipo di architettura ma anche un tipo di macchina; è un’architetturamacchina e segnatamente una “macchina del tempo”, che non può muoversi lungo il tempo come quelle di H.G. Wells ma può “muovere” il tempo, e tra le possibili macchine del tempo appartiene al tipo specializzato nel produrre ritardo. In un trattato di Bonaiuto Lorini, architetto rinascimentale, si legge che il suo fine era fabbricare «il corpo della fortezza […] con ordine tale che i pochi difensori si possano difendere da numero assai maggiore col fargli perdere tempo». La vera arma della fortificazione era produrre lentezza, dilatare il tempo fino a renderlo inoffensivo. E la durata del ritardo prodotto poteva essere calcolata; gli allievi di Sébastien de Vauban (m. 1707) avevano messo a punto un metodo teorico per stabilire, sulla carta, la quantità di lentezza prodotta da una fortificazione e dunque il tempo necessario per espugnarla. Tale metodo, che prese il nome di «analisi delle fortezze» e fu alla base della scuola francese di Mézières, la scuola del genio militare creata nel 1748, prevedeva, ad esempio, che l’esagono bastionato dovesse cadere in mano all’attaccante in ventitré giorni; peraltro questo tipo di calcolo, che spesso produceva grandi illusioni, fu decisamente contestato da Napoleone. Tempo ritardato, dilatato, furono i quarantadue giorni dell’assedio di Ostenda nel 1601, i trentanove giorni dell’assedio di Luxemburg nel 1684, diretto dallo stesso Vauban, e l’intero anno necessario per la caduta di La Rochelle nel 1627. Era un tempo impiegato a costruire altre parti di quella macchina della lentezza, come nell’assedio di Candia (1637), quando difensori e attaccanti condussero una guerra di mine e contromine davvero al limite e la stessa postazione saltò in aria diciassette volte in ventiquattro mesi. Era il tempo delle ronde notturne, degli occhi che si sforzavano di distinguere il minimo movimento o un baluginio nel buio, il tempo degli appostamenti alle feritoie sparando alla cieca, presi dal terrore, oppure con parsimonia, valutando il tempo di avvicinamento del nemico e quello di ricarica delle proprie armi, era un tempo abbastanza rallentato da permettere l’agonia, il dolore, la percezione di un significato possibile e di un finale. Le fortezze sono musei muti che conservano un’idea speciale dello sguardo. Il modo in cui si guarda una fortezza, o si guarda da una fortezza, benché opera d’arte, non ha nulla dello sguardo contemplativo della chiesa, la fortificazione non è il luogo del vedere, della “visione”, ma del “guardare”, anzi del traguardare, è il luogo dello sguardo per collimazione, e della mira. Qualunque costruzione doveva permettere di guardare e colpire di fronte a sé, ma anche di fiancheggiare ed essere fiancheggiata, proteggere ed essere protetta, ogni punto doveva essere visibile da un altro punto, e tutto stava nell’evitare luoghi coperti allo sguardo e alla mira. Il modo di guardare si trasformava immediatamente in un modo di colpire, i calcoli erano quasi gli stessi, con molta probabilità la prospettiva e la balistica sono nate dalla stessa teoria. È quasi impossibile capire una fortificazione senza immaginare questo sistema di sguardo e mira che era parte fondante della sua funzionalità e della sua sicurezza. Le fortezze sono musei di un rapporto speciale tra dentro e fuori. Senza dubbio la fortificazione nasce dall’interno, anzi dal centro di un giro di compasso. Quale figura inscrivere all’interno di questo cerchio? un pentagono? un esagono? una figura con più lati, una stella? Ma più lati vuol dire più angoli, e più sono gli angoli più sono ottusi, e più le mura sono frontali, e più offrono possibilità di impatto ai colpi. Nei secoli, la trattatistica delle fortificazioni non fa che discutere se è meglio l’angolo acuto o l’ottuso, se molti lati o pochi lati, se lati corti o lunghi. Ogni angolo proiettato in fuori crea angoli morti verso l’interno, cioè punti morti allo sguardo e al tiro, dove gli attaccanti possono insinuarsi e alzare scale o ammassare cumuli di terra, aprire varchi nelle mura e metterci del materiale esplosivo. Tutto nasce dall’interno, ma tutto può essere modificato dall’esterno. Sono i tiri di artiglieria e le loro accresciute potenza e precisione nei secoli a determinare il mutamento o l’evoluzione delle fortezze, occorreva tenere conto dei diversi tipi di fuoco: fuoco di infilata, fuoco ficcante, fuoco rovescio o obliquo, fuoco diretto, e questi tipi di fuoco, sia da parte dei difensori sia degli assedianti, erano direttamente complementari alla forma della fortificazione, ne erano in qualche modo il calco esterno. Ogni oggetto teso verso l’esterno serviva a guardare e a prendere la mira e a proteggere i punti più rientrati verso l’interno, ma poi bisognava fare postazioni più avanzate, aggettate sull’esterno per controllare quell’interno da fuori, bisognava farsi esterno, vedersi da fuori, vedere la fortezza come la vedevano gli assedianti. E comunque i nemici potevano aprire una breccia e penetrare nella fortificazione, tutto poteva capovolgersi da un momento all’altro, dunque tutto ciò che era stato pensato verso l’esterno doveva essere a rovescio, rivoltarlo verso l’interno. Una caponiera avanzata serviva soprattutto a colpire alle spalle chi fosse arrivato sotto le mura, ogni interno doveva poter essere difeso dall’esterno, la fortificazione doveva guardare e colpire gli attaccanti dal proprio punto di vista, ma anche guardarsi dal punto di vista di chi la assediava, e proteggersi. In fondo, la fortificazione è l’arte di essere dentro e anche fuori, di dire noi e anche gli altri. Q Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 2 MARZO 2008 CULTURA* Un libro, “Così tante vite”, e una prossima mostra online ricostruiscono la vicenda culturale del secondo Novecento attraverso le carte lasciate da Giancarlo Vigorelli, intellettuale e giornalista: i salotti letterari, i giochi dietro le quinte dei premi più prestigiosi, i rancori e le rivalità tra sommi poeti vincitori di Nobel PROTAGONISTI Nelle cinque foto qui sopra e accanto, da sinistra: Giancarlo Vigorelli con Ignazio Silone; Dacia Maraini; Emilio Vedova; Salvatore Quasimodo; André Gide E Quasimodo insultava Montale PAOLO MAURI li archivi di Giancarlo Vigorelli riserveranno probabilmente molte sorprese viste le numerose amicizie testimoniate nell’album fotografico Così tante vite a cominciare da quella con Gadda foriera di lettere inedite: di volume in volume l’epistolario gaddiano comincia a diventare davvero cospicuo, una sorta di racconto parallelo alle opere. Ci dobbiamo, intanto, contentare dei frammenti finora emersi e diluiti nel corso del tempo: lettere di Montale, di Quasimodo, di Moravia e di Dacia Maraini, della Ginzburg. Lettere al critico, ma anche lettere all’amico: la società letteraria italiana è sempre stata abbastanza ristretta, limitata a pochi circoli, geograficamente legati alle solite città, Milano, Firenze e poi Roma e, finché c’erano, ai soliti caffè. Nel nostro caso è Vigorelli a spostarsi: da lombardo diventa romano e da critico giornalista per dirigere Momento sera. Tornerà poi a Milano. Ma veniamo ai «frammenti»: il primo, cospicuo, è firmato da Montale (Eusebio) che gli scrive chiamandolo Eustachio. La lettera, da Firenze, è datata 4 marzo 1940 e qui la trascrivo: «Caro Eustachio, sono atterrito. Come farai? E poi chi legge l’“Assalto”? Ti pagano almeno? Finirai per maledirmi. Ma non fare note biografiche. Quelle poche le vedi nella Treccani “volume supplemento”. Non ho però compiuto studi come crede A. Bocelli al quale io non l’ho mai detto. Ne ho fatti, dai Barnabiti, senza esito. Sapevo qualcosa di latino, nulla di greco. Ma queste cose non dirle, ché mi rovineresti. In più puoi dire che ho tradotto 3 lavori di Shak.: Winter’s Tale, Timon of Athens e Comedy of Errore — e da Eliot, da Guillén, da Leonie Adams. (Non sono, tra parentesi, come crede Titta Rosa, un eliotiano: il monthly (allora) criterion ha pubblicato Arsenio nel 1928, “prima” cioè che uscissero le liriche che avrei imitato in Arsenio. Confronta e vedi.) Ora traduco persino dello Steinbeck, per vivere. Delle Occasioni esce a giorni la 2a ediz. con quattro aggiunte da poco. Inediti proprio non ne ho. Come fare? Se mi venisse fatto qualcosa in questi giorni non mancherei di avvisarti. Puoi dire, en passant, che il New York Timesdel 29 gennaio mi ha dedicato un grosso feuilleton, che se t’interessa poso anche mandarti. È di Henry Furst. In Corrente mi ha salvato Traverso, altrimenti si restava alla nota dell’aficionado Elio. Stroncature poche: quella di Sigillino e quella di Eurialo. E G questa, io non ho mai detto che sia stata suggerita da altri: ma che certe conversioni di E. (che ormai non è più fermo a Betti) escludendomi rivelano il solito traffico, al quale non mi assoggetto. All right. Tutto è andato bene. Io sono un bischero ma non è colpa mia se gli altri sono più bischeri... «Nell’antologia metti anche due o tre ossi, in modo che le occasioni non siano più di un 60% dell’intera serie pubblicata. (Anche per ragioni editoriali) Sai che Ojetti m’aveva proposto (dopo essersi comprato il libro) per un piccolo pourboire dell’Accademia, ma Papini si oppone a spada tratta, persino con accuse politiche? Quanto alle poesie dice che le faceva meglio lui 20 anni fa, ma che ora ha mutato idee. Quindi è probabile che resterò a becco asciutto. Tanto meglio, se non fosse per quei quattro maledetti soldi. «Qui noia, ma non si sta certo peggio che altrove. Il Marques girava con una tua lettera pazzo di felicità. È convinto di muoversi in una pepiniera di genii che gli faranno una piattaforma immortale. Siccome l’ho scoperto io, anni fa, tra gli abbonati del W.C. (Vieusseux), mi crede il suo Virgilio. Carlino è un po’ abbacchiato, sospeso tra la vita militare incomben- “Eusebio nei miei riguardi si è dimostrato il peggior lacchè di un monarca decaduto...” te e le varie stroncature; ma si rimetterà. «Come vedi, temo di poterti dare poco aiuto. Se vuoi rifiutare l’onorifico incarico del camerata Granzotto fallo pure. Ti devo già fin troppo. «Non so come stai fra i varii “gruppi” e se puoi ancora uscire di casa. Salutami quelli che si ricordano benevolmente di me». La lettera è firmata con un «sempre aff. mo Eugenio Montale». A questo punto servirebbero molte chiose per mettere in chiaro, fin dove possibile, i numerosi riferimenti a persone ed eventi. Mi limito a far notare il pro- blema dei «maledetti soldi». Montale è stato licenziato dal Vieusseux in data 1 dicembre 1938, «nonostante i suoi meriti letterari e lo zelo e competenza», si legge nel verbale, poiché sprovvisto dell’appartenenza al Pnf. Gli viene liquidata l’indennità di preavviso e quella di licenziamento, ma all’atto pratico si ritrova privo di uno stipendio. Come accenna anche in questa lettera incomincia a tradurre per sopravvivere. Nel ‘40 esce un solo articolo di Montale ed è la recensione al Ricordo della Basca di Antonio Delfini. Quanto alle Occasioni, il libro di poesie cui si fa più di un cenno, è uscito alla fine di ottobre del ‘39. Il disoccupato Montale, che per un po’ pensò anche di andarsene in America, aveva scritto in quei mesi a Bobi Bazlen di aver evitato due suicidi in due mesi: e così registrava l’invio a Einaudi dell’opera: «Sono 50 poesie di cui 40 brevi e 17 sono inedite. Verrà un 120 pagine. Versi 1131 di fronte ai 1600 degli Ossi. Totale versi 2731; Leopardi ne ha scritto (esclusa la Batracomiomachia) 3996». Delle stroncature e delle altre chiacchiere del tempo non c’è ormai quasi più traccia. *** Vent’anni dopo un altro poeta italiano, Premio Nobel (1959) molto prima di Montale, e cioè Salvatore Quasimodo, scrive a Vigorelli a proposito di una intervista venezuelana contenente giudizi su Ungaretti e Montale. «Quello che riguarda Ungaretti, è chiaro, non l’avrei detto oggi e di questo puoi rassicurare il poeta. Per Montale, pur non avendo detto nulla in quella occasione, non mi pentirei di sottoscriverlo anche oggi perché Eusebio nei miei riguardi si è dimostrato, e continua a dimostrarsi, come il peggior lacchè di un monarca decaduto. Comunque Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 NERI POZZA Accanto, una lettera dell’editore Neri Pozza a Vigorelli (nel cerchio la firma). Nelle foto, Neri Pozza con Eugenio Montale, ancora Montale e, sotto, Alberto Moravia ENNIO FLAIANO “Caro Vigorelli, grazie di cuore per il tuo articolo sul mio libro”, comincia così la lettera di Ennio Flaiano riprodotta qui accanto Nel cerchio la firma, sotto una foto di Flaiano NATALIA GINZBURG A sinistra, una lettera di Natalia Ginzburg e, sotto, la scrittrice con Mario Soldati e Guido Piovene EUGENIO MONTALE A sinistra, una lettera autografa di Eugenio Montale (nel cerchio la firma) e, parzialmente coperta, una sua lettera dattiloscritta L’avventura di vivere tra libri, quadri e film GIAN PAOLO SERINO n libro e una mostra on line raccontano le «così tante vite» di Giancarlo Vigorelli, protagonista della vita culturale del secondo Novecento. Critico instancabile, scopritore di talenti destinati alla storia, da Pier Paolo Pasolini al pittore naïf Antonio Ligabue, sceneggiatore per Roberto Rossellini, consigliere e amico di Luchino Visconti, Sartre, Borges, Ionesco, Bacon, de Chirico, Pound e Senghor. Intellettuale capace tra i primi di intuire l’importanza del dialogo tra letteratura, cinema e arte, Vigorelli ha diretto per anni la Settimana Incom e ha fondato nel 1958 la Comunità europea degli scrittori, poi La nuova rivista europea, battendosi per l’idea che l’Europa andasse unita nella cultura prima ancora che «nel carbone e l’acciaio». Tra i principali promotori della liberazione di Solgenitsyin e di Aksionov, ha assegnato il Premio Taormina a Anna Achmatova, priva di passaporto e da anni ridotta al silenzio, ha fondato Il Corriere lombardo, è stato presidente della Segisa, società editrice del Giorno e fino alla morte, il 16 settembre 2005, presidente del Centro nazionale di studi manzoniani. Davvero Così tante vite, come testimonia anche il volume da pochi giorni in libreria e curato dalla moglie Carla Tolomeo: oltre trecento fotografie inedite che raccontano un altro Novecento. I salotti letterari, i giochi dietro le quinte dei premi più prestigiosi e i molti segreti mai raccontati dei tanti amici artisti. Immagini tratte dall’Archivio Vigorelli, ora acquisito dalla Biblioteca Sormani di Milano, che testimoniano la vivacità di un intellettuale che ha sempre inseguito l’idea di un’Europa unita ante litteram e che fino all’ultimo è stato incredulo di aver vissuto, come scrive Claudio Magris nella prefazione del libro, «una vita avventurosa, che lo portava a battersi per scrittori e culture perseguitate». E proprio dal libro, pubblicato dalla casa editrice Mattioli 1885 (336 pagine, 33 euro), prende vita una mostra su internet: sarà inaugurata venerdì 7 marzo alle 11 su www. wuz. it, il portale culturale di Ibs. Un vero e proprio vernissage virtuale durante il quale verranno esposte una trentina delle foto pubblicate, la prefazione integrale di Magris, uno scritto inedito di Vigorelli sull’amato Manzoni e una sezione, Caro Giancarlo, con molte delle lettere inedite che qui in parte anticipiamo. Da Gide a Moravia, dalla Morante a Quasimodo, da una poesia inedita di Attilio Bertolucci a uno scritto di Eugenio Montale. Autografi che testimoniano, citando Magris, un tempo in cui la letteratura non era ancora assenza ma autentica vita d’avanguardia e non, come spesso accade oggi, da ritirata. U LETTERE INEDITE I documenti inediti che pubblichiamo in queste pagine per gentile concessione dell’archivio Vigorelli testimoniano la fitta attività della “cucina” letteraria del critico novecentesco. Scrittori, poeti, artisti, intellettuali si rivolgevano a lui per i motivi più svariati: chiedere un parere su un’opera, sollecitare un appoggio presso un editore o la giuria di un premio letterario, protestare per una stroncatura e così via. Dal basso in alto, a partire dalla macchina da scrivere, le lettere sono di: Dacia Maraini; André Gide (completa di busta); Emilio Vedova con un disegno dell’artista; Salvatore Quasimodo; Alberto Moravia; un altro manoscritto di André Gide non sono stato io mai a dirottare dalle buone qualità umane che ogni uomo di cultura dovrebbe avere “dentro”. E se Eusebio, invece di fare gli scongiuri insieme col suo diletto fossile salottiero appena sente il mio nome, si mettesse una mano al posto del cuore (almeno sulla giacca) le cose andrebbero meglio. Io vivo a Milano e la città di Milano (parlo della ruota dei chierici) non mi sarebbe stata per lungo tempo nemica in virtù della presenza del nostro poeta». Dunque se Montale alludeva ai benevoli nei suoi confronti, Quasimodo reclama meno ostilità: Vigorelli, ma non solo lui, avrebbe potuto testimoniare della complessa vita (e psiche) dei letterati, spesso alle prese con invidie, maldicenze e colpi bassi. *** Di un colpo basso si lamenta Dacia Maraini in una lettera del ‘62 a Vigorelli, piena di amarezza. Era accaduto che Vigorelli se la prendesse con L’età del malessere, opera della giovanissima Maraini candidata al Premio Formentor (che poi vinse). Vigorelli aveva attaccato la scrittrice, presentata da Moravia, alla libreria Einaudi di Roma. Poi aveva scritto alla Maraini ed ecco che lei gli rispondeva: «Caro Vigorelli, La ringrazio per la sua lettera. Soltanto non riesco a capire come lei possa scindere così facilmente la persona dello scrittore dalla sua opera. Lei non può dire che non ha nulla contro di me se tratta con tanto disprezzo ciò che scrivo e i termini in cui mi si è attaccato quella sera alla libreria Einaudi mi hanno offesa proprio perché i miei libri sono la più diretta espressione della mia persona. Ed io non mi presento al pubblico per essere ammirata per la mia faccia o per la mia giovane età, ma lavoro seriamente per dire alcune cose che mi stanno a cuore...». A sostegno della Maraini era intervenuto anche Moravia con una successiva lettera a Vigorelli: «Caro Vigorelli, come già ti dissi il giorno del nostro incontro per strada, non ho niente in contrario, per quanto riguarda la mia persona, a dimenticare quanto è accaduto dentro e fuori la libreria Einaudi. Tuttavia vorrei dire alcune cose circa la tua lettera a Dacia Maraini. Secondo me avresti dovuto riflettere un poco prima di riconfermare con tanta sicurezza e decisione il tuo giudizio negativo sull’opera della Maraini». Moravia aveva scritto una prefazione e presentato l’opera al premio Formentor. Grande bagarre. I premi sono un’altra occasione di scontro, non sempre effimero, tra i letterati. Per questo mi piace citare una lettera a Vigorelli di Natalia Ginzburg che, a proposito della candidatura al Campiello del suo libro Caro Michele, avverte il giurato Vigorelli: «Non desidero concorrere al Premio, anche perché, essendovi fra quei libri scelti alcuni libri che trovo molto belli, e nomi di amici che mi sono molto cari, non desidero entrare in competizione». Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la lettura Impostori DOMENICA 2 MARZO 2008 “Identità rubate” è un romanzo di T.C. Boyle che racconta come si possono trafugare i dati di un altro, entrare nella sua vita e devastarla. Lo spunto, per un giovane scrittore italiano, per riflettere su un fenomeno che colpisce dieci milioni di americani ogni anno e che mette a rischio ogni giorno un cittadino europeo su quattro TOMMASO PINCIO o pagato i miei debiti, ho persino lasciato una mancia» dice di sé Christopher Rocancourt. Se lo ha davvero fatto lo sa soltanto lui. Di sicuro, però, non lo ha fatto di tasca sua. Oggi Rocancourt ha una quarantina d’anni ed è uno fra i più grandi impostori in circolazione. Nel corso della sua poco onorata ma fantasiosa carriera si è spacciato per membro della famiglia Rockefeller, produttore cinematografico, finanziere, figlio di Sophia Loren e nipote di Dino De Laurentis. Le sue effettive origini sono assai più modeste, sebbene dal sapore vagamente romanzesco. Sua madre era una prostituta a tempo perso e suo padre adottivo un alcolizzato che lo ha pescato in un orfanotrofio «H giare video con l’intenzione di non restituirli oppure molestare telefonicamente una ragazza. Quindi si passa al livello successivo, il più ricorrente: accumulare debiti e svuotare conti correnti. Infine, se siete davvero sfortunati, si può arrivare a reati di prima grandezza quali traffico di stupefacenti e terrorismo. La possibilità di vedersi sottratti pezzi della nostra persona è meno remota di quel che si potrebbe credere. «In America viene rubata un’identità ogni sei secondi» si diceva in un film di qualche tempo fa ispirato a una storia vera. Probabilmente è un’esagerazione. I numeri ufficiali non sono però più confortanti. I rapporti governativi parlano di dieci milioni di vittime ogni anno. Dalle nostre parti il fenomeno non è ancora altrettanto diffuso ma è comunque preoccupante. In base a una recente ricerca effettuata da una nota azienda specializzata nella sicurezza informatica, un per- siete persa d’animo e conducete un’esistenza normale. Insegnate inglese in una scuola per non udenti e avete un fidanzato che lavora nel cinema, ritocca gli effetti speciali al computer. Una mattina uscite di casa un po’ trafelata perché siete in ritardo sulla tabella di marcia. È un vostro difetto, quello di essere sempre ritardo. Così vi mettete a correre un po’ più del dovuto e nella foga vi capita di bruciare uno stop sotto il naso della polizia. Vi viene intimato di accostare. Vi vengono chiesti patente e libretto. L’agente si allontana per i controlli di rito. Voi restate in attesa. Sbuffate e pensate che la giornata è cominciata male. Non immaginate quanto avete ragione. Dopo qualche minuto l’agente torna e vi punta la pistola contro. Sembra piuttosto agitato. Urla qualcosa. Voi non potete udirlo ma vedete le sue labbra. Ciò che vi leggete non è il genere di cosa che ci si aspetta di sentirsi dire per non avere ri- spettato uno stop. «Metta le mani dove possa vederle»: è questo che vedete nel movimento delle labbra. Complimenti, siete appena diventati un pericoloso criminale. La lista di accuse a vostro carico è lunga: assegni scoperti, droga, rapina a mano armata e una sfilza di altri reati commessi un po’ qui un po’ là, in posti di cui fino a ieri ignoravate perfino l’esistenza. L’incubo in cui precipita Alex Halter e che potrebbe riguardare ciascuno di noi è il tema di un romanzo dell’americano T. Coraghessan Boyle: Identità rubate, per l’appunto. Abbiamo dunque scherzato? Niente affatto. Benché si tratti di finzione narrativa, il libro di Boyle è «così attuale e ben informato che l’Fbi potrebbe perquisirgli casa in cerca di carte di credito clonate» ha scritto il Washington Post. La sua storia immaginaria ha inoltre molti aspetti in comune con un caso presentato quattro anni fa nella tra- per lui così da poter carpire al padre Isacco la sua benedizione. Lo fece presentandosi al cospetto del genitore con il corpo coperto di pelli di capra perché suo fratello era molto peloso. «Sono Esaù, il tuo primogenito. Dammi la tua benedizione» gli disse. Isacco, la cui vista era ormai indebolita, lo invitò ad avvicinarsi perché lo voleva tastare. Sentendo tutto quel pelo si convinse e diede la sua benedizione, seppur con qualche dubbio: «La voce è quella di Giacobbe, ma le mani sono di Esaù». Questa storia biblica è una metafora perfetta del mondo in cui viviamo oggi. I sistemi di verifica e controllo sono spesso ciechi come Isacco. Non potendo vedere, si affidano alle pelli di capra dell’era informatica: stringhe di dati. Non di rado la cecità non è un inconveniente della tecnologia, bensì della cultura del credito istantaneo. Compra oggi, paga quando sarà: è l’affare del secolo e chi lo gestisce è talvolta di- Quelli che ci rubano il nome all’età di cinque anni. Ma vai a sapere se è realmente così. Questa storia l’ha raccontata lui stesso in un’intervista rilasciata un paio di anni fa, e tutto quello che dice Rocancourt va preso con le molle. Si stima che l’ammontare delle sue truffe superi i quaranta milioni di dollari. Il New York Times ha tracciato il suo profilo con un’iperbole: «Le donne si gettavano ai suoi piedi, gli uomini gli gettavano contante». Di talenti come Rocancourt non ne esistono molti, ciò nonostante la truffaldina arte dell’impostura è un’attività in continua espansione. Tecnicamente si chiama furto d’identità. In parole povere significa che qualcuno ha pensato bene di appropriarsi dei vostri dati personali. Nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, numero di cellulare e forse anche della carta di credito. Se ne è appropriato per essere voi. Gli scopi possono essere molteplici, per non dire infiniti. Si parte da abusi quasi innocenti, come noleg- sona su quattro in Europa rischia di subire un furto d’identità perché usa password troppo semplici per accedere ai propri account online. E internet costituisce soltanto una faccia del problema, in quanto la sottrazione dei dati personali avviene perlopiù nel mondo reale. A peggiorare le cose c’è poi il fatto che la scoperta del furto non è mai immediata. Non è come quando ti rubano l’auto. Il ladro può servirsi della vostra identità per mesi o addirittura per anni prima che ve ne accorgiate, e quando ciò avviene è sempre perché, da un giorno all’altro e senza motivo apparente, vi ritrovate nei guai. Ecco uno dei tanti modi in cui può andare: vi chiamate Alex Halter, siete una giovane donna di trentatré anni che non ha mai avuto a che fare con la giustizia. Da bambina, una meningite spinale vi ha danneggiato i nervi uditivi e siete rimasta sorda. La natura vi ha però fornito di un carattere indomito, per cui non vi IL LIBRO Identità rubate è il nuovo romanzo di T.Coraghessan Boyle in libreria il 4 marzo (Einaudi, 300 pagine, 17 euro) È la storia di una donna alla quale viene clonata l’identità Dopo essersi trovata carica di debiti per spese non fatte e denunciata per violazioni mai commesse, decide di mettersi sulle tracce del truffatore smissione Mi manda Rai Tre, quello di un giovane napoletano affetto da una grave malattia invalidante la cui identità è stata rubata per aprire due conti correnti ed emettere assegni a vuoto. È opinione diffusa che la proliferazione di simili truffe sia dovuta a internet. In effetti una delle tecniche preferite dai criminali è il cosiddetto phishing, lo “spillaggio” di dati sensibili attraverso l’invio di falsi messaggi di posta elettronica che simulano la comunicazione di una banca o magari di un ente pubblico. Il fine è quello di convincere il malcapitato a rispondere fornendo informazioni personali. Questa è però soltanto una delle insidie possibili. Spesso il furto viene messo in atto con sistemi ben più artigianali e che non lasciano tracce. Del resto, stiamo parlando di un imbroglio vecchio quanto il genere umano. Nel libro della Genesi si legge che Giacobbe, approfittando della momentanea assenza del fratello Esaù, si spacciò sposto a chiudere un occhio pur di accaparrarsi un nuovo debitore. Quanto ai Giacobbe di oggi, hanno mille modi per procurarsi le loro pelli di capra. Internet, lo si è detto, è soltanto uno di questi e nemmeno il più consistente: soltanto l’uno per cento dei furti avviene attraverso il famigerato phishing. I ladri d’identità possono sapere quello di cui hanno bisogno rubando portafogli o la corrispondenza dalle cassette della posta o addirittura rovistando alla maniera dei barboni tra i rifiuti. Oppure rivolgendosi a chi le informazioni le ha già. Un tabloid britannico ha fatto una prova assoldando un esperto di sistemi di sicurezza. Costui ha preso contatto con l’operatore di un call center il quale gli avrebbe offerto dati riservati, inclusi codici di carte di credito, al modico prezzo di quattro sterline e venticinque per ogni informazione. Ma c’è dell’altro. Una bella fetta dei furti d’identità avviene alla maniera di Giacobbe, vale a dire Repubblica Nazionale LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 ILLUSTRAZIONE DI GIPI DOMENICA 2 MARZO 2008 in casa. Un rapporto della Federal Trade Commission rivela che ben il sedici per cento delle vittime conosce il ladro. A quanto pare, bisognerebbe guardarsi da amici, vicini, domestici e, nel sei per cento casi, persino da parenti e membri del nucleo familiare. La buona notizia è che al momento più della metà delle vittime riesce a cavarsela senza sborsare una lira sbrigando le noie burocratiche derivate dal furto in un tempo medio di quattro ore. Basta dunque augurarsi di non finire in quello sventurato cinque per cento che ci rimette almeno cinquemila dollari e passa più di centotrenta ore tra banche, studi legali e commissariati. Per quanto: i danni di un furto d’identità non si pesano soltanto in termini economici. Ci sono persone che hanno perso il posto di lavoro o si sono viste negare un prestito o sono state molestate in vario modo e per lungo tempo da un’agenzia di recu- Solo l’un per cento dei furti avviene su Internet mediante DAVID HAMPTON CARLOS LOMAX JEAN-CLAUDE ROMAND FRÉDÉRIC BOURDIN ALAN CONWAY Immortalato da John Guare in Sei gradi di separazione, negli anni Ottanta derubò alcuni milionari newyorkesi convincendoli che era figlio di Sidney Poitier Condannato di recente a 37 mesi di reclusione dopo essere stato riconosciuto colpevole dell’apertura di 14 linee di credito usando l’identità dell’attore Will Smith Sterminò la famiglia quando non poté più impersonare la falsa identità che si era costruito. La sua tragica vicenda è narrata in un romanzo di Emmanuel Carrère Denunciato nel 2005 per aver frequentato a 31 anni un liceo francese spacciandosi per un orfano quindicenne. La preside: «Sembrava un po’ più grande» Ha girato l’Europa e gli States nei panni di Stanley Kubrick offrendo pranzi nei più costosi ristoranti. Nel 2006 la storia è diventata un film, Color Me Kubrick riconoscerlo in quanto tale è impresa non da poco. Nella nostra società la soluzione più pratica di cui disponiamo sono piccoli pezzi di carta o plastica con una fotografia, un nome, una data di nascita e pochissimo altro. Sappiamo bene però che questi documenti sono un’espressione assai riduttiva e falsificabile della persona. Il codice genetico potrebbe essere un’alternativa infallibile e nemmeno troppo fantascientifica, ma siamo disposti ad accettarla? Il controllo è una sicurezza a doppio taglio. In Francia, la carta d’identità fu introdotta nel 1940 e l’uso immediato che ne fece il governo di Vichy fu di facilitare l’individuazione di settantaseimila ebrei da deportare nei campi di concentramento. Senza contare che quel che la scienza prova è solo la nostra identità biologica. Il cuore dell’identità umana è però un altro: il posto che ciascuno di noi occupa nella società. Qui il discorso si fa più Il codice genetico il famigerato phishing può essere l’alternativa Ma è accettabile? pero crediti. Un uomo ha pure rischiato di essere lasciato dalla moglie perché il suo ladro d’identità ha avuto un incidente automobilistico mentre se ne andava in giro con una graziosa fanciulla. Essere impersonati da qualcun altro ha conseguenze imprevedibili e rappresenta inoltre un grosso shock emotivo. Michelle Brown, una ragazza il cui caso è stato tra i più pubblicizzati negli Stati Uniti, ha definito l’esperienza come il «capitolo più terrificante della mia vita». La si può capire. Ognuno di noi tende a considerare la propria identità come un patrimonio scontato, naturale. Eppure basta che qualcuno si appropri di frammenti della nostra esistenza per ritrovarci nella sconvolgente situazione di dover provare chi siamo. E può non essere facile. Come definire l’identità? Per il sentire comune è l’insieme di cose che ci rende persone, vale a dire esseri unici e distinti dagli altri. Ma anche un fiocco di neve è unico e distinto, ciò nonostante complesso perché l’identità sociale comprende tantissime cose, va dalla fedina penale al pettegolezzo. È proprio questo sterminato territorio dagli incerti confini che gli impostori inquinano rubandoci l’identità. Ciò che costoro ci sottraggono è quel che gli altri pensano di noi, il nostro buon nome, forse la cosa più preziosa che abbiamo, giacché, non dimentichiamolo, siamo pur sempre animali sociali. La paura di perdere la reputazione è talmente radicata che talvolta arriviamo addirittura al punto di temere che il ladro siamo noi. Gli psicologi la chiamano sindrome dell’impostore: è la paura di aver imbrogliato il prossimo inducendolo a sopravvalutarci, a stimarci più bravi, competenti e onesti di quel che in effetti siamo. Una sindrome connessa a un malessere tipico del nostro tempo: l’ansia da prestazione. Poi ci sono quelli che impostori di se stessi lo sono veramente, ma questa è un’altra storia. O forse no. Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 2 MARZO 2008 SPETTACOLI Il più celebre cartoonist italiano si racconta Mezzo secolo di carriera, centinaia di film, una nomination all’Oscar “La mia fortuna sono stati i Caroselli: mi hanno dato da vivere e mi hanno permesso di fare i corti, dove non guadagno nulla ma posso esprimermi in totale libertà”. E per festeggiare regala a “Repubblica” uno dei suoi mini-racconti inediti: da leggere come un piccolo cartoon ANNA BANDETTINI i voleva la mano di un inventore geniale per trasformare un omino di cartone, timido e ordinario, animoso e bonaccione, uno che arditamente, ma solo talvolta, osa mostrare una nascosta faccia di bronzo, in un piccolo, splendido eroe che fa ridere e fa venire il magone. Il signor Rossi, che in doppiopetto e senza sorriso si ficca sempre nei guai, come uno di noi, uno dei tanti che sempre si rialza, era tragicomico allora e tragicomico adesso, dopo mezzo secolo di avventure animate. «Mi è sempre piaciuto raccontare l’uomo ridendoci su. Deve essere per via di mio padre, gran spirito critico. Se guardi il mondo con occhio critico, lo vedi più in profondità e dunque puoi anche scherzarci. Ecco da dove sono nati i miei film», dice Bruno Bozzetto, settant’anni domani, ancora ironici, entusiasti, appassionati. «Ma di festeggiarli non se ne parla. Starò con Tommaso, il mio piccolo nipote, che tanto mi diverte». Dopo centinaia di film e una cinquantennale, lusinghiera carriera, il più amato cartoonist italiano, un culto del cinema animato per invenzione grafica, ironia, impegno morale, il più celebre all’estero, il solo che sia riuscito a raggiungere una nomination all’Oscar (col magistrale Cavallette del 1990), continua a godersela immerso nelle sue passioni. «Non so star fermo — racconta Bozzetto — Sono una locomotiva. Nei rari momenti in cui non lavoro, disegno ma soprattutto scrivo. Raccontini, nulla di più, che poi rimetto prontamente nel cassetto. Meglio che faccia cinema». Pochi grandi hanno fatto tanto come lui, anche partendo da giovani. Un Oscar per il signor Rossi, il primo vero cortometraggio — dopo l’esperimento di Tapum! La storia delle armi del ’58 —, il primo con l’omino qualunque che sarebbe poi diventato una celebrità, è del ‘60. «A Bergamo c’era un festival del film d’arte diretto da un certo Nino Zucchelli, dove ero di casa. Al festival ci si divertiva, era pieno di artisti jugoslavi che mi svuotavano la cantina. A un certo punto decisi di mandare un mio film in concorso, che però non fu accettato. Me la presi anche perché sinceramente al festival vedevo cose più brutte delle mie. Fu lì che mi venne la storia dell’omino appassionato che sta su la notte per montare il film della sua vita… La storia è la mia caricatura, ma il signor Rossi è quel Zucchelli che mi rifiutò il film». Quello sguardo sarcastico è rimasto come un marchio di fabbrica: dalla parodia western di West C and soda del ’65 all’imitazione ironica dei zuccherosi cartoon Disney di Allegro non troppo del ’77 (qualche anno fa entrambi restaurati dalla Cineteca Italiana di Milano), agli indimenticabili lungometraggi con l’altro popolarissimo personaggio Vip mio fratello superuomo del ‘68, fino agli sberleffi delle serie tv (Spaghetti family, I Cosi). Ma soprattutto quello sguardo ha marchiato gli innumerevoli cortometraggi, dirompente sintesi di una commedia umana: undici minuti di sarcasmo sulla guerra, la fame e la tv con I sottaceti(‘71), due minuti di disastri planetari con la Storia del mondo per chi ha fretta (2001), sei minuti per lo sghignazzante ritratto degli italiani in Europa di Europa & Italia, primo film in 2D (2000), trafugatissimo sul web... e così via. «La mia vera passione è il cinema, non il cinema d’animazione. Fin da quando era ragazzino. Mio padre aveva comprato una Bauer, come la “Allegro non troppo Ho settant’anni” Bruno Bozzetto vidi non la mollai più scoprendo che il cinema era bellissimo come mezzo per raccontare storie. Bello ma impegnativo. Perché voleva dire ogni volta chiamare gli amici, mettere le luci... Allora cominciai a fare pasticci nel block notes e a riprenderli. Deve essere nato così Donald Duck Cartoon, primissima prova animata». Aveva quindici anni, mai avrebbe pensato che quello era il suo futuro. «Con coerenza mi ero iscritto prima a biologia, poi a geologia e infine a legge. I cartoon li facevo per passione, finché dopo qualche pubblicità mi chiamarono a Carosello. Allora i maestri che mi avevano stimolato erano Pagot dei Fratelli dinamite, Richard Williams della Pantera Rosa, gli autori della Zagreb Fil di Zagabria. Poi soprattutto Norman Mc Laren che mi ha dato il coraggio di fare qualcosa di diverso, di di- verso da Disney e Tom e Jerry, voglio dire. Io volevo fare discorsi sulla società. Oggi posso dire che la pubblicità è stata una fortuna, perché dandomi da vivere mi permise di fare i tanti cortometraggi che non facevano guadagnare nulla ma dove mi esprimevo in totale libertà e creatività. Sono stati anni formidabili». Erano gli anni Sessanta in una Milano, dove è nato, che aveva la voglia di vivere della sua gioventù. «Il primo studio fu il salotto di casa, in San Babila. Quando cominciai con i Caroselli c’erano centinaia di disegni da far asciugare, erano dovunque, per terra, in corridoio. Poi, una volta sposato, andai ad abitare a Bergamo e lo studio si trasferì in via Melchiorre Gioia». Di lì sono passati devoti allievi come Manuli, Nichetti, Alvise Avati, il figlio di Pupi. Luogo mitico per i cinefili, lo studio ha chiuso nel 2000 sostituito da una strana “factory famigliare”: Bruno, il figlio Andrea e Pietro Pinetti lavorano insieme a Bergamo, dove adesso abitano; Fabio, l’altro figlio, ha aperto a Milano una sua società di animazione; di computer si interessa anche una delle due gemelle che con moglie, cane, canarino compongono la «banda di matti» autoritratta nella serie la Famiglia Spaghetti. «Le idee più belle le ho avute in coda in auto- Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 LE IMMAGINI Tutte le immagini delle pagine sono opera di Bruno Bozzetto Quella grande al centro è una scena da West and Soda (1965) Dall’alto a sinistra: i personaggi di Vip mio fratello superuomo e de Il Signor Rossi; una scena da Vip mio fratello superuomo (1968); una da Cavallette (1990); la scena di folla è stata realizzata per Superquark. La vignetta qui accanto sul tema del compleanno è stata disegnata apposta per la Repubblica in occasione dei settant’anni di Bozzetto Sotto, una scena da Il Signor Rossi La strega e il piccoletto BRUNO BOZZETTO orse era lui. Non lo so con sicurezza, e d’altronde è più che normale sbagliarsi dopo tanti anni. E se non era lui gli assomigliava moltissimo. Piccoletto, con gli occhi molto vicini tra loro e le orecchie a sventola. Non era una bellezza, lo so, ma in questi casi non é il lato esteriore che conta. La prima volta che lo vidi stava attraversando una strada del centro. Un tram gli stava volando addosso e riuscii ad evitare la tragedia facendo lievitare il piccoletto da terra e deponendolo due metri più avanti… Lui non capì, e, tranne un bambino che mi lanciò una strana occhiata, nessuno notò il fatto. Ma il bambino pensò di aver sognato, e tutto finì lì. Poi ci fu il ristorante. Avevo appena varcata la soglia, quando ti vedo il piccoletto già seduto al suo tavolo, proprio sotto al lampadario centrale. Mi bastò un’occhiata per “sentire” che pochi secondi dopo quell’ammasso di cristalli gli sarebbe precipitato sulla testa, sfracellandogliela. Il piccoletto dalle orecchie a sventola non si poteva certo definire un tipo fortunato… Comunque mi affretto a passargli accanto e scivolo a terra, fingendo un malore. Lui si alza per soccorrermi, e il lampadario piomba giù come una freccia, polverizzando la sua sedia e schizzando miliardi di cristalli nei piatti di tutti i commensali. Tanta paura, ringraziamenti alla sorte, brindisi e pace amen. E poi questa sera, davanti al teatro. Eccotelo ancor lì, con tanto di smoking e papillon, in compagnia di una grassa occhialuta. Due vetture si urtano, poco distante, e la più gagliarda sbanda veloce verso la donna e il piccoletto. Riesco a far deviare l’auto di quel poco necessario per salvargli la pelle anche stavolta. La grassa occhialuta invece si fratturò tre costole. Si sa che stando alle “regole” non dovrei far di queste cose sotto gli occhi della gente, ma il piccoletto era fatto spaccato quel tipo che avevo incontrato in una delle mie precedenti vite. Credo nel 1320 o 21, non ricordo la data con esattezza. Ricordo solo che stava iniziando l’inverno. Ero una poveraccia allora, senza una gamba e sicuramente meno attraente di adesso. Un balordo di cavallo mi aveva urtato mentre tornavo dal mercato, e caddi nel fango. In quel secolo avevo una brutta reputazione perché ero stata vista più volte raccogliere erbe di gatto che poi usavo bollire nelle notti di plenilunio. Dicerie senza alcun fondamento, ma a quei tempi tra una faccenda del genere e l’affibbiarti l’epiteto di “strega” non ci correva molto. E si sa che con un appellativo del genere davanti al tuo nome di battesimo le probabilità di morire di morte naturale diminuivano del 97 per cento. Comunque ero lì in mezzo al fango, incapace di rialzarmi, e tutti mi evitavano, sghignazzando e preferendo ignorarmi che mostrare amicizia verso una donna «fortemente sospetta di pratiche occulte». Tranne quel piccoletto con le orecchie a sventola. Lui ignorò quelle stolte dicerie, non si preoccupò del pericolo e mi aiutò a rimettermi in carreggiata. Ed era anche un nobiluomo, con tanto di spada, stivali di vero cuoio e mantello di seta rossa. Mi aiutò porgendomi la mano, proprio come si fa con una vera signora. Fu un gesto molto carino, e dopo avermi fatta rialzare e raccolto le cose che mi erano cadute, mi regalò anche un bella moneta d’argento. Sembra incredibile. Erano trascorsi quasi settecento anni ma quel piccoletto me lo ricordavo come fosse oggi… F LA FOTO Qui a destra, Bruno Bozzetto in una foto di Federico Buscarino A sinistra, un disegno tratto dal film Allegro non troppo strada durante i tragitti Milano-Bergamo. Avevo, anzi ho ancora, un registratore. Quando mi viene una frase indovinata, un pensiero, registro. Per anni, per esempio, vedevo di fianco all’autostrada una montagna di rifiuti che cresceva e che poi un giorno fu coperta di terra. E se un domani un contadino va a zappare lì sopra, cosa ci trova sotto? Mi chiesi un giorno». Venne fuori Big Bang, un corto dove la terra diventa un enorme cassonetto in procinto di scoppiare, che oggi sarebbe perfetto… «Le idee non sono un problema, il difficile è svilupparle perché il cartoon richiede tempo e professionalità». E tecnica, che Bozzetto ha sperimentato avidamente. «Per lazzaronismo, mi creda. Il cartone è un lavoro lungo, arcaico. Il digitale rende tutto più veloce. Per questo sono un fan della Pixar e di John Lassiter, vera pietra miliare dell’animazione 3D. Prima di lui c’erano delle sagome meccaniche senza anima, dopo di lui sono diventati umani. Prenda Nemo, con Bambi è il più bel cartone mai fatto. Anche internet è un mezzo stupendo, fai un film e dilaga come una epidemia, te lo vedono in trequattro milioni. Il problema è che non ci guadagni niente. Da anni mi sto spaccando la testa per trovare un modo per farlo fruttare, per i giovani sarebbe l’ideale. Ma ora ho altri progetti». Il primo progetto è un film pilota per Disney Channel che potrebbe diventare una serie di ventisei episodi. «Sempre la Disney mi ha chiesto un altro film pilota sulla falsariga dei miei corti su internet, stilisticamente semplici. Ci sono poi i cartoon sulle pensioni per Superquark. E nel cassetto una sceneggiatura di un lungometraggio, un Minivip e Supervip nella fantascienza, ma trovare una produzione oggi è dura. Quello che mi dà ai nervi è che in Italia fai il cartoon e tutti pensano ai bambini. Per adulti non è concepito e produrne diventa sempre più difficile. Così io che sono un velocista ho dovuto rallentare. Avrei potuto fare trenta lavori, ne faccio dieci. Pazienza, un po’ di tempo per il windsurf lasciamocelo». Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 2 MARZO 2008 i sapori itinerari Tavola italiana Accademico della cucina, Andrea Grignaffini è uno dei più appassionati e colti esperti di parmigiano reggiano Insegna Metodologia di degustazione all’Università di scienze gastronomiche di Parma Pasta in bianco Nuvola Tortellini Aria Consistenze Con gli ingredienti di un piatto basic, il torinese Alfredo Russo elabora una squisita millefoglie di pasta all’uovo Il parmigiano reggiano viene utilizzato come farcitura (crema cotta), spuma aerea che avvolge la lasagna e in piccole chips croccanti Tra gli sfizi d’apertura del suo affascinante menù, Massimiliano Alajmo propone un trittico da acquolina in bocca In alto di un bignè ripieno di pomodoro e una cialda croccante ai cereali, troneggia una nuvola di parmigiano reggiano Moreno Cedroni rivisita gli storici anolini parmigiani, offrendoli con una piccola battuta di manzo al coltello e salsa di pomodoro Al posto del ripieno tradizionale (parmigiano reggiano e pane grattugiato), un cucchiaino di golosa fonduta Dopo il mitico gelato di parmigiano, Ferran Adrià ha inventato altre ricette dedicate, estreme e deliziose, come la finissima polvere ghiacciata servita nella tradizionale vaschetta di polistirolo, accompagnata da un muesli di chips di frutta disidratata Il modenese Massimo Bottura trasforma cinque stagionature (dai 18 ai 40 mesi) in un demi-soufflé caldo. In alto, una spuma fredda, una crema tiepida, una galletta croccante, un brodo fatto con le croste e un “40 mesi” grattugiato, montato ad aria Mentre l’Europa boccia “Parmesan” e cloni, nel fazzoletto di terra dove è nato si preparano a festeggiarlo. E a difenderne la genuinità Parmigiano Reggiano LICIA GRANELLO na scheggia tira l’altra. Un assalto irresistibile alla “punta” che troneggia sul tagliere: uno sguardo voglioso, il coltellino sagomato (mandorlina) che incide e separa con rustica gentilezza, rispettando la fine granulosità della polpa, una sorta di ruvidezza setosa assaporata tra le dita, un attimo prima della bocca. Morbido, sapido, croccante, deliziosamente odoroso, ricco di calcio e fosforo, meno calorico di tanti suoi compagni di caseificazione, il parmigiano reggiano è forse il più virtuoso dei formaggi in circolazione. Tutto, dalla lavorazione con solo latte crudo di mucche alimentate senza insilati, alla limitata area di produzione — uno sghembo quadrato di terra tra le province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna (ma solo a sinistra del Reno) e Mantova (ma solo a destra del Po) —, profuma di buono. Raccontano che intorno all’anno mille, i monaci benedettini misero a punto un metodo per trasformare il latte prodotto dai bovini con cui bonificavano le paludi della pianura padana in “formaggione”, capace di conservarsi nel tempo. Da allora a oggi, l’invenzione salva-latte si è trasformata in seimila aziende agricole, cinquecento caseifici, quasi trentamila mucche e un fatturato al consumo che supera il miliardo e mezzo di euro. La preparazione, in compenso, è rimasta uguale e affascinante. Il latte, addizionato di caglio naturale e siero, viene scaldato fino a poco più di cinquanta gradi in caldaie di rame. È l’uomo, e solo lui, con la sua mano callosa e arrossata, a palpare il liquido bollente, decidendo il momento in cui rompere la cagliata (ovvero il latte coagulato) in granuli. La massa biancastra, estratta con l’aiuto di pertiche di legno, avvolta in tela di lino, e fatta scolare, viene divisa in due fascere, battezzate con placche di caseina (il grasso del latte) che le identificano. Dopo tre settimane di riposo “attivo” in salamoia (vanno rigirate spesso per uniformare la penetrazione del sale), comincia l’anno di stagionatura, alla fine del quale il marchio a fuoco promuove le forme senza difetti, pronte per la seconda fase di affinamento. Copiare tanta bontà non è facile, ma ci provano in molti, soprattutto fuori confine. In settimana, la Corte di giustizia europea ha bocciato la commercializzazione del Parmesan per la felicità di governo e consorzio di tutela, pur evitando di sanzionare la Germania produttrice. Il guaio è che non sempre il parmigiano reggiano mandato sugli scaffali è all’altezza delle aspettative. E come spesso succede, quando l’eccellenza non è perfettamente riconoscibile, la tentazione di comprare un clone a prezzo minore è grande. Negli anni, il conferimento del latte si è trasformato da garanzia a limite, perché non tutti gli allevatori puntano al meglio. Così, mentre in Francia è invalsa la tendenza a rendere più severi i disciplinari di produzione, da noi si abbassano i tempi di stagionatura, non si incrementa la qualità dei foraggi, si evitano parole chiare su un tema delicato come la presenza di ogm nell’alimentazione animale. Un livellamento in basso che ha ridotto le distanze dal grana padano, l’acerrimo rivale realizzato secondo norme meno stringenti (sono consentiti insilati e antifermentativi). Per fortuna, esistono gli artigiani. Produzioni piccole, appassionate, di qualità alta, altissima, rigorosamente ogm-free, che funzionano da volano per tutto il settore: biologici, di montagna, da razze locali. Il loro successo obbliga le aziende dei grandi numeri ad alzare l’asticella della qualità. Andate a gustarli sul posto, i parmigiani reggiani virtuosi: senza gocce di balsamico, mostarde, mieli, salse. Nudi come casaro li ha fatti. E fate posto in macchina, per portarvi una mezza forma a casa. Sarà l’investimento più saggio e goloso della vostra vita. U L’italiano più imitato nel mondo Vacche rosse Salvate dall’estinzione dopo anni di strapotere delle iperproduttive frisone, le rosse reggiane producono latte altamente proteico, che garantisce longevità e gusto Mangimi ogm free, almeno 90 per cento di foraggio locale, stagionatura minima di 24 mesi Extra È la dicitura premio per la stagionatura di 18 mesi e l’esame di “espertizzazione” da parte dei “maestri” del Consorzio La “prima stagionatura”, invece, segnala le forme difettate nella struttura o nella crosta, ma senza alterazioni delle caratteristiche Biologico Il disciplinare di agricoltura bio viene adottato lungo l’intera filiera, dal campo alla stagionatura del formaggio La naturalità della produzione è supervisionata dall’Associazione dei produttori biologici e biodinamici dell’Emilia Romagna Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 Reggio E. Parma Modena Mantova Bologna DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE LA GHIRONDA Via XX Settembre 61 Montecchio Emilia Tel. 0522-863550 Chiuso domenica sera e lunedì, menù da 30 euro LOCANDA DEL SALE Località Maestà Lesignano de’ Bagni Tel. 0521-857170 Chiuso lunedì e martedì, menù da 28 euro OSTERIA VECCHIA Via Michelangelo 690 Guiglia Tel. 059-792433 Chiuso lunedì e martedì, menù da 30 euro NEGRI Martiri della Libertà 14 Gonzaga Tel. 0376-52818 Chiuso domenica sera e lunedì, menù da 25 euro TRATTORIA TOMBA Via Armarolo 26 Budrio Tel. 051-878104 Chiuso mercoledì e domenica sera, menù da 25 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE ISTITUTO AGRARIO ZANELLI Via Fratelli Rosselli 41 Tel. 0522-280340 AZIENDA BONATI Via Bosco 3 Piazza di Basilicanova Tel. 0521-681707 CASEIFICIO ROSOLA Casello 1026 V. Rosola 1083, Zocca Tel. 059-987115 AZIENDA PORTIOLI Via Viola Sacca 16 Pegognaga Tel. 0376-58642 CASEARIA S. ANNA Via Sparate 1 Anzola Emilia Tel. 051-739659 La seconda vita delle vacche rosse CORRADO BARBERIS opire, troncare: sopire». Ecco la formula proposta dal contezio di manzoniana memoria per soffocare sul nascere lo scandalo Tutti con la mandorlina in mano del nipote Rodrigo. E «segmentare, domenica 30 marzo nel centro frammentare: frammentare, segmendi Collecchio, cuore della Food Valley tare» sembra eccellente rimedio contro la “scandalosa” inappetenza del parmense. Nata da un’idea di Paolo consumatore verso prodotti, anche tie Rosangela Gennari, appassionati pici, di troppo vasta mole. In una conproduttori, la mostra-mercato giuntura che tende alla diminuzione più che all’aumento delle spese aliFormaggio & compagnia mette mentari. Eppur si cresce. Secondo le a confronto i migliori caselli statistiche Assolatte quel simpatico pachiderma del parmigiano reggiano au(micro-caseifici) del territorio menta il suo volume da 110 a 117mila Tra gli assaggi più interessanti, tonnellate tra 1998 e 2006. Grazie, in il tosone, ma anche stagionature primo luogo, alla sua straordinaria bontà. Ma grazie, anche, ad una certa estreme come il 60 mesi immagine di novità che gli si è creata attorno. L’antichissimo si è intrecciato col giovanissimo. Frammentare, segmentare. A cominciare è stato, una ventina d’anni fa, un coltivatore diretto laureato, Luciano Catellani, presidente dei superstiti allevatori di vacche rosse, la tradizionale bovina reggiana dei tempi dell’Ariosto e di Filippo re, poi soppiantata Altro salvataggio in extremis dalle bruno-alpine in epoca fascista e dalle frisone in era democristiana. Proper un parmigiano antico, prodotto duceva meno latte questa razza — da con latte di razza modenese, qui la sua quasi scomparsa — ma un latte adattissimo alla caseificazione. e protetto da un presidio Slow Food Non fu agevole impresa ottenere di 24 mesi per la stagionatura minima coagularlo autonomamente invece di delle forme, caratterizzate disperderlo nei cento rivoli cooperativi, ma il Consorzio capì e oggi il parmida un eccellente rapporto giano reggiano delle vacche rosse, il cui fra grasso, proteine e caseine marchio si affianca a quello principale, spunta prezzi notevolmente superiori, anche di un terzo, rispetto alla media. Visto il successo reggiano, i modenesi non hanno voluto essere da meno. Avevano anche loro un razza storica, dal mantello bianco? Da circa un anno è possibile acquistare forme della razza bianca caseificata in purezza. Il Consorzio Qualità Tipica E ci si è messo pure il ParlaVal Baganza e il Consorzio Terre mento. La legge di Montagna sono tra i protagonisti 97 del 31 gennaio 1994 autodelle produzioni da latte d’altura a mar(sopra i 600 metri). Ricco, aromatico, rizzava chiare come spesso certificato come biologico, prodotti della montagna, cioè garantisce un parmigiano adatto di erbe particoa lunghe stagionature di prodotto larmente pregiate, i formaggi che pur già godessero il marchio di un consorzio di tutela. Altra occasione perché alcuni caselli dell’Appennino emiliano approfittassero della doppia timbratura. E poi c’è la campagna biologica. La gente si sente rassicurata quando compra bio: e non solo quando si tratta di cereali o di frutta. A Cremona Fiere, nella manifestazione dedicata al Cheese of the year, per il secondo anno consecutivo ha spopolato il Parmabio, una stalla di Bardi, nell’alta quota parmense, che ostenta un prodotto biologico. Si aggiunga che, mentre fino a qualche tempo fa era considerato ottimo il cacio di due anni e venerando quello di tre, oggi fanno capolino quelli da quattro, da cinque anni e ancor più. Una sfida per il gourmet, costretto a fare assaggi di tutte le varianti. Segmentare, frammentare. O non è stato così fin dai tempi di Carlo Magno? Fu il grande imperatore a creare il primo bisticcio, assegnando alla contea di Reggio ma alla diocesi di Parma alcuni territori oggi all’avanguardia casearia. E poi fu la volta dei Landi, gente emiliana con terre di sinistra di Po, nel lodigiano. Il loro grana era così perfetto che la Camera di Commercio di Milano, con una delibera del 1895, vietava di chiamare parmigiano IL LIBRO le forme che non fossero prodotte a LoEsce il 4 marzo di e dintorni. A ristabilire il buon senso l’edizione provvide una sentenza della Corte di ampliata Cassazione di Torino che riconobbe i e aggiornata diritti degli emiliani. Ma intanto tra Lodel Dizionario di e Parma, tra Parma e Reggio, il forenciclopedico maggio grana aveva vissuto un’appasdei formaggi sionante vicenda della segmentazioa cura ne. Proprio come oggi tra vacche rosse, di Corrado bianche o frisone, tra montagna e bioBarberis logia, tra un’annata e l’altra. (Mondadori, L’autore è presidente dell’Istituto 1.215 pagine, nazionale di sociologia rurale 30 euro) «S L’appuntamento Bianca Montagna Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze Abitare oggi DOMENICA 2 MARZO 2008 In occasione dell’8 marzo s’inaugura a Torino una grande mostra interamente dedicata al design al femminile che mette in vetrina il meglio della produzione industriale e artistica. Protagoniste, documenti e oggetti illustrano un percorso di lavoro, spesso sconosciuto, del made in Italy ed evocano i variegati successi degli ultimi anni 2 1 ELEONORE PEDUZZI RIVA In argento, come tipico del marchio De Vecchi, Jarra (ovvero caraffa in spagnolo) è modellata senza angoli. Firmata Eleonore Peduzzi Riva 2 LORENZA BOZZOLI Cuore caldo, come dice il nome, è una borsa dell’acqua calda a forma di cuore, pensata da Lorenza Bozzoli per Antiquità 3 CARLA BARATELLI Ventiquattro antenne telescopiche che terminano con led a basso consumo È Bib Bang di Carla Baratelli per Aldabra 4 FRANCESCA DONATI Micama è un’isola per il relax che si srotola e si compone a piacere Tutta sfoderabile, di Francesca Donati per Antidiva Forme Femmina AURELIO MAGISTÀ 1 Altri progetti, altro futuro così le donne si raccontano «C on il passare degli anni, ero diventata sempre più consapevole di quanto più brava e preparata e determinata doveva essere una donna per poter occupare spazi e mietere successi rispetto a un uomo, malgrado pari condizioni, preparazione e opportunità». Sono parole di Anty Pansera, curatrice con Luisa Bocchietto dell’evento D come Design, la mano, la mente e il cuore. L’appuntamento è una rassegna sul design al femminile che apre l’8 marzo (e proseguirà fino al 27 aprile) e propone un calendario di eventi con epicentro a Torino, World Design Capital per il 2008. Le parole della Pansera vogliono anticipare le accuse di femminismo e i dubbi sull’opportunità di presentare ancora una volta un’ipotesi di lettura sessuata della creatività. Legittimo chiedersi se esiste un design cui possiamo assegnare l’etichetta di femminile, e se la femminilità, il femminismo, non possano diventare una forma di ghettizzazione. Resta il dato di fatto, incontrovertibile e verificabile in tutte le società e in tutti i contesti professionali, che per le donne è sempre più difficile affermarsi. Anche se questo fosse l’unico argomento a sussistere, la rassegna avrebbe ragione di essere. Perché assume il valore, se non di un risarcimento, almeno di un accertamento storico del ruolo che le donne ebbero e hanno nel design. E il centenario dell’8 marzo, il giorno della donna, è proprio l’occasione giusta per cominciare questa elementare operazione di giustizia. L’operazione, articolata fra Alessandria, Bra, Biella, con altre iniziative che si apriranno fino alla fine di maggio, adombra nei contenuti il sospetto di un cedimento a un certo provincialismo. Anche per questo resta di riferimento l’appuntamento di Torino, con la mostra al Museo di scienze naturali (via Giolitti 36, info allo 011-4326354) di cui si sottolinea la struttura tripartita. La prima sezione, Un “cuore” torinese: dagli inizi del Ventesimo secolo ad oggi, è dedicata alle pioniere, dalle donne presenti all’Esposizione universale di Torino del 1902, a progettiste e imprenditrici come Elena Scavini Koenig e Paola Navone, e a car designer come Giulia Moselli e Anna Visconti. La seconda sezione fa da ponte tra la prima e la terza: focalizza l’attenzione sulle coetanee (entrambe del 1920) Anna Castelli Ferrieri e Franca Helg. Da ponte nel senso che racconta due protagoniste del design che non ci sono più per condurci al passato più recente e al presente. Nella terza sezione infatti, Sei decenni di progettualità al femminile, 1948-2008, sono raccolti esempi, oggetti (tra cui quelli riprodotti in queste pagine) e progetti che illustrano come le donne hanno lavorato e sono intervenute negli spazi privati della casa, nell’ufficio, nella scuola, negli ospedali e nelle comunità. Il dato positivo resta l’impressionante aumento della presenza femminile nel design. Oltre ai pezzi in mostra, firmati anche da nomi simbolo come Gae Aulenti o Cini Boeri, l’esposizione fa emergere figure come Patrizia Moroso, Maddalena De Padova, Adele Cassina, sottolineandone quell’eclettismo in cui qualità imprenditoriali e creative si integrano bene. 9 ANGELETTI E RUZZA Se ci si vuole dedicare alla cucina meglio farlo con le padelle tonde Easy Cook di Stefania Angeletti e Daniele Ruzza per Guzzini 10 GARGAN E GIOVANNONI Linea aerodinamica, colori accesi e nome molto ironico (Gnam) per il porta pane firmato Alessi. Di Elisa Gargan e Stefano Giovannoni 11 MIRIAM MIRRI Si chiama Giotto il vaso totem di Miriam Mirri per Plus Collection È antropomorfo anche nella dimensione: quasi a misura d’uomo 5 12 MONICA GRAFFEO Lazy (pigra) Mary: nome di donna per la chaise longue che dondola di Monica Graffeo Sfrutta il baricentro del corpo.Da Disguincio 6 7 Repubblica Nazionale DOMENICA 2 MARZO 2008 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 3 4 5 AULENTI E CASTIGLIONI Il sistema di illuminazione Cestello fu progettato da Gae Aulenti e Piero Castiglioni per i Guzzini La prima versione ha più di vent’anni 6 AGNOLETTO E RUSCONI Laura Agnoletto e Marzio Rusconi Clerici disegnano El: da un lato specchio in lamiera acciaio inox, dall’altro libreria. Da Pallucco 7 CHIARA, GIOIA E GIULIANA Di Chiara Caramelli, Gioia Giovannella e Giuliana Gramigna, Frog di Mandarina Duck ha il guscio metà morbido e metà rigido 8 GIBERTINI E MIRRI Sembra un accessorio moda, il porta-sacchetti igienici per padroni di cani creato da UnitedPets Di Ilaria Gibertini (nella foto) e Miriam Mirri Matite creative crescono dal merletto alla moto LAURA LAURENZI a mano, la mente e il cuore lavorano diversamente se sono di una donna? Difficile stabilire se esista una via femminile al design, come in qualunque altro campo, un approccio specifico, difficile sbarazzarsi dei luoghi comuni, difficile non ricadere nello stereotipo. Se il maschio è homo faber, la donna che disegna e progetta che cos’è? Aiuto. Quanto è meglio essere considerate prima di tutto una persona, indipendentemente dal genere. Unica valutazione accettabile è quella sul merito: l’oggetto che disegni è bellobrutto, è utile-inutile, è intelligente-stupido. Bene hanno fatto gli organizzatori della mostra di Torino a intitolare la mostra D come design e non D come donna. Le donne non sono una categoria. No, non c’è e non deve esserci uno stile riconoscibile, un linguaggio autonomo, una femminilità o, peggio, una femminilizzazione del design. Il design nasce dalla volontà di dare al maggior numero possibile di persone uno standard estetico elevato, e questo non attiene alle differenze di genere, ma ci riguarda tutti. In teoria. La pratica è molto diversa. La vita di tutti i giorni è una strada in salita, fatta di insidie, trabocchetti e sgambetti. Le designer, le donne che hanno avuto l’ardire e la passione di scegliere uno dei lavori più contemporanei e moderni, sono molte (molte rispetto al passato) e sono brave, ma come succede in altri settori, fanno il doppio di fatica per emergere e per affermarsi. Il loro lavoro è spesso oscuro. Tante giornaliste donne ma così poche riescono a diventare direttori, tante donne in cucina ma i grandi chef sono tutti uomini, sempre più donne medico ma quante diventano primario? La moda poi è una fucina di talenti femminili ma le stiliste donne, quelle conosciute e riconosciute, sono ancora un’eccezione. È così anche nel design: le vere star, i veri creativi sono uomini. Certo il termine designer può essere inteso con grande elasticità. È una designer Gae Aulenti ed è una designer anche un’oscura ricamatrice. Artigiana o artista, una donna è una designer a tempo pieno, nell’uso creativo e geniale delle risorse che ha a disposizione, nel riempire la vita e le ore di sostanza e quando può di bellezza e di armonia, nella flessibilità, nella facoltà di progettare spazi e cose, vita e quotidianità. E nel dare forma e corpo a un’idea immateriale che si trasforma in oggetto, nel caso faccia la designer di mestiere. La mostra sul design delle donne allestita a Ferrara nel 2002, dal titolo Dal merletto alla motocicletta, censiva circa un centinaio di donne affermate. Oggi a Torino il loro numero è triplicato. Qualche segnale di cambiamento c’è, lo conferma Luisa Bocchietto, art director della mostra di Torino, nonché da pochissimo tempo presidente dell’Adi, associazione designer italiani, che dal 1956 ad oggi ha avuto una donna alla sua guida soltanto una volta (con Anna Castelli, dal ‘69 al ‘71) per il resto è sempre stata solidamente in mani maschili: «Ci sono molti tabù da superare, ma qualcosa si sta muovendo», assicura. Le donne disegnano di tutto, certo non soltanto oggetti da cucina, spremiagrumi e mestoli. Le donne disegnano radiatori, disegnano lavandini, lampade tecniche, sedie pieghevoli, locomotive. Non esistono designer uomini e designer donne, ma designer bravi e designer meno bravi, più o meno in grado di creare non in modo astratto, ma tenendo conto delle rigide regole dettate dalla produzione industriale. Creando non ci si sente donna o uomo ma, immagino, progettista. Connotare le forme soffici e tondeggianti come tipicamente femminili e fare distinzione fra l’attitudine progettuale dell’uomo e quella della donna è un atteggiamento antico e stantio, un luogo comune banale, un’idea superata. La ghettizzazione della donna con la matita in mano costretta a occuparsi soltanto di brocche e scolapasta o di food design è al tramonto. «Faccio parte della giuria dell’Anfia che ogni due anni premia i giovani carrozzieri di maggior talento, e nella rosa dei cinque finalisti del concorso, l’ultima edizione, c’erano due donne», racconta con orgoglio Luisa Bocchietto. Il suo sogno, dice, è che il visitatore della mostra di Torino non si accorga che gli oggetti esposti sono progettati da donne, ma li possa valutare soltanto per la loro qualità, accorgendosi magari soltanto alla fine del percorso che hanno tutti firme femminili. Allora perché organizzare un’esposizione di designer donne? «Ad animarci non è stato uno spirito femminista o rivendicativo, ma semplicemente il desiderio di valorizzare il lavoro di tante donne, e di dar loro maggiore visibilità, di mettere in risalto la loro professionalità. Di fare un omaggio alla passione che mettono nel loro lavoro. Non in quanto donne, ma in quanto designer. Credo che ognuna di noi vada valutata e considerata come un individuo, in base al merito, all’intelligenza, alla creatività». L ‘‘ Søren Kierkegaard La donna ha soprattutto un altro talento innato, un dono originario: un assoluto virtuosismo per dar senso al finito Da AUT-AUT (1843) 12 11 8 10 9 Repubblica Nazionale 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 2 MARZO 2008 l’incontro Tanto teatro, un film in lavorazione, due regie d’opera lirica in progetto, un nuovo disco in uscita dove si leva lo sfizio di cantare brani di Paoli, Battisti, perfino Vasco. La “seconda giovinezza” di questo artista arrivato alla soglia dei 57 anni è frenetica. Trasuda forza e allegria ma sotto si avverte il demone della continua insoddisfazione “Sono fatto così - dice - sono curioso, voglio sempre andare a vedere cosa c’è un passo più avanti” Perfezionisti Massimo Ranieri ove andare a cercare Massimo Ranieri? Ma in teatro, è ovvio. Dove altrimenti? Una casa ce l’ha, com’è naturale, una di quelle vere, con mura, balconi e stanze da letto, ma il vero Ranieri è proprio lì, tra le assi del palcoscenico dove vive una parte più che rilevante della sua vita, sempre in giro, zingaro d’elezione, come i saltimbanchi, come gli attori girovaghi che piantavano la tenda in un angolo di strada e mettevano in scena la loro recita. «Nel nostro caso dovremmo dire emigranti, sapete, noi napoletani siamo sempre emigranti. Basta poco, basta venire a Roma, ma basta anche cambiare quartiere e già ci sentiamo emigranti». La sua casa è il teatro, la sua passione è il teatro, la sua massima aspirazione è il momento perfetto in cui celebrare quella magnifica ossessione del rapporto col pubblico. Ora è a Napoli, per girare un film di Maurizio Scaparro, tratto da un antico copione di Roberto Rossellini, la storia di un attore che portò Pulcinella a Parigi, alla fine del Seicento, la vera vicenda di Michelangelo Fracanzani, uno dei celebri Pulcinella della storia, ma trasportata ai nostri giorni in uno sdoppiamento e sovrapposizione tra la rappresentazione teatrale e il mondo contemporaneo che irrompe coi suoi conflitti. Il camerino del San Carlo lo accoglie come un figlio prediletto, gli posa addosso l’aura nobile della recitazione, la grandezza dei foyer e il velluto delle sedie ricordano anni e anni di depositi di antica arte teatrale. Ranieri è vestito da Pulcinella, momentaneamente senza maschera, che è lì sul tavolino, a un me- l’immersione totale e incondizionata nelle tante possibilità del suo lavoro, come se fosse una seconda giovinezza, anche se parliamo di un uomo di appena cinquantasei anni, nato a Napoli come Giovanni Calone il 3 maggio del 1951. Forse sarebbe meglio parlare di maturità, ma priva di quella sedentaria consapevolezza, della pigra soddisfazione che talvolta prende quelli che arrivano in cima. Meglio parlare piuttosto di uno stato di grazia. «Credo che in gran parte lo si deve alla mia donna, giovane, bella, una donna che mi fa sentire amato come non mi sono mai sentito prima. Chi mi conosce da molto tempo, sa delle mie angosce, delle mie disperazioni, ora è tutto diverso e questa è già una cosa molto importante. Poi sono in quell’età in cui si vive la piena maturità di artista e di uomo, e questa è una conferma di una cosa che ho imparato col tempo. Il pubblico vuole sentirsi garantito. I cantanti che hanno più successo ai concerti sono quelli che hanno Io ringrazio sempre ’o pateterno: faccio un lavoro che mi piace, non ho padroni, non mi devo alzare alle cinque come faceva mio padre... e mi pagano pure FOTO OLYCOM D NAPOLI tro dalla sua faccia, ma se ne percepisce l’attrazione, il terribile, amoroso, conflittuale abbraccio tra il volto e il suo doppio scenico. Ranieri si rilassa, inzuppa pane in una tazza di latte, universale panacea per molti napoletani, si riposa tra un ciac e l’altro. Un film, il teatro sempre incombente, i dischi, un’attività vulcanica, incessante, già programmata per mesi con incastri perversi. Ma non sarà troppo? «Ma no», scandisce con flemma, con un sorriso a mezza bocca, «non è mai troppo, in fondo prima di tutto è un piacere, è il mio mestiere, la mia vita, se no questi ritmi sarebbero impossibili da tenere, ma c’è un’altra cosa. Io ringrazio sempre ‘o pateterno, faccio un lavoro che mi piace, non ho padroni, non mi devo alzare alle cinque di mattina come faceva mio padre, non devo rendere conto a nessuno, per fortuna me lo fanno fare, e poi... mi pagano pure. Che posso volere di più?». Ora ride, sornione, il cerchio è chiuso, non c’è stress che tenga di fronte a questo sogno a occhi aperti, confortato da un successo di pubblico di proporzioni imbarazzanti, repliche su repliche, esauriti ovunque, gente che torna a vederlo due o tre volte di seguito. Ora c’è il film, ma sta già pensando al nuovo spettacolo che deve allestire, a due regie d’opera lirica, e al disco in uscita, che però ha inciso molti mesi fa temendo, a ragione, di non avere tempo in seguito. I dischi sono stati uno dei punti di forza della sua rinascita, da quando si è trovato con Mauro Pagani a rileggere la storia della canzone napoletana, la sua carriera di cantante ha preso una nuova entusiasmante piega. E ora? «Può sembrare sorprendente ma erano quarant’anni di carriera e in questo disco mi sono voluto togliere molti sfizi, canzoni che mi sono sempre piaciute, anche se sulla carta non sono adatte a me, tipo Vita spericolata. Uno dice, e che c’entra con te? Eppure c’entra, e l’ho voluta cantare. Ho cantato Paoli, Aznavour e perfino Battisti, ma sì, Prendi fra le mani la testa. C’è un motivo: ero al Cantagiro con lui quando la eseguiva. Allora pensavo: quanto mi piacerebbe cantarla. Ho aspettato quarant’anni ma ce l’ho fatta. E poi c’è O sole mio, altra canzone napoletana, come dire, intoccabile. Però mi sono ricordato di come è nata. L’autore si trovava a Odessa, davanti a una landa desolata, ‘nu fridd’e pazz, e in quel momento gli è venuta in mente Napoli. Questo è il vero significato di O sole mio, e allora l’abbiamo realizzata in una versione sobria, asciutta, ricordando quella visione ghiacciata nel contrasto con il calore di Napoli. Ho un solo grande rimpianto, volevo fare Zazà con Gabriella Ferri, dissi a Mauro chiamiamola, ma tre giorni dopo è morta». C’è qualcosa nel suo modo di parlare che riflette una speciale ebbrezza, un appagamento interiore forse mai conosciuto prima, la pienezza dei sensi, superato la quarantina, anche in altri campi. Perfino nel rock, vedi Vasco e Ligabue. Perché danno garanzie, perché hanno storie importanti da raccontare. E il pubblico ama associare la sua storia a quella di un artista». Una strana maturità la sua. Il volto è divertente, la simpatia è quella di un monello, cresciuto ma mai del tutto addomesticato, eppure le pieghe del viso stanno scavando un’espressione che a tratti ricorda quella di Eduardo. Trasuda forza, allegria, ma sotto sotto si avverte il demone della continua insoddisfazione. La voglia di andare sempre avanti, di vivere come se non ci si dovesse mai fermare a raccogliere, piuttosto salire, scalare, conquistare una vetta sempre più alta. «È il frutto di un lavoro continuo, massacrante, di dedizione. Io non è che ce l’ho da quest’anno il successo, con Canto perché non so nuotare, l’ho accumulato in anni, giorno dopo giorno, cercando di fare sempre almeno un passo più in là nella qualità degli spettacoli, senza mai sedersi e compiacersi. Non voglio dire da uno a dieci quanto valgono i miei spettacoli, non sta a me dirlo, ma se all’inizio valevano almeno uno, oggi valgono sicuramente di più, e il pubblico lo percepisce, ti segue, si sente garantito, sa che non butterà i suoi soldi. E questo, strano a dirsi, invece di tranquillizzarmi mi mette ancora più ansia, più senso di responsabilità». Ma come si fa a riflettere, a capire dove si sta andando quando si corre ad alta velocità tra uno spettacolo, un film, una regia e un disco? «Sono fatto così, mentre sto facendo un lavoro, c’è qualcosa, magari una frase, un episodio, un pensiero che mi dà lo spunto per qualcosa che magari farò tra due anni, quindi elaboro, costruisco quello che farò, non è normale, lo so, ma sono fatto così, è il mio modo di riflettere, le cose, anche se sono sempre preso, hanno una gestazione lunga, maturano nel tempo. Il rischio è la maniacalità, elaboro sempre inconsciamente. Sono sempre curioso, voglio sempre vedere cosa c’è un passo più avanti». Allo steso tempo, se pure guarda sempre avanti, Ranieri rivela qualcosa di antico, le tracce di un’etica del lavoro, forse oggi in estinzione, un’etica che lo spinge a pensare prima di tutto all’arte e poi al conto in banca. E quando parla di questo il volto diventa serio, rigoroso, come se stesse trasmettendo una lezione che viene da lontano: «Il mio conto in banca non crescerà mai, perché tutto quello che guadagno lo reinvesto. Quando faccio uno spettacolo faccio in modo che non ci sia mai una calza smagliata di una ballerina, mai, che non ci sia un granello di polvere sul palcoscenico, mai. Ma questi sono insegnamenti che si ricevono. Io ho avuto il privilegio di avere grandi maestri, che purtroppo non ci sono più, e i giovani non possono avere questa stessa fortuna. Maestri come Scaparro, Strehler, Patroni Griffi, Romolo Valli, maestri che mi hanno spaccato in mille pezzi, ma mi hanno dato prima di tutto un’educazione civile e poi quella del palcoscenico: guardare fino all’angolo più piccolo del teatro e prenderne possesso, pienamente. Sono stato molto fortunato». In tutto questo tempo la maschera di Pulcinella è lì, sembra ascoltare con strafottente e irridente distacco. E non è una maschera qualsiasi. È la maschera di Ranieri, fatta su misura, come si usa, costruita da un grande artigiano, Santelli, tutta in cuoio, è solo sua, da quattordici anni, e solo lui può portarla, come una piacevole condanna, la croce e delizia di un personaggio che ha portato in scena innumerevoli volte e che si insinua con forza spiritata, con diabolica indipendenza nella persona che la porta. «Me ne sono impossessato, ce l’ho sempre a casa». Alla fine gli chiediamo di indossarla. Per favore, Ranieri, la può indossare? Dobbiamo fare una domanda proprio a lei. «A chi, alla maschera?» Sì, proprio alla maschera: che ne pensa Pulcinella di Massimo Ranieri? L’attore la indossa, perplesso, la maschera si sovrappone perfettamente al volto, crea una strana simbiosi, lo sguardo diventa un altro, anche la bocca si deforma, guizza subito in uno sberleffo: «Ranieri?», dice la maschera, «ha cercato di dominarmi, ma non c’è riuscito. Io sono uno spirito libero, senza catene, non ho serragli, nessuno può prendermi del tutto». Ce ne andiamo dal San Carlo con un dubbio: chi era veramente a parlare? Massimo Ranieri o la sua terribile maschera? Pulcinella di sicuro lo sa, ha la coscienza della storia, ne ha viste tante, ha sofferto, riso, beffato, si è umiliato, ha amato, ha vinto, proprio come l’attore che lo impersona. REPUBBLICA.IT Oggi su Repubblica.it lo speciale interattivo con l'intervista di Gino Castaldo a Massimo Ranieri (a cura di Anna Zippel) ‘‘ GINO CASTALDO Repubblica Nazionale
Scarica