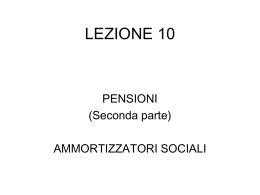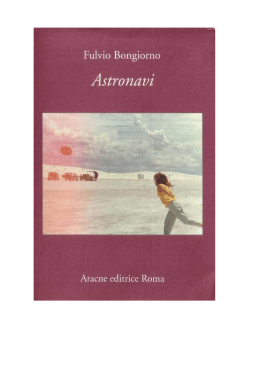EDITORIALE Scuola: uno sguardo da lontano Giuseppe Bertagna D icono, giustamente, che le vere élite di un paese dovrebbero essere capaci di vision riformatrici. Chiamando poi tutti a riconoscerle e, soprattutto, a condividerle, quasi per generazione spontanea tanto parlerebbero da sole e sarebbero automotivanti. La circostanza è vera, naturalmente, anche per la scuola o, meglio, per le riforme che il «sistema educativo di istruzione e formazione» del Paese è chiamato a promuovere per aggiornarsi alle sfide dei tempi e, se possibile, anticipare le esigenze della società che viene. A questo proposito, è ormai chiaro da almeno due decenni che nessuna vision riformatrice della scuola può essere elaborata a prescindere dalla lungimirante presa d’atto di alcuni dati conclamati. Anzitutto, la globalizzazione. Non si tratta soltanto di un fenomeno economico-finanziario, ma anche e non meno di natura demografica e culturale. Nessun Paese al mondo le si può sottrarre. In secondo luogo, la cosiddetta, abusata «società della conoscenza» che ne dovrebbe conseguire. Per noi, e per l’Europa, dovrebbe essere un must, visto che lo ripetiamo quasi compulsivamente in ogni dove da Lisbona in avanti. L’epoca delle «conoscenze frammentate», delle discipline iperspecialistiche, compartimentalizzate, separate in orari, epistemologia e docenti va archiviata. Serve sempre di più una conoscenza in grado di confrontarsi con il senso globale delle specializzazioni disciplinari e di produrre un pensiero ecologizzante ed ologrammatico che, per dirla alla Morin, situi «ogni evento, informazione o conoscenza in una relazione di inseparabilità con il suo ambiente culturale, sociale, economico, politico e, beninteso, naturale». In terzo luogo, la sempre più capillare diffusione e moltiplicazione delle nuove tecnologie Nuova Secondaria - n. 2 2015 - Anno XXXIII della comunicazione, dell’informazione e della produzione, ormai diventate, pur nella loro artificialità, quasi l’«ambiente più naturale» di ogni vita umana, in particolare delle ultime generazioni. Infine, anche per non subire in maniera disordinata i precedenti fenomeni, la necessità di un cambio epocale di paradigma delle politiche sociali sull’educazione: non si tratta più di accontentarsi, com’era possibile un tempo, della formazione eccellente di qualcuno o comunque di pochi; occorrono, al contrario, percorsi di insegnamento e di apprendimento che riescano a valorizzare e a promuovere nello stesso tempo l’eccellenza di tutti, nessuno escluso, e di ciascuno. Il compito di una vera élite del Paese, sarebbe, dunque, in questo contesto, nient’altro che quello di negare la propria autoriproduzione inerziale e corporativa, trovando le modalità efficaci ed opportune per universalizzare le proprie prerogative qualitative. Proviamo adesso a dare uno sguardo alle politiche dell’istruzione e formazione degli ultimi vent’anni. E, soprattutto, a procedere ad una comparazione con la situazione istituzionale, ordinamentale, organizzativa, culturale e politicosociale dell’inizio Novecento. Molta manutenzione, moltissimi cambiamenti anche non esornativi, senza dubbio. Non vanno sottovalutati. Sul piano strutturale, nei suoi nodi paradigmatici, tuttavia, la situazione, nonostante tutto, non pare essere cambiata di verso. Giovanni Gentile, nel 1923, aveva, come è noto, impostato la sua riforma della scuola su un principio: selezionare i «migliori»; partire in 100 studenti alle scuole popolari dei futuri subordinati, arrivare in 4 alla laurea per la classe dirigente. L’impianto istituzionale, ordinamentale, organizzativo, culturale e pure politico-sociale era coerente al proposito. E aveva anche una sua riconosciuta affidabilità qualitativa. Il paradosso è 3 EDITORIALE che la progressiva democratizzazione della scuola, in Italia, ha significato sforzarsi di aprire sempre più a tutti un impianto pensato a fini opposti. Con gli effetti incomprimibili e perversi che conosciamo: renderlo non più coerente e tantomeno affidabile non solo al proposito per cui era stato pensato, ma anche a quello, sebbene astrattamente volenteroso, di natura contraria. Sempre Gentile, con l’avocazione dell’istruzione tecnica (ragionieri e geometri) non solo governata ma, soprattutto e in particolare, anche gestita dal Ministero della Pubblica Istruzione e dallo Stato invece che da enti locali, imprese e privati come ancora capitava, allora, per i rimanenti rami dell’istruzione tecnica, avviò un processo che il Fascismo avrebbe poi completato: statalizzare tutta l’istruzione tecnica, secondaria e superiore e centralizzarla sotto la responsabilità del Ministero. Per la verità, nemmeno il Fascismo pensò mai di statalizzare e centralizzare governo e gestione dell’istruzione e formazione professionale. Era, in effetti, un’antinomia. Ci pensò, invece, la Repubblica a «nobilitare» l’istruzione professionale rendendola interamente «ministeriale» e a lasciare la formazione professionale, ormai residuale, nelle responsabilità dei territori e della dinamica socioprofessionale del mercato del lavoro. Nemmeno la “Buona scuola” di Renzi tocca, al fondo, questa impostazione. Anzi, senza più alcuna reticenza, con la riforma costituzionale in discussione al Senato, ritratta perfino quel poco di novità sul tema che, grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione varata dal centro sinistra nel 2001 e all’attuazione di questo nuovo dettato legislativo, disposta dalla riforma Moratti (20032005), era stato possibile introdurre ad inizio del XXI secolo. Il sistema educativo di istruzione statale non è più, infatti, programmaticamente, di pari dignità educativa, culturale e sociale con quello regionale di istruzione e formazione professionale. Solo lo Stato può salvare dal dio gnostico minore che ha introdotto il «male nel mondo». Che da noi, poi, significa: solo l’amministrazione centralizzata del Miur può salvare, con il suo taumaturgico e divinatorio potere battesimale. Tutto, dagli ordinamenti ai concorsi, dagli organici alle carriere, dai piani di studio ai profili professionali, dal reclutamento ai 4 trasferimenti, dalla formazione iniziale a quella in servizio, deve, perciò, passare dall’imbuto romano che, ovviamente, in barba ad ogni tanto proclamato quanto svuotato omaggio ai principi costituzionali della sussidiarietà e dell’autonomia, sa meglio di ogni Regione, di ogni parte sociale (imprese e sindacati di territorio), di ogni «autonoma» istituzione scolastica e formativa, di ogni famiglia, di ogni docente e di ogni ragazzo che cosa serva a loro e sia davvero bene per loro, ieri, oggi e domani. Ma non finisce qui. Rispetto a cento anni fa, il sistema scolastico continua senza imbarazzi ad ordinare (nel senso di disciplinare) le sue «reclute» per «leva obbligatoria», secondo la bicentenaria innovazione franco-napoleonica. Il concetto di «leva o classe d’età», quindi, si rifrange, per sineddoche, nell’ordinamento didattico e amministrativo delle varie «classi I, II…», e questo dai 2 anni e mezzo di vita («classi primavera») fino all’età dell’università. Ogni «classe», inoltre, continua a lavorare come le api negli alveari: ciascuna nella propria «celletta», senza aggregazioni sistematiche e quotidiane che le superino, le rompano e semmai le ricompongano per livelli differenti di apprendimento, per compiti da svolgere, progetti da elaborare, prodotti da realizzare o per libere attività elettive. All’interno di ogni celletta dell’alveare, si registra poi una specie di moltiplicazione del paradigma separatorio, non solo a livello di lavoro dei docenti e di organizzazione delle discipline e delle ore di insegnamento, ma anche a livello della stessa concezione degli apprendimenti per cui, da un lato, il cognitivo sembra separabile dall’affettivo, dal manuale, dal relazionale, dall’espressivo, dall’etico e dal religioso e, dall’altro lato, per usare Bateson, protoapprendimento, deuteroapprendimento e apprendimento di terzo livello non costituiscono mai un’unità organica e integrata, ma solo vettori successivi sul piano non solo logico, ma anche cronologico. Non stupisce, di conseguenza, che, nel sistema scolastico italiano, si continui a sentir dominante, perfino oggi, più una lingua con un registro militare che pedagogico («decreti e circolari», «comandi», «disciplina», «condotta», «voti», «trasferimenti», «ambiti territoriali», Nuova Secondaria - n. 2 2015 - Anno XXXIII EDITORIALE «assegnazioni provvisorie», «punizioni», «premi», «commissioni di disciplina», «punteggi», «graduatorie», «scala gerarchica», «concorsi», «gradi», «passaggi di grado», «permessi», «congedi», «solve et repete», «turni di vigilanza», «registri di classe» ecc.). Possibile che, sul piano strutturale, dunque, quasi cento anni siano passati nel sistema scuola senza provocare o rivendicare nette discontinuità? Possibile che, con i cambiamenti di contesto nel frattempo intervenuti, così peraltro accelerati negli ultimi vent’anni, nella scuola, si sia sempre in presenza di tendenze di così lunga durata da far coincidere ogni passo avanti con un nostalgico, ancorché riverniciato, ritorno all’indietro? Certo, troppi storici della scuola non aiutano a maturare uno sguardo «da lontano». Contagiati essi stessi, quelli di questo tipo, dalla logica che dovrebbero contribuire a superare, hanno inventato, quasi unici in Europa, una storia tutta Nuova Secondaria - n. 2 2015 - Anno XXXIII interna al sistema scolastico stesso. Siamo così fin troppo ricchi di storie della scuola condotte sulle leggi relative alla scuola, sui programmi ministeriali di insegnamento e sui loro effetti, sui ministri, sui decreti perfino sulle commissioni di studio del Miur. L’esterno contestuale, più o meno epocale, è semmai costituito dalla recensione di qualche documento di associazioni e partiti militanti che commentano a favore o contro queste dimensioni interne al sistema scuola. Peccato, perché aveva ragione il compianto Emanuele Samek Lodovici a sostenere che «solo la storia esemplare è importante e lo è perché il suo ricordo salva». Ma «storia esemplare», appunto. Anche della scuola e dei suoi impianti strutturali. Viceversa, non può che contribuire a dannare. Il che vuol dire, nella migliore delle ipotesi, a cambiare «padrone», ma non condizione. Giuseppe Bertagna 5
Scaricare