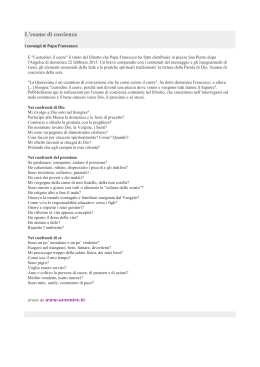Domenica il fatto Atletica, ai confini dei corpi da record La di DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 EMANUELA AUDISIO e MARINO NIOLA il reportage Repubblica Il ritorno delle fabbriche degli orrori FEDERICO RAMPINI L’ultimo morto Torri delle 11 settembre, sei anni dopo ILLUSTRAZIONE DI GIPI l’America vuole voltar pagina Ma la cronaca quotidiana e le parole di un grande scrittore la tengono ancorata a Ground Zero MARIO CALABRESI D la memoria DON DELILLO NEW YORK iane Kettenacker aveva aspettato per tutto il mese di settembre notizie di suo marito Edward Ryan, poi all’inizio di ottobre aveva rotto gli indugi, non si poteva più attendere, anche i suoi quattro figli avevano il diritto di piangere il padre, di sentirlo ricordare, di fare i conti con la sua morte. Non che si fosse mai fatta illusioni, Edward lavorava al novantaduesimo piano della Torre Nord del World Trade Center, la prima ad essere colpita, e nessuno dei suoi sessantotto colleghi alla Carr Futures era tornato a casa l’11 settembre. Il volo numero 11 dell’American Airlines, un Boeing 767 partito dall’aeroporto Logan di Boston con destinazione Los Angeles e dirottato da Mohammed Atta, si era infilato poco sopra la testa di Edward, tra il novantaquattresimo e il novantottesimo piano. Poteva essere morto subito, nell’incendio che il carburante scendendo lungo la struttura aveva propagato fino al quartier generale della Carr, o molto più probabilmente era stato soffocato dal fumo dopo essere rimasto intrappolato dal crollo delle strutture interne. Ma, se anche fosse riuscito a sopravvivere all’impatto, era certamente rimasto intrappolato sulle scale. (segue nelle pagine successive) Manzi, maestro a suon di pugni N on era più una strada ma un mondo, un tempo e uno spazio di cenere in caduta e semioscurità. Camminava verso nord tra calcinacci e fango e c’erano persone che gli correvano accanto tenendosi asciugamani sul viso o giacche sulla testa. Avevano fazzoletti premuti sulle bocche. Avevano scarpe in mano, una donna gli corse accanto, una scarpa per mano. Correvano e cadevano, alcuni, confusi e sgraziati, tra i detriti che scendevano tutt’intorno, e qualcuno cercava rifugio sotto le automobili. Nell’aria c’era ancora il boato, il tuono ritorto del crollo. Il mondo era questo, adesso. Fumo e cenere rotolavano per le strade e svoltavano angoli, esplodevano dagli angoli, sismiche ondate di fumo cariche di fogli di carta per ufficio in formati standard dai bordi taglienti, che planavano guizzando in avanti, oggetti soprannaturali nel sudario del mattino. Lui indossava giacca e pantaloni e portava una valigetta. Aveva vetri tra i capelli e sul viso, capsule marmorizzate di sangue e luce. Superò un cartello “Breakfast Special” e altri gli sfrecciarono accanto, una corsa di vigili urbani e guardie private, con le mani premute sui calci delle pistole per tenerle ferme. ALBERTO MANZI, MASSIMO MANZI e MICHELE SMARGIASSI la società Riecco i precetti di Donna Letizia LAURA LAURENZI e COLETTE ROSSELLI cultura Le parole ribelli della nuova America VITTORIO ZUCCONI spettacoli Tutte le strade del cinema erotico CONCITA DE GREGORIO e AMBRA SOMASCHINI (segue nelle pagine successive) Repubblica Nazionale 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 la copertina New York è sempre più restia a ricordare l’attentato, ma la piaga di Ground Zero è ancora aperta. Lo dimostra 11 settembre il caso di Edward Ryan, dissolto nel crollo e ritrovato, in forma di qualche frammento d’ossa, solo un mese fa ILLUSTRAZIONI DI GIPI Questa è la sua storia e la storia dell’incubo vissuto dalla moglie Diane e dai suoi quattro figli Sei anni, aspettando Eddie L’ MARIO CALABRESI (segue dalla copertina) unica certezza che aveva è che il corpo del marito non c’era, non era tra quelli di coloro che si erano lanciati nel vuoto in preda alla disperazione e nemmeno tra i cadaveri recuperati nelle prime tre settimane di scavo tra le macerie. Aveva atteso una notizia, aspettato che le telefonassero, poi aveva capito che era inutile attendere ancora e si era decisa a chiamare il sacerdote che da quasi undici anni incontravano ogni domenica. Così il 6 ottobre del 2001, alle dieci e tre quarti del mattino, nella piccola chiesa cattolica dell’Immacolato cuore di Maria a Scarsdale, quarantadue minuti di treno a nord di Manhattan, aveva fatto celebrare una messa in suffragio. Un funerale senza una bara, senza niente da poter seppellire. Al posto dei fiori aveva chiesto opere di bene e non aveva avuto nessun segna tutte le formule di rito, «un grande imbarazzo a dare il suo numero di conto figlio, un grande padre, un grande maricorrente e a spiegare che i soldi sarebbeto, un grande lavoratore, un grande amiro serviti per far studiare Edward jr, Meco», disse la frase su cui tutti si trovarono gan, Joseph e Kelly. d’accordo: «Era un grande cuoco». Così La chiesa era pienissima e il primo a Eddie, il vicepresidente della Carr Futuprendere la parola alla fine della funzione res, lo studente che aveva preso una lauera stato William, il padre di Edward: «La rea e un master, il sua reputazione di broker che si era uomo gentile e corconquistato un uffiretto era leggendacio con vista su tutta ria. Diciamo la veI DISEGNI la Baia di New York, rità, era il più simpaIl disegno di queste pagine dalla Statua della Litico di tutti». Per ine quello di copertina sono di Gipi, bertà all’Atlantico, cantesimo si ruppe le cui opere sono esposte da ieri fino laggiù dopo il ponte ogni formalismo e al 7 ottobre alla Galleria comunale di Verrazzano, lagli amici, a turno, cod'arte contemporanea sciò questo mondo minciarono a ricordi Monfalcone (Gorizia) con la fama di re dei dare le battute di pefornelli. Ma non sca sulla costa del trovò un posto al ciNew Jersey, la birra, i mitero, perché Diane e i suoi figli non ebsigari, le partite della piccola lega di basebero nulla da poter mettere nella terra, un ball di Eastchester, in cui giocava Eddie jr, luogo dove andare a trovarlo, portare i a cui non era mai mancato. Poi Tommy fiori, raccontare segreti ad alta voce, un Taylor, compagno di scuola e di giochi fin posto dove piangere. dall’infanzia, raccontò l’amore di Eddie Sette mesi dopo attraversarono il canper la cucina e dopo aver passato in ras- cello in ferro battuto dello Scarsdale Memorial Garden, un piccolo giardino, poco meno di un ettaro, situato tra la piscina comunale e il campo d’atletica. Lì, il 5 maggio del 2002, all’ombra di un boschetto di aceri e querce piantato da un gruppo di reduci alla fine della Seconda guerra mondiale, venne inaugurato un monumento in memoria delle vittime che vivevano nell’area di Westchester. C’erano i boy scout e la banda, e lì sarebbero tornati ogni anno la sera dell’11 settembre, per una veglia a lume di candela dopo il tramonto. Poi il nome di Edward venne inciso sulla stele posta alla base della diga di Kensico, dove il Bronx river viene intrappolato e diventa acqua potabile per tutta la città di New York. Nacquero borse di studio in memoria di Edward, la prima nel 2003 la organizzò Eugene Desoiza, presidente delle “Aquile di Eastchester”, lo sport club dove portava tutta la famiglia, poi gli venne perfino intitolato un torneo di golf. Da Ground Zero però nessuna notizia. I lavori di rimozione della macerie finiro- Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 Cadevano uomini e torri il mondo era anche questo DON DELILLO (segue dalla copertina) entro, dove avrebbe dovuto trovarsi, le cose erano distanti e immobili. Stava accadendo ovunque intorno a lui, un’automobile mezzo sepolta dai detriti, finestrini sfondati e rumori che fuoriuscivano, voci radiofoniche che sfioravano i calcinacci. Vide persone che correndo spargevano acqua, abiti e corpi infradiciati dai getti dei sistemi antincendio. C’erano scarpe abbandonate per strada, borsette e computer portatili, un uomo seduto sul marciapiede che tossiva sangue. Bicchieri di carta avanzavano rimbalzando in modi strani. Il mondo era anche questo, sagome dentro finestre a trecento metri d’altezza, che cadevano nel vuoto, e tanfo di combustibile in fiamme, e lo squarcio costante delle sirene nell’aria. Il rumore si posava ovunque fuggissero, strati di suono che si raccoglievano intorno a loro, e lui se ne allontanava e vi entrava al tempo stesso. Poi ci fu un’altra cosa, fuori da tutto questo, qualcosa che non c’entrava, su nel cielo. La osservò discendere. Dall’alto del fumo sbucò una camicia, una camicia che risalì e fluttuò nella poca luce, per poi di nuovo cadere, giù verso il fiume. Correvano e si fermavano, alcuni di loro, continuando a ondeggiare, cercando di strappare fiato all’aria bollente, e poi le grida convulse di incredulità, e le bestemmie e le urla perdute, e le carte che si ammassavano nell’aria, contratti, curricula che volavano, frammenti intatti di affari, veloci nel vento. Continuò a camminare. Di quelli che correvano, alcuni si erano fermati, altri imboccavano vie laterali. C’era chi camminava all’indietro, lo sguardo fisso al centro di tutto, alle tante vite che laggiù si dibattevano, e le cose continuavano a cadere, oggetti bruciati che si trascinavano dietro scie di fuoco. Vide due donne singhiozzare nella loro marcia al contrario, guardando al di là di lui, entrambe in calzoncini sportivi, le facce appese. Vide membri del gruppo di tai chi del vicino parco, in piedi, con le mani tese grosso modo all’altezza del petto e i gomiti piegati, come se tutto questo, loro stessi inclusi, potesse essere collocato in uno stato di sospensione. Qualcuno uscì da una tavola calda e cercò di porgergli una bottiglia d’acqua. Era una donna che indossava una mascherina antipolvere e un cappellino con la visiera e ritrasse la bottiglia e svitò il tappo e quindi gliela tese di nuovo. Lui posò la valigetta per prenderla, a malapena conscio che non stava usando il braccio sinistro, che aveva dovuto posare la valigetta prima di poter prendere la bottiglia. Tre furgoni della polizia svoltarono e si precipitarono verso downtown, a sirene spiegate. Chiuse gli occhi e bevve, e sentì l’acqua scorrergli nel corpo trascinando giù con sé polvere e fuliggine. La donna lo stava fissando. Gli disse qualcosa che lui non sentì, quindi le restituì la bottiglia e raccolse la valigetta. Il lungo sorso d’acqua gli lasciò un retrogusto di sangue. Riprese a camminare. Un carrello del supermercato giaceva immobile e vuoto. Dietro c’era una donna, rivolta verso di lui, con del nastro della polizia avvolto intorno alla testa e al viso, di quel nastro giallo con la scritta CAUTION che delimita la scena di un delitto. I suoi occhi erano piccole increspature bianche nella maschera sgargiante, e lei stringeva la maniglia del carrello e se ne stava lì, a guardare dentro il fumo. Fece in tempo a udire il suono del secondo crollo. Attraversò Canal Street e cominciò a vedere le cose, per qualche motivo, in modo diverso. Non parevano pregnanti come al solito, le strade lastricate, i fabbricati in ghisa. C’era una qualche mancanza cruciale nelle cose intorno a lui. Erano incompiute, per così dire. Erano inosservate, per così dire. Forse era quello l’aspetto che avevano le cose quando non c’era nessuno che le vedesse. Udì il suono del secondo crollo, o lo avvertì nel tremore dell’aria, la torre nord che cadeva, uno sconcerto sommesso di voci in lontananza. La torre nord che crollava era lui. Il cielo era più leggero, lì, e riusciva a respirare più facilmente. C’erano altri dietro di lui, migliaia, che andavano riempiendo la media distanza, una massa prossima a formarsi, gente che fuoriusciva dal fumo. Proseguì finché non dovette fermarsi. Lo investì rapida, la consapevolezza di non poter andare oltre. Provò a dirsi che era vivo, ma era un’idea troppo oscura per riuscire a prendere corpo. Non c’erano taxi e il traffico in genere scarseggiava e allora apparve un vecchio furgoncino, una ditta elettrica di Long Island City, e gli si accostò e il conducente si sporse verso il finestrino dal lato del passeggero a esaminare ciò che stava vedendo, un uomo incrostato di cenere, di materia polverizzata, e gli chiese dove voleva andare. Fu solo una volta salito in macchina e chiusa la portiera che capì dov’era diretto fin dall’inizio. D © Don DeLillo 2007 no, venne costruito il memorial e cominciarono i piani per stabilizzare il terreno e costruire le fondamenta della nuova Torre della Libertà che sarà alta 1776 piedi (541 metri), in onore dell’anno della dichiarazione d’indipendenza americana, e verrà inaugurata nel 2011. Ma del corpo di Edward nessuna traccia. Finché il capo dei medici legali parlò chiaro: ormai le possibilità scientifiche di identificare nuovi resti sono bassissime, con le attuali tecnologie tutto il possibile è stato fatto. Le famiglie di più di millecento scomparsi nell’attentato alle Torri Gemelle si convinsero che non avrebbero mai avuto una certezza né la possibilità di seppellire qualcosa. Poi, l’anno scorso, a sorpresa, ricevettero una lettera del capo dei medici legali, che parlava di una nuova tecnica di esame del dna, del Bode Technology Group, un laboratorio capace di estrarre informazioni da frammenti di ossa finora ritenuti inutilizzabili. «Non sappiamo quanto tempo ci metteremo, ma non smetteremo di provare», spiegarono. E si misero a lavorare al più grande progetto di idenpersone», come recitò il comunicato uffitificazione dei dna della storia: ripresero ciale. Erano frammenti di ossa di dimenventimila frammenti umani che erano sioni che andavano da uno ad otto centistati catalogati ma che non avevano trometri. Ma rappresentavano la scoperta vato un’appartenenza. Ricominciarono più consistente da molto tempo. La notigli esami incrociati con tutto il materiale zia rianimò speranze e riaccese dolori. genetico recuperato nei pettini e negli Finché, il 24 luglio di quest’anno, Diane spazzolini da denti ricevette la telefonaforniti dai parenti ta di Ellen Borakove, degli scomparsi alla portavoce del diretfine di settembre del tore dei medici legaIL LIBRO 2001. Riuscirono li della città di New Falling man (Scribner, 246 pagine, quasi subito ad York. Le comunica26 dollari), il romanzo di Don DeLillo identificare dodici va che avevano trodi cui pubblichiamo qui il primo identità. vato Eddie, o perlocapitolo, descrive l’America post meno quello che re11 settembre. In Italia sarà edito Ma nemmeno tra stava di Edward da Einaudi nel 2008 quelle c’era qualcoRyan. Era lui l’ultimo sa che appartenesse morto identificato a Edward. Fino aldelle Twin Towers. l’ottobre dell’anno Era la fine di un’incertezza, dei fantasmi, scorso quando, passando al setaccio la era la sicurezza che era morto intrappolaterra di una rampa d’accesso usata in queto nella Torre Nord. Ma i resti di suo maristi anni per scendere nel cratere di to erano talmente poca cosa che le sono Ground Zero e di una cabina elettrica non stati consegnati custoditi in una provetta. più funzionante della Con Edison, si scoprirono i resti di «potenziali trentacinque Lei è rimasta in silenzio, non ha voluto raccontare cosa prova, non ha voluto dire se lo avrebbe sepolto come hanno fatto altre famiglie. «È una cosa che provoca sentimenti contrastanti», ha detto per lei Eugene Desoiza, il presidente dello sport club, la persona che è stata più vicina ai ragazzi in questi sei anni. Ora c’è un punto fermo, una sicurezza, ma il dolore di vedere che di una persona è rimasto così poco è terribile. «Posso solo dirvi che in tutta la comunità sentiamo ancora la sua mancanza, che la sua perdita è ancora davvero dolorosa». Diane e i ragazzi martedì ascolteranno in televisione il nome del loro padre letto insieme a quello degli altri 2.749 morti degli attacchi terroristici a New York. Ma forse sarà l’ultima volta, perché i network non ne vogliono più sapere di trasmettere la cerimonia, sostengono che la città è stanca del lutto. A loro resterà la cerimonia al tramonto con le candele sotto le querce. William Ryan invece è morto ad aprile di quest’anno, senza fare in tempo a sapere che i resti di suo figlio Edward erano stati trovati. Repubblica Nazionale 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 il fatto Ai Mondiali d’atletica di Osaka nessun primato è caduto Miti dello sport C’entra naturalmente la lotta al doping, c’entrano la velocità nello sviluppo di metodi di allenamento e tecnologie dei materiali. Ma c’è anche da chiedersi se non sia stata raggiunta quella frontiera fisica e psicologica oltre la quale l’atleta non può più spingersi Ai confini dei corpi da record N EMANUELA AUDISIO OSAKA el ‘69 l’uomo andò sulla luna. Ma nel ‘68 lo sport anticipò l’orbita e andò su Marte. Si allacciò le cinture soprattutto l’atletica, sempre più marziana. Niente più limiti, né confini, solo alta velocità. Uno schiaffo agli dei. A Città del Messico era autunno, i record caddero come foglie. Una ventina in sette giorni, quattro solo nel triplo. Ai Giochi esordiva il tartan, la rabbia nera, la consapevolezza bianca. L’aria rarefatta fece il resto. Bob Beamon nel lungo prese l’unica pedana della sua vita e allunò a 8.90 metri, quasi fuori della buca. Ralph Boston, suo compagno, disse: «È un fenomeno, ma è completamente idiota». La notte prima Beamon aveva fatto sesso con una prostituta, solo al momento dell’orgasmo, scrisse lui, si ricordò che l’indomani aveva la gara olimpica. L’atletica mise i razzi, se ne fregò della gravità, e continuò a volare. Tut- CECOSLOVACCHIA JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ dell’83 in classifica mondiale era sesto con 80,94. Possibile questo balzo in avanti? 20 luglio, Hohn (Germania Est), 104,80 nel giavellotto. Per la prima volta si superano i 100 metri. Hohn era scomparso dalle scene agonistiche, non risultava nemmeno tra i primi trenta. Le donne non stavano a guardare: 27 maggio, Lissoskaia (Urss), 22,53 nel peso. L’anno prima era sesta, ma le sue masse muscolari sono molto cambiate. 3 giugno, la staffetta tedesca dell’est, 3’15’’92 nella 4x400. Brave e veloci, il colpo d’occhio su alcune loro trasformazioni però lascia dubbi. 5-6 giugno, Paetz (Germania Est), 68,67 nell’eptathlon. Gara in cui si afferma che l’autoemotrasfusione è «necessaria». 20 luglio, Andonova (Bulgaria), 2,07 nell’alto. Sara Simeoni commenta: «Si può migliorare di una decina di centimetri in un attimo?». 17 agosto, Meszynsk (Germania Est), 73,36 nel disco. Mai a quelle misure prima. 26 agosto, Kazankina (Urss), 8’22’’62 nei 3000. Un record migliorato di quattro secondi a trentatré anni. Una grandissima atleta, ma tutto regolare? 26 agosto, Silhava (Cecoslovacchia), 74,56 nel disco. Undice- to sembrava fantastico, il corpo umano si mise in viaggio, attraversò gli anni Ottanta e Novanta, senza mai una sosta. Aveva benzine naturali, ideologiche, chimiche. Tutto al meglio: la metodologia di allenamento, la disponibilità al sacrificio, l’aiuto della scienza. Il campione era un sacerdote, il record la sua religione. Pietro Paolo Mennea, ragazzo di Barletta, passava sul campo di Formia anche il giorno di Natale. Con la sua schiena piegata, le sue gambe storte, la sua corsa da schiavo che diventa padrone fermò per diciassette anni il cronometro a 19”72 sui 200 metri. Poco dopo a Las Vegas venne presentato a Muhammad Ali come uno che correva veloce. Ali lo squadrò sorpreso: «Ma tu sei bianco». Sì, gli rispose Pietro, però sono nero dentro. L’est rispose con lo stacanovismo, il partito andava servito, in pista come in miniera. La scuola russa conosceva la pedagogia, il resto dell’impero offrì i corpi. Nei laboratori di Lipsia si costruirono campioni e si generarono mostri. Era bello illudersi, tutto era magico, l’anno 1984 soprattutto: 4 luglio, Syedik (Urss) 86,34 nel martello. Alla fine DDR DDR sima a Mosca, sesta a Helsinki. Un exploit troppo inaspettato. Il 10 aprile ‘87 nella clinica di Magonza muore l’eptathleta Brigitte Drexel, l’autopsia le trova nel corpo tracce di centodue farmaci differenti. Il doping fa volare, ma anche ammalare. Diventa programma di allenamento: lavoro e steroidi. Il soprannome di Marita Koch, 47”60 sui 400 metri, è Compagna Milligrammi. E dal doping di stato si passa a quello del bricolage, del fai-da-te, degli specialisti delle droghe. Ogni primato ha la sua pillola: Apocalypse Now. Qualsiasi tempo e misura viene profanata. Ben Johnson è il napalm della velocità. Il diserbante delle piste. I cronometri impazziscono: 9”83 a Roma nell’87, 9”79 a Seul nell’88. Tra le donne Florence Joyner Griffith mostra la sua parte maschia: 21”34 sui 200. Roba da extra-terrestri, da corpi marziani. Che però paga con la morte ad appena trentanove anni. Ma la rotta dell’atletica non si ferma, scendere al volo non si può, contraffazione e violazione sono ormai compagni di viaggio, le acrobazie si trasfor- DDR URSS CORSA 800 METRI CORSA 400 METRI 4X100 FEMMINILE LANCIO DEL DISCO LANCIO DEL MARTELLO Registrato a Monaco il 26.07.1983 Registrato a Camberra 06.10.1985 Registrato a Camberra 06.10.1985 Registrato a Neubrandenburg 06.06.1986 Registrato a Stoccarda 30.08.1986 1:53.28 MARITA KOCH 47.60 MARLIES GOHER 41.37 JÜRGEN SCHULT 74.08 YURIY SEDYKH 86.74 LA CLASSIFICA DEI RECORD LONGEVI USA FLORENCE GRIFFITH-JOYNER URSS USA USA USA CORSA 200 METRI 4X400 FEMMINILE LANCIO DEL PESO SALTO IN LUNGO 400 OSTACOLI Registrato a Seul il 29.09.1988 Registrato a Seul il 01.10.1988 Registrato a Westwood (Ca) 20.05.1990 Registrato a Tokyo il 30.08.1991 Registrato a Barcellona il 06.08.1992 21.34 TATYANA LEDOVSKAYA 3:15.17 RANDY BARNES Gli erculei eroi che sfidarono le leggi di Zeus MARINO NIOLA 23.12 MIKE POWELL 8.95 importante è vincere, non partecipare. Con buona pace del barone de Coubertin. Ed è sempre stato così. Ai nobili ideali sportivi del creatore delle Olimpiadi moderne in realtà non credevano neanche atleti e pubblico di quelle antiche. Per i campioni di Olimpia infatti una vittoria valeva più dell’oro. Significava diventare ricchi e famosi. E soprattutto conquistarsi la fama di eroi. Essere adorati come semidei proprio perché capaci di imprese impossibili per i comuni mortali. Corridori, pugili, lottatori e altri recordmen dell’antichità venivano idolatrati dall’uomo della strada e celebrati da grandi poeti come Pindaro e Simonide che immortalavano quei mitici fuoriclasse nei loro epinici. Un genere poetico dedicato proprio ai trionfi sportivi, lo dice il nome stesso che deriva dalla parola nike, che significa vittoria. Proprio come quelle scarpe che ai nostri giorni promettono di dare le ali ai piedi. L’ KEVIN YOUNG 46.78 È chiaro che per una vita da superstar gli atleti erano disposti a tutto. Sacrifici e sotterfugi per superare se stessi e stracciare i rivali. Come Milone di Crotone, vincitore di ben trentuno ori tra il 540 e il 512 avanti Cristo. Sei alle Olimpiadi, sei ai giochi Pitici, dieci a quelli Istmici e nove alle gare Nemee. La strapotenza atletica di questo superman degli stadi era il risultato di un programma alimentare che avrebbe stroncato anche Schwarzenegger. Ogni giorno una fiorentina da dieci chili annaffiata da dieci litri di vino di Samo. Una bomba proteica per un corpo da ciclope. Altri ricorrevano invece ad abbuffate pantagrueliche di carni di maiale, o alle prodigiose virtù dei testicoli di toro per assicurarsi una preziosa riserva di testosterone da spendere nel rush finale, quando gli avversari erano ormai scoppiati. Non tutti però si accontentavano di questi integratori caserecci. Molti volevano tutto e subito. Così giocavano sporco, dopandosi con sostanze Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 IL MIRAGGIO DEGLI 800 FEMMINILI Nell’infografica sopra e sotto l’illustrazione di pagina è riportata la classifica dei venti record più longevi dell’atletica mondiale. Quello che resiste da più tempo è il primato di Jarmila Kratochvílová negli 800 metri femminili, imbattuto da ventiquattro anni Al ventesimo posto il leggendario Sergey Bubka col primato del salto con l’asta, che dura da tredici anni mano in spettacolo, lo show paga alti ingaggi, i primati rendono la vita più soft, l’illusione è che ogni barriera abbia i secondi contati. E la pillola va giù. Le cliniche hollywoodiane offrono agli attori dello sport cicli per ripulirsi. Bisognava superare e superarsi, il corpo è un ostacolo, guai avere dubbi, fare controlli seri. Non si spara mica ai trapezisti. I dottori diventano più ricercati degli allenatori: seguire la forza bruta e brutta, il suo lato oscuro, Guerre Stellari diventa marcio. Il doping diventa il braccio armato del record. Si avanza, senza stile, ma con potenza: se hai più forza vai più su. Salti male, in modo orribile, ma vinci. I farmaci sostituiscono la tecnica, perché perdere tempo a memorizzare un gesto? Se sei d’accordo con il croupier è inutile studiare i numeri, basta puntare. Primo Nebiolo, presidente della federazione internazionale, asciuga lo stile anglosassone e spinge per una megalomania latina. L’atletica deve strafare, i suoi campioni oscurare il calcio. Nei meeting dilagano «le lepri», atleti che hanno il solo compito di condurre il predestinato al record. E poi all’orizzonte c’era la ge- URSS BULGARIA più asciugata e depressa. Le nuove generazioni non cercano più lo scontro, l’esaltazione agonistica, al contrario vogliono un riparo dalla battaglia per paura di vedere abbassare la loro quotazione. Vivono i confronti diretti come un verdetto di condanna. Prima i grandi duelli incendiavano l’estate, ora bisogna aspettare mondiali e olimpiadi. Meglio non ferire le carriere, proteggerle dai tagli. Bubka, invece, tuttora primatista mondiale dell’asta nella sua vita è stato in volo più del Concorde, più di tredicimila salti l’anno. Oggi è diversa anche la selezione, il modo di trovare i talenti: non più la pratica a scegliere i forti e condannare i deboli, ma tabelle e misurazioni dettate da basi scientifiche. Test, non strada. Prove di muscoli, non di cervello. Spiegò Mennea: «Oggi c’è una società che rifiuta tutto quello che ho rappresentato: io allenavo la fatica con l’allenamento, ogni giorno, fino all’esaurimento. Soffrivo, ma sognavo di più». Così dal Duemila l’atletica è diventata una bella addormentata. Sette anni senza più voglia o forza di stupire. Pochi (e falsi) movimenti in avanti. Bassa in- URSS tensità di talenti, meglio dare poco e durare. Anche ai Mondiali di Osaka belle prestazioni, ma zero primati. L’atletica non affascina più, non ribalta il mondo. Senza l’erezione del doping la corsa, i lanci, i salti, tornano a misure normali. Si è persa la pratica quotidiana del lavoro, il tempo dell’attesa, il sapere del tecnico. Mancano i riferimenti culturali: una volta c’era la patria, lo stato, l’orgoglio di appartenere ad una scuola e a una tradizione, di seguire orme antiche; oggi c’è l’individuo, lo sponsor, la taglia per il record. Centomila dollari, grazie. Il francese Thierry Vigneron, nell’84 tra un primato e l’altro dell’asta si accendeva sigarette Gauloises. Oggi l’atleta è più sano, non fuma, mangia meglio, spesso è vegetariano, usa integratori dietetici. Ma sembra quasi che cominci ad accettare i limiti e che senza doping si senta menomato, incapace di reagire. Bubka a ventidue anni a Parigi era solo un ragazzo, studente di educazione fisica, appena diventato padre, che amava Prokofiev e Celentano. Impugnò l’asta, guardò il cielo, non vide cancelli, e si disse: perché no? Oggi invece i campioni non sanno più cavalcare senza sella. DDR USA LANCIO DEL PESO SALTO IN ALTO SALTO IN LUNGO LANCIO DEL DISCO CORSA 100 METRI Registrato a Mosca il 07.06.1987 Registrato a Roma 30.08.1987 Registrato a Leningrado l’11.06.1988 Registrato a Neubrandenburg il 09.07.1988 Registrato ad Indianapolis il 16.07.1988 22.63 STEFKA KOSTADINOVA 2.09 GALINA CHISTYAKOVA 7.52 GABRIELE REINSCH 76.80 FLORENCE GRIFFITH-JOYNER 10.49 FOTO FOTOTECA GILARDI NATALYA LISOVSKAYA netica e la tecnologia: il materiale migliorava, piste pedane e scarpette pure. Diceva Pasteur: un po’ di scienza ci allontana da Dio, più scienza ci avvicina. Arrivò il Duemila e lo shuttle dall’atletica si trovò sfiatato, chi avvisava Houston del problema? Nessun record ai Giochi di Sydney, nessuno ai mondiali di Edmonton, niente salti mortali, solo un respiro corto e affannato. L’antidoping cominciava a fare vittime, i controlli a sorpresa aumentavano. L’atletica si stava scaricando: niente prestazioni, campioni spesso rotti, troppe gare, pochi confronti, tanto stress. Lo sprint accelerava di poco, per il problema dei meccanismi di sincronizzazione ad alta frequenza. La muscolatura aumentava, ma una Ferrari con i freni della Cinquecento è inutile. Il problema era il tendine, non allenabile, e che protetto da una guaina, che si irrita e s’infiamma, comincia a gonfiarsi e a comprimere. Troppa la sollecitazione per l’organismo umano, il sistema immunitario si indebolisce, il corpo non riesce più a recuperare la forma. Più gare, più soldi, meno allenamento, prendi i soldi e scappa. Basta miracoli, l’atletica tornava a terra, USA CARL LEWIS CINA CINA CUBA URSS 4X100 MASCHILE CORSA 10.000 METRI CORSA 1500 METRI SALTO IN ALTO SALTO CON L’ASTA L’ Registrato a Barcellona l’08.08.1992 Registrato a Pechino l’08.09.1993 Registrato a Pechino l’11.09.1993 Registrato a Salamanca il 27.07.1993 Registrato al Sestriere il 31.07.1994 37.40 JUNXIA WANG cui venivano attribuiti poteri miracolosi. Come i semi di sesamo, tassativamente proibiti al punto da costare la squalifica a chi ne veniva trovato in possesso. Ugualmente vietati erano anabolizzanti naturali come il fieno greco, nonché certi cocktail di frutta fermentata e alcool. A fare i controlli antidoping erano nientemeno che i sacerdoti di Zeus che, nella loro veste di garanti supremi della morale pubblica, annusavano l’alito dei concorrenti per assicurarsi che non avessero violato le regole della giustizia sportiva prendendo intrugli per migliorare artificialmente le loro prestazioni. Se i più sleali cercavano di pompare il proprio corpo altri invece lavoravano per alleggerirlo, per ridurre al minimo peso e attrito. Come Orsippo di Megara, che alle Olimpiadi di duemilasettecento anni fa corse totalmente nudo sbaragliando gli avversari appesantiti da ingombranti perizomi. L’astuto velocista aveva intuito che la pelle è il più aerodinamico dei tessuti. Con un an- 29:31.78 YUNXIA QU 3:50.46 ticipo di tre millenni sulle prodigiose tutine hi-tech che oggi ricoprono gli atleti di una seconda nudità: un film più liscio e sottile di qualsiasi epidermide naturale. Finendo così per ibridare i corpi degli sportivi che appaiono sempre più simili a quelle creature mitologiche — centauri, tritoni, uomini uccello — che con la loro natura doppia, metà uomini metà animali, simboleggiavano l’oltrepassamento dei confini dell’umano. Come il birdman Patrick De Gayardon che planava nel più alto dei cieli con la sua tuta da Batman, dotata di membrane ispirate a quelle degli scoiattoli volanti del Madagascar. Molto più di una semplice protesi tecnologica, le ali spalancate del surfista celeste erano un’estensione del suo corpo. E insieme il mascheramento della natura umana e dei suoi limiti invalicabili. La tragica fine del temerario francese, il 13 aprile del 1998, ne fa per molti versi un Icaro moderno. E la sua caduta assume il senso di un ammonimento sulle terribili conse- JAVIER SOTOMAYOR 2.45 SERGEY BUBKA 6.14 guenze di una sfida alla morte che sconfina in un atto di folle arroganza. In quella fatale mancanza di misura che i Greci chiamavano hybris. Ancor più che nelle gare atletiche, dove pure scendere al di sotto di certi tempi sembra ormai impossibile, è dunque nelle performance estreme che vengono veramente rimessi in discussione i confini del corpo. Questi eroi dell’impossibile — discesisti della morte che sciano su pareti verticali, canoisti che si gettano in cascate violente, bungee jumpers che si lanciano da altezze vertiginose — sono in realtà degli Ercoli moderni. Le loro imprese sovrumane ricordano le agonistiche fatiche del divino forzuto. Con la differenza che le dodici prove del figlio di Zeus — un autentico dodecatlon — avevano un valore sociale. Insegnavano ai giovani che l’uomo non è un dio. Che il coraggio no limits è solo una narcisistica, funesta ipertrofia dell’io. Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 il reportage Specchio retrovisore I recenti allarmi sull’industria cinese accusata di sfornare prodotti tossici o contraffatti hanno un precedente illustre: le inchieste di Dickens e Sinclair sui misfatti dell’industria Usa tra Ottocento e primo Novecento. Ora un libro dello storico americano Stephen Mihm stabilisce il parallelo tra due forme di capitalismo adolescente, allo stesso tempo uguali e molto diverse Le fabbriche dell’orrore una storia già raccontata FEDERICO RAMPINI FOTO CORBIS n fumo immenso dalle ciminiere oscura il cielo e sporca la terra… avvicinandosi alla città l’atmosfera cambia, diventa più cupa, l’erba dei campi sempre meno verde, il paesaggio è spoglio e squallido. E insieme col fumo sempre più spesso si comincia a sentire un odore strano, nauseabondo». Nella fabbrica «ci sono bambini piccoli, appena sopra i dieci anni, che arrivano a stento all’altezza della catena di montaggio. I genitori hanno mentito sulla loro età, per trovargli un posto pagato cento dollari all’anno». Nel reparto dove gli operai preparano il manzo in scatola «il pavimento è lurido, ma un vecchio deve raccogliere con la scopa tutti gli scarti. I rifiuti finiscono nel camion mescolati al resto della carne». Sembrano descrizioni da un reportage sulle “fabbriche dell’orrore” che pullulano nella Cina di oggi: lo smog denso che avvolge le metropoli industriali e rende l’aria irrespirabile, lo sfruttamento del lavoro minorile, le condizioni igieniche disastrose. Un incubo che tormenta i consumatori occidentali, dopo la catena di scandali sui prodotti made in China contaminati e nocivi per la salute, scoperti nei nostri supermercati. Ma quelle citazioni iniziali non dipingono il gigante asiatico che ha invaso i nostri mercati nel Ventunesimo secolo. Sono brani tratti da un romanzo-denuncia che ha più di cent’anni: La Giungladello scrittore americano Upton Sinclair, pubblicato nel 1906. Il luogo è Chicago, allora una città di frontiera lanciata in uno sviluppo economico tumultuoso. I protagonisti che si aggirano in quel paesaggio industriale sinistro sono poveri immigranti lituani, prima attratti dal “sogno americano”, e ben presto stritolati negli ingranaggi di un capitalismo senza pietà. Mezzo secolo prima di Sinclair, un altro scrittore celebre ha descritto la nascente potenza americana come una nazione senza regole. Il romanziere inglese Charles Dickens fa il suo primo viaggio negli Stati Uniti nel 1842. Nel diario dove raccoglie le sue impressioni annota una caratteristica del capitalismo americano: «È il dominio dei furbi che ingannano la fiducia degli altri; i truffatori e i disonesti la fanno franca e sono ai vertici della società». Lo colpisce anche la «diffusione di malattie che potrebbero essere prevenute con semplici precauzioni igieniche… come le fognature». Nel centro di New York, sulla Broadway, vede passeggiare indisturbati i maiali randagi «che sono i veri spazzini della città». Soprattutto Dickens è sconvolto dal dilagare della contraffazione. Ne è vittima lui per primo. Tutti i suoi romanzi di successo, come Oliver Twist e Il circolo Pickwick, vengono copiati e diffusi sul mercato locale senza pagargli i diritti d’autore. Le sue proteste sono inutili: lo stesso diario di viaggio in cui denuncia l’industria del falso (America) esce in versione-pirata appena quattro giorni dopo la pubblicazione in Inghilterra. A New York se ne vendono centomila copie illegali in un mese. Oggi il pubblico occidentale è sgomento di fronte alle rivelazioni che arrivano dalla Cina: la salute del consumatore, la sicurezza dei prodotti, il rispetto del copyright, ogni valore viene calpestato in nome del profitto. Reagire è legittimo ma stupirsi è ingenuo. Solo un’amnesia storica può farci credere che le “fabbriche dell’orrore” siano una novità. A rinfrescarci la memoria ci prova uno storico americano, Stephen Mihm, docente all’università della Georgia. In questi giorni la Harvard University Press pubblica il suo saggio A Nation of Counterfeiters. La patria della contraffazione a cui allude il titolo non è la Cina, è l’America. Quello che sta accadendo oggi dall’altra parte del mondo non è un fenomeno inedito, sostiene il professor Mihm. «Un secolo e mezzo fa un’altra nazione in rapido sviluppo aveva la reputazione di sacrificare le regole “La Cina - dice Mihm - siamo noi da giovani Se ce ne rendiamo conto, capiamo che il capitalismo mordi-e-fuggi non è un fenomeno cinese né un complotto per avvelenarci ma una fase dello sviluppo” FOTO CORBIS «U PECHINO alla rincorsa del profitto, e quella nazione emergente era l’America». Dalle edizioni-pirata dei dvd di Hollywood e dei libri di Harry Potter fino agli scandali recenti dei cibi adulterati e dei medicinali tossici, osservare la Cina del Ventunesimo secolo secondo lo storico è come vedere nello specchietto retrovisore l’economia americana dell’Ottocento. Lo stesso dinamismo spregiudicato e spesso disonesto. «La Cina — dichiara Mihm — per certi aspetti è la versione giovane di noi stessi. Se ce ne rendiamo conto, allora capiamo che il capitalismo mordi-e-fuggi non è un tratto del carattere nazionale cinese, né tantomeno un complotto per avvelenare noi, ma è una fase dello sviluppo. Lo chiamerei il capitalismo-adolescente: scoppia di energia, è esuberante, dinamico. E come tutti gli adolescenti ha anche comportamenti folli, irresponsabili, pericolosi». Riscoprendo cos’era davvero l’America dell’Ottocento impressionano le analogie con la Cina dei nostri giorni. Non è esatto sostenere che gli Stati Uniti allora fossero la terra del liberismo sfrenato, del laissez-faire. Sulla carta c’erano tante regole (così come abbonda di regole la Repubblica popolare, che ha ereditato l’armamentario del dirigismo comunista). Ma erano state scritte per una realtà ormai superata, non erano adeguate alla impetuosa modernizzazione che stava avvenendo. Le istituzioni che avrebbero dovuto disciplinare il mercato erano inefficienti, o più deboli degli interessi privati. La corruzione regnava. In un passaggio illuminante della Giungla Sinclair descrive con perfidia l’ispettore sanitario: pagato per sorvegliare lo stabilimento dove i maiali vengono macellati e trasformati in prosciutti, spesso costui finge di non vedere le nefandezze che avvengono in fabbrica. «Questo funzionario statale non aveva l’aria di uno che si ammazza di lavoro; non sembrava molto preoccupato che qualche maiale potesse sfuggire ai suoi controlli. Bastava rivolgergli la parola e lui era felice di spiegarti il pericolo mortale per chi mangia carne di maiali malati di tubercolosi; e mentre lui ti parlava dozzine di carcasse gli passavano dietro aggirando l’ispezione… Nel reparto per la produzione delle salsicce uomini e donne lavoravano in mezzo a un fetore vomitevole, i visitatori fuggivano per non soffocare». Sinclair non lavorava di fantasia. Prima di scrivere quel romanzo si era documentato accuratamente, con mesi di inchieste nelle tre maggiori aziende alimentari di Chicago, i famigerati “meatpackers” (produttori di carne in scatola) Armour, Swift e Morris. Come racconta in uno dei brani più disgustosi, nelle salsicce e nei prosciutti finivano non solo le carni scadenti o infette, ma perfino arti umani o interi cadaveri delle vittime di incidenti sul lavoro. Nell’industria americana i vizi abominevoli non erano limitati alla produzione di carne in scatola che Sinclair prese di mira nel suo romanzo-verità. Mihm ricorda che il primo studio sistematico sulla qualità dei prodotti alimentari, realizzato a Boston nel 1859, rivelò una situazione terrificante: caramelle all’arsenico, birra con stricnina, sottaceti imbevuti di solfato di rame, farina e zucchero “allungati” con gesso e polvere di marmo, latte contaminato da mucche al pascolo nelle discariche di rifiuti. Proprio come accade oggi ai cinesi, le principali vittime erano i consumatori americani, ma gli scandali scoppiarono all’estero. Nel 1879 le autorità tedesche accusarono l’America di esportare maiali malati di colera e salsicce piene di vermi. Nel 1880 fu l’Inghilterra a bloccare partite di margarina importata dagli Stati Uniti, adulterata con interiora di bestiame putrefatte. I paesi europei più evoluti nella tutela della salute pubblica cominciarono a boicottare il “made in Usa” e a stendere un cordone sanitario attorno ai prodotti alimentari sospetti. «Nella Cina di oggi — sostiene Mihm — la facilità con cui proliferano l’industria della pirateria e gli imprenditori senza scrupoli si spiega con gli stessi mali che perseguitavano gli Stati Uniti centocinquant’anni fa: una legislazione inadeguata, superata dalla rapida evoluzione dell’economia; la scarsa motivazione dello Stato nel combattere le frodi; e una Repubblica Nazionale LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 FOTO CORBIS DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LE IMMAGINI In alto, un bambino trasporta le confezioni di cibo in scatola in una fabbrica alimentare Baltimora Maryland, 1909 Qui accanto, Addie Laird, di dodici anni, al lavoro in una fabbrica di cotone North Pownal Vermont, 1910 Nella pagina accanto, in alto, due bambini arrampicati su un telaio elettrico al lavoro in uno stabilimento Macon Georgia, 1910 FOTO CORBIS In basso, Nannie Coleson, undici anni, cuce calzini per tre dollari alla settimana Scotland Neck North Carolina, 1914 Tutte le immagini pubblicate in queste pagine sono frutto di un reportage fotografico di Lewis Hine percezione sociale inadeguata della distanza tra l’arricchimento onesto e quello disonesto». Resta una differenza: gli Stati Uniti erano già allora una democrazia, la Repubblica popolare fondata dalla rivoluzione comunista del 1949 è un regime autoritario. Che non sia una distinzione da poco lo dimostra la vicenda di Upton Sinclair. La Giungla ebbe un immenso successo popolare prima come feuilleton a puntate su una rivista socialista, poi come libro vendette centinaia di migliaia di copie. Secondo la studiosa di storia letteraria Cynthia Brantley Johnson «nessun romanzo americano del Novecento provocò una tale indignazione, e nell’ultimo secolo solo il romanzo anti-schiavista La capanna dello zio Tom ha avuto un’influenza paragonabile a La Giungla». Non sembrano affermazioni esagerate. Tra gli ammiratori di Upton Sinclair c’era il presidente Theodore Roosevelt. All’estero la sua fama era tale che Gandhi gli scrisse lettere dal carcere. Il successo di quel libro incoraggiò una nuova tendenza nella stampa americana, il giornalismo d’inchiesta, i cosiddetti muckraker (letteralmente “rastrellatori di letame”), i reporter specializzati nel denunciare la corruzione. Nel 1906 l’impatto della Giungla contribuì a far passare al Congresso di Washington il Pure Food and Drug Act, la prima legislazione generale con- tro l’adulterazione dei cibi. Nel 1908 il Congresso metteva al bando il lavoro minorile. Esiste un autore cinese contemporaneo che si può considerare l’erede di Upton Sinclair. È lo scrittore Zhou Qing, che in un romanzo del 2004 ha rivelato le vergogne dell’industria alimentare del suo paese. Ha descritto operai che versano insetticidi nei barattoli di conserve alimentari per uccidere gli scarafaggi; supermercati che aggiungono la candeggina sulle torte di panna perché siano più bianche; fabbriche di bibite che riciclano le bottiglie scadute cambiando semplicemente l’etichetta con la data di produzione. Ma la sua storia è stata letta da pochi intimi. La censura del regime controlla i mass media e vieta di diffondere “allarmismo” tra la popolazione. L’ignoranza dei consumatori resta abissale. In mancanza di libertà politica e di una società civile agguerrita in Cina, la pressione internazionale può essere utile. Lo storico Mihm ricorda che un secolo fa l’embargo decretato da varie nazioni europee sulla carne americana ebbe l’effetto di un elettroshock. Privata di sbocchi sui mercati esteri, l’industria americana dovette correre ai ripari. I controlli sui metodi di produzione e sulla qualità si fecero più severi. «Avvenne un cambiamento fondamentale: gli imprenditori più avanzati capirono che conquistarsi la fiducia del mercato era la migliore garanzia per fare profitti». Dickens ebbe solo una rivincita postuma. La prima legge internazionale sul diritto d’autore fu adottata dagli Stati Uniti nel 1891, vent’anni dopo la sua morte. Non per effetto delle sue denunce ma perché nel frattempo era fiorita la letteratura americana e con essa un business editoriale che aveva interessi da tutelare. Sinclair da parte sua rimase deluso dall’impatto della Giungla. Lui aveva sperato che quel libro servisse la causa del movimento operaio. Sognava una rivoluzione di sinistra contro il capitalismo americano. L’opinione pubblica invece si mobilitò contro le “fabbriche dell’orrore” soprattutto perché gli alimenti prodotti in quelle condizioni erano un attentato alla salute. Colui che sperava di essere un profeta del socialismo fu involontariamente il precursore del consumerismo. Sul finire della sua vita Sinclair commentò: «Avevo puntato al cuore dei miei lettori, invece li ho colpiti allo stomaco». Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 la memoria A dieci anni dalla morte il Festival Filosofia di Modena dedica una mostra al protagonista di quella leggenda catodica che fu “Non è mai troppo tardi”. E, a sorpresa, si scopre Pionieri tv che Alberto Manzi non era un santino buonista ma un uomo di ideali, furori, delusioni e ribellioni. E che si conquistò, perfino a botte, il diritto di insegnare in un carcere minorile Manzi, maestro a suon di pugni MICHELE SMARGIASSI I MODENA l diritto di chiamarsi maestro non glielo diede il diploma magistrale, che prese di malavoglia; non glielo diede neppure la tivù, che lo consacrò maestro d’Italia per antonomasia; non glielo diedero di certo i provveditori che lo sospesero otto volte dall’insegnamento per ripetuti ammutinamenti didattici. Il diritto di chiamarsi maestro, il maestro Manzi se lo conquistò a suon di cazzotti. Autentici e sonanti manrovesci da ex marò della San Marco. Lo volle raccontare lui stesso, dieci anni fa, imbarazzato ma anche orgoglioso, nell’intervista filmata che l’Università di Bologna gli fece poco prima che morisse, per mettere al sicuro l’eredità dell’uomo che inventò, con quella leggenda catodica che fu la trasmissione Non è mai troppo tardi, l’alfabetizzazione televisiva. Forse gli stava ormai stretto, quel cliché di maestro in bianco e nero, buono, dolce, timido e quasi ingenuo, dopo tanti anni passati a far tutt’altre cose, dopo aver rischiato la galera in Sudamerica, dopo essere diventato (con Orzowei, primo di molti romanzi) lo scrittore italiano per ragazzi più tradotto nel mondo dopo Collodi, dopo aver litigato con ministri e ispettori, dopo aver fatto, soprattutto, quotidianamente, per quarant’anni, il maestro puro e semplice, il maestro di scuola elementare. Insomma la storia dei cazzotti andò così: che nel 1946 l’unica cattedra per il giovane Alberto Manzi era la più terribile di Roma, quella del carcere minorile Aristide Gabelli, novanta piccoli guappi tra gli otto e i diciotto, quattro maestri già fuggiti in un mese per disperazione. «All’inizio della prima lezione mi s’avvicina un ragazzo, il boss dei detenuti, e mi dice: tu ti metti lì a leggere il giornale e noi ci godiamo quattro ore di tranquillità. E io: mi spiace ma mi pagano, qualcosa devo insegnarvi. E lui: allora ce la giochiamo, se vinci tu insegni, se vinco io te ne stai zitto e buono. Bene, ce la giochiamo a carte? No, a botte. Eravamo quasi coetanei, ma io uscivo da quattro anni di Marina. Vinsi senza fatica, e salii in cattedra». Qualche mese dopo usciva il primo numero del giornalino del carcere, La tradotta. Di quei novanta, Manzi s’informò, solo due tornarono in carcere da grandi. A pugni e schiaffi contro l’ignoranza che fa schiavi: non era un santino buonista, il maestro Manzi, era un essere umano. Per Andrea Canevaro, pedagogista che lo conobbe bene, era anzi «uomo di furori, di ideali, di delusioni, di ribellioni». È ora che lo sappiano le migliaia di italiani oggi cinquantenni che, prima ancora di sedersi sui banchi, davanti alla sua cattedra di vetro impararono l’abicì, intrufolandosi di straforo tra i destinatari di quei tardi pomeriggi Rai (ore diciannove, quando i contadini tornano dai campi) che dovevano in realtà aggredire l’analfabetismo adulto, e lo fecero, portando alla licenza elementare tardiva l’incredibile massa di un milione e mezzo di persone in otto anni, e per questo si meritarono la medaglia Unesco di migliore trasmissione educativa del mondo. Scommettiamo sulle lacrime, tra pochi giorni nei corridoi del Castello dei Pio a Carpi, dove il Festival Filosofia di Modena gli tributa una mostra a dieci anni dalla morte, davanti agli schermi che rimanderanno i violini stiracchiati e le ombre incrociate della sigla di Non è mai troppo tardi. «Siamo qui per imparare a leggere, ma anche a conoscere noi stessi e il mondo», l’esordio di quel maestrino gentile ed educato, bel viso da attore. «Mare pino casa nave» le prime parole calligrafate sul foglio bianco, «voi non sapete decifrare questi segni, eppure vogliono dire queste cose», e la mano rapida col gessetto nero di- segnò un mare, un pino, una casa, una nave, «e noi impareremo a capire le parole come capiamo i disegni». Quel gessetto nero grasso era un disastro per i polsini. Manzi riceveva dalla Rai duemila lire di «indennità camicia» ogni puntata. Unico pagamento, perché «come maestro prendevo già uno stipendio dallo Stato». Stipendio da fame: lo aveva scritto al ministro Gonella in una lettera amarissima e feroce, che esordiva «Onorevole adesso mi stia ad ascoltare». Ma questo, i tele-alunni non lo sapevano. Che ci fosse un uomo, dietro il personaggio nella scatola di vetro, un uomo un po’ diverso da Mike Bongiorno o da Mario Riva, magari lo sospettavano: si vede dalle lettere che gli scrivevano, valanghe, tanto che Manzi dovette ingaggiare lo zio Filippo, tipografo a Torino, che gliene facesse una sintesi settimanale, da quello che gli contestava la grafia di aeroplano, a quella che gli rimproverava l’accento romanesco, «non si dice conzonante!». Ma di che pasta fosse fatto quell’uomo, è rimasto per i più un mistero. Bene, eccolo finalmente, il vero maestro Manzi, fuori dall’icona. L’uomo passionale, provocatore, iperattivo. L’intellettuale con due lauree, Biologia e Filosofia, che abbandona un incarico alla Scuola sperimentale di Magistero «perché non si sperimentava niente», e torna sulla cattedra delle elementari. Il maestro che ama la scuola al punto da detestare chi ne fa cattivo uso, infuriato con i «provveditori che non provvedono», con i colleghi sfaticati o indegni. Dai documenti privati (donati dalla seconda moglie Sonia alla Regione Emilia Romagna, che ne ha fatto un archivio pubblico), dai dattiloscritti inediti, dagli appunti pieni di sfoghi e «cattivi pen- Il primo incarico lo ebbe a Roma, al riformatorio Gabelli Il primo giorno il boss lo sfidò: “Insegni solo se mi batti...” CARTA Presente in tutte le forme, dal foglio protocollo al brandello di giornale, puntualmente coperta da appunti e disegni. La riciclava in tutti i modi non solo per spirito ecologico ma per onnivora voracità del suo materiale preferito LESSICO FAMIGLIARE MASSIMO MANZI ANIMALI Di ogni taglia e specie, popolavano in egual modo l’aula scolastica e le mura domestiche ma guai a non rispettarli. Le visite allo zoo (il bioparco era di là da venire) erano una costante delle nostre passeggiate romane sieri» gelosamente conservati, dai quaderni a righe riempiti in diligente calligrafia con amarissimi brandelli di diario, affiora il ritratto di una scuola italiana anni Cinquanta approssimativa, clientelare, tragicomica e burocratica, piena di maestri tanto maneschi quanto ignoranti, diretta da funzionari tronfi e inefficienti, fin troppo simile a quella dei romanzi di Mastronardi, fin troppo specchio all’Italia di allora. Disgustato: «Ho visto molte maestre leggere Grand Hotelcome le domestiche». Indignato: «Alcuni maestri frequentano le bettole e ne escono ubriachi. Ne ho visto uno con un occhio pesto, glielo avevano tappato con un pugno all’osteria». Sarcastico: «Una maestra di facili costumi suscitò la protesta delle madri, il direttore prese provvedimenti: la nominò sua segretaria». Contegno, dignità: il maestrino Manzi sembra inclinare al moralismo. Ma non è indignazione bacchettona, è preoccupazione civile. Nel romanzo-verità di quell’italietta meschina, il cittadino Manzi intravede un futuro nero per quella che non si vergogna di chiamare Patria: «Provate a far leggere gli alunni di una quinta rurale... La scuola passa e non lascia traccia...». Non aveva neanche la tivù in casa nel 1960 quando il direttore didattico lo spedì a fare un provino in Rai, dove si cercava affannosamente un maestro telegenico; ne avevano già scartati un centinaio e la trasmissione doveva iniziare a giorni. «Di tivù non sapevo nulla, se non che le immagini si muovevano». Per questo strappò il copione che prevedeva un’inquadratura fissa, si fece portare fogli e gessetti neri e improvvisò un’animata lezione sulla lettera O. «Abbiamo trovato il maestro!», gridò fuori campo la voce del regista. La Rai di Bernabei, senza crederci molto, inaugurava la sua trasmissione più rivoluzionaria. Socialmente avanzata. Interattiva, perfino: duemila “punti d’ascolto” nei circoli, nei bar, nei municipi, dove duemila maestri riunivano ogni sera migliaia di adulti davanti al televisore: «Il merito fu tutto loro, io ero solo un pupazzo televisivo». Ma il democristianissimo direttore di viale Mazzini celebrò in LIBRI L’amore di una vita, tappezzavano la casa Gelosamente custoditi e firmati a pagina 101 come uccelli migratori con l’anellino alla zampa Tra i preferiti, i volumetti Bur essenziali nella loro copertina grigia, allineati uno accanto all’altro DISEGNI Schizzi velocissimi utilizzati da sempre per accompagnare una lezione ma anche nel corso di una telefonata o riunione: sempre intento a scarabocchiare qualcosa La chiave di volta delle sue trasmissioni tv L’educazione dei ragazzi, un testo-invettiva del maestro “Scuola di oggi, rovina del futuro” ALBERTO MANZI ensierini sulla scuola d’oggi. Non è un’inchiesta. Sono forse pensierini cattivi, scaturiti da una mente malsana, avvelenati dalla bile di un fegato marcio. Scuola d’oggi: rovina d’un prossimo futuro. Il male è alle radici, è nel tronco, è nei rami: ovunque. È nei maestri, nei direttori, negli ispettori, nel ministro. Cosicché le patrie galere rigurgitano di minorenni. Maestri improvvisati e che non vogliono prepararsi sono dilagati nella scuola travolgendo i pochi onesti, tutti presi dal loro lavoro. Concorsi che non sono stati concorsi hanno aperto la diga facendo tutto sommergere. «Ti sei preparato?» «No. Che importa? Conosco il tale…». Oppure: «No! Tanto sono reduce!». Oppure, e meglio: «Sono dieci anni che insegno!», «Monsignor Tale m’ha assicurato… L’onorevole Caio ci pensa… Ho pagato il ragionier Cappiccia… Ho il tema… Sono profugo… Sono partigiano… antifascista… razziata… bombardata…». (...) Quanti sono? Centinaia e centinaia. Impreparati, ma ricolmi di titoli e di patacche. E nella classe portano i titoli e le patacche. Poi, appena nominati, trasferiti in sedi più comode. Il signor L. F. comandato a Roma per allattamento. Sicuro: ben quindici maestri allattano a Roma. Uno l’ho prenotato per il prossimo pargolo. (...) Un’apparenza di cultura e via. Chi s’interessa dell’animo infantile? Chi lo cura? Chi lo educa? Qualcuno: lo scemo, il pignolo. E gli ridono dietro, l’allontanano. E quello o cede o cammina solo. Didattica? E cos’è ‘sta bestia? Attivismo? Sì, delle mie mani su quelle teste dure. Avanti, avanti! (...) E ci sono maestri che vorrebbero prepararsi, che cercano aiuto. Ma il direttore si fa vedere ogni morte di papa, e quando viene cerca i pidocchi nella testa dei ragazzi. (...) «Signor direttore, quel ragazzo, sa, che devo fare? Mi disturba gli altri». «Lo bocci». Direttori così e peggio. Direttori che si vedono una volta all’anno, alla fine, e brontolano perché il programma non è stato svolto tutto. Direttori in gamba: due. Ispettori che non si vedono mai. O ogni tre anni, affogati, impelagati in ordinanze, contrordinanze, circolari e conti. Ispettori che non ispezionano. Provveditori che non provvedono a nulla, ignari dei più semplici problemi della scuola elementare. (...) E forse ci rivedremo tutti all’inferno: io e voi, maestri che dimenticate il vostro sacrosanto dovere, che ve ne infischiate dei ragazzi; io e voi, direttori illustri incogniti; io e voi, ispettori viventi fra le tarme. Ma con loro signori provveditori, no. Loro andranno un pochino più giù di me, perché «potevano provvedere e non hanno provveduto». Ma speriamo di non incontrarci. Speriamo che queste mie siano tutte cattiverie. Speriamo. Perché è col nostro lavoro che potremo migliorare il mondo. Perché non voglio credere che la scuola sia tutta così: che quei visi rosei e paffutelli si tramutino in visi duri, crudeli. No! Le mie son cattiverie. Servano però a svegliare i dormienti. P TIMBRO POLEMICO Nella foto grande a centro pagina, Alberto Manzi durante una puntata di Non è mai troppo tardi Nelle altre immagini, in senso orario: il maestro Manzi all’epoca del successo tv; il timbro che si fece fabbricare per valutare, in polemica col ministero, gli alunni a fine anno; la copertina del suo manuale per il disegno veloce alla lavagna; un’altra copertina di un suo libro didattico sulla lettura Questo testo, inedito, scritto negli anni Cinquanta, è stato trovato nelle carte di Alberto Manzi. Il “Lessico famigliare”pubblicato sopra è scritto da suo figlio Massimo Manzi Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 LA MOSTRA Il Festival filosofia ripercorre nella sede di Carpi la vita di Alberto Manzi attraverso le sue opere: la collezione dei materiali esposti comprende infatti l’archivio del maestro e dei suoi allievi Curata da Francesco Genitoni ed Ernesto Tuliozi, la mostra verrà inaugurata il 14 settembre (fino al 21 ottobre) all’interno di Palazzo Pio, in concomitanza con l’avvio del Festival filosofia L’evento si svolge in collaborazione con il Centro studi Alberto Manzi e il patrocinio del Segretariato sociale della Rai Manzi «un benefattore del popolo italiano». Avesse saputo a quale «testa calda» rivolgeva i suoi elogi. Il Manzi extra-televisivo era la disperazione degli ispettori. Si rifiutava di insegnare storia «perché un bambino di dieci anni non ha ancora un chiaro concetto di spazio e tempo». Aveva letto Piaget, lui: gli ispettori forse no. Sospeso da cattedra e stipendio. Si rifiutava di dare i voti. Si rifiutò anche di dare i «giudizi», quando arrivarono: «I bambini cambiano, ma i giudizi restano nero su bianco, non posso bollare un ragazzo per sempre». Sui primi moduli, per rabbia, scrisse «merda»: sospeso ancora. Allora si fece confezionare un timbro con la scritta Fa quel che può, quel che non può, non fa, «didatticamente ineccepibile», e stampigliò pagelle in serie. Sospeso di nuovo. Non piegato: «Continuai a scrivere quella frase a mano sui moduli». Ribelle solitario. Si firmava, a volte, El loco, il matto, come il personaggio di un suo romanzo. «La Rai mi proibì di parlare dell’assassinio di Kennedy: ma andavamo in diretta, e lo feci lo stesso». Sovversivo senza partito. I colleghi impegnati, anzi, lo insospettivano: «Partecipano alle lotte politiche in modo fazioso, aspirano tutti a divenire sindaci. Raggiunto lo scopo si rivelano incapaci di fare sia i sindaci che i maestri». La ministra Falcucci, incontrandolo in una commissione, lo canzonò: «Lei è un cane sciolto? Allora può abbaiare quanto vuole». Credente, certo: nella lunghissima lista dei libri che scrisse c’è anche un catechismo per bambini, per conto della Cei. Idealista, senza dubbio. Non stava a chiedersi per chi suona la campanella. Nel ‘56 un ateneo lo mandò in Amazzonia a studiare certe formiche (in fondo era un biologo). Ma lì Manzi scoprì cose più importanti. Andò a vivere nei villaggi Kjivari, «quelli che essiccano le teste umane», cominciò ad alfabetizzare i campesinos perché potessero iscriversi al sindacato. «Infilare le dita nelle piaghe del mondo era vietato, quindi mi attirò subito». Un dirigente Alitalia gli forniva biglietti gratis, purché partisse quando c’era posto: maestro last-minute. Per vent’anni passò le estati sulle Ande, prima solo, poi con discepoli. Quel piccolo esercito armato di matite insospettiva i governi: fu cacciato come «indesiderabile», sospetto di simpatie «guevariste, papiste, marxiste o di un qualunque accidente che finisse con — iste», e senza la protezione dei salesiani forse non sarebbe neppure tornato a casa. A scrivere, ovviamente, romanzi di denuncia: «Con grande rammarico devo affermare che i fatti qui narrati sono veramente accaduti». «Fate funzionare il macinino del vostro cervello», si congedò dagli ultimi alunni. Aveva voluto essere un maestro globale: per l’Italia restò solo un maestro televisivo. Una tivù «sempre più futile» gli commissionò nuovi programmi, per insegnanti, per extracomunitari, alcuni gli piacquero, altri meno, non si tirò mai indietro. Dicono che ci rimase male quando il ministro Berlinguer non lo volle consulente della sua riforma. Pensionato, incapace di riposarsi, fece il sindaco a Pitigliano. Continuavano ad arrivargli lettere dei suoi tele-alunni, come Marzia: «Caro maestro ti volio bene, lego senpre». Se ne andò tra necrologi sui giornali locali e striscioni della scuola elementare del paese, «Ciao maestro». L’Italia ministeriale, cattedratica, l’Italia dei provveditori e degli ispettori, non gli ha mai detto grazie. Qualche volta non è vero, che non è mai troppo tardi. Nel 1960, quando fece il provino per la Rai, non aveva neanche il televisore. Alla fine il regista gridò: “Lo abbiamo trovato” TELEVISORE Fonte in egual misura, come tutti gli amori, di soddisfazione e aspre delusioni Gli chiesi perché non avesse mai scritto un trattato di pedagogia, mi guardò strano come fossi un ispettore del ministero Anni dopo mi illuminò una frase di Pennac: non esistono pedagogie ma solo pedagoghi MACCHINA DA SCRIVERE Il ticchettio di una vecchia Olivetti fece da sottofondo ai pomeriggi della nostra infanzia intervallato dal “dling” dell’a capo. Ci leggeva spesso la pagina appena terminata o ce la dava da leggere, infilava un nuovo foglio e via così STORIE DI SUCCESSO FOTO ARCHIVIO RAI TECHE /ALINARI Qui sopra: quattro copertine di libri di Alberto Manzi tra cui le edizioni, in lingua italiana e slava, di Orzowei In basso, da destra: un biglietto di ringraziamento spedito al maestro e una sua poesia inedita Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 la società Torna in libreria dopo oltre mezzo secolo la bibbia delle buone maniere di Donna Letizia. Consigli preziosi e regolette per comportarsi in ogni occasione privata Nel dopoguerra le italiane impararono leggendoli a gestire casa e marito mantenendo il ruolo di “angeli del focolare” IL SAPER VIVERE Così il galateo diventò l’ancora di salvezza della signora senza qualità DI DONNA LETIZIA INVITATI BALLI a signora che è invitata a una colazione evita di fare, prima, molte commissioni, per non presentarsi carica di pacchetti. Non si toglie il cappello se non è intima della casa. Prima di entrare in salotto, affida alla cameriera il mantello e l’ombrello e si sfila i guanti per porgere la mano ai padroni di casa. In sala da pranzo, l’invitata si siede senza aspettare l’esempio della padrona di casa, ma fa in modo di non precederla troppo. L’invitato, invece, si siede dopo le signore. Gli invitati incominciano a mangiare appena si sono serviti: solo per il dessert è consuetudine aspettare che la padrona di casa sia stata servita. In nessun caso, la persona invitata si rivolge al cameriere per chiedere del pane, del sale, del vino, o qualsiasi altra cosa. Questo comportamento è ammesso solo al ristorante. L N RACCOMANDAZIONI AUTOMOBILE a signora che desidera un posto per il nipote, non approfitti di un cocktail o di una serata brillante per parlarne con l’influente commendatore che le è stato proprio allora presentato. Tutt’al più si limiti, in quell’occasione, a chiedergli se può riceverla in ufficio uno dei giorni seguenti. Quando sarà nel suo studio, sia breve, precisa e seria. Ottenuto il favore, ringrazi con una lettera. Alcuni giorni dopo, se crede, lo inviti a pranzo. Il nipote andrà in persona a ringraziare. Se la visita al commendatore non ha dato i risultati sperati, la vera signora si riterrà comunque sua debitrice (è stata cortesemente ricevuta e ascoltata), l’invito a pranzo avrà luogo lo stesso, e la sua cordialità non apparirà offuscata. L I ADOLESCENTI SEPARAZIONE olte mamme si proclamano con un misto di compiacenza e civetteria «le migliori amiche» delle loro figliole, concludendo immancabilmente: «Non abbiamo segreti, ci raccontiamo tutto!». I rapporti tra madre e figlia che «si raccontano tutto» covano quasi sempre epiloghi burrascosi. Alla prima divergenza di una certa importanza, la mamma cerca invano di risalire in fretta gli scalini dell’autorità: la figlia le risponde da pari a pari, magari rinfacciandole le sue confidenze, come farebbe appunto con un’amica che volesse improvvisamente imporle la propria volontà. L’assoluta confidenza «reciproca» è ragionevole e naturale solo quando la figlia, ormai sposata, ha assunto la responsabilità della propria vita. M L FIDANZAMENTO VILLEGGIATURA S G e, passati i ventitré o i venticinque anni, la ragazza che fino a ieri era un fiore incomincia improvvisamente ad appassire, si fa acida e nervosa, la madre accorta non tarda a “capire”. Capisce cioè che quello che angustia la poverina è il fatto di non aver ancora trovato marito, e che è giunto il momento, per lei, di intervenire. Con estrema discrezione comincerà a darsi da fare: riaggancerà i rapporti con la signora X, che forse non le è simpatica ma ha tre figli in gamba, tutti scapoli. Solleciterà il consiglio e l’aiuto dell’immancabile amica che «conosce tutti». Spronerà il marito a invitare a teatro il giovane ingegner Rossi che è povero, ma ha una zia ricchissima e zitella, o l’avvocato Bianchi che non è più di primo pelo, ma ha una vasta clientela e un appartamento arredato... ei dancing si va a coppie o in comitiva. Se la comitiva è stata invitata da una coppia, lui inviterà a ballare per prima la signora più di riguardo, e pazienza se è vecchia e sgraziata. La moglie verrà invitata dal signore che le siede più vicino. Se la comitiva è in numero dispari, non si lascerà mai una signora sola al tavolo. Di volta in volta, una coppia rimarrà a farle compagnia. La signora non dovrà mai ballare con sconosciuti. Se una tra le invitate balla meglio delle altre, i cavalieri non devono precipitarsi a contendersela all’inizio di ogni giro. Oltre tutto le farebbero maturare intorno un’atmosfera nociva di antipatia femminile. Se il giovane con cui balla non la lascia più tornare al tavolo, la signora potrà interrompere il giro con il facile pretesto che è stanca. l vero signore non si lascia stordire dal possesso di una macchina. Non scambia un’utilitaria per un’Alfa da corsa, assordando con lo scappamento aperto i passanti e terrorizzandoli con sterzate stridenti come ha visto nei film polizieschi. E la signora non strombetta irritata se un pedone esita nell’attraversare: se lei ha fretta, lui ne ha forse altrettanta, senza avere il vantaggio di un mezzo veloce. Se a smontare la sua impazienza non vale la buona educazione, valga almeno una certa prudenza: gettando in faccia al pedone un adirato: «Cretino», rischia di provocare un «Ma stia zitta tardona!» o qualche altro complimento del genere, particolarmente scottante se accanto a lei siede un ammiratore. a separazione e l’annullamento, sinonimi di fallimento, non vanno partecipati, come non si partecipa una bancarotta o l’epilogo disastroso di un affare. Del resto, le notizie di questo genere volano rapidamente e, in quei periodi di crisi, è consigliabile tenersi appartati, parlare il meno possibile e soprattutto non lasciarsi andare a sfoghi rancorosi contro l’altra parte, sfoghi che tutti, naturalmente, son pronti ad accogliere avidamente e con apparente simpatia, per poi trarne conclusioni raramente benevole. In caso di separazione, dovrebbe essere il marito a lasciare il domicilio coniugale. La moglie si deciderà a questo passo soltanto se la situazione sarà diventata insostenibile per lei: andrà ad abitare, almeno provvisoriamente, in casa dei genitori... iustamente persuasa che da una vacanza estiva possa fiorire l’agognato fidanzamento della figlia, la madre previdente prima di decidere la villeggiatura sottopone la sua ragazza a un lucido, spassionato esame. Ha le gambe stortine? Alta un metro e sessanta pesa ottanta chili? Montagna e gonne a campana. Ha le gambe affusolate e un busto da statua? Spiaggia e bikini. Ma anche su questo punto la madre accorta ha idee precise. Il reggiseno del “due pezzi” non avrà le proporzioni di un paio di occhiali da sole, e le mutandine non saranno così piccole da potersi confondere con quelle di un neonato. La signorina protesta? Le verrà ricordato che l’immodestia, se attrae i mosconi, mette in fuga i partiti seri. Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 APPARECCHIATURA Ci sono due tipi di apparecchiatura: alla latina e all’americana . La prima comporta la tovaglia grande, la seconda centrini di tessuto... Nel pranzo normale posate e piatti si dispongono così: 1) tovagliolo 2) forchetta da 2ª pietanza (normale) 3) piatto normale, sul quale verrà appoggiato il piatto fondo da minestra già pieno prima che ci si metta a tavola 4) coltello da 2ª pietanza (normale) 5) cucchiaio da minestra 6) piattino per il pane 7) posate da dolce. Quelle da frutta verranno servite sul piattino da frutta 8) bicchiere acqua 9) bicchiere vino MOBILE BAR La signora bene attrezzata avrà sempre a disposizione nel mobiletto bar: Una bottiglia di Carpano Una bottiglia di Campari Una bottiglia di Martini (secco) Una bottiglia di anisette Una bottiglia di cognac Una bottiglia di gin Una bottiglia di whisky Una bottiglia di rabarbaro per chi non beve alcoolici (da servirsi allungato con un po’ di spremuta di limone, ghiacciata) Potrà anche avere in soprappiù: Una bottiglia di sherry (jerez), da servirsi in sostituzione del Carpano e Campari Una bottiglia di menta (pippermint) Avrà anche una scorta di biscottini da cocktail e di mandorle salate COCKTAIL Inviti a cocktail di tono formale Erano gli anni Cinquanta, vigilia del boom, quando si passò bruscamente dal colletto di lapin alla mantellina di visone, dal filobus all’utilitaria, dalla pensioncina alla crociera mediterranea E nuovi dilemmi attanagliavano i ceti sociali emergenti L’Italia vorrei ma non posso svelata da Colette Rosselli LAURA LAURENZI Q uantoc’è, quanto c’era di Colette Rosselli in Donna Letizia? Amava ripetere: «Donna Letizia è una maschera che mi sono messa per anni, ma che non mi appartiene neppure tanto». Spiegava: «Io sono tutt’altro che perfetta, sono distratta, pressappochista, scendo sulla terra soltanto quando c’è qualcosa che davvero mi colpisce». L’espressione non poteva essere più azzeccata: «sulla terra». Colette era così chic, così ironica e colta che sembrava arrivata da un altro pianeta. Svagata ma neanche tanto. Sempre presente a se stessa, informata, lieve. Inarrivabile, assai poco latina. Padrona di una dote rarissima, oltre al senso dell’umorismo: l’autocontrollo, la supremazia sulle emozioni. Sorrideva realizzando che era toccato a lei insegnare agli italiani a «saper vivere». Erano gli anni Cinquanta, quelli del boom, dell’improvviso benessere, quando si passò bruscamente dal colletto di lapin alla mantellina di visone, come amava ripetere lei, dal filobus all’utilitaria, dal tinello finto-provenzale al salotto finto-inglese, dal Ferragosto in pensioncina alla crociera mediterranea, e nuovi dilemmi attanagliavano i ceti emergenti. Non semplici quesiti di etichetta ma modelli di comportamento, scelte di eleganza d’animo, codici dello stare insieme civilmente, con rispetto reciproco. Come apparecchiare il tè, come rivolgersi a un arcivescovo o a un principe ereditario, come utilizzare le forchette da ostriche, ma anche come lenire la solitudine, come capire e come crescere i propri figli, come non fare scorrettezze e offese gratuite. Non solo i «guanti galcés di antilope finissima» o le mezzelune da insalata, ma anche il rapporto con la suocera, le gaffes da evitare con scrupolo, i passi falsi che ti possono azzoppare. Cominciò a dispensare quei consigli di stile che un giorno sarebbero confluiti — rielaborati — nel Saper vivere nel lontano 1953, prima su Grazia e più tardi su Gente. Riceveva centinaia di lettere alla settimana: quesiti di galateo ma spesso anche problemi umani. Non soltanto da donne, ma anche da uomini (le arrivarono pure varie proposte di matrimonio, con tanto di foto del candidato, il che la divertiva moltissimo). Insegnare a saper vivere: un’impresa. «Per tutti ho cercato di trovare la parola giusta, e a molti piaceva proprio quel mio cocktail di humour e serietà, quella mia ironia talvolta pungente ma molto più spesso benevola, di fioretto e mai di spada, così diversa dall’amaro sarcasmo degli italiani», mi raccontò molti anni dopo, seduta nel suo salotto affacciato su Piazza Navona, nella casa che divideva col marito Indro Montanelli, quando — era l’ottobre dell’84 — decise che Donna Letizia non esisteva più. Basta. Un’epoca era finita per sempre. Ero andata a intervistarla per La Repubblica. Fu allora, accarezzando il magnifico e scontroso gatto persiano Bel Ami, che mi raccontò come nacque quel suo pseudonimo così fortunato: «In quel periodo sulla Settimana Incom Irene Brin teneva una rubrica di bon ton molto sofisticata, dai timbri letterari, estremamente raffinati, un po’ proustiani, firmata Contessa Clara. Arnoldo Mondadori mi propose di scrivere qualcosa del genere, ma in cui si insegnassero veramente le buone maniere. Era l’epoca dei noms de plume blasonati e raggelanti, provinciali e tutti fasulli, Duchessa di Bedford, Lady Troubridge. Mondadori voleva darmi un nome del tipo marchesa non so come; io dissi che di titoli nobiliari non volevo saperne». Nacque così Donna Letizia e nacquero i primi fondamenti del Saper vivere. Uscì come manuale, ed ebbe immenso successo, nel 1960, con illustrazioni — spiritosissime — dell’autrice, che sapeva disegnare con lo stesso garbo intuitivo, lo stesso brio e lo stesso stile con cui scriveva, e aveva pubblicato suoi schizzi su riviste estremamente raffinate come Vogue, Harper’s Bazaar, New Yorker. In Italia basta andarsi a guardare con quale grazia e con quale ironia illustrò Il Diario della signorina Snob scritto da Franca Valeri. Insegnava l’elegante signora a scrivere correttamente i segnaposti e a «non arricciare il mignolo a coda di volpino», ad aborrire stuzzicadenti e calzini corti e a dare le giuste precedenze davanti a una porta girevole. Citava Montesquieu e l’Inno alla pazienzadi Kipling, il barone de Rothschild e Edoardo VII. Inventava prototipi come la signora Casachiesa e la signora Semprelesta, suggeriva un rimedio per ogni occasione, una formula magica per trarsi d’impaccio, una soluzione brillante per cadere miracolosamente in piedi. Invocava il buon gusto ancora prima del buon senso, sconsigliava alle signore di essere frivole, insegnava l’arte difficilissima della conversazione. E aveva ritmo. L’Italia che ne esce, guardata oggi attraverso la lente d’ingrandimento della nostalgia, è remota e idillica insieme. Un mondo sparito quello in cui si muoveva la Grande Signora, divisa fra crociere in transatlantico, viaggi in wagon-lit, hostess di volo «affabili e premurose», colazioni cui era impensabile presentarsi senza cappello. Quanti cambiamenti, e in quanto poco tempo. Era l’Italia pre-divorzio in cui alle ragazze veniva chiesta la «prova d’amore» e in cui il costume a due pezzi, decretava Donna Letizia, era «sconsigliabile sopra i trent’anni, anche se magrissime». Inevitabile che il Saper viverepossa oggi per certi versi risultare datato, ma non certo nell’eleganza che lo sottende, e nei valori fondanti che lo contraddistinguono dalla prima pagina all’ultima. La stessa Colette — che Federico Fellini, affettuosamente, chiamava Colettona, e cui, proprio negli anni ruggenti di quella fortunata rubrica, voleva affidare una parte ne La dolce vita — si poneva il problema, a ogni fortunata ristampa. Aggiornarlo? Modificarlo? Lasciarlo così com’è? Riscriverlo da capo a fondo? Tutto è cambiato così velocemente, diceva, si è come capovolto: «In trent’anni mi sono passati davanti agli occhi vari periodi storici». Raccontava di aver risposto alla ragazza disperata per aver perduto la verginità e a quella, vent’anni più tardi, ancora più disperata, addirittura in lacrime, ma per il motivo opposto, che le scriveva: come faccio? sono ancora vergine. Sì, tutto è cambiato. Tranne una cosa, ripeteva Colette: la solitudine di fondo, l’ansia, l’angoscia, il senso di incertezza, la paura di sbagliare. E quando sono in troppi a voler dare lezioni, meglio fare un passo indietro. Nel 1984, proprio nella stagione in cui le librerie furono sommerse e inflazionate da nuovi manuali di buone maniere, Colette Rosselli, che su Gentevide ridimensionare gli spazi della sua rubrica a favore di una pagina fissa di lettere affidata a Raffaella Carrà, scelse di abbandonare la sua trincea. Donna Letizia è morta e sepolta, ripeteva, non esiste più. E invece è vivissima, e ci ha raccontato giorno dopo giorno come eravamo e soprattutto come avremmo voluto, o dovuto, essere, come siamo cambiati e come si è evoluto, o involuto, il nostro Paese. IN LIBRERIA Torna in libreria il 12 settembre nella collana BurSaggi Il saper vivere di Donna Letizia (280 pagine, 8,60 euro) Il libro che ha formato generazioni di italiani alle norme della buona educazione uscì la prima volta nel 1953. Oggi Bur ripropone il volume in un’edizione arricchita dai disegni originali dell’autrice In queste pagine pubblichiamo alcuni brani e alcuni disegni di Colette Rosselli tratti dal volume Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 Va in libreria per Mondadori un insolito dizionario che raccoglie e traduce venticinquemila voci dei nuovi gerghi americani. Un’opera di consultazione ma anche una lettura curiosa che ci guida nel mosaico dei gruppi - etnici, professionali, generazionali - che formano l’impasto degli States. E che racconta, malgrado lo scandalo dei puristi, la furiosa vitalità di una società e di una cultura ALKY ANGST Alcolizzato nel gergo dei vagabondi È storico alky-cooking, la distillazione clandestina durante il proibizionismo Stato di inquietudine esistenziale che spesso sfocia nella depressione In voga tra i membri della Generation X DOGGONE America Maledetto, dannato Ma usato avverbialmente significa “con i cazzi”, nel senso di moltissimo Lo slang della nuova I cacciatori delle parole ribelli VITTORIO ZUCCONI S WASHINGTON ua Altezza Reale era inquieta. Due secoli e mezzo dopo avere perduto un continente per mano di un gruppo di contadini evasori armati di schioppi e forconi, un’altra perdita catastrofica si annunciava per la Corte di San Giacomo. Questi maledetti americani, intonò Sua Altezza Reale principe Carlo d’Inghilterra in conferenza stampa, «si sono messi a inventare ogni sorta di parole nuove e di verbi che non dovrebbero esistere» lamentò e poi lanciò il grido di battaglia: «Dobbiamo agire subito per salvare l’inglese inglese, non quella cosa che parlano in America». Hey, Prince, ‘a principe, gli rispose a stretto giro da Los Angeles l’attore comico Bill Maher: «Ma vai a farti fottere tu e il cavallo che ti ci ha portato», espressione non soltanto rudemente texana, ma, peggio ancora, figlia di quell’orrore che la povera altezza, e il suo cavallo, aborrivano: dello slang. Un miliardo di esseri umani usano oggi per comunicare tra loro qualche forma o metamorfosi della lingua che genericamente chiamiamo inglese, ma che re Giacomo, traduttore della Bibbia nel 1611, faticherebbe a riconoscere come il Queen’s English, l’inglese inglese. Dalle frasette rudimentali e buffe dei principianti, come quelle usate da Silvio Berlusconi nei memorabili incontri con Bush e immortalate negli archivi di You Tube, al pidgin english, i dialetti incomprensibili parlati nel Caribe, per arrivare al glossario da catecumeni impiegato dai fedeli di Internet e dei messaggini, la frantumazione dell’inglese e la sua reinvenzione quotidiana sono semplicemente la conferma del dominio planetario della cultura e delle sottoculture che esso rappresenta. Ma dopo essere sfuggito al controllo di troni e virtù. Ma non è di Berlusconi o del dialetto giamaicano che Sua Altezza Reale s’inquieta. L’oggetto della sue preoccupazione è quella fucina meravigliosa e per lui satanica di espressioni, verbi, forme, sintassi, grammatica che l’America alimenta da quando nacque, partorita dalla mescolanza furiosa di popoli e dal comune desiderio di ribellarsi al proprio passato e dunque alle lingue che il potere impiegava per controllarli. Ogni popolo, ogni gruppo sociale, ha sempre creato una propria lingua privata, un argot, un lingo, un patois, un vocabolario informale, furbesco e spesso criminoso (la madama per la polizia, nel gergo della mala milanese) per costruire la propria identità. Ma in nessuna epoca o luogo, la produzione di derivati linguistici è stata cosi furiosa, ingorda e strutturale come negli Stati Uniti. Si può dire che non esista gruppo — dai brothers, dagli afro americani che vivono nell’hood, abbreviazione obbligatoria di neighborhood, quartiere, vicinato, agli yuppies oggi trasformati in metrosexual che ruotano attorno alla street, che non è la strada felliniana, ma Wall Street — che non abbia inventato un proprio glossario e che non ne inventi uno ogni giorno. William Cran, autore di una meravigliosa Storia del- l’Inglese trasmessa dalla televisione pubblica americana, ha calcolato che alla fine di ogni puntata di due ore, almeno dieci parole nuove sarebbero state nel frattempo inventate da qualcuno, in qualche college, o liceo, o ghetto, o stadio, o taverna. Una osservazione che rende ogni tentativo di produrre un dizionario dello slang un’impresa tanto encomiabile quanto frustrante. Lo Ncid, il centro nazionale per le ricerche sulla tossicodipendenza, calcola, con ogni approssimazione, che esistano almeno 180 sinonimi di gergo per definire la cocaina, e 270 per la marijuana, dalla Santa Marta usata dagli ispanici che esprimono la loro profonda devozione cattolica, fino all’ormai universale grass, erba. Soltanto il sesso tenta di competere con la droga come fucina di neologismi che, senza il bisogno di passare per i tribunali, entrano nell’alveo del linguaggio corrente e accettato, come screw, avvitare, dove il senso figurato è evidente, o lo snafu, parola che nessuno studente di inglese potrebbe mai adoperare in classe, ma che è l’acronimo, diffusissimo tra i militari, in pace e in guerra: situazione normale, siamo tutti fottuti. Forme e formule che indignarono il sociolinguista Kenneth Wilson: «La nuova lingua sembra costruita usando verbi e sostantivi ripresi dai muri dei gabinetti». Ma di principini e di studiosi l’America, che non ha un sistema educativo centralizzato e affida programmi e insegnamenti all’autonomia degli stati e delle contee, si disinteressa. L’ameringlish, l’amerese o l’inglano, parlato nella vita quotidiana, che nessuno studente straniero, per quanto diligente, potrà mai imparare in un corso a Milano o a Delhi, è stato paragonato al grande fiume padre e madre del continente nordamericano, il Mississippi, che trascina con sé detriti, terriccio, carogne, fortune e nutre e travolge tutto ciò che gli si oppone. Sulle acque della istintiva riottosità alle regole e all’autorità, la nuova lingua dell’informale, del permissivo, spesso del trasgressivo, corre come quei battelli a pale che portavano anch’essi il proprio carico linguistico e idiomatico, nei gilet dei riverboat gamblers, dei giocatori d’azzardo, e di espressioni come «la mano del morto», la doppia coppia di assi e otto che Wild Bill Hickok stringeva fra le dita quando fu ammazzato. La schizzinosa e celebre osservazione di George Bernand Shaw, secondo il quale «Inghilterra e America sono due popoli divisi soltanto dalla lingua» è sempre meno vera, nelle onde di ritorno che portano anche in Inghilterra il riflusso dell’americanizzazione dell’inglese attraverso il cinema, la televisione, la musica e la pubblicità. Lo slang delle ragazzine bene della California, le Valley Girls cresciute nella grande vallata oltre le colline di Hollywood, raggiunge le loro coetanee della vecchia costa atlantica, le ragazze inglesi, e diventa il glossario di una generazione di donne, che se lo porteranno dietro da adulte e lo trasmetteranno ai figli, interpuntando ogni discorso con l’avverbio totally, totalmente, che infilano ovunque: sono totalmente stanca, quello è totalmente carino, mi sono totalmente divertita. Squittendo continuamente ohmygod, ohmygod, omioddio omioddio. Ma appena una studentessa universitaria scopre che qualche espressione viene adottata nei licei, la abbandonerà con ribrezzo, come abiti usati passati alle sorelle minori. Il moto linguistico deve sempre riciclarsi senza sosta, per sembrare accettabile. E se arriva da ambienti guardati con sospetto o paura, magari dalle strade dei ghetti, dove i giovani di colore producono incessantemente neologismi e sintassi immaginarie e spaventosamente sessiste e politically incorrect, quanto più forte sarà lo scandalo degli adulti, tanto più certo il successo. Il bello, l’interessante, il desiderabile diventa phat, che si pronuncia come fat, grasso, ma tradisce le iniziali di pretty hips, ass and tits, belle cosce, tette e sedere. Il fatto amaro che anche lo slang tradisca la stessa prepotenza e violenza, in questo caso dei maschi sulle femmine, che vorrebbe sfidare nell’inglese ufficiale, sfugge ai creatori dei neologismi. Come la country music, che è la musica del sud, e il jazz, così oggi rap e hip hop neri hanno influenzato e penetrato il vocabolario di tutti i giorni. Così ampio e complesso è ormai il vocabolario dell’America nera, che molti vorrebbe- Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 IL LIBRO Il Dizionario global italiano - slang americano (Mondadori, 608 pagine, 16,90 euro) presenta i termini di slang in uso oggi nella lingua americana, segnalandone gli ambiti di pertinenza: dall’informatica al rap, dalla politica allo sport, al sesso, al turpiloquio, eccetera. È il risultato di un lungo lavoro di linguisti madrelingua e di esperti italiani di gergo, guidati dagli anglisti Roberto Cagliero e Chiara Spallino ORANGES Le arance della traduzione letterale si trasformano in metafora nelle pasticche di Lsd REDNECK Letteralmente “collo rosso” È un termine spregiativo che sta per bifolco, reazionario, razzista MICKEY Termine gergale per definire una bevanda alcolica drogata con un sedativo Amico, compare Ma anche sbirro, poliziotto Oppure: soldi, grana; buco, pera, l’alcol denaturato bevuto dai barboni BARF Vomitare ma anche non funzionare, non capire, andare in tilt, detto di un computer che non esegue l’ordine ro codificarlo e insegnarlo in una lingua nuova e autonoma, l’Ebonics, da “ebano”, nero, e “phonics”, fonetica. Le forze armate, nella loro perenne fretta, sono fabbriche instancabili di slang e di acronimi. Dal tragico fraggin’, prodotto in Vietnam quando i soldati uccidevano gli ufficiali troppo cretini o troppo aggressivi con una bomba a mano a frammentazione lanciata fra le loro gambe, ai klicks, abbreviazione di kilometer, sostantivo troppo lungo, i militari vivono di Dod, Nco, Tlam, Aamram, Psyop, Bdg, Lams, e almeno altri millecinquecento acronimi in un universo linguistico tutto loro, che spesso finisce in un gigantesco Fubar come il Vietnam o l’Iraq: Fottuto oltre ogni possibile riconoscimento. Ed è inutile inseguire e spiegare la genesi dei significati, le altalene del gergo, che può fiorire o tornare nell’oscurità dell’archeologia linguistica, morendo con le generazioni che l’avevano partorito. Per l’America che sbarcò in Normandia, una cosa buona era swell, espressione che oggi nessun giovane si farebbe cogliere a usare. Per i loro figli, era groovy, scomparsa con gli hippies, grandi fabbri di glossari. Per i loro nipo- ti ciò che va bene, che piace è cool, fresco, ma può anche essere l’opposto, cioè hot, bollente, arrivando a generare frasi apparentemente insensate, ma comprensibilissime per chi le usa, come «quel ragazzo è fresco, perché è bollente». Sono parole di «resistenza», come le definiva uno dei massimi poeti americani, Walt Whitman, sono la letteratura informale di un popolo che parla a se stesso. La proposta di creare un’Accademia nazionale della lingua, sul modello di quella francese che insegue ogni giorno con la bombola del ddt gli insetti dei neologismi stranieri, è sempre rimasta lettera morta, respinta come una possibile monarchia linguistica. Nella repubblica popolare del linguaggio, per ogni falla tappata dai difensori del linguisticamente corretto, un’altra se ne apre. Irrompe l’onda di internet, con la sua minestra primordiale di Lol, iniziali di «lots of laughs», mi fai ridere, di Blog. E puntualmente, un nome proprio diventa un verbo, come Google, il famoso motore di ricerca: ho googled quell’uomo politico e ho scoperto che mente, I google, you google. Può un insegnante, un accademico, arginare queste maree, respingere questi sciami? No, non lo deve fare, pensa Jaesse Sheidlower, il direttore dell’edizione americana dell’Oxford English Dictionary, un linguista di origine ebraica, nato e cresciuto in uno dei più ribollenti calderoni etnici e linguistici d’America, Brooklyn. Sheidlower religiosamente compulsa le riviste più sordide, ascolta la musica più estrema, cataloga ogni espressione sconosciuta che affiori nel web, la rete, osservando se essa ce la faccia, come la proverbiale ameba, a uscire dal brodo e camminare verso i media, le tv, i quotidiani, i periodici più conosciuti. «Se la gente la usa, chi sono io per respingerla?», si chiede questo rispettatissimo studioso che scrisse il saggio definitivo su una sola parola: fuck. Scopare. Dunque lo slang, essa stessa parola dall’etimologia oscura, non è la morte della lingua, ma il suo metabolismo. È l’America. «Una lingua appartiene a chi la parla, alle moltitudini ignoranti come alle élite ben istruite», diceva Mark Twain che nel suo Huckleberry Finn aveva ampiamente saccheggiato i tesori dello slang. È un segnale di ribellione dei sudditi, e per questo spaventa il principe. Povero principe. E povero anche il cavallo. Repubblica Nazionale ILLUSTRAZIONE DI SAUL STEINBERG JACK 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 “Il sesso è più eccitante sullo schermo che tra le lenzuola”. Sulla scia di quel che diceva Andy Warhol, “Erotico”, l’ultimo dei dizionari del cinema Electa-Accademia dell’Immagine, ci guida nella foresta dell’emozione amorosa per fotogrammi e nell’esplorazione di quel confine malcerto tra eros e luci rosse che nessuna regola potrà mai fissare PEDRO ALMODOVAR MAE WEST TINTO BRASS EDWIGE FENECH Leader dell’ascesa del nuovo cinema spagnolo, è il regista che ha una visione più libertaria dell’erotismo Attrice dalla spiccata verve provocatoria, negli anni Trenta fu accusata di corrompere con i suoi film la gioventù americana È l’esponente per antonomasia dei film erotici all’italiana. Esecrato dai critici, ha lanciato una serie di star e starlette Icona della commedia sexy italiana degli anni Settanta, la bella attrice si è trasformata ora in produttrice Cinema Erotico BRIGITTE BARDOT RUSS MEYER PIER PAOLO PASOLINI RODOLFO VALENTINO L’attrice, che ha esordito sul grande schermo a quindici anni, è stata uno dei sex symbol degli anni Cinquanta Il regista americano scomparso tre anni fa inventò quel genere di film che hanno per protagoniste vamp dagli enormi seni Sul grande schermo lo scrittore raccontò il sesso più problematico e tormentoso. Feroci le stroncature Morto a trentuno anni, ebbe il tempo di diventare un mito del cinema muto, adorato dalle donne di tutto il mondo CONCITA DE GREGORIO iceva un grande maestro di tango, a Buenos Aires, durante una lezione collettiva a ballerini provetti arrivati da tutto il mondo ad ascoltarlo: «Immaginate di essere in un film: quando passate da una scena di tango a una di sesso lo spettatore deve avvertire un netto calo di tensione erotica». Era un uomo piccolo di statura e sovrappeso, un uomo brutto a vederlo seduto al tavolino di un bar. Diventava irresistibile nel ballo, desiderabile e magnetico come la nostalgia. Fermava il passo e diceva con improvvisa freddezza quella faccenda del tango e del sesso come fosse una semplice notazione tecnica. In effetti lo è. La parola chiave è tensione. Questo il segreto dell’erotismo e della danza. Mostrateci, ballerini, il luogo verso il quale siete incamminati senza farcelo vedere mai. Lasciatecelo indovinare, che ciascuno degli spettatori possa immaginarne l’esito secondo il suo privato e segreto desiderio: che sia un rifiuto, persino, se questo è ciò che appaga il bisogno di chi guarda. Uno schiaffo, uno sgarbo oppure un bacio e solo quello, una carezza e niente più. Un congedo di sguardi o una fusione liquida di corpi, certo, ma qui, quando si arriva, il tempo del cammino è già finito. Il dopo è il meno. Il dopo è la fine del viaggio la cui bellezza — come in quel tango — è solo una promessa. Tensione verso, desiderio di. Itaca, diceva il poeta, non è la meta: è il cammino per raggiungerla. L’erotismo, scrivono i dizionari, si distingue dalla pornografia per la «presenza di un vissuto emotivo»: l’attesa, si potrebbe anche dire. Il crescendo del preludio, l’intelligenza dei sensi che si attiva e si mette in moto verso un orizzonte. In Erotico di Valerio Caprara, l’ultimo dei dizionari del cinema Electa-Accademia dell’Immagine, Lezioni di tango non c’è, per la fortuna di quelli che lo considerano un patrimonio emotivo privato. Non c’è il bacio di Notorius né Grace Kelly che poggia le labbra sulle mani di Cary Grant in Caccia al ladro («lei sa bene che questa collana è un’imitazione», «sì, ma io non lo sono»), non c’è lei che si spoglia ne La finestra sul cortile né niente di Hitchcock, di nuovo e con sollievo per fortuna. Un’antologia del cinema erotico è in realtà un’impresa impossibile perché niente è più privato, imprevedibile e individuale del desiderio. Cosa lo scateni, in memoria di cos’altro, perché. Chiedete a trenta persone, a quaranta: la scena erotica per te più conturbante. Non otterrete due ri- D La parola-chiave è “tensione” Mostrateci, registi e attori, il luogo verso cui siete incamminati senza farcelo vedere mai... sposte uguali. Estratti dal mio campione: la carezza di Harvey Keitel sulla nuca della pianista in Lezioni di piano. La partita a scacchi fra Steve Mc Queen e Faye Dunaway nel Caso Thomas Crown. Candice Bergen che si cambia tenendo un telo tra i denti nel Vento e il leone. La signora della porta accanto, tutto. Di Eyes Wide Shut solo la scena in cui lei, in mutande, discute in camera con lui. Di Ultimo Tango non quella riprodotta all’infinito, no: l’altra invece, quando lui la lava nella vasca. Fra i più giovani: Clooney e Lopez chiusi nel bagagliaio della macchina in Out of sight. Scarlett Johansson che cammina tra la folla in Lost in Translation e lui che scende dal taxi per dirle qualcosa all’orecchio, sfiorandola alle spalle. Cosa le dice, potete indovinarlo? È già un altro gioco, però: un altro desiderio. Y tu mamà tambien, la scena in cui ballano in tre, due ragazzi e una donna, è lì che Garcia Bernàl diventa l’uomo (l’idea di uomo) con cui andresti in vacanza anche in Islanda e senza parlare la sua lingua. Atame, dove Antonio Banderas poco più che ragazzino la lega perché lui sa che lei non sa quel che lui invece sa perciò è costretto a costringerla, come sarebbe bello e desiderabile e quasi sempre impossibile fare negli incontri della vita. It takes two for tango, dicono gli americani per tornare al principio, il tango: bisogna essere in due per dare forma al desiderio e se uno manca all’appello, se non riesce non vuole non può, non c’è ballo possibile. Almodovar, che dell’erotismo è un moderno genio poetico e dissacratore, ha fatto diventare un’icona sexy una donna in coma e bisogna immaginarsi la scena di un regista qualunque che va dal produttore e gli dice: dunque, io avrei un soggetto, lei è in coma tutto il tempo e c’è un infermiere vecchiotto basso e un po’ scemo che l’accudisce. Era Almodovar, solo per questo gliel’hanno fatto fare. Non c’è scena erotica più divertente della gara di virilità in cui i candidati espongono, in piedi e al buio di un cortile notturno, le proprie qualità. Al pubblico votante il banditore munito di centimetro annuncia cifre iperboliche: 82, applauso; 90, boato; 94, ovazione. È Almodovar il primo a dirlo in chiaro: lunghezza per circonferenza, è un prodotto la chiave della felicità. Non serve il righello, ci vuole un metro a nastro. Marlene Dietrich diceva con opportuna schietta sintesi che «solo i froci sanno come si fa a far sembrare una donna sexy» ed in effetti Penelope Cruz se la incontri per strada dopo averla vista in Volver non ti capaciti che sia la stessa e non è per via del sedere imbottito che le ha messo il regista in omaggio alla Loren, no. È come canta, è FOTO HELMUT NEWTON/TDR Il desiderio ai tempi della cinepresa Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 Il nuovo dizionario capolavori LOLITA (1962) Tratto dal romanzo di Vladimir Nabokov e diretto da Stanley Kubrick, il film gioca sui flashback di Humber Humbert, pazzamente attratto dall’eros di Lolita, figlia adolescente della sua compagna Il regista si ispira liberamente all’ultimo capitolo del libro BELLA DI GIORNO (1967) Primo film a colori di Buñuel. Catherine Deneuve-Séverine, moglie insoddisfatta di un medico, si prostituisce tutti i pomeriggi in un bordello parigino dando così sfogo ai suoi desideri più intimi e perversi Ma poi un cliente s’innamora di lei ULTIMO TANGO A PARIGI (1972) Firmato da Bernardo Bertolucci e interpretato da Marlon Brando e Maria Schneider, il film racconta di Paul e Jeanne, due sconosciuti che si abbandonano ad un’intensa attività erotica. Contestata per anni la scena in cui i protagonisti hanno un rapporto anale IL PORTIERE DI NOTTE (1974) Diretto da Liliana Cavani, il film ha imposto l’icona Charlotte Rampling nei panni di Lucia, a torso nudo coperta solo dall’ornamento feticistico delle esili bretelle, mentre balla per gli ex ufficiali nazisti con cui aveva avuto rapporti sadomasochisti nei lager L’IMPERO DEI SENSI (1976) Scritto e diretto da Nagisa Oshima, il film è centrato sulla relazione sessuale tra il ricco Kichizo e Sada, sua cameriera ed ex geisha I loro rapporti diventano sempre più estremi fino a che Sada strangolerà l’uomo per renderne più potente l’erezione SU REPUBBLICA.IT Quattro audiogallery a cura di Repubblica.it, Repubblica tv e La Domenica di Repubblica realizzate da Matteo Pucciarelli e Valentina Clemente Ottanta titoli nell’hit parade AMBRA SOMASCHINI on esiste una distinzione certa tra erotismo e pornografia. Il cinema materializza i fantasmi e la abolisce, la cancella, la smonta. Esiste una linea di confine fragile, sottile, che si insinua tra erotico e pornografico senza seguire criteri morali, illuminata dal talento del regista e degli attori quando sanno suscitare emozioni nello spettatore. Erotico (di Valerio Caprara, Electa/Accademia dell’Immagine, 352 pagine, 20 euro, in libreria da martedì 11 settembre) fa coincidere la nascita dell’eros filmico con la nascita del cinema. Costruito su nove parole chiave (trasgressione, letteratura, censura...), trenta protagonisti (Monroe, Valentino, Madonna, Truffaut...), ottanta film e dieci capolavori, il dizionario va avanti per immagini, divide, seleziona, racconta un genere trasversale che percorre gli altri generi: Duello al sole, western-eros; Pulp Fiction, noir-erotico; Hiroshima mon amour, politico-erotico... Una cascata di sequenze centrate su sguardi magnetici, silenzi, corpi avvinghiati che hanno fatto sognare l’erotismo anche a chi non l’ha mai conosciuto. L’hit parade della cinepresa erotica va da Lulù di Pabst, la frangia perfetta e perversa di Louise Brooks, a Lolita di Kubrick tratto da Nabokov, da Bella di giorno di Buñuel a Ultimo tango a Parigi, fino a L’impero dei sensi, senza escludere Gilda, i guanti di raso e Rita Hayworth dark-lady. Ogni film condensato in ventiquattro fotogrammi, emozioni in bianco e nero che riportano indietro, lontano, a un elenco essenziale: Un tram che si chiama desiderio, Jules et Jim, Brivido caldo, il più recente In the Mood for Love in cui non succede nulla e proprio per questo l’eros sale. Vorremmo rivederli tutti, uno dopo l’altro, vorremmo restare inchiodati in poltrona come si faceva nei Settanta quando si andava ancora al cinema, non si vedevano i cult in dvd, cenando, leggendo, dormendo comunque facendo altro. Caprara, professore di Storia e critica del cinema all’Università Orientale di Napoli, nell’elenco ha infilato Gola Profonda. «Il cinema — spiega — colma il fossato tra immaginazione e rappresentazione e questo film è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. Per selezionare i titoli — aggiunge — mi sono ispirato a L’érotisme du cinéma del ‘58, ho assistito a visioni infinite, ho fatto confronti multipli e incrociati, sono stato tormentato da incertezze e dubbi spossanti. Alcuni film trascendono le divergenze suscitate negli spettatori per motivi religiosi o morali e, di fronte alla rappresentazione erotica, più o meno metaforica o esplicita secondo l’evoluzione del costume, premiano soltanto le sensazioni del pubblico». Perché, scrive Andy Warhol, «Il sesso è più eccitante sullo schermo e tra le pagine che tra le lenzuola». N come lava i piatti. Di straordinario il dizionario di Valerio Caprara, che pure ha fatto un lavoro notevolissimo tra gli infiniti possibili, c’è la selezione delle immagini. La quasi totalità degli umani, per quanto amanti del cinema, non è in grado di ricordare come si chiamasse l’episodio di Wong Kar-wai nel film collettivo Eros e di che anno fosse ma se vede l’immagine di lei spalle al muro e occhi bassi con quel vestito pazzesco e la schiena di lui che le si fa addosso e la stringe alla parete si ricorda, o crede di ricordare, che è lo stesso. Gli abiti accollatissimi e disegnati sul corpo perfetto di Maggie Cheung nell’amore mai consumato di In the mood for love sono meno, più o altrettanto erotici delle bretelle di Charlotte Rampling, anoressica quando non si usava, nel Portiere di notte? Un film perché diventi patrimonio di tutti non è necessario averlo visto: il foulard stretto al collo di lui nell’Impero dei sensi, i corpi che rotolano in Zabrisky point, le mutande bianche di Richard Gere in American Gigolo, le calze di Laura Antonelli in Malizia, la corsa di lei con loro due dietro in Jules e Jim, i nudi carponi di Salò, gli occhiali e il lecca lecca di Lolita. La sottoveste di seta di Kim Basinger ma soprattutto Joe Cocker che canta You can leave your hat on, di quante autoradio predisposte all’uopo, negli anni Ottanta, è stata la colonna sonora? Sharon Stone che accavalla, certo, ma bisogna anche tenere conto dell’anagrafe. Se hai ottant’anni niente ti impressionerà più come il primo nudo di Clara Calamai. Se ne hai quaranta non puoi dimenticare Valery Kaprinsky che balla nuda nella Femme publiquedi Zulawsky né Maruska Detmers in Prenom Carmen di Godard, chissà che fine hanno fatto tutte e due, erano senza dubbio i più bei corpi degli anni Ottanta, seni piccoli pre-silicone e sederi naturalmente tondi, nudità sfacciata e prepotente. Se ne hai trenta sei venuto al mondo con Sesso bugie e videotapes, con le Età di Lulù di Bigas Luna (e avevi già letto il libro, ovvio, fonte di inesauribili piaceri privati e fantasie). Agli animi più torbidi piacque Tokyo decadence, alle minoranze rivendicative Tokyo-Ga. Da quando sono arrivati i giapponesi è stato tutto più violento e più esplicito, va detto: un’altra cultura. Noi eravamo quelli delle lenzuola sul terrazzo di Una giornata particolare. Eravamo quelli del vorrei ma non posso. Poi è arrivato Crash e abbiamo persino detto bravo. Sì, Johnny Depp in Chocolat è fantastico, Juliette Binoche è da portasela a casa ma diciamo la verità, anche a caro prezzo: come Marcello e Sofia non c’è stato più nessuno. Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 i sapori Il gorgonzola e i suoi “fratelli” si affinano, conquistano i palati Peccati di gola femminili e diventano, con la loro complessità piccantina, strumento di seduzione gastronomica. Assaggiarli è un’esperienza da gourmet Bleu di Moncenisio Murianengo Gorgonzola Castelmagno Ovinfort L’erborinato vaccino dell’alta Val di Susa si produce sui due versanti del passo del Moncenisio, tra Italia e Francia. Crosta sottile, pasta morbida, di colore paglierino con venature bluastre ben distinte, ha gusto deciso ma non piccante La toma di tre latti – bovino, ovino, caprino – figlia della necessità contadina negli alpeggi piemontesi, è preziosa. Dopo la stagionatura, subisce forature per facilitare l’ingresso delle muffe, rade ma intense. Ha gusto forte, burroso Viene realizzato in due tipologie: dolce e piccante. Secondo la ricetta originaria, quasi scomparsa, la cagliata del mattino si aggiunge a quella della sera prima, fatta sgrondare. Erborinatura naturale dai fori praticati con aghi di rame Due mungiture successive, latte vaccino (d’alpeggio) e stagionatura nelle grotte della zona per l’erborinato-culto inventato nel Medioevo dai contadini dell’Alto Cuneese. La pasta color avorio rigata di verde ha gusto d’erba Forma cilindrica e crosta grigiomarrone per lo squisito erborinato di pecora della provincia di Sassari Almeno due mesi di stagionatura perché la pasta, prima compatta, divenga morbida, cremosa, venata d’azzurro, dolce-piccante Formaggi Bleu Il piacere ruvido delle muffe nobili LICIA GRANELLO lauschimmelkäse, bleu cheese, fromage persillé, queso azul. Il formaggio colorato inquieta sempre un poco, anche se ha il giallo dello zafferano o il rosso dei peperoncini, aggiunti per regalare sapore a caci altrimenti troppo timidi. Ma il bleu è un’altra storia, perché le venature d’azzurro-verde che si irradiano nella fetta trionfalmente burrosa di gorgonzola e roquefort non danno scampo. Bastano un tozzo di pane, un grissino, perfino un magro gambo di sedano (a uso e consumo dei refrattari alle farine) per realizzare il boccone più goloso del pianeta, in via di assoluzione dopo tanto penare. Gli ex simboli della grassezza casearia, conclamati attentatori della colesterolemia, stanno uscendo dal ghetto. Smascherata la finta superiorità dei prodotti cosiddetti magri, che magri non sono — dai formaggini industriali a grana e parmigiano, capaci di assommare un buon dieci per cento di calorie in più! — i bleu hanno ritrovato il loro sacrosanto spazio sul carrello dei formaggi. Un mercato che i grandi marchi cercano di aprire anche all’universo femminile, tradizionalmente restio a gusti ruvidi ed eccessivi carichi calorici. Pubblicità mirate stanno facendo di gorgonzola e i suoi fratelli un elemento di seduzione gastronomica ad alto impatto erotico, senza distinzione di sesso. Il guaio è che la cremosità spinta oltraggia la complessità piccantina della ricetta originale. Chi li ha creati, molti secoli fa, infatti, non ha avuto dubbi, battezzandoli, da una parte all’altra delle Alpi, con il nome del prezzemolo (erborìn nel dialetto lombardo, persil in francese) per imprimere il legame indissolubile tra colore insolito e sapore voluttuosamente stuzzicante. Il “nonno” di erborinati e persillé, invece, si chiamava Stracchino Tondo, perché stracche, stanche, erano le mucche in transumanza dagli alpeggi alla pianura, con sosta nella campagna intorno a Gorgonzola. Difficile dire se all’inizio fu sapienza casearia o dimenticanza benedetta: il latte cagliato lasciato senza cura per una notte, aggiunto a quello fresco del mattino, unione precaria che lascia aperti minuscoli spazi invasi dalle spore. Il risultato comunque fu così buono e particolare che gli erborinati furono promossi a cibo di riguardo. Raccontano che Carlo Magno, invitato a pranzo da un prelato e redarguito per aver scartato le parti verdognole, dopo una degustazione integrale se ne invaghì a tal punto, da pretendere un’abbondante fornitura annuale. Figli di muffe nobili e pazienza contadina — la prima cagliata messa a sgrondare in attesa di essere unita alla seconda, la foratura con aghi di rame per incrementare l’erborinatura, la stagionatura accurata — i bleu più prestigiosi accettano malvolentieri le manipolazioni della gastronomia. Troppo facile e banale impreziosire bistecchine, uova, paste, risotti: lontani dalle ricette sontuose degli anni Settanta, quando in Francia (e in Italia per emulazione) imperversavano quiches e aragoste al roquefort, i nuovi chef sono orgogliosi di proporre ricercatissime produzioni super-artigianali, accompagnate semplicemente da un cucchiaino di miele e un bicchiere di passito (ma anche porto, rum e sherry non scherzano). Se i formaggi sono in cima alla vostra personale classifica gourmand, fate qualche giorno di penitenza culinaria e andate a godervi la summa della cultura casearia in quel di Bra, dove i bleu verranno celebrati lungo tutti i quattro giorni di “Cheese”. Se poi i piaceri forti non vi intimoriscono, portatevi appresso dell’eccellente fondente (settanta gli ettari di pascolo per cento) e quando vi sentirete pronti, presentain Italia tevi allo stand Guffanti. Lì troverete Carlo Fiori, deus ex machina degli affinatori italiani, che ha inventato un abbinamento da brividi: piccole scaglie di cioccolato con un super gorgonzola stagionato trecento giorni. Il mondo sarà mille volte blu. B 8 kg il peso di una forma di stilton 3,6 mln le forme di gorgonzola prodotte ogni anno 4,7 mln Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 Occasione perfetta la rassegna “Cheese” che celebra, a Bra tra pochi giorni, i preziosi erborinati( italiani ed esteri) frutto della summa di un’antica sapienza casearia Bleu di Termignon Cabrales Stilton Roquefort Fourme d’Ambert Figlio degli alpeggi savoiardi – e del borgo che lo battezza – è un raro persillé dalle muffe naturali come testimonia la pasta bianca e friabile, con screziature irregolari Stagiona almeno sei mesi Sapore di pascolo e nocciole Il queso azul, formaggio azzurro, è prodotto millenario da agricoltura montana delle Asturie. Stagionato in grotte arieggiate dai venti della Baia di Biscay,ha erborinatura naturale, profumo intenso, gusto forte, consistenza cremosa “The king of cheese”, come lo chiamano in Inghilterra, porta il nome della cittadina a nord di Londra dove venne gustato a partire dal 1700. Iscritto nella pdo (la nostra dop), è di latte vaccino Cremoso, sapore burroso-piccante Il magnifico cilindro persillé, celebrato da Plinio il Vecchio, è realizzato con latte di pecora nelle campagne dell’Aveyron Il disciplinare dell’aoc prevede l’affinamento di tre mesi nelle grotte di Roquefort-sur-Soulzon L’etimo (fourmage, fromage) e il paese identificano un’antica, golosa toma vaccina dell’Auvergne, protetta da aoc (la dop francese) dopo anni di comunione con la Fourme de Montbrison Erborinatura intensa e gusto dolce Aosta Taleggio (Bg) itinerari Guglielmo Locatelli è l’indomito casaro che ha resuscitato lo Strachitunt, antenato del gorgonzola degli alpeggi bergamaschi Ogni estate, accompagna le mucche dai 1300 ai 2000 metri. Erbe, fiori e tradizione per un formaggio strepitoso Montbrison (Francia) Non un paese, ma un ampio altipiano tra le gole del Brembo La tradizione casearia si esprime nei formai de mut (monte) tra cui gli stracchini, quadrati come il taleggio (Strachiquader) o tondi (Strachitunt) I formaggi valdostani – dalla Fontina d’alpeggio alla Toma di Gressoney – si sono arricchiti di un saporito erborinato vaccino, il Blue d’Aoste, primo premio alle Olimpiadi del formaggio di montagna 2005 Millenario borgo della Loira, fortificato dopo i saccheggi nella guerra dei cent’anni, ha dato i natali al direttore d’orchestra Pierre Boulez. Al suo nome è legata anche la produzione di un eccellente bleu DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE ALBERGO DELLA SALUTE (con cucina) Costa d’Olda di Taleggio Tel. 0345-47003 Doppia da 70 euro, colazione inclusa HOTEL MILLELUCI Località Porossan Roppoz 15 Tel. 0165-235278 Doppia da 120 euro, colazione inclusa MARYTEL 95 route de Lyon Tel. (0033) 04-77587200 Doppia da 95 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE LIBERTY (con camere) Via Arnoldi 53, Peghera di Taleggio Tel. 0345-47025 Chiuso in inverno (dicembre escluso) menù da 25 euro TRATTORIA DEGLI ARTISTI Via Maillet 5 Tel. 0165-40960 Chiuso domenica e lunedì menù da 30 euro LA ROSERAIE 61 Avenue Alsace Lorraine Tel. (0033)04-77581533 Chiuso domenica sera, martedì sera e mercoledì, menù da 20 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE ARRIGONI VAL TALEGGIO Via Provinciale 160, Peghera di Taleggio Tel. 0345-47059 CENTRALE LATIÈRE Frazione La Cure de Chevrot 11 Tel. 0165-251511 HERVÉ MONS FROMAGER AFFINEUR Le Pré Normand, Saint Haon le Chatel Tel. (0033) 04-77644079 Gli ostinati casari sentinelle del futuro CARLO PETRINI I formaggi erborinati sono il tema guida della nuova edizione di “Cheese” (in programma a Bra dal 21 al 24 settembre, informazioni su www.cheese.slowfood.it), la manifestazione nata dieci anni fa per promuovere le migliori produzioni casearie tradizionali del pianeta. Nella casa dei bleu sarà possibile degustare quaranta super latticini realizzati con latte di mucca, pecora, capra, bufala, in arrivo da Europa, Stati Uniti e Australia ‘‘ e si vivono tempi in cui si può arrivare a parlare di caseificazione eroica, forse più che sui casari sarebbe meglio riflettere sui tempi che si vivono e del perché chi fa certi formaggi arrivi ad assurgere addirittura allo status di eroe. Stare mesi in malga, vivere in zone montagnose lontane da quella che chiamiamo civiltà è già di per sé una scelta di vita difficile e coraggiosa. Produrre secondo metodi antichi, facendosi portatori di savoir faire che rischiano di scomparire per sempre, è poi un fatto che — per loro più o meno consapevolmente — rende questi personaggi unici e preziosi per la nostra cultura materiale. Essi spesso restano soli, gli unici, che creano dei prodotti incredibili, dalle caratteristiche organolettiche superiori e capaci di dare una gratificazione particolare a chi se ne nutre. In alcuni casi, come ad esempio per lo Strachitunt o il Murianengo, pochissimi casari, nell’isolamento dei loro alpeggi, hanno consentito un futuro a questi formaggi, li hanno tramandati alle nuove generazioni. In altri casi invece hanno lottato stoicamente contro le leggi iper igieniste e industriali che di fatto decretavano la fine dei loro prodotti. Ma questi casari sono eroi perché continuando a fare i loro formaggi di fatto salvano anche un territorio che altrimenti sarebbe abbandonato a se stesso, salvano il paesaggio montano e la sua biodiversità, danno l’esempio di produzioni ecologicamente sostenibili e rinvigoriscono le economie locali. Il valore del loro lavoro, svolto tra tante avversità, va ben al di là del piacere gastronomico assoluto che ci possono regalare assaggiando il loro formaggio. Si tratta di un valore culturale ed economico profondo, che supera quei crismi della modernità che l’hanno messo in secondo piano. È un valore da era post-moderna, in cui si mescolano sensibilità ecologica, tradizione, innovazione e qualità della vita. Per questo li possiamo chiamare eroi: con la semplice forza della loro identità hanno resistito a tempi avversi e si affacciano a un futuro che sicuramente li vedrà protagonisti. S Luciana Littizzetto Via la soia, niente fagioli azuki, basta col riso basmati. Gorgonzola Gorgonzola a pranzo e a cena Sì al bollito misto. Ok alle acciughe al verde. E la mattina appena svegli un bel bicchiere di bagna cauda. Fredda Da COL CAVOLO Mondadori ‘‘ Cheese Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 le tendenze Nuovi business Per decenni ha governato il paese più popoloso del mondo e il suo volto è quello più riprodotto di tutti i tempi Ma ora, nel passaggio dal socialismo al consumismo, quel volto è il volano di un commercio modaiolo che fa del Grande Timoniere, con la mostra “Mai dire Mao”, l’attrazione del prossimo “Mercanteinfiera” a Parma Icone Pop Dalla storia al modernariato così Mao è diventato merce RENATA PISU uperstar del post modern consumate, riprodotte in ogni tipo di gadget, miti rinverditi la cui icona è diventata il logo di un merchandising di tendenza che punta a riproporre personaggi di appena ieri come se venissero dal passato più remoto, fossero senza tempo. E invece è il nostro Tempo che avidamente fa di Elvis Presley, di Marilyn, di Che Guevara e di tante altre divinità minori dell’Empireo del Kitsch, le belle statuine di un presepe globale e ne inventa la leggenda per il mercato del modernariato, fratello minore dell’antiquariato ma non il fratello povero perché gioca su di una dimensione che all’antiquariato manca, la nostalgia. E adesso, dalla Cina dove già da qualche anno impazza la “Febbre di Mao”, arriva da noi anche Lui, l’ultima icona uscita dalla storia e entrata nel modernariato. Sì, proprio Lui, il Mao che domina sulla piazza di Tian An Men circonfuso da un’aura sacrale, il quale si è fatto merce insediandosi nei mille mercatini delle pulci della Cina dove consulenti di marketing, ingaggiati dal Partito comunista cinese, suggeriscono quale sua immagine tirerà di più. Lui da giovane, da signore di mezza età o da S Insieme con lui tornano le immagini di operai, contadini, e guardie rosse raffigurati nei gesti dell’“ira proletaria” Grande Vecchio? Meglio il Nuotatore, il Poeta o Il Grande Timoniere? E quali manifesti con la sua bella faccia riproporre sul mercato? Ad ogni modo non si capisce bene che Mao sarà mai questo Mao che ritorna: uno spettro che si aggira per la Cina e “scaverà la fossa” ai nuovi padroni? Oppure un’icona inoffensiva, un Mao per tutte le stagioni? Lo si evoca per scongiurarne l’ancora temibile forza, oppure per irridere al suo culto cucinandolo in salsa pop? Assieme a lui tornano anche le immagini di operai, contadini e soldati, di girasoli e bambini paffuti, di guardie rosse adolescenti e vecchi contadini rugosi il cui sorriso svela una chiostra di bianchissimi denti. Eroi, eroine, giustizieri, la cui ira proletaria si concentra nel sopracciglio arcuato e guizzante come coda di rondine nel momento in cui si scagliano contro il borghese, l’intellettuale, il professore, anche lui raffigurato nelle statuine del post-maoismo: il reprobo è in genere costretto a stare in ginocchio, con al collo il cartello dove sono elencati i suoi crimini nefandi, i caratteri del suo nome cancellati con delle grandi spregiative X. Rispunta anche sui banchetti delle fiere il suo Libretto Rosso dalla copertina di plastica, diventato un feticcio; e i distintivi con il suo volto, di faccia o di profilo. Si stima che dal 1966 al 1969 in Cina ne siano stati prodotti e messi in circolazione dai tre ai quattro miliardi. I distintivi erano di vari colori ma prevaleva il rosso con scritte in oro. Le forme erano le più variate, ce n’erano di tondi, di rettangolari, di quadrati, a forma di cuore, a goccia, di grandi e di piccolissimi, per lo più in alluminio ma anche in altri materiali come oro, argento, madreperla, bambù, porcellana, legno e rottami di aerei americani abbattuti in Vietnam. Un giorno, il 12 giugno del 1969, Mao passando in rassegna migliaia di guardie rosse esultanti, tutte con uno o più distintivi sulla giacca, esclamò: «Restituitemi i miei aeroplani!». Suonò bizzarra, allora, questa sua richiesta ma c’è chi, dopo la Rivoluzione culturale, ha fatto i conti dell’alluminio impiegato per una stima al ribasso di quattro miliardi e ottocentomila distintivi: se per ogni distintivo ne sono stati usati mediamente venti grammi, si ha un totale di 96mila tonnellate. Posto che per un Mig 21 occorrono due tonnellate e mezzo di alluminio, allora i distinti- LIBRETTO ROSSO Ai margini delle pagine, due versioni del libretto rosso che contiene “in pillole” il pensiero di Mao Durante la Rivoluzione culturale ne circolavano cinque miliardi di copie MEDICO SCALZO Giacca e berretto con stella del distaccamento femminile rosso. A sinistra, una borsa da “medico scalzo” che risale al periodo della Rivoluzione culturale cinese Repubblica Nazionale DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 CULTURA CONTRO La statuetta in ceramica rappresenta la guardia rossa e l’intellettuale controrivoluzionario Sul cappello dell’uomo in ginocchio c’è scritto: “Abbasso la puzzolente nona categoria”, riferito al basso livello della classe intellettuale A sinistra: borsa in tela con stella rossa del periodo rivoluzionario LA BANDA DEI QUATTRO Statuetta in ceramica della Banda dei Quattro, conosciuta anche come Banda di Shangai Da sinistra: Wang Hongwen, Jiang Quing (moglie di Mao), Yao Wenyuan, Zhang Chunquiao L’ESPOSIZIONE Dedicata a una grande icona del Ventesimo secolo, la mostra Mai dire Mao-Servire il Pop (ideata e curata da Gherardo Frassa) è in programma a Parma dal 22 al 30 settembre nell’ambito della rassegna “Mercanteinfiera”. Esposte in oltre 1200 metri quadrati della Fiera di Parma (Padiglione 8) si trovano circa diecimila oggetti da collezionismo dedicati al Grande Timoniere e più di 250 opere inedite realizzate da 170 artisti contemporanei vi di Mao sarebbero bastati per 39.600 aerei. E si capisce allora perché Mao si fosse un po’ incazzato. Oggi i collezionisti cinesi sono tantissimi, forse chi detiene il primato è il signor Wang Anting, il quale vanta il possesso di oltre ventimila pezzi, e un collezionista americano pare che gli abbia offerto cinque milioni di dollari, ma lui non ha venduto. I distintivi di Mao, infatti, sono stati per la maggior parte ritirati nel 1980 quando una circolare del dipartimento di propaganda del partito ordinò che fossero restituiti e molti, ma ovviamente non tutti, obbedirono all’ingiunzione. La mania di raccogliere distintivi era comunque già diffusa alla fine degli anni Sessanta quando, in alcune zone “segrete” si svolgeva un vero e proprio mercato nero in cui si scambiavano distintivi di Mao come francobolli o figurine dei calciatori, in genere non per soldi anche se si sa che c’era chi riusciva a monetizzare sul Grande Timoniere; e già fiorivano i “falsi”, abili imitazioni eseguite da artigiani che sottraevano alluminio o altri materiali dalle fabbriche che producevano i pezzi autentici e forgiavano clandestinamente i loro. Insomma, calcolando anche tutti questi “falsi”, probabilmente in Cina circolarono appesi a petti intrepidi, appuntati a giacche blu o cachi di ordinanza, all’incirca otto miliardi di distintivi. Otto miliardi di facce di Mao… Wang Anting, collezionista cinese, ha rifiutato cinque milioni di dollari per i suoi ventimila pezzi “maoisti” Ma non basta. Una stima del 1979 fa ammontare a circa due miliardi e trecento milioni i manifesti stampati con un ritratto di Mao, cioè tre Mao per ogni cinese (allora erano in meno). Se si sommano alle facce di Mao sui distintivi, a quelle stampate sul frontespizio delle sue Opere Complete nonché sul Libretto Rosso, quanti Mao avremo mai? E se si pensa che oggi sul biglietto da cento yuan appare il suo ritratto dallo sguardo benevolo e si osa immaginare quante banconote da cento circolino nella sua Cina, allora quanti, ditemi per favore quanti Mao abbiamo mai? Quella di Mao è senza dubbio l’effigie più riprodotta nella storia dell’umanità e la sua immagine dall’aura ambigua dimostra la versatilità del medium propagandistico che crea una corrispondenza inattesa tra il sistema di comunicazione di massa socialista e quello consumista. Mao ebbe a dire una volta che, chissà, tra mille anni i posteri avrebbero riso di Marx e anche di lui. O li avrebbero ignorati. Invece è successo che L’ORA DI CAMBIARE Sveglia rosso Cina degli anni Cinquanta Sopra, un berretto con la stella rossa dell’Esercito di liberazione popolare Mao è entrato nel regno del kitsch, si è fatto merce. La sua immagine e l’evento nel quale si è imposta come sacra, cioè la Rivoluzione culturale, oggi non evocano altro che nostalgia, cioè intrattenimento, facili lacrime e un corale sommesso rimpianto di un “come eravamo” che genera profitto. Così, grazie alla dilagante Febbre di Mao è sorta una nuova fiorente industria, l’Industria Rossa, che ben si adatta a un “socialismo di mercato”, e si ha oggi una forma davvero molto politica di fuga dalla politica. No al museo della Rivoluzione culturale che il grande scrittore Ba Jin voleva che venisse costituito, ma sì a un parco a tema dedicato ai Dieci Anni Terribili, quelli della Rivoluzione culturale, un complesso che sorge nel distretto di Dayi nella provincia del Sichuan, tanti ristoranti con cibo povero, tante belle ragazze in divisa da guardie rosse con il cinturone ben stretto in vita, tante canzoni rivoluzionarie adattate al karaoke, il tutto per fare soldi e ricordare ai cinesi che un tempo erano “poveri ma belli”. Ma lo sanno, i nuovi cinesi lo sanno, che il potere primordiale della politica (la politica al primo posto! diceva Mao) è stato sostituito dal potere spettrale del simulacro. L’aura rimane ma ogni passione è spenta. È il disincanto, è il presepe, è il modernariato bellezza! L’EFFIGE SACRA Piattino in ceramica decorata con l’effige di Mao Zedong da appendere alle pareti di casa RAZZI NEL CIELO Una statuina in ceramica con razzo militare risalente all’epoca della Rivoluzione culturale cinese Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007 l’incontro Gente contromano È appena tornato dalle vacanze e l’aria di casa gli ha causato un mal di pancia psicosomatico all’idea dei prossimi impegni: la nuova serie di “Markette” e il palco di Sanremo con Baudo (“ ma non gli farò da valletta”) “Mal di pancia perché racconta - la televisione è stata lo sfogo della mia timidezza, la rivincita di uno che è sempre stato l’ultima ruota del carro. Ma la timidezza, se ce l’hai dentro, ti rimane per sempre” Piero Chiambretti è la fanfara macedone che suona in piazza Carlo Alberto, il sole di settembre che accarezza le tovaglie gialle dei tavoli, e Torino, la sua città, che non è mai stata più bella di adesso. Eppure Chiambretti ha mal di pancia. E non è colpa del ristorante, Sfashion è di sua proprietà (ne ha tre in tutto): il cuoco gli prepara manicaretti, il pizzaiolo la focaccia calda, il cameriere lo coccola, il barista gli monta la panna proprio come facevano una volta le suore. Allora cos’è? «Lo stress. Ogni anno colleziono una serie di malattie psicosomatiche, alcune allo studio all’università della California. Mi vengono dolori che poi spariscono, sintomi che sembrano più dei jingle che veri e propri malanni. Come il mal di pancia che ho in questo momento. Che, se mi conosco bene, è dovuto al ritorno a casa, alle vecchie abitudini collegate al lavoro, ai rapporti con gli altri, agli obiettivi da raggiungere». Ma come? Allora la vacanza a che serve? «Anche quello è un lavoro, bisogna fare una settimana di vacanza per riprendersi dalla vacanza. Quest’anno mi sono buttato sulla cultura con la K e adesso so tutto delle dominazioni berbere, arabe, normanne e spagnole in Sicilia». Markettenon riprenderà prima di gennaio, un po’ presto per essere già in tensione. La rete felice, come Piero Chiambretti chiama La7, ha deciso di concedergli un po’ di tregua, dopo le settanta puntate e l’abbondante quattro per cento di share dell’ultima edizione. «Markette è stato qualcosa che è andato al di là del prodotto televisivo riuscito», dice affondando la forchetta nella pasta in bianco che, date le circostanze, gli hanno preparato. «È diventato un gruppo, un laboratorio. È il progetto di cui vado fiero, considerando che in certe zone d’Italia per trovare La7 bisogna chiamare un medium. meni del nuovo trio che ha preso il posto della fanfara macedone crederebbero alla sua timidezza. «Quella se ce l’hai dentro ti rimane per sempre», insiste. «Ancora oggi alle feste mi trovo in difficoltà. Anzitutto per l’effetto scimmia: entri e tutti ti guardano. Poi il fatto che all’altezza del mio naso vedo solo ginocchia, mi crea una forma d’ansia. La televisione è stato lo sfogo della mia timidezza, la rivincita di uno che è sempre stato l’ultima ruota del carro: senza una famiglia importante alle spalle, in una città che all’epoca non era la meraviglia di oggi, senza tessere di partito né amici influenti, uno fatica anche ad andare al chiosco a prendere il gelato». Come avvenne il passaggio dal mondo dello sport a quello dello spettacolo? «Tentavo di giocare a tennis e a pallone sperando che le donne si accorgessero di me. Poi qualcuno mi disse: per rimorchiare ci vuole un cane. All’epoca era di gran moda il cocker, ma costava sessantamila lire. Così decisi di andare ai mercati generali a scaricare cassette per recuperare i soldi, ma ero troppo minuto per essere preso sul serio. Allora cambiai tattica e decisi di buttarmi sulla disco mu- Per anni ho militato in radio e tv locali senza prendere una lira. Nella tv di un vivaista mi pagavano in tronchetti della felicità. Ero felice ma al verde FOTO WEBPHOTO C’ TORINO Insomma, quest’anno pensavo di starmene tranquillo, poi è arrivata la telefonata di Baudo. I risultati del Dopofestival e la mia attitudine a far sempre bene a Sanremo, mi hanno indotto ad accettare. Starò sul palco con Pippo, ma non sarò la sua valletta. Insomma, addio tranquillità». A sottolineare la solennità del momento, neanche avessero capito che si parla di canzonette, quelli della fanfara attaccano una languida versione zigana di Tico tico. Chiambretti scruta i passanti, abbronzatissimi bellimbusti appena rientrati dalle località balneari, elegantissime signore al primo shopping d’autunno. Magari il tizio in pantaloni a quadri che sbuca dalla galleria diventerà la prossima star di Markette. «No, non funziona così, se mi metto a cercarli non li trovo. Sono loro che vengono a me, come gli animali a san Francesco», scherza. «In tv tutti imitano tutti, rischi sempre di fare qualcosa di già visto. Perché questo non avvenga, devi trovare chi nonvede la tv. L’incontro con questi personaggi è raro e casuale. Per fortuna io catalizzo tipi bizzarri: in Sicilia ho conosciuto una “figurina” che cercherò di far venire a Markette. L’ho scoperta al Teatro Greco di Taormina, dove sono stato invitato a vedere il concerto dei Pooh. Osservando un loro fan, più che il concerto, ho capito che lì c’era qualcosa che poteva far comodo, un ragazzo di diciotto anni. Mi ha detto subito: sì, ma prima devo finire la scuola. E io: guarda che devi venire solo per una registrazione. Lui: comunque prima ne devo parlare col mio papà. E alla fine: però poi i Pooh me li fai conoscere? In quel momento era già assunto». Sono anni che si fa scudo con una presunta timidezza, eppure oggi, in bella mostra davanti al passeggio del centro, riesce a farsi udire sul fracasso della fanfara macedone. Il cantante passa con il cappello, Piero ci fa scivolare dentro una manciata di monete. A ruota, arriva un barbone con i capelli rasta che chiede soldi e sigarette, un habitué. «Questo è l’unico clochard italiano», esclama il presentatore. «No, presentatore no, che mi aumenta il mal di pancia. Autore televisivo, battitore libero, quel che vuole, ma non presentatore. Sa che da piccolo volevo fare il giornalista sportivo, o il tennista? Poi è successo che mi è cresciuta molto la testa e poco le gambe e ho dovuto abbandonare tutti gli sport. La carriera televisiva è stata un ripiego. Se dovessi rinascere, mi butterei sullo sport, che ha la stessa creatività del mondo dello spettacolo con una marcia in più, un fisico bestiale. Ho fatto outing anch’io: a vent’anni ero innamorato di Adriano Panatta. Avevo i suoi manifesti, mi piacevano le sue Superga, le sue magliette Lacoste verdi un po’ sbiadite, i capelli lunghi, il gioco sottorete, al punto tale che cercavo di emularlo, avevo anch’io i capelli lunghi e fino a trent’anni ho giocato con la racchetta di legno. Poi quando è diventato grasso, ho cominciato a guardare le donne». Con la verve che si ritrova, neanche i ro- sic. Sempre per rimorchiare, sottinteso, perché non sapevo neanche da che parte cominciare. Destino volle che finissi in un locale di Torino che si chiamava Ritual, frequentato solo da ragazzi di colore. Il proprietario, Claudio Barulli, mi disse: sto cercando un dj bianco che metta della musica che li mandi via tutti, voglio farne un locale diverso. Con grande coraggio, senza aver mai visto una consolle, un disco e neanche un nero, mi buttai nell’avventura. Negli anni della discoteca nascevano anche le radio locali: non avevano una lira, ma cercavano gente che avesse dischi (e io avevo quelli del locale). Questa piccola catena di sant’Antonio mi portò, nel giro di un anno, a diventare un dj di Torino e un dj di una radio di Torino. Ecco come entrai a far parte dello sfavillante mondo dei disoccupati dello spettacolo». E il cocker? «Ci rinunciai, ma le donne arrivarono lo stesso. Per anni ho militato in radio e tv locali senza prendere una lira. Ricordo che il proprietario della seconda televisione in cui lavorai aveva un grande vivaio, mi pagava con i tronchetti della felicità. Ero tanto felice, ma sempre al verde». Il colpo di fortuna arrivò un giorno del 1989, quando Angelo Guglielmi, direttore di RaiTre, gli chiese di realizzare il programma del pomeriggio contro una Domenica In che allora faceva dieci milioni di spettatori. «In Prove tecniche di trasmissioneradunai tutti gli eroi che avevano popolato la tv della mia infanzia (ore e ore di televisione in bianco e nero, che non era bella come dicono, ma sempre meglio di quella di oggi). Sandro Paternostro, che recuperai a Londra, dove viveva già da pensionato in una casa modesta della periferia, tornò in Italia, e dopo aver vissuto tre anni straordinari con me, si risposò (purtroppo). Poi Marianini, Helenio Herrera, il Professor Cutolo e Nanni Loy. Figure dimenticate della Rai che in un contesto diverso riacquistavano una incredibile vitalità». Abbassa la voce quando gli tocca ricordare come, dodici anni dopo, l’azienda che aveva sempre portato alle stelle spezzò il sogno della tv in cui credeva. Si rifugiò a La7 senza far la vittima né scrivere il suo nome nella lista degli epurati, ma il giorno in cui la Rai disse no a Markette fu assai più traumatico del primo stipendio pagato in tronchetti. «Non si può pretendere che la televisione sia meglio della società. Il motivo per cui la tv è peggiorata, è che sono peggiorati gli uomini. Fu una storia dolorosa: l’anno in cui fui cacciato — perché di cacciata si trattò — riuscii a deprimermi talmente tanto che un giorno, andando a giocare a tennis per allontanare la disperazione, riuscii a rompermi una gamba. In quel momento capii che il mio fisico stava dicendo stop, e per un anno niente televisione. Ricordo ancora l’ultimo incontro con Cattaneo, accompagnato da Marzullo e dal loro capo ufficio stampa Paglia che masticava chewingum. Mi guardavano come se già fossi un cadavere che scivolava lungo il fiume, anzi lungo il canale, visto che era- vamo a Venezia». Niente secondo, di dessert, oggi, neanche a parlarne. La Rai gli ha fatto passare l’appetito più del mal di pancia. Resta solo il posto per un espresso, addolcito con la panna delle suore, mentre il discorso precipita sui cinquant’anni compiuti l’anno scorso. «Il tempo che passa non mi entusiasma. Mi fa paura la morte. L’ho visto anche quest’estate nella Sicilia grecoromana: l’angoscia della morte veniva cantata, dipinta, mosaicata. La vita non vale proprio nulla, è talmente poco preziosa che neppure fa notizia». Rimpianti? «Avrei potuto occuparmi un po’ più di me, della mia persona, della famiglia, delle amicizie. È chiaro che per raggiungere dei risultati devi impegnarti anima e corpo e oggi, guardandomi indietro, mi rendo conto che avrei potuto concedere di più ai sentimenti». Arriva Ingrid Muccitelli, la sua compagna, ventotto anni, anche lei volto de La7, parecchio più bella che in tv. Il tempo di un saluto timido, poi lei si accomoda un tavolo più in là, con altri amici. «Ho una bella storia d’amore, ma non ci tengo a raccontarla, perché quando parlo di queste cose mi sento nudo di fronte al lettore. Farà ridere, ma sono riservato e tradizionalista su argomenti che sono privati, privatissimi». Ingrid ha riportato il sereno. Persino Sanremo 2008 sembra meno spaventoso. «Ma sì, in fondo è un antistress. Che fai quando sei a casa, bombardato dai telegiornali, assalito dall’ansia delle newsonline? A un certo punto chiudi la finestra e ti guardi la partita. O Sanremo. Il Festival, per noi italiani, è come un discorso di Fidel Castro per i cubani, una forte rassicurazione sul passato che non muore mai e il timore che questo passato possa essere il nostro presente. Il Festival è la certezza che siamo vivi, che tutto cambia, ma per il fatto che lui è ancora lì, in quel teatro, in quelle date, con quei cantanti, con quei criteri, vuol dire che non è cambiato niente. Sanremo è il simulacro della continuità. Vuol dire tutto va bene, almeno per cinque giorni». ‘‘ GIUSEPPE VIDETTI Repubblica Nazionale
Scarica