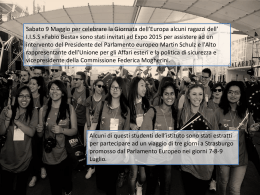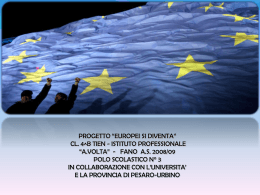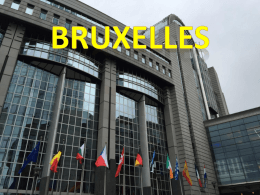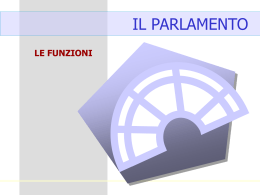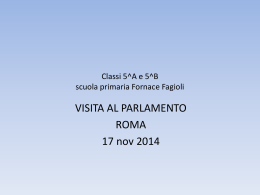- Dlrez. e Redaz.: Plazza dl Trevl, 86 00187 ROMA ANNO XXVIII N. 7-8 Luglio-Agosto 1980 Spedlzlone In abbonamento postale Gruppo 111/70 - ORGANO MENSILE - D E L L ' AICCE, ASSOCIAZIONE dal quartiere alla regione per una Comunità europea federale UNITARIA DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI Il disegno federalista e la caricatura confederale di U.S. Evitiamo di partire a priori dall'enunciazione di un disegno federalista delllEuropa e vediamo se esso risulta necessario per il raggiungimento di fini che, tutto sommato, si presentano anche ai confederalisti o ai consoli della Comunità. La crescita dei prezzi petroliferi sembra inarrestabile, addirittura una loro impennata ulteriore non k da scartarsi e l'Europa occidentale - chi più chi meno: e i rimedi si prospettano lenti e parziali - vive col fiato in gola. Si dice: l'Europa potrebbe offrire all'Opec una stabilizzazione monetaria contro una stabilizzazione dei prezzi. Analizzianio che cosa ciò potrebbe significare e in che quadro potrebbe avere prospettive di successo. La politica energetica della C o m u n i t à europea e gli E n t i locali. Una stabilizzazione monetaria potrebbe garantirla l'Europa all'Opec solo se essa fosse capace di battere una sua moneta, espressione di un'unione econoniica razionale ed efficace. In ogni modo si dovrebbe trattare di una moneta europea reale, indice di una integrazione autentica: come potrebbe sussistere altrimenti una moneta europea capace addirittura di intervenire autorevolmente in campo internazionale? Direi soprattutto che il do ut des potrebbe essere preso in considerazione da un primo gruppo di paesi dell'Opec, solo se non fosse un espediente economico senza lungo respir o , alternativa contingente di operazioni coi dollari, con le sette sorelle e con le banche private di mezzo mondo. Su questo scmplice e contingente terreno economico i paesi dell'opec con le loro maggioranze interne e le attuali classi dirigenti ( o i loro despoti) possono poi non aver tanta intenzione di "stabilizzare", vòlti come sono a creare un nuovo equilibrio economico e (perché n o ? ) politico e a ritagliarsi un loro spazio in un nuovo oligopolio imperiale. Proporre una stabilizzazione monetaria contro una stabilizzazione dei prezzi del luglio-agosto 1980 COMUNI D'EUROPA potrà non riflettere attentamente alle illumipetrolio, prospettare eventualmente un ricinanti conclusioni a cui sta arrivando il grupclaggio dei petroldollari verso una parte mep o internazionale, guidato da Giorgio Fuà(*), n o ricca del terzo m o n d o ( o quarto mondo) su un modello di "sviluppo ritardato" per le p u ò essere solo una proposta coraggiosa e regioni d i industria1izzaz.ione meno avanzata. coerente che fa un'Europa diversa dall'attuale Si tratta, beninteso, dell'esatto contrario d i a quei ceti o classi o gruppi politici e sociali e intellettuali dei paesi dell'opec, i quali con la una Comunità europea a più velocità (forma loro emancipazione dall'iinperialismo vogliamimetizzata di irnperialismo interno alla C o n o congiungere la lotta per un nuovo ordine munità), e cioé di u n o sviluppo articolato, internazionale, persuasi che non si deve passotto comuni istituzioni democratiche sovrasare dall'imperialismo bipolare alla rivincita nazionali. L'eliminazione del "ritardo" nello del nazionalismo e all'imperialismo multiposviluppo è previsto come un processo molto lare, ma occorre superare una volta per tutte lungo (ammesso e non concesso che si debbal'anarchia internazionale e creare, uniti, le no rincorrere pedissequamente le regioni d i strutture e le istituzioni per la convivenza sviluppo più antico): dunque accanto a una planetaria. strategia per la crescita è necessario ideare, N o n sembri del tutto utopistico questo nelle zone più arretrate, una strategia comdiscorso, perché, se non la offusca definitivaplementare "per vivere con il gap durante i mente con operazioni d i piccolo cabotaggio, decenni avvenire". Fiià critica la concentraI'Europa ha ben più delle superpotenze una zione in imprese moderne e settori avanzati sua credibilità nel mondo delle cosiddette della scarsa disponibilità d i capitale e d i nazioni emergenti: tuttavia non è certo più capacità imprenditoriale delle zone povere: sufficiente l'Europa d i Yaoundé e d i Lomé, questa concentrazione genera, d i rimbalzo, serve ben altro. I'arretramento ulteriore del resto. Occorrono Ecco: la stabilizzazione monetaria che poincentivi basati sulla capacità occupazionale e trebbe offrire l'Europa dovrebbe essere il non su puro e semplice fatto d i investire, e ' simbolo, da una parte, d i un'Europa che bisogna studiare attentamente il ruolo delle sapesse attuare al s u o interno un modello attività minori e dell'agricoltura, verificandopolitico, economico e sociale esemplare, cane le implicazioni sociali. In agricoltura si pace, d'altra parte, di affrontare con traspadeve mirare al miglioramento del livello d i rente coerenza i problemi, che - tanto per vita delle popolazioni e non certo alla massicapirci - sono quelli esposti nel rapporto mizzazione della rendita terriera; per le imBrandt Nord-Sud. prese a bassa intensità di capitale bisognerà N e nasce la conseguenza che una stabilizprevedere la costituzione d i agenzie (pubblizazione monetaria europea che potrebbe inche elo private) in condizione d i fornire teressare i più lungimiranti paesi e uomini servizi richiesti da imprese "piccole", incapadell'opec, come alternativa offerta loro al c i - d i fruire dei vantaggi dell'economia d i tentare la ripetizione della millenaria politica scala. Occorre rimeditare largamente sul ruodi "un nuovo equilibrio", dovrebbe essere lo dell'impresa pubblica (questa tappabuchi, anzitutto l'espressione d i una convergenza al servizio del corporativismo) e rilanciare, nel senso più profondo e in una cornice economica delle nazioni che fanno parte della moderna, la cooperazione (Fuà non esclude Comunità europea in vista di un progetto che neanche lo studio delle esperienze, tedesche e non sia in contraddizione con questi fini israeliane, di imprese a proprietà sindacalé). internazionali, cioé con fini che potrebbero Soprattutto si afferma -- a proposito di dualitranquillamente far loro anche i paesi produttori d i petrolio, ove volessero passare con s m o salariale - che è destinato a rimanere particolarmente nelle regioni arretrate, per piena consapevolezza dal mondo degli affalungo tempo avvenire, il divario d i produttiri a breve-medio termine a quello della vità e d i correlata capacità retributiva del politica e dal mondo dei rancori (spesso lavoro: poiché bisogna scartare (perché assogiustificati) a quello della ragione. Se vuole negoziare su solide basi e stabilire lutamente irragionevole) un riequilibrio le autentiche premesse della pace (non della fiscale, occorre faf fronte "secondo giustizia" semplice e labile distensione) l'Europa deve al problema. Sostiene Fuà che "un mercato darsi al suo interno una struttura - si diceva - del lavoro unificato con un unificato livello d i esemplare. salario non t: proposta attuabile in tali circoCertamente un progetto comunitario d i stanze. U n doppio ( o piuttosto multiplo) convergenza delle economie nazionali non mercato del lavoro non solo deve essere potrà prescindere dall'esigenza, nel confronaccettato come inevitabile, ma deve essere t o d u r o e teso tra est e ovest, d i darsi la appositamente modellato per renderlo quanpossibilità d i co~npetere sul terreno delle to più possibile efficiente e ordinato, ed i tecnologie più sofisticate dell'industria d i meccanismi d i contrattazione salariale e di punta (areonautica, telematica, ecc.): è un determinazione delle condizioni d i lavoro devono essere funzionali a questo scopo". A campo in cui la Comunità europea non p u ò rinunciare a priori alla sua autonomia e alla questo punto l'equità della proposta dipenderà non solo e non tanto da una adeguata sua capacità competitiva e, insomma, alle tassazione dei redditi (positiva e negativa) e premesse sostanziali d i una equa1 partnership da un congruo schema distributivo dei servizi con l'America. C i ò detto, la Comunità eurosociali, che privilegi nettamente le aree depea specialmente in fase di allargamento non presse, ma anche e forse soprattutto dall'atFoto in prima pagina: (sopra) la cittadinanza di Lariano partecipa alla cerimonia di gemellaggio con Sausset les Pins (v. pag. 12); (sotto) Altiero Spinelli e George Marshall (v. pag. 1). * Già nel n. 12 (dicembre) 1976 "Comuni d'Europam si occupò (nell'editoriale "Il compromesso europeo") di un "prezioso libretto" di Giorgio Fuà, "Occupazione e capacità produttive: la realtà italiaria". SOMMARIO Pag. Il disegno federalista e la caricatura confederale, d i U. S. . . . 1 Cronaca delle Istituzioni europee: Ampliare la funzione delle operazioni integrate, di Pier Virgi3 lio Dastoli . . . . . . . . . Promemoria per T h o r n , di Piero Soldati . . . . . . . . . 3 Occupazione: una battaglia politica europea, d i Gabriele Panizzi.. . . . . . . . . . . . 5 ~ H e a r i n g -del P . F . con i rappresentanti delle autonoinie locali e regionali, di Giovanni Franchi. . . . . . . . . . . . 6 L'integrazione europea all'esame della XV C P L R E , d i G. M. . 7 Attività del C C E e dell'AICCE . 8 Incontro tra città gemelle: Lecco-Micon . . . . . . . . . 10 Pensiero e azione dei federalisti europei, a cura d i Luciano Bolis.. . . . . . . . . . . . l1 Gemellaggi: Bardonecchia-Modane. . . . Lariano-Sausset les Pins . . . 11 12 Inserto: La politica energetica della C o munità europea e gli Enti locali, di Gianfranco Martinz tenzione alla qualità d i vita e d i lavoro, in opposizione dei beni disponibili. Si dice a questo punto nella relazione del gruppo internazionale: "In questa prospettiva è importante delineare misure specifiche adatte a favorire un maggiore sviluppo (e ad educare le masse ad un maggiore apprezzamento) di quegli aspetti non monetari della vita lavorativa quali iniziativa, responsabilità, partecipazione nel controllo, indipendenza, vita d i comunità, ecc.. Queste caratteristiche anzi si possono rivelare più facili da coltivare in quei segmenti dell'economia affetti da minore produttività e livelli d i guadagno a causa della loro misura subottimale, della bassa intensità d i capitale, dell'assenza di una organizzazione complessa e / o dell'allocazione ~ e r i f e r i c a I. progressi nel!a direzione accennata dipendono a~npiamentedai movimenti cooperativi, ma i governi devono fornire la struttura adeguata". , Q u i si possono fare riserve (come si fanno nella pregevole "sintesi" delle proposte del gruppo Fuà comparsa in "Mondo economico" nello scorso febbraio e di cui ci siamo valsi noi stessi) sulla capacits delle pubbliche autorità, proprio in paesi spesso "ritardati" anche amministrativamente, ad assumersi un ruolo tanto gravoso e delicato: ma proprio qui si dovrà anche verificare la storica alleanza tra autorità comunitarie, sovranazionali e (continuazione a pag. 4 ) luglio-agosto 1980 COyUNl D'EUROPA Cronaca delle Istituzioni europee Riduzione degli squilibri regioriali: è necessario ampliare la junzione delle operazioni integrate di Pier Virgilio Dastoli 1. Alla fine del 1980 verrà a scadenza la seconda fase di funziqnamento del Fondo europeo di Sviluppo regionale: nonostante le sollecitazioni del Parlamento europeo (da ultimo la risoluzione presentata a nome della commissione di ~ o l i t i c aregionale dal presidente D e Pasquale) il commissario Giolitti ha confermato recentemente che non è sua intenzione rispettare l'impegno della modifica del Regolamento, fissato per la fine dell'anno. Il Parlamento europeo durante la procedura di concertazione relativa al regolamento attualmente in vigore, sostenne con forza la necessità di potenziare il ruolo delle azioni nell'ambito del «fuori-quota. ed una più ampia articolazione delle operazioni a favore dei settori infrastrutturali. 11 Consiglio, pur rifiutando di accettare gli orientamenti del Parlamento europeo, prese l'impegno di fissare una scadenza alla validità .politica. del Regolainento e la Commissione accettò di presentare delle proposte di revisione globaie in tempo utile per il rispetto di questa scadenza. L'inattività della Commissione è dunque una grave mancanza d i rispetto nei confronti del Parlamento europeo: ma, quel che è più grave, non consente di intervenire con decisione sull'insoddisfacente struttura del Fondo, che ha provocato e provoca ira l'altro inaccettabili ritardi nei pagamenti e strozzature nelle sue capacità redistributive e d i incentivazione. 2. In questi ultimi anni, tuttavia, il commissario Giolitti ha rivolto il suo impegno verso iniziative definite nello «jargonn comunitario *operazioni integrate,,, concentrando per il momento i suoi interventi nelia zona di Napoli, di Belfast ,ed in Scozia. Questi interventi hanno una specifica validità politica ed economica anche se rappresentano probabilmente un surrogato del .coordinamento degli strumenti finanziari della C o munità,,, compito afidato nel gennaio 1977 allo stesso Giolitti e mai effettivamente esercitato a causa delle resistenze d i altri commissari (in primo luogo il vicepresidente Ortoli). Si tratta ora di ~ u f i c i a l i z z a r elo ~ strumento delle operazioni integrate, inquadrandolo nella necessaria modifica del regolamento del Fondo regionale e nel potenziamento dei ruolo della sezione .fuori quota.. 3. U n o degli aspetti più dificili e delicati della politica regionale della Comunità riguarda indubbiamente la capacità di sviluppare una forte azione di redistribuzione per promuovere il necessario riequilibrio a favore delle zone economicamente svantaggiate. In particolare il Mezzogiorno d'Italia, la Calabria e la Basilicata sembrano richiedere una modifica dello stesso modo d i concepire l'interventc) della Comunità. Tutta l'area tirrenica che va dalla piana di S. Eufemia alla zona di Gioia Tauro anche a causa di iniziative irresponsabili, al limite deila legalità come gli stabilimenti della SIR, o a causa d i errori d i programmazione come la questione del Quinto Centro siderurgico - ha subito e subisce la superficialità di autorità centrali o locali; gli effetti negativi di pressioni elettorali, clientelari o mafiose; il disinteresse delle forze economiche con maggiori capacità di investimento. Tutta quest'area, nonostante l'incuria umana, possiede capacità di sviluppo e potenzialità agricole, artigianali, turistiche e residenziali che attendono soltanto di essere utilizzate nell'ambito di un progetto ampio e articolato che sia prospettato in un ambiente socio-economico orientato in termini integrati e organici, tendenti a comporre all'interno del territorio diversi elementi della vita associata. In questo spirito si era mossa, nel novembre 1978, una proposta elaborata dalla Finanziaria Meridionale (FI.ME), finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi tiell'area di Gioia Tauro, ed ispirata all'esperienza americana del 4Tennessy Valley Authority». Le principali iniziative previste, destinate allo sviluppo d i un'area compresa fra ia piana di S. Eufemia e la zona d i Gioia Tauro, sono: a) una zona costiera con un certo margine di rispetto dell'entroterra, adibita a sviluppo residenziale e parzialmente turistico; b) la zona del porto di Gioia Tauro, con adeguato retroterra, centro residenziale e polo di insediamento alberghiero, per ospi- tare il flusso turistico con il Nord Europa (collegabile, attraverso una metropolitana leggera fuori terra, all'aereoporto di Lamezia Terme). Una zona industriaie del porto potrebbe essere sfruttata per la costruzione, riparazione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto del Nord Europa; C) una zona di sviluppo sperimentale agro-alimentare con la coltivazione ed il trattamento industriale di specialità e primizie ortofrutticole destinate al Nord Europa. Anche questo polo si avvarrà del collegamento speciale con l'aeroporto di Lamezia Terme; d) una zona di sviluppo legata alla floricoltura, anche questa orientata all'esportazione nel Nord Europa attraverso Lamezia Terme; e) una zona industriale per ospitare le iniziative IRI e dei lotti liberi opportunainente attrezzati, per occupare in un primo comprensorio almeno 3.000 persone; f) una seconda zona industriale da avviarsi d o p o il decollo della prima zona industriale; g) una zona destinata ad attività di ricerca scientifica. La proposta elaborata dalla FI.ME. prevedeva inoltre tutto uno studio dedicato all'agricoltura nello sviluppo integrato dell'area. 4. Le operazioni integrate della Commissione europea - come è noto - si basano sull'utilizzazione coordinata degli strumenti finanziari della Comunità ed in particolare: Fondo regionale, Fondo sociale, Feogaorientamento, Bonifici di interesse SME (Italia e Irlanda), Prestiti Ortoli e Prestiti BEI. I1 progetto predisposto dalla FI.ME., come abbiamo visto, interessa in egual modo i settori industriale, agricolo, sociale ed infrastrutturale, settori tutti con possibilità di finanziamento comunitario, se i progetti vengono sviluppati nel quadro di una politica con interesse europeo. Riteniamo utile non approfondire ora il discorso, lasciando spazio alle reazioni delle autorità e delle forze politiche, economiche e sociali locali, per ritornare successivamente sull'argomento. Promemoria per Gaston Thorn di Piero Soldati I . D o p o l'accordo intergovernativo sulla candidatura del lussemburghese Gaston Thorn alla presidenza della Commissione, si è avviata di fatto la procedura di rinnovo dell'Esecutivo comunitario, che avrà termine il 6 gennaio 1981 con lo scambio delle consegne fra l'attuale presidente Jenkins ed il suo successore e con :a formale distribuzione dei «portafogli,, fra i nuovi commissari. La nomina di T h o r n 2 un successo in primo luogo della diplomazia tedesca che aveva puntato le sue carte su un presidente di statura ed e s p e r i e n z ~politica di alto livello, opponendosi alle resistenze fra l'altro dei governi francese ed inglese e dello stesso Jenkins, che non aveva nascosto - negli ultimi tempi - le sue preferenze pe,r l'attuale commissario all'agricoltura, il danese Finn Gundelach. I n secondo luogo è un successo della presidenza italiana che, seppure tardivamente e debolmente e con l'incertezza che ha contracidistinto momenti importanti del periodo 1 gennaio-30 giugno 1980, ha saputo superare da ultimo gli ostacoli ed i veti di Parigi. In terzo ed ultimo luogo t; un successo dello stesso Thorn che, d o p o aver perso maldestramente la battaglia per la Presidenza COMUNI D'EUROPA del Parlamento europeo, giunge ora al vertice delle istituzioni comunitarie nel momento in cui sono richieste molte qualità politiche e diplomatiche per recuperare gli errori commessi d a Jenkins. N o n t. invece un successo del Parlamento europeo, che aveva chiesto in aprile al Consiglio di essere formalmente consultato durante la procedura di nomina del nuovo Presidente: la richiesta ha ricevuto a Venezia un [[fin de non recevoir». Eppure era stato lo stesso Colombo, nella sua qualità di presidente della Commissione politica dell'assemblea europea, a sostenere e portare in aula la risoluzione Rey sui rapporti fra Parlamento -.europeo e Commissione! I1 Parlamento europeo ha ancora la possibilità di chiedere con fermezza al nuovo Presidente il rispetto del secondo impegno, indicato nella risoluzione Rey: il presidente della nuova Commissione deve presentare il suo programma all'Assemblea e chiedere il voto di fiducia. N o n t. difficile immaginare che Thorn comprenderà il significato politico di una simile procedura ed i vantaggi che da essa possono derivare alla stessa Commissione. 2. Dedicheremo questa e le prossime ~ C r o n a c h e ~ agli elementi del programma della nuova Commissione, che riteniamo centrali per lo sviluppo dell'integrazione europea nei prossimi anni (1981-1984). I1 problema della riforma istituzionale è oggi il tema che condiziona le capacità di evoluzione delle più importanti politiche comuni, insieme a settori-chiave come il bilancio e le relazioni esterne della Comunità. Probabilmente uno dei primi atti del nuovo Presidente dovrebbe essere la nomina di un <<commissarioresponsabile dei problemi istituzionalin, incaricato di seguire l'attività che il Parlamento europeo sembra voler iniziare a seguito del progetto Spinelli (vedi punto 3). Del resto, la Commissione non parte da zero se t. vero che fu essa ad elaborare - ad uso del presidente Tindemans - il miglior rapporto sulle prospettive di evoluzione dell'unione europea. La rilettura di quel testo sarebbe utile sia ai nuovi commissari, che al Parlamento europeo e agli stessi movimenti europeistici. Mentre la Coinmissione si deve preparare ad affiancare l'aytività del Parlamento europeo, nella sua qualità di «saggio. incaricato di elaborare il progetto di riforma istituzionale, il s u o Presidente deve essere capace di riappropriarsi del ruolo di motore dell'integrazione europea, garante del rispetto dei trattati ed esecutivo (= governo) della Comunità, ruolo progressivamente abbandonato per far posto a quello di segretariato del Consiglio. 3. Sappiamo che Thorn segue ~ e r s o n a l m e n t e con interesse gli sviluppi dell'iniziativa presa da Spinelli il 25 giugno e tendente a responsabilizzare il Parlamento europeo sul tema della riforma istituzionale. Gli inizi sono stati incoraggianti, tenuto conto che hanno già aderito democristiani come Tindemans, Gaiotti, Cassanmagnago, von Wogau e Lucker; socialisti come Brandt, Ruffolo, Did ò , Wieczorek-Zeul, Balfe, Enright, Key, Pelikan, Ripa di Meana; liberali come Visentini e N o r d ; conservatori come Johnson e Jackson; comunisti come Ippolito e Leonardi. A settembre si svolgerà una riunione del gruppo di deputati che ha appoggiato il progetto Spinelli: l'obbiettivo .procedurale» è quello di costituire una commissione <<costituente,>, che prepari per l'Assemblea il progetto di riforma. 4. Un'ultima parola per I'UEF: crediamo che in questo momento, estremamente delicato per la Comunità e per il Parlamento europeo, sarebbe molto pericolosa una confusione di ruoli. E' utile ed opportuno che I'UEF e gli altri movimenti europeistici sollecitino il Parlamento dall'esterno, anticipandone le posizioni e salvaguardando l'obiettivo finale dal rischio di compromessi poco chiari, di affossamenti o annacquamenti (sempre possibili, a causa della lunghezza e difficoltà della procedura), di ritardi ed ostacoli frapposti dai governi e dalle amministrazioni nazionali. I1 disegno federalista e la caricatura confederale Ytontrnuazione da pag. 2) ABBONATEVI A C O M U N I D'EUROPA 28 anni di rigorosa e libera battaglia per gli Stati Uniti d'Europa , dotate di poteri reali, ed autorità democratiche regionali e locali. C o m u n q u e ci importa evidenziare che l'estensore della "nota" di "Mondo economico" ammetteva che le "proposte Fuà" possono offrire "la preziosa possibilità di elaborare un modello non solo nuovo ma anche più umano". Dalle proposte per i paesi europei e le regioni comunitarie "di più recente industrializzazione" ( o , semplicemente, economicamente arretrati) possiamo trovare preziosi suggerimenti per estendere il discorso a un modello o a un progetto complessivo di Europa (e quindi a u n o scopo accettabile per la convergenza delle diverse economie nazio: nali), che si ispiri molto di più a Ernst Schumacher e a Erich Fromm che non all'attuale sviluppo selvaggio: quest'ultimo su terreno internazionale e in particolare nei riguardi del terzo e quarto mondo non potrebbe che proporre o nuove impostazioni criptocolonialiste o la dissipazione rapida e disastrosa di tutti i beni naturali del pianeta. Dicevo alla conferenza di Magonza delle città gemellate (nel settembre del 1978): "non luglio-agosto 1980 è semplice.. . un riorientamento qualitativo dello sviluppo: ma bisogna dedicarcisi, senza un attimo di indugio". Aggiungevo poi, citando il nostro vecchio compagno di lotta Raymond Rifflet, che "in definitiva il riorientamento qualitativo dello sviluppo implica.. . una rivoluzione culturale (con una sua austerità: inutile tentare di divincolarsi) e insieme richiede una mutazione istituzionale (democrazia economica e partecipazione effettiva dei lavoratori e dei consumatori)". Se l'Europa, unendosi con vincoli federali, sapesse poi cambiare totalmente faccia (O, meglio, corpo), avrebbe un senso quel piano Marshall verso il terzo-quarto mondo di cui a più riprese ha parlato Altiero Spinelli. Esso perderebbe quell'aspetto puramente economicistico, che avrebbe qualora si limitasse a rendere i paesi della fame non tanto compratori dei prodotti europei ma, come si vorrebbe ingenuamente ribaltando soltanto il problema, compratori del nostro know how e di alcune poche produzioni estremamente sofisticate. T r o p p o comodo questo sottile neoimperialismo: in realtà noi potremo contribuire a un nuovo ordine internazionale non tanto o non solo modificando le ragioni di scambio coi paesi ex coloniali (quello scambio ineguale, su cui si è sempre basato l'autentico imperialismo) quanto dandoci una struttura e forme di consumo che ci permettano realmente non di predicarla, ma di attuarla fino in fondo questa diversa logica degli scambi internazionali. Tra l'altro così facendo non solo ristabiliremo u n rapporto di giustizia fra gli uomini, ma anche un ragionevole rapporto tra gli uomini e i beni (limitati) della natura. C o m e si vede non sono i rapporti economici o , meglio, i rapporti economici contingenti a determinare nuovi rapporti politici, ma t. una nuova visipne della politica e delle istituzioni che ad essi devono presiedere e che potranno trovare una logica collocazione anche ai rapporti economici, con reciproca soddisfazione di tutti, a condizione che tutti vogliano sobbarcarsi un'equa parte di sacrifici accanto ai tanti vantaggi. Siamo dunque partiti da un'esigenza, quella di stabilizzare il prezzo del petrolio, siamo passati attraverso la moneta europea e siamo finiti a trattare della struttura stessa dell'Europa. I1 pateracchio confederale non crea nessuna moneta europea reale e ancor meno dà agli europei la credibilità per fare ai produttori di petrolio una proposta che non sembri immediatamente una furbizia di mercanti, da vagliare quindi in funzione di altre furbizie che possono presehtarsi come più redditizie. I confederalisti non persuaderann o mai i paesi dell'opec e i loro uomini migliori e manderanno in malora tutte e ciascuna le nazioni dell'Europa, conservata tenacemente a regime balcanico: e insieme al danno d'Europa faranno il danno della pace e del mondo. Si ricordi (i cinesi hanno ragione) che probabilmente per l'Europa si avrà il terzo conflitto mondiale (e la fine del mond o ? ) : l'Europa federata p u ò tbttavia essere anche la democrazia "giusta, libera e solidale", che evita il terzo conflitto mondiale e avvia l'autentico superamento dell'equilibrio del terrore. COMUNI D'EUROPA luglio-agosto 1980 Londra conferma il segnale negativo di Liverpool Occupazione : una battaglia politica europea di Gabriele Panizzi D o p o Liverpool Pochi i alla prima riunione del G r u p p o di lavoro sui problemi dell'occupazione nelle aree urbane, tenutasi a Londra il 2 luglio scorso. I Paesi presenti sono stati, oltre la Gran Bretagna, il Belgio, la Francia, l'Italia e l'Olanda. Presenti anche rappresentanti del C C E , della I U L A e della Comunità europea. I1 G r u p p o di lavoro sui problemi dell'occupazione è stato formato, insieme agli altri due sulla energia e problemi dell'ambiente e sul mercato delle aree urbane, d o p o la Conferenza d i Liverpool del 6-9 novembre 1979 sui problemi urbani nella Comunità europea. .Comuni d'Europa. ha già dato ampia informazione e documentazione sulla Conferenza di Liverpool nel dicembre 1979. In quella occasione è stata sottolineata la posizione della delegazione italiana che votò contro la risoluzione finale della Conferenza, ritenendola inadeguata ai problemi che travagliano sul piano politico, su quello economic o territoriale e su quello istituzionale la Comunità economica europea. Nei momenti di crisi, rifugiarsi in àmbiti ristretti di azione con l'illusione della concretezza costituisce un errore. N o n vogliono capirlo i nostri amici inglesi ed altri. Lo capisca però la dirigenza del C C E (e della I U L A 2 ) . La riunione d i Londra, avvenuta dopo ben 8 mesi da Liverpool è stata inutile ed il rischio è che tali risulteranno anche le prossime, a partire d a quella già convocata a Bruxelles per il 12 novembre p.v. Politica economica,. occupazione e poteri locali I problemi della occupazione sono la conseguenza d i impostazioni di politica economica che i poteri locali (Regioni e Comuni) non riescono a modificare. C h i decide sono le grandi concentrazioni economico-finanziarie che ristrutturano gli apparati produttivi su scala mondiale in relazione ad obiettivi da esse stesse definiti, in assenza di poteri politici commensurabili alla loro scala di intervento. Compito di organismi sovranazionali come il C C E (e la I U L A ? ) non p u ò essere quello di sommare le lagnanze dei singoli poteri locali, essi, viceversa devono formulare una politica che, per la sua organicità, sappia incidere sui comportamenti delle istituzioni comunitarie e delle forze politiche e sindacali in ordine ai temi (squilibri territoriali, settoriali e monetari, energia, ambiente) dai quali dipende anche il problema della occupazione, con particolare acutezza in alcune aree. E' stato detto a Londra agli amici inglesi: siamo d'accordo circa I'esigenza che le olit ti- che comunitarie non si risolvano in tutela di interessi costituiti e corporativi (nell'agricoltura, ad esempio). Ma questa giusta esigenza non p u ò avere risposte a dimensione nazionale e settoriale. O si ha il coraggio di compiere un salto d i qualità (dalla dimensione nazionale-settoriale dei problemi a quella europea-organica) ovvero passeremo dalle lagnanze verso gli organi comunitari (ma quali poteri i governi gli lasciano esercitare?) a forme di nazionalismo esasperato (con ulteriore regressione dei problemi). Prendiamo appunto l'occupazione (di cui, sia ben chiaro, a Londra non si è affatto discusso!). Nel corso degli anni '60 e '70 abbiamo assistito a forti correnti migratorie dalla periferia al centro Europa. L'attenuazione di tali correnti t. stata possibile solo con il ricorso a lavoratori portoghesi, spagnoli, turchi, greci e jugoslavi. Per almeno quindici anni (fino alla metà degli anni '70) non vi è stata alcuna politica comunitaria capace di contenere la libera circolazione della mano d'opera e di attivare la circolazione dei capitali. E che dire della politica agricola volta a conservare le strutture antiche ed a fornire mano d'opera per la emigrazione industriale? I1 Fondo sociale europeo, in mancanza di una organica politica di equilibrio degli investimenti ha avuto come risultato la sovvenzione d i attività di sussistenza. Nel 1975 il Fondo europeo di sviluppo regionale fa la sua timida apparizione in assenza di una politica regionale che sola può consentire la corretta utilizzazione del FSE e dello stesso FESR (le ultime modificazioni regolamentari del FSE sono state infatti un regresso rispetto a quelle avanzatedel 1971). L a politica dell'impiego n o n h a spazio s u scala nazionale N o n vi è politica dell'impiego da parte dei pubblici poteri ne1l:'area europea. Ciascun Paese va dietro i problemi che la dinamica economica (governata da centri di potere sovranazionale) loro crea: l'Italia col Mezzogiorno in particolare ma anche gli altri Paesi con le loro aree in declino o con quelle congestionate (sono facce di uno stesso poliedro). Scoprire da parte di alcuni paesi ora i problemi della disoccupazione strutturale (non quella frizionale) nelle aree urbane in declino non p u ò riportarci indietro nella battaglia politica che stiamo combattendo da decenni: la politica dell'impiego non p u ò essere affrontata con successo nell'àmbito degli angusti confini nazionali. La conseguenza di questo modo di procedere it stata la devianza sindacale sui problemi degli occupati (gli emigrati so110 stati considerati come categoria speciale ed i disoccupati, quando sono divenuti tanti - almeno ufficialmente, tralasciando le questioni del lavoro sommers o - hanno spiazzato le organizzazioni sindacali perché è loro mancato un terreno di lotta sul quale affrontare, insieme a tutti i lavoratori, il nodo di politica economica stretto dalle concentrazioni economico-finanziarie multinazionali) e la incapacità di proposta politica dei partiti, anche essi condizionati da schemi nazionalisti. Sono prevalse le azioni assistenziali su scala nazionale con rigurgiti di nazionalismo e di gretto spirito di impresa che non giovano, a mio parere, nè ai lavoratori nè agli imprenditori e tanto meno al processo di unificazione politica, su basi federali, dell'Europa. Nel momento in cui rischiano di prevalere tendenze disgreganti nella costruzione comunitaria dobbiamo assolvere, come usuale, al nostro compito di autentici europei: iichiedere al C C E alcuni passi ad evitare che il segnale negativo d i Liverpool (v. C.d'E., dicembre 1979) divenga sempre più forte, da una parte; dall'altra, partecipare con onestà ai prossimi incontri dei tre gruppi di lavoro formati d o p o Liverpool non stancandosi di prospettare l'esigenza di un maggiore taglio politico delle questioni da affrontare. P a r l a m e n t o europeo e CCE Ad un solo anno di distanza dalle elezioni del Parlamento europeo sembra quasi esse non vi siano state e scarsi appaiono i rapporti fra le organizzazioni di massa ( C C E ) ed il Parlamento stesso. Ciò, in presenza di un degrado della Commissione C E E e del C o n siglio dei ministri ( & paradossale.. . difenderlo) nei riguardi del Direttori0 degli Stati, lascia spazio ad una alienazione del Parlamento e determina lo svuotamento del C C E per mancanza di interlocutori. La posta in gioco è di non poco conto: lo stemperamento dei problemi politici in settori di apparente concretezza è nocivo per la ripresa di vigore della battaglia europea (sovranazionale e federalista), per la pace e la democrazia nel mondo. direttore responsabile: Giuseppe Piazzoni direttore comitato scientifico: Prot Lucio Susmel direzione e redazione: Roma-116,Viale CastroRelorio -Teleforu,46.4683 amministrazionee abbonamenti GRUPPO GIORNALISTICO EDAGRICOLE Bologna - 3,Emilia Levante - C C p 8/32028 abbonamento zniiuo, L.10.000 , l 6 COMUNI D'EUROPA «Hearing» del P.E. con i rappresentanti delle autonomie locali e' regionali La Commissione d i politica regionale e assetto del territorio del I'arlamento europeo si è fatta promotrice di un hearing>>( o udienza conoscitiva) con rappresentanti delle autonomie locali e regionali della Comunità, svoltosi a Bruxelles il 27 maggio. Accogliend o volentieri I ' i n ~ i t o del p residente della Coinmissione predetta, o n . Pancrazio D e Pasquale, una delegazione rappresentativa del Comitato consultivo delle Istittrzionr loca- . l i e regionalz deglr Stati m e m b ~ della i CEE, che è presieduto congiuntamente da E'lorindo d'Aimmo, presidente della Regione Molise e da Sir Meredith Whittaker, membro del N o r t h Yorkshire C o u n t y Council, ha partecipato alla riunione ( l ) . Scopo dell'incontro era d i favorire un franco scambio di informazioni e d i opinioni tra i parlamentapiù direttamente impegnati nel ri europei . campo della politica regionale e i portavoce delle autonomie territoriali che, per i loro compiti istituzionali, s o n o a diretta conoscenza dei problemi dello sv.iluppo, fanno quotidiana esperienza delle incidenze negative degli squilibri regionali e sono particolarmente sensibili al coordinamento orizzontale - proprio perché enti politici e territoriali a fini generali - dei diversi interventi pubblici e privati in favore dello sviluppo delle comunità locali e regionali e in grado d i meglio verificare l'efficacia delle azioni che la Comunità europea svolge nelle diverse aree. Più specificamente, la discussione si è articolata sui seguenti temi tutti di grande rilievo per il futuro della Comunità e per una sua più incisiva azione nel campo regionale: Sui primi due temi il Clomitato consultivo delle istituzioni regionali e locali aveva già centrato i suoi lavori nel corso della riunione svoltasi a Campobasso nei giorni 1 1 -1 2 aprile e di cui abbiamo dato ampio resoconto su « C o m u n i d'Europa., n. 5 (maggio, 1980). Proprio il dibattito approfondito svoltosi in quella sede e conclusosi con I'approvazione di due elaborati documenti ha permesso al Comitato coiisultivo di portare un apprez.zat o contributo all'incontro con i parlamentari europei. I due documenti finali d i Campobasso pubblicati a cura della segreteria della Commissione d i politica regionale e assetto del territorio (documento PE 65.373 e P E 65.374) hanno fornito una serie di valutazioni, rilievi e suggerimeriti sulla normativa luglio-agosto 1980 comunitaria relativa ai temi predetti; non già in termini astratti ma alla luce dell'esperienza che nei singoli paesi membri è stata fatta d i tale normativa da parte degli enti territoriali nei loro rapporti con la popolazione, con i poteri nazionali e con le istituzioni comunitarie. Sui problemi posti da una revisione della disciplina del Fondo europeo d i sviluppo regionale che dovrebbe entrare in vigore (anche se è probabile uno slittamento) con il 1" gennaio 1981, i rappresentanti degli enti locali e regionali presenti a Bruxelles hanno formulato una serie d i proposte atte a migliorare I'eficacia del Fondo, a concentrarne le azioni, a renderne più spedito il funzionamerito e a rafforzare il loro ruolo nell'elaborazione ed attuazione della politica regionale (di cui il Fondo e solo u n o strumento) I parlamèntari europei e , nel suo intervento conclusivo, lo stesso presidente D e Pasquale, hanno manifestato un sincero apprezzamento per il contributo fornito dai loro i programmi d i sviluppo regionale; le azioni del settore .fuori q u o t a » del F o n d o europeo di sviluppo regionale; - indicazioni e suggerimenti per la futura revisione della disciplina del Fondo europeo di sviluppo regionale. - - ( 1 ) Erano re senti alla riunione: Merrdirh Whittaker, iiietnbro del North Yorkshii-e C o u n t y Council, presidente della Srzionc inglese del C C E e della I L L A e co-Presidente del Comitato consultivo: Elisabetli Gdteau, ~egretariogenerale aggiunto del C C E , co-segretarici del Comitato consultivo; Philippe Waddington, segretario generale aggiunto della I U L A , co-segretario del Coiriitato coiisultivo. I iiieiiibri: P.iiiI Bongers, segr. esec. della Sezione inglese del C C E ; H . J . Brinei. vice presidente dell'Associarione delle Regioni di frontierz dell'Europa; Claude Deloriiie, sindaco di Forcalquier; Hartmut Hausmann, segretario dell'Associazione delle Kegioni di trontiera dell'Europa; Harry Jeurissen, della Sezione olandese del C C E ; M . Kneer, dell'Associazi«ne delle citti e coiriuni tedeschi; H . G . Lang, segretario generale aggiunto dell'Associazione delle città e comuni tedeschi; A . Leidinger, direttore dell'Associazione dei Landkreise Nordrhein-Westfalen; H. Letschert, sindaco d i Tilburg; Mamitsch, della cancelleria del Land Baviera; Gianfranco Martini, segretario generale aggiunto della Sezione italiana del C C E : Aliso Mizzau, assessore alla Regione f:riuli-Venezia Giulia; Georges Pirrret, segretario generale della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d ' E u r o p ì ; G o r d o n Pirie, consigliere della città di Westniinster; J.A. Keijnen, sindaco di Heerlen e presidente della Sezione olandese del C C E ; Charles Ricq, segretario generzle zggiunto della Commissione A G E G ; Wolfgzng Scheuble, presidente dell'Associaziorie delle Regioni di trontiera dell'Europa. Per il Comitato dell'arco alpino ha partecipato Giovanni Martinengo che e anche presidente d e l l 9 U N C E M e membro del Consiglio nazionale dell'AICCE. Certo, I'ltalia è un lus3go splendido per passarci le vacanze. Ad ogni angolo si incoritrano millenni di storia, di arte, di cultura. Ma l'ltalia non e soltanto questo. Italia è anche tc?cnologiaavanzata, paziente ricerca, intelligente inventiva. Ne è un esempio il "Robogate": un impianto industriale completamente "Made in Italy" che unico al mondo consente la saldatura automatica delle scocche d'automobile. Cltalia è anche un mercato aperto, pronto ad intraprendere con qualunque paese estero importanti e validi rapporti commerciali. E l'Istituto Bancario San Paolo di Torino può darvi una mano. Con la sua efficiente e specializzata La tua banca di fiducia da 400 anni. Orqanizzazione Estero. Con i suoi ~ i diu Quattro secoli di storia e di conoscenza del mercato italiano. Il San Paolo puo essere il vostro giusto e sicuro tramite per I'ltalia e per tutti i paesi del mondo. 300 filiali in Italia. Sedi a: Torino, Bari, Bologna, Firenze, ISTITLTTO BI~YCARIO Genova, Milano, Napoli e Roma. S.-\N PAOIO 111 'TIIRlh'O Delegazioni 'di Credito Fondiario a: Cagliari, Catania, Pescara e Reggio Calabria. Istit~Aodi Credito di Diritto Pubblico londato nel 1563 ~ i l i ~estere li a: ~ ~ ~ ~~~~~~~~~t~~~~ ~ ~ a: ~ Sede f Centrale: ~ Torino ~ - Piazza t San ~Carlo. 156 ; Fondi patrimoniali. 813,7 miltardi di lire Londra, Parigi, T0ky0 (A.I.C.1.) e Zurig0. - - s!om luglio-agosto 1980 interlocutori locali e regionali e h a n n o rico?osciuto l'utilità d i più frequenti contatti tra il Parlamento e u r o p e o e i rappresentanti delle autonomie territoriali nell'intento d i assicurare a questo necessario dialogo contenuti sempre più concreti e specifici. C i ò n o n significa naturalmente, è stato sottolineato, voler ridurre la partecipazione degli enti locali e regionali al processo d i integrazione europea solo ad aspetti, p u r importanti, d i natura tecnica e finanziaria: il loro a p p o r t o è invece a u s ~ i c a b i l eed estremamente utile ad entrambe le parti se d e t t o dialogo si colloca in una indispensabile prospettiva politica, cioè d i rafforzamento delle istituzioni rappresentative ai diversi livelli, d i apertura d i più ampi spazi d i collaborazione e d i partecipazione e d i una migliore canalizzazione nei d u e sensi dei flussi d i informazione. La Commissione delle C o m u n i t à europee pubblica periodicamente delle « schede e u r o pee ,, su vari argomenti, destinate all'opinione pubblica generalizzata. I n una scheda recente che contiene una serie d i d o m a n d e e risposte sulla C o m u n i t à europea, viene affrontato anche l'argomento, sempre così attuale e d essenziale, dell'incidenza della C o m u n i t à sulla realtà regionale c o n particolare riguardo a COMUNI D'EUROPA NUOVE ADESIONI DI ENTI TERRITORIALI LOCALI ALL'AICCE Amministrazione provinciale di: a b . Foggia. . . . . . . . 657.292 C o m u n e di: San Bellino ( K O ) Panicale (PG) 1.324 5.050 quella delle aree più deboli e in difficoltà. Ebbene, è p r o p r i o moltiplicando i contatti fra i rappresentanti democratici d i tali regioni e le istituzioni comunitarie che si contribuisce a rendere l'azione d i queste ultime in favore d i u n o sviluppo territorialmente più equilibrato più pronta, più adeguata, più continuativa e più prossima al cittadino. 11 Consiglio dei C o m u n i d'Europa e il C o m i t a t o consultivo degli enti regionali e locali che esso ha contribuito, in m o d o determinante, a costituire, intendono fare sempre più d i questa collaborazione u n p u n t o qualificante della loro azione politica. Giovanni Franchi L'integrazione europea all'esame della XV CPLRE Dal 10 al 12 giugno si t svolta a Strasburgo la X V sessione plenaria della Conferenza dei poteri locali d'Europa. O g n i a n n o , infatti, questo organismo consultivo creato alla fine degli anni '50 nell'ambito dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, riunisce le delegazioni dei 21 paesi membri oltre ad alcuni osservatori di paesi esterni. La delegazione italiana, formata previa intesa tra I'AICCE, I ' A N C I , I'UPI e I ' U N C E M , ha p o t u t o assicurare una efficace presenza ai lavori della Sessione nonostante essa si aprisse immediatamente a ridosso dei giorni d i voto p e r le elezioni comunali, provinciali e regionali (*),. Nella prima giornata dei lavori s o n o stati eletti il presidente della Conferenza (lo svizz e r o Bernard D u p o n t presidente della Sezion e svizzera del C C E ) e i vice-presidenti. Successivamente si è aperto un dibattito sullo stato dell'integrazione europea introdotto d a u n a m p i o rapporto presentato, a n o m e della Commissione permanente, dal borgomastro d i Russelsheim (KFT) Karl Storsberg, che t: al t e m p o stesso presidente della Sezione tedesca del C C E , sul tema: <' I progressi dell'integrazione europea n. U n a serie d i comunicazioni presentate rispettivamente dal presidente in esercizio del C o m i t a t o dei Ministri del Consiglio d'Europa, dai rappresentanti dell'Assemblea parlamentare e del Segretario generale di detta istituzione, nonché del Parlamento e u r o p e o e della Coinmissione della C o m u n i t à europea h a n n o fornito ai delegati un a m p i o panorama sull'attività del Consiglio d'Europa e della C o m u n i t à e sulle linee orientative del loro impegno futuro. N e l corso dei successivi lavori della Conferenza s o n o stati affrontati, in m o d o più diretto, il ruolo e i1 bilancio politico ed operativo della Conferenza stessa nonché temi specifici d'interesse locale e regionale sulla base d i 3 rapporti: «L'azione degli enti locali e regionali nel campo della protezione dell'ambiente d i fronte allo sviluppo dell'energia nucleare D (relatore la signora Helena Rosetadella delegazione portoghese, a n o m e della Commissione per l'ambiente e l'urbanistica); .Le istituzioni regionali in E u r o p a (relatore A . Galette della delegazione tedesca, a n o m e della Commissione delle strutture e delle finanze locali) ; La cooperazione transfrontaliera in E u r o p a (relatore i1 sindaco di Losanna, Delamuraz, a n o m e della Cominissione dei problemi regionali e dell'assetto del territorio); quest'ultima relazione t stata poi integrata da una comunicazione sugli aspetti culturali d i detta cooperazione (presentata d a T h e o d o r H o t z della delegazione svizzera a n o m e della C o m m i s sione culturale). Giancarlo Piombino, presidente delI ' A I C C E e capo delegazione italiana ha illustrato il progetto di parere sul secondo piano a inedio termine ( 1 981 -1 986) del Consiglio d ' E u r o p a , s o t t o il profilò delle sue incidenze sulla realti locale e regionale e quindi sulla futura attività della Conferenza. L o stesso Piombino e E n z o Baldassi, deputato nazionale e m e m b r o del C o m i t a t o esecutivo d e l l l A I C C E , s o n o stati designati a far parte della Cominissione permanente: gli altri delegati italiani si s o n o ripartiti tra le varie commissioni e gruppi d i lavoro. G i u seppe Bufardeci, vice presidente vicario dell'AICCE è stato designato quale rappresentante della conferenza al C o m i t a t o organizzativo della campagna p e r il rinnovamento della città. I n considerazione della complessità degli argomenti posti all'ordine del giorno anche d i questa sessione e d a t o che è stata ripetutamente constatata l'opportunità d i adeguare l'attività della Conferenza sia alle esigenze prioritarie degli enti locali e regionali sia al ruolo specifico del Consiglio d'Europa rispetto ad altri organismi ed istituzioni (in p r i m o luogo la C o m u n i t à europea), i delegati italiani h a n n o convenuto sulla necessità d i mantenere più stretti collegamenti con loro e con I'AICCE al fine d i : a) meglio coordinare la loro attività nelle diverse commissioni; b) assicurare il rispetto d i una c o m u n e linea politica; C) contrastare eventuali proliferazioni d i iniziative non necessarie; d) evitare il rischio d i dispersione. I n vista d i ciò potrebbe anche rivelarsi utile un incontro della delegazione italiana con il presidente neoeletto della Conferenza. Alla vigilia della Conferenza, il 9 giugno, si era riunito a Strasburgo il Comitato d i presidenza del CCE per la messa a p u n t o d i u n orientamento unitario della nostra associazione, e dei suoi m e m b r i nelle varie delegazioni nazionali, nel corso dei lavori della Conferenza. Vi h a partecipato per I ' A I C C E l'on Baldassi: gli altri membri del C o m i t a t o d i presidenza erano stati trattenuti nelle rispettive sedi p e t le conclusioni delle operazioni del voto regionale e amministrativo. G.M. '-L'elenco dci delegati italiani, trasinesso al Consiglio d'Europa tramite il ministero dell'lnterno, era il seguente (sono in corsivo i nomi dei delegati presenti a Strasburgo): Walter Anello - membro della Direzione della Lega per le Autonomie e i Poteri locali; Enzo B a l d ~ s i i -Deputato- Palazzo Montecitorio - Roma; Rosario Ballatore - Presidente della Provincia di Trapani; Enzo Bernardi - Consigliere regionale del Lazio; Armando Bertorelle -Presidente della prima Cominissione di Studio dell'AICCE: "Le strutture dell'amrninistrazione locale e la finanza locale"; Moreno Bucci- Consigliere comuiiale d i Viareggio; Gluseppe Bufardeci - Consigliere comunale di Forino - Vice Presidente Delegato A I C C E ; Teresa Grrya Cantoni - Consigliere comunale di Pesaro; Filippo Caria Assessore alla Regione Campania; Stelio De Carolis - Consigliere provinciale di Forli; Giorgio De Sabbata - Senatore - Palazzi) Madama - Roina: Aurrlio Dozlo - Sindaco di Erve; Nicola Girolami - .Consigliere provinciale di Roma; R e n ~ t oGrilli Assessore alla Provincia di Parina; Libero Lucconi -Consigliere regionale delle Marche; Angiolo Marroni - Vice-Presiderite della Provincia di Roina; Edourdo Martiriengo- Presidente dell'Uriione Nazionale Comuni ed Enti montani ( U N C E M ) ; Grarifia~ico Martini - Segretario Generale Aggiunto dell'A.1.C.C.E.; Ezio Martone - Vice -Presidente deHa Provincia di Tricste; Ugo Marzola - Presidente della 1)rovintia di I'errara; Car~rillo.LloserSegretario Generale dell'UPI; Giorgio Pasìtto - Consigliere coniunale di Anzio - Consigliere Proviiiriale di Konia; Maurizio Pessato - Assessore alla Provincia di Ti-ieste; Tonino Piazzi Consigliere cornunale <liCastelnovo ne' Moiiti; Giuseppe l'iazzoni- Segretario Generale d e l l ' U N C E M ; Giancarlo I>iombrnoConsigliere Comunale di Genova - Presidente dell'AICCE; Franco Ravà - Presidente della Provincia di Fircrize - Presidente dell'U.I'.I.; C a m ~ l l oKipamonti- Senatore - Sindaco di Gongorzola - Presideiite dell'ANCI; Ario Kupeni - Consigliere circosrrizioiiale di Koinl: Dornenico Santese - Sindaco di Sanarica. Umberto Seratini - Consigliere coniunale di Vidracco - Segretario generale dell'AICCE; Dante Stefani - senatore - Segretario nazionale della Lega per le Autonomie e i Poteri locali; Luigi Tarricone - Presidente del Consiglio regionale della Puglia: Ferdimndo Vera - Consigliere comunale di Reano - Consigliere regionale del Piemonte; U g o Vetere - Deputato - Assessore al C o m u n e di Roma; Gian Carlo Zoli - Consigliere comunale di Bagno a Ripoli. COMUNI D'EUROPA 8 luglio-agosto 1980 Riassunto schematico del1 'attività del Consiglio dei Comuni CCE I Comrnissione culturale e sottocommissione per la preparazione del IV confronto europeo delle città storiche (Bruxelles, 27 marzo) R i u n i o n i istituzionali del CCE A Commissione delle strutture e la finanza locale (Nam u r , 23-25 aprile) Riunione preparatoria della Commissione permanente (Madrid, 19 maggio) e Con~missionePermanente (Madrid 20 maggio) R i u n i o n i degli o r g a n i dirigenti Bureau (Parigi, 21 -22 gennaio) Comitato d i presidenza (Torino, 26 marzo) Comitato d i presidenza (Strasburgo, 9 giugno) B Varie Incontro informale tra la Sezione italiana e la Sezione olandese del C C E per la preparazione del Bureau (Parigi, 20 gennaio) IV Conferenza tra i ministri responsabili degli enti locali e le delegazioni dell'Assemblea parlamentare e della C P L R E (Madrid, 21-23 maggio) XV sessione plenaria (Strasburgo, 10-12 giugno) Preparazione e pre-rapporto sul regolamento interno e gli eventuali emendamenti statutari del C C E (Strasburgo, 18 marzo) Cornmissione culturale (Strasburgo, 11 giugno) Corninissione ambiente e urbanistica (Strasburgo, 11 giugno) Riunione del gruppo d i lavoro europeo per la preparazione del ~ D o s s i e rEuropa>)(Torino, 27 marzo) Assemblea generale della Sezione olandese del C C E (Hulst, 24-25 aprile) Commissione per i problemi regionali e la pianificazione del territorio (Strasburgo, 11 giugno) I V Convegni, I n c o n t r i , Colloqui, promossi dal C C E Riunione dei segretari generali delle Sezioni del C C E (Parigi, 8 maggio) Convegno su «Gli enti locali di fronte ai problemi della salute., (Grenoble, 1-2 febbraio) Incontro con la Commissione d i gestione della costituenda Sezione spagnola del C C E (Madrid 19 maggio) I1 Attività in collegamento c o n la C o m u n i t à europea Tavola rotonda sul tema .Vogliamo veramente l'Europa unita., promossa dal C C E e dal Consiglio regionale del Piemonte (Torino, 27 marzo) Riunione preparatoria per la creazione dell'Intergruppo degli eletti locali e regionali del Parlamento europeo (Strasburgo, 16-17 gennaio) Incontro fra amministratori locali italiani e francesi su * I problemi dell'integrazione europea., promosso dalla Sezione italiana e dalla Sezione francese del C C E (Torino, 28 marzo) Contatti vari con la Cornrnissione per la politica regionale e assetto territoriale del Parlamento europeo (Bruxelles, 28-29 gennaio e 24-25 aprile) Partecipazione allo ~ H e a r i n g . della Commissione ambiente, della salute pubblica e della protezione dei consumatori del Parlamento europeo (Dublino, 26-27 febbraio) Partecipazione al Congresso su .I1 patrimonio architettonico europeo., promosso dalla commissione C E 5 in collaborazione con i1 Consiglio d'Europa (Bruxelles, 27-29 marzo) Riunione del Comitato consultivo delle Istituzioni regionali e locali dei Paesi membri della C E E (Cainpobasso, 11-12 aprile) I Riunione dell'Intergruppo degli eletti locali e regionali del Parlamento europeo (Strasburgo, 17 aprile) Consegna del Trofeo europeo di civismo alla città d i Ravenna (Ravenna, 3 maggio) Partecipazione allo "Hearingn della Comrnissione d i politica regionale e assetto del territorio del PE e Bureau del Comitato consultivo delle Istituzioni regionali e locali dei Paesi membri della C E E (Bruxelles, 27 maggio) Riunione dell'lntergruppo degli eletti locali e regionali del P E (Strasburgo, 17 giugno) I11 Attività in collegamento c o n il Consiglio d'Europa Seininario su « L a Coinunità europea negli anni '80., promosso dalla Maison de 1'Europe (Marienberg, 13-15 giugno) Riunioni della C o n f e r e n z a dei P o t e r i locali e regionali europei (CPLRE) e dei s u o i o r g a n i p e r m a n e n t i Bureau (Parigi, 25 gennaio) Commissione ambiente e urbanistica (Strasburgo, 20 febbraio) Commissione permanente (Strasburgo, 21-22 febbraio e 13 giugno) Corninissione per i problemi regionali e la pianificazione del territorio e sottocommissione delle Regioni rurali, agricole e di rnontagna (Strasburgo, 17-18 marzo) V Attività varie A Gemellaggi e scambi Bardonecchia (I) M o d a n e (F): l a cerimonia d i gernellaggio a Bardonecchia (15 giugno); 2" cerimonia di gemellaggio a Modane (29 giugno) L a r i a n o (I) Sausset les Pins (F): l a cerimonia di gernellaggio a Lariano (25 maggio) Lecco (I) M a c o n (F): concerto dell'Accademia corale d i Lecco a Macon (aprile); incontro quadrangolare di rugby a Lecco e concerto della corale « A coeur Joie. d i M i c o n a Lecco (maggio); visita a Lecco d i una delegazione ufficiale dell'amministrazione comunale d i M i c o n , guidata dal sindaco (6-8 giugno); soggiorno d i 22 studenti lecchesi presso le famiglie di M i c o n (giugno) Lucca (I) C o l m a r (F) S c h o n g a u (RFT) Sint Niklaas (B) Abingdon (GB): riunione di funzionari comunali delle città gernelle a Colinar per la inessa a punto del programma di attività (2 febbraio); congresso dei giovani delle città gemelle a Colmar per discussione su contenuti e organizzazione delle attività da svolgere per la costituzione di Comitati per le attività giovanili (a Lucca t. stato già costituito) (17-18 febbraio); torneo di calcio a Colmar (24-25 maggio); scambi di giovani studenti con Schongau e Colmar (marzo e maggio); concerto della banda d i Sint Niklaas a' Lucca (20 giugno); riunione dei sindaci delle città gemelle a Lucca con la presenza d i delegazioni ufficiali, in occasione del11inaugurazi6ne di Palazzo Fanner (20-22 giugno) M a r i n o (I) Boulogne Billancourt (F) Neukoelln (RFT) Z a a n d a m (PB) Anderlecht (B) H a r n m e r s m i t h (GB): soggiorno d i 20 bambini di Marino a Boulogne Billancourt, scambio in reciprocità (gennaio); soggiorno d i 24 bambini d i Boulogne Billancourt, inseriti in classi parallele di scuole di Marino, per scambio d i esperienze e d i materiale didattico (febbraio); cerimonia d i rinnovamento del gemellaggio a Zaandain con la luglio-agosto 1980 COMUNI D'EUROPA XVII (1) La politica energetica della Comunità europea e gli Enti locali di Gianfranco Martini segretario generale aggiunto dell'AICCE 'Pubblichiamo il testo integrale della comunicazione presen tuta a nome dell'AICCE dal segretario generale aggiunto Gianfranco Martini al convegno svoltosi a Roma il.15 aprile e promosso dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia ( A N C I ) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)sul tema: «Ruolo dei comuni e delle loro aziende nella politica d ell'en ergia ». L'iniziativa predetta ha fornito ai partecipanti (amministratori locali e regionali, dirigenti di imprese pubbliche locali particolarmente interessate all'argomento ed esperti) ampio materiale di riflessione e di dibattito; lo svolgimento del programma ne offre suficien te testimonianza. Ricordiamo in particolare la relazione generale del vice presidente delegato della CISPEL, Carlo Castagnoli, seguita dalla relazione sulla metanizzazione del Mezzogiorno di Attilio Oliva, presidente della F N A M G A V. Sono seguite alcune comunicazioni: oltre quella d i Martini che pubblichiamo, ricordiamo fra le altre quelle sulle indicazioni e proposte della Federelettrica per più eficienti ed economici sistemi d i illuminazione pubblica e sulle prospettive di sfruttamento. dell'energia solare in base alle ricerche condotte dal Craies di Verona nonché quella del sindaco di Brescia Cesare Trebeschi, sulla produzione combinata energia-calore e il teleriscaldamento. Le finalità del convegno sono state sottolineate negli intementa di apertura e in conclusione dei lavori rispettivamente, dal presidente dell'A N C I , Sen. Hiparnonti e dall'On. Sarti, presidente della CISI'EL. Si è voluto offrire, con le relazioni, con le comunicazion i e con il dibattito un orientamento agli amministratori comunali e ai responsabili delle loro aziende sulle possibilità e le prospettive di impegno e di realizzazioni concrete nella soluzione dei gravi problemi che oggi caratterizzano tutto il settore dell'energia e che condizionano in misura così determinante non solo lo sviluppo economico ma anche l'intera uescita sociale. Gli atti del convegno, già in corso di stampa, forniranno ampiamente la base, sul piano politico e tecnico, ad ulteriori approfondimenti su un tkma che è destinato a rimanere uno degli elementi condizionanti l'intero sistema economico mondiale e quindi lo stesso processo 'di integrazione europea. Il tema dellénergia si intreccia sempre piW anche con l'ambito di competenza e con le responsabilità specif;che degli enti regio- nali e locali, non solo per le ovvie incidenze che esso ha sulla popolazione, ma in considerazione unche delle iniziative che detti enti possono e debbono assumere nel campo energetico, per favorire le indispensabili economie di energia, favorire l'accesso a fonti alternative, garantire la salvaguardia dell'ambiente umano e naturale e utilizzare tutte le opportunità che le iniziative e gli strumenti della Comunità europea offrono per meglio fronteggiare la sfida energetica degli anni '80. Proprio per questo la Federazione iombarda dell'AICCE si era fatta promotrice in data 8 Marzo 1980 di una giornata di studio a Brescia sul tema: «programma energetico e programmazione locale in Lombardia*. I lavori si sono articolati su tre relazioni: «aspetti qualitativi e quantitatiui del problema energetico~;«ii;rfrastrutture energetiche e politiche del territorio» e «energia e problem i di localizzazio?ze in Lombardia» introdotte dal sindaco di Brescia, Cesare Trebeschi. Hanno partecipato all'incon tro il segretario generale aggiunto dell'AICCE, Gianfranco Martini, e il Borgomastro della città di Bussum (Paesi Bassi) che ha svolto una interessante comunicazione sui problemi, le esperienze e le realizzazioni degli - Enti locali olandesi in materia energetica. *C 1) I problemi degli Enti locali e regionali e il ruolo dell'AICCE In questo Convegno, opportunamente promosso per dibattere un tema di grande rilevanza pratica pt:r i Comuni ed altri enti locali, la partecipazione dell'AICCE (Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa) ha un suo specifico significato e una sua precisa finalità. L'AICCE, infatti, è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa, organismo sovranazionale europeo che raggruppa attualmente non solo i Comuni, ma anche le autorità territoriali a livello regionale ed intermedio. La sua attività mira a sensibilizzare - politicamente, in primo luogo gli eletti locali e regionali europei ai problemi dell'unificazione politica, e non solo economica, dell'Europa secondo un modello federale, facendo sì che questo processo di unificazione non risponda a schemi centralistici; ma rispetti e potenzi tutte le autonomie territoriali, garanzia di democrazia, di pluralismo, di ricchezza di apporti diver- si pur nel comune impegno verso gli Stati Uniti d'Europa. Accanto a questo obiettivo, va ricordato anche il complesso sistematico di iniziative volte a fornire agli enti territoriali un "servizio" di informazione, documentazione, scambio di esperienze che attualmente non costituisce più soltanto un contributo culturale, ma un mezzo ormai indispensabile per rendere più efficace la stessa attività amministrativa o legislativa dei Comuni, delle Province, delle Regioni. Infine, proprio questa compenerrazione di attività locali e regionali e di <<politiche» della Comunità europea rende sempre più necessario un corretto rapporto di consultazione, di collaborazione, di partecipazione degli enti territoriali alla elaborazione ed attuazione delle norme, delle iniziative e delle politiche comunitarie: ciò evidentemente richiede un sistema di dialogo e di contatti tra i predetti enti e le istituzioni della Comunità europea (il Parlamento eletto, la Commissione, il Comitato economico e sociale): alcuni risultati positivi sono stati già raggiunti in questa direzione, come vedremo, ma si tratta di passare sollecitamente ad una fase meno sperimentale e pragmatica e più istituzionalizzata. 2) Politiche nazionali e politiche europee: una progressiva interdipendenza Questa premessa non ha soltanto il valore di una presentazione, ma serve anche a capire meglio in quale ambito e quindi anche con quali limiti I'AICCE interviene a portare un proprio contributo alla tematica oggetto del Convegno. Si tratta dunque di fornire alcuni elementi essenziali di conoscenza sui programmi e sulle realizzazioni della Comunità europea nel campo energetico. In questa materia così complessa, in cui si mescolano studi, riflessioni, ipotesi di lavoro, progetti, provvedimenti normativi, abbiamo scelto, con criterio che certamente potrà non essere esente da rilievi, ma in qualche maniera inevitabilmente soggettivo, alcuni dati che ci sembravano di più diretta utilità per gli amministratori locali italiani. Ciò che ci preme sottolineare è che le principali politiche nazionali (tra queste, certamente, quella energetica) non sono più concepibili e realizzabili avulse dal quadro di riferimento europeo. N o n si tratta qui soltanto del condizionamento esterno che le vicende internazionali da sempre esercitano sulle economie e sulle (2) XVIII società nazionali, ma dell'intreccio crescente che un sistema d i solidarietà istituzionalizzata (qual'è appunto la Comunità europea) provoca tra scelte nazionali e scelte europee. 3) La Comunità europea e i problemi energetici: motivazioni ed orientament i fondamentali (1) Tralasciamo l'analisi dei problemi - certamente determinanti - che si collocano però a monte del nostro Convegno, cioè l'importanza essenziale dell'approwigionamento energetico, la sua incidenza sullo sviluppo economico e sociale dell'intera Comunità europea e sul tenore di vita dei suoi cittadini, l'evoluzione che ha contraddistinto i consumi di circa 260 milioni di cittadini dei paesi membri, le condizioni diverse, ad esempio sotto il profilo dei prezzi, in cui l'approvvigionamento di energia awiene oggi rispetto al passato. Tutto ciò può essere letto e verificato in innumerevoli pubblicazioni. Può invece essere utile ricordare che le prime iniziative prese dalle istituzioni europee per coordinare l'azione degli Stati membri della Comunità nel settore energetico risalgono al 1962, ben prima della crisi. Una tale azione, in pieno periodo di euforia, si giustificava: a) In virtu dei trattati della C E C A e dell'Euratom. La Comunità europea del carbone e dell'acciaio è stata costituita nel 1951 ; l'Euratom, la Comunità europea dell'energia atomica, nel 1957. I problemi che la penetrazione del petrolio importato doveva necessariamente porre all'industria del carbone, così come i suoi e'ffetti sullo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, esigevano un approccio europeo globale dei problemi energetici. b) In virtu del trattato che istituisce la Comunità economica europea. I Nove hanno un dovere di solidarietà; devono aumentare la sicurezza dei loro approwigionamenti energetici ed evitare che si verifichino tra di loro distorsioni o squilibri tali da compromettere la realizzazione del mercato comune e dell'unione economica. I1 grado di dipendenza nei confronti delle importazioni non è infatti identico per tutti gli Stati membri dato che alcuni di essi dispongono di maggiori risorse indigene. La crisi dell'energia ha reso ancora più imperiosa e urgente la necessità di una politica comune in questo settore. Infatti: a) L'Europa occidentale è apparsa molto vulnerabile. Le interruzioni o le restrizioni delle forniture, nonché i forti aumenti dei prezzi, hanno sollevato nei nostri paesi innumerevoli problemi economici. b) Le reazioni nazionali isolate e disperse si sono rivelate inefficaci; alle prese con il fronte dei paesi produttori, i paesi consumatori devono reagire in maniera solidale. (1) Più ampie informazioni possono essere ricavate dalle pubblicazioni ufficiali e dagli studi della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo ai quali abbiamo largamente attinto. COMUNI D'EUROPA luglio-agosto 1980 più basso g a d o possibile di rischio per i lavoratori, per le popolazioni e per l'ambiente. I1 loro sfruttamento deve anche tener conto del carattere limitato delle risorse materiali di cui dispone l'umanità. e) L'accresciuta autonomia che occorre perseguire non può condurre all'autarchia. Con le fonti e le riserve di energia delle quali dispone, l'Europa non può aspirare ad essere autosufficiente. O allora sarebbe necessario un tale sforzo di ricerca e d'investimento che il prezzo dell'energia sarebbe troppo elevato. L'energia deve d'altra parte conservare un posto negli scambi internazionali: alcuni prodotti, il petrolio per esempio, costituiscono per certi paesi esportatori una risorsa pressoché unica e il principale mezzo di sussistenza e di sviluppo. C) La ricerca di una minore dipendenza dagli approvvigionamenti esterni è diventata assolutamente indispensabile. N o n la si può ottenere soltanto attraverso il gioco spontaneo delle forze economiche sul mercato. Essa implica al contrario un insieme di misure che riguardano fattori molteplici, e dunque una politica energetica globale inquadrata anch'essa in una politica economica e sociale a lungo termine. L'unità del mercato comune e la realizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria dei nostri paesi esigono dunque una politica dell'energia che sia, in larga misura, comune ai Nove. Una politica comune è anche una condizione di efficacia, essa permette infatti: a) di evitare gli sforzi nazionali dispersi o contraddittori e i doppi impieghi che essi comportano, in particolare nel campo della ricerca scientifica. b) di trar partito dal peso economico e politico di un'entità di 260 milioni di abitanti nelle relazioni con gli altri paesi importatori di energia, con i paesi produttori nonché con le società multinazionali che dominano il settore della commercializzazione. Purtroppo siamo ancora assai lontani da una vera e propria politica comune dell'energia in sede europea. Questo risultato è il frutto di una presa di coscienza non puramente verbale della nuova situazione, è condizionata da un profondo mutamento di mentalità e di comportamenti da parte delle autorità nazionali degli Stati membri, è legata ad un reale e rapido progresso verso forme di sostanziale integrazione sul piano economico e politico, cioè alla costituzione di un vero e proprio governo europeo capace di scelte coordinate e globali in sostituzione di quella che spesso è ancor oggi re va lente mente - una forma di cooperazione intergovernativa. Si possono tuttavia individuare fin d'ora alcuni orientamenti fondamentali ai quali questa politica energetica comune europea dovrebbe ispirarsi:. a) conviene economizzare l'energia, risorsa rara e costosa, utilizzandola più razionalmente. Una crescita economica sostenuta deve ormai essere combinata con un aumento proporzionalmente minore del consumo di energia primaria. b) la sicurezza dell'approvvigionamento e la sua regolarità, in quantità e in prezzi, sono nell'insieme meglio assicurate dalle forniture indigene che dalle importazioni, sottoposte a grandi rischi. E' necessario dunque ricercare un alto grado di autonomia a condizioni di prezzo accettabili. C) L'obiettivo della sicurezza e della stabilità degli approvvigionamenti è anche facilitato dalla diversificazione delle fonti. l rischi di interruzione delle forniture e di aumento dei prezzi sono minori se si ricorre a delle fonti di natura e di origine geografica molteplici. d) Le risorse accertate che ci si sforza di mobilitare e le nuove fonti di energia che ci si sforza di .sviluppare devono presentare il 4) La Comunità europea e i problemi energetici: le tappe principali della sua attività normativa e di indirizzo ' Quando si fa riferimento alla Comunità europea (più esattamente, alle Comunità europee, CECA, CEE ed Euratom, ancora formalmente distinte se pur rette da organi comuni) è opportuno precisare che i problemi energetici hanno fatto oggetto di prese di posizione, regolamentazioni normative, disposizioni programmatiche ed orientative da parte della Commissione, del Consiglio dei ministri e del Parlamento, ciascuno secondo le proprie competenze e secondo il ruolo specifico che tali organi svolgono nel complesso quadro istituzionale delineato dai Trattati: di impulso, di proposta, di gestione per quanto riguarda la Commissione, di decisioni normative definitive il Consiglio, di partecipazione alla funzione normativa e di controllo politico e di bilancio il Parlamento europeo, specie dopo la sua recente elezione diretta. Anche il Comitato economico e sociale, nella funzione consultiva che gli è propria, ha concorso a delineare un complesso di azioni comunitarie nel campo energetico. Per limitarci agli anni più recenti, quando cioè il problema energetico ha assunto connotati di maggiore urgenza e drammaticità, ricordiamo che i fondamenti di una politica europea comune dell'energia sono già stati posti a seguito delle iniziative prese ai Consigli dell'ottobre 1972 e del dicembre 1.973. Alla fine del 1974 e agli inizi del 1975, sono state approvate dal Consiglio tre risoluzioni che definiscono orientamenti generali per la politica comunitaria e obiettivi settoriali specifici per il 1985. Nella prima risoluzione, si è stabilito che la "politica energetica comunitaria" significa l'elaborazione di comuni obiettivi numerici che servano da riferimento per le politiche nazionali e anche per i produttori ed i consumatori di energia della Comunità; uno stretto coordinamento delle posizioni degli Stati membri della Comunità per consentire a quest'ultima di esprimere un punto di vista comune sui problemi energetici nei confronti dell'estero; una partecipazione comunitaria che si esprima attraverso la coo- luglio-agosto 1980 perazione con altri paesi consumatori da un lato e tra paesi consumatori e paesi produttori dill'altro lato. Nella risoluzione si afferma inoltre che la politica energetica comunitaria dovrebbe mirare a ridurre la domanda energetica, a migliorare la sicurezza dell'approwigionamento mediante lo sviluppo di risorse interne e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne. Nella seconda risoluzione sono fissati gli obiettivi per il 1985: riduzione della dipendenza della Comunità, nei confronti dell'energia importata, al 50% e possibilmente al 40%; ripartizione di quote e di obiettivi di produzione per ogni tipo di combustibile nel bilancio energetico generale; riduzione del consumo energetico del 15% rispetto alle previsioni elaborate nel 1973 per il 1985 (cioè 1.450 milioni di tep anziché 1.700 milioni di tep). Nella terza risoluzione del febbraio 1975 si specificano le politiche e le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi convenuti attraverso sostegni comunitari, politiche di prezzi volte a favorire gli investimenti, interventi di sostegno a favore del carbone, una politica comunitaria di approvvigionamento del combustibile nucleare nonché una maggiore trasparenza del mercato petrolifero della Comunità. Queste risoluzioni restano la base formale della politica comunitaria e hanno ispirato in larga misura la successiva legislazione e azione comunitaria in materia. Dopo il 1973-1974, si sono aggiunti però diversi altri obiettivi. Ai Consiglio europeo di Brema (1978) è stato deciso di ridurre il rapporto tra la crescita della domanda energetica e la crescita del PIL della Comunità a 0,8 entro il 1985 grazie a misure rigorose di risparmio di energia. E' stato ribadito l'obiettivo di una dipendenza energetica da ridurre al 50% per il 1985. I1 Consiglio europeo svoltosi nel marzo 1979 a Parigi ha deciso di contenere il consumo di petrolio del 1979 al livello di 500 milioni di t., vale a dire una diminuzione, rispetto alle previsioni precedenti, di poco superiore al 5% convenuto da tutti i paesi dell'AIE. A1 ' Consiglio europeo di Strasburgo (giugno 1979), si è deciso d i mantenere fino al 1985 le importazioni ad un livello pari o inferiore a quello del 1978, a condizione di un impegno analogo da parte degli altri paesi industrializzati. Al vertice economico di Tokio del giugno scorso vi sono state indicazioni soddisfacenti in questo senso. L'attività della Comunità nel campo energetico si sviluppa in vari settori che ci limitiamo a indicare, non essendovi, obiettivamente, la possibilità di approfondirne i contenuti. Vi è una piattaforma di proposte, analisi ed obiettivi che costituiscono il punto di partenza per stabilire le tendenze energetiche nella Comunità e la direzione e la convergenza dei programmi degli Stati membri. La politica dei prezzi è considerata la chiave di volta del risparmio di energia, oltre a favorire le condizioni propizie agli investimenti (che alcuni strumenti finanziari COMUNI B'EUROPA della Comunità contribuiscono ad incrementare). I1 risparmio di energia è un elemento essenziale della complessa politica energetica: per la sua importanza generale e per lo specifico interesse per gli enti locali, vi dedicheremo il prossimo paragrafo della presente relazione. I1 programma comunitario di ricerca energetica persegue tre obiettivi: migliorare le conoscenze sulla tecnologia nucleare (in particolare le tecniche e le norme di sicurezza), migliorare le tecniche volte a risparmiare energia ed ampliare le conoscenze sulle nuove fonti energetiche. Inoltre, la Commissione comunitaria, ben sapendo che il ritardo con cui un risultato soddisfacente a livello di laboratorio trova la piena applicazione commerciale è spesso riconducibile in parte alla difficoltà di ottenere finanziamenti nel periodo di lancio, ha proposto un sistema di interventi finanziari a favore di progetti dimostrativi. Per singole fonti energetiche (petrolio, carbone, energia elettrica e nucleare) ricordiamo che, a medio termine, gli obiettivi della Comunità possono essere così sintetizzati: Per il petrolio. Migliori relazioni con i paesi produttori; diversificazione degli approvvigionamenti esterni; maggiore esplorazione all'interno della Comunità per impedire una contrazione della produzione dopo il 1990; continuazione delle azioni di risparmio e di sostituzione del petrolio; limitazione del petrolio ad usi speciali; limitazione delle importazioni a 470 milioni di t. fino al 1990. Per il carbone. Incremento delle capacità di consumo e di produzione del carbone; commercializzazione delle tecniche di gasificazione e fluidificazione del carbone. Per l'energia elettrica e nucleare. Impedire un ulteriore slittamento dei programmi di costruzione di centrali nucleari in modo da disporre nel 1990 di una capacità quasi uguale alle previsioni nazionali; sfruttamento massimo delle possibilità del carbone e del nucleare nella produzione di energia elettrica; accordo sulla politica comunitaria in materia di ritrattamento, superconvertitori e smaltimento dei rifiuti; accordo sulla politica riguardante il capo VI del trattato Euratom; risultati soddisfacenti nelle trattative con l'Australia e il Canada e nelle discussioni con gli USA sull'approwigionamento di combustibili nucleari; riduzione della dipendenza esterna per i combustibili nucleari. Fin qui c i siaino soffermati soprattutto sull'attività del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee. I1 Parlamento europeo, prima e dopo la sua elezione a suffragio universale e diretto, ha svolto, anche in questo campo, la sua importante funzione di controllo, di contributo alla definizione delle varie politiche ed azioni della Comunità e di dibattito democratico con la partecipazione delle varie forze politiche e dei rappresentanti eletti dei cittadini europei che ad essi si richiamano. l1 Parlamento europeo ha proseguito, con particolare vigore dopo la sua elezione diretta, la sua funzione di apporto critico alla normativa comunitaria anche nel campo della politica energetica. Senza fare richiami dettagliati ai vari dibattiti parlamentari su questo argomento (il che avrebbe scarso significato senza una corrispondente analisi dei ~ r o b l e m iaffrontati e delle diverse posizioni emerse) ci sembra tuttavia indispensabile ricordare che il Parlamento europeo si muove su linee ben diverse da quelle del Consiglio dei ministri ancora legato a valutazioni nazionali e, spesso, a defatiganti compromessi intergovernativi sui quali si arenano i tentativi di elaborazione di una vera politica energetica europea. Va pure sottolineato che, a monte di varie politiche (tra cui anche quella energetica) il Parlamento europeo ha condotto e conduce una battaglia politica per una nuova impostazione - in termini di maggiori disponibilità e di diverso equilibrio delle varie voci - del bilancio comunitario tale da condizionare positivamente l'azione futura della Comunità e porla meglio in grado di affrontare i gravi problemi che le stanno dinnanzi. I1 Comitato economico e sociale ha anch'esso svolto il ruolo consultivo che i Trattati comunitari gli attribuiscono, dando il suo apporto di organismo rappresentativo delle categorie professionali. Ricordiamo, in particolare, per le connessioni con l'azione degli enti locali, i suoi ripetuti richiami alla necessità di ottenere ampi consensi da parte dei cittadini della Comunità per favorire uno sviluppo economico che comporti un minore consumo di energia. Alla formazione di questi consensi possono certamente fornire un prezioso contributo proprio gli enti locali: non a caso la Sezione .Sviluppo regionale» del Comitato economico e sociale si è fatto promotore di un parere nettamente favorevole ad una più stretta collaborazione degli enti territoriali locali e regionali - all'uopo consultati - alla formulazione e alla realizzazione della politica comunitaria di sviluppo. 5) I1 rapporto Saint-Geours sulle relazioni t r a crescita economica e risparmio energetico Sempre nel campo delle economie di energia, va ricordato un ampio studio dal titolo: «Per una Comunità economa in energia. reso pubblico nel giugno 1979. Esso è noto come «Rapporto Saint Geours» dal nome del presidente dell'apposito gruppo di lavoro costituito su iniziativa della Commissione comunitaria, due membri della quale, il vice-presidente Natali e il commissario Brunner, ne hanno seguito più direttamente l'attività per la loro specifica competenza per i problemi dell'ambiente e dell'energia. Pur rimandando alla lettura integrale del testo, desideriamo riassumerne le caratteristiche fondamentali e le linee ispiratrici, con particolare riguardo ai suggerimenti che possono più direttamente riguardare gli enti territoriali, locali e regionali. Per la prima volta, senza dubbio, un'analisi rigorosa del potenziale comunitario e COMUNI D'EUROP'A delle tecniche di economia d'energia è inquadrata nel suo contesto globale: economico, istituzionale, sociale e culturale. Conclusione principale del gruppo presieduto da Jean Saint-Geours: le nostre società possono affrontare la sfida energetica senza mettere in pericolo le tradizioni, il benessere, le libertà e i valori ai quali gli europei sono legati. Lo sviluppo di una società sobria in energia non può essere deciso in un ufficio di pianificazione. Esso richiede, al contrario, un alto g a d o di iniziativa e di responsabilità individuali. N o n si tratta di rinunciare alla crescita economica, ma piuttosto di migliorarne profondamente il contenuto e la qualità. Da una parte una crescita troppo debole frenerebbe gli adattamenti necessari ad una maggiore sobrietà economica. D'altra parte, in un mondo nel quale l'aumento del prezzo dellYenergia importata genera la disoccupazione e l'inflazione, una crescita sostenuta può essere duratura solo se si basa su una politica di economie di energia a lungo termine, più completa e più radicale di tutto ciò che è stato fatto nel passato. Una simile politica ha delle possibilità di successo solo se è sostenuta da un largo consenso popolare. In una lettera al presidente della Commissione europea, Roy Jenkins, il presidente del gruppo di esperti rileva che l'adesione dei cittadini sarà tanto più grande quanto più l'azione politica sarà percepita come elemento di una strategia comunitaria tendente a realizzare una crescita economica efficiente in termini di consumo di energia. I1 gruppo raccomanda di mettere in opera questa politica in, tre settori chiave: i prezzi, la ricerca, le condizioni tecniche di utilizzazione dell'energia. a) I Nove dovrebbero adottare delle politiche armonizzate che tendano a far coprire dai prezzi dell'energia i costi di sostituzione delle risorse. Costi e prezzi dovrebbero essere resi pubblici e trasparenti. b) I programmi di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione relativi alle tecnologie atte ad economizzare l'energia dovrebbero essere sviluppati attraverso la creazione di strutture europee di ricerca scientifica e lo studio delle questioni economiche e sociali legate alla diffusione e all'utilizzazione effettive di queste tecnologie. C) Delle norme minime comuni di «performance,, tecnica dovrebbero essere messe a punto attraverso accordi volontari o disposizioni legali per le automobili, le istallazioni di riscaldamento e i principali elettrodomestici, che siano importati o prodotti nella Comunità. Il gruppo chiede che una politica completa ed integrata di dissociazione tra la crescita economica e il consumo di energia sia definita dalla Commissione europea e raccomandata ai Nove. Si tratta di creare in ogni paese un clima favorevole agli investimenti e alle innovazioni sobrie in energia. I suggerimenti del gruppo riguardano le norme di efficienza energetica applicabili agli immobili; l'informazione e la pubblicità: l'istituzione di reti di consulenza, che bisogna inoltre appoggiare attraverso un'azione di informazione; la promozione di dispositivi di misura, (di regolazione e di controllo; infine, I'aumc'nto sensibile dei contributi finanziari alle economie di energia (aiuti agli investimenti in particolare). Quest'ultima azione dipende soprattutto dalle autorità nazionali, regionali e locali. I loro acquisti, le loro regolamentazioni e sistelni di tassazione possono esercitare una grossa influenza sull'uso efficiente dell'energia. Dei veri adattamenti in questi settori permetterebbero di aprire delle nuove strade all'iniziativa industriale e di fare dell'economia di energia un «buon affare* e un'occasione di creazione di nuovi posti di lavoro. A medio termine, le economie di energia costituiscono un favoloso giacimento di nuove risorse. Esse sono a portata di mano, se solo si uniscono gli sforzi dei ricercatori, dei produttori, dei consuinatori e dei governanti. Secondo il rapporto Saint-Geours, le economie possibili di qui all'anno 2000 potrebbero raggiungere dal 20 al 35% del consumo nel settore dei trasporti, dal 15 al 35% in quelli dell'industria e dell'agricoltura, fino ai 50% nei servizi e nelle abitazioni. a) Nel settore dei trasporti, le possibilità tecniche sono: - Per i trasporti stradali (due terzi del consumo di questo settore): si delinea un nuovo modello di automobile, più piccola, meno pesante, che offre meno resistenza all'aria, che dispone di pneumatici, carburanti e lubrificanti migliorati, di un motore - Diesel di preferenza - e di un sistema di alimentazione più economico grazie a sistemi di regolazione elettronici. Al volante di queste nuove automobili, un nuovo conduttore forse meno teso, più preoccupato di economizzare che di dare prestazioni spesso ridicole.. . e pericolose. Va ugualmente ricercato un miglioramento della rete dei trasporti collettivi, soprattutto nelle città, anche se non ci si deve attendere di realizzare importanti economie da una loro ipotetica sostituzione al trasporto individuale. - Per le ferrovie: l'alleggerimento dei materiali, la riduzione della loro resistenza all'aria e il recupero dell'energia che deriva dalla frenatura possono permettere delle sensibili economie. - Per l'aeronautica: ci si possono attendere dei guadagni importanti dalla nuova generazione di motori, da una nuova concezione delle ali e da un alleggerimento delle strutture. b) Nel settore domestico e dei servizi, e in particolare nel settore del riscaldamento (80% del consumo di questi settori), le economie possibili risulteranno: - da una migliore disciplina degli utenti. E' il grado di temperatura supplementare al di là dei 19" o 20" che aumenta più degli altri il consumo. - Da un miglioramento dell'isolamento termico grazie al rinnovo degli immobili esistenti, ad una migliore concezione delle costruzioni nuove, all'impiego di nuovi materiali. luglio-agosto 1980 - Da un miglioramento dei materiali e delle attrezzature (caldaie, ecc.) e da un ricorso massiccio all'elettronica per assicurare la regolazione e il controllo delle temperature. - Dall'estensione, laddove le condizioni vi si prestano, del riscaldamento urbano collettivo e della messa a punto, a più lungo termine, di nuove tecniche: pompe di calore, riscaldamento solare; ecc. C) Nel settore dell'industria e dellYagricoltura, le economie d'energia verranno soprattutto : - dal declino relativo di alcuni settori ad alto consumo di energia: la siderurgia, che assorbe un quarto del consumo energetico dell'industria in Francia e in Gran Bretagna, ma anche la chimica, la cellulosa, alcune attività legate alla costruzione, ecc. - Dal recupero dell'energia sotto forma di calore e, in alcuni casi, dallo sviluppo della produzione combinata di calore e forza. I1 rendimento energetico, rispetto al combustibile utilizzato, di una centrale termica, non è che del 35% circa. In compenso, a certe condizioni, un'installazione integrata può raggiungere un rendimento del 75%: 25% di elettricità e 50% di calore riutilizzabile in particolare nelle reti collettive di riscaldamento urbano. - Da un maggiore impiego dell'elettronica e dei micro-processori per migliorare la regolazione e il controllo del flusso energetico. - Dalla messa a punto di iluovi prodotti più sobri in energia, e con dei componenti di base riciclabili. - Da un maggiore ricorso alle energie rinnovabili come quella solare. Ma, va sottolineato, lo sviluppo di una società sobria in energia non è soltanto una questione scientifica e tecnica. Si tratta anche di sbloccare numerosi freni economici, culturali ed istituzionali, e, al limite, cambiare i nostri modelli-di produzione e di consumo. Questo significa che non si tratta solo di imporre delle norme o dei controlli. Il rapporto Saint-Geours sostiene la necessità di una maggiore partecipazione dei cittadini. Questi devono essere maggiormente associati alla determinazione delle grandi scelte collettive. Essi devono anche essere incoraggiati, all'interno di una società pluralista, a sperimentare autonomamente delle nuove forme di vita sociale e dei nuovi modelli di comportamento più sobri in energia. A lungo termine si potrebbe immaginare, per esempio, il moltiplicarsi di piccole città o di comunità di media grandezza alimentate in gran parte dall'energia solare. Le aspirazioni attuali ad una migliore qualità della vita, ivi compreso un lavoro che diventi meno impegnativo e competitivo, il rispetto accresciuto dell'ambiente naturale che traspare dal diffondersi dell'ecologia sono altrettanti fattori che favoriscono un minor consumo di energia. N o n bisogna tuttavia sottovalutare gli ostacoli: a) alcuni vengono dal prezzo dell'energia. Quando questi prezzi sono mal cono- luglio-agosto 1980 sciuti dall'utente o quando non si tiene sufficientemente conto dei costi reali a lungo termine, e in particolare della scarsità di alcuni tipi di energia, si premia in effetti lo spreco. b) ~~~i ostacoli sono legati ad una preoccupazione troppo esclusiva della redditività a breve termine. Essi si riscontrano, in particolare, per quanto riguarda gli investimenti nel settore dell'industria e degli alloggi, sòprattuttb se questi ultimi non sono occupati dal loro proprietario. A cosa serve rimodernare una caldaia se la nafta viene pagata dall'inquilino ? COMUNI D'EUROPA Sulla base dei Trattati europei e di diverse risoluzioni adottate dai Nove di definire una politica comune dell'energia, la Comunità si è sforzata, da pai;te sua, di favorire gli scambi d i informazione tra i Nove e d i assicurare u n certo coordinamento delle 10'0 azioni tendenti ad economiuare ltcnergia. a) Le misure prese dai paesi membri norme, aiuti agli investimenti, ecc. - potrebbero, in mancanza di un'armonizzazione, creare degli ostacoli alla libera circolazione delle merci O falsare la concorrenza al1 interno del mercato comune. b) Il carattere sperimentale dei programmi nazionali rende articolarm mente preziosi gli scambi di esperienze e di informazioni; il coordinamento della ricerca permette di portare avanti, in condizioni migliori, degli studi di interesse generale e di evitare dei C O S ~ O Sdoppioni~ . La Commissione europea propone oggi ai Nove di aumentare i loro sforzi e di adottare dei programmi di economia d'energia comparabili. La Commissione ha tracdi un Programma generale. cia" lo I principali punti di questo schema sono i seguenti: nomia di energia nei asporti, programmi educativi nelle scuole di ogni livello, aggiornamento e informazione dei professionisti. 6) Interventi finanziari della Comunità a sostegno della politica energetica Alle Regioni, alle Province e ai Comuni interessano certamente non solo il quadro orientativo generale e il complesso normativo comunitario in materia energetica (che abbiamo cercato di schematizzare anche se a grandi linee) ma anche le concrete possibilità di attingere ad aiuti finanziari della Comunità nelle loro iniziative in questo campo. Le norme e le esigenze legali sono a E' appena il caso di sottolineare che l'esivolte inadeguare in quei settori ad alto constenza di interventi finanziari comunitari sumo di energia che sono l~automobile e il nel campo dell'energia, così come in altri riscaldamento degli immobili. produzione e l'utilizzazione razionale del calore e campi, non sostituisce le politiche di cui essi dovrebbero essere uno strumento. Codell'elettricità sono spesso ostacolati da sì, anche nello specifico ambito energetico un'organizzazione troppo rigida che priviledi cui qui ci occupiamo, gli aiuti finanziari gia la centralizzazione della ~ r o d u z i o n epur provenienti dalla Comunità sono certamendividendo in compartimenti la distribuzione te opportuni e da utilizzare nel modo midei diversi tipi di energia. gliore, ma lasciano scoperto il problema di d) L,informazione e l,edrrcazione dei confondo che è quello della necessità di una rrmn<ori restano spesso insufficienti. Gli politica energetica comune. stessi professionisti ignorano a volte i mateLa Comunità prevede, come è noto, una riali e i procedimenti dei quali potrebbero serie di strumenti finanziari direttamente fidisporre. a) una politica dei prezzi e delle tasse nalizzati a favorire lo sviluppo regionale sull'energia trasparente e realista, che tenga Abbiamo sottolineato, in questa breve (Fondo europeo di sviluppo regionale, Bansintesi, alcuni degli aspetti del rapporto conto della scarsità e dei costi a lungo ca europea per gli investimenti). o comunSaint-Geours che possono anche più diret- termine; que su di esso incidenti (Feoga-Sezione tamente chiamare in causa l'attività degli b) una revisione progressiva verso lyalto, orientamento, Fondo sociale europeo, inenti locali. in funzione dcl progresso tecnico, delle perterventi C E C A ; più recentemente il cosidVa però precisato che la realizzazione di formance richieste a; nuovi immobili, nondetto «Sportello Ortoli» o Nuovo strumencondizioni favorevoli alle economie di ener- ché dei to comunitario - NIC). di riscaldamento, la cui magia rientra in generale nelle competenze dei nutenzione dovrebbe inoltre essere meglio I rapporti tra energia e territorio sono governi nazionali. Questi ultimi hanno preevidenti, ma proprio per questo è imporcontrollata; d i s ~ o s ~dei o programmi che hanno PermeStante conoscere quali mezzi specifici offra la un codice di costruzione che imponga so, tra il 1974 e il 1977, di ridurre il consu- delle norme Comunità nel settore energetico. per gli uffici ed m o di energia dei Nove di circa 1'8%. Al di altri servizi, e Per favorire il risparmio d i energia è stato riguarda in particolare i fuori di alcune misure assunte in crisi reemanato il Regolamento C E E n. 1303178 di riscaldamento e di condizionacenti, che limitano per esempio la circola- mento d'aria o di vcntilazior,e; del 12.6.78 che prevede la concessione di zione automobilistica o il consumo di nafta sostegni finanziari - per un totale di 55 d) degli aiuti finanziari per il riadattaper il riscaldamento, la gamma delle dispoM U C E (cioè milioni di unità di conto eumento degli immobili esistenti, e un prosizioni adottate è molto ampia e si allarga ropeee - U C E - per l'intero programma) gramma modello per gli alloggi e gli uffici sempre d i più. Esse riguardano in partico(1) a progetti dimostrativi che permettono appartenenti al settore pubblico. lare : tale risparmio (per una più precisa conoe) Uno sforzo d i ricerca scientifica e descenza, rimandiamo al testo del provvedia) l'isolamento termico degli immobili: gli aiuti finanziari per assicurare la promomento). Nel marzo 1979 il Consiglio dei obbligo di isolare le nuove abitazioni, ma zione commerciale dei nuovi procedimenti ministri della Comunità ha confermato la anche rinnovamento degli immobili già esi- ed attrezzature ,-he ad economizdecisione della Commissione di approvare stenti (si distinguono a questo riguardo, la zare 53 progetti per un investimento totale di 79 Danimarca, la Germania e l'Olanda). f) Degli aiuti finanziari per incoraggiare M U C E con un contributo finanziario cob) I sistemi di riscaldamento: migliora- gli investimenti industriali che permettono munitario di circa 21,s milioni di UCE. mento O riconversione delle attrezzature, di economizzare lPenergia e per sviluppare Questi progetti riguardano i processi indunorme d'istallazione, controllo della manu- le attività di consulenza presso le piccole e striali, gli edifici, le pompe di calore ed il tenzione, limi~azione della temperatura medie imprese, che mancano spesso di perriscaldamento urbano, le centrali elettriche, mass'imale degli uffici e degli alloggi, ecc. sonale qualificato. i trasporti, l'orticultura, ecc. C) I trasporti: campagne d'informazione, g) L'incoraggiamento della U n progetto dimostrativo potrà ricevere limitazione della velocità, controllo della combinata e dell'uso razionale del calore e un contributo compreso tra il 25 e il 49% pubblicità che riguarda il consumo di cner- dell'elettricità. del suo costo totale o del sovracosto rispetgia, accordi volontari con l'industria autodi informazione, di to ad una instaliazione tradizionale. h) Un grande mobilistica per migliorare progressivamente educazione civica e di sui prezzi I1 contributo della Comunità è rimborsale prestazioni dei veicoli. dell'energia, sul consumo delle attrezzature bile in caso di sfruttamento commerciale dei alla ricerca, allo sviluppo e e sulle economie possibili: etichettatura de- risultati del progetto, tranne che per le sped) gli elettrodomestici, calcolo e fatturazione se sostenute per il programma di misure chc alla dimostrazione di nuovi procedimenti, nonché l'aiuto agli investimenti industriali. individuale del riscaldaniento negli immobili saranno prese in carico dalla Comunità fino Sforzi notevoli sono fatti in questi settori e negli alloggi ,mu!tipli, standardizzazione dalla Danimarca, la Germania, l'Olanda e la dei metodi di calcolo e di pubblicità relativi (1) II valore di ogni UCE è variabile: a titolo indicativ o ricordiamo che al 1.1.1980 era pari a Lit. 1.160. al consumo dei veicoli, campagne sull'ecoGran Bretagna. (6) XXII a concorrenza massima del 75% del contributo finanziario stesso. Per il nuovo bando i possibili settori di applicazione sono l'edilizia, l'industria in genere, quella energetica in particolare, i trasporti. Per quanto riguarda lo sviluppo di «nuove» energie, il Consiglio della Comunità ha adottato - il 12 giugno 1978 - un regolamento C E E n. 1302178 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti dimostrativi basati sullo sfruttamento delle fonti energetiche alternative (sfruttamento dell'energia solare; liquefazione e gassificazione di combustibili solidi; sfruttamento dei giacimenti geo-termici; sfruttamento dell'energia dei fluidi, delle maree e dei venti). Ai progetti dimostrativi nel campo dell'energia alternativa si può concedere un contributo massimo del 40% del costo del progetto, di cui il 50% (e quindi il 20% del costo del progetto) è non rimborsabile. A titolo di esempio citiamo il recente bando di gara (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31/1/80) per piscine a riscaldamento solare. Alcune comunicazioni della Commissione, in attuazione del nuovo programma quadriennale 1979-1983 di ricerca e sviluppo nel settore energetico (Decisione del Consiglio 791785lCEE de11'11/9/79) prevedono dei finanziamenti (contributi a fondo perduto del 50%) a favore di ricerche in materia di conservazione dell'energia; produzione e impiego dell'idrogeno; energia solare; energia geo-termica; analisi di sistemi energetici e studi strategici. Per progetto dimostrativo si intende la realizzazione su scala industriale di nuove apparecchiature, nuovi prodotti o nuovi processi o di una nuova applicazione di apparecchiature, prodotti o processi noti. Un progetto dimostrativo deve perciò essere nuovo (cioè di prima realizzazione a livello europeo), deve presentare dei rischi legati al passaggio dalla scala pilota alla scala reale e avere un buon potenziale di applicabilità su scala europea. Nell'ambito del Fondo europeo d i sviluppo regionale sono previste delle azioni «fuor i quota». La Commissione ha già avanzato cinque proposte di impiego, una delle quali (per complessivi 16 milioni di UCE) concerne la diversificazione della fonte di energia nelle zone montane del Mezzogiorno italiano ( ~ i c c o l e centrali idroelettriche, energia eolica, ecc.). I1 Parlamento europeo, il 12 marzo scorso, si è pronunciato favorevolmente - con qualche ulteriore precisazione - sulle proposte della Commissione che ora dovranno essere adottate dal Consiglio. La BEI accorda, senza scopi di lucro, i finanziamenti o garanzie per progetti d'investimento pubblici e privati: - che promuovano uno sviluppo regionale equilibrato (inclusi quelli volti a migliorare I'approwigionamento energetico per favorire l'industrializzazione regionale, ecc.); - che presentino un interesse comune a più paesi membri della Comunità nel suo COMUNI D'EUROPA insieme (principalmente progetti volti a limitare la dipendenza della Comunità dalle importazioni di petrolio); - che ~ o n t r i b ~ i s c a n oall'ammodernamento o alla riconversione industriale. Negli ultimi tre anni i progetti nel settore energetico, a finalità regionale o d'interesse comune, hanno assorbito quasi il 40% dei finanziamenti della Banca nella Comunità. Dal 1973 alla fine del 1979 la Banca ha effettuato in Italia 50 interventi per un totale di 948 M U C (milioni di unità di conto) pari a 969 miliardi di lire. Oltre all'ENEL, AGIP, SNAM, ecc. ne è stato beneficiario anche il Comune di Brescia, per il suo progetto di teleriscaldamento, per complessivi 18 miliardi di lire. La BEI ha confermato la sua disponibilità ad operazioni proposte da enti territoriali aventi ad oggetto, oltre al teleriscaldamento, la combustione di rifiuti urbani per ricupero di calore ed energia, impianti idroelettrici, ecc. Quanto al Nuovo strumento comunitario - N S C (Sportello Ortoli) la Commissione delle Comunità europee è stata autorizzata dal Consiglio delle Comunità europee ad emettere prestiti sino a concorrenza di )in miliardo di unità di conto europee a nome della CEE; questi fondi sono versati alla Investimenti, che ha Banca europea per il mandato di accordare finanziamenti per conto della Comunità a favore di progetti dichiarati ammissibili dalla Commissione e conformi agli obiettivi prioritari fissati dal Consiglio; la prima ~tranche*di 500 M U C è stata destinata a progetti nei settori delle infrastrutture e dell'energia. Nel 1979 i mutui su risorse dell'NSC sono stati destinati per più della metà (quasi 150 MUC) al finanziamento di centrali idroelettriche e termiche in Irlanda, in Italia e nel Regno Unito. Si ricorda che con decisione del Consiglio delle Comunità europee, un abbuono d'interesse del 3% a carico del bilancio della Comunità può essere accordato a favore di taluni finanziamenti concessi su risorse proprie della BEI e su quelle del Nuovo strumento comunitario, dal 1979 al 1983, nei paesi membri meno prosperi della Comunità che partecipano a pieno titolo al Sistema monetario europeo (sono così designate l'Irlanda e l'Italia). Tali mutui a tasso agevolato devono essere concentrati sui progetti d'infrastrutture che contribuiscono a risolvere i principali problemi strutturali nei paesi interessati nonché a ridurre le disparità regionali ed a migliorare la situazione occupazionale; la decisione di ammissibilità dei progetti all'abbuono viene presa dalla Commissione. Taluni progetti energetici in Italia hanno già beneficiato di questa misura. Per la formazione professionale anche in settori connessi con,lo sviluppo energetico, si può fare ricorso (anche d'a parte di enti locali e regionali) al Fondo sociale europeo, che concede contributi a fondo perduto. Alcune iniziative prese da enti locali italiani nel campo specifico dell'energia non solo hanno suscitato l'interesse della Comu- luglio-agosto 1980 nità e di altri enti analoghi in altri paesi membri, ma sono state studiate e discusse anche in sedi politiche nazionali. Ricordiamo l'.udienza conoscitiva* disposta dall'Assemblea nazionale francese tramite la sua Commissione della produzione e degli scambi, il 10 maggio 1978, alla quale è stata invitata la città di Brescia nella persona del suo sindaco, a w . Cesare Trebeschi, e dell'ing. Luciano Silveri, presidente della Azienda servizi municipalizzati di Brescia (per maggiori informazioni si veda il n. 911978 della rivista .Comuni d'Europa,,, organo mensile dell'AICCE). Va ricordato che la C E E e il Canada hanno deciso di collaborare allo sviluppo dell'Energiebus, un metodo nuovo ed originale per risparmiare l'energia che ha già dato buone prove in Canada e che costituisce un esempio pratico di informazione in particolare delle piccole e medie imprese sul potenziale delle economie di energia. L'Energiebus è munito di strumenti sofisticati capaci di misurare ed analizzare il consumo di energia negli impianti industriali e commerciali e di identificare i risparmi d'energia potenziali. In Canada i governi federale e provinciali ne assicurano il funzionamento; gli industriali lo considerano uno strumento eccellente per migliorare il rendimento energetico e per ridurre così i costi connessi al consumo di combustibile e di elettricità. L'Energiebus è munito di calcolatori, di strumenti per misurare, di apparecchi di dimostrazione, di materiale audio-visivo. Prima di ricevere la visita dell'Energiebus, una società deve fornire informazioni sul genere e la quantità di energia che esso consuma, e sulle caratteristiche fisiche dell'impianto. La squadra di controllo si reca in seguito in loco per raccogliere i dati supplementari di cui ha bisogno per fare un'analisi con computer. Alla fine della visita la società riceve suggerimenti per aumentare il rendimento energetico del suo impianto come pure una valutazione dei risparmi finanziari possibili seguendo i suggerimenti pratici dati. L'esperienza canadese mostra che 1'Energiebus può realizzare risparmi di energia potenziali di circa 20-30% a visita. Questo sistema di verifica ha sollevato molto interesse nel mondo. In seguito a una dimostrazione effettuata in Canada davanti ai rappresentanti della C E E nel giugno 1979, sei Stati membri hanno già manifestato l'intenzione di adottare un sistema del genere, prendendo esempio sul programma canadese. Parecchi Stati membri hanno già incominciato ad elaborare i loro programmi e i Paesi Bassi pensano di applicare il loro sistema fin dall'inizio del 1980. Nel quadro del programma dell'Energiebus della Comunità, l'accento sarà messo sull'assistenza alle piccole e medie imprese. I1 sistema sarà gestito dagli Stati membri individualmente. La Commissione avrà il compito d i coordinare i vari sistemi nazionali e di adottare un sistema di scambio di dati e di programmi di ordinatori, al suo centro di ricerca di Ispra in Italia. I1 gover- luglio-agosto 1980 no canadese ha offerto alla Comunità i programmi di informatica del suo sistema di controllo energetico. Oltre all'Energiebus che ha visitato i vari paesi europei, il Canada ha anche offerto di formare la prima équipe di esperti dei paesi membri che adotteranno il sistema dellYEnergiebus. 7) L'ente locale territoriale, la C o m u n i t à europea e i problemi energetici N o n è certo necessario, in un Convegno a cui partecipano così numerosi e qualificati eletti locali, dilungarsi sul ruolo che gli enti territoriali sono chiamati a svolgere nel campo energetico e sui rapporti tra energia, sviluppo economico e sua necessaria proiezione territoriale. Basterà ricordare telegraficamente che detti enti 'Ono d i energia' di potere di interessi dei territorio' rappresentanti cittadini e portavoci loro gestori di propri impianti di produzione e distribuzione di energia' pubblici chiamati a concorrere alle iniziative volte alla conservazione e al risparmio energetico, responsabili della tutela dell'ambiente, portatori, al tempo stesso, di istanze di razionalità tecnica e di partecipazione. Tutto ciò legittima la pretesa di detti enti, nell'esercizio delle competenze specifiche riconosciute a Regioni e Comuni, di essere soggetti attivi a pieno titolo e non solo destinatari della politica energetica quale si articola a diversi livelli, locale, regionale, nazionale ed europeo. Non entriamo nel merito dei problemi e delle potenzialità che si pongono agli enti territoriali autonomi del nostro paese nel settore energetico, alla luce anche del b16 del 1977 e delle altre norme già in vigore o auspicate-che concernono i compiti di detti enti in questo campo, sia in modo diretto sia tramite gli interventi programmatori, la connessione tra produzione, gestione del territorio e protezione della salute e dell'ambiente, il rapporto tra centralizzazione e decentramento del sistema energetico: tutti temi di enorme interesse ma che richiederebbero ben altre dimensioni di questa comunicaz~onee che, del resto, coinvolgono direttamente le associazioni di enti locali che operano in sede nazionale, prime tra esse I'ANCI e la CISPEL, promotrici del Convegno. Desideriamo invece, prima di concludere, I'attenzione sulle implicazioni politiche, istituzionali ed operative - della connessione tra azione degli enti regionali e locali e la Comunità europea. Tale connessione postula adeguati canali e procedure di contatto, di consultazione e di partecipazione degli enti territoriali all'azione della Comunità (Parlamento europeo e Commissione) e alle decisioni delle autorità nazionali preparatorie di quelle che verranno poi adottate dagli organi comunitari: naturalmente intendiamo riferirci alle politiche che hanno incidenza sviluppo locale e regionale e che riguardano materie di competenza degli enti predetti. I1 problema ha rilevanza generale e non concerne solo l'energia. COMUNI D'EUROPA XXiii (7) sburgo, verrà discussa la relazione re disposta dall'on. Linde sulle nuove linee di azione della Comunità europea nel settore del risparmio di energia: in essa, tra l'altro, si insiste perché la Comunità fissi obiettivi inderogabili, non essendo certo sufficienti gli appelli a produttori e consumatori. Nel settembre 1978, sotto il patrocinio della CEE, è stata costituita a Lussemburgo una Conferenza tecnologica permanente delle autorità locali europee (STCELA: Standing technological conference of european local authorities) in cui sono rappresentate le due più importanti associazioni di enti locali che operano sul piano europeo ed internazionale: il Consiglio dei Comuni d'Europa e la IULA. Alcuni gruppi di studio sono già al lavoro e la loro attività concerne, oltre alle tecniche relative ai centri d'acquisti per gli enti locali, per la raccolta ed il trattamento di rifiuti chimici tossici, per la raccolta dei rifiuti urbani, i metodi di gestione di parchi di autoveicoli e l'analisi dei fabbisogni, anche il ruolo degli enti locali nel campo delle economie di energie. L'Assemblea della «STCELA» ha deciso di dar corso allo studio di un progett0 comunitario sul ruolo degli enti locali nel campo dei risparmi energetici. U n progetto di base per visite e scambi di studio e di Un altro punto di riferimento importante esperienze di funzionari di enti locali della Comunità, con riferimento all'uso delle teceuropeo eletto e le sue il nologie più moderne, è attualmente in via Commissioni. Tra queste la Commissione di impostazione. per la politica regionale e l'assetto del terriE' certo che l'efficacia del dialogo tra enti torio è certamente quella che più direttamente si ricollega ai ~ r o b l e m idegli enti locali e regionali e Comunità europea e la tempestiva mente^ territoriali come soggetti promotori dello loro capacità di correttamente e nella misura massima consvilu~~O e locale. Ma proprio Persentita, gli strumenti finanziari europei nel ché a questo e ad una campo energeticoy negli altri che incicrescita delle comunità locali concorrono d o " ~ sullo sviluppo economico-sociale e altri fattori (l'industria, l'agricoltura, i propiù territoriale, dipendono oltre che da una gressi sociali, la cultura e, certamente, ampia e specifica informazione, anfhe da l'energia) il consiglio dei comuni d'Europa altre due condizioni: da contatti meno epiha proposto ai gruppi politici d e ~ pariamensodici tra le varie associazioni di enti locali t0 europeo, che vi hanno aderito, di dar Sezione vita ad un N ~ r o u pde e liaison,, (o I ~ operanti ~ sul piano ~ nazionale ~ con la ~ italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa P') da parlamentari meinbri di diverse commissioni ma aventi un (AICCE) e con gli Uffici della Comunità (Commissione, Parlamento, BEI), nel riinteresse convergente ad affrontare con visione interdisci~linare i vari e complessi spetto delle loro competenze specifiche, e problemi delle comunità locali e regionali, dalla creazione - presso le Regioni e gli enti locali di maggiori dimensioni, città capoluoferme restando, ovviamente, le competenze ghi, ecc. - di un apposito «Servizio. o formali delle diverse Commissioni parlamentari. ~~i confronti del12~ntergruppoil "Ufficio> per i problemi della Comunità, non~ per complicare le~ struttuconsiglio dei comuni d y intende ~ ~ ~ulteriormente ~ Svolgere, Pur suo re burocratiche, ma per consentire un punto di riferimento per l'«imput>>e I'«output» funzionamento, unyazione propositiva di temi e di problemi suggeriti dall'esperienza di e degli enti territoriali. L'energia, alla quale Un Promosso dalla CEE e dall'AICCE, Per proprio nel febbraio scorso, il Parlamento Commissione funzionari e dirigenti di Uffici Stampa reeuropeo ha dedicato un ampio esame sulla base della relazionedell'on. ~~~l ~~~b~(su- gionali, ha confermato l'utilità di queste gli obiettivi energetici della comunità per il iniziative e della proposta dell'AICCE di 1990, sulla convergenza delle politiche degli farsi carico di un'agile Agenzia periodica di notizie ed informazioni limitata ai problemi Stati membri, sull'energia nucleare e europei di interesse locale e I-egi~nale. politica energetica), offrirà certamente l'oc- I1 Consiglio dei Comuni d'Europa - di cui 1'AICCE è la Sezione italiana - sta operando per la creazione, in sede comunitaria, di una Conferenza o Assemblea dei poteri locali e regionali in analogia con quanto già esiste nell'ambito del Consiglio d'Europa, ma con ben altra incidenza, tenuto conto della diversa natura della Comunità, delle sue piu concrete ripercussioni di ordine economico, sociale e finanziario e, soprattutto, delle sue ~otenzialitàpolitiche. Nell'attesa e in ~ r e ~ a r a z i o ndie questo risultato ottimale, il Consiglio dei Comuni d'Europa ha promosso la costituzione di un Comitato consultivo delle Regioni ed enti locali della Comunità al quale hanno aderito anche altri organismi di enti locali. Detto Comitato, che ha come obiettivi l.approfondimento dei problemi, il confronto delle esperienze tra le autonomie territoriali dei nove paesi membri e il dialogo con le istituzioni comunitarie (Parlamento, Commissione di Bruxelles, Cornitato economico e sociale) ha fino ad oggi orientato la sua attività prevalentemente sui temi di politica regionale, ma proprio nei mesi il dell'energia e dei suoi rapporti con lo sviluppo economico e la pianificazione territoriale poIarizzeranno la sua attenzione. casione a l " I n t e r g r u ~ ~ odi aPPrOfondimenti collegati con lo sviluppo del ter'ito'io- la politica regionale e la protezione dell'ambiente. Proprio nella sessione ~ l e n a r i adel Parlamento europeo, attualmente in corso a Stra- Questa comunicazione che, per la complessità dei problemi e la molteplicità delle esperienze e delle informazioni che era opportuno far conoscere, si è dilatata oltre il ~ (8) XXIV previsto, n o n p u ò essere certo considerata come un contributo esauriente, ma solo come uno stimolo ad ulteriori approfondimenti, ad una costante sensibilità al contesto europeo, ad una coerente volontà di coordinare l'azione amministrativa locale e quella legislativa regionale con la politica comunitaria che dovrà però, a sua volta, n o n calare dall'alto, secondo modelli centralizzati, inaccettabili dalla nostra democrazia «fondata sulle autonemie., ma essere la risultante della collaborazione e del coordinamento - quindi del dialogo - dei vari livelli di decisione politica ed amministrativa. Un'ultima precisazione, ma certo n o n secondaria. Proprio per quanto sopra esposto, per l'incidenza crescente dell'integrazione europea sulla realtà locale e regionale, le autonomie locali e regionali n o n possono essere spettatrici passive della Comunità, dei suoi successi e dei suoi scacchi, dei suoi slanci e delle sue timidità, delle sue potenzialità e delle sue lentezze. Le lezioni dirette del Parlamento europeo hanno creato delle possibilità nuove di partecipazione dei cittadini allo sviluppo COMUNI D'EUROPA dell'unificazione europea che vanno coltivate, rafforzate con azione costante di tutte le forze politiche, sociali, economiche e culturali: con l'azione, dunque, capillare e preziosa delle decine e decine di migliaia di eletti rappresentanti della democrazia locale che nei paesi membri sorio i portavoce delle attese dei cittadini e, a] tempo stesso, punti di riferimento essenziali per una crescita civile e reale della società europea possibile solo nella solidarietà istituzionalmente garantita di una federazione europea. Vi è quindi largo spazio per un'azione degli eletti locali e regionali in collegamento con la Comunità, ma vi è ancor più spazio e necessità di un loro impegno per farla progredire verso traguardi politici ed istituzionali ben più adeguati alle sfide che ci stanno dinnanzi. Si 6 parlato più volte dell'esigenza di una politica comune europea (cioè sovranazionale) dell'energia. I1 Consi-gli0 dei Comuni d'Europa ne chiedeva espressamente la creazione nella risoluzione conclusiva dei suoi VII Stati generali (Roma, 1964). Essa n o n significa la somma delle politiche nazionali dei singoli Stati membri della Comunità o aggiustamenti a luglio-agosto 1980 posteriori delle stesse per renderle compatibili, né si identifica con un sistema di <<convenzioni. sia pure inserito in un quadro comunitario. Essa vuol dire elaborazione in comune di una politica energetica comune senza che simultaneamente esistano altre politiche comuni (ad es., industriale, monetaria, ecc.). Detta politica energetica comune dovrà essere sostenuta da un adeguato bilancio comunitario, inserita in un disegno coerente, attenta non solo alle esigenze interne, ma al quadro più generale degli scambi economici e commerciali tra paesi produttori di beni strumentali e prodotti finiti e paesi produttori di materie prime (ad esempio, ma non solo, il petrolio). I n altre parole i cittadini europei (e i loro rappresentanti eletti negli enti locali e regionali) sono direttamente interessati a che la Comunità europea abbia finalmente un vero governo, democraticamente responsabile di fronte al Parlamento eletto, in g a d o di cogliere positivamente anche le implicazioni della crescente interdipendenza tra il rilancio delle nostre economie (cioè del mondo occidentale) e lasoluzione dei problemi dello sviluppo del Terzo e Q u a r t o mondo. COMUNI D'EUROPA luglio-agosto 1980 9 (CCE) e della sua Sezione italiana (AICCE) - I semestre 1980 Comitato promotore della Federazione abruzzese (Roma, 7 marzo) Convegno su M I problemi energetici .e la programmazione locale in Lombardia. promosso dalla Federazione lombarda e dal Comune di Brescia (Brescia, 8 marzo) Comitato promotore della Federazione siciliana (Palerm o , 17 rnarzo) partecipazione di una delegazione di 60 marinesi oltre agli amministratori locali di Marino (8-12 maggio) N e t t u n o .(I) T r a u n r e u t (RFT): visita di una delegazione di amministratori locali di Traunreut a Nettuno, guidata dal Borgomastro (maggio); partecipazione di una delegazione di Nettuno alle feste di Traunreut (27 giugno) Traversetolo (I) O r a i s o n ( ~ j l: a cerimonia di gemellaggio a Traversetolo (25 maggio) C B Partecipazione a convegni, incontri, ecc. . Comitato internazionale della Gauehe Européenne (Bruxelles, 19 gennaio) Incontro internazionale su *L'Europa per la pace., promosso dalla Gauche Europeenne (Bruxelles, 29 febbraio 1" marzo) Colloquio europeo su « L o sviluppo delle istituzioni comunali nell'Europa unita», promosso dalla Fondazione Friederich Ebert Stiftung e dalla Lega socialdemocratica tedesca per la politica comunale (Berlino, 14-1 8 aprile) Seminario su -Sicurezza e difesa», promosso dalla Fondazione Adenauer (Bruxelles, 24-26 aprile) Bureau del P P E sulla politica regionale (Bruxelles, 14 maggio) Incontro in preparazione del XVIII Congresso internazionale di scienze amministrative su «Amministrazione e regionalismo, autonomie e federalismo~, promosso dall'Istituto internazionale di scienze amministrative (Barcellona, 26-27 giugno) VI Attività in collegamento con le altre organizzazioni Federaliste a) Rapporti con il M E (Mouvernent européen) Consiglio federale (Venezia, 22-23 febbraio) Congresso (Parigi, 9 maggio) Consiglio federale (Parigi, IO maggio) b) Rapporti con I'UEF (Union européenne des FédéraIistes) Congresso (Strasburgo, 14-16 inarzo) Comitato federale (Lussemburgo, 28-29 giugno) AICCE I Riunioni istituzionali dell'AICCE -. A . Riunioni di o r g a n i dirigenti a) Direzione nazionale (Torino, 8 febbraio, Roma, 7 inarzo) Esecutivo (Roma, 19 febbraio, 29 aprile) Consiglio nazionale (Roma, 7 inarzo) b) Coinmissione aprile) finanziaria (Roma, 6 iiiarzo, 23 C) Revisori dei conti (Roma, 26 marzo) B Attività in collaborazione c o n Regioni, Province, C o m u n i e C o m u n i t à europea Federazioni regionali Comitato direttivo della Federazione lombarda (Brescia, 14 gennaio) Comitato promotore della Federazione trentina (Trento, 25-27 gennaio) Comitato promotore della Federazione Sudtirolese (Bolzano, 28-30 gennaio) Comitato promotore della Federazione siciliana (Palerino, 28 gennaio) Giunta esecutiva della Federazione piemontese (Torino, 3 marzo) I1 Incontri di una delegazione dell'AICCE con i rappresentanti della consulta regionale dell'emigrazione dell'umbria, per la preparazione del convegno di Assisi sull'emigrazione (Roma, 9 e 24 gennaio) Incontro dei membri italiani del comitato consultivo delle Regioni ed enti territoriali dei paesi membri della C E E (Roma 16 gennaio) , Incontro di studio su ~ L u c c a , tra pianificazione e gestione del territorio*, promosso dal Comune di Lucca in collaborazione con la Regione Toscana e I'ANCI (Lucca, 1-2 febbraio) Convegno su -11 piano siderurgico e l'attuazione della legge di riconversione industriale., promosso dal C o mune di Terni (Terni, 7-8 febbraio) Convegno su «Riformare i1 Potere locale per realizzare lo stato delle autonomie., promosso dalla Giunta regionale lombarda, in collaborazione con I'ANCI, I'UPI e I'UNCEM (Milano, 8-9 febbraio) X Congresso nazionale dell'unione segretari comunali e provinciali (Roma, 21 -23 febbraio) Convegno nazionale regionale su .Dieci anni di Regioni>>,promosso dalla Giunta regionale toscana (Firenze, 4-6 marzo) Convegno europeo su .Partecipazione degli emigrati alla vita amministrativa politica e sociale nei paesi di accogli mento^, promosso dalla Regione Uinbria, dal Consiglio regionale umbro per l'emigrazione e dall'AICCE (Assisi, 8-9 marzo) Incontro di informazione per responsabili degli Uffici stampa, direttori di pubblicazioni regionali, coordinatori per i problemi comunitari nelle Regioni su .La Comunità europea, le Regioni e l'informazione», promosso dall'Uficio per l'Italia della C E E e dall'AICCE (Roma, 10-13 marzo) Convegno nazionale su «Il diritto all'inforinazione nelle realtà regionali», promosso dall'Istituto di studio e ricerche per lo sviluppo dell'informazione regionale e dalla Regione Campania (Napoli, 17-1 8 aprile) Seminario regionale di formazione europea su .Le autonomie locali e la Coniunità europea., promosso dall'Ufficio ~ e l'Italia r della C E E in collaborazione con I'AIGE (Castellammare d i Stabia, 24-25 maggio) Partecipazione a Convegni, Incontri, ecc. Convegno internazionale di studi su .I1 ruolo del Parlamento europeo nella costruzione dell'unità politica europ e a ~ ,proinosso dalla Cassa di Risparmio di Torino, in collaborazione con i1 Movimento europeo (Torino, 12-13 gennaio) XXVII Giornata europea della scuola (Roma, 4 febbraio) Incontro-dibattito su su normativa per gli immigrati in Italia: esigenze e responsabilità», promosso dall'UCE1lCaritas (Roiiia, 28 fabbraio) Convegno su <(Le Regioni e la nuova politica agricola comunitaria., promosso dal Centro europeo studi economici e sociali (Perugia, 9-10 maggio) Convegno sul tema «Proposta delllAnfe per una legge quadro sulla scolarità dei figli degli emigrati., promosso dall'ANFE (Roma, 14 giugno) (segue) luglio-agosto 1980 COMUNI D'EUROPA 10 Convegno su -Energia e sviluppo alternativo in Europa*, (Verona 12-13 aprile) Convegno su *Il mezzogiorno di fronte all'integrazione europea>>,proinosso dal C I F E in collaborazione con 1'UfLcio per l'Italia della C E E e 1'MFE (Alcamo 19-20 aprile) Tavola rotonda su .I problemi economici della Federazione europea,,, promossa dal C I F E e dalla G F E (Frascati, 4 maggio) Convegno su .Prospettive della telematica in Europa., promosso dal C I F E (Roma, 8 maggio) Comitato direttivo (Koma, 12 maggio e 23 giugno) Attività in collegamento con altre organizzazioni A Federaliste a) Rapporti con il C I M E (Consiglio Italiano del Movimento Europeo) Corniiiissione per il coordinamento delle iniziative femminili (Roma, 4 gennaio e 14 maggio) Incontro fra il Consiglio italiano e tedesco del Movimento europeo (Roma, 7-8 inarzo) Consiglio di presidenza (Rorna, 23 gennaio, 12 febbraio, 27 tebbraio, 14 aprile, 26 ii-iaggio e 16 giugno) Comitato direttivo(Roma, 27 febbraio e 1 8 giugno) Consiglio nazionale (Ron-ia, 18 giugno) Incontro tra il Consiglio Italiano e Il Consiglio spagnolo del Movimento europeo su -La Spagna nell'Europa per rinnovare la C o r n u n i t à ~(Rorna, 20 giugno) Convegno su .Il fondo monetario europeo e il pi-oblema dell'energia*, (Roma, 21 giugno) b) Rapporti con il M F E (Movin-iento federalista europeo) Congresso (Bari, 23-24 febbraio) Direzione (Milano, 29 marzo) Comitato centrale (Roma, 31 inaggio) Incontro-dibattito sul tema ~Un'iniziativa europea per la costruzione di uno stato palestinesen, proinosso dal MFE e dall'OLP (Roma, 19 giugno) C) d) Rapporti con I'AGE (Associazione dei giornalisti europei) Direttivo (Roina, 14 febbraio) e) Rapporti con lo I A I (Istituto Affari internazionali) Coii-iitato direttivo (Roma, 24 gennaio) Riunioni varie nel quadro del «Progetto Venezia. su * L o Stato della Comunità,,, %L'energia., « I prvbleini monetari», *il quadro macroeconomico internazionale*, «il rapporto nord-sud >, .il contesto politico inondiale* (Roma, 11 gennaio, 1 e 22 febbraio, 7 e 21 marzo, 11 aprile) B Rapporti con il C I F E (Centro italiano formazione europea) Convegno sui problemi linguistici europei e tavola rotonda sul terna -Parlare europeo: coine?. proi-i-iosso dal C I F E e dall'AEDE (Roma, 19 gennaio) Seminario di intormazione su .La politica regionale europea e i problemi d e l l ' o c ~ u ~ a z i o n proinosso e~~ dal CIEE, dall'ainininistrazione provinciale di Foggia e dall'AICCE (Foggia, 29-30 marzo) di Poteri locali Congresso della Lega per le autonomie e i Poteri locali (Firenze, 25-27 gennaio) Consiglio nazionale dell'unione nazionale comuni, Comunità ed Enti Montani ( U N C E M ) (Roma, 31 gennaio) Seminario di studio su « I servizi pubblici locali nell'economia e nella società),, promosso dalla CISPEL (Firenze 27-29 marzo) Giornata di studio su *Ruolo dei Comuni e delle loro aziende nella politica dell'energian, promosso dall'ANC I e dalla CISPEL (Roii-ia, 15 aprile) Inc-ontuo tua città gemelle: Lecco-Macon I rapporti fra le città gemelle di Lecco e Macon, hanno ricevuto i n questi ultimi anni un particolare impulso; sempre più numerosi sono infatti gli scambi che avvengono ai più diversi livelli: culturali, sportivi e di ospitalità fra i cittadini dei due centri lombardo e borgognone. I n particolare dal 6 a11'8 giugno, la città di Lecco ha ricevuto la visita di una delegazione ufficiale dell'Amministrazione comunale di Macon, guidata dal Sindaco MichelAntoine Rognard, da alcuni suoi assessori e consiglieri comunali e da membri del Comitato gemellaggi, e sabato 7, si è avuto I'incontro nel salone corisiliare del Comune fra gli Amministratori delle due città gemelle. I1 sindaco Resinelli, nel suo indirizzo di saluto, ha sottolineato l'importanza dei rapporci di gemellaggio fra le città d'Europa: .oggi più che mai., ha detto fra l'altro Resinelli, «in questo momento travagliato della storia d'Europa e del mondo, si avverte l'urgenza di una dimensione nuova, si sente che occorre uscire dalle visioni ormai sterili dei nazionalisnii, per costruire col contributo di tutti un'Europa dei popoli, dei popoli liberi e democratici che scelgono liberamente la strada del proprio futuro, facendo certamente tesoro del patrimonio inestimabile del proprio passato, ma che nello stesso tempo uniscono i propri sforzi per dare vita insieme, ponendo a vantaggio di tutti i valori storici, culturali e sociali di ciascuno, a u n grande disegno di civiltà, per forgiare la nuova idea che sta alla base del progresso comune: l'unità europea.. H a preso la parola anche il Ministro di Grazia e Giustizia, sen. Tommaso Morlino, presente all'incontro assieme a Ezio Citte- rio, deputato al parlamento. Morlino ha avuto parole di apprezzamento per l'attività intensa e continua fra le due città, sottolineando lo spirito di fratellanza che unisce i popoli d'Europa. E' poi intervenuto Aurelio Dozio, co-segretario dell'A.1.C.C.E. che ha portato il saluto dell'Associazione. H a quindi preso la parala Emilio Sangregorio, presidente del Comitato gemellaggi di Lecco, al quale ha risposto il suo collega di Macon, Pierre Joureau. nella foto: (da sinistra in alto) Rognard, sindaco di Micon, Resinelli, sindaco di Lecco, Dozio, membro della Segreteria politica dell'AICCE; Citterio, deputato; (in basso) Mauri, assessore al Comune di Lecco, delegato per i rapporti di gemellaggio, Sangregorio, presidente del Comitato per i gemellaggi di Lecco, Joureau, presidente del Comitato per i gemellaggi di Macon; Tommaso Morlino, ministro di grazia e giustizia. luglio-agosto 1980 COMUNI D'EUROPA Pensiero e azione dei federalisti europei a cura di Luciano Bolis A un anno dalla prima elezione popola;e del Parlamento europeo e mentre non accenna ancora a rientrare la crisi comunitaria (la ritrovata intesa finanziaria con la Gran Bretagna fu realizzata solo a patto di un implicito riconoscimento dell'assurda tesi nazionalistica del «giusto ritorno,,; la protezione dei prezzi agricoli continua a mangiare i tre quarti del bilancio senza lasciare adeguato spazio alle pur impellenti iniziative di ristrutturazione del settore; il bilancio '80, approvato dal Parlamento con ben sei mesi di ritardo, riproduce sostanzialmente difetti e lacune di quello precedentemente respinto; salvatasi in corner la Grecia, sono vergognosamente respinti in alto mare Portogallo e Spagna, malgrado le altisonanti promesse con cui si sono per tanto tempo sciacquata la bocca certi grandi personaggi dell'europeis m o ufficiale), era naturale che i federalisti rimeditassero le loro tattiche e strategie, distinguendo u n piano più immediato d'intervento - che faccia leva sugli appigli a portata di mano per uscir dallo stallo e rimettere le carte in gioco - e un piano a medio o lungo termine, che presuppone la stessa ridefinizione degli scopi e la conseguente ricognizione dei mezzi più atti a raggiungerli. H a aperto il fuoco (ne tirez pas sur le fédéraliste!) il Comitato dell'UEF tenutosi a Lussemburgo a fine giugno, ove si sono proficuamente incontrati, e in qualche misura anche scontrati, più orientamenti scaturiti da difformi valutazioni e esperienze: da quella olandese, appiattita sulla proposta di un'avvilente e rinunciataria identificazione formale col Movimento europeo, a quella tedesca, fedele all'impegno di sempre per un governo europeo che rappresenti il passo successivo a quello già compiuto dell'elezione, e a quella italiana, particolarmente sensibile alle istanze contenutistiche, le quali soltanto sembrerebber0 fornire la necessaria giustificazione e premessa per l'invocato complemento istituzionale. La mozione finale su cui i vari filoni hanno ritenuto di poter convergere, dopo aver constatato che <<laComunità, con la sua attuale struttura, e incapace non solo di affrontare i compiti che discendono dai Trattati, e in particolare quelli dell'allargamento, ma anche di risolvere i gravi problemi interni e internazionali, i quali richiedono, da un lato, la sollecita costruzione dell'unione economica e monetaria e , dall'altro, iniziative autonome di un'Europa che affermi sempre più la sua indipendenza sul terreno monetario e della .politica estera, senza escludere la sicurezza, nella prospettiva di realizzare un reale rapporto d i equal partnership con gli Stati Uniti., fa notare che «senza una riforma in profondità delle istituzioni, che giunga sino alla creazione di un vero e proprio governo europeo, con poteri limitati ma reali, responsabile di fronte al Parlamento eletto, non si potrà garantire alla Comunità una volontà politica comune e un'azione efficace» e che «il compito di elaborare questo progetto di riforma dovrà essere affidato al Parlamento eletto dal popolo eu.ropeo*. Il testo così risultante ci appare evidentemente equilibrato e relativamento completo, almeno nel senso che esprime l'essenziale del nostro compito odierno; anche se un pochino ci spiace che il gioco finale delle mani alzate ( O piuttosto, in questo caso, non alzate) abbia lasciato cadere nel limbo delle iritenzioni una frasetta che troviamo invece nella proposta iniziale del presidente Albertini, e cioé una garbata stoccatina per i cosiddetti «saggi. di nomina più o meno governativa, i quali farebbero indebita concorrenza ai soli veri rappresentanti del popolo che sono oggi i parlamentari europei. v > . $ , U n contributo originale di pensiero all'elaborazione d i un piano strategico, che imprima alla costruzione europea il salto qualitativo di cui ha bisogno per rilanciarsi, è stato 11 portato da Spinelli nel corso di una relazicae svolta il primo luglio davanti ai federa1,sti romani. U n o Spinelli sempre lucido e battagliero malgrado gli anni (73), il quale ci ha fornito un'analisi puntuale del difficile momento (si far per dire!) che attraversiamo, corredandola d'indicazioni precise sui nuovi equiLbri istituzionali da raggiungere (il Consiglio deve cedere una parte dei suoi poteri in direzione della Commissione e del Parlamento) e sui mezzi per potenziare adeguatamente il bilancio (lo sfondamento dell'l YO dell'IVA fino a realizzare un'entrata complessiva corrispondente al 2,5% del PILE, secondo MacDougall), al fine di consentire la necessaria apertura verso nuove politiche (specialmente industriale, energetica ed ecologica), senza per questo dover distruggere quella agricola, che andrebbe soltanto convertita da una prevalente difesa dei prezzi in un accresciuto impegno di ristrutturazione di tutto il meccanismo produttivo e distributivo del delicato settore. Fin qui, diciamo pure, niente di nuovo, dal COMUNE BI BARWNECCHIA GEMELLAGGIO BARDONECCHIA - Città di Bardonecchia 15 Giugno - COMMUNE BE MODANE M O D A N E JUMELAGE Ville de Modane 29 Juin Per rendere più solenne la prossima apertura al traffico del Traforo Autostradale del Fréjus, le confinanti città di BARDONECCHIA e MODANE hanno deliberato di gemellarsi. Pour rendre plus solennelle la prochaine ouverture au trafic du Tunnel routier du Frejus les deux villes frontièresde MODANE et BARDONECCHIA ont décidé de se jumeler. Un simbolico rito di amicizia nel solco di una storia comune ed antica, per un futuro sempre crescente di unione e solidarietà. Un rite symbolique d'amitié dans le sillage d'une histoire commune et ancienne, pour une union et une solidarité toujours plus importantes dans I'avenir. Nato nel segno delle direttive del Consiglio dei Comuni d'Europa, il Gemellaggio si propone di considerare idee e interessi comuni. N é sous le signe des directives du Conseil des Communes d'Europe, le jumelage se propose de considérer des idées et des intérets communs. Le finalità di una iniziativa che scopre un modo nuovo di vivere il tempo delle Comunità Economiche Europee, sono diverse ed importanti. Les finalités d'une initiative qui permet de découvrir une facon tiouvelle de vivre au sein des Communautés Economiques Européennes, sont diverses et importantes. Un servizio Autobus-Navetta tra le due Comunità, la possibilità operativa di scambi più rapidi e frequenti di beni e di pubbliche utilità, una interpretazione attiva del movimento di uomini e cose attraverso il Traforo del Fréjus, il desiderio delle due popolazioni di recuperare e consolidare relazioni durevoli e compatibili, sono tra i principali e più immediati traguardi che il Gehellaggio intende conseguire. IL SINDACO Alessandro Gibello Un service Autobus-Navette entre les deux Communautés, la possibilité de créer des échanges plus rapides et fréquents dans le domaine commercial et public, une interprétation ective du mouvement des hommes et des choses par le Tunnel du Fréjus, le désir des deux populations d'obtenir et de consolider des relations durables et compatibles, sont les objectifs principaux et immediats que le Jumelage entend réaliser. LE MAIRE lean Gauthier il manifesto predisposto per il gemellaggio svoltosi il 15 giugno a Bardonecchia e il successivo 29 giugno a Modane. Alla prima cerimonia h a partecipato, in rappresentanza dellYAICCE, Aurelio Dozio. COMUNI D'EUROPA momento che chi ~ a r l aè un u o m o dall'esperienza e dalla capacità critica di S ~ i n e l l i .Ma ciò, nel suo disegno, non era che la premessa di un impegno cui i federalisti, dall'esterno, dovrebbero concorrere allo stesso titolo dei parlamentari all'interno dell'istituzione, secondo un' elementare divisione dei compiti che appare irrinunciabile condizione per il s u o successo finale. Era ben chiaro, infatti, ch'egli intendeva delegare ai più giovani federalisti che lo attorniavano il compito esterno., mentre riservava per sé quello, non meno arduo, di resistere nella città assediata, la quale però saprà salvarsi solo se tenterà, nei modi e tempi opportuni, le necessarie .uscite.. D i qui l'indispensabile coordinamento tra i due piani che egli si è sforzato d'impostare. C i è stata così offerta la primizia dell'appello da lui rivolto qualche giorno prima ai colleghi parlamentari europei, in cui si dichiara convinto che il Parlamento deve ~ a p r i re un grande e forte dibattito sulla crisi istituzionale della Comunità; nominare un gruppo di lavoro ad h o c che gli prepari il progetto delle riforme istituzionali necessarie; discutere e votare questo progetto dandogli la forma precisa di u n progetto di trattato che modifichi e integri quelli attuali; proporne formalmente l'adozione ai parlamenti nazionali della Comunità*,. Si tratta, in sostanza, del progetto costit u e n t e per il quale i federalisti si battono da sempre e in particolare si è battuto proprio Spinelli trent'anni fa quando, in un'analoga situazione di crisi, si è ottenuto la convocazione della famosa .assemblea ad hocn d'infausta memoria. O g g i Spinelli rinuncia al nome, non certo alla sostanza di quel progett o , che t. già per sua natura costituente. Ma questa sua preoccupazione tattica di non usare termini che possono ancora metter paura, potrà anche valere all'interno della cinta comunitaria ov'egli prevalentemente opera, non però al di fuori di essa, dove il compito dei federalisti è piuttosto quello di .spiegare. all'opinione pubblica il significato dell'operazione in corso, ciò che è sempre riuscito meglio facendo appello ad espressioni che già di per sé siano quanto più possibile evocative del risultato che appunto si intende conseguire. Se questa è stata I'impostazione generale del discorso, essa esprime una sostanziale e rassicurante coincidenza di propositi con le già richiamate posizioni dell'UEF. Spiacemi soltanto di dover passare sotto silenzio, per i soliti imperativi di spazio e di tempo, le numerose battute di cui, accessoriamente, s'iniesseva l'esposizione: come l'accenno a Pannella, suggerito ai federalisti come modello da non scartare per l'effetto mobilitante delle sue azioni, e la esortazione agli stessi federalisti a non ~ e r d e troppo r tempo dietro a problemi la cui soluzione non appare manifestamente ancora matura per il nostro tempo, citando a questo proposito l'esempio della difesa europa. . I1 terzo v o l e t di questo trittico di mezza estate fa perno sul Movimento europeo e si svolge fortunatamente secondo linee di con- vergenza sulle posizioni già espresse nei due punti precedenti, realizzando anzi tra esse u n coordinamento che, sul piano delle precedenze da attribuire ai singoli momenti e su quello del linguaggio impiegato per esprimerle, non potrebbe essere più appropriato. La circostanza del resto non meraviglia, se si pensa al ruolo preminente che nello stesso Moviment o europeo - almeno nella sua proiezione italiana che è il C I M E - giocano componenti storiche di antica milizia e indubbio prestigio quali lo stesso M F E e la nostra A I C C E , a proposito della quale non posso che riferirmi, per non ripetermi, a quanto già contenut o nell'editoriale -Costituente e fronte democratico europeo» apparso sul numero precedente di questa rivista con la sigla U.S. I1 documento conclusivo dei recenti dibattiti svoltisi nell'ambito del C I M E su questi stessi temi inizia con la rievocazione di un passato di lotte - il periodo delle origini - che non dovrebbe cessare d'ispirarci e che ha visto, per la prima volta al Congresso dell'Aja del '48, tutti gli europeisti nostrani in posizione esposta sullo scenario del tempo. «I1 Movimento europeo, vi si legge infatti, p u ò ritrovare il suo ruolo di avanguardia morale dell'opinione pubblica europea e di interlocutore efficace dei governi, delle forze politiche e sociali, delle ancor fragili istituzioni europee, solo se saprà tornare alle grandi ispirazioni ideali che ne accompagnarono la nascita e le prime battaglie,,. Proseguendo: .Con le stesse ispirazioni ideali e con la stessa determinazione politica con cui intraprese allora il primo tentativo di costruire una comunità politica democratica ed efficace, oggi il Movimento, sulla base del voto europeo che costituisce il primo passo sulla strada della costruzione dell'Europa, luglio-agosto 1980 deve perseguire l'obiettivo del completament o costituzionale>>. Per concludere: *L'idea-forza, cui deve essere subordinata ogni indicazione tattica, sarà pertanto quella del g o v e r n o europeo. La parola d'ordine che i nostri militanti hanno levato a Strasburgo il 17 luglio 1979 - nous avons voté, qui va gouverner? - deve divenire il riferimento costante della nostra lotta». Perché «se si chiede alla Comunità di affrontare le questioni dell'energia, dell'occupazione, dell'inflazione, della riconversione industriale e di una presenza attiva dell'Europa sulla scena internazionale, ma non si fa nulla per creare il mezzo indispensabile per questi scopi - un governo - si provoca la sfiducia nell'idea stessa dell'Europa,,. .Ma per battersi efficacemente per u n governo europeo» afferma ancora ii documento in questione «bisogna disporre di precisi orientamenti in ordine alle sue competenze e alla sua f o r m a » ; orientamenti che lo stesso documento illustra e sviluppa passand o in rassegna i campi della politica interna ed estera e postulando in particolare, oltre al controllo politico del Parlamento europeo, anche quello costituzionale del potere giurisdizionale; per arrivare infine a sottolineare [[l'urgenza di un grande dibattito sul nuovo modello politico e sociale, in modo da associare alla costruzione dell'Europale forzevive della società e della gioventù europea,,. Torniamo così a un vecchio tema agitato proprio dal C C E nei suoi Stati Generali di Roma del '64 col s u o famoso progetto per un .Fronte democratico europeo», di cui mai tanto quanto oggi si sono sentiti l'esigenza e il bisogno. Ma saprà questo Movimento europeo' soddisfarli? Ecco l'impegno attuale di tutti i federalisti, comunque organizzati, che il documento opportunamente ci riproprone. Gemellaggio: Lariano - S a u s s e t les Pins I1 25 maggio scorso si è tenuta a Lariano (Roma) la cerimonia di gemellaggio con la città francese di Sausset les Pins i cui ha partecipato il segretario generale dell'AICC E , Umberto Serafini. L'intera cittadina laziale ha festeggiato l'avvenimento nel corso della settimana del gemellaggio insieme alla delegazione francese guidata dal sindaco Pierre Matraja, che nel s u o saluto ha espresso la convinzione che l'unione fra le due città serva la causa europea. « I tempi sono evoluti ed è passata l'epoca ha continuato Matraja - in cui i popoli vivevano rinchiusi in se stessi. Oggi i confini hanno una utilità relativa di fronte al gran destino dell'umanità. Congiungere i popoli, agire cosicchè gli uomini si conoscano meglio e si capiscano di più alfine di stimarsi maggiormente e di evitare, così, gli scontri che purtroppo abbiamo incontrato nel passato e che tanto spesso trasformarono la nostra Europa in un vero campo di battaglia. D a tanto tempo gli uomini di buona volontà hanno operato per raggiungere questo simbolo di pace che rappresenta l'Europa unita. D a voi Alcide D e Gasperi, in Germania Konrad Adenauer, nel Belgio Paul H e n r y Spaak, in Francia Jean Monnet e Robert Schuman hanno per anni e anni gridato la loro volontà comune di creare l'Europa che tutti volevamo. C i ò ebbe per risultato il trattato di Roma, la Comunità europea carbone-acciaio e oggi l'Assemblea Europea di Strasburgo. Quanta strada percorsa in un mezzo secolo. C h i poteva credere che saremm o oggi riusciti a fondare nove popoli e luglio-agosto 1980 COMUNI D'EUROPA (al centro, da sinistra) il sindaco di Sausset les Pins, Pierre Matraja, con il sindaco di Lariano, Tiberio Bartoli e i1 segretario generale dell'AICCE, Umberto Serafini. domani dodici, anche se talvolta sorgono difficoltà in questa marcia in avanti. Festeggiamo oggi il gemellaggio nell'allegria, nell'amicizia, nella fratellanza; aggiungiamo la nostra pietra all'edificazione della città europea futura che faremo se tutti lo vorremo, libera, felice e generosa. Al di là delle divergenze oli ti che, tramite il gemellaggio fra Lariano e Sausset les Pins, vogliamo. contribuire all'opera immensa che consiste nel far nascere un'amicizia maggiore fra gli uomini e una fraternità maggiore fra i popoli". D a parte sua il sindaco di Lariano, Tiberio Bartoli, dopo aver auspicato che in futuro le due città possano parlare l'unica lingua, quella europea, ha detto fra l'altro: « In epoca relativamente recente, fu il Consiglio dei Comuni d'Europa ad ideare il gemellaggio tra Comuni di diverse nazioni con il preciso obiettivo di rinsaldare politicamente, con la partecipazione diretta delle popolazioni, i vincoli di solidarietà e d'impegno comune nella costruzione dell'unificazione europea. A tali funzioni questi gemellaggi hanno seriamente ed efficacemente adempiuto, proprio perché i Comuni sono da considerare i primi interlocutori per una Europa unita. Infatti, un gemellaggio, se ben ideato, e se costruito su solide fondamenta, è l'incontro di due o più Comuni che proclamano di associarsi per agire nelle prospettive di una federazione europea costruita, appunto, dalla base, per confrontare i loro problemi, per migliorarsi moralmente e materialmente, per sviluppare, in definitiva, fra di loro vincoli d'amicizia sempre più stretti nel più perfetto spirito che anima le leggi morali della libertà e della democrazia. Sono queste iniziative che deb-. bono servire soprattutto a contatti durevoli per sviluppare nelle popolaz;oni il senso di appartenere all'Europa per contribuire tutti insieme alla sua definitiva unificazione. L'azione del gemellaggio risulterà tanto più efficace, quanto più alle forze.autonomi- ste, rappresentate dagli enti locali, si saprann o affiancare i partiti politici, i sindacati, le forze culturali e del mondo del lavoro e tutte le associazioni a livello locale. E' compito, quindi, non solo di tutti gli eletti ai Consigli comunali, ma anche di tutte quelle forze sociali che in un modo o in un altro coinvolgono la vita del cittadino, di interessare e sensibilizzare l'opinione pubblica nella storica impresa dell'unificazione politica dell'Europa come elemento caratterizzante e condizionante della costruzione di una autentica democrazia e di un sempre.migliore modello di società. C o n le elezioni dirette del Parlamento europeo del giugno dello scorso anno e con la composizione dello stesso l'arlamento si è raggiunto un grande traguardo ma guai a considerarlo il traguardo definitivo. Anzi, l'aver eletto il Parlamento europeo non significherebbe nulla se a questo importante atto non si intende dare continuità tramite la sensibilizzazione popolare, la eliminazione morale e materiale delle barriere che ancora esistono fra Stato e Stato e se tutti insieme non lavoreremo per il mantenimento ed il rafforzamento della pace, di questo grande mare al quale anche Lariano e Sausset portaiio le loro gocce d'acqua quale contributo, piccolo ma sincero, a tutti i cittadini del mondo. Al di sopra delle parti, che possono spesso dividere gli uomini ma possono anche permettere il confronto fra di essi, siamo qui riuniti con intenti di leale collaborazione, siamo qui riuniti per dare vita Concreta a ' questo gemellaggio con la piena e ferma convinzione di fare così il nostro dovere di uomini-guida del nostro paese. C o n lo stesso intento sono qui, ne sono certo, gli amici di Sausset. A noi di Lariano ed a loro di Sausset spetta dare vera forma al gemellaggio che oggi si concretizza, una forma morale e materiale. Gli scambi che nel futuro si effettueranno dovranno avere come perenne pre- supposto il bene reciproco dei due comuni. D a oggi Lariano sa di avere, anche oltre le Alpi, degli amici e di altrettanti sentimenti può andarne certa Sausset. I1 gemellaggio non deve servire a far mostra di quanto di bello posiiamo avere; esso deve servire a migliorarci, deve servire ad imparare. N o i avremo sempre da offrire a Sausset cose e sentimenti utili; ma anche noi avremo da Sausset tanto da apprendere per migliorarci sempre di più e per sempre di più essere pronti all'aperto confronto con tutti, per sentire tutti nostri pari e fratelli. Ai più giovani - ha concluso il sindaco offriamo questo gemellaggio e ad essi diciamo che come noi abbiamo saputo crearlo, così a loro spetta il renderlo robusto facendolo crescere bene. I sentimenti che oggi legano i Comuni di Sausset les Pins e Lariano siano dai giovani mantenuti saldi e siano, anzi, rafforzati dalla reciproca maggiore conoscenza nel futuro. Questo è ciò che noi, uomini di oggi, ci auguriairio per coloro i quali saranno gli uomini di domani: possano Lariano e Sausset, tramite il loro gemellaggio, sempre migliorarsi ed essere d'esempio ad altri per intraprendere, tutti insieme, la strada che porta al grande viale dell'unità e della pace fra i popoli p . COMUNI D ' E U R O P A Organo del1'A.I.C.C.E. A N N O XXVIII - N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 1980 Direttore resp. : UMBERTO SERAFINI Redattore capo: EDMONDO PAOLINI T- DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE Piazza di Trevi, 86 - Roma 6.784.556 6.795.712 Indir. telegrafico: Comuneuropa - Roma Abbonamento annuo L. 5.000 - Abbonamento annuo estero L. 6.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 25.000 - Una copia L. 500 (arretrata L. 1.000) - Abbonamento sostenitore L. 300.000 - Abbonamento benemerito L. 500.000. I versamenti debbono essere effettuati sul c/c postale n. 35588003 intestato a : Istituto Bancario San Paolo di Torino, Via della Stamperia, Sede di Roma n. 64 - Roma (tesoriere dell'AICCE), oppure a mezzo assegno circolare - non trasferibile - intestato a uAICCE* , specificando sempre la causale del versamento. - Aut. Trib. Roma n. 4696 dell'll-6-1955 Associato all'USPI Unione Stampa Periodica Italiana 26' ESEliK=IZIO L'Assemblea dei Partecipanti al Fondo d i dotazione dell'lSVEIMER -Istituto per lo Sviluppo Economico dell'ltalia Meridionale - ha approvato il Bilancio relativo all'esercizio 1979 che si compendia nelle seguenti cifre: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1979 \ ATTIVO - DisponibilitA 151.253.972.775 -Partecipanti per quote da versare 1 aumento fondo di dotazione 1.656.000.000 - Mutui e crediti verso mutuatari 2.131.735.825.415 -Partecipazioni 4.935.140.026 -Investimenti in titoli 143.899.504.278 -Altre partite 232.647.625.064 L. 2.666.1 28.067.558 -Impegni verso terzi -Conti d'ordine 853.322.312.735 193.085.210.325 L. 3.712.535.590.618 PASSIVO -Fondi di dotazione,di riserva e a copertura rischi - Prestiti obbligazionari -Mezzi forniti dal Tesoro dello Stato. dalla Casmez, dal Mediocredito e dalla BEI -Prestiti in valuta estera -Fondi di accantonamento ed amniortamento -Altre partite -Utile netto - Impegni verso terzi - Conti d'ordine 400.720.992.1 55 1.654.200.31 2.268 344.646.527.037 84.81 2.500.000 28.957.386.835 140.670.778.292 12.119.570.971 853.322.312.735 193.085.21 0.325 L. 3.71 2.535.590.61 8 A tasso agevolato Finanziamenti per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione. riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali. Finanziamenti al commercio. Operazioni di credito a medio termine per l'esportazione di merci. di servizi e per l'esecuzione di lavori all'estero. Credito navale per la costruzione, la trasformazione di navi e gli acquisti all'estero di naviglio giA in esercizio. Credito turistico-alberghiero A tasso ordlnario Finanziamenti per costruzioni. rinnovi od ampliamenti di stabilimenti industriali, nonche per le scorte. Sovvenzioni e sconti cambiari. Aperture di credito. Sconti ed anticipazioni in base a regolari deleghe su annualità dovute dallo Stato, dalle' Regioni. dalle Province, dai Comuni, da Consorzi e da altri Enti Pubblici. Sottoscrizione di prestiti obbligazionari all'atto dell'emissione. Riporti ed anticipazioni su titoli di Stato. titoli obbligazionari. nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro. Altre operazioni previste da particolari disposizioni di legge. Istituto per lo Sviluppo Economico dell'ltalia Meridionale Ente di Credito di Diritto Pubblico Sede: Napoli - Via A De Gasperi. 71 - Tel 7853.1 11 s p Uffici dl rappresentanza: Roma - Via Porpora. 1 - Tel. 0440341/2/3 - 8440229 Milano - Via Turati. 29 - Tel. 6571951/2 Pescara - Via Emilia, 14 - Tel. 377106/7 Bari - Via Michelangelo Signorile. 28 - Te1.540600/1- 540863 Potenza - Via Pretoria. 118 - Tel. 20991 Catanzaro - Via Tommaso De Filippis -Parco Millefiori Tel. 53111/2 Campobasso - Via Roma, 25 a - Tel. 96241 L'isveimer svolge la sua attività creditizia a medio termine, a tasso sia agevolato che ordinario, nell'ltalia meridionaie continentale, attraverso le seguentl operazioni: SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO p. a. CON SEDE IN TORINO ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 1980 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA In data 26 giugno si A tenuta a Torino l'Assemblea ordinaria della SIP, sotto la presidenza del prof. Antonio Gigli, che all'inizio della riunione ha ricordato, con commosse espressioni di cordoglio, il compianto Presidente della SocietA ing. Carlo Perrone, tragicamente. scomparso nel settembre 1979. L'Assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio, dal quale dopo l'accantonamento ad ammortamenti di 636 miliardi di lire - risulta la perdita di 485,8 miliardi; l'Assemblea a deliberato di coprire detta perdita, dopo l'utilizzo di 183 milioni di residuo utili di esercizi precedenti, mediante il prelievo di 485,6 miliardi dalla riserva di rivalutazione per conguaglio monetario formata ai sensi della legge 2 dicembre 1975, numero 576. Successivamente, l'Assemblea ha nominato Consiglieri di Amministrazione i signori ing. Ottorino Beltrami, prof. Giuseppe Vaccaro e dott. Giorgio Massone. Infine, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.13'6, ha conferito l'incarico per la revisione e la certificazione dei bilanci sociali alla Price Waterhouse & Co., per il triennio 1981-1982-1983. - PRINCIPALI REALIZZAZIONI NEL 1979 (E INCREMENTI RISPETTO AL 1978) ITALIA INVESTIMENTI [miliardi di lire) di cui nel MEZZOGIORNO 1.588 715.789 + 6,2% ) ( 4% ( 217.549 7,2% ) ( 274.585 65% ) + 1.004.654 APPARECCHI + 5,9% ) ( DENSITA' TELEFONICA [apparecchi x 100 abltantl] 31,7 NUMERI DI CENTRALE 20,8 734.081 5,8% ) ( + 5,5% ) 3.122.409 + 6,3% ) ( 999.890 + 6,9% ) 1.197.162 6,1%) ( 490.141 + 9,-?'O) ( RETI URBANE E SETTORIALI (km circultol + + ( 191.728 RETE INTERURBANA (km clrcuito) TRAFFICO EXTRAURBANO (mliloni di comunicixionl) di cui in teleselezione ( - ABBONATI COLLEGATI i l 31 dicembre 1979 + 3.093,6 ( + 13,3% ) 769,- (+ 14,9%) 3.082,7 ( + 13,5% ) 766,l + 15,-% ) 12.171.553 3.258.207 18.082.292 4.481 327 APPARECCHI IN SERVIZIO al .31 dicembre 1970 FRIULI=VENEZIA GIULIA Una regione da visitare perché.. . perché nel Friuli-Venezia Giulia potrete sempre scopr,ire qualcosa d i diverso dal solito, un qualcosa che darà un significato alla Vostra vacanza. perché nel Friuli-Venezia Giulia troverete la romanità d i Aquileia, le testimonianze longobarde d i Cividale, il Carso d i Slataper, la laguna d i Biagio Marin, le montagne d i Giulio Kugy, il Timavo d i Virgilio, gli affreschi del Tiepolo, del Pordenone, i luoghi che ispirarono le pagine d i Umberto Saba, d i Italo Svevo, d i Ippolito Nievo, di Reiner Maria Rilke, le 4 1 lotte>. d i Zardini.. . perché nel Friuli-Venezia Giulia potrete scoprire, nel breve volgere d i una giornata, le infinite modulazioni d i un paesaggio che in un continuo variare d i forme e colori - invita a sostare al mare, a raggiungere le tante valli della montagna, a trovare ristoro tra le colline in un mondo spesso ancora arcaico.. . 'perché nel Friuli-Venezia Giulia potrete scoprire i sapor i irripetibili d i una cucina genuina, dei formaggi d i malga, il profumo d i vini d i antica nobiltà... perché potrete scoprire il tessuto che ha prodotto I'incontro d i p i ù civiltà, d i più lingue, d i diverse culture, in una terra che ha tre confini. Ciò è quanto potrete trovare ... . . . nel FRIULI-VENEZIA GIULIA (a cura dell'Assessorato regionale del turismo)
Scarica