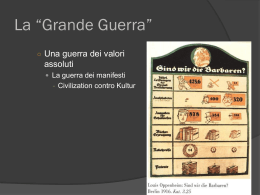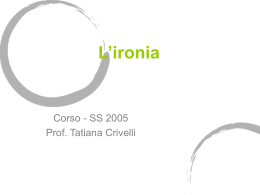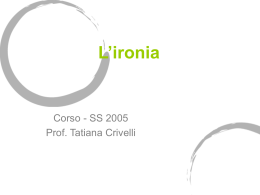IRENE STELLADORO
L'IRONIA
INDICE
1. Introduzione:
Definizione di ironia
pag. 2
2. Le varietà dell'ironia:
L'ironia retorica e le sue sottospecie
Ironia drammatica e ironia narrativa
Satira e parodia
pag. 5
pag. 5
pag. 6
3. Aspetti teorici:
ironia semplice e ironia complessa: il "caso" Socrate (greco-filosofia)
ironia "socratica" e ironia "romantica" (filosofia)
Kierkegaard e la funzione metafisica dell'ironia (filosofia)
Pirandello e l'umorismo (italiano)
pag. 8
pag. 11
pag. 14
pag. 18
4. Esempi di ironia:
a) letterari:
Pirandello, Il fu Mattia Pascal (italiano)
Leopardi, Il Copernico (italiano) *
Lucano e l'epos antifrastico (latino)
Oscar Wilde, The importance of being Earnest (inglese)
Italo Calvino e le Cosmicomiche (italiano-scienze)
Luciano di Samosata, il re dell'ironia: (greco)
Alessandro o il falso profeta
Morte di Peregrino Proteo
Luciano e i cristiani *
b) politici:
l'ironia come arma ideologica: Marco Travaglio
c) storico-artistici:
René Magritte, l'ironia come depistaggio (storia dell'arte)
d) esistenziali:
John von Neumann: la tragica ironia del destino (storia-fisica)
e) storici:
Ironia come hybris: Hiroshima e Nagasaki (storia)
la bomba H: fissione e fusione (fisica)
f) scientifici:
ironia matematica e paradossi (matematica)
perché la Luna ci mostra sempre la stessa faccia? (scienze)
pag. 23
pag. 23
pag. 26
pag. 31
pag. 37
pag. 44
pag. 44
pag. 50
pag. 52
pag. 54
pag. 55
pag. 65
pag. 69
pag. 75
pag. 80
pag. 85
Appendice:
Giacomo Leopardi, Il Copernico
Lucano, il proemio del Bellum civile
Luciano, Alessandro o il falso profeta
pag. 88
pag. 93
pag. 96
Bibliografia e sitografia
pag. 107
N.B.: gli argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti tramite un lavoro di
gruppo.
1
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
1. INTRODUZIONE
DEFINIZIONE DI IRONIA
Per il soggetto ironico la realtà data
ha perso completamente il suo valore,
gli è diventata una forma imperfetta e intralciante. [...]
Per l'altro verso però, non possiede il nuovo.
Sa una cosa sola, che il presente non corrisponde all'idea [...].
In un certo senso l'ironista è veramente profetico.
(S. Kierkegaard, "Il concetto di ironia
in costante riferimento a Socrate", 1841)
Un'eccellente introduzione, sintetica e precisa, al fenomeno dell'ironia, si trova nel capitolo "L'ironia nel
libro di Giobbe" che fa parte del saggio di Gianantonio Borgonovo "La notte e il suo sole: luce e tenebra nel
libro di Giobbe; analisi simbolica" (Analecta Biblica 135, Roma, 1995).
L'autore, in modo metodologicamente ineccepibile, prende le mosse dalla definizione fornita da Heinrich
Lausberg nel suo celebre manuale Elementi di retorica (Il Mulino, Bologna 1969; titolo originale Elemente der
literarischen Rhetorik, München, Max Hueber Verlag, 1949), a sua volta debitore delle teorie retoriche
classiche, e classifica i diversi fenomeni riconducibili all'ironia suddividendoli in alcune categorie
fondamentali.
Mi sembra che questo sia il miglior punto di partenza per la mia ricerca: ne riassumo perciò di seguito
l'inizio, riportandone gli stralci fondamentali.
Søren Kierkegaard
Anzitutto è necessario fare un po' di chiarezza sul significato del vocabolo: come afferma infatti Luis Alonso
Shökel in un suo saggio del 1987, vi è oggi un uso "confuso ed abusivo" del termine ironia.
La retorica classica greco-latina distingueva solo due forme di ironia: quella retorica (o verbale) e quella
drammatica; Quintiliano ad esempio (Inst. Or. IX, 2, 44), e tutti i classici citati dal Lausberg, non ne
conoscono (o riconoscono) altri tipi.
La distinzione "canonica" odierna tuttavia è triplice: ironia retorica, drammatica e narrativa.
Tutte e tre mantengono un certo ancoramento, in diverso modo, al significato etimologico del termine: in
greco infatti eironèia indicava il modo di parlare e di comportarsi di un tipico personaggio della commedia
classica, l'èiron, ovvero "dissimulatore", il quale veniva contrapposto nell'agòn al suo opposto, l'alàzon o
2
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
"millantatore"; il primo, in grado di nascondere la sua astuzia sotto la maschera dimessa del perdente, finiva
sempre per vincere sul secondo, spaccone e ingenuo, incapace di fingere.
Tutte le forme di ironia hanno in comune il fatto di fare perno sulla distanziazione che si crea tra l'autore e i
suoi personaggi (nel dramma o nella narrazione).
L'ironia retorica viene classificata come uno dei tropi sia della parola sia del pensiero. E' bene ricordare che
tropo, figura di sostituzione o paradigmatica, è qualsiasi utilizzo figurato di una parola.
Più precisamente s'intende per tropo una figura retorica in cui un'espressione può:
a) essere trasferita dal significato che le si riconosce come proprio ad un altro figurato;
b) essere destinata a rivestire, per estensione, un contenuto diverso da quello originario e letterale.
Il Lausberg, sulla scorta degli autori classici che ne hanno trattato diffusamente, classifica come tropi
undici figure retoriche, e cioè le seguenti:
Allegoria, sostituzione del pensiero che si intende per mezzo di un altro pensiero che si trova in un rapporto
di somiglianza con il pensiero che si vuole intendere;
L'allegoria dantesca della "selva oscura"
raffigurata da Gustave Doré (1861-1868)
Catacrèsi, estensione usuale di una parola o di una locuzione oltre i limiti del suo significato proprio;
Metafora, trasferimento ad un oggetto del nome proprio di un altro, secondo un rapporto di analogia;
Sineddoche, uso in senso figurato di una parola al posto di un'altra, mediante l'ampliamento o la restrizione
del senso;
Metonimia, sostituzione di un termine proprio con un altro appartenente allo stesso campo semantico, che
abbia col primo una relazione di contiguità logica o materiale;
Antonomasia, sostituzione di un nome con una denominazione che lo caratterizza;
Eufemismo, sostituzione di un termine diretto con uno attenuativo;
Iperbole, esagerazione di un concetto oltre i limiti della verosimiglianza;
Litote, negazione del contrario di ciò che si vuole affermare;
Ironia, affermazione del contrario di ciò che si pensa;
3
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Perifrasi, sostituzione di un termine con un giro di parole.
Come si vede, l'ironia è uno degli undici tropi, ed è in un certo senso l'opposto della litote.
Ma occupiamoci specificamente dell'ironia.
4
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
2. LE VARIETA' DELL'IRONIA
Come tropo della parola, l'ironia è la caratteristica espressione antifrastica, che fa perno sul contesto
linguistico o extra linguistico perché sia avvertito lo scarto.
Il Lausberg la definisce così: "l'uso del vocabolario partigiano della parte avversa, utilizzato nella ferma
convinzione che il pubblico riconosca la incredibilità di questo vocabolario. La credibilità della propria parte
risulterà, quindi, rafforzata tanto che, come risultato finale, le parole ironiche verranno intese in un senso che
sarà completamente opposto al loro senso proprio" (tr. it. pagg. 128s).
Come tropo del pensiero "è in primo luogo ironia di parola continuata come ironia di pensiero, e consiste
nella sostituzione del pensiero che si vuole intendere con un altro pensiero che sta in un rapporto di senso
contrario al primo e che corrisponde quindi al pensiero dell'avversario" (tr. it. pag. 237).
L'esempio sublime di ironia retorica del pensiero è il Socrate dei dialoghi platonici (ironia socratica). Egli,
dissimulando la sua opinione in un modo simile all'èiron della commedia, si presenta con modestia e fa
professione di ignoranza, pronto ad assumere il punto di vista dell'avversario per condurlo però al punto
estremo di assurdità e quindi alla sua negazione (cfr. Lausberg pag. 237).
Casi particolari dell'ironia retorica possono essere considerati il sarcasmo, lo humour, il paradosso (o
l'ossimoro) e il doppio senso.
Socrate ritratto da Lisippo (IV a.C.)
Definiamoli uno per uno:
- il sarcasmo è l'uso crudele e beffardo di un'affermazione per esprimere in realtà la sua negazione;
- lo humour si ha "quando il riso entra in azione ad una certa distanza dall'oggetto, intriso d'affetto o venato
di simpatia" (la definizione è di Luis Alonso Shökel);
- il paradosso è un uso sintagmatico di termini tra loro incongruenti o addirittura contraddittori (esempio il
raggio delle tenebre);
- il doppio senso è dato dall'utilizzazione di termini "aperti" o di sintagmi che possono essere interpretati a
diversi livelli, e corrisponde a ciò che la poetica araba classifica sotto il nome di taurija o di talhin.
L'ironia drammatica può essere sia tragica che comica ed è imperniata sul triangolo autore-personaggiolettore.
5
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
L'ironia tragica o "sofoclea" ha luogo in una situazione (dramma o narrazione) in cui lo spettatore, e più in
generale l'interprete, condivide con l'autore una conoscenza non posseduta da uno o più personaggi.
L'esempio più tipico è costituito dall'Edipo re di Sofocle, in cui il protagonista agisce e parla senza sapere
quanto egli stesso stia tragicamente procurandosi, mentre lo spettatore (ed ovviamente l'autore) ne sono al
corrente.
Inoltre, come è ovvio a partire dalla stessa etimologia del termine, che, come si è detto, fa riferimento ad un
personaggio tipico della commedia, l'èiron o dissimulatore, vi può essere una ironia comica, basata
sull'espediente della sorpresa e del coup de théatre. Si pensi, ad esempio, ai racconti di Boccaccio o alle
commedie di Molière e di Shakespeare.
A questo tipo di ironia si riferisce anche l'espressione corrente "ironia della sorte", che M.H. Abrams chiama
"cosmic irony": al "Fato" (o a Dio) viene attribuita una volontà ironica, che si fa beffe dei piani e delle
speranze degli uomini; esponente tipico di questa concezione del Fato è il romanziere e poeta inglese
Thomas Hardy.
Anche l'ironia narrativa si basa sul triangolo ermeneutico autore-personaggio-lettore, ma essa "si verifica
quando l'autore prende le distanze dal suo personaggio e lo costringe a compiere azioni ridicole davanti al
pubblico" (così ancora Luis Alonso Shökel).
In altre parole, nell'ironia narrativa l'autore, d'intesa con il lettore (o il pubblico), si prende gioco del suo
personaggio: è quel caratteristico atteggiamento che in francese si definisce persiflage, termine impiegato
anche al di fuori della sfera letteraria come sinonimo colto di "presa in giro", che trova un illustre ed
istruttivo utilizzo da parte di Giacomo Leopardi nel suo "Discorso sopra lo stato presente dei costumi
degl'italiani" del 1824.
Molière ritratto da Nicolas Mignard, 1658
Due altri generi vanno menzionati, in quanto, pur non essendo sempre legati all'ironia, possono tuttavia
utilizzarne il linguaggio: la parodia e la satira.
La satira è un genere fluttuante, che sfugge ad ogni interpretazione precisa. È difficile trovare oggi due
autori che concordino nel definirla, come nota J.T. Shipley. Tuttavia, alcune caratteristiche sono rimaste
costanti nella sua definizione, da Quintiliano a Northrop Frye: la satira è concepita "as attack to expose folly
or vice, dullness or evil - or even to advance some amoral position (e.g., H.L. Mencken) or an immoral stance
(e.g. Machiavelli) - whether by gentle rebuke or scarifying verbal onslaught, by ridicule or invective, whether
6
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
direct through burlesque or indirect through irony" (J.T. Shipley, Dictionary of World Literary Terms, The
Writer Inc., Boston, 1970); ovvero "come attacco per esporre follia o vizio, ottusità o male - o anche per
proporre qualche posizione amorale (ad esempio, H.L. Mencken) o un atteggiamento immorale (ad esempio
Machiavelli) - sia attraverso un blando rimprovero che un furibondo assalto verbale, sia attraverso il ridicolo
che l'invettiva, sia direttamente attraverso il burlesco che indirettamente attraverso l'ironia".
Interessante è notare che proprio Northrop Frye (Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton University
Press, 1957, pag. 223) distingue la satira dall'ironia per il fatto che nella satira la situazione viene percepita
immediatamente "grottesca", mentre nell'ironia il conflitto viene celato sotto un'apparente contenuto
realistico.
Northrop Frye
La satira sarebbe dunque una militant irony: "Irony is consistent both with complete realism of content and
with the suppression of attitude on the part of the author. Satire demands at least a token fantasy, a content
which the reader recognize as grotesque, and at least an implicit moral standard, the latter being essential in
a militant attitude to experience" (op.cit. pag. 124).
La parodia, infine, potrebbe in qualche misura essere considerata una forma di ironia socratica: essa
presuppone una conoscenza previa da parte dell'interprete di uno standard (narrativo o di valori), a cui
l'autore fa riferimento per discostarsene e offrirne una reinterpretazione più o meno sarcastica o satirica. Per
citare un esempio dalla letteratura greca, si pensi alla parodia dei poemi omerici nella Batracomiomachia.
7
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
3. ASPETTI TEORICI
IRONIA "SEMPLICE" E "COMPLESSA": IL CASO SOCRATE
Quintiliano (35-96 d. C.) definisce l'ironia come una figura del linguaggio o tropo in cui contrarium quod
dicitur intelligendum est, cioè nella quale si deve intendere il contrario di ciò che letteralmente si dice.
Questo senso della parola "ironia" è arrivato fino a noi, sia nel caso in cui questa figura è usata per prendere
urbanamente in giro gli interlocutori, sia quando è usata per denunciare velatamente l'incommensurabilità
del singolo alla realtà, cioè la sua difficoltà ad adeguarsi e a ritrovarsi in un mondo che gli è estraneo. Questo
è il caso dell'ironia romantica, come descritta, per esempio, da Kierkegaard (1813-1855), sebbene
Kierkegaard abbia una visione dell'ironia alquanto riduttiva rispetto agli altri Romantici, come spiegato in
un capitolo successivo.
Nel greco del V secolo, tuttavia, il significato primario di "ironia" non era quello riportato da Quintiliano, ma
quello che ritroviamo in bocca al sofista Trasimaco nel I libro della Repubblica platonica, e cioè
"dissimulazione" o "finzione" finalizzata ad ingannare. Il "fare finta" per gioco o per scherzo era solo un
significato secondario, ed era tipico soltanto di Socrate.
Se oggi noi intendiamo il termine "ironia" al modo di Quintiliano e non a quello di Trasimaco, è solo in virtù
del rovesciamento dovuto alla durevole impressione che il comportamento di Socrate produsse sui
contemporanei e sulla posterità. Socrate ha dunque prodotto un vero e proprio spostamento semantico del
termine.
Gregory Vlastos, che si interroga sulla figura di Socrate nel suo libro Socrates. Ironist and Moral Philosopher,
Cambridge, Cambridge U.P., 1991 (trad. it di A. Blasina, Socrate, il filosofo dell'ironia complessa, Scandicci, La
Nuova Italia, 1998), chiarisce bene la natura del tutto particolare dell'ironia socratica.
Raffaello, Socrate e i suoi discepoli nella Scuola di Atene
dalle Stanze Vaticane (1511)
Egli ritiene che essa non possa ridursi a ironia semplice, ed introduce perciò il concetto di ironia complessa.
Socrate si dice ignorante: infatti non espone né scrive mai una propria filosofia. Ma, nello stesso tempo, è
persona capace di affrontare la morte in nome della conoscenza.
Se si riducesse l'ironia socratica ad ironia semplice, dovremmo dire che Socrate fa finta di essere ignorante,
ma in realtà è sapiente. Ma questa affermazione è oltremodo riduttiva e ci fa perdere un aspetto
8
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
fondamentale della figura speculativa di Socrate, vale a dire il suo uso dell'èlenchos (confutazione), che
comporta che ogni discussione cominci con premesse esplicitamente poste, e non con l'affermazione di una
verità data per indiscutibile e nota.
Il testo che ci fornisce un esempio illuminante di èlenchos socratico, insieme a tutte le implicazioni filosofiche
che esso comporta, è il Gorgia platonico. Poiché però questo è un dialogo in cui già molte delle teorie
platoniche fanno il loro esordio, sarà meglio limitarci ad analizzare il percorso argomentativo ‘tipico’ seguito
da Socrate così come appare nei dialoghi giovanili di Platone, che sono i più marcatamente "socratici".
In primo luogo, il termine èlenchos indica quel genere di ‘confutazione’ che si attua con la dimostrazione
della contraddittorietà della tesi dell’avversario. Esistono due generi di èlenchos: quello diretto e quello
indiretto. Di solito l’èlenchos socratico è di carattere indiretto e consiste non nel dimostrare l’assurdità o la
contraddittorietà della tesi dell’opponente mediante una dimostrazione che diriga le sue obiezioni contro la
tesi stessa, ma piuttosto nel dimostrare che, data l’affermazione A, A implica B, B implica C e D e che, infine,
C e D stanno in contraddizione tra loro o in contraddizione con la tesi di partenza di cui costituiscono le
implicazioni logiche.
Quando Socrate ingaggia le sue discussioni con il suo opponente di turno, fa in modo che dopo alcuni
convenevoli introduttivi l’interlocutore faccia almeno un’affermazione sull’argomento che a Socrate
interessa discutere. Allora il resto della discussione si snoda con la fluidità di un teorema matematico.
Socrate pone la prima domanda sull’affermazione del rispondente, che di solito assume una delle due forme:
‘X è Y?’ oppure ‘Cos’è X?’.
Esempi del primo genere possono essere: ‘La giustizia è migliore dell’ingiustizia?’ (Repubblica); ‘È giusto
fuggire di prigione?’ (Critone). Esempi del secondo tipo sono ‘Cos’è la temperanza?’ (Carmide); ‘Cos’è il
coraggio?’ (Lachete).
Ritratto di Socrate
Con queste domande Socrate non è mai alla ricerca di una definizione da vocabolario di un termine che gli
è sconosciuto, perché di solito il suo ‘X’ è un concetto che lui e i suoi rispondenti usano in modo
estremamente ricorrente. Inoltre la sua domanda non è mai una richiesta di informazione né una specie di
‘richiesta-verifica’, propria del maestro che intende verificare la preparazione dell’allievo, perché Socrate
ricerca insieme con il suo interlocutore. Le domande di Socrate sostano su un gradino intermedio tra questi
due estremi. La risposta cercata da Socrate è da un lato una definizione analogica che fornisca degli
equivalenti di X, dall’altro una risposta che restringendo il campo degli attributi di X, si limiti a definirlo con
l’elencazione di tutte quelle caratteristiche per cui X è X e per cui tutte le X vengono dette X.
9
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
I presupposti filosofici sottesi a questo metodo di inchiesta sono i seguenti:
a) X è un termine univoco;
b) la cosa X ha un’essenza;
c) l’essenza non è una struttura primaria, ma ha una struttura che può essere ancora analizzata e
spiegata.
La definizione elenctica è in cerca della singola cosa che è comune a molti individui singoli. La certezza che
la definizione e l’esistenza di questa ‘cosa singola’ che si predica di molti individui siano possibili deriva
dall’evidenza per cui a molte cose viene attribuito un nome comune. A sua volta quest’ultimo fatto è reso
possibile dalla natura comune che apparenta le cose.
La definizione che Socrate ricerca mira dunque all’elemento comune (definiens) a tutte le cose chiamate con
un unico nome (definiendum).
Perché si abbia tuttavia un perfetto dispiegamento dell’èlenchos socratico si rendono necessarie alcune
condizioni.
In primo luogo, alle affermazioni dell’interlocutore di turno devono realmente corrispondere delle
convinzioni profonde. Il rispondente deve poi essere convinto della validità logica dell’argomentazione
socratica e convenire sulle premesse da cui prende inizio l’argomentazione.
Quando la confutazione elenctica consiste nella riduzione all’assurdo delle tesi del rispondente, quest’ultimo
deve vedere con evidenza questa assurdità. L’èlenchos non è il tribunale di Socrate, ma è il tribunale della
ragione, il cui verdetto viene pronunciato da Socrate solo perché egli è il solo interlocutore che non
rappresenta se stesso, ma il paradigma dell’interlocutore razionale. Tutto questo gli è consentito
esclusivamente dall'ironia, che, abbassando l'individuo Socrate a livello di "colui che non sa (ma desidera
sapere)", innalza per contrapposto la Ragione di cui egli si fa rappresentante.
Per questo Vlastos introduce la figura dell'ironia complessa: a differenza dell'ironia semplice, in cui il senso
letterale di ciò che si dice è falso, nell'ironia complessa il contenuto superficiale è vero in un senso e falso in
un altro. Perciò Socrate è ignorante in senso letterale, ma è sapiente in un altro e più profondo senso, e cioè
perché le sue confutazioni, e soprattutto il modo in cui le compie, attraverso l'èlenchos e la maieutica, servono
a dare avvio a un cammino verso la conoscenza che ognuno deve compiere da sé.
Di qui parte la riflessione sull'ironia che si svolge nei secoli successivi, e che coinvolge anche la storia della
filosofia.
10
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
IRONIA "SOCRATICA" E "ROMANTICA"
La storia della filosofia distingue due forme fondamentali d'Ironia:
- l'Ironia socratica;
- l'Ironia romantica.
L'ironia socratica
Essa consiste, come abbiamo visto, nella sottovalutazione che Socrate, un po' per finta e un po' per davvero,
fa di se stesso nei confronti degli avversari con cui discute. Quando nella discussione sulla giustizia Socrate
dichiara: "Io ritengo che l'indagine è al di là delle nostre possibilità e che voi che siete bravi dovete aver pietà
di noi piuttosto che arrabbiarvi con noi", Trasimaco esclama: "Ecco la solita ironia di Socrate!" (Rep., I, 336 e337 a).
Aristotele non fa che enunciare genericamente questo atteggiamento socratico quando vede nell'ironia uno
degli estremi nell'atteggiamento di fronte alla verità. Il veritiero è nel giusto mezzo; chi esagera la verità è il
millantatore e chi invece tenta di diminuirla è l'ironico.
Aristotele
L'ironia, dice Aristotele, è, sotto questo aspetto, simulazione (Et. Nic., II, 7, 1108 a 22). Cicerone si rifà a
questo concetto affermando che "Socrate spesso nella disputa abbassava se stesso ed alzava coloro che
voleva confutare; e così, parlando diversamente da come pensava, adoperava volentieri quella simulazione
che i Greci chiamano ironia" (Acad., IV, 5, 15). E a questo concetto del termine fa riferimento anche S.
Tommaso, che la considera una forma lecita di menzogna (Summa Theologica, II, 2, q. 113, a. 1).
L'Ironia romantica
Essa poggia sul presupposto dell'attività creatrice dell'Io assoluto. Identificandosi con l'Io assoluto, il
filosofo o il poeta (che molto spesso coincidono, per i Romantici) è portato a considerare anche la realtà più
salda come un'ombra o un gioco dell'Io: è portato cioè a sottovalutare l'importanza della realtà, a non
prenderla sul serio.
11
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Secondo Friedrich Schlegel, l'ironia è la libertà assoluta di fronte a qualsiasi realtà o fatto: "trasferirsi
arbitrariamente ora in questa ora in quella sfera come in un altro mondo, non solo con l'intelletto e con
l'immaginazione ma con tutta l'anima; rinunciare liberamente ora a questa ora a quella parte del proprio
essere, e limitarsi completamente a un'altra; cercare e trovare il proprio uno e tutto ora in questo, ora in
quell'individuo e dimenticare volutamente tutti gli altri: questo può solo uno spirito che contiene in sé come
una pluralità di spiriti e tutto quanto un sistema di persone, e nel cui intimo l'universo che, come si dice, è in
germe in ogni mondo, s'è dispiegato ed è pervenuto alla sua maturità" (Fragmente, 1798, § 121).
Queste notazioni sull'ironia trovarono una sistemazione concettuale nell'opera di Karl Wilhelm Ferdinand
Solger, intitolata Erwin - Quattro dialoghi sul bello e sull'arte (1815), nella quale l'ironia viene interpretata dal
punto di vista della soggettività che comprende se stessa come cosa suprema e che perciò abbassa a un puro
nulla tutte le altre cose, anche ciò che c'è di più alto.
Pur polemizzando contro qualche particolare, definito " platonico " della dottrina di Solger, Hegel la faceva
sua nel descrivere l'ironia nel modo seguente: "Prendete una legge, e schiettamente qual è in sé e per sé: io ne
sono perciò anche al di là e posso fare così e così. Non la cosa è superiore, ma sono io superiore e sono il
padrone, che al di sopra della legge e della cosa, scherza con esse come con il suo piacere e in questa
coscienza ironica, nella quale lascio perire il Sommo, godo soltanto di me" (Fil. del dir., § 140).
L'ironia così intesa, come coscienza della Soggettività assoluta, la quale, come tale, è tutto e di fronte alla
quale perciò tutte le altre cose sono nulla, e pertanto come coscienza dell'assoluto arbitrio di tale
soggettività, è, secondo Hegel, un risultato della filosofia di Fichte quale è stata intesa e interpretata da
Schlegel (FU. del dir., § 140, Zusatz).
Un giovane Hegel
"Qui il soggetto si sa in sé medesimo come l'Assoluto e non dà alcun peso a tutto il resto: esso sa
distruggere sempre di nuovo tutte le determinazioni che esso stesso si dà del giusto e del bene. Esso può
dare a intendere a sé ogni cosa ma non mostra altro che vanità, ipocrisia, sfrontatezza. L'ironia sa di
dominare qualsiasi contenuto: essa non prende nulla sul serio, scherza con tutte le forme" (Geschichte der
Phil., III, sez. 3, C, 3; trad. ital.. III, 2, pag. 370-71).
Quel concetto è rimasto a contrassegnare uno degli aspetti fondamentali del romanticismo tedesco. Di esso
Kierkegaard ha dato un'interpretazione attenuata o metaforica, da un lato concependo l'ironia socratica
come la superiorità di Socrate sopra la nequizia del mondo (Diario, X3, A, 254); dall'altro lato intendendo in
generale l'ironia come "l'infinitizzazione dell'interiorità dell'io", ma come infinitizzazione puramente
"interiore", in un significato che non ha più assolutamente la portata che Fichte attribuiva all'infinità stessa.
"Cos'è l'ironia?" egli scrive. "L'unità di passione etica, che accentua in interiorità il proprio io infinitamente, e
di educazione, la quale nel suo esteriore (nel commercio con gli uomini) astrae infinitamente dal proprio io.
12
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
L'astrazione fa sì che nessuno s'accorga della prima unità vissuta ed in ciò sta l'arte per la vera
infinitizzazione dell'interiorità" (Diario, VI, A, 38, trad. Fabro).
Poiché l'infinità dell'io è qui soltanto un'infinità "interiore", cioè l'accentuazione all'infinito del valore dell'io
nella coscienza, ma non è l'infinità effettiva e creativa dell'Io assoluto dei romantici, l'ironia di
Kierkegaard non ha più il suo significato romantico: è solo il contrasto tra la coscienza esaltata che l'io ha di
sé e la modestia delle sue manifestazioni esterne.
13
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
KIERKEGAARD E LA FUNZIONE METAFISICA DELL'IRONIA
Kierkegaard affronta il problema dell'ironia nella sua tesi di laurea, pubblicata nel 1841 con il titolo Il
concetto di ironia in costante riferimento a Socrate. Si tratta di un'opera ricca di riferimenti al dibattito
letterario e filosofico, poiché l'ironia - a partire dall'età del romanticismo - era diventata un tema
particolarmente vivo ed aveva attirato su di sé l'attenzione di autori come Tieck, Schlegel e Solger.
È tuttavia Hegel l'autore cui il giovane Kierkegaard si sente più vicino: nelle pagine della sua tesi di laurea, il
filosofo danese ha infatti ben chiara davanti agli occhi la riflessione hegeliana sulla valenza soggettiva e
negatrice dell'ironia, ed una delle mete cui il suo lavoro approda può essere forse indicata proprio
nell'acquisizione di una prima parziale autonomia del giovane filosofo dalla pagina hegeliana.
Il primo passo per venire a capo dell'ironia è, per Kierkegaard, di natura descrittiva: occorre infatti cercare
di caratterizzare questa forma del comportamento, indicando quali sono le differenze strutturali che ci
permettono di distinguerla da altri atteggiamenti della soggettività.
Osserveremo allora che, da un punto di vista descrittivo, l'ironia si rivela come quella forma del discorso "la
cui caratteristica è di dire l'opposto di quello che si pensa" (ivi, p. 192).
Søren Kierkegaard
Parlare significa dare al pensiero un'apparenza sensibile, e ciò è quanto dire che "mentre parlo, il pensiero,
l'opinione è l'essenza, la parola l'apparenza" (ivi). Nell'atteggiamento ironico, tuttavia, la parola cessa di
essere manifestazione del pensiero: il fenomeno non ci conduce più alla sostanza che in esso dovrebbe farsi
visibile, ma ci vincola apparentemente ad un pensiero che è per noi del tutto privo di verità e di sostanza.
L'ironia è dunque una sorta di sovversione del rapporto tra fenomeno ed essenza, ed appartiene proprio
per questo alla famiglia dei fenomeni "doppi": nell'ironia il fenomeno diviene infatti un'apparenza
ingannevole che allude ad una realtà che deve essere tuttavia negata. L'ironia sembra essere dunque una
peculiare forma di ipocrisia: le cose, tuttavia, non stanno affatto così; osserva infatti Kierkegaard:
L'ipocrisia pertiene di fatto all'ambito della morale. L'ipocrita si sforza in continuazione di
sembrare buono, pur essendo cattivo. L'ironia, per contro, si situa in un ambito metafisico, e per
l'ironista si tratta sempre solo di sembrare diverso da come veramente è, sicché, come nasconde il
suo scherzo nella serietà, e la sua serietà nello scherzo [...], così può anche venirgli di passare per
cattivo, pur essendo buono (ivi, p. 199).
14
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Del resto, la differenza tra ironia e ipocrisia traspare già nel fatto che l'ipocrita non vuole che il suo pensiero
sia colto e lo dissimula quindi interamente, mentre chi fa dell'ironia lascia trapelare nel riso la sua vera
opinione. L'ipocrita, dunque, non dice ciò che pensa perché non vuole essere giudicato: l'ipocrita dunque
nega se stesso perché non intende confrontarsi con la realtà che lo circonda, perché non se la sente di
contrastare un'opinione che gode di credito nel mondo. L'ironia segue una strada diversa: chi nel sorriso
ironico riconosce la distanza che lo separa da ciò che ha detto, non nega sé, ma la sua adesione ad una realtà
che appare per qualche verso priva di valore (ivi, p. 102). L'ironia, dunque, permette al soggetto di prendere
le distanze da ciò che ha detto, liberandosene, tagliando i ponti che lo vincolano ad una realtà che è
riconosciuta priva di valore.
Ora, proprio in questo suo far "piazza pulita" della molteplicità dei legami che stringono l'uomo alla realtà
che lo circonda, l'ironia sembra inaugurare un nuovo cominciamento per il soggetto. La battuta ironica, che
fingendo di confermarla, nega l'adesione del soggetto ad un mondo dato, libera di fatto l'io da una realtà cui
non crede, ed è proprio questo senso di liberazione che si esprime nel riso dell'ironia:
Ma quanto in tutti questi casi ed altri simili emerge dell'ironia è la libertà soggettiva che tiene ad
ogni istante in suo potere la possibilità di un cominciamento senza l'intralcio di legami anteriori. In
ogni cominciamento c'è qualcosa di seducente, poiché il soggetto è ancora libero, e questo è il
piacere desiderato dall'ironista (ivi, p. 196).
La funzione di cominciamento dell'ironia, il suo porsi come uno strumento per mettere tra parentesi una
realtà ritenuta inessenziale, traccia una chiara linea di demarcazione tra l'ironia e l'ipocrisia, ma sembra
riconnetterla al dubbio, poiché anche nel dubbio - come Cartesio insegna - il soggetto si libera dai vincoli di
un sapere tradizionale per inaugurare un nuovo cominciamento. Il rapporto tra ironia e dubbio ha del resto
più di una ragione per essere istituito: anche il dubbio ci dispone in un atteggiamento di natura negativa
rispetto alla realtà e ci libera dalle convinzioni cui eravamo precedentemente legati.
Anche in questo caso, tuttavia, sulla somiglianza prevale il contrasto: nel dubbio il soggetto vuole
penetrare nell'oggetto, vuole appunto conoscerlo, ma l'oggetto gli sfugge, proprio perché il dubbio non
permette mai alla soggettività di riposarsi e di stare ben salda sulle sue acquisizioni conoscitive. Nell'ironia
invece il soggetto non vuole affatto cogliere l'oggetto, non intende penetrare nella sua intima essenza:
intende piuttosto prenderne le distanze. In altri termini: chi dubita, crede di non conoscere la realtà, ma è
certo che valga egualmente la pena di comprenderla, ed è per questo che cerca di farsi presso la natura
intima delle cose; chi fa dell'ironia, invece, crede di conoscere la realtà, ma è certo che non valga la pena di
soffermarvisi, e nel sorriso ironico prende commiato da un mondo che gli appare privo di valore.
L'ironia, infine, ha una relazione con il raccoglimento religioso, ma anche da esso si discosta. Come
l'ironia, anche l'atteggiamento religioso del raccoglimento mette tra parentesi il mondo circostante,
riconoscendone la vanità. Tale riconoscimento, tuttavia, si affianca alla negazione del sé: il gesto del
religioso che allontana da sé il mondo colpisce in eguale misura la persona del fedele, che riconosce se stesso
come "cosa miserrima fra tutte" (ivi, p. 200). Al contrario, nota Kierkegaard,
Nell'ironia, [...] mentre tutto si fa vano, la soggettività diviene libera. Quanto più tutto si fa vano,
più leggera vuota di contenuto e fugace si fa la soggettività. E mentre tutto diventa vanità, il
soggetto ironico, invece di diventare vano a se stesso, salva la sua vanità (ivi, p. 200).
Dal naufragio del mondo che essa stessa provoca, l'ironia salva lo spettatore - l'io che si fa ironista.
Sin qui Kierkegaard si è mosso all'interno di un'analisi prevalentemente descrittiva, volta a chiarire quali
fossero i tratti distintivi che caratterizzano l'ironia come comportamento soggettivo. Il compito che si
prefigge in seguito è diverso: si tratta infatti di comprendere quale sia la funzione generale dell'ironia, quale
sia - in altri termini - la funzione metafisica che all'ironia è affidata.
Questa funzione può essere colta se dall'ironia come gesto occasionale si passa all'ironia come
atteggiamento generale verso il mondo. Proprio come il dubbio da empirico si fa filosofico quando Cartesio
lo estende al di là dei limiti cui la quotidianità lo vincola, così anche l'ironia guadagna una sua dimensione
15
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
metafisica non appena si solleva al di sopra dei singoli casi empirici per diventare un atteggiamento generale
della soggettività:
L'ironia sensu eminentiori non si rivolge contro questo o quel singolo esistente, bensì contro tutta la
realtà data in un determinato tempo e sotto determinati rapporti (ivi, p. 197).
Un disegno satirico raffigurante Kierkegaard
Ciò è quanto dire che "a essere considerato sub specie ironiae non è questo o quel fenomeno, ma la totalità
dell'esistenza" (ivi): l'ironia si pone così per Kierkegaard come lo stile di vita che colora emotivamente la
forma dialettica hegeliana della negatività infinita e assoluta.
Scrive Kierkegaard:
Per il soggetto ironico la realtà data ha perso completamente il suo valore, gli è diventata una
forma imperfetta e intralciante ovunque. Per l'altro verso, però, possiede il nuovo. Sa una sola
cosa, che il presente non corrisponde all'idea (ivi, p. 202).
Di fronte ad una realtà nella quale non si riconosce, il soggetto ironico non contrappone una protesta
determinata, non contrappone al dato un "dover essere" che in qualche modo vincoli la sua volontà ad un
progetto e la sua condotta futura ad un insieme di norme e di convinzioni; tutt'altro: l'atteggiamento ironico
non si impegna nel mondo per un mondo nuovo ma - additandone la possibilità - libera il soggetto nel
presente, permettendogli di negare in interiore homine quell'adesione al mondo che pure a parole tributa.
Il sorriso ironico ci permette così di estraniarci dal mondo, di non riconoscergli alcun valore. Da questa
negazione tuttavia non derivano alla soggettività impegni di nessun genere: la negazione ironica del mondo
scompare nell'atto stesso del negare e non si solidifica in un che di positivo. E ciò è quanto dire che
nell'ironia il soggetto guadagna una libertà soltanto negativa:
L'ironia è una determinazione della soggettività. Nell'ironia il soggetto è libero in negativo; difatti
la realtà suscettibile di dargli contenuto è assente, e il soggetto è libero dallo stato di costrizione in
16
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
cui lo tiene la realtà data, ma è libero in negativo e come tale fluttuante, poiché nulla v'è che lo
tenga. Ma proprio questa libertà, proprio questo fluttuare trasmette all'ironista un certo
entusiasmo, nel senso che si ubriaca degli infiniti possibili [...]. A questo entusiasmo tuttavia non
si abbandona, ma nutre in sé e ravviva solo quello dell'annientare (ivi, p. 203).
Kierkegaard in un'interpretazione moderna
La libertà dell'ironia è dunque sempre e soltanto libertà da qualcosa, mai libertà di agire per qualcosa - è
appunto una libertà vuota e soltanto negativa.
A partire da questo si può davvero comprendere non soltanto perché Socrate, il filosofo con cui si chiude la
stagione della "felice immediatezza" del mondo greco, debba essere per Kierkegaard il vero campione
dell'ironia, ma anche la ragione per la quale in un passo del suo libro si parla dell'ironia come di una
personcina invisibile: nel sorriso ironico, l'io ritrova e guadagna se stesso proprio nel momento in cui si
sottrae ad ogni sguardo che lo cerchi nel mondo. La soggettività che l'ironia ci consegna paga così il gesto di
diniego, che sancisce la sua superiorità sul mondo e sul reale, con il suo divenire invisibile, con il suo
perdersi in una vuota possibilità: il luogo da cui la soggettività ironizzante guarda il mondo è così lo spazio
vuoto della pura possibilità.
Nelle pagine conclusive della sua tesi di laurea, tuttavia, Kierkegaard prende silenziosamente commiato
dall'ironia come negatività infinita e assoluta e ne suggerisce una considerazione più positiva ed urbana.
L'ironia può essere infatti dominata, e ciò significa che anche questo atteggiamento negativo della
soggettività può essere preso con la giusta dose di ironia. Dalla smania ironica si deve prendere un ironico
distacco, ponendo un frena alla sua tendenza a svuotare il reale di ogni valore; e se l'ironia impedisce all'io
di perdersi nel mondo, l'ironia sull'ironia gli impedirà di perdersi di là da esso.
L'ironia smette così di essere la lama tagliente che rescinde una volta per tutte il nesso dell'io con il mondo e
diviene la coscienza critica che ci impedisce di restare chiusi nei dati di fatto della vita, di idolatrare i
fenomeni, cui occorre certo dare peso, ma solo alla luce della consapevolezza della loro insufficienza a
racchiudere una volta per tutte la ricchezza di significato della soggettività.
L'ironia come stato d'animo sconfina così in una superiore forma di saggezza che ci insegna a vivere nel
mondo senza tuttavia rimanervi impaniati. Ed in questo volto bonario che l'ironia sa assumere, e che le
permette di essere il viatico in nome del quale l'uomo può attraversare la vita senza disgustarsi della
ripetitività delle sue forme e della vuotezza delle manifestazioni dello spirito oggettivo, traspare già un
primo indizio di quel rifiuto della filosofia hegeliana cui Kierkegaard perverrà nelle sue opere più tarde.
17
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
PIRANDELLO E L'UMORISMO
Il celebre saggio L’umorismo fu scritto da Pirandello nel 1908 con intenti accademici, evidenti nella
trattazione storica che costituisce la prima parte, mentre la seconda, dedicata all’analisi dell’”essenza”
dell’umorismo, riflette maggiormente il programma letterario dell’autore; ma già le Premesse iniziali del Fu
Mattia Pascal, del 1904, avevano gettato le basi della nuova poetica.
L'opera si apre infatti con due premesse: la prima in cui ci viene presentato il protagonista-narratore e il suo
strano caso; e la seconda, "filosofica", nella quale l'autore espone, per bocca di Mattia, la sua concezione
dell'uomo e della vita.
Riporto la parte finale della seconda premessa, intitolata Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa, che
ritrae Mattia, ormai "fu Mattia", all'interno della biblioteca in cui aveva lavorato in passato, alle prese con
don Eligio Pellegrinotto, il suo amico bibliotecario, che lo esorta da tempo a scrivere un libro:
Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria
nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e
spuntoni.
- Eh, mio reverendo amico, - gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone,
mentr'egli attende alle sue lattughe. - Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, neppure per
ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito
ritornello: Maledetto sia Copernico!
Luigi Pirandello
- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato sotto il
cappellaccio di paglia.
- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava...
- E dàlli! Ma se ha sempre girato!
- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira.
L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m'ha risposto? ch'era una buona scusa per
gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole. Ma
18
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l'uomo, vestito da greco o da romano, vi
faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo
bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari. Si legge o non si legge
in Quintiliano, come voi m'avete insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per
provare?
- Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi
minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s'è messa a girare.
- E va bene! Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise... La signora contessa
indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola... Teresina si moriva di fame...
Lucrezia spasimava d'amore... Oh, santo Dio! e che volete che me n'importi? Siamo o non siamo su
un'invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gita e
gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci
sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire - spesso con la coscienza d'aver
commesso una sequela di piccole sciocchezze - dopo cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don
Eligio mio ha rovinato l'umanità, irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla
nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'Universo, con
tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle
nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete
letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel
canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto d'impazienza, e ha sbuffato un po' di fuoco per
una delle tante sue bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli
uomini che non sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti.
E tiriamo innanzi. Chi ne parla più?
Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di
strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo.
Per fortuna, l'uomo si distrae facilmente.
Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni, e
spesso - se è nuvolo - ci lascia al bujo.
Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci
lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E
dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e
siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente
compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili.
Ebbene, in grazia di questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di
me, ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie.
Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore; ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale,
che posso considerarmi come già fuori della vita, e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta.
Cominciamo.
Pirandello oscilla fra una visione “ontologica” dell’umorismo, considerato come una possibilità durevole
dell’uomo, e una sua visione “storica”, derivante da particolari condizioni che hanno posto in crisi le antiche
certezze. Da un lato egli vede un limite ontologico dell’uomo, che da sempre vive in un mondo privo di
senso e che tuttavia si crea una serie di autoinganni e di illusioni attraverso i quali cerca di dare significato
all’esistenza: l’umorismo sarebbe l’eterna tendenza dell’arte a svelare tale contraddizione. Dall’altro egli
individua nella caduta dell’antropocentrismo tolemaico e nell’affermazione del pensiero copernicano e
galileiano (uomo e terra sono entità minime rispetto all’universo) la nascita di quel malessere che induce alla
percezione della relatività di ogni fede, di ogni valore, di ogni ideologia, che sono solo autoinganni, utili per
sopravvivere ma del tutto mistificatori.
L’umorismo pirandelliano non è solo una poetica; è anche l’espressione coerente del pensiero e della
cultura del “relativismo filosofico”. Esso presuppone la messa in discussione sia del positivismo, sia delle
ideologie romantiche. Del positivismo Pirandello rifiuta il criterio della verità oggettiva, garantita dalla
19
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
scienza; del Romanticismo l’idea della verità soggettiva, della centralità del soggetto e della sua capacità di
dare forma e senso al mondo.
Con Pirandello entrano quindi in crisi tanto l’oggettività quanto la soggettività ed il concetto stesso di
verità, che viene posto radicalmente in questione. Ne deriva un assoluto relativismo.
Le categorie di bene e di male, di vero e di falso, su cui si basano la tragedia e l’epica, sono infatti venute a
mancare. L’umorismo è l’arte del tempo moderno, in cui tali categorie sono entrate in crisi e in cui non
esistono più paramentri certi di verità.
Perciò l’umorismo non propone più valori, né eroi che ne siano portatori, ma un atteggiamento
escusivamente critico-negativo e personaggi problematici e dunque inetti nell’azione pratica.
L’arte umoristica è volta continuamente ad evidenziare il contrasto tra forma e vita e tra personaggio e
persona.
René Magritte, The son of Man, 1964
L’uomo ha bisogno di autoinganni: deve cioè credere che la vita abbia un senso, e perciò organizza
l’esistenza secondo convenzioni, riti, istituzioni che devono rafforzare in lui tale illusione. Gli autoinganni
individuali e sociali costituiscono la forma dell’esistenza.
In una prospettiva filosofica largamente debitrice della teoria dell'élan vital di Bergson, la forma è sentita
come ciò che cristallizza e paralizza la vita. Quest’ultima è una forza profonda ed oscura che fermenta sotto
la forma, ma che riesce ad erompere solo saltuariamente nei momenti di sosta o di malattia, di notte o negli
intervalli in cui non siamo coinvolti nel meccanismo dell’esistenza. La vita è il caos, la forma è l’ordine.
La realtà tutta è vita, perpetuo movimento vitale, flusso continuo, incandescente, indistinto. Tutto ciò che
assume forma distinta ed individuale, comincia a morire. L'uomo tende a fissarsi in una forma individuale,
che lui stesso si sceglie, in una personalità che vuole coerente ed unitaria; questa, però, è solo un'illusione e
scaturisce dal sentimento soggettivo che ha del mondo. Inoltre gli altri con cui l'uomo vive, vedendolo
ciascuno secondo la sua prospettiva particolare, gli assegnano determinate forme. Perciò mentre l'uomo
crede di essere uno, per sé e per gli altri, in realtà è tanti individui diversi ("uno, nessuno e centomila"), a
seconda di chi lo guarda.
20
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Ciascuna di queste forme è una costruzione fittizia, una "maschera" che l'uomo s'impone e che gli impone il
contesto sociale; sotto questa non c'è nessuno, c'è solo un fluire indististo ed incoerente di stati in perenne
trasformazione.
Ciò porta alla frantumazione dell'io, sul quale si era fondato tutto il pensiero sino a quel tempo, in un
insieme di stati incoerenti in continua trasformazione. La crisi dell'idea di identità e di persona è l'ultima
tappa della crisi delle certezze che ha investito la civiltà dei primi del Novecento.
Proprio per questo nell’arte umoristica non sono più possibili né persone né men che meno eroi, ma solo
maschere o personaggi.
Un disegno rappresentante l'io scisso e frammentato
Il personaggio ha davanti a sé solo due strade: o accetta l’ipocrisia delle forme, oppure vive
consapevolmente, amaramente la scissione fra forma e vita. Nel secondo caso la scissione interviene
continuamente a porre una distanza ironica fra il soggetto e i propri gesti; il personaggio si guarda vivere,
guarda da fuori e compatisce non solo gli altri, ma se stesso. Questo distacco riflessivo, amaro, pietoso e
ironico insieme, è il segno distintivo dell’umorismo.
Esso è da distinguere dalla comicità. Nel comico è assente la riflessione. Il comico nasce infatti dal semplice
e immediato “avvertimento del contrario”, la constatazione che una situazione o un individuo sono il
contrario di come dovrebbero essere: questo provoca il riso. Invece l’umorismo è il “sentimento del
contrario” che nasce dalla riflessione: riflettendo sulle ragioni per cui una persona o una situazione sono il
21
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
contrario di come dovrebbero essere, al riso subentra il sentimento amaro della pietà, che induce al sorriso
insieme ironico ed indulgente.
I caratteri dell’arte umoristica riscontrabili nella produzione narrativa e teatrale di Pirandello sono
molteplici: la discordanza, la disarmonia, la contraddizione, la consapevolezza che la vita “non conclude” e
quindi l'adozione di strutture aperte e inconcluse, scelta del linguaggio quotidiano, l’unico adatto a
comunicare una concezione della vita che non rivela nulla di essenziale, ma solo i momenti insulsi di
un’esistenza insensata.
22
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
4. ESEMPI DI IRONIA
A) LETTERARI
PIRANDELLO E LEOPARDI
Il noto explicit de Il fu Mattia pascal va letto, come le premesse di cui ho parlato sopra, in chiave ironica:
Mattia affida la propria identità postuma (il manoscritto dovrà essere aperto dopo la sua morte) ad una
storia che, paradossalmente, racconta di un'identità impossibile.
La biblioteca cui è affidato il manoscritto - fuor di metafora, la letteratura - è sì deserta e in abbandono,
sconsacrata come la chiesetta che la ospita, ma può sempre conservare un'opera «da poter servire
d'ammaestramento a qualche curioso lettore»; e dunque essa mantiene una pur sminuita forma di sacralità.
Nella già citata Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa, il fu Mattia Pascal afferma di scrivere «in grazia di»
una «distrazione provvidenziale» che consente all'uomo di vivere, nonostante gli sforzi «di distruggere le
illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene».
Mattia Pascal affida dunque alla scrittura la propria identità, illudendosi per un attimo e dimenticando la
moderna sconsacrazione della letteratura, in grazia di una «distrazione» che costituisce un preciso riscontro
leopardiano inserito in un contesto interamente e chiaramente leopardiano, in cui appare decisivo il
motivo copernicano, che prefigura la teorizzazione poetica del saggio su L'umorismo.
Infatti nel saggio sull'umorismo (cap. 5 della seconda parte) Pirandello richiama esplicitamente Il Copernico
di Leopardi del 1827 (leggibile per intero in Appendice), una delle Operette morali: nell'ottica divertita e
garbatamente ironica di Leopardi, il movente che spinse Copernico a sconfessare la teoria geocentrica per
imporre quella eliocentrica sarebbe semplicemente... un attacco di pigrizia del Sole!
Nel dialogo, infatti, il Sole, stufo di vagabondare e fermamente deciso a non muoversi più intorno alla Terra,
manda l'Ora Prima, venuta inutilmente a svegliarlo per portare il giorno, a chiamare il primo filosofo che le
capiti a tiro:
Sole: Dunque tu farai una cosa: tu te n'andrai là in Terra; o pure vi manderai l'una delle tue compagne, quella che tu
vorrai: e se ella troverà qualcuno di quei filosofi che stia fuori di casa al fresco, speculando il cielo e le stelle; come
ragionevolmente ne dovrà trovare, per la novità di questa notte così lunga; ella senza più, levatolo su di peso, se
lo gitterà in sul dosso; e così torni, e me lo rechi insin qua: che io vedrò di disporlo a fare quello che occorre.
L'Ora Prima passa l'incarico all'Ora Ultima, la quale trova Copernico intento ad osservare la stranezza della
notte che sembra non finire mai, e dopo un comico equivoco iniziale (Copernico pensa infatti che sia giunta
la sua ultima ora) lo invita a seguirla presso il Sole. Questi esorta Copernico a ratificare la soluzione che gli è
venuta in mente per evitare al pianeta il buio ed il gelo: d'ora in poi sarà la Terra a muoversi intorno al Sole.
Copernico, sconcertato dalla proposta, risponde che non sa come si possa fare a farla muovere, ed il Sole gli
suggerisce di usare una leva, come Archimede; ma, obietta Copernico, il Sole la fa troppo semplice: in realtà
questo comporterà una imponente serie di conseguenze.
Leggiamo il brano:
Sole: Che fa cotesto al caso? Non si racconta egli di un vostro matematico antico, il quale diceva che se gli fosse dato un
luogo fuori del mondo, che stando egli in quello, si fidava di smuovere il cielo e la terra? Or tu non hai a
smuovere il cielo; ed ecco che ti ritrovi in un luogo che è fuor della Terra. Dunque, se tu non sei da meno di
quell'antico, non dee mancare che tu non la possa muovere, voglia essa o non voglia.
Copernico: Signor mio, cotesto si potrebbe fare: ma ci si richiederebbe una leva; la quale vorrebbe essere tanto lunga,
che non solo io, ma vostra signoria illustrissima, quantunque ella sia ricca, non ha però tanto che bastasse a
mezza la spesa della materia per farla, e della fattura. Un'altra difficoltà più grave è questa che io vi dirò adesso;
anzi egli è come un groppo di difficoltà. La Terra insino a oggi ha tenuto la prima sede del mondo, che è a dire il
mezzo; e (come voi sapete) stando ella immobile, e senza altro affare che guardarsi all'intorno, tutti gli altri globi
dell'universo, non meno i più grandi che i più piccoli, e così gli splendenti come gli oscuri, le sono iti rotolandosi
23
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
di sopra e di sotto e ai lati continuamente; con una fretta, una faccenda, una furia da sbalordirsi a pensarla. E
così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio suo, pareva che l'universo fosse a somiglianza di una
corte; nella quale la Terra sedesse come in un trono; e gli altri globi dintorno, in modo di cortigiani, di guardie, di
servitori, attendessero chi ad un ministero e chi a un altro. Sicché, in effetto, la Terra si è creduta sempre di
essere imperatrice del mondo: e per verità, stando così le cose come sono state per l'addietro, non si può mica
dire che ella discorresse male; anzi io non negherei che quel suo concetto non fosse molto fondato.
Niccolò Copernico (1473-1543)
Che vi dirò poi degli uomini? che riputandoci (come ci riputeremo sempre) più che primi e più che
principalissimi tra le creature terrestri; ciascheduno di noi se ben fosse un vestito di cenci e che non avesse un
cantuccio di pan duro da rodere, si è tenuto per certo di essere uno imperatore; non mica di Costantinopoli o di
Germania, ovvero della metà della Terra, come erano gl'imperatori romani, ma un imperatore dell'universo; un
imperatore del sole, dei pianeti, di tutte le stelle visibili e non visibili; e causa finale delle stelle, dei pianeti, di
vostra signoria illustrissima, e di tutte le cose. Ma ora se noi vogliamo che la Terra si parta da quel suo luogo di
mezzo; se facciamo che ella corra, che ella si voltoli, che ella si affanni di continuo, che eseguisca quel tanto, né
più né meno, che si è fatto di qui addietro dagli altri globi; in fine, che ella divenga del numero dei pianeti;
questo porterà seco che sua maestà terrestre, e le loro maestà umane, dovranno sgomberare il trono, e
lasciar l'impero; restandosene però tuttavia co' loro cenci, e colle loro miserie, che non sono poche.
Naturalmente al Sole non importa un fico secco di questi ridicoli problemi umani. Copernico, messo alle
strette, non può che obbedire, e la sua buona fede è tale che, addirittura, egli dedicherà proprio al Papa il suo
rivoluzionario trattato De revolutionibus orbium coelestium (Delle rivoluzioni dei corpi celesti), che per
un'assurda coincidenza vedrà la luce esattamente il giorno in cui morirà l'autore, il 24 maggio 1543.
E' così che ha luogo la rivoluzione copernicana, che di colpo espropria l'essere umano della sua unicità ed
importanza, ponendolo allo stesso livello di un "vermuccio".
24
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Ispirandosi a questo dialogo leopardiano, Pirandello considererà umoristica la compresenza di due
sentimenti opposti: quello della piccolezza dell'uomo che, dopo la rivoluzione copernicana, si scopre parte
infinitesimale dell'universo; e quello opposto, ma paradossalmente inscindibile, della grandezza dell'uomo,
basato però non più sulla sciocca superbia razionalistica, ma sulla percezione di una compenetrazione
all'infinito. Se la fonte prossima di questo atteggiamento umoristico, come abbiamo visto, era Leopardi,
quella più lontana era Blaise Pascal (da cui deriva con ogni probabilità il cognome di Mattia).
Jan Vermeer, L'astronomo, circa 1669
Con Il fu Mattia Pascal nasce il romanzo del Novecento. Le «storie di vermucci» che Mattia Pascal rifiuta
di scrivere sono quelle, nei canoni ottocenteschi del realismo (e poi del naturalismo), di una narrazione fatta
«per raccontare e non per provare», cui egli preferisce un romanzo filosofico, saggistico, il moderno romanzo
umoristico. Da questo punto di vista è veramente emblematica la vicenda dell'incontro - proprio nella
tipografia che stampava il romanzo - tra Pirandello e Verga, e della loro successiva, breve corrispondenza
(non ancora ben indagata). Verga si vedeva superato da una nuova forma di romanzo in cui si «intuiva la
presenza non più del personaggio che vive, anzi lotta per la vita, ma del personaggio che si sente vivere.
L'evento indicherebbe una radicale trasformazione dell'ottica narrativa: quella che intercorre tra la
deformazione "strabica" dell'umorista e la focalizzazione convergente del verista» (Nino Borsellino).
L'ambivalente duplicità dell'umorismo pirandelliano, qui già in atto, nella scrittura, in un misto di
narrazione, riflessione e commento, si manifesta però, prima ancora, nell'atteggiamento di «distrazione» che
la rende possibile. La letteratura, per quanto sconsacrata e morta, rinasce e vive: essa - come l'uomo - può
essere grande solo a patto di riconoscere la propria piccolezza (senza atteggiamenti da nuovi vati
dannunziani); e la grande luce della sua piccola lampada può accendersi perché, leopardianamente e
umoristicamente, a fianco della visione demistificante dell'arido vero, persiste, antinomicamente, l'illusione
stessa.
25
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
LUCANO E L'EPOS ANTIFRASTICO:
IL PROEMIO DEL BELLUM CIVILE
L'interpretazione in chiave ironica o "seria" del discussissimo e sconcertante proemio del Bellum civile
(leggibile per intero in Appendice) è stata per anni una vera e propria vexata quaestio negli studi lucanei (la
bibliografia sull’argomento è molto ampia; si vedano ad esempio G.G. Biondi, Laudatio e damnatio di Nerone:
L'aenigma del proemio lucaneo, in Gualandri - Mazzoli 2003, pp. 265-276., G. B. Conte, Il proemio della Pharsalia,
“Maia” 18 (1966), pp. 42-53 ed Enrica Malcovati, Zum Prolog der Pharsalia, in: Lucan, hrsg. von W. Rutz (ed.),
WdF Bd. 235, Darmstadt, 1970, pp. 299-308).
Di recente (2002) è apparso in rete un contributo sull'argomento, a firma di Alerino Palma, nel contesto di un
saggio sul Bellum civile per molti versi apprezzabile; sul proemio però la sua posizione appare oscillante e un
po' contraddittoria.
Eduardo Barrón, Nerone e Seneca, 1904
Leggiamo le sue considerazioni:
"L’elogio di Nerone
La prima parte dell’elogio (I 33-45), è la più significativa perché contiene la contestata, e contrastata, oltre
che reiterata, affermazione per cui gli orrori della guerra civile sono meno duri da sopportare se
commisurati al “premio” che portano con sé: l’avvento di Nerone. La seconda parte svolge invece l’elogio
vero e proprio ed appare densa, più di quanto non lo sia la prima, di motivi convenzionali: si predice a
Nerone, esaltato in ogni modo pensabile, quando ascenderà alla reggia del cielo (regia caeli, ma si intende, ciò
accadrà il più tardi possibile: serus) un destino da dio (anzi, davanti a lui ogni dio si ritirerà: tibi numine ab
omni / cedetur). Ma Nerone è già un dio (mihi iam numen) ed è invocato come forza e ispirazione per i carmina
romana che Lucano si accinge a dare. Gli auspici rivolti al principe sono occasione anche di una più ampia
aspettativa di pace: assunto Cesare in cielo si chiudano le porte di Giano e in... vicem gens omnis amet: i popoli
si amino vicendevolmente .
26
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Sulla base dell’attività poetica di Lucano negli anni tra il 60 e il 63 e supponendo un’evoluzione politica di
Lucano simile a quella di altri intellettuali contemporanei - e quindi una cesura tra i primi tre libri e i restanti
sette -, si è ipotizzato che la lode di Nerone, benché convenzionale, sia sincera, probabilmente dettata
dalla volontà di compiacere l’imperatore .
Numerosi elementi, esterni e interni, farebbero propendere invece per un’interpretazione in chiave ironica
dell’elogio: innanzitutto il fatto che l’elogio non fu eliminato nelle successive edizioni del Bellum civile
neppure dopo la damnatio memoriae dell’imperatore, ma anche la presunta unità ideologica del poema di
Lucano .
Sarebbe stato tuttavia interessante, per valutare quale spazio occupano nell’elogio elementi convenzionali,
conoscere almeno il contenuto delle lodi di Nerone che Lucano componeva, contemporaneamente ai primi
tre libri del Bellum civile, per le occasioni letterarie del regime neroniano. Esse sarebbero preziose anche per
dare più profondità al problema del rapporto dell’intellettuale Lucano con il potere che risulta dall’analisi
del proemio, così come di tutta l’opera, molto contraddittorio, con più ombre che luci.
Per attenersi al testo, sembra certamente eccessiva l’enfasi con cui gli scelera e il nefas della guerra civile,
puntigliosamente elencati ai vv. 40-43, sono ricondotti alla buona novella dell’avvento di Nerone, salutato
per ben tre volte come il prezzo (v. 38: mercede) di tanto sangue, come una via obbligata nel cammino del fato
(vv. 33-4: non aliam venturo fata Neroni / invenere viam), per concludere con l’iperbole dei vv. 44-5 (multum
Roma tamen debet civilibus armis, / quod tibi res acta est), che se presa alla lettera ribalterebbe il significato di
tutto il poema in quanto assegnerebbe un senso, o una giustificazione, alle vicende della guerra civile, di cui
tutto il poema esemplifica la evidente e incontrovertibile insensatezza e mancanza di possibili giustificazioni.
E ciò non nei reliqui septem composti dopo la rottura con il principe, ma anche, e a maggior ragione, nei
primi tre libri, a cominciare dai versi iniziali del I libro nei quali Lucano annunciava che avrebbe trattato
(canimus) di guerre più atroci di quelle civili (Bella… plus quam civilia).
Per non tralasciare che all’interno dello stesso elogio a Nerone, l’espressione dei vv. 37-8 (scelere ista nefasque /
hac mercede placent) costituisce certamente una forma di preterizione, con un marcato effetto di contrasto, per
introdurre l’impietosa sequenza di sangue, pene e dolore dei vv. 38-43, un compendio ritmato (Pharsalia…
Munda… Perusina… Mutinaeque… Leucas… sub Aetna) delle fasi della guerra civile."
Fin qui mi sembra che l'analisi di Palma non faccia una grinza: in effetti, per prendere alla lettera questo
proemio, bisognerebbe supporre in Lucano una dose di distrazione (per non dire altro) tale da impedirgli di
rendersi conto delle insanabili contraddizioni ideologiche che verrebbero a crearsi nel suo poema: infatti, se
considerassimo questo proemio "sincero", Lucano stesso fornirebbe una inoppugnabile giustificazione
ideologica (in un certo senso di tipo hegeliano) a tutti gli orrori della guerra civile: questo farebbe perdere
ogni senso ed ogni valore a tutto il poema, che non fa che deprecare tali orrori e gli effetti anche a lungo
termine della guerra civile: e, come giustamente nota Palma, non nei libri successivi ai primi tre, ma anche
e soprattutto nei primi tre, a cominciare da questo stesso proemio.
Ma purtroppo, dopo avere svolto questi efficaci ragionamenti, Palma si appiattisce sulle posizioni di alcuni
critici che, al di là di ogni evidenza e del semplice buon senso, si ostinano a leggere questo proemio come
una forma di adulazione "eccessiva" ma sincera, una sorta di sfoggio di retorica che "prende la mano" al
poeta e va al di là delle sue intenzioni.
Scrive infatti Palma:
"Nessuno di questi elementi, come già quelli extra-testuali elencati precedentemente, sembra tuttavia
determinante per individuare quali fossero i reali intenti di Lucano e da qui risolvere, in un senso o
nell’altro, la natura del suo rapporto con il potere. In generale, si dovrebbe diffidare di conclusioni che
cerchino di armonizzare a tutti i costi le idee politiche di Lucano. Coerentemente con l’immagine [...] di
Lucano come poeta dell’eccesso, può essere accettabile, benché certamente ambiguo, tutto il profluvio di
iperboli di cui l’elogio a Nerone è finemente lastricato. La lettura in chiave ironica dell’elogio appare,
infatti, come una sorta di lectio facilior, un'interpretazione a senso unico, autorizzata dall’immagine
stereotipata di Lucano come poeta “contro” che si ricava, o si vuole ricavare, dalle pagine del Bellum civile."
E qui Palma cita, a riprova di questa presunta lectio facilior, un passo di Ettore Paratore che a me sembra
pienamente condivisibile: “Il poema lucaneo è anzi un’accesa polemica, sotto tutti gli aspetti: è polemica
politica contro il principato dispotico, prima in nome della tradizione augustea, poi, sempre più chiaramente
in nome di quella repubblicana, è polemica letteraria contro Virgilio e il poema di argomento mitologico, in
27
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
nome della tradizione neviana ed enniana del poema storico; è polemica stilistica contro i seguaci della
fluidità espressiva e della varietà metrica, in nome di un asianesimo amante dei nessi risentiti e carichi di
effetto, e di una rigorosa uniformità nella struttura dell’esametro; è polemica moralistica contro ogni
concezione provvidenziale della vita e della storia, in nome dei principi della virtù e della storia, che lo
stoicismo aveva in qualche modo giustapposti e armonizzati” (E. Paratore, Storia della letteratura latina,
Firenze 1991, p. 588).
Jean-Baptiste Romand & François Rude
Catone l'Uticense che legge il Fedone di Platone
prima di suicidarsi (1832-35)
Non condivido affatto questa impostazione, che mi sembra in sé molto bizzarra e quasi offensiva nei
confronti di un personaggio che, in fin dei conti, ha pagato con la vita il suo essere "contro"; ma proseguiamo
nella lettura:
"All’impressione di asprezza e di enfasi, che sembra pesare su tutta la poesia del Bellum civile,
concorrono diversi procedimenti formali. Alcuni di questi sono rilevabili anche nella prima parte
dell’elogio di Nerone, i vv. 33-45.
La diseguale collocatio verborum, pur nell’arco di soli 12 versi, crea un effetto di disarmonia nel ritmo. Si
confronti il complicato intreccio dei vv. 33-6 con la sententia del v. 37 (iam nihil, o superi, querimur), subito
rincarata da una sententia più lunga, ma senza inciso e divisa in due da un enjambement che spacca in due
l’enunciato, di qua il soggetto (scelera ipsa nefasque), di là il verbo e il complemento (hac mercede placent). Lo
stesso accade nel nuovo periodo aperto dall’aggrovigliato succedersi di proposizioni – molte variationes,
iperbati a profusione, falsi parallelismi come Perusina fames Mutinaeque labores - e chiuso da una nuova
sententia: quod tibi res acta est, che occupa il primo emistichio del v. 45. Lo stesso effetto scomposto e nervoso
si realizza con l’uso diseguale degli enjambement: il ritmo è sempre pronto a fuoriuscire dalla misura del
28
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
verso, oppure ad arrestarsi bruscamente laddove sembrava profilarsi un’armonia, come nel caso
dell'enumerazione dei versi 38-40 interrotta dalla virgola, cui segue l’ennesima variatio del soggetto."
Qua Palma sembra indulgere ad un difetto tipico di molti critici: quello di concentrarsi su dettagli formali e
linguistici perdendo di vista il semplice buon senso.
Tutto ciò che egli osserva è vero e ben detto; ma, come direbbe qualche politico nostrano, che c'azzecca?
Il fatto che Lucano, allevato alle scuole di retorica imperiali, faccia sfoggio di abilità (tra l'altro quasi mai fine
a se stessa, ma in genere piegata all'espressione di un ben preciso messaggio), in che modo esclude che egli
volesse anche veicolare un messaggio ideologico anti-imperiale? Francamente non lo capisco.
Ma proseguiamo nella lettura:
"La complessità della sintassi e un certo gusto per i termini più densi di effetto e altisonanti sono compensati,
anzi trovano maggior risalto grazie alla relativa essenzialità del lessico, che prevede molti sostantivi, anche
sinonimi e pochissimi aggettivi e quei pochissimi con uno scarso valore connotativo: l’aspra Leucade a
indicare un luogo roccioso e quindi scosceso, e l’Etna ardente, un vulcano. Farebbe eccezione Munda,
funesta perché ha ospitato uno dei momenti più drammatici della guerra civile, se non si trovasse in un
verso costruito come un complicato meccanismo: un chiasmo (ultima funesta… proelia Munda) e un
parallelismo grammaticale (aggettivo con aggettivo, sostantivo con sostantivo) separati dal verbo concurrant,
collocato dopo la cesura.
John William Waterhouse, Il rimorso di Nerone dopo l'assassinio di Agrippina, 1878
In questa ricerca esasperata di asprezza abbondano naturalmente le figure retoriche del suono: allitterazioni
e consonanze sono la regola (si segnalano invenere viam, aeterna parantur, saturentur sanguine manes), ma non
mancano omoteleuti come quelli, che al pari di rime, caratterizzano le clausole dei vv. 38-9 e 40-1 (campos,
manes, labores, classes)."
E qui, in maniera brusca ed improvvisa, termina la trattazione del problema-proemio da parte di Palma,
senza che egli ci chiarisca cosa mai c'entri tutto questo con il problema centrale e come l'utilizzo di figure
retoriche escluderebbe l'intenzione ironica.
Eppure tutta la parte precedente del discorso mi era sembrata bene impostata e pienamente condivisibile: è
strano che le conclusioni siano queste.
Come ho già detto, non mi sento di avallare la tesi della "sincerità" del proemio: se le cose stessero così,
se Lucano avesse voluto sinceramente elogiare Nerone, dovremmo attribuire al poeta o una incoerenza
degna di miglior causa, o una non comune storditaggine, al limite della vera e propria stupidità, tale da non
rendersi nemmeno conto delle enormi contraddizioni in cui cadrebbe: cosa che mi pare il caso di escludere
sulla base dell'impostazione di tutto il suo poema (per non parlare della stima tributatagli da Giacomo
Leopardi, sulla quale certi critici farebbero meglio a riflettere); stupidità responsabile anche della sua
29
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
goffaggine, se egli non si rendeva conto che i suoi sperticati "complimenti" nei confronti di Nerone erano
malriusciti, ridicoli e maldestri.
A che pro, ad esempio, un'affermazione di questo genere?
"Ma non scegliere la tua sede nella zona dell'Orsa (= il Polo Nord), né in quella opposta, dove si trova il caldo
polo australe, donde vedresti la tua Roma con una traiettoria obliqua: se tu graverai su una sola parte
dell'etere immenso, l'asse dell'universo sentirà il tuo peso." (vv. 53-57).
Questa osservazione sembrerebbe alludere, come hanno notato alcuni critici antichi e moderni, ai problemi
di sovrappeso che affliggevano Nerone, se non addirittura ad un suo strabismo; e se così non è, per quale
altro motivo è stata introdotta? Essa è in sé sciocca, futile, priva di qualsiasi motivazione plausibile, artistica
e non. Possibile che, nell'ottica di elogiare l'imperatore, a Lucano venissero in mente soltanto spiritosaggini
melense e di dubbio gusto?
Ed ancora:
"Allora (= quando sarai morto) il genere umano, deposte le armi, pensi a se stesso, e ogni popolo si ami
vicendevolmente: la pace, diffusa per il mondo, chiuda le ferree porte del tempio di Giano portatore di
guerra." (vv. 60.62).
L'affermazione è tanto sorprendente quanto inequivocabile: la pace ritornerà sulla terra soltanto dopo la
morte di Nerone. Possibile che Lucano non si rendesse conto che un'affermazione del genere è molto
offensiva?
Ma dev'essersene reso ben conto Nerone, se, dopo la recitatio dei primi tre libri, è scattata immediata la
sua censura.
Solo per questioni di "gelosia" nei confronti del più dotato rivale?
Mi permetto di dubitarne.
Non è più semplice, anziché fare letteralmente i salti mortali per voler vedere "altro" in Lucano e per far
quadrare i conti di un discorso fondato su presupposti discutibili, attenersi all'immagine che egli stesso si
sforza di dare di sé, che poi è esattamente quella ben delineata ad esempio da Ettore Paratore nella sua Storia
della letteratura latina (Firenze 1991, p. 588)?
In definitiva, a mio parere, il proemio lucaneo non può essere correttamente interpretato se non alla luce
dell'ideologia complessiva sottesa all'opera. E questa ideologia può essere sintetizzata nella bella formula
trovata da O.S. Due (Lucan et la philosophie, in M. DURRY (ed.), Lucain, «Entretiens Hardt» 15, VandoeuvresGenève 1970, p. 214), il quale afferma che il poema lucaneo esprime la visione del mondo di "uno stoico che
ha perduto la fede".
Per citare le parole conclusive di un saggio di Emanuele Narducci (Provvidenzialismo e antiprovvidenzialismo
in Seneca e in Lucano), "nella Pharsalia la negazione dell’ordinamento provvidenziale del mondo, la quale si
esprime nelle frequenti invettive contro gli dei, si fa particolarmente astiosa e violenta proprio perché si
alimenta dei residui di questa fede perduta: è una frizione stridente, che attraversa l’intero poema, e dalla
quale emerge l’idea di una potenza divina intrinsecamente malvagia: una potenza che nella storia umana
persegue l'annientamento della ragione e della virtù, così come sul piano cosmico essa guida, attraverso una
catena causale ineluttabile, l'intero universo verso una catastrofe senza rinascita.": di qui il pessimismo
storico-cosmico di Lucano.
Di questa catastrofe il principato di Nerone non è che un aspetto, ed è questa la chiave di lettura corretta, a
mio parere, dell'intero proemio, elogio compreso: esso pertanto non può che essere inteso in chiave
inequivocabilmente antifrastica; e l'antifrasi, come sappiamo, è la cifra distintiva dell'ironia.
Chi sceglie la strada contraria si assume la responsabilità di far perdere di significato a tutto il poema ed
entra in un circolo vizioso di contraddizioni non solo insanabili, ma anche difficilmente spiegabili.
30
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
OSCAR WILDE, "THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST"
La beffarda e sfuggente ironia della pièce teatrale The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde (18541900) emerge con evidenza già solo nella difficoltà di rendere in lingua italiana il titolo inglese: non esiste
infatti un modo soddisfacente per tradurlo.
Il titolo comunemente usato, L'importanza di chiamarsi Ernesto, non rende affatto l'idea del gioco di parole
implicito nel termine Earnest, che sovrappone l'aggettivo "earnest" (serio, affidabile od onesto) al nome
proprio "Ernest", che in inglese hanno la stessa pronuncia.
Esso viene così tradotto a volte come L'importanza di essere Probo, L'importanza di essere Franco, L'importanza di
essere Fedele o L'importanza di essere Onesto.
Oscar Wilde nel 1894
Saltare il gioco di parole usando impropriamente il titolo L'importanza di chiamarsi Ernesto vuol dire
rinunciare alle connotazioni di "serietà" che la earnestness inglese sottintende e rinunciare, soprattutto, ai
doppi sensi contenuti nell'opera; si pensi all'anima centrale contenuta nella frase conclusiva, che è una
feroce critica alla società dell'epoca mascherata da esortazione morale:
Lady Bracknell: My nephew, you seem to be displaying signs of triviality.
Jack: On the contrary, Aunt Augusta, I’ve now realised for the first time in my life the vital Importance of
Being Earnest.
Lady Bracknell: Nipote mio, mi sembra che tu stia dando segni eccessivi di leggerezza.
Jack: Al contrario, zia Augusta, mi sono reso conto ora per la prima volta in vita mia, dell'essenziale
importanza di essere Probo.
La traduzione italiana del titolo dell'opera di Wilde che meglio unisce un senso vicino alla parola earnest ad
un nome frequente (e dunque riconoscibile come tale) è dunque L'importanza di essere Franco, sebbene
"franco" ed "onesto" non siano affatto sinonimi.
31
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Si tratta di una commedia in tre atti di Oscar Wilde, rappresentata per la prima volta a Londra il 14 febbraio
1895. Ne riporto di seguito la trama.
Atto primo:
La commedia si apre a Londra nella casa di un giovane aristocratico, Algernon Moncrieff, nel momento in
cui si presenta alla porta il suo amico di vecchia data, Ernest Worthing. Grazie ad un portasigarette
dimenticato dall'amico la sera prima, tuttavia, Algernon scopre che il vero nome di costui è Jack Worthing:
egli, abitando in campagna, finge di avere uno scapestrato fratello a Londra, il cui nome è Ernest, per poter
condurre una vita di piaceri.
In campagna infatti Jack è il tutore della giovane Miss Cecily Cardew e in quanto tale deve assumere un
comportamento moralmente ineccepibile. La piccola Cecily, come da lui viene chiamata, è la nipote di Mr
Thomas Cardew, padre adottivo di Jack. A sua volta, Jack scopre che anche Algernon conduce una doppia
vita grazie all'invenzione di un povero amico invalido, chiamato Bunbury.
Comunque sia, Jack si trova in città per proporsi a Miss Gwendolen Fairfax, cugina di Algernon. Dichiara
quindi il suo amore alla giovane, alla quale si presenta con il nome di Ernest, e questa ricambia il sentimento;
è sua ferma intenzione, però, sposare solo un uomo chiamato Ernest, in quanto quel nome le "procura delle
vibrazioni" e ha qualcosa di speciale.
Una scena del film The importance of being Earnest di Oliver Parker del 2002
Per ottenere il consenso al fidanzamento, Jack ha successivamente un colloquio con la madre di Gwendolen,
Lady Augusta Bracknell, zia di Algernon (ispirata, pare, alla madre di Lord Alfred Douglas detto "Bosie", il
grande amore di Wilde); in questa occasione però si viene a sapere che Jack è un trovatello: Mr Thomas
Cardew lo ha rinvenuto in una capiente borsa di cuoio dimenticata nei bagni di Victoria Station, Brighton
Line. A sentire ciò, Lady Bracknell è indignata e nega il permesso per il fidanzamento, a meno che Jack non
si trovi dei genitori entro la fine della stagione.
Gwendolen però non si scoraggia e chiede pertanto a Jack l'indirizzo della sua casa di campagna;
Algernon, ascoltando la conversazione, si segna l'indirizzo, intenzionato a far visita alla piccola Cecily.
32
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Secondo atto:
La scena si sposta in campagna, nella dimora di campagna di Jack, dove vive la giovane Cecily e la sua
anziana badante e insegnante, Miss Prism. Algernon si presenta alla tenuta dichiarando di essere Ernest e
si innamora della giovane, la quale contraccambia; anch'ella è però intenzionata a sposare soltanto un
uomo di nome Ernest, ritenendo, come Gwendolen, che esso abbia qualcosa di speciale. Quando Jack arriva
costringe Algernon ad andarsene ma egli, intenzionato a fidanzarsi con Cecily, torna di nascosto. Nel
frattempo, entrambi chiedono a Dr Chasuble, il reverendo della vicina chiesa, di essere battezzati.
Intanto anche Gwendolen, ancora desiderosa di fidanzarsi con Ernest, raggiunge la casa di campagna di
Jack, dove incontra Cecily. Dopo qualche battuta le donne scoprono di essere fidanzate con quello che
credono essere lo stesso uomo, ovvero Ernest. Dopo aver chiesto spiegazioni ai rispettivi fidanzati e
scoperta la verità, si ritirano indignate nella villa; poi però perdonano entrambi.
Una scena della prima rappresentazione teatrale commedia (1895)
Terzo atto:
Si apre con l'arrivo alla tenuta di Lady Bracknell, intenzionata a richiamare la figlia fidanzata con Jack.
Avendo inoltre saputo che il nipote Algernon è intenzionato a sposare Cecily, dopo un rifiuto iniziale,
concede il permesso al nipote, una volta venuta a conoscenza dell'ingente rendita della giovane, ereditata dal
nonno. È Jack tuttavia a negare il consenso per le nozze, sperando con questo di strappare a Lady Bracknell
l'autorizzazione per il proprio matrimonio con Gwendolen. Tuttavia la donna è irremovibile.
La "peripezia" si ha quando il Dr Chasuble nomina Miss Prism: a sentire quel nome, infatti, Lady Bracknell
chiede di vedere immediatamente l'educatrice. Si viene a scoprire che essa era un tempo alle dipendenze di
Lady Bracknell come bambinaia e che un giorno, uscita con il neonato a lei affidato, non era mai più tornata:
la carrozzina era stata trovata vuota e Miss Prism e il piccolo erano scomparsi.
La governante confessa che quel giorno era uscita con una grande borsa di cuoio e che, in un attimo di
distrazione, aveva riposto il bambino nella borsa, per poi dimenticarla nel guardaroba di Victoria Station a
Londra, Brighton Line.
Jack viene perciò riconosciuto nel neonato dimenticato da Miss Prism nella borsa e scopre di essere in realtà
il fratello maggiore di Algernon.
33
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
A questo punto, dopo questa vera e propria parodia del meccanismo dell'ἀναγνώρισις tipico della
commedia "Néa" di Menandro e Terenzio, Lady Bracknell autorizza le nozze tra Jack e Gwendolen.
Rimane però ancora il problema del nome, anche perché Jack, non essendo mai stato a conoscenza delle sue
origini, ha un nome che non è il suo. La zia Augusta dice che egli era stato chiamato come il suo defunto
padre, un generale dell'esercito inglese, ma incredibilmente né lei né Algernon ricordano il suo nome.
A questo punto Jack consulta gli elenchi militari scoprendo che il padre, e quindi anch'egli, si chiamava
effettivamente Ernest.
Il paradossale lieto fine non fa che scoprire l'ironia delle intenzioni wildiane: nessuno dei due "Ernest" è
veramente "earnest", ma questo non interessa a nessuno. L'importante è la forma, il suono del nome, quella
cura ipocrita dell'apparenza che è tipica dell'alta società vittoriana e che l'autore detesta con tutto se stesso.
L’umorismo di Wilde è pieno di nonsense, equivoci, ironia, giochi di parole. La commedia è basata fin dal
titolo su un controsenso che vede i protagonisti, due bugiardi abitudinari, conosciuti col nome di Earnest,
"Onesto".
Cecily e Gwendolyn non li avrebbero mai sposati se non si fossero chiamati così: Earnest è un nome che
soddisfa le loro fantasticherie adolescenziali, durante le quali favoleggiavano di un uomo che le amasse,
sincero, onesto, ma soprattutto un uomo che corrispondesse a quel nome che ispira loro cieca fiducia. Ed è
questo che rende la commedia ancora più amaramente divertente: da una parte ci sono le donne,
superficiali, vendicative, passionali, volubili, dall’altra gli uomini, bugiardi, vittimisti, manipolatori.
Un quadretto che attacca con stile la stupidità delle etichette sociali, i ridicoli formalismi dell’alta società, la
vacuità che si annida nel romanticismo infantile delle adolescenti.
Il tutto in una commedia frizzante e briosa, ironica ma profonda.
Riporto di seguito la scena finale.
Gwendolen. [To Jack.] My own! But what own are you? What is your Christian name, now that you have
become some one else?
Jack. Good heavens!… I had quite forgotten that point. Your decision on the subject of my name is
irrevocable, I suppose?
Gwendolen. I never change, except in my affections.
Cecily. What a noble nature you have, Gwendolen!
Jack. Then the question had better be cleared up at once. Aunt Augusta, a moment. At the time when Miss
Prism left me in the hand-bag, had I been christened already?
Lady Bracknell. Every luxury that money could buy, including christening, had been lavished on you by
your fond and doting parents.
Jack. Then I was christened! That is settled. Now, what name was I given? Let me know the worst.
Lady Bracknell. Being the eldest son you were naturally christened after your father.
Jack. [Irritably.] Yes, but what was my father’s Christian name?
Lady Bracknell. [Meditatively.] I cannot at the present moment recall what the General’s Christian name
was. But I have no doubt he had one. He was eccentric, I admit. But only in later years. And that was
the result of the Indian climate, and marriage, and indigestion, and other things of that kind.
Jack. Algy! Can’t you recollect what our father’s Christian name was?
Algernon. My dear boy, we were never even on speaking terms. He died before I was a year old.
Jack. His name would appear in the Army Lists of the period, I suppose, Aunt Augusta?
Lady Bracknell. The General was essentially a man of peace, except in his domestic life. But I have no doubt
his name would appear in any military directory.
Jack. The Army Lists of the last forty years are here. These delightful records should have been my constant
study. [Rushes to bookcase and tears the books out.] M. Generals… Mallam, Maxbohm, Magley, what
ghastly names they have—Markby, Migsby, Mobbs, Moncrieff! Lieutenant 1840, Captain, LieutenantColonel, Colonel, General 1869, Christian names, Ernest John. [Puts book very quietly down and
speaks quite calmly.] I always told you, Gwendolen, my name was Ernest, didn’t I? Well, it is Ernest
after all. I mean it naturally is Ernest.
Lady Bracknell. Yes, I remember now that the General was called Ernest, I knew I had some particular
reason for disliking the name.
34
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Gwendolen. Ernest! My own Ernest! I felt from the first that you could have no other name!
Jack. Gwendolen, it is a terrible thing for a man to find out suddenly that all his life he has been speaking
nothing but the truth. Can you forgive me?
Gwendolen. I can. For I feel that you are sure to change.
Jack. My own one!
Chasuble. [To Miss Prism.] Laetitia! [Embraces her]
Miss Prism. [Enthusiastically.] Frederick! At last!
Algernon. Cecily! [Embraces her.] At last!
Jack. Gwendolen! [Embraces her.] At last!
Lady Bracknell. My nephew, you seem to be displaying signs of triviality.
Jack. On the contrary, Aunt Augusta, I’ve now realised for the first time in my life the vital Importance of
Being Earnest.
Gwendolen (a Jack): Amore mio! Ma amore mio che cosa? Come ti chiami, adesso che sei diventato un altro?
Jack: Dio del cielo!... M'ero completamente dimenticato questo punto. La tua decisione in merito al mio
nome è irrevocabile, suppongo.
Gwendolen: Io non cambio mai, eccetto che negli affetti.
Cecily: Quanta nobiltà d'animo in te, Gwendolen.
Jack: La questione è meglio chiarirla subito. Zia Augusta, un momento. Quando Miss Prism mi abbandonò
in quella borsa, io ero già stato battezzato?
Lady Bracknell: Tutto ciò che i soldi possono procurare, battesimo incluso, era stato sparso a piene mani su
di te dai tuoi affezionati e generosi genitori.
Jack: Quindi sono stato battezzato! Questo è fuori discussione. E adesso: che nome mi è stato dato? Sono
preparato al peggio.
Lady Bracknell: In qualità di primogenito sei stato battezzato naturalmente con il nome di tuo padre.
Jack (con irritazione): Sì, ma come si chiamava mio padre?
Lady Bracknell (riflettendo): In questo momento non riesco a ricordarmi quale fosse il nome di battesimo
del Generale. Che ne avesse uno, ne sono sicura. Era un eccentrico, lo ammetto ma solo in età
avanzata. A causa forse delle condizioni climatiche in India, del matrimonio, della cattiva digestione,
e di altre cose del genere.
Jack: Algy! Non riesci a ricordarti come si chiamasse nostro padre?
Algernon: Amico mio, non siamo neanche mai arrivati a parlarci. Lui è morto prima che io compissi l'anno.
Jack: Il suo nome dovrebbe comunque figurare negli Annuari dell'Esercito di quel periodo, non è vero, zia
Augusta?
Lady Bracknell: Il generale era essenzialmente un uomo di pace, per lo meno al di fuori delle pareti
domestiche. Ma sono certa che il suo nome figura in tutti gli elenchi militari.
Jack: Gli Annuari dell'Esercito degli ultimi quarant'anni sono tutti qui. Deliziosi volumi che avrebbero
dovuto essere oggetto del mio costante studio.
(Si precipita alla libreria e comincia a strappare fuori libri.)
M. Generali... Mallam, Maxbohm, Magley... che nomi orrendi!... Markby, Migsby, Mobbs, Moncrieff!
Tenente nel 1840, poi Capitano, Tenente Colonnello, Colonnello, Generale nel 1869, nome di
battesimo Ernest John.
(Mette giù il libro con molta calma e parla con tutta serenità.)
Non ti ho sempre detto, Gwendolen, che mi chiamavo Ernest? Beh, e infatti mi chiamo Ernest.
Voglio dire che naturalmente mi chiamo Ernest.
Lady Bracknell: Sì, ricordo ora che il Generale lo chiamavamo Ernest. Lo sapevo che c'era un qualche motivo
per cui quel nome proprio non mi piace.
Gwendolen: Ernest! Mio Ernest! L'ho sempre saputo che non potevi avere nessun altro nome!
Jack: Gwendolen, è terribile per un uomo scoprire che per tutta la vita non ha detto altro che la verità. Potrai
mai perdonarmi?
Gwendolen: Ti perdono. Perché sento che cambierai certamente.
35
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Jack: Amore mio!
Chausable (a Miss Prism): Laetitia!
(La abbraccia.)
Miss Prism (con entusiasmo): Frederick! Finalmente!
Algernon: Cecily!
(La abbraccia.)
Finalmente!
Jack: Gwendolen!
(La abbraccia.)
Finalmente!
Lady Bracknell: Nipote mio, mi sembra che tu stia dando segni eccessivi di leggerezza.
Jack: Al contrario, zia Augusta, mi sono reso conto ora per la prima volta in vita mia, dell'essenziale
importanza di essere Ernesto.
36
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
ITALO CALVINO: LE "COSMICOMICHE"
Le Cosmicomiche di Italo Calvino (1923-1985) sono 33 racconti scritti da Calvino e pubblicati in quattro
raccolte: Le cosmicomiche, Einaudi, Supercoralli, 1965, Ti con zero, Einaudi, Supercoralli, 1967, La memoria del
mondo e altre storie cosmicomiche, Club degli editori, 1968, Cosmicomiche vecchie e nuove, Garzanti, 1984.
I primi 12 racconti, che costituiscono le originarie Cosmicomiche, furono scritti tra il 1963 ed il 1964; in origine
pubblicati per la maggior parte sui periodici Il caffè ed Il giorno, furono successivamente ripubblicati sotto
forma di raccolta da Einaudi nel 1965.
Sono storie umoristiche e paradossali relative all'universo, all'evoluzione, a tempo e spazio, nate dalla libera
immaginazione di Italo Calvino, ma basate su ipotesi teoriche avanzate dalla scienza per dare una
spiegazione sull'origine del nostro mondo.
Italo Calvino
"La letteratura italiana sta attraversando un momento di trombonaggine generale. Il mio solo terrore è di
essere in qualche modo confuso con i tromboni che imperversano. Un caro saluto, Italo Calvino".
Con queste poche righe, asciutte e critiche, Italo Calvino annuncia a Giambattista Vicari, direttore della
rivista Il caffè, che nel numero a lui dedicato intende far debuttare un suo nuovo esperimento narrativo. Lo
scrittore ligure mantiene le promesse e nel novembre del 1964 "uno speciale tipo di racconto comicosmico (o
cosmicomico)" fa il suo ingresso nella vita letteraria italiana, prendendo le distanze da qualche trombone di
troppo che imperversa e senza nessun timore reverenziale. Da questo momento fino al '68, Calvino
comporrà quasi tutte le cosmicomiche della sua produzione, eccetto un paio di racconti aggiunti nel 1984.
I primi anni '60 sono un periodo assai fecondo per la riflessione letteraria. In Italia le avanguardie del
Gruppo '63, ma anche artisti molto meno disposti a lasciarsi inquadrare, come Pier Paolo Pasolini, cercano
nuove risposte a domande vecchie e nuove: il ruolo del letterato e della letteratura in un mondo che appare
meccanizzato e artificiale; il ruolo del linguaggio e della comunicazione; il rapporto fra uomo e società.
La grande espansione delle città costruisce intorno all'uomo un groviglio di strade, di palazzi, di suoni, di
luci senza precedenti: cambia lo spazio stesso in cui l'uomo vive, cambiano i ritmi che ne regolano la vita. Il
mondo si trasforma in un labirinto, immagine che in questi anni emerge con forza e che rappresenta in
modo vivido la condizione esistenziale dell'uomo, così complicata da apparire inestricabile. Lo smarrimento
37
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
dei nuovi cittadini è dipinto da Calvino in Marcovaldo, ovvero le stagioni in città (1963) con racconti
divertenti e falsamente ingenui, spesso scambiati per racconti per bambini.
Ma Calvino fa un passo avanti. Per recuperare il rapporto con un ambiente di vita apparentemente del tutto
impoetico e degradato come la periferia urbana, occorre fare i conti con la nuova situazione senza rifiutarla.
Calvino indica nell'osservazione e nella descrizione il metodo per avvicinarsi a quel che ci serve: "e quello
che oggi ci serve è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. Quel che la letteratura può fare
è definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita. [...] E' una letteratura della sfida al labirinto
che vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al labirinto" (La sfida al labirinto, 1961).
La sfida lanciata da Calvino poggia dunque su due elementi che caratterizzano il metodo scientifico
moderno: l'osservazione e la descrizione. E la ricerca linguistica stessa di Calvino, come pure l'inclusione
della esattezza fra i tratti da trasmettere alla letteratura del nuovo millennio (Lezioni americane, 1985),
testimoniano quanto da vicino l'autore condivida con il mondo scientifico la ricerca di un linguaggio
rigoroso e puntuale.
Insomma, i tratti che delineano il metodo di analisi del mondo necessario per interpretarlo e per cambiarlo
appaiono, secondo Calvino, strettamente imparentati con il metodo scientifico.
Ma Calvino non si ferma qui. Ne Le cosmicomiche si rivolge direttamente al patrimonio dell'immaginario
scientifico per trarne un aiuto tutto letterario ed esistenziale. Questo rende le cosmicomiche racconti così
speciali da essere unici: nessuno sarà in grado di seguirlo nella sua proposta.
Che cos'è una cosmicomica?
Cosmicomiche deriva dalla giustapposizione dei termini cosmico e comico. Cosmico evoca l'assoluto: sono
racconti la cui materia è in grado di avere la grandezza del mito. Comico si riferisce invece al temine inglese
comics, che indica la striscia di vignette.
Salvo poche eccezioni, una cosmicomica ha una struttura molto ben definita: in poche righe, staccate dal
corpo narrativo, si enuncia un'ipotesi scientifica. Segue poi un racconto, la cosmicomica propriamente detta,
nel quale lo spunto iniziale viene abbandonato nel volgere di qualche giro di frase, per essere ripreso a vari
livelli, secondo la fantasia creativa dell'autore.
A prima vista può sembrare un genere imparentato con la fantascienza, ma Calvino stesso ha avuto modo di
tornare su questo aspetto più volte: "il procedimento delle cosmicomiche," dice Calvino, "non è quello della
Science Fiction (cioè quello classico - e che pure molto apprezzo - di Jules Verne e H. G. Wells). Le
cosmicomiche hanno dietro di sé soprattutto Leopardi, i comics di Popeye (Braccio di Ferro)" (da Lezioni
americane, Visibilità, 1988).
Dunque episodi a sé stanti, conchiusi, con un inizio, uno svolgimento e una fine. E all'inizio dell'episodio
successivo si può far finta che il precedente non sia neppure avvenuto. Sono quindi delle "messe in scena"
quasi indipendenti l'una dall'altra, secondo l'esempio dei fumetti a "strisce", a cui sono sufficienti poche
vignette per creare una vicenda narrativa definita, per poi riavvolgere il nastro, all'inizio della striscia
successiva, e riprendere esattamente la medesima situazione dando luogo però a un esito diverso.
Protagonista delle cosmicomiche è sempre un personaggio, Qfwfq, cui la celebrità è preclusa dal suo stesso
nome impronunciabile e che risulta anche "difficile da definire, perché di lui non si sa nulla. Non è
nemmeno detto che sia un uomo (...) Si deve calcolare che ha più o meno l'età dell'universo" (dalla
prefazione a Le cosmicomiche).
Qfwfq è stato testimone e protagonista di tutto: dal Big Bang alla formazione del sistema solare, dalla
mitosi cellulare alle enormi, spaventose galassie infestate da buchi neri giganteschi. Ed è stato corporeo
oppure privo di sostanza, a volte bambino, a volte tendente al pesce o al dinosauro. Metamorfosi, queste,
rese accettabili perché la struttura narrativa stessa richiama, in realtà, un'immagine unificante che guida il
lettore: ecco apparire - sotto sotto - un vecchio rompiscatole, con una barba più o meno lunga, che non fa che
ricordare il tempo immemorabile della sua gioventù. Come ci aspettiamo, nonostante la vastità delle
esperienze, Qfwfq non è certo un testimone attendibile. Da lui non avremo mai una visione coerente del
cosmo né della sua storia. Anzi è "pronto di volta in volta ad avallare con le sue memorie d'infanzia o di
giovinezza ipotesi contraddittorie o addirittura opposte."
Strano? Ma no, fa parte del gioco delle comics, delle strisce, appunto, che non compongono una storia
coerente ma tanti sketch che non hanno memoria uno dell'altro. Tanto più che, sebbene Qfwfq sia la voce
narrante e il protagonista di 28 delle 33 cosmicomiche scritte da Calvino, non si può certo dire che il
38
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
personaggio abbia una sua evoluzione psicologica: ogni avventura inizia con Qfwfq alle prese con un
teorema, una congettura, un'ipotesi della scienza moderna, spesso contemporanea, pronto a giurare sulla
sua verità e a raccontare episodi più o meno credibili che si sono verificati proprio perché le cose, a
quell'epoca, andavano in quel modo. E non importa se nel racconto che segue, le cose, a quell'epoca,
sembrano andare in modo del tutto opposto.
Una strip di Popeye
Insomma, Qfwfq quando parla ha lo stesso potere evocativo di un vecchio nonno che rafforza le tradizioni
della famiglia, con le sole armi della propria oralità e delle immagini che ne scaturiscono. A chi interessa se,
ogni tanto, è contraddittorio?
Il senso delle cosmicomiche
"Le denominazioni animali o antropomorfe che le costellazioni portano ancora hanno perduto la loro carica
mitica già dall'antichità (...). A ogni secolo e a ogni rivoluzione del pensiero sono la scienza e la filosofia che
rimodellano la dimensione mitica della immaginazione, cioè il fondamentale rapporto tra gli uomini e le
cose" (Il Corriere della Sera, 7 settembre 1975, nella rubrica Osservatorio del signor Palomar).
Che cos'è la dimensione mitica della immaginazione, che cosa è il mito?
Il mito è una fantasia di ordine superiore, che stabilisce relazioni fra figure e forme primordiali, come per
esempio "la bellezza" e "la madre generatrice di vita". E' il caso per esempio della nascita di Afrodite dalle
acque del mare, rese gravide da Urano. Tuttavia il mito non è vincolante nè matematico, prevede la
contraddizione, l'ambiguità, tanto che ambiguità e contraddizione ne diventano caratteristica fondamentale:
Afrodite, secondo una diversa tradizione, è figlia di Zeus e Dione, divinità è vero, ma che la mettono al
mondo in termini del tutto canonici.
Questo il fascino del mito: da una parte ha la pretesa di raccontare un ordine superiore, un ordine che
precede quello del più antico mondo storico. E dall'altra "ogni interpretazione lo impoverisce e lo soffoca: coi
miti non bisogna avere fretta; è meglio lasciarli depositare nella memoria, fermarsi a meditare su ogni
dettaglio, ragionarci sopra senza uscire dal loro linguaggio di immagini". Pretendere la coerenza dal mito
significa ucciderlo.
39
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Ma se il mito è tutto questo, è vero allora che la dimensione mitica è rimodellata dalla scienza e dalla
filosofia?
E' un'affermazione discutibile, di sicuro è una tesi assai poco frequentata in Italia, se non durante la breve
stagione del Futurismo e della fascinazione per "le macchine". E tuttavia è quanto occorre per comprendere
il presupposto delle Cosmicomiche.
"Nelle Cosmicomiche (...) il punto di partenza è un enunciato tratto dal discorso scientifico: il gioco
autonomo delle immagini visuali deve nascere da questo enunciato. Il mio intento era dimostrare come il
discorso per immagini tipico del mito possa nascere da qualsiasi terreno: anche dal linguaggio più lontano
da ogni immagine visuale come quello della scienza d'oggi. Anche leggendo il più tecnico libro scientifico o
il più astratto libro di filosofia si può incontrare una frase che inaspettatamente fa da stimolo alla fantasia
figurale (...) Ne può scaturire uno sviluppo fantastico tanto nello spirito del testo di partenza quanto in una
direzione completamente diversa." (Lezioni americane, Visibilità, 1988).
La forza mitica della scienza: ecco il punto. Il narratore di miti per eccellenza, Omero, è una sorta di
artigiano che raccoglie immagini preesistenti ed extra individuali (mitiche appunto, collettive) e li tesse
insieme, confezionando un tessuto narrativo del tutto originale. Nel caso di Calvino, il patrimonio di
immagini preesistenti non è altro che quel che scaturisce dal mondo descritto dalla scienza.
Italo Calvino
I temi delle cosmicomiche
"Forse il libro più illuminista che ho scritto è proprio questo, questa rivendicazione antropomorfa al di là
del pensabile in immagini umane. (...)" (Lettera a Sebastiano Addamo - Lentini (Siracusa), 23.6.1966).
Per mettere in evidenza i temi ricorrenti nelle Cosmicomiche, sarà sufficiente fare riferimento all'ultima
pubblicazione, Cosmicomiche vecchie e nuove, che è una raccolta di 31 cosmicomiche.
Nella prima parte di si insegue il tempo ripercorrendolo a ritroso. Ecco quindi brevi storie dei primi
organismi evoluti: pesci, dinosauri, uccelli (Lo zio acquatico, I dinosauri, L'origine degli Uccelli), per passare alla
genesi e all'evoluzione geologica e geofisica del nostro pianeta (Senza colori, Il cielo di pietra, I meteoriti, I
cristalli). Un capitolo a parte merita la Luna, la sua formazione e il suo speciale rapporto con la Terra e i
terrestri (La molle Luna, Le figlie della Luna, La distanza della Luna, La luna come un fungo), per finire alla nascita
del Sole, al suo destino finale e alle sue proprietà fisiche, con il presupposto che sia un dio capriccioso che è
meglio conoscere bene (Sul far del giorno, Fino a che dura il Sole, Tempesta solare).
Nella seconda parte del volume, Calvino abbandona il sistema solare e si occupa delle galassie e della
cosmologia. Il tema della nascita continua a dominare: ecco dunque storie sulla genesi del cosmo, che danno
voce a teorie contrapposte e incompatibili, come il Big Bang e la Teoria dello stato stazionario (Tutto in un
40
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
punto, Giochi senza fine), ma che giocano anche sul destino futuro (Quanto scommettiamo, L'implosione) e con la
struttura stessa dell'universo (Un segno nello spazio, Gli anni-luce, La forma dello spazio, Il niente e il poco).
Per la terza parte, Calvino inventa un nuovo nome: biocomiche. Senza venire meno al senso mitico, la
materia del racconto diventa la biologia, in particolare la biologia cellulare (La spirale, Il sangue, il mare,
Priscilla: Mitosi, Meiosi, Morte). Ancora un mito di nascita, questa volta tutto centrato sulla vita, che prevede,
come definizione di se stessa, anche la morte.
La quarta ed ultima sezione della raccolta è dedicata ai racconti deduttivi: affabulazioni cioè che prendono
spunto dal mondo della logica matematica e della combinatoria. E in essi certamente è presente l'influenza
di Queneau e dell'esperienza dell'Oulipo, acronimo dal francese Ouvroir de Littérature Potentielle, traducibile
in italiano "officina di letteratura potenziale", un Gruppo di scrittori e matematici di lingua francese che
mirava a creare lavori usando, tra le altre, le tecniche della scrittura vincolata detta anche a restrizione. I
racconti che appartengono a questa tipologia sono Ti con zero, L'inseguimento, Il guidatore notturno, Il conte di
Montecristo.
I temi dominanti delle Cosmicomiche, a livello mitologico, sono del tutto evidenti:
- il tema della nascita (della vita, dell'uomo, della Luna, della Terra, del Sole, dell'universo);
- il tema del cambiamento (l'evoluzione umana, il sistema Terra-Luna);
- il tema della morte.
I racconti deduttivi sembrano invece essere un ponte con l'attività che, all'epoca della pubblicazione della
raccolta, era diventata centrale nelle opere di Calvino: l'applicazione del metodo alla descrizione del
mondo.
Analisi de "La distanza della Luna"
L'idea per la prima cosmicomica, La distanza della Luna, risale probabilmente alla fine del 1963 e trae spunto
da una teoria di formazione: "Una volta, secondo Sir George H. Darwin, la Luna era molto vicina alla Terra.
Furono le maree che a poco a poco la spinsero lontano: le maree che lei Luna provoca nelle acque terrestri e
in cui la Terra perde lentamente energia."
Il tema scientifico principale è chiaro, ma non semplice: si tratta dell'allontanamento della Luna dalla Terra
a causa della perdita di energia dovuta alle maree.
Per capire di che cosa di tratta, è necessario riferirsi a una proprietà di certi sistemi, come appunto il sistema
Terra-Luna, di mantenere costante il valore di una grandezza fisica detta momento angolare.
In breve, il momento angolare di un sistema di corpi tiene conto della distribuzione delle masse che ruotano,
nel nostro caso la Luna e la Terra, e della loro velocità di rotazione. Per esempio, se immaginiamo un sasso
che si muove lungo una circonferenza, il momento angolare avrà un valore dato dal prodotto della massa
del sasso, del valore della sua velocità e del raggio della circonferenza sulla quale si muove.
Se poi il sasso ruota su se stesso, si dovrà tenere conto anche di questo movimento.
Il momento angolare di un sistema dipende anche dalle forze che agiscono sul sistema stesso, che possono
modificarne il valore. Nel caso del sistema Terra-Luna, però, non agiscono forze esterne, e il momento
angolare è destinato a conservarsi. In ultima analisi questo è il motivo per il quale la Luna si allontana
dalla Terra. Infatti le maree, a causa dell'attrito generato dallo scivolamento delle acque sui fondali marini,
rallentano la rotazione della Terra intorno al proprio asse (Calvino si riferisce a questo fenomeno dicendo
che la Terra perde lentamente energia). Se tutto finisse qui, allora il momento angolare complessivo del
sistema dovrebbe diminuire. Ma questo non può accadere, perché il sistema Terra-Luna deve mantenere
costante il valore del momento angolare totale. Ebbene, si verifica che un modo per ripristinare il valore del
momento angolare, è proprio che la Luna si allontani dalla Terra. Qui entra in gioco l'attrazione
gravitazionale di Newton nella sua manifestazione "lunare" più clamorosa: l'esistenza della marea di acqua
e le conseguenze di questa sull'orbita lunare e sulla rotazione della Terra.
Ma come si svolge il racconto? Calvino non è affatto interessato ai dettagli del meccanismo che abbiamo
descritto: "la prima cosmicomica che ho scritto, La distanza della Luna, è la più (diciamo così) surrealista, nel
senso che lo spunto basato sulla fisica gravitazionale lascia via libera a una fantasia di tipo onirico. In altre
cosmicomiche il plot è guidato da un'idea più conseguente con il punto di partenza scientifico, ma sempre
rivestita da un involucro immaginoso, affettivo, di voce monologante o dialogante".
41
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Ci sono anche spunti di falsa scienza, se vogliamo definirla in questo modo: a più riprese la Luna è
paragonata a un magnete."Il suo corpo era rimasto calamitato", "Un corpo che scendeva a Terra dal satellite
rimaneva per qualche tempo ancora carico della forza lunare e si rifiutava all'attrazione del nostro mondo".
E' chiaro che si fa leva sul magnetismo come rappresentazione ancestrale e intuitiva di ogni forma di
attrazione. Lo si fa anche nel parlato.
La trama è semplice e bella. La Luna è vicina alla Terra, "l'avevamo sempre addosso, la Luna, smisurata",
così vicina che quando era plenilunio quasi si bagnava nel mare, perché anche le maree erano
particolarmente alte, non quelle poche decine di centimetri a cui siamo abituati oggi. E se Terra e Luna si
sfiorano, che cosa c'è di più naturale per Qfwfq, suo cugino sordo, il capitano e sua moglie, se non prendere
una scaletta, andar sotto la Luna con una barca e, proprio quanto il satellite è alla massima vicinanza, salirvi
agilmente sopra? Ma c'è persino di più: la Luna, nel suo passar vicino al mare e alle terre emerse, attira sulla
sua superficie piccoli animaletti, erbe, radici, che si fermano sotto le sue scaglie - scaglie di Luna - e
fermentando danno origine a un latte, un po' acido forse, ma nutriente e buonissimo. Si avverte qui anche
l'influsso di un romanzo come la Storia vera di Luciano di Samòsata, il cui protagonista Lucino, fra l'altro,
vive avventure mirabolanti sulla Luna, incontra le donne-vigneto che producono latte ed attraversa il "mare
di latte".
E sotto quella Luna così immensa, così grande, che cosa c'è di più naturale di un grande amore?
Specialmente se la moglie del capitano, la signora Vhd Vhd, suona l'arpa: "aveva braccia lunghissime,
argentate in quelle notti come anguille (...)". "Così cominciò la storia del mio innamoramento per la moglie
del capitano, e delle mie sofferenze. Perché non tardai ad accorgermi a chi andavano gli sguardi più ostinati
della signora: quando le mani di mio cugino si posavano sicure sul satellite, io fissavo lei, e nel suo sguardo
leggevo i pensieri che quella confidenza tra il sordo e la Luna le stava suscitando, e quando egli spariva per
le sue misteriose esplorazioni lunari la vedevo farsi inquieta, stare come sulle spine, e tutto ormai m'era
chiaro, di come la signora Vhd Vhd stava diventando gelosa della Luna e io geloso di mio cugino."
Qfwfq è innamorato della moglie del capitano, che a sua volta ama il cugino sordo del protagonista, il
quale ha una sua sintonia naturale con la Luna, e neanche si accorge di aver destato l'attenzione della
signora. O forse sì, ma non se ne cura. Ecco dunque che la Luna esercita due forme di attrazione:
gravitazionale e "animale", per dir così. Quest'ultima in qualità di nutrice (il latte lunare) e di donna
42
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
(oggetto di desiderio da parte dello zio). E in entrambi gli aspetti, la Luna è antagonista di Madre Terra
(nutrice degli uomini) e di una donna, nel contendere l'attenzione del cugino alla signora Vhd Vhd.
Inesorabilmente le maree fanno il loro lavoro e arriva il giorno in cui la Luna è sì abbastanza vicina da salirci
sopra, ma i protagonisti hanno una solo tentativo per scendere con un tuffo e tornare sul pianeta natale.
Non possono sbagliare. Rischiano di rimanere confinati su quel satellite destinato ad essere un'isola nello
spazio. "Ed ecco, appena mio cugino era salito su per la scala, la signora Vhd Vhd disse: - Oggi ci voglio
andare anch'io, lassù! - Non era mai successo che la moglie del capitano salisse sulla Luna. Ma Vhd Vhd non
s'oppose, anzi quasi la spinse di peso sulla scala, esclamando: - E vacci! -"
Dunque la moglie del capitano e il cugino sordo sono sulla Luna. Ma il cugino non desidera altro che
appartarsi con lei, la Luna. E si nasconde in una piega lunare, finché non è il momento di tornare, e rieccolo
sulla Terra con la sua consueta capriola. Senza neanche curarsi della sua innamorata terrestre, la povera
signora Vhd Vhd.
E la moglie del capitano?
Al centro di un triangolo di un marito deluso da lei, lei delusa dal folle amante della Luna e di un
innamorato da lei respinto, decide d'istinto. E rimane sulla Luna: è il tentativo estremo, violento, di
identificarsi con il satellite, oggetto di desiderio del cugino sordo: "Se quel che ora mio cugino amava era la
Luna lontana, lei sarebbe rimasta lontana, sulla Luna".
E' lei, la moglie del capitano, che conferisce un'anima alla Luna, popolandola di se stessa: una Luna
altrimenti deserta e inospitale. E' lei il volto della Luna, quel volto pallido, dal sorriso mesto, ed è per questo
che la Luna ci mostra sempre la stessa faccia. E' la moglie del Capitano che "rende Luna la Luna e che ogni
plenilunio spinge i cani tutta la notte ad ululare, ed io con loro", dice Qfwfq. Sono quindi il desiderio, il
sogno, le speranze umane che rendono Luna la Luna.
43
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
LUCIANO, IL RE DELL'IRONIA
"ALESSANDRO O IL FALSO PROFETA"
Alessandro o il falso profeta non è un dialogo, ma un libello satirico scritto da Luciano di Samosata (120 circa 180 d.C.) nell'anno 180, leggibile per intero in Appendice nella colorita traduzione ottocentesca di
Luigi Settembrini (Opere di Luciano voltate in italiano da Luigi Settembrini, Le Monnier, Firenze, 1861).
La composizione dell'opera prende spunto da un fatto d'attualità: un'oscura città situata sulla costa
settentrionale dell'Asia Minore nella seconda metà del II secolo si trasformò in un centro famoso, meta di
pellegrini provenienti da ogni parte per consultare l'oracolo che vi aveva sede. Il "merito" di tutto ciò va
attribuito ad Alessandro, lo spregiudicato avventuriero e falso profeta protagonista dello scritto di Luciano,
che ne traccia un preciso profilo, dal quale emerge anche il diffuso clima di ansiose aspettative verso un
tramite col soprannaturale tipico del II secolo d.C., clima che favorì l'affermarsi di molti profittatori.
Per certi versi l'Alessandro rientra nel genere delle biografie, o meglio ancora dell'agiografia (vite di santi), ma
in un'ottica antifrastica: qui si pone in evidenza non un modello da imitare, ma un esempio da evitare.
Luciano, con una felice vena d'ironia, prende di mira il falso profeta ma anche i facili creduloni: chi plagia e
chi si lascia plagiare sono corresponsabili dell'offesa alla ragione. Esplicito e dichiarato è il favore di
Luciano verso la razionalità di Epicuro.
L'autore, con raffinata ironia, racconta di un sedicente mago e indovino, diventato famoso ad Abonuteico
(antico centro portuale sul Mar Morto, oggi Jnebolu), nel II secolo d.C.
Alessandro o il falso profeta è la storia di un grandioso mistificatore, del quale rimangono tracce in gemme,
monete, iscrizioni.
Alessandro si presenta all’inizio come un avventuriero pieno di sogni, che voleva superare la gloria di
Alessandro Magno. E di fatto non riuscì a poco. Nato nell’oscura Paflagonia, di aspetto bellissimo (come
Luciano stesso ammette e sottolinea), cominciò la sua carriera prostituendosi e sfruttando un’amante
matura.
Statuetta del dio Glicone
Ma ben altre erano le sue aspirazioni: attraverso una serie di vicende e di trucchi esilaranti riuscì a fondare
un tempio oracolare dedicato al dio Glicone - serpente antopomorfo assimilato ad Asclepio - del quale egli
era sacerdote e indovino. Le folle vi accorrevano e lo ammiravano come un dio.
Il credito riscosso in questo modo fu enorme e - ovviamente - anche le ricchezze che ne seguirono.
44
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Ben presto la fama di Alessandro crebbe in tutta la Grecia e a Roma stessa anche per l'appoggio che ricevette
da un personaggio influente, l'ex console Rutiliano, al quale il "profeta" diede in moglie una figlia che si
vantava di aver generato con la Luna [sic!].
Il dio solare celtico Ogma, raffigurato da G. Gaudenzi nei suoi Tarocchi celtici
con i tratti dell'Ercole gallico descritto da Luciano nel suo Ἡρακλῆς,
saggio sul dio gallico, che Luciano chiama Ogmios ed associa con la figura di Ercole.
Esilaranti le descrizioni relative agli inganni e alle diavolerie usate da Alessandro per abbindolare i
creduloni ed estorcere loro un bel po' di quattrini:
ἐθελήσας δὲ καὶ μειζόνως ἐκπλῆξαι τὸ πλῆθος, ὑπέσχετο καὶ λαλοῦντα παρέξειν τὸν θεόν, αὐτὸν ἄνευ
ὑποφήτου χρησμῳδοῦντα. εἶτα οὐ χαλεπῶς γεράνων ἀρτηρίας συνάψας καὶ διὰ τῆς κεφαλῆς ἐκείνης
τῆς μεμηχανημένης πρὸς ὁμοιότητα διείρας, ἄλλου τινὸς ἔξωθεν ἐμβοῶντος, ἀπεκρίνετο πρὸς τὰς
ἐρωτήσεις, τῆς φωνῆς διὰ τοῦ ὀθονίνου ἐκείνου Ἀσκληπιοῦ προπιπτούσης.
"Poiché sperava di stupire la folla ancora di più, promise di mostrare il dio che parlava e dava oracoli personalmente,
senza un profeta. Non fu cosa difficile per lui collegare insieme tubi attraverso i quali passasse l’aria e farli passare
attraverso la testa che egli aveva modellato in modo che fosse come viva. Quindi rispondeva alle domande mediante
qualcuno che dall’esterno parlava nel tubo in modo che la voce uscisse da quella immagine di Asclepio".
Ma non tutto va per il verso giusto per il nostro santone:
Ἐπεὶ δὲ [...] ἐν ταῖς πόλεσιν ἐπεφώρατο ἠρέμα ἡ πᾶσα μαγγανεία καὶ συσκευὴ τοῦ δράματος, ἐκφέρει
φόβητρόν τι ἐπ' αὐτούς, λέγων ἀθέων ἐμπεπλῆσθαι καὶ Χριστιανῶν τὸν Πόντον, οἳπερὶ αὐτοῦ τολμῶσι
τὰ κάκιστα βλασφημεῖν· οὓς ἐκέλευε λίθοις ἐλαύνειν, εἴ γε θέλουσιν ἵλεωἔχειν τὸν θεόν.
"Dato che [...] nelle città ci si accorge a poco a poco del trucco di tutti questi incantesimi e si scopre la messa in scena
della farsa, Alessandro ricorre alle minacce contro di loro, dicendo che il Ponto è pieno di atei e di Cristiani che osano
45
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
spargere le peggiori calunnie contro di lui, ed ordina di cacciarli a colpi di pietra se si voleva conservare il favore del dio
(Glicone)".
I dissidenti (i filosofi scettici ed epicurei e i cristiani) venivano quindi presi a sassate e cacciati non solo dal
tempio, ma anche dalla città. Lo stesso Luciano, notoriamente miscredente, subì minacce di morte e un
vero e proprio attentato in mare per ordine degli emissari del "santone".
In realtà il comportamento del giovane rètore, in questa occasione, fu tutt'altro che irreprensibile. A
proposito dell'episodio Luigi Settembrini, nella sua prefazione alla traduzione dei dialoghi di Luciano (op.
cit. pag. 23), scrive:
"Nella Vita di Alessandro, o il falso profeta [Luciano] narra come essendo andato dalla Cappadocia nella Paflagonia
con due soldati datigli per guardia dal governatore della Cappadocia suo amico, ed essendo venuto alla presenza del
profeta, costui gli porse la mano a baciare, ed egli irato di quest'atto, gliela morse bruttamente; come gli
astanti volevano sbranarlo per quel sacrilegio, ma le armi dei soldati e la furba dissimulazion di Alessandro lo
salvarono. Ma quando s'imbarcò e partì, trovossi dato nel laccio; chè i marinai indettati da Alessandro volevano gettarlo
a mare, ed appena furono dissuasi dalle preghiere del padrone: e così ei fu salvo da un grave pericolo corso per un atto di
sdegno poco dignitoso, e per una baldanza giovanile che lo traportava ad abborrire tutti gl'impostori".
Non si potrebbe immaginare episodio più rivelatore del razionalismo estremo di Luciano, della sua indole
ribelle e insofferente, del suo amore sfrenato per la libertà (soprattutto di pensiero) e della sua vera e propria
idiosincrasia verso l'irrazionale e le sue manifestazioni.
Del resto, come dargli torto? Si legga ad esempio il resoconto di quella che forse è la più spericolata fra le
invenzioni del falso profeta, nella già citata traduzione di Luigi Settembrini:
"Ma fra tante altre, odi questa che fu la più ardita furfanteria di questo sozzo ribaldo. Avendo non piccola introduzione
presso l’imperatore e in palazzo, pel gran favore che vi godeva Rutiliano, vi mandò un oracolo mentre ardeva la guerra
di Germania, e il divo Marco Aurelio era già venuto alle mani coi Quadi e coi Marcomanni. Comandava l’oracolo di
gettare nell’Istro due leoni vivi con molti aromati, e di fare magnifici sacrifici, e diceva così:
Nei vortici dell’Istro, divo fiume,
Si gittino due servi di Cibele,
due lioni montani; e appresso quanti
Fiori ed erbe odorose India produce.
Così tosto sarà chiara vittoria,
Ed onor grande, e la bramata pace.
Fatta ogni cosa appunto come egli aveva ordinato, i leoni nuotando uscirono all’altra riva, dove i barbari con bastoni li
accopparono credendoli nuovi lupi: ma indi a poco i nostri toccarono una grande rotta [= sconfitta], in cui morirono
intorno a ventimila; e poi seguì il fatto d’Aquileia, la quale per poco non fu distrutta. Ed egli per questo avvenimento
addusse per iscusarsi la fredda risposta di Delfo a Creso, che il dio aveva predetta la vittoria sì, ma non
dichiarato se de’ Romani o dei barbari."
Se nella Morte di Peregrino Proteo, argomento del paragrafo successivo, il tono di Luciano è quello polemico e
risentito della satira, al contrario nell'Alessandro lo sdegno lascia talvolta il posto ad un più rilassato
umorismo; è il caso per esempio dei buffissimi oracoli di Alessandro citati da Luciano, alcuni dei quali
estorti da lui stesso per ingannarlo e metterlo in ridicolo. Leggiamone alcuni, sempre nella traduzione di
Settembrini:
"Siffatto fu l’oracolo dato ad uno Scita:
Morfi erbagulis is schien chnenchierac lipsi faos (1).
Un’altra volta non essendovi alcuno che il dimandasse, uscì, a un tratto con queste parole in prosa: «Ritorna indietro:
chi ti mandò è stato ucciso oggi dal suo vicino Diocle, e dai ladri Magno, Celere e Bubalo, che già son presi e
imprigionati.»
46
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Odi ora alcuni oracoli dati a me. Avendogli io dimandato: "È calvo Alessandro?" e sigillata la polizza
accuratissimamente, ei vi scrisse su quest'oracolo notturno: "Malac figliuolo di Sabardalac era un altro Ati".
In due altre polizze diverse scrissi quest’altra dimanda: "Qual’è la patria del poeta Omero?" e gliele feci dare da altri
sotto altro nome. Egli, ingannato dal mio servitore, che, dimandato, aveva detto come io ero venuto per cercare un
rimedio per un dolore di fianchi, scrisse sovra una: "Ungi col timo e schiuma di destriero" e sull’altra, avendo udito che
chi l’aveva mandata voleva sapere se tornare in Italia per terra o per mare, scrisse, senza dir motto di Omero: "Non
navigar, fa tuo viaggio a piedi".
Lug, il Mercurio gallico, nell'interpretazione di Giacinto Gaudenzi.
Dalla figura di Hermes-Mercurio (identificato con il dio egizio Thoth), inventore di tutte le arti,
deriva probabilmente quella del Bagatto dei Tarocchi, emblema dell'abilissimo ciarlatano.
Di tali tranelli io gliene tesi parecchi: ed un altro fu questo. In una polizza scrissi una sola dimanda, e sopra vi scrissi,
come soleva farsi: "otto dimande del tale", e foggiai un nome; e gli mandai otto dramme e il resto. Egli si lasciò
ingannare ai danari ed alla soprascritta: e rispose a quella sola dimanda, la quale era: "Quando sarà punito questo
furfante d’Alessandro?" con otto oracoli, che, come suol dirsi, non toccavano né cielo né terra, ed erano tutti sciocchi e
strani".
(1) Una parte dell'oracolo (forse in lingua scita?) è indecifrabile; le parole is schien... lipsi faos (εἰς σκιὴν λείψει
φάος) sono greche, e sembrano significare "nell'ombra lascerà la luce".
Alessandro, dopo aver predetto, con un oracolo riguardante la sua persona, che sarebbe vissuto fino a
centocinquant'anni e poi sarebbe morto colpito da un fulmine, terminò la sua vita non ancora settantenne,
divorato dalla cancrena.
47
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Peraltro, a dispetto del ridicolo in cui Luciano cercò di sommergerlo, morì celebre, e il suo culto durò nei
luoghi vicini all’oracolo per più di un secolo.
Riporto in conclusione per intero la bella sintesi con commento di Alessandro o il falso profeta scritta da Luigi
Settembrini (op. cit. pagg. 66-68):
"Alessandro di Abonotechia, piccola città di Paflagonia presso Sinope, uomo di non volgare ingegno, fu un impostore
famoso che acquistò molte ricchezze, per un tempio ed un oracolo che stabilì nella sua patria, al quale traeva gente da
ogni parte, e finanche i più illustri di Roma. Di costui Luciano scrive la vita a consiglio di Celso suo strettissimo amico,
filosofo epicureo, eloquente, ed avversario dei Cristiani.
Il fine che ebbero Celso nel consigliare, e Luciano nello scrivere quest'opera, fu di mostrare apertamente tutte le
astuzie onde i furbi ingannavano i semplici, e di confermare sempre più gli uomini di senno nel disprezzo delle
superstizioni e delle ciarlatanerie.
I pochi savi che si affaticavano ad insegnare e diffondere la verità, dovevano sentire un nobile sdegno contro di quelli che
si affaticavano a diffondere l'errore nel popolo, per trarne profitto a proprio vantaggio. Chi sostiene l'errore perchè ne è
persuaso, e senza fine di utile particolare, può essere sciocco, non è tristo; ma chi abusa della credulità della gente
grossa, e fa bottega del suo ingegno, è un ribaldo che merita davvero di essere dato a sbranare alle scimmie ed alle
volpi.
Incisione tratta da un'edizione ottocentesca delle opere di Luciano
In questo scritto Luciano nomina sé stesso, narra come egli aspreggiò ed offese Alessandro, come lo tentò con varie
dimande, come gli morse la mano datagli a baciare, e poi il pericolo che corse per questo fatto: onde sia per tutto questo
racconto, che per nessuna ragione si può credere finto, sia ancora per la materia dello scritto, e la forma, e la lingua, io
non dubito che sia genuino.
Luciano compose questo scritto quando era già provetto negli anni, e dopo la morte di Marco Aurelio, perché dice
che Alessandro mandò un suo oracolo in Roma mentre ardeva la guerra di Germania, e il divo Marco era alle mani coi
48
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Quadi e coi Marcomanni. Or l'epiteto divo si dava solamente agl'imperatori già morti: ed alla morte di Marco era
Luciano, se non vecchio, molto attempato. Ma i fatti che egli narra, avvennero quand'egli era nel vigore
degli anni, e famoso, e aveva suo padre (cap. 56), ed era pieno di baldanza giovanile, sì che non seppe ridere
dell'impostore, e volle irritarlo.
Egli si scusa di scrivere la vita di costui, che avria dovuto essere dimenticato, o gittato alle fiere, dicendo di fare il
volere dell'amico, ed allegando l'esempio di Arriano, discepolo di Epitteto, prode capitano ed istorico, il quale scrisse la
vita di un Tilliboro ladrone. Ed Arriano, governatore della Cappadocia, forse fu quell'amico che gli diede i due soldati
che lo salvarono, quand'egli morse la mano al profeta.
Tutta la vita di questo furbo, dalla sua fanciullezza, è narrata con molti e minuti particolari, che Luciano
sapeva solamente per fama, e forse potè esagerarli per odio. Ogni cosa è dipinto al vivo: la persona bellissima, l'ingegno
ardito, le prime furfanterie della giovanezza, il disegno di stabilire un oracolo, tutta quella commedia onde l'oracolo fu
stabilito, i prodigi che faceva il nuovo iddio, le risposte che dava, la celebrazione de misteri, nei quali Alessandro faceva
da ierofante e da Adone, e la moglie di un procuratore faceva da Venere, e quei mascalzoni di Paflàgoni fetenti d'aglio,
che gli facevano coro, e gridavano: "viva Alessandro!", tutto è descritto mirabilmente.
Il carattere di Rutiliano è forse più importante del carattere di Alessandro stesso; perché, essendo dipinto senza
odio, pare più vero. Quel patrizio romano, bravo nelle faccende di governo, ma sì perduto di superstizioni, che se pur
vedeva una pietra unta di olio o con una corona sopra, tosto smontava del cocchio e adorava e pregava per molte ore; che
mette sossopra tutta Roma e la corte parlando del nuovo oracolo, e spedisce corrieri sopra corrieri a consultarlo; che,
vecchio com'è, sposa la figliuola di Alessandro; e che dopo la morte di costui non ardisce di succedere egli al profeta, né
vuole che altri gli succeda, è un uomo vero e vivo con tutti i vizi e la virtù d'un Romano di quel tempo, e tu ne
ridi come ne rideva Luciano, ma senza odiarlo.
Nondimeno l'asprezza con cui è trattato Alessandro non offende la verità della narrazione, perché certamente colui fu
un impostore; ed un impostore è sempre un tristo: vi può essere un po' di colorito soverchio, ma il disegno della pittura
è vero. Lo stesso animo generoso dettò la vita di Demonatte e quella di Alessandro; ammirò il savio dabbene, e abborrì
l'impostore ribaldo.
Nella giovanile baldanza combattè e smascherò i furbi; nel senno virile, accortosi di non potere contrastare alla
piena dell'ignoranza e della malizia unite insieme, se ne trasse fuori, e con amaro sorriso vendicò la verità offesa, e
ne infamò in perpetuo gli offensori."
49
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
"MORTE DI PEREGRINO PROTEO"
Una rabbiosa intenzione satirica trapela da ogni riga della Morte di Peregrino Proteo (Περὶ τῆς Περεγρίνου
τελευτῆς), aspra lettera di denuncia scritta attorno al 170, nella quale Luciano stronca senza riserve la figura
di questo pseudo-martire che si diede fuoco durante le Olimpiadi del 167 di fronte alla folla allibita, della
quale faceva parte lo stesso Luciano.
Mentre Luciano vede in Alessandro di Abunoteico un gran bell'esemplare di ciarlatano, non privo di risvolti
comici e surreali, in Peregrino vede invece il campione del trasformismo dottrinale ed il prototipo del
fanatico religioso: Peregrino era stato cristiano, quindi si era "scristianizzato", era diventato un filosofo
cinico, aveva insultato Antonino Pio (uno dei migliori imperatori che la storia romana ricordi) e criticato
aspramente Erode Attico (esponente della Seconda Sofistica e noto filantropo), ed infine per protesta, e per
dimostrare il proprio disprezzo per la morte, si era ucciso gettandosi nel fuoco, insomma aveva
commesso una serie di atti apparentemente inconsulti ed incomprensibili alla luce del razionalismo lucianeo,
ma tutti estremamente gravi, tanto da impedire a Luciano di assumere nei suoi confronti un atteggiamento
ironico e distaccato: prevale e predomina uno sdegno allarmato che è segno della serietà con cui l'autore
affronta il problema del dilagare del fanatismo religioso.
Una vignetta contro il fanatismo religioso, in cui forse Luciano si sarebbe riconossciuto
Ciò che infatti è considerato da Luciano estremamente allarmante non è il fatto in sé che Peregrino si sia
suicidato spettacolarmente, ma il fatto, ben più grave, che il suo assurdo gesto abbia fatto proseliti: infatti,
come ci informa l'autore stesso, il "santone" non solo aveva gabbato una miriade di persone da vivo (primi
fra tutti i Cristiani, dipinti da Luciano come dei terribili sempliciotti), ma si era guadagnato una folla di
fanatici ammiratori anche dopo la sua morte. A Luciano pare che la società del suo tempo sia vittima di una
sorta di allucinazione collettiva, alla quale egli dapprima reagisce con un vivissimo sdegno, infine si
rassegna, accontentandosi di metterla in ridicolo.
Da questo punto di vista la distanza tra Luciano ed il suo contemporaneo Apuleio, come lui fra i massimi
esponenti della Seconda Sofistica, non potrebbe essere più abissale: Apuleio infatti appare totalmente
immerso nel clima irrazionalistico della sua epoca, di cui è un rappresentante tipico, tanto che finirà per
50
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
diventare sacerdote di Iside e per morire in odore di santità, considerato un guaritore e un taumaturgo; un
discorso analogo vale per molti altri rappresentanti della Seconda Sofistica, primo fra tutti Elio Aristìde,
neurolabile, misticheggiante e superstizioso, fanatico adepto del culto di Asclepio; al contrario Luciano è
radicalmente in antitesi con tutte le tendenze più caratteristiche del II secolo d.C., nel quale sembra
veramente essere nato "per sbaglio", risultando da tutti i punti di vista, nonostante il suo enorme successo,
un disadattato.
51
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
LUCIANO E I CRISTIANI
Nella Morte di Peregrino Proteo, come abbiamo visto, Luciano descrive il suicidio di Peregrino, bruciatosi
vivo per protesta durante i giochi olimpici del 167 d.C. Questo strano santone, dai precedenti filosoficoreligiosi alquanto eclettici, era stato anche cristiano: in occasione del suo arresto furono proprio i cristiani a
difenderlo, manifestando così, secondo l'autore, tutta la loro ingenua credulità. Il tono di Luciano nei loro
confronti non è di condanna o di disprezzo, ma piuttosto di compassione: egli non si capacita di come
questa stravagante setta religiosa, fondamentalmente innocua, possa adorare un "sapiente crocifisso" e
credersi immortale.
Si discute da sempre sull'interpretazione del termine σοφιστής usato da Luciano a proposito di Gesù
Cristo: il vocabolo non ha necessariamente un'accezione negativa, ma è piuttosto una vox media; c'è quindi
chi ritiene che esso significhi semplicemente "sapiente", senza connotazioni dispregiative, e chi invece, più
verosimilmente, vi ravvisa un'intenzione ironica (soprattutto per il dissacrante accostamento con il
participio perfetto ἀνεσκολοπισμένον, "crocifisso"), intendendolo nell'accezione moderna di "falso
sapiente", colui che sostituisce al retto ragionare (sillogismo) una parvenza di razionalità (sofisma).
Una raffigurazione di Gesù in cui egli appare ancora imberbe
(dal portale della Chiesa di San Tommaso Apostolo, Caramanico Terme, secolo XIII)
Riporto il brano (Morte di Peregrino 12-13 passim):
Ἕωθεν μὲν εὐθὺς ἦν ὁρᾶν παρὰ τῷ δεσμωτηρίῳ περιμένοντα γρᾴδια χήρας τινὰς καὶ παιδία ὀρφανά, οἱ
δὲ ἐν τέλει αὐτῶν καὶ συνεκάθευδον ἔνδον μετ' αὐτοῦ διαφθείραντες τοὺς δεσμοφύλακας. Εἶτα δεῖπνα
ποικίλα εἰσεκομίζετο καὶ λόγοι ἱεροὶ αὐτῶν ἐλέγοντο, καὶ ὁ βέλτιστος Περεγρῖνος καινὸς Σωκράτης
ὑπ'αὐτῶν ὠνομάζετο. Καὶ δὴ καὶ τῷ Περεγρίνῳ πολλὰ τότε ἧκεν χρήματα παρ' αὐτῶν ἐπὶ προφάσει
τῶν δεσμῶν, καὶ πρόσοδον οὐ μικρὰν ταύτην ἐποιήσατο. Πεπείκασι γὰρ αὑτοὺς οἱ κακοδαίμονες τὸ μὲν
ὅλον ἀθάνατοι ἔσεσθαι καὶ βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον, παρ' ὃ καὶ καταφρονοῦσιν τοῦ θανάτου καὶ
ἑκόντες αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἱ πολλοί. ἔπειτα δὲ ὁ νομοθέτης ὁ πρῶτος ἔπεισεν αὐτοὺς ὡς ἀδελφοὶ
πάντες εἶεν ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ παραβάντες θεοὺς μὲν τοὺς Ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσωνται, τὸν δὲ
ἀνεσκολοπισμένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτὸν προσκυνῶσιν καὶ κατὰ τοὺς ἐκείνου νόμους βιῶσιν·
καταφρονοῦσιν οὖν ἁπάντων ἐξ ἴσης καὶ κοινὰ ἡγοῦνται. ἢν τοίνυν παρέλθῃ τις εἰς αὐτοὺς γόης καὶ
τεχνίτης ἄνθρωπος καὶ πράγμασιν χρῆσθαι δυνάμενος, αὐτίκα μάλα πλούσιος ἐν βραχεῖ ἐγένετο
ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανών.
52
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Fin dall'alba era possibile veder sostare dinnanzi al carcere (= di Peregrino) anziane vedove e bambini orfani, ed i loro
capi, corrotti i carcerieri, trascorrevano perfino la notte con lui dentro il carcere. Poi gli venivano portate cibarie di ogni
sorta e si recitavano per lui le loro preghiere, e l'ottimo Peregrino era considerato da loro un novello Socrate. E per
l'appunto in quell'occasione a Peregrino, con il pretesto del carcere, vennero da loro molte ricchezze, ed egli si procurò
in questo modo una non piccola rendita per l'avvenire. Infatti quegli sventurati (= i cristiani) sono assolutamente
convinti che saranno immortali e che vivranno per sempre, e perciò la maggior parte di essi disprezza la morte e la
affronta volentieri. E poi il loro primo legislatore (= Cristo) li persuase che sono tutti fratelli tra loro, una volta che
abbiano rinnegato gli dèi dei Greci disobbedendo loro e adorino quel sapiente crocifisso e vivano secondo le sue leggi:
dunque disprezzano allo stesso modo tutti i beni terreni e li credono comuni. Perciò, qualora arrivi tra loro un uomo che
sia un abile ciarlatano e che sappia approfittare delle situazioni, in un attimo diventa straricco, beffando quegli uomini
sempliciotti.
53
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
B) POLITICI
L'IRONIA COME ARMA IDEOLOGICA:
MARCO TRAVAGLIO
Abbiamo visto, parlando di Luciano, come l'ironia sia frutto di un'estrema razionalità, indizio di
superiorità intellettuale ed anche di una freddezza emotiva che esclude qualsiasi compromesso e qualsiasi
"empatia" con il bersaglio della propria critica, a costo di risultare presuntuosi ed unilaterali nella propria
visione delle cose.
Mi viene spontaneo un accostamento con Marco Travaglio, che a mio parere ha molto in comune con lo
scrittore greco, ma è più coerente di lui: non si deve dimenticare, infatti, che Luciano smentì
clamorosamente le sue stesse dichiarazioni programmatiche di ostilità nei confronti dell'impero romano
accettando la lucrosa carica di archistator praefecti Aegypti (una sorta di cancelliere): tale incarico rivela le
prestigiose amicizie che Luciano aveva stretto in quel torno di anni ed è in evidente contraddizione con
l'avversione da lui professata nei confronti di coloro che si "vendevano" ai Romani (egli infatti non assunse
mai la cittadinanza romana e critica in modo estremamente aspro i "venduti" nell'opuscolo Su coloro che si
fanno noleggiare). Di tutte queste ambiguità egli cerca di giustificarsi nell'Apologia.
Travaglio è inoltre, a mio parere, un esempio se possibile ancor più perfetto di utilizzo dell'ironia come
arma ideologica: più determinato nel suo zelo di smascheramento delle imposture, più intellettuale nella sua
vena sarcastica, più aristocratico e raffinato nella sua denuncia, più gelido nel suo disprezzo per la
menzogna, meno disposto al compromesso con il potere e meno propenso al sorriso disincantato dell'ultimo
Luciano.
Luciano di Samòsata e Marco Travaglio: si nota perfino una certa rassomiglianza...
Cito come esempio uno dei suoi interventi che hanno suscitato maggiore scalpore negli ultimi tempi,
intitolato "Il fidanzato d'Italia", inserito nella puntata di Annozero del 20 gennaio 2011, visibile a questo
indirizzo: http://arjelle.altervista.org/Tesine/Irene2/alessandro2bis.htm
L'ironia di Travaglio è tagliente come una lama, il suo sorriso è acido, freddo e superiore, mai
compassionevole, la sua satira è sempre politically uncorrect, perché la ricerca della verità, suo unico scopo
dichiarato, non ammette le strizzatine d'occhio, i balletti e le collusioni che inevitabilmente sono connessi con
la cosiddetta "diplomazia", arte in cui i politici sono maestri e che spesso si identifica direttamente con la
menzogna e il raggiro.
54
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
C) STORICO-ARTISTICI
RENÉ MAGRITTE, L'IRONIA COME DEPISTAGGIO
Lirico e sognante, il belga René Magritte (Lessines 1898 - Bruxelles 1967) fu artista perennemente in bilico fra
la notte e il giorno, fra il terso e limpido equilibrio della sua lucida stesura pittorica e l’ombrosa inquietudine
delle sue ossessioni visive, sempre controllate, comunque, da una sottile ed elegante ironia. Ripercorrere la
vicenda biografica dell’artista belga significa scoprire che la sua pittura è stata una sorta di vita parallela
vissuta in un'affascinante dimensione intermedia tra sogno e realtà, tra fantasia e memoria.
Il pittore, che non amava le biografie, andava affermando che l’opera di un artista deve smentire la sua vita,
o meglio, deve farla mentire: con ciò egli poneva la finzione, ovvero l'ironia, come base e fondamento della
sua arte.
Così gli oggetti-immagini che egli costruisce, e che sono gli elementi strutturali più rappresentativi della sua
arte, vanno probabilmente interpretati come surrogati della sua fantasia, proiezioni fantasmatiche attraverso
cui dipinge la propria interiorità, senza necessariamente doverla illustrare, in alcuni casi vere e proprie
sostituzioni liberatorie dei fatti più dolorosi della sua storia (primo fra tutti il trauma della morte della
madre, che si tolse la vita quando René era solo tredicenne).
René Magritte nel 1967 davanti ad un suo quadro
Quieto e introverso, Magritte incarna l’esponente tipico di un esercizio di “ricognizione dell’anima” che
avviene nello spazio limitato della propria stanza, alla ricerca di un’identità che si concretizza nella pittura.
André Breton, principale artefice e organizzatore del movimento surrealista e amico del pittore, credeva nel
“futuro risolversi di due stati, in apparenza contraddittori, sogno e realtà, in una specie di realtà assoluta, di
surrealtà”; Magritte, in tutta la sua copiosa produzione artistica, rimase sempre coerente con questa linea di
ricerca, realizzando opere caratterizzate tra loro da un’inconfondibile unità tecnica e tematica.
Tuttavia il suo approdo ad esiti surrealisti si delinea con tratti di assoluta originalità. Ad una visione
d’insieme, infatti, la sua appare come la storia della ricerca di una grande avventura intellettuale certamente
debitrice nei confronti delle suggestioni del mondo surrealista, ma, in verità, largamente indipendente da
esse. Un'avventura intellettuale prevalentemente indirizzata ad un’indagine espressiva che si svolge con
55
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
lenta e continua coerenza in una parabola solitaria, nutrita degli apporti più diversi, ma vigilati da una
mente lucida e razionale, capace di un distacco ancora una volta tutto ironico, anche se dominata da un
flusso irruente di ispirazione.
Fondamentale è stato l’incontro spirituale di Magritte con la Metafisica di De Chirico, in particolare con
l’opera Il canto d’amore del 1914, riprodotto qua sotto, dipinto nel quale il maestro vide liberate le idee sulla
pittura che fino a quel momento egli aveva avuto in mente.
Fortemente sedotto dal senso enigmatico del mistero che permeava il dipinto del maestro italiano, egli
comprese, come in un’improvvisa epifania, quale dovesse essere il linguaggio attraverso cui esprimere il
proprio mondo interiore. Fu questo, di fatto, il vero punto di partenza del percorso che Magritte sviluppò
in maniera del tutto personale e unica e che lo condusse a condividere il progetto surrealista in modo tanto
originale.
Enigmatici uomini vestiti di nero, oggetti che perdono la loro funzione quotidiana perché messi in relazione
tra loro in modo da stravolgere l'idea comune a noi nota, cieli azzurri attraversati da candide nuvole
irrealmente immobili, illusioni spaziali ai limiti dell'assurdo: sono queste le immagini ricorrenti che il
maestro dipinge attraverso l’utilizzo di una tecnica pittorica meticolosa, quasi fotografica, vicina al
metodico realismo di sapore accademico.
Una simile tecnica è in sé ironica: creando un'illusione di tipo visivo, strettamente legata alla percezione
ottica dell'oggetto rappresentato, e smentendola nelle scelte compositive, nelle incongruenze di un mondo
da lui composto e ricomposto in una dimensione quasi allucinatoria, egli suscita un profondissimo senso di
sconcerto e di spaesamento nello spettatore.
Questo aspetto concettuale, analitico, sotteso alla pittura magrittiana, eserciterà una sostanziale influenza su
alcuni movimenti artistici del Novecento come la pop art o la stessa arte concettuale. Si ricordi, a questo
proposito, che la mostra dedicata all'artista belga organizzata a New York intorno alla metà degli anni
cinquanta fu determinante per artisti quali Andy Warhol, Robert Rauschenberg e Jasper Johns.
Anche la pubblicità e i mezzi di comunicazione di massa devono moltissimo a Magritte per la sua
capacità di inventare immagini raffiguranti idee: non a caso l'universo magrittiano evoca suggestioni che in
larga parte appartengono all'immaginario collettivo.
Rappresentando soggetti tratti dalla realtà quotidiana in rapporti e contesti insoliti, Magritte realizza dipinti
pervasi da una sottile inquietudine. Grazie a un’aura di umorismo e di assurdo, alla costante ironia che le
56
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
pervade e che impedisce di prendere sul serio la realtà rappresentata (ma anche quella che funge da
referente), le opere di Magritte approdano ad una sorta di "realismo magico".
La vena ironica di Magritte è evidente soprattutto nelle sue versioni surreali di dipinti famosi; un esempio
famoso è la sua Madame Récamier de David del 1950, che, parodiando il celebre ritratto realizzato da
Jacques-Louis David nel 1800, raffigura una bara adagiata sul divano.
57
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Ma anche nella vita quotidiana Magritte era dotato di un umorismo caustico e piuttosto volgare: alla
domanda «Come sta?» gli piaceva rispondere «Come vuole lei»; inoltre amava terminare le lettere con un
affettuoso «buona inculata».
Fedele alla sua vena sarcastica e beffarda, egli si creò nel 1948 a Parigi il cosiddetto periodo «Vache», una
sorta di parodia del fauvismo. I dipinti appartenenti a questo periodo “Vache”, di tendenze fauviste, furono
realizzati negli anni della seconda guerra mondiale, e furono caratterizzati dai colori accesi e la cui tecnica
ricorda il modo di dipingere di Renoir.
Tuttavia, sempre nel 1948, Magritte eseguì un gruppo di dipinti e acquerelli chiaramente diversi dal resto
della sua produzione, in particolare per una mostra personale a Parigi, per farsi beffe dei parigini che
avevano impiegato tanto tempo per capire la sua opera. Sulla base di uno stile nuovo, rapido e aggressivo
particolarmente ispirato a spunti popolari come le caricature e i fumetti, Magritte realizzò in poche settimane
una serie completa di circa trenta opere che causarono autentica indignazione a Parigi. L'artista concepì
deliberatamente la mostra come una provocazione rivolta al pubblico parigino, dipingendo in modo
intenzionatamente crudo, scherzoso, anti-artistico e persino "cattivo", all'insegna del feroce sarcasmo. Eccone
un paio di esempi:
René Magritte, Pom'po Pon Po Pon Pon Pom Po Pon, 1948
René Magritte, La famine, 1948
58
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Considerando sia i soggetti che lo stile, le opere del Période vache non costituiscono un insieme consistente,
ma piuttosto una specie di "patchwork" di diversi pseudo-stili. Questi elementi diventano qualcosa di
comico, di triviale o grottesco che si mescola ad aspetti della cultura popolare visiva. Con numerosi
riferimenti storici Magritte ridicolizza i tradizionali valori culturali e le norme estetiche. Contrariamente a
quanto accade con le sue opere dal taglio più “classico”, in cui primeggiano la precisione e l’aspetto
concettuale, le opere del Période vache ci sorprendono per la loro esplosione cromatica, la loro
bidimensionalità, la velocità di realizzazione e l’assoluta, diretta spontaneità.
Ma Magritte è capace di ironia ben più sottile e raffinata.
Le sue composizioni, ad esempio, suggeriscono interessanti nessi tra il mondo degli oggetti e quello dei
nomi: partendo dalla convinzione che il linguaggio, abitualmente impiegato per descrivere la realtà, non può
in effetti che dare luogo a un’infinita serie di fraintendimenti, Magritte decide di esplicitare questo
paradosso attraverso immagini quanto più possibile riconoscibili, in modo da rendere evidente la loro
intrinseca insufficienza rappresentativa. Il caso più celebre è quello di Ceci n'est pas une pipe.
Le pipe hanno una lunga storia, nell'opera di Magritte: una storia che parte nel 1926. In quell'anno
Magritte aveva già realizzato uno schizzo raffigurante tre forme: una forma astratta, la rappresentazione di
una pipa e la parola pipa.
Ma il tema della pipa conosce la sua massima notorietà nel 1928-29: in quell'anno infatti egli dipinge un
quadro nel quale è raffigurata inequivocabilmente una pipa, ponendo sotto di essa la sconcertante didascalia
Ceci n'est pas une pipe. Il titolo del dipinto è tutto un programma: La trahison des images, ovvero "Il
tradimento delle immagini".
René Magritte, Il tradimento delle immagini (1928-29)
In seguito l'artista belga riproporrà questo tema più volte ed in varie versioni (11 in tutto), ripetendo la
scritta anche in inglese ("This is not a pipe"), con variazioni sul tema ("Questa continua a non essere una
59
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
pipa") e con divertenti picchi di autoironia (come ne Il lume filosofico del 1936), fino ad approdare alla
versione più recente, altrettanto nota rispetto a quella del 1928, risalente al 1966, intitolata I due misteri.
Essa raffigura non una, ma due pipe:
René Magritte, I due misteri (1966)
Una delle due pipe è inquadrata in una tela-lavagna posta su un cavalletto da pittore; l'altra, più grande e
come fatta d'aria e di fumo, fluttua nello spazio e scivola nel vuoto. Al di sotto della prima si legge la scritta:
«Ceci n'est pas une pipe»: «questo non è una pipa», ed a questo punto ci accorgiamo che non si tratta di una
pipa qualunque, ma del dipinto omonimo del 1928-9: non per nulla esso è appoggiato su un cavalletto. Ma
l'altra pipa, quella che fluttua sulla parete, cos'è?
Sul senso della spiazzante ironia implicita nell'uso dell'immagine della pipa associata alla sua
contemporanea negazione verbale molto si è detto e scritto, attribuendo ai dipinti-con-pipa di Magritte un
significato metafisico che forse non hanno; potrebbe trattarsi semplicemente di un geniale scherzo, di un
divertissement senza troppi sovra- o sotto-significati. Forse Magritte, sornione come sempre, se la rideva dello
sconcerto dei critici e dei loro tentativi di decrifrare il "mistero", anzi, il "doppio mistero".
Non bisogna dimenticare una famosa affermazione dello stesso Magritte a tale proposito: "il mistero è la
banalità che accomuna tutte le cose" egli scrive nel 1955; e ancora: "l'amore per l'ignoto equivale all'amore
per la banalità: conoscere significa scoprire la banale conoscenza, agire significa conoscere la banalità dei
sentimenti e delle sensazioni". Anche questa affermazione è in sé enigmatica: che significa che il mistero è la
banalità? Probabilmente l'opposto di quello che sembra significare: banale non è il mistero in sé, ma il nostro
60
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
considerarlo tale e la pretesa di penetrarlo. E' un tema, quello del banale, su cui Magritte torna per precisare
che la natura non deve essere conosciuta. E' la conoscenza che è banale (ed erronea), mentre l'intuizione e
l'evocazione mantengono intorno a loro un'aura di mistero che è propria della natura, la quale può essere
vista solo con l'occhio dell'irrazionalità.
René Magritte, L'inganno delle immagini (1935)
Si capisce dunque quanto poco opportuni possano essere i tentativi di "decifrare" Magritte in chiave
razionalizzante. Tuttavia è il caso di vedere almeno una di queste interpretazioni critiche, contenuta in un
articolo specificamente dedicato a «Ceci n'est pas une pipe» dalla rivista on line Surrealismo. Lo riporto di
seguito.
"La dichiarazione, del tutto superflua per quanto riguarda una qualsiasi riflessione sul linguaggio (chi non
sa, da sempre, che il linguaggio non combacia con la realtà?), ha tuttavia una violenza disarmata tanto più
efficace quanto più sotterranee potevano sopravvivere le tradizioni consolatorie del naturalismo. Peraltro la
sua flagrante banalità, nonché la negazione di un qualcosa che si nega da solo, veicolano sull'immagine una
carica di mistero e di "suspence" interpretativa che ne alimentano la magia. La pipa di Magritte nasce dal
presupposto di non poter essere una pipa, e nello stesso tempo ha ragione di essere solo per il fatto di
evocare l'oggetto reale cui si riferisce.
René Magritte, L'inganno delle immagini (1952)
Michel Foucault sostiene che l'opera vada interpretata come un calligramma di cui Magritte sveli la
frantumazione e la frattura interna. In altre parole l'artista avrebbe preso spunto dalla caratteristica
organizzazione visiva del calligramma, in cui la disposizione dei segni che formano il testo, e che "dicono" la
61
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
cosa di cui si parla, coincide con la forma della cosa stessa: «In quanto segno, la lettera permette di fissare la
parola; in quanto linea, essa permette di raffigurare la cosa». La conseguenza più immediata è data dal fatto
che al cospetto del calligramma il risultato del guardare e del leggere coincidono perfettamente. Tuttavia
tra loro vi è un insopprimibile disaccordo e rimane latente un potenziale conflitto, non del tutto scongiurato
dall'occasionale convergenza tra lo stilema generale della forma e quello della parola. L'uno tende
inevitabilmente a prendere il sopravvento sull'altro, schiacciandolo sul fondo e riducendolo a fantasma, a
realtà volatilizzata.
Nel caso in cui l'occhio si disponga a guardare da lontano, la forma trionfa nella sua organica interezza e la
parola si scioglie nei rivoli dei mille imperscrutabili particolari; quando invece l'occhio s'impegni ad
avvicinarsi al testo per leggerlo, vocale per vocale, consonante per consonante, allora prende corpo la parola
e la cosa che essa raffigura si sfilaccia e si perde nel regno senza forma dei fantasmi.
René Magritte, L'inganno delle immagini (1953)
Magritte, insomma, metterebbe in luce (dopo aver provocato la frattura) il fallimento della congiunzione
del guardare e del leggere: infatti, sia la frase scritta sia la pipa raffigurata conservano, se così si può dire, la
"memoria" di un antecedente calligramma che però ha subito una serie di sollecitazioni, tali da distaccare le
parti, e adesso scrittura e raffigurazione vivono in uno stato di autonomo isolamento, l'una negando all'altra
qualsiasi autenticità e autorità interpretative. Adesso il rumore della battaglia è solo una lontana
reminiscenza e in un ironico silenzio di negazioni reciproche, e di autonegazioni brucianti, quello che non
c'è più è proprio la pipa: essa sta per scivolare via, grigia forma vuota e gigantesca, pronta a involarsi oltre la
cornice:
62
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
La magia e il mistero di questa immagine hanno le loro radici proprio nel principio della perdita, in quel
naufragio dell'interezza e dell'unità del calligramma che metaforicamente innesta un parallelo principio di
scollamento e di vanificazione della realtà. L'oggetto-pipa già si è dipartito sulla linea di un orizzonte
contrassegnato dal limite del pavimento in legno: come una nube di fumo, come un aerostato senza timone.
E però le cose si complicano, perché quello spazio simbolicamente infinito è anche parete, superficie su cui a
sua volta può essere stata tracciata l'immagine, e la grande pipa di fumo è tanto poco pipa come nel caso di
quella dipinta sulla tela-lavagna.
Semioticamente parlando, l'opera appare come un vero e proprio "trattato", in linea con i postulati di de
Saussure [grande linguista svizzero fondatore dello strutturalismo, N.d.R.]. Tutto, o quasi, ricorda il Trattato
di linguistica generale, che peraltro è la vera e propria culla della semiotica. D'altra parte, l'opera si presenta
come una lucida e per così dire fredda evocazione della crisi che attraversa e terremota le certezze del
linguaggio tra la fine del XIX secolo e l'inizio del nostro: da de Saussure a Hoffmansthal, da Rimbaud a
Jarry a Lautréamont, da Seurat a Balla, Boccioni, gli artisti Dada, laddove insomma il mondo reale e quello
dei segni si separano inesorabilmente e il secondo non riesce più ad "affermare" la tangibilità o comunque
la consistenza del primo.
In tal senso le "tavole" pubblicate da Magritte qualche tempo dopo «Ceci n'est pas une pipe», non sono solo
una sorta di "summa" analitica della nuova coscienza antinaturalistica dei linguaggi e della frattura
insanabile che li separa dalla realtà, ma nei vari passaggi sottolineano soprattutto l'eclissi di ogni possibilità
in base alla quale sia dato al mondo dei segni di "affermare", o se volete di sottolineare, gli oggetti cui esso si
riferisce: il segno è autonomo, liberato da ogni vincolo, esso invade e domina il mondo, e più il suo
predominio si rafforza più il mondo svanisce come cipria di farfalla; ma più ancora, e in conseguenza a ciò, il
linguaggio, svuotato da ogni necessità e da ogni funzionalità interpretativa, imitativa o referenziale,
appare a sua volta definalizzato, armatura vuota e allucinante cui manca un corpo capace di impugnare la
spada, la lancia, gli elmi e gli scudi sparpagliati sui tetti dei palazzi aristocratici dell'Europa centrale e
nordica del secolo.
René Magritte, Il lume filosofico (1936),
forse la rivisitazione più surreale e autoironica del tema della pipa
Ciononostante "il mistero" (o "i due misteri") di «Ceci n'est pas une pipe» non consiste nel principio
contraddetto di somiglianza e di affermazione che caratterizzano il rapporto tra i protagonisti principali
dell'opera, la pipa raffigurata e le parole scritte, il loro ironico attestato di non verità e lo scollamento nei
63
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
riguardi del mondo reale e tangibile: il sortilegio dell'opera di Magritte nasce da una concezione spoglia e
disarmata del mistero e dal fatto che la sua esistenza si situa per lui al centro del mondo, ne è l'essenza
stessa. Tutto ciò era ampiamente condiviso dall'"esercito" surrealista coagulatosi agli inizi degli anni Venti
attorno a Breton e poi ramifìcatosi attraverso le successive ondate. Ma, al di là delle evidenti diversità degli
esiti, Magritte si distingueva nelle premesse stesse. Se, al pari dei suoi colleghi dell'entourage parigino,
rinuncia alla pittura come finalità e non lavora per ricercare una "modifica" relativa alla specificità strutturale
del linguaggio, egli tuttavia non abbandona il terreno che è il luogo deputato all'attività del pittore;
profondamente europeo, rivendica alla pittura la prerogativa della visione e a questa il primato sulla
realtà. Da un lato egli rappresenta un ramo autonomo rispetto all'ortodossia freudiana del surrealismo
storico; ma da un altro lato ne costituisce la polarità più lucida e precisa, quella che più sottolinea i capisaldi
e i modelli che ne costituiscono la poetica. Nessuno, infatti, è stato in grado, come Magritte, di sorprendersi
prima ancora di sorprendere, di stupirsi "candidamente" prima ancora di stupire. Fatta la debita eccezione
per Max Ernst, che però è e rimane un grande pittore alla ricerca finalizzata di uno stile capace di
combaciare con il mondo delle idee, per il resto nessuno traduce in immagini la naturalezza (la
"naturalità") della magia, del mistero, dello svaporare del mondo come l'artista di Bruxelles. Non
Salvador Dalì, che presto scivola nel "teatro" della metamorfosi e della metafora; non Tanguy, che sterza
verso una germinazione cerebrale di fantasmi desertici, immersi nell'irrealtà di pullulazioni notturne; non gli
altri della prima o delle successive ondate, strette nella tenaglia di un inconscio dispotico destinato a un
consumismo sovrastrutturale che, con l'andare degli anni, diventerà perfino reazionario."
64
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
C) ESISTENZIALI
JOHN VON NEUMANN E LA TRAGICA IRONIA DEL DESTINO
"Dopo aver conosciuto Jancsi von Neumann
mi sono reso conto di quale sia la differenza
tra un matematico di primo livello e uno come me."
(E. Wigner, premio Nobel per la fisica)
Una tragica ironia segna la vita e la morte di John von Neumann, tanto da far pensare che nella sorte che gli
è toccata sia implicita una sinistra logica di contrappasso.
John von Neumann, all'anagrafe János Neumann, è stato una delle menti più brillanti e straordinarie del
secolo appena passato e, per giunta, era anche ungherese, il che, probabilmente, faceva di lui un alieno;
almeno secondo quanto andava dicendo il suo amico e connazionale Leo Szilard. Quest'ultimo, insieme a
Edward Teller, Paul Erdős, Eugene Wigner e allo stesso von Neumann, faceva parte del "clan degli
ungheresi" ai tempi di Los Alamos e del Progetto Manhattan (criptonimo del programma di ricerca
condotto dagli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, che portò alla realizzazione delle prime
bombe atomiche).
Intorno a quello che è forse lo scienziato più famoso del XX secolo dopo Einstein sono sorte delle vere e
proprie leggende, che peraltro hanno tutta l'aria di corrispondere alla realtà: nato a Budapest il 28 dicembre
del 1903 da una ricca famiglia di banchieri ebraici, già a sei anni János era una sorta di fenomeno da
baraccone, che intratteneva gli ospiti di famiglia con la sua prodigiosa memoria, imparando a mente pagine
dell'elenco telefonico o eseguendo a mente divisioni con numeri da otto cifre.
John von Neumann
Non contento, "Jancsi" si divertiva con il padre conversando in greco antico, arrivando a padroneggiare,
intorno ai dieci anni, quattro lingue. Quando vedeva la madre assorta le chiedeva che cosa stesse calcolando;
in bagno si portava due libri, per paura di finirne uno prima di aver terminato i suoi bisogni. Nel 1911 entrò
nel Ginnasio Luterano e le sue capacità matematiche attirarono subito l'attenzione degli insegnanti, e
d'altronde in fatto di bambini prodigio la scuola era già abituata, visto che nella classe superiore a quella di
von Neumann si trovava Eugene Wigner, uno degli alieni. Così Laszlo Ratz, il prestigioso professore di
matematica del ginnasio, si adoperò affinché al giovane Jancsi non mancasse un precettore privato
65
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
universitario che lo seguisse e lo introducesse a poco a poco nell'ambiente matematico. Tra i suoi precettori
va ricordato in particolare Mihaly Fekete. In seguito frequentò contemporaneamente le università di
Budapest e Berlino, e l'ETH di Zurigo: a ventitré anni era laureato in ingegneria chimica ed aveva un
dottorato in matematica.
In questo ambiente ricco di stimoli culturali, di contatti con gli ambienti più colti e influenti della società,
János maturò a poco a poco la convinzione che gli aspetti economici e sociali della società e le relazioni tra
individui possono essere trattati in termini matematici. Questa visione "pan matematica" del mondo
caratterizzerà il pensiero e la vita del giovane genio fino alla fine dei suoi giorni e si tradurrà poi nella
celebre "teoria dei giochi", presentata per la prima volta nel 1927 alla rivista Mathematische Annalen con
l'articolo Sulla teoria dei giochi di società, ma che vedrà la luce ufficialmente nel 1944, quando, insieme a Oskar
Morgenstern, von Neumann pubblicherà un testo destinato a diventare un classico, Theory of Games and
Economic Behavior, che contiene anche la "teoria minimax", secondo la quale in molti giochi, ad esempio gli
scacchi, esiste un algoritmo, il minimax, che permette di scegliere qual è la mossa migliore. Più tardi il
matematico americano John Forbes Nash (nato nel 1928) svilupperà ulteriormente la "teoria dei giochi".
La velocità di pensiero e la memoria di von Neumann divennero ben presto tanto leggendarie che anche
Hans Bethe (premio Nobel per la fisica nel 1967) finì per chiedersi se esse non fossero la prova di
appartenenza ad una specie superiore, che sapeva però imitare bene gli umani. In realtà, il sospetto di
un'origine marziana era esteso non solo a von Neumann, ma a tutto il resto della banda dei figli della
mezzanotte, i coetanei scienziati ebrei ungheresi emigrati. Quando un giorno Enrico Fermi, una delle figure
più importanti all'interno del grande progetto, manifestò un certo scetticismo sull'esistenza di una civiltà
aliena superiore che non fornisse nessun segno della propria esistenza, sembra che Szilard gli abbia risposto
"probabilmente sono già qua, e li stai chiamando ungheresi".
E lì, in mezzo ai massimi scienziati mondiali e agli alieni, John von Neumann era considerato un alieno,
uno di un altro pianeta, un semidio dei numeri. A Los Alamos si raccontava che quando c'era da fare un
calcolo complesso nascesse una sfida a tre tra Feynman, che armeggiava con il suo calcolatore meccanico,
Fermi, che scarabocchiava su un pezzetto di carta, e von Neumann che faceva affidamento solo sulla sua
mente (lo stesso aneddoto si riporta anche a proposito di un altro genio matematico, Ettore Majorana).
Quella mente straordinaria gli ha permesso di apportare contributi significativi, e talora assolutamente
nuovi, praticamente in ogni campo della ricerca, tanto che sarebbe vano elencarli qui: egli lasciò traccia di sé
in àmbiti che vanno dalla matematica alla meccanica statistica, dalla meccanica quantistica alla cibernetica,
dall'economia all'evoluzione biologica, dalla teoria dei giochi all'intelligenza artificiale. E, naturalmente, alla
bomba atomica.
Ma Johnny, come lo chiamavano i suoi colleghi americani, era anche un grande amante della vita, e accanto
alla personalità cinica, spietata e geniale, conviveva apparentemente senza contraddizione alcuna, l'altro
volto dello scienziato ungherese, quello affabile, mai presuntuoso, simpatico, goliardico e pure donnaiolo. I
suoi party erano famosi, numerosi e piuttosto lunghi e, da bravo padrone di casa, egli sapeva intrattenere
amabilmente gli ospiti con un repertorio vastissimo di barzellette e storielle, naturalmente in molte lingue.
Il 1944 è per von Neumann un anno di svolta: non solo, come s'è detto, pubblica la sua "teoria dei giochi", ma
viene anche a conoscenza da un suo collega, Herman Goldstine, impegnato nel Progetto Manhattan, dei
tentativi effettuati presso il laboratorio balistico di costruire una macchina capace di trecento operazioni al
secondo.
Johnny, l'alieno, rimane profondamente colpito da questa cosa e dentro alla sua mente si aprono come per
magia nuovi e affascinanti scenari.
Il primo incontro con un calcolatore risale a poco tempo dopo, con la macchina Harvard Mark I (ASCC) di
Howard Aiken, costruita in collaborazione con l'IBM; poi conosce ENIAC (Electronic Numerical Integrator
And Computer), un ammasso enorme di valvole, condensatori e interruttori da trenta tonnellate di peso,
costruita da Presper Eckert e John Mauchly.
Questo mastodonte è utile per eseguire calcoli balistici, meteorologici o sulle reazioni nucleari, ma è
fondamentalmente una macchina molto limitata, quasi del tutto priva di memoria e di un briciolo di
elasticità; in altre parole, una macchina stupida. Per migliorare un simile marchingegno c'e bisogno di
quell'intuizione che una decina d'anni prima aveva avuto Alan Turing nel suo articolo sui numeri
computabili, e cioè permettere al computer di modificare il proprio comportamento, o, in altre parole,
66
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
imparare un software. Nel 1945 nasce così l'EDVAC (Electronic Discrete Variables Automatic Computer), la
prima macchina digitale programmabile tramite un software: è nata "l'architettura di von Neumann".
Naturalmente il merito dell'invenzione, come il nome dell'architettura fa pensare, va tutto allo scienziato
ungherese, mentre passano in subordine Turing (autore dell'idea), Eckert e Mauchly (che l'avevano
realizzata).
Ma gli anni della guerra vedono von Neumann soprattutto profondamente coinvolto nel progetto
Manhattan per la costruzione della bomba atomica; è un coinvolgimento alimentato da un profondo odio
verso i nazisti, i giapponesi e successivamente verso i sovietici. Già nel 1937, dopo aver ottenuto la
cittadinanza statunitense, gli viene proposto di collaborare con le forze armate, e da quel momento la sua
escalation ai vertici delle istituzioni politico-militari non conoscerà più soste.
E qui la sua personalità incomincia a rivelare risvolti veramente inquietanti: von Neumann è preso da una
sorta di frenesia, una smania, una vera e propria sbornia di carneficina, che è difficile spiegare alla luce delle
sole convinzioni politiche; come nella storia dell'apprendista stregone di Goethe, von Neumann mette in
moto meccanismi di spaventosa portata, gioca con le potenze della Natura, in un certo senso si crede Dio, si
sostituisce a Lui anche in veste di giustiziere. Un vero e proprio delirio di onnipotenza.
John von Neumann e l'EDVAC
È von Neumann a suggerire come deve essere lanciata la bomba atomica per creare il massimo danno e il
maggior numero possibile di morti, è lui che interviene nella costruzione della bomba al plutonio
realizzando la cosiddetta "lente al plutonio", ed è ancora lui a incentivare la costruzione di ordigni nucleari
sempre più potenti. Ma si spinge oltre, proponendo alle autorità militari di bombardare preventivamente
l'Unione Sovietica per scongiurare il pericolo rosso. La sua teoria dei giochi viene pesantemente utilizzata in
questo contesto, per studiare e ipotizzare tutti i possibili scenari bellici che si potevano sviluppare in seguito
a certe decisioni.
Il fervore con cui John appoggia lo sviluppo degli ordigni atomici lo spinge a seguire di persona alcuni test
sulle armi nucleari nella seconda metà degli anni quaranta, che raggiungeranno l'apice con l'esplosione
della bomba H nelle Isole Marshall nel 1952.
Ma ecco subentrare l'imponderabile gioco della sorte, che interviene, a detta di Erodoto, ogni qual volta
l'uomo oltrepassa la misura a lui consentita, commettendo così ὕβρις: come il Creso erodoteo, così anche
von Neumann credeva di poter dominare interamente il proprio e l'altrui destino; e come Creso, anch'egli
verrà abbattuto con una perfida ironia che gli ritorcerà contro le sue certezze: infatti, con ogni
67
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
probabilità, saranno proprio le radiazioni sprigionate da questi test, alle quali egli si espone
volontariamente, a condannarlo a morte.
Nello stesso anno dell'esplosione della bomba H, von Neumann viene nominato membro del General
Advisory Committee della potente AEC (Atomic Energy Commission) e consigliere della CIA (Central
Intelligence Agency, l'agenzia statunitense per lo spionaggio all'estero). Tre anni più tardi diventa membro
effettivo dell'AEC. Nel pieno della Guerra Fredda, a metà degli anni Cinquanta, si impegna al massimo per
appoggiare la costruzione del missile balistico intercontinentale (ICBM) Atlas che, successivamente e per
fortuna, servirà a scopi ben più nobili della guerra; un Atlas modificato, infatti, porterà John Glenn nello
spazio nel 1962.
Ma il male incombe: gli viene scoperto un tumore alle ossa che lo costringe ben presto sulla sedia a rotelle;
questo non gli impedisce di seguire di persona le riunioni strategiche con i militari, mentre si dedica a nuovi
studi che riguardano programmi capaci di autoriprodursi e che lui chiama automi cellulari. La malattia però
è inarrestabile, e il geniale Johnny, colui che sapeva godere della vita, che amava le donne e le belle auto (che
puntualmente sfasciava tutte le volte) si trova impotente di fronte al dolore e alla morte. La malattia lo coglie
del tutto impreparato, e la consapevolezza del declino delle proprie facoltà intellettive è più di quanto possa
sopportare. E alla decadenza fisica subentra quella psicologica, con crisi isteriche, pianti irrefrenabili e grida
di terrore durante la notte. S.J. Heims, un suo biografo, scrive: "Johnny von Neumann che tanto
profondamente aveva saputo godere la vita, non sapeva come morire".
Spiato da infermieri e agenti, e confortato da pochi amici che gli saranno vicini fino all'ultimo, come Wigner,
Johnny von Neumann, l'alieno, muore l'otto febbraio del 1957.
Quello che in assoluto colpisce di più, in questa come in altre storie di grandi geni del Novecento, è
l'incredibile sproporzione tra la grandezza intellettuale e la piccolezza morale, per non dire l'infantilismo,
di cui alcuni di essi hanno dato prova. Per fare un esempio fra i tanti, il confronto tra il comportamento di
Socrate e quello di von Neumann di fronte alla morte è veramente impietoso, e pone il serio problema di
cosa significhi "essere grandi". Von Neumann, che aveva progettato e pianificato a tavolino, con lucida e
spietata freddezza, lo sterminio di centinaia di migliaia di persone, e che quindi sapeva bene che si deve
morire, non sapeva di dover morire. Simile in questo ad Alessandro Magno, considerava la morte un
accidente riservato solo agli altri.
La vicenda impressionerà Stanley Kubrick a tal punto da indurlo ad ispirare - pare - proprio a von
Neumann la figura dello scienziato pazzo e guerrafondaio protagonista del suo film-capolavoro Il dottor
Stranamore del 1964. Non tutti sono d'accordo sull'identificazione: Merkwürdigliebe, il suo nome tedesco,
ha fatto pensare ad Herman Kahn e Wernher von Braun; alcuni critici hanno voluto riconoscere in
lui atteggiamenti e tic dell'altro scienziato ungherese fuoruscito Edward Teller, padre della bomba H;
tuttavia quel suo scorrazzare con la sedia a rotelle in compagnia dei militari a decidere le sorti del mondo
assomiglia innegabilmente alla figura dell'alieno mago dei numeri che abbiamo imparato a conoscere.
Il film gioca la carta di un esilarante sarcasmo che colpisce il delirio di onnipotenza degli scienziati e degli
uomini di potere e soprattutto il loro terribile infantilismo morale, raffigurandoli come bambini che giocano
con strumenti di cui non sono assolutamente in grado di controllare gli effetti.
Una delle scene più celebri del film è visibile qui:
http://arjelle.altervista.org/Tesine/Irene2/vonneumann2.htm
68
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
D) STORICI
IRONIA COME HYBRIS: HIROSHIMA E NAGASAKI
Se il nazismo è un fenomeno essenzialmente "tragico", in cui tutto si svolge all'insegna della più tremenda
serietà, ciò che al contrario colpisce nell'atteggiamento statunitense nei confronti della guerra è l'atmosfera
scherzosa, quasi goliardica con cui gli USA sembrano affrontare le vicende belliche, in particolare durante la
seconda guerra mondiale.
Come sappiamo, l'ironia è sempre connessa con un senso di superiorità intellettuale, che esclude emozioni
e sentimenti e crea una inevitabile intercapedine di distacco rispetto agli oggetti di cui si ride, impedendo
che si crei qualsiasi empatia con la sofferenza altrui. Forse questo è in qualche modo necessario per poter
agire con la necessaria freddezza, ed inoltre probabilmente lo scherno nei confronti degli avversari fa parte
delle "esibizioni di muscoli" che sono tipiche delle competizioni e delle guerre e che servono anche a tenere
alto il morale delle truppe; tuttavia, nel caso di carneficine come quelle di Hiroshima e Nagasaki, sentirsi
"superiori" e indifferenti fino a scherzarci su è indice di vero e proprio disprezzo nei confronti della vita
altrui. I Greci avrebbero qualificato questo atteggiamento come intollerabile arroganza, ὕβρις.
Inutile tentare di giustificare tutto questo con la necessità di porre fine al più presto al conflitto, alla follia
nazista ed alla resistenza giapponese, come da sempre fa la storiografia "allineata" con la propaganda
filoamericana: la motivazione non regge.
Cito dal blog di "Lameduck": «"Muso giallo" (in inglese "gook") era l'appellativo con il quale venivano
chiamati negli Stati Uniti i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale e che abbiamo conosciuto
attraverso i film americani di guerra: "ok, ragazzi, portiamo questo baby a fottere quei dannati musi gialli e
torniamo a casa".
"Go Ahead, Please - Take Day Off!" ("Va' avanti così, perdi tempo!"):
è l'ironico invito rivolto da un giapponese agli statunitensi
in un famoso manifesto americano di propaganda anti-giapponese del 1941-1945.
Creatore: Office for Emergency Management
69
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Lo stesso appellativo razzista era servito in precedenza per altri "gialli" come i cinesi che a migliaia avevano
costruito le ferrovie dell'Ovest a mani nude e in seguito per coreani e vietnamiti, i nemici della ventennale
guerra indocinese. I cittadini americani di origine giapponese, in seguito all'attacco di Pearl Harbor, furono
rinchiusi in campi di concentramento e privati dei fondamentali diritti civili solo perchè appartenenti alla
stessa etnia di chi aveva dichiarato guerra agli Stati Uniti. La Guantanamo di allora, in pratica, e su ancor più
larga scala.
L'attacco di Pearl Harbor, tra l'altro, non fu poi così proditorio come si è sempre creduto. Tra il 2000 e il 2001
uscirono diversi libri di storici che raccontavano come l'attacco fosse stato non solo previsto ma in qualche
modo incoraggiato o "lasciato accadere" dalle autorità americane, in modo da avere un pretesto per entrare a
tutto campo in guerra e bypassare il tradizionale isolazionismo e non interventismo del popolo americano.
Sembra incredibile ma se fosse per il popolo americano gli Stati Uniti sarebbero il paese più pacifista del
mondo.
Se il bombardamento criminale di Dresda e di altre città tedesche fu semplicemente oscurato dalla storia e
fatto dimenticare, sul bombardamento atomico del Giappone, per decenni, si è tentato di indorare la
pillola: era un attacco necessario, la bomba ha impedito l'invasione di un paese fiero e indomito che
avrebbeo comportato un milione di morti, è stato il male minore. Balle. La guerra era praticamente già finita
anche per il Sol Levante, nell'agosto del '45, dopo la resa della Germania e la fine della guerra in Europa l'8
maggio.
I bombardamenti convenzionali avevano già fiaccato il morale dei giapponesi e devastato le città più
importanti come Tokyo. Il popolo era stremato. Il Giappone era pronto a firmare la resa con l'Unione
Sovietica. Per evitare che il Giappone passasse sotto l'influenza dell'ormai già nuovo nemico e per dare una
prova di forza ai russi la bomba fu scelta come botto finale di una fiera dell'orrore che aveva già riempito
il mondo di mostruosità.
Un altro manifesto americano di propaganda anti-nipponica
raffigurante un "Tokyo kid"
70
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Fu un atto dimostrativo di forza e come tale barbaro e incivile. Barbaro anche perché probabilmente ci fu
chi pensò che dopo tutto quello era il posto ideale per testare gli effetti della bomba, visto che quelli erano
solo musi gialli.»
Penso che "Lameduck" abbia ragione: l'elemento rivelatore è proprio l'ironia, il cinico disprezzo nei
confronti dei civili giapponesi sterminati senza pietà. I fatti in sé sono già abbastanza terribili, ma forse se ne
potrebbe comprendere, se non condividere, la logica bellica, inclusa la cinica ricerca di un casus belli
attraverso l'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941, a quanto pare largamente evitabile dal presidente
Roosevelt; quello che proprio resta senza giustificazione è il ridere di tutto questo, il farne pretesto per
battute di spirito.
Ne sono un evidente indizio i nomignoli scherzosi con cui gli americani battezzarono le loro micidiali
armi di distruzione di massa ed i loro test nucleari: qui l'ironia suona davvero sinistra, fa un effetto
agghiacciante.
Il primo test per un'arma nucleare fu chiamato "Trinity test": il fisico statunitense Oppenheimer spiegava
l'origine del nome del nome con questi versi di John Donne (Holy Sonnets XIV): «Batter my heart, three
person'd God - Beyond this, I have no clues whatever», ovvero «Percuoti il mio cuore, Dio in tre persone - a
parte questo, non ho altri indizi».
Il "Trinity test" fu condotto dagli Stati Uniti il 16 luglio 1945 nell'ambito del cosiddetto Progetto Manhattan
(criptonimo del programma di ricerca condotto dagli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, che
portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche) ed ha aperto - purtroppo - una nuova era: quella delle
armi nucleari.
Ricostruzione di "Fat Man", la bomba di Nagasaki, tecnicamente una Model 1561 (Mk.2)
Esso riguardava una bomba al plutonio, detta anche bomba atomica o bomba A, simile a "Fat Man", la
bomba che verrà utilizzata dalle forze armate statunitensi per distruggere la città giapponese di Nagasaki. La
bomba del "Trinity test", cioè in assoluto la prima bomba atomica mai realizzata, era chiamata in codice The
Gadget, "L'aggeggio".
La bomba atomica o bomba A è il nome comune della bomba a fissione nucleare incontrollata. Nell'uso
comune talvolta il nome "bomba atomica" è impropriamente esteso ad altre armi nucleari di potenza simile o
superiore, includendo così anche le bombe che utilizzano l'altro tipo di reazione nucleare, la fusione
termonucleare dei nuclei di elementi leggeri. Ma le bombe che utilizzano la fusione termonucleare sono
chiamate più correttamente bombe H o bombe all'idrogeno, o anche raggruppate nella definizione di "armi
termonucleari".
71
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
La prima bomba atomica all'uranio venne invece soprannominata "Little Boy" e fu sganciata sul centro
della città di Hiroshima il 6 agosto 1945. La seconda bomba al plutonio, come ho detto prima, era
denominata in codice "Fat Man" e fu sganciata su Nagasaki il 9 agosto 1945.
I tre bombardieri americani di Hiroshima si chiamavano Enola Gay, dal nome della madre del comandante
Paul Tibbets, The Great Artiste, "Il Grande Artista" (un'allusione al Demiurgo gnostico?), e Necessary Evil,
cioè "Male necessario", un soprannome sinistro e significativo, attribuito peraltro in seguito; questo aereo
non aveva altra funzione che quella di documentare, attraverso una serie di fotografie, gli effetti dell'impiego
dell'arma atomica.
La sorte di Hiroshima fu segnata da un'incredibile sfortuna: fino all'ultimo non fu chiaro quale città colpire;
si pensava a Kokura, ma tutto dipendeva dalle condizioni meteorologiche. Quando gli aerei stavano
volando in ricognizione ricevettero l'ok per bombardare Hiroshima, dato che il cielo sopra Kokura era
troppo coperto per permettere il lancio. Tutti i dettagli erano stati studiati nei minimi particolari e tutto si
svolse così come era stato stabilito a tavolino, a parte - incredibilmente - la scelta del bersaglio.
Alle 08:15 del 6 agosto 1945 Enola Gay lanciò "Little Boy" sul centro di Hiroshima. L'esplosione si verificò a
580 metri dal suolo, con uno scoppio equivalente a 13 chilotoni, uccidendo sul colpo tra le 70.000 e le 80.000
persone. Circa il 90% degli edifici venne completamente raso al suolo.
La città di Hiroshima dopo il bombardamento
Il bombardamento di Nagasaki invece fu caratterizzato da una serie di strani contrattempi che, se da una
parte condannarono la città, dall'altra salvarono la vita a una parte della popolazione. La mattina del 9
agosto 1945 l'equipaggio del bombardiere B-29 Superfortress Bockscar, il bombardiere designato per la
missione, comandato dal Maggiore Charles W. Sweeney, si alzò in volo con a bordo "Fat Man" diretto a
Kokura, l'obiettivo iniziale della missione, ma ancora una volta le nubi non permisero di individuare
esattamente l'obiettivo, e l'aereo venne dirottato sull'obiettivo secondario, Nagasaki. Alle 11:00 l'osservatore
del bombardiere, creduto aereo di ricognizione, sganciò degli strumenti attaccati a tre paracadute: questi
strumenti contenevano dei messaggi diretti al professor Ryokichi Sagane, fisico nucleare che aveva
studiato all'Università di Berkeley insieme a tre degli scienziati "padri" della bomba atomica, perché
informasse la popolazione dell'immane pericolo che stava per correre. I messaggi vennero ritrovati dalle
72
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
autorità militari ma non furono consegnati. Alle 11:02, alcuni minuti dopo aver iniziato a sorvolare
Nagasaki, il comandante decise, in contrasto con gli ordini, di accendere il radar in modo da individuare
l'obiettivo anche attraverso le nubi. Così "Fat Man", che conteneva circa 6,4 kg di plutonio-239, venne
sganciata sulla zona industriale della città. La bomba esplose a circa 470 metri d'altezza a quasi 4 km a
nord-ovest da dove previsto. Questo "sbaglio" salvò gran parte della città, protetta dalle colline circostanti.
Tuttavia il computo delle vittime rimase drammaticamente elevato. Secondo la maggior parte delle
valutazioni, circa 40.000 dei 240.000 residenti a Nagasaki vennero uccisi all'istante, e oltre 55.000 rimasero
feriti.
9 agosto 1945: il "fungo atomico" della bomba sganciata su Nagasaki
Il numero dei morti provocati da "Piccolo Ragazzo" e '"Uomo Grasso" non è mai stato rivelato con
precisione: nel suo libro del 1999, Downfall, lo storico Richard Frank, analizzando diverse fonti e studi,
concluse: "la massima approssimazione del numero di vittime è compresa tra le 100.000 e le 200.000".
Questo numero è sicuramente sottostimato: infatti alle vittime provocate dall'esplosione delle due bombe va
aggiunto l'ingente numero delle persone che morirono in seguito alle radiazioni nel corso dei mesi e degli
anni successivi: circa 340.000 nella sola Hiroshima, cui vanno aggiunti i circa 80.000 di Nagasaki. Un numero
impressionante, di gran lunga superiore a quello riportato nei testi "ufficiali".
Gli effetti e le conseguenze dell'esplosione non furono tutti subito chiari: in un certo senso gli americani
usarono i "musi gialli" per sperimentarli. Le cause immediate di morte furono le macerie causate dalla forza
d'urto dell'esplosione e il fuoco divampato a causa del forte calore; ma furono le radiazioni l'incognita
principale.
A differenza delle altre bombe, quelle convenzionali, la bomba atomica emette infatti grandi quantità di
radiazioni: furono proprio queste a causare i granni più gravi a medio-lungo termine. Penetrando
profondamente nel corpo umano, le radiazioni danneggiarono le cellule, alterarono il sangue, diminuirono
la funzione di generazione del sangue, compromisero polmoni, fegato e altri organi.
I danni da radiazioni variavano considerabilmente a seconda della lontananza dall'ipocentro o dalla
presenza di alti corpi di riparo. Le radiazioni iniziali emesse entro il primo minuto furono letali fino alla
distanza di un chilometro. La maggior parte delle persone in quell'area morirono in pochi giorni. Molti di
73
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
coloro che sembravano rimasti indenni ebbero conseguenze di vario genere e morirono pochi giorni o mesi
dopo.
L'esplosione lasciò radiazione residua nel suolo per un lungo periodo. Di conseguenza, molti di coloro che
entrarono in città dopo l'esplosione alla ricerca di parenti o colleghi di lavoro, nonché coloro che arrivarono
per aiutare i superstiti, ebbero sintomi simili a quelli con esposizione diretta alle radiazioni. Molti di questi
morirono.
Sintomi da radiazioni, onda d'urto e calore apparivano inesorabilmente subito dopo l'esplosione. Questi
comprendevano, oltre alle lesioni esterne, vomito e perdita dell'appetito, insonnia, perdita dei capelli,
vomito di sangue, sangue nelle urine, febbre, disordini mestruali, riduzione di leucociti e eritrociti. Anche
senza lesioni esterne visibili, i sintomi da radiazioni sembravano essere fatali per molti.
I disordini acuti scomparvero verso il dicembre del 1945 e si pensava che gli effetti della bomba fossero
cessati; ma era un'illusione: gli effetti delle radiazioni erano ben lontani dall'essere svaniti.
I due bambini raffigurati nella foto qui sotto, una ragazzina e suo fratello minore, furono fotografati il 6
ottobre 1945. A causa delle radiazioni avevano perso tutti i capelli.
Il fratellino morì nel 1949, quattro anni dopo, e la ragazza nel 1965, addirittura vent'anni dopo, entrambi a
causa degli effetti delle radiazioni.
Al momento dell'esplosione si trovavano in una casetta di legno a circa un chilometro dall'esplosione.
Su catastrofi di questa portata, molto semplicemente, l'ironia non è ammissibile.
74
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
LA BOMBA "H": FISSIONE E FUSIONE
L'ultimo atto della vita di John von Neumann è legato, come abbiamo visto, agli esperimenti condotti nella
seconda metà degli anni quaranta per la realizzazione della "bomba H", un ordigno ancor più micidiale della
"bomba A" sperimentata nel corso della seconda guerra mondiale su Hiroshima e Nagasaki. L'arma letale
progettata dal collega Edward Teller e da lui salutata con entusiasmo, per una terribile ironia della sorte, fu
letale anzitutto per lui: l'eccesso di sicurezza ed un evidente senso di onnipotenza fecero sì che si esponesse
alle radiazioni senza prendere le dovute precauzioni e ne morisse.
Ma vediamo di che si tratta.
La bomba all'idrogeno o bomba H (più propriamente bomba a fusione termonucleare incontrollata, in
gergo "la superbomba") è una bomba a fissione-fusione-fissione in cui una normale bomba atomica (o
bomba A), che serve da innesco, viene posta all'interno di un contenitore di materiale fissile insieme ad
atomi leggeri. Quando la bomba A esplode, innesca la fusione termonucleare dei nuclei degli atomi leggeri;
questo processo provoca a sua volta la fissione nucleare del materiale che la circonda (la reazione di fissione
corrisponde a 2/3 della potenza totale, mentre quella di fusione ad 1/3).
In questo tipo di bomba dunque l'energia liberata deriva, oltre che dalla fissione nucleare, anche dalla
fusione termonucleare fra nuclei di isòtopi diversi dell'idrogeno: il deuterio ed il trizio.
Un isòtopo è un atomo di uno stesso elemento chimico, e quindi con lo stesso numero atomico Z, ma con
differente numero di massa A, e quindi differente massa atomica M. La differenza dei numeri di massa è
dovuta ad un diverso numero di neutroni presenti nel nucleo dell'atomo a parità di protoni (numero
atomico).
Nella fissione nucleare il nucleo di un elemento pesante - ad esempio uranio 235 o plutonio 239 - viene
scisso in frammenti di minori dimensioni, ovvero in nuclei di atomi a numero atomico inferiore, con
emissione di una grande quantità di energia. La fissione viene indotta tramite bombardamento di neutroni:
Fu una donna, la chimica Ida Noddack, ad ipotizzare per prima la fissione dell'atomo nel 1934, mentre i
fondamenti teorici si devono ad un'altra donna, Lise Meitner.
La prima fissione nucleare artificiale (cioè provocata dall'uomo) della storia fu realizzata il 22 ottobre 1934
da un gruppo di fisici italiani guidati da Enrico Fermi (i cosiddetti "ragazzi di via Panisperna") mentre
75
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
bombardavano dell'uranio con neutroni. Il gruppo di fisici italiani però non si rese conto di ciò che era
avvenuto, ma ritenne invece di aver prodotto dei nuovi elementi transuranici. Alla fine del dicembre 1938,
esattamente nella notte tra il 17 e il 18, due chimici nucleari tedeschi, Otto Hahn e il suo giovane assistente
Fritz Strassmann, furono i primi a dimostrare sperimentalmente che un nucleo di uranio 235, qualora
assorba un neutrone, può dividersi in due o più frammenti dando luogo così alla fissione del nucleo. A
questo punto per i chimici e fisici iniziò a prendere forma l'idea che si potesse utilizzare questo processo,
costruendo dei reattori che contenessero la reazione, per produrre energia o degli ordigni nucleari; la prima
bomba atomica esplose il 16 luglio 1945 nel poligono di Alamogordo, in New Mexico.
La fusione nucleare è l'opposto della fissione: due nuclei atomici leggeri (es. idrogeno) si fondono per
formarne uno più pesante, con perdita di massa e quindi con liberazione di energia secondo la famosa
equazione einsteiniena E=mc2. Il processo è analogo a quello che avviene nel Sole.
A rendere particolarmente difficile la fusione nucleare è il fatto che il processo avviene per unione di due
particelle, che per potersi avvicinare devono vincere la naturale repulsione, causata dalle cariche elettriche
uguali. Per avvicinare le particelle bisogna fornire loro molta energia, riscaldando del gas reagente fino alla
temperatura di 50 milioni di gradi.
Nel caso della bomba al deuterio e litio, tale processo avviene secondo una reazione nucleare del tipo:
2
H + 3H
→ He + n + 17,6 MeV
4
Ovvero: da deuterio e trizio si ottengono elio 4, un neutrone e un'energia pari a 17,6 MeV (1 MeV = 1
megaelettronvolt, cioè un milione di elettronvolt), che si manifesta dapprima come energia cinetica del
nucleo di elio 4 e del neutrone prodotti, e quindi si trasforma in energia termica, determinando un rapido
riscaldamento del gas circostante.
Il trizio non è di per sé presente nella composizione iniziale della bomba, ma viene prodotto dall'urto di
neutroni veloci contro nuclei dell'isotopo del litio avente numero di massa 6 e nuclei di deuterio, secondo
queste due reazioni nucleari:
6
Li + n
→ H + He + 4,8 MeV
e
2
H+n
3
4
→ H + 6,2 MeV
3
76
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
La temperatura e la pressione elevatissime necessarie affinché avvenga la fusione termonucleare nonché i
neutroni veloci indispensabili per generare l'idrogeno 3 vengono forniti, come già detto, da una bomba A.
A differenza di quanto accade con la bomba atomica, con quella H non vi è alcuna limitazione teorica di
potenza. Inoltre la bomba termonucleare non necessita di una massa critica, a differenza della bomba A
(con il termine massa critica di un materiale fissile si indica la quantità di tale materiale necessaria affinché
una reazione a catena possa autosostenersi). In realtà, però, essendo necessaria quest'ultima per il processo
di fissione termonucleare, rimane ugualmente la necessità a monte di una massa critica.
La prima bomba H venne sperimentata dagli U.S.A. nel novembre del 1952.
Seguì a ruota l'Unione Sovietica, che sperimentò il suo primo ordigno (alla cui realizzazione molto
contribuì Andrej Sakharov) nell'agosto 1953. Le imitarono il Regno Unito, la Repubblica Popolare Cinese e
la Francia rispettivamente nel 1957, 1967 e 1968.
A differenza della bomba A, la bomba H non è mai stata impiegata in operazioni belliche, e dato il suo
enorme potenziale distruttivo si spera che non lo sia mai.
Il più classico tipo di bombe a fusione è la bomba Teller-Ulam.
E' una bomba a tre stadi (fissione-fusione-fissione) spesso applicata ai missili balistici intercontinentali con
testata nucleare di elevato potenziale e il suo nome deriva dai due scienziati Edward Teller e Stanislaw
Ulam.
Edward Teller
Teller, che faceva parte del leggendario "clan degli Ungheresi" legati al "Progetto Manhattan", è
universalmente considerato il "padre" della bomba H (e per questo è stato spesso chiamato in causa come
ispiratore del personaggio del "dottor Stranamore" di Kubrick), ma deve condividere questo discutibile
merito con Ulam (anche se questo traguardo fu raggiunto, contemporaneamente, anche dal fisico sovietico
Andrei Sakharov). Infatti Ulam, in collaborazione con C.J. Everett, che si adoperò per la parte dei calcoli,
dimostrò che il modello della bomba ad idrogeno proposto da Edward Teller era inadeguato e ne propose
uno migliore: suggerì di posizionare tutti i componenti in un unico contenitore nella bomba H, mettere la
bomba a fissione da una parte e il materiale termonucleare dall'altra ed usare lo 'shock meccanico’ provocato
dalla bomba a fissione per comprimere e poi detonare il materiale da fusione.
Teller rigettò inizialmente tale idea, ma poi ne vide i benefici e suggerì di usare il plutonio come spark
plug, localizzandolo al centro del materiale di fusione per iniziare a scatenare la reazione di fusione. Teller, a
sua volta, modificò l'idea di Ulam sulla compressione, comprendendo che le radiazioni della fissione
nucleare sarebbero state più efficaci del semplice 'shock meccanico'. Questo metodo divenne uno standard
per la creazione di bombe H.
77
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
In questo tipo di micidiale ordigno, la fissione è provocata da una bomba ad implosione; è presente un
involucro esterno (detto tamper) costituito da un cilindro di uranio 238, contenente il solido composto da litio
e deuterio (deuterato di litio) oltre ad una canna vuota di plutonio 239 posta al centro del cilindro. La
necessaria separazione tra la bomba a fissione e il cilindro è permessa da uno scudo in uranio 238 e da una
schiuma che riempie in sicurezza gli spazi vuoti rimasti.
Una volta che la bomba a fissione viene fatta esplodere, si verifica una serie complessa di eventi:
1. i raggi X dovuti allo scoppio della bomba a implosione riscaldano l'intero nucleo, mentre le protezioni
prevengono una detonazione prematura;
2. il riscaldamento provoca un forte aumento di pressione che comprime il deuterato solido;
3. nel frattempo comincia un processo di fissione nella canna di plutonio, il che provoca emissione di
radiazioni e di neutroni;
4. l'urto fra questi neutroni e il composto solido porta alla formazione del trizio;
5. a questo punto si verifica la vera e propria fusione;
6. all'enorme energia e calore appena sviluppati si aggiungono quelli della fissione indotta nei frammenti
di uranio 238 interni all'ordigno (provenienti da cilindro e scudo);
7. le energie prodotte da fissione e fusione si sommano dando vita ad una potentissima esplosione
nucleare, dell'ordine di grandezza di numerosi megatoni.
L'intero processo dura 600 nanosecondi.
Sono quattro i fattori distruttivi dovuti all'esplosione di un ordigno nucleare del genere:
1. onda di calore fino a 320 MK (Megakelvin) in corrispondenza del punto di detonazione;
2. onda d'urto;
3. emissione di radiazioni (direttamente con l'esplosione e tramite successivo fallout radioattivo);
4. effetto EMP (Electro Magnetic Pulse), questo scoperto solo a partire da alcuni test nucleari dei primi anni
sessanta. Esso consiste nella generazione di un forte impulso elettromagnetico che si propaga in tutte le
direzioni come un’onda d’urto e con una intensità che inizialmente era stata sottostimata. Questa onda
d’urto elettromagnetica è in grado di indurre elevate correnti nei dispositivi elettrici e elettronici anche
posti a notevoli distanze. I picchi di corrente in alcuni casi sono di entità tale da generare il calore
sufficiente a portare a temperatura di fusione i circuiti o a interrompere i fusibili. Esiste, quindi, la
potenziale capacità di ottenere pesanti danni su vasti territori, pur senza causare direttamente perdite di
vite umane, ma rendendo inefficienti i sistemi elettrici ed elettronici.
Nel 1961, in una serie di test nucleari, l'URSS fece esplodere la più potente bomba H mai realizzata (la
bomba Zar) che liberò energia pari a 57 megatoni, ovvero oltre 4.500 volte più potente della bomba all'uranio
lanciata su Hiroshima ("Little Boy").
La bomba fu sganciata il 30 ottobre 1961 alle ore 8:33 da un Tupolev Tu-95 opportunamente modificato (il
pilota del quale divenne poi eroe nazionale) nella baia di Mityushikha, sull'isola di Novaja Zemlja, a nord
78
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
del Circolo Polare Artico, e fu fatta esplodere a 4.000 metri dal suolo con l'ausilio di un gigantesco
paracadute finalizzato a frenarne la caduta e quindi a consentire al velivolo di allontanarsi indenne.
La nube a fungo risultante dall'esplosione raggiunse un'altezza di 60 km, l'onda d'urto fece tre volte il giro
del mondo (impiegando per il primo circuito 36 ore e 27 minuti) e il lampo dell'esplosione risultò visibile ad
oltre 1.000 km di distanza. Ci fu anche un black out delle comunicazioni radio di circa 40 minuti in tutto
l'emisfero settentrionale.
79
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
F) SCIENTIFICI
IRONIA MATEMATICA E PARADOSSI
La matematica svela il suo volto beffardo ed ironico nella presenza al suo interno di paradossi ed antinomie.
I due termini vengono spesso usati come sinonimi, ma non lo sono: chiariamo la questione.
Un paradosso, dal greco παρὰ (contro) e δόξα (opinione), è una conclusione che appare inaccettabile perché
sfida un'opinione comune: esso consiste in una proposizione dimostrabile e logicamente coerente, ma
lontana dall'intuizione; l'antinomia, invece, consiste in una vera e propria contraddizione logica.
Si capisce quindi come la seconda sia più grave ed imbarazzante del primo.
Le antinomie matematiche (volgarmente dette paradossi), nonostante la loro apparente marginalità,
sono assolutamente basilari per gli sviluppi di questa disciplina: alcune di esse, infatti, investono gli stessi
fondamenti logici della matematica, andando a mettere in crisi i princìpi primi del retto ragionare e
minando alla base l'intero edificio logico-matematico su di essi costruito.
Di qui l'esigenza di risolvere tassativamente queste antinomie da parte dei matematici.
Di seguito ne prenderò in esame un paio.
Il paradosso di Russell o "paradosso del barbiere"
E' un paradosso che riguarda la teoria degli insiemi.
Bertrand Russell
Bertrand Russell immaginò di suddividere gli insiemi in due categorie:
• Gli insiemi che tra i loro elementi hanno loro stessi;
• Gli insiemi che tra i loro elementi non hanno loro stessi.
Come esempio della prima categoria possiamo prendere "l'insieme di tutti i concetti astratti": essendo esso
stesso un concetto astratto, ha se stesso tra i suoi elementi.
80
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Si suol dire che questi insiemi appartengono a se stessi; il simbolo è:
Come esempio della seconda categoria possiamo prendere quello che usò Russell stesso: "l'insieme di tutte
le tazze da tè". Ebbene, l'insieme di tutte le tazzè da tè non è evidentemente una tazza da tè, per cui l'insieme
non ha se stesso al suo interno.
Si suol dire che questi insiemi non appartengono a se stessi; il simbolo è:
Prendiamo ora in considerazione l'insieme di tutti gli insiemi della seconda categoria (= che non
appartengono a se stessi), che chiameremo R.
Abbiamo:
che si legge: R è l'insieme di tutti gli insiemi tali che l'insieme non contenga se stesso al suo interno.
Il problema posto da Russell a questo punto è:
R appartiene o no a se stesso?
Questa domanda ammette soltanto risposte paradossali. Infatti:
• se R appartiene a se stesso, essendo R l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi,
allora non appartiene a se stesso;
• se R non appartiene a se stesso, essendo R l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se
stessi, allora appartiene a se stesso.
Il simbolo è:
che si legge: R appartiene a R se e solo se R non appartiene a R.
In sintesi, il paradosso di Russell si può enunciare così: l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a
se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. Formalmente,
81
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Caricatura di Bertrand Russell
Il "paradosso di Russell" viene spesso definito "il paradosso del barbiere" e la contraddizione viene
formulata in questi termini:
Il barbiere di un paese fa la barba a tutti quegli uomini del paese che non si fanno la barba da soli. La
domanda è: il barbiere si fa la barba da solo?
• Se supponiamo che si faccia la barba da solo, poiché abbiamo detto che fa la barba solo a coloro che
non si fanno la barba da soli, allora non si fa la barba da solo;
• se supponiamo che non si faccia la barba da solo, poiché abbiamo detto che fa la barba a coloro che
non si fanno la barba da soli, allora si fa la barba da solo.
Il tutto è palesemente assurdo e contraddittorio.
Nonostante tutto questo abbia l'aspetto di uno scherzo innocente, non c'è nulla su cui scherzare: stiamo
parlando dei fondamenti stessi della logica: se questi fanno acqua, allora crolla anche tutto l'edificio
logico-matematico, che, essendo costruito su falsi presupposti, rischia di non avere alcuna validità.
Ne è prova il grande allarme che la scoperta di Russell destò nel mondo matematico.
Il paradosso di Russell e la crisi della Grande Logica
Bertrand Russell approdò alla sua antinomia all'inizio del 1900, semplificando il teorema di Cantor.
Nello stesso periodo il grande logico tedesco Gottlob Frege stava portando avanti un tentativo di fondare
tutta la costruzione della matematica sulla logica, e aveva già pubblicato il primo volume dei suoi Principî
dell'aritmetica.
Il 16 giugno 1902 Russell scrisse a Frege, informandolo dell'antinomia da lui scoperta, connessa con gli
argomenti dei Principî dell'aritmetica, che il filosofo britannico aveva letto circa un anno prima. Il secondo
volume dell'opera di Frege uscì pochi mesi più tardi, nel 1903, e il suo autore poté solo aggiungere
un'appendice in cui rendeva pubblica l'antinomia e confessava il suo sconforto, aprendo la "crisi dei
fondamenti della matematica": "Qui non è in causa il mio metodo di fondazione in particolare, ma la
possibilità di una fondazione logica dell'aritmetica in generale", scrisse desolato Frege.
Nel frattempo, l'antinomia era stata riscoperta da Ernst Zermelo, e va ricordato che era stata anticipata,
pochi anni prima, da Georg Cantor.
82
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Nei primi vent'anni del 1900 altre antinomie contribuirono a mettere in crisi le basi logico-concettuali che la
matematica si era data, e quindi anche il programma di fondare la matematica stessa su basi logiche che
fossero al riparo da qualsiasi contraddizione.
Gottlob Frege
Le contraddizioni messe in luce dal paradosso di Russell sono insolubili nell'ambito della teoria di Cantor
e Frege, se non generando altri paradossi; per superare questo scoglio furono elaborate diverse teorie sui
fondamenti della matematica. Lo stesso Russell cercò di superare la contraddizione posta dalla sua
antinomia, elaborando in seguito, in collaborazione con il filosofo e matematico britannico Alfred North
Whitehead, la teoria dei tipi, basata sull'idea che gli insiemi vadano classificati gerarchicamente, in modo
che un insieme possa essere membro di un altro solo se quest'ultimo è di un tipo più "generale": gli insiemi
venivano distinti in diversi livelli, tali per cui al livello 0 c'erano gli elementi, al livello 1 gli insiemi di
elementi, al livello 2 gli insiemi di insiemi di elementi e così via.
Quella che ebbe più seguito fu però la teoria assiomatica degli insiemi, formulata inizialmente da Ernst
Zermelo e perfezionata da Abraham Fraenkel e Thoralf Skolem, che, con le successive estensioni, fornisce
tuttora la base teorica per la maggior parte delle costruzioni matematiche.
La vecchia teoria degli insiemi (peraltro tuttora largamente utilizzata a livello scolastico e divulgativo) viene
chiamata teoria intuitiva degli insiemi, in contrapposizione alla teoria assiomatica degli insiemi.
Il paradosso di Burali-Forti
Un'altra antinomia che riguarda la teoria degli insiemi è il cosiddetto paradosso di Burali-Forti (da Cesare
Burali-Forti, che lo affermò nel 1897), che dimostra che costruire "l'insieme di tutti i numeri ordinali" porta
ad una contraddizione logica insanabile.
Vediamone il perché.
L'insieme di tutti i numeri ordinali, che chiameremo Ω, possiede tutte le proprietà di un numero ordinale ed
è quindi da considerare a sua volta un numero ordinale. Quindi si può costruire il suo successore Ω + 1. Ma
questo numero ordinale deve essere un elemento di Ω, in quanto Ω contiene tutti i numeri ordinali.
83
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Quindi si giunge a:
.
Un'evidente assurdità logica.
Cesare Burali-Forti
La moderna teoria assiomatica degli insiemi riesce ad aggirare questa antinomia non consentendo la
costruzione di insiemi con formule di comprensione senza restrizione.
Peraltro, è da sottolineare che alcuni celebri matematici come Henri Poincaré e Leopold Kronecker hanno
sollevato serie obiezioni sull'uso della teoria degli insiemi come fondamento per la matematica,
dichiarando che è solo un gioco dotato di elementi di fantasia.
Si suole attribuire ad Henri Poincaré questa affermazione: "la teoria degli insiemi è una malattia da cui la
matematica un giorno si riprenderà". Quanto ad Errett Bishop, egli respinse la teoria degli insiemi
considerandola matematica di Dio e sostenendo che, appunto per questo, dovremmo lasciarla a Dio.
84
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
PERCHE' LA LUNA MOSTRA SEMPRE LA STESSA FACCIA?
Perché la luna ci mostra sempre la stessa faccia?
Uno sprovveduto potrebbe pensare che il nostro satellite ci mostra sempre la stessa faccia perché non ruota,
ma non è affatto vero. La Luna ruota sia intorno alla terra, sia su se stessa. Il motivo per cui vediamo sempre
lo stesso lato è perché sulla Luna il tempo impiegato a compiere un giro su se stessa, chiamiamolo
impropriamente un giorno, è identico al tempo impiegato per fare un giro intorno alla terra che per analogia
al sistema sole-terra, potremmo altrettanto impropriamente chiamare anno. In poche parole, un giorno è
lungo un anno.
Ogni volta che guardo la Luna dalla Terra, questa si sarà ruotata di un certo angolo in modo da mostrarmi
sempre la stessa parte:
Verrebbe da dire: che assurda ironia della sorte! Ma non poteva esserci un po' di differenza tra il giorno e
l'anno lunare, così da vederne tutta la superficie? Siamo davvero sfortunati.
Non è questione di fortuna o sfortuna: è proprio la fisica che impone questa rotazione sincrona.
La risposta sta in una deformazione del campo gravitazionale del sistema terra-luna, ovvero ad un
momento di forze che modifica il momento angolare del nostro satellite. Ma facciamo un passo alla volta.
Tutta colpa della marea
Questo effetto in inglese si chiama Tidal Locking, che possiamo interpretare come sincronia di marea, e si
applica tutte le volte che un corpo astronomico di dimensioni ridotte ruota intorno ad un corpo più
grande, come nel caso del sistema Terra-Luna.
Seguiamo il discorso attraverso tre fasi.
Fase 1: la deformazione della marea
Prendiamo due corpi celesti come per esempio la Terra (T) e la Luna (L), con L che ruota intorno a T, mentre
entrambi ruotano su se stessi in modo non sincrono, cioè il giorno di L è diverso dal suo anno ed un
ipotetico osservatore su T vedrebbe tutta la superficie di L.
85
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
L è molto più piccolo di T e di conseguenza T esercita un'intensa attrazione gravitazionale su L, tanto da
deformarlo. Esagerando l'effetto per renderlo più visibile è come se L si trasformasse da un pallone da
calcio perfettamente sferico in uno da rugby con le due punte posizionate sulla retta che unisce il centro di
L al centro di T.
Queste punte si chiamano onde di marea.
Fase 2: la marea che gira
Abbiamo detto che L, oltre a girare intorno al suo asse, gira anche intorno a T.
Le due creste alte dell'onda di marea (le punte del pallone da rugby) sono sempre orientate lungo la
direzione che unisce i due corpi.
Però L ruota su se stesso: di conseguenza la posizione della deformazione di marea si sposta sulla
superficie di L in modo da rimanere sempre allineata verso il centro di T.
Fase 3: ruotare le maniglie
Consideriamo ora cosa accadrebbe nel caso in cui il giorno lunare fosse più breve dell'anno. Il caso opposto
si risolve in modo del tutto analogo.
La deformazione di L risentirà di una maggiore attrazione verso T
provocando un rallentamento della rotazione di L
Sempre esagerando le dimensioni, possiamo immaginare le sporgenze dovute alla marea come se fossero un
paio di maniglie: come mostrato nella figura qui a fianco, possiamo immaginare come la sporgenza più
vicina a T risenta maggiormente della gravità rispetto agli altri punti della superficie.
86
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Questo agisce come una sorta di freno: nel tentativo di tenere la sporgenza di L il più vicino possibile a T (si
ricordi che le due creste alte dell'onda di marea sono sempre orientate lungo la direzione che unisce i due
corpi), l'intera rotazione di L subirà un rallentamento, fino a quando la deformazione non tenderà né a
precedere né a seguire la rotazione sul proprio asse di L, ovvero fino a quando un giorno sarà lungo
esattamente come un anno.
87
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
APPENDICE
GIACOMO LEOPARDI, OPERETTE MORALI
IL COPERNICO: DIALOGO
Scena prima.
L'Ora prima e il Sole
Ora prima. Buon giorno, Eccellenza.
Sole. Sì: anzi buona notte.
Ora prima. I cavalli sono in ordine.
Sole. Bene.
Ora prima. La diana è venuta fuori da un pezzo.
Sole. Bene: venga o vada a suo agio.
Ora prima. Che intende di dire vostra Eccellenza?
Sole. Intendo che tu mi lasci stare.
Ora prima. Ma, Eccellenza, la notte già è durata tanto, che non può durare più; e se noi c'indugiassimo,
vegga, Eccellenza, che poi non nascesse qualche disordine.
Sole. Nasca quello che vuole, che io non mi muovo.
Ora prima. Oh, Eccellenza, che è cotesto? si sentirebbe ella male?
Sole. No no, io non mi sento nulla; se non che io non mi voglio muovere: e però tu te ne andrai per le tue
faccende.
Ora prima. Come debbo io andare se non viene ella, ché io sono la prima Ora del giorno? e il giorno come
può essere, se vostra Eccellenza non si degna, come è solita, di uscir fuori?
Sole. Se non sarai del giorno, sarai della notte; ovvero le Ore della notte faranno l'uffizio doppio, e tu e le tue
compagne starete in ozio. Perché, sai che è? io sono stanco di questo continuo andare attorno per far lume a
quattro animaluzzi, che vivono In su un pugno di fango, tanto piccino, che io, che ho buona vista, non lo
arrivo a vedere: e questa notte ho fermato di non volere altra fatica per questo; e che se gli uomini vogliono
veder lume, che tengano i loro fuochi accesi, o proveggano in altro modo.
Ora prima. E che modo, Eccellenza, vuole ella che ci trovino i poverini? E a dover poi mantenere le loro
lucerne, o provvedere tante candele che ardano tutto lo spazio del giorno, sarà una spesa eccessiva. Che se
fosse già ritrovato di fare quella certa aria da servire per ardere, e per illuminare le strade, le camere, le
botteghe, le cantine e ogni cosa, e il tutto con poco dispendio; allora direi che il caso fosse manco male. Ma il
fatto è che ci avranno a passare ancora trecento anni, poco più o meno, prima che gli uomini ritrovino quel
rimedio: e intanto verrà loro manco l'olio e la cera e la pece e il sego; e non avranno più che ardere.
Sole. Andranno a caccia delle lucciole, e di quei vermicciuoli che splendono.
Ora prima. E al freddo come provvederanno? che senza quell'aiuto che avevano da vostra Eccellenza, non
basterà il fuoco di tutte le selve a riscaldarli. Oltre che si morranno anco dalla fame: perché la terra non
porterà più i suoi frutti. E così, in capo a pochi anni, si perderà il seme di quei poveri animali: che quando
saranno andati un pezzo qua e là per la Terra, a tastone, cercando di che vivere e di che riscaldarsi;
finalmente, consumata ogni cosa che si possa ingoiare, e spenta l'ultima scintilla di fuoco, se ne morranno
tutti al buio, ghiacciati come pezzi di cristallo di roccia.
Sole. Che importa cotesto a me? che, sono io la balia del genere umano; o forse il cuoco, che gli abbia da
stagionare e da apprestare i cibi? e che mi debbo io curare se certa poca quantità di creaturine invisibili,
lontane da me i milioni delle miglia, non veggono, e non possono reggere al freddo, senza la luce mia? E poi,
se io debbo anco servir, come dire, di stufa o di focolare a questa famiglia umana, è ragionevole, che volendo
la famiglia scaldarsi, venga essa intorno del focolare, e non che il focolare vada dintorno alla casa. Per
questo, se alla Terra fa di bisogno della presenza mia, cammini ella e adoprisi per averla: che io per me non
ho bisogno di cosa alcuna dalla Terra, perché io cerchi di lei.
Ora prima. Vostra Eccellenza vuol dire, se io intendo bene, che quello che per lo passato ha fatto ella, ora
faccia la Terra.
88
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Sole. Sì: ora, e per l'innanzi sempre.
Ora prima. Certo che vostra Eccellenza ha buona ragione in questo: oltre che ella può fare di sé a suo modo.
Ma pure contuttociò, si degni, Eccellenza, di considerare quante cose belle è necessario che sieno mandate a
male, volendo stabilire questo nuovo ordine. Il giorno non avrà più il suo bel carro dorato, co' suoi bei
cavalli, che si lavavano alla marina: e per lasciare le altre particolarità, noi altre povere Ore non avremo più
luogo in cielo, e di fanciulle celesti diventeremo terrene; se però, come io aspetto, non ci risolveremo
piuttosto in fumo. Ma sia di questa parte come si voglia: il punto sarà persuadere alla Terra di andare
attorno; che ha da esser difficile pure assai: perch'ella non ci è usata; e le dee parere strano di aver poi
sempre a correre e affaticarsi tanto, non avendo mai dato un crollo da quel suo luogo insino a ora. E se vostra
Eccellenza adesso, per quel che pare, comincia a porgere un poco di orecchio alla pigrizia; io odo che la Terra
non sia mica più inclinata alla fatica oggi che in altri tempi.
Sole. Il bisogno, in questa cosa, la pungerà, e la farà balzare e correre quanto convenga. Ma in ogni modo,
qui la via più spedita e la più sicura è di trovare un poeta ovvero un filosofo che persuada alla Terra di
muoversi, o che quando altrimenti non la possa indurre, la faccia andar via per forza. Perché finalmente il
più di questa faccenda è in mano dei filosofi e dei poeti; anzi essi ci possono quasi il tutto. I poeti sono stati
quelli che per l'addietro (perch'io era più giovane, e dava loro orecchio), con quelle belle canzoni, mi hanno
fatto fare di buona voglia, come per un diporto, o per un esercizio onorevole, quella sciocchissima fatica di
correre alla disperata, così grande e grosso come io sono, intorno a un granellino di sabbia. Ma ora che io
sono maturo di tempo, e che mi sono voltato alla filosofia, cerco in ogni cosa l'utilità, e non il bello; e i
sentimenti dei poeti, se non mi muovono lo stomaco, mi fanno ridere. Voglio, per fare una cosa, averne
buone ragioni, e che sieno di sostanza: e perché io non trovo nessuna ragione di anteporre alla vita oziosa e
agiata la vita attiva; la quale non ti potria dar frutto che pagasse il travaglio, anzi solamente il pensiero (non
essendoci al mondo un frutto che vaglia due soldi); perciò sono deliberato di lasciare le fatiche e i disagi agli
altri, e io per la parte mia vivere in casa quieto e senza faccende. Questa mutazione in me, come ti ho detto,
oltre a quel che ci ha cooperato l'età, l'hanno fatta i filosofi; gente che in questi tempi è cominciata a montare
in potenza, e monta ogni giorno più. Sicché, volendo fare adesso che la Terra si muova, e che diasi a correre
attorno in vece mia; per una parte veramente sarebbe a proposito un poeta più che un filosofo: perché i poeti,
ora con una fola, ora con un'altra, dando ad intendere che le cose del mondo sieno di valuta e di peso, e che
sieno piacevoli e belle molto, e creando mille speranze allegre, spesso invogliano gli altri di faticare; e i
filosofi gli svogliano. Ma dall'altra parte, perché i filosofi sono cominciati a stare al di sopra, io dubito che un
poeta non sarebbe ascoltato oggi dalla Terra, più di quello che fossi per ascoltarlo io; o che, quando fosse
ascoltato, non farebbe effetto. E però sarà il meglio che noi ricorriamo a un filosofo: che se bene i filosofi
ordinariamente sono poco atti, e meno inclinati, a muovere altri ad operare; tuttavia può essere che in questo
caso così estremo, venga loro fatta cosa contraria al loro usato. Eccetto se la Terra non giudicherà che le sia
più espediente di andarsene a perdizione, che avere a travagliarsi tanto: che io non direi però che ella avesse
il torto: basta, noi vedremo quello che succederà. Dunque tu farai una cosa: tu te n'andrai là in Terra; o pure
vi manderai l'una delle tue compagne, quella che tu vorrai: e se ella troverà qualcuno di quei filosofi che stia
fuori di casa al fresco, speculando il cielo e le stelle; come ragionevolmente ne dovrà trovare, per la novità di
questa notte così lunga; ella senza più, levatolo su di peso, se lo gitterà in sul dosso; e così torni, e me lo rechi
insin qua: che io vedrò di disporlo a fare quello che occorre. Hai tu inteso bene?
Ora prima. Eccellenza sì. Sarà servita.
Scena seconda.
Copernico in sul terrazzo di casa sua, guardando in cielo a levante, per mezzo d'un cannoncello di carta; perché
non erano ancora inventati i cannocchiali.
Gran cosa è questa. O che tutti gli oriuoli fallano, o il sole dovrebbe esser levato già è più di un'ora: e qui
non si vede né pure un barlume in oriente; con tutto che il cielo sia chiaro e terso come uno specchio. Tutte le
stelle risplendono come fosse la mezza notte. Vattene ora all'Almagesto o al Sacrobosco, e dì che ti assegnino
la cagione di questo caso. Io ho udito dire più volte della notte che Giove passò colla moglie d'Anfitrione: e
così mi ricordo aver letto poco fa in un libro moderno di uno Spagnuolo, che i Peruviani raccontano che una
volta, in antico, fu nel paese loro una notte lunghissima, anzi sterminata; e che alla fine il sole uscì fuori da
89
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
un certo lago, che chiamano di Titicaca. Ma insino a qui ho pensato che queste tali, non fossero se non ciance;
e io l'ho tenuto per fermo; come fanno tutti gli uomini ragionevoli. Ora che io m'avveggo che la ragione e la
scienza non rilevano, a dir proprio, un'acca; mi risolvo a credere che queste e simili cose possano esser vere
verissime: anzi io sono per andare a tutti i laghi e a tutti i pantani che io potrò, e vedere se io m'abbattessi a
pescare il sole. Ma che è questo rombo che io sento, che par come delle ali di uno uccello grande?
Scena terza.
L'Ora ultima e Copernico
Ora ultima. Copernico, io sono l'Ora ultima.
Copernico. L'ora ultima? Bene: qui bisogna adattarsi. Solo, se si può, dammi tanto di spazio, che io possa far
testamento, e dare ordine a' fatti miei, prima di morire.
Ora ultima. Che morire? io non sono già l'ora ultima della vita.
Copernico. Oh, che sei tu dunque? l'ultima ora dell'ufficio del breviario?
Ora ultima. Credo bene io, che cotesta ti sia più cara che l'altre, quando tu ti ritrovi in coro.
Copernico. Ma come sai tu cotesto, che io sono canonico? E come mi conosci tu? che anche mi hai chiamato
dianzi per nome.
Ora ultima. Io ho preso informazione dell'esser tuo da certi ch'erano qua sotto, nella strada. In breve, io sono
l'ultima ora del giorno.
Copernico. Ah, io ho inteso: la prima Ora è malata; e da questo e che il giorno non si vede ancora.
Ora ultima. Lasciami dire. Il giorno non è per aver luogo più, né oggi né domani né poi, se tu non provvedi.
Copernico. Buono sarebbe cotesto; che toccasse a me il carico di fare il giorno.
Ora ultima. Io ti dirò il come. Ma la prima cosa, è di necessità che tu venga meco senza indugio a casa del
Sole, mio padrone. Tu intenderai ora il resto per via; e parte ti sarà detto da sua Eccellenza, quando noi
saremo arrivati.
Copernico. Bene sta ogni cosa. Ma il cammino, se però io non m'inganno, dovrebbe esser lungo assai. E come
potrò io portare tanta provvisione che mi basti a non morire affamato qualche anno prima di arrivare?
Aggiungi che le terre di sua Eccellenza non credo io che producano di che apparecchiarmi solamente una
colazione.
Ora ultima. Lascia andare cotesti dubbi. Tu non avrai a star molto in casa del Sole; e il viaggio si farà in un
attimo; perché io sono uno spirito, se tu non sai.
Copernico. Ma io sono un corpo.
Ora ultima. Ben bene: tu non ti hai da impacciare di cotesti discorsi, che tu non sei già un filosofo metafisico.
Vien qua: montami in sulle spalle; e lascia fare a me il resto.
Copernico. Orsù: ecco fatto. Vediamo a che sa riuscire questa novità.
Scena quarta.
Copernico e il Sole
Copernico. Illustrissimo Signore.
Sole. Perdona, Copernico, se io non ti fo sedere; perché qua non si usano sedie. Ma noi ci spacceremo tosto.
Tu hai già inteso il negozio dalla mia fante. Io dalla parte mia, per quel che la fanciulla mi riferisce della tua
qualità, trovo che tu sei molto a proposito per l'effetto che si ricerca.
Copernico. Signore, io veggo in questo negozio molte difficoltà.
Sole. Le difficoltà non debbono spaventare un uomo della tua sorte. Anzi si dice che elle accrescono animo
all'animoso. Ma quali sono poi, alla fine, coteste difficoltà?
Copernico Primieramente, per grande che sia la potenza della filosofia, non mi assicuro che ella sia grande
tanto, da persuadere alla Terra di darsi a correre, in cambio di stare a sedere agiatamente; e darsi ad
affaticare, in vece di stare in ozio: massime a questi tempi; che non sono già i tempi eroici.
Sole. E se tu non la potrai persuadere, tu la sforzerai.
Copernico. Volentieri, illustrissimo, se io fossi un Ercole, o pure almanco un Orlando; e non un canonico di
Varmia.
90
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Sole. Che fa cotesto al caso? Non si racconta egli di un vostro matematico antico, il quale diceva che se gli
fosse dato un luogo fuori del mondo, che stando egli in quello, si fidava di smuovere il cielo e la terra? Or tu
non hai a smuovere il cielo; ed ecco che ti ritrovi in un luogo che è fuor della Terra. Dunque, se tu non sei da
meno di quell'antico, non dee mancare che tu non la possa muovere, voglia essa o non voglia.
Copernico. Signor mio, cotesto si potrebbe fare: ma ci si richiederebbe una leva; la quale vorrebbe essere
tanto lunga, che non solo io, ma vostra signoria illustrissima, quantunque ella sia ricca, non ha però tanto che
bastasse a mezza la spesa della materia per farla, e della fattura. Un'altra difficoltà più grave è questa che io
vi dirò adesso; anzi egli è come un groppo di difficoltà. La Terra insino a oggi ha tenuto la prima sede del
mondo, che è a dire il mezzo; e (come voi sapete) stando ella immobile, e senza altro affare che guardarsi
all'intorno, tutti gli altri globi dell'universo, non meno i più grandi che i più piccoli, e così gli splendenti
come gli oscuri, le sono iti rotolandosi di sopra e di sotto e ai lati continuamente; con una fretta, una
faccenda, una furia da sbalordirsi a pensarla. E così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio
suo, pareva che l'universo fosse a somiglianza di una corte; nella quale la Terra sedesse come in un trono; e
gli altri globi dintorno, in modo di cortigiani, di guardie, di servitori, attendessero chi ad un ministero e chi a
un altro. Sicché, in effetto, la Terra si è creduta sempre di essere imperatrice del mondo: e per verità, stando
così le cose come sono state per l'addietro, non si può mica dire che ella discorresse male; anzi io non
negherei che quel suo concetto non fosse molto fondato. Che vi dirò poi degli uomini? che riputandoci (come
ci riputeremo sempre) più che primi e più che principalissimi tra le creature terrestri; ciascheduno di noi se
ben fosse un vestito di cenci e che non avesse un cantuccio di pan duro da rodere, si è tenuto per certo di
essere uno imperatore; non mica di Costantinopoli o di Germania, ovvero della metà della Terra, come erano
gl'imperatori romani, ma un imperatore dell'universo; un imperatore del sole, dei pianeti, di tutte le stelle
visibili e non visibili; e causa finale delle stelle, dei pianeti, di vostra signoria illustrissima, e di tutte le cose.
Ma ora se noi vogliamo che la Terra si parta da quel suo luogo di mezzo; se facciamo che ella corra, che ella
si voltoli, che ella si affanni di continuo, che eseguisca quel tanto, né più né meno, che si è fatto di qui
addietro dagli altri globi; in fine, che ella divenga del numero dei pianeti; questo porterà seco che sua maestà
terrestre, e le loro maestà umane, dovranno sgomberare il trono, e lasciar l'impero; restandosene però
tuttavia co' loro cenci, e colle loro miserie, che non sono poche.
Sole. Che vuol conchiudere in somma con cotesto discorso il mio don Niccola? Forse ha scrupolo di
coscienza, che il fatto non sia un crimenlese?
Copernico. No, illustrissimo; perché né i codici, né il digesto, né i libri che trattano del diritto pubblico, né del
diritto dell'Imperio, né di quel delle genti, o di quello della natura, non fanno menzione di questo
crimenlese, che io mi ricordi. Ma voglio dire in sostanza, che il fatto nostro non sarà così semplicemente
materiale, come pare a prima vista che debba essere; e che gli effetti suoi non apparterranno alla fisica
solamente: perché esso sconvolgerà i gradi delle dignità delle cose, e l'ordine degli enti; scambierà i fini delle
creature; e per tanto farà un grandissimo rivolgimento anche nella metafisica, anzi in tutto quello che tocca
alla parte speculativa del sapere. E ne risulterà che gli uomini, se pur sapranno o vorranno discorrere
sanamente, si troveranno essere tutt'altra roba da quello che sono stati fin qui, o che si hanno immaginato di
essere.
Sole. Figliuol mio, coteste cose non mi fanno punto paura: ché tanto rispetto io porto alla metafisica, quanto
alla fisica, e quanto anche all'alchimia, o alla negromantica, se tu vuoi. E gli uomini si contenteranno di
essere quello che sono: e se questo non piacerà loro, andranno raziocinando a rovescio, e argomentando in
dispetto della evidenza delle cose; come facilissimamente potranno fare; e in questo modo continueranno a
tenersi per quel che vorranno, o baroni o duchi o imperatori o altro di più che si vogliano: che essi ne
staranno più consolati, e a me con questi loro giudizi non daranno un dispiacere al mondo.
Copernico. Orsù, lasciamo degli uomini e della Terra. Considerate, illustrissimo, quel ch'è ragionevole che
avvenga degli altri pianeti. Che quando vedranno la Terra fare ogni cosa che fanno essi, e divenuta uno di
loro, non vorranno più restarsene così lisci, semplici e disadorni, così deserti e tristi, come sono stati sempre;
e che la Terra sola abbia quei tanti ornamenti: ma vorranno ancora essi i lor fiumi, i lor mari, le loro
montagne, le piante, e fra le altre cose i loro animali e abitatori; non vedendo ragione alcuna di dovere essere
da meno della Terra in nessuna parte. Ed eccovi un altro rivolgimento grandissimo nel mondo; e una infinità
di famiglie e di popolazioni nuove, che in un momento si vedranno venir su da tutte le bande, come funghi.
91
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Sole. E tu le lascerai che vengano; e sieno quante sapranno essere: ché la mia luce e il calore basterà per tutte,
senza che io cresca la spesa però; e il mondo avrà di che cibarle, vestirle, alloggiarle, trattarle largamente,
senza far debito.
Copernico. Ma pensi vostra signoria illustrissima un poco più oltre, e vedrà nascere ancora un altro
scompiglio. Che le stelle, vedendo che voi vi siete posto a sedere, e non già su uno sgabello, ma in trono; e
che avete dintorno questa bella corte e questo popolo di pianeti; non solo vorranno sedere ancor esse e
riposarsi, ma vorranno altresì regnare: e chi ha da regnare, ci hanno a essere i sudditi: però vorranno avere i
loro pianeti, come avrete voi; ciascuna i suoi propri. I quali pianeti nuovi, converrà che sieno anche abitati e
adorni come è la Terra. E qui non vi starò a dire del povero genere umano, divenuto poco più che nulla già
innanzi, in rispetto a questo mondo solo; a che si ridurrà egli quando scoppieranno fuori tante migliaia di
altri mondi, in maniera che non ci sarà una minutissima stelluzza della via lattea, che non abbia il suo. Ma
considerando solamente l'interesse vostro, dico che per insino a ora voi siete stato, se non primo
nell'universo, certamente secondo, cioè a dire dopo la Terra, e non avete avuto nessuno uguale; atteso che le
stelle non si sono ardite di pareggiarvisi: ma in questo nuovo stato dell'universo avrete tanti uguali, quante
saranno le stelle coi loro mondi. Sicché guardate che questa mutazione che noi vogliamo fare, non sia con
pregiudizio della dignità vostra.
Sole. Non hai tu a memoria quello che disse il vostro Cesare quando egli, andando per le Alpi, si abbatté a
passare vicino a quella borgatella di certi poveri Barbari: che gli sarebbe piaciuto più se egli fosse stato il
primo in quella borgatella, che di essere il secondo in Roma? E a me similmente dovrebbe piacer più di esser
primo in questo mondo nostro, che secondo nell'universo. Ma non è l'ambizione quella che mi muove a voler
mutare lo stato presente delle cose: solo è l'amor della quiete, o per dir più proprio, la pigrizia. In maniera
che dell'avere uguali o non averne, e di essere nel primo luogo o nell'ultimo, io non mi curo molto: perché,
diversamente da Cicerone, ho riguardo più all'ozio che alla dignità.
Copernico. Cotesto ozio, illustrissimo, io per la parte mia, il meglio che io possa, m'ingegnerò di
acquistarvelo. Ma dubito, anche riuscendo la intenzione, che esso non vi durerà gran tempo. E prima, io
sono quasi certo che non passeranno molti anni, che voi sarete costretto di andarvi aggirando come una
carrucola da pozzo, o come una macina; senza mutar luogo però. Poi, sto con qualche sospetto che pure alla
fine, in termine di più o men tempo, vi convenga anco tornare a correre: io non dico, intorno alla Terra; ma
che monta a voi questo? e forse che quello stesso aggirarvi che voi farete, servirà di argomento per farvi anco
andare. Basta, sia quello che si voglia; non ostante ogni malagevolezza e ogni altra considerazione, se voi
perseverate nel proposito vostro, io proverò di servirvi; acciocché, se la cosa non mi verrà fatta, voi pensiate
ch'io non ho potuto, e non diciate che io sono di poco animo.
Sole. Bene sta, Copernico mio: prova.
Copernico Ci resterebbe una certa difficoltà solamente.
Sole. Via, qual è?
Copernico. Che io non vorrei, per questo fatto, essere abbruciato vivo, a uso della fenice: perché accadendo
questo, io sono sicuro di non avere a risuscitare dalle mie ceneri come fa quell'uccello, e di non vedere mai
più, da quell'ora innanzi, la faccia della signoria vostra.
Sole. Senti, Copernico: tu sai che un tempo, quando voi altri filosofi non eravate appena nati, dico al tempo
che la poesia teneva il campo, io sono stato profeta. Voglio che adesso tu mi lasci profetare per l'ultima volta,
e che per la memoria di quella mia virtù antica, tu mi presti fede. Ti dico io dunque che forse, dopo te ad
alcuni i quali approveranno quello che tu avrai fatto, potrà essere che tocchi qualche scottatura, o altra cosa
simile; ma che tu per conto di questa impresa, a quel ch'io posso conoscere, non patirai nulla. E se tu vuoi
essere più sicuro, prendi questo partito: il libro che tu scriverai a questo proposito, dedicarlo al papa [1]. In
questo modo, ti prometto che né anche hai da perdere il canonicato.
[1]
- Copernico in effetto lo dedicò al Pontefice Paolo III.
92
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
LUCANO
IL PROEMIO DEL BELLUM CIVILE
(versi I 1-66)
Bella per Emathios plus quam ciuilia campos
iusque datum sceleri canimus, populumque potentem
in sua uictrici conuersum uiscera dextra
cognatasque acies, et rupto foedere regni
certatum totis concussi uiribus orbis
5
in commune nefas, infestisque obuia signis
signa, pares aquilas et pila minantia pilis.
quis furor, o ciues, quae tanta licentia ferri?
gentibus inuisis Latium praebere cruorem
cumque superba foret Babylon spolianda tropaeis
10
Ausoniis umbraque erraret Crassus inulta
bella geri placuit nullos habitura triumphos?
heu, quantum terrae potuit pelagique parari
hoc quem ciuiles hauserunt sanguine dextrae,
unde uenit Titan et nox ubi sidera condit
15
quaque dies medius flagrantibus aestuat horis
et qua bruma rigens ac nescia uere remitti
astringit Scythico glacialem frigore pontum!
sub iuga iam Seres, iam barbarus isset Araxes
et gens siqua iacet nascenti conscia Nilo.
20
tum, si tantus amor belli tibi, Roma, nefandi,
totum sub Latias leges cum miseris orbem,
in te uerte manus: nondum tibi defuit hostis.
at nunc semirutis pendent quod moenia tectis
urbibus Italiae lapsisque ingentia muris
25
saxa iacent nulloque domus custode tenentur
rarus et antiquis habitator in urbibus errat,
horrida quod dumis multosque inarata per annos
Hesperia est desuntque manus poscentibus aruis,
non tu, Pyrrhe ferox, nec tantis cladibus auctor
30
Poenus erit: nulli penitus descendere ferro
contigit; alta sedent ciuilis uolnera dextrae.
quod si non aliam uenturo fata Neroni
inuenere uiam magnoque aeterna parantur
regna deis caelumque suo seruire Tonanti
35
non nisi saeuorum potuit post bella gigantum,
iam nihil, o superi, querimur; scelera ipsa nefasque
hac mercede placent. diros Pharsalia campos
inpleat et Poeni saturentur sanguine manes,
ultima funesta concurrant proelia Munda,
40
his, Caesar, Perusina fames Mutinaeque labores
accedant fatis et quas premit aspera classes
Leucas et ardenti seruilia bella sub Aetna,
multum Roma tamen debet ciuilibus armis
quod tibi res acta est. te, cum statione peracta
45
astra petes serus, praelati regia caeli
93
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
excipiet gaudente polo: seu sceptra tenere
seu te flammigeros Phoebi conscendere currus
telluremque nihil mutato sole timentem
igne uago lustrare iuuet, tibi numine ab omni
50
cedetur, iurisque tui natura relinquet
quis deus esse uelis, ubi regnum ponere mundi.
sed neque in Arctoo sedem tibi legeris orbe
nec polus auersi calidus qua uergitur Austri,
unde tuam uideas obliquo sidere Romam.
55
aetheris inmensi partem si presseris unam,
sentiet axis onus. librati pondera caeli
orbe tene medio; pars aetheris illa sereni
tota uacet nullaeque obstent a Caesare nubes.
tum genus humanum positis sibi consulat armis
60
inque uicem gens omnis amet; pax missa per orbem
ferrea belligeri conpescat limina Iani.
sed mihi iam numen; nec, si te pectore uates
accipio, Cirrhaea uelim secreta mouentem
sollicitare deum Bacchumque auertere Nysa:
65
tu satis ad uires Romana in carmina dandas.
Canto guerre più atroci di quelle civili, combattute sui campi d'Emazia (= Tessaglia), e il delitto divenuto
diritto, e un popolo potente che ha rivolto la destra vittoriosa contro le sue stesse viscere, le opposte schiere
dello stesso sangue, e - infranto il patto della tirannia - tutte le energie del mondo sconvolto che lottano per
un misfatto comune, e le insegne che vanno contro le insegne avversarie, e le aquile opposte alle aquile e i
giavellotti minacciosi contro i giavellotti.
Quale follia, o cittadini, quale sfrenato abuso delle armi offrire il sangue latino alle genti nemiche?
Mentre si sarebbero dovuti strappare alla superba Babilonia i trofei italici, mentre l'ombra di Crasso
continuava ad errare invendicata, si decise di intraprendere guerre che non avrebbero avuto alcun trionfo!
Oh, con il sangue che venne versato nelle guerre civili, quanto spazio in terra e in mare si sarebbe potuto
conquistare, là donde sorge il sole, dove la notte occulta gli astri, dove il mezzogiorno arde di ore infuocate,
dove il rigido inverno, incapace di sciogliere il suo freddo anche in primavera, stringe il mare glaciale con il
freddo scitico: sarebbero già stati sottomessi i Seri, il barbaro Arasse e la popolazione, se esiste, che conosce
le sorgenti del Nilo!
Allora, o Roma, se brami tanto una guerra empia, - una volta che avrai sottomesso l'orbe intero alle leggi
latine - allora rivolgi la mano contro te stessa: fino ad ora non ti sono mancati i nemici. Adesso invece, del
fatto che, nelle città d'Italia, le mura delle case diroccate minacciano di cadere e, crollate le pareti, grandi
massi giacciono a terra e non c'è più alcuno che custodisca le abitazioni e soltanto qualche raro abitante vaga
per le antiche città e, ancora, del fatto che l'Esperia sia irta di rovi, senza che l'aratro, per molti anni, abbia
lavorato e che mancano le braccia per i campi che le richiedono, di così grandi sciagure non sei responsabile
né tu, o feroce Pirro, né il Cartaginese: a nessuno è toccato in sorte di penetrare così all'interno con il ferro: le
ferite inferte dalla guerra civile sono le più profonde e inguaribili.
Se però il Fato non ha trovato altro mezzo per l'avvento di Nerone, e se a caro prezzo si apprestano gli eterni
regni per gli dèi, e se il cielo poté servire al suo Tonante (= Giove) solo dopo le guerre combattute contro i
crudeli Giganti, noi, o numi, non ci lamentiamo più: approviamo questi nefandi delitti, giacché essi hanno
avuto tali conseguenze.
Farsàlo sommerga pure di sangue i campi maledetti e se ne sazino i Mani cartaginesi; gli estremi
combattimenti abbiano luogo nella funesta Munda; a questi tristi destini si aggiungano, o Cesare, la fame di
Perugia e il travaglio di Modena e le flotte che si trovano sotto la rocciosa Lèucade e le guerre servili sotto
l'Etna infuocato: ciononostante Roma deve molto alle guerre civili, dal momento che tutto ciò si è realizzato
per te (= Nerone).
94
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Te, allorquando, completato il periodo del tuo soggiorno terreno, salirai - il più tardi possibile - verso gli
astri, accoglierà la sede del cielo che avrai scelto, fra il tripudio dell'universo: sia che ti piaccia impugnare lo
scettro, sia che tu voglia montare sul carro fiammeggiante di Febo e percorrere con il fuoco errante la terra
che non avrà timore del nuovo sole, ogni nume si ritirerà dinanzi a te e la natura ti lascerà il diritto di
decidere quale dio vorrai essere e dove collocare il tuo regno sull'universo.
Ma non scegliere la tua sede nella zona dell'Orsa (= il Polo Nord), né in quella opposta, dove si trova il caldo
polo australe, donde vedresti la tua Roma con una traiettoria obliqua: se tu graverai su una sola parte
dell'etere immenso, l'asse dell'universo sentirà il tuo peso. Equilibra con un'orbita centrale la massa del cielo:
quella zona dell'etere sereno sia libera del tutto e nessuna nube sia di ostacolo dalla parte di Cesare. Allora il
genere umano, deposte le armi, pensi a se stesso, e ogni popolo si ami vicendevolmente: la pace, diffusa per
il mondo, chiuda le ferree porte del tempio di Giano portatore di guerra.
Ma tu per me sei già un dio, e se io, accogliendoti nel mio petto, divengo poeta, non desidero sollecitare il
dio che rivela i segreti di Cirra né distogliere Bacco da Nisa: basti tu a dare forza e ispirazione per un poema
romano.
(Traduzione effettuata dall'insegnante)
95
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
LUCIANO DI SAMOSATA
ALESSANDRO
o
IL FALSO PROFETA
(traduzione di Luigi Settembrini)
Tu forse, o carissimo Celso, credi che mi hai commessa una piccola impresa e lieve, di scriverti la vita di
quell’impostore di Alessandro d’Abonotechia, e mandarti raccolte in un libro le sue furfanterie, ribalderie e
ciurmerie: ma a volerle narrar tutte esattamente saria non minore impresa che scrivere le geste di Alessandro
di Filippo: chè l’uno fu grande in malvagità, quanto l’altro in valore. Pure se vorrai leggere con indulgenza,
ed immaginare le cose che mancano da quelle che io narro, io prenderò per amor tuo questa fatica, e tenterò
di spazzare questa stalla d’Augia, non interamente ma per quanto io posso; e da’ pochi cofani che ne trarrò
fuori tu potrai pensare che smisurata quantità di letame tremila bovi han potuto farvi in molti anni. Mi viene
vergogna per entrambi, e per te e per me: per te che credi degno di esser ricordato e narrato agli avvenire un
uomo scelleratissimo; per me che gitto il tempo a scrivere questa fastidiosa istoria d’un uomo, che avria
meritato non di esser letto dalle persone colte, ma in un grandissimo teatro essere di spettacolo al popolazzo,
sbranato da scimmie e da volpi. Che se qualcuno ce ne vorrà biasimare, noi ci scuseremo con un esempio.
Arriano discepolo di Epitteto, assai riputato tra i Romani, e vissuto di studi quasi tutta sua vita, fece
un’opera simile a questa, e scusa anche noi. Ei non isdegnò di scrivere la vita di Tilliboro ladrone: e noi di
più crudel ladrone farem memoria; il quale non nei boschi e nei monti, ma nelle città ladroneggiava; non
andò correndo la sola Misia e l’Ida, nè depredò poche contrade abbandonate dell’Asia, ma quasi tutto
l’impero romano riempì di sue ladronerie.
Primamente voglio fartene il ritratto, quanto posso al naturale, benchè io non sia troppo buon dipintore.
Della persona (per ritrartene anche le fattezze) era grande e bello, e veramente divino; bianca la pelle, poco
folta la barba, la chioma mescolata di capelli posticci similissimi che nessuno avria potuto distinguere, gli
occhi lucenti e splendenti, la voce dolcissima insieme e sonora, insomma bellissimo, e senza una menda. In
siffatto corpo era un’anima, ed un’indole.... o Ercole scacciamali, o Giove protettore, o Dioscuri salvatori,
meglio venire a mano di nemici ed avversarii che d’un uomo tale! D’intelligenza, di sagacia, d’astuzia era
singolarissimo: avido di sapere, pronto ad imparare, memoria maravigliosa, gran dispostezza alle scienze, in
ogni facoltà superlativo, ma ne usava al peggio; ed essendo padrone di questi nobili istrumenti, tosto superò
i più famosi malvagi, e i Cercopi, ed Euribate, e Frinonda, e Aristodemo, e Sostrato. Egli una volta scrivendo
a Rutiliano suo genero, e parlando di sè modestamente, si paragonava a Pitagora. Oh, mi perdoni quel
sapiente, quella divina intelligenza di Pitagora; ma se egli ci fosse vissuto ora, certamente saria sembrato un
fanciullo a petto a costui. Deh, per le Grazie, non credere che io parli di Pitagora per istrazio, nè che io lo
paragoni a lui per le loro opere somiglianti. Ma se uno raccogliesse tutte le più brutte calunnie sparse intorno
a Pitagora, alle quali io non aggiusto punto di fede perchè son false, pure ei non giungerebbe alla metà delle
ribalderie di Alessandro. Insomma escogita ed immagina una singolare natura d’uomo variamente mista di
bugie, di inganni, di spergiuri, di falsità; facile, audace, temerario, paziente nell’eseguire un proposito,
persuasivo, di maniere autorevoli, maschera d’onestà, sembrante il rovescio di ciò che era dentro. Onde
chiunque lo accostava la prima volta, ne partiva con un concetto di lui, come del più buono, del più
modesto, del più sincero, del più semplice di tutti gli uomini.
Ed oltre a tutto questo stava sempre sul grande, rivolgeva in mente grandi pensieri, faceva vastissimi
disegni. Essendo ancor garzonetto e molto leggiadro, come dalla paglia si conosce il grano, e come ho udito a
dire, fece copia di sè sfacciatamente, e davasi per prezzo a chi lo voleva. Tra gli altri amatori se lo prese un
ciurmatore, uno di quelli che spacciano magie ed incantesimi mirabili, legare e slegare innamorati, fare
sprofondar nemici, trovar tesori, avere eredità. Questi, scorta
l’indole del fanciullo, che prontissimo lo
serviva, ed amava tanto quelle trappolerie, quanto egli amava in lui la leggiadria, prese ad educarlo, e l’ebbe
sempre come discepolo ed aiutatore. Costui pubblicamente faceva il medico, ma sapeva come la moglie
dell’egiziano Toone
96
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Mescere molti farmaci salubri,
E mortiferi molti:
ed ei ne fu erede e successore in tutto. Questo suo maestro ed amatore era Tianeo, parente dal famoso
Apollonio Tianeo, del quale conosceva tutta la maravigliosa impostura. Or vedi in che scuola fu allevato
Alessandro. Il quale come messe barba, morto quel Tianeo, essendo caduto in povertà, e sfioritagli la
leggiadria, donde poteva trarre sostentamento, cominciò a mulinare di grandi cose: e fatta comunella con un
Bizantino compositore di balli e ballerino, assai più malvagio di lui, a nome Cocconate, andavano attorno
strolagando, trappolando, e tondendo i grassi, come nel loro gergo magico essi chiamano il volgo. E tra gli
altri, avvenutisi in una ricca donna di Macedonia, che benchè vecchia sentiva ancora il pizzicor d’amore, si
fecero fare le spese da lei, e l’accompagnarono dalla Bitinia nella Macedonia. Era costei di Pella, terra un dì
fiorente sotto i re Macedoni, ed ora piccola villa con pochi e miseri abitatori. Quivi vedendo certi serpenti
grandissimi, ma innocui e mansueti, per forma che sono allevati dalle donne, dormono coi fanciulli,
calpestati e stretti non fanno alcun male, e succhiano il latte dalla poppa come i bambini (e forse da questi
che abbondano nel paese nacque la favola di Olimpia che quando era gravida di Alessandro si giaceva con
uno di questi serpenti), ne comperano uno bellissimo per pochi oboli.
E di qui comincia la guerra, come dice Tucidide. Come questo paio di ribaldi, audacissimi e prontissimi ad
ogni mal fare, si accozzarono fra loro, facilmente compresero che la vita degli uomini è tiranneggiata da due
grandi cose, dalla speranza e dal timore, e che chi opportunamente può usare di una di queste, tosto diventa
ricco: che ed a chi teme ed a chi spera è necessarissima e desideratissima la conoscenza dell’incerto avvenire:
che così Delfo arricchì, così s’illustrarono Delo, Claro, ed i Branchidi, affollandosi in quei templi gli uomini,
signoreggiati da quei due tiranni della speranza e del timore, e per bisogno di conoscere l’avvenire, vi
sacrificavano le ecatombe, e vi appendevano mattoni d’oro. Ripensando insieme a queste cose, e
mulinandovi sopra, determinarono di stabilire un tempio ed un oracolo. Sperarono che, se questo fosse loro
riuscito bene, tosto sarieno ricchi e felici: e riuscì meglio di quello che s’aspettavano e speravano. Indi
presero a considerare prima in qual luogo stabilirlo, poi il modo del cominciamento. Cocconate opinava che
Calcedonia fosse il caso loro, città di gran traffico, sita fra la Tracia e la Bitinia, non lungi dall’Asia minore,
dalla Galazia, e da tutti gli altri popoli più in là: ma Alessandro preferiva il suo paese, dicendo, come era
vero, che queste imprese debbono essere cominciate e condotte tra genti grosse e sore, quali egli diceva che
sono i Paflagoni di là d’Abonotechia, tutti superstiziosi e sciocchi, per modo che se pur veggono uno che
menandosi dietro un sonatore di flauto, di timpano o di tamburello, predica la ventura con un crivello, come
suol dirsi, tosto tutti gli si affollano intorno a bocca aperta, e lo riguardano come uno degl’immortali.
Fatte alcune batoste tra loro, pur la spuntò Alessandro: ed andati in Calcedonia (che questa città parve loro
fosse pur buona a qualcosa) nel tempio di Apollo, che è antichissimo tra i Calcedonesi, nascondono sotterra
alcune tavole di bronzo, su le quali era scritto, che tra breve Esculapio con suo padre Apollo saria nel Ponto,
ed abiteria in quel di Abonotechia. Trovate opportunamente queste tavole, subito ne fecero spargere la fama
in tutta la Bitinia, nel Ponto, e specialmente in Abonotechia, dove quei gonzi subito risolvettero di rizzare un
tempio, e si messero a cavarne le fondamenta. In questo mezzo Cocconate rimasto in Calcedonia per
iscrivere certe dubbie, voltabili ed oblique risposte dell’oracolo, brevemente si morì, credo, per morso d’una
vipera. Alessandro fa la sua entrata pomposamente, con una gran zazzera a ricci, tunica listata di bianco e di
porpora, mantello tutto bianco, ed una falce in mano, per imitare Perseo, del quale si diceva discendente per
madre: e quei lasagnoni de’ Paflagoni che ne conoscevano il padre e la madre, poveri entrambi ed oscuri,
credevano all’oracolo che diceva:
Progenie di Persèo, caro ad Apollo,
Ecco il divo Alessandro, puro sangue
Che uscì di Podalirio dai lombi.
E questo Podalirio fu un lascivo ed impazzato femminiere che venne da Tricca sino in Paflagonia per giacersi
con la madre d’Alessandro!
S’era anche sparso un altro oracolo della Sibilla, che profetava così:
Sul lido dell’Eussin, presso a Sinope,
97
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Sotto l’impero delle genti ausonie
Nascerà gran profeta in una villa.
Un uno, un trenta, un cinque, ed un sessanta
Formano un cerchio in cui sta chiuso il nome
D’un uom che farà bene a molte genti.
Entrato adunque Alessandro con questa pompa dopo molto tempo nella sua patria, era assai riguardato e
tenuto in gran conto, fingendo egli talvolta di essere agitato da furore divino, e mandando schiuma dalla
bocca: il che gli veniva fatto facilmente masticando radice di strutio, erba usata per tingere, e la schiuma
pareva a quegli sciocchi una cosa divina, e ne spiritavano. Era già stato fatto dalla brava coppia e preparato
un ingegno rappresentante una testa di serpente, in certo modo simile ad una faccia umana, dipinta molto al
naturale, e che mediante certi crini di cavallo apriva e serrava la bocca, donde usciva una lingua di serpente
nera, biforcuta, anche mossa per crini. Aveva egli anche il serpente di Pella, il quale nutrito in casa
nascostamente, doveva a suo tempo comparir su la scena, e rappresentare una parte, anzi la prima parte del
dramma. Dovendo adunque incominciare, macchinò questa ribalderia. Di notte scende nelle fondamenta del
tempio testè cavate, dove era rimasta un’acqua scolatavi dai dintorni o piovutavi, e quivi depone un uovo
d’oca vuotato, con dentro un serpentello nato di fresco; lo nasconde sotto la belletta, e tosto ritirasi.
La mattina appresso corre in piazza, tutto nudo, salvo il pudore copertogli da un cinto dorato, e portando la
sua falce in mano, e scuotendo le chiome sparse, come quegl’invasati che celebrano i misteri di Cibele, monta
sovra un’ara che quivi era, e parla al popolo, dicendo beata la città che tra poco riceverebbe e vedrebbe un
dio. La gente che v’era, e vi corse quasi tutta la città, e femmine, e vecchi, e fanciulli, allibbirono, e si messero
a pregare ed adorare. Ed egli profferendo parole ignote, forse ebraiche o fenicie, stordiva quei poveretti che
non intendevano ciò che ei diceva, se non che spesso vi tramescolava i nomi di Apollo e di Esculapio. A un
tratto corre al futuro tempio, e venuto alla fossa che doveva essere la fonte dell’oracolo, discende nell’acqua,
cantando a gran voce inni ad Apollo e ad Esculapio, e chiamando il dio a venire felicemente nella città: poi
chiede una coppa, ed avutala, in essa prende facilmente con l’acqua e con la belletta quell’uovo, nel quale
egli aveva chiuso il dio, turatone il foro con cera e con biacca; e preso in mano l’uovo, dice: Ecco Esculapio.
La gente guardavano fisi, e si maravigliavano come egli avesse trovato un uovo in una pozzanghera. Ma
quando egli lo ruppe, e nel cavo della mano mostrò quel serpentello, tutti che lo vedevano muovere ed
avvolgerglisi intorno le dita, misero un grido, salutarono il dio, dissero beata la città, e ciascuno a bocca
aperta pregava, e gli chiedevano tesori, ricchezze, sanità, e tutti gli altri beni. Difilato egli si ritrasse a casa,
portando seco l’Esculapiuccio due volte partorito, non una come gli altri, e nato non da Coronide nè da una
cornacchia, ma da un’oca: tutto il popolo lo seguivano invasati e pazzi di speranze. Per alquanti giorni si
stette in casa, sperando, come avvenne, che alla fama trarrebbero tutti i Paflagoni. E poi che la città si fu
piena di genti, che avevano perduto ogni conoscenza e sentimento, non ritenendo di uomini mangiapane
altro che le fattezze, e nel rimanente essendo pecore; egli mostrasi in una cameretta, seduto sovra un letto, in
magnifici paramenti, e tenendosi in seno quell’Esculapio di Pella grandissimo e bellissimo. Il quale essendo
lungo, egli se lo aveva avvolto intorno al collo, una parte gliene stava innanzi nel seno, e la coda strascicava
per terra: e nascostasi sotto l’ascella la testa del serpente pazientissimo, sporgevagli da un lato della barba
quell’altra testa fatta di tela, e che pareva fosse veramente la testa del serpe. Immagina una cameretta non
lieta, nè bene illuminata, ed una moltitudine di uomini sconvolti, turbati, stupiditi, stimolati da speranze; i
quali entrando vedono la gran maraviglia di quel serpentello divenuto in pochi dì un così gran drago, e con
faccia umana, e mansueto. Erano poi costretti ad uscire subito: e prima di vedere bene, erano spinti ed
incalzati da altri che entravano continuamente. Dirimpetto la porta era stata aperta un’uscita, come fecero i
Macedoni in Babilonia, quando sparsasi la voce che Alessandro stava ammalato, stava per morire, tutti
vollero vederlo e dirgli l’ultima parola. E questa mostra non la fece una sola volta quel furbo, ma molte, e
massime se gli capitava qualche ricco nuovo pesce.
Intanto, o mio Celso, se si dee dire il vero, bisogna compatire a quegli uomini grossi ed ignoranti di
Paflagonia e di Ponto, se s’ingannavano toccando il serpente, che Alessandro faceva toccare a chiunque il
volesse, e rimirando a un po’di barlume quella testa che apriva e chiudeva la bocca, con tale un ingegno che
ci avria voluto un Democrito, un Epicuro, un Metrodoro, o un altro con la ragione ben salda contro queste e
simili ciarlatanerie, da non vi prestar fede, ed odorar ciò che era; e se non indovinava il modo, almeno essere
98
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
fermamente persuaso di non conoscere il meccanismo, ma tutto essere un’impostura, e non possibile ad
avvenire. In breve vi accorsero genti di Bitinia, di Galazia, di Tracia, e tutti tornando dicevano di aver veduto
con gli occhi loro nascere il dio, e crescere in ismisurato drago, e di averlo toccato con le mani, e che aveva la
faccia come un uomo: dippiù se ne fecero pitture, sculture, immagini in bronzo ed in argento, e fu messo
anche un nome al dio. Si chiamava Glicone, come per divino comando in due versi aveva detto Alessandro:
Son Glicone, nipote di Giove,
E degli uomini sono la luce.
Come fu giunto il tempo di dare i responsi e di fare i pronostici, per il che egli aveva messi in opera tanti
ingegni, tolse ad imitare ciò che fece Anfiloco in Cilicia; il quale dopo che suo padre Anfiarao morì e
scomparve in Tebe, fuggendo dalla patria e venuto in Cilicia, vi fece buoni guadagni predicendo il futuro, e
vendendo le risposte due oboli l’una. Tenendosi adunque Alessandro a questo esempio, annunziò a tutti
quelli che erano accorsi come il dio darebbe suoi responsi il tal dì, e lo determinò. Comandò che ciascuno
scrivesse ciò che voleva sapere in una carta, cucita in una pezzuola e suggellata con cera, creta, o altra simile
materia: che egli poi prenderebbe le polizze suggellate, ed entrato nel santuario (già era innalzato il tempio e
la scena preparata) farebbe chiamare ad uno ad uno per un banditore e un sacerdote quelli che gliele avevan
date: e udita ogni cosa dal dio, restituirebbe le polizze suggellate come erano con le risposte scritte sotto le
dimande. Quest’astuzia ad un uomo come te, e posso anche dir come me, è chiara: ma quei poveri mocciconi
non ne erano capaci, e la tenevano un prodigio. Conoscendo egli varie maniere di dissuggellare, leggeva le
dimande, vi rispondeva ciò che gli pareva, rinvolgeva, risuggellava, e ridava le polizze: e quei
maravigliavano e dicevan tra loro: Donde avria saputo ciò che io ho scritto nella polizza sì ben sigillata, con
sigilli inimitabili, se egli non fosse veramente un dio che conosce ogni cosa? Ma quali sono queste maniere?
forse tu mi dirai. Dirottele, affinchè tu possa smascherare di tali imposture. La prima è questa, o carissimo
Celso. Con un ago rovente liquefaceva quella parte di cera che era sotto il suggello, che egli spiccava intero:
leggeva, e poi con lo stesso ago riscaldando la cera che era su la pezzuola e quella che serbava il suggello,
facilmente le rappiccava. Il secondo modo si fa con quel che dicesi collirio, che è una preparazione di pece
Brezia, di asfalto, di una pietra diafana polverizzata, di cera, e di mastice. Fatto così il collirio, e riscaldatolo
al fuoco, lo poneva sul suggello che era unto di sputo, e ne prendeva l’impronta. Rassodato il collirio, sciolta
facilmente e letta la polizza, vi riponeva altra cera, e con esso la suggellava come con l’anello. Il terzo modo è
questo: gittava gesso nella colla con cui s’incollano i libri, e formatane una specie di pasta, la metteva così
umida sul suggello, e poi togliendola (che presto secca, e diventa più dura del corno e del ferro) se ne serviva
per tipo. Vi sono ancora molte altre maniere, che non voglio ricordarle tutte per non sembrare fastidioso,
massime a te, che contro i maghi hai scritto un libro bellissimo, utile ed istruttivo, nel quale hai esposte
tante cose e maggiori di queste.
Oracoleggiava adunque e profetava con fine accorgimento tenendosi alto su i generali, toccando solo i
probabili, dando risposte ora oblique e dubbie, ed ora del tutto oscure per farle parere più divine:
consigliava e sconsigliava secondo gli pareva meglio: prescriveva rimedi e cure, conoscendo, come ho già
detto, molti ed utili farmaci: raccomandava specialmente le citmidi, che così chiamava una composizione
ristorante fatta di grasso di capra. Le speranze di guadagni e di eredità ei differiva sempre al poi, e diceva:
questo sarà quando io vorrò, e quando Alessandro mio profeta m’avrà dimandato e pregato per voi. Aveva
stabilito per prezzo d’ogni risposta una dramma e due oboli. E non credere, o amico mio, che così ei facesse
magri guadagni, chè ogni anno ei raccoglieva da settanta in ottantamila dimande, perché ciascuno non si
contentava di una, ma gliene faceva dieci e quindici. E de’ guadagni non usava egli solo, nè se li riponeva,
ma aveva intorno molti cooperatori, servitori, esploratori, compositori di oracoli, facitori di suggelli,
segretari, interpetri, con tutti i quali spartiva secondo il merito di ciascuno. Aveva anche spediti alcuni in
paesi forestieri, a sparger fama dell’oracolo, e contare come egli faceva trovare schiavi fuggitivi, scoprire
ladri, rinvenir tesori nascosti, sanava ammalati, ed aveva anche resuscitati alcuni morti. Onde le genti
piovevano a lui da ogni parte, portando sacrifizi e voti, e doppio prezzo al profeta e discepolo del dio.
Perocchè s’era sparso questo verso dell’oracolo:
Il mio ministro e interpetre onorate.
99
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Chè non mi stanno molto a cuore i doni;
Ma il mio ministro e interpetre fedele.
Ma già molti uomini di senno, come risvegliati da profonda ubbriachezza, si levavano contro di lui, massime
i seguaci di Epicuro, che eran molti; e nelle città a poco a poco s’era scoperta l’astuzia e l’apparato del suo
dramma: onde egli se ne sdegnava fieramente e diceva, che il Ponto era pieno di Atei e di Cristiani, i quali
ardivano di bestemmiare bruttamente contro di lui, e comandava li lapidassero se si voleva far cosa grata al
dio. Intorno ad Epicuro rispose con questo oracolo: dimandandogli uno che fa Epicuro nell’inferno, disse:
Tra catene di piombo sta nel fango.
E ti maravigli che l’oracolo si levò a tanta altezza, vedendo che sennate ed aggiustate dimande gli erano
fatte? Ma ad Epicuro ei faceva guerra implacabile a morte: e con ragione. Con chi più doveva pigliarsela un
impostore, amico de’ prodigi, e nimicissimo della verità, che con Epicuro severo osservatore della natura
delle cose, e solo conoscitore della verità che è in esse? I seguaci di Platone, di Crisippo e di Pitagora gli
erano amici, e stava in pace con loro; ma l’inflessibile Epicuro (come ei lo chiamava) era suo nemico sfidato,
come quello che piglia a riso e giuoco tutte queste cose. E però odiava Amastri fra le città del Ponto, perchè
sapeva che v’erano molti della scuola di Lepido ed altri epicurei: e non diede mai oracoli a nessuno
Amastriano. Una volta che ardì di dare un oracolo ad un fratello d’un senatore, rimase scornato, non
trovando come comporre da sè una risposta conveniente, nè avendo a punto chi gliene suggerisse. Quegli si
lagnava di un male di stomaco, ed ei volendo prescrivergli di mangiare un piede di porco cotto con malve,
disse così:
Malva di porco cuoci in sacra pentola.
Spesse volte, come ho detto, faceva vedere il serpente a chi ne lo pregava, non tutto, ma specialmente la coda
e la parte inferiore del corpo: la testa se la nascondeva nel seno. E volendo far più maravigliare la
moltitudine, promise che lo stesso dio parlerebbe e darebbe gli oracoli senza interpetre. Unì facilmente
alcune asperarterie di grue, ed acconciamente appiccatele per un capo a quella finta testa, per l’altro un
uomo da dietro mandava la voce, e rispondeva alle dimande, e la parola usciva da quell’Esculapio di tela.
Questi oracoli erano detti autofoni, cioè di propria voce, e non si davano a tutti, nè alla rinfusa, ma ai soli
nobili e ricchi, e che portavano di gran doni. L’oracolo dato a Severiano, che dimandò se doveva entrare in
Armenia, fu anche autofono. Esortandolo ad invadere il paese, diceva così:
Poi che i Parti e gli Armeni avrai domati
Sotto l’acuta lancia, tornerai
A Roma ed alle chiare onde del Tebro
Con raggiante corona sulle tempie.
E quando persuaso quel semplice del Celta la invase, e fu vinto, fattogli a pezzi l’esercito da Otriade, egli
tolse quell’oracolo dai suoi comentari, ed invece posevi questo:
L’oste in Armenia non menar, chè tale
Di quegli uomini in gonna, saettando
Morte dall’arco, ti torrà la luce.
Ed escogitò questo bellissimo espediente: quando profetava una cosa che riusciva male, egli la medicava con
un’altra profezia dopo il fatto. Spesso prometteva la sanità agli ammalati gravemente, quei morivano, e
pronto un altro oracolo ricantava il contrario:
Più scampo non cercar dal crudo morbo:
Morte t’è sopra, nè potrai sfuggirla.
100
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Sapendo che gli oracoli di Claro, di Didimo, e di Mallo erano in grande riputazione, li carezzava per farseli
amici, e loro inviava molti che venivano ad interrogarlo. Ad uno diceva:
Va tosto in Claro ad ascoltar mio padre;
ad un altro:
Ai penetrali dei Branchidi appressati,
E odi la voce dei divini oracoli;
e ad un altro:
Va in Mallo, dove oracoleggia Anfiloco.
Queste cose avvenivano tra i confini della Jonia, della Cilicia, della Paflagonia e della Galazia: ma come la
fama dell’oracolo giunse in Italia e si sparse in Roma, vi nacque una gara; chi v’andava, chi vi mandava,
specialmente i più potenti e di maggior grado nella città. Tra i quali primo e principalissimo fu Rutiliano,
uomo bello e buono in tutt’altro, e in molti uffizi stimato dai Romani, ma sì perduto di superstizioni e
credulo di miracoli, che se vedeva pure una pietra unta d’olio o coronata di fiori, subito s’inginocchiava,
adorava, vi stava innanzi molto tempo, le chiedeva grazie, le faceva orazioni. Come costui udì le cose che si
dicevano dell’oracolo, poco mancò che non lasciò l’uffizio e gli affari che aveva per mano e non corse in
Abonotechia. Vi mandò corrieri sovra corrieri, i quali, come ignoranti, erano facilmente ingannati; e tornati,
contavano ciò che avevano veduto, e ciò che avevano udito come se l’avessero veduto, aggiungendovi
qualche altra cosa del loro per più piacere al signore: cosicchè rinfocolarono quel povero vecchio, e lo fecero
in tutto uscire del senno. Ed egli essendo amico di moltissimi e de’ più potenti cittadini, andava
strombettando con tutti, sciorinava ciò che gli avevano detto i suoi messi, magnificava, v’aggiungeva del
suo: per modo che ne riempì tutta la città, la mise sossopra, ed invogliò molti cortigiani, che tosto vennero
all’oracolo per dimandar loro ventura. Alessandro li accoglieva assai cortesemente, e con doni ospitali e
magnifici se li rendeva affezionati: e quelli al loro ritorno non pure narravano le loro dimande, ma
ricantavano le lodi del dio, maraviglie dell’oracolo e del profeta, ed un monte di bugie. Quel gran pezzo di
ribaldo usava un’altra astuzia, non isciocca, nè di mariuolo da dozzina: chè sciogliendo le polizze
mandategli e leggendole, se vi trovava qualche sdrucciolo e pericolo nelle dimande, ei non rispondeva nè le
rimandava, per tenere soggetti e quasi servi quelli che gliele avevano mandate, e che temevano ricordando le
dimande fatte. Tu comprendi quali cose potevano dimandare i ricchi ed i potenti. E però egli riceveva gran
doni da costoro, che si sentivano presi nelle sue reti.
Ora voglio dirti alcuni degli oracoli che egli diede a Rutiliano. Gli dimandava costui intorno a un suo
figliuolo avuto dalla prima moglie e già in età da studi, chi dovria dargli per maestro; ed ei rispose:
Pitagora, e il gran Vate delle pugne.
Indi a pochi dì il fanciullo morissi, ed egli smarrito non sapeva che dirsi essendo così subito sbugiardato dal
fatto: ma il buon Rutiliano lo soccorse, difese l’oracolo, e disse che il dio aveva parlato chiaro, additandogli
non un maestro vivo, ma Pitagora ed Omero, morti da tanto tempo, e coi quali ora quel suo figliuoletto si
stava nell’Orco. E perchè biasimar tanto Alessandro, se gli capitavano omicciattoli di sì buona pasta?
Dimandandogli costui un’altra volta, l’anima di chi egli aveva ricevuta, rispose così:
Prima fosti il Pelide, poi Menandro;
Or sei qual sembri: un dì sarai del sole
Un raggio: ci vivrai centottant’anni.
Fattostà che morì a settanta anni di atra bile, e non aspettò la promessa fattagli dal dio e di propria voce.
Un’altra volta saltatogli il grillo di prender moglie, ne dimandò l’oracolo, che rispose apertamente:
101
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Togli pure la figliuola
D’Alessandro e della Luna.
Il furbo aveva già sparso che la sua figliuola gli era nata dalla Luna: che la Luna era perduta d’amore per lui,
avendolo veduto una volta dormire, come ella suole innamorarsi di tutti i bei garzoni che dormono. E quel
gran senno di Rutiliano senza por tempo in mezzo mandò per la fanciulla, conchiuse il matrimonio, divenne
sposo a sessant’anni, e consumò il matrimonio, offerendo intere ecatombe alla suocera Luna, e credendosi
divenuto anch’egli uno dei celesti. Come egli si assicurò delle cose d’Italia, levò l’animo a maggiori pensieri,
e mandò suoi messi per tutto l’impero romano a spargere suoi oracoli, predicendo alle città pestilenze,
incendi, terremoti, e promettendo l’aiuto suo, che salverebbe da tutti questi mali. In una pestilenza che
afflisse tutte le genti, egli sparse questo oracolo autofono, che era un verso e diceva: L’intonso Febo pestilenza
sgombra. Era a vedere queste parole dovunque scritte su le porte, come un rimedio contro la peste: ma per
parecchi furono il contrario; chè per avventura appunto le case con la scritta furono vuotate e deserte. Non
dico io già che la gente periva per quella scritta, ma avveniva così per caso. E forse molti confidandosi
troppo in quel verso, spensierati stravizzavano, e non davano un po’ d’aiuto all’oracolo per iscacciare il
male, tenendosi bastantemente protetti da quelle sillabe, e dall’intonso Febo, saettatore della peste. Inoltre
aveva stabiliti in Roma stessa molti suoi esploratori, i quali lo informavano dell’indole di ciascuno di quei
grandi, delle dimande che gli farebbero, de’ loro desiderii, affinchè egli fosse pronto alle risposte prima di
giungere i messi. E questa era una gran tela di furberie ch’egli aveva ordita in Italia. Stabilì ancora alcuni
misteri con processioni e faci, e altre cerimonie, che duravano tre giorni. Nel primo se ne faceva il bando,
come in Atene, con queste parole: Se un ateo, un cristiano, un epicureo viene a spiare i misteri, fugga via: i
credenti nel nostro dio li celebrino col buono augurio. Dipoi cominciava la processione. Egli andava innanzi
e diceva: Fuori i Cristiani! e la moltitudine rispondeva: fuori gli Epicurei. Poi si rappresentava il parto di
Latona, la nascita di Apollo, le sue nozze con Coronide, dalla quale nasceva Esculapio. Nel secondo giorno si
celebrava l’apparizione di Glicone nel mondo, e la nascita del Dio. Nel terzo giorno le nozze di Podalirio e
della madre di Alessandro, la quale chiamavasi Teda, ed in suo onore si bruciavano tede: infine gli amori di
Alessandro e della Luna, e la nascita della moglie di Rutiliano. Portava la teda, e faceva da ierofante
l’Endimione Alessandro. E veramente si coricava in mezzo al tempio in atto di dormire, e a lui scendeva
dalla volta, come dal cielo, invece della Luna una certa Rutilia bellissima donna, moglie di uno dei
procuratori di Cesare, che veramente amava Alessandro e n’era riamata; e innanzi agli occhi di quel
pecorone del marito si baciavano pubblicamente e si tenevano abbracciati; e se non ci fossero state tante
faci avrian fatto di sotto qualche altra cosa. Dopo un poco entrava di nuovo Alessandro in paramenti di
ierofante in gran silenzio, poi a un tratto gridava: Viva Glicone! E dietro gli venivano invece di Eumolpidi e
di araldi certi Paflagoni, che con le suola allacciate ai piedi, e ruttando agli, rispondevano: Viva Alessandro!
Spesso nella processione con le tede, e tra i mistici balli, mostrava ad arte una coscia che pareva d’oro,
ricoperta forse d’una pelle dorata, che al lume delle faci splendeva. Però nacque una disputa tra due sciocchi
che pizzicavano di saputi, se egli con la coscia avesse avuta anche l’anima di Pitagora, o pure una simile a
quella: e portata la quistione allo stesso Alessandro, il Re Glicone in un oracolo sciolse il dubbio.
Di Pitagora l’alma or manca or cresce.
È figlia profezia della divina
Intelligenza, e la mandava il padre
A conforto de’ buoni in su la terra.
Ed ella a Giove un dì farà ritorno,
Percossa dalla folgore di Giove.
Predicando a tutti di astenersi dall’amor dei fanciulli, come da cosa empia, odi arte che usava quest’uomo
dabbene. Alle città del Ponto e della Paflagonia aveva ingiunto di mandargli ogni tre anni dei giovanetti che
con lui cantassero le lodi del Dio, e dovevano essere scelti i più nobili, i più teneri, i più belli: li teneva chiusi,
e li trattava come schiavi venduti a prezzo, giacendosi con essi, e disonorandoli. Ed aveva fatta una legge che
nessuno che avesse più di diciotto anni gli si appressasse alla bocca, e lo salutasse col bacio: a tutti porgeva la
mano a baciare; ai bei giovani la bocca: onde quelli chiusi con lui si chiamavano gli ammessi al bacio. E così
egli insultava a quei poveri sciocchi, svergognandone le donne, corrompendone i figliuoli. E quei tenevano a
102
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
gran ventura, se egli gettava pure uno sguardo alla moglie di alcuno; e se poi la degnava di un suo bacio,
credevano che tutti i beni del mondo pioverebbero in casa loro: molte si vantavano di esser gravide di lui, ed
i mariti affermavano che elle dicevano il vero. Ora voglio raccontarti un dialogo tra Glicone ed un uomo di
Tio a nome Sacerdote: e dalle dimande vedrai senno. Io l’ho letto io stesso scritto in lettere d’oro nella casa
di Sacerdote in Tio. — Dimmi, o potente Glicone, chi se’ tu? — Io sono il nuovo Esculapio. — Altro
dall’antico, o desso? — A te non lice saperlo. — Quant’anni rimarrai fra noi a dare oracoli? — Mille e tre. —
E poi dove anderai? — In Battro, e nelle vicine contrade: anche i barbari debbono godere della mia presenza.
— Gli altri oracoli in Didimo, in Claro, in Delfo sono di Apollo tuo avo, o son falsi i responsi che vengono di
là? — Non cercar di sapere cotesto, chè non lice. — Ed io che sarò dopo questa vita? — Camello, poi cavallo,
poi sapiente, poi profeta non minore d’Alessandro. — E questo fu il dialogo tra Glicone e Sacerdote. Infine
sapendolo amico di Lepido, dissegli quest’oracolo in versi.
Lepido non seguir, che è minacciato
Da miserabil fato.
Ei temeva molto questo epicureo, come un emulo che poteva smascherarne le imposture. Un altro epicureo
che ardì di convincerlo bugiardo innanzi a molte persone, corse un gravissimo pericolo. Costui gli si parò
innanzi, e ad alta voce gli disse: Tu, o Alessandro, persuadesti al tale Paflagone di dare in mano al
governatore della Galazia i suoi servi come rei di morte, per avere ucciso il suo figliuolo che studiava in
Alessandria: ma il giovane vive, ed è tornato vivo dopo la morte dei servi, dati a sbranare alle fiere per tuo
consiglio. Il fatto fu così. Il giovane rimontando il Nilo in nave, e giunto sino a Clisma, ebbe vaghezza di
andare in India; dove dimorando molto tempo, gli sventurati servi credendolo o affogato nel Nilo, o ucciso
dai pirati, che allora ve n’erano molti, se ne tornarono riferendo come il giovane era sparito. Quindi
l’oracolo, e la condanna; e poi il ritorno del giovane che raccontò il suo viaggio. Di questo fatto parlava colui.
Alessandro scornato e sdegnato, non sostenendo la verità del rimprovero, disse a quelli che aveva intorno:
Lapidatelo, o anche voi siete empi, e vi chiamerò epicurei. Già
cominciavano a volar le pietre, ma un
Demostrato tra i primi del Ponto, trovandosi quivi a caso, si strinse tra le braccia l’epicureo, e lo salvò dalla
morte. La scampò di un pelo, ma gli saria stata bene: che bisognava a lui di fare egli solo il savio fra tanti
pazzi, per cogliere questo bel frutto dalla stoltezza de’ Paflagoni? E così fu il caso di costui. Quando si faceva
l’appello dei venuti a consultare l’oracolo (che si faceva il giorno innanzi di dare le risposte), e quando il
banditore dimandava al profeta: Vuoi rispondere a costui? se si sentiva da dentro rispondere: ai corvi,
poveretto colui! non trovava tetto che il ricoprisse, nessuno che gli desse acqua nè fuoco, doveva andare
errando di paese in paese, come un empio, un ateo, un epicureo, che era la più grande ingiuria. E quest’altra
ridicolezza fece Alessandro: che avendo trovate le massime di Epicuro, libro bellissimo, che in breve ne
contiene tutte le dottrine fìlosofiche, lo portò in mezzo la piazza, e lo bruciò con legno di fico, come se avesse
bruciato proprio Epicuro, ne gittò la cenere in mare, e profferì ancora quest’oracolo:
Del cieco vecchio le sentenze al fuoco.
Non sapeva lo sciagurato quanti benefizi fa quel libro a chi lo legge: quanta pace, costanza, e libertà mette
nell’anima: come la libera dai timori, dai vani fantasmi, dalle sciocchezze dei prodigi, dalle vane speranze,
dai desiderii soverchi; e vi pone la verità ed il senno; e come purifica la mente non con teda e con scilla, e
con altre inezie, ma con la ragione, la verità ed il franco parlare. Ma fra tante altre, odi questa che fu la più
ardita furfanteria di questo sozzo ribaldo. Avendo non piccola introduzione presso l’imperatore e in palazzo,
pel gran favore che vi godeva Rutiliano, vi mandò un oracolo mentre ardeva la guerra di Germania, e il divo
Marco Aurelio era già venuto alle mani coi Quadi e coi Marcomanni. Comandava l’oracolo di gettare
nell’Istro due leoni vivi con molti aromati, e di fare magnifici sacrifici, e diceva così:
Nei vortici dell’Istro, divo fiume,
Si gittino due servi di Cibele,
due lioni montani; e appresso quanti
Fiori ed erbe odorose India produce.
103
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
Così tosto sarà chiara vittoria,
Ed onor grande, e la bramata pace.
Fatta ogni cosa appunto come egli aveva ordinato, i leoni nuotando uscirono all’altra riva, dove i barbari con
bastoni li accopparono credendoli nuovi lupi: ma indi a poco i nostri toccarono una grande rotta, in cui
morirono intorno a ventimila; e poi seguì il fatto d’Aquileia, la quale per poco non fu distrutta. Ed egli per
questo avvenimento addusse per iscusarsi la fredda risposta di Delfo a Creso, che il dio aveva predetta la
vittoria sì, ma non dichiarato se de’ Romani o dei barbari. Crescendo sempre più la folla delle genti che a lui
correvano, e la città non potendo contenere la gran moltitudine che veniva a consultare l’oracolo, e
mancando delle cose necessarie, egli escogitò gli oracoli detti notturni. Prendendo le polizze, vi dormiva
sopra, come ei diceva; e come il dio gli parlava in sogno, ei rispondeva, non chiaramente, ma infruscato,
intricato, confuso; massime se vedeva qualche polizza sigillata accuratamente; chè senza peritarsi, ciò che gli
veniva in mente vi scriveva, credendo che ogni stranezza saria sempre oracolo. E per questo v’erano alcuni
disfinitori, che facevano i più grassi guadagni sciogliendo e interpetrando gli oracoli. Questo ufficio si
comperava, e ciascun disfinitore dava ad Alessandro un talento attico. Talvolta senza essere dimandato,
senza che nessuno gli avesse mandato a chiedere, ei profetava così a caso, per parere più mirabile a quei
baccelloni: ed una volta disse così:
Tu vuoi saper chi Calligenia tua
Sopra il tuo letto ascosamente in casa
Contaminò? Protogene tuo servo,
Cui tu fidavi ogni segreta cosa.
Tu lui disonorasti, ed ei tua moglie;
E con l’oltraggio vendicò l’oltraggio.
Ora entrambi t’apprestano un veleno,
Sì che del loro oprar tu non t’accorgi:
Ma sotto il letto troverai la tazza
Vicino al muro dove poggi il capo;
E l’ancella Calipso è nel segreto.
Qual Democrito non si saria turbato udendo indicare persone e luoghi sì precisamente, sebbene subito dipoi
ne avria riso scoprendo perchè erano così indicati? Anche ai barbari talvolta dava responsi nella stessa
lingua che domandavano, come in Siriaco o in Celtico, trovando facilmente alcuni di quei paesi ond’erano
coloro che lo interrogavano. E però egli metteva molto tempo tra la dimanda e la risposta, per avere spazio
di sciogliere le polizze accuratamente, e trovare chi sapesse leggerle. Siffatto fu l’oracolo dato ad uno Scita.
Morfi erbagulis is schien chnenchierac lipsi faos.
Un’altra volta non essendovi alcuno che il dimandasse, uscì, a un tratto con queste parole in prosa: «Ritorna
indietro: chi ti mandò è stato ucciso oggi dal suo vicino Diocle, e dai ladri Magno, Celere e Bubalo, che già
son presi e imprigionati.» Odi ora alcuni oracoli dati a me. Avendogli io dimandato: È calvo Alessandro? e
sigillata la polizza accuratissimamente, ei vi scrisse su quest’oracolo notturno:
Malac figliuolo di Sabardalac era un altro Ati.
In due altre polizze diverse scrissi quest’altra dimanda: Qual’è la patria del poeta Omero? e gliele feci dare da
altri sotto altro nome. Egli, ingannato dal mio servitore, che, dimandato, aveva detto come io ero venuto per
cercare un rimedio per un dolore di fianchi, scrisse sovra una:
Ungi col timo e schiuma di destriero.
104
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
e sull’altra, avendo udito che chi l’aveva mandata voleva sapere se tornare in Italia per terra o per mare,
scrisse, senza dir motto di Omero:
Non navigar, fa tuo viaggio a piedi.
Di tali tranelli io gliene tesi parecchi: ed un altro fu questo. In una polizza scrissi una sola dimanda, e sopra
vi scrissi, come soleva farsi: otto dimande del tale, e foggiai un nome; e gli mandai otto dramme e il resto.
Egli si lasciò ingannare ai danari ed alla soprascritta: e rispose a quella sola dimanda, la quale era: Quando
sarà punito questo furfante d’Alessandro? con otto oracoli, che, come suol dirsi, non toccavano nè cielo nè terra,
ed erano tutti sciocchi e strani. Le riseppe dipoi queste cose, e come io svolgevo Rutiliano dalle nozze, e dal
fidar troppo nelle speranze che gli dava l’oracolo: onde me ne volle un gran male, e mi tenne per suo
nimicissimo. Ed una volta che Rutiliano lo dimandò di me, ei rispose:
Cerca notturni amori e impuri letti.
Nè io gli volevo gran bene. Come egli intese che io ero arrivato nella città, e seppe che ero Luciano, e che
avevo meco due soldati, un astato ed un picchiere, datimi dal governatore della Cappadocia mio amico, per
iscortarmi sino al mare, tosto mandò ad invitarmi con molta cortesia. Andatovi, lo trovai accerchiato da
molta gente: per buona fortuna avevo meco i due soldati. Egli mi porse la mano destra a baciare, come
soleva fare a tutti; ed io attaccandovi le labbra come per baciarla, con un buon morso poco mancò che non
gliela storpiai. Quella gente voleva strangolarmi ed uccidermi come sacrilego; e già da prima s’erano
scandalezzati che io lo avevo chiamato Alessandro, e non profeta; ma egli generosamente si tenne l’offesa, si
rabbonì, e promise loro che subito m’avria fatto dolce e persuaso, mostrandomi la potenza di Glicone, il
quale si fa amici anche i più acerbi. E fatti allontanare tutti, si giustificava con me, dicendo: Io ben ti conosco,
e so quai consigli hai dato a Rutiliano: oh, perchè mi fai questo, quand’io posso giovarti appo di lui? Io feci
sembiante di compiacermi di questo segno di benevolenza, vedendo a che pericolo m’ero messo: e tosto
mostrai che gli tornavo amico. E gli astanti fecero grandi maraviglie, vedendomi sì subitamente mutato.
Dipoi essendomi determinato a partirmi, ei mandommi di molti doni ospitali (dovevo partire io solo con
Senofonte, avendo già mandato mio padre ed i miei in Amastri), e ci profferse di darci egli una nave e
rematori per menarci via: ed io me lo tenni a buona e sincera cortesia: ma come fummo in alto mare,
vedendo il pilota piangere e contendere di non so che coi marinai, venni in fieri sospetti.
Alessandro aveva loro commesso di prenderci e gittarci in mare: il che se fosse stato, egli avria fatta gran
vendetta di me. Ma quegli con molte lagrime persuase ai marinai di non farci alcun male, e voltosi a me
disse: Per sessant’anni son vissuto sempre puro e senza una macchia, ed ora non vorrei a questa mia età,
avendo moglie e figliuoli, lordarmi le mani con un delitto. E qui mi scoprì perchè ci aveva imbarcati, e la
commissione avuta da Alessandro. Ci fe’ smontare in Egialo, di cui ricorda il buon Omero, e tornossene
indietro.
Quivi avvenutomi a caso in alcuni ambasciatori bosforani, che andavano al re Eupatore in Bitinia a portare
l’annuo tributo, narrai loro il pericolo che avevamo corso, ed accolto cortesemente nella loro nave, giungo
salvo in Amastri, dopo di essere stato sì vicino a morire. D’allora in poi anch’io me gli armai contro e il
combattei di tutte le mie forze, per desiderio di vendicarmi. Già prima di questa insidia io l’odiavo, e
l’abborrivo pe’ suoi costumi scellerati: onde mi deliberai di accusarlo, avendo molti che mi aiutavano,
massime i discepoli del filosofo Timocrate d’Eraclea. Ma il governatore del Ponto e della Bitinia mi rattenne,
quasi pregandomi e supplicando a rimanermene: dappoichè per amore di Rutiliano, egli non avria potuto
punirlo, ancorchè chiarito colpevole. Così mi furono rotti i passi, e ristetti; chè ogni ardire saria stato
infruttuoso con un giudice sì prevenuto. E tra le altre temerità di Alessandro non fu grande quella di
chiedere all’imperatore di mutare il nome di Abonotechia, e di chiamarla Ionopoli; e di coniare una nuova
medaglia che in una faccia avesse l’immagine di Glicone, e nel rovescio quella di Alessandro con in capo le
bende dell’avo Esculapio, e in mano la falce di Perseo, dal quale si vantava di discendere per madre? Aveva
profetato di sè che gli era destinato di vivere centocinquanta anni, e che poi morrebbe di fulmine; ma con
miserabile fine morì di settant’anni, come degno figliuolo di Podalirio, per cancrena che da un piede gli salse
105
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
all’inguine, e tutto roso da vermini. Ed allora si scoprì che egli era calvo, quando i medici gli bagnavano la
testa per i dolori che vi aveva: il che non potevano fare se non tolta la parrucca.
Tale fu il fine della tragedia di Alessandro, e la catastrofe di tutto il dramma: la quale parve avvenuta per
provvidenza, e fu caso. Ma bisognava ancora che il suo funerale fosse degno della sua vita, e che per
succedergli nascesse un contrasto tra i principali ribaldi e ciurmadori che lo avevano accerchiato: i quali
andarono da Rutiliano e lo fecero arbitro di scegliere tra loro chi dovesse avere l’oracolo, ed essere coronato
con le bende di ierofante e di profeta. Tra costoro era un certo Peto, medico di professione e vecchio, il quale
fece cose sconvenevoli all’arte ed alla sua canizie. Ma l’arbitro Rutiliano li mandò via, e non volle coronare
nessuno, serbando ad Alessandro il diritto di profetare anche dopo la morte. Questi pochi fatti ho voluto
scrivere come un saggio di molti altri, sì per far cosa grata a te, che mi sei caro amico e compagno, e che io
ammiro grandemente pel sapere che hai, per l’amore che porti alla verità, per i tuoi dolci costumi, per la tua
moderazione, per la tranquillità della vita, e per la cortesia che usi con chi teco conversa; e sì ancora, il che
certo ti piacerà, per vendicare Epicuro, divino sacerdote della verità, della quale egli solo ha conosciuta e
rivelata la bellezza, e liberatore di coloro che ne seguitano le dottrine. E penso che anche ai leggitori questo
libro parrà buono a qualche cosa, perchè e smaschera un’impostura, e conferma le opinioni degli uomini di
senno.
106
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
L'ironia:
Heinrich Lausberg, Elementi di retorica (Il Mulino, Bologna 1969; titolo originale Elemente der literarischen
Rhetorik, München, Max Hueber Verlag, 1949)
Gianantonio Borgonovo "La notte e il suo sole: luce e tenebra nel libro di Giobbe; analisi simbolica" (Analecta
Biblica 135, Roma, 1995)
http://www.ousia.it/SitoOusia/SitoOusia/Manuale/Antica
http://www.swif.uniba.it/lei/personali/pievatolo/platone/indstr.htm
http://www.rodoni.ch/busoni/nietzsche/socrate-nietzsche.pdf
Kierkegaard:
appunti presi in classe
http://www.filosofico.net/kkierk539.htm
Pirandello:
appunti presi in classe
http://www.inftube.com/letteratura/letteratura-italiana/Luigi-Pirandello54963.php
http://users.libero.it/rrech/pirandello_2.html
http://www.pirandelloweb.com/romanzi/1904_il_fu_mattia_pascal/fu_mattia_pascal_copertina.htm
Lucano:
appunti presi in classe
Emanuele Narducci, Provvidenzialismo e antiprovvidenzialismo in Seneca e in Lucano, leggibile in
http://www.fondazionecanussio.org/atti2001/narducci.pdf
O.S. Due, Lucan et la philosophie, in M. DURRY (ed.), Lucain, «Entretiens Hardt» 15, Vandoeuvres-Genève
1970
http://www.alepalma67.com/lucano.doc
Luciano:
appunti presi in classe
Luigi Settembrini, Opere di Luciano voltate in italiano da Luigi Settembrini, Le Monnier, Firenze, 1861
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_o_il_falso_profeta
http://www.forumlibri.com/forum/piccola-biblioteca/11533-luciano-di-samosata-alessandro-o-il-falsoprofeta.html
http://www.adelphi.it/libro/9788845909238
Oscar Wilde:
appunti presi in classe
http://it.wikipedia.org/wiki/L'importanza di chiamarsi Ernesto
http://www.sololibri.net/L-importanza-di-chiamarsi-Ernesto.html
Calvino:
http://www.digila.it/public/iisbenini/transfert/Sebastiani.pdf
Magritte:
appunti presi in classe
http://www.surrealismo.it/magritte_il%20pensiero.htm
http://www.stilearte.it/articolo.asp?IDart=1042
107
IRENE STELLADORO
L'IRONIA
John Von Neumann:
http://www.torinoscienza.it/personaggi/john_janos_von_neumann_19778
http://www.ildiogene.it/EncyPages/Ency=Neumann.html
Hiroshima e Nagasaki:
http://lameduck.wordpress.com/category/hiroshima/
http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_atomici_di_Hiroshima_e_Nagasaki
La bomba "H":
http://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_all'idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Fissione_nucleare
Paradossi matematici:
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Russell
http://insegnomatematica.splinder.com/post/18458333/il-paradosso-di-russell
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Burali_Forti
La faccia della Luna:
appunti presi in classe
http://unico-lab.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
108
Scaricare