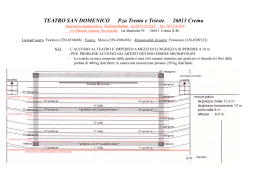26 — dove va il teatro pubblico italiano? Dove va il teatro pubblico? (parte prima) cato i molti settori in cui si suddivide l’universo spettacolare, e abbiamo rivolto il nostro quesito non solo naturalmente a moltissimi studiosi e critici, ma anche a chi lavora dentro le arti dal vivo, dal celebre attore di prosa al regista lirico di tradizione, dall’organizzatore di festival sperimentali al sodossier a cura di Leonardo Mello e Ilaria Pellanda vrintendente di grandi Fondazioni, dall’esperto in management al poeta itinerante per i palcoscenici, dal drammaturgo nnunciata qualche mese fa, e anticipata da un coral compositore, dal gruppo di ricerca al direttore artistico di rosivo articolo di Quirino Principe, che nel difendere Stabile... Senza ovviamente avere alcuna velleità di raggiuncon passione il Teatro utilizzava talvolta i toni dell’ingere l’esaustività all’interno di un mondo così variegato, abvettiva (cfr. VMeD n. 36, p. 49), ecco ora la promessa riflesbiamo provato a proporre un mosaico frastagliato, che riunisione a più voci – il cui primo spunto ci venne qualche mesce in un’unica, corale riflessione professionalità, vocaziose fa dal Presidente dello Stabile del Veneto Laura ni e generazioni diverse. La quantità dei contributi Barbiani – dedicata al teatro pubblico, argoIl nostro quesito che sono arrivati in redazione ci ha però «comento di questi tempi piuttosto ricorrente stretti» a ridurre il corpo del testo, e succes«Come in altri Paesi europei, anche in sulle pagine di molti quotidiani italiani. sivamente anche a scindere la nostra inItalia esiste un sistema teatrale pubblico, finanL’erosione lunga e progressiva del Fonchiesta in due parti, scegliendo, per orziato, seppur sempre in misura minore, attraverso le do unico per lo spettacolo, cui attindinare i materiali, un criterio cronoloerogazioni del Fondo Unico dello Spettacolo. A questa gono in misura diversificata moltis- fonte unitaria attingono realtà diverse per storia, genesi e gico che privilegia la data di riceziosime realtà teatrali, è stata lo spunto finalità, come le Fondazioni liriche e i Teatri Stabili di pro- ne (adattato all'impaginazione per iniziale di questo nutrito dossier, do- sa, cui si sono aggiunti da qualche anno anche i cosiddetti Sta- ottimizzare gli spazi). Perciò molve però, più che di analizzare la que- bili d’Innovazione. A fronte della loro natura eterogenea, que- te importanti riflessioni che già sostione in termini esclusivamente fi- ste istituzioni culturali sono accomunate proprio dal coinvol- no state spedite troveranno spazio nanziari, si è chiesto a tutti gli invi- gimento dello Stato nelle loro attività. Nel complesso conte- – insieme ad altre illustri – nel prostati a rispondere di esprimere il pro- sto socioculturale in cui viviamo, che peso deve avere l’inter- simo numero. prio parere sul concetto di teatro pub- vento statale nelle strategie organizzative e produttive del In chiusura resta da precisare che, nostro teatro nazionale? E più in generale, quali sono blico e sulla funzione che dovrebbe ricome di consueto, dopo aver lanciato le caratteristiche e la funzione prioritarie per il tecoprire, in particolare nel nostro Paese e lo stimolo al dibattito, ci siamo limitati atro pubblico in epoca contemporanea, anin questo preciso momento storico. La doa raccogliere diligentemente i diversi scritche ripensando eventualmente il simanda, uguale per tutti, ha dato, come era inti e a organizzarli all’interno delle nostre pastema ora vigente?» tuibile e auspicabile, luogo a interventi della nagine, lasciando ai nostri lettori il compito e il piatura più varia, come del resto differenziata è anche la cere dell’interpretazione. numerosa schiera di chi ci ha voluto omaggiare della propria opinione. Partendo dal presupposto che istituzioni differen* La maggior parte dei contributi ci sono pervenuti in forma scritta. ti per storia e percorso potessero, forse, condividere alcuni A questi si sono aggiunti alcuni interventi frutto di interviste realizzaobiettivi (e problemi) di fondo, abbiamo idealmente unifite dalla redazione. dove va il teatro pubblico italiano? A Roberto Alonge I disastri della politica italiana È difficile parlare di finanziamento pubblico del teatro (di pro- sa e lirico) perché implica un discorso di politica generale. E in Italia è ancora più difficile perché da sedici anni c’è una visibilissima rissa che divide l’Italia in due, pro e contro Berlusconi, a prescindere. Qualunque cosa Berlusconi faccia, per la sinistra non va mai bene. Persino il divieto di fumare in locali pubblici fu oggetto di qualche vignetta ironica da parte del giornale-partito «Repubblica». Certo, a Berlusconi e dintorni la cultura non importa nulla: importano le veline, la sotto-cultura televisiva e altre cose del genere. I tagli alla cultura si inseriscono in questo quadro, e sono ovviamente deprecabili. Dobbiamo però dire con eguale forza che la sinistra ha le sue colpe, che pochi vedono, ma che sono non meno devastanti di quelle della destra. È sempre operante il vecchio spirito del ’68: aumenti salariali uguali per tutti, nessuna meritocrazia. Basti pensare alla battaglia contro la legge Gelmini: perché tutti i ricercatori devono fare carriera e diventare tutti associati? Mediamente l’eccellenza è il venticinque per cento. Non basta mettere a disposizione soldi per il venticinque per cento degli attuali ricercatori? La stessa cosa vale per il teatro (musicale e di prosa), che è una realtà di nicchia. È giusto dare soldi alle realtà eccellenti (più di quelli che sono dati oggi, e anche più di quelli che sono stati dati ieri dai governi di centro-sinistra), ma c’è un livello di industria della cultura di livello medio-basso che potrebbe essere tranquillamente spazzato via. È vero che tutti hanno diritto al lavoro, ma perché deve essere per forza un lavoro artistico o da professore universitario? Non potrebbe fare l’operatore di agenzia turistica o l’impiegato di biblioteca o il professore di scuola media? Perché un ricercatore (che forse vale poco) protesta perché a quarant’anni guadagna solo duemiladuecento euro, dal momento che un professore di liceo eccellente, a sessant’anni non arriva a duemila euro? Ecco, mi pare che que- sto sia il guaio della sinistra: difende la cultura, ma tutta la cultura, in maniera lobbistica. Per non dire poi della pratica di voler infilare spesso alla direzione dei teatri e dei consigli di amministrazione personale di partito che quasi sempre non capisce nulla di teatro. Dobbiamo avere il coraggio di dire che i politici rappresentano un ceto, una oligarchia (senza nessuna differenza fra destra e sinistra), strapagata in modo inverecondo (rispetto a parametri internazionali) e che, per di più, pretende di mettere il becco anche negli organismi estranei alla politica (cultura, radio, televisioni, ecc.). Questi sono i nodi. Che strozzano a monte ogni altro discorso, ahimé. Cristina Palumbo Un piano strategico nuovo per le arti dal vivo? D a qualsiasi parte rivolga il pensiero, vado contro il sistema auto- rizzato, perché secondo me oggi l’attuale sistema nazionale pubblico per le arti dal vivo non è più difendibile. E mi preoccupo del fatto che questo mio apparente «andare contro» sia corroborato da qualche aspetto costruttivo. Penso non sia retorica né qualunquismo affermare la necessità di definire il tempo storico che ha prodotto questo sistema. Credo che non si possa costruire nessuna riflessione se prima non ci si prende la responsabilità di definire l’età che ha il teatro pubblico, e al suo interno la divisione in Stabili pubblici, privati e d’innovazione. Prendersi la responsabilità vuol dire, in parole povere, riconoscere che stiamo parlando di modelli «d’annata» e non più riproducibili. E subito dopo chiedersi che cosa invece è più vicino alle esigenze contemporanee. Credo ci vorrebbe un piano strategico nuovo per le arti dal vivo. Altrimenti com’è possibile parlare di teatro pubblico? A questo proposito pongo due interrogativi. Il primo è qual è il valore culturale che questo Paese vuole attribuire alle arti dal vivo, quindi alle arti non invisibili ma immateriali. E il secondo, subito conseguente, è quale incidenza si vuo- le che abbiano le arti dal vivo nel patrimonio culturale del nostro Paese. Mi rendo conto che sono domande immense, ma se non si prova a rispondervi non si può ipotizzare alcun piano programmatico. Quindi se questi organismi, che hanno una delega forte a livello nazionale, nel loro agire non corrispondono a delle linee generali e al valore strategico che a loro viene attribuito – e di conseguenza non sono portatori d’acqua al mulino che si vuole mettere in funzione – io non riesco di per sé a concepirli, come di per sé non riesco a concepire il finanziamento statale. Aggiungerei che in una visione strategica e profetica, che riguarda il futuro a partire dal nostro presente (che a mio parere ci sta dando frutti e indicazioni importanti), un posto di primo piano dovranno necessariamente averlo gli artisti e gli autori, a pari livello. Paolo Rossi Quando c’è luce c’è meno criminalità C redo che si debba partire analizzando l’affermazione abbastan- za incauta del ministro dell’economia: «Con la cultura non si mangia!». È falso. E lo è per almeno tre buoni motivi: innanzitutto, a partire dalle programmazioni dei teatri lirici per arrivare alle rassegne dei più piccoli teatrini off, l’indotto di ristoranti, bar, alberghi, mezzi pubblici, privati, negozi, è a cascata; in secondo luogo, quando c’è luce per strada c’è meno criminalità e questo è comunque un guadagno per l’economia nazionale; infine, mi chiedo perché, se è vero che con la cultura non si mangia, io e la mia compagnia di prosa dobbiamo prestare allo Stato il quaranta per cento degli incassi. Credo invece che l’intervento pubblico vada regolato con più lungimiranza. E non condivido la scelta dei lavoratori dello spettacolo di protestare manifestando in un modo rappresentativo e senza rischiare conseguenze concrete. Fa quasi sorridere pensare che il sindacato degli attori abbia scioperato di lunedì, nel loro giorno di riposo. Credo che si dovrebbe piuttosto attuare una forma di «sciopero al contrario», che faccia conoscere il teatro – e lo intendo sia come luogo fisico sia come il lavoro che noi svolgiamo – portandolo e offrendolo alla gente che la cultura non se la può pagare. Inoltre, più che andare per strada, sarebbe una buona idea salire negli uffici e controllare che le sovvenzioni non siano fatte con criteri clientelari, nepotistici o politicamente interessati. Con ciò non intendo dire che in passato le sovvenzioni funzionassero al meglio, e non sto affermando nemmeno, come spesso ho sentito dire da alcuni miei colleghi «della prosa», che la lirica costa troppo: non riesco infatti a immaginare come i commercianti di Verona potrebbero vivere senza l’Arena. Tutte le forme di spettacolo dovrebbero iniziare a riempire un vuoto e a occuparsi delle scuole. È questo il vero punto centrale: in questi ultimi venticinque/trent’anni di rivoluzione culturale, commerciale e mediatica, abbiamo infatti perso tre o quattro generazioni. Proprio per questo dovrebbe essere compito e responsabilità civile di tutti – dal direttore d’orchestra all’ultimo mimo –rivolgere grande attenzione alle nuove generazioni e agli studenti, altrimenti il disastro sarà totale. Bisogna ricominciare dalla base: non si può costruire una casa dal tetto, si deve cominciare dalle fondamenta. Saverio La Ruina Il Pubblico non è all’altezza del pubblico I l teatro è imprescindibile nella crescita civile e culturale dei citta- dini con l’alto compito di fornirgli gli strumenti per interpretare e affrontare al meglio la realtà che li circonda. Riconosciuta l’importanza fondamentale della sua funzione, il teatro non può non essere necessariamente finanziato. Il rischio sarebbe quello di lasciarlo alla sola mercé del mercato a inseguire logiche completamente diverse. Ma paradossalmente il problema degli Stabili è quello di operare secondo logiche molto vicine al mercato con i soldi pubblici. Anche stando ai criteri delle circolari ministeriali emanate annualmente, gli Stabili disattendono continuamente i loro compiti senza conseguenza alcuna (lo stesso discorso vale più o meno anche per i Circuiti Pubblici), salvo eccezioni isolate e a singhiozzo. Non si pongono come punto di riferimento territoriale per i giovani artisti capaci di sviluppare i linguaggi del contemporaneo. Investono molto raramente sulla nostra drammaturgia contemporanea e men che meno sui giovani autori. Non si preoccupano in alcun modo di contribuire al rinnovamento della nostra scena. Non si preoccupano della formazione di un pubblico nuovo. E tantomeno riescono ad attrarre un pubblico giovane che si dimostra molto più interessato ai nuovi linguaggi, più aderenti ai temi, ai codici e alle contraddizioni dei tempi in cui viviamo. E a questo proposito rimando alla pletora di piccole realtà indipendenti che con quattro soldi pubblici realizzano iniziative di grande spessore culturale, investono sui giovani artisti, promuovono i nuovi linguaggi, sostengono i giovani autori e sono seguiti da masse di giovani. In altre parole assolvono il compito che primariamente spetterebbe agli Stabili Pubblici. Sono quelle realtà a farsi carico della formazione della nuova generazione di registi, attori, autori. Sono loro a formare il ricambio. Anche quello del pubblico. Hanno direttori artistici dinamici, curiosi, attenti, vitali. Raramente hanno posizioni o rendite da difendere (quali rendite?). Personalmente sono convinto che spostando quei direttori artistici a capo degli Stabili si raggiungerebbero risultati inimmaginabili. In una certa misura ritengo c’entri anche l’età. Non che l’età sia un valore a priori, ma confrontando i dati anagrafici dei direttori di queste realtà e di quelli dei Teatri Stabili, a fronte di differenze così eclatanti, è innegabile che denuncino anche un problema di carattere generazionale. E quindi culturale. Tornando ai compiti disattesi dagli Stabili, lo Stato dall’altra parte cosa fa? Dovrebbe riconoscere e tutelare il rischio culturale del progetto dello Stabile e verificare nel tempo se l’investimento è andato nella giusta direzione. In caso positivo continuare a investire, in caso negativo investire su altri. Ma qui arriviamo all’aspetto meno edificante della questione. Quello di una politica che non è in grado né di valutare i progetti né di verificare i risultati. Valutazione che riguarda anche i Teatri Stabili d’Innovazione che dapprima si sono fatti un certo carico del loro compito istituzionale ma che poi lo hanno abbastanza disperso, salvo alcune eccezioni. Ma per entrambi il problema sta a monte. Qualsiasi cosa facciano l’atteggiamento dello Stato ne livella pregi e difetti. E qui tocchiamo un nodo fondamentale che è quello delle commissioni ministeriali. A seconda dell’entità delle risorse disponibili, le commissioni si limitano a tagliare o ad accrescere le sovvenzioni in modo orizzontale. Piccole compagnie cresciute a livello esponenziale sia dal punto di vista artistico che quantitativo rimangono bloccate sui parametri di sempre, allo stesso modo di altre quasi scomparse dalla geografia teatrale. A mio parere un contributo importante verrebbe dai critici teatrali. I critici sono professionisti dello «sguardo», lo esercitano per mestiere e passione, sono gli unici a monitorare in lungo e in largo la scena teatrale al di là dei generi e degli steccati. Non credo sia un’eresia affermare che seguono una quantità di spettacoli molto superiore a quella delle altre categorie. Il loro contributo cambierebbe senz’altro qualcosa. Concludo affermando che è il «Pubblico» a non essere all’altezza del «pubblico». Dario De Luca Piccole riflessioni «di pancia» sugli Stabili A derisco e sottoscrivo, per anni di riflessioni condivise su questa e altre «questioni aperte», le considerazioni fatte da Saverio, ma vorrei ancora ritornare su un punto: tutta una gran quantità di piccole realtà indipendenti sopperiscono, con il loro operato, a quello che non fanno le stabilità e le stagioni, dando visibilità a tutto un movimento teatrale scaturito negli ultimi vent’anni che altrimenti non avrebbe spazio. Il sistema teatrale istituzionale (e metto dentro il calderone Stabili Pubblici e Stabili d’Innovazione) non vuole vedere che ci sono fior di artisti e un numero incredibilmente vasto di pubblico che si confronta sull’oggi, parlando la stessa lingua, e che ha sancito un rinnovamento e un ricambio generazionale nel panorama teatrale italiano che, come giustamente dice Renato Palazzi, non ha eguali in Italia perlomeno da quarant’anni. Vogliamo prenderne atto? Vogliamo aprire le porte degli Stabili a questi artisti, che sono i protagonisti del nostro tempo, decretandone una volta per tutte il meritato riconoscimento? E ancora: vogliamo spostare questi operatori attenti e innovativi (che guarda caso spesso sono artisti) dalle situazioni di nicchia ai teatri istituzionali? Vogliamo rinnovare un repertorio che si è cristallizzato in una sorta di fermoimmagine perenne su titoli e autori consolidati, che non convince e intrattiene più neanche lo stanco pubblico degli abbonati? Possibile che festival indipendenti, penso a Short Theatre, al nostro Primavera dei teatri, ma anche alla rinascita di Santarcangelo ad ope- dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 27 28 — speciale teatro pubblico ra dei Motus e tanti altri sparsi nello Stivale, debbano farsi carico dell’opera che spetta agli Stabili senza però averne né i mezzi finanziari adeguati né nessun altro tipo di tutela per il «rischio d’impresa» che si accollano? La nostra generazione, penso a quella nata negli anni novanta, ha tutte le carte in regola, artistiche e organizzative, per ridare senso e rinnovare gli obiettivi di questi stabili (intesi come edifici) senza anima. E già c’è la generazione dopo la nostra che scalpita. Non fateci arrivare a certi posti quando saremo anche noi invecchiati, stanchi, senza idee né lucidità critica e con la vista ormai appannata. Non parlo di poltrone alle quali accedere, per carità. A noi basterebbe occupare tutte quelle disposte in platea con un pubblico curioso e partecipe. Andrea Porcheddu Cambiare aria speciale teatro pubblico 1. Abbiamo passato un periodo, peraltro recente, in cui la parola «impresa» sembrava essere la panacea di tutti i mali, il grimaldello per entrare in mondi favolosi, il trampolino di lancio per spiccare voli ultraspaziali verso il magnifico e progressivo mondo del «mercato». Impresa doveva essere anche il teatro: si sarebbe trattato di fare marketing and fundraising, colpire target e siglare jointventure. Più realisti del re, i teatranti si sono lasciati convincere dalle nuove parole d’ordine e si sono lanciati nella «ottimizzazione» forzata dell’azienda: piccole e medie imprese, al pari di quelle che nelle Marche fanno le scarpe, i teatri si sono dovuti confrontare con il mercato. Niente più finanziamenti ma fondazioni, niente fus ma business. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lo spettro del fallimento è dietro l’angolo. E se pure non tutto è stato male, in quella ventata di imprenditoria applicata – anzi, a volte la professionalizzazione necessaria è partita proprio da lì – ora ci si rende conto che una repubblica civile non può allegramente dimenticare l’articolo 9 della propria carta fondativa. Le arti, insomma, tutte le arti, vanno sostenute. Ma la strategia, qui, è evidentemente altra: aveva iniziato Baricco, con un articolone su «Repubblica», dicendo e argomentando che, in fondo, tagliare si può, anzi fa bene. Poi i tagli sono arrivati, e i crolli pure. Tanto con la cultura non si mangia, dice un nostro qualche ministro: immediatamente sbugiardato da rigorose ricerche di fior d’università (recente quella di Torino) che dimostrano, dati alla mano, che per ogni euro investito in cultura ne ritornano almeno cinque. Il problema, allora, non è tanto se l’intervento statale deve avere peso, ma che lo Stato sappia gestire il proprio intervento, il che è altra cosa, ben lontana dalla portata dei nostri vivaci governanti. Detto ciò, il teatro dovrebbe sapersi libero, scevro dai condizionamenti dei partiti e dei politici (non da quelli dello Stato, che deve esigere sane e oculate amministrazioni). Ma qui, ovviamente, cadiamo dalla padella alla bracetta: i nostri teatrini provincialini e capitolini sono perfettamente allineati ai voleri del politichetto di turno: veline e starlette salgono disinvolte sui palcoscenici grazie alle loro grazie e le produzioni, a volte, si allineano compiacenti. L’ingerenza della politica è insopportabile: assessori che fanno i direttori artistici, ministri che si dichiarano poeti: sarebbe bello fosse il contrario. Un poeta ministro e un direttore artistico assessore. Da qui, dovremmo ricominciare. Non più la politica che invade il teatro, ma il teatro che – come un virus – si insinua nella politica. E magari la migliora… 2. Da molte parti si sostiene che i teatri pubblici (limito il mio discorso ai Teatri Stabili pubblici che si occupano della cosiddetta prosa) siano morti. Forse è vero. Ma se rinunciamo a gestire questi mausolei, questi campisanti più o meno polverosi, allora abbiamo veramente perso. Sono ormai poco più che baluardi screpolati ma riconoscibili; torrioni cadenti eppure eleganti; «marchi di fabbrica» consunti ma capaci di ricordare passati più o meno illustri. Sono fossili ma di storie condivise: insomma, sono quel che ci resta (assieme a tanto altro, ovvio: festival, ricerca, cantine, centri sociali, innovazione, ragazzi, ecc ecc). La caratteristica degli Stabili è che sono la principale traccia, in fatto di teatro, che può essere interpretata da chi non si occupa di teatro: ad esempio da quei tanti, la maggioranza, che hanno accettato il berlusconismo o che hanno portato il Paese alle tre I: imbecilli, incompetenti, iperattivi. Chi si occupa, a vario titolo, di arte, teatro, cultura, ha perso: venticinque anni di Mediaset hanno ottenuto più risultati di duemilacinquecento anni di teatro politico. I cittadini non sono migliorati: nessuna catarsi, al massimo la pubblicità. Allora, siamo rimasti una minoranza, non migliori, né orgogliosi, semplicemente pochi e spaventati. Per questo, forse, dobbiamo tenerci care queste vecchie insegne che sono i teatri. Rivendicarli, combattere per loro, aprirli il più possibile. Ma il problema italiano non si limita a questo, è anzi ancora più sottile: e ha un comune denominatore nella gerontocrazia. I venerati maestri. Gli ottantenni che fanno bunga bunga, i settantenni che vivono la seconda o terza giovinezza creativa. Ora, stranamente, arrivano dei segnali «inquietanti», certo spiazzanti: sembra che non si debba aver compiuto settant’anni per dirigere uno Stabile. Segnali in assoluta controtendenza, addirittura rivoluzionari: un trentenne può dirigere uno Stabile! Aiuto! E come si fa? E come la mettiamo con le nomine a vita, con le partitelle politiche, con le sindacalizzazioni esasperate e esasperanti, con la produzione che «firmoioregiascenecostumi»? Eppure ci sono dei cinquantenni, un paio di quarantenni, addirittura un trentenne! Fosse in arrivo una marea? Una nuova aria? Ecco cosa potrebbe essere prioritario, dunque: cambiare aria. Un limite d’età e di mandato. Massimo sessant’anni (che è pure tanto), massimo tre stagioni. Poi si cambia, almeno negli Stabili pubblici. Con buona pace dei politici. Maria Grazia Gregori Due risposte R isposta 1: L’investimento culturale qualifica un Paese Fin da quando ho iniziato a occuparmi di teatro – in realtà da parecchi anni prima –, c’è sempre stata qualche anima bella che si è chiesta se in tempi difficili (ma anche in tempi affluenti, a ben pensarci) fosse giusto, necessario che lo Stato contribuisse al funzionamento dei teatri e non dedicasse queste risorse a progetti più utili socialmente. Salvo poche illuminate eccezioni il quesito ha attraversato i decenni assumendo via via un’aria sempre più minacciosa. Per arrivare ai giorni nostri al paradosso inquietante di un ministro che credendo di essere spiritoso ha fatto la seguente, qualunquistica affermazione «epocale»: la cultura (e dunque anche cinema e teatro) non si mangia, forse ipotizzando l’avvento di una futura generazione di obesi per via del surplus di cibo, ma con un cervello, un pensiero, un cuore asfittici. Certo un teatro deve essere «sano» contribuendo in modo fattivo alla propria vita, al proprio futuro. Ma uno Stato incapace di pensare a degli investimenti culturali mirati, in grado di nutrire intelligenze, progetti, ricerche, pensieri senza chiedere in cambio un piatto conformismo politico ma, semmai, una crescita dell’immagine culturale e artistica del Paese è uno Stato volgare, mercantile. L’investimento culturale, infatti è uno dei momenti qualificanti di una politica degna di questo nome e di un progetto Paese che fa della cultura una delle voci più significative del suo bilancio. Un fine economista potrebbe forse spiegarci tecnicamente questa paradossale necessità di rendere infecondi i nostri più appetibili crediti. Gli si potrebbe rispondere riflettendo sull’indotto del teatro, per esempio, non solo misurabile in sbigliettamenti, numero di recite e spettatori (che contano, certo) ma che produce ricchezza, che dà lavoro oltre che ai suoi dipendenti a una rete più o meno ampia di botteghe artigiane, di industrie ecc. Ma non vorrei divagare né soffermarmi sulla differenza palese fra teatro pubblico e teatro d’innovazione (perché penso che un teatro pubblico debba anche essere innovativo, fare ricerca, dunque). L’importante è la qualità del prodotto, la sua capacità di confrontarsi con gli spettatori, di porsi interrogativi invece di dare risposte definitive. Da tempo non credo che il nostro sia il migliore dei mondi (e dei teatri) possibili. Risposta 2: Innovazione e contemporaneità come parole chiave Non si può dire che cosa sia o debba essere un teatro se non ci si chiede prima a che cosa serva. Innanzi tutto non credo che ci sia un solo teatro, un teatro universale, ma che ce ne siano tanti quanti potenzialmente sono i pubblici e che la vitalità del teatro non si misuri soltanto sulla qualità degli spettacoli, che pure è irrinunciabile, ma anche sulla possibilità che esistano diversi modi di fare teatro in cerca del loro pubblico. Penso però che un teatro pubblico degno di questo nome debba fare proposte culturali innovative, chiedendosi per chi le fa, che tipo di pubblico vuole raggiungere ponendosi all’incrocio dei nuovi linguaggi, ecc. Un teatro pubblico dovrebbe proprio chiedersi come formare gli spettatori dentro una società liquida come la nostra, come essere stabile e pure in movimento, dunque non monolitico ma sviluppato a macchia di leopardo. Una vera, grande città teatrale di livello europeo si fonda sull’artico- speciale teatro pubblico — 29 Renato Quaglia Accettare la crisi per aggiornare i modelli C erto lo Stato (e con esso le articolazioni dell’Ente pubblico ter- ritoriale) deve proseguire a finanziare la cultura. Dovrebbe continuare a farlo anche se fosse finalmente capace (come non è) di decretare un sistema di norme e leggi di defiscalizzazione o agevolazione dell’intervento privato a favore della cultura, per convincere imprese e cittadini a partecipare attivamente al sostegno dell’unico patrimonio produttivo nazionale, sul modello del sempre citato sistema anglosassone e d'oltreoceano (dove la spesa pubblica non è comunque marginale, ma decisiva e diffusa, a differenza di quanto si tende erroneamente a far credere). L’investimento pubblico in cultura deve proseguire, seppur rimodulando le proprie ragioni sulla nuova situazione economica determinata dalla crisi. La crisi è internazionale, reale, strutturale. Sarà di lungo periodo e imporrà (o permetterà – dipende dai punti di vista) una ridefinizione dei valori e dei parametri su cui misurare i limiti e i costi dei nostri sistemi di produzione e consumo, della nostra socialità come dei nostri tenori di vita. Il sistema di produzione e di promozione teatrale (ma anche musicale) che affronta questa ennesima crisi di finanziamenti (che oltre che economica, è anche culturale e di futuro) è un sistema nato nell’immediato dopoguerra; che si è in parte articolato ulteriormente a partire dagli anni settanta; che ha scelto comunque modelli fondativi e di sviluppo novecenteschi. Modelli del secolo scorso, caratterizzati dalla costruzione di strutture complesse, solipsistiche e autosufficienti, che riproducevano completamente in sé, al proprio interno, l’intero ciclo di processo proprio del modello industriale novecentesco: dall’ideazione alla produzione e alla vendita, dalla gestione dell’offerta alla determinazione dei valore di giudizio del proprio stesso processo. È un modello di lavoro, di produzione e di gestione, basato su logiche di netta divisione disciplinare e auto-assunzioni di ruolo tipiche del secolo passato. Nasceva quando i telefoni erano apparecchi di bachilite nera, a muro e a filo. Apparentemente indifferente alle conquiste evolutive che nel frattempo hanno costretto a mutare irrimediabilmente e continuamente non solo la comunicazione telefonica e di scrittura, ma tutti i modelli novecenteschi, quello teatrale è uno dei pochissimi modelli che sia riuscito a tramandarsi ai giorni nostri senza evoluzioni sostanziali, approvando solo minime correzioni o declinazioni del proprio stesso archetipo originario. La presunta tenuta economica dei suoi livelli di sostenibilità (l’aver considerato sufficiente e bastante il livello di finanziamento e raccolta economica che gli si offriva, anno dopo anno) è stata probabilmente la ragione che ha convinto nel tempo almeno tre generazioni di questo sistema dell’inutilità di ogni cambiamento sostanziale, a favore di una quieta deriva, cullata da annuali micro-assestamenti della sua struttura di funzionamento. Forse però la grave e strutturale crisi iniziata da alcuni anni in Europa – che inizialmente pareva attestata su scenari finanziari di carattere macro, e ora si dichiara invece nella sua quotidiana e concreta durezza sui micro-scenari della vita comune – determinerà dei bruschi smottamenti nella lenta deriva intrapresa, che dovrebbero consigliare ridiscussioni di ruolo e di modi. Il sistema deve aggiornare i propri statuti, uscire dal- la propria disciplinata cristallizzazione, resettare le proprie arzigogolate modalità di auto-valutazione. Le discipline e i generi scelti (la musica, la lirica, la danza, la prosa o il teatro per ragazzi, quello di innovazione o quello di giro, quello promosso o quello prodotto...) potranno allora essere non più la ragione su cui fondare la propria differenza e affermare il proprio ruolo autosufficiente e solipsistico (e quindi il proprio posizionamento e la propria attesa di finanziamento pubblico). I generi potranno essere delle possibilità da attraversare contemporaneamente; le discipline d'arte diventare occasione per proposte indisciplinate da rivolgere a un pubblico curioso perché già acquisito da altri media al gusto e alla domanda di contemporaneo; la stessa idea di istituzione potrà essere ridefinita, diminuendone l’obbligo di assoluta autosufficienza di matrice industriale, a favore di più aggiornati modelli di rete; di funzioni condivise con altri soggetti; di ruoli temporanei e non più definitivi. Ruoli provvisori e non più assegnati una volta per tutte, da confermare periodicamente, rispetto a necessità e capacità che il territorio esprime, come proprio delle realtà in movimento, che assumono funzioni e interpretano ruoli in un continuo mutare e aggiornarsi, talvolta seguendo, talvolta anticipando una realtà che sull’innovazione dei propri statuti fonderà la sua fiducia di futuro. Cesare Lievi Avere come riferimento la realtà in cui si opera B isogna dirlo: rispondere alle domande che mi avete posto non è facile. Innanzi tutto perché presuppongono una visione generale del sistema teatrale italiano, la cui descrizione è assai complessa, come del resto ammettete, secondo perché all’interno di tale descrizione sarebbe necessario individuare e definire scopi e funzioni dei singoli componenti. Ad ogni modo si potrebbe rispondere, in maniera breve ma non impropria, che il peso «dell’intervento statale nelle strategie organizzative del nostro teatro nazionale» dovrebbe dipendere proprio da questi ultimi fattori: scopi e funzioni. Una realtà teatrale che si pone come fine il lucro non può essere paragonata a una che agisce secondo altri principi e altre finalità, così come una fondazione lirica non può essere equiparata, per quanto riguarda scopi e funzioni, a un teatro stabile, e questo a uno privato o a uno di innovazione o a un teatro comunale, ecc. ecc. A questo punto però il discorso, invece di concludersi, si complicherebbe facendo nascere spontaneamente le domande: quali sono i fini e le funzioni delle singole realtà? Chi li stabilisce? Chi verifica la loro realizzazione? E poi: l’intervento deve essere solo statale o anche degli enti locali o magari solo di essi? Ed esistono già strutture in grado di meritare il massimo delle attenzioni statali (e più in generale pubbliche) o queste sono inesistenti, latitanti e compromesse con il sistema generale, per cui la loro azione appare indistinta e per niente efficace? Conta il prestigio e la tradizione o valgono i meriti conquistati sul campo? E poi ancora: il privato, che ruolo deve coprire? Come vedete la matassa dei problemi è assai aggrovigliata e io veramente – almeno in questa sede – non sono proprio in grado di districarla. Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, mi è più facile rispondervi, perché me la sono posta molto spesso in questi ultimi anni come direttore del ctb, Teatro Stabile di Brescia, e continuo a pormela, quasi quotidianamente, anche ora come sovrintendente del teatro «Giovanni da Udine». Innanzi tutto penso che il teatro pubblico debba avere come riferimento primo la realtà in cui opera ed essere in grado di stabilire con essa un rapporto privilegiato in modo da rispondere, in termini culturali ed estetici, alle sue esigenze di comprensione del mondo. Il suo fine non è solo produrre, distribuire, ospitare spettacoli (il sistema italiano e la scarsità di finanziamenti obbligano, a differenza di molti altri Paesi, al «giro») ma soprattutto porsi come luogo vivo di cultura, cuore pulsante di una città. Non deve chiudersi su se stesso nel culto del Teatro, della Tradizione e dell’Arte, ma aprirsi il più possibile a tutte quelle forme e quei contenuti (e non sono pochi) che, per sua peculiarità, è in grado di coinvolgere e mostrare. E non per cadere nell’eccesso opposto della distruzione, della negazione e dell’oblio, ma per coordinare e determinare quel fondamentale equilibrio tra conservazione e rinnovamento, ricordo e sparizione, vecchio e nuovo senza il quale, ora, penso sia impossibile avviare nessun progetto di comprensione del mondo. speciale teatro pubblico lazione di più proposte, ciascuna con la sua autonomia. Un teatro stabile, un grande regista, un grande attore non dovrebbero mai pensare che il loro pubblico sia l’unico, semmai dovrebbero chiedersi come ampliare il proprio pubblico: la vita del teatro è fatta di confronti non di esclusive. Penso a un teatro stabile come a un luogo in cui tutto ciò che si fa serva per conoscere anzi per riconoscere qualche cosa: per esempio l’esperienza, un itinerario conoscitivo. In questo senso penso a un teatro stabile come luogo ideale (ma non astratto), dove sia possibile fare crescere un teatro contemporaneo non solo mettendo in scena testi di oggi, ma pensando alla contemporaneità come qualcosa che investe il teatro nella sua totalità ben aldilà di qualsiasi luogo comune. Il teatro è un modo, uno strumento che ci permette di orientarci nella contemporaneità, ma non il modo in cui sentirmi contemporaneo. Stabile è un teatro che dovrebbe vivere con la continuità di una lunga prospettiva di lavoro con una stessa compagnia. Il teatro è continuità, l’importante è che ci siano possibilità per cercare «altre» continuità, il che non significa creare degli altri teatri stabili, ma ribadire la necessità del confronto. 30 — dove va il teatro pubblico italiano? Ma per fare questo, il teatro deve essere veramente libero e sempre più impegnato a costruire se stesso come luogo pubblico della «problematizzazione» di ciò che siamo stati, siamo e ci accingiamo a essere. Luogo della proposta e della discussione. Il più possibile chiara. Sincera. Partecipe. Luogo dove una società magari ritrova se stessa in nome della conoscenza, della cultura e – perché no? – del suo equilibrio e della sua felicità. Pietro Valenti Un ruolo di cuscinetto tra creazioni artistiche e pubblico I dove va il teatro pubblico italiano? n primo luogo penso che il teatro pubblico abbia come punto di rife- rimento il territorio dove opera. Secondo me la sua funzione si esplica prevalentemente su questo piano, e dunque la questione centrale consiste nel collegamento che riesce a sviluppare con il territorio che abita e dove produce spettacoli. In secondo luogo bisogna dire che in questo momento nessuno riesce a dare al teatro pubblico una missione. Perciò queste istituzioni si inventano delle missioni sulla base delle richieste che partono dal loro territorio. Un’altra cosa importante è che i teatri pubblici, per questa ragione, non possono essere tutti uguali: ognuno di loro ha una funzione che può essere anche molto diversa a seconda del contesto in cui si trova a operare. Non è pensabile che il teatro pubblico di una grande città sia identico a quello di un centro più piccolo. C’è un’ecologia all’interno del teatro che mi porta ad affermare che il ruolo prevalente nelle realtà medie come quella che dirigo io sia quello di coltivare il lavoro artistico in attesa che questo si rafforzi e diventi importante e riconosciuto. Vale a dire aiutare i giovani drammaturghi, attori e registi a formarsi quell’esperienza che poi permette loro di raggiungere obiettivi sempre maggiori. Certo il tema del teatro pubblico è stato molto dibattuto, e tutti noi facciamo riferimento all’esperienza strehleriana, cioè a un teatro che vuole essere servizio pubblico. Credo che questo sia il nodo intorno al quale ognuno di noi lavora, e in questo senso immagino la diversità come ricchezza. Quando penso all’ert credo sia un teatro sempre in movimento, che ha un rapporto molto intenso con le realtà del suo territorio, che ascolta quello che di nuovo emerge in esso. Insomma, nel concetto di teatro pubblico io vedo presenti l’ascolto, la passione, la curiosità e tutti quegli elementi che permettono di essere attenti a quello che succede attorno a noi. Credo inoltre che al teatro pubblico spetti il compito di mettere al centro il contemporaneo. Il teatro che nasce e vive oggi va accompagnato nella sua crescita e nel suo sviluppo. Per questo mi sembra più importante per noi produrre un teatro che sia contemporaneo invece che un classico come Goldoni, oppure, all’interno del progetto europeo Prospero, sostenere i Menoventi (una giovane compagnia della nostra Regione). In questo modo intendiamo svolgere un ruolo di cuscinetto tra le nuove creazioni artistiche e il pubblico. Infatti cosa fondamentale e distintiva del teatro pubblico è proprio... il pubblico, che noi intendiamo come spettatore attivo e pensante, che non subisce passivamente quello che gli viene proposto. Come ultima considerazione aggiungo infine che – per poter realizzare gli obiettivi che ho brevemente tratteggiato – ciascun teatro pubblico dovrebbe poter contare su una direzione almeno triennale, che assicuri la continuità e una stabilità non condizionate dalla politica. Edoardo Erba Incentivare la coproduzione fra pubblico e privato F rancamente sono più preoccupato delle sorti del teatro privato che di quello pubblico. Con contributi tagliati e perennemente in ritardo, con una ridotta disponibilità degli enti locali a comprare spettacoli per i teatri in provincia, i produttori privati sono allo stremo. La loro ridotta operatività fa in modo che migliaia di famiglie di lavoratori dello spettacolo si trovino in seria difficoltà. E che la tradizione tutta italiana del teatro itinerante sia in serio pericolo, se non in via di estinzione. Questa situazione mi pare ben più grave di quella dei teatri pubblici. Lo dico anche per un evidente interesse personale. Se il teatro privato non avesse creduto nel mio lavoro farei ancora spettacoli nelle cantine romane. In più di vent’anni di attività, dal teatro pubblico ho ricevuto due solo com- misioni: una dal Metastasio di Prato, che ha prodotto un ottimo spettacolo ma si è rivelato incapace di circuitarlo, e uno dalla Compagnia del Dramma Italiano di Fiume, che però è in Croazia. Se fosse solo un caso personale, non sarebbe grave. Ma il teatro pubblico ha dimostrato di non credere a tutta la nuova drammaturgia italiana, ha investito sugli autori poco e niente, e non ha sfruttato il nuovo repertorio che si andava formando. Si tratta insieme di un ritardo culturale e di un’ottica distorta, che ritiene – come accadeva nel secondo Novecento – che il regista sia la figura centrale attorno a cui ruotano le altre competenze. Nel ventunesimo secolo le figure si sono livellate, è maturato un gioco di squadra dove talvolta è il regista, talvolta l’attore, altre volte l’autore a fare da perno. La figura del regista-demiurgo appartiene al secolo passato, e penso che fra dieci, vent’anni ce ne accorgeremo anche qui. Non ho mai capito bene quanti soldi prendono i teatri pubblici, credo che una prima cosa per fare chiarezza sarebbe pubblicare i bilanci sui depliant che si usano per vendere la stagione agli abbonati. Ho l’impressione che gran parte dei contributi ministeriali siano spesi per mantenere strutture interne elefantiache. E il resto per produzioni dove il risultato non conta: che lo spettacolo sia bello o brutto, sia un successo o un fiasco, poco importa, tanto il «prodotto» si sottrae alle regole del mercato che invece i privati subiscono crudelmente. L’unica proposta che mi sento di fare è che venga incentivata – con sgravi fiscali e innalzamento dei contributi – la coproduzione fra pubblico e privato. È un semplice spiraglio, attraverso cui far entrare linfa nuova nelle cattedrali del teatro italiano. Fabio Nieder Rinverdire il repertorio e far vibrare i classici A nche se vivo in Germania e non ho particolare dimestichezza con le nuove leggi che stanno affliggendo il panorama culturale italiano, la mia impressione è che, in generale, il teatro musicale sia rimasto un po’ provinciale, legato all’opera di repertorio e a realizzazioni sceniche tendenzialmente obsolete. Che senso ha riproporre come presente il passato? Un’opera può infatti essere pensata e ripensata registicamente in maniera profonda, senza che questo voglia però dire sovrapporre una sorta di nuova drammaturgia a quanto è già partitura e libretto. Non amo molto le ultime mode, come quella che individua la figura del «regista-drammaturgo». La drammaturgia di un’opera di Čajkovskij, ad esempio, è già scritta e impostata dalla struttura musicale. Invece al giorno d’oggi accade che si cerchi di modificarne l’assetto sovrapponendovi un’altra storia. E tuttavia, anche se rispetto a questa tendenza rimango molto critico, penso anche che – come ad esempio avviene a Monaco di Baviera, dove i tre teatri lirici sono sempre esauriti, sia che vada in scena il repertorio sia che vengano proposti lavori contemporanei – ci dovrebbe essere una maggior cura nel ricercare registi che possano dare un senso di contemporaneità anche ai classici, tirandone fuori l’essenza per proporla in maniera viva, attuale e ancora sorprendente. Bisogna fare in modo di restituire quella freschezza e quello stupore che senz’altro hanno toccato la sensibilità del pubblico nei secoli addietro e che devono tornare a far vibrare di emozione le platee odierne. Fiamma Nicolodi Lo Stato dev’essere il primo finanziatore N on è dubbio che, tenuto anche conto di quanto poco peso (fatta eccezione per il Teatro alla Scala di Milano) rivestano nei bilanci delle istituzioni teatrali i contributi dei privati, sia sotto forma di società sponsorizzatrici, sia sotto forma di soci a vario titolo sostenitori, benemeriti, ecc., il fus debba contribuire in maniera più consistente di quanto oggi non accada al regime finanziario dei teatri pubblici (mi riferisco in particolare alle Fondazioni Liriche, realtà che conosco meglio e che, per ovvie ragioni, costano molto di più di un Teatro Stabile di prosa). E ciò principalmente in considerazione dell’interesse pubblico che dette istituzioni rivestono. Non è detto che ulteriori, più consistenti sgravi fiscali saprebbero attirare maggiori erogazioni finanziarie da parte dei privati, ma sarebbe comunque utile tentare, sulla scia di quanto, per esempio, già accade negli Stati Uniti. Non penso comunque che lo Stato debba e possa, in prospettiva, sottrarsi al suo ruolo di primo finanziatore delle attività culturali e dello spettacolo. Esiste anche il pericolo che sponsor privati, divenuti decisivi sul piano del bilancio, vogliano esercitare un’influenza preponderante sulla programmazione dei teatri, soprattutto nel senso di scelte più corrive. Già adesso, d’altronde, mi pare che le Fondazioni Liriche vadano troppo incontro ai gusti del pubblico, privilegiando il repertorio più prevedibile, e dimenticando le loro evidenti, insostituibili funzioni educative, sia sul piano del gusto, che su quello storico-culturale. Il Novecento, per esempio, è un secolo ricchissimo di capolavori operistici, tutti poco o punto frequentati dai nostri teatri. Quanto al problema della fruizione, credo che una più avveduta campagna dei prezzi (oltre che per fasce di età, differenziabili in base alle condizioni socio-economiche degli spettatori o al tipo di spettacolo: nuovo allestimento o ripresa, titolo noto o raro, compagnia titolata o di giovani, ecc.) potrebbe aiutare ad allargare la base dei frequentatori. Infine, sul fronte delle scelte artistiche, mi sembra che – almeno per quanto riguarda i principali allestimenti delle stagioni liriche – la parte musicale (direttore d’orchestra e cantanti) tenda a passare in subordine rispetto alla componente spettacolare, per la quale troppo spesso si ricorre non a registi specializzati nel genere musicale, ma a nomi più o meno celebri provenienti dalle arti sorelle (cinema, teatro di parola, danza), cooptati più a fini pubblicitari che in ragione delle loro intrinseche capacità professionali. Franco Cordelli Accrescere i finanziamenti per favorire drammaturgia e ricerca A lla fine degli anni ottanta scrissi sull’«Europeo» un articolo piut- tosto aspro sull’idea di teatro-azienda in quel lasso di tempo promossa dal Partito socialista. Mi valse una piccola polemica (telefonica) con il Ministero dello spettacolo. Adesso che quell’idea è andata sempre più diffondendosi ovviamente il mio punto di vista non è mutato. Al contrario, lo ribadisco con energia pensando al fatto che in Germania, finanziati dallo Stato, vi sono più di quattrocento teatri. I nostri non arrivano a quaranta. Mi rendo conto delle difficoltà economiche generali, ben più gravi che venticinque anni fa. Ma proprio per questo il finanziamento pubblico dovrebbe essere accresciuto. In che direzione? Non vorrei parlare in modo generico. Allora chiarisco che compito del teatro pubblico dovrebbe essere innanzitutto quello di mantenere viva la tradizione drammaturgica mondiale, possibilmente ampliando l’orizzonte non solo degli autori ma anche delle loro opere. In secondo luogo, sarebbe ragionevole sostenere quella ricerca che ha cominciato ad affermarsi spontaneamente, in teatri privati e più piccoli. Considerando che i grandi teatri privati sempre più effettueranno le loro scelte sulla base del già conosciuto o del molto conosciuto, i teatri Stabili e gli Stabili di Innovazione dovrebbero costantemente tener d’occhio questo restringimento crescente nella varietà dei cartelloni. Dunque, la loro guida si dovrà configurare come sempre più complessa e culturalmente avanzata. Geppy Gleijeses Sostegno pubblico al teatro d’arte C ari Amici, senza intervento dello Stato, il teatro di qualità, il teatro d’arte a cui siamo abituati non può esistere perché i suoi costi non sono sostenibili con gli incassi del botteghino, viste le gabelle a cui lo Stato ci sottopone che sono assai più consistenti di quello che poi ci restituisce. Se vogliamo rispettare la nostra cultura e tradizione e rimanere in Europa si deve capire che è impossibile farlo senza un sostegno pubblico, in qualsiasi modo corrisposto. Giovanni Morelli Fare futuro C iò che nel quesito è indicato come «sistema ora vigente» sta vi- vendo al momento una crisi che talvolta e non solo a tratti sembra terminale. La cosa potrebbe aprire il campo a una solenne «tempesta di cervelli e pensieri» di cui non si avvertono però segnali premonitori. Per quel che concerne il settore musicale che personalmente «vedo» più distintamente, mi permetto di osservare che la funzione di «museo» assunta nel XX secolo dai teatri ed enti di grande e media tradizione (liri- ca e concertistica), ha superato il punto critico della insostenibilità economica e della fine della sua stessa funzione (già che, conoscitivamente parlando, il museo espone un repertorio smagrito ed emaciato oltre ogni immaginario possibile, che accede alle «novità» con esplicito atteggiamento di osservanza di atti dovuti imposti da un senso di accondiscendenza ad uno stereotipato modello di rispetto per la creatività che è ben poco condiviso dal pubblico «specializzato», abitudinario, abbonato, senile e nostalgico dei teatri lirici, e che, infine, non fa più il ruolo del museo da quando ha chiuso le porte ai volonterosi esperimenti di allargamento dei repertori sotto lo scudo della ricerca scientifica musicologica). Non credo che duri a lungo l’impegno nell’investimento «turistico» già che gli stessi non sempre garantiti pienoni non sostengono minimamente una immaginaria autonomia produttiva delle cose come stanno. Credo che nel sogno di una palingenesi quelle che ho chiamato «le cose come stanno» debbano essere restituite alla iniziativa tutto-privata, di un impresariato geniale, del tutto responsabile (more classico ac veneto) dei suoi forse inevitabili tracolli. L’intervento pubblico dovrebbe essere riservato, invece, a tempo determinato, possibilmente con atti di fiducia non rinnovabili se non in termini di continui scatti evolutivi, a progetti sperimentali di contatto con pubblici viventi, non sopravviventi: bambini, giovani, outsiders; progetti del tutto riservati alla illuminazione della contemporaneità, della attualità etnica e planetaria, al futuro digitale e soprattutto post-digitale. La corsa all’apertura di questo campo dovrebbe essere il più conflittuale possibile, atta a evidenziare un numero preoccupante ma eccitante di tendenze, di rivalse della marginalità, di riscoperte delle gioie della pratica della antitesi, di rinnovamento dell’etica dell’avanguardia, ma, nb, men che mai culto della «storicità» della stessa. Pur sapendo di stare parlando di un sogno, credo fermamente che lo stagnare della crisi favorirà l’avvento di qualcosa di epocale che accenderà molto combustibile da troppo tempo pressato in aree di stoccaggio, arginate da cumuli di mobbing e di stalking. Giuliano Scabia+Quinto Orazio Flacco Viva Mecenate I o sono un piccolissimo teatro privato mai stato finanziato (mai ho chiesto contributi), ho partita iva, ricevo cachet per gli eventi letture regie laboratori. A volte ingaggio musicisti o attori, a mie spese o a spese di chi mi invita. Essere azienda libera da qualunque dipendenza mi fa bene, così scrivo e canto come e dove voglio. Sono stato legato per diversi anni all’Università di Bologna, ente pubblico, come docente di drammaturgia, e ho potuto usufruire dei beni, limitati ma costanti, che l’Università come luogo di ricerca mette a disposizione se ci si impegna profondamente e duramente per costruire modificare rinnovare le strutture (spesso inadeguate, in ritardo sul mercato tecnico) che l’istituzione mette a disposizione. Sempre il rapporto con un teatro o lirico o di prosa, dove si accumulano professionalità eccellenti, è stato nella mia esperienza (ho dovuto inventare un itinerario, era la prima cattedra di drammaturgia in Italia: 1972: non provenivo dall’accademia ma dalla libera professione) fondamentale. Anche all’Università ho cercato di lavorare da professionista del teatro mettendo gli studenti collaboratori in relazione con enti pubblici a privati per realizzare spettacoli e tournées di formazione, secondo me fondamentali per non rimanere intrappolati nel sogno d’oro della scuola (sogno d’oro che non va eliminato, ma va fatto scontrare con la durezza e bellezza del lavoro). Credo che il teatro lirico come si fa in Italia costi troppo – ma il livello va salvaguardato. Bisognerebbe studiare come lavorano a Praga, a Stoccolma, a Vienna, forse anche a Pechino, a Seul, a Shangai, ad Amsterdam, a Kabul. E a New York. Fare dei confronti. Ma confronti spietati, perché mi pare che i conti non tornino e la sparate demagogiche non servono a niente. E ci sono brutture che sarebbe meglio non fare. E (lo dice un poeta che va per campi e boschi perché quasi dappertutto in Italia gli hanno censurato e proibito i testi – è dal ‘79 che un Teatro Stabile italiano non mette in scena un mio testo, con tutti i soldi che hanno: così ho scelto di farmeli da me) ci vuole anche un po’ di spirito d’azienda, e non pensare che tutto sia dovuto dalla società: perché dopo tutti si trovano a essere clientes, e dipendenti e ricattabili. Ciò detto, viva i mecenati: da Olivetti a Pecci, da Ford a Pirelli, dal pci feste dell’Unità all’Estate Romana, da Peggy Guggenhaim a Maeght, da Lenin a Trotski, alla Biennale, allo Stato eccetera… ah, Mecenate… dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 31 32 — dove va il teatro pubblico italiano? Leonetta Bentivoglio Un Requiem per la lirica? D dove va il teatro pubblico italiano? a quando lavoro come giornalista culturale occupandomi so- prattutto di musica classica e di lirica – ormai si parla di un paio di decenni – il genere di domanda che mi avete rivolto (formulato in vari modi, ma sostanzialmente uguale) si riaffaccia e incombe come una specie di condanna o tormentone. Non c’è anno che il giornale per cui lavoro non mi solleciti a scrivere interventi o inchieste sul tema. Soldi pubblici o privati? Sistema privatistico americano per le istituzioni culturali, o modello semipubblico europeo? Sopravvivrà la lirica alla grande crisi? Chiuderanno i teatri più piccoli? Qual è il destino dell’opera? Non so neanche più quanti articoli ho fatto sull’argomento. Davvero una marea. Né riesco a ricordare quante volte mi è capitato di ripetere le stesse cose, o di raccogliere pareri dei vari esperti che a loro volta dicevano sempre le stesse cose. Mi domando quale tipo d’aiuto possa dare al lettore un ennesimo sondaggio, e non penso che la risposta al vostro interrogativo possa essere data alla spicciola, in poche righe, trattandosi di un territorio particolarmente vasto, dibattuto e complesso. Ma «Venezia Musica e dintorni» è una rivista troppo bella e curata per dirvi di no. Perciò provo a rispondervi, limitandomi a segnalare (per l’ennesima volta) che i teatri lirici costituiscono delle realtà culturali assolutamente anomale, in quanto mastodontiche ed enormemente vulnerabili, nel senso che per le loro dimensioni ed esigenze specifiche non possono essere assimilate ad altre istituzioni culturali, e neanche agli altri teatri pubblici (quelli che accolgono e producono la prosa). Le case d’opera riuniscono infatti dipendenti molto diversi tra loro (orchestrali, coristi, ballerini, tecnici di scena, impiegati amministrativi, artigiani…) in numero assolutamente anti-economico, inconciliabile con qualsiasi criterio imprenditoriale, con orari ed esigenze di lavoro differenti e con sindacati tuttora fortissimi. Per questi ed altri motivi, non si potrà mai pensare a un teatro d’opera come a un’azienda produttiva e degna di forti investimenti da parte di finanziatori con intenti speculativi. È chiaro che l’intervento statale è necessario per questo tipo di «assurde» istituzioni, con le loro spese fisse abnormi per il mantenimento delle masse. Mettere in discussione il sostegno dello Stato significa contemplare la possibilità della cancellazione della lirica dal vivo. La domanda da fare è quindi un’altra: è rinunciabile la lirica, così come sono rinunciabili i grandi musei? Ci si può permettere di condannarla a morte? L’ipotesi non è così remota: sappiamo quanto fastidioso suoni il termine «cultura» ai politici che ci governano. E il pericolo è che all’indifferenza dello Stato, e al suo progressivo disimpegno in questo settore, non corrisponda affatto il tanto auspicato arrivo di denaro da parte dei privati, che non sono mai stati stimolati (come accade negli usa, e anche questo è stato già detto milioni di volte) da una legge che consenta loro di detrarre fiscalmente eventuali contributi. Dunque, nelle attuali contingenze economiche, si rischia veramente l’agonia. Non vedo soluzioni e ricette che prescindano da considerazioni molto più ampie e di ordine politico, economico e sociale. Se s’insisterà nel valutare tutto (come si tende a fare) nella prospettiva di un rapporto causaeffetto tra programmazione e fruizione (cioè consenso e incasso), i teatri d’opera, o almeno i più «deboli» tra di essi, chiuderanno. È inevitabile. E non si può non tenere conto, parlando di cultura, di quanto sta accadendo nel sistema dell’istruzione pubblica in Italia, sia sul versante della scuola che dell’università. Da tempo, nel segno di una precisa strategia politico-sociale, si stanno minando le basi più elementari della formazione di un futuro pubblico, non soltanto musicale. Credo sinceramente che non abbia senso parlare della consapevolezza culturale di un Paese (come fate nella vostra domanda, cercando risposte che riguardano «le caratteristiche e le funzioni prioritarie del teatro pubblico») senza prima riflettere sulle conseguenze del violentissimo processo di diseducazione collettiva al quale stiamo assistendo. A chi dovrebbe rapportarsi la lirica dal vivo del terzo millennio? A quali spettatori sarà destinata? Luca Francesconi La vera arte è sempre ricerca C redo possa essere utile porre una sorta di cesura fra ciò che è in- trattenimento e ciò che è cultura. Per quel che riguarda il primo caso, ci si basa sull’idea di profitto e accade che vengano rimesse in circolazione delle formule conosciute e preesistenti, comprensibili a tut- ti: si sfruttano idee già realizzate con lo scopo di far rilassare e consentire l’evasione e la distensione. Anche per quel che concerne lo spettacolo di intrattenimento, tuttavia, esiste la qualità: vi sono infatti forme di distrazione intelligenti e forme invece enormemente sciocche, che distinguono l’intrattenimento divertente, apprezzabile sul serio, da quello assolutamente becero, che ha un facile successo perché fa leva su quei bassi istinti comuni a tutti gli esseri umani che la cultura dovrebbe in qualche modo riuscire a smussare e portare verso un’accettabilità. Mi riferisco a tutte le pulsioni di infima lega che riguardano la prevaricazione dell’uno sull’altro, quella muscolare e sessuale, insomma a quegli istinti molto primitivi che in una società moderna andrebbero controllati e regolati dall’educazione e dalla cultura. L’intrattenimento rientra nel mercato perché si avvale di funzioni e meccanismi conosciuti, riconosciuti, collaudati e in quanto tali giudicabili al botteghino, così com’è giudicabile se un’automobile ha un buono sterzo o un ottimo cambio. Tutt’altro discorso riguarda invece la ricerca artistica. Tutta la vera arte è da sempre ricerca e la cultura, dal canto suo, è una specie di seconda pelle dell’essere umano: l’uomo, non essendo solo guidato dall’istinto ma potendo contare anche su un po’ di ragione, ha dovuto costruirsi nel corso del tempo una seconda natura che stabilisse quali erano i confini e quali erano i modi per risolvere i bisogni reali (combattere le fiere, trovar da mangiare e sconfiggere il freddo) e per riuscire a non azzannarsi con il vicino che aveva le medesime esigenze. Tutto è quindi cultura, a partire dalla famosa scimmia che in una delle prime sequenze del film di Kubrick 2001: Odissea nello spazio lancia un osso e comprende che si sta assistendo alla nascita della tecnica. E della cultura. All’interno di questa seconda natura l’uomo ha stabilito e posto delle regole. A esplorare i confini e le frontiere di senso che delimitano tale territorio sono gli artisti. Ma questi confini si spostano in continuazione e ciò che costituisce o meno il senso, ciò che conta e ciò che non conta viene stabilito e ristabilito in continuazione, in ogni epoca e in ogni ora, in tutte le culture e durante tutte le stagioni dell’umanità. Tale ricerca è da sempre affidata all’arte: la tecnologia ha parcellizzato i corpi sociali, ormai la massa è un mero insieme di individui e non esiste più un punto di riferimento per la qualità delle cose. Una delle grandi rivoluzioni attuate dai media è la distruzione della memoria, per cui il senso deve diventare leggero e reversibile: non avendo più un radicamento verticale nella storia, nell’esperienza, nella cultura, viene reso plastico e trasformato in maniera orizzontale. I sottoposti, gli schiavi di una volta, coloro che non hanno il potere sono stati convinti e illusi da questo sistema di assomigliare molto da vicino a coloro che invece il potere lo hanno. Lo si può ravvisare ad esempio nella corsa folle delle ragazzine, che sgomitano pur di comparire anche per un solo minuto in televisione intesa come l’unico mezzo che certifica l’esistenza. È davvero agghiacciante. Credo che l’unica arte possibile, a maggior ragione in una situazione di questo tipo, sia un’arte di ricerca, che, in quanto tale, deve essere finanziata dal pubblico, il quale dovrebbe comprendere che la cultura è alla base dell’aggregazione sociale. In questo momento, purtroppo, si sta facendo di tutto, in maniera assolutamente miope e per ragioni di tornaconto immediato, per fare a pezzi questi fondamenti comuni. La consapevolezza culturale è molto importante, ed è quella che permette di utilizzare il cervello e non delle teorie dogmatiche preconfezionate per capire il mondo. Maturando un sempre rinnovato interesse per la cultura, andrebbe creata una struttura di sostegno alla ricerca e alle arti, distinguendo ciò che è intrattenimento e rende un immediato profitto da ciò che è ricerca. L’aspirina vende da sola, non servono sovvezioni statali, mentre la ricerca sulla distrofia o sul cancro ne ha bisogno in quanto non si tratta di un processo che permette guadagni tempestivi. Nessun privato offre i propri soldi se non li può vedere tornare indietro moltiplicati il giorno dopo. Il bene della collettività deve essere garantito dal pubblico. Ogni musica vera parla del tempo che le è attuale e non bisogna dimenticare che il nostro tempo non è quello di Mozart, non è l’epoca in cui per andare da qui a Praga ad ascoltare una sinfonia dal vivo si doveva affrontare un viaggio in carrozza di almeno una settimana. Al mondo d’oggi si schiaccia un tasto e su youtube si vede e si ascolta tutto ciò che si vuole senza nemmeno spostarsi dalla propria poltrona. Sono cambiate molte cose e la cultura deve servire ad aprire gli occhi. I problemi non si risolvono facendo finta che non ci siano: bisogna innanzitutto guardarli, starci male, arrabbiarsi per poi trovare le forze per lottare e cambiare le cose. Il nostro petrolio è il talento e mi sembra miope non investirvi. Non si può vivere di rendita su Dante e Michelangelo da qui all’eterni- tà. Bisogna invece ricordare come anche loro abbiano fatto ricerca, cercando quei confini di senso in continuo movimento. Certo ci vogliono anche delle regole, bisogna creare una struttura che permetta alle persone di lavorare e vanno stabiliti criteri di merito e qualità. I teatri nel loro assetto attuale non sono efficienti e i finanziamenti a pioggia su mille piccole istituzioni sono un’altra forma di clientelismo che non serve assolutamente a niente. Dino Villatico Un Paese da rottamare! E visto che ci siete, rottamate anche il teatro! I problemi, per non dire i disastri, del teatro italiano hanno radici re- mote. Esattamente nel periodo, in cui, tranne una piccola minoranza illuminata, la cultura italiana, anche quella più aggiornata, per esempio Manzoni, voltò le spalle alle modernizzazioni introdotte dalla Rivoluzione Francese, e recepite perfino dalla storica nemica della Francia, l’Inghilterra. Per non parlare del Paese che ha radicalmente, e per ben due volte, trasformato il palcoscenico europeo: la Germania, dapprima con l‘esperienza di Goethe a Weimar e di Lessing ad Amburgo, che inventarono di fatto la regia moderna, e nel secondo Ottocento con la rivoluzionaria concezione e realizzazione teatrale di Wagner. Significativo che tanto in Francia che in Germania non si facesse distinzione tra teatro musicale e teatro cosiddetto di prosa, tant’è vero che Wagner ebbe un influsso decisivo sugli spettacoli teatrali francesi e tedeschi e stimolò perfino la riflessione teatrale di uno Stanislavskij, in Russia. Di questo influsso determinante del teatro francese e tedesco sulla scena europea sono una spia grandissima il numero sempre crescente, nel teatro musicale, di opere tratte da opere teatrali francesi e tedesche. A cominciare dal Barbiere di Siviglia di Paisiello e dalle Nozze di Figaro di Mozart. Ma che cosa avrebbero composto, tanto per limitarci ai due sommi dell’Ottocento italiano, Rossini (che si misurò anche lui con il Barbiere di Beaumarchais) e Verdi, senza Voltaire (Semiramide e Alzira), Schiller (Guillaume Tell e Don Carlos, e Masnadieri, Luisa Miller), Dumas (La traviata), Hugo (Ernani, Rigoletto), e così via? Perfino Beethoven prende a modello un opéra comique1 francese per il suo unico capolavoro teatrale (ma andrebbero riconsiderate anche il balletto Le creature di Prometeo, bellissimo e francesissimo, e le musiche di scena, inimmaginabili senza il clima – e lo stile! – delle musiche della Rivoluzione: dietro quasi tutte le marce beethoveniane, infatti, Fidelio in primis, si trasente sempre un’eco della Marsigliese). Dunque anche in Italia quella rivoluzione teatrale venne assimilata dai musicisti, ma anche dagli attori, dagli impresari, basta leggere le memorie di un’attrice del livello di Adelaide Ristori. Un po’ meno, per non dire nient’affatto, dalle istituzioni e dai governi. Sia prima che, ancor più, dopo la raggiunta unità del paese. «Le difficoltà interne alla struttura teatrale verificano un’impasse ulteriore con l’unificazione nazionale. Lo Stato decise drasticamente che strumenti di unificazione culturale fossero essenzialmente la scuola e l’esercito, e non già il teatro. Stabilì pertanto d’investire in quei settori e non nel teatro. Né la Destra né la Sinistra (quest’ultima sia quando era all’opposizione che quando divenne forza di governo) pensarono mai seriamente – fatta eccezione ovviamente per singole posizioni del tutto marginali – che il teatro meritasse un discorso organico. Non solo non fu ipotizzata una legge che assicurasse delle sovvenzioni ai teatri, ma fu votata una legge che soppresse le sovvenzioni che già c’erano»2. La rivoluzione, in Europa, era consistita nel fatto che da intrattenimento il teatro era diventato un avvenimento culturale. Goethe, nel 1795, mette in scena a Wiemar l’Amleto di Shakespeare nell’adattamento dell’attore Friedrich Ludwig Schröder, ma riscrive scene intere per la rappresentazione, aggiornandole ai costumi e alle idee del suo tempo, e riservando per se stesso il ruolo del principe danese. Nello stesso anno scrive le pagine del Meister dedicate all’analisi della tragedia shakespeareana. Nasce qui l’idea di riscrittura drammaturgica dei classici, che i teatri tedeschi praticano tuttora, e che tanto scandalizza il nostro pubblico, che si dimostra al solito provinciale e conservatore: nei teatri tedeschi è prevista, infatti, fin dal Settecento, la figura del Dramaturg per ogni spettacolo, talora uno scrittore, come Heiner Müller al Berliner Ensemble, ma più spesso un regista, come Peter Mussbach alla Staatsoper unter den Linden, sempre a Berlino. In ogni caso non sempre il Dramaturg è anche scrittore di teatro: la sua funzione non è di scrivere opere nuove, bensì di riscrivere la drammaturgia di un’opera già scritta, per adattarla all’interpre- tazione che di volta in volta se ne vuole dare. Uno spettacolo in Germania assomiglia pertanto di più a un saggio critico, che alla pura e semplice lettura del testo rappresentato. Questa impostazione dello spettacolo teatrale ha oggi conquistato i palcoscenici di tutto il mondo: quasi solo l’Italia sembra opporvi resistenza. Da che cosa nasce questa resistenza? o da che cosa è dettata la supponenza di un ministro della Repubblica che denigra gli attori chiamandoli «fannulloni»? Una grande attrice mi confessò indignata di sentirsi profondamente offesa dalle dichiarazioni del ministro: «Ho recitato con 39 di febbre per non far saltare la rappresentazione e rovinare la compagnia!». L’attore, il musicista, per l’italiano medio è poco più di un clown. In Inghilterra ottiene il titolo di baronetto. Sta qui la differenza tra noi e l’Europa. Non solo: ma in Francia, in Inghilterra, in Germania, non si parla di «sovvenzioni», cioè di elemosina, bensì di «finanziamento», anche quando sostenuto dai privati. Perché l’idea di servizio pubblico non consiste nel fatto che sia lo Stato a sostenerlo, bensì nella destinazione della sua funzione. Un teatro, un ospedale, una scuola, sono d’interesse pubblico non perché statali, ma perché rivolti alla cittadinanza, la interessano, perché si occupano della sua cultura, della sua salute, o della sua educazione. È questa cultura della convivenza civile che manca agli italiani: l’idea che un servizio, gestito che sia dallo Stato o dai privati, resta comunque, proprio perché servizio, un servizio d’interesse pubblico. Fino a che la nostra classe politica, ma anche il pensare comune degli italiani, non entrerà in questo ordine di idee, la scuola, il teatro, i musei, si vedranno costretti a vivere alla giornata, a elemosinare una sovvenzione appena sufficiente a nascondere l’immondizia sotto il tappeto. E non si venga a parlare di sprechi, che certo ci sono, ma non sono quelli che si pensa dai più e soprattutto dai ministri che s’improvvisano d’un tratto intenditori di teatro, di musei, di siti archeologici, di libri, quando forse nella loro vita avranno sì e no visitato magari Ostia antica e gli Uffizi e letto uno o due libri, magari il best seller del giorno! Un allestimento costoso incide per una minima parte nella gestione di un teatro. A incidere sono le spese correnti, non quelle straordinarie. Le maestranze devono ricevere lo stipendio tutti i mesi, anche quando non lavorano. Che fare, dunque? La crisi, certo, non colpisce solo l’Italia. Ma un paese dalle strutture fragili la sente di più. E le nostre sono fragilissime. Rimboccarsi le mani per l’Italia dovrebbe dunque significare soprattutto due cose: detassare integralmente il denaro offerto ai teatri dai privati, ma detassarlo per davvero. Un ministro di qualche anno fa (di sinistra!) osò dichiarare che anche detassata, per il fisco quella somma costituisce una «presunzione di reddito» (sic!). Bisogna decidersi inoltre finalmente non a continuare a sostenere i carrozzoni dei Teatri Stabili e delle Fondazioni Liriche, così come sono giunti fino a oggi. Bensì a obbligare tutti, ma proprio tutti i teatri, a convertirsi al sistema tedesco del repertorio, con spettacoli in scena tutte le sere: il teatro di Monaco di Baviera chiude i battenti solo trenta giorni l’anno. Ogni città, anche la più piccola, dovrebbe avere il suo teatro, che apra i battenti tutte le sere con una compagnia fissa. Ciò eviterebbe agli attori le attuali massacranti e costose trasferte alle quali sono costretti in Italia, e permetterebbe al teatro musicale di offrire finalmente una scelta davvero vasta di opere in cartellone. Nel 2000 la Staatsoper unter den Linden di Berlino, oltre al repertorio tradizionale, da Händel a Wagner e Verdi, mise in scena venti opere del secolo che stava per finire, da Debussy e Puccini a compositori del secondo Novecento, alcuni ancora viventi, pescando nel vasto repertorio dei propri allestimenti, ma commissionò anche due nuove opere a un compositore americano, Elliott Carter, What the Next? e a un compositore britannico, Harrison Birtwistle, The Last Supper. E furono strepitosi successi che riempirono il teatro tutte le sere. En passant, faccio notare che quello che è forse il più importante teatro tedesco ha commissionato le opere non a un compositore tedesco, ma a un americano e a un inglese. E non ne nacque nessuna polemica. Ci decideremo, noi italiani, una buona volta, a entrare davvero in Europa, anzi nel mondo, o dobbiamo ancora sentirci dire da un sindaco di una grande città come Milano che il kebab non fa parte della tradizione milanese e che dunque andrebbero chiusi i luoghi dove si prepara e si vende? È mai stata a Parigi la giunta comunale milanese? A Parigi si può mangiare il kebab da almeno settant’anni e non per questo i parigini sentono infranta la propria tradizione culinaria, di cui anzi vanno fieri. Ma vanno anche fieri di essere una città cosmopolita. note 1 Attenzione! opéra in francese è maschile. dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 33 34 — dove va il teatro pubblico italiano? 2 Roberto Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo ottocento, Bari, Editori Laterza, 1988, p. 19. Ernesto Napolitano L’opera è un bene pregiato (e dunque costa) N dove va il teatro pubblico italiano? on sono particolarmente ferrato sulle normative fra Fonda- zioni Liriche e lo Stato e, per fare un esempio, non mi è affatto chiaro perché lo Stato possa bloccare il turn-over e le assunzioni negli Enti lirici, assumendosi un compito che sembrerebbe spettare unicamente alla dirigenza dei teatri. Sarà per ingenuità, o per l’ignoranza cui accennavo, ma in un contesto che non assomigli a un protettorato, qualunque ente culturale riceva contributi dalla comunità (Università, Teatro, Museo) a mio parere deve godere della massima autonomia; salvo naturalmente rendere conto delle scelte sbagliate (tutte, non solo cachet esorbitanti o allestimenti zeffirelliani) e subirne, in sede di bilancio, le conseguenze. È solo in un orizzonte come questo, che vedrei il peso dell’intervento statale nelle «strategie organizzative e produttive» dei teatri: il più leggero possibile, quanto alle scelte, e il più severo, se è il caso, dopo i consuntivi. Tagliare i finanziamenti alla cultura (all’università, alla ricerca…), come fa un governo totalmente estraneo a queste cose? Se un intellettuale in vena di originalità non si fosse dichiarato qualche tempo fa favorevole al taglio dei fondi pubblici per la cultura (salvo, si apprezzi l’accoppiata: scuola e televisione), non metterebbe conto nemmeno parlarne. A parte che in qualche caso la cultura rende, anche nell’immediato, si tratta in genere di un bene a cui non possiamo chiedere di fornire dividendi il giorno dopo. Consegnarsi al mercato? Ci si domandi quanto ha pesato e quanto vale a tutt’oggi il contributo dei privati nelle Fondazioni liriche: utile, benvenuto, ma non certo decisivo. L’importante è non avere paura del fatto che la cultura, non parliamo poi di quella musicale, sia un bene elitario: è solo in questo modo, come ha osservato recentemente, per il patrimonio umanistico, Maurizio Ferraris, che riuscirà a non essere classista. Riconoscere ai teatri d’opera (parlo solo di quelli) il privilegio di gestire un bene pregiato, che costa un prezzo alla comunità, equivale a un’assunzione di responsabilità e impone un obbligo di competenze. L’attuale tendenza a sottovalutare, a volte a eludere, il senso e la qualità di una direzione artistica è un errore, significa lasciarsi colonizzare dai soli aspetti aziendali: importanti, ma non certo esclusivi, tanto più che poi le decisioni «artistiche» si prendono comunque. Resta il fatto che ogni direzione artistica implica indirizzi soggettivi e deve rappresentare un ciclo, non durare in eterno. Anche qui, l’importante è non pensare che i teatri d’opera, e nemmeno i musei, siano enti preposti alla «conservazione» di beni culturali. È sufficiente sfogliare il recente Dive e maestri di Philip Gossett, per capire quali e quante opzioni comporti, a direttori, registi, cantanti, la messa in scena di un’opera dell’Ottocento; solo che se ne sia consapevoli. Essere contemporanei, vivere nel presente, passaggio obbligato anche per le opere del passato, diventa una funzione ineludibile se pensiamo alla musica del nostro tempo; e di un tempo allungato, che nel nostro orizzonte culturale estenderei a ritroso ben dentro il Novecento. Ma è difficile chiedere intuito e coraggio a chi, anche solo per un sussulto di autocoscienza, è poco sicuro dei propri mezzi. Non sembra infine di troppo, almeno per i teatri maggiori, l’invito a seguire esempi europei: distinguendo un repertorio, con opere che si replicano per più anni, dalla novità di pochi e selezionati nuovi allestimenti, e complessivamente aumentando in modo decente il numero delle rappresentazioni. Giordano Montecchi Teatro versus Potere: la guerra dei mille anni D a sempre il potere ha cercato di controllare e plasmare l’imma- ginario degli individui a lui soggetti. E da sempre, forse non solo in Occidente, il teatro ha rappresentato una porta aperta su un «altrove» pieno di incognite. In quanto tale esso ha conteso al potere uno spazio, un varco attraverso il quale arricchire l’immaginazione degli uomini di storie e di fantasie. La lunga, interminabile «storia della libertà» ha sempre avuto fra i suoi protagonisti il teatro, l’antica fabbrica della fantasia, perennemente sospinto fra controllo ideologico e libertà potenzialmente sovvertitrice. L’inarrestabile deriva mediatica della democrazia postindustriale ha rilanciato prepotentemente un’esigenza di controllo dell’immaginario sociale di cui la teatralità, intesa come paradigma di tutte le forme di rappresentazione non mediate e quindi scarsamente controllabili, fa pesantemente le spese. In effetti prima di tramontare come luogo fisico, il teatro ha iniziato il suo crepuscolo scomparendo progressivamente dalle trasmissioni televisive che, originariamente, basavano gran parte dei loro palinsesti proprio sulla messa in onda di spettacoli teatrali. Ma via via che la tv andava imponendo il suo linguaggio e la sua rappresentazione del mondo, il teatro le diventava sempre più incompatibile. Il tramonto o, in una prospettiva meno catastrofista, la temporanea «eclissi» del teatro ha dunque prima di tutto un fondo ideologico; è il frutto dell’ostilità di un potere che aborre qualsiasi forma di linguaggio – dal teatro, ai giornali, alla letteratura, alla musica da concerto – che in quanto non omologata al codice televisivo lascia troppo spazio alla libertà del giudizio individuale e al pensiero critico. Non pare azzardato affermare che in Italia il sempre più vistoso ridursi dei finanziamenti statali allo spettacolo dal vivo (fenomeno tipicamente italiano), derivi non da penuria di risorse, ma proprio dall’imporsi del diktat televisivo come efficientissimo strumento di potere e dalla sempre più scoperta tendenza della classe politica a plasmare e amministrare la tv ai propri fini, prosciugando per quanto possibile gli altri concorrenziali affluenti dell’immaginario sociale. Il dissanguamento del sistema teatrale ha colpito più pesantemente i vecchi Enti lirici, dispendiosissimi carrozzoni la cui campana a morto ha iniziato a suonare dal momento della loro trasformazione in Fondazioni, cui avrebbe dovuto dare sostegno una partecipazione privata che le leggi vigenti, nel frattempo, continuavano imperterrite a disincentivare. Leggi che, per sovrammercato, riducevano senza sosta i finanziamenti continuando a imporre, con la inconsapevole quanto miope complicità dei sindacati, la sostanziale invariabilità degli organici. Nel giro di quindici anni questa lenta garrota ha trasformato i maggiori teatri d’opera in anacronistiche fabbriche di debiti, tanto inefficienti quanto impopolari davanti a un’opinione pubblica che, per lo più, vede nei tagli al fus l’eliminazione di inutili sprechi. Da questa trappola mortale di un’improduttività imposta per legge e alimentata dall’interno da incompetenze e clientele, altri soggetti hanno potuto difendersi relativamente meglio, in virtù di una struttura più flessibile, meno costosa e relativamente meno vulnerabile. È il caso dei teatri di tradizione e di prosa, i cui costi unitari di produzione, le possibilità di circuitazione e quindi l’esportabilità e la longevità media degli spettacoli prodotti disegnano un sistema dotato di una «resilienza» relativamente maggiore rispetto ai vecchi dinosauri dell’opera. Rilanciare oggi le istanze di un teatro come componente essenziale del tessuto socioculturale significa combattere frontalmente un costume politico congenitamente votato – non per inettitudine, non per mancanza di risorse, bensì per una sorta di «strategia ininitenzionale» – a dissanguare il sistema dello spettacolo dal vivo. Non è solo questione di tagli. Sono i meccanismi fondamentali della costruzione sociale dei bisogni e della domanda culturale a essere sistematicamente aggrediti dall’incessante propagazione di una redditizia mercanzia televisiva tagliata su misura per un elettorato a basso livello di alfabetizzazione. Scuola e università sono a loro volta sotto attacco. La «catena alimentare» da cui il teatro e le arti della performance traggono la loro linfa inizia con l’accumulazione originaria del capitale scolastico che induce nella popolazione valori e bisogni concernenti la cultura. Questi bisogni vengono recepiti dalle politiche culturali che sollecitando l’intervento delle realtà economiche pubbliche e private, operano per valorizzare e migliorare il sistema incrementando, alla fine del ciclo, i benefici economici dell’indotto. Oggi questa catena è compromessa. La riattivazione di questo «ciclo dell’azoto» della vita teatrale deve passare attraverso un cambiamento radicale delle logiche e degli obiettivi delle politiche culturali (e della politica tout court) che, indipendentemente dallo schieramento, appaiono al momento assai poco verosimili. Quasi totalmente screditata appare l’idea che finanziare l’offerta di cultura e nella fattispecie le performing arts sia da intendere come un investimento di medio e lungo periodo, e debba coordinarsi alla sua premessa necessaria: l’investimento sulla domanda, vale a dire l’incremento del capitale culturale della popolazione a partire dalla scuola. Viceversa è quasi generalizzata l’idea devastante (oltre che del tutto erronea storicamente ed economicamente) che il teatro e lo spettacolo in genere debbano possedere un appeal bastante ad attirare pubblico e sponsor e a generare introiti tali da garantirne l’autosufficienza. Sempre più si fa strada nelle commissioni governative e locali la tesi aberrante che la quantità (di pubblico, di introiti, ecc.) sia un indicatore di qualità. È un’aberrazione che mira a legittimare quel progressivo venir meno del finanziamento pubblico alle performing arts; un disimpegno che, al contrario, si configura come un vero e proprio crimine sociale perpetrato sotto l’insegna populista del fare piazza pulita in un settore come quello teatrale, dipinto come un combinarsi di sprechi, privilegi e improduttività. È una miscela il cui scandalo, in tempi di così grave crisi economica, risulta eclatante agli occhi di una vasta opinione pubblica teledipendente, apertamente incoraggiata a pensare che certa cultura d’élite è rea di affamare il popolo. Anche se suona utopistico in un momento in cui le politiche culturali nazionali vivono il culmine del loro degrado, l’investimento pubblico a sostegno della vita teatrale e musicale può e deve essere massiccio. Ma perché questo sostegno abbia un valore autenticamente culturale e non solo assistenziale (come di regola accade) deve combinarsi con altri due imperativi che, per il nostro Paese, sono categorici a prescindere dalle sorti dei teatri nazionali. Il primo di questi imperativi è l’obbligo di colmare l’enorme gap che ci separa dall’Europa d’oltralpe sul terreno della scolarità e dell’alta formazione. Il secondo consiste nel ridurre gli esorbitanti costi del lavoro che nel teatro derivano da un letale combinarsi di inefficienze multiple (tecnologie e strutture inadeguate, cattiva organizzazione del lavoro e della produzione, normative anacronistiche) e uno smodato gravame di oneri previdenziali, fiscali e di altra natura. L’improbabilità che questi due imperativi vengano soddisfatti ci dice quanto sia inverosimile che il dramma dei teatri italiani giunga in tempi brevi a un lieto fine, il quale potrà essere tale solo in un contesto anch’esso profondamente mutato. Certi jackpot del Superenalotto raggiungono annualmente o anche più spesso cifre da capogiro che da sole superano di gran lunga i tagli al Fus. Quando ci si comincerà a scandalizzare per questa autentica patologia sociale e si comincerà a curarla e a prevenirla sarà un segnale che le cose stanno cambiando. Ma non accadrà presto. Siro Ferrone Un teatro più libero, più povero e autonomo dal presente C « ome in altri Paesi europei»: così comincia la domanda che ci ave- te rivolto. Ma l’Italia è – per molti aspetti della sua vita culturale – un’anomalia in Europa. Credo si debba partire dal contesto dei nostri giorni per prendere atto della nostra diversità. Oggi, più che in passato, evidente. Per fortuna non ci si chiede se i nostri prodotti (come direbbe un neomanager della cultura), il nostro talento artistico (come direbbe un idealista), la nostra formazione artistica (come direbbe un professore) siano o meno in declino. Perché in quel caso, le vie di fuga sarebbero numerose. Ci sono tanti eccellenti artisti, e ciascuno di noi ne conosce qualcuno. Come artisti dello spettacolo, musicale o di parola o di ballo, siamo quelli che siamo. E allora se la questione che ci viene posta riguarda «solamente» le strategie organizzative e produttive del nostro teatro nazionale e le sue caratteristiche e funzioni, il ragionamento diventa paradossalmente più semplice. La risposta è analoga a tutte quelle che potremmo dare in riferimento a ciò che riguarda lo Stato, il Bene pubblico, l’Interesse collettivo. Con molte specificazioni relative al nostro campo d’interesse. Forse solo nel settore degli studi universitari si è registrata una analoga sciagura. La creazione – ad opera di petulanti clientele locali e di lobbies intraprendenti – di numerosi centri di produzione dislocati in tutte le parti d’Italia, legittimati a ricevere finanziamenti sia dal centro che dalla periferia delle casse statali. La nascita del cosiddetto decentramento e la successiva ideologia regionalista (che nel nostro Paese ha significato e significherà solo moltiplicazione dei centri di potere e di spreco, con buona pace dei mistificatori del pensiero di Cattaneo) non hanno portato né una maggiore diffusione della cultura teatrale né un rafforzamento delle energie artistiche e produttive. La formula populista dei dieci, cento, mille fiori, ha fatto appassire quei pochi fiori che germogliavano discretamente o bene. Oggi occorre prendere atto che il decadimento delle capacità ideative dei nostri quadri dirigenti è conseguenza di un adeguamento alla domanda di un pubblico che appare disorientato e progressivamente meno colto. La ricerca dell’audience ha contaminato tutto il territorio della cultura. E la responsabilità non va cercata – come spesso superficialmente si fa – nel sistema televisivo o nella sua capacità di creare modelli di comportamento culturali degradati; la responsabilità va cercata in coloro che, occupando posizioni di potere o di controllo culturale (appunto nei teatri, ma anche nell’editoria, nella scuola, nel governo locale e nazionale) si sono messi ad imitare, ad inseguire quel modello nella convinzione che «il popolare è bello». Il popolare adesso è degradato. Popolare è il cattivo gusto di cui dà prova una parte del personale politico della Lega; popolare vuole essere il cattivo gusto e l’ignoranza con cui si esprime il nostro presidente del consiglio; popolare fu ed è la bussola che guidò la vanitosa inconsistenza dei veltroniani. Tutti quelli che esibendo posizioni di cinico adeguamento al presente stanno comodamente in coda. I nuovi codini. Tra i quali, non pochi sindaci o presidenti di enti lirici o teatrali. Non mi pare che ci siano vie d’uscita, il popolare è diventato populismo, il populismo scolora in demagogia, la demagogia eccita il qualunquismo del gusto, il qualunquismo premia l’opinione corrente, l’opinione corrente insegue la corrente. Che è precipite… Resta solo l’utopia di un Paese che non c’è e che non ci sarà a lungo finché… …finché non si selezioneranno pochi enti lirici o teatri stabili delegati a svolgere una programmazione d’interesse pubblico che non tenga conto delle ragioni commerciali; finché agli altri enti teatrali e lirici non sia restituito uno statuto di autentici privati, cui si accompagni però una radicale detassazione dei bilanci; finché non sarà introdotto un calmiere nei budget degli enti teatrali e lirici pubblici (sul modello del tetto-ingaggi che funziona per le società del basket americano nba); finché il sistema televisivo pubblico non sarà messo in sinergia con lo spettacolo dal vivo attraverso coproduzioni e promozioni pubblicitarie che in altri paesi (Germania, Francia) hanno dato qualche risultato; finché non sarà introdotta una formazione seria dei professionisti dello spettacolo (amministratori, direttori, funzionari) che sottragga questa struttura portante del nostro sistema agli improvvisatori, ai clienti e alle corporazioni dei maneggioni; finché la povera scuola pubblica, di cui il governo pare voler ulteriormente abbassare la dignità, non avrà dato lo spazio dovuto a quelle forme di educazione, di formazione spirituale e materiale che sono il teatro e l’opera, la recitazione e la musica. Così come era previsto addirittura nella ratio studiorum dei Padri Gesuiti. Ma come potranno capirla i trafelati commessi viaggiatori e i supponenti economisti che pretendono di governarci? Il teatro ha bisogno al contrario di progettisti originali che sappiano intuire quel che si nasconde nei segreti pensieri degli spettatori eventuali e futuri e per fare questo ha bisogno di libertà sì dai vincoli economici, ma ha bisogno anche di ostacoli economici contro cui convocare le energie della fantasia. Ha bisogno di una maggiore povertà. Ha bisogno di essere diverso dal tempo suo, non imitatore o documento del presente, non riflesso delle angosce o delle disperazioni, non eco delle soddisfazioni e dei lussi. Deve essere autonomo dal presente. Una cattiva politica dello Stato centrale è preferibile ad una cattiva politica dello stato regionale. Di buone politiche non se ne vedono. Fortunato Ortombina La cultura è una risorsa, non un costo L a situazione attuale affonda le proprie radici lontano nel tempo. Un passo in avanti, ma assolutamente incompiuto, è stato fatto dalla legge che ha istituito le Fondazioni Liriche e che, ispirandosi a modelli non italiani, ha cominciato a porre gradualmente la questione di sottrarre parte della sovvenzione pubblica per favorire l’ingresso dei privati. Si è preso il la dalla Scala, e Milano, che è sempre stata in grado di guardare lontano, ben sapeva che sarebbero giunti momenti difficili. Non bisogna dimenticare che ogni teatro è anche espressione della propria città, e che il contesto finanziario meneghino è quasi un unicum in Italia e abbastanza singolare in Europa e nel mondo. Per questo, le risorse private che si possono trovare in una città come quella non è detto si possano dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 35 dove va il teatro pubblico italiano? 36 — dove va il teatro pubblico italiano? trovare altrove, indipendentemente dalla storia e dal prestigio della casa. La legge, fatta su misura per la Scala, è poi stata adeguata ad altre istituzioni. Ma, se mi si permette il gioco di parole, perché la legge sia uguale per tutti, forse dovrebbe essere diversa per tutti... Perché il risultato fosse il medesimo, infatti, allora si sarebbe dovuto tener conto dei differenti contesti produttivi. Si è invece passati al taglio progressivo e indifferenziato dei fondi, e anche nel 2010 si è parlato di un’ulteriore riduzione di centocinquanta milioni di euro. Credo che questo scenario sia sintomatico del fatto che vi è la totale incapacità di considerare la cultura come una risorsa invece che esclusivamente come un costo. Quello che mi rende ottimista è l’afflusso del pubblico, che, sempre più numeroso, testimonia il fatto che il teatro musicale è un vero e proprio bene dell’umanità. E se l’umanità va a teatro, il teatro non deve chiudere. La Fenice conta oggi molti più spettatori di quelli che la frequentavano vent’anni fa. Vi è una tendenza nel mondo, e in particolare in Europa, che va presa in considerazione: a fronte della recente crisi economica non si sono registrate flessioni nella vendita di biglietti per l’opera. Anzi, nonostante la crisi – a causa della quale la gente compra meno case, meno vestiti, meno automobili – i biglietti per andare a teatro continuano a essere regolarmente acquistati. Penso che qualunque ipotesi di chiudere i teatri sia soltanto una sciocchezza, in quanto non è possibile cancellare un aspetto della cultura universale. Ma siamo in un periodo di difficoltà e dobbiamo quindi elaborare progetti meno costosi, che comunque non vanno a incidere sull’afflusso del pubblico. Per il 2011 la Fenice ha programmato una stagione che ha già venduto molte migliaia di biglietti per un cartellone che presenta un aumento delle rappresentazioni del cinquantadue per cento rispetto al 2010. Questo vuol dire che in quest’anno si stima che trentamila persone in più si siederanno sulle nostre poltrone: è un incremento da considerare come risorsa e non come spesa. Non va infatti dimenticato che queste trentamila persone, composte necessariamente anche da turisti, quando soggiornano a Venezia non vanno solo a teatro ma dormono negli alberghi, visitano i musei, ecc. ecc. D’altro canto l’intervento statale non può certo scemare, ed è chiaro che se lo Stato continuerà nella strada dei tagli si finirà in ginocchio: l’incasso dei biglietti, infatti, se consente di pagare i costi variabili, non mi permette certo di retribuire gli stipendi degli orchestrali. Lo Stato e gli enti locali non possono tirarsi indietro come hanno fatto finora, perché stiamo parlando del nostro patrimonio culturale, della nostra letteratura nazionale. All’estero allibiscono per come viene trattata l’opera in Italia, non se ne capacitano, perché la crisi non giustifica certo un attacco così feroce. Se però lo Stato deve smettere di tagliare i fondi, i teatri dal canto loro devono organizzarsi meglio per far sì che le platee siano sempre più frequentate: la produzione non va diminuita, e soprattutto non va mortificato il flusso del pubblico. Il teatro musicale è un patrimonio inestimabile e i tagli possono essere compresi, se così si può dire, solo alla luce di un disegno chiaro: quello cioè di indebolire gradualmente questo sistema. Ma è tempo perso. E quello che non uccide sicuramente fortifica. Manlio Santanelli Educare al piacere dello Spettacolo G entili Signori, nel rispondere al vostro questionario non trovo un «incipit» migliore delle parole che Dante mette sulla bocca di Francesca da Rimini, ossia «nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria». A dire il vero, per quel che ci riguarda il Teatro non ha mai conosciuto un tempo del tutto felice, ma di contro non s’è mai trovato nella «miseria» come in questo momento. Prima che me ne venga fatto carico, confesso che non sono un esperto di quel tormentoso rapporto che ha legato e continua a legare lo Stato e lo Spettacolo, anche se non faccio mistero che nella mia immaginazione lo associo al Laocoonte di ellenistica memoria. E tuttavia non è nella mia indole esimermi dal fornire una risposta, ancorché trasversale, alle domande che mi sono cortesemente rivolte. In questo spirito, pur considerando l’aneddotica personale la malattia infantile dell’autobiografia, non posso evitare il ricorso a un’esperienza diretta, che forse nella sua natura esemplare può in qualche modo venire incontro alle esigenze della vostra indagine. Il lavoro mi aveva portato a Parigi per l’anteprima di una mia commedia. Un autobus speciale partiva da Chatelet per condurre gli spettatori a Epinay, una delle cittadine satelliti nelle quali ogni spettacolo riceve il suo battesimo prima di affrontare il pubblico della Capitale. Per ventura sedeva accanto a me l’Assessore alla Cultura (niente auto blu, dunque). Durante il percorso la mia traduttrice ritenne doveroso presentare l’uno all’altro, e mai presentazione fu più provvidenziale ai fini della conoscenza di quanto stava a cuore a entrambi, vale a dire le condizioni dello Spettacolo nei nostri due rispettivi Paesi, nelle convergenze come nelle divergenze. E così l’Assessore, dopo una breve esitazione dettata dalla sua naturale discrezione, cominciò col chiedermi la cifra che stanziava lo Stato Italiano per il Teatro in generale. Non è azzardato dire che alla mia risposta cadde dalle nuvole, aggiungendo poi che da loro il sussidio statale non superava il decimo di quello nostro. Seguì un silenzio durante il quale meditai su quella enorme disparità di interventi finanziari. Finché non sopraggiunse in mio soccorso la curiosità di conoscere quanto si spendeva nelle scuole francesi per la cultura teatrale. Alla sua risposta toccò a me sbalordire. Per farla breve, loro educano i cittadini fin da ragazzi alla conoscenza e al piacere dello Spettacolo, per poi ritrovarseli in avvenire spettatori paganti e competenti. A quel punto l’intervento di «Papà Stato» può assumere il modello di un incoraggiamento piuttosto che quello di una bombola di ossigeno. Morale – sempreché ne occorra una –: lì si semina a monte per raccogliere a valle. Non mi restò che far tesoro di quella lezione di lungimiranza, ora rubricata nel libro dei tanti insegnamenti che ricevo ogni qualvolta valico la frontiera del nostro Paese. Marco Bernardi L’obiettivo è ancora un teatro d’arte per tutti I n primo luogo desidero segnalare che quasi tutto il sistema produt- tivo e distributivo teatrale italiano, sia pubblico che privato, è finanziato dallo Stato attraverso il fus. Senza questi fondi, e senza quelli delle amministrazioni locali (comuni, province, regioni), un teatro nazionale d’arte diffuso capillarmente sul territorio non potrebbe esistere, perché con i soli incassi del botteghino non si coprono i costi di produzione e di gestione di uno spettacolo teatrale di medie dimensioni. Quindi penso che dobbiamo semplicemente decidere se questo Paese vuole ancora permettersi di avere un teatro d’arte socialmente diffuso, un sistema musicale serio, un teatro musicale accessibile a tutti. Io penso che queste siano necessità irrinunciabili per un Paese europeo con la nostra tradizione culturale e con il nostro livello di benessere, probabilmente altri non la pensano così. Per esempio ad oggi (9 dicembre 2010) il fus 2011 è iscritto nel bilancio dello Stato con la somma di 270 milioni di euro e cioè con un taglio del trentacinque per cento rispetto al 2010, in tre anni dal 2009 al 2011 il fus calerà quindi del cinquanta per cento. Così si uccidono il teatro, la musica, la danza, l’opera, con una lenta asfissia. La maggior parte dei tagli che siamo costretti a fare si ripercuotono sui contratti degli attori e dei tecnici, i quali di questo passo non potranno più vivere con questo mestiere. Il risultato sarà quello di distruggere l’arte teatrale e le professionalità del teatro che occupa in questi anni oltre duecentomila addetti. Trovo tutto questo vergognoso per la sesta potenza industriale del pianeta: stiamo parlando di cifre che equivalgono al costo di qualche chilometro di autostrada o di alcune gallerie… Detto questo penso che la funzione del teatro pubblico sia quella di produrre, distribuire, promuovere il teatro d’arte presso i più ampi strati della popolazione. Non mi sembra che la «mission» sia molto cambiata rispetto al manifesto di fondazione del Piccolo Teatro di Milano che Giorgio Strehler e Paolo Grassi firmarono il 14 maggio del 1947. Sono forse mutate le mode teatrali, ma la sostanza è la stessa: teatro d’arte per tutti. O almeno l’aspirazione a tentare di raggiungere l’obbiettivo dei padri del teatro italiano dopo più di sessant’anni. Marco Martinelli e Ermanna Montanari Tesi, antitesi, sintesi: il nodo Stato-Teatro T esi. Lo Stato deve sostenere la cultura, che è pungolo al pensare con la propria testa e quindi ribellione contro lo stato delle cose. Cleone finanziava Aristofane anche quando questi lo sbeffeggiava sulla scena. Lo Stato non deve finanziare la propaganda. Non deve erogare finanziamenti per acchiappare voti. Non deve alimentare la macchina del consenso. Non deve finanziare un Teatro di Stato, il teatro che è già stato, ma sostenere quello che è, che respira, che si muove corsaro. Ci sono meno soldi? Bene, che a qualcuno venga data la responsabilità di distinguere tra i parassiti e gli artisti veri. antitesi (apparente). Che i teatranti si facciano l’esame di coscienza prima di chiedere soldi pubblici: il mio lavoro è utile alla collettività? Parliamo di quella utilità che è il superfluo e il lusso della poesia, ovviamente. Ma nulla è ovvio nel regno della chiacchiera, quindi è bene specificare. È utile il mio lavoro alle persone che vivono nella mia stessa società? Posso guardare in faccia un muratore, un contadino, un insegnante, e spiegare loro il nostro fare, e come questo fare sia necessario come l’aria perché aiuta tutti a pensare meglio? Necessario come quel rivoltare la terra, quel costruire case, quell’insegnare ai piccoli? Fuor di retorica: se non so spiegare e raccontare tutto ciò, non posso chiedere soldi alla collettività. Aristofane veniva pagato dagli arconti (genere di Ministri della Cultura della città-Stato), ma poteva con orgoglio affermare che il suo far ridere la polis aveva il «profumo dell’intelligenza», e per questo gli ateniesi gli erano grati. sintesi. Ci ha detto un amico, un funzionario del Ministero, un fedele servitore dello Stato (sì, ne esistono ancora): «La cultura forse non farà mangiare, ma l’ignoranza ci divora». Che ognuno, nel suo, ne tiri le conseguenze. Massimo Cacciari Il teatro è una responsabilità collettiva S e uno Stato, un Governo, un Paese, una Società Civile, tutti insie- me ritenessero che tra il patrimonio culturale da difendere non ci siano solo i monumenti, le chiese, ecc. ma anche tradizioni di tipo teatrale, musicale, letterario, ecco allora che, esattamente come si custodisce o si dovrebbe custodire Pompei, si custodirebbe la tradizione lirica e teatrale italiana, naturalmente non in termini isolazionistici ma nel rapporto con la tradizione, con la storia della musica e del teatro in Europa. Se invece un Paese ritiene che Pompei sia un optional, che Palazzo Ducale possa andare a pezzi a meno che non ci sia il privato che ci attacca sopra – per nostra fortuna – le reclame della Coca Cola, e che il teatro lirico o di prosa debbano essere sovvenzionati dai privati stessi altrimenti ce li possiamo dimenticare… Be’, lo scenario non è certo dei migliori. Se infatti un Paese decide che la sua storia e la sua tradizione sono qualcosa di morto, sono una lingua defunta, perché mai la si dovrebbe continuare a parlare? La questione è molto semplice e non vedo grandi spiragli. Si va inesorabilmente verso il peggio. Così come si ritiene che studiare il latino sia qualcosa di superfluo, si ritiene anche che Pompei possa crollare in pezzi – tanto qualche turista andrà a visitarla lo stesso – e che la Fenice possa chiudere. È una china oramai inesorabile. Per rialzarci dovremmo cessare di votare le persone che abbiamo votato finora, per esempio, cambiare politica e cambiare volti. Mi sembra chiaro ed evidente. Dobbiamo modificare le priorità nel nostro modo di vita, immaginare che, magari, investire una lira in più per difendere il teatro lirico e di prosa e una lira in meno per andare a mangiare una pizza forse sarebbe una scelta intelligente: è una questione di responsabilità collettiva. Non è solo un Governo che va a rotoli, è tutto il Paese a essere allo sfascio. Marco Cavalcoli Il teatro e il suo doppio B isogna partire da una considerazione economica che viene spes- so trascurata quando si ragiona sul ruolo del sostegno pubblico al teatro, in particolare se si pensa che lo si fa sempre all’ombra di un diffuso giudizio critico sull’incapacità o l’indisponibilità del teatro a stare sul mercato, come ultimamente sottolineato anche da autorevoli ministri. Intanto per quale motivo questa critica dovrebbe sembrare naturale? L’esperienza storica del teatro è più quella dell’arte di Stato e di corte o del mecenatismo che di un prodotto dotato di un valore commerciale di scambio. Ma concediamo pure di volerci confrontare con il mercato artistico contemporaneo; non possiamo ignorare che negli ultimi cento anni la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte ha cambiato per sempre lo statuto del teatro nella società e nella sua economia, alcune funzioni che gli si riconoscevano vengono svolte in grande scala dal cinema e dalla televisione, lo spettacolo gira sui più diversi media e ciò che chiamiamo teatro lo riconosciamo nella condivisione fisica di un tempo e di un luogo in cui farlo accadere, cioè in buona sostanza nella sua impossibilità di partecipare all’economia moderna dell’arte riproducibile, come ben si conviene del resto ad un’arte che viene da così lontano. Il fus finanzia anche gli Stabili Privati, le istituzioni culturali che non ricevono contributi pubblici lavorano di sponda con la notorietà televisiva per sostenersi, non c’è un autentico mercato privato specificamente teatrale. Il denaro pubblico che viene speso nelle politiche culturali ritorna alla società come politica di costruzione del suo tessuto, ma studi diversi tra loro ci dicono che produce anche ricchezza monetizzabile, come hanno compreso tanti Paesi europei che considerano gli investimenti pubblici nel teatro uno strumento di sviluppo delle proprie società. La questione non è il mantenimento assistenziale degli artisti e degli operatori dello spettacolo (per quanto in realtà l’argomento si sollevi invece con autorevolezza quando si tratta di salvare il destino di agricoltori, operai e trasportatori, ma tant’è...), ma l’affermazione che andare a teatro è un diritto dei cittadini. Uscire di casa e recarsi in un luogo dove insieme ad altre persone si fa vivere uno spettacolo è un gesto pubblico e politico almeno tanto quanto comprare una mela, un formaggio o un’automobile, beni prodotti con robuste iniezioni di sostegno statale e comunitario. E mentre può essere equivalente, o addirittura più vantaggioso, acquistare il forno elettrico in un grande magazzino piuttosto che nel negozio sotto casa, al punto che il negozio ad un certo punto chiude, non c’è alcuna convenienza per le persone nel veder scomparire la pluralità e la complessità delle esperienze teatrali a cui possono partecipare a vantaggio di alcuni spettacoli di massa. In Italia la sola preparazione poi abortita del G8 alla Maddalena è costata ai contribuenti quanto l’intero Fondo Unico per lo Spettacolo di un anno, non stiamo parlando di cifre capaci di risollevare le sorti finanziarie del Paese, anche se potrebbero forse contribuire a farlo, se fossero spese con l’intenzione di aumentare gli spazi di libertà e di condivisione dei cittadini, per dinamizzare la società. Ma forse è questa la scelta che non viene considerata strategica. La sfiducia nelle qualità rigeneranti dell’arte, che si avverte a livello politico, ma alberga anche nelle abitudini degli stessi artisti e operatori, è un dramma per la cultura italiana. Il teatro viene considerato politico quando parla di politica, oppure si occupa di problemi sociali del territorio, spesso le rivendicazioni del sostegno pubblico poggiano sul ruolo sociale svolto da teatri e compagnie, come se si dovesse trovare una giustificazione esterna alla politica del sostegno statale, niente di più fuorviante. La forma d’arte che prende nome dalla parola greca «vedere» non è importante oggi perché può essere vista (la televisione per questo è più che sufficiente), ma perché vede. Il teatro ci guarda ed è pubblico nella misura in cui apre le porte alle caverne della nostra immaginazione in un modo che gli altri media non conoscono, cioè nella condivisione fisica del nostro presente. Possiamo tutti noleggiare per pochi euro l’Amleto di Laurence Olivier e consumarlo tra le mura domestiche, ma per regalare all’attualità l’Amleto della Socìetas Raffaello Sanzio è necessario un investimento collettivo, un dispendio di energie che non ha nulla a che vedere con le richieste del consumo e del commercio. Lasciamo il mercato al mercato, magari spezzando le clientele con cui decenni di intervento politico l’hanno inquinato, sciogliamo l’equivoco che equipara il teatro pubblico al teatro di Stato, buono per regimi di varia natura. Le risorse statali servono alla libertà dei cittadini di partecipare alla creazione degli immaginari che li riguardano e di condividerne la visione, è una funzione pubblica dell’arte che non riposa nelle mani dello Stato, ma che può essere da questi ostracizzata o valorizzata. Dipende da quanto si tiene in conto la partecipazione del cittadino alla formazione delle identità culturali che lo definiscono. Luca Mosca Musica nuova per nuovi pubblici N ella mia vita la musica gioca un ruolo fondamentale, e certo non pretendo che tutti la amino quanto l’amo io. Credo però che, semplicemente, bisognerebbe capire che fa parte della vita di tutti. dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 37 38 — speciale teatro pubblico La classe politica è ignorante, musicalmente analfabeta, e forse lo è anche per quel che riguarda altre discipline, rappresentando degnamente l’analfabetismo culturale della maggioranza degli italiani. A monte c’è senz’altro il problema dell’istruzione scolastica, dove è assente ogni opera di sensibilizzazione verso il repertorio classico e non commerciale. Ma essendo molto ottimista di natura penso si tratti solo di momenti: momenti migliori e peggiori, alti e bassi. Purtroppo oggi ne stiamo vivendo uno tragico per l’economia mondiale, che si riflette anche sulla gestione dei teatri. Un altro dei problemi del nostro teatro è il suo adagiarsi su una programmazione basata soprattutto su titoli storici: ci vorrebbe più coraggio, bisognerebbe osare di più, e invece si tende a vivere come se si fosse ancora nell’Ottocento, continuando a proporre quasi esclusivamente opere di quel periodo. Da un lato può anche andare bene, altrimenti verrebbe meno lo zoccolo duro costituito dal pubblico dei melomani. Ma l’opera lirica potrebbe essere uno spettacolo modernissimo, completo, in cui tutte le discipline vengono coinvolte per realizzare produzioni che riuscirebbero probabilmente a coinvolgere un pubblico assai più ampio, senza per questo scadere nel trivio e nell’idiozia. Parlo di operazioni che vantino un alto livello artistico e che possano comunicare con platee rinnovate e vitali. Se fossi un direttore artistico punterei su spettacoli di musica nuova, non demenzialmente avanguardistica. Il linguaggio di alcuni compositori è maturo per comunicare davvero con un pubblico inedito e da «educare». Punterei molto su questo e sui titoli del Novecento: penso per esempio ai capolavori di Hindemith, compositore che ha scritto delle opere straordinarie e che compare troppo di rado nei cartelloni. Michele Sambin speciale teatro pubblico Ripensare nuove regole (…) Oggi un sempre minor numero di persone si interessa all’arte. Ciò che accade oggi è sinonimo didistruzione della vita spirituale. Che ne sarà della nostra lotta? E quando dico nostra intendo parlare di quel gruppo che non va in cerca di un successo esteriore. Ma finiamola con la politica! Con quale ritmo il pericolo va crescendo e la situazione mutando. Già da un paio d’anni s’è cominciato a vedere dei mutamenti nella produzione artistica – eppure l’arte ha le sue proprie leggi e non ha niente a che fare con la politica- ma si pensava che in qualche modo sarebbe stato possibile uscirne. Oggi non siamo lontani dal veder imprigionata una persona per il fatto di essere un artista vero. anton webern, marzo 1933 L a complessità del mondo in cui viviamo con le infinite sovrastrut- ture che confondono ci fa spesso perdere l’origine del teatro. L’origine sta nel rapporto opera – spettatore. Difficile immaginare però che nella contemporaneità il rapporto si risolva esclusivamente tra i due soggetti: produttore – consumatore. D’altra parte il teatro non è merce di consumo. Chi produce, nella maggioranza dei casi, crea un’opera non perché sia consumata ma per condividerla con altri esseri umani. Non si tratta di vendere patate (anche se questa primaria e nobilissima attività nella complessità dell’oggi è anch’essa diventata complicata), si tratta di creare un rapporto culturale che coinvolga la comunità. Riuscire a stabilire questo rapporto svincolati da un intervento pubblico renderebbe ogni tensione creativa dipendente dalle esigenze di mercato, con risultati che a mio avviso avrebbero poco a che fare con la cultura. Se è vero che il teatro, nel suo necessario bisogno di evolvere per adeguarsi a nuovi modi di comunicare, ha bisogno di essere alimentato dalla ricerca, si sa anche che la ricerca non può vivere di sbigliettamento. Di conseguenza per chi fa ricerca teatrale l’intervento pubblico è necessario, ma di fronte alla macchinosità, alla mancanza di trasparenza, alle disparità dell’attuale sistema teatrale, sono stato spesso tentato di immaginare un possibile reset, un azzeramento che ci riporti tutti grandi e piccoli a ricominciare dall’inizio, da un’origine che ci consentirebbe di ripensare nuove regole in grado di ristabilire un giusto rapporto tra lavoratori dello spettacolo – opera – spettatori – risorse pubbliche. Le nuove regole dovrebbero ripensare al sistema rendendolo meno dipendente dalla politica e rimettendo in equilibrio le disparità che ora esistono tra i diversi soggetti teatrali. Chi determina il valore di una creazione artistica? La risposta è molto difficile ma forse dovrebbe essere proprio l’ente pubblico (e la sua utopistica neutralità) a tentare di dare risposta alla questione attraverso un’equa distribuzione delle risorse che non tenga in considerazione la regola che chi urla più forte vale di più, ma che si attrezzi per conoscere direttamente come vengono spesi i soldi che investe. È solo con un pensiero radicale come l’azzeramento che si può immaginare di cambiare le cose? Forse le altre soluzioni sono solo aggiustamenti dell’esistente. Proviamo comunque a fare i conti con questi aggiustamenti e allora si dovrebbe considerare che oltre a «realtà diverse per storia, genesi e finalità, come le Fondazioni liriche e i Teatri Stabili di prosa, cui si sono aggiunti da qualche anno anche quelli definiti Stabili d’Innovazione» esistono realtà più piccole, ma non per questo di minor importanza e con una lunga storia alle spalle. Ebbene queste realtà sparse sul territorio nazionale, attive e in buona salute creativa nonostante le difficoltà che devono affrontare per continuare ad esistere, sono espressione di un radicamento, punto di riferimento e luogo di incontro per cittadini e artisti. Essere riconosciuti dal Ministero e quindi sostenuti dal fus come «Residenza» significherebbe vedere valorizzata questa identità. Paolo Petazzi Necessaria una riforma reale che coinvolga tutti I n Italia, come in molti altri Paesi europei, non esiste una legislazio- ne adeguata per favorire l’intervento di privati a sostegno di iniziative culturali. Nella nostra situazione, anche tenendo conto della mentalità diffusa, non ci sono condizioni «culturali» paragonabili a quelle degli Stati Uniti, o comunque dei Paesi dove l’intervento di privati è di grande peso. Il ruolo del finanziamento pubblico non può che restare decisivo, come in Germania. Sarebbe essenziale che la misura di questo finanziamento fosse resa nota con adeguato anticipo e fosse garantita nel modo più assoluto, nella quantità e nei tempi: i tagli a stagione già programmata e avviata sono la negazione di ogni possibile efficienza e puniscono soprattutto le amministrazioni più sane e corrette. Non si tratta solo di inefficienza italica; ma anche di un modo per ridurre le possibilità di indipendenza delle istituzioni culturali. Aggiungo che considero una ricchezza cui non si dovrebbe rinunciare il numero delle Fondazioni e dei teatri «di tradizione» attivi in Italia. L’idea di chiudere teatri che non siano la Scala e l’Opera di Roma (!!!) non ha senso comune, ed è tanto più insidiosa e pericolosa perché non viene resa esplicita. La legge sulle Fondazioni non funziona e non poteva funzionare, anche perché notoriamente ideata solo pensando alla Scala. Il recente tentativo di far calare dall’alto discutibilissimi provvedimenti non serve a nulla. Per quanto faticosa e difficile una reale riforma del sistema ora vigente deve coinvolgere tutti. Richiede anche un superamento di vecchie mentalità corporative, e una riduzione delle spese fisse (che oggi nel bilancio di un teatro lirico sono sproporzionate: è purtroppo un dato oggettivo). Ma i semplici tagli producono solo inefficienza, cioè riduzione del numero degli spettacoli e del servizio che i teatri dovrebbero offrire. Tutte queste sono solo ovvietà; ma è inevitabile ripeterle perché non per tutti sono una premessa scontata, come dovrebbero essere. Pier Luigi Pizzi Una nebbia di indifferenza P arlare del teatro pubblico e della sua funzione al giorno d’oggi non è facile, perché la ricetta risolutiva non la possiede nessuno, soprattutto nelle condizioni in cui ci troviamo attualmente, e non solo per ciò che riguarda la cultura, il teatro e la musica. È veramente un momento di confusione terribile, nel quale quello che mi colpisce maggiormente è l’indifferenza. Credo che sia questa la vera malattia del nostro Paese, anche se ho raccolto impressioni simili anche fuori dai confini nazionali. Sono però appena stato a Mosca, dove mi hanno invitato ad allestire La sonnambula al Bolscioi, e lì ho trovato un clima positivo, proiettato in avanti. Il progetto sull’opera di Bellini si realizzerà nel 2013, e questo è indicativo della differenza di approccio rispetto a quanto accade da noi, dove non si sa nemmeno cosa succederà domani. Sono le prospettive sul futuro a essere diverse. In Italia, quell’indifferenza che evocavo poc’anzi è davvero un grande pericolo, perché riguarda in primo luogo il Governo, che sembra sordo ad ogni sollecitazione. Da parte delle isti- speciale teatro pubblico — 39 tuzioni, il continuo temporeggiare, rimandare, non prendere le situazioni in mano in modo definitivo equivale a lasciar andare la barca alla deriva. Il disastro è annunciato. Venezia affonderà nell’indifferenza totale, e il Teatro affonderà come Venezia, come si sciolgono le nevi della Patagonia, come sprofondano le Maldive. Intanto nell’indifferenza si consuma il nostro immenso patrimonio artistico. Cosa si può fare, se non opporre all’indifferenza dilagante la propria passione, la consapevolezza e la forza attiva della propria professionalità? Il male è che questa indifferenza rischia di contagiare la stessa gente che fa teatro e in ultima analisi perfino il pubblico, che a volte sento deluso, amareggiato, defraudato anche se alla fine è ormai pronto a trangugiare qualsiasi cosa, senza più discernimento e a subire passivamente quel progressivo depauperamento, come naturale conseguenza delle riduzioni dei finanziamenti. Si assiste ad un atteggiamento rinunciatario da parte di un pubblico sempre più amorfo. Manca la vivacità dei giovani, che rinnovano il gusto e forniscono un punto di vista fresco su quel che viene proposto, senza nostalgie di tempi passati, irripetibili. A Parma, recentemente, in occasione di un’anteprima dei Vespri siciliani di Verdi, ho visto una sala traboccante di giovanissimi spettatori scatenarsi in un consenso convinto ed entusiastico di altissimo significato. Esempi come questo vanno incoraggiati. S’è fatto a Milano per Wagner e forse altrove. Le nostre sole speranze per il futuro sono fondate unicamente sull’adesione di un pubblico nuovo, ricettivo, esigente. Anche paralizzato dall’eseguità delle risorse, il nostro maggiore sforzo deve consistere in programmazioni articolate con fedeltà al repertorio ma anche con aperture al contemporaneo, anche se difficili e provocatorie, in modo da stimolare le aspettative di un pubblico rinnovato e attento, non contagiato dall’indifferenza. sa come la nostra non poteva certamente avere un semplice meccanismo di produzione, organizzazione e diffusione della materia culturale. Il meccanismo che permette l’incontro tra artisti e pubblico si è quindi evoluto, possiamo discutere se in meglio o in peggio, ma che comunque si sia evoluto, anche in virtù della nuova consapevolezza del ruolo esercitato dai governi regionali e locali in materia di diffusione culturale, è un fatto. Questa contrazione della filiera reca con sé alcuni oggettivi vantaggi rispetto al pil regionale, ma comporta il rischio di una chiusura sul piano dello scambio artistico che è alla base di ogni progressione culturale. Ripensare a un nuovo sistema teatrale senza tenerne conto potrebbe rivelarsi un pericolo, che sarebbe meglio non correre. Nella continua evoluzione di un sistema degno di questo nome non è da trascurare l’analisi delle azioni comportamentali e delle reazioni delle istituzioni culturali e degli enti locali nei confronti della cultura in un momento di crisi globalizzata. Nessuno di questi soggetti si è lasciato trascinare in attività più «commerciali» a discapito della qualità delle iniziative. Nessuno si è lasciato prendere dal panico. Il sistema regionale sta tenendo grazie a una combinazione tra le proposte degli artisti, il contenimento del costo di accesso allo spettacolo, qualità e quantità dell’offerta, miglioramento della comunicazione. Questi indirizzi che il sistema si è dato senza forzature hanno determinato una reazione del pubblico teatrale che non è mai stata così forte: in un momento depressivo per i consumi gli spettatori sono in crescita con percentuali a due cifre mai registrate prima. Pierluca Donin teatro indica uno slittamento che è insieme strutturale e culturale. Lo slittamento, ai margini della formazione culturale nazionale, del teatro e della musica da beni pubblici da salvaguardare ed eventualmente incrementare, in beni di consumo privato e come tali affidabili alla «inesorabile» legge del mercato. Nel dopoguerra si riteneva in Italia che la musica e il teatro fossero centrali per la formazione della cittadinanza, si riteneva altresì che si dovessero porre delle politiche di incentivazione in modo tale che un sempre maggior numero di cittadini, soprattutto i meno abbienti, partecipassero a questo processo collettivo di formazione. Si riteneva cioè che orchestre e teatri servissero soprattutto a diffondere la cultura, a «formare», a far divenire attiva la grande eredità nazionale. Da qualche decennio quella spinta si è arenata e si è inaugurata l’epoca dello slittamento. Qui mi riferisco soprattutto alle Fondazioni Liriche che condividono molti problemi con gli Stabili di prosa ma che rispetto ad essi sono davvero meno virtuose e duttili. La crisi fiscale dello Stato, una cattiva interpretazione, tutta «politica» e «bipartisan», dell’autonomia degli enti lirici e sinfonici, la crescente superfetazione ad essa connessa di garanzie corporative promosse dai sindacati; l’idea che a correggere il pubblico dovesse soccorrere il privato che in Italia, come si sa, è più propenso, in linea di massima, a finanziare il calcio, dal quale si aspetta ben altri ritorni che le detrazioni fiscali oggi promesse per gli investitori in cultura; la linea decrescente – con le sempre lodevoli eccezioni – di competenza e di responsabilità sia culturale che amministrativa di coloro che si son trovati e si trovano al timone delle Fondazioni; la crescente colonizzazione politica di enti che vedono il Consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco direttamente eletto dal popolo: sono questi gli elementi che concorrono allo slittamento. I tedeschi hanno ritenuto a partire dai primi vagiti dell’assolutismo illuminato che il teatro fosse un pezzo importante dell’identità nazionale; gli italiani gridando «Viva Verdi» sottolineavano un’appartenenza, irrompevano in massa sulle scene, prima ancora di uscire per le strade. Questi gli antefatti, le memorie collettive. Oggi basterebbe rileggere l’idea che il finanziamento dello Stato serve ad incrementare e diffondere la cultura, ma anche la sperimentazione sia in musica che in teatro: serve cioè a puntare sulla produzione culturale e sulla sua innovazione allentando la morsa del botteghino che decreta il sold out soltanto davanti al noto. Senza progetto culturale, senza il coraggio di innovare e di sfidare le abitudini del pubblico alla fine a farne le spese è il repertorio che si è ulteriormente ristretto, mentre i conti sono rimasti in rosso dal momento che l’incidenza del botteghino soprattutto per la lirica rispetto ai costi generali di produzione rimane spesso non significativa. Il I l complesso di soggetti che concorrono alla realizzazione delle at- tività teatrali in Italia non è equiparabile ai sistemi di altri Paesi. L’apporto economico da parte dello Stato è difficilmente, seppure indispensabile, una partecipazione prevalente. Si deve ormai alle Regioni che, assieme a Province e Comuni, costituiscono la base economica ovvero il sostegno che permette agli Enti e alle Istituzioni di realizzare i propri progetti culturali. Con la soppressione dell’eti, Ente Teatrale Italiano, si evidenzia ancor più la mancanza e forse anche la volontà di condurre la politica teatrale nazionale a un sistema. Se in Italia ne esiste uno, questo è costituito da soggetti che dialogano tra loro, spinti più da comuni interessi culturali che da un vero e proprio «sistema», se lo si intende come una filiera tra le diverse funzioni nell’ambito dello spettacolo. Negli ultimi venticinque anni, dato non trascurabile, l’inflazione e un maggior numero di soggetti aventi diritto ai contributi dello Stato hanno fortemente compromesso la politica statalista, che ha lasciato il passo alla sussidiarietà e alla definizione dello spettacolo quale materia concorrente, mutando così l’assetto che vedeva nella centralità del fus l’unico contributo alla cultura dello spettacolo. Per forza di cose questo riassetto ha condizionato anche la natura dei soggetti portati ad avere sostanzialmente due visioni: una nazionale o internazionale, a seconda della propria vocazione, e una territoriale. Ed è su quella territoriale che possiamo trovare qualche somiglianza con un «sistema» ovvero un meccanismo coordinato tra le funzioni dei diversi soggetti operanti. Sul piano delle indicazioni ministeriali, nel merito delle funzioni, va da sé che tutti i soggetti sono uguali tanto che operino in Liguria quanto in Sardegna. Ma è sul piano operativo che la mancanza di una differenziazione di indicazioni comportamentali, determinate dalla natura morfologica del territorio, ha costituito una serie di soggetti molto adattati all’area operativa creando istituzioni ben modellate sulle reali esigenze artistiche e che agiscono con un fortissimo rapporto con il territorio. Quindi in Italia non è visibile un sistema teatrale nazionale, ma molteplici sistemi regionali che a mio parere, sommati tra loro, non costituiscono un vero sistema nazionale omogeneo. C’è dell’altro. Cito ad esempio la rete tra Teatri Stabili che è, di fatto, un sistema teatrale nazionale, un perno che, quando ben gestito, porta vantaggi anche per i sistemi regionali. Siamo quindi di fronte a una serie di reti e di filiere che si intersecano tra loro costituendo il nuovo tessuto di relazioni artistiche e tecniche che, non dimentichiamolo, permette al cittadino di partecipare al Teatro anche quando non vive in una grande città. Del resto una società comples- Da bene pubblico a bene di consumo I l crescente disimpegno dello Stato nei confronti della musica e del speciale teatro pubblico Il «sistema» italiano e la visione territoriale Piero Violante 40 — dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? problema non è il botteghino, ma l’incidenza delle spese fisse, l’elefantiasi di strutture alimentate dal clientelismo, la crescente colonizzazione politica. I sindaci non possono restare al vertice delle Fondazioni liriche perché inevitabilmente le trasformano in municipalizzate. Il problema oggi nella gestione dei teatri è sì strutturale, finanziario ma è soprattutto culturale. Ho l’impressione che ci si ripari dietro il deficit delle finanze per mascherare il personale deficit di idee sia nei teatri che nel ministero competente. Insomma non si ha un progetto sul ruolo dei teatri oggi se non quello minimale di far cassa. Invece in una società in trasformazione e che si avvia a divenire sempre più multiculturale è importante pensare al ruolo del teatro e della musica come luogo di elaborazione di valori comuni. È importante allargare il pubblico ma non solo scegliendo la via più semplice che è quella di rivolgersi alle scuole. Per un teatro d’opera o per un teatro di prosa andare in scena dovrebbe essere l’atto finale di una serie di relazioni e interdipendenze create nel territorio e per il territorio in nome della formazione. E qui bisogna dire che i teatri di prosa, gli Stabili sono molto più virtuosi e soprattutto sensibili al rapporto con le altre esperienze del territorio in cui insistono. Si possono fare molte cose ma bisogna averne voglia e bisogna scommettere. Bisogna bloccare lo slittamento e riconquistare la centralità formativa delle performing arts ed in generale la centralità della cultura e dell’università nella vita del paese. È questa la vera scommessa. Come hanno dimostrato in queste settimane gli studenti medi e universitari che si son trovati a braccetto con i lavoratori dello spettacolo. Il mio compianto amico Francesco Agnello, recentemente scomparso, dopo aver speso una intera vita per sostenere la musica come bene pubblico e come centrale nell’identità civile e negli affetti, nel suo beffardo e scorato autonecrologio, nel dare notizia della sua scomparsa a parenti e amici suggerisce: «Non fiori, ma un concreto aiuto per la musica». Romeo Castellucci La «sensibilità vivente» della cultura C redo sia molto difficile riuscire a individuare delle formule che possano risultare valide in ogni luogo. Penso piuttosto che ciascuna città debba potersi confrontare con la propria realtà, con il proprio tessuto sociale e le proprie esigenze. Cercando di fare un discorso più generale, direi che il compito dei programmatori – e ancor di più delle istituzioni – è prima di tutto quello di mettersi in ascolto, con una certa umiltà, delle esigenze della cultura, intesa come vero e proprio bisogno primario. I nostri politici normalmente non si interessano di arte, non hanno idea di cosa significhi il teatro o l’arte visiva. E questa è una grande differenza rispetto a quanto accade all’estero, laddove i ruoli istituzionali relativi alla cultura sono affidati a persone che provengono da quel mondo, e che quindi non ricoprono quel ruolo in base a meri giochi di potere ma sulla scorta di una preparazione e di una vocazione. In Italia, chi ha i mezzi per organizzare e decidere dovrebbe rendersi conto che il panorama teatrale è una forma in continuo movimento, dovrebbe comprendere che non esiste un repertorio fisso con dei canali privilegiati – che sono poi sempre gli stessi – ma che si tratta di una materia in perenne trasformazione: ogni anno cambiano le cose, ogni anno muta il sentire. Si tratta di una sensibilità vivente che non può permettere di far pensare alla cultura come a una forma fissa, consegnata nel tempo da un repertorio: ecco perché non devono esistere dei canali privilegiati, come ad esempio il teatro di testo o la danza classica. Ci sono forme sempre nuove, che si creano con notevole rapidità. Bisogna essere informati circa quanto succede nel mondo. Ma altra caratteristica italiana è purtroppo quella della chiusura: nel nostro Paese passano pochissime realtà internazionali e questo temo avvenga per sciatteria culturale, perché non c’è curiosità, non c’è tensione. Molto di rado – potrei fare solo un paio di nomi – mi è capitato durante i grandi festival internazionali di incontrare dirigenti, programmatori o politici italiani: da parte loro manca l’interesse, perché probabilmente queste manifestazioni non raggiungono i numeri che le renderebbero vetrine appetitose. Il teatro è una comunità abbastanza piccola ma fondamentale, che non può incuriosire i politici proprio perché non è fatta di grandi cifre. Forse per questo si trova in uno stato di totale abbandono. E se le soluzioni sono proprio di tipo politico, dal canto loro gli artisti non devono sempre e solo lamentarsi, sempre e solo chiedere, ma piuttosto concentrarsi sul proprio lavoro. La situazione è infatti oramai a una fase di metastasi ed è perfino inuti- le protestare. D’altra parte anche Governi precedenti a questo hanno lavorato per il peggio. Non è una questione di schieramento politico: è la classe dirigente in generale ad aver sempre ignorato e abbandonato, per disattenzione, il campo del teatro vivente. Renato Palazzi Il finanziamento pubblico non si tocca. Ma gli Stabili servono ancora? C redo che, soprattutto in momenti di difficoltà economica co- me quello che stiamo attraversando, vada comunque ulteriormente ribadito l’irrinunciabile principio in base al quale la cultura – e il teatro, che ne fa parte – sono beni primari che devono essere sostenuti e finanziati dallo Stato. Non si tratta di una mera richiesta di risorse, che possono essere reperite anche da altre parti, ma della difesa di una sacrosanta conquista dell’epoca moderna, per cui alla produzione artistica, alla creatività, alla promozione intellettuale va garantito – come già sosteneva Paolo Grassi più di sessant’anni fa – uno statuto di pubblica utilità non inferiore a quello di altri servizi indispensabili. Lo Stato, poi, potrebbe e dovrebbe promuovere delle leggi che favoriscano e sollecitino l’apporto di capitali privati: ma questi capitali non dovrebbero a mio avviso diventare comunque sostitutivi delle sovvenzioni da parte dello Stato e degli Enti Locali, perché tali sovvenzioni vanno intese come il riconoscimento di una funzione essenziale, come la finalizzazione di ogni singola impresa e iniziativa a un progetto politico più ampio e generale. Perciò ritengo che tutti i tentativi di privatizzazione di enti e istituzioni culturali costituiscano comunque un passo indietro rispetto a delle certezze già acquisite, rischiando di snaturarli e svuotarli dei loro compiti e degli scopi per i quali sono nati. Certo, il fatto di riconoscere la cultura come un servizio di pubblica utilità imporrebbe di distinguere fra le attività di autonoma e disinteressata ricerca artistica – che più necessitano di rendersi indipendenti dal mercato – e quelle svolte a puro fine di interesse commerciale. E renderebbe indifferibile la scelta di destinare i pochi fondi disponibili soltanto alle prime, tagliandoli immediatamente alle seconde. Sappiamo però quanto sia difficile stabilire i criteri che delimitino dei confini definiti fra le une e le altre: infatti, negli ultimi decenni, questa elementare ridistribuzione non è mai stata neppure concepibile, e così probabilmente dovrà continuar a essere, per non correre il rischio di incorrere in equivoci anche peggiori. Da antico fautore del concetto di teatro pubblico, non posso tuttavia non rilevare come l’idea di una cultura al servizio della collettività propugnata da Grassi – al di là delle distorsioni che ha nutrito – sia oggi inesorabilmente tramontata: essa si legava a degli ideali divulgativi e didascalici, a degli intenti di diffusione e democratizzazione del sapere che ormai difficilmente riscontreremmo nelle istituzioni attuali. Erano obiettivi legati a una certa fase della società italiana: non a caso il loro momento in qualche modo culminante fu quello dei cosiddetti decentramenti, dei tendoni o di altre iniziative consimili che portavano l’esperienza del teatro nelle più remote periferie industriali. Oggi tutto questo non sarebbe possibile, e non avrebbe forse ragion d’essere. Ma l’identità, l’esistenza stessa degli Stabili pubblici si legava indissolubilmente – oltre che ad altre esigenze di qualificazione artistica – a questa vocazione pedagogica. E infatti il declino del sistema degli Stabili storicamente comincia, a mio parere, con un passaggio all’apparenza marginale e secondario, ma in effetti determinante: mi riferisco al ritorno di Giorgio Strehler alla direzione del Piccolo Teatro di Milano, nel ’72 – dopo la parentesi della cooperativa Teatro e Azione – alla precisa condizione di poter chiudere l’era dell’impegno civico e dei Teatri Quartiere, per tornare a fare del primo Stabile italiano un’entità unicamente produttiva, nel segno di un’alta ed esclusiva dimensione estetica. Lì comincia l’inarrestabile tramonto, più che di uno specifico organismo, di un intero modello operativo. Va inoltre osservato che la storia degli Stabili italiani è indissolubilmente legata all’ascesa e al trionfo del teatro di regia. Della generazione dei padri della regia italiana, degli Strehler, degli Squarzina, dei De Bosio, dei Missiroli, gli Stabili sono stati la casa e la cassa di risonanza, l’approdo senza il quale un certo modo di intendere la messinscena non si sarebbe potuto sviluppare. Ma essi hanno anche costituito un vero e proprio sistema di potere, che ha fatto in parte terra bruciata intorno a dove va il teatro pubblico italiano? — 41 Sandro Cappelletto Fare un passo avanti e uno indietro L a prima risposta che i nostri legislatori devono dare oggi è se il prin- cipio dell’intervento pubblico a sostegno delle arti deve continuare o no. Due tesi si contrappongono: la liberista e la statalista. La prima ha largamente prevalso negli usa, dove l’intervento federale esiste, ma in proporzione assai ridotta rispetto ai finanziamenti privati e alle agevolazioni fiscali previste per i donatori. In Europa, l’intervento dello Stato e degli Enti locali rimane indispensabile per garantire la produttività di teatri, istituzioni musicali e di danza, del cinema, dei circhi. Esso non è stato, formalmente, messo in discussione neppure negli ultimi anni, neppure in Italia. E tuttavia viviamo in una perenne situazione di attesa, di annunci, smentite, minacce, foschissime previsioni. La politica decida se lo spettacolo va sostenuto. Se la risposta è affermativa, allora ne devono discendere i principi attuativi: regole, modalità e tempi certi di erogazione delle somme stanziate, controllo del modo in cui sono impiegate. Normative vincolanti per tutti, per chi dà e chi riceve. Chi dà deve sapere che l’economia dello spettacolo è un volano di prima importanza per la realtà produttiva e per l’indotto turistico nazionali. Chi riceve, che la sicurezza del posto di lavoro deve essere figlia della propria qualità professionale e che quando le spinte corporative prevalgono, si innesca allora un perverso, paralizzante meccanismo di trattativa. Un passo avanti e uno indietro, contemporaneamente. Avanti nella consapevolezza che il sistema dello spettacolo è radicato profondamente nella cultura e nel lavoro italiani, di cui rappresenta una storica e prestigiosa risorsa artistica e professionale, capace di attrarre – se funziona in modo trasparente – anche capitali privati. E insieme un passo indietro, perché esso non sia più merce di scambio tra lobby, in estenuanti trattative, ma un servizio. Pubblico. Giovanna Marinelli Un’idea di Teatro Pubblico: il futuro tra creatività, innovazione e produttività I l contesto politico, economico e sociale nel quale oggi siamo im- mersi impone una riflessione profonda sul sistema dello spettacolo dal vivo italiano così come si è venuto stratificando nel secondo dopoguerra. Appare del tutto evidente che quel sistema – che rispondeva a condizioni storiche precise – ha improntato il suo modello di programmazione, gestione e sviluppo sul finanziamento pubblico, nella convinzione – peraltro per lungo tempo fondata – che tale intervento (del solo Stato, prima, e degli Enti Locali, poi) non solo non sarebbe venuto meno, ma sarebbe aumentato in base alle esigenze e ai fabbisogni del settore. Questo sistema è entrato in crisi alla fine degli anni novanta, ma si è continuato a cercare di tenerlo in piedi con provvedimenti tampone, dell’ultim’ora, in una sorta di silenziosa complicità tra spettacolo e politica, tra artisti/produttori e amministratori pubblici, che hanno accettato un gioco delle parti fatto di leggi promesse e mai emanate, di deboli proteste e di comune assenza di strategie. Oggi il sistema tradizionale di finanziamento non è più in affanno, è sostanzialmente in recessione e non si vede una strategia alternativa, ma solo tagli orizzontali e qualche tardivo e insufficiente reintegro in una situazione di drammatico disinteresse da parte della politica per la cultura in generale. Il tutto senza che il pubblico (il vero azionista di riferimento del sistema) sia mai stato veramente coinvolto, informato, interrogato. Perché non pensare che il pubblico potrebbe essere più lungimirante dei suoi amministratori, e che, distinguendo tra intrattenimento e cultura (una distinzione mai veramente accettata dai nostri legislatori), potrebbe alimentare una autonoma iniziativa, per così dire, dal basso, esprimere un impegno civile. Ovviamente occorrono alcune riforme (dell’art. 118 della Costituzione, del codice civile, del regime fiscale, ecc), una indicazione chiara su chi fa che cosa tra Stato, Regioni e Enti locali, ma questo è il vero compito del legislatore, chiamato a regolare e a controllare/monitorare. In questa situazione di impoverimento culturale e di crisi economica, i Teatri Stabili Pubblici, il cui modello di servizio pubblico e di teatro d’arte per tutti ha segnato il punto più alto del teatro italiano del dopoguerra, hanno visto progressivamente restringersi il loro campo d’azione, moltiplicarsi i competitors, ridursi fortemente (anche per ingerenze politiche) la spinta innovativa e creativa, sfumare il contatto con il territorio. L’area della stabilità pubblica e privata italiana risulta difficilmente comprensibile a qualunque operatore europeo del settore: le funzioni appaiono simili, i requisiti sostanziali sono gli stessi, la concorrenza è assente, il mercato (se di mercato si può parlare) è lo stesso, uguali gli stakholders. Guardando al futuro, credo che proprio dalle funzioni occorra ripartire per capire se c’è ancora spazio oggi per un teatro pubblico, per un teatro, cioè, che sia pubblico non perché interamente finanziato da denaro pubblico, ma perché in nome di ciò svolge delle funzioni esclusive a vantaggio sia della propria comunità di riferimento, per garantirne l’accesso più ampio e la formazione, sia del mondo del teatro per sostenerne innovazione e creatività: in altre parole, il teatro pubblico oggi deve essere il teatro della conoscenza. Per raggiungere questo obiettivo occorre percorrere una strada irta di ostacoli: politici economici organizzativi, ma soprattutto occorre superare la coazione a ripetere rituali e comportamenti consumati e sempre meno efficaci. Occorre lavorare su un diverso modello di sviluppo che sposti l’asse del teatro pubblico dal sistema di garanzie, di relazioni chiuse, di connivenze e di ambizioni commerciali, a quello di un lavoro umile e quotidiano nel proprio territorio, a un modello di industria creativa leggera che ascolta e offre opportunità, a un progetto artistico e culturale plurale e aperto. Rosanna Purchia Il ruolo delle istituzioni locali L’ intervento statale non può essere il solo. A questo, infatti, deve necessariamente aggiungersi quello delle istituzioni locali, cioè dei nostri enti fondatori. Siamo delle realtà proiettate a livello nazionale e internazionale e che tuttavia hanno il dovere di essere profondamente dove va il teatro pubblico italiano? sé. Ora tutti i segnali sembrano indicarci un declino del teatro di regia, un bisogno di cercare altre forme di linguaggio, altre modalità di realizzazione degli spettacoli da parte dei registi stessi. E questo rischia di fare degli Stabili non più gli spazi privilegiati di un certo tipo di «teatro d’arte», ma dei meri contenitori di proposte indiscriminate. Oggi, nel momento stesso in cui si riafferma l’irrinunciabilità dell’intervento pubblico a favore del teatro, non ci si può tuttavia non chiedere per quale ragione esistano dei teatri automaticamente – e sproporzionatamente – finanziati più di altri, il cui livello di capacità creativa non sembra certo inferiore, anzi appare in molti casi decisamente più vivace e stimolante. A cosa servono gli Stabili pubblici, e perché mai dovrebbe ancora valere la pena di tenere in piedi un insieme di strutture così ingombranti e così ferme nel tempo? Essi in genere non propongono spettacoli migliori rispetto a quelli di altre realtà: al contrario, restano invece ancorati spesso a uno schema di «grandi produzioni» ormai piuttosto superato. Non risulta che siano particolarmente dediti alla tutela della tradizione, della classicità, del grande repertorio nazionale. Salvo lodevoli eccezioni – come l’ert di Modena, e pochi altri – non paiono d’altronde favorire politiche di rinnovamento: per quanto se ne sa, nessun nuovo gruppo, nessuna nuova linea di ricerca è uscita in questi anni dai loro «cartelloni». A parte casi rari – la rassegna «Prospettiva» dello Stabile di Torino, dove però i vari titoli sono presentati per una sola replica – tendono anzi a una programmazione abbastanza vecchia e polverosa, in grave ritardo rispetto a quanto di significativo accade quotidianamente su altre ribalte. Difficilmente fanno fronte ai bisogni di un nuovo pubblico che si va formando, e che richiede esperienze più avanzate. E tuttavia, come diceva tempo fa un saggio operatore, in Italia il sistema degli Stabili per sua natura non si può cambiare o riformare, visto che tutti hanno interesse a farne solo un’enorme macchina burocratica. E invocarne la chiusura per reinventarne le funzioni, o per attribuirne le risorse ad altri destinatari più al passo coi tempi, sarebbe un puro esercizio di masochismo: in un Paese dove non si rifonda nulla ma ci si limita a tagliare, sarebbe una ghiotta occasione per abolire delle strutture dispendiose senza sostituirle e senza utilizzarne i fondi a fini migliori. Dunque, in attesa di momenti più proficui, teniamoceli così come sono, contentandoci di parlarne male non appena possibile, e cercando delle proposte più interessanti dovunque esse si presentino. 42 — dove va il teatro pubblico italiano? radicate nel proprio territorio. Il vero problema italiano è che la cultura, almeno da qualche anno a questa parte, viene vissuta come un qualcosa che possa riempire lo spirito e le menti di pochi, anziché essere sentita come un bene primario, come un profondo servizio formativo e sociale che ognuno –Fondazioni Lirico-Sinfoniche, teatri di prosa, ma anche musei, ecc. – ha il dovere di promuovere costantemente. Ed è qui che le Istituzioni locali devono entrare pesantemente in gioco. Oggi non possiamo non tener conto del fatto che i tempi sono cambiati, che non basta modificare uno statuto per mutare la mentalità delle persone: credo sia mancata una profonda fase formativa, a tutti i livelli, una presa di coscienza di cosa significhi essere una Fondazione di diritto privato, con tutte le agilità che offre un simile assetto, e anche con tutte le incombenze, a cominciare dalla pianificazione dei bilanci e dal rigore delle entrate e delle uscite. Ogni anno ci troviamo di nuovo ancorati a una Finanziaria, a un fus che oscilla tra tagli più o meno importanti. E questo non capita di certo negli altri Paesi europei. Carla Moreni Art. 9: «Lo Stato promuove la cultura» L’ dove va il teatro pubblico italiano? articolo 9 della Costituzione ormai nei Teatri d’Italia lo cono- scono tutti. Il primo a richiamarlo, senza retorica, come un dato oggettivo, è stato Daniel Barenboim, in apertura della stagione scaligera, lo scorso 7 dicembre. A breve distanza, tre giorni dopo, da un’altra sala, all’altro capo dell’Italia, di nuovo l’articolo 9 diventava il cuore di un comunicato dei lavoratori della Fondazione, letto in pubblico prima dello spettacolo: ed eravamo a Palermo, il 10 dicembre, al glorioso Teatro Massimo. Per una singolare coincidenza, a ridosso dell’anno in cui si celebreranno i centocinquant’anni dell’unità del nostro Paese, due città agli antipodi dello Stivale, ricordavano che «lo Stato promuove la cultura». Uno dei punti fondativi della nostra Costituzione. Uno dei primi, baluardo per il tempo di crisi che stiamo attraversando. Scritto così, semplice e piano, come si voleva dopo le orge di trionfalismi, il fascismo, la guerra, la sconfitta, fa effetto. Col verbo centrale – promuovere – così concreto, al tempo presente, e i due interlocutori ai lati: Stato e cultura. Non è solo una coincidenza il fatto che l’articolo 9 sia stato evocato in due Teatri d’opera, due tra i più grandi per la storia artistica. Nei Teatri, così vuole la tradizione, si è fatta l’Italia. Nei Teatri, che sono monumenti vivi, si fondono alcune delle creazioni portanti della nostra cultura. La riflessione conseguente riguarda proprio quest’ultimo termine. Perché anche se è molto confortante ascoltare giovani studenti che scendono in piazza, occupano monumenti simbolici, addirittura arrivano a gesti sbagliati, violenti ed estremi – come è successo spesso in questi ultimi mesi – in nome della difesa della cultura, questa non è una parola generica. Nella sua radice contiene un rimando al culto, simbolico, al sacro. Ma esprime anche l’immagine tutta concreta e quotidiana di un qualcosa che vada coltivato, seguito, lavorato, nell’alternarsi delle stagioni, povere e ricche, benevole o meno, come il lavoro dei campi. L’articolo 9 della Costituzione muove il futuro della cultura. Se concordiamo sul fatto che i Teatri siano luoghi di cultura, dobbiamo chiedere che continuino a restare patrimonio pubblico: sollecitati a una programmazione ricca, con un numero elevato di repliche, come ci insegnano le sale più produttive d’Europa. Che sono poi anche quelle più aiutate dal finanziamento pubblico. Perché se ben gestito, sfrondato nei rami secchi, valorizzato per il cuore artistico, il Teatro non è un passivo, è una ricchezza. Anna Beltrametti Chi ha paura del teatro? I l Ventunesimo secolo si è aperto con le guerre e continua nella po- vertà. La crisi, conclamata dal 2008, è esplosa nel mondo a macchia d’olio. La miseria non è solo materiale e la soluzione di sottrarre risorse alla cultura, che «non si mangia», per sopperire a bisogni più concreti e urgenti è una mossa falsa che può solo aggravare il malessere. Se «la cultura che non si mangia» fosse solo un’uscita estemporanea, sarebbe una battuta infelice, non giustificabile, ma riconducibile all’esasperazione di questo tempo troppo difficile e troppo lungo. Purtroppo non è così. L’espressione coglie perfettamente e sinteticamente nel segno di una politica finanziaria che ha posto in contrapposizione la cultura e la vi- ta quotidiana, intesi come il superfluo e il necessario. Scopre, senza reticenza e quasi con orgoglio, il nucleo ispiratore di chi ha scelto di operare con l’accetta invece che con il bisturi nel groviglio di una crisi senza alcun dubbio soffocante. Non potranno tuttavia dare lungo respiro queste scelte fondate sulla semplificazione. Per un verso, esse trascurano o cercano di negare l’evidenza palmare che in Italia la consistenza dei beni materiali coincide in gran parte con l’eccezionale ricchezza dei beni culturali, riconosciuti come patrimonio dell’umanità e non solo italiano, disseminati nel nostro territorio nazionale e iscritti nel paesaggio prima ancora che raccolti nei musei e nelle chiese. Per l’altro, sembrano non cogliere una verità più sottile e più delicata da amministrare, sembrano – forse vogliono – non riconoscere la cultura come risorsa di miglioramento, come forma di ammortizzatore potente delle tensioni sociali vecchie e nuove, come strumento e occasione di ricomposizione oltre che di analisi. C’è una certa miopia in questo andamento, tanto più se fosse un progetto consapevole e non una negligenza necessaria. C’è anche qualcosa di inedito in questo esibito e prolungato penalizzare la scuola e la ricerca pubblica, in questo deprezzare «le arti». Difficile trovare paralleli nella storia d’Italia, compreso il triste Ventennio con le sue retoriche, e in quella del mondo occidentale moderno. Regola aurea della buona austerità è, è sempre stata, colpire e punire gli sprechi effettivi, non anemizzare il sistema di conservazione, trasmissione e innovazione della conoscenza e dei saperi. Per venire al teatro che insieme con la scuola è la forma di acculturazione più antica. Non è affamando i teatri che si sospenderà la ragione critica e la critica dei poteri. Il tema della censura è particolarmente in voga collegato al diritto di libertà di espressione previsto dall’articolo 21 della nostra Costituzione, ai diritti-doveri del buon giornalismo e alle forme della satira. Ma i comici sono solo un aspetto, sebbene molto significativo e forse il più vistoso, dell’attività teatrale che è particolarmente efficace quando meno ha l’aria di esserlo, o di volerlo essere, trascinando il suo pubblico nella noia didascalica. Attraverso il teatro, fin dai tempi della polis ateniese – i governi non possono permettersi di non saperlo o di dimenticarlo, specie quando rivendicano a gran voce le nobili origini greco-romane contro la barbarie degli altri – passa prima la cittadinanza, poi la cittadinanza consapevole. Non avevano paura del teatro gli uomini che hanno segnato la storia di Atene e che hanno fatto della polis con i suoi meccanismi istituzionali, di cui il teatro era al centro, il miracolo antico universalmente riconosciuto. A Pisistrato, al tiranno per antonomasia, l’uomo forte del potere personale evocato poi come spauracchio, indistintamente, dai democratici e dagli oligarchici del V secolo, si deve l’istituzione dei concorsi drammatici delle Grandi Dionisie, nel 535. Ai padri della democrazia, Temistocle e Pericle, si devono celebri allestimenti di cori tragici in momenti politicamente molto delicati. A Pericle si fa risalire il theorikon, il discusso sussidio che permetteva ai cittadini meno abbienti di assistere agli spettacoli. Eppure dai drammaturghi, questi grandi uomini sapevano di non potersi attendere benevolenza assoluta né, tantomeno, propaganda. Temistocle, Cimone e Pericle, il grande statista Pericle in particolare e poi i suoi successori, erano bersagliati dai comici che ne caricaturavano i difetti fisici e ne colpivano i comportamenti pubblici e privati sia direttamente sia sotto metafora. E la tragedia, il genere drammatico nobile, alludeva spesso alle personalità del momento, ai grandi eventi e ai dibattiti che ne conseguivano, ma mai in forma di elogio. Si pensi, un caso per tutti e senza richiamare troppo facilmente il corrosivo nichilismo euripideo, alla conclusione delle Eumenidi, alla fine dell’Orestea di Eschilo: nel 458, negli strascichi pesanti della rivoluzione che pochi anni prima aveva ridimensionato il potere politico dell’Areopago e inaugurato la democrazia matura di Pericle, la drammaturgia insiste sulla violenza fondativa prima di celebrare la nuova giustizia, sul matricidio come prezzo insostenibile e scandaloso del nuovo mondo. A teatro, diversamente che nell’assemblea, parlavano le donne, gli stranieri, i supplici e gli espulsi, i marginali, gli eccentrici. Ma il teatro era riconosciuto come luogo della memoria collettiva – il mito faceva sopravvivere il passato eroico della Grecia –, della riflessione sul presente e dell’aggregazione: a teatro si andava, in Atene come nei teatri lirici italiani ed europei dell’Ottocento e del primo Novecento, per vedere e per vedersi, anche per farsi vedere come componenti di una società coesa e identificabile anche quando era attraversata da conflitti. Per capire. Perché non garantire la sopravvivenza dei teatri d’opera, quando siamo consapevoli che il mondo della lirica sta all’immaginario e alla sto- dove va il teatro pubblico italiano? — 43 Ascanio Celestini Un ente di promozione per il teatro nazionale T utti gli anni vengono effettuati tagli alla cultura. Non è una novi- tà. Il problema più rilevante non è però questo: si tratta piuttosto di una serie di questioni fra loro correlate. Una di esse, per quanto concerne il teatro di prosa, riguarda il fatto che in Italia si vive in una situazione bloccata da una parte e completamente fuori dalle istituzioni dall’altra. Mi spiego. A essere finanziati sono soprattutto i Teatri Stabili, che – tranne alcune eccezioni – vivono oramai esclusivamente con una politica di scambi: una struttura che produce e che ospita, alla fine produrrà spettacoli che saranno poi ospitati dalle altre strutture a loro volta ospitanti, e ospiterà le produzioni delle altre strutture, e così via... Si tratta di un sistema diventato quasi completamente vincolante. Anche gli Stabili, infatti, cominciano ad avere pochi soldi, per cui riescono a comprare solo spettacoli di altri Teatri Stabili, perché i loro progetti rientrano nei parametri per essere acquistati. È un vero e proprio circolo vizioso, che chiaramente non nasce oggi, con questo Governo o con quello precedente, ma che ha una storia molto lunga alle spalle. L’altra parte della questione riguarda la totale assenza del teatro negli ambiti extrateatrali: non se ne parla nei giornali, non se ne discute in televisione… Il teatro non è da nessuna parte se non nei teatri, e quindi automaticamente diventa un ghetto, con tutti i caratteri, negativi e positivi, che lo contraddistinguono: ci si incontra, ci si conosce, ci si riconosce e si vive completamente isolati da tutto quello che accade fuori. Tant’è vero che risulta strano il fatto che chi si dedica al palcoscenico spazi poi anche in ambito televisivo, cinematografico o letterario. E lo dico per esperienza personale. Se il teatro avesse o gli si volesse davvero riconoscere una funzione pubblica, dovrebbe allora entrare di diritto all’interno del dibattito nazionale. Invece questo non accade. In Italia non esiste un ente di promozione per il teatro. Prima che il Ministero lo chiudesse c’era l’eti, una struttura che aveva senz’altro dei limiti notevoli, e che tuttavia non si sarebbe dovuta chiudere ma piuttosto far funzionare. Quanto ad esempio Filmitalia realizza per il nostro cinema dal punto di vista promozionale ha fatto sì che le pellicole italiane in questi ultimi anni abbiano guadagnato una notevole visibilità all’estero: dal Festival di Toronto a quello di Shanghai il nostro cinema è sempre presente e spesso vince dei pre- mi. Per cui è fondamentale che esista anche per il teatro un ente di promozione e collegamento, in Italia e all’estero. In assenza, accade che in molte Province e in altrettanti Comuni si verifica uno sbandamento, uno spaesamento: l’assessore alla cultura del piccolo comune friulano, ad esempio, fa fatica a capire quali siano gli spettacoli che potrebbero essere adatti al proprio teatro, e spesso non sa in che maniera organizzare una rassegna e una stagione. Da questo deriva il fatto che, oggi, in Italia ci sono compagnie del Nordest che girano solo nel Nordest, compagnie del Centro che girano solo nel Centro, compagnie napoletane che non si muovono da Napoli e gruppi siciliani che non escono dalla Sicilia. È assurdo. E si tratta solo di alcuni dei grossi problemi che vive il teatro in questo momento. Lo ribadisco: manca un ente teatrale. E forse mancava anche prima, quando c’era. Adesso però la situazione è incredibile. È come se il Ministero avesse detto: questo ospedale non funziona bene perché alcuni malati non vengono adeguatamente curati, quindi lo chiudiamo. Un’assurdità. Quando è stato chiuso l’Ente Teatrale Italiano mi trovavo a Parigi, al Théâtre de la Ville, con uno spettacolo organizzato insieme allo stesso eti, ed è stato davvero imbarazzante sentire che ci stava sfuggendo da sotto i piedi, per giunta nello stupore generale dei francesi che non si capacitavano del fatto che non avessimo più in Italia una struttura di riferimento a livello nazionale. Sparse sul territorio ci vorrebbero tutta una serie di realtà organizzate come punto di riferimento per le compagnie, grandi o piccole che siano. Oggi la piccola compagnia lavora nella cantina di papà (se la cantina di papà c’è); una compagnia grossa invece o è completamente invischiata nei parametri del sistema, entro i quali deve stare per prendere due lire, oppure ne sta completamente al di fuori. È una situazione piuttosto ridicola. Carlo de Incontrera Il sistema musicale rischia l’asfissia A bbiamo sentito tutti, penso, le sbraitate volgarità di certi nostri governanti contro il teatro, contro tutti i lavoratori dello spettacolo. Sarebbe un insulto all’intelligenza e alla dignità, rispondere a tono, tentare un dialogo. Del resto, una dimostrazione evidente di quanta parte della popolazione abbia ormai rinunciato al dibattito, abbia preso le distanze dalla politica di questi urlatori di slogan è la massiccia defezione agli appuntamenti elettorali. Non si tratta dunque, per una evidente mancanza di interlocutore, di spiegare, di ragionare, di convincere. E non si tratta nemmeno di rassegnazione. Ma in assenza di nuove regole di gioco, tali da riportare il Paese ad un assetto democratico, o quantomeno al ritorno di quella democrazia che avevamo conquistato nel dopoguerra, temo che non si possa far altro che prendere atto della penosa realtà dell’oggi. Il fus, dunque. Ritenere che un’opera di diffusione culturale – drammatica, lirica, musicale –, di spettacolo dal vivo possa reggersi senza un contributo consistente pubblico e/o privato è pura follia. In nessun Paese al mondo accade un simile miracolo. La forbice tra il costo di uno spettacolo e le sole entrate (abbonamenti e biglietti) è facilmente dimostrabile, anzi, parlarne è addirittura fatica sprecata, tale è l’evidenza del problema. Il mercato dello spettacolo, nel suo sistema assai complesso, fatto di noleggi, spese fisse, servizi tecnici, vigilanza, apparati amministrativi e artistici, cachet artisti, viaggi, alberghi, tasse varie... non è sostenibile con i soli incassi di botteghino. Gli elementi che sono costitutivi di uno spettacolo non permettono di creare profitto, se non nel cosiddetto indotto. Rare le eccezioni. E, praticamente senza eccezioni, sono le manifestazioni culturalmente più impegnate, basate sulle novità, su titoli poco conosciuti. Anche un teatro tutto esaurito non riesce a coprire i costi. O si dovrebbe far pagare allo spettatore prezzi proibitivi, soprattutto proibitivi in momenti di vacche magre. E in ogni caso non sarebbe un’azione culturale democratica, proponendosi soltanto ad un’élite danarosa, escludendo tutti gli altri, ingenerando persino delle distorsioni interpretative dello spettacolo stesso: non opera di cultura ma di snobismo presenzialista. Vorremmo tutti, comunque, i teatri pieni. E ognuno di noi: per fare il tutto esaurito, oggi si deve inseguire il pubblico con le proposte più scontate, con i titoli più popolari, con gli artisti lanciati o consacrati nei salotti televisivi. Oppure invitando artisti stellari, quelli più universalmente conosciuti (e in questo caso si possono anche avere amare sorprese, in quanto nomi ovunque celeberrimi non risultano tali nell’agen- dove va il teatro pubblico italiano? ria degli Italiani come il mito stava all’immaginario e alla storia dei cittadini ateniesi? Perché non riconoscere agli Stabili di Prosa e agli Stabili d’Innovazione la funzione insostituibile di mantenere il pubblico, i pubblici, in rapporto costante con la nostra tradizione e il compito di lanciare le sfide del rinnovamento, le provocazioni necessarie? Perché non sostenere le nicchie di ricerca più autentica, i giovani più promettenti e meno noti, quindi fuori dai circuiti del teatro commerciale? Perché rinunciare alla tradizione lirica troppo costosa per potersi mantenere con l’autofinanziamento, ma troppo prestigiosa e significativa per essere lasciata morire? Non tutto può trasformarsi in impresa e compito, o forse merito, dello Stato, dovrebbe essere quello di promuovere le alternative al mercato e al conformismo commerciale, quello di sostenere, attraverso una redistribuzione corretta di entrate correttamente prelevate, i servizi che per definizione sono a carico pubblico, la sanità, l’istruzione, la giustizia. Cosa possiamo immaginare dietro i tagli sulla scuola, la ricerca e lo spettacolo? O i disinvestimenti sottintendono il disegno di smantellare scientemente, progressivamente i più forti fattori di cittadinanza nazionale matura e consapevole in vista di una pedagogia diversamente fondata. O sono effetti della paura. Temiamo il teatro come luogo di critica e di dissenso? Il dissenso aperto e dichiarato è strumento di crescita collettiva e reciproca, per chi critica e per chi ne raccoglie le voci. Dell’altro, i governi dovrebbero avere più paura, del dissenso che viene soffocato e cova sotto le ceneri, nel disagio, pronto a deflagrare rovinosamente. Lo aveva ben detto Emone, il figlio di Creonte, al suo implacabile padre: «[…] Tu non puoi accorgerti di tutto quello che uno dice o fa o disapprova. Il tuo sguardo temibile mette a tacere l’uomo della strada, non gli fa dire le cose che non ti farebbero piacere. A me invece è possibile udire certi discorsi nell’ombra, sentire che la città è addolorata per questa giovane. […] Questa voce, coperta, serpeggia nel silenzio» (Antigone vv. 688-700). Ma il padre non gli aveva dato ascolto, si era anzi scagliato contro di lui ed era finito travolto dalla propria sordità non meno che dal proprio fondamentalismo. dove va il teatro pubblico italiano? 44 — dove va il teatro pubblico italiano? da del pubblico italiano), dai cachet vertiginosi e traumatici per il bilancio della serata o dell’intera stagione. Sempre più evidente appare la mancanza di curiosità del pubblico. Un fenomeno non solo italiano, ma soprattutto italiano. E la responsabilità di questo spaventoso declino della coscienza collettiva, risiede nella politica del nostro Paese, in quanto promotrice di una lenta e sistematica azione anticulturale, costruita con machiavellica abilità. Mi riferisco soprattutto al mio campo, alla musica. Quella che dovrebbe essere una delle fondamentali risorse spirituali, intellettuali e sociali, in Italia è considerata un’arte minore, una disciplina immeritevole di particolari attenzioni e studio. Piuttosto sentimento che sgorga direttamente dal cuore, intrattenimento facile, spensierato. Tutti ingredienti perfetti per i mass media, che li accolgono e li amplificano, perché producono audience, ossia profitti. Di contro, la musica cosiddetta classica, frutto di una società colta, in una società allevata nella incultura musicale, non produce audience, ossia profitti. Di conseguenza viene esclusa dai maggiori veicoli di comunicazione, che contribuiscono in maniera esponenziale alla sua impopolarità... Solo lo Stato può salvaguardare il patrimonio musicale «classico», se ha coscienza di tale patrimonio. Solo lo Stato può garantire l’esistenza alle opere musicali più complesse e come tali difficili, se non incomprensibili a un pubblico impreparato. Il privato, che nel sostenere queste manifestazioni culturali gode di ben pochi benefici fiscali, non può sostituirsi allo Stato, in quanto attratto, quasi esclusivamente, da quelle manifestazioni che rendono in immagine di mercato. Evidentemente diversa è la situazione negli altri Paesi occidentali, dove gli incentivi ai privati favoriscono il mecenatismo culturale. E dove, comunque, lo Stato interviene massicciamente a sostegno delle attività teatrali e concertistiche. In ultima analisi il problema può riassumersi nel credere o non credere nell’importanza della musica, quale valore inalienabile. E di riflesso, nel volere e nel sapere attuare le politiche adeguate. Certamente non erano e non lo sono quelle dei contributi a pioggia clientelari e a fini elettoralistici, la creazione di stipendifici negli organigrammi delle istituzioni culturali e artistiche, sempre per gli stessi fini, facendo aumentare ingiustificatamente le spese fisse di gestione a discapito della qualità delle produzioni; non erano e non sono politiche adeguate certe nomine affatto improbabili, sfacciatamente lottizzate, ai vertici di varie istituzioni artistiche, come non lo erano e non lo sono le ingenti sovvenzioni a certe manifestazioni pomposamente etichettate come «grandi eventi». E così di seguito, a «effetto domino», con grande spreco di denaro pubblico e con risultati spesso inadeguati. È bene sottolineare, comunque, che tali pesanti interferenze albergano ovunque nella vita italiana, e il settore cultura, tanto preso di mira, non è certamente l’eccezione: è la vittima sacrificale – perché implicitamente poco considerata rispetto ad altre necessità – ogni qual volta si affronta il problema dei tagli di bilancio. La musica poi, in particolare la concertistica, è la cenerentola per antonomasia, la più fragile fra i generi musicali. Quando si parla di tagli si comincia sempre dalla cultura, mai dalle spese di gestione della politica, mai dagli scandalosi privilegi dei professionisti della politica, per non dire di quelli, tra i privilegiati, che decidono con il loro voto i tagli alla cultura, imbullonati alle poltrone nonostante le impietose interviste delle Iene. La situazione economica generale impone, sicuramente, dei sacrifici, anche nel settore culturale e musicale. Peraltro, come evitare il paragone tra l’Italia e gli altri Paesi europei che hanno deciso in maniera opposta a noi, investendo maggiormente nella cultura, con massicci aumenti di finanziamento. Il rischio che si corre a seguito dei ripetuti, pesanti tagli del fus – e a cascata di quelli degli enti locali – è la asfissia del sistema musicale, reso già fragile dalla mancanza di un supporto scolastico adeguato. Tutti lamentiamo la mancanza di ricambio del pubblico, la scarsità di giovani ai concerti, ormai frequentati per la stragrande maggioranza da persone di mezza età. Ben difficilmente si potrà riconquistare un pubblico ancora più anziano e attirarne uno nuovo e giovane, vista l’assenza, nella riforma scolastica, di un credibile percorso musicale. Una cosa è certa: il dovere morale di chiunque abbia la responsabilità artistico-musicale di un teatro, o di qualsiasi altra istituzione organizzatrice di concerti, deve essere quello di resistere alla tentazione di riempire la sala a tutti i costi, cedendo alle pressioni e alle tentazioni di fa- re «ciò che piace alla gente». Perché alla gente piace solo quel poco che già conosce. E oggi quel poco è diventato ancora più modesto, succube di una programmazione tv influenzata dalle indagini di mercato. Una sorta di avvitamento culturale che sta spegnendo ogni curiosità. Questa è la tragedia. Sia ben chiaro, tutti vorremmo i teatri sempre pieni di gente appassionata ed entusiasta. Ma se per riempire i teatri diamo in pasto al pubblico sempre le stesse cose, le sole cose che il pubblico ama, non facciamo che contribuire allo spegnimento di quel poco che è rimasto di curiosità. Dunque, non facciamo cultura, ma solo killeraggio della cultura. Non dobbiamo essere complici di questo scempio. Dobbiamo reagire, dobbiamo essere creativi, dobbiamo unire le forze, aumentare le coproduzioni, prendere le distanze dai lacchè della partitocrazia, dobbiamo fare più sacrifici e produrre meglio di prima. Dobbiamo avere fiducia nei giovani talenti, seguirli, aiutarli, anche, umilmente, chiedere a loro aiuto, metterci a loro disposizione anziché privarli di qualsiasi prospettiva. Tentare di aiutarli ad imporsi alle platee, impigrite e desiderose solo di «eventi». Certo, non è facile essere creativi, non basta essere davvero professionalmente capaci, se la classe politica ritiene che la cultura sia un optional inutile, una macchina mangiasoldi, del tutto improduttiva. Ma non abbiamo scelta, se non vogliamo scadere definitivamente agli ultimi posti nella classifica mondiale della incultura musicale. Vitaliano Trevisan Se costringono a fare scelte, benvenuti i tagli U n’idea semplice e banale: leggere gli statuti che configurano scopi e finalità degli enti in oggetto e prenderli sul serio, cioè comportarsi di conseguenza. Basterebbe questo. Ma quell’imprescindibile «contesto socioculturale in cui viviamo» – vedi quesito, presuppone, per tacito accordo tra le parti, esattamente l’opposto. A questo punto i famigerati tagli, per quanto non certo pensati a questo scopo, costringendo gli operatori, pubblici e non, a operare delle scelte, potrebbero anche sortire effetti positivi. Certo, almeno per ora – vedi cartelloni dei vari in-stabili, l’effetto sembra risolversi nella semplice riduzione in numero dei cosiddetti soliti noti. Al fondo la totale mancanza, in Italia, dell’idea di possedere una cultura viva, e perciò utilizzabile – nell’accezione migliore del termine, in senso politico e civile. Al contrario, radicato e diffuso l’esiziale concetto che, specie in tempi di crisi, ogni soldo dato alla cultura è rubato al pane. Perciò, per quanto mi riguarda, nessuna speranza. Non per questo lascerò di far teatro nei modi e nelle forme che, di volta in volta, si renderanno possibili. Non avere speranza non è mai scusa bastante. Cesare De Michelis Il tramonto del teatro pubblico I l teatro pubblico è un’idea giacobina che si afferma con la rivoluzio- ne e trova le sue ragioni nel ruolo educativo che allora si assunse lo Stato, ruolo a sua volta reso necessario dalla pratica democratica del suffragio popolare drammaticamente indebolita dall’ignoranza e dall’incompetenza delle nuove masse rurali e anche inurbate ma costrette dal bisogno a un’esistenza marginale. Lo Stato, dunque, fece suo il compito pedagogico di una formazione al tempo stesso civile e morale per un verso e professionale per l’altro per sottrarre il popolo all’ignoranza e alla miseria. Il teatro così, riallacciandosi alle sue origini classiche e mitiche, veniva trasformato in un’aula nella quale il pubblico conveniva per imparare anziché per divertirsi com’era stato durante l’ancien régime, quando la stessa sala era stata trasformata in un condominio di palchetti signorili dove, al riparo di occhi indiscreti, gli spettatori assistevano allo spettacolo di una vita al quadrato, arricchita da scenografie baluginanti, da macchine e diavolerie sorprendenti, e dalla seducente bellezza delle attrici. Da un lato, dunque, la commedia e l’opera incantavano un pubblico pagante che voleva divertirsi scordando affari e negozi, doveri e impegni, e dall’altro un pubblico sollecitato in nome di astratti valori doveva assistere a una vicenda inequivocabilmente «catartica», nel senso che la condanna dei reprobi valeva come monito per diventare migliori. Nessuno mai avrebbe finanziato il primo teatro, che peraltro nep- dove va il teatro pubblico italiano? — 45 Cesare Mazzonis Il teatro è servizio pubblico, come scuole e ospedali I l teatro pubblico è una caratteristica essenzialmente europea, con- trariamente a quanto avviene ad esempio negli usa e ora in diversi paesi emergenti. Inutile disquisire qui su reciproci vantaggi e svantaggi nonché sulle condizioni di nascita. Resta il fatto che non si può scardinare né capovolgere quella che è stata una scelta chiara: scuole, ospedali, teatri sono un servizio pubblico. Troppo onerosi? In un contesto di bilancio statale totale certo no, ma nulla vieta che ci si possa sedere a un tavolo e intelligentemente trovare soluzioni intelligenti per oggi. Purché non si parta da pregiudizi o slogans, né da una parte né dall’altra. Mi riferisco sia al sindacato, che è stato miope sulle conseguenze di certe «conquiste» (ma quali conquiste, a bene esaminarle) assolutamente non funzionali all’andamento teatrale, sia alle Direzioni sovente lassiste «pro bono pacis», sia a quelle autorità dello Stato che arrivano a uscirsene in certe «boutades» del tipo che l’opera lirica è cosa per vecchi borghesi con il pannolone: e qui vorrei sapere che cosa pensano di offrire a una società della quale si piange e lamenta l’imbarbarimento, se poi si falcidia la cultura. Stéphane Lissner La cultura è un bene di tutti F in dal primo giorno del mio arrivo a Milano, nel maggio del 2005, ho affermato un concetto fondamentale: la Scala, per quanto organizzata come Fondazione di diritto privato, è un teatro pubblico. La Scala è impegnata a fornire un servizio ai cittadini. Per questa ragione credo sia dovere dello Stato sostenere la Fondazione Teatro alla Scala con fondi adeguati al compito di cui è investita. Così avviene in ogni parte d’Europa, perché è nel dna, nel pensiero, nella storia dell’organizzazione sociale europea che la cultura sia un bene di tutti, dunque sostenuto con denaro pubblico. Oggi la Scala riceve dallo Stato, attraverso il fus, circa il venticinque per cento del suo budget annuale (che è pari a circa centoquindici milioni di euro). Le sovvenzioni pubbliche salgono al quaranta per cento con i contributi di Comune, Provincia e Regione. Il sessanta per cento del budget annuale è formato da risorse proprie: abbonamenti, vendite di biglietti, contributi dei Soci Fondatori, di Sponsor, di privati. Con queste proporzioni la Fondazione Teatro alla Scala copre con risorse proprie anche i costi fissi del lavoro, delle masse artistiche e tecniche, mentre la logica del finanziamento pubblico è appunto di garantire il funzionamento della «macchina» teatrale, demandando agli eventuali contributi privati (variabili in virtù delle capacità «attrattive» di ogni Fondazione) la possibilità di produrre di più e meglio. Anche sotto questo punto di vista, la Scala è un teatro virtuoso perché il costo del lavoro incide per il cinquanta, cinquantacinque per cento del budget. La percentuale più equa e sicura per una sana gestione è quella opposta: sessanta per cento di contributi pubblici, quaranta di risorse proprie. Così avviene nei teatri d’Europa che sono il riferimento della Scala: l’Opéra di Parigi riceve più del sessanta per cento dallo Stato, come la Staatsoper di Vienna. Analoga la situazione nella Germania federale. Il sistema prevalentemente privatistico che vige nei Paesi anglosassoni è legato a una diversa cultura e sostenuto da un sistema fiscale logicamente conseguente, sia per le imprese sia per i privati cittadini. Nel 2009 la Scala ha ricevuto dallo Stato, come percentuale del fus nazionale, trentasette milioni di euro, ma ne ha versati trentanove in tasse. Evidentemente qualche cosa non funziona nel giusto verso in questo meccanismo. Antonio Cognata Finanziamento pubblico e nuovi incentivi P er certi tipi di spettacolo dal vivo, e l’esempio tipico è proprio il te- atro d’opera, non c’è dubbio che l’intervento economico dello Stato sia assolutamente necessario. Il processo produttivo e le caratteristiche strutturali dei costi e dei ricavi fanno infatti dell’opera un’attività che non può finanziarsi con i soli ricavi propri. È quindi necessario l’intervento esterno, in questo caso pubblico, perché nessun privato produrrebbe l’opera poiché andrebbe inevitabilmente in perdita. L’intervento dei privati tuttavia può esserci in quei sistemi in cui quello statale non avviene in maniera diretta bensì attraverso un sistema di incentivi che normalmente incidono sulla detassazione dei contributi: si tratta comunque sempre di soldi pubblici, ossia di quella parte di tasse che lo Stato non riscuote. Anche in questo caso l’intervento è sempre pubblico ma i Teatri lo ricevono indirettamente attraverso le donazioni private. Per quanto concerne il teatro di prosa, invece, il suo processo produttivo non è necessariamente no-profit: infatti non si può dire che le caratteristiche strutturali di uno spettacolo di prosa impediscano che la produzione possa essere ripagata con i propri ricavi. Se poi si decide che per ragioni di politica culturale la prosa debba anch’essa essere finanziata con risorse pubbliche, questo si può sempre fare, ma avendo presente che in quel caso mancano quelle caratteristiche specifiche che rendono lo spettacolo insostenibile economicamente. In diverse parti del mondo, infatti, la prosa non è per niente finanziata attraverso sussidi pubblici e questo proprio perché non vi è la necessità che ciò avvenga, necessità che invece è sempre e comunque ravvisabile per il teatro d’opera. Una volta stabilito che una parte rilevante delle risorse per la produzione degli spettacoli devono arrivare attraverso il finanziamento pubblico in forma diretta, allora diventano rilevanti le modalità di finanziamento. Lo Stato, indipendentemente dal budget che decide di assegnare, dovrebbe creare un meccanismo che obblighi il finanziato – in questo caso il teatro d’opera – a essere in qualche modo il più virtuoso possibile: deve produrre e produrre bene, avere una strategia per minimizzare i costi massimizzando la produzione, garantire una buona affluenza di pubblico, avere i bilanci in ordine sotto gli aspetti economici e patrimoniali, ecc. Bisognerebbe insomma individuare dei parametri da inserire in un meccanismo di controlli e incentivi. Oggi purtroppo questi ultimi sono davvero pochissimi. Basti pensare che la parte di fus che viene assegnata a ciascuna Fondazione Lirica sulla base della quantità di spettacoli prodotti è appena del venti per cento: decisamente troppo poco. Sicuramente sarebbe anche molto utile avere in anticipo certezza sull’ammontare delle risorse destinate ai teatri da qui ai prossimi tre anni. Ma purtroppo affinché questo sogno possa avverarsi biso- dove va il teatro pubblico italiano? pure cercava sostegno o consenso dai pubblici poteri, tutti al contrario pretendevano aiuti consistenti per il secondo, che infatti divenne subito «pubblico» e tale per sempre da allora è restato. Perché mai questa idea di teatro pubblico, tramandatasi nei secoli della modernità, oggi scricchiola e vacilla? Sarebbe troppo facile sostenere che il suo tempo si è compiuto, che la modernità è giunta al termine del suo corso liquidando uno dopo l’altro gli idoli che aveva costruito, a partire dall’idea del progresso come una strada che diritta va incontro alle magnifiche sorti futuribili, della quale resiste appena una parodia tecnologica svuotata di senso e caricata invece di desideri e consumi, continuando con l’idea dello sviluppo e della crescita, costretta a misurarsi con l’esigenza di un limite, e con la produzione seriale con la conseguente divisione del lavoro, che a sua volta diventava la premessa della struttura classista della società, a cui poi è succeduta una polverizzazione sociale che è al tempo stesso culturale e morale. In questo scenario tutt’affatto imprevisto quell’idea giacobina del teatro, dell’educazione e della cultura ha perso straordinariamente fascino e forza, mostrando la sua natura paternalistica e autoritaria, il proprio proposito inevitabilmente propagandistico, e diventando pertanto occasione di noia se non addirittura di insofferenza. Si spiega così nelle democrazie europee il progressivo disinteresse degli Stati per la cosiddetta «politica culturale» e conseguentemente la riduzione sempre più drastica dei finanziamenti statali allo spettacolo dal vivo, percepito piuttosto come un privilegio d’èlite estraneo e lontano rispetto ai «bisogni» della gente comune. C’è invece una nuova attenzione per lo spettacolo libertino che sostituisce quell’altra per il teatro libertario che dettava leggi e imponeva regole; ora, piuttosto, si ha voglia di distrarsi, disposti anche a pagare pur di avere l’opportunità di scegliere e decidere. La transizione dalle pratiche della modernità a quelle altre sconosciute dell’età che viene dopo è tutt’altro che compiuta, anzi siamo proprio nel mezzo del guado, ma, è chiaro, indietro non si torna e per andare avanti c’è bisogno di una riforma davvero «grande», della quale nessuno sinora si è provato a immaginare e disegnare il progetto, mentre sarebbe persino urgente metterlo in atto. 46 — dove va il teatro pubblico italiano? gnerebbe cambiare le regole della finanza pubblica italiana. E mi sembra piuttosto complicato. Alberto Bentoglio Teatro, pubblico servizio dove va il teatro pubblico italiano? 1. Il peso dell’intervento pubblico deve essere quantificato in merito all’importanza che le singole strutture rivestono nel tessuto sociale. Quindi, se una struttura possiede parametri quantitativi e qualitativi elevati, l’intervento pubblico (attraverso fus, regioni, province, comuni, altri enti pubblici) deve essere altrettanto consistente. Ricordo solo che, per quanto riguarda le Fondazioni Lirico-sinfoniche, i parametri quantitativi sono dettati soprattutto dalla presenza di un numero molto elevato (ma indispensabile) di personale a tempo indeterminato. Da qui, la necessità di un intervento pubblico cospicuo (nel 2009 il quarantesette per cento del fus). 2. La funzione del teatro pubblico (intendo con «teatro» lo spettacolo dal vivo in tutte le sue manifestazioni: prosa, musica, lirica danza, ecc.) è sempre la stessa. Non mi sembra sia cambiata, almeno negli ultimi settanta anni. Si tratta di un «pubblico servizio» che si assume precise responsabilità culturali e politiche. Paolo Grassi, lo sanno tutti, diceva sempre: il teatro è un servizio pubblico come la metropolitana, l’ospedale, la scuola. Quindi, con precisi diritti e doveri. Ciò non toglie che possa esistere anche un teatro «privato», ma questa è un’altra cosa. Non meno importante, ma è differente. Per quanto riguarda il sistema vigente, è impossibile dare un giudizio globale. Nel senso che alcune cose, a mio modesto parere, funzionano, e anche bene (penso ad esempio al lavoro svolto da molti enti locali), altre un po’ meno e necessitano di correzioni (le critiche ai regolamenti che determinano gli stanziamenti fus sono state molte). Il problema semmai è a monte ed è squisitamente politico: il «pubblico» (lo Stato, per primo) investe poco nei Beni Culturali, troppo poco e, per conseguenza, nello spettacolo dal vivo con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Anna M. Alessandra Merlo Teatro pubblico tra Stato e management Q uando si guarda alle problematiche del proprio tempo è piutto- sto naturale considerarle come se fossero più gravi che in altri tempi e contesti: si tratta di cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che ci toccano da vicino, e dunque rispetto a cui abbiamo una percezione intensa, e siamo più sensibilizzati. Ma occorre invece sforzarsi sempre di guardare anche altrove, in altre epoche e in altri luoghi, per riequilibrare le nostre valutazioni e avere un quadro più completo e bilanciato. È vero in effetti che il contesto in cui viviamo è complesso, e che in tale contesto non è affatto facile trovare un buon assetto, tra le altre cose, anche per il teatro, lo spettacolo, la cultura. Ma se per esempio si pensa al passato, ci si rende conto facilmente che non è mai stato facile, per queste tipologie di attività, godere di una buona collocazione, se non in casi molto particolari, all’ombra di pochi potenti illuminati. Per il resto, evidentemente a titolo non di consolazione bensì di consapevolezza, la storia ci trasmette vicende innumerevoli di artisti anche geniali ma generalmente trascurati quando non perseguitati. In fondo, i decenni tra il secondo dopoguerra e gli anni ottanta in Europa hanno rappresentato anche per la cultura, come per molti altri ambiti a partire dall’economia, una fortunata eccezione, da cui stiamo recedendo rapidamente e non senza traumi. «Nihil novum sub sole». Però in realtà oggi qualcosa è cambiato, rispetto al passato, qualcosa che rende oggi molto meno accettabile che in precedenza il fatto che la cultura e chi la rappresenta non ricevano attenzione e anzi, per dirne una per tutte, subiscano dei tagli in modo indiscriminato. Si tratta del fatto che la cultura in senso lato incorpora e rappresenta ciò che oggi dovrebbe essere l’essenza dell’economia e più in generale della società e degli individui: la conoscenza, la creatività, i valori immateriali. Se nei secoli e nei decenni precedenti per certi versi poteva essere comprensibile che la cultura restasse in second’ordine rispetto ai valori materiali (terra, beni, braccia, denaro), oggi appare sempre più anacronistico e miope, soprattutto in contesti più che maturi come l’Europa, liquidare il discorso considerando che «la gente non mangia cultura». La constatazione dell’importanza specifica della cultura in questa fase aiuta a ragionare su che peso potrebbe avere al riguardo l’intervento statale: se la cultura è davvero un fattore strategico nelle economie e nelle società moderne, l’intervento statale, in quanto deputato a «garantire condizioni» all’interno della società e dell’economia, dovrebbe avere un peso ugualmente strategico. Che l’intervento statale debba avere un peso strategico, però, è un’espressione alquanto generica, per più di un elemento. Prima di tutto per il fatto che «statale» può essere un modo per identificare convenzionalmente tutti i possibili livelli pubblici, quindi non soltanto lo Stato (livello politico, istituzionale e amministrativo che in realtà negli scenari moderni va diminuendo di importanza) ma anche se non soprattutto le regioni, i comuni, i vari soggetti istituzionali pubblici territoriali e non. In secondo luogo per il fatto che «intervento» può significare varie cose, non esclusivamente finanziamento. Anzi: che fosse anche per un «equivoco» di questo tipo che a oggi il settore culturale è così gestionalmente fragile? Finanziamento, poi, come spesa oppure, meglio sarebbe, come investimento? Ma non è la sede per questi approfondimenti. Intervento può significare per esempio: formulazione di politiche (ottimizzare o indebolire l’efficacia di misure fiscali come il 5/000), valutazione di risultati (definendo parametri e standard per poter prendere decisioni in modo più razionale). Per essere sistematici, i possibili interventi pubblici in campo culturale, così come in altri ambiti di competenza, possono sostanziarsi in cinque principali macro-famiglie: policy making proprietà finanziamento gestione policy evaluation. Il finanziamento è dunque una delle cinque macro-famiglie di competenze pubbliche, anche in campo culturale. Non solo, andando a ingrandire tale macro-famiglia, possono essere individuate quattro principali tipologie di finanziamento: diretto all’offerta, costituito tipicamente dai trasferimenti pubblici alle istituzioni culturali indiretto all’offerta, costituito tra l’altro da possibili agevolazioni fiscali a favore di istituzioni culturali diretto alla domanda, ben poco utilizzato per ora, e rappresentato per esempio da voucher a favore di spettatori e visitatori indiretto alla domanda, anch’esso per ora molto poco diffuso, e rappresentato per esempio da eventuali sgravi fiscali a favore della fruizione culturale. Da questa classificazione si desume che il finanziamento in quanto trasferimento diretto, pur essendo la modalità di sostegno alla cultura più tradizionale e certamente al momento più utilizzata, non è affatto l’unica possibile, vi sono anzi altre tre tipologie, che presentano aspetti interessanti e potrebbero generare virtuose conseguenze, quando ben attivate. Intervento, quindi, non significa necessariamente finanziamento, e finanziamento a sua volta non significa necessariamente trasferimento diretto; significa certamente «investimento». In terzo luogo, gli interventi pubblici, certamente strategici in campo culturale, possono essere indirizzati a vari livelli, da quello della singola organizzazione culturale a quello di intere filiere / sistemi territoriali, distretti, ecc. E possono rivolgersi dal piano operativo (a esempio un comune potrebbe approvare con propria delibera le tariffe e le condizioni per l’affitto di una sala da parte di un’istituzione teatrale) a quello strategico (a esempio il Ministero potrebbe ratificare la nomina dei vertici di un teatro, oppure potrebbe emanare delle linee-guida per la finanziabilità di progetti in campo teatrale). Anche alla luce del nuovo ruolo di coordinamento e valutazione che si sta delineando per la pubblica amministrazione un po’ in tutti i settori, è evidente che l’intervento pubblico in campo culturale non dovrebbe indirizzarsi a livello organizzativo e produttivo in senso stretto, bensì a livello di indirizzo strategico. A esempio, la pubblica amministrazione potrebbe dare indicazioni di raccordo con le linee di sviluppo strategico a livello generale, potrebbe definire obiettivi relativamente al coinvolgimento di nuovi pubblici, o anche relativamente a progetti di promozione territoriale, corredati da parametri per l’implementazione e la valutazione, sulla cui base le singole istituzioni culturali verrebbero pertanto valutate, riconosciute, accreditate, verificate periodicamente, e in virtù dove va il teatro pubblico italiano? — 47 Definire priorità / obiettivi politici chiari, attuali, intelligenti, realistici e sufficientemente condivisi Mettere a punto strumenti agili, ai fini della realizzazione degli obiettivi da parte della pubblica amministrazione e parimenti anche da parte di soggetti terzi Tra gli strumenti, definire dei sistemi efficaci, e dunque articolati ma non troppo pesanti, di criteri, parametri, indicatori, da utilizzarsi in alcune fasi: valutazioni ex ante, azioni e valutazioni in itinere, valutazioni ex post Attivare condizioni adeguate, a livello normativo / regolatorio, istituzionale, operativo, finanziario, fiscale, contrattuale, ecc., ai fini della realizzazione degli obiettivi Applicare le regole e gli strumenti definiti in modo trasparente e lineare (non vi è nulla di più devastante che produrre molti riferimenti, e poi non applicarne mai nessuno in maniera sistematica e omogenea) Razionalizzare il sistema, eliminando eventuali ridondanze, riducendo le inefficienze, concentrando gli sforzi e perseguendo le massime sinergie Stressare ragionevolmente il sistema nel suo complesso e le singole istituzioni sui risultati, incrementando progressivamente il livello atteso degli stessi Applicare in modo equilibrato ma incisivo premi e sanzioni in rapporto alle performance ottenute Considerare i conflitti come una componente strutturale dei sistemi, da governare e da cui non essere però condizionati; sfidare i conflitti sul piano dei risultati Mantenere una capacità evolutiva intrinseca al sistema, anche grazie ad adeguati meccanismi di rappresentanza e mediazione di interessi, grazie ad architetture di governance e relazioni di network. Carmelo Alberti Un’idea di teatro nello spazio-tempo della contemporaneità C iò che, dal secondo dopoguerra a oggi, è cambiato nel «valore» del teatro è la sua sintonia – ma sarebbe più corretto dire la sua dissonanza – con il tempo e lo spazio dell’immaginazione collettiva. Il carattere «pubblico» del teatro, pertanto, corrisponde raramente alla diffusione del pensiero condiviso: perché si attui nuovamente tale condizione, servirebbe un ampio lavoro preparatorio per riattivare la circolarità degli scambi fra artefici e partecipanti; occorre cioè un’azione educativa in grado di condurre lo spettatore a riconquistare un vocabolario di base in ambito teatrale e musicale, che proceda anzitutto dalla conoscenza del grande patrimonio culturale e che agevoli all’interno delle strutture scolastiche l’attività diretta teatrale e musicale. Il primo livello d’intervento dovrebbe riguardare la predisposizione al più presto di un quadro di riferimento legislativo, che definisca linee di orientamento generale e criteri programmatici per un possibile sviluppo futuro. Negli ultimi anni si è assistito a un’effettiva evoluzione del gusto e dell’immaginario collettivo, per cui non conta tanto la separazione dei generi, o la differenziazione dei linguaggi espressivi, quanto piuttosto la valorizzazione dei nessi e delle corrispondenze con l’universo delle emozioni personali, la consonanza tra proposta artistica e realizzazione scenica, i legami invisibili che attraversano i cicli della civiltà umana, non in astratto, ma in uno spazio-tempo ben determinato, quello della contemporaneità. Il futuro delle culture dello spettacolo, a mio parere, è inscindibile da un deciso rilancio della creatività e dall’ampliamento della partecipazione al processo produttivo sia delle componenti artistiche, sia di quelle organizzative e gestionali. È utile nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione, prevedere la presenza di futuri spettatori fin dal momento dell’ideazione, perché aiuta a ridimensionare gli individualismi nell’uso dei codici espressivi. Paradossalmente la nostra epoca ha un gran bisogno di ritrovare le forme della partecipazione e della collaborazione collettiva, riscoprendo la relazione fra specificità linguistiche e territorialità; ecco perché l’insistere sulla contiguità tra ideatore, produttore e distributore diviene una ricchezza irrinunciabile, che permette di ipotizzare al meglio la molteplicità delle soluzioni rappresentative. È utile, altresì, dare rilievo a comparazioni effettive tra sistemi nazionali e internazionali, allo scopo di superare sia gli incomprensibili arroccamenti dei grandi enti, sia le incongruenze della frammentazione culturale. Una legge-quadro può dare incentivo, da un lato, alle responsabilità pubbliche, rispettando – ad esempio – le scadenze amministrative nell’assegnazione e nel trasferimento delle sovvenzioni, dall’altro, alle competenze istituzionali, vale a dire al dovere di programmare, dall’altro ancora, alle aree dell’eccentricità, cioè al diritto a ricercare e sperimentare. Occorre, poi, incrementare la formazione a tutti i livelli possibili, sia sul piano dei saperi artistici e professionali, sui mestieri tecnici, in particolare, sia sul versante dello spettatore, al quale bisogna restituire l’alfabeto dell’immaginazione e il pensiero critico. Dovrebbe esistere un sistema-osservatorio dello spettacolo, agile e sicuro, nel quale far coesistere le ideazioni e i recuperi, le innovazioni tecnologiche e i vantaggi della riproducibilità, e il rilancio delle scuole artistiche che innalzino il livello di abilità espressiva e rinnovino le file degli artefici e dei mediatori teatrali. dove va il teatro pubblico italiano? di ciò sostenute, ossia finanziate, agevolate, incentivate, ecc. Ottenendo così un insieme di istituzioni anche tra di loro eterogenee, per caratteristiche, dimensioni, e così via, le cui strategie però siano ben raccordate con gli obiettivi politici, e ben concertate, ma le cui azioni siano sufficientemente autonome e libere, e robuste dal punto di vista gestionale e imprenditoriale. Tale insieme costituirebbe di fatto l’ossatura di un sistema teatrale (e più in generale culturale dunque anche museale, bibliotecario, ecc.) «pubblico», il che non significherebbe necessariamente un sistema di proprietà pubblica, finanziato dal pubblico, gestito dal pubblico. Ma significherebbe piuttosto un sistema coerente con regole e condizioni create dal pubblico, per il perseguimento di funzioni di pubblica utilità, espresse per il tramite della rappresentanza politica. Una riflessione molto ampia e importante si potrebbe a questo punto aprire sul significato, nell’epoca e nei contesti attuali, dell’espressione «funzioni di pubblica utilità» per quanto riguarda lo spettacolo e la cultura più in generale; la risposta a tale interrogativo aiuterebbe a formulare gli obiettivi politici, e di conseguenza a definire le caratteristiche principali per il teatro pubblico. Naturalmente, vi sono alcune risposte ampiamente condivise e accreditate, circa le funzioni moderne delle istituzioni culturali: sviluppare capacità autonome di pensiero e di azione nelle persone, promuovendo così proattività, imprenditorialità, creatività, innovazione, e anche sensibilità, consapevolezza, responsabilità, eticità, dunque nuove modalità di sviluppo, e originali declinazioni di competitività. Ma è molto importante anche pensare che possano essere date valenze specifiche al concetto di funzione di pubblica utilità, a seconda delle circostanze, di risultati puntuali che si vogliano raggiungere, di chi rappresenti e sia dunque incaricato e responsabile della pubblica utilità, in un dato momento e contesto. La cultura infatti ha talmente tante potenzialità, da offrire inesauribili e fondamentali sollecitazioni, sui versanti della pubblica utilità! Ritornando brevemente alla possibile definizione per un sistema teatrale pubblico, bisogna anche sottolineare che un modello come quello proposto non escluderebbe né dovrebbe certo precludere l’esistenza di altre funzioni, modalità, tipologie di istituzioni, al di fuori di esso. Si tratterebbe di realtà, e magari anche di sistemi, al di fuori delle funzioni pubbliche individuate come prioritarie, dunque realtà rispondenti a criteri privati, o comunque, dovendo perseguire delle priorità, connotate da valenze pubbliche meno evidenti. Garantendo però permeabilità tra le due sfere, in maniera che un’istituzione rientrante nel sistema pubblico possa a un certo punto, e per più di una ragione, passare nella sfera privata, e viceversa un’istituzione rientrante in quest’ultima possa a sua volta passare nella sfera pubblica. In modo da evitare così quelle cristallizzazioni che hanno caratterizzato e caratterizzano a tutt’oggi i sistemi istituzionali, teatrali, culturali, provocando conseguenze talora anche inique, a carico oppure a vantaggio di qualche realtà, in virtù di fattori non più esistenti ma consolidati come tali. Tutto ciò renderebbe senza dubbio necessario un ripensamento del sistema vigente. In quali direzioni? Si azzarda, per concludere, correndo il rischio di risultare semplicistici, un sintetico decalogo di punti principali. 48 — speciale teatro pubblico Corrado Augias Federico Tiezzi L L’ Il teatro è lo specchio della realtà a prima parte del quesito richiede un complemento di tipo stori- co: le manifestazioni artistiche – le arti figurative, il teatro, l’opera – hanno sempre avuto, dai tempi dell’antica Grecia ai nostri giorni, un rapporto di mecenatismo con qualcuno che ne pagava le spese. Gli spettacoli, soprattutto quelli costosi e quelli che non possono essere riprodotti – come avviene ad esempio per le opere fotografiche – hanno infatti la necessità di una sovvenzione. In tempi moderni il mecenate non è più il cardinale o il granduca: è lo Stato, che dunque, continuando a sovvenzionare il teatro, non fa altro che proseguire una doverosa tradizione secolare. Per quel che concerne la seconda questione, il teatro – quello vero, quello vivo – ha sempre parlato della contemporaneità. È stato lo specchio, come dice Amleto nella tragedia omonima, nel quale far riflettere la realtà. Oggi questa funzione è venuta un po’ meno perché ci sono altri strumenti di comunicazione: il cinema, la televisione, i nuovi media ecc. Al teatro restano dunque due funzioni: la prima è quella di conservare e tener viva una tradizione illustrissima, in quanto è impensabile che si smetta di rappresentare le tragedie di Shakespeare, le commedie di Goldoni, i drammi politici di Brecht e così via. La seconda riguarda il suo tentare – quando ciò può accadere e, anzi, cercando le occasioni per farlo accadere – di perseverare nel farsi specchio, che è, per quanto riguarda la mia modesta attività teatrale, quello che cerco di realizzare, allestendo degli spettacoli molto semplici e sempre però centrati sull’attualità. Cristina Ventrucci speciale teatro pubblico Il teatro è pubblico C omincio col chiedermi innanzitutto cosa ancora s’intenda con la parola Stato. È la prosciugata questione del senso della cosa pubblica. E ormai è chiaro che sta passando, che è già passata, la concezione dello Stato come di un ente parassitario, corrotto, deteriore. Come di qualcosa che non dipende da noi. Per forza di cose e per comodo di molti: i parassiti, i corrotti, i deteriori; coloro che in questo modo mantengono il potere e sanciscono il distacco dei cittadini dal proprio destino. Il dibattito italiano sui finanziamenti pubblici destinati ad arte e cultura passa dal tentativo di creare sensi di colpa in chi ne usufruisce, a quello di gettare ombre sulla gestione del sistema teatrale (che comunque non è certamente immune dalla malattia dilagante) tanto da giustificarne l’azzeramento purificatore. Non interessa a nessuno, tranne a chi tormentato da un’idea utopica di comunità, che il senso della cosa pubblica ritrovi spazio tra gli ipermercati. Che tra i beni comuni vi siano conoscenza e ricerca della bellezza. Ancora maggior fastidio è procurato dall’idea che i teatri proseguano a essere, o diventino ancor di più, luoghi del fare, creazioni di comunità, aree di un felice e condiviso «non rendimento» (economico), attori della crescita di un senso di partecipazione, territori in cui sperimentare relazioni e sensi, visioni, sentimenti e rivoluzioni. Chi poi tenta di difendere e rafforzare la validità di questi investimenti di fondi pubblici, risponde al pensiero distruttore dei ministri in carica cercando in tutti i modi di dimostrare che la cultura dà da mangiare a molti, che i finanziamenti ritornano nelle casse statali in termini di tasse e che l’indotto delle manifestazioni e attività culturali e artistiche in genere ha cifre sbalorditive. Ma a ben pensare sfiora il ridicolo questo scendere sul piano di battaglia scelto dal potente di turno, e mettersi a compitare la pur sacrosanta dimostrazione con un ritardo sornione quanto grave. La cultura non si mangia, per fortuna. E accettare la contrapposizione tra il problema della fame a quello della bellezza significa in qualche modo rientrare in un disegno diabolico. Eresia vuole che il denaro pubblico debba creare luoghi e contesti, aprire mondi e non imbrigliarli, permettere di tirare fuori ciò che è dentro in nome dell’educare etimologico. Che grazie a esso si possa accendere e non sedare, seminare differenza e non uniformare. Che esso si leghi ai concetti filosofici di gratuità, di «spreco», di «asinità». Il teatro è pubblico. Se parlare del finanziamento al teatro significa difendere questi valori come assoluti, allora ci sto, perché solo così si ribadisce un valore prima ancora di una funzione. Diversamente è meglio fare senza, e come sempre ci penserà il teatro, ovvero il luogo pubblico per antonomasia, a ricreare la meraviglia che gli uomini hanno distrutto. Teatro Stabile come cuore del territorio importanza dei teatri nazionali (quelli che in Italia sono chia- mati Teatri Stabili) è pari alla loro necessità. Territori regionali e città hanno bisogno assoluto di un luogo teatrale che funzioni come un cuore: un organo che sia il centro motore di un apparato circolatorio costituito dallo spettacolo, anzi, dal teatro. Anche centro, il cuore, della vita spirituale e simbolo della natura dell’uomo: del suo carattere, della sua vita affettiva, delle sue emozioni. Oppure, un teatro nazionale, è immaginabile come un respiro che innesta uno scambio dall’esterno all’interno e poi dall’interno all’esterno. Scambio con la realtà. Ho immaginato, durante il periodo della mia direzione dello Stabile della Toscana, un teatro dinamico, una macchina produttrice di cultura che scambiasse e confluisse la sua acqua con quella di altri fiumi, torrenti, laghi (teatrali) di cui la Toscana è ricchissima. Lo Stabile è divenuto, nel corso di questi tre anni, il centro organico del «teatro d’arte» italiano, punto di riferimento per tutti gli strati sociali, per tutte le generazioni, specialmente le più giovani. Soprattutto per tutti gli artisti. Un teatro pubblico, per statuto, dovrebbe essere «dalla parte» degli artisti, assicurando loro strutture produttive e funzioni organizzative e distributive; e dalla parte dello spettatore, degli spettatori, primi e ultimi beneficiari di quella massa di lavoro che sta dietro uno spettacolo. Attraverso uno «scambio» con l’esterno lo Stabile si è modificato ed è stato luogo di unione delle diverse declinazioni della comunicazione. A quale funzione dovrebbe assolvere un teatro pubblico? Di conservazione e catalogazione, come una immensa biblioteca, di repertorio e di tecniche; di connessione con il teatro indipendente; di riappropriazione di una identità culturale possibile solo nell’interazione completa con il territorio e la società che lo accoglie. Gerardo Guccini Il problema dei «teatri pubblici» fra globalizzazione e civiltà della cultura C ito da un recente intervento di Lamberto Trezzini: «Quando questa crisi sarà passata il sistema teatrale quale lo conosciamo non esisterà probabilmente più». L’eti è già stato sciolto; le Fondazioni Lirico-sinfoniche si dibattono fra problemi di bilancio e allestimenti ad altissimo costo; la progressiva riduzione del fus avvilisce la base del mondo teatrale e scuote il sistema degli Stabili; oltre a ciò, i tagli ai comuni, alle regioni e alla scuola minacciano di dissolvere il sistema economico misto che, a partire dagli anni settanta (non da poco, quindi), ha consentito ai teatranti di integrare sovvenzioni, incassi e proventi dalle attività nel sociale (laboratori, progetti, spettacoli con non-attori). Il nodo dei problemi non è però solo economico. Anzi, la crisi non fa che evidenziare la frattura fra la civiltà globalizzata e l’insieme di pratiche e conoscenze che fonda la civiltà della cultura. I teatri, le università, la case editrici, le compagnie e le formazioni musicali, le scuole, gli scavi archeologici, le biblioteche, gli archivi, le mostre, i musei, i conservatori, i parchi, le oasi ecologiche e i centri storici sostanziano una civiltà della cultura i cui valori non coincidono con quelli della civiltà globalizzata. Questa mitizza il guadagno e impone il predominio del presente a discapito delle memorie del passato e delle possibilità future; all’opposto, la civiltà della cultura vive nella storia e venera un paradossale pantheon di poveri: filosofi romiti, musicisti morti in miseria, poeti suicidi, folli visionari, attori senza un soldo. Mozart è stato seppellito in una fossa comune. Van Gogh non trovava acquirenti. Artaud assorbiva elettroshock. La civiltà della cultura non misura i valori dai redditi, ma dall’allargamento delle conoscenze e dei linguaggi. Per la civiltà globalizzata, la sua esistenza è un corpo estraneo, quasi una moderna struttura di peccato, oppure, volendo considerare i lati positivi, un fattore di trasformazioni autenticamente dialettiche e non governate da interessi particolari. *** Nel corso dell’età moderna, i significati di «cultura» e di «civilizzazione» si sono rispecchiati l’uno nell’altro, compenetrati oppure contrapposti. Credo che, fra le loro tante e diverse accezioni, si prestino in particolar modo a descrivere la situazione attuale quelle fissate dalla lingua tedesca, per la quale il termine kultur tende a indicare l’espressione dei speciale teatro pubblico — 49 no altrove prodotte; un fattore di connessione; una rete di circuitazione, un contesto che, nel conservare testi o partiture, rigenera le tecniche necessarie alla loro realizzazione scenica. I teatri attivi nei piccoli centri – ha recentemente dimostrato una ricerca della Regione Emilia Romagna – aumentano il valore degli immobili perché migliorano la qualità della vita: gli esercizi restano aperti fino a tardi, gli spettatori si spostano dai centri vicini, si moltiplicano le occasioni di incontro, per ogni euro investito se ne movimentano molti di più nel territorio. La cultura è anche questo: un complemento identitario che lancia il vivere individuale nelle trasformazioni di quello collettivo. Ogni teatro è una sua casa. Marco Tutino La macchina è rotta È una domanda interessante, perché è evidente che la cultura, l’ar- te, un certo tipo di spettacolo dal vivo di tradizione sicuramente del tutto italiana – e cioè facente parte del nostro patrimonio culturale – hanno bisogno di un sostegno da parte dello Stato. Non va dimenticato però che spesso, in passato, tale sostegno si è tramutato in un appoggio senza controllo – e quindi in quello che si definiva «statalismo» – o in finanziamenti del tutto privi di ragioni: nel nostro Paese, infatti, si sono verificate abitudini a finanziare alcuni settori culturali che erano in realtà slegati dalla effettiva necessità o dai risultati che tali investimenti avrebbero dovuto produrre. Il problema è molto complesso. Ed è ben vero che negli altri Paesi, soprattutto per quel che riguarda l’Europa, il finanziamento alla cultura è più elevato rispetto a quanto accade in Italia; ma è anche vero che le strutture, le istituzioni che questi finanziamenti vanno a sovvenzionare sono macchine produttive, che rendono dei risultati. Il nostro problema, almeno per quanto riguarda il settore delle Fondazioni Liriche, è che la macchina è rotta. E dunque, per usare una metafora, se noi chiediamo indiscriminatamente benzina per una macchina rotta non possiamo che sprecarla. La questione, come dicevo è molto articolata, perché è evidente che ci sono in campo ideologismi, demagogie, frasi fatte ed è altrettanto chiaro che lottare per la cultura e la sua sopravvivenza è senz’altro molto bello e nobile. Penso però che gli uomini di cultura dovrebbero rimboccarsi le maniche per fare in modo che le Istituzioni e i nostri sistemi organizzativi, prima di chiedere soldi, subiscano alcune correzioni. E solo a questo punto si potrà organizzare la reale battaglia per chiedere e ottenere dei finanziamenti. Ritengo infatti sbagliato finanziare istituzioni che hanno personale in eccedenza, che viene stipendiato quattordici mesi per lavorarne otto. Tutto ciò non si sposa davvero con la sacrosanta richiesta di finanziamenti per la cultura. Paolo Pinamonti Le Fondazioni Liriche a un bivio? P er evitare ambiguità e fugare equivoci sono profondamente con- vinto che una prospettiva esclusivamente economicistica nell’affrontare i problemi del teatro musicale sia una prospettiva che può alterare il problema. A tutti è noto il famoso paradosso del «Quartetto» di Mozart, di cui parlano William Boumol e William Bowen nella loro ormai consacrata analisi economica sui cosiddetti spettacoli dal vivo (W. Boumol, W. Bowen, Performing Arts, the Economic Dilemma, Cambridge Mass, MIT Press,1966). Gli autori distinguevano due differenti modelli produttivi, o meglio due differenti settori, uno a produttività crescente ed uno a produttività stagnante. Nel primo, il prodotto per ora-lavoro aumenta più rapidamente dell’aumento del salario e quindi il costo unitario del lavoro diminuisce; nel secondo invece non essendoci alcuna possibilità di ridurre il tempo di produzione, ad ogni aumento dei salari corrisponde un aumento dei costi unitari del lavoro. Ed in questo senso l’esempio del quartetto mozartiano è chiarissimo: il tempo di esecuzione richiesto oggi non è cambiato rispetto a quello dell’epoca del compositore, il prodotto per ora-lavoro resta fisso poiché l’arte violinistica non si è avvantaggiata di nessuna innovazione che consenta risparmi di lavoro. In questa strutturale incapacità di conseguire una autosufficienza economica, la sopravvivenza del teatro musicale ha sempre richiesto nella sua storia e richiede tuttora un flusso costante di contributi prove- speciale teatro pubblico valori naturali e istintivi dell’essere umano, mentre il termine zivilisation significa l’insieme costituito dalle norme e dai comportamenti sociali e, anche, dalle capacità tecnologiche e materiali in quanto trasmissibili. Lontanissimo è il senso settecentesco di civilisation che descriveva il processo civilizzatore per cui l’intera specie umana tendeva a passare da uno stato selvaggio a stati via via superiori. La civilizzazione ha, infatti, portato al riscaldamento globale, all’innalzamento dei mari, alla riduzione delle specie botaniche e animali. Certo, le conquiste del sapere scientifico sono innegabili, tuttavia la concreta possibilità che vengano utilizzate in funzione di esclusivi riscontri economici ne mina alla base la consistenza umanistica. Di qui l’opportunità d’un pensiero che individui e nomini i conflitti che stanno modellando la configurazione antropologica della collettività globale. La contrapposizione di kultur e zivilisation mi sembra agire in tal senso. Per adeguarla alla situazione contemporanea occorre fare un passo ulteriore e considerare che alla «cultura» umanistica, il cui scopo è promuovere nell’individuo la conoscenza di sé e delle cose, si affianca una «cultura» derivata e strumentale, che, essendo essa stessa una funzione economica, non ha bisogno di sovvenzioni o di mecenati, e che, all’opposto di quella umanistica, satura gli orizzonti dell’immaginario atrofizzando la necessità d’immaginare in prima persona. Cos’è accaduto? L’aggregato materiale della zivilisation ha prodotto una cultura che corrisponde, non già alle esigenze dell’economia (per la quale la stessa cultura umanistica è un investimento vantaggioso), ma a quelle dell’arricchimento individuale. È cioè una cultura che vede nell’individuo sociale un consumatore potenzialmente collaborativo, e che quindi rieduca, in funzione di tale riduttivo ma imperioso modello, le dinamiche percettive, ricettive e di pensiero. Si è lentamente corroso e infine spezzato il legame fra il potere e la cultura nel senso latino di humanitas. Il potere attuale non ha alcun bisogno di venire giustificato, magnificato, potenziato o avvalorato dalle conquiste ed espressioni del mondo culturale perché non è più un potere antropomorfo bensì il fulcro sistemico d’una società «liquida» in cui – come Bauman ci ha insegnato a capire – la forza economica prevale sulla dialettica fra le parti sociali. Da questa disgregazione fra potere e cultura aulica nascono spaesamenti significativi. I manifestanti, che hanno protestato in occasione della prima della Scala (7 dicembre 2010), erano consapevoli di stare attivamente sostenendo il diritto di pochi a usufruire d’una spettacolarità ad altissimo costo realizzata grazie ai versamenti erariali dell’intera comunità? E, all’interno del teatro, questo pubblico sontuoso, allorché applaudiva la nobile allocuzione del maestro Barenboim a favore della cultura, sapeva di sostenere una logica non allineata alle trasformazioni di civiltà che stanno prevedendo, proprio per le regioni del privilegio, status symbol e sistemi d’appagamento edonistico addirittura contrapposti all’arcaica esposizione di sé all’interno di ritualità collettive? Probabilmente, sia in strada che nella splendida sala del Piermarini, si è diffusamente avvertito che i frutti della pianta umana sono un valore fondante e irrinunciabile. Non si tratta soltanto di salvaguardare le opere della cultura, ma di mantenere funzionanti e vive le radici che ne hanno consentita e alimentata la crescita. Conservate, le opere dell’uomo ci consegnano una mente allargata, un vero e proprio «Ade psichico», come lo chiama Hillman, che arricchisce l’irriducibile vita trasmettendole la capacità di creare. *** Quanto più la civiltà globalizzata produce una cultura gregaria e funzionale, tanto più le strutture e i retaggi delle culture umanistiche evidenziano una sorta di trasversale e composita civiltà della cultura, che consente esperienze interne alla continuità dei saperi essenziali. Credo che il problema del «teatro pubblico» vada valutato in questo quadro complessivo. Se penso al teatro come a un insieme isolato di pratiche e di opere, debbo riconoscere che il sistema dei Teatri Stabili (a iniziativa pubblica, a iniziativa privata e d’innovazione) non ha suscitato le presenze artistiche più stimolanti e vive di questi ultimi anni, e che le correnti calde delle necessità sono spesso circolate in altri paraggi. Se, però, penso al teatro come a un’attività integrata alla civiltà della cultura, che sta interagendo dialetticamente con trasformazioni di ordine globale, allora la visione cambia. In questo quadro, i teatri sovvenzionati costituiscono un interfaccia sociale; un contesto di sviluppo per identità creative che si so- dove va il teatro pubblico italiano? 50 — dove va il teatro pubblico italiano? nienti dall’esterno. In Italia dal secondo dopoguerra lo Stato si è assunto l’onere di finanziare il teatro d’opera, anche se a onor del vero dobbiamo riconoscere che i primi teatri ad essere riconosciuti come enti lirici, Il Teatro alla Scala di Milano, La Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, avevano ottenuto tale riconoscimento durante gli anni del fascismo. Dopo la famosa legge 800, del 16 settembre 1967, che cercava di regolare l’attività musicale e concertistica con l’istituzione dei tredici enti lirici e dei cosiddetti teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, si è arrivati al decreto legislativo n. 367 del 29.vi.1996, approvato dal governo Prodi, con il quale si prevedeva la trasformazione degli enti lirici in Fondazioni con l’ingresso dei privati. Fu appunto negli anni novanta, a causa dei gravi problemi di finanza pubblica, che venne introdotta, per via legislativa, questa trasformazione dei teatri lirici – soggetti di diritto pubblico – in fondazioni di partecipazione di diritto privato. Tali modifiche legislative vennero realizzate per attuare e giustificare un graduale disimpegno finanziario da parte dello Stato che avrebbe dovuto essere compensato da un crescente intervento dei contributi privati. Intenzione che tuttavia non è stata realizzata, salvo qualche raro caso come il Teatro La Scala, per ragioni connesse sia al tipo di imprenditoria presente nel nostro Paese sia alla poco incisiva politica di incentivazione fiscale finora adottata. Ed ora, con i tagli annunciati e confermati dall’attuale Governo per la cultura, la sopravvivenza delle Fondazioni teatrali in Italia è sottoposta ad un’ulteriore pressione, tanto che si sta ventilando l’ipotesi di salvare solo tre o quattro grandi teatri di interesse nazionale: Roma, Firenze e Milano, forse Napoli, con naturalmente il festival estivo dell’Arena di Verona. Dico naturalmente, riferendomi all’Arena veronese, perché così tocchiamo un altro paradosso dello spettacolo lirico dal vivo ai nostri giorni, il problema del pubblico. Problema che ha molte declinazioni possibili: dai dati della presenza al suo impatto finanziario sui costi di gestione, dalla sua tipologia che ha visto progressivamente un invecchiamento degli spettatori, perché è un dato di fatto non solo italiano, che all’opera vanno sempre meno giovani e l’età media del pubblico si sta alzando rispetto a vent’anni fa. Se il festival lirico dell’Arena di Verona può contare su una presenza media per sera di circa dodicimila persone che, considerando le dodici serate in cui mediamente si replica uno spettacolo, raggiungono le centoquarantaquattromila presenze per un’opera, con un impatto finanziario che è unico nel panorama nazionale e non solo, una tale presenza di pubblico garantisce infatti delle entrate che coprono più del 50% dei costi globali. Tale raporto non lo possiamo certamente trovare nei teatri lirici come la Fenice di Venezia o il Comunale di Bologna, con le tradizionali sale «all’italiana», che possono raggiungere al massimo un totale di sette/ottomila spettatori per una produzione di grande repertorio con una incidenza sui costi che si attesta tra il 12% e il 16%. Tutto ciò significa che lo Stato in Italia mediamente sovvenziona ogni spettatore che si siede in una sala teatrale, visto l’indice di produttività, con un contributo di circa duecento/duecentocinquanta euro. Sulla base di questi numeri ed anche a fronte della progressiva disaffezione delle nuove generazioni e dell’esclusione degli immigrati, che ormai rappresentano una percentuale significativa della popolazione italiana, dai teatri d’opera, è evidente che la prima reazione potrebbe essere un invito ad una interruzione dell’attività di questi costosi teatri. Tuttavia vorrei ricordare che il problema economico, come viene posto generalmente dai mezzi di comunicazione, è un problema mal impostato. Nessun ministro delle finanze di nessun paese europeo avverte una effettiva ricaduta, per le inevitabili operazioni di contenimento della spesa pubblica, dai tagli che compie nei confronti degli investimenti nelle attività culturali. Se osserviamo il rapporto tra bilancio complessivo di uno Stato e quanto questo stesso investe nelle attività culturali, non c’è Paese europeo il cui rapporto non sia compreso tra lo 0,12% del Portogallo, lo 0,20% dell’Italia da un lato e un po’ più dell’1% della Germania, dall’altro, che oltre al finanziamento dello Stato centrale può conteggiare anche i finanziamenti dei Länder. Ossia ciò che i tagli alla cultura portano in termini di risparmio effettivo è irrisorio, rispetto ai danni gravissimi che poi, a medio termine, si ripercuotono sullo stesso indotto economico delle attività culturali. Se si taglia il 30% degli investimenti per la cultura, il che significa decapi- tare e paralizzare l’intero settore, in un bilancio che vale 0,20% del bilancio generale dello Stato, significa in termini di risparmio effettivo risparmiare lo 0,06%. Eppure questa sostanziale irrilevanza economica del finanziamento alle attività culturali non può giustificare il mantenimento delle attuali Fondazoni Liriche senza una loro profonda trasformazione che sappia confrontarsi in termini di progettualità artistica con alcuni fattori importanti, primo fra tutti la disaffezione del pubblico giovane e i mutamenti sociali come la presenza sempre più significativa dell’immigrazione. Riproporre, seppur con allestimenti creativi o innovativi, un repertorio museificato e ripetitivo è forse inutile. Senza volere raggiungere la radicalità delle proposte della Birmingham Opera Company, diretta da Graham Vick, che con coraggio ha cominciato a lavorare in una città dove nel 2020 l’evoluzione demografica ridurrà la componente inglese ad essere minoranza, rispetto alla presenza degli indopakistani o delle popolazioni di origine africana, costruendo degli spettacoli operistici che sappiano dialogare con questa mutata realtà sociale, anche i teatri lirici italiani devono cambiare. Fondamentale è non tanto il richiamo ad un generico aziendalismo che, vuoto di contenuti, non significa nulla, quanto l’avvio di una profonda trasformazione culturale e artistica attraverso un allargamento dei repertori e delle proposte concertistiche, dal barocco al contemporaneo, un’apertura verso le plurali declinazioni delle esperienze musicali di oggi, nonché una collaborazzione continuativa e non saltuaria o di facciata, con i centri di ricerca (Università e Conservatori). Il modello di teatro a stagione è ormai obsoleto, le Fondazioni Liriche non possono continuare a pensare di museificare ulteriormente un repertorio limitatissimo di titoli dove l’ossessione per l’evento legato al nuovo allestimento registico (molte volte inutilmente costoso) ha portato, come scrive Todorov in bel saggio comparso alcuni anni fa nella rivista dell’Opera Bastille («Ligne 8», Journal de l’Opera Nationale de Paris, n. 25, maijullet 2009), alla dittatura di un fastidioso «presentismo», che si sostituisce al vacuo «passatismo» melodrammatico d’un tempo, quale alibi di una presunta modernità. Sylvano Bussotti Prima di tutto educare gli spettatori P er quel che riguarda i finanziamenti al teatro pubblico, in Italia stiamo vivendo una situazione davvero assurda, che va al di là di ogni possibile immaginazione. Non ho consigli da dare e quello che posso fare è limitarmi a sottolineare e a denunciare tale insensatezza. Un breve accenno lo vorrei spendere anche nei confronti del pubblico che frequenta teatri e manifestazioni, un pubblico che purtroppo nel susseguirsi degli anni è stato educato sempre meno e sempre peggio, dominato oramai com’è dall’impero della televisione, attraverso cui – anche se a volte è possibile assistere anche a programmazioni abbastanza dignitose – non si insegna assolutamente niente. Manca la sensibilizzazione, manca l’istruzione. E da qui si dovrebbe ripartire. Walter Vergnano Preservare un bene culturale riconosciuto nel mondo L a legge istitutiva delle Fondazioni Liriche, la cosiddetta Legge Veltroni, conteneva a mio giudizio un presupposto decisamente innovativo per quel che riguarda il sistema di finanziamento dei teatri lirici, per i quali è possibile individuare almeno due modelli: uno tipicamente italiano, francese, tedesco, austriaco, a prevalente finanziamento pubblico, e uno anglosassone a prevalente – se non esclusivo, almeno per quanto concerne gli Stati Uniti – finanziamento privato, dove i privati sono individuati per il settanta per cento nelle persone fisiche, e non giuridiche, e sono quindi individui più che aziende. La legge Veltroni, che trasformava in norma uno studio realizzato dalla Bocconi per la Scala di Milano, partiva dalla ricerca di una possibile terza via di finanziamento dei teatri lirici affermando che, fermo restante l’impegno dello Stato, le Fondazioni Liriche hanno il dovere di trovare risorse private pari almeno al dodici per cento del contributo pubblico. Quando questa legge, la n. 367, tra il ’99 e il 2000 diventa operativa, e nel nostro Paese accade che, dopo un primo periodo in cui in effetti rimane concreto l’impegno dello Stato, questi stessi finanziamenti cominciano a subire delle riduzioni, per cui quello che avrebbe dovuto essere un contribu- dove va il teatro pubblico italiano? — 51 premi Carlo Repetti Spettacoli di qualità e ricambio generazionale D al punto di vista economico l’intervento statale nel nostro Pae- se è decisamente molto inferiore a quello stanziato nei Paesi europei più evoluti dal punto di vista culturale, come ad esempio la Francia, la Germania, l’Inghilterra. Per il teatro di prosa italiano, una legge vera e propria manca sin dal dopoguerra: a surrogato, vi sono dei decreti ministeriali con valore annuale. Una legge avrebbe invece dei binari più solidi sui quali far viaggiare lo spettacolo dal vivo, indicandone peso, funzione e rapporto con i cittadini. I decreti che il Ministero ha invece emanato nel tempo non hanno una visione innovativa e al passo coi tempi, limitandosi a fotografare l’esistente, cercando di normarlo. Purtroppo questa funzione è piuttosto ingessante, per cui i provvedimenti che governano il teatro di prosa italiano, e più in generale lo spettacolo dal vivo, limitano la libertà del teatro stesso in maniera quasi involontaria, a causa di un assommarsi di regole e regolette che va a costituire una maglia di obblighi inutili al buon funzionamento di un teatro pubblico e alla sua eventuale capacità di rinnovamento costante, e utili solo a tenere congelata una situazione esistente oramai circa quarant’anni. A tali obblighi, inoltre, non corrisponde un reale aumento del contributo. Avviene anzi l’esatto contrario, tanto che una recente indagine istat ha verificato come negli ultimi venticinque anni i contributi pubblici dello Stato siano scesi del cinquantasei per cento. Noi lavoriamo dunque con meno della metà del denaro con il quale si operava venticinque anni fa. Considerando poi quale funzione deve avere lo spettacolo dal vivo in un Paese di alta valenza culturale qual è l’Italia, sarebbe fondamentale dar forma a una legge che desse delle indicazioni di partenza sulla base delle quali far derivare i contributi, i regolamenti, ecc. Per quanto concerne nello specifico lo Stabile di Genova, credo sia già in linea con quella che dovrebbe essere oggi la funzione di un teatro pubblico. Le nostre prospettive si sono andate evolvendo nel tempo: cerchiamo di seguire i mutamenti della società e di parlare un linguaggio contemporaneo. Abbiamo alcune linee guida, come ad esempio quella che vuole lo Stabile come teatro della città, non solo nominalmente, ma attraverso la proposta di un repertorio di teatro d’arte che costruisca spettacoli di qualità: anche se ci sono pochi soldi a disposizio- ne non si possono infatti lasciare in secondo piano elementi come la traduzione di un testo, la scenografia, la distribuzione. Dal punto di vista del repertorio, poi, non bisogna rivolgersi solo al passato e ai classici ma anche al teatro europeo contemporaneo. Altro punto di forza e di apertura è dato dalla collaborazione con i giovani: la nostra scuola di recitazione è considerata una delle migliori in Italia. Grazie a lei nella nostra compagnia stabile si aggiungono sempre forze nuove. Operare coi giovani è, in epoca contemporanea, una delle caratteristiche irrinunciabili per un teatro pubblico. Lorenzo Bianconi Il teatro d’opera museo della storia sentimentale dell’uomo C ome storico del melodramma, so bene che il teatro d’opera è da sempre un’impresa fallimentare. Tanti anni fa, con l’indimenticabile Thomas Walker, analizzammo tre modelli produttivi di metà Seicento, molto diversi: un’opera di corte (Roma, teatro Barberini), una impresariale (Venezia, teatro S. Cassiano) e una mista (Reggio, teatro della Comunità). Arrivammo alla conclusione, lapalissiana, che il vero committente – e alla fin fine il destinatario ideale dello spettacolo – è sempre chi appiana il deficit, chi salda la differenza tra il ricavato e l’esborso: in altre parole, i nipoti del papa che invitano a palazzo, l’aristocrazia che possiede e gestisce i teatri veneziani, il sovrano che conferisce la «dote» (il duca di Modena). Nei tre casi osservammo anche i benefici riflessi, l’indotto calcolabile in termini di prestazioni di mano d’opera e di servizi, di richiamo turistico, di incentivo al commercio, di beneficio d’immagine. Oggi come allora? Sì e no, le cose son cambiate cento volte. Ma resta che il teatro d’opera costa molto, e perciò soffre; dà lustro, e perciò è sovvenzionato; seduce molti, e perciò non chiude; e disgusta pochi, e perciò ogni tanto spunta un intellettuale, di preferenza torinese – Baricco nel millennio scorso, Ceronetti il mese passato –, che vorrebbe chiudere il Regio e deportare i piemontesi in pullman alla Scala; o vorrebbe chiudere la Scala addirittura. (A Ceronetti avranno spiegato che si comincia col chiudere i teatri d’opera e si finisce col chiudere i teatrini delle marionette e i libri di poesia?). La sovvenzione pubblica, in Italia come dovunque sul pianeta, è insopprimibile: si può e deve evitare lo spreco, razionalizzare la gestione, calmierare i cachets (nb: l’inflazione dei costi dei cantanti è iniziata intorno al 1640!), lavorare in rete, incrementare la formazione del pubblico, arginare la megalomania dei registi, incentivare l’investimento e il sostegno privato. Ma si può e deve anche ricordare il precetto di politica culturale che ci ha lasciato detto Fedele d’Amico in un’intervista pochi giorni prima di morire: «Nell’opera l’uomo cerca un mondo di certezze sentimentali che la società oggi non gli dà. E se le trova nell’opera vuol dire che dentro di sé vive ancora questo bisogno». E a chi gli obiettava che i teatri d’opera sono musei in cui si contempla il passato, ha dato una risposta memorabile: «I musei ci vogliono. E forse la musica lirica ha avuto questa sorte». I musei sono un fondamento della vita associata, e dunque della politica. I musei costano. Nessun museo si regge soltanto sui propri proventi. Il teatro dell’opera è il museo che conserva, viva e fruibile e godibile, la storia sentimentale dell’uomo moderno e contemporaneo. Possiamo farne a meno? Ci costa troppo? Troppo rispetto a che? Claudio Longhi «Teatro Pubblico» e «pubblico a teatro»: appunti per un’idea di teatro pubblico come valore culturale È difficile dare oggi una risposta univoca e di perfetta coerenza ad un quesito spinoso come quello che concerne identità e funzioni della scena pubblica in Italia: quaestio ad un tempo appassionante e vexatissima nel nostro Bel Paese, ahinoi – a ben vedere – d’antica data. In clima di celebrazioni del Centocinquantesimo dell’Unità, difficile non ricordare, infatti, che il dibattito più o meno acceso su ruolo e legittimità del «teatro pubblico» italiano è già tutto interno alla nostra preistoria sabauda, cifrato, in nuce o en abîme, nelle discussioni intorno alle non certo «magnifiche sorti» e per nulla «progressive» della Compagnia Reale Sarda. dove va il teatro pubblico italiano? to aggiuntivo all’impegno statale diviene invece sostitutivo. In quel periodo interpellai tutto il sistema delle aziende private del territorio torinese – sistema industriale, finanziario, economico –, chiedendo un impegno per perseguire obiettivi ulteriori rispetto a quanto il Teatro Regio già realizzava. Trovai molta attenzione e adesione, riscontrando l’interesse da parte di molti soggetti a contribuire a rendere concreto un progetto che per noi significava aumentare quantitativamente e qualitativamente le produzioni. I contributi privati passarono da zero a quattro miliardi e cinquecento milioni delle allora vecchie lire, circa due milioni e mezzo di euro. Fu un enorme risultato nell’immediato. Oggi la richiesta di risorse al sistema economico ha una forza ben più debole, in quanto si domanda a un’azienda di contribuire a mantenere in vita un teatro dando in cambio poca visibilità al suo intervento, e invocando quasi un’azione di supplenza rispetto all’assenza dello Stato. Gli enti lirici hanno considerevoli costi fissi – e questo non vale solo per l’Italia – e se si pensa che all’intervento pubblico si debba sostituire quello privato, andrebbe completamente modificato il rapporto fra cittadino e Stato per quel che riguarda il pagamento delle imposte. E quando sento dire al Governo che lo Stato deve investire in maniera minore in cultura, mi chiedo come si potrebbero diminuire ulteriormente i finanziamenti, che già oggi corrispondono allo 0,20% del bilancio statale rispetto all’1, 5 della Francia e della Germania. Il Regio ha avuto la straordinaria opportunità, nel luglio 2010, di essere in Giappone con due opere del repertorio italiano fra le più classiche, Bohème e Traviata. Lì abbiamo capito veramente cosa stia a significare un bene culturale com’è l’opera per il nostro Paese. E penso che solo il fatto di preservarlo sia già una funzione importantissima per i teatri lirici nazionali, così com’è importante per gli Uffizi tenere aperte le sale per continuare a far ammirare le meraviglie che vi sono conservate. Questo per quel che riguarda l’aspetto museale, e quando penso a un museo non alludo a un luogo polveroso ma a una struttura viva, dove la gente va, mossa dalla passione, e si emoziona, dove l’umanità entra ed esce arricchita da quello che ha visto e a cui ha assistito. dove va il teatro pubblico italiano? 52 — dove va il teatro pubblico italiano? Sullo sfondo di un paesaggio politico-culturale accidentato sin dai suoi primi abbozzi ottocenteschi, il problema della definizione del profilo contemporaneo del teatro pubblico italiano, nel tormentato orizzonte delle scene d’Occidente coeve, si è venuto complicando, negli ultimi decenni, per effetto di un gioco concomitante di fattori che, a un dipresso, assemblando sveltamente protocolli nazionali e fascicoli internazionali, si potrebbero censire così. Ricodificazione del sistema di relazioni arte-museo-mercato dettata dalla cultura dell’avanguardia, storica ma non solo, secondo un asse di riflessione che da Benjamin e dai Surrealisti mena, in Italia, dritto dritto a Sanguineti e al suo scontro con Pasolini (anche nuovoteatrista sui generis), tutto centrato sul (mitico piuttosto che verificato) perno Brecht-Berliner. Tentativo di archiviazione del segno del «cult» di ogni prospettiva ideologica nel dibattito estetico odierno promossa dai teorici del postmoderno. Impatto dei fenomeni di massificazione sociale e mediatica sull’«inattuale» e fatalmente esoterico linguaggio del teatro. A voler essere ottimisti, ambigua e malcerta definizione statutaria della scena nel quadro dell’istituzione culturale italiana (e del prontuario di strategie politico-culturali che da quel paradigma istituzionale sono diuturnamente dedotte). Stante il «pasticciaccio» di ragioni e sragioni che si è appena passato approssimativamente in rassegna, ritengo che la più lucida presa di posizione intorno all’affaire «Teatro Pubblico» patrio sia a tutt’oggi quella su cui si è attestato una manciata d’anni fa Luca Ronconi, nella sua veste di allora neodiplomato «capitano» del Piccolo Teatro di Milano – notoriamente culla (o se si preferisce incunabolo) della tradizione «gracilina» del teatro pubblico italiano. In un suo breve articolo giornalistico, agli albori del nuovo millennio Ronconi sostanzialmente sanciva ufficialmente la crisi della filosofia del teatro pubblico come pubblico servizio (figlia della società del dopoguerra e della sua ansia di ricostruzione: e proprio il manifesto fondativo del Piccolo Teatro docet); ponendo altresì radicalmente la questione della promozione del teatro pubblico a valore (a ben vedere di fatto già avallata dal relativamente recente riconoscimento del teatro come «bene culturale»). Determinante, in questa prospettiva, la diagnosi del collasso di una «domanda» «competente» di teatro di fine XX secolo. Un’attenta esegesi di una lettura così raffinata eccede naturalmente le possibilità di questi brevi appunti. Mi limiterò allora ad alcuni frammentari (e mi rendo conto un po’ apodittici) «rilievi a margine» a mo’ di corollario del verbo ronconiano che vogliono essere il mio contributo personale (anche se non certo originale) alla discussione. Implicito presupposto ad ogni dichiarazione che segue la condizione: «Se vivessimo nel migliore dei mondi possibili»… In primo luogo penso che la definizione dello statuto del teatro pubblico in Italia non possa non passare anche attraverso una riflessione sulla categoria di Teatro Nazionale, nelle sue più diverse accezioni, in dialogo con i modelli attualmente vigenti dei teatri pubblici a base locale (municipale e regionale). Ça va sans dire: al capo opposto della realtà locale, interlocutore privilegiato delle scene nazionali dovrebbe essere l’Europa. In secondo luogo sono incline a credere che il teatro pubblico, in un regime di marcata distinzione di competenze e modalità gestionali dalla scena privata, sia investito di una imprescindibile funzione di pietra del paragone per il molteplice esplicarsi della vita teatrale del nostro Paese e che, in questo senso, dovrebbe porsi tanto come operoso opificio per la messa a punto – necessariamente e debitamente problematica – di un canone scenico «in fieri» presupposto di ogni dialettica innovativa (sia essa sperimentale, avanguardistica o di citazione postmoderna, qui, poco importa); tanto come uno dei primi tutori di una cultura del laboratorio che restituisca ossigeno alla ricerca, nel senso pragmaticamente fondo e non stilistico del termine; tanto come campo di sperimentazione di nuove e quanto mai necessarie modalità di coniugazione del plesso organizzazione/creazione. In terzo luogo, a rischio di risultar monotono e fin troppo prevedibile, ma repetita iuvant, sono convinto del fatto che nell’attuale congiuntura del mercato planetario la gestione della politica culturale – nel teatro come negli altri domini della cultura – sia tutt’uno con la gestione dell’economia della cultura e che, per dirla a chiare lettere, non è possibile procedere oltre per la via del risanamento dei conti pubblici attraverso i tagli indiscriminati alla cultura. Non si dimentichi che l’intervento sui meccanismi di finanziamento è uno dei più drastici strumenti di censura. Posto che la strozzatura finanziaria imposta alla scena (pubbli- ca e privata) non rende un buon servizio non soltanto al teatro, ma al «sistema Italia» nel suo complesso, diventa poi nevralgico terreno di confronto la parametrazione dei criteri di erogazione delle risorse finanziarie: e forse, in questo senso, il desueto modello meritocratico (con tutte le difficoltà che comporta la definizione di cosa sia il merito) sarebbe da restaurare a petto dei perversi e demagogici teoremi generazionali, lottizzanti e di troppo rigido asservimento alla chimera del «territorio» non di rado adottati per la distribuzione delle risorse negli ultimi lustri. In quarto luogo credo che il teatro pubblico sia uno degli spazi deputati ad una ormai sempre più necessaria riformulazione del «patto drammaturgico», specie in ordine ai problemi della ri-costruzione del rapporto con il pubblico (o forse meglio con i pubblici) d’oggidì. Ne consegue che uno dei più urgenti temi di discussione è oggi quello dell’educazione teatrale. Il teatro pubblico non può certo sopperire alle lacune storico-strutturali in ambito teatrale della pubblica istruzione nazionale, ma non può certo permettersi il letterale lusso di restare estraneo ai tentativi di soluzione organica di questo problema. In tema di problemi, problema speculare è notoriamente quello della formazione delle nuove generazioni dei teatranti: ma per una più meditata riflessione in tal senso si rimanda ad altra inchiesta. Gianni De Luigi Teatro pubblico in epoca contemporanea S e in altri miei interventi suggerivo di indagare sul territorio per ca- pire le sue esigenze e a che livello un teatro pubblico come il Teatro Stabile del Veneto debba operare (ma credo che un qualsiasi Teatro Stabile dovrebbe avere questo come fondamento), devo riconoscere che il nuovo direttore Alessandro Gassman (in un’intervista di Fabio Marzari) dimostra una grande lungimiranza dichiarandosi direttore «alle prime armi» che si trova a disposizione una montagna di soldi tanto da poterne avanzare, rispettoso nell'utilizzare la cosa pubblica quasi fosse qualcosa di proprio, «ciò malgrado il momento di crisi terrificante e la politica di chi ci governa che dimostra scarsissima attenzione verso la cultura». Aggiungo che bisogna comunque riconoscere che gran parte del successo al quale lui fa riferimento, con l’aumento di abbonati del venti per cento, di cui nuovi sottoscrittori sono al novantanove per cento studenti universitari, è da ascriversi al merito di Giovani a Teatro, progetto della Fondazione di Venezia. Certamente di qualità il nuovo programma di «Extreme Teatro» e il laboratorio in cui giovani attori, selezionati e retribuiti, si confrontano con un giovane regista come Massimiliano Civica e un testo di Tiziano Scarpa, coinvolgendo anche allievi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio; senza tralasciare nuove produzioni di teatro dialettale del Novecento. Il mio giudizio è meditato sulla base di un’esperienza di otto anni come consigliere d’amministrazione dello Stabile, nominato da Massimo Cacciari, facendo la spola tra Venezia e Parigi e combattendo contro direzioni artistiche che non rispondevano agli spettatori-cittadini sperperando il biglietto pagato da loro quattro volte, con tasse allo Stato, alla Regione, al Comune oltreché al botteghino. In seno allo Stabile ho fatto nascere l’icai (www.icaiveneto.it) per poi uscire dall’alveo pubblico. Non sono riuscito a pagare gli attori che partecipavano ai master ma uno dei fondamenti, che tutt’ora perseguo, è offrire laboratori gratuiti sotto la guida di maestri di chiara fama internazionale, per onestà verso il bene pubblico e verso la libertà artistica, potendo continuare grazie al contributo della Fondazione di Venezia. In questo mondo dello spettacolo in cui si è arrivati ad una filosofia dell’evento a tal punto che esiste perfino una figura che viene chiamata «producer di eventi», esiste una dimensione pubblica e collettiva di comunione con gli altri? A cosa si dovrebbe opporre il pubblico? Indubbiamente a questo processo di analfabetizzazione di massa: i cervelli sono rinTRONATI da Maria De Filippi. È necessaria una dose di disintossicazione e recupero per un’epoca di intelligenza di massa. È vero che la cultura non è più un privilegio circoscritto ad un’élite abbiente? A me pare che l’élite rimanga anche tra quegli spettatori fedeli e anziani, invecchiati su poltrone di velluto rosso. Diventa necessaria una formazione estetica indipendente che dia strumenti di giudizio critico: spettatori coscienti e attivi. Bisognerebbe cominciare dalle scuole elementari: ecco, dove l’investimento pubblico raggiunge la democrazia. Perché si è lasciato scorrere questo fiume di denaro in teatri, musei, festival, rassegne, convegni, fondazioni e associazioni? Adesso che il fiume si sta prosciugando comincia la tensione. Ma si è effettivamente allargato il privilegio della crescita culturale alla maggior parte della realtà? È chiaro che nel difendere la statura culturale del cittadino le democrazie salvano se stesse: i greci del V secolo a.C. lo sapevano benissimo, e ancor di più lo hanno capito le nascenti democrazie del primo dopoguerra. Se ancora esistono dei privilegi culturali in questo momento sono aggrediti e inglobati da internet, globalizzazione e nuove tecnologie. Esiste, dalle nostre parti, una indubbia maggior ricchezza collettiva, anche se chi vive di spettacolo (che sia musica, teatro o una delle altre arti) si sposta in offerte di tutti i generi pur di guadagnare: in particolare in teatro nella formazione di attori. Più in generale bisognerebbe riflettere sull’educazione dell’arte e sull’arte dell’educazione, per tutti i cittadini che non accedono alla vita culturale e che sono raggiungibili attraverso la scuola e la televisione. Mi chiedo: quando interagivamo come attori e spettatori con il Living Theatre, Grotowski, Barba, Wilson, Monk, Serban, Ronconi e molti altri, era lo Stato, il denaro pubblico (o del pubblico) a contribuire come mecenate? O erano gli stessi artisti a rischiare con le loro ideologie il loro denaro e adattare lo spettacolo alla mancanza dello stesso? Sicuramente tutti loro hanno segnato involontariamente l’arte di pensare a teatro. Enzo Restagno Fare dell’economia sull’opera è una fesseria e uccide la vita culturale dell’Italia P er quel che concerne l’intervento dello Stato, la tendenza affer- mata e già messa in atto da qualche tempo è quella di diminuire significativamente il contributo finanziario del Ministero, quindi della Cosa Pubblica. E i teatri, organizzati e gestiti in Italia come degli enti pubblici, chiaramente patiscono questa situazione. Si pensa e si auspica che alla ritirata dello Stato e del suo intervento finanziario possa sostituirsi quello dei privati e degli sponsor. Ma non credo sia una buona soluzione. Innanzitutto perché gli sponsor sono rari; in secondo luogo, la cosiddetta legge del tax shelter, che funziona abbastanza bene in America e credo anche in Inghilterra, in Italia funziona poco e male, per cui l’apporto delle risorse private, salvo alcuni casi piuttosto rari, in realtà è piuttosto modesto e comunque non sufficiente. Ma anche ammesso e non concesso che questo intervento fosse significativo, non risolverebbe comunque i problemi, e anzi a mio avviso li aggraverebbe, spingendo i teatri verso una programmazione di tipo uniforme: nel momento in cui lo sponsor si dicesse disponibile a investire i propri soldi, infatti, chiederebbe anche un ritorno di immagine cospicuo, vorrebbe la sala piena, ecc. Tutto ciò si tradurrebbe, alla fine, in una sorta di sclerotizzazione del repertorio, in cui si privilegerebbero soltanto i cosiddetti best seller. Ritengo che l’intervento statale sia decisivo e doveroso, un dovere reale a difesa dell’istituzione culturale. Lo Stato dovrebbe spendere per l’opera molto di più di quanto spendeva in passato, pretendendo però di ritorno un’ottimizzazione dei servizi che noi siamo ancora lontanissimi dal raggiungere. I teatri dovrebbero stare sempre aperti, come avviene in tanti altri Paesi. Si obbietterà che la nostra tradizione è un po’ diversa, che il teatro aperto tutte le sere comporta degli standard spesso mediocri. Se da un lato questo può essere vero, dall’altro è altrettanto vero che il teatro dovrebbe diventare un’attività a tempo pieno. Il sistema italiano andrebbe ristrutturato, anche se non necessariamente adeguato ai parametri europei, perché credo ci voglia comunque una differenza specifica. Tuttavia sarebbe utile cercare di imitare alcuni aspetti dell’organizzazione dei teatri esteri. Molte istituzioni italiane sono aperte troppo di rado rispetto a quanto costano e a ciò che producono. Guardando la storia del teatro musicale nazionale degli ultimi trent’anni, ravviso certo delle punte d’eccellenza disseminate qua e là, ma per lo più mi sembra che nell’insieme prevalga un bilancio piuttosto negativo, anche per quel che concerne i risultati musicali veri e propri: vi è troppa routine, che sarebbe ammessa solo se – come ho già più volte ribadito – il teatro fosse aperto tutte le sere. Il repertorio si fissa e si chiude a scapito dell’opera contemporanea. E non ne parlo da paladino, anche se ho in effetti sempre nutrito una forte passione per il nuovo, perché ritengo che il senso della vita culturale (nonché della vita in generale) sia quello di percorrere strade sempre inedite. Questo non mi impedisce naturalmente di ap- prezzare le meraviglie del passato, anche se penso si dovrebbe imprimere alle programmazioni un po’ più di coraggio e audacia, altrimenti si rischia di diventare dei musei. La maggior parte dei nostri teatri concentra la propria attività sul grande repertorio, che poi cronologicamente si muove in un limite temporale piuttosto angusto. Questo va innanzitutto a scapito di quello che è l’aspetto educativo proprio del servizio pubblico: assistere solo e continuamente alle rappresentazioni di Traviata, Rigoletto, Aida, Butterfly, Don Giovanni, Carmen – per citare solo dei capolavori – alla lunga rimbecillisce. A essere penalizzata è la voglia e la curiosità di scoprire e di approfondire. La musica deve far pensare, è questa la sua vocazione più alta. L’ascolto di un Preludio di Bach non può non far maturare dei pensieri, e ogni ascolto dovrebbe essere una nuova tappa verso la conoscenza. La musica è certo un divertimento supremo, che ha anche i suoi aspetti frivoli e deliziosi, ma il teatro per me è innanzitutto educazione, senza la quale viene meno la sua missione fondamentale. Quindi l’impegno verso un repertorio più vasto avrebbe dovuto già essere portato avanti, quando esistevano più ampie coperture statali. Se poi vogliamo parlare di costi, bisogna dire che il ricavato del box office, bene che vada, ne copre solo una parte effimera. Opere e concerti non potrebbero perciò esistere senza essere sovvenzionati. Vorrei porre un interrogativo un po’ provocatorio: perché i sovrintendenti e i direttori artistici dovrebbero preoccuparsi affinché venga venduto il più alto numero di biglietti se poi anche il tutto esaurito permette di coprire solo il quindici o il venti per cento dei costi globali? Non inseguiamo una falsa immagine di grande successo solo perché abbiamo la sala piena! I teatri vanno sovvenzionati robustamente dallo Stato, in misura maggiore rispetto agli stanziamenti precedenti. E affermando questo non voglio fare l’utopista: alla fine dei conti, i soldi che il Ministero stanzia per lo spettacolo sono una cifra ridicola e fare dell’economia in questo ambito è una fesseria che uccide la vita culturale di un Paese che proprio di cultura vive. Toni Servillo Adottare il sistema francese N onostante me l’abbiano proposto più volte, e le tentazioni eco- nomiche fossero notevoli, non ho mai realizzato una sola recita in collaborazione con un teatro privato. Per scelta ho sempre lavorato con le istituzioni pubbliche, anche per una forma di coerenza: la mia compagnia, che è sovvenzionata dallo Stato, favorisce un teatro di ricerca e di approfondimento culturale, tende alla scoperta di nuovi talenti e alterna una lettura non convenzionale dei classici alla messinscena di drammaturgie contemporanee. Perciò io credo debba operare all’interno del circuito pubblico, che per statuto deve favorire, rispetto al teatro commerciale, questo tipo di realtà. Per statuto – ripeto – il teatro pubblico deve guardare alla formazione, alla ricerca di nuovi linguaggi, alla promozione delle nuove drammaturgie. E deve poterlo fare senza l’incubo del ricavo immediato. Per questa ragione sostengo da anni che andrebbe adottato anche in Italia il sistema francese, nel quale è prevista una netta separazione fra un teatro di impegno artistico e un altro di natura commerciale. Il primo è sovvenzionato dallo Stato, il secondo no. Vorrei fare l’esempio della Trilogia della villeggiatura di Goldoni, che è stata promossa in undici diversi Paesi nei quali non solo ho portato la lingua italiana, attraverso le parole di uno dei nostri massimi autori, ma ho contribuito anche ad avvalorare un’immagine diversa e non stereotipata di questo gigante del nostro teatro, quella cioè di un grande drammaturgo del Settecento europeo che nelle sue commedie prelude al dramma borghese. Ho portato dunque in giro per il mondo la cultura italiana, e non l’ho fatto servendomi di nomi di grosso richiamo: dei diciassette attori che si alternano in scena oltre la metà – e in ruoli da protagonista – sono giovani al loro debutto e sotto i trent’anni. Questo credo giustifichi il sostegno dello Stato, sia per quanto riguarda la ricerca sui linguaggi sia – ed è forse l’elemento più rilevante – per il grande lavoro sul versante della formazione. Il mio modo di fare teatro non ha niente a che spartire con i vari tipi di intrattenimento, dal musical di derivazione americana ripreso dalla compagnia italiana alla barzelletta del comico locale. Non capisco perché compagnie come la mia debbano essere sovvenzionate allo stesso modo del Teatro Sistina, che da trent’anni ha deciso di mettere in scena Aggiungi un posto a tavola con Johnny Dorelli o suo figlio. Fa benissimo a farlo, ci mancherebbe, ma si mette sul mercato e rischia, come fa chi domani decidesse di commercializzare le scarpe con la suola aerodi- dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 53 54 — dove va il teatro pubblico italiano? namica. Tutt’altro appoggio e sostegno va invece rivolto a coloro che si pongono gli obiettivi che ho cercato di elencare. Letizia Russo I doveri dello Stato (e quelli degli artisti) I dove va il teatro pubblico italiano? nnanzitutto mi scuso per le gravi lacune tecniche e legislative che ho in merito al funzionamento dei finanziamenti pubblici al sistema teatrale italiano. Non esprimerò quindi concetti che hanno a che vedere con flussi di denaro o percentuali che non sarei in grado di formulare, ma colgo l’occasione per condividere delle riflessioni su quello che, secondo me, potrebbe essere un «principio poetico» alla base del rapporto Stato/teatro nel mondo in cui viviamo. Tanto per dire una novità, il dibattito è ampio e spesso acceso. Allo stesso tempo, però, quasi mai si considera, negli appelli promulgati per il salvataggio del fus, nelle discussioni tra artisti e operatori, nei trattati in materia (ma anche qui confesso che potrei avere delle lacune) l’altro lato di quello che dovrebbe essere, a tutti gli effetti, un «patto» tra Stato (cioè i cittadini) e artisti. L’idea che mi sono fatta della percezione che le persone hanno delle lotte e dei dibattiti per il finanziamento pubblico al teatro (e al cinema ecc.) è che nel cosiddetto «mondo fuori» si vivano queste istanze come istanze di privilegio. Non è secondo me interessante stare ad analizzare quanto la percezione delle persone che pagano le tasse sia lontana dalla realtà, perché già sento un coro di artisti rispondere che di sopravvivenza trattasi, e non di privilegio, e che nella stragrande maggioranza dei casi un artista, un attore, un regista, un tecnico, un autore, fa tanta fatica ad arrivare a fine mese quanto un impiegato o un operaio. Funziona solo in parte come spiegazione di questa percezione diffusa sull’utilità dell’artista il fatto che da sempre artisti e teatranti richiamino nell’immaginario collettivo anche un simbolo che poco ha a che fare col lavoro. Una volta mi hanno raccontato una storia (vera) e vorrei riportarla come se fossi io la persona che l’ha vissuta, così, per economia narrativa. Insomma eravamo a una cena e c’era con me un mio amico, di professione antennista. Cena con persone sconosciute a questo mio amico, che mano a mano si presenta ai commensali. Finché uno gli chiede: «Anche tu fai l’attore?» e lui: «No no. Io lavoro». Racconto questo perché tutti ci saremo trovati a dover rispondere alla domanda «Che fai nella vita?» e uno risponde, per esempio, «il/la drammaturgo/a», e ad aspettare come un rigore prevedibile la seconda domanda «Sì ma per vivere, per vivere, dico, cosa fai?» Eppure non penso ci si possa fermare al folklore, né all’atavica riluttanza degli italiani a stare seduti non tanto composti quanto vigili e reattivi e con cadenza regolare sulle sedie di un teatro per spiegare questo fatto. Sembrerà magari un fatto di poca importanza di fronte al crollo lento e silenzioso di un mondo, ma non essere coscienti dell’immagine che le persone, cioè in parte anche i nostri spettatori, hanno del teatro significa iniziare un discorso senza tutte le premesse. Ci sarà pure un motivo più profondo per cui le persone, i cittadini che formano questo Stato, spesso considerano le lotte per il finanziamento pubblico al teatro (e al cinema ecc.) come una lotta per un privilegio. In questo senso i commenti che hanno accompagnato gli articoli pubblicati sulle edizioni on line dei principali quotidiani a proposito della manifestazione degli artisti lo scorso mese di novembre sono un esempio di quanto dico. Rappresentare una scontata solidarietà da parte dei cittadini, gettarsi nel mondo delle lotte per i diritti senza neanche chiedere agli altri se si è davvero i benvenuti, se ci si può davvero considerare tutti dalla stessa parte, è un atto poco ancorato alla realtà. La conseguenza è che spesso le persone, a questo tentativo di costruire un noi (cittadini + artisti) contro loro (governi brutti e cattivi) aprioristico, reagiscono guardandoci in faccia e rispondendo «Guarda che noi, cioè noi + voi, non siamo uguali per niente. Anzi se ve la devo dire tutta i governi restano brutti e cattivi, però non vedo l’ora che vi tolgano tutto il fus, così magari andate un po’ a spaccarvi le mani come facciamo noialtri». Oltre che essere ingenuo, è molto distante dalla realtà, ragionare e comportarsi in questo modo, da parte del mondo della cultura e del teatro in particolare. Significa che diventa difficilissimo immaginare cosa si può fare, was tun?, come chiedeva Lenin, perché non si ha neanche la percezione di cosa siamo, realmente, spietatamente, all’interno dello Stato. Perché le persone dovrebbero sostenere, col proprio lavoro precario, con la spremuta di tasse che versano ogni mese al fisco, con le difficoltà che il mondo di oggi mette dinanzi a tutti noi, perché, dico, le persone dovrebbero sostenere con azioni e pensieri un finanziamento pubblico all’arte? Potrebbero farlo, penso io, se riconoscessero il teatro come mattone fondante di una società. Potrebbero considerare in questo modo il teatro se il teatro veramente lo fosse. Non penso che abbiamo da insegnare niente a nessuno, non penso che l’Italia in questo momento abbia bisogno di grilli parlanti costantemente impegnati ad annunciare il giorno del diluvio universale, mentre fuori le persone sono già morte di caldo, o di sete, o di freddo. Non penso che le persone abbiano bisogno di lezioni per quel che riguarda i propri reali profondi bisogni. Penso che però dovremmo tutti noi trarre, amaramente ma non nichilisticamente, la lezione che, forse, in questo momento, non rappresentiamo un arto di cui il corpo non può fare a meno. Quando i bisogni crescono e la sopravvivenza diventa un limite più tangibile che in passato, e quando molte persone cominciano a vivere al di sotto di quello stesso limite, la trama cambia, cambia il racconto, ed è necessario ripensare anche le cose più piccole, anche i principi più elementari. Parlo per me: io spesso mi rendo conto di quanto sia distante la mia consuetudine al teatro da un vero contatto con la realtà. Come se lentamente si disimparasse un linguaggio e se ne imparasse uno nuovo, del tutto autoreferenziale. Un discorso sul rapporto Stato-teatro non può, secondo me, prescindere dal fatto che lo Stato è composto di persone con un nome e un cognome. Dico tutto questo non per affermare che l’arte e il teatro sono, oggigiorno come si diceva a scuola, elementi «trattabili» o addirittura eliminabili in un dibattito sociale. Non penso che azzerare il fus abbia senso. Non penso che privatizzare la cultura, in un panorama da neoliberismo galoppante, sia una soluzione degna di essere considerata, né che il teatro debba diventare un terreno di scontro tra poveri per delle briciole sempre meno consistenti. Dico tutto questo perché penso che innanzitutto dovremmo creativamente cercare nuovi criteri. Creare nuovi principi per un nuovo patto. Riconoscere che un patto è fatto di diritti ma anche di doveri reciproci. È dovere dello Stato non lasciare morire il proprio teatro. Non è dovere dello Stato alimentare meccanismi di mantenimento perenne di uno status quo. È dovere dello Stato giudicare le idee e non le persone. È dovere dello Stato cercare, curare e far crescere progetti che vadano al di là del singolo spettacolo, bello o brutto che sia, classico o contemporaneo, tradizionale o di ricerca. È dovere dello Stato sapere che l’artista può criticare. È dovere dello Stato disinnescare i meccanismi di clientelarismo e favoritismo. È dovere di un artista farsi una bella sedia di chiodi per non sedersi mai sull’ultima buona idea avuta dieci anni fa. È dovere dell’artista non dare per scontato nulla, neanche il fatto che lo Stato debba mantenerlo. È dovere di un artista cominciare a ragionare anche in termini e in ambiti che apparentemente non c’entrano nulla con l’arte, come la produzione e l’organizzazione. È dovere dell’artista uscire dall’isolamento. È dovere dell’artista parlare anche agli indifendibili e non solo alle piccole platee di convertiti. È dovere dell’artista riuscire a raccontare il proprio Paese. Altrimenti è dovere dell’artista ingoiare le proprie lamentele e ammettere che combatte per un proprio minuscolo spazio di privilegio, comportandosi di conseguenza, senza falsa coscienza. È dovere dell’artista capire che non è il singolo spettacolo a salvare le sorti del teatro. Semmai salva solo se stesso, e per un numero limitato di mesi. È dovere dell’artista riprendere in mano i propri strumenti, guardarli come se fosse la prima volta, riconsiderarli, ricostruirli come è necessario. È dovere dell’artista agire. Anche nell’ombra. Anche lentamente. Ma con costanza. La lista dei diritti però non la faccio. Quelli sono più facili. Laura Barbiani Le sale teatrali come luoghi di relazione intergenerazionale S gombriamo subito il campo da un’ambiguità di fondo che sta in pre- messa alle vostre domande: il fus non finanzia solo gli Stabili pubblici, le Fondazioni liriche e gli Stabili di innovazione, ma anche molti altri soggetti, e fra loro molto eterogenei per figura giuridica, tipologia di attività, dimensione, rilevanza nazionale e continuità operativa. Primi fra tutti, le imprese di produzione e le compagnie private, gli Stabili privati e i circuiti di distribuzione, ma anche i gestori pubblici e privati di sale teatrali, gli organismi di promozione e formazione teatrale, e poi rassegne, festival, teatro di figura, artisti di strada e via così fino alle stesse Amministrazioni comunali per specifiche iniziative di spettacolo. In altri termini il fus finanzia tutto, o meglio, si distribuisce fra tutti. In barba a ogni politica attuativa degli indirizzi di competenza regionale in materia di spettacolo. Una precisazione non banale, perché mi pare evidenzi una sostanziale (e storica) carenza di obiettivi e strategie dello Stato per lo sviluppo dello spettacolo in Italia. Il che ovviamente la dice lunga sulla possibilità che lo Stato decida di investire nel settore: chi infatti avvierebbe una politica di investimenti senza obiettivi? Prima dei «tagli», insomma, credo che a condannarci sia la prassi dei cosiddetti «contributi a pioggia» che in tempi di crisi ha il destino segnato: ridursi a una triste elargizione di mance. Chi se ne meraviglia è ipocrita, e chi ne dà tutta la colpa al Ministro di turno è in malafede. Alla prima domanda rispondo dunque: non lo so. Non so che «peso dovrebbe avere l’intervento statale nelle strategie organizzative e produttive del nostro teatro nazionale» finché l’intervento statale per il teatro resta quel che è oggi: una disponibilità indistinta e residuale, priva di qualunque obiettivo Paese. Un fus che vediamo sempre più virato al fes (dove la «e» sta per esangue, elemosinato, eventuale, ecumenico, emorragico e soprattutto emerito, come quegli onori e gradi mantenuti dopo averne perso le funzioni) o peggio al fas, come fas-tidio di dover sostenere un settore di cui si stenta a riconoscere ogni valore identitario, sia esso culturale, sociale, occupazionale, professionale, di tradizione o di indotto economico. Ma veniamo alla seconda domanda: quali caratteristiche e funzioni ritengo prioritarie, oggi, per il teatro di produzione a iniziativa pubblica. Su questo, ho pochi dubbi: 1. farsi riconoscere dal pubblico come soggetto di eccellenza e attualità nella produzione di spettacoli e nella programmazione dei propri teatri, è senz’altro un carattere ineludibile per ogni grande teatro pubblico; 2. contribuire allo sviluppo culturale del territorio in cui operiamo, favorendo in ogni modo il ricambio generazionale dei suoi punti di riferimento, mi pare sia la nostra funzione principale. Partiamo dal punto 1. Gli Stabili nascono attorno agli anni cinquanta e sessanta del Novecento per consentire ai registi e agli attori che hanno fatto grande il nostro teatro, di dire quel che avevano da dire su quest’arte millenaria senza dover sottostare ai vincoli di gradimento del mercato; bisognava dare «casa» al teatro d’arte, perché non fosse la stessa tipicità espressiva del teatro a perdere senso e forza evocativa in una società che cambiava rapidamente, bisognava cioè impedire che il teatro scivolasse ineluttabilmente verso un esercizio di puro intrattenimento, non importa se o quanto virtuoso. Una strada che ha fatto nascere il grande teatro italiano moderno, dandoci per decenni i frutti preziosi di tanti registi, attori, scenografi e costumisti indimenticabili, ma che ha anche contribuito a scavare quei profondi fossati tra linguaggi teatrali, segmenti di pubblico, testi classici e storie contemporanee, che sono alla base di quel forte senso di autoreferenzialità che oggi ci ammala tutti: chi attento soprattutto ad affermare se stesso nell’esercizio degli infiniti virtuosismi possibili del «teatro di regia», e chi convinto d’essere fattore decisivo d’alternativa al «vecchio» senza mai aver letto Goldoni o Pirandello, né mai essersi procurato i video degli spettacoli di Carmelo Bene o di Tadeusz Kantor. Oggi gli Stabili non possono più permettersi di produrre guardando solo al gusto consolidato del proprio pubblico, ma devono anzi chiedersi se quel pubblico sia davvero così impermeabile a ogni infiltrazione, e così privo di curiosità da chiedere solo ciò che già conosce. Naturalmente so bene che a fare Amleto o Traviata i nostri teatri si riempiono facilmente, ma ciò non basta a spazzare via queste domande. Domande cui si può rispondere solo riprendendo ad ascoltare il presente, e non solo se stessi. Neppure ove si sia il portato di una grande storia, e anzi tanto più se lo si è. Il teatro non può eludere le sensibilità e le tensioni contemporanee, perché accade nell’ineludibile fisicità del presente: in teatro ci sono corpi, di attori e spettatori, non ologrammi. E credo che, più o meno consapevolmente, la voglia d’essere parte di questa autenticità ci sia in chiunque lo frequenti: oggi nessuno va a teatro solo per essere intrattenuto o rassicurato, si può voler ridere, piangere, pensare, fantasticare, farsi sorprendere o diosà cos’altro, ma nessuno si aspetta d’essere solo baloccato. A questo basta la televisione. E passiamo al punto 2, che è forse il piano di maggiore distanza dal passato. È quanto si è detto prima sul fus, infatti, a imporsi oggi come punto di riferimento obbligato per le strategie future degli Stabili pubblici: se lo Stato non cambierà rotta, continuando a non darsi alcuna motivata priorità di intervento, il suo impegno nel settore sarà destinato a contrarsi nel tempo, con l’ovvia conseguenza di sottrarsi alla sua storica funzione fondativa e di sostegno del grande teatro nazionale. Uno scenario che vedrebbe la fonte principale dei nostri contributi pubblici spostarsi sempre più verso un ambito di matrice territoriale. Un fatto né buono né cattivo in sé, ma certamente dirimente. E un cambio di prospettiva che se ovviamente non potrà in alcun caso dislocare gli obiettivi produttivi degli Stabili sul piano del solo interesse locale, altrettanto certamente dovrà riflettersi sull’insieme delle nostra attività. E a questo punto, ben sapendo di rischiare il marchio di provocatrice, dico che se per farci riflettere sull’attualità della nostra funzione culturale serviva una crisi come quella che oggi rischia di ammazzarci tutti, sia benvenuta anche la crisi. Una crisi da cui certamente il nostro Stabile non potrebbe mai uscire se almeno i soci fondatori non facessero scudo all’impegno per superarla che abbiamo messo e metteremo in campo, ma che sta comunque a noi superare. Come? Facendo esattamente il contrario di quel che fa lo Stato con il fus: focalizzare obiettivi e priorità, scegliere di conseguenza, e fare proprio di queste scelte (di qualità e radicamento) il fattore identitario delle nostre politiche – e poetiche – teatrali. Per loro stessa natura, gli Stabili non sono nomadi né affittuari casuali delle case che abitano. Sono istituzioni culturali residenti in un determinato territorio, lì fanno teatro e lì svolgono la loro funzione culturale. Per alcuni, questo dovrebbe indurli a fare soprattutto eco a ciò che il pubblico locale conosce meglio e dunque si aspetta gli venga proposto; per altri, significa invece prepararsi a interloquire, proprio da lì, con le eccellenze teatrali di ogni dove. Mai come ora, forse, gli Stabili portano la responsabilità di produrre spettacoli capaci di infiltrare le proprie società di riferimento di valori estetici contemporanei; e mai come ora, senza forse, i loro spettacoli devono avere la forza necessaria per entrare nell’universo emozionale di chi li ha applauditi, arricchendone in modo permanente il patrimonio di esperienza culturale. E anche sociale: al cinema non si applaude, ciascuno assiste, giudica, e va a casa; a teatro il pubblico applaude, fischia o bofonchia insieme e di fronte agli attori, alla fine e durante lo spettacolo, facendo vibrare tra sala e palcoscenico un percettibile senso di comunità, omogenea o divisa, empatica o meno, non importa. In questo contributo degli Stabili allo sviluppo culturale del loro habitat, c’è una parte assolutamente strategica che a me pare anche quella di maggiore rottura col passato. L’investimento sui giovani. L’Italia, si sa, è un Paese vecchio, un Paese la cui popolazione cresce in modo inversamente proporzionale all’età della sua classe dirigente, e che però continua a lamentarsi della scarsa intraprendenza dei giovani. Un Paese ipocrita, insomma. Indipendentemente da quanto l’abbiano fatto in passato, oggi gli Stabili devono porsi l’obiettivo di dissonare da quel coro con estrema efficacia. Seppure non appartiene al linguaggio teatrale, dico lo stesso che tra le funzioni prioritarie degli Stabili sta senz’altro quella di contribuire a rinnovare la classe dirigente del territorio che abitano. Un compito e una responsabilità che condividono con chiunque abbia funzioni di leadership, in qualunque ambito tematico o contesto territoriale operi. Il tema forte dunque resta il rapporto dei nostri teatri con le nuove generazioni, in relazione alla funzione di leadership culturale che – nel nostro ambito e contesto – siamo chiamati a esercitare. È noto che chi, per guardare ai giovani, distoglie occhi e cervello dalle altre fasce generazionali dimostra un imbarazzante grado di stupidità, visto oltre a tutto che nelle nostre società l’aspettativa di vita va allungandosi ogni anno. Ma messi al bando gli sciocchi e inutili giovanilismi, c’è da chiedersi invece se non siano proprio le sale teatrali i luoghi deputati a creare delle comunità inter e intra generazionali in un mon- dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 55 56 — dove va il teatro pubblico italiano? do che invece crea barriere giorno dopo giorno sempre più alte, a partire dalle stesse tecnologie comunicative, in costante, rapidissimo mutamento. Al contrario a teatro, dove in fondo si parla dell’uomo e si vivono i fondamentali dell’esperienza umana, accadono ancora cose condivise da tutti. Ecco che quindi, quasi paradossalmente, le nostre sale potrebbero essere viste proprio come un luogo quasi sperimentale di relazione intragenerazionale. E chiudo queste mie riflessioni con due piccoli esempi tratti dalla nostra attuale stagione. Il primo è uno spettacolo, Roman e il suo cucciolo: al di là delle valutazioni di tipo estetico, il successo di questo lavoro anche di fronte a una platea composta da anziani è stato straordinario, avvalorando con forza la tesi secondo la quale a teatro si possono affrontare (e apprezzare) anche tematiche molto lontane dal proprio vivere quotidiano, come nel caso specifico l’orrore della droga, le problematiche legate all’immigrazione e via dicendo. Il secondo esempio, ancora più palpabile, riguarda il Premio Off celebrato a Padova ad ottobre. Per l’occasione avevamo predisposto una giuria «mista», e composta da studenti delle scuole superiori, universitari e abbonati. La piccola comunità che si è formata ha vinto gli ostacoli di tipo anagrafico, ed è stato splendido vedere i giurati discutere tra loro, litigare e condividere le proprie emozioni, vincendo sempre più la diffidenza iniziale. Credo che per il teatro pubblico questa potrebbe essere davvero la direzione giusta. Paolo Puppa Vera ricerca e «tradizione del nuovo» L dove va il teatro pubblico italiano? a prima cosa da dire è che lo Stato dovrebbe intervenire per aiuta- re la ricerca. Se facciamo un confronto con l’università, è subito evidente come la linea di questo Governo – ma anche degli ultimi che si sono succeduti – tenda a omologare atenei privati e pubblici, scippando ai secondi una quota importante di finanziamenti. Nel teatro accade la stessa cosa: esistono organismi privati che sono considerati alla stregua di quelli pubblici. Detto questo, bisogna anche aggiungere però che andrebbe ridimensionata la tendenza meccanica a garantire finanziamenti pubblici automatici, che spesso si risolvono a tenere in vita organismi malati. In questo senso si potrebbe ricordare Eduardo, che affermava come il teatro dovrebbe essere finanziato dal pubblico, intendendo con questa parola unicamente gli spettatori, non certo il Governo, la Regione o gli enti locali. D’altro canto affidarsi totalmente al pubblico – inteso come audience – presta il fianco al rischio che tutto ciò che è realmente innovativo, non essendo riconosciuto automaticamente dai modelli di attesa dello spettatore, venga di fatto condannato a essere respinto. Per queste ragioni, considero positivi i finanziamenti propulsivi per il futuro, che appoggino i nuovi gruppi e promuovano giovani talenti. In Inghilterra ad esempio lo Stato investe sistematicamente nei giovanissimi drammaturghi, che lavorano con attori presi nelle scuole secondarie e attraverso lunghi workshop e stage diventano poi gli autori e gli interpreti di domani. È dunque possibile ipotizzare la legittimità di una sovvenzione pubblica solo laddove si può parlare autenticamente di un teatro di ricerca. Il problema però non finisce qui, perché è necessario stabilire i criteri con cui si decide qual è la vera ricerca e quale invece, per fare solo un esempio, è solo una imitazione pedante delle vecchie neoavanguardie. Per raggiungere questo obiettivo, al posto di nuovi carrozzoni ministeriali o delle famigerate commissioni, bisognerebbe servirsi di organismi di controllo e selezione leggeri e flessibili, rinnovabili ogni due o tre anni al massimo, che possano rilasciare una patente di autentica novità e quindi giustificare l’erogazione. Entrando nello specifico della scrittura teatrale, vorrei introdurre il concetto di «tradizione del nuovo», che in Italia non esiste ma è invece in auge in molti Paesi europei, e in particolare in Francia. In parole povere lì accade che un testo nuovo crei una vera e propria tradizione perché non scompare dopo un’unica messinscena, ma tre o quattro anni più tardi viene ripreso da un regista differente e in seguito da un altro ancora e così via. In questo modo si sedimentano degli strati di memoria tra gli operatori teatrali (registi, attori, spettatori competenti che possono diventare a loro volta operatori), e grazie a tali depositi progressivi nella memoria un po’ alla volta quel testo viene metabolizzato. Di fatto, prima dell’avvento del teatro di regia, le pièces che venivano allestite erano quasi sempre novità attraverso le quali, mancando i talk show e i telegiornali, erano affrontati i grandi temi d’attualità. Quando invece entra in campo la regia moderna – pur portando con sé un generale migliora- mento professionale – il desiderio di cose nuove sparisce e si va piuttosto a rivedere o a risentir suonare un testo già assimilato. Da qui hanno origine le migliaia di allestimenti di volta in volta pirandelliani, shakespeariani, goldoniani, ecc. a scapito degli autori contemporanei. Il meccanismo della «tradizione del nuovo», se importato anche da noi, consentirebbe a un testo di essere come il vino, che invecchia in cantina e poi si comincia a distillarlo e ad assaporarlo. Alessandro Gassman Arroccarsi a difesa P er la cultura italiana questo è il periodo di maggiore sofferenza dal dopoguerra. I tagli ai fondi del fus sono gravi e ingiustificati, prima di tutto perché indifferenziati e rivolti verso tutti, senza nessun riferimento a criteri meritocratici. Come Stabile del Veneto, che è l’istituzione che dirigo, noi cercheremo di lavorare in difesa dei giovani, della drammaturgia italiana contemporanea e di quella alternativa ai classici, che fortunatamente si difendono da soli. Credo che compito del teatro pubblico sia proprio difendere tutto ciò che non compare sul piccolo schermo, distanziandosi ancora di più dalla proposta televisiva. Anche perché con questi tagli sciagurati le strutture private saranno probabilmente costrette ad abbassare il livello dei propri spettacoli e a chiamare – ancor di più di quanto già facciano oggi, secondo me sbagliando – personaggi celebri del mondo della televisione come star in improbabili rappresentazioni teatrali, che lasciano il tempo che trovano e muoiono poco dopo essere nate. Noi invece ci arroccheremo, diventeremo una sorta di Fort Apache, per esempio confermando anche per l’anno venturo le rassegne di teatro off, che tanto successo hanno avuto tra Venezia e Padova. Allo stesso tempo, per far quadrare i conti, cercheremo di risparmiare producendo meno ma mantenendo alta la qualità, o eventualmente anche aumentandola. Il teatro pubblico deve fare cultura e favorire l’innovazione, e lo deve fare nel rispetto dei soldi pubblici. È questo il suo primo dovere. Per il resto esistono i privati. Roberto De Simone Via la politica dal teatro P er quanto riguarda la situazione dei teatri lirici, non credo si pos- sa dire che negli ultimi anni siano stati ben amministrati, nella maggior parte dei casi. Spesso vengono affrontate spese astronomiche, magari soltanto per aggiudicarsi il nome di spicco e dare vita ai cosiddetti grandi eventi. Rispetto a quando frequentavo io l’opera le cose sono molto cambiate. Sul versante della prosa oggigiorno il teatro pubblico è solamente un teatro politico. In questo senso Napoli è paradigmatica: durante il lungo governo di Bassolino il Teatro Mercadante è stato appannaggio dei suoi amici, che erano gli unici a vedere realizzate le proprie idee. Ai dissidenti come me era negato ogni accesso (ma non ero il solo: nemmeno Ruggero Cappuccio e Mariano Rigillo, per fare due nomi di importanti uomini di teatro napoletani, hanno potuto esprimere il loro parere). Così, per esempio, il teatro di tradizione è completamente scomparso, perché non aveva la possibilità di reggersi da solo. Ma il teatro pubblico deve invece essere il teatro di tutti, non può essere soggetto al potere politico. Anzi dovrebbe essere guidato da una squadra di esperti, da un consiglio di amministrazione di illuminati, che sappiano individuare i fiori nascenti che si vanno formando in ogni città. Antonio Latella Una nuova modalità di (vivere il) teatro C redo che il teatro pubblico abbia la grande responsabilità di riu- scire a far capire che la cultura è un nutrimento e non una questione elitaria. Mi affascina pensare alla cultura come qualcosa di concreto, quasi di fisico. Se ho fame vado al supermercato e mi compro qualcosa da mangiare. Allo stesso modo la mia anima ha fame e va nutrita. Il teatro dovrebbe assecondare questo bisogno di appagamento dell’anima, la necessità di riflettere, di scegliere, di pensare. Più nello specifico, a mio parere sono tramontati i tempi in cui si spendevano trecento-quattrocentomila euro per scenografie e costumi. Credo sia proprio finito il tempo artistico di quel tipo di allestimenti, non è solo una questione di estetica. Sono convinto che si possa fare teatro in un altro modo, che non significa necessariamente proporre un teatro povero: è arrivato il momento che la riflessione con il pubblico sia diretta e non più mediata attraverso orpelli. Questo è il mio pensiero rispetto alla funzione di un teatro pubblico al giorno d’oggi. Per quel che riguarda il nostro Paese, mi dispiace dire che dal punto di vista politico apparteniamo al terzo mondo. Non riesce a passare il concetto che la cultura sia una grandissima bandiera di comunicazione, forse la più potente. Non è un caso, io penso, se i Paesi che hanno fatto della cultura la loro carta di presentazione in questo momento sono anche i più forti sul versante economico. Da noi invece non si arriva a capire che la cultura è un’industria: è lavoro e dà lavoro. Questo mi provoca un’incredibile tristezza, perché abitando all’estero mi piange il cuore quando penso che l’Italia, che è stata per secoli il giardino della cultura, oggi non ne è che il fanalino di coda. E intanto quanti hanno voglia di far qualcosa sono costretti a scappare. Questo è stato il solo motivo che mi ha spinto a tornare a Napoli per proporre un modello nuovo, pur sapendo che nessuno mi appoggerà. In molti invocano il cambiamento, ma in realtà ho l’impressione che questo cambiamento poi non lo voglia nessuno per davvero, perché ciascuno è concentrato sul proprio ego. Senza riflettere sul fatto che è doveroso dare delle possibilità a quelli che verranno dopo di noi. Che territorio prepariamo per loro? Cosa gli consegniamo? Su questo versante non è più il momento di riflettere: bisogna agire, anche se si deve pagare un prezzo altissimo. È il momento di fondare una nuova modalità teatrale, senza per questo essere accusati di non rispettare la tradizione. In questo periodo viviamo di memorie, di fotografie sbiadite che non sono nemmeno più la tradizione: la nostra infatti era una tradizione che scendeva per strada e urlava alla gente, la faceva ridere, la faceva piangere, la faceva riflettere. Ora non accade più. Credo che il nostro compito oggi sia ricreare un luogo del ragionamento, della discussione, dello scambio. E sono fiducioso che ve ne sia ancora la possibilità, nonostante la pornografia culturale che ci hanno imposto in questi ultimi trent’anni. A Napoli stiamo provando a fare ciò che è normale in altri Paesi europei. L’obiettivo è creare una stabilità, far nascere nuovi testi, dare spazio ai giovani, perché l’Italia è un Paese assai poco fertile, in tutti i campi, e ci ritroviamo dappertutto sessantenni, che parlano un linguaggio magari meraviglioso ma che probabilmente non arriva più direttamente alla gente. In concreto, al Nuovo Teatro Nuovo si è creata una compagnia, regolarmente assunta, che rimarrà in sede e lavorerà a stretto contatto con registi, drammaturghi e coreografi. L’idea è creare una vera e propria fabbrica di produzione, scardinandone i consueti meccanismi e creando un rapporto diretto con la città. Cambiano anche i criteri della programmazione, e le conseguenti abitudini degli abbonati: uno spettacolo non si consuma più in una settimana ma rimane in repertorio per tutto l’anno, quindi il pubblico è libero di vederlo quando vuole. Tra noi si è creato anche una specie di dogma, in base al quale non si devono mai superare delle soglie economiche, che sono oggettivamente molto basse. Tutto questo com’è ovvio spaventa alcuni, perché c’è certamente il rischio di perdere una parte di abbonati insoddisfatti. Ma è un esperimento che va fatto, si deve partire da qua per studiare a fondo questo meccanismo e comprendere come possa funzionare qui da noi e a cosa ci possa portare. spesso affidano i propri teatri a sovrintendenti senza grosse sensibilità e con poca ampiezza di orizzonti; la responsabilità quindi non è imputabile sempre e solo al Ministero, a Bondi o al Governo attuale. È stato da sempre un problema politicamente trasversale. Lo dico cercando di essere il più obiettivo possibile. Le difficoltà che la cultura si trova ad affrontare oggi sono presenti già da molti anni: c’è sempre stata una certa trascuratezza verso questo settore, una certa sbadataggine, una certa superficialità nel trattare le cose. E oggi ci troviamo a pagare un pegno molto alto, accumulo di una politica sbagliata perpetrata per anni e anni. Sono assai preoccupato per l’intero sistema musicale e teatrale italiano, e non credo che le cose si possano risolvere con le fughe in avanti di una o due Fondazioni. Sarebbe necessario rifondare un contratto nazionale del lavoro che risani le fratture che oggi lo connotano: ogni Fondazione infatti lo interpreta alla propria maniera, variandone le regole. L’autonomia delle singole Fondazioni Liriche è un punto estremamente delicato a cui aspirano alcuni sovrintendenti, attratti dalla garanzia di un finanziamento pluriennale, che se da un lato potrebbe fornire una maggiore libertà nell’organizzazione, dall’altro potrebbe far sorgere il rischio di incontrollate richieste all’interno del teatro. Inoltre potrebbe scatenare una irrazionale competizione tra istituzioni analoghe, che non gioverebbe al mondo musicale italiano e, più in generale, all’assetto culturale del nostro Paese. I teatri e le Fondazioni musicali sono terrorizzati dall’idea di perdere pubblico. Ma si dovrebbe cercare di far capire ai politici – a tutti i politici – che la cultura non può sempre produrre denaro: si tratta piuttosto di un investimento che lo Stato dovrebbe fare per determinare la crescita e l’arricchimento della collettività. La cultura è un panorama, un affresco estremamente diversificato, che deve essere sempre e di nuovo arricchito, al di là delle questioni meramente economiche. Un teatro moderno deve riusicre a capire il mondo che cambia. C’è una mancanza di curiosità verso il nostro tempo, ci muoviamo in una politica di conservazione che non consente le aperture e la dinamicità che ad esempio troviamo nell’assetto politico-culturale francese o tedesco. E non mi riferisco solo allo (scarso) inserimento della musica contemporanea all’interno delle programmazioni sinfoniche o delle Fondazioni Liriche, ma più in generale al fatto che manca la volontà di comprendere il nostro tempo, cioè quello che sta accadendo. Solo con una proposta di analisi e di stimolo creativo si potrà capire il presente, e solo in questo modo si riuscirà a creare un nuovo pubblico, non «museificato», e nuovi sovrintendenti e direttori artistici non «mummificati» (e lo dico sapendo che alcuni di loro sono in carica da venti o trent’anni). Il sistema percettivo di noi contemporanei è notevolmente cambiato anche solo rispetto a quindici o vent’anni fa. La cultura deve essere capace di tradurre e interpretare tutto ciò, e deve essere in grado di farlo attraverso un luogo di incontro dove si possa trovare il proprio presente tradotto. Le distanze tra i vari linguaggi vanno drasticamente ridotte: oggi la letteratura ha una velocità, la musica un’altra, il teatro un’altra ancora. Queste sono le riflessioni estetico-filosofico-linguistiche che un teatro si deve porre. Non vi può essere solo un’analisi di tipo economicistico. Si parla sempre di un contenitore: il rischio è quello di non guardare mai al contenuto. Giorgio Battistelli Pubblico e privato? La differenza non c’è Verso linguaggi inediti S tiamo vivendo un momento di perturbazione molto forte, che coinvolge il pensiero sulla musica e sulla sua funzione, dal quale talvolta germogliano idee contrastanti tra chi compone e chi organizza e produce. Per quel che concerne i teatri d’opera, mi sembra che l’ultimo regolamento delle Fondazioni Lirico-sinfoniche, con il suo riferimento al concetto di eccellenza, continui a creare una notevole confusione e una grande divaricazione all’interno del mondo musicale italiano. L’eccellenza di una Fondazione, di un teatro, di un’orchestra non può essere stabilita per decreto ma piuttosto guadagnata sul terreno passo dopo passo grazie alle conquiste artistiche, risultati che non riguardano tanto l’immagine quanto piuttosto la qualità delle produzioni. Va poi considerata la spiccata attenzione al bilancio: vengono definite d’eccellenza le istituzioni che hanno dimostrato un certo virtuosismo nella gestione economica e che quindi non hanno registrato un passivo negli ultimi cinque anni. Ma perché una Fondazione va in passivo? Alcune volte è individuabile anche una corresponsabilità da parte dei sindaci, che Giampaolo Vianello N on esiste un teatro pubblico e uno privato: esiste il teatro. In uno Stato democratico gli orientamenti sono i medesimi, sia che si parli di pubblico che di privato. Un dibattito su cosa faccia l’uno e cosa l’altro non ha senso. La differenza è data da chi paga le perdite. Fin dall’epoca greca, infatti, il teatro costa più di quello che incassa. Chi paga dunque? Lo Stato? Il Comune? Un privato? Uno sponsor? Un mecenate? Fino all’Ottocento circa, a Venezia è la classe imprenditoriale patrizia a finanziare i teatri. Ma quando anche i nobili si impoveriscono, i teatri chiudono. I tagli sono la stessa cosa. Nel 1930, sotto il fascismo, nascono i teatri finanziati: le istituzioni che erano state chiuse perché non ricevevano più i soldi dai privati, riaprono in pompa magna grazie al finanziamento pubblico. Ma quando anche questa fonte di sostentamento inizia a cedere, ecco allora che i sipari si chiudono nuovamente. Questa è la storia. E non è che lo Stato uccida la cultura. La domanda vera è: il teatro serve? Sembra di sì, perché dopo duemila anni ancora esiste. Il pubblico è in grande crescita e l’imponente richiesta di spettacolo dal vivo non è tanto un fatto culturale, quanto piuttosto l’espressione del de- dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 57 speciale teatro pubblico 58 — speciale teatro pubblico siderio di uscire dalla sfera del virtuale che oramai avvolge in larga parte il nostro mondo. Ma a questa grande domanda di spettacolo dal vivo non corrisponde una crescita numerica dei teatri, perché mancano i soldi. Non è però la prima volta che accade nella storia. I denari sono sempre mancati. Venezia aveva sette teatri e non ce n’era uno che non fallisse ogni stagione. I proprietari erano le famiglie nobili e i sostenitori, gli sponsor, erano i palchettisti, che molto spesso diventavano morosi. In questo caso la Repubblica veneta non interveniva economicamente; attuava piuttosto delle pressioni politiche sul sostenitore inadempiente perché versasse i soldi necessari a non far chiudere le strutture. Vi era tutto l’interesse, da parte del potere, che la gente si divertisse, che fosse occupata culturalmente e non avesse il tempo di pensare alla crisi della Repubblica. Venezia diventa così la capitale della cultura europea: non c’era città al mondo che avesse sette teatri attivi. Poi, nell’Ottocento, la censura decide di chiuderne quattro. Nel frattempo era però nata la Fenice e i teatri rimasero quattro, con l’assoluto divieto di costruirne di nuovi. Ma quando anche questo divieto fu abolito, non si progettarono comunque nuove strutture: ancora una volta mancavano i soldi. Questo fino al 1936, quando lo Stato decide di offrire dei finanziamenti: nasce così la Biennale Musica, la Fenice diventa un Ente lirico e le affidano anche il Malibran, il Goldoni diventa Teatro Stabile e il Rossini invece chiude. Nessuno riabilita un teatro, perché costa moltissimo gestirlo. L’intervento statale deve avere esattamente il ruolo che hanno coloro che da sempre sostengono i teatri: se questi costano cento e incassano venti, ottanta li dovrà investire qualcuno. Dal 1936 al 1990 lo Stato ha finanziato la differenza. Poi si è pensato dovessero esserci anche gli sponsor. Ma tale mescolanza di denaro non implica una cultura privata e una pubblica: significa invece che lo scarto che manca al pareggio lo paga un po’ lo Stato e un po’ il privato. Tutto sta nel trovare gli sponsor. E non è facile, perché spesso – e forse giustamente – i privati privilegiano altri ambiti: il calcio, l’automobilismo, gli eventi sportivi, che vantano un pubblico vastissimo e hanno mediaticamente un maggior successo. Uno stadio raccoglie molte più persone di quelle che occupano le poltrone della Fenice, della Scala o del Metropolitan. Sono cifre imparagonabili. Se a queste aggiungiamo tutti coloro che seguono la diretta televisiva… il gioco è fatto. E se i privati non si palesano e lo Stato riduce le sue quote, ecco che i teatri dovranno chiudere i battenti. Rinasceranno fra quarant’anni? Non lo so. Secondo il ministro Brunetta il pubblico dovrebbe pagare ciò a cui assiste: se una messinscena costa mille e ci sono mille spettatori, allora pagheranno uno a testa. Ma se si adottasse questa politica le persone dovrebbero sborsare cifre astronomiche, col risultato che il Teatro rimarrebbe probabilmente deserto. Il problema è sempre il medesimo: trovare qualcuno che paghi la differenza tra costi e ricavi. E non è vero che i costi sono alti perché si spreca: se si vogliono artisti di livello bisogna pagarli. Negli anni, poi, ai cantanti si sono sommate le masse artistiche, che si sono sindacalizzate e che chiedono onorari più alti. Una volta il rapporto fra costo degli artisti e costo delle masse era dieci a uno. Adesso è metà e metà. Ne sono state fatte di conquiste da parte dei lavoratori dei teatri! Però questo ha aumentato le perdite. E se le perdite sono eccessive, si chiude il teatro. Come si è sempre fatto. È una legge economica. Giorgio Brunetti Il teatro lirico: una sfida di sopravvivenza! I tagli alla Cultura, frutto della «manovra finanziaria», hanno ri- proposto il tema antico del finanziamento alle istituzioni culturali, organizzazioni che per loro natura non possono autofinanziarsi. Privato e pubblico, in alternativa o assieme, sono quindi i soggetti investiti del ruolo di finanziatori. In un caso, lo Stato come quello francese, che della Cultura fa il suo fattore distintivo, il suo elemento di differenziazione rispetto agli altri Paesi, dall’altro, privati e imprese, come nel sistema americano, che per spirito di mecenatismo o per scopi commerciali erogano fondi alla Cultura. In questi tempi, in cui si procede a grandi passi verso una società della conoscenza, la Cultura non può esser più una questione per ricchi o per particolari ceti di persone, diventa un fattore importante di sviluppo per un Paese. Non solo perché contribuisce alla produzione di ricchezza (occupazione, stretto rapporto con la produzione di beni e servizi), ma anche perché, essendo costituita da un insieme di attività che definiscono l’identità di un territorio, di un Paese, ne costituisce un fattore determi- nante della competitività. Il teatro in quanto narrazione della storia, forma di comunicazione e di formazione delle coscienze, certo non si sottrae a questo. È un elemento fondamentale della nostra Cultura che va sostenuto con fondi pubblici e in prospettiva, in sempre maggior misura, anche con fondi privati. Fermiamo, in particolare l’attenzione sul teatro lirico, un vanto per il nostro Paese perché qui l’opera lirica è nata. Rispetto ad altre forme teatrali, il teatro musicale impegna rilevanti risorse finanziarie, offre occupazione diretta di alto livello ed alimenta un indotto di qualità nel campo dell’arte, dell’artigianato e non solo. La criticità del teatro lirico sta proprio nella sua incapacità di autofinanziarsi perché i ricavi da botteghino non sono in grado di coprire i costi dello spettacolo. Vincoli derivanti dall’ampiezza della sala, la necessità di tante masse artistiche e tecniche per la messa in scena, l’impossibilità di aumentare la produttività del prodotto teatrale sono i fattori alla base di questo strutturale «distacco tra ricavi e costi». Interventi finanziari pubblici o privati o di entrambi sono quindi necessari. D’accordo, vi è sempre spazio per il recupero di efficienza interna evitando sprechi, per la coproduzione artistica tra i teatri alla ricerca di sinergie, per lo sviluppo del merchandising al fine di integrare i proventi, ma, non possiamo illuderci, occorre sempre l’intervento finanziario esterno senza il quale l’opera chiuderebbe. Nel nostro Paese quindici anni fa si era avviata la terza via nel finanziamento dell’opera lirica: pubblico e privato insieme a sostenere i tredici teatri lirici. Pensando che bastasse un posto in CdA del teatro per spingere i privati a finanziare l’opera. Il risultato è stato che un solo teatro, La Scala, è riuscito ad equilibrare il suo bilancio, pur con rilevante sostegno pubblico, visto il rilievo mondiale che essa ha e l’area ricca in cui insiste. Senza una legge fiscale di effettiva incentivazione non si attrae nessuno, specie in un Paese dove il mecenatismo è merce rara e le attività di sponsorizzazione in questo campo sono viste ancora con sospetto. Un testo di legge in questo senso è già stato anche approntato, ma Tremonti non intende farlo passare, dal suo punto di vista, per evidenti ragioni di bilancio. Credo che tutti siano consapevoli che il teatro musicale abbia bisogno di una riforma profonda. Oltre a coinvolgere i privati in termini di contributi finanziari, occorre mettere a punto un disegno organizzativo che offra flessibilità tra orchestra, coro e teatro, come per esempio è stato fatto in Francia, sviluppando le attività nei territori dove i teatri insistono. Ma al di là delle linee di riforma, da discutere, quello che preoccupa è il metodo seguito. Fondo unico dello spettacolo ad erogazione decrescente e sopratutto instabile con grave pregiudizio sulle programmazioni artistiche, intervento come quello del Decreto Bondi volto a bloccare le assunzioni. Un secondo decreto, emesso di recente, stabilisce i requisiti perché una Fondazione possa avere autonomia gestionale. Altri decreti sono previsti ma ancora ignoti nel contenuto. Uno stillicidio che crea preoccupazione per chi vi opera e che sconcerta tutti. Visto che questo federalismo fiscale costituisce il punto di arrivo di tutto e molto probabilmente anche dei teatri lirici, perché lo Stato non fa uno sforzo di continuità fino a quell’appuntamento? Impegnandosi per un dato ammontare del fus, ripartito in modo tale da premiare i teatri virtuosi, approvando una legge di incentivazione fiscale, arrivando ad un accordo con i sindacati per contratti aziendali che tengano conto delle specificità dei singoli teatri. Sono linee di azione ragionevoli, augurandoci che la ragione abbia ancora spazio in questo campo. Giorgio Pestelli Il teatro è luogo di cultura e occasione di svago N ella conduzione di un teatro lirico in Italia l’intervento statale, tenendo presenti caratteristiche e tradizioni locali, deve avere il peso prevalente; questa è una idea generale, naturalmente suppone una reale competenza teatrale e musicale nel Ministero dei Beni Culturali e nei componenti del Fondo Unico dello Spettacolo; interventi di privati sono anche importanti, ma la struttura portante deve essere stabilita dallo Stato con una visione complessiva di tutto il territorio nazionale. Oggi come ieri e domani il carattere e la funzione prioritaria di un teatro lirico pubblico deve essere duplice, intendendo il teatro come luogo di cultura e occasione di svago; quindi tenere d’occhio il repertorio classico, come un grande museo da curare, individuando anche titoli di va- speciale teatro pubblico — 59 Gabriele Lavia Il teatro italiano è tutto pubblico T utto il teatro italiano è pubblico, perché tutto, direttamente o indirettamente, è sovvenzionato dallo Stato, che ritiene che il teatro abbia un valore irrinunciabile per la Repubblica. Questo è ciò che si può evincere dal fatto che il Ministero promuove il teatro, tutto il teatro. Dopodiché ci sono alcuni teatri che si chiamano Stabili a funzione pubblica, come il Piccolo di Milano, il Teatro di Roma, quello di Catania, di Palermo, e via dicendo. Personalmente non credo che debbano esistere differenze nel momento in cui si pensa il Teatro, perché nella mia visione il Teatro è qualche cosa che non si vede e non si sente, è un’astrazione, è un infinito, è un non ente, è un niente, però è quel non ente che illumina tutti gli enti, che sono gli spettacoli. Ma gli spettacoli che non hanno come tensione ideale il Teatro – questa strana cosa che non si può misurare, né definire, né catalogare, questo incommensurabile, questo infinito – non sono teatro. Non tutto quello che si fa ad apertura di sipario è teatro, anzi quasi nulla. In base a queste premesse non penso che ci dovrebbero essere obiettivi diversi tra chi gestisce un teatro privato o uno pubblico. Io nella mia carriera ho diretto lo Stabile di Torino, uno Stabile privato e ora ho una mia compagnia, ma non per questo faccio cose diverse: faccio solo quello che mi sento di dover fare. Se poi mi si chiede come dovrebbe operare uno Stabile a gestione pubblica, be’, avendo una propria struttura dovrebbe in qualche modo cercare di promuovere il Teatro all’interno della città, cioè della realtà sociale cui fa riferimento. Arturo Cirillo Allestimenti sobri e compagnie stabili P remetto che – parlando di teatro – l’idea di sposare una logica pri- vatistica e legata esclusivamente al mercato mi fa rabbrividire. Detto questo, ho molto rispetto per il teatro privato, e credo che avrebbe qualcosa da insegnare anche a quello pubblico, soprattutto per quanto riguarda una più ponderata valutazione dei costi. Mi sembra che a volte gli Stabili si facciano quasi un vanto nel realizzare produzioni nate morte, destinate a essere soltanto degli eventi isolati. Il teatro pubblico secondo me dovrebbe essere un po’ più attento ai suoi conti, come del resto era – a quanto ne so – anche lo stesso Paolo Grassi quando amministrava il «suo» Piccolo Teatro. Mentre invece purtroppo gli Stabili sono spesso divenuti luoghi nei quali il regista o il direttore di turno si insedia per un paio d’anni, fa quello che vuole e in genere produce soprattutto spettacoli suoi. E talvolta autorizza e promuove scelte fallimentari in partenza. Ecco, questa situazione e questa consuetudine penso sia bene che scompaiano, e la mia impressione è che effettivamente negli ultimi tempi ci sia stato qualche incoraggiante segnale di cambiamento. C’è chi sta addirittura avanzando l’ipotesi che stia tramontando il teatro di regia: questo non lo so, ma posso dire con certezza che si sta concludendo l’epoca degli spettacoli grandiosi (e costosi), la cui forza di suggestione è data proprio dal piano estetico e dalla confezione. Mi piacerebbe inoltre che – un po’ come sta cercando di fare in questo periodo Antonio Latella a Napoli – i teatri pubblici potessero creare al loro interno delle compagnie realmente stabili: questo implicherebbe una più stretta relazione tra l’istituzione e la città che la accoglie, la quale vedrebbe nascere tra le sue mura una schiera di nuovi attori e registi. E credo che anche dal punto di vista economico questi non siano percorsi impossibili. Basterebbe – ripeto – risparmiare sugli allestimenti, evitare assunzioni e consulenze inutili, dimostrare insomma verso la cosa pubblica quell’oculatezza e quel buon senso che sono propri di un qualsiasi privato, anche per ritornare alla dimensione artigianale che ha sempre contraddistinto la nostra arte. Giorgio Barberio Corsetti L’ultimo luogo per ascoltare la poesia U n teatro pubblico – ma il teatro in generale, secondo me – ha a che fare con il mondo che ci circonda. Quindi deve diventare un luogo di incontro, forse l’ultimo luogo dove collettivamente ci si può ritrovare ad ascoltare la poesia. Proprio per questo non deve essere una fortezza chiusa bensì uno spazio che vive e pulsa tutto il giorno, e non si spegne nemmeno quando finisce lo spettacolo. In Italia invece i teatri pubblici – tranne alcune meritevoli eccezioni – sono autoreferenziali, pesanti e scarsamente gestibili, e dunque molto costosi. Vivono scambiandosi produzioni l’un l’altro, all’interno di una programmazione piuttosto mediocre. Altra cosa è lavorare sul presente, divenire centro nevralgico e punto d’intersezione. Il che non significa affatto escludere il pubblico. Il teatro che immagino deve avere anche una connotazione popolare, e invogliare i propri spettatori, senza però fornire loro ciò che si aspettano secondo canoni che derivano dai mezzi di comunicazione di massa e dalla televisione. Al contrario, proponendo opere che, essendo belle, piacciano alla gente, assumendosi dunque anche il compito di educare il gusto. E tenendo sempre a mente che il punto centrale del teatro è la poesia e non certo il prodotto. Detto questo il problema dell’Italia è che le strutture esistenti dovrebbero essere molto più snelle e meno condizionate dalla politica, come accade in altri Paesi. Grazie a una delle mie ultime esperienze all’estero ho potuto conoscere da vicino la realtà dell’Odéon di Parigi: è il più grande teatro cittadino, eppure è diretto da un regista che ha poco più di quarant’anni. Proprio lì ho debuttato con il testo di un drammaturgo contemporaneo su cui quel direttore aveva focalizzato la sua attenzione, dedicandogli una serie di allestimenti differenti. Un grande teatro di Stato ha dato dunque la possibilità a un autore vivente di essere portato in scena con grandi interpreti e con i mezzi propri delle grandi produzioni. In quel frangente ho potuto verificare di persona che tutte le decisioni venivano prese dalla direzione artistica in totale autonomia (con l’unico obbligo, a fine mandato, di rendere conto di come ha funzionato il teatro). In Italia invece ho sempre la percezione di dover sottostare a equilibri dettati dal potere, che finisce in questo modo per esercitare dei pesanti condizionamenti. Il problema è che da noi vengono adottati dei principi giusti (l’idea che esista un teatro pubblico, ad esempio, mi sembra fondamentale), ma le realtà che li dovrebbero incarnare concretamente non funzionano e andrebbero radicalmente riformate. C’è però il rischio che, nel momento in cui la situazione di queste istituzioni divenga di troppo difficile gestione, invece che promuovere trasformazioni e meccanismi migliorativi, si butti via tutto indistintamente e senza alcun discernimento. Armando Punzo Uno Stabile alla Fortezza P arlando in generale si rischia sempre di trascurare eccezioni im- portanti. Comunque, se devo esprimere un parere sulle strutture pubbliche del nostro Paese, mi sembra che esse siano generalmente caratterizzate da un alto tasso di chiusura, e che al loro interno possa avere accesso solo un certo tipo di teatro, che – ad onta dei professionisti che lo praticano, spesso molto bravi – è diventato il braccio armato della conservazione e del disimpegno, invece di esercitare la sua funzione originaria di specchio che crea contraddizioni e fa discutere. Senza nulla togliere al mestiere e alle difficoltà che comunque viviamo tutti di questi tempi, sinceramente non sono affatto persuaso che l’intrattenimento debba essere finanziato dallo Stato. Ma c’è di più: nel teatro italiano vi sono anche persone che – portando il discorso a un livello più alto rispetto al mero intrattenimento – si prestano comunque a questo gioco, fingendo soltanto di opporvisi magari mettendo in scena una drammaturgia un po’ più illuminata, o costruendo un’operazione meno facilmente inseribile nella più becera tradizione. Quest’accettazione dei meccanismi consolidati e dello status quo riguarda anche molti della mia generazione, che qualche tempo fa sembrava dovessero fare la rivoluzione e mettere il mondo sottosopra. L’impressione di fondo è che non si vogliano affrontare veramente le questioni. In questo senso mi convince assai poco anche il furore «denunciatorio» che caratterizza molti artisti, da cui nascono di volta in volta spettacoli contro la guerra, contro speciale teatro pubblico lore che per qualche motivo sono andati fuori corso, e produzioni contemporanee selezionate con criteri di qualità; ma non bisogna dimenticare di inserire periodicamente anche spettacoli divertenti, di grande richiamo popolare: il così detto «nuovo pubblico» dell’opera, tanto ricercato, entra in teatro per questo canale e forse amerà ritornarci per cose più impegnative. dove va il teatro pubblico italiano? 60 — dove va il teatro pubblico italiano? la camorra e via dicendo. Per quanto sia sempre giusto gridare a voce alta verità sgradite e scomode (che peraltro il più delle volte sono ben note a tutti, e in particolare a chi si occupa di politica), fermarsi alla denuncia significa non essere in grado (o non avere la voglia) di inventarsi niente altro. A mio parere riprodurre a teatro la realtà così com’è (direi anzi orribile com’è) assomiglia un po’ a un’operazione autistica. Il lavoro che facciamo in carcere va nella direzione diametralmente opposta, si dirige alle persone, cerca di intervenire direttamente, prova a modificare. Queste sono alcune tra le riflessioni che mi hanno spinto a immaginare un Teatro Stabile a Volterra. L’obiettivo era invertire di segno il concetto di stabilità, che riferito ai teatri, come accennavo prima, richiama appunto l’idea di conservazione, mentre accostato al carcere evoca una certa immobilità (anche se quest’immagine è falsa, perché se ci si avvicina a una prigione ci si rende conto che è uno dei luoghi meno stabili al mondo): ebbene ribaltando questa duplice matrice negativa il nostro Teatro dovrebbe fare in modo che la stabilità produca movimento, in tutti i sensi. Un progetto del genere non credo debba essere legato solo al mio nome, al nostro vissuto, all’esperienza particolare di agenti straordinari che ci hanno seguito, di detenuti che hanno fatto percorsi incredibili, di direttori illuminati e meno illuminati: il nostro lavoro anzi andrebbe considerato alla stregua di un esperimento che ha dato dei risultati e fornisce delle indicazioni alla politica, esattamente come un laboratorio di ricerca scientifica dimostra che l’utilizzo di certe scoperte tecnologiche migliora la vita. Anche se quest’esperienza finisse domattina, sono certo che tutti noi abbiamo dimostrato che un lavoro come il nostro trasforma, oltre alle persone, anche i luoghi, li migliora, rendendoli più capaci di realizzare quello per cui sono stati pensati. Si badi bene che il progetto è molto concreto, abbiamo costruito un documento dettagliato in cui si prevedono le ricadute in ambito economico, si fanno precise previsioni sulle assunzioni e si valutano gli effetti che quest’iniziativa avrebbe sui detenuti. Non stiamo insomma parlando di qualcosa di astratto e inutilmente utopico. Se davvero riuscissimo a convincere le istituzioni della bontà di questo disegno, a trarne vantaggio sarebbe in primo luogo il discorso artistico, che si potrebbe realizzare con una tranquillità molto maggiore. È escluso che potremmo riprodurre qui quel concetto di stabilità già evocato, che equivale alla morte artistica e che, quando abbiamo iniziato a parlare in giro di quest’idea, ha fatto arricciare il naso a molte persone che da sempre ci sono vicine. In realtà la morte di quest’esperienza la rischiamo se continuiamo in questo modo, se non troviamo una forma di sviluppo al nostro lavoro. Dopo ventidue anni cosa possiamo mai riuscire a fare di più di quello che stiamo facendo e abbiamo fatto? Il rischio è invece perdere attori, per una banale questione di concretezza. Se il detenuto che esce dal carcere trova un lavoro – mettiamo – da lavapiatti, questa per lui è un’occasione concreta, alla quale ora come ora io non posso contrapporre nulla. Il mestiere di lavapiatti è dunque più concreto, più sicuro del percorso artistico che ha sviluppato per anni. E così facendo ripiombiamo a braccia aperte nella mentalità comune, conservatrice e tipicamente italiana, per cui «è già tanto, per un criminale, trovare un impiego da lavapiatti». Questo pensiero comune la cultura lo deve abbattere, e in questo senso la creazione di uno Stabile sarebbe una manna dal cielo, perché ci permetterebbe di avviare una serie di percorsi professionalizzanti che avrebbero strettamente a che fare con l’arte teatrale. In fondo si tratta di costruire un teatro a contatto con una comunità di persone: non stiamo in realtà proponendo niente di nuovo, anche se la nostra è una comunità dove le problematiche sociali non sono assopite, una comunità che non crede che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il quotidiano è attraversato invece da quest’idea tranquillizzante, sulla quale è facile che anche il teatro si assopisca. Se si entra in carcere invece si ritrovano tutte le contraddizioni del nostro mondo e dell’umanità, dell’uomo in quanto uomo e dei suoi riflessi sociali. Chiaro che un teatro a contatto con questa comunità potrebbe far riemergere molte riflessioni. zo delle risorse. Lo Stato riconosce dunque (articolo 9 della Costituzione) allo sviluppo della cultura una funzione fondante per la nostra società, comunicando chiaramente ai soggetti destinatari degli investimenti, con anticipo rispetto alla programmazione, quali sono le risorse che intende investire in tale settore. E questo avviene dunque prima che i soldi siano stati investiti, perché in altri tempi succedeva invece che venissero presentati conti delle spese che variavano a seconda che i teatri fossero stati gestiti bene o male. E a ciò si doveva porre un freno. Lo si fece appunto nel 1985 con quella legge del fus, che oggi viene tanto bistrattata. Nello stesso testo normativo venivano quindi stabiliti i criteri di finalizzazione delle risorse, risorse certe, date nei tempi e nei modi giusti affinché venissero spese correttamente e ci si potesse assumere la responsabilità di rendere conto di come sarebbero state impiegate. Venne stabilito che i criteri con cui sarebbero stati investiti questi soldi avrebbero dovuto essere determinati da leggi di settore per le diverse componenti della cultura e dello spettacolo, che il Parlamento si impegnava ad approvare nel giro di un tempo ragionevole. Quindi una logica perfetta che restituiva responsabilità alla politica e ai soggetti destinatari. Un meccanismo davvero virtuoso. Nel frattempo, però, per motivi biechi che non esito a definire di codardia politica, e anche per piccoli interessi corporativi o elettorali, questo assetto legislativo, queste regole di fondo che danno sostanza a tali decisioni non sono mai state realizzate. Non è mai stata fatta una legge quadro di riferimento per lo spettacolo dal vivo. Paolo Grassi la chiedeva già nel 1946. Molti anni sono passati da allora e in questa legislatura è stato approvato da tutte le componenti del Parlamento un testo che stabilisce sic et simpliciter che siccome ci sono meno soldi la legge non si fa. E se c’è una logica demenziale è proprio quella che afferma che se ci sono meno risorse allora non si stabilisce come ripartirle. In questo modo si delegittima l’investimento pubblico e lo si riporta a un sottobosco di discussione – quanti e quali sono gli sprechi, quali sono le eccellenze, e via dicendo – effetto della vigliaccheria politica di chi non si è assunto la responsabilità di indicare le linee con cui lo Stato dovrebbe intervenire, come accade in tutti i Paesi civili. La Francia per esempio ha stabilito per legge quali sono i teatri nazionali, ha destinato altre forme di sostegno alla drammaturgia e ha fissato con esattezza i criteri di finanziamento. Il nostro Paese ha ucciso il fus non perché qualcuno abbia sprecato i soldi – come in molti continuano a sostenere – ma perché non ci si è assunti la responsabilità di dare regole certe sulla finalizzazione dei contributi. E adesso siamo al paradosso per cui si effettuano «tagli» non tanto in vista di una risoluzione della crisi quanto piuttosto a mo’ di drastici pretesti per massacrare orizzontalmente qualsiasi attività, senza discriminare fra quelle bene e quelle mal gestite e riconoscere funzioni differenziate ai vari soggetti. I criteri con cui lo Stato dovrebbe investire sono già stati enunciati e sono a portata di mano. Ma quello cui si assiste è piuttosto la delegittimazione dell’investimento pubblico. Quando nel 2010 si decidono riduzioni del trentacinque per cento sulle attività del 2011 – che si sommano a quelle del quindici per cento del biennio precedente – è a tutti evidente che non ci si sta riferendo all’attività futura dei teatri, bensì a quella passata: gli impegni, le attività produttive e la vendita degli spettacoli, infatti, sono già avvenute almeno sei mesi prima. Nel 1947 nasceva il Piccolo Teatro, il primo Stabile pubblico italiano. Paolo Grassi diceva che il teatro è il luogo dove la comunità si riconosce; io dico che ai giorni nostri è diventato il luogo dove la comunità si conosce, perché i cambiamenti che sta attraversando la società sono di portata tale che il teatro può aiutare a comprenderne i connotati inediti, le peculiarità, le contraddizioni, la frammentazione, e alla fine può contribuire a ricomporre un’idea di cittadinanza. Nel ’47 si trattava semplicemente di ritrovarsi attorno a dei valori condivisi, ora il teatro crea nuovi valori attorno ai quali aggregare una società sostanzialmente disgregata. Sergio Escobar Il peso abnorme dell’apparato Si assiste alla delegittimazione dell’investimento pubblico V enticinque anni fa lo Stato italiano si è dotato di una legge avan- zatissima: la Finanziaria dello Spettacolo, ossia il fus, norma lungimirante fondata su presupposti molto chiari, con al centro la responsabilità delle parti nel garantire il servizio pubblico e finalizzare l’utiliz- Walter Le Moli I n Germania il teatro, così come la musica e la danza, rientra nel si- stema scolastico, ed è inserito al pari di altre materie nei programmi didattici. Non è fatto confluire nell’indistinto calderone dello spettacolo, che comprende invece intrattenimenti di massa come il calcio e la televisione. Ma la differenza più grande tra la nostra situazione e quella di molti altri Paesi europei sta nella formazione: altrove per fare l’attore, il regista, lo scenografo è necessario aver compiuto un percorso, come per diventare medico o ingegnere. Quindi da un lato ci si trova di fronte una grande folla di persone che hanno fatto esperienza teatrale in modo dilettantistico a scuola, nei licei, nei college universitari. Ed è un bene, perché in questo modo esiste già un’utenza giovane e preparata, che affollerà le sale e valuterà con competenza ciò che le viene proposto. Dall’altro lato c’è invece una ristretta schiera di professionisti, che hanno compiuto il loro iter formativo dentro accademie e conservatori ai quali si accede in virtù di una precisa vocazione. In Italia invece nessuno a scuola studia teatro e danza, pochissimi la musica, perciò le istituzioni teatrali si devono preoccupare di sollecitare il consumo, facendo nascere dal nulla la necessità di quel bene. Mentre sul versante del professionismo il moltiplicarsi di persone che si autoproclamano di volta in volta registi, attori e via dicendo ha distrutto completamente la credibilità della categoria. La sempre crescente disoccupazione intellettuale giovanile si è sfogata d’altro canto nei pochi luoghi che non erano blindati o a numero chiuso. Tutti possono scegliere di fare carriera teatrale. Così ci troviamo in presenza di un numero spropositato di attori, per esempio, di cui solo una piccolissima parte contribuisce a rinnovare questa forma espressiva. Però la moneta cattiva scaccia la buona, è una regola dell’economia. Comunque sia, la cosa certa è che così non si può andare avanti, il sistema vigente ha dato il massimo e oggi bisogna necessariamente riformarlo, distinguendo fra quello che è lavoro professionale e quello che invece chiamerei da «filodrammatiche con la laurea». Che non mi disturba, tutt’altro: utilizzando un paragone preso dallo sport, tutti giocano a calcio, ma non tutti in serie A. E un pubblico di tifosi appassionati spinge gli stessi professionisti della serie A a giocare meglio. Basta però non confondere le cose. Il secondo elemento negativo riguarda la divisione artificiale dei generi. In Italia le performing arts sono burocraticamente suddivise in rigidi compartimenti: danza, musica, opera, prosa, circo e via aggiungendo. In altri Paesi c’è molta più commistione, scambio, vicinanza. E questo si ripercuote beneficamente anche nella crescita dei singoli artisti, che sono costretti a misurarsi con più discipline. In ambito scientifico questa è ormai la norma: un biologo non può non lavorare fianco a fianco con un chimico o con un matematico. Allora mi chiedo: ha ancora senso tenere separate queste pareti? Non sono davvero possibili economie di scala? Questi interrogativi conducono dritto al nocciolo della questione che attanaglia il teatro pubblico italiano, vale a dire il peso abnorme dell’apparato, che finisce per inibire la produzione. L’apparato e la struttura, nati per supportare l’attività teatrale, sono divenuti il terminale, il destinatario e la ragione di esistere delle istituzioni. Eppure esse sono state istituite proprio per produrre teatro, non per pagare gente che il teatro lo tenesse aperto. Un caso emblematico è l’Ente teatrale italiano. Come è riuscita a fallire una struttura che non produceva alcunché e si limitava a ospitare, ricevendo dallo Stato venti milioni di euro, più di qualunque Stabile? Semplice, perché il costo dell’apparato, che va dalla maschera fino al presidente, assorbiva tutto. Questo significa essere usciti dai binari. Ma perché tutto questo lo devono pagare gli artisti? Perché alla fine a pagare dev’essere la sola vera ragione di esistenza di queste istituzioni? Oreste Bossini La crisi dello Stato N el quesito si trova un’espressione in apparenza abbastanza neu- tra, ma in realtà essenziale per rispondere alla domanda: «nel complesso contesto socioculturale in cui viviamo». Il terremoto che sta scuotendo alle fondamenta il sistema del teatro pubblico infatti non è provocato dalla crisi economica (il nostro Paese ne ha attraversate altre, forse più drammatiche, senza chiudere i teatri), bensì proprio dal mutato «contesto socioculturale». Secondo me è un errore continuare a dipingere l’attuale Governo e il suo ministro dei Beni e delle Attività Culturali Sandro Bondi come nemici della cultura e feroci rottamatori del mondo dello spettacolo. Mi sembra un’analisi rozza e rischia di diventare un cliché, confondendosi alla fine con una sterile propaganda politica. I gusti del Presidente del Consiglio e della cerchia di personaggi di cui si circonda sono senza dubbio improntati alle forme più volgari d’intrattenimento, tuttavia non ritengo che il tentativo di smantellare il fus e più in generale il sistema dei cosiddetti Beni Culturali dipenda da un’avversione personale di questo o quel ministro per la musica di Verdi o per i dipinti del Carpaccio. Magari fosse così, perché in quel caso si potreb- be ragionevolmente sperare che il problema sarebbe risolto al prossimo cambio di maggioranza con l’avvento di un ministro diversamente sensibile. Temo però che questo auspicabile scenario non sia sufficiente di per sé a rimettere in sesto una situazione ormai compromessa. Il cancro si è sviluppato nelle zone profonde della società e ha cominciato a intaccare anche le parti sane dell’opinione pubblica. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, senza rifugiarsi in illusioni consolatorie. La classe politica al governo e anche quella all’opposizione, con sfumature poco rilevanti, hanno infatti una visione analoga del rapporto tra capitale pubblico e istituzioni culturali. Lo Stato, secondo la stragrande maggioranza dei nostri parlamentari, non ha il compito né d’infornare panettoni, né di allestire spettacoli d’opera. Per motivi di rappresentanza e di prestigio internazionale, può mantenere la Scala e l’Accademia di Santa Cecilia, ma non tutti gli altri. Se i cittadini di Genova, di Napoli o di Bologna desiderano andare all’opera, dovrebbero sborsare i soldi di tasca propria, tramite gli enti locali, o trovare delle risorse private. Il teatro sembra l’unico settore dove il federalismo alla Bossi non desta nessuna opposizione. Questo teorema sta alla base della legge sulle Fondazioni del 29 giugno 1996, varata dal governo Prodi e promossa dal ministro Veltroni, su pressione del sovrintendente del Teatro alla Scala Carlo Fontana. Tutti politici di centrosinistra, com’è noto. La legge finora non è stata attuata fino in fondo soltanto per l’opposizione dei sindacati e per la difficoltà di maneggiare una materia così rovente in campagna elettorale, con il risultato che l’agonia dei teatri è stata lenta ed estenuante. L’attuale Governo, forte di numeri parlamentari procurati da una legge truffaldina ma non di un vero consenso politico, ha tentato in maniera maldestra di portare a compimento i presupposti di una legge pensata da uomini dello schieramento avversario, creando un guazzabuglio politico e istituzionale dal quale non si sa più come venirne fuori. La vicenda del Carlo Felice di Genova è emblematica, con una «sindaca» del centrosinistra costretta a portare avanti una politica antisindacale (e credo per lei suicida alle prossime elezioni) ispirata da un petroliere, Riccardo Garrone. La via dell’inferno in questo caso è lastricata dalla buona intenzione di salvare il posto ai lavoratori del teatro, ma con il diabolico risultato di conculcare nell’opinione pubblica l’idea che le Fondazioni sono un baraccone mangiasoldi per colpa dei sindacati e che professori d’orchestra, artisti del coro, ballerini e maestranze artistiche in genere siano dei vampiri per il contribuente. Marchionne docet. È noioso ripetere quel che sanno bene tutte le persone di buona volontà e di buon senso. In nessun Paese al mondo esiste il pareggio di bilancio (reale, non solo contabile) per un museo, per un’orchestra o per un teatro d’opera. In forme diverse, lo Stato contribuisce sempre a mantenere in vita le istituzioni culturali. Può versare i fondi in maniera diretta come avviene in Francia e in Italia, oppure tramite i Ländler come in Germania, o in maniera indiretta, come negli usa, rinunciando a una parte delle imposte private. L’obiettivo dell’autonomia economica nel campo dell’arte non è un’utopia, è una fesseria. L’intervento della mano pubblica per la produzione e la conservazione del patrimonio artistico non dovrebbe neppure rappresentare un tema di discussione. Nessuno, nemmeno il più accanito sostenitore dell’individualismo liberista, tranne forse Sarah Palin, metterebbe al centro della propria campagna elettorale la proposta di togliere il finanziamento statale alla sanità, all’istruzione, alle forze armate. In un Paese civile e di lunga storia, qual è il nostro, nemmeno quello per mantenere il patrimonio naturale, artistico e culturale verrebbe considerato opinabile. La discussione casomai dovrebbe vertere sul modo con il quale si spendono le risorse pubbliche, in base a quali criteri e per quali obiettivi. Ho l’impressione che l’attuale smottamento delle istituzioni culturali sia la conseguenza di una crisi dello Stato in quanto espressione di una nazione. Lo sfacelo dei teatri secondo me non deriva tanto dalla mancanza di soldi, quanto piuttosto dal venir meno di un’idea dello Stato. Le scorie di un Bildungsroman nazionale pieno di problemi irrisolti, di ingiustizie sociali e di arroganza militarista stanno sommergendo tutte le istituzioni pubbliche di questo Paese, proprio alla vigilia di un evento simbolico come le prossime celebrazioni dell’Unità d’Italia. Per centocinquant’anni il Paese ha evitato di affrontare con onestà e giustizia i suoi problemi, preferendo nascondere le magagne sotto il tappeto della retorica via via del Risorgimento, della Guerra d’Indipendenza, del Fascismo. Ora che anche l’ultimo bordo di questo tappeto, la Resistenza antifascista, si sta consumando, se non altro per motivi anagrafici, dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? — 61 62 — dove va il teatro pubblico italiano? dove va il teatro pubblico italiano? sembra che non resti più nulla a coprire il vuoto di uno Stato che non sa più in nome di chi e di che cosa dovrebbe funzionare. L’opera, la musica e il teatro sono forme d’espressione artistica universali, che prescindono dalle condizioni sociali e culturali del loro tempo, mentre le Fondazioni sono istituzioni della politica. L’opera continuerà a esistere, anche se tutte le Fondazioni dei teatri italiani dovessero portare i libri in tribunale. Il pericolo in realtà non consiste nel fatto che i cittadini italiani vengano privati delle opere di Verdi, di Rossini e di Mozart, bensì che gli spettatori di un futuro teatro tutto rivolto al marketing e al consumo perdano via via la coscienza che quei capolavori parlano di loro, delle loro sofferenze e delle loro speranze. Questo infatti dovrebbe essere l’unico motivo per giustificare tutte le spese che lo Stato dovrebbe sostenere (e sostiene sempre meno) per produrre una forma di spettacolo così dispendiosa ed effimera. In altre parole, l’intervento dello Stato nell’organizzazione dei teatri ha senso se contribuisce a formare la coscienza dei cittadini, garantendo a tutti quelle esperienze che altrimenti rimarrebbero riservate a pochi privilegiati. Questo è possibile però solo se lo Stato rappresenta l’espressione di una comunità che si riconosce come nazione, che reputa d’interesse generale conservare la memoria del proprio passato e tramandare alle nuove generazioni le idee e i valori di quelle precedenti. Il destino dei teatri italiani non dipende dai soldi, bensì dalla rinascita dell’Italia come nazione, dalla voce dei suoi scrittori, dei suoi artisti, dei suoi scienziati. Tremonti può chiudere i teatri, ma Saviano potrebbe salvarli. ◼ Serie fotografica dedicata ai teatri italiani (alle pagine 26-27, 28-29, 36-37, 3839, 46-47, 48-49, 56-57, 58-59), da sinistra a destra: Arena, Carlo Felice di Genova, Comunale di Ferrara, Goldoni di Venezia, La Scala, Mercadante, Metastasio, Storchi di Modena, Petruzzelli, Piccolo, Rossetti di Trieste, San Carlo, Malibran, Regio di Parma, Rossini di Pesaro, Argentina, Bellini di Catania, Biondo, Comunale di Firenze, Comunale di Treviso, Gobetti di Torino, Lirico di Cagliari, Massimo di Palermo, Rasi di Ravenna, Regio di Torino, Verdi di Padova, Verdi di Trieste, Opera di Roma, La Fenice, Olimpico, Bonci di Cesena, Greco di Taormina, Elfo-Puccini di Milano, Covent Garden, Metropolitan di New York, Odéon di Parigi, Nazionale di Pechino, Reale di Stoccolma, Opéra Bastille, Sydney Opera House, Kabuki-za Theater di Tokyo, Colon di Buenos Aires, Municipal di San Paolo, Bolscioi di Mosca, Liceu di Barcellona. Serie fotografica dedicata agli autori di teatro (alle pagine 30, 40, 50, 60), da sinistra a destra: Sofocle, Aristofane, Seneca, William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca, Carlo Goldoni, Molière, Anton Cechov, Alfred Jarry, Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Jean Genet, Eduardo de Filippo, Samuel Beckett, Heiner Müller, Bernard Marie Koltès. mondi, Simone Del Savio, Vittorio Grigolo, Walter Fraccaro, Sara Mingardo, Giovanna Casolla, Maria Pia Piscitelli, Martina Serafin, Micaela Carosi, Mirella Freni, Patrizia Ciofi, Maria Luigia Borsi, Roberto Frontali, Fabio Armiliato, Fiorenza Cedolins. Carmelo Alberti • Associato di Storia del teatro e dello spettacolo e di Antropologia teatrale all’Università Ca’ Foscari di Venezia Roberto Alonge • Ordinario di Storia del teatro rinascimentale all’Università di Torino – Direttore del Dipartimento di Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo dell’Università di Torino Corrado Augias • Giornalista e scrittore Giorgio Barberio Corsetti • Regista Laura Barbiani • Presidente del Teatro Stabile del Veneto Giorgio Battistelli • Compositore – Già direttore del settore Musica della Biennale di Venezia Anna Beltrametti • Associato di Storia del teatro greco e latino all'Università di Pavia Leonetta Bentivoglio • Inviato speciale per Cultura e Spettacoli della «Repubblica» Alberto Bentoglio • Associato di Storia del teatro e dello spettacolo e di Organizzazione ed economia dello spettacolo all’Università di Milano Marco Bernardi • Direttore del Teatro Stabile di Bolzano Lorenzo Bianconi • Ordinario di Drammaturgia musicale all’Università di Bologna Oreste Bossini • Giornalista – Conduttore radiofonico Giorgio Brunetti • Professore emerito di Strategia e Politica aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano – Docente di Governance e Management delle aziende dello spettacolo all'Università Ca’ Foscari di Venezia Sylvano Bussotti • Compositore Massimo Cacciari • Ordinario di Estetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Serie fotografica dedicata ai compositori (alle pagine 31, 41, 51, 61), da sinistra a destra: Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Anton Bruckner, Johann Strauss, George Bizet, Giacomo Puccini, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Maurice Ravel, Igor Stravinskij, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, Bruno Maderna. Sandro Cappelletto • Scrittore – Critico musicale della «Stampa» – Docente di Economia e gestione delle arti e delle attività culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia Serie fotografica dedicata ai registi di teatro (alle pagine 32, 42, 52, 62), da sinistra a destra: Jerz y Grotowski, Tadeusz Kantor, Giorgio Strehler, Luchino Visconti, Ariane Mnouchkine, Robert Wilson, Luca Ronconi, Peter Brook, Peter Stein, Robert Lepage, Christoph Marthaler, Anatolij Vasil’ev, Lev Dodin, Ejmuntas Nekrosius, Patrice Chéreau. Marco Cavalcoli • Attore – Presidente di Fanny & Alexander Serie fotografica dedicata agli attori di teatro (alle pagine 33, 43, 53, 63), da sinistra a destra: Franca Valeri, Giorgio Albertazzi, Giulia Lazzarini, Ferruccio Soleri, Piera Degli Esposti, Paolo Poli, Milena Vukotic, Franco Branciaroli, Maddalena Crippa, Massimo Popolizio, Laura Marinoni, Danio Manfredini, Francesca Mazza, Fausto Russo Alesi, Pia Lanciotti, Umberto Orsini, Mascia Musy. Serie fotografica dedicata ai direttori d'orchestra (alle pagine 34, 44, 54), da sinistra a destra: Antonio Pappano, Ottavio Dantone, Riccardo Chailly, Herbert Von Karajan, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Arturo Toscanini, Daniel Barenboim, Daniel Oren, Eliahu Inbal, Dimitrj Kitajenko, Myung Whun Chung, Jeffrey Tate, Attilio Cremonesi, Renato Palumbo. Serie fotografica dedicata ai cantanti lirici (alle pagine 35,45,55), da sinistra a destra: Leonardo Cortellazzi, Lorenzo Regazzo, Natale de Carolis, Ruggero Rai- Romeo Castellucci • Regista – Fondatore della Socìetas Raffaello Sanzio – Già direttore del settore Teatro della Biennale di Venezia Ascanio Celestini • Attore, scrittore e regista Arturo Cirillo •Attore e regista Antonio Cognata • Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Franco Cordelli • Critico teatrale del «Corriere della Sera» Carlo De Incontrera • Compositore e musicologo – Già Docente di Storia ed Estetica della Musica presso il Conservatorio «Giuseppe Tartini» di Trieste e presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste Dario De Luca • Attore, drammaturgo e regista – Direttore artistico del festival «Primavera dei Teatri» Gianni De Luigi • Regista – Fondatore dell’Istituto della Commedia dell’Arte internazionale Cesare De Michelis • Ordinario di Storia della critica e della storiografia letteraria all’Università di Padova dove va il teatro pubblico italiano? — 63 Roberto De Simone • Regista e compositore Fabio Nieder • Compositore Pier Luca Donin • Direttore di Arteven-Circuito Teatrale Regionale Fortunato Ortombina • Direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia Sergio Escobar • Direttore del Piccolo Teatro di Milano Siro Ferrone • Ordinario di Storia del teatro e dello spettacolo all’Università di Firenze Luca Francesconi • Compositore – Direttore del settore Musica della Biennale di Venezia Alessandro Gassman • Attore e regista – Direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto Geppy Gleijeses • Attore e regista – Direttore artistico del Teatro Stabile di Calabria Maria Grazia Gregori • Critico teatrale dell’«Unità» Gerardo Guccini • Associato di Drammaturgia e di Teoria e tecniche della composizione drammatica all’Università di Bologna Saverio La Ruina • Attore, drammaturgo e regista – Direttore artistico del festival «Primavera dei Teatri» Antonio Latella • Regista – Direttore artistico del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli Renato Palazzi • Critico teatrale del «Sole 24 ORE» Cristina Palumbo • Operatore teatrale Giorgio Pestelli • Critico musicale della «Stampa» – Già Ordinario di Storia della musica all’Università di Torino Paolo Petazzi • Critico musicale dell’«Unità» – Docente di Storia della musica al Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano Paolo Pinamonti • Ricercatore all’Università Ca’ Foscari di Venezia – Direttore artistico del Festival «Terras sem sombra» di Lisbona Pier Luigi Pizzi • Regista Andrea Porcheddu • Critico teatrale – Docente di Metodologia della critica allo iuav di Venezia Armando Punzo • Regista – Fondatore della Compagnia della Fortezza di Volterra Paolo Puppa • Ordinario di Storia del teatro e dello spettacolo all’Università Ca’ Foscari di Venezia – Drammaturgo Rosanna Purchia • Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Gabriele Lavia • Attore e regista – Già direttore artistico del Teatro Stabile di Torino Renato Quaglia • Direttore artistico e organizzativo del Napoli Teatro Festival Italia Walter Le Moli • Regista – Direttore del corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche del teatro allo iuav di Venezia – Già direttore artistico del Teatro Stabile di Torino Carlo Repetti • Direttore del Teatro Stabile di Genova Cesare Lievi • Regista e drammaturgo – Direttore artistico del Teatro Giovanni da Udine – Già direttore artistico del Centro Teatrale Bresciano Stephane Lissner • Sovrintendente e direttore artistico del Teatro La Scala di Milano Claudio Longhi • Regista – Associato di Discipline dello Spettacolo allo iuav di Venezia Enzo Restagno • Musicologo – Direttore artistico del Festival MiTo Settembre musica Paolo Rossi • Attore e regista Letizia Russo • Drammaturga Michele Sambin • Regista, musicista e pittore – Fondatore del Tam Testromusica Manlio Santanelli • Drammaturgo Giovanna Marinelli • Già direttore del Teatro di Roma Giuliano Scabia • Drammaturgo e scrittore Marco Martinelli • Regista e drammaturgo Toni Servillo • Attore e regista Ermanna Montanari • Attrice – Direttore artistico del Festival di Santarcangelo 2011 Federico Tiezzi • Regista – Già direttore artistico del Teatro Metastasio di Prato Cesare Mazzonis • Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Vitaliano Trevisan • Scrittore e drammaturgo Anna M. Alessandra Merlo • Direttore scientifico del Master in Management per lo Spettacolo della sda Bocconi di Milano – Docente in ruolo presso l’Università della Valle d’Aosta Giordano Montecchi • Critico musicale dell’«Unità» – Docente di Storia della musica al Conservatorio di Parma Carla Moreni • Critico musicale del «Sole 24 ORE» Giovanni Morelli • Ordinario di Filologia musicale, Musicologia e Storia della Musica all’Università Ca’ Foscari di Venezia – Direttore dell’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia Luca Mosca • Compositore Ernesto Napolitano • Associato di Storia della musica moderna e contemporanea all’Università di Torino Marco Tutino • Sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna Pietro Valenti • Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione Cristina Ventrucci • Critico teatrale Walter Vergnano • Sovrintendente del Teatro Regio di Torino Giampaolo Vianello • Già Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia Dino Villatico • Critico musicale della «Repubblica» Piero Violante • Associato di Storia delle idee politiche e Sociologia della musica all’Universìtà di Palermo – Critico musicale della «Repubblica» – Già Consigliere del Teatro Biondo Teatro Stabile di Palermo e della Fondazione Teatro Massimo di Palermo dove va il teatro pubblico italiano? Edoardo Erba • Drammaturgo e scrittore
Scarica