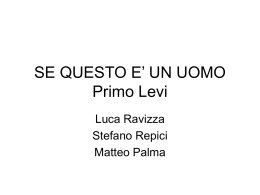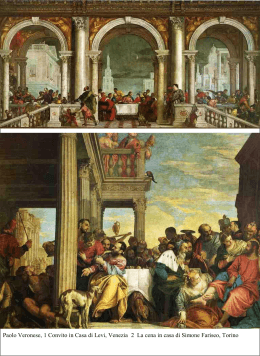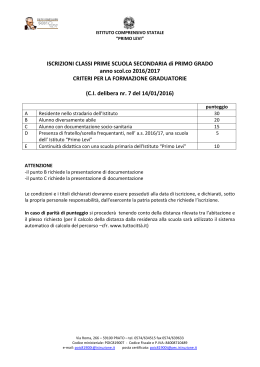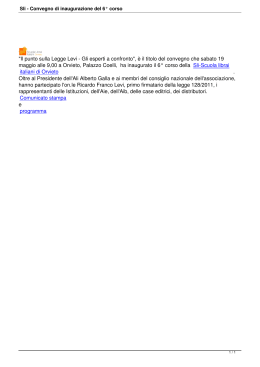Alias – 20.5.12 Famiglia mista con la smania di avere di più - Luca Briasco Pubblicato negli Stati Uniti lo scorso agosto e accolto da recensioni entusiastiche (in un articolo su Esquire, Benjamin Percy lo ha salutato come l’esordio di «un nuovo talento selvaggio») Noi, gli animali (Bompiani, «Letteratura straniera, pp. 140, € 16) è il primo romanzo di Justin Torres, giovane narratore di origine portoricana. Breve, compresso, costruito attraverso una serie cronologica di «quadri», sketch più ancora che racconti, il libro si concentra sui cinque componenti di una «famiglia mista»: un padre portoricano, che si barcamena tra mille lavoretti più o meno puliti e sfoga la sua naturale esuberanza alternando manifestazioni di affetto travolgente ed esplosioni di violenza; una madre bianca, operaia in un birrificio, sposatasi a soli quattordici anni, ora succube del marito, ora in fuga, ora disperatamente innamorata; tre figli maschi, che vivono, in perfetta simbiosi, l’euforia dell’infanzia. Basta leggere le prime righe di «Volevamo di più», il capitolo di apertura del romanzo, per comprendere lo sforzo di mimesi linguistica che Torres profonde nel tentativo di rendere la frenesia con la quale i tre fratelli aggrediscono il mondo che sta loro intorno, muovendosi e agendo come un’unica entità: «Volevamo di più. Picchiavamo sul tavolo il manico delle forchette, sbattevamo i cucchiai contro le scodelle vuote: avevamo fame. Volevamo più baccano, più casino». E ancora: «Eravamo sei mani che strappavano, sei piedi che pestavano; eravamo fratelli, tre maschi, tre piccoli re asserragliati nella smania di avere di più». Fin dalle prime pagine, il romanzo conquista soprattutto per le virtù ritmiche della prosa (resa con efficacia e adesione da Sergio Claudio Perroni), per la precisione quasi antropologica con cui vengono riprodotte le dinamiche infantili e lo sguardo dei tre bambini sul mondo degli adulti, per l’umanità straziata che caratterizza il ritratto dei due genitori e per la limpida esattezza delle dinamiche famigliari, sottratte a qualunque facile cliché. Nelle molte interviste concesse in occasione della pubblicazione, Torres ha più volte ribadito come la materia trattata nel romanzo non sia immediatamente autobiografica, ma oggetto di un lavoro di filtro e rielaborazione; d’altro canto, proprio il fatto di attingere a vicende e ambienti molto vicini a quelli della sua infanzia e adolescenza consente alla maggior parte degli sketch di cui si compone Noi, gli animali di elevarsi ben al di sopra del mero esercizio stilistico – ancorché di alta scuola – per toccare una sostanza più profonda, insieme oscura e potente. Il percorso personale di Torres somiglia da vicino a quello di quasi tutti i nuovi «prodigi» della narrativa americana: studi di scrittura creativa presso il prestigioso Iowa Writers Workshop, che fin dal secondo dopoguerra ha rappresentato il bacino di coltura delle più importanti scuole e tendenze letterarie maturate oltreoceano, dal postmoderno al minimalismo; una Wallace Stegner Fellowship presso la Stanford University, in California, di cui hanno usufruito, in passato, stelle di prima grandezza, da Raymond Carver a Jeffrey Eugenides; racconti e frammenti pubblicati su quasi tutte le maggiori riviste statunitensi, dal «New Yorker» a «Granta», a «Tin House». Molti dei rapporti di filiazione o fratellanza alla radice di Noi, gli animali, sono dichiarati dallo stesso Torres nei ringraziamenti in coda al libro. Tra i nomi citati, appaiono i numi tutelari della letteratura gay maschile e femminile, da Dorothy Allison a Michael Cunningham e Allan Gurganus,ma anche i vincitori di due tra gli ultimi premi Pulitzer, Marilynne Robinson e Paul Harding, e uno dei più grandi autori di racconti contemporanei, Tobias Wolff, caposcuola minimalista e cattedratico di scrittura creativa proprio a Stanford. Si tratta di una squadra estremamente composita, e l’influsso degli autori richiamati sulla scrittura e sulle tematiche di Torres appare fortemente disomogeneo. Certamente, Noi, gli animali ha un debito scoperto con la narrativa di Dorothy Allison (i racconti di Trash, meritoriamente tradotti, alcuni anni or sono, dalle edizioni Il dito e la luna, ma soprattutto la superba epopea di Bastard Out of Carolina, ancora inedito in Italia) per la furia travolgente con cui viene esplorato il misto inestricabile di amore e violenza alla radice dei rapporti famigliari, e con l’opera di Tobias Wolff, per la ricerca di una scrittura tersa ed essenziale, suggestiva ben più che esplicita. E forse, un debito più indiretto ma non meno pregnante è quello contratto con Paul Harding, per il fraseggio quasi musicale della prosa. Un fraseggio che trova la sua misura più piena e felice nella prima parte del romanzo, dove la coralità della prima persona plurale fa da cifra e contraltare all’unità quasi animalesca del nucleo famigliare: un’unità che assorbe e neutralizza lo squallore di vite sempre precarie e segnate dalla violenza. Un fraseggio che si perde e si spezza, paradossalmente, negli ultimi capitoli, quando la scoperta dell’(omo)sessualità da parte del protagonista, il più piccolo dei tre fratelli, rompe il legame primordiale su cui la famiglia ha costruito la sua linea di galleggiamento, e segna le premesse di un confronto con il mondo esterno non più eludibile. Con la separazione dei tre fratelli, il ritmo che scandiva il racconto non ha più ragione di esistere, e gli subentra una scrittura impreziosita, carica di metafore, quasi raffreddata. Noi, gli animali ci consegna, in estrema sintesi, due autori distinti: il primo, capace di aderire alla materia del racconto con un livello di visceralità che ha pochi eguali nel romanzo americano contemporaneo; il secondo, che sa prodursi in esercizi di stile eleganti, ma sempre leggermente fuori fuoco. Non resta allora, di fronte a questo che rimane uno degli esordi più convincenti degli ultimi anni, che attendere Torres alla prova dell’opera seconda, nella speranza di vederlo ritrovare la fisicità e la potenza che risuona nelle pagine migliori di questo piccolo, grande romanzo. Il romanzo, gioco di verità sulla vita - Daniele Balicco Nonostante l’agonia a cui è stata forzatamente condannata la ricerca umanistica italiana, mai come in questi ultimi anni il lavoro dei suoi migliori studiosi è riuscito a riscuotere un successo e un riconoscimento internazionali. Nella teoria anglosassone da un po’ di tempo, ormai, si discute una costellazione di autori nostrani eterogenei (Agamben, Bodei, Braidotti, Cavarero, Esposito, Negri, Tronti, Virno) alcuni di loro più o meno impropriamente raggruppati sotto un’unica etichetta: Italian Theory. Mentre una grande audience internazionale è stata data al nuovo realismo proposto dal libro di Ferraris, di cui si è parlato anche su queste pagine. Due sono le matrici con cui è stata costruita, ex post e fuori dai confini nazionali, la corrente di pensiero dell’Italian Theory. Con la prima si lavora a una filosofia della vita capace di radicalizzare alcune categorie dell’ultima grande tradizione francese; con la seconda si esercita invece una critica del potere, per lo più di derivazione operaista, orientata a valorizzare la potenza dell’insubordinazione e della resistenza. Potrebbe non essere del tutto capzioso discutere a fondo le ragioni, anche improprie, del successo d’esportazione di questo sofisticato made in Italy teorico. Intanto, però, leggere un saggio davvero monumentale come Teoria del romanzo di Guido Mazzoni (Il Mulino, pp. 412, € 28) può aiutare a comprendere meglio soprattutto i punti di forza di questa nuova atmosfera teorica. Su tutti, Pasquali e Garin. Tanto per cominciare, il volume di Mazzoni è un saggio di filosofia del romanzo. Il titolo richiama l’omonimo studio di Lukács, pubblicato a Berlino nel 1916. È un richiamo senza dubbio ambizioso, ma il libro, che è frutto di un lavoro di ricerca durato oltre quindici anni, regge pienamente alla sfida. In Mazzoni, infatti, il rigore della tradizione storica italiana corregge, e potenzia al massimo, la vivacità teorica francese e anglosassone in un programma di lavoro serio e persuasivo. Categorie altrove disincarnate qui camminano su gambe solide. Per di più Teoria del romanzo bandisce tanto lo stile intimidatorio dei nostri cugini francesi, quanto la semplicità divulgativa senza cuore, e un po’ metallica, anglosassone. La scrittura è nitida, precisa, razionale. Più che alla saggistica italiana, lo stile del libro fa pensare ai grandi maestri della nostra tradizione scientifica: su tutti, Pasquali e Garin. Delle due matrici teoriche dell’Italian Theory, è la prima, la filosofia della vita, il nucleo forte che sorregge, come un architrave, l’intera costruzione del libro. Non a caso, infatti, il saggio si apre e, dopo oltre quattrocento pagine, si chiude, con la stessa citazione: «nulla è importante se non la vita». Tratta da un articolo di D.H. Lawrence, scritto nel 1925 e intitolato Why the Novel Matters, questa frase è la vera stella polare attorno alla quale ruota e si orienta ogni pagina del libro. Ma altrettanto decisive, citate dallo stesso brano di Lawrence, sono le parole che seguono: «Nulla è importante se non la vita. Per questa ragione sono un romanziere. Ed essendo un romanziere, mi considero superiore al santo, allo scienziato, al filosofo e al poeta – che sono tutti grandi esperti di parti diverse dell’uomo vivente, ma che non colgono mai l’intero». Dunque, il romanzo e la vita. Il romanzo come genere letterario che più di qualsiasi altro genere sa narrare seriamente la vita delle persone comuni, nella sua oggettiva e idiosincratica particolarità – unico genere esclusa la lirica moderna, a cui per altro Mazzoni ha dedicato il suo precedente e gemello lavoro teorico (Sulla poesia moderna, Il Mulino, 2005); il romanzo come gioco di verità che più di ogni altro sa incorporare la totalità della vita, esprimendola nella sua forma. Due forze plasmanti. Come si vede, la prima ipotesi pone problemi di storia e di teoria della letteratura; la seconda, di estetica e di ontologia. Teoria del romanzo discute il significato antropologico di una metamorfosi interna al campo della letteratura occidentale. Il romanzo è il genere che può raccontare «qualsiasi cosa in qualsiasi modo». A lungo, però, l’arte non ha potuto raccontare «qualsiasi cosa in qualsiasi modo». Per quali ragioni? E soprattutto: quale forma di vita è implicitamente inscritta in questa possibilità estetica che solo la modernità rende pienamente operativa? Mazzoni descrive con precisione le due forze che hanno plasmato nel profondo, almeno fino al Settecento, le strutture di senso occidentali: il platonismo cristiano e la poetica classicistica della divisione degli stili. Se il primo impone ciò che è lecito narrare, la seconda impone come, ciò che può essere narrato, deve essere tradotto in una forma. Il libro segue la lenta emersione del romanzo contro l’operare di questa potente macchina di selezione e di censura del narrabile. In un primo tempo, l’eterodossia del genere agisce come formazione di compromesso. In un orizzonte ancora dominato da veti morali e interdizioni estetiche, la scrittura romanzesca inizia, quasi di nascosto, a mettere a fuoco alcune tecniche di rappresentazione della vita, che il romanzo realista ottocentesco, e poi modernista, porterà a perfezione. Mazzoni discute criticamente la tradizione interpretativa che riconosce solo all’Inghilterra, e alla sua nascente borghesia, l’habitat privilegiato di questa maturazione estetica. Se è innegabile, infatti, che la cultura britannica, più empirica e meno condizionata dal classicismo europeo, ha saputo inventare un vocabolario dell’estroflessione come conoscenza della vita del mondo esterno all’Io, non può essere tuttavia dimenticato che va cercata nella Francia della società di corte l’origine di quel vocabolario dell’introspezione egocentrica, senza il quale la scrittura romanzesca saprebbe raccontare l’eterogeneità, ma non l’idiosincrasia. Del resto, solo quando queste due grandi tradizioni nazionali si intersecano, il romanzo conquista l’egemonia sugli altri generi letterari, diventando la forma capace di raccontare, seriamente, la vita invisibile dell’Io e quella che agisce, all’esterno, nel Mondo. Tre soglie storiche. Arrivati a questo punto, il libro disegna tre soglie storiche fondamentali: 1800, il 1850 e il 1940. Semplificando al massimo, secondo Mazzoni, la generazione di Balzac, di Scott e di Manzoni è quella che costruisce la grande narrazione ottocentesca della vita, che è, per lo più, teatrale e melodrammatica. Superata la soglia del 1850, questo modello inizia a complicarsi. Con Flaubert e George Eliot, con Henri James e Tolstoj, resiste l’impalcatura esterna del romanzo realista. Ma iniziano ad essere sperimentate tecniche di rappresentazione della vita che il modernismo (Proust, Woolf, Musil, Broch, Joyce) potenzierà al massimo. Queste nuove tecniche sono particolarmente importanti perché strutturano un’idea dell’accadere dispersivo ad intensità intermittente ed un’idea della vita interna dei singoli personaggi come campo di forze in conflitto, che corrisponde, più di ogni altra, alla forma di vita a cui ancora apparteniamo. Superato il 1940, il romanzo diventa mondiale; si susseguono e si sovrappongono ovunque sperimentazioni, correnti, mode. E tuttavia, secondo Mazzoni, nessuna di queste avrà la forza grammaticalizzante delle forme del narrare nate all’interno delle prime due soglie. A quel bacino di temi e di tecniche, di mondi e di modelli formali, la vita moderna ancora oggi attinge quando vuole capire qualcosa di se stessa. È difficile non pensarlo. Teoria del romanzo diventerà molto presto uno dei lavori teorici imprescindibili della nuova Italian Theory. Il problema è che un libro importante come questo sembra quasi fatalmente destinato, come il Chianti o il nostro migliore design, a diventare solo un ottimo prodotto di esportazione, se non verrà rapidamente invertita la rotta che sta distruggendo la possibilità stessa di fare ricerca umanistica in Italia. Su Primo Levi. Cavaglion cerca le sue passioni letterarie, Bartezzaghi vi legge il gusto per i palindromi - Niccolò Scaffai Quali sono stati, e quali sono adesso, i lettori di Primo Levi? Gli specialisti (e dei migliori, da Cesare Segre e Pier Vincenzo Mengaldo a Marco Belpoliti, Domenico Scarpa e Sergio Luzzatto) e gli studenti; i lettori forti e quelli occasionali. A quante generazioni appartengono? In senso lato, almeno a tre: quella di chi c’era e ha visto, o ha saputo poco tempo dopo; quella dei figli, nati mentre Levi era ad Auschwitz o negli anni immediatamente successivi; quella dei nipoti, che andavano ancora a scuola o all’università quando Levi è morto. Perché, e in che modo, le tre generazioni hanno letto Se questo è un uomo? Per i primi, è stato il libro «fatale» (così si espresse Umberto Saba, in una lettera all’autore), il libro necessario che qualcuno doveva scrivere. Per i secondi, Levi ha incarnato la testimonianza, fino ad assumere – certo anche suo malgrado – il ruolo di patrono laico nella religione della memoria. Per gli ultimi, per quelli che appartengono grosso modo alla mia generazione, Primo Levi e le sue opere hanno rappresentato anche qualcosa di diverso: la Storia e la Scrittura, unite dal filo sottile ma resistente di una morale implicita, che la scuola e l’università italiane hanno a lungo trasmesso. Leggere Primo Levi, cioè, serviva a imparare quello che era successo e ad assimilare l’economica efficacia, l’altissimo decoro stilistico con cui tutto ciò veniva raccontato. Il massimo risultato con il minimo ingombro. Quanto riduttiva possa essere quest’idea igienica della scrittura di Levi, l’hanno mostrato gli studi linguistici di Mengaldo e di altri. Ma il punto non è questo; il punto forse è che, pur cambiando le età e le esperienze dei lettori, è rimasta costante un’idea: che Levi sia più un mezzo per accedere al valore – la coscienza storica, la competenza stilistica o entrambe – che non un valore in sé. Che la prima edizione einaudiana di Se questo è un uomo abbia visto la luce in una collana di saggistica e non di narrativa; che le storie della letteratura novecentesca abbiano stentato a dare all’opera una collocazione plausibile, assimilandola con deboli motivazioni perfino al neorealismo; che Levi sia stato uno scrittore a lungo più amato dai critici-filologi che non dai critici-teorici, sono tutte circostanze legate a questa visione strumentale. Alla generazione successiva alla nostra, quella che si sta formando adesso e che legge per la prima volta Se questo è un uomo a venticinque anni dalla morte del suo autore, resta da scoprire Levi come fine. Intendiamoci: le implicazioni storiche e stilistiche restano valide tanto sul piano etico-culturale quanto su quello didattico. Quello che ancora mancava, però, era un modo per far capire ai nuovi lettori – e a moltissimi tra i vecchi – che Levi è anche uno scrittore da scoprire in sé e per sé, comunicando loro in forma accessibile i risultati già raggiunti dai critici di professione. Risultati felici, per lo più, confermati ultimamente dall’uscita, tra gli altri, di un denso profilo di Levi scritto da Enrico Mattioda (ed. Salerno, 2011) e dall’attività del Centro Internazionale di Studi Primo Levi (www.primolevi.it), che promuove le Lezioni annuali pubblicate nella collana einaudiana in cui hanno visto la luce i volumi di Robert S. C. Gordon (“Sfacciata fortuna”. La Shoah e il caso, 2010), Massimo Bucciantini (Esperimento Auschwitz, 2011) e Stefano Bartezzaghi (Una telefonata con Primo Levi, 2012). A far da tramite tra gli specialisti e gli altri lettori c’è ora l’edizione commentata da Alberto Cavaglion di Se questo è un uomo (Einaudi, pp. 261, € 20,00; il volume amplia e aggiorna la versione uscita alcuni anni fa nei Cd-Rom della Letteratura Italiana Einaudi), che non si è limitato allo spoglio della bibliografia e alla trasmissione dei dati acquisiti, ma ha arricchito il suo lavoro con molte proposte e agnizioni di prima mano. È un commento ricco quello di Cavaglion (seguito dagli indici, a cura di Daniela Muraca), in cui le note, più interpretative che esplicative, tendono a espandersi in piccoli saggi o in voci di una «enciclopedia leviana». La sintesi e la selezione del dato intertestuale in base al grado di pertinenza e probabilità – l’etichetta del corretto commentatore – vengono a volte accantonate a vantaggio della digressione (penso alla lunga nota sul canto di Ulisse, quello che Primo si sforza di ricordare e tradurre per spiegarlo a Pikolo). Era un rischio, è un rischio, perché il commento può finire per emanciparsi dal testo e sopravanzarlo. Ma forse non c’era altro modo per attrarre il lettore nella rete di un interprete tanto colto quanto empatico nei confronti del libro e del suo autore. Né c’era altra via per assecondare l’idea-guida che ha ispirato la stesura del commento e che lo stesso Cavaglion spiega nella sua Presentazione: il «fascino di Se questo è un uomo ci appare oggi nella sua inattualità, ovvero nella possibilità che ci offre di riscoprire una passione letteraria inaspettata nella persona che lo scrisse». Questa «inattualità» è quella che allontana la fonte di luce puntata sul contemporaneo, lasciando che il raggio si allarghi anche alle zone rimaste finora in ombra. Nel caso di Levi, la minor concentrazione del fascio luminoso puntato sul messaggio permette di rischiarare meglio il mittente: cioè l’autore stesso, con la sua cultura, con la sua «passione letteraria inaspettata». Una passione di cui il commentatore riconosce i segni più ostinati nelle parole e nelle frasi di Levi, dove si depositano le reminiscenze di buone letture scolastiche. Non c’è solo Dante, infatti, nella memoria letteraria di Levi: ci sono anche Tucidide, Galileo (lo ha mostrato Bucciantini), Manzoni, Baudelaire. Il ruolo degli ultimi due quali possibili «fonti» di Levi è una proposta originale di Cavaglion, che convince a patto di distinguere tra la citazione (tali sono gli echi di Dante o di Lorenzo de’ Medici in Se questo è un uomo) e la cultura pratica, che agisce sullo scrittore senza che da parte sua vi sia una specifica intenzione o coscienza (su questo versante, direi, sta soprattutto il Manzoni di Levi). Nuova luce su Levi arriva anche dal volume di Stefano Bartezzaghi, Una telefonata con Primo Levi / A phone conversation with Primo Levi, trad. inglese di Jonathan Hunt (Einaudi, pp. 195, € 16,00). Bartezzaghi ci restituisce un’immagine insolita dello scrittore, facendone affiorare un’altra passione, quella per i palindromi, per le scritture combinatorie di cui si trova traccia per esempio nei racconti. Passione condivisa con un altro dilettante geniale, Giampaolo Dossena, e con scrittori come Calvino e Queneau, che Bartezzaghi fa reagire con Levi. Il palindromo leviano più celebre, tratto dal racconto Calore vorticoso, è addirittura bilingue: «In arts it is repose to life: è il filo teso per siti strani». Bartezzaghi tiene un capo di quel filo e lo tende, mostrando come per Levi la scrittura stessa sia un grande palindromo, capace di invertire il senso del tempo tra il presente e la storia. Attraverso quel filo, le voci del passato e dell’esperienza ci raggiungono; purché il messaggio sia chiaro, purché chi sta all’altro capo sia messo in grado di ascoltare. «Chi non viene capito da nessuno – si legge in Dello scrivere oscuro – non trasmette nulla». Una saga familiare di sapore fiabesco - Giulio Ferroni Il libro di Carmine Abate, La collina del vento (Mondadori, pp. 260, €17,50) può far pensare ad altre recenti saghe familiari, come quelle di Antonio Pennacchi (Canale Mussolini) o di Aurelio Picca (Se la fortuna è nostra), o alla storia di un piccolo paese immaginario come quella di Sebastiano Vassalli (Le due chiese). In effetti si tratta della storia di una famiglia contadina, gli Arcuri, entro la storia di un piccolo paese dal nome immaginario, Spillace, ma collocato entro una ben identificata zona della Calabria ionica, davanti a Punta Alice, tra Cirò e Cirò Marina, dall’inizio del secolo fino a un tempo non direttamente identificato, ma abbastanza vicino a oggi. Le vicende non si presentano però secondo un filo lineare, ma sono progressivamente ricostruite attraverso un punto di vista presente, quello del narratore, che ormai ha abbandonato la Calabria e vive nel Trentino, e viene lì a Spillace a trovare il padre Michelangelo, che in un’ansia di continuità familiare e di «verità» ripercorre le varie vicende, che sembrano prendere avvio da un oscuro episodio datosi all’inizio del secolo (una cosa vista dal nonno Arturo bambino) restato a lungo come un «segreto» nella vita familiare e di cui si arriverà a conoscere, appunto, la «verità », solo verso la fine, dalle parole di Michelangelo (e l’ansia della verità viene chiamata in causa fin da una citazione da Canetti, posta in epigrafe del libro). La storia della famiglia e del paese è anche una storia di lavoro, del modo in cui generazioni di contadini lottano per rendere sempre più fertile e produttiva una terra che sentono come parte di sé, una storia di resistenza alle violenze che la grande storia carica su di essi (le guerre mondiali, il fascismo), una storia di opposizione ai prepotenti che agiscono più da vicino – come un barone locale, che diventa podestà durante il fascismo e fa di tutto per impossessarsi della terra degli Arcuri), una storia che segue le trasformazioni di quel mondo e del suo orizzonte sociale e ambientale nel dopoguerra (con l’occupazione delle terre, le lotte contadine, l’esito della riforma agraria) e nei decenni a noi più vicini (con il vario business controllato dalla criminalità, dalle dissennate costruzioni di villaggi turistici all’altrettanto folle invasione delle pale eoliche). E nello stesso tempo è la storia di un legame fortissimo con un luogo, la «collina del vento» che dà titolo al libro, il Rossarco, esposta ai venti e aperta verso il mare, carica di colori e di profumi, di suggestioni e di segreti in cui la vita degli Arcuri riconosce e identifica se stessa, afferma il proprio essere più. Ma sull’orizzonte di questa vita contadina si sovrappone la traccia del lontanissimo passato storico della Magna Grecia: e sul romanzo contadino (che a tratti potrebbe far pensare a una coniugazione neorealistica) si proietta una sorta di romanzo «archeologico»: tutto ha origine dall’incontro, nella primavera del 1915, poco prima dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale, sulla collina del Rossarco, tra Alberto Arcuri (il padre di Arturo e dei suoi due fratelli che moriranno in guerra) l’archeologo trentino Paolo Orsi, che in quella zona cerca le rovine dell’antica Krimisa e del tempio di Apollo Aleo: si tratta di un personaggio reale, che per Carmine Abate costituisce così un punto di raccordo tra la sua Calabria e il Trentino (dove vive, come il suo narratore), e di cui ha potuto consultare vari documenti nella Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto. Negli anni ’20 Orsi ha effettivamente compiuto importanti ricerche e ritrovamenti nella zona di Punta Alice: il romanzo colloca sulla immaginaria collina del Rossarco i dati relativi a queste ricerche archeologiche, e fa affacciare a un certo punto la figura di un altro importante archeologo e meridionalista, Umberto Zanotti-Bianco. Tutto ruota così intorno a quella collina: la storia del mondo contadino calabrese del Novecento, nella sua distanza e nella sua intimità con quell’antico mondo cancellato e sepolto; il ritmo rovinoso del tempo che porta via le vite e le generazioni; la passione per i luoghi, per una natura resistente a tutte le lacerazioni, il cui rigoglio, i cui colori e profumi imperiosi, i cui frutti esuberanti sono come nutriti da ciò che essa nasconde nelle sue viscere. In questo orizzonte trovano poi spazio le vite e le passioni individuali, le occasioni di confronto che portano quel mondo ad uscire fuori di sé, a incontrare punti di vista diversi (Michelangelo Arcuri diventa maestro elementare e sposa un’archeologa torinese, la sorella emigra in Inghilterra e diventa pittrice, lo stesso narratore, come si è detto, vive nel Trentino con moglie tedesca, ecc.). Il libro intreccia variamente tutte queste prospettive, con momenti di narrazione tenuti sempre sul filo di una delicata misura, di una sorta di rispetto per lo scorrere della vita, per la consistenza degli esseri umani e per la concreta evidenza dell’ambiente e della fisicità. La continuità delle cose e delle presenze amate si vela spesso di inquietudine e di mistero: nella solitudine della campagna i personaggi possono avere la sensazione di essere seguiti da presenze reali o immaginarie. E c’è una figura simbolica che sembra costituire una sorta di emblema familiare e che si affaccia due volte, all’inizio e alla fine del racconto: si tratta di una «rondine albina» (che Abate garantisce sia effettivamente ritrovata da un suo parente). E in effetti dati simbolici e suggestione dei luoghi, segreti sepolti nella terra e ricerca di «verità » archeologiche e di «verità» su vicende familiari, con tutti i momenti della vita individuale e collettiva di cui si è detto, finiscono per dare all’intero libro e alla saga degli Arcuri qualcosa di fiabesco: la collina del vento, pur nei vari riferimenti alla realtà di oggi (che in alcuni casi, come per i richiami all’imprenditoria criminalizzante che vorrebbe impiantare pale eoliche, avrebbero potuto trovare uno sviluppo maggiore) si delinea alla fine come una sorta di luogo magico, che in sé concilia presente e passato, ultimo residuo di una forse non più possibile felicità. Note ascetiche di Carlo Bo - Massimo Raffaeli In uno dei testi della piena maturità, L’ospite ingrato primo e secondo, Franco Fortini lascia a futura memoria quello che forse è l’epigramma più conciso ed efferato della letteratura italiana: CARLO BO. No. Non deve tuttavia stupire che a Palazzo Passionei di Urbino, dimora quattrocentesca in faccia alla chiesa di San Bernardino che oggi ospita la «Fondazione Carlo e Marise Bo» nonché l’immensa biblioteca del Magnifico Rettore che fu virtualmente l’ultimo dei Montefeltro, si trovi conservata una copia di Sere in Valdossola con una dedica nient’affatto encomiastica e però di segno opposto: «Al Carlo Bo di oggi/ dal Fortini di allora». A leggerli insieme e in retrospettiva, l’epigramma nega recisamente ciò che la dedica riafferma con enfasi, o viceversa, perché il primo intende cancellare il segno di una eredità che la seconda è costretta comunque a riconoscere: tale ambivalenza di Fortini, si potrebbe qui aggiungere, ha segnato in Italia non meno di tre generazioni di scrittori. Per tutti costoro, Carlo Bo ha rappresentato in emblema la dinamica che segna nel profondo la parola del Novecento, vale a dire la contraddizione, che in effetti è un’antitesi, fra lo splendore intransitivo delle forme e i richiami ex abrupto di una realtà storico-sociale incandescente, vorticosa, più spesso eccedente il dominio delle forme medesime. Pochi alla pari di Bo hanno goduto di una specola così ampia, da cui controllava l’intero invaso delle letterature neolatine, non esclusi i modernissimi come il suo amico Paul Eluard o Federico Garcìa Lorca, da lui tradotto in anni impossibili; nessuno ha potuto e saputo parlare da un pulpito così alto e aggettante (prima le riviste di punta dell’ermetismo fiorentino poi nel dopoguerra i grandi giornali, La Stampa e Il Corriere della Sera, per tacere lo scranno di senatore a vita) tanto che al suo amico Gianfranco Contini venne in mente una volta l’immagine dell’Innominato assiso sullo sprone urbinate e cioè il profilo di una figura incombente ma che sempre adombrava il distacco e persino lo sdegno intellettuale. Decenni di attività amministrativa e politica, da democratico cristiano e da cattolico in odore di modernismo, migliaia di interventi e di pagine occasionali dentro una attività così frenetica da sembrare negli ultimi anni ubiquitaria, non debbono oscurare il fatto che Bo è il firmatario di un libro cruciale come Otto studi, dove compare il saggio Letteratura come vita, specchio ustorio della sua generazione e incipit di una bibliografia che annovera, fra i titoli più memorabili, Della lettura e altri saggi e L’eredità di Leopardi, entrambi accessibili fino a non molto tempo fa nella monumentale Letteratura come vita. Antologia critica edita da Rizzoli nel ’94 a cura di Sergio Pautasso con una introduzione di Jean Starobinski che, a proposito della critica di Bo, parla di un «diario personale (intimo e non) che rimane sempre aperto (…) come se nei suoi saggi egli mettesse contemporaneamente alla prova se stesso e i libri letti». Un diarista che rigetta tanto la metafisica del testo e la dittatura dei significanti quanto le sirene di un engagement che non sia testimonianza etica e coinvolgimento fino alla più riposta fibra di sé: è clamoroso, per uno della sua generazione, che si sia sottratto al magistero di Croce, lo è molto meno se si pensa che i suoi primi e mai sconfessati maestri di esistenzialismo cristiano furono invece Jacques Rivière, Charles Du Bos, Georges Bernanos e su tutti André Gide, specialmente il diarista che gli ricordava, nel contenzioso quotidiano e implacabile, l’amatissimo Renato Serra. E che la forma-diario gli fosse pienamente consona lo conferma la attuale riproposta del Diario aperto e chiuso 1932-1944 (con una nota di Katia Migliori, Quattro Venti, pp. 341, € 34.00), ristampa in anastatica del libro uscito nelle Edizioni di Uomo che reca nel colophon la data del 3 agosto 1945. Si tratta, alla sua tipica maniera, di un palinsesto dove confluiscono annotazioni quotidiane, abbozzi di articoli e di saggi in via di redazione, minute di lettere, nei modi di uno zibaldone itinerante che duplica, scrive nella nota Katia Migliori, «il calendario, custode ispiratore». Prima che taciuta, la realtà degli eventi esterni è abolita: la dittatura fascista non vi è mai nominata, anzi è deliberatamente tenuta al di fuori della pagina, la quale registra semmai anonimi e sinistri rimbombi, ovvero si imbeve del colore livido e tetro che sembra arrivare dai suoi margini. A tale riguardo, si è detto tante volte di un arroccamento da parte sua, di un antifascismo solamente virtuale, insomma di una ascesi che equivale a una fuga oppure a una sublimazione. È vero anche questo ma resta il fatto che l’ascesi di Bo (quel suo leggere inseguendo un rovello morale, quel suo intendere la pagina altrui evadendo ogni mediazione linguisticostilistica, infine quel suo nudo corpo a corpo con la letteratura) rimanda a una religio diversa, a un vincolo che rovescia il presupposto stesso del Decadentismo per cui l’estetica riassorbe l’etica e di fatto la rende inessenziale: infatti Letteratura come vita, vero segnavia di questo Diario, non è altro se non una eversione del motto dannunziano che vorrebbe celebrare la cosiddetta «vita inimitabile». È stato anche ripetuto, in proposito, che Bo è il teorico dell’ermetismo in quanto è l’autore della monografia su Mallarmé che fu suo livre de chevet negli anni neri della guerra (come ha ricordato Luca Pietromarchi in una bellissima relazione al recente convegno urbinate Dal progetto di lettura di Carlo Bo alla lettura nell’era digitale i cui Atti, editi dalla «Fondazione Bo», sono di prossima uscita a cura di Marta Bruscia): ciò è vero se si guarda al compagno di via di Mario Luzi, di Alfonso Gatto o del primo Quasimodo, ma il Diario documenta come nella cerchia fiorentina il poeta più suo, per il senso di pietas e l’afflato francescano, fosse invece Carlo Betocchi, il cui titolo d’esordio, Realtà vince il sogno, non potrebbe essere più esatto. Peraltro basta aprire il Diario emettere a confronto due necrologi scritti quasi in contemporanea: nell’uno, datato «marzo 1938», la morte di D’Annunzio gli detta un’ambigua e imprevista euforia «per quell’uomo che poteva averci disgustato in diverse maniere e che a volte ci era sembrato a dirittura un pagliaccio ma proprio adesso ci trovavamo davanti un’opera immensa, quasi nuova»; triste paradosso di cui proprio non necessita l’altro, datato «febbraio 1939» e scritto per Antonio Machado, morto da profugo antifranchista in un campo di prigionia francese: «In questo tempo precipitato in cui sembra che tutti i giuochi stiano per essere fatti ci basta un libretto misero e perduto per riportarci di fronte a noi stessi, per opporre la nostra non-presenza al chiasso e alla menzogna che ci assediano». La modesta copertina delle Soledades come vessillo silenzioso, privatissimo antidoto al secolo totalitario: è probabile che Carlo Bo, nel prosieguo di una vita in pubblico e nei mille interventi della sua militanza longeva, abbia più volte guardato con rimpianto o con senso di colpa a quel simbolo stento di humanitas e di perfetta dignità. È altrettanto probabile che Franco Fortini paventasse i postumi di una antica complicità nel momento in cui scagliava con violenza il suo No definitivo. La felicità elettrica dei Sessanta - Riccardo Venturi Dicembre 1913, quasi un secolo fa, alle soglie del primo conflitto mondiale. Malevic concepisce la scenografia e i costumi de La Vittoria sul Sole, uno spettacolo presentato – e puntualmente fischiato – al teatro Luna-Park di Pietroburgo. Durante il secondo atto lo sfondo viene occupato da un quadrato diviso diagonalmente in due triangoli, uno bianco e uno nero. Si tratta di una scena urbana: solo in uno scenario metropolitano, habitat dell’uomo moderno con le fabbriche e i palazzi di vetro e acciaio, è concepibile una vittoria su questo residuo naturale che è il sole. Sulla scena, le finestre dei palazzi si affacciano verso l’interno «come tubi forati», perché in questo mondo, che oggi ci appare distopico più che trasognato, le finestre hanno perso il ruolo di filtrare la luce esterna. Forato è anche il linguaggio in zaum di Khlebnikov e Kruchenykh, sgrammaticato, privo di logica, risolto sul piano fonetico. Per le stesse ragioni, i quadri non sono più ritagli sulla realtà concepiti sul modello della finestra albertiana ma superfici intransitive, ottuse, che non rimandano ad altro che a loro stesse. Sebbene d’ispirazione cubo-futurista, Malevic retrodaterà a questo momento la nascita del suprematismo e del monocromo nero. Che questo sia o meno il primo nella storia dell’arte contemporanea poco importa; interessante è che uno dei momenti liricamente più alti dell’astrazione storica sia legato alla detronizzazione del sole, al tentativo di oscurarlo, di preparargli il funerale; che le due azioni siano in qualche modo connesse, l’eclissi come tabula rasa necessaria per azzerare le forme della tradizione artistica. Questa titanica quanto eccentrica eliomachia si colora ovviamente di un portato simbolico: la vittoria sul sole è una vittoria sul passato, in particolare sul retaggio simbolista dell’Ottocento, così come sulla razionalità e sull’universo euclideo con le sue anguste coordinate spazio-temporali in cui l’uomo era costretto a vivere. 2012: cento anni dopo, c’è tempo fino al 27 maggio per visitare Arte programmata e cinetica Da Munari a Biasi a Colombo e…, la mostra curata da Giovanni Granzotto e Mariastella Margozzi alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Si tratta di uno dei periodi artistici più sperimentali e felici dal punto di vista dell’apporto italiano. Per chi non ha vissuto gli anni sessanta, è facile confondersi tra questi artisti dalle formazioni più varie, dalla comunicazione visiva al disegno industriale, dall’architettura alla filosofia, dalla poesia visiva alla musica sperimentale, dalla fotografia alla fenomenologia della percezione e alla psicologia della forma. Artisti che, una volta trascorsa la fase propriamente cinetica, si volgono alla scenografia, alle opere ambientali, persino alla moda. È facile confondersi tra le sigle e i gruppi, con i loro attriti, le loro divergenze e defezioni: il Gruppo N (Biasi, Chigio, Costa, Landi, Massironi) che nasce a Padova nel 1959; il Gruppo T (Colombo, Anceschi, Boriani, De Vecchi, Varisco), Milano 1959; il Gruppo Uno (Biggi, Carrino, Frascà, Pace, Santoro, Uncini), Roma 1962; il Gruppo 63 (Di Luciano, Drei, Guerrieri, Pizzo), Roma 1963; il Gruppo MID, Mutamento Immagine Dimensione (Barrese, Grassi, Laminarca, Marangoni), 1964. Senza dimenticare gli antecedenti, tra cui si distingue la figura di Bruno Munari, di cui ogni opera potrebbe inaugurare una nuova genealogia artistica: la serie Negativo-positivo, in versione bi- e tri-dimensionale (1956), Scultura da viaggio (1958), Tetracono (1964), Polariscop (1966). Ancora, le figure non legate a movimenti come Getulio Alviani ed Enzo Mari, per finire col contributo straniero del gruppo Zero tedesco (1958) e del GRAV francese (1960). Tanti nomi ma nessun proclama esplicito contro il sole. Eppure molte di queste opere mi sembrano continuare quella disperata lotta avanguardistica, con altri mezzi e senza il fervore rivoluzionario e messianico di un Malevic. L’accecamento del sole coincide con la fabbricazione di un sole artificiale, elettrico, di un’opera capace di emanare luce, d’illuminare lo spazio circostante, non più soggetta alle condizioni climatiche esterne che segnano le condizioni della sua visibilità. Coincide con la costruzione di ambienti immersivi e interattivi, come le camere stroboscopiche di Davide Boriani o quelli programmati e sonorizzati del Gruppo MID. Secondo la prospettiva classica della storia dell’arte (penso in particolare a Hans Sedlmayr), la modernità è segnata dal passaggio dalla luce trascendentale e metafisica alla luce fisica, dalla natura sacra alla natura profana della luce in quanto mero fenomeno naturale e fisico. La situazione è più complessa, come dimostrano alcuni eventi espositivi di questi ultimi anni, dalla mostra-catalogo Light Art from Artificial Light. Light as a Medium in 20th and 21th Century Art (ZKM di Karlsruhe, 2005) fino alla recente Néon. Who’s afraid of red, yellow and blue? (appena conclusa alla Maison Rouge di Parigi e presto al Macro di Roma). Lo dimostra anche la parabola di Dan Flavin – che preferiva Tatlin a Malevic –, quando abbandona il seminario per intraprendere una carriera artistica, tenendo però a modello l’icona della scuola di Novgorod conservata al Metropolitan di New York. Del resto già nel 1962 realizza Icon V (Coran’s Broadway), una tela monocroma con delle lampadine fissate sui quattro bordi della tela, che fanno pensare alle candele elettriche degli altari delle chiese. Flavin era rimasto segnato dalle processioni cattoliche cui partecipava sin da piccolo, affascinato, oltre che dalla musica e dall’incenso, proprio dalla luce delle candele. E la sua carriera si concluse coerentemente con la commissione per Santa Maria in Chiesa Rossa a Milano, un lavoro che non vedrà mai realizzato. Non serve insomma ripercorrere la storia della luce – dal Pantheon alle sculture ready-made di neon di Dan Flavin – per rendersi conto che la vittoria sul sole non ha esitato a servirsi, in campo artistico, dei mezzi più disparati, non sempre adeguatamente, come dire, messi in luce dalla critica. Rispetto all’arte programmata e cinetica, c’è un lavoro enorme da fare, se si considera che, ancora oggi, viene compresa con gli stessi strumenti storiografici degli anni sessanta, strumenti che oggi, anziché essere d’aiuto, sono d’impaccio. La mostra romana costituisce così un’ottima occasione per ripulirsi la vista e lasciarsi inondare dalle opere, per seguire poi diverse linee di fuga, ad esempio l’emergenza di nuove forme di soggettività alternative all’individualismo dell’atto di creazione, che passavano a volte per la logica matematica, altre per la militanza politica (come in Julio Le Parc). Un discorso a parte meriterebbe infine il movimento. Da una parte questo è percettivo, ovvero è una sensazione ottico-dinamica, una vibrazione, una rifrazione, una deformazione generate dalla posizione dello spettatore in movimento che si sposta da destra a sinistra, arretra e si avvicina alla parete dove è esposta l’opera. Dall’altra parte il movimento è letterale, indotto agli elementi dell’opera attraverso degli elettromotori, che producono un ronzio distinto, vera e propria colonna sonora della mostra. Ho l’impressione che queste ultime appaiono oggi più datate, o perlomeno invecchiate più velocemente, rispetto alle prime, un po’ come i Mobiles motorizzati di Calder. Forse sono influenzato dalla confidenza di un amico pittore, secondo cui non c’è dubbio che il dinamismo è dalla parte dei quadrati di Mondrian e non delle sculture di Calder: «sì, Dan Flavin è affascinante», dice, «ma quando stacchi la presa il gioco è finito». È un po’ come New York, la cui bellezza dipende dalle miriadi di luci elettriche, al punto che con il black out il fascino della città svanisce. Ma allora perché tutti questi sforzi per vincere il sole? La Stampa – 20.5.12 Non ti vergogni più come una volta - Giorgio Boatti Per afferrare davvero le complesse geometrie della vergogna bisognerebbe forse rinunciare alle parole. Si dovrebbe ricorrere piuttosto al lampo delle immagini. Alla persistenza dei ricordi. O a una cartografia delle emozioni capace di dare sintesi visiva a un paesaggio esperienziale - il sentimento della vergogna - dove prima o poi transitiamo tutti, viandanti smarriti tra i movimenti sussultori dell'interiorità e la perentoria orografia di una socialità che su questo tema detta legge, segnalando i crinali non superabili e i varchi consentiti per riemergere. Ma per rinascere occorre passare attraverso questo desolato terreno in cui - come scrive Gabriella Turnaturi nel suo denso saggio Vergogna. Metamorfosi di un'emozione - la vergogna, urticante sentinella, «sta a guardia dei confini tra lecito e illecito, tra buono e cattivo, tra trasgressione e conformità». Certo, sia nel linguaggio privato sia in quello pubblico, non mancano le espressioni - «Uno spettacolo vergognoso!», «Che vergogna!», «Mi vergogno di te!» - che allertano quando il confine viene varcato e le regole infrante. Tuttavia, sostiene la Turnaturi nella prima parte del suo saggio, queste esclamazioni oggigiorno risuonano sempre meno e con sempre minore efficacia. I tempi cambiano e anche la vergogna non è più quella di una volta. Se non l'avessimo capito basterebbe sfogliare le pagine dei giornali di questi giorni per incontrare facce di bronzo reduci da vertiginose malversazioni ai danni della collettività, o signorine dall'incerto curriculum professionale beneficate da prestigiose ascese: anziché sottrarsi allo sguardo della collettività, si offrono spavaldamente all'occhio delle telecamere. Respingono ogni valutazione negativa, qualsiasi sanzione sociale o morale nei loro confronti. La metamorfosi della vergogna deve aver compiuto un bel lungo cammino se ormai, a coloro che si indignano, gli impuniti, in schiere sempre più folte, replicano con un perentorio «E perché mai dovremmo vergognarci?». Nella bussola dei comportamenti umani la vergogna un tempo aveva un tetto: abitava dirimpetto a dove stavano decenza, pudore, onore. Ma se i punti cardinali si mescolano, e i riferimenti si fanno sempre più relativi, anche la vergogna si trasforma. Diventa un confuso laboratorio del fai-da-te. In tempi recenti - spiega la Turnaturi attingendo anche a rimandi letterari, da J. M. Coetzee a Kurt Vonnegut, da Philip Roth a Salman Rushdie - a contare sempre di più nel funzionamento individuale della «fabbrica della vergogna» non sono i riflessi di stima e disistima che conseguono a un'azione, ma, visto che si è entrati nella società dello spettacolo, la capacità di stare efficacemente alla ribalta. La prestazione che ci viene chiesta si sottrae al senso complessivo della vita, alle categorie del lecito e dell'illecito, del giusto e dell'ingiusto, confluisce in uno scenario dove conta l'abilità di comporre e scomporre la propria vita come fosse un Lego intercambiabile. Su questa ribalta non c'è scacco, malvagità, oscenità, tradimento, di cui ci si debba vergognare. In questo mondo dove impera la cultura del «problem solving» - che disseziona per segmenti sostituibili e riparabili l'apporto di ciascuno al mondo circostante e persino la relazione con sé stessi - si può inciampare al massimo in una prestazione scadente. Nulla di preoccupante: in una realtà costituita da regole e comportamenti autoreferenziali basterà un «sorry», possibilmente pronunciato con studiato e autentico coinvolgimento, per guadagnarsi un nuovo ruolo, una successiva replica. Questa parte iniziale del saggio, assieme a quella conclusiva «sul buon uso della vergogna» (memore della marxiana affermazione secondo la quale «la vergogna è già una rivoluzione») si china sui tempi relativamente brevi del presente, analizzando dunque anche i variegati risvolti dell'indignazione sociale. Questa, a differenza della vergogna, è «una passione riformista», una reazione costruttiva all'ingiustizia e mira al riconoscimento della dignità di ciascuno. Ma è nella parte centrale del saggio, dedicata al rapporto tra potere e vergogna e tra vergogna individuale e collettiva, che la complessità dell'architettura della vergogna viene collocata dalla Turnaturi in tutte le sue diramazioni. La vergogna sarà anche una sentinella, ma il mondo al quale fa la guardia ha i confini che si spostano: sia dentro sia fuori di noi. E questo rende tutto complicato: a partire dalle vergogne collettive. Lo storico Carlo Ginzburg, ad esempio, in un recente saggio, riferendosi alla stagione del bunga-bunga che ha ferito l'immagine italiana nel mondo, afferma di aver realizzato in questa occasione «che il paese cui si appartiene non è, come usualmente si crede, quello che si ama ma quello di cui ci si vergogna. La vergogna può essere un legame più forte dell'amore». Simenon, Vichy sotto la maschera – Giovanna Zucconi Mentre Adelphi, mannaggia, pubblica «l'ultimo Maigret», il biografo di Simenon e gran cronista letterario Pierre Assouline rilancia e insieme rintuzza, su Le Monde, l'ultima polemica su Maigret. Che, a dire la verità, non è tale, essendo già stato ripetutamente sminuzzato, in passato, il tema del presunto collaborazionismo del commissario. Maigret, c'est la France: e quindi sarebbe a favore di Vichy. Fra i colpevolisti c'è anche Corrado Augias, che una decina di anni fa così spiegava la mancata caratterizzazione politica del personaggio: «Un uomo come lui, in un paese come la Francia (o l'Italia) non può non avere una riconoscibilità politica. Credo di sapere da che parte Maigret si sarebbe per esempio schierato durante la Resistenza e l'occupazione nazista? Simenon questo non ha potuto dircelo perché scriverlo lo avrebbe costretto a fare i conti non tanto con il personaggio ma con il suo ambiguo passato. Un narratore del suo tipo, che su di sé ha detto e ridetto forse più di quanto avrebbe dovuto, questo tipo di conti non poteva permettersi di farli», e l'allusione è forse al salvacondotto che Simenon (non Maigret) fornì durante la seconda guerra al fratello Christian, collaborazionista. Ora invece l'accusa proviene dal dotto sociologo Luc Boltanski, il quale in Enigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes analizza l'epoca di fine Ottocento nella quale sono nati contemporaneamente il romanzo giallo, la sociologia e il complottismo: nella quale, cioè, è cambiata l'investigazione sul potere. Analizzando soprattutto Maigret et son mort, del 1947, Boltanski sostiene che il «vichismo» di Maigret esiste ma è bonario e modesto come tutto in lui: non ideologico, semmai questione di temperamento. Però la sua bonomia popolaresca non sarebbe altro che una maschera per ingraziarsi i lettori di sinistra, mentre in sostanza il personaggio è paternalistico, autoritario, con qualche striatura di xenofobia e di antisemitismo. Che anche Boltanski veda dietrologie e complotti ovunque? Maigret commenterebbe forse con il motto che compare negli ex libris di Simenon: «Comprendere e non giudicare».
Scarica