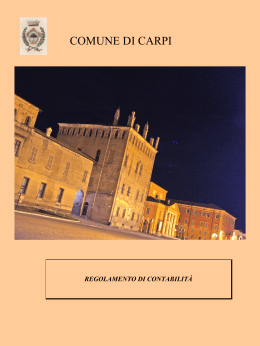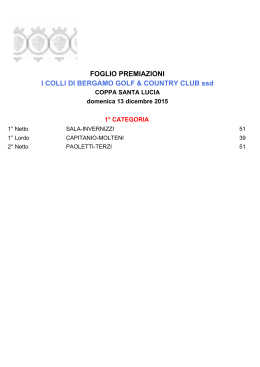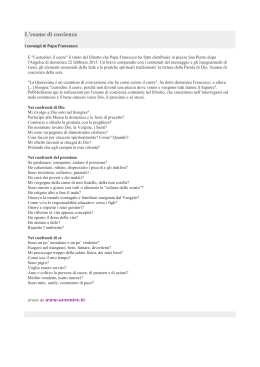Domenica La DOMENICA 24 GENNAIO 2010 di Repubblica l’attualità Coppa Davis, sangue blu e business GIANNI CLERICI e ADRIANO PANATTA cultura Il Piemonte nudo di Josef Koudelka CARLO PETRINI PRIMO LEVI “Io, vivo per miracolo” Alla vigilia del Giorno della Memoria, FOTO ARCHIVIO PRIVATO DI GIULIA COLOMBO DIENA in una lettera inedita dello scrittore lo stupore di essersi “salvato” PRIMO LEVI B spettacoli TAHAR BEN JELLOUN KATTOWICE 6 giugno 1945 ianca carissima, finalmente mi si presenta un’occasione di comunicare con l’Italia con una certa garanzia di arrivo a destinazione. Io non accompagno il latore della presente che viaggia con mezzi suoi solo perché le finanze non me lo permettono, ed inoltre perché il giorno del rimpatrio collettivo sembra prossimo. Come i pochi compagni italiani superstiti, io sono vivo per miracolo. Al momento in cui i tedeschi hanno abbandonato l’Alta Slesia, io ero convalescente di scarlattina nell’Ospedale di Monivitz con altri ottocento malati; pare che i tedeschi avessero ordine di ucciderci (come fecero altrove in altre circostanze) e forse non ne ebbero il tempo. Sono riuscito a sfamarmi alla meglio, per dieci giorni sfuggendo a un tremendo bombardamento, poi il 27 gennaio, sono arrivati i russi. Dopo parecchi pellegrinaggi, sono finito qui, in un campo cosiddetto “di attesa”. Effettivamente, tutti gli stranieri che hanno soggiornato qui sono stati smistati verso le relative patrie, solo gli italiani attendono ancora. Di coloro che partirono con me da Fossoli siamo ora qui in sei. (segue nelle pagine successive) C CARPI (Modena) arpi, una delle più graziose cittadine dell’Italia settentrionale, cinquantotto chilometri da Bologna, non va confusa con Capri. Un gruppo di turisti americani vi si è ritrovato qualche mese fa, e si è chiesto per quale motivo il mare non si vedesse. Carpi ha sessantamila abitanti, più di diecimila dei quali immigrati in buona parte da Pakistan, Marocco e Cina e al lavoro nei campi e nell’industria dell’abbigliamento. È una cittadina tranquilla che va fiera della propria piazza, la più grande in Europa: si chiama piazza dei Martiri in memoria di sedici partigiani, i cui cadaveri furono esposti per tre giorni dai soldati fascisti nell’agosto 1944. Carpi, da sempre di sinistra, conserva una buona qualità della vita. Ma questa città che a fine Ottocento contava oltre cinquemila ebrei oggi se ne ritrova soltanto sette, un numero insufficiente per aprire una sinagoga. Gli ebrei di Carpi erano andati incontro a persecuzioni tra il 1290 e il 1294, ma soltanto nel 1719 il ghetto fu chiuso e ricevettero l’autorizzazione a costruirsi un luogo di culto. (segue nelle pagine successive) con un servizio di MASSIMO NOVELLI Carlo Verdone, trent’anni di cinema CURZIO MALTESE i sapori Frutta & alcol, convergenze parallele GIAN LUCA FAVETTO e LICIA GRANELLO le tendenze Passerella addio, la moda è di tutte LAURA ASNAGHI e IRENE MARIA SCALISE l’incontro Carmen Consoli, musica da non sprecare GINO CASTALDO Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GENNAIO 2010 la copertina Lettera di un salvato Il 6 giugno 1945 l’autore di “Se questo è un uomo” è appena stato liberato e per la prima volta scrive all’amica Bianca Guidetti Serra dell’arrivo dei russi, del tatuaggio al braccio, “segno di infamia per chi ora dovrà espiare”, ma soprattutto chiede notizie sulla sorte degli altri compagni. Ecco il documento inedito in occasione di una grande mostra a Torino Primo Levi: “Cara, sono vivo” PRIMO LEVI (segue dalla copertina) egli inabili al lavoro (donne, vecchi, bambini) non abbiamo che pochissime notizie, risulta purtroppo certo che Vanda Maestro è morta. Luciana Nissim partì in settembre per Breslavia: forse si è salvata. Di noi 95 del campo di Monivitz, 75 sono morti colà di fame e di malattia; quattordici furono deportati dai tedeschi in fuga (fra questi Alberto della Volta di Brescia, Franco Sacerdoti di Torino, l’ing. Aldo Levi di Milano, Eugenio Gluecksmann di Milano). Di loro non si hanno notizie sicure, ma corrono voci assai preoccupanti sulla loro sorte. Restiamo noi sei. Qui non si sta male. Si mangia in abbondanza (ma la cucina russa richiede stomaci appositi) si dorme bene, non si lavora, si gode una certa libertà, per cui con un po’ di iniziativa si può circolare, pagarsi il lusso di qualche alimento extra, di qualche cinematografo, o almeno qualche visita economica turistica alla città. Siamo ora più di mille italiani, fra prigionieri di guerra, politici e “rastrellati”. La popolazione è molto benevola, i russi anche. Non credere a quanto ho potuto scrivere da Monovitz; l’anno passato sotto le SS è stato spa- D ventosamente duro a causa della fame, del freddo, delle percosse, del pericolo costante di essere eliminato in quanto inabile al lavoro. Porterò (spero) in Italia il numero di matricola tatuato sul braccio sinistro, documento di infamia non per noi, ma per coloro che ora cominciano ad espiare. Ma la maggior parte dei miei compagni portano nelle carni più gravi segni delle sofferenze patite. Spero di poter salire presto la tradotta: ad ogni modo tieni presente che il servizio postale non è ancora regolare e ti sarei gratissimo se tu cercassi di affidare ad un polacco o un russo rimpatriante anche sommarie notizie delle mie carissime e di Voi tutti. Con l’incarico una volta giunto in Polonia di scriverle indirizzando a Primo Levi, presso il Comitato Ebraico di qui. CENTRANLY KOMITET ZYDOW POLSKICH — KATOWICE ULICA MARIAWKA 21. Viviamo qui con l’ansia terribile di qualche vuoto al nostro ritorno: se fossimo rassicurati su questo, non ci sarebbe grave l’attesa. Ti prego tenta tutte le vie: Croce Rossa, Svizzera, i partiti: pensate alla nostra tremenda incertezza Il mio cuore è con Voi. (Torino, Archivio Ebraico “B. e A. Terracini”, Delegazione per l’assistenza agli emigranti ebrei (Delasem), Privati, enti diversi. Fascicoli nominativi (L) 1945-1946, n. 82 sottofascicolo 62) © RIPRODUZIONE RISERVATA FOTO DI GRUPPO FOTO ARCHIVIO PRIVATO DI GIULIA COLOMBO DIENA Primo Levi (nel tondo) con Carla Consonni, un amico sconosciuto, Anna Maria Levi, Laura Jona e dietro Silvio Ortona e Giulia Colombo a Saccarello nel ’43 La fame e le ricette del lager MASSIMO NOVELLI lla sera, al rientro in baracca accucciate nei letti a castello, s’incominciava a parlare di minestre e pietanze; di tante minestre da sentirne il profumo e di tante pietanze da sentirne il sapore e parlando si scrivevano ricette sui ritagli bianchi dei giornali». Campo di concentramento di Ravensbrück, sottocampo di Rechlin, novanta chilometri a nord di Berlino. Qui, tra il settembre del 1944 e l’8 maggio del ’45, quando verranno liberate dall’Armata Rossa, le sorelle Maria Camilla e Maria Alessandra Pallavicino di Ceva e di Priola, giovani nobildonne piemontesi, vivono l’inferno del lager. Arrestate nell’aprile del ’44 dai tedeschi a Nucetto, vicino a Ceva, nella loro casa di villeggiatura, con l’accusa di avere collaborato con la Resistenza e aiutato il fratello partigiano, sono deportate in Germania. «A Ravensbrück, il Ponte dei Corvi, a Maria Camilla, ventunenne, appare «come un enorme paese di baracche di legno dipinte di verde scuro», con le strade «coperte di carbonina». Il «tutto lugubre, ma davanti ai blocchi principali non mancano i fiorellini molto ben curati». Negli ultimi mesi, dopo le evacuazioni dei lager polacchi, «i forni cominciarono a funzionare notte e giorno». Bisogna sopravvivere, soprattutto alla denutrizione. È in quei mesi trascorsi nei block che Maria Camilla e le compagne provano a dimenticare per un po’ la fame che le lacera. Lo fanno parlando di «meravigliose pietanze» e discutendone l’esecuzione fino anche «a litigare per le divergenze di come avrebbero dovuto essere preparate». Giorni e notti senza fine, una babele di lingue — polacco, russo, ceco, slovacco, ungherese, francese, italiano — che vuo- Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GENNAIO 2010 O DA C RONAC HE NO D DI MILA I EUGE NIO GE NTILI TE DESCH I ORIGINALE A sinistra, un disegno di Primo Levi e la lettera inedita di Levi a Bianca Guidetti Serra; nell’altra pagina in basso, il ricettario originale di Maria Camilla e Maria Alessandra Pallavicino Ritorno a Fossoli stazione per l’inferno TAHAR BEN JELLOUN (segue dalla copertina) iò non rese loro in ogni caso la vita facile. Se ne andarono: nel 1898 a Carpi erano rimasti non più di trenta ebrei, e ciò portò alla chiusura della sinagoga nel 1922. Quando nel 1938 furono promulgate le leggi razziali — sulla falsariga delle leggi tedesche del 1935 — gli ebrei italiani furono presi apertamente di mira. Formavano l’élite intellettuale, appartenevamo alla borghesia o a una classe media molto agiata. Per loro quelle leggi furono veramente inimmaginabili. Non pensavano affatto che un giorno sarebbero stati discriminati nel loro stesso Paese, scacciati dalle scuole, esclusi dai mezzi pubblici, umiliati pubblicamente dai fascisti. Attesero il peggio e il peggio arrivò. Il premio Nobel per la medicina del 1986 Rita Levi Montalcini, oggi centenaria, nel 1938 era scappata in Belgio. Il governo di Mussolini aprì alcuni campi di concentramento per ammassarvi l’opposizione politica da una parte e gli ebrei dall’altra. Ciò accadde proprio nei dintorni di Carpi, per la precisione a Fossoli, in aperta campagna. Agli ebrei furono destinate otto baracche, nelle quali furono rinchiuse intere famiglie. In ogni camerata c’erano tra le centocinquanta e le centosessanta persone. Le condizioni di detenzione erano «più o meno corrette» — raccontano oggi alcuni dei sopravvissuti —, soprattutto se paragonate a quelle che avrebbero vissuto a Auschwitz o a Bergen-Belsen, dove il novantadue per cento dei prigionieri fu sterminato dai nazisti. Gli oppositori politici furono spediti a Mauthausen, in Austria. Primo Levi fu arrestato per motivi politici il 13 dicembre 1943 in Val d’Aosta, ma nel suo interrogatorio confessò di essere anche ebreo. Fu spedito immediatamente nel campo di Fossoli dove rimase un mese nelle baracche riservate agli ebrei, per la precisione nella sesta. Poi, il 22 febbraio 1944, fu deportato ad Auschwitz. Nel suo libro Se questo è un uomo parla poco di Fossoli: «Ci caricarono sui torpedoni, e ci portarono alla stazione di Carpi. Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi e la cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore, nel corpo né nell’anima. Soltanto uno stupore profondo: come si può percuotere un uomo senza collera?». La discrezione e il coraggio di Levi furono notati dai suoi compatrioti, come testimoniamo alcuni sopravvissuti. Egli aveva assistito all’esecuzione di donne incinte e di anziani, perché in attesa della morte in ogni caso certa non erano risultati adatti a lavorare nei campi. Quell’uomo ferito così profondamente si convinse che le parole non potessero bastare a reggere il peso di una simile tragedia. Il 12 luglio 1944 i nazisti uccisero nel campo di Fossoli settanta antifascisti, i cui nomi sono scritti sulle pareti del museo di Carpi. Il campo di Fossoli è diventato oggi un luogo della memoria. È visitato dalle scolaresche (fino a quarantamila studenti ogni anno), da stranieri, da storici, dai familiari di chi vi perse la vita. Una mostra permanente ricorda che cosa fu quel luogo, cosa fu quell’epoca. È interessante vedere il primo numero della rivista fascista La difesa della razza, datato agosto 1938, un mese prima che entrassero in vigore le leggi razziali. Foto, testimonianze, disegni, modellini, tutto ciò che serve a rendere l’idea di quello che accadde in quegli anni disgraziati è lì esposto. La sinagoga principale, situata all’angolo tra la piazza dei Martiri e via Giulio Rovighi, è vuota. Funge da ufficio per la Fondazione dell’ex-campo di Fossoli. Più lontano, il museo della memoria è situato di fronte alla più vecchia chiesa di Carpi, Santa Maria del Castello detta la Sagra. Sulle sue pareti sono incisi migliaia di nomi. Vi sono delle voci registrate, dei disegni su pietra, uno dei quali di Picasso, e un muro dipinto da Guttuso in ricordo delle Fosse Ardeatine, l’esecuzione di 335 civili nella rappresaglia per l’attentato del 23 marzo 1944 a Roma nel quale erano stati uccisi trentatré tedeschi. Le pareti del museo sono interamente ricoperte di brani di lettere scritte dai deportati: «Le porte si aprono… ed ecco i nostri assassini. Sono vestiti di nero. Le loro mani sporche indossano guanti bianchi» (Esther); «Io muoio, ma vivrò» (Alekscin); «Se tu avessi visto, come io ho visto in questa prigione, ciò che fanno patire agli ebrei, rimpiangeresti di non averne salvati in numero maggiore» (Odoardo); «Sono fiero di meritare questa pena» (Pierre); «Che cosa può fare un uomo che si trova in prigione e che è minacciato di morte sicura? Eppure mi temono» (Sawa); «La mia bocca vi porterà sulle labbra mute» (Emile). E così Carpi mantiene viva la memoria delle vittime del fascismo e del nazismo. I suoi abitanti amano altresì ricordare che è una regione ricca, che non ha mai votato a destra e che coltiva le sue tradizioni culinarie, famose per il parmigiano e l’aceto balsamico. C’è un centro culturale molto attivo, e ogni anno si organizza un grande festival letterario, la Festa del racconto. Alcuni ricordano con umorismo che i genitori dell’attore americano Ernest Borgnine sono di Carpi. Dicono: «Carpi ha regalato al cinema il più celebre interprete di ruoli secondari, spesso cattivo e crudele. Ma Ernesto Bordino (il suo vero nome) è un uomo così affascinante!». Traduzione di Anna Bissanti C FOTO ARCHIVIO FONDAZIONE FOSSOLI N DISEG LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 LA MOSTRA Dal 27 gennaio al 20 marzo 2010 all’Archivio di Stato di Torino, in via Piave 21, la mostra A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947, prodotta dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e promossa dal Museo diffuso della Resistenza di Torino Un percorso interattivo e multimediale, che attraverso un gruppo di giovani amici, tra cui Primo Levi, racconta le vicende degli ebrei torinesi La mostra è nata dagli studi di Alessandra Chiappano, che ne è la curatrice, sull’archivio privato di Luciana Nissim Momigliano e su altri documenti inediti (www.iltempoinsorte.it) FOTO A le allontanare la morte. «La nostra fantasia lavorava, immaginando l’impasto del burro con la farina e le uova, se ne sentiva quasi il sapore. Forse questo rendeva ancora più triste il nostro destino di affamate croniche, ma era una cosa più forte di noi e non la si poteva controllare». Le ricette vengono scritte su pezzi di carta trovati qua e là, nascosti alle ispezioni. Anche Maria Camilla le copia: «In minutissima calligrafia c’è la cucina di gran parte d’Europa. Si trovava sempre un’interprete gentile che traduceva le ricette come quella per confezionare il dolce di Pasqua russo. Tra noi italiane avevamo discusso dell’enorme difficoltà che avremmo incontrato a casa per trovare la panna acida o altri ingredienti strani per le pietanze ungheresi e polacche; più il piatto era difficile e più ci aveva interessate». RCHIV IO DI A LBER MIGLI TO MO Il ricettario la seguì nel lungo viaggio di ritorno: «Non abbandono certo questo libretto, conservato con grandi fatiche e sotterfugi». Ritrovato nella casa di Nucetto, viene proposto in versione anastatica (su cd) nel libro che raccoglie le memorie dell’ex matricola numero 49569, morta nel 1989. Curato da Elisa Mora, Non perdere la speranza. La storia di due sorelle in Lager è pubblicato dalle Edizioni dell’Orso, nella collana Quaderni della Memoria diretta da Mariarosa Masoero e da Lucio Monaco. Da tempo si sapeva dell’esistenza di quaderni del genere. Ma finora, come sottolinea la professoressa Masoero, «non ne erano mai stati scoperti». È dunque «un documento eccezionale; una testimonianza, tipicamente femminile, di resistenza. Ed è un atto di fiducia nel futuro». © RIPRODUZIONE RISERVATA ANO D ONATO A ISTO RETO PRIGIONE In alto, Luciana Nissim, una cartolina che spedì dal campo di Fossoli e un’immagine del campo di prigionia In copertina, Primo Levi il giorno della laurea nel ’41 © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA l’attualità Sport e costume DOMENICA 24 GENNAIO 2010 Centodieci anni fa, all’esordio del Novecento, nasceva il prestigioso torneo di tennis per squadre nazionali La sua storia ci accompagna dai “gesti bianchi” dei gentlemen pionieri al circo tv degli atleti muscolari e sponsorizzati. E adesso c’è chi propone di rivoluzionare il trofeo in nome del box office I MOSCHETTIERI FRANCESI Da sinistra, Cochet, Brugnon, Muhr, Lacoste e Borotra nel 1923; Panatta e Bertolucci nel 1976 in Cile; a destra, la foto della prima edizione con Whitman, Davis e Word Sangue blu e business la parabola della Davis GIANNI CLERICI os’è la Davis Cup? Fisicamente una coppa di sei chili e centocinquanta grammi d’argento, commissionata da Dwight Filley Davis, studente ad Harvard (Boston) ai gioiellieri Shreve Crump and Lowe, disegnata da Rowland Rose e realizzata dai cesellatori William Morton e Warren Peckman. Com’è nata? In seguito a un viaggio in California, compiuto dallo stesso Davis in compagnia di Beals Wright, Malcolm Whitman e Holcombe Ward, i campioni della costa atlantica, nell’intento di meglio conoscere, o addirittura affratellare, i club di tennis americani. Da quell’iniziale proposito, in seguito ad una conversazione con il dottor James Dwight, padre della patria tennistica, il giovane Davis trasse l’audacia per immaginare un C match con la Gran Bretagna, il paese che gli anglosassoni, ignari delle origini rinascimentali, ritenevano avesse inventato il tennis: soprattutto grazie ad un copyright depositato a Londra dal maggiore Walter Clopton Wingfield nel 1874. In seguito al suggerimento del giovane Davis, James Dwight, allora presidente della Federazione americana, inviò ai parigrado britannici una lettera che ebbi occasione di leggere, nel cottage di Dwight jr: «La Lawn Tennis Association pensa che sia desiderabile, nell’interesse del gioco, organizzare un match tra il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America». Erano talmente compresi dalla loro presunta invenzione, e insieme intrisi del loro complesso di superiorità, i britanni, che impiegarono tre anni per accettare con degnazione l’invito americano. E non inviarono nemmeno al Longwood Tennis Club di Boston i loro migliori giocatori, i primi campioni della storia, i Fratelli Laurie e Reggy Doherty. I presuntuosi furono giustamente puniti, con un netto tre a zero, che avrebbe potuto addirittura tramutarsi in umiliante cinque a zero, non fosse giunto un temporale ad interrompere la terza giornata. Gli inglesi non affrontarono nemmeno la traversata l’anno seguente, e si sarebbe dovuto attendere la riluttante adesione dei Fratelli Doherty perché portassero la Coppa a Londra, nel 1903. Di lì sarebbe iniziata una storia squisitamente anglosassone, in pratica limitata agli inglesi, agli americani e ad un paese inesistente, Dopo la Grande guerra si affacciò a sorpresa anche il Giappone, in finale nel ’21 denominato Australasia, un team composto dall’australiano sir Norman Brookes e dal neozelandese e grandissimo Tony Wilding, che tennero la Coppa dal 1909 al 1911. Ad imitazione della Americas Cup di vela, e forse di un suggerimento esoterico rintracciabile ne Il ramo d’orodi Frazer, la struttura della Davis prevedeva che il detentore non partecipasse alle eliminatorie dell’anno seguente, ma attendesse in casa la sfida (challenge) del vincitore di una prima fase, chiamata All Comers. A rendere la Coppa un tantino meno anglosassone si sarebbero via via inseriti i più ricchi e sportivi tra i paesi europei, e la Germania sarebbe giunta a minacciare gli australiani, in semifinale, proprio alla vigilia della guerra ’15-18. Terminata quella strage, che rapì tra gli altri il grandissimo Wilding, vincitore di ben quattro Wimbledon, giunsero ad affacciarsi molti paesi, tra i quali, sorprendentemente, il Giappone che raggiunse la finale del 1921 contro gli Stati Uniti. Era divenuta di fatto internazionale, la Davis, come ormai la si chiamava succintamente. E finì per uscire dalla gravitazione anglosassone con l’irruzione della Francia, una straordinaria squadra formata dai Quattro Moschettieri, Cochet, Lacoste, Borotra e Brugnon. Capaci, I Moschettieri, di imporsi a Filadelfia, la città natale del grande Big Bill Tilden, considerato sin lì imbattibile. A Parigi, nei sotterranei della Banque Nationale, la Coppa sarebbe rimasta dal ’27 al ’31, sinché un nuovo fenomeno, il professionismo, non fosse giunto a privare, ogni anno, la nazione vincitrice di qualche tennista né nobile né facoltoso, come i campioni d’inizio secolo. Con un ritardo certo comprensibile a chi si occupi di storia, anche i nostri si erano affacciati alla Coppa, nel 1922. Una squadra composta dal genovese Mino Balbi di Robecco e dal milanese Cesare Colombo venne sorteggiata contro un Giap- pone privo del grande Satoh, suicidatosi in mare per depressione tennistica. I giapponesi non affrontarono la traversata, e i nostri si ritrovarono in secondo turno contro gli ingiocabili britanni. L’anno successivo vide l’accesso in squadra di uno dei migliori italiani di tutti i tempi: italiano di passaporto, perché il Barone Uberto de Morpurgo, nato a Trieste, si professava cittadino dell’impero austroungarico, e si rivolgeva in francese al suo partner Gaslini. Questa squadra, confortata dall’altro singolarista De Stefani, primo nella storia a servirsi di due diritti, sarebbe giunta a superare due volte l’Australia, e avrebbe addirittura affrontato gli americani nella semifinale di Parigi, dove si disputava il match di accesso al Challenge Round. Fu, quello del 1930, il nostro maggior successo sino al termine di un’altra guerra mondiale, i cui vincitori non ci consentirono di ritornare in campo sino al 1948, addossando ai tennisti le colpe di Mussolini. Ma, in quegli anni e nei seguenti, una congiuntura tra ex-raccattapalle e signorini impoveriti issò il paese a ruoli di primo piano. Un giovane profugo dalla Tunisia, Nicola Pietrangeli, e un fiumano scacciato da Tito, Orlando Sirola, riuscirono addirittura a battere gli americani, in Australia, e ad accedere alla finale 1960, seguita da un’altra, anch’essa vana contro gli imbattibili aussies, l’anno seguente. I loro nipotini, quattro piccolo borghesi, Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, riuscirono a fare ancor meglio, conquistando ben quattro finali, tutte fuori casa, e la nostra unica vittoria. Fu, quel successo del 1976 a Santiago, complicatissimo per gli scoraggianti dissidi politici del Paese, ancor prima che per la non eccelsa qualità degli avversari. Il Partito comunista si oppose a lungo alla Dc e ai tennisti, il cui capitano, Pietrangeli, si comportò non meno coraggiosamente del numero uno Panatta, che si dichiarò pronto a li- Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GENNAIO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 Quella coppa-mamma raddrizzava le storture di un gioco per uomini soli ADRIANO PANATTA l regalo per la vittoria in Coppa Davis, a Santiago, mille e passa anni fa, fu addirittura doppio, e noi nemmeno ci eravamo abituati. Tre giorni di vacanza a Rio de Janeiro e un orologio. I giorni a Rio servirono a convincerci che nessuna formazione di tennisti italiani, adulti e ben allenati, avrebbe potuto battere una qualsiasi squadra di ragazzini fra i nove e gli undici anni reclutata sulla spiaggia. Ci facevano passare il pallone fra le orecchie… Sull’orologio, invece, sfoggiammo le nostre più recondite manie di grandezza. Scegliemmo, figurarsi, un Rolex d’acciaio, con la scritta Davis 1976 sul retro. La federazione acconsentì, poi ce ne regalò un altro. Il Rolex, dissero, costava troppo. I Ma andava bene così. Appartengo a una delle ultime generazioni di tennisti che ha avuto una Coppa per mamma. E di Coppa, va da sé, ce n’è una sola. La Davis era al centro della preparazione e della programmazione annuale. Coppa, Roma, Parigi, per me. Coppa, Miami e Us Open per un americano… E così via. Poi si giocava ovunque, certo, ma quelli erano gli obiettivi e su quelli si costruiva la carriera. Oggi è diverso, e non vi verrò di certo a dire che sia peggio. È diverso e basta. La Coppa si divide con altre esigenze, sconta quell’individualismo un po’ ottuso che permea i nostri tempi. A noi faceva da contraltare, bilanciava con lo spirito di gruppo le storture di uno sport per uomini soli, ci faceva bene e ci apriva gli occhi. Avvertivamo che fosse giusto tenerla in gran conto, non solo per la bandiera, ma anche per noi stessi. Oggi questo non è venuto meno, ma altre esigenze si sono fatte avanti, prima fra tutte fare cassa. Così, c’è chi vuole cambiarla la vecchia Davis. Un’aggiustatina, certo, le farebbe bene, ma organizzarla come un Mondiale ogni due anni la condurrebbe a morte certa. Questa è l’ultima proposta. Ma mi sono informato, anche fra gli addetti ai lavori ne parlano come della barzelletta di fine anno. Meglio così… La Coppa crea ancora opportunità, e per molti paesi c’è solo quella. Fosse solo per questo, meriterebbe di vivere in eterno. © RIPRODUZIONE RISERVATA ALBUM Da sinistra, in senso orario, la premiazione del 1914; un incontro del ’53; Jack Kramer con i reali inglesi; gli italiani nel ’76; Kramer in famiglia Uberto de Morpurgo, barone, Dopo il match con il rumeno nato a Trieste, si professava Ion Tiriac, l’americano Stan cittadino austroungarico Smith fu ribattezzato “San” berarsi del passaporto italiano. Ma, alla fine, riuscimmo a partire nonostante lo scoraggiante atteggiamento di balilla rossi capaci di invadere gli uffici federali, o del cantautore Modugno, autore dello slogan «Non si giocano volé contro il boia Pinochet». Era, in quegli anni, giunto alla presidenza della Federtennis il romano Luigi Orsini, la cui proposta avrebbe mutato la struttura della Davis. Pareva infatti ingiusto, a Orsini e ai suoi sostenitori, che la squadra detentrice dovesse affrontare un solo incontro, e per di più in casa, contro un avversario che aveva dovuto superare quattro altri paesi. La proposta di Orsini venne approvata e, nel 1972, fummo costretti ad assistere all’aspetto più preoccupante della Coppa, un rigurgito di sciovinismo di un pubblico ineducato al tennis, integrato da giudici di linea capaci di ben sedici chiamate dolose nel match della finale tra il rumeno Ion Tiriac e l’americano Stan Smith, da quel giorno ribattezzato San Smith. Il nuovo formato non si limitò tuttavia all’abolizione del Challenge Round. Dapprima si crearono tre ripartizioni geografiche, America, Europa e Asia, e nel 1981 si procedette all’attuale divisione tra una Serie A di sedici squadre e una B le cui vincitrici si battono con le retrocedende dalla A. Oltre a ciò, una base variamente assortita che ammonta alle attuali centotrenta iscritte. È contro questo aspetto nazionalistico ed elefantiaco, del tutto opposto alla filosofia del gioco più individuale e internazionale, insieme al golf, che sembra apparentemente diretta l’opposizione di Federer e Nadal, e del loro portavoce Djokovic. Rappresentanti, insieme a Ljubicic, di una Associazione (Atp) troppo a lungo maldiretta da dirigenti sciaguratamente eletti e strapagati dagli stessi tennisti. Hanno di recente suggerito, i giocatori, che la obsoleta Davis Cup venga sostituita da una sorta di Campionato mondiale biennale, una competizione da svolgersi in un’unica sede, tra trentadue paesi raggruppati in gironi, con i vincitori destinati a scontri diretti dagli ottavi di finale in poi. Simile semplificazione assumerebbe aspetti innovatori con la possibilità di sostituzioni tipo basket, tempi ridotti tra un punto e l’altro, e tie-break accorciato a cinque punti. Sotto questa nuova pelle giovanile, si celano tuttavia ben altri interessi. Il calendario mondiale, imperniato sulle date in altri tempi accettabili dei quattro Grand Slam (Melbourne, Parigi, Wimbledon, Flushing Meadows), costringe oggi i pur ricchi tennisti ad un minimo di dodici tornei obbligatori, più la finale della Masters per i primi otto. I quattro ipotetici turni di Davis vanno a collocarsi in date disagevoli, prima di Indian Wells (11 marzo), subito dopo Wimbledon (9 luglio), la settimana seguente lo U.S. Open (17 Settembre) e, nell’ultima settimana della stagione subito dopo il Masters (4 Dicembre). Alla indubbia fatica di simili collocazioni, va sommato un probabile mancato guadagno, poiché i compensi sono gestiti dalle Federazioni. È, a mio parere, soprattutto questa la svolta decisiva del problema. Pur avendo perduto il controllo del sindacato giocatori, le Federazioni sono rimaste proprietarie non solo dei quattro più grandi impianti, ma del copyright di Davis. I tennisti spingono per sottrarsi all’obbligo di una gara faticosa e non redditizia. Schierate con loro appaiono le multinazionali produttrici dell’abbigliamento, delle racchette, e di molte implicazioni televisive. Guarda caso, il nuovo direttore Atp, Adam Helfant, era sino a ieri un importante funzionario della Nike. Non si tratta ancora di guerra che, dice il proverbio, è fatta dall’argent, dal denaro. E forse non ci si arriverà, se il bilancio economico pendesse a favore dei tennisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GENNAIO 2010 CULTURA* Il grande fotografo della Primavera di Praga alle prese con i campi, le colline e i resti industriali di una delle regioni più addomesticate dal lavoro dell’uomo Scatti di tristezza o di speranza per il male e il bene fatti alla natura E un messaggio per il figlio nella dedica: “Che ami la sua terra e la rispetti più di quanto non abbiano fatto le generazioni che l’hanno preceduto” TORINO. Lingotto, ex stabilimento Fiat, pista di collaudo Il Piemonte di imbarazza vedere il Piemonte nudo. Non tanto per la nudità in sé, ma perché essa fa sembrare indifesi. Josef Koudelka dedica al Piemonte una raccolta di fotografie (Piemonte, Contrasto, 168 pagine, 82 foto, 45 euro) che spiazzano, perché raccontano di un paesaggio che immaginiamo e crediamo di conoscere bene — montagne, colline, laghi, prati, pianure — ma del quale sottovalutiamo l’antropizzazione. La mano dell’uomo disegna, cura, costruisce, ma spesso sfregia, devasta, ricopre, snatura per sempre. È questa mano comunque pesante, che i piemontesi hanno imposto sulla propria terra, la protagonista di un volume elegante ma essenziale, con ottantadue fotografie di un bianco e nero senza accenti, lancinante per il suo realismo. Koudelka non ha bisogno di presentazioni perché ha fatto la storia della fotografia, a partire dalla sua documentazione della Primavera di Praga, quando le truppe del Patto di Varsavia repressero il riformismo ceco e lui fu in grado di far trapelare il reportage attraverso la Cortina di ferro. Nel suo ultimo periodo, dopo aver collezionato premi di ogni tipo e rango, Koudelka ha focalizzato la sua attenzione sui paesaggi vuoti da uomini in carne ed ossa, ma a ben vedere pregni di presenza umana. Sono indeciso sul fatto se queste foto comunichino più malinconia e tristezza per l’assenza, oppure speranza per una presenza che resiste anche se ingombrante e sregolata. Il Piemonte è nudo perché il paesaggio si fa imbrigliare dalle reti per la raccolta nei frutteti vicino a Saluzzo, perché teli di plastica coprono la terra smossa dai lavori all’Oval di Torino. È nudo nei tubi e nei reticoli che raccontano di tanti lavori di costruzione, momenti di passaggio che svestono la natura per vestirla di ciò che dovrebbe essere cultura. Ma il freddo cementificio ne è l’emblema. Anche di fronte al paesaggio M’ Koudelka Paesaggio nudo con tracce umane CARLO PETRINI TORINO. Piazza Carlo Alberto Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GENNAIO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 IL LIBRO Si intitola Piemonte il libro di Josef Koudelka pubblicato da Contrasto e ora in libreria (con un testo di Giuseppe Culicchia, 168 pagine, 82 foto in bianco e nero, 45 euro). Nato nel 1938 in Cecoslovacchia, Koudelka nel ’68 documenta l’invasione di Praga. Le sue foto passano la frontiera di nascosto e Magnum le distribuisce anonime Verranno pubblicate con il suo nome solo nel 1984 TORINO. Dintorni di Porta Palatina LA MORRA. Vigne e vigneti FOTO DI JOSEF KOUDELKA/MAGNUM/CONTRASTO più idilliaco, al prodigio della natura, si contrappone l’opera dell’uomo: la schiera del pioppeto sullo sfondo di un vecchio e rugoso albero solitario; la diga che imbriglia il torrente appena sceso tra rocce imponenti; quelle stesse rocce tagliate nette, come burro, in una cava. Anche il maestoso Belvedere delle Langhe, a La Morra, ha in primo piano la mappa che aiuta a leggerlo e dare nomi ai paesi. Non credo sia un caso che Koudelka l’abbia ritratto offuscato da nuvole basse, una nebbia che fa perdere l’orientamento tra i colli, che così diventano anonimi e indistinti. Il cedro dell’Annunziata, cartolina perfetta sempre di La Morra, è tra la foschia in fondo: in primo piano una siepe alta e ordinata e la sbarra di un cancello. I luoghi più duri da raggiungere, più apparentemente incontaminati, contengono il bestiame, tracce di trattori, stradine precarie. C’è una continua tensione tra ordine e disordine, tra il tentativo (vano?) di sistemare qualcosa che però già seguiva il suo sistema interiore, il suo perché, da millenni. Tracce della storia, tracce rivolte al futuro. Imbarazza questo sguardo, ma è un voyeurismo su ciò che è stato, che ha un’utilità, una missione, alta o bassa che sia. Il primo impatto è di tristezza, o di rimpianto per ciò che si è perso e rovinato. Poi subentra il compiacimento per la capacità di costruire, di inventare, di caratterizzare, di sforzarsi in una convivenza che vorrebbe essere armonica anche se non sempre ci riesce. Infine emerge il monito, che non è una condanna: possiamo fare del bello e del funzionale, possiamo toccare con la nostra mano, a patto che sia leggera e intelligente. È ciò che dice Koudelka a suo figlio Nicola, che vive e studia a Torino, nelle uniche parole che l’autore riserva per il libro: «Che ami la sua terra e la rispetti più di quanto non abbiano fatto le generazioni che l’hanno preceduto». Ripeto, non è una condanna, perché Koudelka certo non fotografa soltanto il male che l’uomo sa procurare ai suoi luoghi, ma restituisce piuttosto il distaccato racconto di una presenza, che pur ha avuto meriti, compiuto imprese, reso importante una terra. Una presenza di passaggio: «In Piemonte come altrove non interpretiamo altro che la parte degli ospiti», ricorda giustamente Giuseppe Culicchia nello scritto che fa da introduzione al libro. E siamo ospiti in una terra fortunata, perché di confine, e molto diversa al suo interno, dove manca soltanto il mare. Perseverare nell’imparare a rispettarla è il nostro compito, conservarla, celebrarla. Forse presi dal viverla non riusciamo a vedere le cose come Koudelka: se guardiamo il Belvedere quello vediamo, se guardiamo il vecchio albero o il cedro dell’Annunziata non scorgiamo altro. È un po’ il contrario del vecchio adagio: guardiamo la luna e ne restiamo affascinati, ma non vediamo di che pasta è fatto il dito che la indica. Perché quello, forse, potrebbe essere imbarazzante. © RIPRODUZIONE RISERVATA ROBILANTE. Cementificio Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GENNAIO 2010 Nel gennaio 1980 usciva il primo film dell’attore e regista romano. Da quell’opera fino a “Io, loro e Lara”, adesso nelle sale, ha catturato tic, difetti e mutazioni degli italiani in una memorabile galleria di personaggi. Siamo andati a trovarlo per ripercorrere assieme tre decenni: “Gli Ottanta sono stati la fine dell’utopia I Novanta quelli del grande imbroglio. E ora siamo alla resa dei conti” SPETTACOLI Tutto iniziò trent’anni fa con gli schiaffi di Leone CURZIO MALTESE LEO L’ingenuo e goffo ragazzo trasteverino che in Un sacco bello si imbatte nella turista spagnola Marisol ENZO Jeans attillati, camicia aperta sul petto, ciondolo al collo, in Un sacco bello è il coatto in partenza per la Polonia RUGGERO Hippie alla romana, praticante dell’amore libero In Un sacco bello, il padre cerca di riportarlo sulla retta via con Don Alfio DON ALFIO Tenta di convincere l’hippie Ruggero a tornare alla normalità. Ma le sue troppe divagazioni non ottengono il risultato L ROMA a casa di Carlo Verdone è dove te l’immagini, sulla salita per il Gianicolo, con un’imperiale vista su Roma, ma non come l’immagini. «Sembra la casa di un critico rock, vero?», anticipa l’ospite. I ricordi di trent’anni di cinema e sessanta di vita, vissuta da prima e sempre nel mondo del cinema, sono sommersi dal magazzino di cimeli pop, chitarre, bacchette (Verdone è un batterista di valore), album in vinile con dediche degli Who e dei Led Zeppelin, poster di Jimi Hendrix. La raccolta completa dei Walker Brothers, il suo culto personale, una meteora negli anni Sessanta, un trio dallo stile londinese, salvo che non erano di Londra, non erano fratelli e non si chiamano Walker. Ma il più sconvolgente di tutti è appeso alla parete davanti all’ingresso: un quadro cupo e potente. Ed è davvero quello. «È il primo quadro dipinto da Yoko Ono a quarantotto ore dall’assassinio di John Lennon. Sono le parole di Imagine spezzate da nuvole grigie. Ho smosso mezzo mondo per averlo». Ogni generazione conserva nella memoria il suo tragico fermo immagine. Dov’era, cosa faceva quando hanno ucciso i Kennedy o l’11 settembre. Chi è nato nel 1950 come Carlo Verdone non può dimenticare la notizia della morte di Lennon. Tanto più viste le circostanze. «È stato Sergio Leone a darmela. Ero all’ultimo giorno di montaggio di Bianco, rosso e Verdone. Entrò maestoso come sempre e mi disse: “Mi sa che hai perso un idolo”. Rimasi agghiacciato, non so per quanto tempo, a contemplare la fine della mia giovinezza. Poi arrivò Ennio Morricone che voleva festeggiare la fine del film. Mi scattò lui questa foto con Sergio Leone, dove mi sforzo di essere allegro». È paradossale che il magico 1980 di Carlo Verdone, l’anno dell’esordio travolgente con Un sacco bello, sia celebrato nella sua casa soprattutto da quel triste ricordo. «Eppure è andata così. L’inizio dell’avventura nel cinema coincise con la fine di un’avventura ancora più bella, gli anni Sessanta e Settanta. I più belli della storia d’Italia, di sicuro i miei, di quando ero felice e sconosciuto. Gli anni dell’amicizia, delle gite in Vespa alla spiaggia di Anzio, delle sere al cineclub e delle notti poi volate a parlare di Buñuel o De Sica, Fritz Lang e Dreyer, gli anni degli studi al centro sperimentale, della bella politica. In fondo a un’infanzia trascorsa, grazie a mio padre, in mezzo a personaggi straordinari, da Federico Fellini a Pier Paolo Pasolini, passando per Monicelli, Germi, Lattuada e tanti altri. Quel giorno di dicembre del 1980, mentre tutti volevano festeggiare il successo, io avevo capito che quell’epoca era finita per sempre. Massì, sono un malinconico di natura e si vede anche nei miei film più comici. La verità è che non capivo cosa stava accadendo. Fu tutto troppo veloce. Ero uscito dal centro sperimentale deciso a fare il regista di documentari. Una via di mezzo fra le avanguardie underground di Warhol e Julian Beck e il cinema politico. Per passare il tempo e divertire gli amici, ogni tanto facevo qualche spettacolino comico al teatro Alberichino, roba di quaranta posti, scomodi. Ma un giorno sono arrivati Enzo Trapani e Bruno Voglino, un geniale capostruttura Rai, e così mi sono ritrovato a fare il comico a No Stop. In meno di un anno ero sul set, con Sergio Leone, a girare Un sacco bello. Un sogno, una follia». Con Un sacco bello nasce una galleria di personaggi che ci accompagnerà per trent’anni. Un cinema umile, intelligente, generoso che ha raccontato l’Italia reale meglio forse di qualunque altro. Da dove prendeva l’ispirazione? «Mi guardavo intorno e imitavo senza forzature. La realtà era già abbastanza caricaturale. Il mammone che ospita la spagnola era un mio amico del cortile. Il viaggio in Polonia per rimorchiare ragazze l’avevo fatto davvero, a Breslavia, in un ostello della gioventù dove gli unici stranieri erano italiani. Perfino la Fiat Dino nera targata Viterbo era la stessa di un playboy da ostello incontrato laggiù. Quanto alla regia, mi ha insegnato tutto Sergio Leone». Le interviste a Carlo Verdone andrebbero filmate. Uno spettacolo. Si alza, vaga per la stanza, assume la voce e i gesti dei personaggi citati e dopo un po’ sei immerso in una folla. Una delle sue imitazioni formidabili è Sergio Leone. Il primo colloquio fu catastrofico. «Qual è il mio film che ti piace di più?», chiede il maestro. E lui: «Il buono, il brutto e il cattivo». «Sei proprio un burino…». «Leone interpellò mezzo cinema, dalla Wertmüller a Steno, poi decise: “Lo giri tu”. Mi disse di dimenticare quello che avevo imparato al centro sperimentale e di andare ogni giorno a lezione da lui, dalle 10 alle 18. Lo feci per sei mesi. Era durissimo. Mi menò due volte. Uno schiaffo in pieno viso perché non avevo fatto il giro di corsa dell’isolato che mi aveva chiesto per farmi venire l’affanno in una scena. Si era appostato alla finestra per controllare. E poi un calcio violento nel sedere perché avevo rimontato un primo piano secondo lui tagliato male. Ma naturalmente fu anche un maestro formidabile». Un sacco bello diventa un fenomeno d’incassi e di costume. L’avvio di una nuova stagione della commedia. «Allora non me ne resi conto. Pensavo di aver vinto una lotteria e basta. Non andai mai a vederlo in sala, mi vergognavo. Non capivo nemmeno perché la gente ridesse tanto. I grandi sì. Tullio Kezich, Ermanno Olmi, Oreste Del Buono. Beniamino Placido, per esempio, disse: “Ma ti rendi conto che hai fatto una rivoluzione?”». A distanza di tanti anni, se ne rende conto? «Era una miscela giusta, fra qualcosa di riconoscibile e di nuovo. Da una parte il carattere perenne italiano, quello che meglio di tutti ha descritto Ennio Flaiano e che era al centro della commedia all’italiana. Dall’altra i mutamenti antropologici dell’italiano medio al principio degli Ottanta». Il trionfo di Un sacco bello è anche un boomerang. Spiana la strada al successo di una nuova generazione della commedia, da Massimo Troisi a Roberto Benigni a Francesco Nuti. E Verdone finisce un po’ nell’ombra. «Bianco, rosso e Verdone non incassò altrettanto. Se ne andarono tutti, Sergio Leone, la Medusa, rimasi solo. Per un paio di mesi pensai seriamente di rispolverare la laurea e mettermi a fare documentari. Ma un giorno mi MEMORABILIA Il copione aperto sulla prima scena di Un sacco bello; il David di Donatello vinto e la foto di Carlo Verdone con Sergio Leone alla fine delle riprese di Bianco, rosso e Verdone nel 1980 Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GENNAIO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 FURIO PASQUALE MIMMO IVANO Metodico, ansiogeno, esaspera la moglie Magda prima e durante il viaggio in Bianco, rosso e Verdone È l’emigrato in Germania che in Bianco, rosso e Verdone si mette in viaggio verso il paese natale per votare Bambinone inesperto che viaggia con l’anziana e saggia nonna (la Sora Lella) in Bianco, rosso e Verdone “Lo famo strano?” è il suo richiamo d’amore indirizzato a Claudia Gerini in Viaggi di nozze chiamò Mario Cecchi Gori. S’era innamorato di un personaggio del film, l’immigrato che torna in Italia per il voto. Ne uscì Borotalco, il film che ha avuto più riconoscimenti, cinque David, le lodi della critica. Ma per me, soprattutto, l’apprezzamento di mio padre, Mario. Ero passato da virtuosista ad autore, per raccontare un’Italia che stava cambiando, sempre più prigioniera del mito dell’immagine». Torniamo un po’ al rapporto con la sua generazione, Troisi, Benigni, Nanni Moretti. «Stima, am- mirazione, affetto e anche, perché no, un pizzico d’invidia. A me la critica non mi ha mai preso tanto sul serio. Forse c’entra anche la politica. Io non andavo alle feste dell’Unità, non ero considerato uno impegnato, un riferimento. Insomma, a un mio film la stelletta Repubblica non l’ha mai data». Eppure è Verdone a inaugurare la comicità “di sinistra”, un modo di guardare con sarcasmo un po’ moralista e non con compiacimento ai vizi nazionali. L’erede eversore di Alberto Sordi. «Sordi l’ho conosciuto proprio nel momento più difficile, quando mi propose di girare In viaggio con papà. Mi considerava davvero un figlioccio e mi sequestrava per giorni, raccontandomi tutta la sua incredibile vita. Un genio, si capisce. È stato rivoluzionario quando menava le vecchiette e faceva il compagnuccio della parrocchietta. Ma anche un gran reazionario. Un giorno Marcello Veneziani scrisse che era stato il peggior educatore degli italiani. “Ma chi è ’sto comunistaccio?” urlò lui. Quando gli spiegai che veniva dall’Msi, ci rimase malissimo. Anche con lui sbagliai la domanda sul film migliore. Per me era I vitelloni. Sordi protestava che Fellini era un falso mito, un grande imbroglione». Ora Verdone si alza dalla poltrona, dov’era Sordi, e diventa Fellini. «Prima di capire chi fosse, da bambino Fellini era lo zio Federico, il più formidabile narratore di storie di provincia che abbia mai conosciuto». Quanto ha contato quell’infanzia passata all’ombra dei grandi, tutti amici di quella magnifica figura intellettuale che è stata Mario Verdone? «È quello che più manca nell’Italia di oggi. Grandi figure di artisti, sostenuti da una forte visione etica. Perché è l’etica, l’ho imparato da loro, che ti fa guardare avanti. Il berlusconismo c’è già tutto in Ginger e Fred di Fellini, scritto venticinque anni fa. L’Italia televisiva degli anni Ottanta era stata prevista e paventata da Pasolini. Era importante per me, perché il lavoro del comico ha una natura cinica, ti spinge a ridere di qualcosa di cui dovresti vergognarti. I miei amici francesi non capiscono il culto di Alberto Sordi: come fate, dicono, ad amare uno che vi rappresenta come mostri?». Gli chiedo quale di questi decenni è stato il più difficile da raccontare. «Gli Ottanta sono stati la vera svolta, la fine dell’utopia. Borotalco e Compagni di scuola sono i film dove ho cercato di raccontare un’Italia di bugie, cinismo e solitudine. A un tempo edonista e lugubre. Come la politica che ha espresso, nella miseria del rampantismo. In Compagni di scuola c’è per la prima volta un politico, Ghini, che sniffa cocaina in bagno. Ma la figura più patetica e significativa è quella di Christian De Sica, il cantante senza talento e senza successo che supplica una raccomandazione o almeno un prestito. Gli anni Novanta sono quelli del grande imbroglio, degli hedge found. Dei mitomani che diventano leader, come il Gallo Cedrone, che vuole trasformare Roma in una Los Angeles con i lungotevere a sei corsie. Anni fragili, dove tutti vanno in analisi. Questi sono gli anni della resa finale all’assurdo. Ma anche, mi piace pensarlo, della fine del tunnel. Il punto più basso l’abbiamo toccato e non si può che risalire. Sta tornando, in maniera magari caotica, la voglia di partecipare. Quando vedo mio figlio con gli amici a discutere di futuro, quando giro l’Italia per presentare un film e incrocio tante storie straordinarie, dopo tanti anni mi torna un po’ di ottimismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i sapori Armonie di opposti DOMENICA 24 GENNAIO 2010 Dalle antiche ricette da alchimisti che mettevano insieme distillati e bacche ai Bellini, Cosmopolitan e Piñacolada, passando attraverso la tradizione universale dall’acquavite Il binomio tra pere, mele, noci, prugne e alta gradazione accompagna da sempre l’uomo. Come testimonieranno i maestri dell’alambicco il prossimo weekend Sangria Slivovitz Sotto spirito Distillato Frutta, alcol e zucchero sono alla base della bevanda spagnola più festaiola. Oltre al vino rosso (color sangue, sangre in spagnolo), cannella, chiodi di garofano, frutta e, volendo, brandy La tradizionale acquavite serba, sorellina della balcanica rakija e del britannico old plum brandy, è un distillato ricavato dalle prugne Gusto abboccato e robusto, si beve liscio e a temperatura ambiente La golosità della frutta spiritosa ha come base una leggera sbollentatura in acqua. Una volta scolata e messa in vaso, si riempie di metà acqua zuccherata e metà alcol puro. Due mesi di riposo prima del consumo Frutta matura pressata, fermentata grazie ai lieviti e distillata nell’alambicco tradizionale discontinuo Il kirsch (acquavite alla ciliegia) prevede l’utilizzo anche di parte dei noccioli Frutta &alcol Se lo spirito tenta il corpo LICIA GRANELLO l’appuntamento Festa grande a Percoto, Udine, il prossimo fine settimana, in occasione del trentacinquesimo Premio Nonino La famiglia che ha riscattato l’acquavite dai piani bassi della qualità alcolica e introdotto in Italia la cultura dei distillati di frutta, accoglierà un migliaio di ospiti celebrando i premiati, sotto la regia di Ermanno Olmi, con il nuovissimo distillato di frutti e bacche dei boschi di Carnia ssaggio con Angelo Solci il distillato di uva malvasia rosa di Vittorio Capovilla. È sbalordito. Lo vedo impallidire. O vita mia. Sprezza anche lui, come Jacopone da Todi, la vita celeste de l’odorifera rosa?». Luigi Veronelli non era uomo da commenti banali. L’emozione sua e dell’amico Solci — storico enotecaro milanese — davanti al gioiello di uno dei grandi mastri distillatori italiani regala brividi alcolici. Perché magico è l’incontro tra alcol e frutta, purché guidato da mani sapienti. Se è vero che i superalcolici fruttaioli sanno inebriare, la prima corrispondenza di amorosi sensi tra due ingredienti tanto diversi da sembrare inconciliabili si realizza molti gradi più in bas- «A so e attraversa l’intero panorama gastronomico. Da dove cominciare, Bellini o sangria, pere al vino rosso o marroni al rum, fragole&champagne o pesche al rosolio? In realtà, ogni volta che la frutta non basta, quando occorre irrobustire e corroborare, aggiungere personalità e forza, sensualità e trasgressione, l’alcol si presenta come il serpente tentatore. I verbi della contaminazione danno il senso della resa: la frutta viene profumata, macerata, avvolta, immersa, ricoperta, cotta, pressata, disciolta e poi lasciata riposare prima di finire in piattini, tazze e bicchieri. Esistono frutti a cui la manipolazione alcolica regala una passerella altrimenti impraticabile: pere martin sec, graffioni, mele e pere cotogne, a cui aggiungere gran parte della cosiddetta frutta dimenticata (giuggiole, azzeruoli, nespole, corniole, uva spina…). Così, non c’è banco-bar senza ciliegie candite e fettine d’arancia, rondelle di mela e succo di limone. Guai al pasticciere che non tiene a portata di mano kirsch e cointreau o che scorda di battezzare il “monte bianco” con il rum. Quanto agli chef, agrodolci e brasati difficilmente prescindono da frutta (fresca o secca) e alcol. Ma la lavorazione più rigorosa, delicata, speciale, è quella dedicata alla fusione tra alcol puro e frutta, ottenuta grazie alla tecnica della distillazione. Fino a trent’anni fa, i segreti di questa alchimia erano tutti nelle mani di distillatori tedeschi e austriaci, fieri dei loro tipi di acquavite di bacche e frutti di bosco, mentre qui non si andava al di là della grappa. Gli sforzi dei migliori artigiani italiani arrivarono a compimento il 27 novembre 1984 quando, grazie alla pervicacia di Giannola Nonino, un decreto ministeriale sancì l’autorizzazione a produrre acquavite d’uva (che i Nonino chiamarono ÙE, uva in dialetto friulano). Se avete la vocazione dei distillatori, comprate una delle 435mila reticelle di arance rosse che sabato i volontari dell’Associazione per la ricerca sul cancro venderanno nelle piazze. Prendete un vaso dalla bocca larga, sospendete un’arancia a pochi millimetri dalla superficie di mezzo litro d’alcol da dolci e chiudete ermeticamente. Una settimana più tardi, mescolate l’alcol aromatizzato con uno sciroppo di zucchero e godetevi il profumo del sole di Sicilia a piccoli sorsi. Con il resto delle arance, fate spremute per tenere lontana influenza e sensi di colpa. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GENNAIO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 San Vigilio (Bz) itinerari Mattia Pastori, barman dell’Hotel Park Hyatt a due passi dal Duomo di Milano, è fresco vincitore del concorso Wirspa con il cocktail “Carribean Sun”. Tra gli ingredienti, oltre al rum, frutto della passione, ananas e lime Cesenatico (Fc) Ercolano (Na) L’Emilia Romagna è terra benedetta per le ciliegie. In un’antica pasticceria artigianale della riviera romagnola, si perpetua la tradizione dei golosi boeri Le Dolomiti abbracciano l’incantato borgo adagiato in Val Marebbe, tra boschi e malghe, dove Enrico Willeit distilla mele, frutti di bosco e bacche raccolte in alta quota Tra Costiera e Parco Nazionale del Vesuvio, la frutta gode di terreno fertilissimo e microclima straordinario. Noci e limoni vengono trasformati in liquori squisiti DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE HOTEL OLYMPIA (con cucina) Strada Valiares 40 Tel. 0474-501028 Mezza pensione da 78 euro a persona GATTI DI MARE Via Cremona 23 Tel. 338-7654005 Camera doppia da 60 euro, colazione inclusa IL CRATERE B&B Via San Vito 140 Tel. 347-1667414 Camera doppia da 70 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE OSTARIA PLAZORES (con camere) Strada Plazores 20 Tel. 0474-506168 Chiuso lunedì, menù da 25 euro OSTERIA DEL GRILLO Via Fiorentini 94 Tel. 0547-82140 Chiuso mercoledì, menù da 25 euro ’E CURTI Via Padre Michele Abete 6, Sant’Anastasia Tel. 081-5313840 Chiuso la domenica, menù da 25 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE MASO CIANORÈ Strada Cianorè 1, Pieve di Marebbe Tel. 0474-501203 DALBA Via Adriatica 15 Tel. 0547-86089 ENOTECA CAROTENUTO Via Madonnelle 9/11 Tel. 081-7390246 Punch La versione elegante del grog prevede cinque ingredienti (da cui il nome, di derivazione hindi): tè, zucchero, cannella, limone e acquavite o rum arricchiti da frutta secca o passa e buccia d’arancia Grappa alla Williams La bottiglia vuota viene infilata sul frutto appena sviluppato, fissata al ramo con il collo rivolto a terra Quando la pera è giunta a maturazione, si stacca dall’albero e si riempie la bottiglia di grappa Boeri I cioccolatini dalla carta rossa come la divisa boera (seicentesca colonia olandese in Sudafrica) I frutti sotto spirito vengono immersi prima nella glassa di zucchero e poi nel cioccolato fondente fuso Cocktail Ciliegie da tinello per ospiti mai visti GIAN LUCA FAVETTO ruttasotto alcol. L’immagine che viene è gozzanian-gargantuesca, da signorina Felicita che si accoppia con Pantagruel. Un’immagine morotea: da Aldo Moro (1916-1978), politico e statista di talento democristiano, capace di formule ardite che sfidano la logica, annunciano un paradosso e certificano la realtà. L’immagine è quella delle convergenze parallele. Non tanto tra frutta e alcol, che stanno bene insieme, quanto fra zia Romilda e Sias, che insieme non sono immaginabili. Zia Romilda era esile e caparbia, l’ostinazione fatta esistenza, voce educata e cristallina, una gran capote di capelli bianchi raccolti in un largo chignon, indossava grembiuli scuri, calze di lana grezza al ginocchio — o collant, sempre al ginocchio — e mocassini. Era l’incarnazione della vecchiaia: vecchia a quarant’anni, è rimasta vecchia fino a ottantanove. Aveva due specialità, che faceva con le sue manine. Sias è sempre stato grosso. A quindici anni era il più grosso di tutti. A trenta, non parliamone. Oggi, che ne ha cinquanta, è grosso al cubo. Sias viene da Ezio, Eziaccio, poi girato in dialetto. Simpatico, di buon colorito, con la voce emetteva tuoni non parole. Pochi capelli, ma molto in disordine. Magliette e camiciotti anche d’inverno. Uno che ha sempre mangiato due piatti di tutto; d’insalata, tre. Anche lui aveva due specialità, che faceva con le sue manone. Sono loro le mie convergenze parallele. Convergono parallelamente sulla frutta sotto alcol. La specialità di zia Romilda erano le amarene al cherry — ton F sur ton, gusto su gusto — i mirtilli alla grappa e i datteri al rum. Preparava tutto da sola. Mentre lo faceva, era inavvicinabile. Conservava il frutto del suo lavoro nella credenza della sala, in bottiglie di foggia ricercata che sembravano ricamate. Non l’offriva mai a nessuno: era sempre per un’altra occasione. Bisognava rubarlo. Da ragazzi, il sapore ci faceva schifo: ma vuoi mettere l’ebbrezza del furto? Bevevamo sorsate, più che masticare mirtilli, e poi rimboccavamo con acqua e zucchero, una volta anche con un resto di birra. Quando è morta, ha lasciato in eredità una mezza dozzina di bottiglie. Piene. Una è ancora lì. La specialità di Sias, invece, era qualunque cosa con l’alcol: albicocche, ciliegie, uva. Soprattutto, castagne alla Vecchia Romagna. Sapeva far lui, garantiva, ed era piuttosto veloce. In un pomeriggio, con i suoi al lavoro, era tutto fatto. Le metteva in una latta con coperchio e dopo una settimana erano già buone, diceva. Tendevamo a dar ragione a Sias e mandavamo giù senza masticare, a golate. Il suo motto era: tieni alto lo spirito, bocia. Bocia, nel senso di ragazzo e, spirito, nel senso di alcol. Lo diceva in dialetto. E noi in dialetto bevevamo. Per completezza. La seconda specialità di Sias era annodare gambe e braccia dei gagni che si mettevano contro di lui. La seconda specialità di zia Romilda era tirare il collo alle galline: ancora meglio, tagliare loro la lingua e lasciarle dissanguare appese per le zampe. Diceva venissero più buone. © RIPRODUZIONE RISERVATA Dal Cosmopolitan, a cui il succo di mirtilli selvatici regala il classico colore rosa pallido, alla Piñacolada (base ananas e latte di cocco), i barman celebrano la frutta nelle loro creazioni alcoliche Calvados La celebre acquavite di mele nata in Normandia e invecchiata nelle botti di quercia è il prodotto della distillazione del sidro, ottenuto dai frutti fermentati. È diffuso tra Francia, Inghilterra e Paesi Baschi Limoncello Limoni rigorosamente bio per il liquore della Costiera Amalfitana. Alle scorze, affettate sottili e senza il bianco, dopo due settimane di infusione in alcol, si aggiunge sciroppo di zucchero Filtratura finale Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GENNAIO 2010 le tendenze Sei sarebbero le silhouette a cui ricondurre le tipologie del corpo femminile. Mediterranea tutte curve, “petite” Stratagemmi ovvero Venere tascabile, “a pera”, “Olivia”, androgina e “compatta”. La moda prêt-à-porter offre a ognuna una gamma di proposte per valorizzare al meglio le forme Perché l’abito giusto, spesso, può fare miracoli Una, nessuna e centomila a ciascuna il suo stile IRENE MARIA SCALISE GLOSSARIO • Androgina Il tipo magro con seno piatto e spalle larghe • A mela Tipi appesantiti e con pancetta • A pera Il tipo dal “fondoschiena ingombrante” • Stangona Il tipo lungo e asciutto • Petite Il tipo piccolo e agile • Tutta curve Con seno abbondante «L a moda passa lo stile resta», ammoniva lapidaria Coco Chanel. Ma le donne, che pure Mademoiselle la adoravano, non hanno mai fatto tesoro dell’insegnamento. A ogni cambio di stagione affrontano con eccesso di disinvoltura lo scollamento tra aspirazione e realtà. Strizzate dentro vestiti pensati per le magrissime, anche se la bilancia scricchiola, o innalzate su tacchi vertiginosi, pur se l’altezza è da giocatrici di pallacanestro, le ragazze di ogni taglia s’interrogano su cosa osare ogni volta che incontrano uno specchio. Ma il più delle volte sfidano a testa alta ogni logica. E così il rapporto tra le donne e la moda è burrascoso, contraddittorio e in certi momenti esaltante. Secondo un ingeneroso Oscar Wilde: «La moda è una forma di bruttezza cosi intollerabile che siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi». Complice anche la crisi economica, il vorticoso valzer degli abiti ha però subìto un rallentamento. Se prima si compravano tre stivali adesso si riflette LE FORME anche sul singolo paio. Se una gonna lascia perplessi, in attesa di congiunture più favorevoli si posticipa la decisione. Ma quante sono le tipologie fisiche femminili? Sembrano riconducibili a sei silhouette, e le aziende, da Simona Barbieri e Celin B sino a Pinko e Liu Jo, offrono soluzioni per tutte. La mediterranea, o tutta curve, dovrà valorizzare le forme con abiti attillati invece d’ingolfarsi in camuffamenti a sacco. Il tipo petite, la Venere tascabile, è minuta e magra e potrà giocare con i tacchi per conquistare i centimetri mancanti. Da evitare i cappotti lunghi. Meglio le giacche corte che slanciano la figura. Per la donna “a pera”, quella dal fondoschiena un po’ ingombrante, l’importante è spostare l’attenzione sulla parte alta del corpo. Maglie a righe, camicie bianche, tutto è lecito pur di distogliere lo sguardo da quell’ostile circonferenza sotto il punto vita. Problemi opposti, ovvero la totale mancanza di forme, sono la consuetudine per la donna troppo lunga e magra. Un’eterna “Olivia” che dovrà cercare di creare delle curve illusorie. Per lei è consigliato sovrapporre strati di tessuti e aggiungere volant e pieghe. C’è poi la figura androgina, simile a quella di un ragazzo: spalle larghe, seno piatto e gambe magre. Un fisico piuttosto fascinoso, se esaltato da pantaloni maschili, camicie e gilet che ricordano la meravigliosa Diane Keaton di Io e Annie. Ultima tipologia femminile, decisamente poco fortunata, è quella appesantita e compatta. Una donna a tutto tondo che può tentare di allungarsi con sapienti scollature a V e, comunque, dovrà attingere tra i colori più scuri del guardaroba per un risultato snellente. Perché la moda, se ben gestita, può fare miracoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA tutta curve l’androgina la petite LUI JO DIOR CHIARA BONI PIANURA ROSSETTI NOLITA COCCINELLE JUCCA FORNARINA Per sdrammatizzare qualche centimetro in più ecco la t-shirt Liu Jo con fumetto di Mafalda Orecchini Milly Carnivora, per la nuova collezione firmata Dior Joaillerie Sarebbe piaciuto alle formose star anni Cinquanta il vestito a drappeggi di Chiara Boni Camicia di Pianura a mini quadretti ingentilita dal collo bianco che smorza lievemente le forme Scamosciata, punta in vernice e senza tacco, la scarpa dei Fratelli Rossetti Elegante e divertente il pantalone Nolita nero con le pence È un capo-jolly Pochette verde stampa cocco con fiocchetto di Coccinelle Must di eleganza Per le Veneri tascabili non può mancare il vestitino nero anni Trenta a balze di Jucca Mini gonna per ragazze non altissime. Questa è di Fornarina a disegni cachemire Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GENNAIO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 Simona Barbieri / Twin-Set “Il mio guardaroba evergreen disegnato dalla parte delle donne” LAURA ASNAGHI l twin-set è uno dei capi che non può mancare in un guardaroba iperfemminile, che profuma di donna. Ed è forse per questo che Simona Barbieri (lei creativa) e Tiziano Sgarbi (lui la mente economica) hanno scelto questo nome, quando, negli anni Novanta, hanno dato vita al loro marchio di moda, partendo dalla maglieria. Twin-Set è cresciuto rapidamente e oggi è un po’ il simbolo della griffe che rispetta il corpo delle donne, non le costringe a diete ferree per entrare in un abito e le fa belle, esaltando anche le rotondità e camuffando abilmente i “punti deboli”. Simona Barbieri, lei è una stilista che disegna «stando dalla parte delle donne». Quali sono i segreti per fare collezioni molto fashion ma, allo stesso tempo, «tutte da mettere»? «Quando disegno un abito penso a una donna come me. Che lavora ma è anche madre, che è curiosa, gira il mondo e vuole sempre essere molto femminile». Un gioco non facile da reggere. «Vero. Ma se chi crea è una donna, tutto diventa più semplice. Il cardigan con l’abito sottoveste è uno dei miei must. Sta bene a tutte, magre e rotondette, piccole e alte, discrete o esibizioniste. Questo abbinamento ha la fortuna di essere sexy e grintoso, senza sfiancarti». Lei è una fan di Chanel. Nel suo studio ci sono molte immagini dei dettagli creati da “Mademoiselle Coco”: dai fiori al gioco dei bianchi e neri, dalle catene ai ricami. Elementi ricorrenti nelle sue collezioni. «Vero. Io sono convinta che in un guardaroba femminile non possa mai mancare una catena dorata da usare come cintura o collana, un tubino leggermente svasato sui fianchi o un abito con un bel decolté che cattura subito l’attenzione dei maschi. Perché è vero che le don- I la stangona a mela ne vogliono, innanzitutto, piacere a se stesse ma non dimentichiamo che vogliono anche fare colpo sugli uomini». Quali sono, secondo lei, i pezzi che non possono mancare in un guardaroba “evergreen”? «Ai capi indicati prima vanno aggiunti un cappotto sartoriale, tagliato a trapezio, perfetto per le occasioni importanti, i pantaloni “skinny”, quelli super sottili (in alternativa ai leggings delle ragazzine) e le canotte da vogatore veneziano, quelle a righe, molto care a Chanel. Quelle canotte possono essere veramente eleganti con una gonna stretta o molto sportive con un paio di jeans tagliati alla perfezione». Le donne, a differenza degli stilisti maschi, hanno una marcia in più. Qual è? «Noi il corpo femminile lo conosciamo bene, non abbiamo bisogno di chiedere ad altri com’è. E quando disegniamo una collezione sappiamo fino a dove spingerci per uno spacco, una scollatura. Siamo più abili nell’usare i pizzi “vedo non vedo”, abbiamo più malizia nel creare un giro vita magari più morbido per tollerare meglio qualche peccato di gola a tavola». Simona Barbieri, lei, quando crea a chi si ispira? «Io sono una viaggiatrice accanita. E per ogni città che frequento, da Parigi a Londra piuttosto che a Los Angeles, mi attrezzo con i miei quaderni foderati di cuoio. Annoto tutto quello che mi piace. Un manifesto sorprendente, una vetrina speciale, il modo in cui una donna porta una borsa, un fiore, un colore. Raccolgo tutto e poi quello diventa il mio libro dei sogni da cui ricavo idee per vestire la mia donna». © RIPRODUZIONE RISERVATA a pera [email protected] BRACCIALINI FURLA MISS SIXTY REFRIGIWEAR LOUIS VUITTON TWIN-SET PINKO GANT CELYN B Sembra pensata per la donna alta la borsa in stile gitano di Braccialini Ballerina in colore rosa adatta anche per l'abito da gran sera di Furla Piacerà a tutte Per chi ha gambe chilometriche e troppo magre c'è il jeans a tubo secondo Miss Sixty Un sobrio cappotto come quello Refrigiwear ideale per assottigliare la figura Se il punto debole sono le braccia in carne, il guanto Louis Vuitton smagrisce e allunga Per chi preferisce agire in incognito l'abito di Twin-Set nasconde ogni imperfezione Copre qualsiasi difetto il cappotto nero di Pinko di foggia militare con collo in pelliccia Gonna arricciata ai fianchi di Gant per chi non ama mettere in primo piano il lato b Per chi preferisce sorvolare sul punto vita c'è l'abito casacca in organza di Celin B Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GENNAIO 2010 l’incontro Trentacinque anni, da quindici sulla scena, la “cantantessa” siciliana è cresciuta. Ha smesso i panni della ragazza “Confusa e felice” che si esibiva sul palco di Sanremo. Adesso è una donna riflessiva e attenta all’ascolto di sé Tanto da essersi fatta una promessa: «D’ora in poi tutti i dischi che realizzerò saranno frutto di un sentimento profondo e voluto Non voglio più sprecare la mia musica» Vulcaniche Carmen Consoli rima dell’espressione arrivano due occhi neri che bucano una piccola mappa siciliana impressa sul volto, forza e malinconia incise come un graffito, da sirena minuta e caparbia un tempo confusamente felice, oggi addirittura capace di calarsi nei panni di Elettra, come ha intitolato il suo ultimo disco nel quale mette fuori sentimenti forti, molto privati. «Ha coinciso col tentativo di superare un dolore forte, quasi invalicabile. Ovvero la morte di mio padre. Questo mi ha fatto capire l’importanza che la musica ha nella mia vita. Ha trasformato un sentimento di disperazione in gioia». Parla con una cadenza perfetta dalla quale affiora come un vezzo il dialetto siciliano, anzi catanese, un chiddu e chistu ogni tanto messo lì a intercalare il suo sguardo spalancato sulla vita, questo sì, ancora da bambina. «Da questo momento nutro una gratitudine ancora più grande nei confronti della musica. Non è la prima volta, certo, ma è la prima volta che mi sono trovata a superare una fase così dura. Diciamo tre anni impegnativi, mi sembrava che mi camminasse vicino il concetto di morte, è morto il mio bassista, poi c’è stata la morte di mio padre, e poi intendiamoci ci sono state esperienze meravigliose, sono stati anni intensi e belli, e alla fine anche la scomparsa di mio papà ha avuto una sua parte molto bella, diciamo una parte di saluto, avvenuta in una maniera speciale». La sua casa romana, in un palazzo qualsiasi del quartiere Prati, è linda ed essenziale, bianca, quasi a contrasto col nero degli occhi e dei capelli. «Quando ni e tanti dischi, rischi di non farlo più, di fare le cose a tavolino. Da questo punto di vista forse sono anche un po’ tornata indietro, e sono molto ispirata, il disco è uscito da tre mesi, ma io ho continuato a scrivere, scrivo di tutto, quello che mi pare, pezzi onirici con accostamenti improbabili, pezzi strumentali, ma del resto chi me lo impedisce? Dopo quindici anni è facile crearsi degli schemi, invece gioco, sperimento, provo cose diverse. A volte in passato ho usato la musica per esprimere rabbia, rancore, oppure la mia insoddisfazione riguardo alle ingiustizie che vedevo, ora è diventato un atto d’amore, ho una sensazione di esaltazione, la passione è la chiave, e vuol dire anche sofferenza, sudore, bisogna lavorare tanto per tirare fuori il grano dalla gramigna, perché a volte ci si inganna, ma quando si lavora tanto, poi succede il miracolo. La canzone che ho scritto sul mio papà, Mandaci una cartolina, l’ho scritta in mezz’ora, tutta intera, frrr… era fatta. A volte mi sembra che noi da qualche parte lo sappiamo già quello che vogliamo dire, ed è un mezzo, una cosa nobile, come la bellezza. È bello ciò che è vero, Continuo a studiare: armonia, basso, quattro ore al giorno Magari tra qualche tempo scrivo un bolero, un’opera, chissà. Mi piace l’idea di evolvermi, superare i limiti FOTO GUIDO HARARI/CONTRASTO P ROMA ci arrivo da Catania preferisco arrivarci in macchina, così per sedimentare la distanza. In aereo non mi piace, finisco per avere nostalgia di quello che lascio, della terra ai piedi dell’Etna, invece quando ci metto delle ore ho il tempo di assaporare tutti gli stati d’animo e alla fine non vedo l’ora di arrivare a Roma. È il problema che abbiamo tutti, oggi non ci prendiamo più il tempo di cui le cose hanno bisogno. A me piace sentirmi itinerante, non pellegrina o viandante, semplicemente itinerante». Ormai cresciuta, Carmen Consoli ha imparato a pesare bene ogni cosa, ad apprezzare le forme del vivere come specchio dell’anima. La vita che racconta sembra un incastro prezioso, senza sprechi e al centro campeggia enorme il culto della musica. «A trentacinque anni la musica ha assunto un altro significato, non la voglio più sprecare. Tutti i dischi che farò saranno frutto di un sentimento profondo e voluto, non voglio sciupare queste opportunità, non l’ho mai fatto in realtà ma adesso più che mai: la rispetto troppo e ho capito che non la venderei mai, prescinde dal business, se un giorno mi sentirò di fare un disco in arabo, assolutamente non commerciabile, ma è quello che dice la mia voce interiore, allora lo farò. L’ho fatto anche con Elettra. Ho iniziato dicendo faccio un disco acustico, non ci voglio mettere troppo ketchup (come dicono i discografici, visto che ormai è tutta una gastronomia). Loro mi lasciano completamente libera, devo dire, però mi dicevano: così è difficile da vendere, ma io ho insistito, lo voglio così, e non è un problema di coraggio. Un disco è come fare un bambino, è un atto d’amore, esce come deve uscire e lo accetto com’è. Poi è stato come una medicina, mi ha portato una guarigione quasi completa, regalandomi momenti di estasi, di gioia, quindi anche simbolicamente rappresenta un punto importante della mia vita. Ci ho lavorato tanto, in modo epidermico, non l’ho lasciato un attimo, i dischi li ho sempre fatti con trasporto, ma qui non era più solo musica: è quello che sono, non quello che faccio, sono io». È talmente infervorata che sembra diventata la sacerdotessa di uno speciale culto dell’arte. «Al di là dei fatti personali, sono arrivata alla decisione di dedicare la mia vita alla musica. Ed è sicuramente il frutto della mia crescita proprio in un’età che sembra stare nel mezzo del cammin di nostra vita. Diciamo che ci sono state esperienze e circostanze che mi hanno portato a ricorrere alla musica tutte le volte che dovevo centrarmi. Succede che, dopo tanti an- questo mi interessa oggi. O meglio, non è bello tutto ciò che è vero, ma sicuramente ciò che è bello è vero». Dalla convinzione con cui afferma la sua fiducia nella musica si intravede qualcosa di spiritualmente forte. Da qualche anno ha iniziato una pratica buddista. Ed è facile immaginare che questa scelta abbia avuto un ruolo importante nella sua crescita. Magari non è una cosa di cui ha voglia di parlare, oppure sì? «La pratica c’entra molto, perché ti insegna a trasformare le avversità in opportunità, quindi fondamentalmente ti spinge all’azione, è fondata su un preciso rapporto di causa ed effetto, per cui c’è di mezzo anche la passione per la vita. E io la voglio celebrare, e nel farlo sono come un archivista, come Darwin, cerco di guidare i miei pensieri e le mie azioni perché possano produrre valore. La pratica ha esaltato il gusto di trovare piacere anche da piccole cose, ti rendi conto delle fortune che hai. Prima se un giornalista diceva che il mio disco faceva schifo, e altri dieci dicevano che era un capolavoro, io che andavo a pensare? Ovviamente a chiddu che gli faceva schifo, e invece no, non è giusto. Quello che mi piace è che parla dell’oggi, non dice: tranquilli perché poi sarete felici con Dio, e che facciamo, lo statalismo della religione? Tutte quelle anime messe lì in deposito che non fanno niente? A me piace l’attuazione nella pratica, nel buddismo quello che fai ti torna, questa filosofia mi porta molta calma, mi spinge a non prendermela per questioni irrilevanti, a dare la giusta gerarchia alle cose». Ma non per questo è pacificata, anzi, sembra un tumulto di ragazza, una che il vulcano sotto il quale è cresciuta se lo porta dentro, metabolizzato e relativamente sotto controllo. E non si stanca, questo è importante, di trovare stupore nel consumatissimo mestiere di fare canzoni. Possibile, dopo un secolo in cui sono state inventate milioni di canzoni e le combinazioni sembrano praticamente esaurite? «In realtà le combinazioni sono infinite, anche se le relazioni tra le note sono sempre le stesse. E come quando dici che una donna è bellissima, lo dici dopo millenni di bellezze femminili, ma ciò non impedisce di stupirti ed emozionarti di fronte alla sua bellezza anche se in fondo gli elementi sono gli stessi di sempre. Per la canzone accade la stessa cosa. Ma per crescere bisogna studiare, io sto studiando armonia, studio il basso, insomma studio, sempre, quattro ore al giorno, magari tra dieci anni scrivo un bolero, un’opera, chissà, ma io intanto studio perché voglio evolvermi, voglio superare i miei limiti musicali proprio in termini di conoscenza. Quando studio trovo soluzioni che mi stupiscono, ci sono leggi incredibili, uno schema matematico che sembra riflettere ordini superiori, la cosa incredibile è che oggi capisco che anni fa, senza rendermene conto, lo facevo d’istinto, c’ero arrivata con l’orecchio. Noi sappiamo riconoscere la bellezza, questo è l’orecchio, l’essere umano sa quello che vuole dire poi il linguaggio codifica, a volte avevo riconosciuto il bello, che certe volte corrisponde anche a delle leggi matematiche irreversibili, inconfutabili, quando automaticamente dici a orecchio questo accordo ci sta bene, poi lo vai a studiare teoricamente e ti rendi conto che c’era un motivo matematico che tu non conoscevi». Poi alla fine prende la chitarra, fa esempi di come un accordo possa cambiare con un semplice passaggio, una settima qui, una diminuita lì: «Nel romanzo Presto con fuoco di Roberto Cotroneo c’è una cosa che mi ha colpito moltissimo. La gente, dice, può essere paragonata agli accordi musicali, uno ci può avere una faccia da do maggiore, l’accordo più bestia che c’è, oppure do minore settima bemolle, e l’espressione si complica, una faccia triste va in minore, se invece si trasforma in nona è più malinconico, insomma crea paralleli tra esseri umani e armonie». Così che alla fine la domanda è praticamente obbligatoria. Ma lei, Carmen Consoli, con quale accordo si descriverebbe? Prova a suonare, cerca, sembra che si stia specchiando nella chitarra per poi dire sicura: «Io sono un accordo in minore sesta, che non è triste, casomai è quello della saudade brasiliana, è minore ma con la sesta ti apre la strada verso qualcos’altro». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ GINO CASTALDO Repubblica Nazionale
Scarica