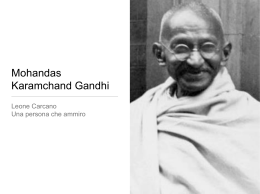Modelli di sviluppo e modelli di difesa Nanni Salio Prima di analizzare i possibili nessi che si possono intravedere tra modelli di sviluppo e modelli di difesa, è bene riassumere a grandi linee l’analisi critica del concetto stesso di sviluppo, oggetto di una lunga controversia che coinvolge un gran numero di discipline. Nell’accezione comune, soprattutto in campo economico, lo sviluppo è inteso prevalentemente e sostanzialmente come crescita economica, misurabile attraverso il PIL (prodotto interno lordo) definito come somma complessiva dei beni e servizi prodotti in un anno in un singolo paese oppure su scala globale, mondiale, prescindendo da un giudizio di merito su quanto viene prodotto. Si sommano con lo stesso segno positivo sia i beni che i mali, i servizi e i disservizi, senza alcuna attenzione al dato qualitativo, ma solo a quello quantitativo. La tesi tuttora dominante tra gli economisti, fatta propria dalla quasi totalità del mondo politico, è che il PIL deve crescere costantemente, di anno in anno, senza fine, illimitatamente, pena la stagnazione del sistema economico (nella vastissima letteratura si veda: Peter L. Berger, Le piramidi del sacrificio, Einaudi, Torino 1981; Gilbert Rist, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Bollati Boringhieri, Torino 1997; Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, No PIL! Contro la dittatura della ricchezza, Castelvecchi, Roma 2005; Johan Galtung, “Teoria dello sviluppo”, in Pace con mezzi pacifici, cap. 3, pp233-354, Esperia, Milano 2000). Cosa intendiamo per modello di sviluppo Sebbene si senta spesso usare l’espressione “modello di sviluppo”, si fatica a trovarne una definizione critica nella letteratura corrente. In generale si usa questa espressione per indicare le dottrine soggiacenti alla politica economica con la quale viene amministrato un determinato territorio, su scala locale, nazionale, macroregionale, mondiale. Secondo l’accezione diffusa in ambito scientifico, il termine “modello” indica inoltre una costruzione teorica con la quale si cerca di descrivere e interpretare la realtà oggetto di studio e quindi “modellare” significa dare forma a un particolare sviluppo. A ciascun modello corrisponde una scuola di pensiero e un ideal-tipo. Come è ulteriormente precisato in altri contributi presentati in questo volume, vengono individuati quattro principali modelli di sviluppo e si suppone che il passaggio dall’uno all’altro comporti il cambiamento del paradigma di riferimento. Per quanto sia sempre difficile ingabbiare una realtà assai complessa in uno schema con poche variabili di riferimento, questo esercizio è utile per tentare di andare oltre i limiti di un’analisi soggettiva e cercare di individuare una struttura oggettiva di riferimento. In effetti, questa analisi, che richiederà di essere verificata da ulteriori ricerche, ci permette di sostenere che sembra esistere una sorta di incommensurabilità tra i diversi modelli di sviluppo e tra le teorie alle quali essi fanno riferimento. Una proposta di classificazione dei modelli di sviluppo In passato, Johan Galtung aveva già individuato quattro modelli di sviluppo (vedi l’articolo riportato in questo volume), che in seguito ha caratterizzato mediante variabili sociali strutturali. Partendo dalle due variabili stato e mercato, egli propone una classificazione secondo una “teoria dei colori politici”, che porta a individuare quattro principali modelli (blu e rosso, verde e giallo) secondo lo schema di fig. 1. A questi modelli aggiunge inoltre quello di colore rosa e una possibile degenerazione del blu e del rosso verso il totalitarismo bruno (non rappresentato in figura, ma descritto nel suo saggio I blu e i rossi i verdi e i bruni, in: IPRI, a cura di, I movimenti per la pace, vol. I, Le ragioni e il futuro, EGA, Torino 1986, pp. 31-59). A questa classificazione fanno riferimento anche alcuni lavori di Antonino Drago e di Alberto L’Abate, riportati in questo volume. Nello schema proposto da Galtung, la variabile stato (sull’asse verticale) può assumere un valore minimo, prossimo allo zero, nel caso di una “società senza stato”, con un mercato solo su scala locale, che Gandhi stesso prefigurava con le seguenti parole: "Lo stato, nel passaggio alla società senza stato, sarà una federazione di comunità democratiche rurali nonviolente e decentralizzate. Queste comunità si baseranno sulla ‘semplicità, povertà e lentezza volontaria’, cioè su un tempo di vita coscientemente rallentato, nel quale l'accento sarà posto sull'autoespressione, attraverso un più ampio ritmo di vita, piuttosto che attraverso più veloci pulsazioni nell'avidità e di lucro" (Citato in: Aldo Capitini, Educazione Aperta, La Nuova Italia, Firenze 1967, vol I, .pag. 172). Il modello rosso corrisponde invece a una società in cui predomina il controllo centralizzato dello stato, anche in questo caso con un mercato minimo, non di tipo liberista. All’opposto, il modello blu corrisponde al libero mercato, idealmente senza nessun controllo dello stato. Nel modello giallo ideale si ha contemporaneamente massimo sviluppo del mercato e dello stato. Infine, nel modello rosa stato e mercato sono presenti come compromesso delle società socialdemocratiche. Questa schematizzazione corrisponde inoltre alla modalità di soluzione di un conflitto tra due obiettivi contrastanti, secondo l’elaborazione che lo stesso Galtung ha proposto nei suoi lavori sulla “trasformazione nonviolenta dei conflitti” (La trasformazione nonviolenta dei conflitti, EGA, Torino 2000, manuale mini; il manuale più ampio è in corso di stampa da parte del Centro Studi Sereno Regis. Entrambi sono disponibili in rete, nell’edizione inglese originale, nel sito www.transcnd.org ). Fig. 1 Classificazione dei modelli di sviluppo secondo la “teoria dei colori politici” di Galtung. Per una analisi gandhiana dei modelli di sviluppo E’ essenziale completare la presentazione dei modelli di sviluppo facendo riferimento al pensiero gandhiano, che verrà ripreso più ampiamente, in questo stesso volume, da Fulvio Manara: Sin dall’inizio del secolo scorso, Gandhi analizzò con grande lungimiranza e acuto senso critico la civiltà occidentale, denunciandone l’assoluta insostenibilità, oltre che l’immoralità. Come osserva Giuliano Pontara, “il discorso di Gandhi muove… da una durissima, e tutt’altro che inattuale, critica del capitalismo predatore, dell’industrialismo esasperato e del consumismo sfrenato, componenti di un sistema saturo di violenza strutturale e che se non fosse stato bloccato, egli riteneva destinato a ‘denudare il mondo al modo delle locuste’”.( Giuiano Pontara, L’antibarbarie, EGA, Torino 2006, p. 15) Questa critica è contenuta in forma sintetica, sebbene non seguendo lo schema strutturale che qui proponiamo, in un famoso libretto del 1909, Hindi Swaraj (M.K.Gandhi, Civiltà occidentale e rinascita dell’India, Edizioni del Movimento Nonviolento, Perugia 1984). E’ noto che Gandhi ha suscitato e suscita tuttora le reazioni più diverse, che in molti casi fanno riferimento proprio al testo appena citato. Da alcuni è stato visto come un eccentrico reazionario tradizionalista e conservatore che suscitava “una sorta di disgusto estetico” (George Orwell, “Riflessioni su Gandhi”, in: George Orwell, Nel ventre della balena e altri saggi, Sansoni, Firenze 1988, p. 174), o come un “fachiro mezzo nudo” (Churchill). Albert Einstein, invece, lo ammirò tanto da affermare che “le generazioni future faticheranno probabilmente a credere che un uomo simile si sia mai realmente aggirato in carne ed ossa su questa terra”. E Aldous Huxley anticipò un giudizio che oggi appare quanto mai attuale “Prima o poi si verificherà che questo sognatore aveva i piedi ben piantati a terra, e che l’idealista è il più concreto degli uomini” (A Note on Gandhi, www.swaraj.org/huxley.htm ). E’ dunque quanto meno curioso che due autorevoli docenti di scienze politiche dell’Università di Chicago abbiano dedicato un libro intero per sostenere la tesi di un “Gandhi postmoderno” (Lloyd I. Rudolph & Susanne Hoeber Rudolph, Postmodern Gandhi, Oxford University Press, Delhi 2006). Come osserva in una acuta recensione Jyotirmaya Sharma (“Gandhi as postmodern thinker, The Hindu, 4/7/2006) “scrivere su Gandhi… assomiglia a uno stato di cose che cade tra due estremi: un abbraccio appassionato e un’autopsia. Gandhi diventa ogni sorta di cosa per chiunque. I suoi interpreti lo hanno visto a seconda dei casi come tradizionalista, modernista, femminista, socialista, comunista, ambientalista, e così via”. In un’altra recensione, P.V.Subraya (“Gandhi: Postmodern or transmodern?”, Deccan Herald, 5/3/2006) si chiede invece se “la vastità del discorso gandhiano non sia troppo elusiva per poterlo “intrappolare” in queste definizioni: “Gandhi sembra trascendere tutte le categorie” e volendolo classificare potremmo definirlo “transmoderno”, secondo la definizione di questo termine data da autori come Ziauddin Sardar (Islam and the West in a Transmodern World, http://www.islamonline.net/english/Contemporary/2002/05/Article20.shtml ) e Marc Luyckx ( 11 September was the end of the legitimacy of Western modernity as a dominant model, http://www.siyassa.org.eg/esiyassa/ahram/2002/10/1/INTE1.HTM ). Ma tornando ai Rudolph, essi sostengono che proprio Hindi Swaraj può essere considerato il primo libro “post-trans-moderno” perché in quel testo Gandhi respinge i paradigmi fondativi della modernità che si basano sulla pretesa di certezze razionali assolute della scienza, della politica e della filosofia moderne e anticipa le analisi di una serie di autori (Ivan Illich, Fritz Schumacher, Arne Naess, Serge Latouche, Vandana Shiva) che, richiamandosi spesso al suo pensiero, criticano le moderne società industriali basate sul mito della crescita economica e del progresso lineare inarrestabile e su uno stile di vita da “sogno americano”, individualista, consumista, alienato. Famosi sono il richiamo di Gandhi a quella che in seguito è stata indicata come “filosofia del limite”: “il nostro pianeta ha risorse sufficienti per soddisfare i bisogni fondamentali di tutti, ma non l’avidità di alcuni” e l’invito a una scelta di vita ispirata alla “semplicità volontaria”, l’unica strada che potrà consentire di avviare a soluzione i principali problemi dell’umanità: fame, protezione ambientale, autorealizzazione. L’analisi di Gandhi non si limita tuttavia alla sola critica distruttiva, ma propone un programma costruttivo che coglie il meglio del pre-moderno e del moderno in una sintesi transmoderna: un superamento dei limiti della modernità, senza limitarsi né alla sterile critica postmoderna né ad auspicare un ritorno acritico alla premodernità. Per comprendere pienamente il pensiero di Gandhi si deve tuttavia esplicitare il suo punto di vista etico. In un’ampia comparazione che mette a confronto la visione gandhiana con quella di altri autori (da Marx a Sen, da Tariq Ali a Vandana Shiva e Arundhati Roy), Howard Richards individua come punto chiave della critica gandhiana alla moderna società industriale la mancanza di dharma, di una legge, di una “via” (The Gandhi Series, http://howardrichards.org ). La tensione esistenziale che animava Gandhi è proprio questa incessante sete e ricerca della verità, per approssimazioni successive, mediante una continua serie di “esperimenti etici con la verità”. Lo scopo della vita di ognuno di noi è dunque questa costante tensione alla ricerca della verità che permetta di autorealizzarci pienamente, lasciando che ciascuno segua in piena libertà morale e intellettuale (questa è la vera libertà) la propria via, con un unico vincolo, quello della relazione Classificazione dei modelli di difesa Ancora una volta partiamo da una proposta fatta da Galtung (Ci sono alternative!, EGA, Toino 1986, p.198) per individuare i principali modelli di difesa che derivano ciascuno da una specifica teoria o dottrina. Nello schema di fig. 2 si distinguono i modelli di difesa innanzi tutto in due grandi categorie: modelli offensivi oppure difensivi, a seconda della tipologia di sistemi d’arma che, nel primo caso, consentono di portare l’offesa ovunque con potenziali distruttivi massimi, mentre nel secondo caso permettono solo di resistere e contrastare un’azione offensiva sul proprio territorio, contenendo i livelli distruttivi. Una seconda soglia, interna ai modelli difensivi, permette di distinguere tra una difesa con armi esclusivamente difensive (difesa difensiva) e una totalmente nonviolenta, la DPN (difesa popolare nonviolenta), sulla quale ritorneremo più avanti. A questi tre modelli, offensivo, difensivo, nonviolento, se ne può aggiungere un quarto, la non resistenza o non difesa. Fig. 2 Classificazione dei modelli di difesa secondo Galtung Correlazioni tra modelli di sviluppo e modelli di difesa Se si assume come variabile la crescita quantitativa, si può riprendere la precedente classificazione dei modelli di sviluppo mettendola in correlazione con i modelli di difesa, anch’essi classificati secondo un’unica variabile, l‘intensità della reazione a un’aggressione, ovvero il livello di distruttività, come indicato schematicamente in fig. 3. Possiamo ipotizzare l’esistenza di una correlazione tra modello di sviluppo a crescita illimitata e modello di difesa offensivo. Come ebbe a dire in modo molto colorito ed esplicito l’allora segretario della difesa USA, Margaret Albright: “Per avere McDonald ci vuole McDouglas”, ovvero per sostenere la globalizzazione economica liberista (crescita illimitata e modello blu) è necessario esportarla e difenderla manu militari, come è sempre avvenuto storicamente da parte delle potenze imperiali capitaliste (si veda, per tutti, William Blum, Il libro nero degli Stati Uniti, Fazi, Roma 2003). Che non si tratti soltanto di una indebita illazione, è confermato dall’ampia letteratura sull’argomento nonché dai documenti pubblicati da vari organismi ufficiali USA e dalla teoria neocon “del nuovo secolo americano” (vedi la documentata analisi sul “Progetto per un nuovo secolo americano” o PNAC Project for the New American Century. su http://it.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century . Vedi anche l’ampia riflessione svolta da Giuliano Pontara in L’antibarbarie. La concezione etico-politica di Gandhi e il XXI secolo, EGA, Torino 2006. Pontara individua delle esplicite tendenze naziste nell’attuale politica internazionale ). Fig. 3 Correlazioni tra modelli di sviluppo e modelli di difesa Ma non tutti i paesi capitalisti hanno una politica così aggressiva e un’economia così vorace come quella statunitense. Sin dal 1972 con il famoso rapporto del Club di Roma sui Limiti dello sviluppo (Mondadori, Milano 1972. Il titolo dell’originale inglese era, più correttamente: Limits to growth, limiti della crescita. Lo studio è stato riproposto in versione aggiornata: Donella e Tennis Meadows, Jorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori, Milano 2006. Per una rilettura critica si veda infine: Dennis L. Meadow, “Evaluating Past Forecast: Reflection on One Critique of The Limits to Growth”, in: Robert Costanza, Lisa J: Graumlich and Will Steffen, eds., Sustainability or Collapse. An Integrated Historyand Future of People on Earth, MIT Press, Cambridge-London 2007) si è sviluppato un ampio e controverso dibattito che ha portato alcuni paesi a elaborare l’idea di uno sviluppo sostenibile che, pur mantenendo ancora una ambiguità non pienamente risolta tra sviluppo e crescita, ha consentito di avviare alcuni processi di razionalizzazione e di contenimento della crescita, o quanto meno di messa in discussione del paradigma dominante. Parallelamente, di fronte alla manifesta follia della dottrina nucleare MAD (Mutua Distruzione Assicurata) è sorto, intorno agli anni ‘70 del secolo scorso, un movimento di “generali per la pace” che ha teorizzato un cambiamento di modello, passando dalla difesa offensiva a quella puramente difensiva. Questo è il modello applicato da vari paesi, tra i quali spiccano i seguenti: Svizzera, Austria, paesi scandinavi, Costarica, Canada. Così come lo sviluppo sostenibile si propone di mantenere quanto meno sotto controllo i processi di crescita dell’economia riducendone i tassi e l’impatto ambientale, anche nel caso della difesa si propone una riduzione dell’intensità distruttiva, mantenendola entro i limiti delle armi convenzionali difensive. Il passaggio da un modello di difesa all’altro viene chiamato transarmo, un termine che, a differenza di disarmo, si propone innanzi tutto il cambiamento della dottrina militare, per rendere possibile anche operazioni di disarmo, per quanto limitate ad alcuni sistemi d’arma. Il passo successivo, o parallelo, è quello della transizione a un modello di sviluppo basato su un’economia nonviolenta, stazionario, in cui l’impatto ambientale sia autenticamente sostenibile, ispirato a uno stile di vita che si richiama alla scelta della “semplicità volontaria” (per una introduzione, vedi Giovanni Salio, Elementi di economia nonviolenta, Quaderni del Movimento Nonviolento, Verona 2001). Ad esso è associata l’idea di una difesa popolare nonviolenta, che si ispira alle molteplici lotte nonviolente, su varia scala, avvenute nel corso di tutta la storia umana e in particolare nel Novecento. Fig. 4 Punti nodali di attacco per le misure di disarmo Lo schema in figura 4, proposto da Johan Galtung in Ambiente, sviluppo e attività militare (EGA, Torino 1984), è un utilissimo punto di partenza per individuare i “punti nodali di attacco per le misure di disarmo”, per capire perché molto spesso le azioni sia degli organismi internazionali (ONU) sia dei movimenti per la pace sono poco efficaci e per introdurci criticamente all’idea di DPN (vedi Antonino Drago, Difesa popolare nonviolenta. Premesse teoriche, principi politici e nuovi scenari, EGA, Torino 2006). Il più delle volte, il movimento per la pace interviene nell’ultima fase del processo, quando la potente macchina da guerra è già avviata, pronta per l’uso. Non ci si deve stupire se di solito si fallisce, anche quando si è in presenza di movimenti tanto vasti come quelli che culminarono nelle manifestazioni del 15 febbraio 2003 e che furono nientemeno definiti dal New York Times, con molta enfasi, come “seconda superpotenza mondiale”. Si interviene troppo tardi e solo nelle fasi ultime del processo, per fermare una macchina da guerra che funziona ventiquattrore al giorno, con decine di milioni di persone a tempo pieno e mille miliardi di euro/dollari a disposizione. Il processo messo in moto da questa gigantesca megamacchina diventa inarrestabile, se ci si limita a intervenire all’ultimo minuto. Si capisce quindi perché le misure di puro e semplice disarmo sortiscano risultati modesti. Si prenda il caso, pur interessante, del trattato contro le mine antiuomo. E’ stato un successo (sebbene alcuni dei paesi più importanti non l’abbiano sottoscritto), tuttavia oggi ci accorgiamo che una nuova categoria di armi, le cluster bombs, agiscono a tutti gli effetti come mine antiuomo, ma non sono messe al bando perché non previste dal trattato. Questo fatto è ricorrente in tutta la corsa agli armamenti. Se si lasciano immutate la dottrina militare e la ricerca militare, esse si industrieranno nel cercare nuovi sistemi d’arma con cui aggirare gli ostacoli posti dalle leggi e dai trattati internazionali. E’ una sorta di corsa tra guardie e ladri, con questi ultimi che corrono più veloci e non vengono quasi mai acciuffati. Se vogliamo realmente estirpare la guerra dalla storia umana, dobbiamo andare alle radici, culturali e teoriche, dei modelli di difesa e di sviluppo che stanno a monte dell’intera “catena di comando” della macchina da guerra. Le dottrine del falso realismo che vengono insegnate nelle accademie sia civili, le università, sia militari, le scuole di guerra, sono inadeguate e continuano a provocare il sacrificio incessante di vite umane con la violenza diretta della guerra e con quella strutturale dei modelli di sviluppo, delle spese militari, delle priorità che ignorano i bisogni fondamentali delle popolazioni. Gli attuali modelli di difesa adottati da gran parte dei paesi sono in realtà modelli di offesa, che basandosi su sistemi d’arma oggettivamente offensivi (a largo raggio e ad alto potenziale distruttivo) comprendono ogni possibile arma di distruzione di massa, senza alcuna soglia superiore che ne limiti la distruttività. Questi modelli creano insicurezza invece che sicurezza, instabilità invece che stabilità (vedi Johan Galtung, Ci sono alternative!, op. cit.) Dopo la fine della guerra fredda, nel mondo della peace research si è posta l’attenzione sul concetto di conflitto e sulla trasformazione nonviolenta dei conflitti, più che sulla difesa. I teorici dei modelli di difesa armati intendono il conflitto come sinonimo di guerra. Nella concezione nonviolenta il conflitto è invece visto come una condizione esistenziale normale dell’umanità, che si presenta al tempo stesso come “pericolo e opportunità”, come possibilità di crescita oppure di distruzione (Angela Dogliotti, Elena Camino, Conflitto. Rischio e opportunità, Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi 2005). Mentre la peace research poneva al centro della propria indagine l’idea di conflitto, l’establishment politico-militare-accademico ha riproposto il concetto di sicurezza, inteso in senso globale, con sfumature e giochi linguistici di tipo orwelliano che hanno comunque come conseguenza una crescente insicurezza e instabilità dei sistemi. Il modello di difesa offensivo ha reso paesi come gli USA meno sicuri, non solo rispetto a possibili rappresaglie con armi nucleari da parte di grandi potenze, ma anche attivando il fenomeno del blowback, di cui gli attentati dell’11 settembre 2001 sono un clamoroso esempio, previsti con acutezza e lungimiranza da Chalmers Johnson (Gli ultimi giorni dell’impero americano, Garzanti, Milano 2001, lavoro “profetico” pubblicato nell’originale nel 2000. Il secondo volume, Le lacrime dell’impero. L’apparato militare industriale, i servizi segreti e la fine del sogno americano, è anch’esso pubblicato da Garzanti, Milano 2005. Il terzo volume, Nemesis: The Last Days of the American Republic pubblicato nel 2007 da Metropolitan Books , non è ancora stato tradotto. In questi lavori, l’autore analizza, tra l’altro, con una imponente quantità di dati il pericolo che il complesso militare industriale USA costituisce non solo per la situazione internazionale ma anche per il futuro e la stabilità degli stessi Stati Uniti). La scelta dei paradigmi di difesa e di sviluppo che si richiamano alla nonviolenza sono la coerente conseguenza di uno stile di vita e di una politica che vogliano realizzare una società nonviolenta, della quale per il momento si vedono solo alcuni esperimenti in corso, purtroppo ancora troppo minoritari sebbene di grandissimo valore sperimentale e profetico. Infine, si possono associare le società tradizionali, basate su un’economia di sussistenza, che non conoscono l’idea di sviluppo, con l’assenza di un’organizzazione collettiva della difesa (livello zero di reazione), che pertanto le rende più esposte a essere travolte in caso di aggressione, come è avvenuto nel Tibet invaso dalla Cina. Nello schema di fig. 3 è indicato anche, sulla linea verticale dello sviluppo, il caso del “mattatoio” per evidenziare il fatto che una conseguenza dell’attuale sistema economico è la miseria estrema, uno sviluppo negativo, vera anticamera della morte, in cui versa circa un sesto dell’umanità: una violenza strutturale pari a circa centomila vittime al giorno per la fame e le malattie connesse. E’ una strage pari a una Hiroshima quotidiana prodotta da una violenza strutturale di intensità almeno dieci volte superiore a quella diretta di tutte le guerre in corso. Spesa militare e costi di opportunità Non si presta sufficiente attenzione a un’altra delle nefaste conseguenze dei modelli di difesa militari, provocata soprattutto dalla difesa offensiva realizzata nella sua forma più estrema dagli USA. Sono i “costi di opportunità” che tutta l’umanità, ma in particolare quella che vive nelle condizioni di estrema miseria, paga a causa della sottrazione di una quantità talmente ingente di risorse che, se impiegate correttamente, potrebbero consentire di avviare a soluzione gran parte dei problemi più gravi, realizzando effettivamente gli ambiziosi obiettivi del Millennium (Sachs, La fine della povertà, Mondadori. Milano 2006). Un utilissimo esercizio sui costi di opportunità viene proposto dal World Game Institute con una mappa di “Che cosa vuole il mondo e come pagarlo usando le spese militari” che si può consultare all’indirizzo internet http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/mod02/www.worldgame.org/wwwproject/ind ex.shtml . Ma l’analisi più profonda è quella svolta da Seymour Melman in tutta la sua infaticabile opera. Nel suo ultimo libro, Guerra S.p.A. (Città Aperta, Troina, Enna, 2006) egli analizza le conseguenze perverse e disastrose dell’”economia permanente di guerra” che gli USA perseguono ininterrottamente sin dalla fine della seconda guerra mondiale. Tra i critici più espliciti che hanno denunciato queste pericolose conseguenze della corsa agli armamenti, abbiamo nientemeno che un ex generale, diventato presidente degli USA, Dwight D. Eisenhower che in un famoso passo del suo messaggio di congedo del 17 gennaio 1961 metteva in guardia il popolo statunitense dal grave pericolo che il nascente complesso militare-industriale comportava per la democrazia USA. Egli denunciava con forza che "L'America deve vigilare contro l'acquisizione di un'ingiustificata influenza da parte del complesso militare-industriale e il pericolo di diventare prigioniera di un'elite scientifico-tecnologica" (http://web.peacelink.it/pace2000/webstoria/4evocon/pentag.html ). Inoltre, in un discorso di alcuni anni prima, pronunciato il 15 aprile del 1953, aveva detto: “Ogni cannone che viene costruito, ogni nave da guerra che viene varata, ogni razzo che viene preparato rappresenta un urto a coloro che hanno fame, a coloro che hanno freddo e non hanno da coprirsi. Infatti un bombardiere pesante costa quanto trenta scuole o due centrali elettriche capace ognuna di fornire luce ad una città di 60 mila abitanti, o a due ospedali; un solo aeroplano da caccia costa come 150 mila quintali di grano; con i dollari necessari per allestire un cacciatorpediniere, si potrebbero costruire case per 8.000 senzatetto….” Dopo la stagione del 1989 e la fine della guerra fredda, quando la spesa militare si ridusse di quasi il 30% facendo sperare a un’inversione di tendenza, essa è tornata a crescere rapidamente (e pericolosamente) sino a superare i massimi storici raggiungendo l’iperbolica cifra di oltre un trilione di euro all’anno, di cui il 50% da parte degli USA. Per renderci meglio conto del significato di queste cifre, traduciamole in spesa militare pro capite giornaliera. Ogni cittadino/a statunitense spende da 5 a 6 dollari al giorno in spese militari contribuendo a creare, paradossalmente, una condizione di maggiore insicurezza e instabilità. Per i/le cittadini/e italiani/e i valori sono molto più bassi, intorno a 1 euro al giorno, ma pur sempre significativi poiché corrispondono al reddito pro capite giornaliero di quel miliardo di persone che vive con meno di un euro (o un dollaro) al giorno. Nel caso USA, la spesa militare pro capite giornaliera è circa il doppio di quanto i due terzi dell’umanità ha a disposizione ogni giorno per vivere. Da questi dati appare ancora più chiaro il prezzo che l’umanità intera sta pagando per mantenere la perversa correlazione tra modello di sviluppo centrato sulla crescita illimitata e difesa offensiva. La transizione verso un modello di sviluppo ispirato alla semplicità volontaria e a un sistema di trasformazione nonviolenta dei conflitti mediante la difesa popolare nonviolenta costituisce l’ambizioso, ma indispensabile e concretamente fattibile, progetto che i movimenti per la pace di tutto il mondo debbono assumere come prioritario nella propria agenda politica.
Scaricare