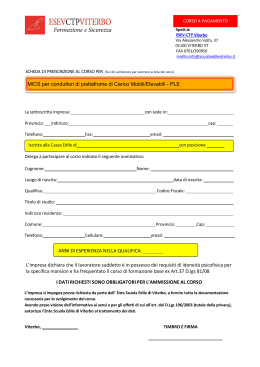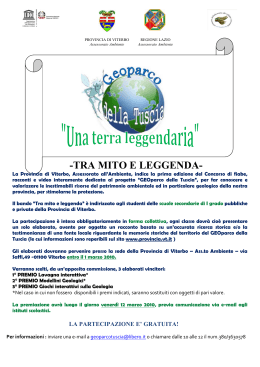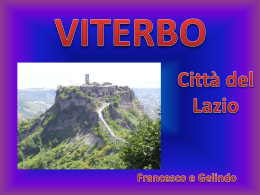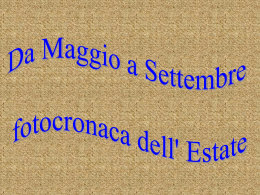MARIA TERESA
MARSILIA*
S. Maria
della Palomba
Viterbo, S. Maria della Palomba
Della piccola chiesa di S. Maria
della Palomba non sono visibili
che i ruderi inglobati nel circuito
delle mura urbiche, accanto all'antica Porta di Valle: verso l'esterno emerge ciò che rimane
dell'abside semicircolare, distrutta
dai bombardamenti e parzialmente ricostruita nel corso dei restauri
post-lxllici. Su via S. Antonio si
apre tutto il vano della navata,
sventrato e scoperchiato ormai da
parecchio tempo: già allo stato di
rudere, anche se ancora dotata
del catino absidale, delle relative
pitture e del portale, la chiesa appare nel 1920 nelle foto pubblicate da Scriattoli
Questi resti, relegati in un angolo piuttosto dimenticato della
nostra città, appena visibili, se
non del tutto nascosti agli occhi
distratti degli automobilisti di passaggio, sono la preziosa testimonianza di una delle fondazioni ecclesiastiche più antiche di Viterbo. Già l'evidenza, infatti, mostra
come la sua costruzione debba
avere preceduto il completamento di quell'ultimo tratto della cinta
di mura, che incastrò l'abside nel
suo percorso: stabilire a quando
risalì la fondazione, però, è alquanto problematico. Lo stile e la
tecnica che mostrano le murature
originali della chiesa inducono a
supporre per essa un'origine assai
remota nel tempo, tanto che Cristofori2 la fa risalire alllVIII o IX
sec., mentre Pinzi3 si pronuncia
per una generica anteriorità ri-
'.
* (le ricerche d'archivio sono state
condotte i n collaborazione con Giuseppe Romagnoli e Giacomo Malaspina; alla redazione del dossier presentato in
stampa
partecipato anche Fabrizio Trentacoste e
Stefano Marson).
spetto al Mille. Comunque le prove documentarie non risalgono a
tempi tanto remoti, e non potrebbe essere altrimenti, dato che l'atto più antico delllArchivio della
Cattedrale è datato 1031: e forse
non è un caso che vi è la possibilità di associarvi il nome di S. Maria della Palomba, in quanto si
tratta della vendita a Illdizzo e
sua moglie Itedilda di "[una
calsa ... que est edificata in balle
s u p t o castro Biterbu iu[sta
ecclelsiam Sanctam aria^ ". La
chiesa, per quanto non venga nominata specificamente, potrebbe
essere proprio quella di S. Maria
della Palomba, poiche collocata
sotto il Castello di Viterbo, e non
al suo interno, come invece nel
Andrea Scriattoli, Viterbo n e i suoi
monumenti. Roma, 1915-20, pp. 160162.
1
Francesco Cristofori, Le chiese in V
-i
terbo, «La Rosa, strenna viterbese per
I,anno 1886)), 1886, Viterbo, p. 106.
2
Cesare Pinzi, Storia della città di Vit e r b o n e l Medioevo, vol. I, Roma,
1887, p. 80.
3
caso dell'altra fondazione rnariana
altrettanto antica, S. Maria della
Cella. Purtroppo poi i documenti
tacciono per un ternpo assai lungo: non si conosce nessuna menzione della chiesa fino al 1208,
quando la pergamena 1009 dell'Archivio Comunale nomina un
tal "Guarnerius, Sacri I'alatii Lateranensis notarius et Ecc1.e S.c.e
Marie in palumpa prior" j.
Tra gli atti duecenteschi, che
segnalano leggere variazioni del
nome, da S. Maria in Palomnis a
S. M. in 13alomba o de l'alumba,
si rivela particolarmente interessante quello del 1296 O , che parla
di un legato a favore dell'ospedale della chiesa, attestando così la
presenza di questa attività caritati-
P. Egidi, L'Archivio della Cattedrale
di Viterbo, «Bollettino dell'lstituto
Storico Italiano)) , 1906, doc. XIII, pp.
11 e 38-39.
5 Documento citato nel manoscritto di
G. Signorelli, Chiese, conventi, confraternite, Biblioteca Anselmi, mss. C 10
(inv. 108), C. 101 t . Signorelli legge
"Camere" al posto di "Sacri".
a. 1296: "legato hosp. S.M. in P. ",segnalato in G. Signorelli, ms. cit., c. 101
t. e tratto dalla perg. n. 161 del Fondo S. Maria in Gradi, presso l'Archivio
.ol!n6as u! o ~ ! ~ a s u !
uou a aleu!6!io eJnieJnw elle alenisai
- u o ~eJqwas 'ac(3!uo$iai!c(3ie a y q s ! ~
-aUeJe3 aso!Jn) o p u e ~ u a s a ~~dn 'aie1
d
'6 L '3 'XXX JwJo+!t] oz
od I! alenb ellap ol!quie,llau 'oiuaw
'EOS L eiep el
-nuow lap ale!Jaiew eJniLnJis ellap
-le ozuaJo1 .s !p oiseie3 lep eiieJl e!z
!s!leue,un e o!l6aw a ~ a p u o d s ond
! ~ ep
-!iOi.i J' 201 '3 "$!3 ' s u ' ! ~ ~ J J o u ~
' 3! s6,
- u o m e1 'exye~6!daeJnfal ellap e3!6
-01 ellau al!q!sneld n!d !~quias!saiod!
'ZL-IL L '3 'IIAXX auiJo4!t] 8,
e u i ! ~ de( oiuenb Jad .oiuauieiie!J ons
'SL '3 ~ X 'awJo~!t]
X
L,
ens
d ee1 a i u a w e ~ ! i i a d s
un o e ~ n ~ ~ a
',,"'d ellaP 'qqV e3
-!J a~e3!y!u6!se aJeLs a q q a ~ l o d'oiue3
->e a l e ~ ~ oled aiuaweJn3!s !saiuaJay!J -!uoinal euuv : E ~ P,, L',,(E '3 '!u!$el ou
-!$e1 g . $ o J ~eqwoled
)
ellap ay3euow
'elo~edew!~ln,l( v l v l d v o vltl3dv) PJ
-ni$al esJaA!p elpp epuoxs t, .a~!ldnp allap alessaw : E ~ P L ,:-i, Z O L '3 "q! 9 ,
aJassa ond 'e~nuaiuo3essa u! auo!z
'89P L
-e!AaJqqe,lle 0pJen6!~a~elo3!iiedu!
OUUe,l ad 'J$UJU~JUOJJJ
'a~J04!t]
'eL$!J3S eisanb !p J U O ! Z ~ ~ ~ J ~ J J ~allap
U ! , ~ossed olsanb eleu6as (J 201
,,
.3 '.~!3.su) ! 1 l a ~ o u 6addasn!3
!~
'69bL
o!euua6 L Z eiep elle J' $32 '3 'IIAX 'aw
-~04!t]',,eq'nled u! a!Jeyy allues a ' p
-33 JOilat] SnaUiOlOqVea JaL!qSJJd,,
P6 'd "J!3 '".P3!UOJJ
'L6
'3
,
'X aUJJo4!t]E,
?q! ,,,ay3
-euoui alias u03 equioled ellap 0i.m
Il ,, :!PeJ3 !P EEZEILES ' 6 ~ a d'09E L 'e
'>>aowop ul,,
:.q! ',,eqwnlo3 u!
:"uiO3 'Y3Jt/,llap L95 .6Jad '6SEL ' P
:'q! ',,d U! 'W'S !P 'm le
oie6al,, :ola6uv .S ~ E Z '6Jad
L
'~PE
L 'e
:i
' ~ 'd
g '0681 'ewot] '!~o/ojs
1 0 '3
~ "y3 .sui ' ! l l a ~ o u 6 '!3~ u! ' , , " ' s L ' ~
-IJJ oJsar,ueJj ajuor, lap o!pnjs a eJn3
u! o ~ e l o n b! i ~ ! p a u a a'5 . p ~ oequrnl
J J ~
~J ~ J J ~ ~ PJ
I I ! Pupa ' I I I X X ~ ~ ~ ~ J W
-ed u! 'W.S 'uon,, : ' J ~ ! I I V'PPEL 'e o,
ouue,lle ou!s e!xnl ellap oaluolojJeg
!p elor,!N ep ejenuguoJ ~ 7 3 ouue,l
3 ~
-€
/p'
'aSJqJJJ!A O)JO//!ZUv !P eJ!UOJJ Z,
' € 9 ~ ouue,l
1
ad eiouue
01 ('L ~ 0 I.1 "i!> 'su) ! 1 l a ~ o u 6' 3! ~
,,
Ul,, :ZZL
'3
'q! d
;,'
ap 'W'S oJisnel3
'O!ZOJeyy ' i 0 J d '06EL 'e
t? a ~ u a u r c ~ ~ a j soJaqcjaJJan
ad
!uue
!1;f ari3 o ~ e p'!3~11~33
!ep !ssow
- o ~ dauo!zesr-illnsls!~ !luailsal
-u! !18ap auo!smno u! q e ~ a l e lalel
o!iz!qnJv,lIap olsele3 lau :ec{uro[ -0!3Snl[[.31>!uo!zepuou! ayn!l3o!J
-ed elle aluaurnn!sy ouoJi:!pasu! !s -ad a111: i?ja,uoj olsodouos 'o~iin
!]~tis;)3I ayn 5 0 ~ 11 x 1 010s IIJ
-!s a~!peilalod !s uou eila8~os!nn
.sL,,ele3nad la e~alansurt1-1 u! olsod I! cm r c ~ ~ ~ c ~!Ca l!Aa n
-oa ~ a i d o ~ dele!paurur!
,,
auo!zow
ayn auo!zr-:J!j!snd elpp ~ilsajalli:
-!J o ~ o ellns
l
aluarrrcJaizas aJals!su!
aJ!uahialu! e !ltiual oueJa ~ s s aayn
c o!l8!suo3 I! opui?nuyuo2 '(anp yjeju! aWa1 !s !ueIouo !18ap 0 2
+ V.I;cIv
OIoS oui?Ja 6 6 9 I IaU) EqUI<>Icd -nli:ls o11au :r?le~uai~basj
olso~lti!d
,LInd IIXCIN IIVN IIIX 3IcI +
e1 ouoJcuopueclcle a ozua.107 '(; !p a-rasca r?ilailop t:sa!yn clo;>o!d i i l
: el!pau! c ~ o u esalrln ellap aJoilq i? oJalseuouI
.oLo~~so!y3
un
0651
-!j I:I~!J~S i?[ 'auo!zela3a~cllep els Ins oll!~!p o ~ o l!u8o c amyzunu 1cp o u a r u ~ e~ l e l o p' ~ J O I I Sallas
-034'1?U!UIaS ' ~ 1 0 3 ~ 1
alS!Sa
:
'T?~a!y3 -!J oJallailop arlnr:uow a7 ',, IIUI1lJ a~el!dso e p r?zuelseclqc apues8
c11ap o ~ l s a ponui:!j Ins '!ll~ju! a - o ! ~ c rrrn1epue3s la s!uo!kl!la~ a 'ma! y n e11e cssauuc aIenluailuo3
:alr:!z!u!
o u e ~ aa ~ a d oa[ ouue,I urt~!qo~ddo
l!s au,, ayncuow allap esnllnJ3s eun eizals!sa opo!sad
-1anb u! ayn omc!dde(; .,,T !pnns auo!s~ndsa,~
~pueurop!s 9()pl Iau olsarib u! ~ ! ayn
8 !pu!nb aluap!Aa
sz !p olncljauon un odonc ols ?rlnu!g '9Lessapeya u r o ~~ p u o l t ~ a ?~ .:,,equrnIo3u! 'M'(; '333 OUIOP
-aiib e 0101 !lf.rela aunruo3 p 9151 cuuv alel eun eiel!r, ? odop yuue u!,, a3!p aunuro3 1 . 3 ~
'8Jad
1au :os~~sl:UoUI
1ap O ~ U ~ U I ~ ! ~ ~ !na!p
U I ~ ?a alcssaur o ~ o lu11 !p elsed
e1 64£1 1au a ' o ~ a ~ s c u oolsanb
w
!l> a csa!rln i:IIap o.rriclsaJ !p !.roi\
£891 1 x 1 O J U E I I ~u! 'ayneuow al !p !UO!ZUaUl 31 OlU339JJ4 lal) Tl3UI
-1:~ a.~i?!zucu!ji: a !uaq !ynnascd -1ap ezuasa~de1 als!ssad 'sLequrol i:ur!~d cIIau oueilu!luo3 .(, errrox e
,3.Il?[llUIil.33':
1: !SO3 OU<>J!I)SIl!J
-Ed cIIap aJollaJ oaUIo[C)lJeg U I I I ~ O S IU! E ! J ~ ~'S\ !p
I osalscuour on!]
-11:~u! oucjai(; .S !p a1i:padsoI1 ol c 01uenn1: :1?33asa!y3 e1le a olalscu -alod! un cp !luapuad!p a ouapau
-J!JJI:
U! O J ~ C ~EJI
I opuapuald ' y ! ~ -OLU 1" ~ p ~ ~ t l (ki la !~~< ) ! ~ t ? ~ ~ a -ag
~ l b.s
a ~!i3j au!p.ro,IIe !luaual.reddii !s
-!ui: a!.rciz o ~ a s s o w o ~'ossa[duron
d
!p aynue as-roj) azua~adrrron!p -uan~alspayneuour 113 czuasa~de1
[;SU !s!le!pasu! c q o ~
c u ~ i' ! ~ I : u ~ u I a u o ~ z ~ s o d d e s ~
i?so!Jn2
os
t?uti 6991 ouur? olsaiib uy ~ ! ouclsall~:
8
s!ll~
I '(,, o1uailuo2 o ~ o l