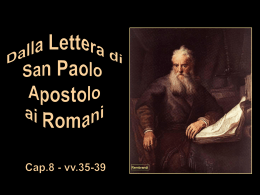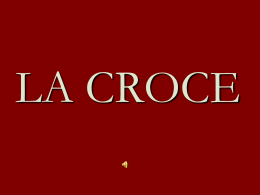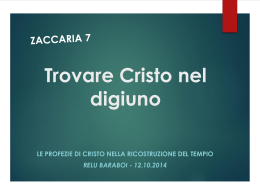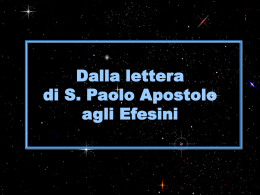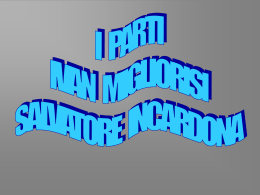LA VISITA PASTORALE «Oggi devo fermarmi a casa tua» COME NASCE E COME VIVE LA COMUNITÀ CRISTIANA SCUOLA DI METODO – CRISTO E LA REALTÀ Mestre VE, Centro Card. Urbani 7 febbraio 2009 1 LE IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE DEI MISTERI CRISTIANI APPUNTI PROVVISORI AD USO ESCLUSIVO DEI MEMBRI DELLA SCUOLA DI METODO Sintesi di don Renato Divido questa sintesi in due parti: 1. la prima parte riprende alcuni passaggi che è possibile cogliere dal dialogo che c'è stato tra noi; 2. la successiva approfondisce il tema delle implicazioni dei misteri cristiani. Prendendo spunto dal dialogo iniziato la volta precedente, il Patriarca sottolineava in particolare il tema della sinodalità e come la Scuola di metodo sia legata strettamente a questa «modalità di esercizio comunionale dell'autorità del Vescovo» e, quindi, «della responsabilità qualificata testimoniale che c'è tra noi e del lavoro personale e comunitario che dobbiamo fare». Proprio iniziando dall'approfondimento delle implicazioni, in particolare quella dell'unità duale, dobbiamo affrontare l'esistenza e l'esistente a partire dall’incontro con Cristo. È questa la logica delle implicazioni. Prendendo spunto da un intervento dell'assemblea “la via ammirativa” - è emersa dal dialogo questa modalità di esprimersi - scaturisce dalla via dell'incontro: Cristo l'uomo reale, l'uomo vero, si è implicato con noi perché noi ci implicassimo con lui. Questo, in sintesi, quello che è emerso dal dialogo. Approfondendo il tema della scorsa volta - le implicazioni antropologiche dei misteri cristiani: Maria-Chiesa e i sacramenti (anche se poi ci siamo soffermati in particolare sul tema della Chiesa) il Patriarca ha cominciato con una ripresa che sottolineava come fosse necessaria e urgente la comunicazione della fisionomia dell'uomo nuovo in Cristo. A questo collegava un dato molto concreto e molto pastorale della difficoltà che emerge dall'accostamento alla confessione che evidenzia come ci sia un'intenzione certo a seguire e a imitare Cristo, ma nella pratica e nella concretezza (anche nostra) la realtà del mancato avvicinamento alla confessione è proprio un segno del fatto che non c'è una partecipazione reale ed effettiva. Successivamente è ritornato sul concetto di implicazioni. Entrando poi in merito al tema, abbiamo cominciato con delle premesse. La prima: il tema “MariaChiesa e i sacramenti” avrebbe bisogno di essere affrontato unitariamente, quindi interrelando, mettendo sempre accanto il tema di Maria-Chiesa e il tema dei sacramenti. Siccome questo non è possibile, per una questione di metodo, si è proceduto dividendo gli argomenti (così come stiamo facendo oggi) e quindi attraverso una distinzione. 1 Il presente manoscritto, provvisorio e non pubblicabile, è riservato ai partecipanti alla Scuola di metodo. Per capire meglio l'implicazione, il riferimento sintetico all’esposizione dell'altra volta era dato da questo schema: l’idea della Chiesa come soggetto, il tema della Chiesa come disegno di Dio, l'approfondimento delle quattro note della Chiesa. Partendo dalla Chiesa come soggetto, abbiamo approfondito i quattro numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il 167 (all'inizio della trattazione del Credo), sottolinea la natura di soggetto che è la Chiesa, il noi ecclesiale che, secondo la definizione di Von Balthasar, è intorno a Maria che dice sì. A questo consegue l'idea di una Chiesa sposa e - il Patriarca ha solo accennato a questo - di una chiesa mariana. Il secondo numero - il 748 – è quello che approfondisce propriamente il tema della Chiesa, dopo l'approfondimento del tema del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il 748 sottolinea l’inseparabilità del mistero della Chiesa dal mistero di Cristo e di come Cristo è in qualche modo incomunicabile senza la mediazione della Chiesa; quindi la responsabilità di ciascuno di noi, la responsabilità testimoniale come Chiesa di testimoniare Cristo. Il terzo numero, il 749 (solo accennato), fa riferimento a come questa inseparabilità da Cristo sia legata anche all’inseparabilità dallo Spirito Santo. L'ultimo numero era il 750 e sottolineava quel “credere la Chiesa” e non credere “nella Chiesa”. Il credere la Chiesa come riflesso di Cristo e quindi della Trinità. Si è sottolineato poi che la Chiesa è il “soggetto proprio della fede”: noi possiamo dire io credo perché partecipiamo della fede della Chiesa. Questa partecipazione alla fede della Chiesa è nel vissuto quotidiano, nell'esperienza concreta e reale. Ci sono stati poi due punti di riflessione. - Qui approfondiamo la seconda parte che poi conseguirà nelle implicazioni cioè quella del disegno di Dio. Il riferimento della Chiesa alle missioni trinitarie. La Chiesa è la modalità con cui Dio fa vivere ad ognuno la realtà che c'è un disegno buono: l'idea del disegno di Dio sta proprio dentro il concetto di missione che abbiamo affrontato. La Chiesa è inclusa (non successiva) nell'evento di Cristo. La Chiesa si riceve: per questo è Sposa e Madre. C'è stato, qui, un accenno a questo tema che verrà affrontato poi. - Il secondo punto di riflessione era quello delle Note che esprimono meglio il disegno salvifico della Trinità. o o o o La Chiesa una che richiama al fatto che tutti gli uomini sono chiamati verso l'unità; la Chiesa santa: la partecipazione alla santità di Dio; la Chiesa cattolica: che non ha confini ma anche che è integra; la Chiesa apostolica: che è radicata nella storia di Gesù con i Dodici. Le implicazioni Le implicazioni ricavate da questi tre elementi (la Chiesa come soggetto, la Chiesa come disegno di Dio, e dalle note della Chiesa) sono: 2 1. La Chiesa come soggetto ha delle implicazioni fondamentali e storiche. Implicazioni fondamentali sono: • l’accesso alla verità è un accesso comunitario, proprio per il fatto che l’altro (l’alterità) è dentro il nostro io, è dentro la persona; • l’appartenenza come condizione di conoscenza. Implicazioni variabili (questa idea di variabilità e storicità sta nell’urgenza storica, non nel fatto che non siano fondamentali) sono: • la necessità di combattere l’individualismo, ma anche un eccesso di comunitarismo (comunità come rifugio, non veramente una comunione); • il peso della tradizione; • non ridurre l’esperienza religiosa al privato (privatistico). 2. La seconda fascia di implicazioni sono quelle che partono dalla Chiesa come disegno di Dio e, quindi, dall'idea di Chiesa sposa e di Chiesa madre. Implicazioni fondamentali: • l’inseparabilità dell'esperienza dell'amore, del volere, e del dovere: l'approfondimento del tema del compito • la corresponsabilità di ogni fedele perché la maternità della Chiesa è la maternità verso tutti e quindi tutti siamo corresponsabili della missione della Chiesa. Implicazioni storiche: • la cultura della vita; • il genio profetico femminile nell’attenzione verso l'altro, nell'andare verso il bisogno. 3. L’ultima fascia di implicazioni sono quelle che scaturiscono dalle note della Chiesa (la Chiesa una, la Chiesa santa, la Chiesa cattolica e la Chiesa apostolica) sono: Implicazioni fondamentali: • il destino comune di tutti gli uomini: la necessità del dialogo (del dialogo interreligioso ma anche delle altre modalità di dialogo); • la Chiesa santa: il primato della redenzione sul male. Questa vittoria di Cristo sul male non significa che a noi ci sia tolta la lotta: il Patriarca citava gli approfondimenti dottrinali su questo; • la verità è comunicabile di generazione in generazione, collegata quindi alla nota dell'apostolicità. Implicazioni storiche: • una nuova riflessione sulla natura dell'uomo (chi è e che cosa è l'uomo) non solo a partire dalle sue origini ma anche dal suo destino, ciò verso cui si sta andando; • l'accettazione del proprio tempo come tempo da vivere dato dalla Provvidenza; • il tema dell’educazione. 3 Dialogo Paolo Fusco (Comunicazioni sociali - Gente Veneta) Da tre settimane ho un rovello - qualche notte mi ha tolto anche il sonno - che parte da queste implicazioni, ma ha origine in particolare da un fatto preciso che, tre settimane fa, è stato riverberato da un servizio di Gente Veneta e che si intitolava “Lezioni di sesso senza amore”. Anzitutto mi sembra che questo sia stato un tema che tocca le implicazioni e poi spiegherò il perché. In secondo luogo è una vicenda in qualche modo trasversale a molti altri temi come quello dell'urgenza educativa, quello della laicità e, più in generale, quello della presenza dei cristiani nella società. Riassumo brevissimamente: in una Scuola media mestrina (in una terza) sono state fatte delle istruzioni di sesso contrabbandate per Educazione affettiva e per Progetto sulla salute. 1. La prima questione che mi colpiva - che poi non è venuta fuori su Gente Veneta ma che nasce da lì – è: quanto la fede incide veramente sulla vita, ovvero quanto davvero ci lasciamo educare dal pensiero di Cristo e riteniamo valide per noi e per i nostri figli queste implicazioni dei misteri della Chiesa e della fede? Non si tratta solo di educare al pensiero di Cristo, ma anche fare secondo il pensiero di Cristo: una volta usciti di qua sono bastate le cose che ci siamo detti o le sappiamo anche mettere in pratica? Secondo le reazioni che ci sono state, mi sono accorto che è sotteso un certo pensiero secondo cui, in fondo, visti i tempi, è bene istruire anche i nostri adolescenti su queste cose; l’Humane Vitae sì ma, insomma,… Al livello poi di docenti cristiani che insegnano nelle scuole statali, la domanda è: ma qual è il soggetto educante? È la scuola da sola o è la scuola insieme alla famiglia? 2. C'è stata anche una conseguenza che le singole persone hanno dato come reazione a questo tema: c'è stata una certa diaspora nella scuola, nel momento in cui si andava al confronto con gli insegnanti e con la preside. C'è chi ha taciuto, chi si è detto contrario al metodo e cose di questo genere. La riflessione è che mai come questa volta si è sentita la mancanza di un luogo per la discussione di questi problemi tra i genitori perché noi qui facciamo Scuola di metodo e magari tra di noi ci diciamo certe cose, ma poi si fa fatica a far arrivare questo anche all'ultimo dei genitori, per esempio, di una scuola. 3. Terza e ultima cosa. Il bisogno di una presenza organizzata all'interno della scuola anche per poter dare verità a quell'implicazione che è stata ripetuta prima da don Renato e cioè l'impossibilità di una riduzione della dimensione religiosa alla sfera del privato. Nella scuola poi si è arrivati alla conta e questa conta, secondo la dirigente, ha dato esito negativo e cioè che pochi si erano preoccupati di questo fatto. Un’ultimissima annotazione sul tema della laicità. Si va al confronto ma alla fine il confronto può anche essere di minoranza. Che cosa fare in questi casi? Maria (parrocchia di Sant’Antonio di Marghera): Parlo come mamma e come educatrice. Il mio intervento è legato al discorso fatto precedentemente da Paolo. Quando ho riletto e meditato, quando ci sono arrivati anche i documenti, una cosa mi ha colpito e toccato particolarmente: l'ultima frase “l'educazione è l'opera primaria di generazione e rigenerazione del soggetto cristiano” e una frase che la precede di alcune righe “se non si impara a coniugare il volere al dovere…”. Senza generalizzare, penso che per chiunque svolga un lavoro educativo (penso anche a chi lavora nella scuola) vediamo questa difficoltà e anche mi pare questo problema è passato trasversalmente anche nei nostri convegni anche riguardanti l'iniziazione cristiana, riguardanti i giovani, che è proprio quello dell'educazione. Mi piacerebbe che l'educazione - in particolar modo quella operata dalle famiglie - fosse un tema da riprendere e da approfondire. Mi è parso che la frase dove Sua Eminenza dice che “se non si impara a coniugare il volere al dovere” appartiene alle mie generazioni anzi Lei è stato illuminante per tante difficoltà che uno può incontrare nella vita perché la vita non scorre facile 4 per nessuno. Però la vedo meno applicata e vissuta nei figli grandi che diventano poi papà e mamme. Coniugare il dovere al volere sembra molto fuori moda, mentre Lei mi ha confermato che questa è la strada per andare avanti. Grazie. Marilena (Terziari carmelitani): Io avevo inviato un’e-mail 15 giorni fa sul vescovo Williamson, ma mi pare che adesso la faccenda sia già stata ben chiarita dal Papa. Volevo invece un breve commento dal Patriarca su un intervento di Emanuele Severino un filosofo bresciano di ieri sera, alle 20.30, nel quale parlava della violenza della Chiesa: “la Chiesa ha un impulso irrefrenabile ad affermare la teocrazia sul governo del mondo, imponendola con violenza anche a chi non crede”. Ovviamente ci si riferiva al caso della povera Eluana che lui sosteneva essere - adesso è anche un caso politico - una ragazza lacerata tra due opposte violenze in cui gli unici che non hanno certezze sono i medici. Patriarca: Volevo cominciare anzitutto ringraziandovi per la fedeltà a questo gesto, nonostante oggi il clima non sia favorevole. Mi pare che il numero dei partecipanti sia rimasto sostanzialmente stabile anche in occasione di questo 10° incontro di Scuola di Metodo, più i tre Convegni ecclesiali che abbiamo fatto e che, come abbiamo sempre detto, ne sono parte costitutiva. Il nostro cammino sta diventando un percorso, sta assumendo realmente quella fisionomia di scuola a cui tanto teniamo. Spero che, attraverso il lavoro di Sua Eccellenza e all'assistenza di Simone Scremin, arriviamo realmente a coinvolgere stabilmente in questo stile di lavoro tutte le realtà parrocchiali (che ci sia qualcuno che sia espressione di tutte le parrocchie) e di tutte le realtà aggregative del nostro patriarcato per quel lavoro sinodale di accompagnamento di tutti i nostri fedeli teso alla rigenerazione del popolo di Dio che, nella comunione gerarchica della Chiesa, è insostituibile e deve vedere ogni fedele corresponsabile, ciascuno al suo livello, a partire dalla propria vocazione. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa fa anche da premessa al mio tentativo di risposta. È molto importante - anzi è decisivo - che il momento assembleare porti a galla le questioni brucianti che uno sente sulla sua persona, nella sua famiglia, dentro la nostra società, per l'educazione dei suoi figliuoli; in breve, per la vita buona, personale e sociale, come tutti i primi tre interventi di oggi hanno mostrato. D'altro canto è però importante che l'impeto che nasce dalla vita sia realmente paragonato alla proposta di contenuto che durante la Scuola viene fatta, in modo tale che la Scuola (la lezione che viene offerta già a partire dalla Scheda e poi la successiva sbobinatura del testo) e il suo contenuto lentamente informi il nostro modo di pensare, di giudicare, di confrontarsi, così che impariamo a fare sintesi tra la carne della nostra vita e la sua radicazione ecclesiale, nella potenza dello Spirito del Risorto che è tra di noi. Come si può raggiungere questa unità? Lo scopo della Scuola di Metodo è proprio quello di educarci insieme al pensiero di Cristo che - come ci siamo detti molte volte - non è un pacchetto astratto di principi (anche se ha nella Parola di Dio, nella catechesi, e quindi nel Catechismo, uno strumento utile di approccio) ma è l'immedesimazione vitale, esistenziale, pratica, quotidiana, con la potenza del Suo Spirito, che la vita di comunità ci consente, così che poi i problemi dell'esistenza diventano, come è stato per lo stesso Figlio di Dio, la carne delle nostre comunità. Questo perché si possano sempre più staccare da una pratica dualistica della fede, per cui in parrocchia o nell'associazione si celebra l'Eucarestia riducendola ad un rito esteriore, si medita la Scrittura riducendola ad un libro da imparare, si legge un pezzetto di Catechismo riducendolo ad una forma, e poi c'è la vita che si svolge fuori sulla quale io intervengo con un tipo di giudizio che non fa più riferimento a quel pensiero, che non fa riferimento a quella comunità. Questo è il terzo anno nel quale stiamo lavorando sulle implicazioni; e finora, con la lezione di oggi, abbiamo sviluppato soltanto i 4/5 delle implicazioni antropologiche dei misteri della vita cristiana. La prossima volta dobbiamo parlare dell'escatologia (dei temi Morte, Giudizio, Inferno e 5 Paradiso, i Novissimi) e poi ci resterebbero tutte le implicazioni sociali e tutte le implicazioni cosmologiche. Insistiamo sull’implicazione perché - come oggi ha mostrato bene anche la sintesi di Don Renato, nella sua seconda parte - è proprio quello che a noi sembra il metodo per fare unità tra fede e vita così che gli inconvenienti, per esempio, denunciati da Paolo a proposito del tema centrale dell'educazione dei nostri adolescenti, ci trovino vigilanti e capaci di una proposta che noi sentiamo buona e vera per tutti perché sperimentiamo come buona e vera per noi e per i nostri figli. È questo che ci autorizza alla testimonianza. Siamo chiamati ad immettere nella società plurale (così accenno anche al tema della laicità) la nuova laicità, che non è il luogo della neutralizzazione delle proposte dei soggetti che abitano la società, ma è il luogo del racconto, del confronto continuo e permanente, che nasce dal grande valore pratico che siamo tutti insieme e che tende a generare proposte di vita buona comune. La nuova laicità, quindi, implica un portare pubblicamente in campo il nostro modo di concepire i beni spirituali e i beni materiali che abbiamo in comune: il modo di concepire il nascere, il morire, l'educare, la sessualità, la cura dell’ammalato, il fine della vita, la condivisione e il bisogno di tutti, la giustizia, e così via. Allora: implicazione invece che religione civile o invece che diaspora - in chiesa tutti annunciamo la bellezza del Cristo risorto ma questo è un fatto mio individuale, poi ognuno, dentro la vita, agisce secondo l'opinione che gli sembra più giusta -. Abbiamo chiamato questa una diaspora (diaspora vuol dire dispersione) nascosta: una dispersione che nasconde (cripto-diaspora) la propria identità cristiana. Lo sforzo che facciamo sull'implicazione quindi - e così rispondo all'urgenza di Paolo - è uno sforzo teso al cambiamento della nostra vita, teso a far sì che io viva in unità la fede e il concreto (la carne) della mia esistenza. Quello che ci diciamo qui, come quello che sentiremo domani nell'Omelia, come l'immedesimazione alla Scrittura, come quello che approfondiamo nei Gruppi di ascolto o nei momenti di catechesi o quello che studiamo organicamente alla scuola Santa Caterina di Alessandria, piuttosto che al Marcianum, o quello che ascoltiamo da certi relatori ( ed è per questo che invitiamo quelli e non altri; oppure creiamo delle condizioni oggettive di confronto rispettoso di tutti), o i libri che leggiamo … tutto questo è come teso a generare quell'unità di giudizio quell’idem sapite - quel sapore unitario del vivere che discende da Gesù e che la Chiesa, da duemila anni, ci richiama. Ha ragione Paolo: il lavoro che facciamo qui, pur avendo l'andamento organico della scuola, è teso, come per ogni scuola, alla vita. Per questo - raccomandazione finale - se non si ritorna, in maniera personale e comunitaria, sui documenti che qui costruiamo pazientemente dal basso, se non si ritorna organicamente cinque minuti al giorno, un quarto d’ora alla settimana, con il figlio, con il marito, con l’amica della casa di sotto, in parrocchia … - se non si fa questo lavoro di assimilazione nel confronto con la vita, è chiaro che tutto questo resta un gesto intellettualistico e separato, finendo con il diventare solo una riunione in più. Non potrò entrare in dettaglio rispetto a tutte le questioni poste, però ho risposto alla questione della laicità, ho risposto alla questione della diaspora, ho risposto al tema che la testimonianza cristiana - l'avevo già detto prima – è simultaneamente personale e comunitaria. Questo si è visto molto bene, all'inizio di questa settimana, nella Due giorni con i preti dei primi 15 anni dove tutti hanno riconosciuto che per l'educazione dei giovani il fenomeno associazionistico ed aggregativo (sia le aggregazioni storiche tradizionali che i nuovi movimenti) è uno strumento che diventa sempre più insostituibile. Molto più potente del gruppetto che tende a nascere e a morire con grande rapidità. La presenza personale e comunitaria è, quindi, fondamentale. E io credo che il lavoro che Gente Veneta ha fatto - e soprattutto che i genitori di quella scuola da cui il lavoro di Gente Veneta è partito, hanno fatto - sia un esempio preclaro di come si vivono le implicazioni. In questo caso l’urgenza educativa, che è particolarmente gravosa in questo nostro tempo, decisiva ed importante, come abbiamo visto, è implicata in quasi tutti i misteri della vita cristiana che andiamo esaminando. 6 Il problema è che, quando si dice che è implicata, bisogna mostrare come: ecco perché occorre che questo lavoro di assimilazione poi sia portato nella preghiera, perché lo studio non basta. Il punto discriminante l'autenticità di ciò che studio e di ciò che leggo è che ciò che non riesco a portare nella preghiera non ha valore. Quando leggete un libro fatevi questa domanda: riesco a portare nella preghiera questa lettura? Se non riesci a portarla nella preghiera, quella lettura non serve a nulla, non produce quell'accrescimento del punto di vista esistenziale e unitario con cui sono aiutato a vivere. Noi non viviamo nessuna moralità della nostra intelligenza. Ci concediamo tutto e il contrario di tutto: alla televisione, alla radio, nei giornali, nelle letture che scegliamo, il capriccio diventa il criterio della selezione e siccome siamo esseri limitati e il tempo è quello che è, se uno legge della robaccia, alla fine sarà informato della robaccia che legge. Con il termine “robaccia” non mi riferisco al sesto comandamento. C'è una robaccia ben peggiore del sesto comandamento: è la robaccia intellettuale perché distrugge la mens. La fatica dell’implicazione sta, allora, nel mostrare il nesso tra il mistero e la vita. Se io celebro l'Eucarestia, se io vivo la Chiesa come una, santa, cattolica ed apostolica, sono richiamato come ci ha ricordato don Renato - ad affrontare certe implicazioni che sono contenute, sono vissute da me attraverso il mistero della Chiesa - parliamo in questo caso della Chiesa - e quindi diventano nei debiti modi lo stile della mia vita. E, di conseguenza, l'inevitabile comunicazione che io faccio ai miei fratelli uomini, comunque la pensino, in maniera propositiva e non impositiva, di questa sensibilità che io vado maturando. Facciamo l'esempio citato da Paolo: delle famiglie hanno reagito a che cosa? Reagire alla riduzione di una equilibrata e paziente educazione sessuale per gli adolescenti, ritenuta da molti necessaria 2 , a lezioni di sesso intese in senso tecnico, magari attraverso l'intenzione cosiddetta medica o igienica, è sacrosanto. Se io fossi un papà o una mamma - e sono lieto che nella mia diocesi ce ne siano - reagirei a questa cosa affermando a chiare lettere che non hanno il diritto di fare una cosa così. Io non entro a giudicare il merito di quel che è successo in quella scuola, lo lascio giudicare - ecco la responsabilità comunionale - agli attori in campo. Ecco allora l'affermazione delicata di Paolo circa il fatto che non esistono luoghi di confronto. Ora, mi chiedo, le parrocchie che cosa sono? Che cosa ci troviamo a fare in parrocchia? Ci possiamo trovare solo a mangiare e a bere, a fare gli spuntini, a organizzare le partite di calcio e a fare le feste patronali in cui chiamiamo dodici bande a suonare? O ci troviamo anche per aiutarci ad educare i nostri figlioli? Facciamo una gerarchia dei nostri impegni. Mi meraviglio che le nostre parrocchie, che le nostre associazioni, non siano questi luoghi; perché non ci possiamo certo tutte le volte convocare tutti in circolo, in piazza San Marco, per parlare di queste cose. È chiaro che ogni cosa deve avere le sue adeguate proporzioni. Per esempio, io sto facendo la Visita pastorale in talune parrocchie molto piccole. È chiaro che non possiamo scaricare sulle spalle di tutti, soprattutto là dove sono esili, una capacità e un'urgenza di affrontare tutte le problematiche inerenti all’educazione dei nostri figliuoli. Ecco perché diciamo che dobbiamo operare per far crescere le comunità pastorali; ecco perché diciamo che la proposta educativa oggi non può essere solo parrocchiale con i giovani; ecco perché diciamo che dobbiamo recuperare dei luoghi stabili di convivenza come i patronati … e così via. Ecco i corresponsabili che voi siete: favorire questa circolazione di vita: nella mia parrocchia di Ca’ Noghera questo non è possibile ma a Campalto forse sì. Allora, mettendo insieme Campalto, Ca’ Noghera, Leopoldo Mandic, Tessera, forse diventa possibile invitare dei genitori a dialogare. Io ritengo che siano molti i genitori sensibili a come accompagnare i propri figli in una autentica assunzione di una sfera sessuale della loro esistenza. Qui ci vuole creatività. Ma mi preme far vedere l'unità della cosa: più accettiamo di superare la difficoltà in cui le nostre comunità 2 Lasciamo aperta, per mancanza di tempo, la questione circa il chi sia il soggetto cui compete quest'educazione. Certamente, chiunque sia questo soggetto che alla fine, concretamente, la traduce in azione non potrà non farlo in assoluta dipendenza dalla famiglia - questo è fuori discussione - perché, anche dal punto di vista costituzionale, il diritto all'educazione, fino alla maggiore età, tocca alla famiglia. NB: noi sappiamo che le Costituzioni sanciscono dei diritti che sono inerenti alla persona, non creano dei diritti. Il diritto precede ogni Costituzione, è proprio della persona. 7 cristiane sono cadute negli ultimi 30-40 anni a causa della grande mutazione che è in atto in tutto il mondo - e la difficoltà è data da una frattura radicale tra la fede e la vita – e incominciamo a fare unità nella nostra vita personale (la Scuola di metodo è un fattore, un'occasione, un elemento per generare questa unità) e più si vedranno i frutti: la vita discenderà da qui. Vi richiamo soltanto al fatto che voi siete corresponsabili di quella che l'altra volta ho chiamato la responsabilità testimoniale: quel che vivete qui, il lavoro che nasce da qui, deve contagiare gli altri che non sono qui. E questo comporta anche il coraggio di certe scelte. Magari faccio un'iniziativa in meno di quelle che avevo in mente di realizzare nella mia parrocchia per fare spazio a un momento di lavoro così, se lo giudico diventato più urgente. Magari non faccio più in questo modo ma faccio in quest'altro modo. Questa è una cosa che sta lentamente avvenendo tra noi. Mi pare che la sostanza dei problemi posti da Paolo l'ho affrontata nei suoi risvolti che ci consentono, poi, di entrare in maniera positiva e chiara in che cosa sia un'effettiva educazione sessuale. Cosa che non possiamo evidentemente fare adesso, perché non è a tema del nostro incontro odierno: ecco perché dobbiamo accettare uno stile di lavoro. Io ora non so che cosa abbia detto Severino perché io non ho tempo di guardare la televisione, guardo solo qualche telegiornale. In occasione dell'anno galileano a Padova, lo dovrò incontrare in un dibattito, fra qualche settimana, proprio sul tema della morte. Era un incontro già fissato da due anni e cade proprio adesso. In quella occasione cercherò di ascoltare cosa dice e vedrò, nel rispetto della posizione di tutti, di dire che cosa a me sembra giusto, a partire dal bisogno dell'uomo. Circa la questione di Eluana Englaro ho un invito da farvi, una comunicazione che farò alla fine della giornata. Dico subito che è una comunicazione per tutte le nostre parrocchie e le nostre realtà che faccio a voi e che voi dovrete oggi pomeriggio portare dentro alle vostre realtà. Ma questo a dopo. Per quanto riguarda la questione posta da Maria, quello è il punto critico dell'educazione. Vale a dire che noi abbiamo legato l'implicazione del corretto rapporto tra il volere e il dovere alla concezione della Chiesa come la realtà che attua compiutamente il disegno trinitario di Dio sulla storia. Cosa vuol dire? La Chiesa è la modalità con cui il destino di Gloria a cui ogni uomo è chiamato (il Paradiso) e che si anticipa nella vita sacramentale della comunità cristiana in cui si realizza il centuplo quaggiù - cioè una maniera più potente, più conveniente, più autentica di vivere tutte le dimensioni dell'umano (gli affetti, il lavoro, il riposo). La vita eterna, infatti, è già anticipata da questo centuplo, dal fatto che a noi sembra di diventare persone più riuscite, tendenzialmente, nonostante tutti i nostri difetti e tutti i nostri peccati, nella misura in cui partecipiamo intensamente ed ecclesialmente alla persona di Cristo. Allora, se c'è un disegno della Trinità sulla mia persona - lo vedremo nel corso della mattinata parlando di Maria - e su tutta la famiglia umana, lì trova spiegazione ogni dato proprio dell'esperienza elementare di ciascun uomo. Che cosa ci dice l'esperienza elementare di ciascun uomo? Prendiamo, per esempio, la sfera del lavoro. Certamente come minimo ogni uomo sperimenta, di fronte alla necessità di lavorare, che il lavoro mette in campo una tensione, un intreccio di volere e di dovere. Ad esempio: io ho 15 anni e vorrei fare l'astronauta e mi do da fare in tutti i modi. Per fare l’astronauta devo tuttavia accettare prima di fare ingegneria, perciò devo studiare magari 10 o 12 materie di contorno che, secondo me, non servono a nulla per l'astronautica ma siccome devo passare gli esami… Oppure, più in generale: voglio fare l'astronauta, sono il migliore di tutti, mi batto con tutte le mie forze, faccio tutti i concorsi all'Agenzia spaziale europea, poi, per un'ingiustizia, un altro viene scelto al mio posto. Nel frattempo ho trovato una bella ragazza, mi sono sposato, ho avuto tre figli, e adesso devo mantenerli. Accetto, per questo, il dovere di andare a fare il cameriere nel ristorante vicino a casa perché devo mantenere me stesso e la mia famiglia e, come dice Paolo, «chi non lavora non mangi». Un uomo nella sua vita fa sempre l'esperienza elementare che, nel campo del lavoro, il volere si intreccia al dovere: non c'è nulla da fare. Questo si potrebbe ripetere nel campo degli affetti, si potrebbe ripetere nel campo delle fragilità umane ecc. 8 In che senso un equilibrato rapporto tra volere e dovere è un’implicazione dell’attuazione del disegno di Dio sulla mia persona che ho imparato e che continuo a vivere nella Chiesa? Prendiamo un altro esempio: l'indissolubilità del matrimonio. Se io sono certo che l'amore che provo per quella che sarà la mia sposa è un riflesso dell'amore che Cristo prova per la Chiesa Sua Sposa e, a suo modo, è un riflesso dell'amore che vive nel nucleo incandescente della Trinità, da qui consegue una certa concezione dell'amore per cui l'amore effettivo - e non la pura passione che pure è implicata nell'amore - si dà lì dove l'elemento della fedeltà e l'elemento della fecondità che vedo con chiarezza nell'amore intra-trinitario, che vedo con chiarezza nell'amore sponsale di Cristo, che vedo con chiarezza nell'amore di Santa Madre Chiesa per tutti i suoi figli – diventano per me un contenuto essenziale del modo di amare la donna che diventerà la mia sposa e percepisco che questo per sempre aperto alla vita non è qualcosa, al di là di come sono i tempi, che va contro la mia umanità. A tal punto che, siccome tendenzialmente voglio veramente bene alla donna che diventerà mia moglie, quando io sono autentico e nel momento della delicatezza e della tenerezza le dico “ti voglio bene”, mi viene naturale aggiungere “per sempre”. Questa fedeltà la trovo, quindi, dentro alle mie viscere e dentro alla mia esperienza umana, non è qualcosa che mi è imposto. Poi io, cristiano, scopro che questa inclinazione al per sempre è sancita ed è proposta come la condizione dei livelli più elevati dell'amore: l'amore trinitario, l'amore cristico, l'amore di Santa Madre Chiesa, l'amore di Maria. Veramente nella mia fede è implicata una concezione fedele dell'amore. Come posso garantirmi questa fedeltà? Santa Madre Chiesa, interpretando le parole di Gesù: «da principio non era così», da secoli insegna che me la garantisco impegnandomi all'indissolubilità. Mi chiede un amore per sempre, mi chiede di legarmi in maniera pubblica, davanti a tutta la comunità cristiana, che per giunta nel nostro Paese ha poi anche un riflesso di matrimonio come fenomeno a livello civile, mi chiede di legarmi per sempre questa donna. Su che cosa posso fare affidamento? Come posso fare affidamento che questa, che è una donna limitata, non verrà meno alla sua promessa? Ed io, che mi conosco così fragile, io che sono vicino al matrimonio e che pure durante la giornata mentre sono sul lavoro mi lascio ancora dissipare, nei miei pensieri o negli sguardi, da altre fanciulle carine che mi girano intorno, io sono capace di questa fedeltà? Dove trovo la forza? La forza della decisione, del voler dovere questa fedeltà per sempre a lei la trovo sul terreno solido della fedeltà di Cristo alla sua Chiesa. È Lui che consente a me, se obbedisco a questo disegno, di vivere questa fedeltà al di là della mia fragilità. Ecco perché è un voler dovere. Voglio doverti fedeltà indissolubile perché un Altro, che è fedele, mi garantisce questa capacità. Ciò significa che, quando faccio questo passo davanti al sacerdote e davanti alla comunità, io compio una scelta per l'indissolubilità, in nome di Cristo e della Chiesa (Ef 5) alla quale sarò fedele perché l'ho voluto io. A questo dovere sarò fedele per tutta la mia esistenza, costi quel che costi. Se dopo 10 anni, con tre figli, il marito quarantacinquenne, superficialmente, se ne va con un'altra donna e mi pianta lì anche se io non ho nessuna responsabilità in questo (salvo le responsabilità dei limiti personali che sono propri di ogni convivenza); bene, resto fedele al sacramento indissolubile che mi ha legato a questo uomo. A meno che, facendo ricorso alla verifica oggettiva della Chiesa, la Chiesa stessa non stabilisca che non c'è mai stato matrimonio tra me e mio marito. Ora, io conosco decine di persone che vivono così. È che non abbiamo più il coraggio di dire che si può vivere così. Ho cercato di mostrare, purtroppo sinteticamente, l'implicazione: porgiamola tutta, spieghiamogliela tutta; e prima di tutto ai nostri figliuoli. Capisco l'obiezione: “Sì ma ormai i nostri ragazzi che cosa sanno della Trinità? Cosa sanno di Gesù?” È lì il punto, ecco che ritorniamo all'educazione. Anche se non sanno, tuttavia tu puoi far leva proprio sul fatto che Gesù, rivelando il disegno ecclesiale su ogni persona e su tutta la famiglia umana, non ha fatto che esaltare il dato creaturale che la Trinità ha posto nell'essere creando l'uomo, e pone creando ciascuno di noi con la cooperazione dei nostri genitori. Quindi il germe e il fascino di un amore così sta anche di fronte a chi non ha la fede. Per questo, evidentemente, anche con loro si può lavorare in questa direzione. 9 Nei nostri incontri con i fidanzati a me stupisce sempre che, quando si pone la questione in questi termini così globali, molti che magari già convivono si sorprendono: “ Ma noi questa cosa non l’abbiamo mai sentita..!” Allora, in questo modo, la cosa prende un fascino diverso. Perché la vita va verso la fine per tutti. Il matrimonio è come un alveo che ti tiene dentro e senza il quale rischi di disperderti in mille direzioni. Rischi di dissiparti, rischi che la vita sia molto meno riuscita di quanto tu non pensi. Certo tutto questo non si realizza senza grandi dimensioni di dolore, di sofferenza, di rinuncia, di ingiustizie, di umiliazione. Ma chi è l'uomo che può prescindere, nella sua vita, da questi aspetti? Come mi diceva ieri sera, visitando una casa-famiglia di ammalati di Aids, un ammalato molto grave, di origine francese (francofona perlomeno) che, raccontando della sua esperienza in questa casa-famiglia, diceva: “Che cosa posso dire? Dirò che qui faccio l'esperienza della gioia e del dolore contemporaneamente.” Mi è venuta in mente la frase di Claudel: “La vita dell'uomo di gioia e di dolore, in parti uguali, è fatta”. Siamo limitati e l'amore è proprio ciò che dà senso a questo mix di gioia e di dolore. Io credo che quello che abbiamo fatto adesso non sia un esercizio teorico. Può mostrare, attraverso la pertinenza e la pungenza delle vostre domande e il mio tentativo di formulare una risposta, che questo lavoro sul pensiero di Cristo - che incomincia da questa riunione, ma deve estendersi nella vita - se cambia me adesso, può dare dei frutti. Loredana: quanto può inficiare ciò che ha detto il nostro Patriarca la non accoglienza della vita come dono del Signore e come dono da tutelare e che va trasmesso in qualsiasi situazione? Maria Letizia (Consulta delle aggregazioni laicali, Parrocchia di San Ilario di Malcontenta): ringrazio di questa discussione, mi pareva bellissima. Sarà che sono sposata e quindi resto affascinata ogni volta che si parla del matrimonio con questa grande profondità; ogni volta mi innamoro e ringrazio Dio di aver intrapreso questa strada. Volevo proprio riandare a queste implicazioni. Indubbiamente conoscere, vedere, essere stata colpita dalla figura di Gesù ha cambiato la mia vita. Per questo noi siamo qui anche perché non siamo stati indifferenti a questa figura e a questo annuncio. È un semplice pensiero quello che mi veniva: sento che questo aver conosciuto Gesù ha cambiato la mia vita cambiando il mio essere al lavoro, il mio essere con il mio sposo, il mio andare a fare la spesa, il mio essere a scuola con i miei figli. Tutto, proprio tutto ha preso un'altra dimensione, indubbiamente. Ogni giorno appena mi alzo devo fare una scelta e dire che anche oggi voglio vivere per questo. Non è una scelta fatta un giorno per sempre: penso che tutti, ogni giorno, dobbiamo ricominciare. Sento però che questa forza di essere ogni giorno fedele - o provarci almeno - mi viene da questo vivere insieme ad altri fratelli, questo senso di appartenenza e a questa scelta. So essere fedele quanto più vivo questa presenza di Gesù con i fratelli con i quali ho fatto questa scelta. Quindi Gesù fuori di me e, poiché lo vivo, Gesù dentro di me: è una cosa che va proprio avanti insieme. Questa spiritualità di comunione sento che è una condizione oggi perché anche insieme possiamo essere fedeli a questa scelta che facciamo. È come se mi venisse da approfondirla sempre di più. Lei lo ha già esposto in questi incontri che ha fatto, però è un pensiero forte che mi è venuto risentendo e rileggendo quello che Lei aveva detto ma anche quello che ha detto oggi. Patriarca: Anzitutto due cose molto preziose. È relativamente importante e non è primario dire le cose che ci sono sulla scheda o che io cerco di dire con la stessa completezza o con la stessa articolazione. È primario viverle e quindi testimoniarle, come adesso è stato fatto. Io, dopo tanti anni di lavoro, di conoscenza, di studio, di guida delle comunità cristiane e di guida delle chiese, di corresponsabilità vissuta a livello della Chiesa italiana e della Chiesa universale, posso aver assunto una componente di capacità, di competenza espositiva. Ma le persone che io incontro nella Visita pastorale, soprattutto visitando gli ammalati nelle case, i sofferenti, ma anche nel dialogo - penso all'Assemblea del consiglio parrocchiale di ieri a Ca’ Noghera - possono vivere queste cose - e spesso lo fanno - molto più potentemente di me. Questo è 10 il punto. Perché se lo vivono, lo testimoniano. Siamo tutti discepoli gli uni degli altri: impariamo dai bambini. Mi ha colpito che il libretto con i disegni che ho fatto, riportando le domande dei bambini che si preparano alla Prima Comunione, stia continuando a vendere migliaia di copie in tutta Italia. E leggendolo ai bambini, ovviamente lo leggono anche gli adulti. Perché i bambini, con la loro freschezza innocente, ti piazzano delle domande che sono radicali, che ti stanano, che ti costringono a venir fuori. Quindi, per riprendere il tema della via ammirativa, di cui si parlava la volta scorsa - che è la via dell'incontro - il punto della testimonianza è fondamentale. La nostra Pastorale familiare o le nostre parrocchie, le nostre associazioni, dovrebbero essere caratterizzate dalla presenza di famiglie che si amano così - come voi avete detto, come adesso ha detto Maria Letizia - che accompagnano, che si prendono una cura amorosa e medicinale delle famiglie che sono in difficoltà. Non fare sempre e solo riunioni con la teoria sulla famiglia perfetta oppure incunearsi nelle questioni etiche brucianti fino a spaccare il capello in ventisette e non vedere più nient'altro, ma una cura medicinale, un amore medicinale, un accompagnamento di chi è nella prova, a qualunque livello. Io penso che molti più cristiani - i famosi cristiani dell'avambraccio, della Messa della domenica - passerebbero la mano, si mobiliterebbero, se noi li invitassimo in questo tipo di coinvolgimento semplice, elementare, testimoniale che parte dal dare una mano. Se una famiglia è in difficoltà, se ci sono due figli piccoli e la mamma si arrabatta e non ce la fa, ecco che vado a darle una mano a cucinare, a pulire la casa. Lì poi nasce un'amicizia, un rapporto in cui io comunico le mie convinzioni. Non indottrino nessuno, non violento nessuno. Se testimoniamo, non violentiamo nessuno. L'altra volta avevamo estratto dalla meditazione sulla Chiesa e dalla meditazione sul primo punto (la Chiesa come soggetto) - ce l'ha richiamato oggi don Renato - due implicazioni fondamentali a cui si sono rifatte adesso sia la nostra Maria Letizia che Loredana. Abbiamo detto che la Chiesa è un soggetto, che la Chiesa è un chi (e non un che cosa). La domanda giusta è “Chi è la Chiesa?” e non “Che cosa è la Chiesa?”, perché se dico “Che cosa è la Chiesa?” mi tiro fuori, la giudico come struttura, se invece supero la logica del che cos'è la Chiesa ed entro nella logica del chi, nella logica del soggetto, mi gioco io in prima persona. E due implicazioni fondamentali della natura personale della Chiesa tra quelle richiamate la volta scorsa erano: - l'accesso alla verità è comunitario; - l'appartenenza è una condizione di conoscenza. È quello che ci ha ridetto adesso Maria Letizia: vivendo normalmente questa condizione fondamentale, riconoscendo che l'accesso alla verità è comunionale e che pertanto l'appartenenza è una condizione di conoscenza. Anche qui si potrebbero fare degli esempi a partire dall'esperienza elementare di tutti. 1. Quando eravamo piccoli e cominciavamo ad esprimere al nostro papà o alla nostra mamma i nostri perché?, che cosa facevamo? Con i vostri nipotini – se siete nonni - o con i vostri figliuoli, che cosa succede? Succede che il piccolo fa l'esperienza che l'accesso alla verità (che cos'è il bicchiere? Che cos’è questo?...), il primo dare il nome all'oggetto, il portarselo alla bocca ecc…, è comunitario: sta dentro la relazione con il papà e con la mamma. Non ha un accesso individualistico a quel livello elementare della verità che è il dare un nome alle cose, il primo modo di adeguare la verità. 2. Più il piccolo percepisce l'amore di appartenenza al papà e alla mamma, più si butta nel reale. Io sono solito fare questo esempio. La prima volta che l’ho usato, parlando agli universitari di queste cose, la sera precedente ero stato in casa di miei amici, due giovani sposi con una bimbetta di due anni di cui poi ho avuto anche il piacere di celebrare il matrimonio. Era la prima volta che la piccola mi vedeva e appena io sono entrato in casa ho tentato - come si fa con i bimbi, come succede anche adesso in Visita pastorale - di rivolgermi a loro e lei scappava tutta addosso alla mamma, girava la faccia, non mi guardava. Poi ho incominciato a parlare con il papà e la mamma e, dopo due o tre minuti, ho visto che la piccolina aveva girato la testa e cominciava a guardarmi. Dopo un po', constatata la familiarità che avevo con il papà e la mamma, ha cominciato a fare due 11 passi e, lentamente, verso la fine della serata, è venuta anche verso di me, l’ho presa in braccio, mi ha sorriso... Dentro l'esperienza pratica dell'appartenenza al papà e alla mamma, il bambino diventa capace di affrontare la realtà. La Chiesa come soggetto ci insegna che, anche quando siamo maturi, l'accesso alla verità è comunionale. Allora si vede tutto il peso che nella Chiesa ha l'autorità (At 2,42), le quattro finalità della Visita pastorale, il peso che ha il Magistero. Per cui quello che mi dice il Papa non ha lo stesso peso di quello che mi dice il teologo illuminato o di quello che mi dice il mio curato o di quello che mi dice l'intellettuale oggi di grido, il laico teologo che scrive tutti i giorni sui giornali. Perché lì ho una concezione della verità che è indisgiunta dal bene e che implica che l'accesso pieno alla verità sia comunionale e viva dentro un’appartenenza. Perciò a priori io vivo un favor ecclesiae - come dovremmo vivere una favor vitae in questa tragica vicenda di Eluana -, che è più potente della mia opinione e se la mia opinione si discosta da quella del Papa, non sto quieto. Il Papa ha fatto l’atto che ha fatto con i lefevriani, è conseguito quello che è conseguito: non è che questo in me non abbia suscitato delle domande. Ma io continuo a rimuginare questa cosa finché non riesco a capire qual è il punto di vista in cui il Papa si è messo e mi preoccupo di leggere quello che da lui viene, quello che ha detto in passato, di sentire i miei confratelli vescovi che cosa pensano, di ascoltare le opinioni degli altri, di confrontarmi con loro, di dire che cosa mi sembri ragionevole e che cosa non mi sembri ragionevole. Per fare un ulteriore esempio: recentemente ho fatto un dibattito con Schiavone sulle omelie del Papa e, alla fine, discutendo con lui ho visto che il giorno dopo su La Repubblica aveva accettato un principio su cui in un primo momento non sembrava d'accordo e cioè che la vita è indisponibile, anche per il soggetto. Sono rimasto molto stupito al ripensare come la sera precedente, quando avevamo discusso, dicesse fermamente di no. Infatti mi citava anche in quell'articolo lì, criticandomi ma anche dandomi atto di questo. Poi però tirava una conclusione inaccettabile, dicendo che in questo tempo in cui la tecnica soppianterà la natura per cui noi arriveremo, a suo giudizio, a vincere la morte … (è un hegeliano puro), siccome la tecnica crea delle situazioni grigie, allora bisogna lasciare la libertà di sciogliere il problema. E settimana scorsa è ritornato sul tema dicendo una cosa ancora più grottesca: che la vita è sì indisponibile per chiunque, però stabilire quando comincia e quando finisce è una questione che dobbiamo fare, come convenzione, secondo i risultati della scienza. Per cui dovremmo decidere noi quando comincia e quando finisce la vita, un bene indisponibile..! Questo per dire che ci si confronta con tutto e con tutti a 360 gradi, ma con un criterio. Perciò, se il Papa dice certe cose, se il Presidente della CEI dice certe cose, e io faccio parte di questa famiglia, la prima mossa che farò è quella di immedesimarmi fino in fondo con quelle ragioni, come ha documentato molto bene uno degli interventi scritti pervenuti per questa Scuola di metodo da parte di Grazia, che ringrazio molto. L'accesso alla verità è comunionale e vive in pieno nell’appartenenza: è la ricchezza dello scambio. Il vivere insieme come fratelli, la comunità parrocchiale è un luogo che registra questo dato imponente. Pensate a che cosa è stato e a che cosa è ancora in parte il benedettinismo nella nostra Chiesa, pensate a che cos'è una Famiglia religiosa… Certo l'obiezione che si insinua in noi, a partire dall’individualismo radicale legato ad un concetto equivoco di libero pensiero, è che quest’appartenenza sacrifichi la persona. Ma questo lo dice chi non ha mai fatto l'esperienza di una paternità autentica. Una persona che afferma questo, non ha mai fatto l'esperienza della paternità autentica neppure nella sua famiglia, con sua moglie e con i suoi figli, in maniera cosciente. Infatti la paternità vissuta con autenticità è assolutamente liberante nel pensiero e nell'azione. E consente di arrivare fino agli estremi confini del mondo, nel pensiero e nell'azione. Nella comunità cristiana questo vuol dire, certamente, anche essere retti, sorretti e corretti. Tutte e tre le cose. Si può dire: “Questo non lo capisco… questo non riesco condividerlo … su questo io ho un'opinione diversa… ma, questo è opinabile o non è opinabile?”. Se uno vuol essere autenticamente cristiano cioè se uno vuol essere se stesso, perché sceglie lui di essere cristiano. 12 C'è quindi un nesso fra la verità, la comunionalità e l'appartenenza che scaturisce dal fatto che la vita è un dono e che la vita in Cristo è un dono doppio. È un dono che potenzia il dono, è lo svelarci la pienezza del dono. Perché Gesù è venuto a rendere pubblico il nome della Trinità, a dirci che l'essere non è solo una categoria teorica del mio pensiero. L’Essere è il Padre che si dona tutto al Figlio, è il Figlio che si ridona tutto al Padre e che quel legame è così perfetto, il loro nesso è così perfetto, che il frutto di questo nesso è lo Spirito che è identico, nell'essenza, al Padre. Quindi l'Essere è la Trinità e io sono figlio nel Figlio, sono chiamato a questa figliolanza. Gesù è venuto per recuperare lo smarrimento del peccato dell'uomo, del mio peccato, per redimermi e farmi godere ancora più appieno questa figliolanza. Questo dono straordinario ovviamente incide come è stato giustamente detto - sul modo in cui vivo: «Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio». Istruzione del Patriarca LE IMPLICAZIONI DEI MISTERI CRISTIANI LE IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE DEI MISTERI CRISTIANI: LA VERGINE MARIA Introduzione Quando ho preparato la scheda, l’approfondimento delle implicazioni dei misteri mariani si è rivelato molto articolato. Perciò il contenuto di questa scheda è molto più ampio delle altre. Il mistero di Maria esige infatti, da parte nostra, un’accurata meditazione. Mi limiterò realmente a poco più che la lettura, ma vi raccomando di ritornare da subito sulla scheda; soprattutto tenendo conto che il livello in cui io registro la possibilità di cambiamento della mia vita (perciò di conversione e di crescita) è quello in cui vedo l’innesto delle implicazioni nei misteri, perché vedo come essi incidono sulla mia vita, mi chiedono un cambiamento. Quindi nella lettura e nello studio della scheda vi chiedo di essere particolarmente attenti cercando di coglierlo, per la vostra esperienza personale di vita cristiana, con tutto il tempo e la calma che ci vogliono: per imparare queste cose abbiamo tutta la vita che il Signore vorrà darci. 3. Implicazioni antropologiche dei misteri di Maria Premessa Vi è un’importante corrente di riflessione teologica che, seguendo una precisa tradizione, identifica in Maria la “figura della Chiesa”: Ecclesiae typus, diceva San Lorenzo Giustiniani. Il nostro grande protopatriarca - che speriamo di riuscire a rimettere ulteriormente in auge nella nostra chiesa perché è piuttosto dimenticato - definiva Maria come il tipo della Chiesa; si potrebbe anche dire il modello, l'archetipo, il paradigma. Contemplando Maria si capisce chi è la Chiesa. Questo è già molto importante perché fa vedere come tutti i misteri della vita cristiana siano interconnessi. Maria, in quanto figura della Chiesa, è il chi compiuto della Chiesa, cioè il soggetto che attua pienamente la Chiesa. Il passaggio di Lumen Gentium che abbiamo letto questa mattina andava esattamente in questa direzione. Quando ci domandiamo chi è la Chiesa, anziché fare ragionamenti astratti, se guardiamo a Maria ci rendiamo conto di chi è la Chiesa: è il soggetto che la attua in sé pienamente. Attua in sé il disegno della Trinità sulla famiglia umana e su ciascuno di noi, che vuole che siamo figli nel Figlio suo, Gesù Cristo: «Vergine madre, figlia del tuo Figlio» (Dante, Paradiso, 33°). Questa identificazione tra Maria e la Chiesa rende più semplice capire perché parliamo di implicazioni antropologiche dei misteri della Vergine. Se Maria è il tipo, il paradigma, il modello della Chiesa, allora tutte le implicazioni antropologiche del mistero della Chiesa che abbiamo visto 13 la volta scorsa - di cui abbiamo per esempio adesso richiamato quella centrale: che l’accesso alla verità è comunionale e che l’approfondimento della verità ha come condizione l’appartenenza alla Chiesa -, se guardiamo a Maria questo diventa più facile perché guardiamo come ha vissuto lei questa implicazione fondamentale, per es. nel fiat e in tutti i misteri che adesso analizzeremo. 3.1. I misteri della Vergine Maria Iniziamo come sempre dalla lettura di alcuni passaggi fondamentali del Catechismo della Chiesa Cattolica perché il Catechismo ha una forza sintetica, dovrebbe diventare un libro da comodino per tutti noi. Tutte le volte che devo parlare in pubblico o che devo fare un'omelia di un certo tipo o su un certo tema - ovviamente oltre alla meditazione della Scrittura - uso sempre leggere il capitoletto del Compendio che ha a che fare con il tema di cui devo parlare. Se, per esempio, devo parlare della morte, vado a vedere come il Compendio parla della morte perché lì, in una paginetta, si trova un concentrato di tutti i pronunciamenti del Magistero e della Scrittura da duemila anni a questa parte. Si rivela quindi come un grandissimo aiuto. E la forza di queste cose - come le quattro finalità - è la fedeltà nel ripeterle. Ripetizione è ripresa, non è ripetitività: sempre il grande paradigma dell'Eucarestia. Essendo noi creature limitate possiamo penetrare il Mistero solo progressivamente. A questo proposito, per esempio, mi ha colpito moltissimo vedere negli Stati Uniti le scuole connesse alle Università di punta3 che nei più avanzati Licei statunitensi c'è una grande rinascita del metodo dell’imparare a memoria; fin dal primissimo anno, gli studenti ogni settimana hanno un pezzo a memoria da imparare nella loro lingua e nella lingua straniera che studiano. Secondo me è una scelta geniale. Io, che non ho tempo di leggere poesie, quando sono in giro per l'Italia o per la diocesi, di tanto in tanto mi ripeto le poesie imparate a memoria. Ciò che conta è ritornare su queste cose: per esempio, usare fedelmente il Catechismo. L’elemento metodologico fondamentale: CCC 487: Ciò che la fede cattolica crede riguardo a Maria si fonda su ciò che essa crede riguardo a Cristo [Maria è solo in riferimento a Cristo. Qualunque tentativo di sganciare Maria da Cristo già si pone fuori dalla fede cattolica], ma quanto insegna su Maria illumina, a sua volta, la sua fede in Cristo. La fede della Chiesa resta illuminata dall'insegnamento di Maria. Ecco questo intreccio, questo circolo virtuoso. È per questo che dobbiamo essere tutti presenti al pellegrinaggio penitenziale, per la buona riuscita della visita pastorale, che faremo dal 27 al 29 di aprile a Notre Dame du Laus; poi don Beniamino ce lo richiamerà. Ogni mistero della vita della Vergine è in funzione della sua missione nel disegno salvifico di Dio in Gesù Cristo. Non c'è nessun mistero che non sia in funzione di questo. Il mistero per eccellenza - come lo definisce San Paolo -, il disegno di Dio è che tutti gli uomini siano figli nel Figlio suo, Gesù Cristo: è la missione di Cristo, è la missione di Maria. Tutti i misteri della Vergine sono in funzione di questa missione, hanno come scopo che noi diventiamo figli nel Figlio. I principali misteri di Maria a) La predestinazione di Maria Non leggo tutti i passaggi del Catechismo altrimenti esaurirei il tempo: leggo solo il primo perché è il più difficile da capire, il più delicato. Questo tema fondamentale della predestinazione come grande atto di amore della Trinità purtroppo è sparito normalmente dalla nostra predicazione e dalla nostra considerazione della vita. 3 Stiamo cercando di farlo anche noi, tra il Marcianum e il nostro liceo, con grandissima fatica talora anche per l'incomprensione - pregiudicata, ideologica e, soprattutto, molto superata nel tempo - di molti cristiani. 14 CCC 488 «Dio ha mandato suo Figlio» (Gal 4,4), ma per preparargli un corpo, [Cf Eb 10,5] ha voluto la libera collaborazione di una creatura. [Maria poteva dire di no. In effetti, se leggete bene il passaggio di Luca, Lei pone delle domande critiche all'angelo, non subisce la questione: si sorprende del “piena di grazia”, si chiede come sarà possibile questo. Non è uno strumento: è una persona che interloquisce con l'iniziativa di Dio, è libera] Per questo, Dio, da tutta l’eternità, [ecco il senso della parola pre-destinazione: dall’inizio, dall’origine, da sempre. Il destino di Maria scelto dalla Trinità dall’origine, da sempre, da tutta l’eternità] ha scelto, perché fosse la Madre del Figlio suo, una figlia d’Israele, una giovane ebrea di Nazaret in Galilea, “una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria” (Lc 1,26-27). Volle il Padre delle misericordie che l'accettazione di colei che era predestinata a essere la Madre precedesse l'Incarnazione, [l’annunciazione precede l’incarnazione] perché così, come la donna aveva contribuito a dare la morte, la donna contribuisse a dare la vita» [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56; cfr 61]. Questo passaggio del Catechismo è tutto un intreccio di citazioni bibliche e di citazioni conciliari. Il Catechismo è sempre molto rigoroso in questo: non inventa nulla, non crea nulla. La fede nella predestinazione è fondamentale per capire che all’origine dell’esperienza cristiana - della mia esperienza cristiana, della tua, della nostra - si trova la libera e gratuita decisione di Dio di chiamarci ad essere figli nel Figlio. Io esisto, tu esisti; io sono stato creato, anzi, io sono creato perché la creazione è una relazione di dipendenza attuale e presente (io sono creato in questo momento in cui vi parlo). Io sono creato, tu sei creato, per essere figlio nel Figlio Suo, Gesù Cristo. All’origine della vocazione cristiana – con il Battesimo – c’è questa decisione. Da sempre. Leggiamo nel salmo 139: «Signore tu mi scruti e mi conosci, da prima che io fossi concepito da mia madre, Tu mi hai destinato». Predestinazione vuol dire questo: una scelta di amore libera (vedi l’intervento di Loredana circa il dono); una libera e gratuita decisione dalla Trinità di chiamare tutti gli uomini, che non si rifiutano, ad essere figli nel Figlio. Questo ha una conseguenza fondamentale: la grazia - che è la Trinità che si dona - genera la libertà e la precede sempre. È un aspetto di cui oggi ci dimentichiamo spesso nel nostro quotidiano, fin dal primo risveglio. Ecco perché la Chiesa ci raccomanda di incominciare la giornata con la preghiera: di rimetterci nella posizione di chi sente che tutto gli è stato dato, che la vita gli è stata donata. b) L’Immacolata Concezione Per quanto riguarda il mistero dell’Immacolata Concezione voi leggerete i due passaggi del Catechismo e io leggo solo il piccolo commento. Il privilegio di Maria - cioè quello di essere concepita senza peccato perché la sua vocazione speciale fosse tutta sorretta dalla grazia - è in funzione della Sua missione. In forza dell’Immacolata Concezione, il Suo sì al disegno di Dio è perfetto. È messa in condizione di dire un sì perfetto. Per questo è tipo della Chiesa, è paradigma della Chiesa. C'è un passaggio della Santa Messa che ci ricorda questo dato ed è quando il sacerdote prega così: «Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa» (questo si “vede” pienamente in Maria: la fede «della tua Chiesa» brilla in Maria, brilla nella perfezione del suo fiat). Questa è l'Immacolata Concezione: Maria è redenta in anticipo, sin dal suo concepimento. Noi siamo redenti dopo la morte e la croce di Cristo, siamo redenti in Cristo quando con il Battesimo aderiamo a lui. Maria è anch'essa redenta in Cristo, ma lo è fin dal suo concepimento, fin dall'origine. c) La maternità divina di Maria Anche qui lascio a voi lo studio del testo del Catechismo - perché bisogna studiarlo - e leggo solo il breve commento. 15 La maternità divina di Maria è il mistero (il dogma) che garantisce la fede cristologica (ci consente la fede piena nella persona di Gesù) perché Gesù Cristo è vero uomo perché è veramente aria (è documentazione storica che è vero uomo; «nato da donna» dice Paolo ai Galati) – e vero Dio. Per questo la Vergine può essere chiamata Madre di Dio (Teotokos). Nella maternità divina di Maria si vede il nucleo fondamentale della sua missione perché, essendo madre di Gesù, diventa madre nostra, madre di tutti i credenti che sono chiamati ad essere figli del Padre, in Gesù. d) La verginità di Maria La Verginità perpetua di Maria - capirete bene, approfondendo il 499, che cosa vuol dire verginità perpetua - dice che in Cristo ha avuto inizio definitivo l’era messianica (che il Messia è venuto e non lo aspettiamo più, aspettiamo il suo ritorno), il tempo del compimento, perché l’economia definitiva (cioè la storia dell’umanità) non è più segnata dal peccato e dalla morte, ma è dominata da questa novità di relazione con Dio e con gli altri che è la verginità perpetua di Maria. È quella modalità profonda e sostanziale di relazione tra i cristiani in Cristo, è quello stile di possesso con un distacco dentro di cui parleremo fra poco che si vede nella verginità perpetua di Maria. Quindi non siamo più segnati dalle doglie del parto, come simbolo di ogni manifestazione del dolore, della sofferenza, e dalla esposizione alla morte che è legata alla catena delle generazioni 4 . L'economia, cioè il senso della storia, non è più dominata dal binomio peccato-morte, ma dalla salvezza che la verginità perpetua di Maria mostra nella sua verità. La sofferenza non c'è più? C'è ancora. La morte non c'è più? C'è ancora. Il peccato non c'è più? C'è ancora. Ci sono ancora tutti questi elementi ma, per chi aderisce marianamente alla fede in Cristo, non hanno più la forza di essere un progetto alternativo. La morte perde il pungolo «Siamo stati liberati - come dice la lettera agli Ebrei - dal timore della morte che ci teneva in schiavitù». Timore sostanziale della morte. Questo non significa che la morte non ci atterrisca psicologicamente: è un'esperienza reale di morte, ma è una sembianza, in senso forte, di morte. Tant'è vero che il giorno della morte dei santi, che noi festeggiamo, è chiamato il dies natalis. Qui bisogna che tutti, cari amici - lo dico per me, mica per voi - ci interroghiamo su quanto camminiamo, col passare degli anni, dentro a questa coscienza che il Padre ci aspetta. Quando rileggiamo alcuni passaggi: «per me vivere é Cristo e morire è un guadagno», o «voglio vedere il tuo Volto, Signore, il tuo volto» o «dare la propria vita perché chi la perde la ritrova» - insomma io mi trovo tanto zoppicante in proposito, non so voi … Dobbiamo, di tanto in tanto, riflettere su questo. Se non abbiamo il desiderio di vedere il volto di Dio è chiaro che anche la morte, che è certamente la punta più violenta del male, ci tiene in schiavitù. e) L’Assunzione della Vergine L’Assunzione dice il destino di gloria che è donato a tutti noi, se diciamo il nostro sì a Gesù Cristo: tutti gli uomini sono chiamati ad essere figli nel Figlio, tutti gli uomini sono predestinati ad essere figli in Cristo, come dice la lettera ai Colossesi. Ovviamente tutti coloro che non si sottraggono positivamente a questo abbraccio del Padre che è Cristo Gesù e che in Maria ha trovato il suo sì compiuto. 3.2. Implicazioni antropologiche dei misteri della Vergine Vi raccomando ancora molto di non ignorare questa Scheda fino al giorno prima del prossimo incontro: se così fosse, sarebbe come se il nostro lavoro e la nostra compagnia si infragilissero. È 4 E questo perché, come diceva già il Socrate di Platone, ogni figlio che nasce è come se dicesse al padre: “Fatti in là perché adesso tocca a me recitare la parte sulla scena di questo mondo”. 16 importante, invece, assimilarla pazientemente, sempre cercando il nesso tra le implicazioni e i misteri mette in campo subito il cambiamento della nostra vita. a) La predestinazione di Maria Implicazioni fondamentali: * Per dire compiutamente l’uomo (figli nel Figlio) – partiamo dalla predestinazione di Maria, cioè dal fatto che all'origine di ciascuno di noi c'è una decisione di amore da parte della Trinità in cui siamo creati e redenti - è necessario riconoscere il primato dell’amore e della scelta: l’uomo è donato a se stesso. Siamo un dono. In quella che Giovanni Paolo II, già trent'anni fa, chiamava la contesa sull'humanum e che diceva sarebbe diventata ancora più radicale nei decenni a venire (una profezia che è oggi, in maniera chiara, sotto i nostri occhi), la differenza antropologica si gioca su questo: se io sono il padrone di me stesso, se io sono l'artefice di me stesso – si può anche dire: se io sono una conseguenza qualitativa di una evoluzione biologica e basta - oppure se all’origine del mio io c'è una volontà di amore da parte di Dio. Questa è la pre-destinazione. Perché la creazione altro non è se non l'attuazione della predestinazione e la redenzione è l’attuarsi della indefettibilità, della infallibilità della predestinazione. Neanche il peccato è potuto diventare un'obiezione definitiva alla decisione della Trinità di volere figli nel Figlio suo. Per questo, da quando il Padre ha predestinato che il Figlio fosse mandato ad assumere la nostra natura, ha preso in considerazione anche la possibilità del nostro rifiuto, la possibilità del peccato di Adamo, e ha pre-destinato la morte e la resurrezione di Gesù. È affascinante entrare nei misteri della vita cristiana..! Ecco perché quando facciamo i Gruppi di ascolto, quando lavoriamo sulla catechesi, quando facciamo due o tre giorni di vita comune durante l'estate, quando alla sera, durante l'estate in città o a casa, magari ci troviamo in patronato, sarebbe bello prendere in mano qualche piccolo testo e tentare di entrare di più nei misteri della vita cristiana; gustarli dall’interno perché diventino carne della nostra carne, diventino principio di vita. *Per dire compiutamente io è necessario rifarsi a Colui che mi ha voluto e mi ha creato: io sono Tu (Dio, il Padre) che mi fai. Come abbiamo detto la settimana scorsa nell'omelia di ordinazione di Piotr, riprendendo il commento di Agostino al passaggio del vangelo di Giovanni: «Doctrina mea non est mea», la mia dottrina non è mia. Agostino dice: «il mio è il non mio»”. “Io sono tu che mi fai”: l'altro - soprattutto l'altro con la A maiuscola - è condizione per la riuscita compiuta dell’io. E qui torniamo al discorso della comunione come accesso alla verità. Implicazioni legate alla storia e al presente: * Superare la tentazione del prometeismo che caratterizza molto (non tutto) del moderno e del postmoderno. L’uomo che si fa da sé e che si salva da sé. Il peccato originale è questo: è l’autosoterìa: mi salvo da me, non ho bisogno di Cristo. Mi faccio da me, non sono creato. Sono il prodotto di una lunga evoluzione. Ad un certo punto, nell'evoluzione della materia, scatta la prima cellula vivente e poi quella si perfeziona sempre più e non c'è più salto di qualità nel bios; per cui non c'è differenza tra l'organismo vitale monocellulare e il primate uomo. Guardate che questo è sostenuto formalmente dai nostri scienziati ed è inculcato quotidianamente a tutti noi: le pagine più terribili dei nostri giornali non sono quelle dedicate al dibattito sulle opinioni o sui confronti più o meno serrati che sono in atto nel 17 nostro Paese, ma sono quelle dedicate alla scienza. Posso immaginare che cosa passi nei manuali di scuola..! In questo senso il discorso della sessualità è solo un paragrafo della questione. Quando ti trovi a dibattere con Flores d’Arcais, come mi è successo alla Normale di Pisa, che mi diceva: “Tutti i suoi argomenti, Eminenza, sono superati … Perché dobbiamo parlare di creazione, quando sappiamo già tutto? Sappiamo che veniamo dai pesci e dalla scimmia. Non abbiamo più bisogno di altre spiegazioni”. Applichiamo il “principio del rasoio” di Ockham: si taglia via tutto ciò che è superfluo, si sceglie la spiegazione più semplice e il resto via, una rasoiata e via. La spiegazione più semplice è lì: veniamo dai pesci e dalla scimmia. Che bisogno c’è di parlare ancora di Dio? Quella è una cosa finita. Stabiliamo noi quando inizia e quando finisce la vita. * Critica alla riduzione materialistica: l’uomo è più che la sua biologia, è anche la sua genealogia. Sarebbe molto importante, quando parliamo della creazione ai nostri bimbi del Catechismo, spiegare che oltre alla biologia - perché c'è un elemento psico-corporale (anche tutti i discorsi sulle neuroscienze) che viene dal bios in cui c'è ovviamente una continuità con gli altri livelli inferiori di vita - l'uomo ha anche una genealogia. C'è un discorso sull'origine: pro-creazione. Il pro vuol dire da un Oltre, da un Altro. La bella frase di Eva in Genesi: «Ho avuto (ricevuto) un figlio da Javhé». * La dignità di ogni uomo sta nell’essere creato da Dio e non può essere in nessun modo intaccata. È originaria. Qui sarebbe interessante e bello se dalla Scuola di metodo nascessero vocazioni in più dimensioni. Ad esempio: uno ha il gusto di imparare bene queste cose allora si iscrive o fa iscrivere – il problema non sono solo io, ma sono anche gli amici della parrocchia –due o tre amici (come avete già fatto) alla Scuola Santa Caterina d'Alessandria per poter fare meglio i Gruppi di ascolto, la catechesi, la carità, la liturgia. Oppure: ci sono due o tre giovani nel Vicariato che vorrei che un domani vivessero la loro professione occupandosi di bioetica, di beni culturali, della famiglia… ma immersi nella visione cristiana delle cose. Per questo, nel nostro Vicariato facciamo un sacrificio, raccogliamo due borse di studio e chiediamo a due giovani di fare la Facoltà di Scienze Religiose al Marcianum, non di fare Legge, perché in questo modo li aiuteremo a trovare lavoro. Questi saranno professionisti nuovi e la Teologia non sarà più una stella separata e persa nella galassia che non ha niente da dire alla vita dell'uomo di oggi… Dai nostri incontri dovrebbero nascere queste cose. Cito ancora le implicazioni del mistero dell'Immacolata Concezione e tutto il resto lo lascio a voi. b) L’Immacolata Concezione Implicazioni fondamentali: * La libertà compiuta è la libertà innocente, che non ha connivenza alcuna con il male. Una volta, scandalizzando i miei preti di Grosseto (con quelli di Venezia non ho ancora osato farlo), ho detto loro che in santità è più grande Santa Maria Goretti di Sant'Agostino. Intendevo dire che Santa Maria Goretti vive l'innocenza verginale. Noi abbiamo l'idea che il grande peccatore che si converte quello lì è il grande santo, ma questa è ancora una visione umana della santità. L'innocenza è la pienezza della santità. L’Immacolata Concezione ci dice esattamente questo: la libertà compiuta è la libertà innocente che non ha alcuna connivenza con il male. Dall'origine Maria non ha connivenza alcuna con il male. In questo senso è l'uomo riuscito - dico l'uomo perché nella nostra lingua non possiamo distinguere la cosa - è l'uomo e la donna compiutamente riuscita, l'innocente. Il bambino ha solo un certo grado di innocenza perché la radice del male, come conseguenza del peccato originale, è presente anche in lui. Dopo il Santo Battesimo (che per questo va 18 dato ragionevolmente presto) sappiamo che continuano ad essere presenti le conseguenze del peccato (l'elemento della concupiscenza in senso largo). Per questo l’idea pedagogica, oggi dominante (a parte che l'ha già sfatata Freud in maniera radicale) che, per esempio, (costumi che sento qualche volta discorrendo con le famiglie) ha l’abitudine di fare la doccia o il bagno con i bambini nudi come un modo per introdurli con naturalezza alla sessualità… tutte storie! Non è affatto vero. È invece mancanza di profondo senso della psicologia del piccolo. * La libertà per compiersi ha bisogno di un amore che la preceda, a cui aderire. Questo è evidente nell'esempio del piccolo col papà e la mamma; oppure di noi nei confronti di Dio. Pensiamo ai Salmi: come un bimbo, come la serva che guarda le mani della padrona. * Questo implica riconoscere che il livello del libero arbitrio - che è ineliminabile – (scelgo A anziché B, vengo alla Scuola di metodo anziché stare a casa …) non dice tutta la libertà, dice solo un livello della libertà, non dice tutta la libertà, dice una libertà in cammino, ancora imperfetta. Nella libertà vi è anche un elemento di adesione consapevole alle inclinazioni naturali (perché la mia libertà sorge su una natura finita) che ci precedono e un livello di adesione all’amore infinito di Dio che ci attira. La libertà è l’intreccio di questi tre elementi. 1° Assecondare in maniera ragionevole le inclinazioni: l'inclinazione a mangiare e bere è costitutiva della mia natura (certamente io mangio e bevo come un essere razionale non come il cane o il gatto). Quindi applico la mia libertà, coltivo questa inclinazione. La cultura dell'uomo è nata proprio dalla possibilità di coltivare queste inclinazioni. 2° Poi nessun bene che scelgo, in quanto finito, mi soddisfa perché è solo il modo attraverso il quale l’infinito di Dio - Colui che è all'origine e alla fine (l’alfa e l'omega) che mi soddisfa veramente – mi attira a sé. Quando vado in montagna e cammino, sono affaticato e ho sete e quando vedo finalmente il ruscello, la pienezza della mia libertà non sta nello stare lì a dire “bevo o non bevo?”, ma quando bevo e mi disseto e mi soddisfo. 3° quando aderisco, allora la libertà è piena. Sarà così nella gloria. Implicazioni legate alla storia e al presente A questo proposito l'intervento iniziale di oggi di Paolo è molto prezioso, e prezioso è il lavoro che Gente Veneta vi ha fatto sopra. È importantissimo oggi educare alla libertà, e questo comporta: * Educare alla libertà integrale in una società che ha fame di libertà: dal semplice libero arbitrio all’adesione al Bene Sommo assecondando le “inclinazioni naturali”. Poi su questo concetto di natura potremmo discutere molto. * Gli ambiti comunitari come luoghi di libertà: critica alla cultura dell’assenza di legami. Oggi c'è questa idea diffusissima che uno è libero se rompe i legami; invece è libero davvero se vive dei legami profondi e autentici. Tale dev’essere la natura dei legami nella comunità cristiana. [Tralascio tutto il resto perché, purtroppo, andremmo fuori tempo. Il fatto che io non abbia potuto e non possa spiegare la scheda adeguatamente deve essere un incentivo per lavorarci sopra di più personalmente. Queste sono cose che il Patriarca, in mezzo a tutto quello che deve fare, scrive alla mattina presto rubando un po' di tempo al suo sonno: quindi sono iper-perfettibili, non solo perfettibili. È possibile fare le proprie considerazioni e correzioni ma questo implica un lavoro]. 19
Scarica