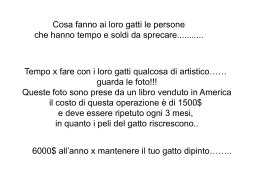n.0
2
The Godfather
Friedrich Dürrenmatt
di JACOPO CIRILLO
F
riedrich Dürrenmatt, famoso per i suoi Fisici, ha scritto molti racconti nella
sua vita. Alcuni sono di 10 righe, altri di 60 pagine. I più intelligenti, i più memorabili, sono quelli corti. Corti ad un livello per cui stiamo a contare le parole, più
che le pagine di troppo.
Un banchiere fallito arriva per sbaglio in una cittadina sperduta in Svizzera, chiama un taxi e il tassista lo lascia in mezzo a una piazza con una bomba innescata in
mano. E scappa via.
Il racconto è aperto, nel senso che non finisce. E questa sua germinalità, così opposta agli sbrodolamenti di un Tolkien, per esempio, lo rende incredibilmente affascinante. Da un lato perché usa l’inferenza, cioè quel meccanismo per cui il testo ti
fa intendere certe cose senza dirle. Presentando il protagonista come un banchiere
fallito, si capisce immediatamente che non ha soldi per pagarsi l’albergo, anche se
non c’è scritto da nessuna parte. Tutti hanno capito che il tassista è un attentatore,
anche se Dürrenmatt si guarda bene dal giudicarlo.
Dall’altro lato, è affascinante perché procede per abduzione, cioè fa ragionare su
ipotesi probabili di effetti derivanti da una certa causa. Ipotesi probabili, non logicamente conseguenti. Permette a ogni lettore di finirsi il racconto da solo. Perché il
povero banchiere butterà la bomba da qualche parte. E ciò che verrà distrutto potrebbe anche non essere il bersaglio del terrorista. Però il terrorista avrebbe dovuto
prevedere questa casualità. Se l’avesse fatto apposta allora? E il banchiere, poi, si
sentirà in colpa? In fondo si è salvato la vita. Non è lui il vero attentatore, fatto sta che
comunque ha buttato lui la bomba e ha “scelto” lui l’obbiettivo.
Che fare? Andare alla polizia? Ci crederanno? E come pagare l’albergo? E se lo
arrestassero per morosità e lui, alle strette, confessasse?
In poche righe è racchiuso un intero mondo di possibilità, mondo che nel lusso
delle tante pagine è precluso perché già raccontato. Ma la letteratura si fonda sul
non-detto, sulla cooperazione con il lettore.
Sulla lettura creativa.
3
Sommario
Versus
Il Labirinto
La citazione del mese
Recensione/1
Recensione/2
Letterature Involontarie
L'Intervista
L'angolo del cinematografo
Recensione/3
Recensione/4
Charlie VS Proust
Iperboloser
Graffetta
Recensione/5
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
15
17
18
18
Recensione/6
Pillole di Scienza
I ferri del mestiere
Recensione/7
Recensione/8
Chi ero?
La posta dei lettori
Graphic Novel
Recensione/9
Recensione/10
Recensione/11
Felinomachia
How i met your cat
Contributi da
Editoriale
19
20
21
22
22
23
24
26
27
27
28
29
31
33
Le idee buone sono sempre brevi. E innumerevoli. Ogni
libro, reale o inesistente, le porta con sé. L’impegno di queste pagine, e di quelle future, sarà di parlare di libri attraverso le loro idee: brevi, diagonali, alla svelta. Sarà di non
entrare in nessun libro ma circolare in tutti. Non diluiremo
intelligenze in sbrodolamenti, non nasconderemo ingegni
con sinossi.
J
orge Luis Borges ha scritto un libro, Finzioni, che dà
il titolo a questa rivista. Finzioni parla di biblioteche
impossibili, personaggi straordinari e libri mai scritti. Lo fa
bene. E lo fa alla svelta.
Consideriamo i libri come oggetti culturali costantemente in relazione tra loro in un sistema interdefinito di libri e
di discorsi attorno a essi, da cui acquistano valore e identità. Per questo vogliamo essere lettori, non scrittori. Crediamo che la lettura sia un atto creativo e, semplicemente, la
trascriviamo.
Borges pensava che una buona idea richiedesse uno spazio minimo per essere articolata e uno spazio infinito per le
sue ramificazioni. Per questo ha recensito libri immaginari, lamentando che“delirio faticoso e avvilente [fosse] quello
del compilatore di grossi libri, del dispiegatore in cinquecento pagine d’un concetto la cui perfetta esposizione orale [si] capirebbe in pochi minuti! Meglio fingere che questi
libri esistano già e presentarne un riassunto”.
“Menino vanto altri delle pagine che hanno scritte; il
mio orgoglio sta in quelle che ho lette”.
Jorge Luis Borges e tutta la redazione.
4
L
e braci di Sandor Marai (Adelphi 1998, 172 pagine, 10 euro)
è piaciuto a tutti. Ed è facile capire il
perché.
Due vecchi amici, tanto diversi all’apparenza quanto uniti nello
spirito, cresciuti insieme imparando
l’uno dall’altro la virilità, la sensibilità e lo stare al mondo, si rincontrano
nel castello del primo dopo quarantun anni di lontananza; entrambi
hanno vissuto così a lungo solo per
questo momento. Si erano conosciuti da fanciulli, in un collegio per giovani ufficiali ed erano diventati subito inseparabili: dopo una ventennale
amicizia, in un giorno terribile, uno
dei due, inspiegabilmente sparisce,
lasciando dietro di sé dubbi, rimorsi e rabbia, salvo tornare improvvisamente così tanti anni dopo per il
confronto. Per soffiare sulle sopite
braci. Nell’austera sala da pranzo
del castello reso grande dalla sua
imponenza, dai suoi enormi saloni vuoti e dall’eco che risuona nelle
cantine, i due amici si riuniscono,
ricordano insieme tutti i particolari
dell’ultimo loro incontro, proprio in
quella stanza di cui ricordano tutti i
particolari, e iniziano un dialogo che
dura praticamente tutto il libro. Dialogo vibrante di passione, arricchito
da perle di saggezza e mature consapevolezze sulla vita di due vecchi
giunti al lumicino con una dignità
d’altri tempi.
Henrik, nobile schiatta e fedele
soldato, è sempre rimasto fedele
all’esercito e adesso, dopo la morte
della moglie, conduce una vita ritirata e dignitosa, mentre Konrad, di
umili origini e di sensibilità artistica,
ha vissuto ai Tropici dopo la sua fuga
e per tutta la sua assenza, tra rimorsi,
rimpianti e umili lavori.
Ora, è risaputo che scrivere dialoghi realistici sia una delle cose più
difficili del mestiere, perché bisogna
bilanciare l’incoerenza e la sconclusionatezza delle interazioni quotidiane con l’esposizione piana e organica propria di un libro. Sandor Marai
rende perfettamente questo delicato
bilanciamento: Henrik ce l’ha con il
suo amico perché lo ha abbandonato
all’improvviso, perché durante l’ultima battuta di caccia insieme ha avuto terribili e fondati sospetti, perché
non ha saputo amare la sua defunta
moglie abbastanza, anche per colpa
di Konrad. Una rabbia che sale insieme alla tensione, battuta dopo battuta, in un vertiginoso monologo nel
quale Henrik dimostra di possedere
un rigore verbale e una ferrea capacità logica (senza contare la prestanza fisica nel parlare quasi tre ore) che
chiaramente lo pongono a simulacro
dell’autore, la cui vita futura rassomiglierà sinistramente a quella del suo
personaggio.
Forse questa è l’unica cosa più
incredibile del giusto successo del
libro.
Versus
Le Braci
di JACOPO CIRILLO
L
e braci di Sandor Marai (Adelphi 1998, 172 pagine, 10 euro)
è piaciuto a tutti. E non riesco a capire perché.
Due vecchi amici e commilitoni,
uno ricco e l’altro povero, uno virile e
l’altro sensibile, uno inserito e l’altro
disadattato e altre dicotomie dello
stesso grado di banalità, si rincontrano nel castello del primo dopo quarantun anni di lontananza, apparentemente senza una buona ragione. Si
erano conosciuti da fanciulli, in un
collegio per giovani ufficiali ed erano
diventati subito inseparabili; dopo
una ventennale amicizia, un bel
giorno, quello povero ma sensibile
sparisce, salvo ritornare anta anni
5
dopo per il confronto. Per soffiare
sulle sopite braci.
Nell’austera sala da pranzo del castello più stereotipato di Ungheria,
della quale entrambi ricordano tutti
i particolari del loro ultimo incontro
(yawn), inizia un dialogo che dura
praticamente tutto il libro. Dialogo
ammorbato di retorica, punteggiato da banalità sulla vita e l’amicizia
maschile e diluito con lunghissime
digressioni di ogni tipo, continuamente ripetute senza neanche curarsi di usare termini equipollenti a
ogni reiterazione.
Henrik, nobile schiatta e fedele soldato, è rimasto nell’esercito e
adesso, dopo la morte della moglie,
conduce una vita ritirata e dignitosa,
da vero austroungarico, mentre Konrad, umili origini e velleità d’artista,
ha vissuto ai Tropici dopo la sua fuga
e per tutta la sua assenza, tra rimorsi,
rimpianti e umili lavori.
Ora, è risaputo che scrivere dialoghi realistici sia una delle cose
più difficili del mestiere, perché bisogna bilanciare l’incoerenza e la
sconclusionatezza delle interazioni
quotidiane con l’esposizione piana
e organica propria di un libro. Se si
trascrivesse una vera conversazione
sentita per strada o al bar, questa sarebbe illeggibile. Sandor Marai però,
che immagino uomo noiosissimo, fa
parlare il suo personaggio come un
attore che recita una piéce un po’
troppo pretenziosa per il teatro popolare in cui si sta esibendo.
Leggendo un dialogo si sincronizza quasi perfettamente il tempo reale
di lettura con il tempo finzionale del
discorso, di modo che se impiego tre
ore a leggere la loro conversazione,
in un mondo possibile in cui si è veramente svolta sarà durata all’incirca
lo stesso tempo.
Il vecchio e sclerotico generale
Henrik (ce l’ha col suo amico di una
vita praticamente senza nessun motivo o prova concreta se non la •
senilità galoppante) dimostra allora di possedere il rigore verbale, la
ferrea capacità logica e la prestanza
fisica necessarie per sostenere una
conversazione di svariate ore senza
un cedimento, un refuso, un colpo di
tosse. Un bicchier d’acqua.
Forse questa è l’unica cosa più
incredibile dell’acclamato successo
del libro.
A
possibile l’arrivo del viaggiatore al
centro (un po’ l’inverso di tutto ciò
che si trova fuori dal giardino stesso,
ovvero la Parigi dei grandi boulevard
di Haussman, costruiti nello stesso
periodo e che portano nel minor
tempo possibile a destinazione).
In secondo luogo, l’arrivo al centro
consiste in un’elevazione o, meglio,
in un passaggio di grado. La spirale
sale fino alla cima della collinetta e,
una volta al centro, ecco il segreto
del labirinto, o ciò che esso permette
di guardare dal comodo chiosco che
vi è stato costruito: il labirinto stesso.
Calvino disse che non esiste labirinto per chi l’ha attraversato. Dall’alto
l Jardin des Plantes, giardino
botanico di Parigi,
si trova un curioso tipo di
labirinto. E’ facile notare
lo spaesamento nei bimbi,
che frequentano in massa
il luogo. Non ci si perde
nel labirinto del Jardin des
Plantes. Si tratta di una
spirale che dall’esterno
porta al centro seguendo
un unico tragitto e coprendo tutta la superficie
disponibile. Si sviluppa
su una piccola collina, la
butte Coypeau, e il centro
ne è il punto più alto. Un
chiosco in metallo decora
la sommità permettendo
di MATTEO TRELEANI
ai visitatori di osservare il
giardino e il percorso che
lo possediamo, ne vediamo la struthanno fatto. Datata 1786, tre anni
tura e la mappa. Allo stesso modo,
prima della rivoluzione, si dice sia
Dedalo, l’ingegnoso architetto che
addirittura la più antica struttura in
Minosse getterà nella sua stessa
metallo di Parigi. Quell’unico tragitopera dopo l’uccisione del Minotauto lascia perplesso chi lo visita, pronro, per uscire dal labirinto scopre la
to a perdersi in un dedalo di siepi, al
terza dimensione. Volando, con le ali
punto che qualcuno ha ben pensato
fatte di piume tenute insieme con la
di scavare dei percorsi secondari, col
cera, trova l’unico modo per uscire
chiaro intento di rendere il cammino
da un garbuglio inestricabile: scopre
più complesso.
la dimensione che lo trascende, effettuando un passaggio di livello che
Un’innocua passeggiata al giardiconsente di osservare il sistema da
no botanico insidia allora molti dubun’altra prospettiva. Vederlo, in una
bi nella nostra concezione di quella
parola, e dunque possederlo. Solo
figura archetipica che è il labirinto.
uscendo dal labirinto volando, DeAlmeno due caratteri si rivelano inudalo può, per la prima volta vedere
suali. Contrariamente al pensiero
nella sua globalità la struttura che lui
comune, il tragitto è unicursale. Lo
stesso aveva costruito.
scopo pare quello di ritardare il più
Si direbbe che per uscire dal labirinto sia necessario un cambio di
prospettiva. Il mito ce ne offre svariate di queste intuizioni che qualche
psicologo cognitivo chiamerebbe insight. Dal filo di Arianna alla conchiglia di Dedalo. Decisamente meno
nota del filo, la storia della conchiglia
è quella del concorso bandito da Minosse per ritrovare Dedalo (esiliato
in Sicilia dopo la fuga dal labirinto).
Il re indice un premio per chi riuscirà a far passare un filo attraverso
una conchiglia. Dedalo, incapace di
rifiutare la sfida, cosparge le estremità di miele e lega il filo a una formica
che fa il resto (furbamente
il mito sorvola sul come
sia riuscito a legare il filo
alla formica). Ecco un altro rimodellamento del
punto di vista (e si noti
l’assonanza tra i fili, il labirinto e la conchiglia).
Anche la formica è un
salto di dimensioni: dalla
constatazione ovvia del
non poter entrare nella
conchiglia a quella di farci entrare qualcun altro.
Così come il filo di Arianna ribalta l’idea, data per
scontata, della perdita,
con uno strumento che
permette di non perdersi
mai, tracciando il percorso dall’esterno. Naturalmente poi,
l’idea del filo era di Dedalo.
Sui labirinti
Il labirinto del Jardin
des Plantes e gli
insight di Dedalo
6
Il tragitto unicursale e l’insight
sottendono la medesima idea, quella del passaggio complesso da uno
stato all’altro. Il pensiero del labirinto non è mai diretto, avviene per
associazioni indebite e salti di grado.
Ma quando si tratta coi labirinti non
si deve ragionare in termini di strumenti per risolvere problemi. E non
si creda troppo facilmente che un insight basti per uscire dalla sua complicazione. E’ l’eroe di James Joyce,
dall’inequivocabile nome di Stephan
Dedalus, a ricordarci che il labirinto
si ricostituisce senza fine: l’uscita da
esso dà su un altro labirinto.
U
con altri concatenamenti, in rapporto con altri corpi
senza organi. Non si domanderà mai quel che un libro
vuole dire, significato o significante, non si cercherà
niente da capire in un libro. Scrivere non ha niente a
che vedere con significare, ma con misurare territori,
cartografare, perfino delle contrade a venire.
n libro non ha né oggetto né soggetto, è fatto di
materie diversamente formate, di date e di velocità molto differenti. In un libro, come in ogni cosa,
ci sono linee di articolazione o di segmentarità, strati,
territorialità; ma anche linee di fuga, movimenti di deterritorializzazione e di destratificazione. Non c’è differenza tra ciò di cui un libro parla e la maniera in cui
è fatto. Il libro non ha più nemmeno oggetto. In quanto
concatenamento, è se stesso solamente in connessione
Gilles Deleuze e Felix Guattari. Millepiani. 1980.
La citazione del mese
Comma 22
C
omma 22 fa ridere. E non me
lo aspettavo. E’ famoso per il
suo titolo che si è catcresizzato, diventando un modo di dire: catch 22
(che io avrei tradotto più volentieri
con inghippo 22). Un paradosso.
“L'unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia;
Chiunque chieda il congedo dal
fronte non è pazzo”. Questo comma
è diventato nel tempo l’emblema
dell’antimilitarismo e dell’assurdità
dell’esercito degli Stati Uniti che bla
bla bla.
No, Comma 22 non è un libro. E’
un flusso. Un concatenamento continuo di avvenimenti insignificanti
relati tra loro da costanti, designate
da nomi propri. Ogni capitolo prende il titolo da un nome che, come diceva Deleuze, “designa qualcosa che
è anzitutto dell’ordine dell’evento”.
Comma 22 è un concatenamento
di eventi, comici, ironici, terribili,
senza inizio né fine. E senza senso.
Potrebbe iniziare da pagina 50, potrebbe finire a pagina 50. Da qualsiasi punto si inizi a leggere, ci si troverà
sempre in medias res. E’ circolare,
esattamente come l’idea di Deleuze:
il libro non ha oggetto né soggetto, è
se stesso solamente in connessione
con altri concatenamenti.
di JACOPO CIRILLO
Ogni personaggio possiede nominalmente un capitolo, si diceva, lo
marchia con il proprio nome. Ogni
personaggio, e sono talmente tanti
che il soprannumero abolisce la loro
importanza in quanto singoli, viene
presentato nel suo capitolo, come se
fosse davvero il suo, di sua proprietà.
Come se possedesse un terreno.
Questa cosa si capisce meglio nella traduzione italiana, grazie alle note
del traduttore. Al soldato Hugry Joe
corrisponde una precisazione a piè
pagina che lo presenta come “press’a
poco Joe Fame”; il capo White Halfoat è “letteralmente Mezzo grano
d’avena bianca”. Ecco, solo che questi
personaggi erano già comparsi nei
capitoli precedenti e compariranno
nei successivi (se mai abbia ancora
senso parlare di ordine dei capitoli),
senza ricevere l’onore di una nota
a piè pagina. Questo significa due
cose: ogni nome proprio esiste solo
in quanto abitante di un territorio,
seppur grafico (la presentazione del
traduttore, extradiegetico, coincide
con la loro esistenza fenomenologica); il libro non significa ma traccia,
disegna delle cartine. Delle contrade rette da un nome, dunque da un
evento, che le caratterizza e le conferisce senso nel sistema dei capitoli
del libro.
7
L’ampiezza narrativa di ogni personaggio non è altro che la misurazione del suo territorio, le azioni non
spiegano né dicono ma cartografano.
Comma 22 è la metonimia del
sistema dei libri deleuziano o, meglio, ne è il frattale. Il frattale è un
oggetto geometrico autosimilare che
si ripete nella sua struttura su scale
differenti, dunque ogni sua parte è
uguale al tutto (guardate un abete, o
un cavolfiore).
Comma 22 funziona come, secondo Deleuze, funzionano i libri in generale. Non ha inizio né fine e svuota
di senso queste due nozioni perché
è circolare; è fatto di materie diversamente formate, di date e velocità
molto differenti perché i personaggi, dunque gli eventi, sono diversi
tra loro per quantità e qualità e allo
stesso momento esistono solo nelle
loro interazioni; non ha niente a che
vedere col significare, al contrario
misura territori, quando addirittura
non li crea.
Recensione/1
Il Giovane Holden
Viviana Lisanti
I
l giovane Holden è uno dei romanzi più incompresi e allo
stesso tempo abusati di tutti i tempi.
Gli holdeniani continuano ad essere vittime inconsce di quell’operazione commerciale che, confezionando Holden come ennesima
icona della ribellione giovanile, ha
fatto sì che il romanzo diventasse
un best-seller in tutto il mondo. I detrattori del romanzo invece partono
dall’assunto che la validità dell’opera
di Salinger sussista solo in relazione
alla portata rivoluzionaria che ebbe
sulla società perbenista americana
degli anni ‘50 e credono quindi che,
ai giorni nostri, l’anticonformismo
holdeniano sia ridicolo.
Se ci si volesse limitare ad un’interpretazione “politica” del personaggio di Holden, il sedicente rivoluzionario che Salinger ci dipinge
apparirebbe ben strano: cancella le
scritte volgari dai muri pensando
possano offendere la sensibilità dei
bambini; si tira indietro con una prostituta; le bevute, più che praticarle
le esibisce.
Afferma che “certe cose dovrebbero restare come sono, dovreste metterle in una di quelle grandi bacheche di vetro e lasciarcele”, parole che
suonano più come una difesa dello
status quo che come un incitamento
alla rivoluzione.
D’altra parte, solo una lettura superficiale può negare l’importanza
attuale del libro, fermandosi alla
semplice constatazione che un ado-
lescente degli anni ’50 esprimeva il
proprio disagio in merito a valori che
oggi sono totalmente superati. L’approccio all’opera deve quindi partire
da basi diverse, esaltando l’aspetto
del romanzo che in assoluto concorre a farne un capolavoro del novecento: il linguaggio.
Aldilà dell’interesse filologico letterario che può costituire, essendo una trasposizione fedele del college-slang, il gergo usato tra i giovani
newyorkesi negli anni ’50, l’idioma
di Holden acquista senso in quanto
esempio della forza espressiva della
parola e del ruolo salvifico che può
costituire per chi la pronuncia. L’autore ha creato un linguaggio che si
dimostra coerente in ogni singola
scelta lessicale e sintattica e che, più
di qualsiasi descrizione dettagliata,
concorre a fornire l’immagine vivida
8
di un personaggio indimenticabile.
Un esempio su tutti è fornito
dall’uso del termine “phony” (“fasullo” nella traduzione italiana),
una delle parole che più ricorrono
nel vocabolario di Holden. Phony
sono tutti quei comportamenti che
le persone sono tenute ad avere per
mantenersi in buoni rapporti con gli
altri: “Non faccio che dire piacere di
averla conosciuta” a gente che non
ho affatto piacere d’aver conosciuta.”.
Phonies sono le persone che a teatro
si mettono a parlare a voce alta della
commedia alla quale hanno appena
assistito“in modo da farsi sentire e
fare apprezzare a cani e porci quanto
erano geniali”; o ancora si sprecano in grandi cerimonie quando incontrano un conoscente per strada:
“Avreste dovuto vedere come si salutarono. Da credere che non si vedessero da vent’anni”. Il disgusto verso
certi atteggiamenti è interiorizzato
a tal punto da Holden che finisce
per essere trasposto nel suo modo
di parlare. L’intercalare ossessivo
con espressioni quali “if you want
to know the truth”, “I know what I’m
talking about”, “I’m not kidding”, “I
really do”; la tendenza a riformulare
i concetti con parole diverse ("She likes me a lot. I mean she’s quite fond
of me."), o addirittura ripetendo la
stessa frase due volte ("He was a very
nervous guy- I mean a very nervous
guy."), sono frutto della necessità
impellente di prendere le distanze
da una realtà “schifa” e convincere l’interlocutore della sincerità di
quanto sta raccontando, per non essere percepito a propria volta come
“phony”.
Sembra evidente che, a più di cinquant’anni dalla sua pubblicazione,
il valore de “Il giovane Holden” vada
misurato in altri termini perché, se
l’adolescenza è stata spesso indagata
nei romanzi e continuerà ad esserlo,
solo Salinger è riuscito attraverso
la sua scelta stilistica, a catturare in
maniera autentica lo spirito di un
adolescente.
Recensione/2
Una Testa Mozzata
Andrea Rinaldi
C
’è una cosa da fare prima di
recensire questo libro: rendere omaggio al suo traduttore, Massimo Bocchiola. Spesso si tende a dare
per scontato o addirittura a ignorare
il lavoro di trasformazione e di filtraggio occorso tra la storia che stiamo leggendo nell’edizione italiana e
la storia in sé, come è nata nella sua
lingua, con tutto il suo background
di folklore e slang. Ecco, Bocchiola è
stato egregio nel consegnarci la parlata del giovane protagonista scozzese di questo libro, ma la lode forse
è superflua per una persona che da
dodici anni ci consegna i romanzi di
Irvine Welsh, Martin Amis, Jonathan
Safran Foer, Nick Hornby, Paul Auster e Charles Bukowski.
L’unica nota stonata, la mancanza
di note a piè pagina. Quando Irvine
Welsh parla di Burberry (descrive un
ragazzo “che annega in un mare di
Burberry”), usa una metonimia per
indicare le gang giovanili scozzesi,
che amano vestire con i capi di quel
marchio, ma il lettore come fa a saperlo?*
Veniamo alla storia. In Una testa
mozzata Jason King, ex-fantino e
giocatore di Subbuteo, e Jenny Cahill, figlia viziata di una ricca famiglia
e appassionata di equitazione, sono
due coetanei che vivono a Cowdenbeath, Fife Centrale, Scozia. Le loro
giornate sono quelle di due tipici
venticinquenni. Lui si barcamena tra
il torneo del popolare calcio da tavolo, sussidi, “pinte di oro nero” (leggi
Guinness) al Goth pub in compagnia
degli amici, abbandoni a fantasie
sessuali che al lettore più puritano
lo faranno sembrare un pervertito
bell’e buono. I capitoli di Jason sono
sboccati, a volte poco comprensibili,
ma sono i più spassosi, il suo slang ti
porta all’immedesimazione, a condividere il suo scazzo, a ridere con
lui come faresti con un amico, e insomma se proprio insisti sì dai a farti
anche te “una latta” di birra.
al potente regno dei Pitti (il re Giacomo I di Scozia lo apostrofò come
“un mendicante ammantato d’oro”).
Il titolo originale (Kingdom of Fife)
allude proprio a questo. Forse Welsh
ci dice che tutto il mondo è paese e
che la più remota provincia non ha
molto da invidiare al Fife.
Ci vorrà proprio la “testa mozzata”
che dà il nome all’edizione italiana
per far fuggire i due ragazzi dalla palude del Fife verso sponde più soleggiate, in tutti i sensi. Non aggiungiamo altro per non rovinare la sorpresa
al lettore, se non che ci siamo stancati di sentire Trainspotting agganciato sempre a Irvine Welsh. Dunque
aspettiamo con ansia la prossima
prova, la crime novel ambientata in
Florida “Crime”, già uscita nel Regno
Unito lo scorso settembre.
Lei invece è annoiata, ascolta Marilyn Manson, l’insoddisfazione per
la sua vita (ha rinunciato all’università per cavalcare, ma non è andata
come doveva andare) la sballotta
come un legno nella corrente da una
seduta in palestra, a una cavalcata
con il suo (azzoppato) Midnight, alle
frivole chiacchiere con l’amica del
cuore, ai litigi con il padre.
Le pagine del libro sono istantanee dello squallore provinciale
scozzese in cui i due ragazzi sono costretti a vivere. Intervallate da alcune
situazioni comiche come solo Welsh
sa creare, mischiando sesso e stramberie. Una su tutte: il travestimento
da bambina a cui si sottopone Jason
per scongiurare la sua eliminazione
dal torneo di Subbuteo.
Attraverso le loro riflessioni sentiamo la noia della pioggia insistente che ti bagna tutto, l’inutilità
dell’apertura di un nuovo Costa Coffee, il nulla che spinge gang e giovani
del luogo a passatempi efferati, come
i combattimenti clandestini fra cani
o alle rivalità con altre città, vantando qualità caratteriali appartenute a
un fastoso passato che non c’è più.
Il Fife è infatti la terza regione più
popolosa della Scozia e appartenne
9
* la Burberry ha dovuto ripensare
tutta la sua linea d’abbigliamento
proprio perché i suoi capi si erano
diffusi talmente tra i bulli delle downtown d’oltremanica da diventarne la
“divisa ufficiale”.
D
i sott’al patibolo, ove l’odio e
la festa fan grumo comune,
è ‘l tracotare di letterature involontarie, ineguale ciarlanza d’arrotini
che non si vuole nel letterario in cui
pure s’attarda. E così la mia voce inceda: l’incompiuto vi sia d’oggetto,
l’insaputo di regola.
costa solo 20 dollari. Bottiglia compresa. Un imprecisato spedizioniere
calerà da un furgoncino tutto nero e
ci consegnerà il fantasma sull’uscio
di casa. Firmeremo da qualche parte
e saremo lasciati soli: noi, il fantasma
in bottiglia, e una serie di documenti ufficiali che attestano l’autenticità
che gli impedisce di essere autentico. Non può essere contemporaneamente nostro e autentico. Oppure
può esserlo e, se così stanno le cose,
abbiamo appena dato vita a un mondo nuovo, nel quale vige la regola del
farsi fuori-dentro.
Letterature
involontarie
Fantasmi in bottiglia
di EDOARDO LUCATTI
A difesa del fantasma, non possiamo levare armi. A difesa del fantasma, non possiamo prendere o perdere tempo, né suggerire vie di fuga.
A difesa del fantasma - forse - non
c’è proprio niente che si possa fare.
La difesa del fantasma è impossibile, perché impossibile ne è l’offesa.
Il fantasma non ha luogo, nei due
sensi: non si da e non alberga. Le dimore in cui pare-apparire sono rese
all’illocale di un’epifania che beffa
la loro presenza, traversandone le
pareti e gli anni. Il fantasma non entra nell’ambiente, e certamente non
si preoccupa di uscirne; si limita a
significarne, in assoluto, la vanità. Come salutare, dunque, questi
spazzini di bottega, che il fantasma
– addirittura – vorrebbero venderlo
in pratiche bottiglie? Succede a St.
Augustine, Florida, Stati Uniti. Da
qui, un punto a caso sulla cartina
geografica più brutta del Mondo,
l’involontario letterato coemerge
alla letterarietà dell’involontario. Il
loro reciproco annidarsi, covarsi,
e venire alla luce in questa garrula
azienducola, la Roland-Deese Productions, il cui fantasma in offerta
dell’ectoplasma.
Verosimilmente,
nella grassa e vischiosa penombra
del salotto, passeranno diverse ore
prima che una serie di gravi questioni inizino a cinger d’assedio le nostre
meningi.
Perché 20 dollari? Perché li ho
pagati? Per avere un fantasma, si direbbe. Per disporre, cioè, di un essere – o, meglio, di un ek-sistere – il cui
proprium risieda nell’attraversare
ogni involucro. Ne disponiamo, tuttavia, a mezzo esclusivo di vitreo involucro, nel quale il fantasma medesimo si da per costretto. Lo paghiamo
per disporne e, dunque, perché lì sia
costretto, ma lo paghiamo anche in
quanto fantasma e, dunque, perché
lì non sia costretto. I nostri 20 dollari
cominciano a litigare fra loro. A che
titolo - di grazia – partecipano d’una
stessa impresa? Forse in nome d’un
ozioso paradosso? Oibò.
Il fantasma in bottiglia sfida la nostra pazienza. Affinché sia autentico
non può stare nell’involucro che ci
permette di possederlo. Affinché lo
si possieda deve stare nell’involucro
10
Ora, “farsi fuori” significa uccidersi, ma significa anche prodursi in un
altrove ed è probabile, a un qualche
livello, che l’una e l’altra accezione possano addirittura convergere:
uccidersi è un prodursi nell’altrove
più radicale; prodursi in un altrove
è morire al proprio dentro. Ma cosa
significa farsi fuori-dentro? Essere
un fantasma in bottiglia. Esserlo nel
senso di esisterlo. Esistere nel senso
di ek-sistere: stare nell’uscir fuori, aprirsi dell’ “avvenire – direbbe
Derrida – che risale all’imminenza
di una nascita”. È il problema di Artaud. “L’ineluttabile non ha ancora
cominciato ad esistere” e proprio per
questo è ineluttabile: si profila ma
non si sfila, non disperde la propria
tensione. E così il fantasma: si profila
al di là del vetro ma non se ne sfila e,
nel suo essere – a un tempo – nostro
e autentico, non disperde la propria
tensione. La storia traccia i propri
gesti, nuota sott’acqua e riemerge a
distanza, uguale nella sua diversità.
Ogni esodo, ogni uscita radicale, è in
rapporto a un’internità irriducibile.
L’esodo non è mai esterno a se stesso,
e non conta che continui a farsi fuori,
a fare il fuori di ogni situazione. Non
cessa di eccedere i luoghi a cui accede - è vero - ma è proprio in questo
stesso schema che non finisce mai di
incedere, mai, per l’appunto, esterno
a se stesso. E così il fantasma: dissipato dalla necessità impossibile di
quell’ingresso, non fa che incedere
nell’eccedere dell’accedere. I Ghostbusters, con la stolida villania dei
loro sigilli, sono il colpo di coda di
quella mediocrità che non sa rinunciare al suo piccolo safari.
C’è un carcere, tratto nell’illocale,
dentro il quale si continua a latitare. È
San Vittore, il carcere di Santino Santini, imputato di rapina e omicidio
aggravato, cui un giorno viene proposto di evadere. Laurie Anderson si
accorda con il giudice e proietta Santino su un calco posto in fondo a una
stanza buia della Fondazione Prada,
sempre a Milano. Santino si schiude
a una pradizzazione di San Vittore,
correlativa d’una Sanvittorizzazione di Prada. Santino-sul-calco non
parla, non vede, soprattutto non si
muove, ma si concede a un discorso
altrui che lo autentica nell’ovatta del
distare: “Santino – racconta la Anderson – non ha la possibilità di parlare, e mi ricorda la comunicazione
che c’è fra i bambini quando cercano
l’attenzione dei genitori distratti, oppure conversazioni in cui a un certo
punto del discorso ti rendi conto che
l’altro non c’è o sei tu che non ci sei,
che non comunichi niente.” Così il
fantasma: evade da un involucro
che non lo cede del tutto, sgrammaticandolo quel tanto da renderlo
nostro e autentico, presenza che non
c’è – traspiranza della trasparenza - o
rispetto alla quale siamo noi a non
esserci, a non esserle accordati. Conclude la Anderson: “Avete presente
quelle notti in cui dormite ed è completamente buio e silenzioso e non
sognate? La vera ragione è questa: in
quelle notti siete andati via. Siete nel
sogno di qualcun altro. Occupati nel
sogno di qualcun altro.”
Verbosometro
Verbosometro
L’eloquio deloquia: lo si parametri, dunque, in funzione di soglie di
verbosità che ne dipanino l’evolvere,
l’involvere e l’avvolvere.
Da 0 a 5 espressioni verbose.
Latenza del verboso. Il singolare
riluce nel pauperismo dei villici, ramingo dinoterio prosodico scampato all’impudente glaciarsi del dire.
Da 5 a 10 espressioni verbose.
Brezza verbosa. Distendesi l’eloquio lungo plaghe d’orpelli musabili,
muscovite di senso che rattiene la
voce in gibigiana.
20
15
10
5
Da 10 a 15 espressioni verbose.
Telluria verbosa. Ciacchero clivo del sema che incerona l’abisso a
meta, liberando legioni d’una lutulenza che ‘l pudore tenea per ascosa.
Da 15 a 20 espressioni verbose.
Verbocrazia. Tripudio fulgente
della lingua: di fuètto s’agguizzano i
nervi palatali; ne promana un sentire
che mal s’addice al fucato anelito del
frasaio e ben si predica, invece, d’un
dire-miele la cui voce - per ovunque
- si dissipa.
Più di 20 espressioni verbose.
Verborrimìa. Il nulla s’attarda nel
discorso e ne fa vano asfodelo.
0
Farsi fuori-dentro. 20 dollari spesi
bene.
11
L'Intervista
a Gianluca Morozzi
di ANDREA RINALDI
D
aniel è un rivenditore di dischi e fumetti rari, vive
a Bologna con una fidanzata scrittrice di romanzi
erotici, ma su Terra L., un mondo parallelo simile al nostro. Daniel in realtà è un supereroe di nome Leviatan che
cambia poteri ogni dodici ore e che si ritrova a combattere
contro David Bowie e Lou Reed, diventati folli criminali
dopo che un certo Johnny Grey ha scritto tutte le canzoni
più famose della storia della musica. Intanto sulla Terra,
dove David Bowie e Lou Reed sono rispettate rockstar, un
musicista in crisi di ispirazione ha pochi giorni per scrivere la canzone che rilancerà la sua band.
Gianluca Morozzi torna in libreria con il suo nuovo
romanzo, Colui che gli dei vogliono distruggere (Guanda), dove personaggi strampalati e situazioni surreali si
moltiplicano questa volta in due mondi. Una storia ironica e che sposta i clichè dello scrittore bolognese nella
fantascienza. «Io non volevo essere un romanziere classificabile – spiega – con Blackout ho esplorato il noir, con
il secondo mi sono buttato su un altro genere, poi dopo
aver scritto per un po’ cose simili ho voluto allargarmi alla
fantasia, pensando a un supereroe vero ma nel contesto
realistico di Bologna-. È stato difficile ma ce l’ho fatta, ora
mi sento uno scrittore libero».
Ci sono voluti due anni perché quest’ultima fatica di
Morozzi vedesse la luce: «Dissi al mio editore “Jonatham
Lethem farà sicuramente un romanzo sul supereroe e io
lo voglio anticipare”. Poi con la stessa idea, e più o meno
contemporaneamente, è uscito Marco Mancassola per
Rizzoli… si vede che era nell’aria». Oggi certi exploit cinematografici hanno aiutato il mondo della graphic novel,
dice Morozzi, visto che in Italia non godeva di molta considerazione. In Colui che gli dei vogliono uccidere tornano
inoltre i personaggi di L’era del porco, come Kabra (è lui il
musicista in difficoltà), il gruppo rock dei Despero, Elettra
e l’edicolante Shater Hunder che si crede un supereroe.
«Qui li presenterò di nuovo al lettore perché non voglio
che il libro si trasformi in una saga a puntate, gli appassionati però riusciranno a cogliere alcune citazioni -. Ho
ripescato Kabra perché non volevo descrivere il solito
scrittore in crisi». La musica scandisce la narrazione anche in questo nuovo romanzo di Morozzi, tanto il reading
bolognese di presentazione è stato accompagnato dalla
12
band della sua ragazza, gli Elymania, che ha riproposto la colonna sonora del libro con pezzi di Lou Reed,
Bowie e gli Who.
Colui che gli dei vogliono uccidere «è stato poi
scelto come progetto degno di interesse alla Berlinale, speriamo in bene», confida lo scrittore, che ha
ceduto i diritti de L’era del porco alla Indiana Film,
mentre sui grandi schermi messicani a fine mese
uscirà la trasposizione del romanzo Blackout, dove
due ragazzi rimangono bloccati in ascensore con un
serial killer. «Una ditta di ascensori aveva fatto causa
alla produzione, dopo che il film era pronto per essere distribuito, ora pare che la cosa sia risolta, speriamo arrivi
anche in Italia».
L'angolo del
cinematografo
Quando manca la
primavera
La narrazione è scandita dal
susseguirsi delle stagioni: ESTATE
- fioriscono i sogni – AUTUNNO cadono le certezze – INVERNO - la
solitudine rimane l’unica verità.
di JACOPO SGROI
REQUIEM FOR A DREAM
un film di Darren Aronofsky
B
rooklin, un appartamento
vecchio, sporco e ammuffito:
la vedova Sara Goldfarb vive sola;
a farle compagnia c’è un televisore
sempre acceso, con il suo circo di
imbonitori urlanti, con le risate e gli
applausi preregistrati. Non c’è sogno
o speranza nella vita di Sara fino al
giorno in cui le viene comunicato
di essere stata scelta per partecipare
ad un talk show. In vista della partecipazione, Sara si imbottisce di anfetamine dimagranti per riuscire ad
indossare il vestito rosso che, dal diploma del figlio Harry, non riesce più
a mettere. La dipendenza dai farmaci
la condurrà verso una condizione di
delirio in cui il sogno si farà incubo.
Harry è un tossicodipendente,
vive di piccoli espedienti per sostituire lo squallore che lo circonda con
piacevoli illusioni. Insieme all’amico
Taylor, Harry riesce ad entrare in un
giro di spaccio che gli permette di
guadagnare soldi facili, ma presto i
due capiscono di essere dei semplici
burattini in mano ad un sistema più
grande di loro pronto a fagocitarli e
a vomitarli.
Harry ama Marion, una giovane
e bella designer, col sogno di aprire
una sua boutique. L’amore che lei
delirante. Queste scelte registiche
rendono onore allo stile di scrittura
di Hubert Selby Junior, privo di punteggiatura e di a capo: un tuffo nelle
ossessioni del pensiero umano, in un
continuo crescendo, senza tregua,
senza sosta e senza respiro fino ad
un inevitabile “nero”.
nutre per Harry colma il vuoto lasciato da una famiglia, ricca e assente;
questo però non le basta e, insieme
al suo compagno, si lascia consumare da eccessi ed abusi. Marion sarà
costretta a vendere il suo corpo per
avere quella dose minima di illusioni
necessaria a sopravvivere, ma non
c’è più spazio per i sogni.
Presentatosi agli spettatori poco
più di dieci anni fa con il film Pi
greco. Il teorema del delirio (1997),
Darren Aronofsky sta finalmente ottenendo i meritati riconoscimenti di
critica e di pubblico: The Wrestler (in
uscita nelle sale il 6 marzo), ha vinto
il Leone d’oro al Festival di Venezia
2008 e ora ha ottenuto 2 nomination
ai premi Oscar. Il talento visivo di
Aronofsky è già evidente nella sua
opera seconda, Requiem for a Dream, del 2000 (edito in Dvd Dolmen
Home Video www.emik.it) . Nella
fase di scrittura Aronofsky ha chiamato al suo fianco l’autore del testo
omonimo (Fazi, 2004), il romanziere
americano Hubert Selby Junior [Ultima fermata a Brooklin (Feltrinelli,
2000)]. La solida sceneggiatura scaturita da questa collaborazione ha
trovato soluzione in una trasposizione visiva trascinante: Aronofsky
frammenta le inquadrature sullo
schermo, sovrappone le immagini,
accelera i movimenti, con un ritmo
di montaggio frenetico, ossessivo e
13
Tutti i personaggi hanno in comune il sogno di una vita felice, una
vita in cui la solitudine è bandita e in
cui l’affermazione di sé arriva unicamente dall’amore che riempie i vuoti
in cui si è immersi. Ma nessuno dei
personaggi ha la forza di accettare il
dolore che costituisce il quotidiano e
nessuno ha il coraggio di combatterlo: le piccole speranze che nutrono
le loro vite sono pura finzione che
li conduce verso l’autodistruzione.
All’inverno non farà seguito la primavera.
Requiem for a dream di Darren
Aronofsky (Usa 200) con Jared Leto,
Jennifer Connelly,Ellen Burstyn
Oh oh, Incitatus, oh oh
Vecchio Senatore: Mi strofina il
dito nel palmo della mano. Mi chiama bella mia. Mi tasta il sedere. Basta, deve morire.
(Caligola, Atto II, Scena I)
regista teatrale sarebbe un’idiozia: è
tutto scritto lì, no? Certo, che è tutto
scritto lì. Ma nessuno – nessuno – fa
quello che è scritto lì. Con la stessa
libertà con cui un regista cinematografico adatta un romanzo al grande
schermo, un regista teatrale prende
Recensione/3
Caligola
Simone Rossi
A
h, l’influenza della tragedia nicciana sul Caligola di
Camus. Ah, la coppia Dioniso-Demetra come archetipo della coppia
Caligola-Drusilla. Ah, Hitler come
incarnazione storica di Caligola. Ah,
Caligola come tassello della Trilogia
dell’Assurdo di Camus, insieme a Lo
straniero e Sisifo. Ah, le tre versioni
di Caligola. Ah, Carmelo Bene che fa
Caligola.
un testo e lo allestisce. La divaricazione tra quel che hai letto e quel che
vedrai è spesso abissale. “Com’era il
film?”. “Era meglio il libro”. Com’era
lo spettacolo? Era meglio il testo.
Questa rubrica, se fosse una rubrica, si chiamerebbe: Oh, Scena. Tratteremo i testi teatrali come se fossero
libri e, no, non viceversa. Che cosa significa trattare i testi teatrali come se
fossero libri? Ma soprattutto, stiamo
ancora qua a farci domande sul significato delle pratiche intellettuali?
Ammettetelo: non vi è mai successo di fare un commento simile
dopo essere usciti da teatro. Eppure,
ne avremmo tutto il diritto: un testo
teatrale non presuppone la propria
messa in scena, allo stesso modo in
cui un romanzo non presuppone la
propria riduzione cinematografica
o una ricetta di cucina non presuppone la propria implementazione. Il
testo teatrale sta su anche da solo: la
tensione verso il fuori, verso il film
che deve ancora essere girato (Pasolini), quella tensione lì, è propria di
qualsiasi libro. Qualsiasi libro bello,
almeno.
Uno scrive una commedia, o una
tragedia, o una tragicommedia. Un
altro arriva e la mette in scena. A
volte è la stessa persona: il vecchio
Albert diresse personalmente un
paio di allestimenti dell’opera (nel
’57 e nel ’58, se volete fare i fenomeni
a Trivial Pursuit). Mettere in scena
un testo teatrale, ecco: non è che in
teatro è più facile perché ci sono già
le battute scritte. Altrimenti fare il
Il testo teatrale, dunque, come
genere letterario. Volete raccontare
una storia fatta solo di dialoghi? Se
non andate mai a capo, avrete scritto Colline come elefanti bianchi di
Hemingway (bene che vi vada). Se
andate a capo, e riscrivete ogni volta il nome di chi parla, avrete scritto
un testo teatrale. Scrivere dei buoni
dialoghi è una faccenda complicata. Per questo è complicato scrivere
Duepalle.
14
buoni testi teatrali: ci sono dialoghi
dappertutto.
Poi ci sono quelli che parlano da
soli, e i dialoghi li fanno con lo specchio. Sono i matti. Caligola è matto,
sua sorella era la sua amante e adesso
è morta e lui è matto, completamente matto. “Ho deciso di essere logico.
Vedrete quanto vi costerà la logica.
Il potere ce l’ho io. Eliminerò chi mi
contraddice, e anche le contraddizioni. Comincerò da te, se necessario”. “Da questo momento e per sempre la mia libertà è senza più limiti”.
“Per un uomo che ama il potere, la
concorrenza degli dei è seccante. Io
l’ho eliminata. Ho dimostrato a questi dei effimeri che un uomo, se ci si
mette, può esercitare senza nessuna
pratica il loro ridicolo mestiere”. “Mi
è venuto un bel pensiero, che vorrei
dividere con voi. Il mio regno finora
è stato troppo felice. Nessuna grande
epidemia di peste, nessuna crudeltà religiosa, e nemmeno un colpo
di stato – in breve, niente che possa
farvi passare alla storia. E’ un po’ per
questo, vedete, che cerco di controbilanciare la clemenza del destino.
Voglio dire… non so se mi avete capito (con una risatina) insomma, sono
io che faccio le veci della peste”.
Con una risatina.
Caligola non ha amici (figurarsi).
Caligola ha spettatori. Atto Primo:
Disperazione di Caligola. Atto secondo: Recita di Caligola. Atto terzo: Divinità di Caligola. Atto quarto: Morte
di Caligola. Quattro atti, e mancano
due cose: il quinto atto, e il cavallo.
L’unico aneddoto che tutti sanno su
Caligola è che una volta fece senatore il suo cavallo, per dimostrare ai
senatori che chiunque poteva essere senatore: ti faccio ghirighiri sulla
mano e ti tocco il culo, poi ti sostituisco con uno stallone.
Camus non dice la parola cavallo,
mai. Racconta molti altri aneddoti,
tutti più divertenti. Il cavallo, se vi
interessa, si chiamava Incitatus. Caligola, alla fine, muore.
Recensione/4
Il libro nero
Greta Travagliati
"N
on c’è nulla di sorprendente come la vita. Tranne
lo scrivere. Lo scrivere. Sì, certo, tranne lo scrivere. L’unica consolazione
che abbiamo.” Termina così Il libro
nero di Orhan Pamuk. Tra i quartieri fatiscenti di una Istanbul a due
anni dal colpo di stato, un avvocato,
Galip, cerca la moglie scomparsa ed
il fratello di questa a sua volta sparito, Celâl, noto rubricista accusato di
lanciare messaggi criptici e sovversivi ai suoi lettori, sospetto seguace
de l’ “hurufismo”, affascinante teoria
secondo la quale i volti degli uomini
non sarebbero che lettere, così come
il mondo intero un nido di segni da
decifrare.
Ogni mattino una Istanbul sonnacchiosa si sveglia e legge le sue ru-
briche sul Milliyet, cercando di capire attraverso frasi che descrivono la
vita quotidiana di barbieri, creatori
di manichini o librai, quale sia il proprio destino.
Ogni mattina Galip si sveglia e
deve capire cosa si nasconda dietro
il suo mistero privato, dove sia finita
la moglie Ruya. Per farlo comincia a
“leggere” le cose che lo circondano
come fossero indizi, alla pari degli
investigatori dei gialli polizieschi che
la moglie amava tanto; ma tale percorso finisce per svelargli una Istanbul sconosciuta, incantevole ed incantata, in cui ogni oggetto nasconde
un segreto. Quale segreto? L’unica
cosa chiara è che nulla è ormai chiaro, tutto raggiunge una complessità
disorientante, l’intrigo della moglie
si sovrappone a quello della città e
Galip si ritrova perso in un mondo di
simboli che hanno a loro volta perso il proprio mistero, restando per
questo indecifrabili. Ed è questa la
chiave del racconto. Tutto si infittisce perché ogni cosa sta perdendo
il proprio mistero, lento travaglio di
una città votata all’occidentalizzazione. Egli perde il suo posto, prende
quello di Celâl, fondendosi col ritmo
violento di una cultura complessa,
di una città che, seppur vista mille
volte, appare ora come appena conquistata. “Gli oggetti erano ormai gli
inquietanti segni, per nulla familiari,
di un mondo non più disposto a cedere facilmente i propri segreti”. Galip legge le lettere sul suo volto: non
potrà mai essere se stesso.
E questa è la condizione di ognuno di noi, nessuno potrà mai esserlo
perché non vi è spazio se non per indizi, scoperte e, soprattutto, intrecci
narrativi. Perché “il mondo non rivela facilmente i suoi segreti ma per
penetrarli, questi segreti, è necessario comprendere prima di tutto il
segreto delle lettere”.
Iniziamo?
Charlie VS Proust
Prologo
di CARLO ZUFFA
P
erchè? Non sono un fan della letteratura francese,
neanche in accezione facebookiana (licenza poetica). Non ho quel background per cui questa lettura possa
giustificare un percorso di formazione. Non ho nemmeno
l'idea a cosa vada incontro affrontando quei sette volumi
in brossura (più l'ottavo di commento all'opera che non so
se tenerlo per ultimo come il dolce o usarlo come antipasto) che riposano da un paio d'anni sullo scaffale, figli di
un avventato acquisto su IBS (pubblicità occulta).
Perchè allora? Per vedere di nascosto l'effetto che fa?
Perchè un istinto masochistico mi attanaglia? O perchè in
fondo vantarsi al bar con gli amici di aver letto Alla ricerca
del tempo perduto (più commento all'opera) fa un mucchio figo? Non saprei, fatto sta che queste sfide mi attraggono e quindi ora è arrivato il tuo turno, Marcel. •
15
Nei prossimi mesi (o anni) cercherò di venirne a capo e
riporterò su questo mio diario improvvisato le impressioni di questa mia scalata al tuo K2 letterario.
questa avventura e non sa come (e se) ne uscirà, trascrivendo ciò che riuscirà a snocciolare dal livello di lettura
più infimo e presentarlo solo leggermente infiocchettato,
in modo da poterlo discutere la sera con gli amici.
Beninteso, saranno le affermazioni di chi tiene il Manuale delle Giovani Marmotte in bella vista nella sua libreria, perchè in questa rubrica non si parlerà del livello
semiotico dell'opera, dell'Io multiplo, di felicità e di Tempo, ma di ciò che la casalinga di Voghera si troverebbe di
fronte approciando la Recherche.
Infatti un altro titolo papabile per questa rubrica era
Proust visto la sera dal Bar Sport, ma era troppo lungo e
incasinava l'impaginazione.
Quindi, dopo una dovuta premessa, diamo il via a questo esperimento di lettura creativa.
Il commento non avrà quindi la spocchia di usare accademismi, paroloni e corbellerie di cui neanch'io conosco
il termine, ma di riportare gli umori di chi si imbarca in
- In guardia, Marcel!
Recensione/5
Neve
Alberto Cocchi
N
eve è il romanzo d'esordio di
Maxence Fermine. Neve è un
romanzo, ma anche qualcosa di più:
è un inno di amore per la scrittura.
Un giovane e promettente poeta
celebra, con le sue parole, la gelida e
disperata bellezza della neve. Un anziano pittore dipinge ossessivamente
il ricordo dell'amata fino a diventare
cieco. Un'equilibrista si sente libera
solo quando può sfidare se stessa sospesa nel vuoto. A unire questi personaggi è la ricerca della perfezione
e, in un certo senso attraverso questa, della felicità.
La neve, la carta... e una storia
d'amore, per una donna e per l'arte
della scrittura. Il racconto muove i
suoi primi passi con circospezione,
poi cresce e diventa di folgorante
16
bellezza.
Neve contiene qualcosa, qualcosa
che appartiene solo ad un certo tipo
di letteratura, qualcosa che proietta
il lettore verso un piano secondo,
permettendogli di scorgere la bellezza nella semplicità.
Infatti Fermine, come nell'arte
della poesia haiku, che in pochi versi racchiude una sensazione molto
forte provata dall'autore, riesce a
concentrare in poche pagine (107)
un flusso di emozioni e di sensazioni
davvero impensabile.
Neve fa parte della narrativa Bompiani ed è stato pubblicato nel 1999.
Dopo questo, Fermine, che è nato
a Grenoble nel 1968, ha pubblicato
altri nove libri: l'ultimo, nel 2007, si
intitola Le tombeau d'étoiles (Albin
Michel).
C
i sono due modi per raccontare storie: la noiosa verità e la
mirabolante esagerazione dei fatti.
L’esagerazione dei fatti, o iperbole,
è bella perché è una caricatura. Wittgenstein (yawn) diceva che fare una
caricatura non è altro che privilegiare e mettere l’accento su una parte
in rapporto con il tutto, creando
dunque, dico io, una sproporzione.
O meglio, un’assimmetria. L’asimmetria fa ridere e fa pensare, perché
non è regolare, dunque buffa, e va
messa a posto gestalticamente con
la propria testa. L’iperbole, la storia
esagerata, segue esattamente questa
dinamica: è divertente e fa lavorare il
cervello. Fa ridere e fa pensare.
Ci sono poi due ruoli che si alter-
nano nelle storie: la banalità dei vincitori e il sorprendente spessore dei
perdenti. Le storie dei vincitori sono
retroattivamente incastrate nel rasoio di Occam: la soluzione è spesso la
più semplice e ovvia. Quando le leggi, sembra che tutto sia andato liscio,
che sia successo quello che doveva
succedere e niente altro. L’eroe ha
vinto perché è buono, la soluzione più semplice è che vinca. Non si
scappa.
Karate Kid. Solo che loro perdono
per costituzione.
Le storie dei perdenti invece sono
più belle perché i perdenti, per tirare
acqua al loro mulino, si raccontano
in modo più personale, più soggettivo, si guardano dentro non potendo
ovviamente aggrapparsi alla rassicurazione dei fatti oggettivi. Trovano la
verità dentro di sé, non fuori, come
In questa rubrica accoppieremo
felicemente questi due fenomeni, raccontando storie esagerate di
grandi perdenti. Quel ganzo di Walter Benjiamin ha detto che la storia
è il bottino dei vincitori. L’iperbole,
allora, è la risorsa, forse l’ultima, dei
perdenti.
E la verità soggettiva è infinitamente più interessante: come diceva
qualcuno (quel qualcuno era Kierkegaard ma avevo paura di annoiarvi
ancora di più), con soggettivo non
si intende un attributo relativistico
ma una appropriazione della verità
in termini esistenziali. La verità per
me.
Iperboloser
Lou Gerigh
di JACOPO CIRILLO
L
ou Gherig è tristemente famoso per il morbo di Lou Gherig.
Ma il morbo ha preso il suo nome sia
perché lo ha affetto, sia perché Lou è
stato uno dei più grandi giocatori di
baseball, il più grande “prima base”
della storia dello sport. E soprattutto detiene un record, una striscia di
2.130 partite consecutive in cui ha
giocato titolare.
E chi era la sua riserva? Un tale
Wally Pipp che, a dispetto del nome,
era un buon giocatore. Questa è la
storia di Pipp e della sua aspirina.
Il buon Wally era titolare inamovibile dei New York Yankees e aveva
praticamente alle sue dipendenze
questo ragazzino, Lou, la sua riserva,
che faceva ciò che tutti i “rookies”
nello sport sono costretti a fare: portargli la borsa, cedergli i soldi per la
merenda e calarsi i pantaloni per
celia. Pipp era un gran sbruffone e
agli allenamenti, per fare il bello,
batteva con la mano sinistra, con
gli occhi chiusi, insomma non mostrava nessun senso critico verso la
sua instabile posizione di giocatore
titolare. Quando qualcuno gli faceva notare che sarebbe potuto essere
scalzato, lui faceva la faccia di chi ha
paura per finta e diceva Ooooh, e chi
mi porterebbe via il posto? Il piccolo
Lou? Ma se ha un nome da femmina
ahahahhahaaa!
La notte del 1 giugno 1925, famosa
per una grande tempesta abbattutasi
su New York, Pipp si chiuse in casa
con alcuni amici e si prese una mo-
17
derata sbornia, tanto che il giorno
dopo andò alla partita con un mal di
testa fastidioso ma tranquillamente
sopportabile.
Il coach disse Allora Wally, vai in
campo e lui, sprezzante, disse Coach,
mandaci il ragazzino, io ho mal di
testa. Vieni ragazzino, è il tuo turno.
Pipp gli fece un simpatico sgambetto
proprio mentre saliva le scale dello
spogliatoio, irridendolo rumorosamente e Lou, tutto tremante, iniziò la
sua prima partita tra i professionisti.
Se la cavò bene visto che quella fu
la prima di 2.130 consecutive che relegarono per sempre il povero Wally
Pipp in panchina. Ed è per questo,
e solo per questo, che pippa nello
sport significa scarsone.
"La vita dentro una parentesi graffa" parla di Graffetta, in pillole musicali. E' una lei, ha intorno ai 20 anni e
mi sta terribilmente sulle palle. Le storie di Graffetta, in
bilico fra incomprensibilità e maleducazione, parlano di
musica attraverso la narrativa, e si sviluppano solo sulla
base degli spunti musicali. Una band, un album, le idee,
e Graffetta: "La vita dentro una parentesi graffa" diventa
una microstoria a puntate delle band che mi piacciono
raccontata sulla pelle di una
antieroina del nostro tempo.
modo diverso, anche un tappeto di violini che tiene note
lunghe ha un carattere nebbioso, o nebuloso. Seppur più
primaverile e profumato. In modo ancora diverso, anche
il muro del suono di Phil Spector aveva alcune sembianze
nebulosiche, sebbene più vicine all'afa d'agosto. Le nubi
nebulose di Graffetta invece erano del tutto invernali - o
tardoautunnali - e giocavano a distendersi su tutto ciò che
trovavano a portata di mano: si sciolgono sulla strada provinciale così come sulle cime
dei pini marittimi, sui tetti delle
case ma anche sulle punte dei
' inverno era la stagiofili d'erba di ogni giardino. La
ne preferita di Graffetta.
nebbia, the fog. Allora GrafL'inverno copriva le sue ossa
fetta prendeva la macchina e
sporgenti, l'inverno mascherava
guidava per non più di 500m di
i paesaggi, l'inverno deformava
raggio. Scopo: trovare un paegli umori. "In inverno la gente è
saggio ben ricoperto nel raggio
stitica, di emozioni, e dà la colpa
di 500m. Scopo alla seconda:
al brutto tempo", pensava Grafridisegnare i contorni del paefetta. E' per questo che riteneva
saggio. Graffetta posteggiava la
opportuno tenere in sordina la
Trevis, alzava il riscaldamento
sua preferenza per la stagione
nell'abitacolo e attraverso il
invernale per salvaguardarne la
di LIVIA FAGNOCCHI
vetro appannato osservava purezza. Un atteggiamento popallida e assorta come Montale
sitivo verso l'inverno è social- ciò che si dava ai suoi occhi:
mente controverso, così dicono. Nelle stagioni calde c'è il
una grey anatomy, un'anatomia grigia e confusa, brevissole, c'è caldo, ci sono i fiori, le passeggiate all'aperto. Si è
sime sorgenti di vita, scaglie di profili, tranci di oggetti
accecati e storditi, si suda puzzo, le rose hanno le spine, le
penzolanti. Graffetta iniziava a disegnare un paesaggio
pesche mature sbrodolano, il cemento si scioglie in città.
conforme alle sue immagini, dove si salta sulle pareti di
mattone e ci si arrampica sulle nubi con casco luminoso,
Graffetta amava il paesaggio alterato e camuffato, che
scarponcini e piccone.
fosse di pioggia violenta, che fosse di neve, che fosse di
nebbia all'alba. Quest'ultima raggiungeva gli effetti più
Fatto di pennarello e disegnato sul vetro, il paesaggio di
deturpanti: la nebbia, the fog, 3 lettere come tre e come
Graffetta nasceva sulla nebbia. Così, il paesaggio dei Neu
Neu. Tuttavia la nebbia e i Neu sono a base 4, coprente,
era fatto di chitarre e tastiere, emerse da un paesaggio ritripetitiva, monotona. Prova a stenderla con matterello opmico, profondo, torbido, e pure mantrico.
pure anche a guardarla in orizzontale: è una calza grigia. In
L
Graffetta
post 1 / "a grey
anatomy"
Recensione/6
L'Uomo dei Dadi
Carlo Zuffa
L
'altro giorno sono rimasto
affascinato mentre guardando
quel programma su MTV dove i
teenager d'oltreoceano, con una certa
indole nerd (o finta tale per motivi
di copione), sono affranti dalla loro
18
vita sociale scialba ed emarginata, e
per dimostrare agli amici una certa
rilevanza all'interno del gruppo, si
trasformano in fortissimi quarteback
o assi del motocross nel giro di un
paio di settimane, traviando l'ego
delle prossime due generazioni di
americani che li stanno guardando.
Luke nella New York di quarant'anni fa non aveva questo problema. Anzi risolse i conflitti con il suo
Io annichilendolo completamente.
Affidò tutto ai dadi e decise qualsiasi aspetto della sua vita consultando una coppia di cubi verdi che •
rotolando decidevano per lui il suo futuro. E Luke non
c'era, c'era l'Uomo dei Dadi, una matrioska vuota riempita dalla aleatorietà delle opzioni che egli dava in pasto al
Caso.
caos. Un Fight Club che sostituisce il caso ai cazzotti.
Prendano spunto gli autori di Mtv. Quando una semplice lancio ti fa scendere le scale e violentare la moglie del
vicino, nonche collega, nonchè migliore amico, c'è qualcosa di grosso in ballo.
Ci prese gusto a tal punto da diffondere il suo verbo fra
i conoscenti, e la naturale conseguenza fu aprire i Centri
del Dado, dove la gente imparava ad ammutolire il proprio Io per darsi alle più camaleontiche espressioni del
Ma dimmi Luke, mentire agli altri è moralmente riprovevole, ma mentire a se stessi è profondamente sadico?
Recensione/7
I Sotterranei
Jacopo Donati
C
i sono libri che, per ragioni di
mercato, rimangono nell’ombra di un’altra opera dello stesso autore. È il caso di I sotterranei di Jack
Kerouac, libro meno conosciuto del
più blasonato Sulla strada ma da
molti ritenuto il capolavoro dell’icona della Beat Generation.
Come molti suoi libri, anche
questo è una storia autobiografica,
la storia d’amore tra Leo Percepied
(l’autore) e la bella Mardou Fox (Alene Lee), una ragazza di colore che
strega a prima vista Kerouac.
È un romanzo breve che si narra
fu scritto in sole tre notti grazie alla
benzedrina, subito dopo la fine della loro storia. Le ragioni della scarsa
popolarità sono dovute ad uno stile
particolare che in qualche modo rimanda allo stream of consciousness
di James Joyce e Virginia Woolf. I
sotterranei sono uno dei migliori
esempi di quella che lo stesso Kerouac chiamava prosa spontanea:
far sgorgare le parole senza porre
alcun freno, in maniera automatica
e genuina. Non c’è costruzione per
conformare il pensiero alla lingua,
né deve essere presente uno sforzo,
da parte dell’autore, perché al lettore
sembri un flusso di coscienza. Se lo
scrittore lo compie, la spontaneità è
già persa.
Il risultato è che si fatica un po’
a trovare il giusto ritmo di lettura:
spesso la punteggiatura è assente e
quello che doveva essere un piccolo
inciso stretto tra due virgole, finisce
con il diventare un discorso più ampio che, conclusosi, cede nuovamente il passo alla storia. Ci si perde e ci
si ritrova con una grande naturalezza
e il pregio di questo libro è proprio
il cullare delle frasi. Presto ci si accorge che più ci si sforza per dargli
un’impalcatura logica, più si fatica
a seguirlo: l’unica soluzione è continuare a leggere e far sì che il ritmo
delle frasi – un ritmo assolutamente
bop – si impossessi della mente e si
sincronizzi con essa. Tutto, dopo, diventa naturale, quasi telepatico.
La lettura, infatti, dovrebbe avvenire nello stesso modo in cui Kerouac suggeriva di scrivere, ovvero
“«senza coscienza» in semitrance
[…] permettendo all’inconscio di
19
far entrare il proprio linguaggio non
inibito interessante necessario”. È in
questa maniera che Kerouac riesce
a liberarsi del dolore di quell’amore
finito male. Cosa ottiene in cambio
il lettore? Le emozioni vere, i sentimenti reali che Kerouac patì per poi
riversarli su carta.
Alla fine del libro è presente una
breve postfazione di Henry Miller,
scritta appositamente per l’edizione
italiana. Dipinge Kerouac come un
violentatore della lingua moderna,
un virtuoso che sa giocare con le parole e si prende gioco di ogni regola
convenzionale. Uno scrittore che ha
saputo cristallizzare la parlata come
fosse una fotografia istantanea. In
un’opera come I sotterranei è riuscito proprio a fare questo.
Henry Miller non solo era amico
di Kerouac. Entrambi condividevano
la passione per raccontare la verità
e ciò li portò più volte in tribunale.
Non fece eccezione questo lavoro
che fu accusato di essere un romanzo
osceno e pornografico, un’opera non
degna di essere letta né venduta. La
sentenza che lo scagionò merita di
essere citata (e lo è in quarta copertina) perché riesce a riassumere in poche parole tutti i pregi del romanzo,
come “la bellezza lirica di alcune sue
immagini, la forza e il ritmo del racconto, la ricerca accurata di richiami
ed espressioni come elementi che
consentono al collegio di pervenire
alla conclusione che il romanzo è
opera non pornografica e non oscena; è invece opera d’arte”.
Fa più freddo un freezer a -15°C
o l’acqua a 0°C?
B
eh, la risposta pare ovvia. Un
po’ come chiedere se pesa di
più un chilo di paglia o un chilo di
piombo. Invece no, le cose non sono
così semplici: il “freddo” che noi
percepiamo non è esattamente la
temperatura (che si misura in gradi
centigradi) del mezzo (aria, acqua o
qualsiasi altro corpo) con cui siamo
in contatto, ma piuttosto la quantità
di calore che scambiamo con tale
mezzo per unità di tempo.
Capiamoci meglio: se la temperatura esterna è di zero gradi ma l’aria
è secca e ferma si tratta di un freddo
sopportabile. Se c’è nebbia o soffia
il vento, il freddo diventa intenso. Si
parla quindi di temperatura percepi-
prata dal Pakistano, calda.
Che facciamo allora? Ne mettiamo
una in freezer, a -5°C con aria secca
e ferma o ne mettiamo una a mollo in acqua e ghiaccio, a 0°C, ma in
un mezzo conduttore di calore? Nel
primo caso per raffreddare saranno
necessari 20, 30 minuti, con il rischio
di dimenticarsi la birra e trovarla
esplosa (perché esplode? Presto la
risposta …), nel secondo caso in 5-6
minuti avremo una birra ghiacciata.
Ancora meglio: un bagno di acqua
salata e ghiaccio può arrivare a -4°C
(le famose proprietà colligative), se
teniamo l’acqua agitata scambierà
ancora più calore, e in un paio di minuti la nostra birra sarà pronta per
essere bevuta. Fredda. Provare per
credere.
(è un’operazione facile!) quanti atomi di sodio ci sono in una goccia di
acqua minerale, si accorge che ce ne
sono miliardi di miliardi. Qualcosa
come 1020. E ora tocca fare i conti:
una bottiglia di acqua povera di sodio ne contiene circa 18-25 mg. Una
di acqua normale 50-100 mg. Un etto
di prosciutto in media 2500 mg. Un
italiano medio, normalmente, assimila dalla dieta dagli otto agli undici
grammi di sodio al giorno.
Respirando, si assimilano 2-3
grammi di sodio al giorno a causa
del pulviscolo che entra nei polmoni. Il contributo di sodio assimilato
dall’acqua, quindi, è equivalente a
quello di un colpo di cerbottana durante il bombardamento di Dresda.
Perché poi eliminare il sodio? Il sodio è presente nei fluidi all'esterno
delle cellule e il suo
equilibrio con il potassio (presente all'interno
delle cellule) garantisce
il buon funzionamento
del sistema. Quando si
perdono grosse quantità di sodio con il sudore
e si ingeriscono, all'opposto, grandi quantità
d'acqua pura o con pochissimo sodio si perde la sensazione della
sete, sodio-dipendente,
si riduce la possibilità di idratarsi e
aumenta la produzione di urina per
ridurre la diluizione del sodio. Per
cui, paradossalmente, ci si disidrata
pur bevendo parecchio. In casi gravi,
ma rari, si può incorrere in una vera
e propria "intossicazione d'acqua"
chiamata iponatremia che si manifesta con giramenti di testa, cefalea,
malessere, nausea e crampi.
Pillole di scienza
(per topi da biblioteca)
di FABIO PARIS
ta, che può essere più alta o più bassa
della temperatura reale. Questo perché l’aria secca riesce a scambiare
poco calore (per unità di tempo),
mentre l’aria umida e l’aria in movimento ne scambiano molto di più.
Ancora, quando cuociamo qualcosa in forno a 180°C e mettiamo la
mano dentro sentiamo caldo, ma
niente di che. Se tocchiamo il ferro ci
ustioniamo all’istante. L’aria e il ferro sono alla stessa temperatura, ma
l’aria scambia poco calore mentre il
ferro, conduttore di calore, ci brucia
all’istante.
Ecco un trucco per tutti i topi da
biblioteca che, tra un tomo ammuffito e l’altro, vogliono bersi una bella
birra fresca ma l’hanno appena com-
La particella di sodio.
L’ignoranza che diventa spot.
“C
’è nessuno” urla la “particella” di sodio che si sente
sola. Mai pubblicità fu più ingannevole.
Procediamo con ordine: innanzitutto la “particella” non può essere
definita tale. Il sodio in acqua ci sta
come ione, come atomo al massimo,
se la parola ione non ci piace. Mai
come particella. Tuttavia l’atomo
che grida “c’è nessuno?” potrebbe
essere associato al nucleare, quindi
poco rassicurante, e lo ione… vabbè
avete capito. Meglio parlare di particella. Che poi non è proprio da sola:
se uno si prende la briga di contare
20
A questo punto, perché cercare
un’acqua povera di sodio? E’ il solito
insabbia-insabbia.
I ferri del mestiere
Quando un testo diventa un libro
di AGNESE GUALDRINI
U
na delle cose più divertenti che mi capita da quando
lavoro nel settore editoriale sono le
domande degli amici o di chi non
vedo da un sacco di tempo e devo aggiornarlo sulla mia vita degli ultimi
tempi: “Sì sai, ora sto a Roma, lavoro
in una casa editrice…facciamo libri”.
L’immancabile risposta di chi mi sta
di fronte è “Ah, che bello! Scrivi libri!”,
“No, veramente no” “Ah, ho capito,
fai la giornalista e scrivi le recensioni
dei libri”… “Mah, no. Nemmeno”. Dopodichè, dopo aver pensato che magari lavoro in una tipografia o in una
libreria, fanno di finta di avere capito
e cercano di cambiare discorso (e del
resto sono convinta che molte delle
persone a me vicine tuttora non abbiano affatto ben chiaro che cosa io
faccia veramente ogni giorno, qua a
Roma).
Effettivamente il lavoro in una casa
editrice non lo si capisce davvero
fino in fondo finché non ci si ritrova
a farlo. Del resto io stessa, affascinata
dalle saghe parigine di Sylvia Beach
o dalla tempesta di idee che doveva
animare le riunioni del mercoledì in
Einaudi ai tempi di Pavese e Calvino,
sono stata smentita dai fatti: quel sapore vagamente dandy e quell’aura
che fa dell’editore un appassionato
di libri che cerca di aumentare la presenza di bellezza nel mondo sono in
realtà una carta da parati che fa solo
da sfondo a cose, perdonatemi, assai
più prosaiche. Già, perché la casa
editrice è prima di tutto un’impresa:
è fatta di uffici, settori, ognuno dei
quali ha un proprio budget entro il
quale deve rigorosamente cercare di
rientrare. Perché il bravo editore ha
il compito sì di fare buoni libri…ma
facendo quadrare i conti.
Ma cosa significa fare libri? In una
casa editrice di saggistica come quella in cui lavoro io l’ufficio editoriale
decide cosa pubblicare. Buonissima
parte delle idee nascono dalle riunioni (del giovedì) in cui gli editor
pensano ai temi che potrebbero interessare e agli autori che meglio potrebbero scriverne. Una piccola parte
scaturisce dalle proposte degli autori
stessi (sarebbe spassoso raccontarvi
certe astrusità tra le centinaia di proposte che arrivano ogni giorno – ma
magari la prossima volta), un’altra
parte da testi stranieri i cui diritti di
traduzione vengono acquistati, spesso perché si è vinta un’asta tra diversi
editori italiani.
Una volta arrivato il dattiloscritto
definitivo (che arriva sempre immancabilmente in ritardo), il testo viene
inserito nel programma editoriale (in
ritardo) e si lavora per farlo diventare
un libro (con l’ansia che comunque si
è sempre in ritardo): si colloca in una
collana, si pensa al titolo, si decide
la copertina, si scrivono le bandelle
e la quarta. Le riunioni per la scelta
delle copertine sono le mie preferite.
Per ogni titolo vengono proposte 6/7
copertine diverse (molto diverse) ed
è bello vedere come la scelta di una
piuttosto che un’altra stravolga realmente ciò che abbiamo tra le mani.
Insomma, ciò che mi piace più di
tutti è il momento in cui un testo diventa un certo libro, e non un altro.
(Mi spiego: pensate a una copertina
rossa fuoco con un’immagine grafica di due pistole nere la cui scia dei
21
proiettili si incrocia fino a formare
un cuore. Sotto il titolo: Where have
all the soldiers gone?. Ora pensate a
una copertina bianca con una piccola immagine fotografica che ferma
un istante di una manifestazione
pacifista negli anni 70. Titolo: Guerra e pace nell’età post-eroica. Capite
anche voi la differenza enorme tra i
due libri…eppure sono esattamente
lo stesso!)
A questo punto, scelti titolo e collana, il testo passa al lavoro di redazione e viene presentato ai retailer
che dovranno a loro volta convincere i librai ad appoggiarne sui propri
scaffali un numero considerevole di
copie. In concomitanza con l’uscita
delle novità in libreria, l’ufficio stampa dovrà poi cercare di occupare il
maggior numero di pagine della carta stampata con recensioni, anticipazioni o interviste. A questo punto
il libro è pronto e sarà solo e soltanto
il pubblico a decretarne il successo o
l’insuccesso, la fortuna negli anni o
una rapida fine nel dimenticatoio.
Ogni libro rappresenta insomma
una bella scommessa. Ce ne sono di
più piccole o di più grandi. Si possono perdere, si possono vincere o si
possono ricevere le più inattese sorprese. Questo è il lavoro editoriale,
in questo aspetto sta il suo fascino e
di qui nasce il suo rischio…ed è per
questo che mi appassiona.
La Posta dei Lettori di
Matteo Bettoli
di MATTEO BETTOLI
C
aro Bettoli, seguivo saltuariamente i suoi interventi su
Caspita, apprezzandone l'onestà.
Un parere. Ho letto recentemente
l'ultima fatica letteraria di Ikarmeta La capra dormiva su un lato (ed.
Frantumi) e l'ho trovato irritante. Punto il dito contro un libretto
sull'inutile storia di un allevatore di
ovini, Alejandro, solo coi suoi pensieri inconcludenti per un quarto
di libro, per un altro quarto solo
col gregge, dopodiché francobollato alla sua amata pecoraia redenta
Anunciacion. Sullo sfondo, lo ammetto, l'avanzare in Cile dell'industrializzazione coatta e predona
delle multinazionali dello yogurt ci
offre qualche spunto di riflessione
interessante. In particolare, è apprezzabile la veracità dimostrata
dall'autore nella digressione dicotomica innocenza/artificio, simboleggiata dall'avversione di Alejandro per i new trends dei latticini. Ma
non basta. Non mi interessa leggere
di capre, se la prosa è sconnessa e
non c'è circolarità. Non sento l'odore della campagna, tra le pagine: ciò
che resta è un cappello di paglia e
una storyline ridicola.
Franco, Pavia
C
aro Franco, Ikarmeta si ispira
neanche troppo velatamente
ai maestri cileni del genere, Garis e
Rodinga su tutti. A differenza di questi, però, Ikarmeta ha poche idee e
tutte scadenti. Ikarmeta - in ultima
analisi - ha una prosa che fa scappare i cani e Frantumi dovrebbe smettere di pubblicarlo. Solo una cosa di
La capra dormiva su un lato salvo:
la grottesca sbroccata di Alejandro,
presentatosi agli uffici della multinazionale dei latticini Dan-2 per incontrare l'a.d. Ganjesi, sull'inutilità dello
yogurt come prodotto in-sé. Siamo
indubbiamente allo stadio etico
kierkegaardiano, perché Alejandro fa una scelta che si lega a valori
universali ben precisi, racchiusi qui
nell'antiyogurtismo. Cito la grammatica creativa di Ikarmeta: "Arrivo
negli uffici luccicanti e falsi come lo
sguardo vaqquo dei dingos. Mi spingo all'interno del grande palazzo di
vetro, e penso a Anunciacion. Vorrei
lei qui con me mentre mi spingo. Incontro Ganjesi, è un uomo con mani
che non hanno mai lavorato. Mi dice
di produrre yogurt, e io esplodo. *Lo
yogurt è per voi smidollati yanky
gringos!* glielo urlo in faccia a lui.
*Non è budino, non è gelato* continuo, *lo yogurt è per voi mani viscide, che vorreste essere persone che
lo mangiano, ma che però vi fa schifo
pure a voi!*. Poi esco fiero di me e
degli insegnamenti di mio padre, che
non ho conosciuto mai". A noi tutti
verrebbe da sbattere un pugno sul
tavolo e urlare "viva il βουκολικὰ",
che in greco significa "cantico di bovari". A parte queste poche ispirate
righe, dicevamo, il resto fa pietà.
•
B
uongiorno Bettoli. Senta,
sono un venticinquenne
*bamboccione*, come diceva il ministro Sirchia qualche tempo fa, deluso dalla sinistra con barba e cane
e pure da quella con basette e maglioncino di Zara. Ho deciso che il
22
pacifismo della bandiera arcobaleno non mi rappresenta più, e quindi
invece che andare a lavorare gioco
con videogames violenti e leggo
Sun Tzu, che dà sfogo al mio desiderio di zuffa senza l'effetto indesiderato di prendermi uno schiaffazzo
in faccia. Volevo renderla partecipe di questo mio cambiamento, mi
sembra di crescere e di essere più
onesto con me stesso ogni giorno
che passa.
Rodrigo, Genova
C
aro Rodrigo, era il ministro
Padoa Schioppa. E la mia risposta potrebbe finire qui.
Le voglio donare un po' di sapienza, invece, a mò di perle ai porci: ora
come ora, se la potessi guardare in
profondità negli occhi sentirei solo il
freddo cosmico del vuoto interstellare. Lei non sa chi è Sun Tzu perché
a pochi è concesso saperlo: IO sono
una delle 6 persone che possono
dire di conoscerlo sul serio. Un'altra
di queste è David Lee Roth dei Van
Halen, un'altra ancora - sembrerebbe - la moglie del Presidente brasiliano Lula, Lulù.
Sun Tzu viveva nella Cina di 2500
anni fa, circa. Si narra capisse il latino solo da un orecchio, il destro, e
per questo motivo quando un emissario del governo di Roma (all'epoca
ancora *Romola*) camminava alla
sua sinistra Sun Tzu doveva procedere all'indietro, in modo da accostare l'orecchio avvezzo al latino alla
bocca del romolano. Ogni tanto slappava per terra, e tutti lo deridevano:
"cammini come un gambero, Sunzi,
ahr ahr!". Questa piccola particolarità, congiunta al fatto che sua moglie
era larga come uno di quei frigoriferi
che fanno il ghiaccio, lo rendevano
benevolmente dileggiato dalla community scapigliata di Qi. L'arte della
guerra è uno di quei libercoli che
hanno letto anche i peracottai come
lei, Rodrigo; la vera opera magna di
Sun Tzu è piuttosto L'arte della guerra volume 2: l'arte della festa (edita in
italiano da Kapioski fino al 1987, ora
disponibile alla copisteria di porta
Scagli a Modena), originariamente
bollata come divertissement ma ormai sdoganata come i film di Bombolo. L'incipit è tuttora molto celebre
e recita *si apriranno altre porte, si
devasteranno altri party* (cit.). L'autore snocciola sentenze definitive e
incontrovertibili sull'etica dei baccanali e da leggere in quest'ottica
sono pure certe dichiarazioni della
sua prima, e ingiustamente prevalente, opera: *se sei inattivo mostra
movimento, se sei attivo mostrati
immobile* fa riferimento alla legge
del dancefloor, un'attitudine smooth
ma acuta à la Shaggy; *chi è prudente
ed aspetta con pazienza chi non lo è,
sarà vittorioso* descrive la strategia
vincente dell'attendista di fine serata, comprensivo e di bocca buona,
che piglia su con la rete da strascico; *combatti con metodi ortodossi,
vinci con metodi straordinari* ovviamente concerne il rimorchiare
con semplicità e understatement,
salvo poi sorprendere la conquista
in un secondo momento. Il suggello
dell'opera, lunga 24 rotoli di papiro
in Times New Roman con carattere 12 (interlinea unemmezzo), è la
seguente *quando ti muovi sii [sul
*sii* c'è una scancellatura, Sun Tzu
aveva usato il condizionale al posto
del congiuntivo, ndr] rapido come il
vento, maestoso come la foresta, avido come il fuoco, incrollabile come
la montagna*: se la rapidità non è
più requisito essenziale per l'assenza
di pericoli contingenti quali quello
di cuccarsi una freccia di balestra in
una chiappa, gli altri lampi di luce
sapiente sono più attuali che mai.
•
B
ettoli, cosa amo di mio marito? E' sciocco e vanaglorioso,
frivolo, legato a piccole cose stupide
(potrei farne un elenco: il subbuteo,
le casate reali, gli orologi a parete, la
musica new age, il complottismo).
Cosa amo, dicevo? Risponda! Forse
sono matta. Rispondo io, conscia di
poter dire con certezza solo ciò che
di lui non amo: sicuramente i libri
che compra. L'ultimo è sulle scelte
alimentari responsabili e si chiama
Se fossi un grosso pesce mangerei
solo plancton (Ruspo editore). L'ha
scritto, pensi, il comico toscano che
nelle puntate di qualche anno fa di
*meno Cabaret, più Cabernet* fingeva di piangere a dirotto appena
il pubblico gli urlava "fallito!". Mi
aiuti.
Barbara, Casal Borsetti
do il brano Fight fire with fire, il cui
testo figura oggi nell'introduzione
del volume seminale Scegli: o me, o
patia (ed. Galoppo). Un ultimo accenno su quel burlone di Mitridate
VI, grande re del Ponto, che diede
inconsciamente il via a tutta questa
scena. Mitridate (di origini ucraine, il
vero nome era Dimitri Datev), fifone
per natura e convinto di poter subire subitamente uno scherzo letale
dei Proci, chiese al medico Crautea
di sciogliere nel vodka red-bull - di
cui andava ghiotto - qualche goccia
di veleni assortiti ogni giorno, così,
per diventarne immune. Poi arrivò Pompeo Magno, fratello di Milly
d'Abbraccio, lo sconfisse in 3 set e
Dimitri non riuscì ad ammazzarsi
con nulla: ormai era diventato un
vero e proprio sballone che reggeva
tantissimo.
Storia vera.
L
o molli. Dal verduresimo al
pesciolismo, ormai è tutto
un fiorire di derive alimentari arcane, cabalistiche, astruse. Dio ce ne
scampi. Il peggio del peggio, e lei se
n'è accorta, è rappresentato dal nucleo di "folgorati" delle nuove scuole
mangereccistiche. L'autore del libro,
il fallitissimo comico Polenta, oltre a
non essere mai riuscito a farci ridere non ci convince neppure con le
sue cialtronate sul desinare. Come
scrivevo su Caspita qualche tempo
fa, rimango fermo nell'idea che le
tre peggio-cose del mondo siano la
pena di morte, la censura e la soia.
Mi permetta però di distinguere. Spesso si confonde l'insensismo
alimentare con altre storie serie,
come l'omeopatia. L'omeopatia è
una figata. Il vecchio Hahnemann,
canuto dottore prussiano, riteneva
che su una personcina sana piccole
dosi di una sostanza, veleno o droga
finanche vairus (sic) proteggessero
dalla malattia che generava gli stessi
sintomi. Nel 1984 il batterista danese
dei Metallica avrebbe formalizzato le
blaterazioni di Hahnemann scriven-
23
scrivete a:
[email protected]
Recensione/8
Agnes Browne
Sara Reali
Q
uanto spazio dedicate nella vostra vita all'amicizia?
Quante energie spendete alla costruzione di un rapporto e al suo
mantenimento nel corso degli anni?
E soprattutto: quante volte ne vale
veramente la pena?
Ecco, una cosa che mi accade
spesso è considerare un personaggio di un racconto, di un libro come
un amico: una presenza che inizia e
finisce con la lettura del volume che
però nel tempo continuo a ricordare con piacere e in qualche modo
mi accompagna nel corso della vita.
Spesso si tratta di un'Anna Karenina
o del caro Petit Prince, ma è altrettanto vero che se vi si consiglia un libro di un autore minore e il protagonista diventa vostro amico perchè in
quel preciso momento le sue avventure vi coinvolgono particolarmente,
inevitabilmente capite che ne vale la
pena.
Allora succede che, nei deliri di
una laureanda, ci sia spazio per una
lettura divertente, dai dialoghi freschi, incredibilmente efficace e genuina: Agnes Browne è diventata il
mio idolo di donna. Nella Dublino
proletaria e cattolicissima (con l'accezione Irlandese del termine che,
Recensione/9
La guerra dei dieci anni
Fabio Paris
T
utti noi abbiamo un’idea più o
meno vaga di cosa sia successo in ex-Jugoslavia negli anni 90. Una
guerra lunga, assurda e atroce, come
tutte le guerre. Questa però ha qualcosa “in più” di tante guerre.
Ha dei primati. Dopo la seconda
guerra mondiale, dopo i “mai più” è
qui che si è consumata nuovamente
“la prima volta”, anzi, tante “prime
volte”, come l’assedio di Sarajevo, il
più lungo della storia, dopo c’è solo
il mito con Troia. O gli orrori della pulizia etnica che prepotente ha
cambiato la demografia della Krajina
svuotandola prima dei Croati, poi
dei Serbi. Ne La guerra dei dieci anni
- Jugoslavia 1991-2001, di Alessandro Marzio Magno e altri autori, 11
24
credetemi, ha caratteristiche tutte
sue) si susseguono le vicende di una
donna forte e determinata che nella
morte del marito ritrova slancio e respiro. Se poi consideriamo il contorno e il periodo storico, gli anni Sessanta, allora tutto diventa ancor più
divertente: non si parla di Beatles,
né di moda, tantomeno di Vietnam,
solo del lavoro e delle emozioni quotidiane di una donna che adora le
canzoni di Cliff Richard quanto i suoi
sette figli.
Piccole gioie e grandi sfide accompagnano questa eroina della porta
accanto che non si lascia abbattere
dagli schiaffi della vita, ma prosegue
il suo percorso con verve e sincerità.
L'educazione che non ha ricevuto
permea le pagine in un incalzare di
errori grammaticali e morfologici
(suoi, ma anche di Marion, migliore amica di Agnes e comicità fatta
persona) che ne dipingono un tratto
talmente sincero che ricorda un dialogo con il nonno piuttosto che con
un fruttivendolo ambulante.
euro, 560 pagine, vengono raccontati
i fatti, in maniera imparziale, denunciando le atrocità commesse da tutte
le parti. Serbi, serbo-croati, croati e
mussulmani di bosnia. Kosovari e
macedoni. Tanti. Tanti conflitti, un
tutti contro tutti che in un momento si è concretizzato in quattro conflitti contemporanei in cui cinque
eserciti si combattevano. Se il nome
Srebrenica evoca dei sinistri ricordi
nessuno sa che accadde a Vukovar.
Non vengono negate le responsabilità dei vari capi di governo Jugoslavi
e dei principali attori internazionali.
Corte biografie aiutano a delineare la
psicologia degli uomini che questa
guerra l’hanno creata e spinta oltre
l’estremo. Milosevic, Tudjman, Izebtegovic e molti altri.
Il libro è ben scritto e a tratti estremamente coinvolgente, ha però •
una lettura a volte difficile per i tantissimi (difficili) nomi
e tantissimi fatti accaduti che vanno intrecciandosi ed accavallandosi. Ma d’altronde non si può raccontare la complessità che in maniera complessa. Aiutano i vari indici tra
cui il dramatis personae e la cronologia. Grossa mancanza,
a cui chi volesse leggere deve assolutamente rimediare, è
una dettagliata cartina geografica dei balcani meridionali,
indispensabile per capire dove si sono concentrati i fatti.
Dalle pagine del libro emerge anche una teoria sul perché di questa guerra, una guerra di civiltà, tra popolazione geograficamente mescolate ma spiritualmente divise,
che sulla spinta di antichi odii e rancori e di un furente
nazionalismo ha trasformato quella che un tempo veniva
indicata come la terra della convivenza nel teatro del più
crudele conflitto della storia europea del dopo nazismo.
Recensione/10
No one belongs here more than you
Livia Fagnocchi
S
ono in un terribile umore Miranda July, che in questo caso
è un aggettivo. E' malinconia con il
retrogusto dolce. E' affaticamento
dall'ordinario. E' stupore per i lati BC-D-etc delle cose. E' rassegnazione
ottimista. E' noncurante fiducia. E'
ricerca degli interstizi fra le persone,
le abitudini, i caratteri. Dove si annidano manie, pensieri audaci, stranezze, dove si nascondono, appunto,
i lati B-C-D-etc delle apparenze. Tutte queste cose, Miranda, le racconta
come fossero svegliarsi la mattina e
fare pipì. Uscire di casa e correre al
lavoro. Coricarsi e abbracciare il cuscino. Cose più ordinarie dell'ordinario. E infatti Miranda non racconta
queste, ma racconta tutte le storie di
cui sopra come se fossero queste. Le
fiction italiane raccontano la A dei
drammi quotidiani, perché il pubblico ama vedersi rappresentato dalle
storie televisive.
I racconti di Miranda July parlano
delle trame irrisolte, inimmaginabili,
perverse e geniali, ambientate negli
stessi luoghi e con gli stessi protagonisti: i vicini di casa, la relazione
con il migliore amico, l'adolescente
omosessuale, il trasferimento da cit-
tà a paese, le amiche morbose, e così
via. Sono tutti figli di Cidrolin de I
Fiori Blu, tridimensionali e genuini,
scorretti e credibili.
loro punto di vista è accettabile,
comprensibile, divertente e infine
epico. Ci dice qualcosa di noi che
non sapevamo: No one belongs here
Miranda July ha la dote di scrivere
in maniera calligrafica, se si può
dire. Scrive in prima persona, entra
nell'universo psicologico e maniacale
di ogni personaggio, tira fuori il lato
più comico e surreale, lo sbatte su
uno scenario riconoscibile e ce lo
propone a 10 cm di distanza, come
fosse un fotoromanzo che si sfoglia
di fronte a noi. La sua scrittura è
terribilmente vicina, la sua mano che
scrive ha una calligrafia puntuale,
i personaggi sono amichevoli, il
more than you, è il titolo originale (Tu
più di chiunque altro, la traduzione
al pubblico italiano, che fa molto
Moccia - e anche qui è aggettivo).
25
Miranda July è una scrittrice "confidenziale" (come direbbe Morgan a
X-Factor), e ha una calligrafia spettacolare per descrivere l'obliquità
dei lati B-C-D-etc che ci piacciono
tanto.
Quanto i Pavement.
Graphic Novel
Parola, immagine e immagin-azione
di MARINA PIERRI
I am going to look at the stars. They
are so far away, and their light takes
so long to reach us… All we ever see of
stars are their old photographs.
(Dr. Manhattan, “Watchman”)
I
fumetti hanno rubato alle novelle e le novelle si sono prese
la loro buona rivincita. Così è nato
l’ibrido. Uno di razza. La graphic novel. Che non è fumetto e non è novella, ma è qualcosa di più delle due
cose messe assieme.
Ci sono molte maniere di leggere
un libro: c’è chi lo fa con distacco e
chi vive con la storia, nella storia.
Il primo si fa costruire dalla lettura; quando apre un libro è sempre
nuovo, bianco come una pagina. Il
secondo si riversa su ogni titolo e autore con tutto il peso della sua esperienza, o bagaglio personale. Il primo
lettore si fa costruire dalla lettura,
potremmo dire; il secondo la costruisce. Il primo è più veloce. Immagina
poco, o lo fa senza eccessiva cognizione. Il secondo apre un sipario e,
ogni volta, vede qualcosa di simile a
una piéce teatrale, o a un film. Con
un salto teorico certamente azzardato, perciò, permettetemi di immaginare che esista un lettore “verbale” e
uno “analogico”: una persona-parola
e una persona-immagine.
Ipotizzando (in modo assai riduttivo) che esistano questi due profili
con caratteristiche opposte e speculari, vorrei dire che la graphic novel,
magnifico congegno, serve ugualmente entrambi perché è, per sua
natura, doppia. È un libro-parola e
un libro-immagine: cioè una parolaimmagine che si presenta non come
sembrerebbe “ovvio”, su uno schermo, ma tra le pagine. È la terra di
mezzo dove le proprietà dell’una e
dell’altra cosa convivono.
L’immagine, proprietà del cinema, è “chiusa” per eccellenza: la telecamera, o la macchina fotografica,
è un agente discriminante. Quello
che non viene ripreso o fotografato
nell’immagine, virtualmente esiste
ma non c’è di fatto. D’altro canto, la
parola svolge una funzione opposta
di “apertura”, ossia di evocazione di
quello che non c’è, ma esiste. Jean
Luc Godard usava le scritte in sovrimpressione sui fotogrammi precisamente per questo motivo. Era
convinto del fascismo dell’immagine
e voleva scardinare il fotogramma,
aprire la presenza (l’immagine) con
l’assenza (la parola).
Tornando ai nostri due profili, allora possiamo dire che il primo, la
persona-parola, sia un lettore “aperto”. E l’altro, la persona-immagine,
sia un lettore “chiuso”. Naturalmente
la lettura, reggendosi sulla virtualità
della parola e su essa soltanto, è immagin-attiva. È ragionevole supporre
che entrambi i nostri lettori immaginino e facendo questo agiscano (immagine + azione = immaginazione),
ricostruendo porzioni di universi
finzionali o meno in maniera meno
definita e iper-definita.
La graphic novel, come dicevamo, rappresenta un inconsueto prestadio del cinema e un ancora più
inconsueto post-stadio dell’imma-
26
ginazione. I disegnatori immaginano i contesti, i personaggi descritti
e i luoghi: tolgono l’incombenza di
rappresentazione al lettore “aperto”
e soddisfano il lettore “chiuso”. I testi,
d’altro canto, contengono marche
specifiche (i classici blob bianchi
possono essere tratteggiati se si bisbiglia, o tremolanti se, come Rorscach
in “Watchmen”, la parola è soffocata)
che forzano le didascalie già immaginate a introdurre via via nuovi elementi, mettere in discussione i contorni delle cose mostrate, spezzare
la natura totalitaria del disegno. Non
solo. C’è un passo ulteriore e decisivo, assolutamente immagin-attivo:
la trasformazione, commutazione,
traduzione delle vignette nel mondo
che conosciamo con i nostri sensi.
Un’esperienza di lettura unica.
Se esiste, perciò, un luogo dove
l’attualità è ancora virtuale e la virtualità già attuale, quella è la graphic
novel. Il fumetto ha rubato l’anima
alla novella e la novella gli ha rubato
il corpo.
L
aura. Laura è alta un metro e mezzo. Ha cinquantaquattro anni. Lavora in una fabbrica dove fanno
il gelato: arriva il furgone, si prende il gelato e lo porta ai
gelatai, i bambini mangiano il gelato, i gelatai finiscono il
gelato, il furgone riparte e torna alla fabbrica dove lavora
Laura, che intanto ha fatto altro gelato. Facile. Facile, e alla
crema.
gno per le femmine, e uno per i maschi. Si chiama Magdalene, il locale, ma tutti lo chiamiamo: la Maddalena, come
l’evangelica puttanella. Angie esce dal bagno, mi fa un sorriso gentile e va a prendersi una birra senza passare dallo
specchio. Entro in bagno. Sul muro c’è una fresca scritta
rossa. Incomprensibile.
Nel film Taxi Driver, Jodie Foster fa la parte della puttana. Quando incontra un cliente si accende una paglia, dà
un tiro e mezzo e la appoggia sul posacenere. «Possiamo
stare insieme finché dura la sigaretta», dice. Angie suona
il pianoforte, ma dopo tre minuti si stufa. Allora smanetta
un po’ con il computer, spinge il tasto Rec e si accende una
paglia. Dà un tiro e mezzo, e la appoggia sul posacenere.
Poi si siede al pianoforte, e suona. A caso. Muove le mani
sui tasti finché dura la paglia, poi si inventa un finale, e
spinge il tasto Stop. Il file mister buonanotte.wav finisce
su un cd vergine, il cd si veste di plastica morbida e si tuffa
nella borsa.
Dimentica sempre le luci accese, Laura, e non si trattiene nel mangiare. Sulla gelataia da uno e cinquanta circola
una strana voce: dicono che sappia strappare a metà un
foglio di carta nel senso dello spessore. Chissà se è vero.
Laura ha una figlia della mia età, si chiama Mariangela. Un
nome che odia. Tutti la chiamano Angie, come la canzone
dei Rolling Stones. Angie non sopporta i Rolling Stones.
Questa è la storia di Angie. Anzi, la Storiaccia di Angie e
Mister Buonanotte. Un po' sconclusionata. Ve la racconto
come me l’hanno raccontata.
Un mese prima Angie e Mister Buonanotte hanno fatto qualcosa di simile
al sesso. Il giorno dopo Mister Buonanotte ha chiamato Angie, le ha fatto un
Certo Discorsino e lei ha detto: «Ho capito, ho capito», ma in realtà non aveva
capito niente. Aveva solo mal di pancia,
e voglia di strappare fogli di carta, come
sua madre. Dopo qualche settimana di
vento inutile, la rubrica del cellulare di
Mister Buonanotte torna a gironzolare
dalle parti della lettera A, e parte il messaggio: OH, AVEVI RAGIONE. Quando
arriva il messaggio di Mister Buonanotte, Angie si accende una paglia, dà
un tiro e mezzo e la appoggia sul posacenere. Poi Angie diventa una specie
di Jodie Foster, pensa al collo di Mister
Buonanotte, e suona.
Felinomachìa
La storiaccia di Angie e
Mister Buonanotte
di SIMONE ROSSI
Sputa una cicca nel water, ci fa la pipì sopra e poi tira
l’acqua. Cicca è il chewing gum. Spesso uno dice cicca e
pensa a una sigaretta, o a quel che ne rimane. Le sigarette
da noi si chiamano paglie. Comunque Angie si sputa tra
le gambe, la cicca fa plic sul bianco della liscia discesa del
cesso e lei ci fa la pipì sopra, poi tira l’acqua. Si occupa
della sua igiene come meglio crede e si tira su i pantaloni.
Hanno bussato due volte, da quando abbiamo iniziato a
parlare di gelati.
CERTO CHE AVEVO RAGIONE. CI VEDIAMO ALLA
MADDALENA, STASERA.
– Hai suonato per me. Cazzo, grazie.
– Cazzo, prego.
– Cos’è, non devo dire le parolacce?
– Puoi dire quello che ti pare.
– Ce l’hai ancora con me?
– Lasciamo stare. E comunque non ho suonato per te.
– Ce l’hai ancora con me.
– Lasciamo stare, ti va? Piuttosto: ce l’hai una paglia?
– Una. Ce la smezziamo?
– Vabbè, la scrocco.
– Usciamo fuori.
– Occupato, – dice Angie.
Infila una mano nella borsa e tira fuori un pennarello
rosso. Abituata alla puzza, si concede un sospiro. Poi leva
il tappo al pennarello, appoggia la punta contro il muro
del cesso e, con mano mancina, scrive. La prima delle due
ragazze che hanno bussato è entrata nel bagno di fianco:
era libero. La seconda ragazza sono io. Il locale ha un ba-
Fuori dalla Maddalena, Angie mi scrocca una paglia e
27
raggiunge il suo amichetto.
La pancia aperta sul cemento, tanto di quel sangue,
dappertutto, e peli schiacciati, sporchi. Le zampe dietro
non ci sono più. E la testa: sulla testa la ruota non è passata, e la testa ha gli occhi, gialli, azzurri, spalancati, in bocca
si vedono i denti, gialli pure quelli, la bocca si apre, il gatto
miagola. Il gatto miagola, lurido, rauco, con una gran voglia di morire.
– Ma perché abbiamo fatto una cosa del genere?
– Perché ci andava.
– Già. Credi che lo rifaremo?
– No. Non credo.
– Però è stato bello.
– Bello, e inutile.
– Come il fumo.
– Questo non vuol dire.
– Come ti è venuta, la mia canzone?
– Non mi tremavano le dita, neanche un po’.
– Questo non vuol dire.
– Ma questa faccia? Perché hai questa faccia, Mister
Buonanotte?
– Ma che storiaccia è? – dice Angie.
– Sei tu che mi hai chiesto perché ho questa faccia: te
lo sto dicendo.
– E tu cos’hai fatto?
– L’ho lasciato lì.
– Come, l’hai lasciato lì?
– Cosa dovevo fare, dargli il colpo di grazia?
– Ma no. Che ne so. Spostarlo?
– Non ce l’ho fatta. Non sapevo da dove prenderlo.
– E l’hai lasciato lì.
– L’ho lasciato lì.
– Ma che storiaccia è?
– Eh.
– Suppongo che cose simili capitino in continuazione.
– Come no, – dice Mister Buonanotte spegnendo la paglia. – Ma almeno uccidetelo, ‘sto povero gatto: va bene
l’amore per gli animali, ma per un gatto mezzo morto è
meglio morire del tutto, no?
– Possiamo cambiare discorso?
– Sì. Anche se mi sembra che quello che ci dovevamo
dire ce lo siamo dette.
Mister Buonanotte di nome fa Carlotta. È una femmina,
e le piacciono le femmine. Soprattutto le piace Angie. Non
ha capelli, quasi per niente. Sarebbe bionda, e riccia, ma
ogni ventotto giorni si concia come la luna piena: specchietto, canotta, macchinetta. Bzzz. Succede spesso che la
scambino per un ragazzo, non fateci caso. Un ragazzo magro di 15 anni. Mister Buonanotte è un soprannome nato
al caldo, sotto un cielo di stoffa. Ma questi sono fatti loro.
L’utilitaria di Mister Buonanotte è piccola, sporca e
piena di benzina. È buio da un po’. Carlotta è sola, tiene il
volante e tiene il tempo. Dieci metri più avanti c’è un’altra
automobile, più grossa. Dentro sono in due. Uno guida, e
parla. L’altro non guida, e non parla. Davanti all’automobile grossa c’è uno scooter, probabilmente. Sì, è uno scooter:
senza freccia, lo scooter si butta a sinistra, ma non sta sorpassando nessuno. Nell’altra corsia non c’è un cane. Nella
nostra c’è un gatto. Non c’è niente da ridere. Nella nostra
corsia c’è un gatto. Il gatto attraversa la strada all’improvviso: è bianco, e sta per morire. Lo scooter si butta a sinistra, e lo schiva. Il tizio che non parlava urla, quell’altro sterza, ma il gatto finisce sotto. Carlotta inchioda. Lo
specchietto retrovisore è vuoto, Carlotta accosta, per radio
la gente continua a cantare e uno stupido gatto bianco si
è appena fatto ammazzare. Carlotta spegne il motore, la
radio si spegne da sola. Con una mano davanti alla bocca,
Carlotta cammina verso il gatto.
Angie sta zitta, sa che la sua amica non sarà più la sua
amante ed è dispiaciuta per un gatto che non ha mai conosciuto. Tutt’intorno c’è il solito odore della Maddalena,
la gente in fila per il bagno legge gli adesivi sui muri e i bidoni del vetro tintinnano di bottiglie vuote. Da lontano, da
dove sono io, le due ragazze sembrano una ragazza e un
ragazzo. Un ragazzo di 15 anni, magro. Mister Buonanotte
si guarda il piede con cui ha appena spento la paglia e le
viene un brivido di freddo. Torno dentro o torno a casa?
Torno dentro o torno a casa? Torno a casa. Ancora silenzio, o chiacchiere inutili, che è pure peggio.
– Oh, grazie per il cd.
– Buonanotte, Mister Buonanotte.
– Buonanotte, Angie.
Avrei voluto fare a meno di raccontarvi la storiaccia, ma
l’incosciente felino si è buttato nel mezzo.
– Ma la macchina ha tirato dritto? – chiede Angie. Non
che la cosa cambi le sorti del gatto.
– Non che la cosa cambi le sorti del gatto, – dice Mister
Buonanotte. Comunque, sì: hanno tirato dritto.
– Il gatto, dice Mister Buonanotte, e lo dice con fatica,
era mezzo morto.
– Come, mezzo morto? Che schifo.
– Come, che schifo? Mezzo morto, povera bestia, l’hanno preso di striscio. Ma l’hanno preso.
Il gatto è rimasto per strada una settimana, poi una mattina non c’era più. Saranno passati i netturbini, come si
diceva negli anni Ottanta. E poi stamattina pioveva. Sono
capaci tutti a fare i fenomeni con i gatti morti, con il giubbottino arancione massima visibilità e i guanti. Soprattutto se il gatto è morto da una settimana. Il difficile è reagire
quando la fine arriva di striscio. Ho cercato di spiegarlo a
Angie, e a voi. Angie non ha capito niente. Voi?
28
How i met your cat
metapostilla supersimpa a Felinomachìa
di SIMONE ROSSI
S
eduta al pianoforte, una checca intonatissima
strappa le mutande a tutta Mtv. Checca nel senso
di palesemente effeminato, sai che ci frega a noi dei gusti
sessuali di… Com’è che si chiama? Non lo conosce nessuno, qua dentro. In questa stanza, la checca canterina è un
Carneade totale. Peggio: non se lo chiederà nessuno, chi
era costui. Perché tanto, sai che ci frega a noi di… Confortevole, questo nichilismo.
flaga Disco Pax, la canzone (Superchiome) si è innestata
nel racconto e ha tranciato via le dicotomie maschio/femmina. Magdalene è il nome di un locale che non esiste,
lo inventai dieci anni fa per ambientarci un racconto e mi
piace ancora. Il foglio di carta strappato a metà nel senso
dello spessore l’ho sognato una notte, la parola netturbini
mi ha sempre fatto ridere, eccetera.
Nessuno ha mai capito un tubo di Felinomachìa. Nemmeno Angie. Però a un centinaio di persone il racconto
è piaciuto: mi sono trovato, una sera di metà novembre,
a leggerlo in un teatro di Cuneo. Di fianco a me c’era un
contrabbassista, tutto intorno Esor-Dire, un contest per
giovani scrittori che mi vedeva tra i concorrenti essendo
io un giovane scrittore, dicono. Ci ho vinto mille euro per
acclamazione popolare, e la cosa ha stupito me per primo:
il mio primo concorso, la mia prima vittoria. Incomprensibile. Se i testi si potessero spiegare con altri testi, se l’ermeneutica non avesse bisogno di tutte queste parole, una
buona spiegazione a Felinomachìa sarebbe Mezzogiorno
di Fuoco, il film. Un’ora e mezza per costruire l’attesa di
un Duello Finale che si consuma in due secondi: e allora
capisci che la potenza è lì, nei silenziosi movimenti di raccordo che tengono insieme le storie, altro che Gran Finale.
Ma a farsi troppe esegesi si diventa ciechi.
- Carneade chi?, chiede Omar.
- Uno sconosciuto, dico io.
- In che senso? chiede Laura.
- I Promessi Sposi. “Carneade. Chi era costui?”, lo dice
Don Abbondio a un certo punto. Vabbeh, la storiella è
noiosissima. E’ un modo di dire, ragazzi: si dice Carneade
per dire sconosciuto.
- Ma allora perché non hai detto sconosciuto?, chiede
Omar.
- Eh, sai, sono uno scrittore, dico io.
- Allora scrivimi questo, dice Omar.
Invece di accompagnare la frase con un gesto osceno,
Omar mi racconta Felinomachìa. Quantomeno, la scena
dell’incidente: la macchina che stira il gatto e lui che non
riesce a fare nulla. E’ successo veramente, è successo a lui:
cose del genere capitano in continuazione. La storia, già
disturbante di suo, mi è piovuta addosso surreale e inattesa in un mercoledì sera di ordinario divano, a farsi gocciolare il cervello dal naso a furia di cambiare canale e dirsi
come va, eh, come va, come vuoi che vada, va. Nel mezzo
delle chiacchiere più o meno interscambiabili si materializza la fotografia dell’incidente, come da un bagno d’acido. Troppo grande per stare dentro una bocca sola. Come
quando non vedi un tuo amico da un po’, e lui ti dice che
gli è morto il cane: ci rimani male, ma non puoi farci nulla,
e poi non c’eri nemmeno troppo affezionato, a quel cane.
Una mia amica parla alla radio. Ha, quindi, la voce giusta. Una volta ha letto il racconto davanti a un microfono,
ci ha messo in mezzo un po’ di canzoni e ha spinto il tasto
Rec. Il file felinomachia.mp3, se lo vuoi, puoi scrivere a
[email protected]. Tutti hanno qualcosa da nascondere, eccezion fatta per il sottoscritto e la sua scimmia.
Laura è davvero alta uno e cinquanta, fa davvero il gelato, solo che ha vent’anni. Però "la gelataia da uno e cinquanta" era una frase che avrei sempre voluto scrivere.
Angie è il nome del mio ipod, del mio hard disk esterno
e della protagonista di un’epopea familiare (tipo La casa
degli spiriti) che scriverò quando diventerò femmina e sudamericana. Di nome fa Carlotta è una citazione degli Of-
29
Contributi da:
Jacopo Cirillo non è mai riuscito a spiegare a sua nonna cosa fa nella vita. Prima per colpa della semiotica,
adesso per colpa di una casa editrice. Ha co-fondato
questa rivista solo per poterle dire: faccio il co-fondatore
di una rivista. E anche, ma secondariamente, per poter
dire quello che gli pare sui libri che legge.
prattutto fotografica. È un avido lettore.
Jacopo Donati studia Filosofia estetica a Bologna. La
sua carriera universitaria gli permetterà, al massimo, di
suonare l'organetto per strada: conscio di ciò, per non
pensarci, passa buona parte del suo tempo a scrivere, a
leggere e a inseguire innumerevoli passioni che, per lo
più, svaniscono nel giro di pochi giorni lasciando il posto
a nuove manie.
Carlo Zuffa nelle ultime due decadi non ha raggiunto
traguardi degni di nota e ritiene che la sua infanzia sia
stata traviata dal finale di "Marcellino Pane e Vino". Ora,
di notte nel buio della sua cameretta, studia piani segreti
per i C.O.B.R.A., i quali gentilmente gli hanno concesso
un pò di tempo libero per co-fondare Finzioni.
Livia Fagnocchi è curiosa, entusiasta e dentro tante storie. Si ossessiona facilmente di canzoni, di mongolfiere,
di take-away indiani, di zucca, di misteri, di treni. Cerca
analogie, coincidenze, e stare bene.
Matteo Bettoli nasce in epoca reaganiana su un carro
di bovini, dal quale eredita la passione per la dinamicità.
Scostante, ombroso e pretenzioso - questo dicono di lui
gli amici - a 21 anni controlla i principali media di casa:
3 televisioni, 2 computer, l'abbonamento all'Espresso e
la radio ricevuta in regalo per la cresima. Decide allora di
trasferirsi. Passa un po' di tempo a zonzo occupandosi di
robe politiche. Ultimamente lavora a Bruxelles dove viene
spesso bollato con l'espressione *lobbista*.
Agnese Gualdrini, 27 anni, laureata in Filosofia nel
lontano 2005. Da ormai un anno vive e lavora a Roma in
una casa editrice con un non ben definito ruolo di giano
bifronte (saltella tra l’ufficio diritti esteri e la valutazione
degli innumerevoli dattiloscritti che ogni giorno invadono
la posta). Adora il caffè amaro, il lungotevere, i libri di Natalia Ginzburg e cantare anche se violentemente stonata.
Viviana Lisanti è laureanda in Scienze Storiche all’Università Statale di Milano. Sognando il giorno in cui potrà
vivere della sua sola scrittura, per ora si mantiene improvvisandosi grafica nell’azienda di famiglia.
Alberto Cocchi è laureando magistrale in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Modena-Reggio
Emilia. Concentra i suoi studi sull'uso dell'immagine, so-
30
logna dove scrive per le pagine culturali del Riformista e
dell'edizione locale del Corriere della Sera. Comincia a
credere che Hemingway avesse ragione quando affermava
che "la metà degli italiani scrive e l'altra metà non legge".
Edoardo Lucatti. Edo. Ode. Deo. Un essere flesso
nell’edibile, nella lirica e in un soprannaturale deodorante. Performer di incauta protervia, aruspice della significazione e calciapalle di poca morale. Semiònte per alcuni,
semiòta per altri, è una piccola fucina di omaggi al vostro
personale sconcerto teoretico
Come secondo lavoro, Simone Rossi scrive di musica,
teatro e amenità varie per un noto quotidiano romagnolo.
Il primo lavoro lo sta cercando. Nel frattempo, una volta,
è stato in Etiopia. Il viaggetto è diventato un libretto, La
luna è girata strana (Zandegù, 2008). Stonatuccio musicista da marciapiede, suona l'ukulele e ha un gatto di nome
Chomsky. Tende a scrivere sui muri palindromi intellettualoidi tipo in girum imus nocte et consumimur igni.
Fabio Paris nasce impagliato, e così finirà, per evitare
che gli amici ballino sulla sua tomba. Zingaro, in accezione monicelliana, ha studiato chimica, seguendo la sua
passione per la geopolitica. Ora vive facendo l'inviato da
Pittsburgh per Finzioni e spacciandosi per esperto di nanotecnologie.
Jacopo Sgroi ha un cognome siciliano, catanese, ma è
nato in Trentino, ha vissuto a Firenze, ma è cresciuto a Faenza, ha studiato a Bologna ma è a Milano che è riuscito a
fare della sua passione, il cinema, il suo lavoro.
Marina Pierri ha 28 anni e vive a Milano, dopo dieci gloriosi anni passati a studiare/lavorare/fare radio/fare la dj
in quel di Bologna. Si occupa a tempo pieno del portale
musicale Vitaminic.it ma scrive anche su Rolling Stone,
PIG Magazine e Blow Up. Ascolta una media di tre nuovi
dischi al giorno, legge, guarda un sacco di film e serie televisive americane.
Greta Travagliati, semiotica appassionata di arte, Proust
e culturalizzazione della merce. Si interessa di tendenze e chincaglierie del contemporaneo anche se avrebbe
preferito vivere nell'800. Attualmente vive a Milano dove
lavora in un centro ricerche e dove spera aprano presto
Starbucks colorati, una pasticceria turca ed un centro di
gravità permanente a forma di pera.
Sara Reali, puoi trovarla in mezzo al pubblico di un
concerto, dove tutti sono inevitabilmente molto più alti di
lei, ma non le importa: adora emozionarsi per due accordi
ed una voce calda quanto per un bel film visto in compagnia. Se non esce la sera, è perchè sta leggendo una storia
appassionante e magari ride o tiene il fazzoletto a portata
di mano.
Matteo Treleani è dottorando in semiotica a Paris Diderot e ha una curiosa passione per i campi non affini.
Amante dei miti greci e della musica barocca, è un sommo sostenitore dell'arte dell'insignificanza, ovvero del
non voler dire nulla.
Andrea Rinaldi è giornalista professionista e vive a Bo-
n. 0
Marzo 2009
[email protected]
www.finzionimagazine.it
31
www.finzionimagazine.it
Scaricare