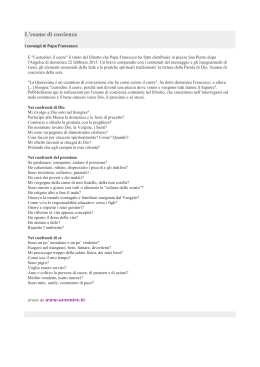Domenica il fatto I detective della nuova tubercolosi La di DOMENICA 24 GIUGNO 2007 MARIO CALABRESI e DARIA GALATERIA il reportage Repubblica I segreti del Taj Mahal, pianto di pietra FEDERICO RAMPINI Benvenuti a Brescia, la nuova capitale dell’Italia futura, dove un bambino su tre nasce da genitori immigrati La città FOTO EDEN Babele la storia GABRIELE ROMAGNOLI P BRESCIA arafrasando la Bibbia (Genesi 11, 1-9): «Tutta la città aveva una sola lingua e le stesse parole. Dissero: costruiamoci una torre e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà possibile. Confondiamo dunque la loro lingua, perché non si comprendano più l’uno con l’altro. Emigrando dall’oriente uomini capitarono nella città, che si chiamò Babele». O Brescia. Dalle targhette sui campanelli delle abitazioni di un edificio in Via delle Battaglie: Palaganas, Ajubaladi, Saharom, Rare Jewei (Bangladesh), Abdal Mohammed, Agal Ibrahim, Shafiquul, Topaktas. A quel punto, fermo in mezzo alla strada, guardando il portone, ascoltando le voci di due egiziani fermi all’incrocio («Essaiek?» «Amdulilleh»), di un cingalese al telefono di una residua cabina, di Radio Padania Libera (97mhz) che combatteva con la colonna sonora di un musical di Bollywood in dvd, il sibilo di una cinese alla collega barista, la preghiera in pijin english di un cameriere nigeriano yoruba e l’esclamazione di un’anziana autoctona entrando dall’ultima parrucchiera, afflitta dal caldo: «Se mùr! Se crepa!», ho capito di essere davvero arrivato a Babele. Il viaggio era cominciato a tavolino. La meta da individuare era il luogo d’Italia che oltre un decennio di immigrazione aveva maggiormente rivoluzionato. E frammentato. Non una Chinatown o un qualunque altro aggregato omogeneo. Un pianeta arcobaleno, la somma di tutte le origini, l’avverato incubo (o sogno, o destino, dipende dai punti di vista) multietnico, che prende il posto della realtà nazionale, spazza via la polvere dell’identità e lascia sulla strada... che cosa? Questo era da verificare. Dove? A Brescia, secondo le indicazioni dell’Istat. Dai loro dati: l’88% della popolazione straniera risiede nel Centro-Nord, ben un quarto in Lombardia, con un’incidenza del 7% cento sul totale dei residenti. Nella provincia di Brescia questa quota sale al 9,4% e supera il 13% quando si considera il comune. L’insediamento più antico è stato di comunità dal Senegal, Filippine, Ghana e Algeria. Ora i residenti stranieri nella Provincia sono oltre centomila in rappresentanza di 151 Paesi, dagli oltre quindicimila marocchini al cambogiano triste e solitario, ma non «finàl», giacché essi si riproducono e un nato su tre non è italiano. Con queste premesse sono entrato a Brescia in una mattina d’estate in cui «se mùr, se crepa» alla ricerca del microcosmo, del simbolo, del marchio di Babele. (segue nelle pagine successive) con i dati di un’inedita elaborazione ISTAT Il Tour de France a pane e acqua GIANNI MURA e PAOLO RUMIZ cultura Goldblatt, poeta del bianco e nero ANDRÉ BRINK la lettura Gli amabili spettri di Conrad e Benet JAVIER MARÍAS spettacoli America, il paese trita-auto SIEGMUND GINZBERG Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 la copertina 54% la percentuale di stranieri sposati Erano il 40% nel 1992 15,4% i matrimoni misti a Brescia In Lombardia sono il 12,6% 21,5% FOTO FRANCESCO GIUSTI i matrimoni tra stranieri o misti a Brescia COPERTINA In copertina, campanelli nel vecchio centro di Brescia In questi vicoli - come certifica l’Istat - convivono 151 etnie, più di un abitante su otto è straniero, un neonato su tre viene da famiglie di immigrati. La città-babele, il melting pot dell’Italia futura sta proprio qui, all’ombra della storica, duecentesca Torre della Pallata Tutte le lingue di Little Brescia GABRIELE ROMAGNOLI (segue dalla copertina) o attraversato periferie in tutto simili, anche per popolazione, al resto d’Italia, quartieri di un futuro mai avverato (Brescia Due) e sono arrivato al centro, dove mi è apparsa la traccia del traguardo. Se cerchi Babele, devi trovare la Torre. Ecco la Torre della Pallata, altezza trentuno metri, eretta nel Tredicesimo secolo. Ai suoi piedi una fontana del 1596 con due bocche a rappresentare altrettanti fiumi. Di lato: un phone center di prossima apertura, colonne romane e Money Gram, antiche pietre e vaglia per la Moldova. Sono ai confini della Contrada del H Carmine, cuore del centro storico di Brescia, strade che portano i nomi di Garibaldi e dei Mille, o quelli più antichi di Rua Sovera e Rua Confettera, negozi che parlano un’altra lingua. Dalle insegne di alcuni esercizi commerciali nelle vie del quartiere: Halal meat, World travels (we speak italian, english, urdu, punjabi, esperanto), Bangla Shop, Emporio Hua Li, Madina Trading, Desent Hair Studio, Nuovi arrivi (in tricolore) Negozio Italiano, Vendesi attività, Vendesi attività, Vendesi attività. I negozi e i palazzi raccontano la storia della contrada. E un po’ lo fa anche Mario Labolani, presidente della circoscrizione, pantaloni rossi e bicicletta elettrica, candidato per Alleanza Nazionale, eletto a maggioranza assoluta e «imbattibile anche la prossima volta, qui votano tutti per me». Se non che «tutti» sono sempre meno. Tutti sono pochi. Ufficialmente gli stranieri nella contrada sarebbero il 34%. Con gli irregolari la cifra raddoppia e si intuisce a vista d’occhio. C’era una volta il centro storico di una città lombarda, vecchie case piene di storia e muffe, in mano quasi esclusivamente a tre famiglie (Boscain, Morosini, Tinti). Cominciarono ad affittare i locali, spazi sempre più piccoli a prezzi sempre più alti. Li potevano pagare i clandestini e i disperati. Magari i fuorilegge. Vennero i senegalesi, vennero gli albanesi, poi i cinesi, i pakistani. Stretti tra loro e gli uni accanto agli altri. Questa è la caratteristica unica, forse al mondo, della Babele del Carmine: percorri una strada e fai il giro del pianeta. Altrove, perfino nelle metropoli d’America, i cinesi si prendono un intero quartiere, i sudamericani stanno tra loro, possibilmente al di là di un fiume, i coreani si radunano attorno a quello che ritengono il simbolo di maggiore potenza della città. Al Carmine, per non avere briciole, hanno diviso la torta e la mangiano allo stesso tavolo. I cinesi si sono presi i bar, i bengalesi i negozi di frutta e verdura, i pakistani i phone center, gli albanesi la prostituzione, i nordafricani (capeggiati dal carismatico Stampella, lesto di mano più che di gamba) il traffico di stupefacenti. È cambiato tutto e ancor più cambierà. Al Carmine, se vedi un cane o un gatto è di un italiano, se vedi un bambino è di uno straniero. La scuola all’ora della ricreazione sembra una pubblicità di Benetton. Chi non vuole mischiarsi va a studiare dalle dorotee. I più restii all’Onu dell’apprendimento sono i cinesi, secchioni e disciplinati per natura, che considerano palle al piede il resto del mondo e spesso emigrano verso banchi di altri quartieri meno frammentati. Al Carmine, se vedi un negozio merceologicamente superato (Coppe, targhe, incisioni Benedini, Caccia e Pesca La Rossana) è italiano, tutto il resto, quel che si compra e si vende davvero ogni giorno, il cibo, le stoffe, le schede telefoniche, è straniero e sottocosto. L’abbigliamento per neonati è cinese. Le onoranze funebri (Curati, o Cùrati, dal 1935, italiano). C’è un ristorante indiano (Taj Mahal) che serve menù italiano a mezzogiorno e ci sono due lumbard che vendono abbigliamento etnico su un banco in piazza. Chi ha passato l’attività è stato pagato in contanti, parte in nero, ha sorriso e adesso critica l’immigrazione selvaggia seduto per ore a un tavolino con il conto in 10,4% gli studenti stranieri sul totale degli alunni In Italia sono il 4,8 12,3% gli studenti stranieri nella scuola primaria a Brescia 17.814 gli studenti stranieri nella provincia di Brescia CITOFONI A sinistra e in alto a destra, il melting pot dei citofoni Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 2,97 i figli per donna straniera in provincia contro l’1,2 delle italiane 35,1% i nati a Brescia con almeno un genitore straniero nel 2005 20% i minorenni sul totale degli stranieri a Brescia COPPIE banca a fare da scudo. Se vuole installare il condizionatore («Se mùr! Se crepa!») chiama Hafeez Tahir, «the best electrician» del quartiere. Dalle scritte sui muri del Carmine: «Quieres cafe mi vida? Sirvetelo», «Ika tangy», «Palestina rossa», «I shin den shin», «Morte al fascio». Il cambiamento lo vedi, lo ascolti, lo puoi perfino annusare. All’ora dei pasti salgono odori multietnici, speziati e forti. Al mercato locale le vendite di cipolle sono più che decuplicate. Un africano cucina nel suo take away dove sono esposti un menù internazionale e l’invito «Vieni, qui trovi Little Senegal a Brescia». Penso che la definizione sia imprecisa. La Babele del Carmine non è la somma di Little Senegal, Chinatown e Rabat Due. È, piuttosto, Little Brescia, quel che resta dal tempo in cui «tutta la città ave- FOTO EDEN A sinistra e sotto, coppie di immigrati nei parchi cittadini Città campione Multietnica Prolifica L’88% della popolazione straniera in Italia risiede nel Centro-nord, un quarto in Lombardia, il 7% sul totale dei residenti Nella provincia di Brescia questa percentuale sale al 9,4% e supera il 13% nel Comune Gli stranieri residenti in provincia sono oltre 110mila suddivisi in 151 etnie. I più numerosi sono i marocchini (oltre 15mila) seguiti da albanesi (14mila), pakistani e indiani (oltre ottomila), romeni (oltre settemila) A livello nazionale i nati di cittadinanza straniera sono il 9,4% del totale dei nati residenti nel 2005. In Lombardia superano il 15% e nel comune di Brescia la percentuale raddoppia arrivando al 31,3% va una sola lingua e le stesse parole». Poi ha cominciato a costruire la Torre, ma nessuno se ne è messo a guardia. Gli uomini emigrati da Oriente sono entrati portando le loro lingue, i costumi e gli ingredienti per il pasto, accolti con un sospetto che l’avidità dissipava. Pagavano il pedaggio, dunque avanti. Quando la distrazione e il tornaconto hanno lasciato il posto alla constatazione tardo sbigottita, Rua Sovera era già una terra di mezzo e nel Carmine la babele di voci si levava da quaranta phone center. C’erano un barbiere per arabi e una parrucchiera per africane, un alimentari cinese e uno pakistano, con un’offerta così variegata e sottocosto, una clientela così precisa e limitata da rendere legittimo il sospetto che a garantire la sopravvivenza fossero anche altri commerci, a cominciare da quelli dei permessi di FONTE ISTAT Tutti i dati che certificano come, sia rispetto al comune che alla provincia, Brescia sia la città-babele, ovvero la città statisticamente più multietnica d’Italia, dati utilizzati per l’inchiesta di copertina e riportati in queste pagine, sono stati elaborati appositamente per la Repubblica dal Servizio statistiche demografiche dell’Istat soggiorno, garantiti da assunzioni di facciata in un qualunque esercizio commerciale. Dalla sezione annunci economici, rubrica incontri, del quotidiano Brescia Oggi: «Cinese, ottima massaggiatrice», «Marocchina calda riceve», «Thailandese cortese, non te ne pentirai», «Argentina bionda, gentilezza e relax», «Trans brasiliana, anche a domicilio», «Russa, tacchi alti e calze nere, condizionatore», «Giovane bulgara, come tu mi vuoi». Adesso si corre ai ripari: una legge regionale ha limitato il numero dei phone center, si impongono restauri negli appartamenti e si controllano gli affitti, ma la legge di natura è implacabile, nel giro di dieci anni l’ultimo italiano lascerà, per scelta o per decesso, la contrada al cui ingresso, ironicamente, esiste e resiste un negozio chiamato «Medinitali». È una maledizione o una benedizione? Il testo della Genesi ha diverse interpretazioni. Una sostiene che la «cittadella universale» che si stava erigendo, con al centro la torre, simboleggiava la cancellazione della diversità delle lingue, delle culture, della gente. Dio sarebbe intervenuto per impedire agli uomini di distruggere una parte essenziale dell’umanità: la diversità, che sarebbe addirittura sacra. Secondo questa teoria quello della torre di Babele è un racconto satirico, è una satira dell’impero, che condanna l’uniformità, esalta la diversità e ci dice che è voluta da Dio, appartiene al nostro patrimonio e non si può cancellare. Qui siamo, cittadini di una contrada globale, tra tonnellate di cipolle, carne halal, massaggi relax, scarpe da cinque euro, preghiere in tutte le lingue del mondo. E così sia. 97.388 i permessi di soggiorno in provincia al gennaio 2006 50,8% gli stranieri in età attiva (18-39 anni) contro il 29% degli italiani FOTO STEVE PREZANT/CORBIS 42.480 gli stranieri che lavorano nel comune di Brescia BABELE In queste pagine, quattro quadri della torre di Babele Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA il fatto Pandemie DOMENICA 24 GIUGNO 2007 È una malattia antica, resa leggendaria dai libri dei nostri nonni. Sembrava sconfitta dai farmaci del Novecento ma in anni recenti, nella distrazione di governi e Big Pharma, è tornata a uccidere. Fino a quando, pochi giorni fa, è spuntato il “malato perfetto” Nel laboratorio-sentinella della nuova tubercolosi MARIO CALABRESI S NEWARK uccesse nel 1990, quando la tubercolosi, ormai quasi scomparsa, incontrò una pandemia nuovissima, apparsa a Manhattan meno di dieci anni prima. Una delle malattie più antiche della storia dell’uomo, presente da quindicimila anni, rintracciabile perfino nelle mummie egiziane, trovò l’habitat ideale per risorgere: i corpi debilitati dall’aids. Ma si presentò con una sorpresa: non era più solo la malattia scatenata da quel micobatterio scoperto da un oscuro medico tedesco, Robert Kock, nel 1882 e curata con farmaci messi a punto negli anni Quaranta, aveva un volto nuovo e sconosciuto, aveva fatto il salto di qualità, era diventata più forte e resistente ai vecchi antibiotici. Il primo caso apparve in un carcere a nord di New York. Sarebbe rimasto isolato, ma il «peggior scenario possibile» doveva avverarsi. L’uomo uscì per curarsi e la sorte volle che nell’ospedale in cui arrivò il reparto dei malati di tbc e quello di chi aveva l’aids conclamato fossero contigui. Fu un gioco da ragazzi e tra le due malattie si celebrò un matrimonio perfetto. La tbc è vigliacca, capace di dormire per anni nei corpi sani per presentarsi non appena riconosce i primi sintomi di debolezza: vecchiaia, alcolismo, malnutrizione, droga. Niente di meglio di una malattia che distrugge il sistema immunitario come l’aids, quello è l’habitat ideale e allora la combinazione diventa esplosiva. L’epidemia a New York fu terribile: in quarantatré mesi, dal gennaio 1990 all’agosto ‘93, i casi furono oltre dodicimila. La città corse ai ripari, spese un miliardo di dollari per fronteggiare l’emergenza, riaprì i laboratori chiusi nell’era reaganiana, stanziò fondi in una lotta contro il tempo e di fronte al vecchio ospedale Bellevue, lo storico sanatorio di New York, nacque un centro d’avanguardia dove raccogliere i migliori medici e microbiologi per fermare l’epidemia e attrezzarsi per il futuro. Il simbolo di quello sforzo oggi si è trasferito in New Jersey, a Newark, attratto da una politica intelligente di finanziamenti alla ricerca: è un edificio nuovissimo che si raggiunge in venti minuti di treno da Manhattan. Qui c’è la sede del TB Center, il centro che studia la tubercolosi del Public Health Research Institute. Nove laboratori d’avanguardia, ognuno ha grandi stanze BL3, spazi di bio-sicurezza di terzo livello, a pressione negativa — l’aria è filtrata ed entra ma non esce — ci si accede solo con la tuta, la mascherina e gli occhiali, qui si studiano i micobatteri della tubercolosi. Ce lo racconta Marilà Gennaro, medico italiano con specializzazione a Londra che fa ricerca da più di vent’anni negli Stati Uniti. Dirige uno dei gruppi che studia le risposte immunitarie e nuovi metodi di diagnosi. Sullo stesso piano, un ambiente impressionante per gli spazi, la luce e le tecnologie d’avanguardia, lavora Barry Kreiswirth, microbiologo. Sul suo tavolo un mattone con incisa una scritta, «Non sputate sul pavimento», viene da un sanatorio degli anni Venti, intorno i poster della prima metà del secolo scorso con i bambini malati che dicono: «Non baciatemi». Lui è un investigatore. È quello che prende le impronte digitali ai batteri della tbc, li scopre, li traccia, li archivia e così li può seguire, può ricostruire percorsi dei contagi, per cercare di rompere la serie. Ha scoperto il colpevole delle morti: «Ci volle oltre un mese, mentre eravamo nel bel mezzo dell’epidemia. Lo isolammo, capimmo che era simile al ceppo Beijing che si trova in Asia e nell’Europa dell’Est ma questo era diverso da tutti gli altri. Era nato qui. Era il ventitreesimo, lo chiamammo «W»: i batteri hanno le lettere dell’alfabeto come gli uragani, qualcuno dice che la scegliemmo perché significava «wicked», malvagio, ma la verità è che era la prima lettera disponibile. Identificammo 357 pazienti con il W, in gran parte sieropositivi, morirono quasi tutti, il novanta per cento, fu terribile ma questo fermò l’epidemia». Oggi i valori sono tornati a scendere ma ci sono ancora un migliaio di casi di tbc l’anno a New York e il ceppo W circola per l’America. Ogni tanto salta fuori da qualche parte, è successo centosessanta volte da allora. Una ventina erano persone che a quel tempo lavoravano negli ospedali. Pochi giorni fa è accaduto nella Carolina del Nord: un malato, uno strano ceppo, dall’ospedale si rivolgono al centro di Newark, gli mandano una mail con l’identikit, a vederlo stampato su carta sembra un codice a barre co- A Newark, New Jersey, sorge il TB Center dove i migliori ricercatori studiano nuovi metodi di diagnosi e nuovi farmaci Il caso Andrew Speaker, giovane avvocato bianco, tipico americano medio, aggredito dalla tbc, ha riaperto il rubinetto dei finanziamenti IERI E OGGI Dall’alto, la corsia di un antico ospedale per malati di tubercolosi Una visita per la prevenzione della tbc in una scuola americana nel 1938 Uno scienziato del TB Center di Newark, nel New Jersey, indossa abiti e mascherina protettivi prima di entrare nei laboratori dove si svolge la ricerca di punta negli Stati Uniti contro le nuove forme di tbc multi resistente me quelli dei prodotti del supermercato. Lo inseriscono nella banca dati dove ci sono 22.493 micobatteri schedati, il verdetto è W: «Chiedetegli subito se è mai vissuto a New York», la risposta arriva quasi subito: «Sì, nella prima metà degli anni Novanta». Già ventidue volte è stato trovato lontano da Manhattan: il W viaggia nei corpi di chi cambia casa, lavoro, amici. Un giorno a sorpresa si presenta, insieme a un tumore, al deperimento dovuto ad un diabete non curato, alla droga, all’alcolismo, a un forte stress; è accaduto a Miami, Las Vegas, Atlanta e perfino a Parigi. «Andrà avanti per generazioni. Ogni volta — conclude Barry — spieghiamo come provare a curarlo, con quale cocktail di farmaci, perché, se diagnosticato in tempo, la metà dei pazienti sopravvive. Isoliamo il paziente, facciamo ricerche sui familiari per prevenire il diffondersi del contagio». Gli Stati Uniti da soli investono più soldi nella ricerca sulla tbc di tutti gli altri paesi del mondo messi assieme. Ma non basta. Nel mondo la situazione si fa più pesante: c’è un morto ogni quindici secondi, che nell’intero 2005 porta alla cifra totale di due milioni di decessi. Il numero dei casi è arrivato a nove milio- ni. «E pensare che era in un declino che sembrava irreversibile, poi l’aids — spiega Marilà Gennaro — ha rotto un equilibrio e quello che è successo a New York si è replicato in modo identico in Sud Africa. La malattia ritorna in auge sfruttando le devastazioni dell’aids e, grazie alle trascuratezze delle cure, fa il salto di qualità, diventa “multi drug resistant”. Prendere novanta pillole alla settimana, nella fase intensiva, per poi continuare sei mesi, un anno, è pesante e faticoso, molti abbandonano la cure, senza controlli, dopo poche settimane non appena hanno la sensazione di stare meglio. Così si selezionano i batteri più resistenti agli antibiotici, i mutanti spontanei». «Nei paesi dell’Europa dell’Est che erano sotto l’Urss — continua Marilà Gennaro — con il crollo del sistema sanitario sono esplosi i ceppi resistenti ai farmaci. Quasi mezzo milione dei nuovi malati ogni anno nel mondo è di questo tipo. Intanto la tbc corre e ha fatto il nuovo salto, il terzo: ora è anche “extensively drug resistant”, è la tubercolosi estrema che resiste anche ai farmaci di seconda linea. Si prova a curarla con farmaci sempre più costosi e tossici. In Sud Africa ha avuto una fiammata all’inizio dell’anno con una mortalità pressoché totale: la sopravvivenza media dal giorno della diagnosi è sedici giorni. Una malattia che era terribile ma affrontabile con farmaci poco costosi e relativamente tossici sta diventando, nelle sue forme estreme, incurabile. Stiamo tornando a scenari di possibile mortalità precedenti alla terapia antibiotica». Bisogna aumentare la ricerca, ma i soldi non bastano, quando in Occidente si deve dare priorità a una malattia per assegnare i fondi di ricerca si sceglie qualcosa che è più vicino a noi, dal cancro al diabete. Non si punta su malattie che colpiscono i poveri, i malati di aids africani e, negli Stati Uniti, i neri, gli ispanici e gli immigrati. Bisogna cercare nuove medicine, l’ultima è del 1963, sono più di quarant’anni che non si mettono a punto terapie antibiotiche aggiornate, che siano capaci di abbreviare le terapie. E si devono trovare metodi per fare diagnosi precoci, prima che i malati diventino contagiosi. Ma costa troppo alle case farmaceutiche, è uno sforzo eccessivo in termini di tempi e investimenti in ricerca per dare vita a una medicina che non sarà mai remunerativa, perché utilizzata soprattutto dai più poveri Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 Quel male letterario “quasi una grazia” DARIA GALATERIA ra il 1928; per diventare scrittore, George Orwell sentì «profondamente» che doveva abbandonare i privilegi, e condividere la vita degli emarginati. Impegnò i cappotti al Monte di pietà, e visse al gelo tra i barboni, che non lo estromisero — come lui temeva — per il suo accento di Eton. I polmoni erano già in disordine; una tempesta di nevischio affrontata in camicia degenerò in polmonite e peggio. Imparò però che a Londra le cimici erano più numerose nei quartieri del sud che in quelli alti; nei dormitori le lenzuola puzzavano maledettamente, e nella notte poteva capitare che un ubriaco venisse a vomitare vicino ai letti, che distavano un metro (e allora costavano nove pence; la distanza di un metro e mezzo si pagava uno scellino); insomma si fece tutta l’esperienza che diventò nel 1933 Senza soldi a Parigi e a Londra, e via via tutti i capolavori — fino a 1984, che gli lasciavano battere a macchina, nell’ultimo sanatorio, per qualche ora al giorno. Nel 1918 il creatore dell’hard boiled Dashiell Hammett aveva contratto in guerra una malattia di petto; questo gli fu di grande aiuto nel lavoro. Era investigatore privato alla Pinkerton Detective Agency di Baltimora, e nei pedinamenti, settantadue chili per due metri di altezza, non passava inosservato. Ora pesava cinquantasette chili, e lo chiamavano Slim; ma quando stava bene gli affidavano compiti turbolenti. In un pedinamento spuntò un complice che lo colpì alla testa con un mattone, ma lui si rifiutò di stare in ospedale; in sanatorio andava, perché flirtava con le infermiere — una la sposò; c’era un degente che quando stava in forze usciva con uno sfollagente a fare rapine, e poi si rinfilava nel letto. «Ma non è morto?», si stupì nel 1937 lo sceneggiatore Budd Schulberg, sentendo che Scott Fitzegerald (che era stato in effetti ricoverato per tbc a Tryon nel North Carolina e poi a Ashville) era stato assunto dalla Metro-Goldwin-Mayer di Hollywood — ma era la crisi del ‘29 che aveva sepolto l’età del jazz e la sua mitica coppia con Zelda. «Il nostro è un tempo che persegue consapevolmente la salute, ma in effetti crede solo nella realtà della malattia», scrive Susan Sontag; «Nietzsche, Dostoevskij, Kafka, Rimbaud hanno autorità su di noi precisamente a causa della loro aria malsana». La superiorità dell’artista è, come la tbc insidiosa, un segreto che rende emaciati. I residenti del sanatorio nella Montagna incantata si avvoltolano con cronometrici gesti dentro le loro coperte come fossero crisalidi e, al riparo dal monCAMPAGNE DI MASSA do, si espongono sulle loro Qui sopra, un poster del 1917 «eccellenti sedie a sdraio della Croce Rossa per la lotta nella fredda umidità del prialla tubercolosi. In alto, raggi X mo autunno». «Avevo subia un bambino nella campagna to intuito che lei fosse, senza anti-tbc (Usa, anni Quaranta) saperlo, uno dei nostri», dice il medico a Hans Castorp, venuto a trovare un cugino, e poi impaniato per anni in quel confortevole mondo rarefatto. Thomas Mann trasfigura il sanatorio di Davos nei Grigioni in un nodo di metafore, della borghesia estenuata, del tempo piatto della ripetizione, del rifiuto. «Ma certo che hai conosciuto René Crevel», gli diceva la moglie, irritata che Mann fosse così distratto sugli amici dei figli; dimenticava che il loro Klaus era andato a trovarlo in sanatorio? Crevel, un incrocio tra un arcangelo imbronciato e un marinaio, a un certo punto si era ucciso, in odio al realismo socialista — infatti era affiliato al surrealismo. «Anche la sua magrezza era una grazia», dice Dumas figlio della Signora delle camelie. Il Romanticismo a suo tempo aveva condannato le donne alla virtù, e le cocottes alla tisi. Nel Novecento i nostri poeti crepuscolari muoiono di consunzione; e subito comincia con Palazzeschi la derisione («Cloffete, cloppete», si lagna la Fontana malata; «la tisi l’uccide. / Dio santo, / Quel suo eterno tossire / mi fa morire»). Il primo giallo di Sciascia rovescia la tbc in male sociale: nel Giorno della civetta il medico delle carceri vuole levare dalle infermerie i mafiosi, e metterci detenuti comuni tisici — impossibile. E l’insetto — segnalato dal respiro — delle Metamorfosi (si chiede Pietro Citati in Kafka) non sarà un malato incurabile visto da congiunti insofferenti? «Guarirà», disse nel 1921 il giovane amico Janouch a Kafka, che andava al sanatorio dei Monti Tatra. Kafka usava i gesti come frasi suppletive; si portò l’indice al petto. Poi disse: «Il futuro è già con me». Nei successivi ricoveri, Dora, diciannove anni, si innamorò di lui, che andava verso «il porto profondo» scrivendo anche quando da un po’ non mangiava più; e ripensava a suo padre, fonte di tutte le sue debolezze, con una sorta di remissività («Abbiamo bevuto la birra insieme, tanti e tanti anni fa, quando papà mi portava a nuotare»). Indicava a Dora, senza parole, i letti che ogni giorno si vuotavano; e con tutto il suo sovrumano controllo, fu visto per la prima volta piangere — per lo sforzo di correggere le bozze. La moglie Fanny nel 1885 aveva invece dovuto accumulare i tavoli attorno alla poltrona di Stevenson per evitare che, nel dettare l’incantevole Principe Otto, si estenuasse come al solito a passeggiare eccitato. Interminabile con i suoi cinquanta chili di peso, i lunghi capelli e i baffi biondi spioventi, Stevenson vagava, squassato dalla tosse, tra sanatori e i mari del sud alla ricerca dell’immortalità e della guarigione; la prima era arrivata con L’isola del tesoro; la seconda con Wailima, la grande casa di legno delle Samoa, con le sedie Chippendale arrivate dall’Inghilterra; gli indigeni e i servitori, con i lava lavatagliati a forma di kilt, ascoltavano estasiati i racconti di “Tusitala”. Erano stati sistemati nelle librerie anche i libri, e Stevenson, a larghe pennellate, ne verniciava i dorsi, per proteggerli dal caldo umido che era — temporaneamente — la sua buona salute. FOTO ROBERT CLARK/NATIONAL GEOGRAPHIC E del pianeta. Così bisogna puntare sui centri di ricerca finanziati con il denaro pubblico. Bill e Melinda Gates invece stanno sponsorizzando la ricerca di un vaccino, prima di loro c’erano solo fondi statali anche in questo campo. Da mesi i laboratori di tutto il mondo e l’Organizzazione mondiale della sanità lanciano l’allarme, ma sono poco ascoltati. Poi arriva il “colpo di fortuna”: si chiama Andrew Speaker. Bianco, giovane, occhi azzurrissimi, avvocato, classe media, con una moglie, Sarah, dai capelli lunghi biondi e con il classico filo di perle al collo. È l’incarnazione dell’americano tipo. Si scopre che ha la tubercolosi nella sua forma peggiore, quella estremamente resistente. Scatta l’allarme perché ha viaggiato tra l’Europa e gli Usa, passando per Roma, indisturbato. Viene messo in quarantena. Televisioni, giornali e siti internet si riempiono delle sue foto. La moglie gli si avvicina coperta da una mascherina con il becco da paperino. La tbc entra nelle case americane all’ora di cena, diventa dibattito da ufficio, da treno di pendolari. Occupa le paure dei cittadini. Conquista prepotentemente un posto di rilievo nell’agenda dell’informazione e della politica. E segna una DETECTIVE Barry Kreiswirth, microbiologo, dirige il TB Center di Newark: è uno scienziato “detective” che studia i ceppi della tbc per scoprirne le “impronte digitali”, schedarli e ricostruirne il percorso In questa foto, mostra la lastra di un polmone attaccato dalla tbc “multi drug resistant” sconfitta dei meccanismi di controllo antiterrorismo: Andrew è entrato serenamente in macchina dal Canada, anche se il suo volto era stato segnalato e l’Fbi aveva diramato l’ordine di bloccarlo senza esitazioni. E se fosse stato un terrorista con un’arma biologica? L’imbarazzo delle autorità è stato terribile. Prima si pensa che Speaker abbia preso la tbc da un parente che lavora al Center for Disease Control, il quartier generale delle emergenze mediche e della prevenzione a stelle e strisce. Invece quel ceppo non esiste nei laboratori di Atlanta, sembra possa venire dal Vietnam o dal Perù, dove lui ha fatto volontariato. Ora Andrew è a Denver e per salvarlo gli dovranno asportare la parte di polmone attaccata dal microbatterio. E subito arrivano i nuovi fondi, la tbc è tornata a fare paura, il Congresso approva stanziamenti straordinari e si fanno avanti anche i privati per rispondere alle apprensioni dell’intera America. Nei corridoi del laboratorio di Newark, al tramonto, dietro le vetrate a tutta parete, risuona una battuta: «È il caso perfetto, un regalo, un vero colpo di fortuna, neanche ce lo fossimo inventato». Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 il reportage Tra harem e templi Viaggio alla scoperta del Taj Mahal, uno dei capolavori dell’arte mondiale sull’altopiano indiano del Deccan. Fu edificato nel Diciassettesimo secolo dall’imperatore Moghul Shah Jahan come tomba per la sua favorita, Mumtaz Mahal. Quando lei non sopravvisse al parto l’uomo più potente del mondo crollò Il marmo scavato dalle lacrime P FEDERICO RAMPINI AGRA er il poeta indiano Rabindranath Tagore la sua forma era «una lacrima sul volto del Tempo». Rudyard Kipling lo definì «il cancello d’avorio sotto il quale passano i sogni». È stato visto anche come un simbolo erotico, per il cupolone immacolato che evoca un seno femminile gonfio di latte. Si può essere irritati dalla sua troppa fama, dall’onnipresenza nelle cartoline e riprese televisive e riproduzioni per turisti. Il romanziere Salman Rushdie per anni si rifiutò di guardarlo, ma dopo la sua prima visita dovette arrendersi: «Il mio scetticismo cadde a pezzi. D’autorità cancellò all’istante milioni di imitazioni. Con il suo splendore riempì una volta per tutte il posto che nella mia mente era occupato dalle riproduzioni. Ecco perché, alla fine, il Taj Mahal deve essere visto; per ricordarci che il mondo è reale, che il suono è più vero dell’eco, che l’originale è più potente dell’immagine riflessa allo specchio. La bellezza è ancora capace, in quest’epoca saturata di immagini, di trascendere le imitazioni. E il Taj Mahal è, ben oltre il potere delle parole per descriverlo, una cosa adorabile, forse la più adorabile di tutte le cose». Il Taj Mahal è uno dei capolavori dell’arte mondiale, immediatamente riconoscibile per centinaia di milioni di persone, l’icona dell’India per eccellenza. Lo status di meraviglia universale non è l’unica dimensione del suo fasci- no. Nella seduzione che esercita il mausoleo di Agra entrano ingredienti che mancano perfino a San Pietro, al Partenone e alla Piramide di Cheope. Il Taj è un luogo che parla della morte e dell’aldilà ma anche di una struggente storia d’amore, è la gigantesca e sublime tomba edificata da un vedovo inconsolabile per ricordare in eterno la moglie. È una fusione di influenze artistiche che spaziano dalla Persia all’Estremo Oriente, così perfetta da alimentare per secoli un “giallo” tuttora irrisolto sul misterioso architetto che lo progettò. È infine il frutto dell’èra più felice della storia indiana, monumento all’armonia tra la religione braminica e l’Islam. La leggiadra eleganza delle sue forme, il candore abbagliante della pietra che cambia riflessi a ogni ora del giorno, la ricchezza dei giardini, la fine tragica dell’imperatore che lo fece costruire, e poi le velenose gelosie tra occidentali, musulmani e indù sulla paternità culturale di questo tesoro: per queste ragioni il Taj suscita estasi e controversie da secoli. Ancora quest’anno ha ispirato due nuove ricostruzioni: Taj Mahal, Passion and Genius at the Heart of the Moghul Empire degli storici oxfordiani Diana e Michael Preston; The Complete Taj Mahal di Ebba Koch, la più autorevole esperta mondiale di storia dell’architettura indiana nell’èra Moghul. Il Taj viene concepito durante la sofferenza di un parto mortale. È una serata torrida, nel giugno 1631, sull’altopiano del Deccan nell’India centrale. Mumtaz Mahal, “la Scelta del Palazzo”, cioè la preferita dell’harem, a trentotto anni sta agonizzando negli spasimi della sua quattordicesima gravidanza. Al capezzale c’è il marito Shah Jahan, quinto imperatore nella dinastia islamica dei Gran Moghul fondata da Babur. Alla moglie morente lui promette di non sposarsi mai più, e di edificarle un mausoleo funebre che sarà la testimonianza perenne del loro amore. Per due anni, prostrato dal dolore che gli imbianca di colpo tutti i capelli, Shah Jahan pensa solo all’amata che non c’è più. Dedica tutte le sue energie a mantenere la promessa, mobilita per la costruzione del Taj le ricchezze del suo regno, il know-how tecnologico, i talenti artistici di tre continenti. Il risultato è un exploit eccezionale: dodicimila tonnellate di pietre e marmi trasportati da grandi distanze; un edificio la cui circonferenza supera la basilica di San Pietro e la piazza del Bernini messe assieme; la perfezione delle forme raggiunta grazie a complessi calcoli matematici; l’eresia del marmo bianco che nella tradizione islamica era riservato alle tombe dei santi; la profusione di pietre rare incastonate nei muri; le pregevoli decorazioni affidate al più grande Al capezzale della moglie promise di non sposarsi mai più, e di edificarle un mausoleo funebre come testimonianza perenne del loro amore calligrafo persiano dell’epoca, Amanat Khan. «Costruito da giganti, rifinito da cesellatori di gioielli», secondo la definizione di un vescovo anglicano, il Taj è così bello che fin dall’inizio gli europei cercano di appropriarsene il merito. Il viaggiatore francese François Bernier nelle sue cronache dall’India del Seicento si dice convinto che i decoratori abbiano copiato dalla Firenze dei Medici la tecnica della pietra dura incastonata nel marmo. In realtà gli indiani padroneggiano quella tecnica secoli prima del Rinascimento italiano. Anche il mistero dell’architetto anonimo eccita le fantasie eurocentriche. «Secondo il sacerdote portoghese Sebastien Manrique che visitò Agra nel 1640 — scrivono Diana e Michael Preston — l’architetto era un veneziano di nome Geronimo Veroneo, giunto in India su una nave portoghese. Per secoli lo sciovinismo europeo diede grande credibilità a questa leggenda. C’era la convinzione razzista che un non-europeo non poteva aver disegnato un edificio di così rara bellezza. Ma l’affermazione di Manrique non ha fondamento. L’influenza europea sull’architettura Moghul era molto limitata. Se un europeo fosse stato l’architetto avrebbe incorporato nell’edificio almeno qualche segno della sua tradizione. Non ce n’è traccia». La risposta all’enigma dell’anonimato è semplice. Con ogni probabilità molti architetti contribuiscono al progetto, e comunque l’ultima parola e un’influenza decisiva spetta proprio all’imperatore Shah Jahan, uomo di cultura e appassionato conoscitore di architettura. ‘‘ È l’incarnazione di tutto ciò che è puro, santo e infelice È il cancello d’avorio sotto il quale passano i sogni Rudyard Kipling Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 ‘‘ Il Taj Mahal è, ben oltre il potere delle parole per descriverlo, una cosa adorabile, forse la più adorabile di tutte le cose FOTO CORBIS Salman Rushdie L’invidia europea per questo capolavoro e i nostri complessi di superiorità sono rivelatori di un’ignoranza sull’India di quel tempo. Con cento milioni di abitanti nel Diciassettesimo secolo i Moghul amministrano la più vasta potenza musulmana mai esistita, cinque volte più grande dell’Impero ottomano. La loro storia spiega perché il baricentro dell’Islam nato in Arabia slitta progressivamente sempre più a Oriente. Se ancora oggi ci sono più musulmani a est dell’Afghanistan che a ovest, lo si deve al successo dei Moghul nel subcontinente indiano. La loro India è una potenza ricca e sviluppata. La capitale imperiale di Agra è detta la Venezia indiana per il lusso e la profusione d’arte, ma le sue dimensioni eclissano qualsiasi città europea dell’epoca. Con settecentocinquantamila abitanti è due volte più grande di Londra, supera di molto sia Parigi che Costantinopoli, le maggiori metropoli europee del Seicento. Un’esibizione dell’opulenza indiana di quell’epoca è la cerimonia annua del compleanno imperiale: il sovrano viene “pesato” su una bilancia prima in argento, poi in oro, poi in gioielli. I metalli rari e le pietre preziose equivalenti al peso regale vengono distribuiti in beneficenza. Mentre l’Europa è terrorizzata dalle guerre di religione e dall’Inquisizione, sotto i Moghul si afferma una versione dell’Islam aperta e tollerante, in convivenza armoniosa con l’induismo e il cristianesimo. La storia di colei che è sepolta nel Taj, Mumtaz Mahal, sfida gli stereotipi sul ruolo della donna nella società islamica. Gli imperatori Moghul praticano la poligamia ma questo non raggiungere l’orgasmo, come la polvere di zenzero mista a pepe nero e miele. Altri afrodisiaci venivano spalmati sul pene dell’uomo due ore prima dell’amplesso, per garantire alla donna sensazioni più intense». La disperazione in cui Shah Jahan piomba alla morte della Mahal non si spiega solo per la fine di un’intesa fisica così perfetta. Tutti i resoconti dell’epoca descrivono tra l’imperatore e Mumtaz un rapporto di fiducia, di vera amicizia, di complicità intellettuale: un amore paritetico, esclusivo, quasi monogamico perché mette in ombra tutte le altre mogli e concubine. La morte precoce della favorita, oltre che alle numerose gravidanze, va attribuita all’insolita abitudine di Mumtaz di viaggiare sempre a fianco del sovrano nelle defatiganti campagne militari. Quasi a sottolineare il rapporto di parità con la moglie, Shah Jahan accarezza il progetto di far costruire per la propria morte un gemello del Taj Mahal, identico ma tutto di colore nero, per esservi sepolto a fianco del mausoleo di Mumtaz. Un cantiere mai iniziato: il figlio Aurangzeb farà morire Shah Jahan in carcere e lo seppellirà nello stesso Taj Mahal. In quattro secoli di esistenza il Taj ha attraversato tutte le tensioni e le contraddizioni della storia indiana. I nazionalisti indù hanno vo- impedisce una certa libertà di costumi negli harem delle loro mogli. La morbosa curiosità dei visitatori occidentali è eccitata dalle descrizioni dei falli d’oro e d’argento che circolano nei serragli, dalle descrizioni esplicite degli amplessi imperiali, dall’uso dilagante di afrodisiaci. L’harem è anche un centro di potere economico dove le donne amministrano fiorenti attività imprenditoriali. «Le donne di corte — scrivono i Preston — erano ricche, istruite e abili nell’usare le loro relazioni. Attivando reti di intermediari dirigevano commerci con il mondo intero, erano armatrici di navi mercantili, esportavano prodotti indiani in Arabia e oltre». Il potere di Mumtaz sull’imperatore deriva in parte, secondo i due storici inglesi, dalle sue arti erotiche. «Perfino dopo sedici anni di matrimonio e tanti figli Mumtaz esercitava chiaramente un’attrazione sessuale unica su Shah Jahan. A trent’anni suonati, aveva un’età in cui molte mogli e concubine erano considerate troppo vecchie per il sesso, la sua bellezza invece resisteva. Alla vagina, detta madan-mandir (tempio dell’amore), applicava delicatamente pomate di canfora miste a miele, fiori di loto schiacciati nel latte, bucce di melograno macinate. Anche il bisogno della donna di provare piacere era riconosciuto, delle miscele afrodisiache l’aiutavano a Per due anni, prostrato dal dolore che gli imbiancò di colpo i capelli, il sovrano dedicò ogni sua energia a mantenere la promessa luto rivendicarne la genesi, inventando una leggenda: Shah Jahan non avrebbe costruito il mausoleo ma lo avrebbe ricavato modificando un pre-esistente tempio di Shiva costruito dal rajah di Jaipur. I musulmani più fanatici dopo l’Indipendenza nel 1947 tentarono di sequestrare il Taj per riservarlo solo alla memoria dei morti di religione islamica. Dovette intervenire la Corte suprema per sottrarlo alla legge della sharia e lasciarlo aperto ai visitatori di ogni fede. Nel 1965, durante la guerra col Pakistan, è stato a lungo incappucciato con un’immensa rete nera per nasconderlo ai raid aerei e sottrarlo ai bombardamenti. Le ultime aggressioni sono quelle dell’inquinamento e del turismo. Per salvare i suoi marmi candidi dalla corrosione dell’anidride solforosa il governo ha dovuto chiudere duecentocinquanta piccole fabbriche locali, costringendo centomila operai alla disoccupazione («Tutta Agra diventerà una tomba per proteggere il Taj», fu il commento di un sindacalista). La siccità e la desertificazione inaridiscono il corso del fiume Jumna che lambisce la cinta del mausoleo, l’erosione fa già inclinare le torri dei minareti. Perfino il fiato dei turisti è una minaccia: tre milioni di visitatori all’anno producono una umidità pericolosa per la conservazione dei dipinti all’interno del mausoleo. Eppure resiste, in uno stato di salute stupefacente, per ricordare che in India i miracoli sono possibili. Il più importante è di quattro secoli fa, un gioiello dell’arte di tutti i tempi nato dall’amore fra un uomo e una donna, e dall’incantevole unione tra la civiltà indiana e l’Islam. ‘‘ Il mondo si divide tra quelli che hanno visto il Taj Mahal e quelli che non l’hanno visto Bill Clinton Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 la storia Sport nella bufera Si chiama Guillaume Prébois, è un giornalista francese di trentacinque anni che ha deciso di correre “in purezza” un ante-Tour destinato a trasformarsi in anti-Tour: farà, il giorno prima e sotto controllo medico, tutte le tappe della corsa più dura e più bella del mondo per dimostrare che il doping non è stato sconfitto PAOLO RUMIZ COLLE DELLA LOMBARDA 3.547 chilometri Il Tour 2007, edizione numero 94, va dal 7 al 29 luglio e si articola in venti tappe per una lunghezza totale di 3.547 km. Undici le frazioni di pianura, sei di alta montagna, una di media montagna, due a cronometro 23.441 metri Il Tour 2007 prevede 400,7 chilometri di salita per un totale di 23.441 metri di dislivello: quasi tre volte l’altezza dell’Everest La percentuale media di tutte le salite inserite nelle venti tappe è del 5,5 40,780 km all’ora Negli ultimi vent’anni, sia pure a onde, la velocità media dei vincitori del Tour ha continuato a crescere: dai 37,020 km del 1986 ai 40,780 del 2006 passando per il record, i 41,650 del 2005 FOTO BRUNO MURIALDO - CARPEDIEM reddo, vento di Nordest, cielo blu sul Piemonte. Alle 11.06 un uomo solo sbuca dai tornanti, alto sul sellino, in perfetto silenzio, in mezzo alle Alpi spruzzate di neve. Punta sul Colle della Lombarda, quota 2351. «Un uomo solo al comando» avrebbero detto di Coppi, ma quello che vedo salire verso la Francia è un uomo solo e basta. Un uomo magro e biondo che zigzaga tra le marmotte e i nevai, leggero come un deltaplano in una corrente ascensionale. Non è un campione, non ha sponsor né auto di grandi marche al seguito. Il solitario tra le pietraie è un uomo normale — o forse un matto completo — che si prepara a scalare la “montagna” più dura di tutte, alta tre volte l’Everest. Il Tour de France. Sul passo c’è gente intabarrata che aspetta. La voce s’è già sparsa che c’è un parigino di trentacinque anni che farà la “gran corsa” all’antica: senza squadra e senza chimica. «A’ l’eau claire», dicono i francesi. All’acqua chiara, in purezza come i ruscelli. In Valle Stura, a Demonte, l’olimpionica Stefania Belmondo, fondista e grande testimonial dello sport pulito, è già corsa a dirgli «in bocca al lupo» e a spiegargli che i momenti di crisi, quando arrivano, sembrano interminabili, ma poi passano in fretta, basta tener duro. E ora anch’io son qui, che aspetto Guillaume Prébois, seduto sul mio paracarro d’ordinanza come se aspettassi Bartali, il cuore che batte forte per la leggenda che torna. Giornalista sportivo, collaboratore di Le Monde, paladino dell’antidoping e presenza talvolta scomoda nei “Processi alla tappa” del Giro d’Italia, Guillaume un giorno ha detto basta e, dopo l’ennesimo scandalo e le ultime “confessioni” dei grandi del ciclismo, s’è organizzato il suo Tour parallelo, per guardare in faccia la fatica. Voleva vedere cosa succede, durante la corsa più dura del mondo, dentro il corpo di un uomo che rifiuta gli additivi. Per questo s’è allenato tremila chilometri al mese, e ora a luglio farà lo stesso percorso dei professionisti, controllato a vista da un’équipe di medici, seguito giorno per giorno da Le Monde e Radio France Internationale. Tutto avverrà — questa l’unica differenza col Tour vero e proprio — con un giorno d’anticipo sulle tappe, in una corsa solitaria, dunque infinitamente più dura, che sarà condivisa dall’inizio alla fine da un’unica persona: un ciclista veneto, Fabio Biasiolo, specialista di lunghe distanze. Uno che fa tirate pazzesche, come la corsa no stop (senza quasi dormire) tra i due mari d’America. Ma già attorno a questo Forrest Gump della corsa pulita si sta formando un plotone di gregari, un codazzo di gente che ha risposto all’appello — diffuso via internet — per formare, tappa per tappa, una libera corsa alternativa. Una sfida che farà notizia, nei giorni in cui tutta la Francia è au bord des routes. Ma voilà, eccolo che arriva in silenzio, buca l’aria fina del passo, rallenta sulla ghiaia, smonta per infilare la giacca a vento e farsi un panino al prosciutto e ricotta prima della discesa. Dal fondovalle ha impiegato un’ora appena, millecinquecento metri in souplesse. Si toglie il casco, e per un attimo non lo riconosco, sembra un’altra persona. Ha lo sguardo blu più luminoso, il viso affilato che mostra cinque anni di meno. Gli chiedo se ha cambiato occhiali. «Mais non», risponde con un lampo di soddisfazione. «Me lo chiedono in tanti, ma è solo che ho cambiato pelle. Mangio diversamente, e ho imparato a usare il mio corpo». Sembrava un cavaliere dell’impossibile solo un anno fa, al momento della decisione più pazza della sua vita. Monsieur Prébois cercava sponsor e riceveva in cambio pacche di compatimento. Oggi tutto gli dà ragione. I ciclisti vuotano il sacco. Ha cominciato Ivan Basso, vincitore del Giro 2006. Poi l’irlandese Floyd Landis, maglia gialla dello stesso anno. Poi il danese Bjarne Riis, vincitore del Tour 1996. Anche una decina di professionisti tedeschi ha scelto di parlare, e tutti dicono la stessa cosa: senza eritropoietina e altre diavolerie non ce la fai. Roba che trasforma un asino in un purosangue. Eppure, nonostante gli scandali, tutto continua come nulla fosse accaduto, come se Pantani non fosse morto come un cane; come se, in assenza di fatica, l’epica della gara esistesse ancora. Le medie continuano ad aumentare, e nonostante questo i vincitori sembrano meno stanchi dei gior- 4.000-5.500 calorie Durante un Tour un ciclista consuma in media, nelle tappe di alta montagna, 4.000-5.500 calorie al giorno. In assenza di doping, i valori ematici (ematocrito, emoglobina) calano mediamente di circa il 10 per cento nalisti che li intervistano. Coppi si accasciava a fine tappa, loro scendono dal sellino freschi come rose. L’allenatore di calcio Zdenek Zeman, altro solitario grillo parlante, a Prébois l’ha detto chiaro un giorno: facile capire chi si dopa, basta guardare chi vince. Ma ormai il treno non si può più fermare, è diventato uno schiacciasassi che inghiotte tutto. Distacchi abissali e uomini soli al comando. «Non sono affatto certo di farcela — confessa il francese alla vigilia della sua “mission impossible” — ma mi impegno a tirare a morte per tagliare il mio striscione sugli Champs Elisées. Sarà dura pedalare duecento chilometri al giorno per tre settimane, venendo probabilmente ignorato dalla stampa sportiva. Ma so che una certa Francia e una certa Italia sono con me. Alcuni verranno in bici; come al Tour delle origini, che era a iscrizione libera. E so che alla fine, per la prima volta, i medici potranno leggere un corpo umano dopo un simile sforzo. Appurare se davvero, come accade tra i professionisti, il livello di globuli rossi resterà invariato, o piuttosto, come sono convinto io, è destinato a scendere». Si tuffa in discesa, non vuol parlare di cose che gli fanno male. Ma c’è chi ricorda i torti che ha subito. Quando nel 2004 i Nas fecero irruzione nelle case dei corridori più forti del Giro e lui osò dire a un “Processo alla tappa” che quegli uomini non sarebbero potuti andare al Tour perché il nuovo corso pulito del ciclismo francese l’avrebbe impedito, venne dileggiato e messo alla berlina. «Chi sei tu per giudicare l’Italia», gli dissero molti colleghi in diretta. Poi, a microfoni spenti, manager e direttori sportivi vennero a minacciarlo, consigliandogli di cambiar aria, e così il Forrest Gump del ciclismo non mise più piede al Giro. Solo la stampa non sportiva espresse voci in difesa, come il critico tv Aldo Grasso che scrisse, rivolto ai commentatori tv: chiedete scusa a quel francese. Ed ancora la stampa non sportiva, sempre lei, l’unica a fargli da sponsor in questa scommessa. La sera lo ritrovo in Valle Stura, nella remota frazione Perdioni, mentre spazzola montagne di tagliatelle, bistecche, patate e dolci alla locanda “La Randoulina”. Con lui, il padre Jean-Claude, che suona Brassens alla chitarra e lo segue a trenta all’ora in automobile da mesi. Ride: «Il mio segreto? Correre tanto, mangiare tanto, dormire tanto. Stop. Ho rivoluzionato i pasti: niente salumi e formaggi; niente panna, burro e latte; niente roba gasata. Nella borraccia solo miele, polline, pappa reale, sciroppo di mirtillo e un mix di silicio che è la mia unica scorta di minerali. Sto infinitamente meglio di un anno fa. La vita è una, e nutrirsi bene è un atto dovuto nei confronti del corpo. Infliggergli della chimica non è solo una punizione. È anche un atto di sfiducia nei confronti di una macchina meravigliosa». Racconta della straordinaria équipe — mezza italiana — che gli si è stretta intorno. Oltre al ciclista Fabio Biasiolo, un allegrone che lo “tira” anche moralmente, ci sono Claudio e Luigi, uomini della Guardia di Finanza innamorati dello sport a pedali, che hanno lavorato sul doping e ora guideranno il camper al seguito, preparando i pasti e tenendo in efficienza la bici di gara. Poi Didier Rubio, dietologo della nazionale francese di rugby. Marco Caon, un fisioterapista padovano incaricato dei massaggi e dei rifornimenti. Infine Dorian Lecamp, medico dell’ospedale universitario di Tolosa, partner scientifico del servizio medico-sportivo di Francia, diretto dal professor Daniel Rivière. Il tutto con l’imprimatur dell’Agenzia francese antidoping, che effettuerà su di lui, a sorpresa, i test-campione dei professionisti. Apre il computer, riversa dal sensore di bordo i dati dell’allenamento. «Al Tour chiunque potrà leggere cosa succede nel mio corpo. I dati saranno on line sul sito www. lautretour. com. Pressione, frequenza, ematocrito, calorie bruciate, potenza media, velocità, esami del sangue prima e dopo la tappa». Fuori il cielo s’è richiuso, un temporale arriva dal Colle della Maddalena, la valle crepita di tuoni. «Preparare un Tour senza una squadra, dimenticati da tutti, è un’impresa. Sei solo, a faticare per nove mesi, la gara è lontanissima, ti senti un pazzo, e sai che tutto può andare in fumo in un attimo. Basta una caduta». Si frega le mani, ora piove a secchi. «Ma ora sento che arriverò in fondo. Sto bene, sono tranquillo. La Francia è dalla mia parte, so che non farò questo Tour da solo». FOTO KEISTONE - EYDEA Il Tour de France a pane e acqua chiara F Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 CICLISMO EROICO Qui accanto, foto d’epoca del ciclismo eroico: la catena dotata di cambio fu permessa al Tour solo nel 1937 Nelle altre foto, Guillaume Prébois in azione I campioni, i tifosi e il sogno di volare GIANNI MURA lla fine del suo Tour Guillaume Prébois sarà un principe azzurro molto concupito, perché i giornali continuano a svolazzare ma non è vero che i francesi s’incazzano come nella canzone di Paolo Conte. Anzi, i francesi ammirano chi si lancia in un’impresa fuori dal comune. E quindi il Tour resta la Grande Boucle (con le iniziali maiuscole anche quando se ne discorre), con le sue piccole storie, le sue grandi imprese, i suoi miti che non erano sfuggiti a un cacciatore di miti come Roland Barthes, da noi suiveurs regolarmente citato il giorno del Mont Ventoux. Guillaume lo conosco da anni, ha un nome da capitano di ventura, che suona campestre anche in italiano — Guglielmo Pratobosco — e in più è alto, magro, biondo e con gli occhi azzurri. Ha già scritto un libro sulle sue pedalate lungo il Danubio, né bello né blu, e un altro certamente uscirà da questo Tour atipico: corso il giorno prima, chilometro su chilometro uguale a quello dei professionisti, giù dalle discese e su per le salite. Saranno diverse, a volte, le temperature, ma non è questo il punto. Il punto è dimostrare che si può correre il Tour senza fare ricorso a quel che Mario Fossati ha chiamato «la farmacia del diavolo», ossia l’aiuto della chimica, in una parola il doping. Vecchio cavallo di battaglia di Guillaume e del giornale che lo sostiene e sponsorizza (Le Monde, scusate se è poco). L’idea in sé non è nuovissima. Anni fa Eric Fattorino, giornalista-scrittore di radici italiane, si lanciò nella stessa impresa, che è poi il sogno di tanti, da Alfonso Gatto a Francesco Guidolin al sindaco di Pordenone, e il titolo d’una raccolta di scritti ciclistici di Gatto: Sognando di volare (lui che nemmeno sapeva stare in equilibrio sulle due ruote). Fare come i giganti della strada, seguirli o precederli visto che con loro non si può stare in gruppo, altra categoria. È un sogno antico e non solo maschile. Negli anni Trenta i coloristi annotarono che per una ventina di km, i primi di una tappa che partiva da Aix, in Provenza, le ospiti di una casa chiusa avevano pedalato in fondo al gruppo. Sulle salite di tutti i ventuno Tour che ho seguito fin qui ho visto la fauna più svariata: cicloamatori di ogni età, da otto a ottant’anni, zainetto in spalla e baguette di traverso sul portapacchi, e anche molte donne. In genere si scelgono le tappe di montagna, prendendo nota dei tempi, cercando di battere se stessi. Si può fare anche una settimana o un mese dopo che ci passa il Tour, ma non c’è l’aria del Tour, sudore, griglia e patate fritte, il riverbero dell’epicità del Tour e della fatica che costa anche a chi non pedala. Perché se vuoi conquistare una buona lochescion (direbbero, diranno) sul Tourmalet o sul Galibier devi muoverti il giorno prima, quello di corsa il traffico è bloccato. E arrangiarti in tenda, o su un camper. E magari starci anche dopo il passaggio della tappa, perché si creano ingorghi paurosi. Il popolo degli appiedati incoraggia quello dei ciclisti per diletto, allez bonhomme, vas-y la belle, una spinta non si nega a nessuno. Una volta in cima ci si fa fotografare. I poliziotti più zelanti (e ce ne sono) forti della circolare che permette il transito solo ai mezzi autorizzati e con l’autorizzazione bene in vista, infieriscono su questi poveracci facendoli scendere di sella per continuare a piedi. I poveracci obbediscono fino alla prima curva, poi risalgono in sella e ridiscendono al poliziotto seguente. È un po’ una comica, ma anche una seccatura. Questo scrivo per dare l’idea di cosa succede prima della corsa vera: una serie di corse e rincorse. L’idea di cimentarsi in una tappa di pianura fa meno gola, si va più forte, c’è meno gente, c’è meno gusto. Guillaume non sarà fermato e diventerà un eroe. Jean-Marie Leblanc, il gran capo del Tour che è da poco andato in pensione, dava questa definizione, facendo nomi e cognomi. «Hinault è un campione, Poli è un eroe». Eros Poli, un gregario, tra l’altro più passista che scalatore, aveva vinto la tappa del Ventoux, che mai e poi mai avrebbe immaginato di vincere. Un uovo fuori dalla cavagna. L’issarsi, sia pure per un giorno, a una dimensione superiore, forse neanche sognata. Guillaume non avrà una squadra ai suoi ordini, nel senso dei gregari, ma una squadra di amici, medici, dietisti. E un padre che suona Brassens alla chitarra è il tocco in più. Probabile che la piccola carovana s’ingrossi per strada, in questo ante-Tour che ha pure i connotati dell’anti-Tour, col suo richiamo a un’etica della fatica, col suo grido d’allarme contro il doping che imperversa e contro l’ipocrisia di chi guarda dall’altra parte. Anche questa del doping non è una novità, purtroppo. Nel ‘24 i fratelli Pélissier dissero al giornalista Albert Londres: «Noi andiamo a dinamite». E gli mostrarono boccettine piene di una polvere bianca che chiamavano la neige, la neve, ed era cocaina. Due anni dopo un tale Mariani fece quattrini in Francia vendendo «le vin Mariani, le vin de l’athlète» che era poi un vinaccio da due soldi che conteneva foglie di coca in macerazione. Non interesserà granché, ma chissà cosa c’era nella pozione magica del druido per Astérix e Obélix. Robetta, comunque, a fronte del «pot belge» così in voga una ventina d’anni fa. Un cocktail di anfetamina, caffeina, eroina, coca e corticoidi. Noi che viaggiamo a pastis e vino rosso, ma anche a litri d’acqua naturale, penseremo a Guillaume senza vederlo mai se non forse a Parigi. Le stesse strade, ma ognuno per la sua strada, lui la tartaruga e noi il pie’ veloce Achille. Da un punto di vista gastronomico un Tour che parte da Londra e poi sconfina in Belgio non mi provoca brividi particolari, lì si gioca per limitare i danni. Tanto vale saperlo prima, poi magari succede come a Eros Poli sul Ventoux, ma è meglio non farci troppo conto. A occhio, si comincia a ragionare verso l’11 luglio, dalle parti di Chablis, la solita pollastra a Bourg-en-Bresse, attenti e arroccati in Savoia, saltare Marsiglia perché c’è troppa confusione e comunque le migliori bouillabaisse si mangiano a Parigi. Possibili sorprese nella zona Castres-Albi, a Orthez vediamo se hanno tenuto in carta l’insalata di manzo bollito, patate (con la buccia) e scalogni e poi di corsa a Parigi. Dove il Tour si ricompatta per separarsi. E dove Guillaume entrerà da vincitore (se non cade prima, se regge la fatica). E dimagrito. Sarà interessante vedere lo spazio che strada facendo gli dedicheranno i giornali, Le Monde a parte. Molto su quelli provinciali e regionali, immagino, poco o nulla su quelli nazionali. Ma questo è un altro discorso. A Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 Da oltre trent’anni questo maestro del fotogiornalismo documenta la storia del Sudafrica, durante e dopo l’apartheid. In occasione della sua prima mostra italiana e della pubblicazione del suo libro, abbiamo chiesto a un grande scrittore di quel paese di raccontarci l’uomo che riesce a catturare in un dettaglio apparentemente inutile l’essenza stessa della nostra umanità David Goldblatt Il poeta del bianco e nero ANDRÉ BRINK essuno lo scambierebbe per una valigia ammaccata, abbandonata da un viaggiatore stanco alla fine di un lungo viaggio in treno. Ma ben pochi, a prima vista, riconoscerebbero in lui uno dei maggiori fotografi del mondo. Eppure in David Goldblatt queste due immagini convergono. E il segno rivelatore sta nell’intensità di quei suoi occhi di un azzurro profondo, a un tempo saggi e ammiccanti, testimoni di una lunga vita ma anche di una giovinezza irrefrenabile, pronta al divertimento e all’avventura. Ho incontrato David per la prima volta vent’anni fa in Sudafrica; mi aveva chiesto di posare per un ritratto ed è venuto a casa mia, a Grahamstown. Di quell’incontro, uno dei dettagli più vividi impressi nella mia memoria è la sua vecchia Leica sbeccucciata, tenuta insieme con un elastico — o almeno, così credevo di ricordare. Ma mi sbagliavo, come mi assicurò lui stesso qualche anno fa, in occasione di un incontro più recente a Cape Town. Indubbiamente le sue due Leica, al pari degli altri apparecchi fotografici che si trascina appresso, portano i segni di una lunga vita e di un uso intenso, ma non tanto da dover essere tenute insieme con l’elastico. E a pensarci bene mi sono reso conto che doveva aver ragione lui, dato che probabilmente gli sarebbe più facile sacrificare una parte del suo corpo asciutto e nervoso, piuttosto che una delle sue fotocamere. Quando ne parla o le maneggia lo fa con abilità e competenza, con rispetto e con cura, direi anzi con vero amore. Perché oltre a essere gli strumenti del suo quotidiano e duro lavoro, sono anche una sorta di estensione del suo essere, la conferma della sua esistenza corporea nello spazio e nel tempo, i custodi di quella profonda visione interiore che porta con sé, e che infonde nelle sue immagini quotidiane il senso di quanto vi è in esse di solitamente nascosto o sottaciuto, della loro vita segreta. Se è vero che uno scrittore, come disse a suo tempo Calvino, può dire quello che dice solo in virtù di quanto da sempre è rimasto non detto, ciò è anche più vero nel caso del fotografo David Goldblatt. In Sudafrica il suo recente libro Some Afrikaner Revisited è stato oggetto, all’indomani della sua pubblicazione, di violente critiche, e accusato di voler diffamare la storia e la moralità degli afrikaner; mentre oggi proprio chi lo ha più duramente attaccato ne riconosce il valore e addirittura gli rende omaggio per aver affrontato quel tema con un senso di verità implacabile unito a una comprensione profonda, che mai prima d’ora aveva trovato espressione su una pellicola fotografica. Riprendendo il concetto di Calvino, ciascuna di quelle immagini rappresenta una vita vissuta due volte: la prima è quella esposta e rivelata senza sconti né camuffamenti, impietosamente, seppure con compassione profonda; mentre l’altra è la vita interiore, dietro l’immagine e al di là di essa, percepibile solo con l’immaginazione, col senso profondo di un’umanità condivisa, della vulnerabilità e mortalità che ci accomuna tutti. Certo, mai nessun fotografo prima di Goldblatt ha saputo catturare la vita, i paesaggi e i popoli del Sudafrica con tanta profondità. Come il mio caro amico Naas ha scritto sulla copia di un altro libro di Goldblatt di cui mi ha fatto omaggio, On the Mines («Nelle miniere»), la sua opera «svela la bellezza nascosta del mondo, e ci fa vedere gli oggetti più familiari come se familiari non fossero». All’ultima mostra del fotografo, dal titolo Some Afrikaner Revisited, mi hanno particolarmente colpito le numerose foto scattate anni fa a Gamkas Kloof, una remota valle di montagna chiamata anche The Hell (L’inferno): una regione quasi inaccessibile, che ho scelto come punto di riferimento per il mio romanzo La valle del diavolo; e tra queste, la straordinaria immagine di una ragazza nella piena, innocente fioritura della sua pubescenza, la stessa foto scelta per la copertina del recente album che accompagna la mostra. E mi ha commosso sentire David parlarmi di questa ragazza, Ella Marais, e della sorella Bettie, per raccontarmi le tragiche vicende che hanno vissuto nei quarant’anni trascorsi dall’epoca di quelle prime fotografie. Il modo in cui si è interessato alla loro sorte nel corso di tutti questi anni è un N LA MOSTRA David Goldblatt inaugura la sua prima grande retrospettiva mercoledì 27 giugno a Forma, Centro Internazionale di Fotografia, Milano, piazza Tito Lucrezio Caro 1 David Goldblatt. Fotografie rimarrà aperta fino al 26 agosto Informazioni su www.formafoto.it IL LIBRO David Goldblatt. Fotografie, con un’introduzione di Martin Parr e testi di Rory Bester e Alex Dodd, è pubblicato da Contrasto Formato: 28 per 26 centimetri, 255 pagine, 155 fotografie a colori e bianco e nero, 60 euro. In tutte le librerie Informazioni su www.contrasto.it DALL’AUTORE DI LA CHIMICA DELLA MORTE UNA NUOVA INDAGINE PER DAVID HUNTER esempio della sua profonda umanità: per lui quelli che inquadra nel suo obiettivo non sono mai solo volti da fotografare, gente incontrata di sfuggita e subito dimenticata, ma persone, protagoniste di una storia, ciascuna con la sua intera biografia. È come se nel momento dello scatto il fotografo l’avesse riassunta nel suo insieme: il prima e il dopo di quell’attimo decisivo — gli sviluppi che hanno portato fin lì, e tutto ciò che da quel momento ha preso il suo corso. Allo stesso modo, ogni singola fotografia di un libro o di una mostra di David Goldblatt non riguarda solo un dato individuo o un ristretto gruppo di individui, ma porta il segno di tutta un’epoca, di una società col suo ethos e i suoi valori, le ramificazioni dei suoi rapporti sociali, culturali e morali. È questa la chiave del senso di responsabilità morale di David Goldblatt: come se in qualche modo si facesse carico, a ogni sua fotografia, di vigilare sul soggetto, sulle sue possibilità; come se si sentisse responsabile delle persone che incontra attraverso il suo obiettivo, e della sorte cui vanno incontro. Ecco perché l’immagine della valigia dimenticata che ho evocato all’inizio di questo breve saggio conserva tutta la sua forza: non è solo un bagaglio qualsiasi, ma l’inventario di un viaggio, il sommario di tutta una vita. Così nelle sue brevi contemplazioni — il minatore nero che emerge al sole dal buio del sottosuolo, duro e risplendente a un tempo; o il viso di un bambino che guarda il mondo con meraviglia; o la famiglia vestita a festa sulla via della chiesa, il picnic di un gruppetto su un prato, due giovani sposi il giorno delle nozze, una coppia di anziani curvi sotto il peso degli anni, che sembrano cedere il passo all’ombra incombente della morte; o ancora le rocce affioranti da una pianura brulla flagellata dal sole, o un fiore in anticipo sulla primavera — c’è sempre un senso di meraviglia davanti all’insondabile mistero dell’universo. Per questo, a prima vista i soggetti scelti da Goldblatt sembrano così «ordinari» (come la valigia abbandonata sullo scaffale), così banali e nient’affatto degni di nota. Ma è proprio attraverso l’atto di osservarli, di «prenderne nota», di isolarli dal contesto e dalle circostanze quotidiane che Goldblatt li pone al centro della sua attenzione concentrata e totale, quasi purificandoli, liberandoli dall’accidentale e dal superfluo per rivelarli nella loro essenza. Per gran parte della sua vita Goldblatt ha lavorato sul bianco e nero. Ho sempre pensato che rispetto alla fotografia a colori, la differenza sia parallela a quella che esiste in letteratura tra prosa e poesia. Nella poesia l’intero patrimonio delle risorse di una lingua è ricondotto all’essenziale, permettendo a ogni singola parola, isolata dai suoi appigli sintattici, di emergere in tutta la sua pienezza. Analogamente, un’immagine spogliata del colore può essere plasmata nella purezza della luce e dell’ombra e rivelare, attraverso l’esiguità stessa delle risorse, tutto il peso e il valore di quelle luci e ombre, costringendoci a un modo nuovo di vedere il mondo, letteralmente «in una luce diversa». È questa la visione dell’uomo che Platone fa emergere dalla caverna, quando vede il mondo per la prima volta. Il colore vi si «aggiunge» solo in un secondo tempo. Forse per questo Goldblatt ha evitato per tanto tempo la fotografia a colori. Per lui il colore era «un’aggiunta», qualcosa che non faceva parte integrante del suo mondo. Solo negli ultimi anni la disponibilità di mezzi più malleabili e versatili lo ha indotto ad appropriarsi della capacità di manipolare l’intera gamma dei colori con la stessa creatività, per far danzare con lo stesso virtuosismo ogni loro sfumatura. Eppure devo confessare che per me, sia che si tratti di un paesaggio o di un ambiente urbano, di un viso o di una figura umana, di una mano escoriata o di un sorriso innocente, della limpidezza dell’infanzia o della contusa saggezza della vecchiaia, il volto del vero poeta del bianco e nero, capace di sfrondare tutto il superfluo da un’immagine per rivelare l’essenza stessa dell’umanità e il posto che occupa in questo mondo inospitale, resterà sempre quello toccante e vero, ironico e schivo, asciutto ed essenziale del fotografo David Goldblatt. Traduzione di Elisabetta Horvat www.bompiani.eu Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 DONNA ELEGANTE DONNE DURANTE UNA PAUSA PRANZO DONNA CHE FUMA Joubert Park, Johannesburg, 1975 Pieter Roos Park, 1975 Johannesburg, 1975 DONNA CON BUCO ALL’ORECCHIO DONNA CHE RACCOGLIE MOLLUSCHI UOMO CON COLLANE Joubert Park, Johannesburg, 1975 Port St Johns, Transkei, 1975 Joubert Park, Johannesburg, 1975 DONNA CHE SI RIPOSA COPPIA AL GIARDINO BOTANICO BAMBINAIA De Villiers Street Park, Johannesburg, 1975 The Wilds, Johannesburg, 1975 Joubert Park, Johannesburg, 1975 NONNA E NIPOTE UOMO CHE DORME DONNA SUL SUO LETTO Transkei, 1975 Joubert Park, Johannesburg, 1975 Yeoville, Johannesburg, 1983 Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 la lettura Contatti con l’aldilà Un grande scrittore spagnolo ritrova in un vecchio libro la storia del bizzarro triangolo spiritista tra l’autore di “Cuore di tenebra”, la sua giovane vedova e Arthur Conan Doyle. E la confronta con una vicenda simile che lo vede protagonista insieme a una medium portoricana e al suo defunto maestro di letteratura e di vita Gli amabili fantasmi di Conrad e Benet JAVIER MARÍAS o spirito molestato di Conrad Qualche mese fa ho ricevuto da una libreria antiquaria un libretto del 1932, pubblicato dalla Mark Twain Society e scritto dalla vedova di Joseph Conrad. Il grande scrittore si era sposato con lei in età avanzata, a trentotto anni, quando Jessie ne aveva appena compiuti ventitré. Questo (e la barba che sfoggiava) spiega senza dubbio perché, durante la luna di miele sulla costa francese, un giovane ospite dell’albergo in cui alloggiavano — e che nella sala da pranzo, con un grosso tavolo comune su cui mangiavano tutti i clienti dell’hotel, aveva proprio il posto accanto alla sposina — un giorno avesse manifestato eccessive attenzioni per la ragazza, suscitando la diffidenza dello scrittore e mettendo a disagio la sposa. Finché, alla fine, il francese non decise di rivolgersi a Conrad, e dopo avergli fatto un inchino, gli domandò: «Signore, potrebbe concedermi l’onore di corteggiare sua figlia?». Fu la prima volta che Jessie Conrad dovette dissuadere suo marito dal battersi a duello lì, seduta stante. Dai due libri che scrisse su di lui dopo la sua morte si vede che la vedova di Conrad era una donna giudiziosa e dotata di senso dell’umorismo, e che lo aveva amato molto. In questo libretto raro, la donna spiega che nutriva una grandissima ammirazione per Conan Doyle, un po’ guastata, però, dal fatto che il creatore di Sherlock Holmes si fosse messo, nel 1929, a importunarla per via epistolare. (È risaputo, ahimè, che quel grandissimo scrittore, negli ultimi anni della sua vita — morì nel 1930 — si dedicò all’occultismo e allo spiritismo, trasformandosi conseguentemente in un gran rompiscatole.) Senza che ci fossero mai stati contatti in precedenza, Conan Doyle le scrisse per comunicarle che era sicuro che il suo defunto marito (Conrad era morto nel 1924) desiderava entrare in contatto con lei, e aggiungeva che per i morti un’impresa simile risultava piuttosto complessa se non potevano contare sull’aiuto dei vivi, perché anche loro, come noi, erano soggetti a delle leggi. Tramite una medium, assicurava il creatore di Sherlock Holmes nella sua lettera, Conrad aveva manifestato il desiderio che lui portasse a termine al suo posto un libro «di storia francese» che era rimasto incompiuto. Secondo Jessie, sir Arthur era assai male informato: un tema simile, così vago, non avrebbe mai stimolato l’interesse di Conrad, e soprattutto non avrebbe mai chiesto a nessuno, nemmeno a un insigne collega, di portare a termine in vece sua una sua opera. L La vedova di Conrad aggiungeva che anche altre tre persone avevano cercato, in seguito, di trasmetterle «messaggi» di suo marito, che lei si era categoricamente rifiutata di ricevere. Inoltre, il segretario di lord Northcliffe, lo stimato editore britannico scomparso nel 1922, aveva reso noto che l’autore di Cuore di tenebra stava aiutando il suo capo in un compito giornalistico, e che i due uomini indossavano abiti di flanella grigia e farfallini rossi. «Mio marito, per sua fortuna», commenta Jessie, «era dotato di sufficiente vanità personale da non avventurarsi a copiare lo stile di abbigliamento di sua signoria, quantomeno in simili dettagli!». E una nipote dello scrittore americano Stephen Crane, morto nel 1900, dichiarò che suo zio e Conrad si erano incontrati in mezzo all’Atlantico poco dopo la sua dipartita. Il massimo che Jessie conceda, riguardo a simili «fenomeni», è che a volte, sola nella sua camera, passa molte ore con la mente concentrata sul ricordo di suo marito, con lo sguardo fisso sulla sua poltrona preferita. E che durante quegli istanti di intensa concentrazione, le capita di vedere la sagoma di lui disegnarsi sulla poltrona. «Quella postura così familiare, quei tratti ben conosciuti, le mani serrate, sì, erano esattamente quelli che ricordo tanto vividamente. Questa visione è durata qualche secondo. Non si potrebbe spiegare, né cercherò di farlo, salvo che questa manifestazione era per me sola». Niente di particolare, direi io, i ricordi a volte possono esserlo estremamente. E al termine della breve opera conclude, giudiziosamente: «Vorrei essere lasciata in pace con la mia convinzione originaria, che quelli che amiamo e abbiamo perduto riposano in pace, senza che alcuna legge li disturbi, e senza che debbano soffrire per il dolore e l’inquietudine di noi che ancora soggiorniamo nella terra dei vivi». E lo spirito inverosimile di Benet Pochi giorni dopo aver ricevuto il libretto della vedova di Conrad, mi arrivò una lettera da Porto Rico, speditami da un’amabile lettrice e professoressa con cui mi ero incontrato qualche mese prima a Madrid. La signora, molto educata e sensata, affermava di non essere religiosa, semmai razionalista e piuttosto scettica, ma nonostante questo ammetteva di provare un certo interesse, negli ultimi anni, «per le tematiche spirituali». Per questo motivo si incontrava una volta al mese con una psicologa cubana «che a quanto sembra possiede facoltà spirituali». Apparentemente, la professoressa le aveva parlato del nostro incontro, e la psicologa, a quel punto, chiuse gli occhi e sembrò sperimentare una sorta di trance, e disse che una persona a cui io avevo voluto molto bene si trovava lì, che lo spirito si chiamava Benet e che sosteneva di manifestarsi per poter entrare in contatto con me. Si riferiva senza dubbio a Juan Benet, un mio “Io credo - scriveva Jessie Conrad - che quelli che amiamo e abbiamo perduto riposano in pace senza soffrire per noi” vecchio amico e uno degli scrittori spagnoli più stimati di tutto il Novecento. La psicologa aggiunse che vedeva Benet «che tirava i capelli a un giovane capellone, e che quel giovane era lei. Ha detto che Benet faceva questa cosa quando la vedeva triste o pessimista». (Non credo sia superfluo sottolineare che tra il 1970 e il 1974, nei primi anni in cui frequentavo Juan Benet, sfoggiavo una folta chioma, all’apache, per così dire, come attestano diverse mie foto.) Visto che continuavo a rimuginare su questa cosa, la mia interlocutrice epistolare decise di parlare con una sua amica, psicologa anche lei, e anche lei, a quanto sembra, dotata di «facoltà spirituali». Questa le disse che Benet si manifestava Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 ILLUSTRAZIONI DI GIPI L’AUTORE Javier Marías risiede a Madrid, in Spagna. È uno scrittore acclamato a livello internazionale. Ha pubblicato dieci romanzi, due raccolte di racconti e numerosi saggi Le sue opere sono state tradotte in 34 lingue, con vendite che sfiorano i 4,5 milioni di copie in tutto il mondo La sua pubblicazione più recente è Il tuo volto domani Marías tiene una rubrica settimanale sul quotidiano El País, dove è stato pubblicato originariamente questo articolo e sollecitava la sua intercessione per aiutare il mio «spirito incarnato». Aggiunse che «Benet era un saggio e sembrava avere un gran senso dell’umorismo, perché eseguiva una genuflessione prima di andarsene». La professoressa rimase attonita, e al successivo appuntamento con la psicologa, si sentì dire che Benet si trovava là e desiderava che io sapessi che lui si era manifestato e che voleva aiutarmi. Aggiunse che era morto con gran dolore, perché lasciava me, una persona che tanto aveva amato e che era importantissima per la sua vita. La mia interlocutrice mi chiedeva nuovamente scusa («Nonostante tutto, le spedisco questa lettera confidando che lei sappia che cosa devo fa- “Se mi raccontano che un morto che conoscevo bene mi ronza intorno, esigo che parli come parlava da vivo” re») e mi salutava, senza dare successivamente vita a niente che ricordasse neanche lontanamente l’insistenza quasi sfacciata del grande sir Arthur Conan Doyle nei confronti dell’afflitta Jessie Conrad. Lo scorso 5 gennaio sono passati quattordici anni esatti dalla morte di Juan Benet, un uomo da cui ho imparato molte cose, non soltanto in campo letterario, e con il quale ho mantenuto un’amicizia lunga più di vent’anni. Come scrittore, curiosamente, sono stati soprattutto i suoi detrattori a impedirgli di finire nel dimenticatoio. In tutto questo tempo, molti colleghi suoi e miei hanno continuato e continuano a inveire contro di lui. Dal momento che idiozia e insolenza spesso vanno a braccetto, la maggioranza di questi de- trattori sono scrittori semplicemente ridicoli. La sua ombra, evidentemente, deve crear loro un bel po’ di complessi. I suoi testi sono ostici e non potrei biasimare chi non senta il coraggio di cimentarcisi. Ma visto che ottusi e ottocenteschi sbraitano, continuino ad andare per la loro strada, e sarà questo il suo «contatto». Quello che non credo è che il suo spirito vada a manifestarsi a Porto Rico presso una delle psicologhe del luogo. Come l’assennata vedova di Conrad, sono del parere che quelli che amiamo e abbiamo perduto riposano in pace, senza che alcuna legge li disturbi». Riesco a immaginarmi Benet che si genuflette per gioco, ma non riesco assolutamente a immaginarmi un Benet che dice simili pacchianerie, o, tanto meno, che confessa quanto io sia stato importante nella sua vita: come ho risposto alla mia interlocutrice, lui fu importante nella mia vita, ma io non lo fui, in alcun modo, nella sua. Non credo nelle apparizioni né nei messaggi dall’oltretomba (salvo che nei racconti dell’orrore e nei sogni, che sono solo questo, però, bei sogni e racconti). Ma se mi vengono a raccontare la storia che un morto che conoscevo bene mi sta ronzando intorno, la prima cosa che esigo è che questo morto continui a parlare come parlava da vivo, senza propinarci inverosimili solennità che mai sarebbero comparse sulle sue labbra. Per favore: è proprio il minimo. Traduzione di Fabio Galimberti © 2007 Javier Marías Distribuito dal The New York Times Syndicate Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 L’ultimo Tarantino, “Grindhouse”, è il punto d’arrivo di un filone cinematografico made in Usa in cui ci si insegue, ci si sfida, si amoreggia, si fanno acrobazie, ci si salva o ci si danna, insomma si sopravvive o si muore sempre a bordo di automobili. Un film che fa il verso ai B-Movie ma che dà l’opportunità di ricostruire - da James Dean a Steve McQueen, da “Duel” a “Thelma e Louise” lo specialissimo rapporto che lega l’America alle sue “macchine infernali” SIEGMUND GINZBERG on saprei dire se gli androidi sognino pecore elettriche, come si chiedeva il titolo del romanzo di Philip K. Dick da cui venne tratto Blade Runner. Ma so esattamente cosa sogna l’America: sognano automobili, un gigantesco autoscontro, un luna park con emozioni non stop al volante da una costa all’altra degli Stati uniti, forse da un polo all’altro del pianeta. Sono andato al cinema a vedere Grindhouse, e ho avuto una specie di illuminazione: il film di Quentin Tarantino mi ha ricordato, con qualche pugno allo stomaco, ma anche con parecchio humour, qualcosa che in fin dei conti avevo sempre saputo, ma forse non mi veniva con tanta evidenza. Donne e motori, certo non è una passione solo americana. Ce l’ha nel sangue tutto l’Occidente, così come il Giappone può avere nel sangue i samurai e la Cina le arti marziali. Ma è in America che ha raggiunto vette inarrivabili. Sono di una generazione che andava al cinema da prima ancora che ci fosse la tv. Ho sempre prediletto i film d’azione. Da bambino mi colpiva, mi pare anzi mi infastidiva un po’ che non ci fosse film, di qualsiasi genere, in cui non ci fosse una storia d’amore, o almeno una scena di bacio. Molto più tardi, negli anni in cui vivevo in America, mi colpì che non ci fosse film americano in cui non ci fossero scene di inseguimento con automobili, di scontri di automobili, di delitti in cui c’entra l’auto, di acrobazie in automobile, in cui insomma non fosse co-protagonista l’automobile. Con l’eccezione dei soli western, in cui l’automobile si chiama però cavallo. Si amoreggia in auto, si soffre e si gode in auto, si gioca con l’auto, ci si salva con l’auto, ci si danna in auto, si ammazza in auto e con l’auto. In auto avevamo incontrato sullo schermo la “generazione maledetta”, appreso del gioco tra gang su chi sterza prima dello scontro frontale, e in un incidete d’auto era morto James Dean, il protagonista di Rebel whitout a cause. Era stata la Mustang Gto a immortalare Steve McQueen in Bullitt, più che viceversa. Erano auto a due ruote le moto di Easy Rider. Ogni film un modello. Le Aston Martin per James Bond, l’Alfa spider per Dustin Hoffman ne Il laureato, una Thunderbird convertibile per Thelma e Louise. Un classico taxi newyorchese per Taxi Driver, il cinegenico modello panciuto con cui si continuarono a girare film per decenni, anche per molto tempo dopo che di quei modelli non ne circolavano più per le strade di New York. Ogni generazione americana ha avuto i modelli in cui identificarsi, con cui giocare all’autoscontro e all’inseguimento ad alta velocità. In genere, come conviene ad una nazione altamente patriottica fino al midollo (nel mondo moderno sono rimasti oramai solo due grandi “patriottismi” viscerali, con convinzione di massa, quello americano e quello cinese, quelli europei, per fortuna o per disgrazia non ci sono più, o sono una pallida ombra del nazionalismo Usa e cinese), su modelli made in Usa, ma qualche volta, nei momenti in cui l’America aveva i blues, su modelli d’importazione. Ronin, di John Frankenheimer, con Robert De Niro e alcune delle migliori scene di inseguimenti e scontri automobilistici degli ultimi anni, aveva praticamente lanciato la Audi. Nei film americani si sono visti talvolta nei ruoli principali Mercedes, Bmw, un famoso maggiolino Vw, e virtuose Mini Morris, ma mai un’auto giapponese, SULLO SCHERMO/1 N IL LAUREATO Il Duetto Alfa Romeo rosso conquista Hollywood grazie a Dustin Hoffman nei panni di Benjamin Braddock nel film Il laureato di Mike Nichols. L’anno è il 1967, corse in auto al ritmo di Mrs Robinson di Simon & Garfunkel BULLITT Steve McQueen, che le auto le amava alla follia anche nella vita privata, è Bullitt nel film del 1968 diretto da Peter Yates Una caccia a killer e mafiosi per le strade di San Francisco a bordo di una Ford Mustang Il sesso, la morte e i film trita-auto American TAXI DRIVER Per calarsi nel personaggio di Travis Bickle, Robert DeNiro, con la solita furia maniacale, ha guidato un taxi per un mese. È il 1976, il simbolo giallo di New York è protagonista nel capolavoro di Martin Scorsese Cars Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 ‘‘ ‘‘ ‘‘ - La Cadi, dov’è la Cadi? - L’ho data via per un microfono - Per un microfono!? Hai dato via la Cadi per un microfono? Bene, hai fatto bene Era nuova di zecca, aveva l’odore delle macchine nuove Che è poi il miglior profumo del mondo, a parte quello di donna Lisa: Papà, abbiamo fatto una cosa terribile! Homer: Avete sfasciato la macchina? Bart: No! Homer: Avete resuscitato i morti? Lisa: Sì! Homer: Ma la macchina sta bene? Lisa: Ahah. Homer: Allora tutto ok John Belushi e Dan Aykroyd THE BLUES BROTHERS (1998) George LeBay CHRISTINE (1983) The Simpsons LA PAURA FA NOVANTA III (1992) una Mitsubishi o una Toyota. Anche noi abbiamo avuto auto mitiche, che rappresentavano un’intera epoca, la Topolino, la Seicento, la Cinquecento, la decappottabile del Sorpasso, guidata da Vittorio Gassman, una metafora degli anni ruggenti e insieme insipidi del miracolo economico, rivista in tv qualche sera fa. Ma, andiamo, chi farebbe oggi un film con protagonista un nuovo modello Fiat? Le nazioni hanno momenti di calo, come le marche e i modelli d’auto. Sono una Mustang modificata e una mitica Dodge Challenger, bellezze degli anni Sessanta, ma in realtà senza tempo, simboli dell’America al meglio, le auto star in quest’ultimo film di Tarantino, che in qualche modo riassume ironicamente un intero mondo di passione per il car chase e il car crash. Passione piena, senza limiti, irrefrenabile, come sanno esserlo solo le passioni infantili. Grindhouse è un titolo che fa venire in mente il tritatutto, tritacarne. È, ho letto da qualche parte, il modo in cui venivano chiamati i cinema decaduti, dove ti offrivano con lo stesso biglietto due film al posto di uno. In effetti così si intitola l’accoppiata del film di Tarantino, che si intitola Deathproof, a prova di morte, e di quello del suo amico Robert Rodriguez, che si intitola Planet Terror. Io mi sono sentito defraudato, perché, a differenza che in America, dove l’accoppiata viene proiettata insieme, un film dopo l’altro, nelle sale italiane con lo stesso titolo vi fanno vedere un film solo. Ma non è di questo che volevo raccontarvi. Ho letto che Grindhouse farebbe il verso ai film “di serie B”, quelli dozzinali che non andranno mai nei cinema d’essai, così come Pulp Fiction lo faceva alla letteratura popolare all’ingrosso, da fumetto. A parte che non bisognerebbe mai sottovalutare la “serie B” (ricordo male, o anche Totò e gli spaghetti western di Sergio Leone venivano considerati di serie B rispetto ai “film d’autore”?), mi sono fatto l’idea che faccia il verso ad uno dei cardini del modo di essere, della cultura americani. Come è impossibile immaginare il Far West senza cavalli, e il grande decollo industriale Usa della seconda metà dell’Ottocento senza le ferrovie transcontinentali, è inimmaginabile l’American way of life senza automobile. Chissà perché dicono «american as the apple pie». Dovrebbero dire «american as the automobile». Che il vecchio Henry Ford abbia inventato modello T e catena di montaggio proprio per costruire automobili può essere una coincidenza (era anche un antisemita pazzesco, da dar lezioni a Hitler, ma non per questo l’America è divenuta nazista). Non può essere solo coincidenza, invece, che dagli anni Venti e Trenta in poi l’automobile sia diventata non solo simbolo di libertà, di movimento nei grandi spazi, ma un vero e proprio “modo di vivere”. «Status symbol, icona religiosa, feticcio erotico, insomma quasi un oggetto “non di questo mondo”, sempre più voluttuoso e carnoso, quasi fosse sull’orlo dell’orgasmo», è il modo in cui ne scrisse Lewis Mumford. Era uno che già agli inizi degli anni Sessanta aveva intuito molte cose. Compresa l’idea dell’automobile americana che evoca eros e thanatos, sesso e morte, piacere e dolore. Arrivò a definirla addirittura come «result of a secret collaboration between the beautician and the mortician», frutto maledetto di una sorta di patto segreto di collaborazione tra salone di bellezza e pompe funebri. Erano gli anni in cui le auto americane erano tutte cromature, curve inutili e siliconate, pacchianerie di stile, gadget, senza alcuna o pochissima considerazione per la sicurezza. Venivano reputate bare su ruote. Ralph Nader era diventato famoso, aveva lanciato una lunga e fruttuosa carriera di contestazione con un libro di denuncia dell’industria dell’auto Usa, in particolare del modello Corvair della Chevrolet: Unsafe at Any Speed, pericolosa a qualsiasi velocità è il titolo del bestseller. Non è più così, nei decenni successivi costruttori di auto americani si sarebbero dati molto da fare per la sicurezza. Ora i loro modelli non dovrebbero più fondarsi per la sicurezza di guidatore e passeggeri solo sul prin- SULLO SCHERMO/2 THELMA & LOUISE Due donne in fuga dal loro passato e da un’accusa di omicidio. Susan Sarandon e Geena Davis dirette da Ridley Scott (1991) attraversano gli Stati Uniti su una Thunderbird decapottabile del 1966 CARS La giovane auto Saetta McQueen, astro nascente delle corse, giunge in una piccola città di provincia abitata da auto semplici che hanno capito che la vita non è solo correre. È la magia Disney/Pixar del 2006 FOTO WEBPHOTO GRINDHOUSE L’ultima adrenalinica e a tratti splatter fatica di Quentin Tarantino. Ragazze, corse in auto, omicidi in stile B-Movie anni Settanta Le auto sono una Dodge Charger del 1969 e una Dodge Cahllenger del 1970 cipio del carro armato (il peso e la quantità di acciaio impiegato). Ma allora, perché il boom imperterrito degli Sport Utility Vehicle? Solo perché più comodi e perché la benzina costa ancora così poco? Certo ci sono gli airbag, ci sono limiti di velocità più severi che in Europa, in teoria al guidatore non sarebbe consentito nemmeno un bicchiere di vino o birra ai pasti. Eppure, ogni anno continuano a morire in incidenti stradali più americani di quanti ne siano morti nella guerra di Corea e in quella in Vietnam, dieci, venti, trenta volte quanti ne sono morti sotto le Torri gemelle o nelle guerre in Afghanistan e Iraq insieme. La prima vittima si era avuta a New York, una tranquilla sera di fine estate, il 13 (non 11) settembre 1899, quando un broker di Wall Street, Henry H. Bliss, fu falciato da un tassì mentre scendeva dal tram che allora percorreva l’8th avenue. Da allora, nel secolo e passa successivo, si calcola che solo i pedoni travolti dalle auto siano stati in America quasi tre milioni. Le vittime in scontri tra veicoli, ovviamente molti di più. Più di quelli ammazzati con la pistola o il coltello, incomparabilmente più delle vittime delle bombe o del terrorismo. Secondo alcune stime, gli incidenti stradali sarebbero già oggi la principale causa dell’aumento dei decessi non correlati a malattie trasmissibili, insomma un killer che tallona cancro e malattie cardiache. Nel film di Tarantino, l’arma del serial killer è un’automobile da stuntman, modificata e rinforzata in modo da garantire la sopravvivenza del guidatore anche in caso di scontro frontale. Per questo la chiamano “deathproof”. Un’altra automobile è l’arma con cui si difenderanno e lo puniranno le ragazze che avrebbero dovuto essere le sue nuove vittime prescelte. L’auto è uno strumento di aggressione, ma anche di esibizione sessuale. La compiacenza sul sangue, le mutilazioni e la carne trita è quella solita, fosse tutto qui non varrebbe nemmeno la pena di prender nota di una sorta di Kill Bill 3 in cui la strage avviene a colpi di lamiere contorte anziché di spada da samurai o arma da fuoco. La novità non è nemmeno l’inseguimento e l’autoscontro, anche se l’autore si vanta di aver girato tutto alla vecchia maniera, dal vero, e non con i soliti trucchi fatti al computer. L’idea di usare una vera stuntwoman australiana per il gioco del cavalcare sul cofano un’auto lanciata a piena velocità è buona, aggiunge molta adrenalina al solito gioco dell’autoscontro, evoca un po’ Europa in groppa al Toro, un po’ la cavalcata di Lady Chatterley, un po’ il supplizio di Mazzeppa nel poema di Byron. Ma tutto questo non basterebbe a dare senso ad un “B-Movie” dichiarato se non ci fosse anche questa faccenda del rapporto particolare tra l’America e le sue automobili. Senza contare che in America l’auto è anche spettacolo, più che in qualsiasi altra parte del mondo. Gli eventi sportivi organizzati dal Nascar (National Association of Stock Car Automobile Racing) hanno oltre dieci milioni di spettatori diretti ogni anno, settantacinque milioni di fan che seguono regolarmente gli eventi, centocinquanta milioni se si contano anche quelli che vi assistono anche saltuariamente sugli schermi tv. Si stima che per seguito le corse d’auto (auto modificate ma somiglianti a quelle che circolano sulle strade, non da fantascienza come le Formula 1) vengano giusto dietro il football americano, ma prima del basket, del baseball e del wrestling, molto prima del calcio, che chiamano soccer e resta una raffinatezza all’europea per pochi intenditori. Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 i sapori Magri, belli, sani: tutto merito del latte cagliato che - acidissimo, cremoso o corretto con zucchero, miele o muesli - consumato quotidianamente assicura vitamine e fermenti al nostro organismo La sua è una storia alimentare lunghissima che affonda le proprie radici nell’antica India degli yogi. Ottomila anni fa l’avevano Oltre il latte battezzato “cibo degli dei”, oggi il consumo continua a crescere La yogurtiera Di forma rotonda o quadrata, la yogurtiera è un contenitore con coperchio che scalda i vasetti contenuti, da sei a dieci, per il tempo (da tre a sei ore) e ai gradi necessari (35-40°) A partire da fermenti secchi (in vendita in farmacia) o da uno yogurt (intero, non zuccherato, possibilmente di pecora, a garanzia di un risultato cremoso) si miscela a temperatura ambiente con latte lasciato sobbollire per un quarto d’ora e fatto intiepidire (40°). Poi, riempiti i vasetti, si accende la yogurtiera. Dopo lo spegnimento automatico, lasciate riposare i vasetti in frigo Intero 7,4% l’aumento del consumo nell’ultimo anno Il latte di partenza è intero, ovvero con un contenuto di grassi non inferiore al 3%. Può essere bianco – il più semplice – con o senza zucchero, addizionato di frutta, aromi, muesli È il più usato nella preparazione di torte, gelati e dolci al cucchiaio LICIA GRANELLO agri, belli, sani, virtuosi: tutto merito del latte cagliato. Impossibile trovare un altro alimento così carico di benemerenze. Bisognerebbe farci il bagno, nello yogurt: corpo, viso, capelli ne guadagnerebbero assai. E mangiarlo con regolarità, per ritrovare, come un filo d’Arianna, tutti i fermenti smarriti per colpa di diete sbagliate, stress incombenti, ambienti inquinati. Abbiamo faticato un poco a farcelo piacere, perché il gusto acido non è tra i più praticati della nostra cucina. Ma alla fine, tra aggiustamenti, trucchi e un po’ di coscienza alimentare in più, siamo riusciti ad adottarlo come un felice passe-partout della cucina estiva. In più, il faida-te è semplice, economico e allegro, l’inserimento nelle ricette variegato e curioso, i margini di tolleranza digestiva ampi, l’appetibilità per grandi e piccini accertata. Da quando, nei primi anni del secolo scorso, lo scienziato russo Ilya Metchnikoff, avviato uno studio sulla longevità del popolo bulgaro, venne folgorato dall’intuizione che lo yogurt fosse la causa di tanto buon invecchiare, la sua diffusione ha avuto un incremento esponenziale. Metchinikoff, battezzato “bulgaricus” il lattobacillo principale responsabile della fermentazione, ci scrisse un libro sopra, intitolato L’allungamento della vita, dove sosteneva che lo yogurt consumato quotidianamente, grazie al suo apporto di batteri buoni, era da considerarsi una sorta di elisir di eterna giovinezza. Una scoperta che gli valse il premio Nobel. Del resto, lo yogurt è citato come simbolo di alimentazione sana nei testi Ayurveda indiani datati ottomila anni fa. Allo stesso modo, molti secoli prima di Cristo gli yogilo avevano battezzato «cibo degli dei». Un’eredità alimentare ben corposa, se è vero che gli indiani sono tuttora infaticabili consumatori di yogurt, che traducono in salse, condimenti e nei gustosi lassi, la bevanda nazionale indiana realizzata con yogurt, acqua (in quantità dimezzata), ghiaccio, spezie o frutta a piacere. Il problema è che esiste yogurt e yogurt. Al supermercato, restiamo incantati e confusi davanti alle scaffalature dove, allineati con implacabile disciplina, centinaia di vasetti promettono mirabilie. Scelta difficilissima: abbassare il colesterolo e ridurre gli zuccheri, far pace con l’intestino pigro o stroncare l’acne giovanile? Nudo e crudo, lo yogurt è irreprensibilmente benefico: il lattosio, scisso dalla fermentazione in zuccheri più semplici (glucosio e galattosio), e i lipidi omogeneizzati risultano altamente digeribili, le proteine contengono tutti gli aminoacidi essenziali, le vitamine del gruppo B proteggono fegato e intestino, l’acido lattico favorisce l’assorbimento di calcio e fosforo, i lat- M Yogurt Elisir di lunga vita tobacilli favoriscono il ricambio della bile, incrementano la produzione di acido folico, migliorano la microflora intestinale. Il resto, lo garantiscono gli optional, equamente divisi tra plusvalore semi-terapeutico e irresistibile golosità. Convinti di regalarci un francobollo di salute, spesso ingoiamo chimica travestita da cibo salutare, tra aromi e coloranti, zuccheri nascosti e frutta col contagocce, senza nemmeno l’alibi dell’economicità: quattro-cinque euro al kg, quasi mai sapendo da dove arriva il latte. La ribellione alla dittatura del vasetto industriale passa dalla yogurtiera, che garantisce ottimi yogurt fatti con tutti i vostri ingredienti preferiti, dal latte biologico al vero muesli integrale. Se invece l’autoproduzione vi atterrisce, organizzate una gita a Vipiteno nelle settimane centrali di luglio, per partecipare all’Olimpiade dello yogurt, con degustazioni a occhi bendati, visita alle latterie sociali (comprese quelle di Merano e Bolzano) e cene dedicate. Verrete trasformati in veri Highlander del probiotico. Da bere La versione fluida si ottiene grazie a rottura del coagulo e successivo passaggio al setaccio fine. Quasi sempre l’appetibilità passa da aromi e dolcificanti Liquido ma diverso il kefyr, di origine caucasica, che oltre ai fermenti vanta la presenza di lieviti Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 Borgo San Lorenzo (Fi) Vipiteno (Bz) itinerari Antonio Palmieri è l’appassionato proprietario di “Vannulo”, caseificio-culto all’ombra dei templi di Paestum. Il latte lavorato (crudo e biologico) proviene dalle bufale allevate in azienda. Mozzarella, ricotta e yogurt da soli valgono il viaggio Presenzano (Ce) Fascino medievale e ospitalità a 360 gradi per l’antica Vipitenum Sterzen (terreno di Starzo) Il paese - i tre quarti dei suoi abitanti sono di madre lingua tedesca è inserito tra i borghi più belli d’Italia. La sua latteria sociale è famosa per l’alta qualità di yogurt e burro Intitolato alla pieve di San Lorenzo, è uno dei borghi della conca del Mugello, alle spalle di Firenze Campi e stalle gestiti con sapienza garantiscono produzioni di alto livello, a cominciare da latte, yogurt e formaggi con il marchio Mukki Mugello Appoggiato a mezza costa nell’alta valle del Volturno, fa parte di uno dei due poli campani dell’allevamento di bufale. In scia all’eterna lotta tra Caserta e Salerno per la supremazia della mozzarella, nei caseifici si producono yogurt gustosi e cremosissimi DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE AQUILA NERA-SCHWARZER ADLER (con cucina) Piazza Città 1 Tel. 0472-764064 Camera doppia da 110 euro, colazione inclusa LOCANDA DEGLI ARTISTI (con cucina) Piazza Romagnoli 2, Tel. 055-8455359 Camera doppia da 110 euro, colazione inclusa In estate sempre aperto, menù da 30 euro AGRITURISMO BOSCO FARNETO (con cucina) Bosco Farneto Tel. 0823-989506 Camera doppia da 60 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE PRETZHOF Località Tulve Tel. 0472-764455 Chiuso lunedì e martedì, menù da 35 euro COLLEFERTILE (con camere) Località La Sughera Frazione Arliano Tel. 055-495201 LE DUE TORRI (con camere) Via Venafrana Km 4700 Tel. 0823-989518 In estate sempre aperto, menù da 30 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE LATTERIA COOPERATIVA VIPITENO Via Passo Giovo 108 Tel. 0472-764155 COOPERATIVA EMILIO SERENI Via La Brocchi 27 Tel. 055-8459100 CASEIFICIO LA FENICE Via Vadopiano 5, Presenzano Tel. 0823-989318 2,2 Cremoso La tecnica prevede una maggior accuratezza nel rimescolare, omogenizzando il composto Più semplice e golosa l’aggiunta di panna (quasi sempre senza percentuale in etichetta) La definizione “crema di yogurt” evita i vincoli normativi i miliardi di vasetti acquistati ogni anno Scremato Preparato con latte la cui percentuale di grassi non supera l’1%. Esiste anche in versione parzialmente scremata, con un contenuto lipidico che varia tra l’1,5% e il 2% Può essere arricchito come l’intero e zuccherato con dolcificanti Alla frutta Arricchito con frutti singoli o miscelati (anche con verdure) a pezzetti, frullati, spesso con aromi Coloranti e conservanti supportano o sostituiscono la frutta. Il contenuto medio varia intorno al 10%, pari a pochi grammi per vasetto Probiotico 75 le calorie in un vasetto di yogurt intero La trovata dei pastori migranti Allo streptococcus termophilus e al lactobacillus bulgaricus, vengono aggiunti altri fermenti egualmente capaci di svilupparsi alla temperatura del corpo e resistenti agli acidi gastrici Tra le loro funzioni: proteggere l’intestino e alzare le difese CORRADO BARBERIS o yogurt sta al formaggio come il chiaro di luna sta all’amore: avendo del chiaro di luna il frescore, la volatilità, l’opalescenza. Se non vi fossero altre ragioni, politiche, a consigliare l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea, basterebbe la paternità dello yogurt a perorare la causa. Paternità culturale, come attesta l’etimo: da yogurmak, mescolare, impastare. Non necessariamente anche biologica. Tanto Plinio (XXVIII, 133) quanto Columella (XII, 8) ricordano il greco oxygala, latte acido insaporito di varie erbe antesignane dei pezzetti di frutta spesso natanti nelle nostre confezioni. E in Sardegna — altra terra di pastori migranti come i turchi — abbiamo tuttora, bovino ed ovino, su gioddu, la cui madre, come descrive il Dizionario geografico storico statistico commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna, pubblicato a Torino nel 1824, era ottenuta facendo fermentare pane nel succo mammario, in attesa di essere aggiunta ad una massa di latte bollito grazie all’immissione di ciottoli arroventati. Un vero trionfo del folclore, oggi semplificato. Paternità culturale, ripetiamo. Infatti, se il prodotto appartiene ad una vena profonda della civiltà mediterranea — quasi una sorta di carsismo gastronomico che qua e là affiora — non ci sono dubbi che a imporlo all’attenzione europea è stata la Turchia. Allo stesso modo che, per il diritto naturale, il padre non è il donatore del seme ma l’individuo additato da giuste nozze, anche lo yogurt vede nei turchi i padri additati da una giusta storia. Perché, nell’immaginario di molti, lo yogurt nasce bulgaro tanto che i suoi fermenti sono detti bulgarici? Perché la Bulgaria è stata, fino alla seconda metà dell’Ottocento, una provincia turca. E perché, entrando in un supermercato, la più raffinata delle confezioni esposte è quasi sicuramente greca? Perché svariati se- L Aromatizzato Magro o intero, si caratterizza per la presenza di cereali, nocciole, caffè, vaniglia, malto, cioccolato. Quasi sempre, si tratta di aromi di sintesi La dicitura “naturali” consente comunque di replicare sostanze naturali con metodi chimici coli di dominazione ottomana hanno consentito agli Elleni di acquisire tutti i segreti del mestiere. A distanza di quasi duecent’anni il regalo dell’arte yogurtina risolve (se non assolve) i massacri di Scio immortalati nel quadro di Delacroix al tempo della guerra per l’indipendenza. Dopo un lungo periodo di gastronomico carsismo il prodotto emerge all’attenzione europea nel 1542. Francesco I, galante Re di Francia, era caduto in uno stato di prostrazione dal quale non riuscivano a sollevarlo i medici abituali. Fu allora che il suo ambasciatore presso la Sublime Porta gli segnalò un medico ebreo di Costantinopoli che faceva miracoli con latte di pecora rappreso in un certo modo. Fu fatto venire a Parigi, a piccole tappe, per restare unito al suo gregge: che, guarito il re, fu invece abbattuto dal rigore dell’inverno europeo. Passarono altri tre secoli prima che Théophile Gautier, il delicato cesellatore di Smalti e cammei, decantasse le esposizioni a vento aperto di questo latte cagliato nelle vie di Costantinopoli. L’Oriente si fa moda. Finché, nel 1919, ecco sorgere a Barcellona il primo stabilimento industriale, con un’etichetta ancora oggi ben nota: Danone. Da allora la corsa allo yogurt, ormai bovino, non conosce soste. Con una accelerazione davvero incalzante. L’Ismea calcola che tra il 1999 e il 2006 i consumi italiani sono saliti da 352 a 497 migliaia di tonnellate, da 6,1 a 8,5 chilogrammi pro capite. Con qualche conseguenza sulla nostra bilancia dei pagamenti, le importazioni essendo cresciute dal 20 al 40 per cento, nonostante i progressi dell’industria nazionale. Ma è uno scotto da pagare volentieri, visto che lo yogurt, promuovendo lo sviluppo della flora intestinale, fa delle nostre trippe i giardini pensili della salute. L’autore è presidente dell’Istituto nazionale di sociologia rurale Compatto Tipico della Grecia, di consistenza quasi soda, simile a un formaggio fresco, viene preparato come quello fluido. Una volta completata la fermentazione, però, si fa “sgrondare” facendo colare il siero dentro una garza tenuta in frigo per qualche ora Repubblica Nazionale 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze Moda virtuale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 Erano poche centinaia nel 2002, quando questo aldilà digitale fu ideato Oggi sono sette milioni e mezzo i residenti di Second Life, un altro mondo dove la creatività è un must e che esprime uno stile spesso eccessivo, impudico, carnevalesco. E adesso gli avatar made in Italy per la prima volta si incontrano (dal vivo) a Pistoia per confrontarsi Farò il replicante ma cosa mi metto? ALESSANDRA RETICO ra vogliono guardarsi negli occhi, la doppia vita non basta. L’orgoglio avatar fa coming out, scende in piazza a Pistoia per il primo raduno dei residenti italiani (virtuali) su Second Life, il gioco online in 3D che definirlo così è ormai solo una prudente convenzione. Il 18 luglio nel parco dell’Aringhese di Montale ci saranno gli alter ego della terza dimensione con i loro corpi, visi, nomi; e un concerto di Freccia Lane, alias Irene Grandi, che ha girato su SL il video del suo Brucia la città, attori-avatar arruolati dalla Ibridarte, l’isola-azienda creata della Pim che è anche il marchio dell’evento pistoiese. Mario Gerosa, giornalista di Architectural Digest, pioniere di mondi virtuali con Second Life (Meltemi), prima guida-saggio sull’argomento, dice: «Conviene tenere conto dei social network come SL, non sono solo un doppio ma un’alternativa concreta del fare e dell’essere». Gli oltre 7,5 milioni di residenti di quell’aldilà digitale lo sanno bene che significa inventarsi un’altra identità e poterci fare tutto. E che piacere sia una vita priva di scopo, senza timbrare cartellini ma anche senza ammazzare mostri e conquistare reami. Al posto di doveri, molte opportunità: di creare, divertirsi, fare soldi (1,6 milioni i dollari scambiati in media ogni giorno). E dire che erano poche centinaia gli utenti nel 2002 quando la Linden Lab di Philip Rosedale a San Francisco si è inventata questa patria di replicanti, di altri, di rovesci. Tutto attorno inchieste, studi, e una fitta manualistica perché andare dall’altra parte è un’avventura complicata. Second Life, guida turistica essenziale si chiama il vademecum degli inglesi Paul Carr e Graham Pond (Il Saggiatore). Second Life, la guida ufficiale è il testo di riferimento di Repubblica-L’Espresso, scritto dai residenti di SL e dai tecnici della società madre californiana. Orientarsi, per perdersi meglio: in questo altrove è necessario uno smarrimento consapevole, la più feconda condizione creativa. Oltre la retorica tecnoutopica, SL è diventato l’universo parallelo non solo mimetico, ma anche fortemente demiurgico. Una vita altra, soprattutto una vita espressiva. Tra le molte professioni degli avatar, da animatore di night a organizzatore di matrimoni, da paesaggista a sviluppatore di abbracci, da agente immobiliare a investigatore privato, non a caso abbondano i designer di oggetti e di moda. Vestire, abbigliare, travestirsi: finalmente lì si può eccedere, esagerare, giocarsi un ruolo. Sessualità ambigue, soprattutto corpi e accessori impudicamente esorbitanti, spettacolari, carnevaleschi. Nella varietà e diversità sociale di SL, la creatività è praticabile, l’utopia d’essere autori accessibile. Qui la dittatura del brand è fragile, le grandi corporation tra cui Reebok, Toyota, American Apparel, Ibm e altre che ormai da anni hanno aperto vetrine per pubblicità, non possiedono più appeal di un qualsiasi Pirandello (cognome parecchio diffuso “in-world”) che apra bottega. Gli stili in circolo spiegano il resto. Gerosa: «Il fetish va molto, perché è la metafora di qualcosa che manca, la pelle e il latex simulano una sensualità che nel virtuale è sorda, priva di appigli sensibili». C’è anche molta classicità, romanticismo e demodè, citazioni dai Sessanta e Settanta, ma sono le sottoculture a emergere, tutto l’immaginario pop del cinema e dei manga giapponesi, il selvaggio, il cyberpunk, il gotico, il vampiresco, l’estetica dei videogame. Le molte riviste specializzate come Second Style e i blog dei creativi come quello di Ginny Talamasca (Dazzle Haute Couture), danno indirizzi: per qualcosa di sobrio, Shiryu Musashi o Rebel Hope Design, street style da Form di Zabitan Assia, molto trendy Nocturnal Threads di Kaia Ennui (alias Calan Ree), jeans a vita bassa e ali (perché in SL si vola, ovvio) nella boutique di Toni Barrett a Butterfly Island, il draculesco da Mistress Midnight, stilista assai in voga almeno come Aimee Weber (Alyssa LaRoche). Secondi corpi e seconde pelli. Non solo il sogno americano rivisitato in digitale, ma il riflesso luccicante della vita, la tentazione del doppio di sempre. O Gli stilisti e gli atelier che vestono le “seconde pelli” amano le sottoculture e dunque dominano il pop, il cyberpunk, i manga, il selvaggio, il gotico-vampiresco I LOOK PSICHEDELICO Suggestioni anni Settanta nei pantaloni a zampa d’elefante, nei top optical e nelle stampe a fiori e psichedeliche delle collezioni di Vitamin Ci, disegnate dall’avatar Ciera Bergman Cultura pop molto in voga su SL NEOROMANTICO CITAZIONISTA MANGA Si ispira alla Russia di Anna Karenina il mantello nero di Ookami Ningen, rintracciabile nella boutique Dark Eden Plaza, Indigo. Vestito neoromantico firmato House of Zen Hinode Shima Un po’ Parigi anni Trenta, un po’ Katharine Hamnett: incrocio di stili e citazioni sono frequenti nei designer di SL A destra: modello di Meekal e AliciaKay Kilara, si trova da A Touch of Ireland Hatchet, Cove Fumetti, manga, bambole, gadget: gli avatar di SL amano vestirsi come i personaggi dei comics giapponesi Qui, una creazione del marchio Tweet, che risponde al nome dell’avatar Sumire Mochi La linea è pensata per teenager e donne Repubblica Nazionale DOMENICA 24 GIUGNO 2007 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 51 7,5 milioni 1,6 milioni 50mila 75% Sono circa 7,5 milioni i residenti in Second Life: in due mesi più di 1,7 milioni i nuovi iscritti Si calcola che siano circa 50mila i residenti italiani nel mondo virtuale in 3D LA GUIDA Con la Repubblica e L’Espresso la guida ufficiale di Second Life, scritta dai residenti e dai tecnici della Linden Lab, proprietaria del gioco in 3D. Tradotto per la prima volta in italiano, il manuale orienta nel mondo online con le risposte e i consigli pratici per costruire il proprio personaggio, l’avatar, per esplorare un universo in continua espansione e per realizzare veri profitti con il lavoro dei propri sogni Il volume conta 360 pagine a colori, si compone di 13 capitoli tematici divisi in tre parti e di 4 appendici: prezzo 7,10 euro Nel giro di 24 ore su SL vengono scambiati in attività commerciali oltre 1,6 milioni di dollari Usa Circa il 75% dei residenti ha acquistato almeno un oggetto, mentre il 25% ha un negozio Quel sogno di un Altrove motore delle nostre vite UMBERTO GALIMBERTI ognare un’altra vita rispetto a quella che ci capita di vivere è, tra i sogni dell’uomo, quello più antico. Senza questo sogno forse non sarebbero nati i miti dove nelle vicende degli dèi ci si rappresenta la vita che si vorrebbe vivere, le religioni che promettono una vita eterna al di là di quella che trascorriamo sulla Terra, la letteratura dove storie fantastiche ci trasportano in mondi altri rispetto a quello in cui siamo costretti a vivere, la musica che ci porta fuori dallo spazio e dal tempo abituali per immergerci in assonanze e dissonanze sconosciute al nostro trascorrere quotidiano. Senza il sogno di un’altra vita non avremmo immaginato alcuna utopia dove possa aver luogo quello che al momento non ha luogo, alcuna rivoluzione che, rispetto all’esistente, promette «nuovi cieli e nuove terre» e, se non proprio, almeno altre condizioni di vita, alcun progresso scientifico promosso dal sogno di ridurre la fatica del lavoro e la crudeltà del dolore, quando non addirittura quello di procrastinare la morte. Senza il sogno di un’altra vita, davvero, ma proprio davvero, non riusciremmo a vivere. Tale è infatti la condizione umana, il suo tratto specifico, la sua peculiarità, la sua bellezza. Su questo sogno primordiale, in cui probabilmente è da rintracciare l’essenza dell’uomo, le religioni hanno costruito il concetto di “trascendenza”, una sorta di oltrepassamento dell’esistenza, in vista di altri scenari possibili e futuri. Dal canto suo la psicoanalisi, sempre a partire da questo sogno, ha costruito il concetto di “inconscio”, dove il desiderio di un altrove, rispetto alla monotonia del quotidiano, irrompe per creare scenari alternativi che, quando non si realizzano, diventano sofferenze nevrotiche. Quando il sogno di un’altra vita oltrepassa i limiti del desiderio e dell’immaginazione e più non si accontenta degli scenari dispiegati dai miti e dalle religioni, né di quelli più modesti dischiusi dalle visioni utopiche o dalle istanze rivoluzionarie, allora può accadere che ci si congedi dalla realtà per inoltrarsi in quei percorsi, ora bui ora folgoranti, che siamo soliti chiamare “follia”. Un tentativo estremo per continuare a vivere quando la realtà non ci offre più le condizioni e, senza il sogno di un assoluto altrove, altro non ci resterebbe che il suicidio. Una realizzazione di questo bisogno tipico dell’uomo — che nasce in un mondo “dato” al solo scopo di ri-nascere in un mondo da lui “creato”, perché solo nelle nostre creazioni reperiamo un senso che sia davvero “nostro” — oggi ce lo concede la frequentazione del virtuale, dove ciascuno di noi può identificarsi nel mito di se stesso, nella storia che vorrebbe e che non può vivere nella realtà, negli amori che gli sono impediti, in spazi che non ha mai frequentato, abitando case o castelli, spiagge o deserti che ha solo sognato, indossando abiti che non sono sul mercato, ma che ciascuno, vestendoli, sente di essere finalmente se stesso. Forse tante terapie psicoanalitiche potrebbero accorciare i loro tempi alla scoperta dell’inconscio, se ogni paziente portasse al suo analista un dischetto in cui descrive la sua “Second Life” e se l’analista avesse l’accortezza di non ricondurre subito l’immaginazione del paziente alla realtà. Perché senza sogni la vita è invivibile, e i sogni forse non vanno solo interpretati ma anche realizzati, a meno che non si voglia rinunciare totalmente al proprio sé profondo, dimenticando l’invito di Nietzsche: «Diventa ciò che sei». Naturalmente più solerte e più attento degli psicoanalisti è il mercato che studia il “Second Life Style” per consentire ad architetti, designer e creatori di moda di alimentare la loro creatività consunta e in via di estinzione e di andare incontro ai desideri segreti, ma in Second Life manifesti, di personalità creative a cui il “sano realismo” che regola la nostra cultura non concede di esprimersi se non nel virtuale. Ma il virtuale anticipa il reale come l’alchimia ha anticipato la chimica, il sogno leonardesco di volare l’aeronautica, l’immaginazione atomistica di Democrito la fisica quantistica, la chimica l’interpretazione goethiana dell’amore a partire dalle “affinità elettive”. A questo punto potremmo pensare che il reale è solo il residuato del virtuale, il passato dell’immaginazione, ciò che resiste all’ideazione e a quella proiezione futura senza la quale l’uomo sarebbe già scomparso in quella noia profonda e letale dove già stava scomparendo Dio, quando, come ci ricorda Kierkegaard, reagendo all’immenso vuoto che lo circondava, con un gesto di immaginazione, creò il mondo. Forse fu proprio ispirandosi a questo gesto che l’uomo divenne immagine e somiglianza di Dio. Ma la Second Life, oltre ad essere un inno alla magia del sogno, è anche un sintomo dell’intollerabilità della vita a cui siamo costretti. Una vita dove ciascuno di noi ha dimenticato il proprio nome perché è riconoscibile solo dalla sua funzione, a sua volta regolata dalle maglie strette e dalle regole ferree dell’apparato di appartenenza. C’è solo da augurarsi che la promessa di una seconda vita virtuale non rimanga solo un’evasione, ma diventi spunto per una progressiva modificazione del reale, senza che un’anticipata rassegnazione lasci tutto irrimediabilmente così com’è. Sarebbe la fine della vicenda umana in quel che ha di più creativo e ideativo. S NEOGOTICO STREET STYLE Dalla strada proprio come avviene nel mondo reale, arrivano le ispirazioni per lo street o urban style, che punta alla comodità e fa tendenza. A destra, modello di Sassafras Designs, negozio su Mo Island dell’avatar Cha Trimble Il neogotico è una delle tendenze più diffuse in SL e mischia suggestioni cinematografiche, delle serie televisive e dei videogame Una delle firme più note è 7 Deadly Sins, marchio che risponde ai nomi dei partner Lilmiss & Loki Corsetti e merletti, ha invece un’estetica vampiresca: rosso e nero i colori preferiti NEOPUNK FETISH Videogiochi, Matrix e Il Quinto Elemento Prevalgono nero, cinghie, fibbie, pelle, stivali, borchie: il neopunk è una delle mode meglio rappresentate in SL Nella foto, un modello del marchio Canimal. Punk e stile vittoriano nelle firme Taliah Talamasca e Hyasinth Tiramisu, mentre l’intera isola Nexus Prime è cyberpunk Latex, pelle, collari, piercing, tatuaggi. Il fetish è tra le cifre più evidenti nel mondo virtuale Nella foto accanto, una creazione della X3D Apparel Molti i marchi di moda, come Draconic Lioncourt e Kyrrah Abattoir Repubblica Nazionale 52 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 24 GIUGNO 2007 l’incontro Il marito e gli amici perduti troppo presto, due figli amatissimi, una straordinaria carriera messa da parte e poi riagguantata Il suo racconto è sempre in bilico tra memoria e futuro ma oggi questa passionale popstar che ha saputo ricominciare da capo parla solo di speranza “Aiutiamo i nostri ragazzi a non aver paura, a combattere, combattere, combattere per costruirsi un avvenire dove la vita possa essere esaltata” Poeti rock Patti Smith l cospetto di Patti Smith si avverte il silenzioso fragore della storia. Storia rock s’intende, ma ricca di riverberi, come una drammaturgia dell’esistenza scritta sotto l’urgenza delle canzoni. Il suo volto scabro, non ritoccato, altamente espressivo, perfino rude, fino a che il sorriso non addolcisce gli occhi spiritati, è l’emblema di questo incontaminato rispetto per la figura della donna. Senza trucchi. Come senza trucchi è la sua arte, una lama affilata da affondare nel parco emotivo che le si distende davanti quando canta, che siano teatri, palasport, o lo sgangherato, enorme, loft dove suona a Copenhagen, nella surreale enclave di Christiania, anzi la libera città di Christiania, il quartiere fondato nel 1974 e ancora oggi gestito con inconfondibile filosofia comunitaria di stampo hippy. «Sì, ho voluto suonare proprio qui, perché bisogna sostenere questo posto. La gente ne ha bisogno». E quando canta, come un esordiente in un club fumoso, fronteggia il pubblico, guarda negli occhi gli spettatori, uno per uno, trasmette lampi chiari di rabbiosa beatitudine, urla: «Voi siete il futuro!». «Ho sempre voluto comunicare direttamente con la gente» spiega, «Sono consapevole della loro presenza, la gente vuole essere riconosciuta, e voglio che la gente sappia che sono lì per loro, voglio vederli, sentirli». Propone canzoni d’altri tempi, tra cui quelle che ha scelto per il suo recente album di cover, Twelve, un’occasione per riflettere sul passato. «Alcune le ho scelte perché era una missione, come Are you experienced, volevo a ogni costo aprire il disco con un pezzo di Jimi Hendrix». Il suo modo di raccontarsi è sempre in bilico tra memoria e futuro. Le persone perse, le persone ritrovate, il figlio Jason, ventiquattrenne, che ora è in tour con lei, e che lei protegge come una no tutti, tutti i giorni, anche qui girando per le strade ho visto una grande statua con King Frederick, e ho subito pensato al mio Fred, ogni giorno mi manca questa gente, non solo per l’amore che avevo per loro, ma per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Potrei dire che la mia vita è più povera, ma provo anche ad apprezzare quello che ho avuto, la mia vita è più ricca grazie al fatto che Fred mi ha dato due stupendi figli, ho incontrato nuovi amici, nuovi musicisti come Michael Stipe o Flea (dei Red Hot Chilli Peppers), ho amici meravigliosi, viaggio, e viaggiare rende la mia vita più ricca, amo arrivare nei paesi, la gente mi dà energia, spero che ci ispiriamo a vicenda, mi manca la mia gente ma loro sono sempre con me, preferisco pensare che cammino con loro in un diverso modo». Metaforicamente, ma anche alla lettera, è una vera viaggiatrice, nel senso che porta con sé poche cose, essenziali, ma cosa esattamente? «Parto sempre con un libro che voglio leggere, poi diventano tanti perché la gente mi regala spesso libri, questa volta ho portato un libro di poesie di William Blake. Porto sempre un Mi hanno detto: facciamo una t-shirt per l’11 settembre Ho risposto: no, facciamone una sul 10 settembre, per ricordare chi eravamo prima FOTO GAMMA A COPENHAGEN leonessa col suo cucciolo, come se fosse la sua proiezione nel domani. «Hendrix, l’ho incontrato una volta, poco prima che morisse» racconta. «Era allo studio Electric Ladyland, c’era un party, stava per partire per l’isola di Wight, io ero troppo timida per entrare nello studio e stavo sulle scale, lui uscì fuori, mi sorrise, mi raccontò i suoi sogni, le sue speranze, il rock’n’roll come linguaggio universale, voleva sviluppare un movimento pacifista dentro le strutture del rock, e poi morì, così cercai di pensare a lui, onorarlo, e io registrai lì il mio primo singolo, Hey Joe, che avevo imparato da lui». Oggi Patti Smith ha sessant’anni. Col tempo ha acquisito una sorprendente e luminosa serenità. A vederla sul palco è una belva scatenata, un furore ininterrotto, come se davvero fosse in missione per conto di cause superiori. La mattina dopo nel bar dell’elegante albergo in cui risiede è tranquilla, calma, attenta a ogni parola che dice, è seduta in un angolo, con un blocco notes in mano, un tè da sorseggiare, sembra un’intellettuale d’altri tempi in cerca di sottili empatie, con un borsalino nero a tese larghe saldamente infilato sulla testa: «Lo amo, quello che avevo mi è volato via mentre ero in viaggio, ero molto triste per questo e quelli della Borsalino me ne hanno mandato subito uno nuovo, ne sono molto riconoscente perché il cappello è come un mio amico». Ha vicino a sé un libro, di Edgar Allan Poe, lo apre a caso e come una monellesca sciamana legge la prima frase che trova: «Permettiti di sognare». Poi mi guarda come dire: vedi? La vita è una meravigliosa catena di casualità. Fa di tutto per sembrare normale: «Non sono una celebrità, non sono una popstar, voglio una vita normale, camminare per le strade, e voglio anche che la gente sappia che non sono inaccessibile, sto sul palco ma questo non fa automaticamente di me una persona migliore, è il mio lavoro, tutti insieme creiamo la notte e ogni concerto è diverso, anche nello stesso luogo la sera seguente sarà diverso, c’è sempre qualcosa che deve essere appreso, qualcosa che deve essere scambiato, ogni notte è nuova anche per me, una notte può essere molto politica, un’altra omosessuale, una anarchica, o solo divertente». Eppure la sua normalità è frutto di una vita votata all’arte, a fianco dei personaggi più fantasiosi e eretici espressi dalla cultura americana, una vita travagliata, lontana dai compromessi, funestata da perdite gravi. In pochi anni, dopo che nel 1979 aveva annunciato un clamoroso ritiro dalle scene, all’apice del successo, ha perso il marito Fred Sonic Smith, bassista del ruggente gruppo Mc5, poi il fratello Tod, l’amico di sempre Robert Mapplethorpe. Poi sono scomparsi i suoi amici poeti, Gregory Corso, Allen Ginsberg. Non è troppo subire così tante perdite? Anche su questo mostra una insospettabile serenità, eppure si capisce che superare il lutto deve essere stata un’esperienza liberatoria ma devastante. «Mi manca- notebook, un paio di penne, una foto di mia figlia, una piccola medaglia di Giovanna D’Arco, qualche t-shirt, dei calzini, porto anche la mia vecchia macchina fotografica, ce l’ho dal 1963, mi piace viaggiare leggera, spesso do via le mie cose, la gente me ne dà, a volte sembra una carovana di zingari, scambio le cose con quelli che incontro». E non si ferma mai, sembra che la sua testa sia ingombra di progetti come un cantiere in costruzione: «Ho molto lavoro da fare fuori dai concerti, voglio lavorare con altri artisti, come l’italiano Marco Turelli, ci sono molte fondazioni e musei che mi chiedono cose, e poi soprattutto voglio scrivere un’opera, una piccola opera, non come quelle di Verdi o Puccini, ma comunque un’opera, poi voglio finire il documentario a cui abbiamo lavorato per dieci anni, col mio amico Steven Sebring. Credo che sarà al festival del cinema di Roma, si intitola Dream of life, è sui dieci anni passati dopo che mio marito è morto, con i figli che crescono, mi segue in viaggio, visitando la tomba di Rimbaud o quella di Gregory Corso a Roma, è la mia ripartenza nella vita, e poi sto finendo un libro su Robert Mapplethorpe». Di tanto in tanto quando parla il volto si illumina, sembra colta da visioni, qualcosa di simile a quello che avviene in concerto quando sembra rapita da un effettotrance. «Capita con canzoni speciali. Una di queste è Smells like teen spirit dei Nirvana. È molto emozionante per molte ragioni, la prima è che ammiravo molto i Nirvana e ho molto sofferto per la morte di Cobain, ma più di questo le liriche della canzone le sento molto personali, come se le avessi scritte io stessa, parlano del conflitto di essere un artista che lavora con la gente con una certa forma di idealismo, essendo allo stesso tempo cinici, sentire quello che la gente ama e desidera, ma qualche volta odiandoti. Tutti gli artisti passano attraverso questo, prima illuminazioni, e poi dubbi su se stessi. Lui deve aver provato questo così intensamente da togliersi la vita, ma anche io sento le stesse cose, capisco la canzone, sono i sentimenti che mi hanno fatto abbandonare il palcoscenico nel 1979. Io ho perseguito la vita, l’amore, la maternità, sentivo la responsabilità, sentivo di aver fatto tutto quello che sapevo di dover fare, e tutto quello che potevo fare finché avessi imparato altre cose, era diventare più ricca e famosa, ma io non ho mai adottato il rock per diventare ricca e famosa, l’ho fatto per servire la gente, e ho pensato nel 1979 di non aver più niente da dare, piuttosto dovevo imparare a diventare una madre, avere bambini, un marito, una vita difficile diventare una vedova, ricominciare da capo. Ora ho molte più cose da spartire, ho più empatia con la gente». Ma da quando ha ricominciato, ricucendo pazientemente gli scopi, il senso stesso del suo mestiere, il mondo è cambiato, e di parecchio. «Quando ho cominciato c’era più ottimismo, la guerra del Vietnam era finita, c’erano state conquiste nei diritti civili, il movimento delle donne, il mio primo disco era anche la celebrazione di essere giovani, di esserci, con nuove idee e la voglia di cambiare il mondo, ora la gente è demoralizzata, non c’è niente che possano fare, perché i governi e l’economia sono troppo potenti, c’è sempre più gente esageratamente ricca che prende decisioni per gli altri. Mi stupisce come la gente possa dimenticare, lascia che l’amministrazione Bush invada l’Iraq senz’altro scopo se non destabilizzare il Medio oriente. Qualcuno mi ha detto: vorrei fare una maglietta per ricordare l’11 settembre, io ho risposto no, devi farne una per ricordare il 10 settembre, per ricordare chi eravamo prima. Gli artisti devono fare la loro parte, riavviare una rivoluzione spirituale, non bisogna mollare, non importa se si è capiti o meno, bisogna fare il proprio lavoro con la stessa passione, la mia missione è fare un buon lavoro, bisogna combattere, combattere, combattere, e magari perdere, ma ricordare alla gente che può sempre combattere. Dobbiamo aiutare i nostri figli a non avere paura. Ricordo che quando ero piccola, dopo la Seconda guerra mondiale, mio padre mi spiegò che cos’era la bomba, io avevo cinque o sei anni, e cercavo di capire: abbiamo una bomba capace di uccidere migliaia di persone? Era spaventoso, mi rendeva molto triste. Poi pensai, no, questa è la mia vita, e non posso viverla nella paura, devo godere la vita che ci è stata data, devo esplorarla, dare il mio contributo. Bush ha capitalizzato la paura della gente, ma noi dobbiamo cacciare la paura fuori dell’atmosfera, ho visto cose brutte, cose tristi, ho visto le peggiori cose, ho perso mia marito, ma devo essere grata di esser stata con lui per un certo periodo. C’è una cosa che ho imparato da Allen Ginsberg, mi chiamò quando morì mio marito, mi disse: lascia andare e continua la celebrazione della vita. È così, ogni giorno penso che sono sveglia, ho un altro giorno da vivere, un altro cielo da guardare, un altro libro da leggere, un altro sorriso, un altro uomo che mi prenderà per mano». ‘‘ GINO CASTALDO Repubblica Nazionale
Scarica