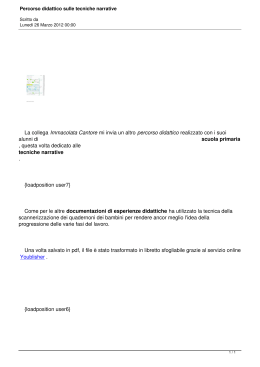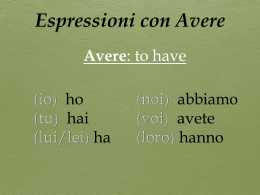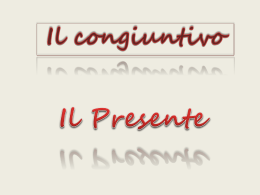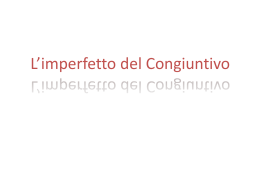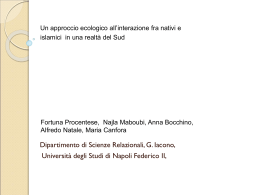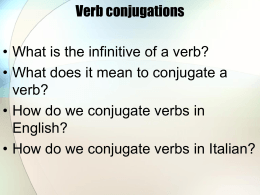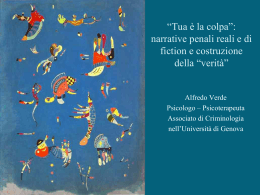RECENSIONI E LIBRI RICEVUTI LA 45 (1995) 533-662 RECENSIONI God, Language, and Scripture (L. D. Chrupcała) 537 The Art of Biblical History (L. D. Chrupcała) 539 Text-Linguistics and Biblical Hebrew (A. Niccacci) 543 Creation Account in the Ancient Near East and in the Bible (E. Cortese) 580 Biblia Hebraica transcripta (M. Pazzini) 584 Profeti e Apocalittici (E. Cortese) 586 I Profeti (E. Cortese) 586 Weigl M. Zefanja und das ‘Israel der Armen’ (E. Cortese) 590 Deiana G. Il giorno dell’espiazione (E. Cortese) 595 Theologische Ethik des Alten Testament (E. Cortese) 599 Textual Criticism of the Hebrew Bible (M. Pazzini) 604 Der Tempelkult in Kanaan und Israel (E. Cortese) 607 La tenda e il bastone (G. C. Bottini) 611 La casa della sapienza (G. C. Bottini) 611 Fredriksen P. De Jésus aux Christs (L. D. Chrupcała) 617 Sesboüé B. Pédagogie du Christ (L. D. Chrupcała) 620 Brown R. Le chiese degli Apostoli (A. M. Buscemi) 621 Carrón J. Jesús, el Mesías manifestado (G. Bissoli) 625 Silva M. Long V. Ph. Dawson D. A. Clifford R. J. Richter W. Marconcini B. et al. Spreafico A. Otto E. Tov E. Zwickel W. Bosetti E. Niccacci A. 536 RECENSIONI Muñoz A. S. El Mesías y la Hija de Sión (G. Bissoli) 625 Sinossi paolina (A. M. Buscemi) 630 Carbone S. Rizzi G. Le Scritture ai tempi di Gesù (G. C. Bottini) 633 Carbone S. Rizzi G. Il libro di Osea (G. C. Bottini) 633 Carbone S. Rizzi G. Il libro di Amos (G. C. Bottini) 633 The First Theologians (M. C. Paczkowski) 641 La croyance des Esséniens en la vie future (M. Pazzini) 644 L’interprétation de la Bible dans l’Église (L. D. Chrupcała) 645 Cent’anni di esegesi. I. L’Antico Testamento (E. Cortese) 650 Cent’anni di esegesi. II. Il Nuovo Testamento (L. D. Chrupcała) 651 Introducción al estudio de los Padres (M. C. Paczkowski) 652 The Joseph of Tiberias Episode in Epiphanius (M. C. Paczkowski) 654 L’Odegitria della cattedrale (M. C. Paczkowski) 657 Pitta A. Gillespie Th. Puech É. Commission Biblique Pontificale Vesco J. L. MurphyO’Connor J. Contreras E. Peña R. Goranson S. C. Bux N. SILVA GOD, LANGUAGE, AND SCRIPTURE 537 Silva Moisés, God, Language, and Scripture. Reading the Bible in the Light of General Linguistics (Foundations of Contemporary Interpretation 4), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1990, X-160 pp. La linguistica generale è una disciplina scientifica che si occupa del fenomeno linguistico in quanto tale. L’attenzione non viene rivolta, quindi, principalmente su una lingua concreta, di cui si studia la grammatica e la produzione letteraria, ma sul linguaggio in genere. “Nella sua sapienza Dio ci parla nella Bibbia attraverso le lingue umane (ebraico, aramaico e greco). Se noi ignoriamo il carattere umano della lingua, probabilmente fraintenderemo la Scrittura. Tutte le lingue, ad esempio, fanno un abbondante uso dell’immaginario. Dimenticate questo fatto e sarete costretti a concludere che Davide non era una persona ma un agnello (‘Il Signore è il mio pastore’). Ma non ogni elemento della lingua si rende così immediatamente evidente. Ed è lì appunto dove rientra la linguistica” (p. 17). Con queste frasi che abbiamo estratto dall’Introduzione, Moisés Silva annuncia l’importanza della problematica che intende illustrare nel suo libro. Questo, in primo luogo, vuol essere una guida all’uso dei linguaggi biblici. Un secondo fine è pure di carattere didattico: iniziare il lettore, soprattutto quello meno esperto, ad apprezzare le ricchezze del linguaggio biblico, facendogli vedere nel contempo quanto spesso questo linguaggio viene compreso male. Nella prima parte, intitolata “Prospettive bibliche sul linguaggio” (pp. 19-40), si cerca di rispondere alla domanda su cosa la Bibbia stessa ha da dirci a proposito del linguaggio. Risulta più di quanto ci si potrebbe aspettare. Il linguaggio è connesso con la storia della creazione: Dio crea attraverso la parola e crea l’uomo “a sua immagine”, ossia lo rende capace di esercitare il dominio su tutto il creato mediante un potente attributo – intrinseco dell’essere e dell’attività divina – che rappresenta appunto il linguaggio. La comparsa del peccato influisce con il suo nefasto influsso sul linguaggio umano. La confusione delle lingue, avvenuta in seguito alla distruzione della torre di Babele, più che un’incapacità di comprendere le lingue straniere, riflette uno screzio prodottosi nel seno dell’umanità. La caduta dell’uomo ha provocato infatti una distruzione, seppure non totale, dell’immagine divina: l’uomo parlando esercita tuttora il dominio, ma questo è profanato e soggetto ad un continuo agire del Male. La parola con la quale Dio ha creato il mondo deve ora trasformarsi in uno strumento di salvezza, la Parola di Dio che svolge il ruolo di giudice e ri-creatore del mondo, che assicura la permanenza del messaggio divino all’umanità (la Scrittura) e che si incarna, diventando una presenza personale nel compimento della redenzione (Gesù di Nazaret). La seconda parte tratta dello “Studio scientifico del linguaggio” (pp. 4158). La linguistica moderna, sia per la sua relativa novità, sia per la sua impronta interdisciplinare non è esente da controversie. Nello studio del linguag- 538 RECENSIONI gio è necessario, pertanto, seguire alcuni principi fondamentali. La “descrizione sincronica” serve per determinare il funzionamento del linguaggio in un concreto, ben definito, periodo cronologico; la sincronia, quindi, è ben più importante della diacronia che si occupa invece dell’evoluzione del linguaggio. Un altro principio afferma che i fatti linguistici non possono essere analizzati come entità individuali, ma in quanto facenti parte di un “sistema strutturato”. Dalla sviluppata struttura grammaticale di una lingua (ad es. il greco o il latino) non si può tuttavia concludere che quest’ultima sia l’espressione massima del pensiero umano, ma semplicemente che la grammatica e la letteratura sono il risultato dell’uso da parte delle grandi menti a cui si deve il pieno potenziale di una lingua. Non si può dimenticare poi il legame tra la linguistica e le altre scienze: umanistiche, naturali, sociali. Nessuno, comunque, di questi campi deve rivendicare dei diritti assoluti sullo studio del linguaggio; infatti, i rapporti interdisciplinari non possono impedire alla disciplina linguistica di avere il diritto ad una totale indipendenza. La terza parte dello studio porta il titolo “La dimensione storica” (pp. 5975). E’ vero che la linguistica moderna s’interessa principalmente dell’approccio sincronico, ma non ritiene neppure irrilevanti le considerazioni di natura storica (diacronica). Una più ampia conoscenza della preistoria del linguaggio e del suo sviluppo storico, aiutano a risolvere diversi problemi, anche nello studio della Bibbia. Grazie al metodo comparativo siamo in grado di stabilire l’appartenenza di una lingua ad una determinanta famiglia linguistica. In secondo luogo, occorre tracciare l’evoluzione della lingua nella sua fisionomia esterna (gli aspetti socio-culturali) ed interna (i cambiamenti linguistici); questi principi vengono applicati dall’A. per tracciare le caratteristiche di tre lingue bibliche: ebraico, aramaico e greco. Nelle due parti successive si procede ad una “Descrizione dei linguaggi biblici” (pp. 77-128). L’esame delle lingue bibliche viene focalizzato in base alle quattro unità del linguaggio: la fonologia (suoni), la lessicografia (parole), la sintassi (frasi e proposizioni) e il discorso analitico (paragrafi e ampie unità narrative). Per le ultime tre si fa un’ulteriore suddivisione in questioni della “forma” (la morfologia in senso largo) e del “significato” (la semantica). Un continuo ricorso ai più svariati esempi biblici aiuta, in questo esame, ad illustrare meglio la problematica trattata. Nell’“Epilogo – Passando oltre” (pp. 129-139), seppure in modo sommario, l’A. dedica alcune pagine ai problemi della critica testuale e della traduzione. Entrambi svolgono un grande ruolo nel dare accesso al testo biblico. Il volume è completato da un’Appendice (pp. 141-145), da una succinta proposta bibliografica per l’approfondimento (p. 147) e dagli Indici (pp. 149160). Lo studio di M. Silva, grazie alla sua chiarezza espositiva unita ad una seria base scientifica, può trasformarsi in un valido e prezioso sussidio per quanti intendono “tuffarsi” nel linguaggio della S. Scrittura. LONG THE ART OF BIBLICAL HISTORY 539 Termino questa presentazione con le parole di sollecitazione e di augurio espresse dall’A. “Lo sforzo speso nell’interpretazione della Bibbia non può finire con la nostra personale soddisfazione. Studiamo per diventare, a nostra volta, insegnanti (cf. Eb 5,12). Riceviamo, per poter donare. Un serio studio del linguaggio umano ci aiuta a comprendere la Parola divina. Potessimo servirci fedelmente di questo linguaggio per comunicare agli altri il messaggio di grazia” (p. 139). Lesław Daniel Chrupcała, ofm Long V. Philips, The Art of Biblical History (Foundations of Contemporary Interpretation 5), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1994, 247 pp., $ 17.99 “Scopo del presente volume è offrire i principi d’interpretazione circa il carattere storico della Bibbia e della storiografia biblica (la storia-scritta)”. Con queste parole Ph. Long descrive nella Prefazione (p. 13) l’intento principale della sua opera. L’investigazione verte sui campi fondamentali della ricerca scientifica riguardante la natura storica della S. Scrittura, cercando di rispondere ad una serie di domande che, non solo oggi, vengono poste dai lettori della Bibbia. Nel tentativo di chiarire le varie problematiche e di trovare le soluzioni alle questioni discusse, l’A. attinge ai migliori risultati dell’indagine biblica, ma non disdegna neppure i validi apporti della ricerca storica fatta dagli studiosi di altre discipline. Talvolta, la documentazione sembra troppo “abbondante”, per non dire pedante (soprattutto per quanto concerne un continuo ricorso a più o meno lunghe citazioni dirette), ma questo può essere anche indice della serietà con cui la materia sottoposta allo studio esige di essere trattata. Il volume comprende un’Introduzione (pp. 17-26) seguita da sei capitoli che studiano le questioni fondamentali riguardanti il carattere storico della Bibbia e della fede cristiana. I. “Storia e genere(i) della Bibbia: la Bibbia è un libro storico?” (pp. 2757). La Bibbia non è un libro storico, nel senso di un libro di testo. La storia, cioè, non rappresenta la natura essenziale della Bibbia. Ugualmente inammissibili sono le classificazioni parziali che vedono in essa un libro di teologia, di scienza o di letteratura. “Libro religioso” oppure “Parola di Dio” sono tra le definizioni che vengono generalmente accettate da tutti. La difficoltà di definire in maniera univoca la Bibbia, e quindi anche in quanto libro storico, deriva dal fatto che in realtà non vi si tratta di un genere solo, ma di una molteplicità di generi letterari (la Bibbia si presenta così come una raccolta di vari generi o un macro-genere). Ne segue allora che, pur riconoscendo alla Bibbia il “valore di verità” (truth value), la “pretesa di verità” (truth claim) contenuta in questo o in quel testo biblico esige di essere dimostrata in base alle caratteristiche specifiche di questo o di quel testo. Utile in tale impresa 540 RECENSIONI è la conoscenza dei generi letterari extra-biblici, antichi e moderni, sempre comunque tenendo presente la grande “diversità” della Bibbia. Per questo motivo la critica dei generi e delle forme, che si fonda essenzialmente sul metodo comparativo, deve cercare di sfuggire ai vari rischi, tra cui emerge anzitutto quello di far dire al testo biblico quale deve essere o meno il suo contenuto. Solo stabilendo un giusto valore letterario del testo, sarà possibile procedere anche verso una sua giusta interpretazione, compreso il discorso relativo al valore storico. II. “Storia e romanzo: che cos’è la storia?” (pp. 58-87). Anche se in apparenza sembra che tra i due concetti di storia (history) e di romanzo (fiction) ci sia una dicotomia, tuttavia tutti e due – dopo essere giunti ad un’adeguata definizione che li protegga da malintesi – possono venir impiegati nella discussione sulla storiografia biblica. L’importante è liberare i concetti dalla confusione in cui sono caduti in seguito alla loro ambiguità. Il termine “storia” va inteso in due sensi distinti: la storia-come-evento (il passato in quanto tale) e la storia-come-racconto (l’interpretazione verbale del passato). Anche il termine “romanzo” si colora di un doppio significato: un “romanzo storicizzato” (il genere letterario) e una “storia romanzata” (l’arte o l’abilità letteraria). Il romanzesco nella storia significa per molti una menzogna nel cuore della storia-scritta, mentre per altri coincide con l’opposto della storia. In realtà però, facendo una distinzione tra la forma e la funzione del romanzo, possiamo usare questo concetto per quelle narrazioni che non sono mai avvenute e ciononostante vengono ritenute vere; un altro caso costituiscono le cosiddette narrazioni storiche che pretendono di raccontare quello che realmente è accaduto. L’A. precisa ulteriormente questa idea, ricorrendo al concetto dell’“arte rappresentativa verbale” (verbal representational art). Come una pittura (l’arte visiva) non è in senso letterale una riproduzione perfetta della realtà, così neppure un racconto (l’arte verbale) può realmente narrare l’evento del passato, benché lo faccia in un modo fittizio. “Gli storici, come gli artisti della rappresentazione verbale, si trovano nella stessa posizione degli artisti della rappresentazione visiva” (p. 70). Anche nella storiografia, pertanto, appaiono dei procedimenti letterari che sono necessari per una riuscita descrizione della realtà: la selettività dei dati, un’angolatura particolare che dipende dagli intenti specifici dell’autore di ordine storico, teologico o estetico, la semplificazione di fatti-eventi, l’attenzione ai dettagli più suggestivi. Qualunque narrazione storica, compresa quella che si propone di essere la più oggettiva possibile, richiede un tocco di romanzesco o, per usare un termine meno ambiguo, di arte creativa. “La storiografia comporta uno sforzo creativo, sebbene limitato, per dipingere ed interpretare gli eventi significativi del passato o le sequenze di eventi” (p. 87). III. “Storia e verità: è importante la storicità?” (pp. 88-119). Mentre il cristianesimo tradizionale ritiene che la storicità, perlomeno di alcuni eventi centrali, è necessaria per la fede, in molte discussioni teologiche moderne si è fatta forte la tendenza di sconfessare la rilevanza della storia in favore, ad es., di LONG THE ART OF BIBLICAL HISTORY 541 una verità artistica o filosofica. La Bibbia non potrebbe essere una grande parabola e, nello stesso tempo, insegnarci le verità riguardanti Dio? La domanda è puramente teorica, dal momento che la Bibbia mostra la pretesa di raccontare la verità e non solo di avere il valore di verità. La storiografia biblica differisce da quella moderna negli intenti e nelle modalità rappresentative, ma difficilmente si potrà negare il fatto che molti racconti biblici riflettano un passato reale. “Ogni forma di discorso presenta la sua propria pretesa di verità, e il valore di verità dei diversi discorsi va valutato in linea con la sua pretesa di verità, ossia stabilendo che cosa ognuno di essi intende comunicare o realizzare” (p. 92). E’ vero che la fede non crea gli eventi della storia salvifica, come pure non richiede che tali eventi vengano comprovati nella loro “fattualità”, tuttavia è altrettanto vero che “senza la storicità degli eventi centrali della storia biblica, la vera fede biblica non potrebbe sopravvivere. […] la caduta della storicità porterebbe inevitabilmente con sé l’abbattimento della fede cristiana” (pp. 98.99). L’illuminismo del XVIII e XIX sec. ha sferrato un forte attacco alla storicità della Bibbia. Diversi studiosi, tra cui H.S. Reimarus e D.F. Strauss, per nominare i più significativi, hanno tentato di demolire la storia biblica – con i loro criteri volti a smascherare la sua presunta non-storicità – cercando di sostituirla con una ricostruzione teologica della fede cristiana. La reazione ortodossa non sempre è riuscita a far fronte adeguatamente a questa tendenza. Per evitare il rischio di cadere in uno dei due estremi, che rispettivamente favoriscono l’importanza dell’evento storico oppure l’interpretazione verbale dell’evento del passato, si deve sottolineare la contemporanea rilevanza di entrambi: il carattere referenziale del racconto biblico (la storia) è infatti inseparabile dalla sua interpretazione artistica. IV. “Storia e scienza moderna: perché gli studiosi non sono d’accordo?” (pp. 120-168). In questo capitolo l’A. cerca di motivare il disaccordo scientifico riguardo al valore storico degli scritti biblici. La lettura storica della Bibbia e la connessa divergenza nelle conclusioni, dipendono in primo luogo dai diversi modelli di realtà adottati dagli studiosi e, secondariamente, da una preferenza data ad un determinato procedimento metodologico. Risulta che alcuni rappresentanti del metodo storico-critico escludono sistematicamente e con insistenza la possibilità di un diretto intervento divino nella storia (una tendenza anti-teologica); alcuni di quelli che seguono gli approcci socio-scientifici e archeologici sottovalutano invece l’importanza delle fonti scritte (una tendenza anti-letteraria); mentre alcuni approcci di tipo letterario sembrano ignorare il valore di referimento dei testi (una tendenza anti-storica). Adottare uno di questi approcci metodologici conduce inevitabilmente ad un pericolo di ricostruire la storia biblica in maniera difettosa, ovvero ad una discordanza radicale nei risultati scientifici, frutto di diversi approcci. Come sempre, anche nell’interpretazione biblica occorre quindi mantenere un giusto equilibrio evitando le 542 RECENSIONI posizioni unilaterali. Ognuno degli approcci analizzati, se propriamente elaborato ed incorporato in una simbiosi metodologica, può svolgere una funzione molto utile nella lettura storica della Bibbia. V. “Storia ed ermeneutica: come, allora, dobbiamo leggere la Bibbia ‘storicamente’?” (pp. 169-200). L’analisi svolta nei quattro capitoli precedenti giunge ora ad un punto positivo, in cui cioè l’A. intende presentare un’ermeneutica storica della Bibbia. Un primo passo preparatorio da compiere è quello di considerare i modelli della realtà e il significato delle credenze antecedenti che hanno influenzato l’autore biblico. Il secondo passo presenta una struttura bipartita di accostamento al testo sacro: ascoltare con attenzione e competenza il testo per determinare la sua pretesa di verità (con l’aiuto di varie discipline esegetiche) e sottoporre alla prova il valore di verità di qualunque pretesa. Nel primo caso sarà richiesta all’interprete biblico un’attitudine aperta e l’attenzione al contesto, mentre nel secondo si cercherà di provare il carattere della testimonianza biblica mediante un esame di consistenza interna (stabilire se la narrazione è coerente in sé) ed esterna (verificare l’impatto delle prove esterne sul valore della narrazione). Il terzo passo è costituito dalla presentazione da parte dello storico degli argomenti per giustificare una concreta ricostruzione storica. Questa operazione rassomiglia molto all’opera del giudice, chiamato a pronunciare, dopo un attento esame dei testimoni, il verdetto finale. VI. “Un ampio esempio: l’ascesa di Saul al trono” (pp. 201-224). In quest’ultimo capitolo dello studio, Long offre un saggio dell’analisi storica del testo biblico. L’approccio programmatico presentato nel capitolo precedente viene ora messo in pratica per ricostruire e argomentare la storicità di 1Sam 9-11. L’A. si serve del ben noto schema di S. Toulmin e giunge alle conclusioni seguenti: dato che la Bibbia presenta una coerenza interna e che il racconto unificato sull’ascesa di Saul al trono dovrebbe essere visto con tutta probabilità come un racconto storico, quindi, probabilmente – basandosi sul fatto che la Bibbia dice la verità e possiede lo status di parola di Dio – il Saul storico divenne re fondamentalmente così come è descritto nel testo, anche se alcuni dati dell’esposizione risultano inesatti e sorge un’evidenza contraria sufficiente per discreditare la dimostrazione. Il volume termina con un epilogo in cui l’A. raccoglie brevemente i risultati dell’indagine; segue una bibliografia commentata (molto utile) a scopo di approfondimento e infine gli indici: degli autori e delle opere citate, dei passi biblici e dei temi. Non saprei mostrare i punti deboli dell’opera, al di là, forse, di quella già menzionata all’inizio: meticolosità che sa di eccessiva diligenza e crea qualche disturbo nella lettura (soprattutto ai meno addetti ai lavori). Però, non mi è difficile menzionarne alcuni pregi. A mio avviso, meritano attenzione: l’originale disposizione del lavoro che analizza i temi-chiave della ricerca storica sulla S. Scrittura, il tentativo di presentare gli scritti storici della Bibbia come una sorta di “arte rappresentativa” e le esemplificazioni delle questioni che man DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 543 mano vengono studiate, fatte con l’ausilio dei vari testi biblici (alla fine di ogni capitolo se ne trova un esempio). Ugualmente meritevoli sono le conclusioni, sia di ciascun capitolo che dell’opera stessa; per chi dovesse perdersi nei meandri dell’investigazione, sarà utile (non voglio dire sufficiente) attingere alla lineare presentazione dei risultati emersi dall’indagine. Sottolineo questo punto perché non sempre si trovano studi che riescono con tanta chiarezza a sintetizzare il percorso fatto e, dato che l’opera di Long vuole essere anche un sussidio per gli studenti della Bibbia, credo che questo aspetto didattico sia degno di essere adeguatamente apprezzato. Lesław Daniel Chrupcała, ofm Dawson David Allan, Text-Linguistics and Biblical Hebrew (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 177), Sheffield Academic Press, Sheffield 1994, 242 pp., £ 37.50 Dawson’s volume is a doctoral dissertation under Professor John Gibson at the Edinburgh University, Scotland, in 1993. I find no better way of presenting its aim and scope than quoting extensively from the Summary at the end of the book. In this study, I have examined five current influential works on the text-linguistic description of Classical Hebrew, a theoretical base and a methodology for such description was presented, and several texts were worked according to this theoretical model. My goals have been to underline the need in such undertakings for good theory and methodology, and for clear and direct communication of findings. To this end, in the first two chapters, I surveyed Niccacci’s Syntax, Eskhult’s Studies, Andersen’s Sentence, Khan’s Studies, and Longacre’s Joseph. Each of these contributes to our growing understanding of test-level features in Classical Hebrew. Each of them also fails to achieve our ideal standards of theoretical–methodological integrity and clarity of presentation. It is claimed (1) that the Hebrew language can be described elegantly and helpfully at the level of ‘text’, and (2) that this cannot be accomplished if the researcher’s theoretical starting point does not allow for the possibility of a variety of text-types, or if the write-up does not explain itself so that linguistically astute, but not linguistically trained, hebraists can both trace the procedures and comprehend the results. Of the five works examined, it was claimed that Joseph offered the greatest steps forward in the description of the language—that is, its description of text-types by a matrix with three distinctive parameters, and the description of each text-type in terms of its own specific scale of clause-type distribution (which Longacre terms ‘clines’); and since Longacre does not offer much theoretical explanation, the third chapter attempted this task. Since space was limited, it was decided that attention should be given primarily to that portion of theoretical basis which would permit the reader quickest access to the most significant contributions of Joseph; this has meant that we worked toward an understanding of certain basic features of ‘tagmemics’ which are particularly important for an understanding of the matrix and the clines. This presentation of the theoretical base also entailed discussing methodological principles, and in the end led to the proposal of some working hypotheses with which we could give the theoretical base a ‘road-test’. 544 RECENSIONI This road-test consisted in asking of several texts whether text-types and main-line forms did in fact appear to be linked, and whether the patterns created by the alternations between main-line and off-line forms coincided with other features to reveal the internal structure of the texts. In addition, we looked at ‘Reported Speech’ to determine, if possible, whether this kind of text had the same text-type and cline characteristics as nonReported Speech. The final analysis attempted to step away from self-conscious theoretical explanation and to apply the theory and methodology, more freely, to a single unified text (pp. 209-210; italics in the original). After this lucid presentation of the study as a whole, I allow myself to comment on certain points of the exposition. In the introduction D. rightly warns against bad customs widespread among linguists and grammarians, such as inventing new terminology, and not clearly stating one’s own presuppositions, theoretical perspective and methodology. He also insists on the importance of the so-called ‘language universals,’ or the general tendencies of human language. I would note that no matter how important the language universals are, they can never replace sound, synchronic description of each language in particular. I think more than one reader would concur with voicing the danger of too great an attention on language universals and too little analysis of particular languages in contemporary linguistic literature. Dawson avoids using the term ‘discourse’ and uses instead ‘text.’ In his words, a text (or a ‘discourse’) is a unit of speech, whose constituents are paragraphs, and other, shorter, units; texts exhibit consistent tendencies in internal development, which features can be described linguistically (p. 21). I would have never suspected that an ‘innocent’ term like ‘discourse’ might cause so many misunderstandings until I became familiar with ‘discourse analysis,’ the USA counterpart of the European text-linguistics. This happened in 1993 during my stay in Dallas to attend a Seminar on discourse analysis and Biblical Hebrew held at the Summer Institute of Linguistics (SIL).1 Although D. did his research under Professor Gibson, he is a pupil of Professor R.E. Longacre, who is the mentor at the SIL. During my exposition, the topic ‘discourse’ will come up several times. §1 Syntax. Dawson raises several critical remarks against my Syntax. In his opinion, it uses the term ‘discourse’ in an improper way without distinguishing the different text-types as is done in the SIL circles. In order to understand this remark, one needs to know that while I distinguish ‘discourse,’ in the sense of direct speech, from historical narrative, D. (following Longacre) posits only one genre, ‘discourse,’ and four text-types – ‘Narrative Discourse,’ ‘Narrative Prediction Discourse,’ ‘Hortatory Discourse,’ and ‘Expository Discourse’ (pp. 115-116). Now, I have observed elsewhere that the so-called ‘top-down 1. The proceedings of this Seminar have been published: R.D. Bergen (ed.), Biblical Hebrew and Discourse Linguistics, Summer Institute of Linguistics 1994. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 545 methodology’ practiced in the SIL circles is unfit for Biblical Hebrew for two reasons.2 First, this approach makes it difficult, maybe even impossible, to perceive a coherent, overall system in Biblical Hebrew verb. Second, since Biblical Hebrew is a dead language and no competent speaker is available, we need to learn it moving from the bottom up, that is, from the smallest unit, the sentence,3 to the paragraph, and finally to the text. A basic precondition is to describe the Hebrew verbal system and try to understand the function(s) of each form in a text-linguistic perspective since one cannot rely on traditional grammars. Indeed, one cannot base a text-linguistic analysis of the Bible on the theory of the traditional (both old and modern) grammars that are bound to the sentence and do not consider the relationships of the verb forms to one another in the text. A major deficiency of D.’s study is, in my opinion, that he relied heavily on the SIL approach without trying to develop a syntax capable of supporting a sound ‘discourse analysis.’ §1a Sentence and Text. A second critical remark is that Syntax remains bound to the sentence. On the one hand, I have already pointed out the necessity of starting from a sound analysis of the sentence because this is the base upon which the verbal system rests. Time and again, I have tried to show the coherence of the Biblical Hebrew verbal system from the sentence level up to the paragraph and the text levels.4 On the other hand, D. may have overlooked the import of Syntax, especially Chapters 5 and 6, for text-linguistic analysis of the texts. I have shown this in the analysis of complete texts from Joshua, Judges, Samuel and Chronicles in Lettura sintattica.5 In this book (not mentioned by D.), first a ‘syntactic commentary’ of each sentence is given and then a ‘macrosyntax’ of the text – its beginning, development, and end.6 Admittedly, this is not the kind of analysis done by D., yet it does go beyond the limit of the sentence. My analysis is only based on the functions of the verbal forms established with text-linguistic criteria. It is, therefore, limited and does not exclude per se the kind of analysis done by D. 2. See my paper, “On the Hebrew Verbal System,” in: Bergen (ed.), Biblical Hebrew, 117137. 3. Dawson objects against the (translator’s) use of ‘sentence’ instead of ‘clause’ in: A. Niccacci, The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, Sheffield 1990; see p. 38. However, according to the sources available to me ‘sentence’ and ‘clause’ can be used alternatively. 4. My last attempt is, “Finite Verb in the Second Position of the Sentence. Coherence of the Hebrew Verbal System” (to be published in ZAW). See also: “Essential Hebrew Syntax”, in: E. Talstra ed., Narrative and Comment. Contributions presented to Wolfgang Schneider, Amsterdam [1995], 111-125. 5. Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e applicazioni, Jerusalem 1991. 6. See also my paper, “Analysis on Biblical Narrative,” published in: Bergen (ed.), Biblical Hebrew, 175-197. 546 RECENSIONI §1b H. Weinrich. A further critical remark is that the present writer “is not rigorously thorough in his application of linguistic principles, and permits himself both short-cuts and inconsistencies” (p. 31). This may be true, yet I have some justifications. First, my decision of prefacing as little theory as I could (three and a half pages: Syntax, pp. 19-22) was a reaction to a tendency towards long theoretical discussion and small (if any) analysis of texts. Something more about theory, presuppositions and methodology is found in Ch. 9 as a short introduction to a summary on the use of the Hebrew tenses in prose. Second, I thought I could permit myself being very short because I adopted a well-defined model, that of H. Weinrich, Tempus.7 It is rather surprising that D. does not even mention this fact. For him, the only text-linguistic theory is the one developed by Longacre. While the whole Ch. 3 of his study is devoted to explaining the ‘Tagmemic Model’ in order to clarify Longacre’s theory, the name of Weinrich is not even mentioned.8 §1c Qatal in ‘Discourse’. Dawson rightly perceives an inconsistency in Syntax, p. 43 as he writes: Niccacci says of the ‘report QATAL’ that it ‘never heads a sentence’ as well as that it ‘is a form with first position in the clause’. These two statements cannot be reconciled with each other, and do not describe the data (p. 33). Yes, this is one of the rather numerous errors crept into the English translation of my work, and for that I owe the reader my apology.9 Yet from a careful reading one notes that something is wrong in the following sentence: “the ‘report’ QATAL never heads a sentence but can be preceded by a particle …” (Syntax, p. 43; italics added). It is clear that the phrase “but can be preceded by …” needs a different antecedent than “never.” In fact, the Italian original reads as follows: “il ‘QATAL di resoconto’ non occupa sempre la prima posizione della frase, ma può essere preceduto da una particella …” Besides, a look at the examples quoted in Syntax §23 shows that in five cases we have an x-qatal (i.e. qatal in second place) and in four cases qatal (i.e. initial qatal). To the other point – i.e. that the data are not described in that way – I shall come back later since this is one of the major points of D.’s research. §1d Rules. Another D.’s remark on Syntax concerns “a certain tendency toward overstatement of ‘rules’ in syntax” (pp. 32-33). This remark is not surprising because D. – and the SIL circles as well – do not see any rule or system in the use of the Hebrew verb. Rather, they look for regularities in the patterns of texttypes in the texts. Now, if this search for linguistic patterns is useful, syntactical 7. H. Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 1964; 4th ed. 1985. 8. About Dawson’s six-line (or even shorter!) description of my (i.e. Weinrich’s) text- linguistic theory in p. 29, note that the three categories mentioned there are not at all ‘mutually exclusive’; on the contrary, they all are to be applied in analysis of texts. 9. Unfortunately I was not given the possibility of checking the text before the printing. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 547 analysis is a prerequisite, as noted above. And, as far as I know, syntax is built up by adopting working hypotheses and refining them until they becomes rules; this happens when the hypotheses are confirmed by sufficient data. §1e Syntax and Semantics. Dawson comments on the role of semantics in the present writer’s syntactic description: On the other hand, while he acknowledges that semantics must play a role even in macro-syntactic description, he restricts his semantic analysis to grammatical forms. He overlooks the fact that, for example, hyh never represents a ‘full’ event, by virtue of its inherent, ‘stative’, meaning, and thus can never be a foregrounded narrative verb. His explanation of the distribution of this verb is fairly convoluted, and could have been simplified with the recognition of the stative nature of hyh (p. 34). This is an aggregate of unproved allegations. First, one would like to know what is exactly meant by “a ‘full’ event.” If this means an ‘action,’ one can observe that several main-line wayyiqtol forms do not indicate any action. Second, who decided that a static information cannot be foregrounded. Foreground is not identical with action as well as background is not identical with state. It is the writer, and no one else, who decides what is foreground and background, and he signals his decision by means of the verb forms used. This seems to me a correct relationship between syntax and semantics – that is, the second is subservient to the first, not vice versa. In other words, syntax is to be established by morphology and analysis of the sentence (position of the verb in the sentence is a decisive factor), and only subsequently by semantics. As for the verb hyh, D.’s analysis is only semantic (see also his note 61, p. 34). The present writer has illustrated the syntactical status of the verb in Syntax §§28-36 and more fully in a special paper on the subject,10 as well as in Lettura sintattica §24. There are two uses of hyh: one where it is a ‘full verb,’ the other where it has a ‘macrosyntactic function.’ hyh is a full verb when it is followed by the subject; it has a macrosyntactic function when it is followed not by its subject but by a ‘circumstance’ (be it a prepositional phrase, an adverb, or a casus pendens). In both its uses, hyh is a verb in its own merit. In the yhiy“w" form, it is a wayyiqtol as any other such verb form. Again, I need to quote D. extensively: One of the difficulties Niccacci runs into here is due to his apparently not having examined larger units for structural similarities. This sort of investigation would have shown that ‘interruptions’ to the main narrative are marked as more or less significant on the basis of (1) how far removed the interruption is from the normal semantic, temporal, and aspectual (etc.) qualities of the main-line of the text, and (2) how many non mainline clause-types occur in tandem. This second factor is significant for the evaluation of hyh forms—if Niccacci were to have worked from the assumption that Classical Hebrew is a ‘bag-of-tricks’ language, the idea that yhyw clauses are among the possible options in 10. “Sullo stato sintattico del verbo häyâ,” LA 40 (1990) 9-23. 548 RECENSIONI the bag of trick available for a specific task, and he would not have to claim a distinction between yhyw as a ‘full form of the verb’ and yhyw as a macro-syntactic marker, since yhyw as a ‘full form’ could still function as a macro-syntactic marker. Comparison of several large units of text would lead as well to the realization that narrative units can be broken down into smaller units without endangering the integrity of the whole, and he would not need to insist that yhyw is always a marker of continuity. (In my reading of the data, yhyw seems almost without exception to function as a paragraph-break marker, and as such is often a marker of discontinuity.) (pp. 34-35; italics in the original) One point of agreement between us is that wayyiqtol is a verb form expressing continuity while qatal indicates interruption in a narrative. D. maintains, however, that yhiy“w" is no normal wayyiqtol. The criterion is semantic, nothing more. In addition to the objections raised above in this section concerning the stative nature of hyh, one would like to understand under what criteria are we to decide “how far removed the interruption is from the normal semantic, temporal, and aspectual (etc.) qualities of the main-line of the text” (note the appearance of ‘semantic’ in the first place and the absence of ‘syntactic’). More verifiable criteria than personal choice are necessary to be convincing. Moreover, the ‘bag-of-tricks’ may be a picturesque expression, but in order to be an acceptable explanation, the contents of that ‘bag’ are to be verified syntactically – a grammarian is not a juggler. §1f Historical versus Oral Narrative. Another objection raised against Syntax is the distinction between ‘narrative proper’ and ‘narrative discourse’ (pp. 3536). Here again we find an unfortunate use of the same phrase for different things. Not accepting my – as well as M. Eskhult’s, and basically H. Weinrich’s – distinction of direct speech and narrative as the two basic genres of the prose, D. employs the term ‘narrative discourse’ in quite a different meaning (see beginning of §1 above). For me it only means ‘oral narrative’ as opposed to ‘historical narrative.’ I shall again discuss this point later. §1g Word Order. A further objection concerns the importance of word order in Hebrew syntax although D. accepts it in principle (as the SIL circles do). He writes: Here, I am largely in favour of Niccacci’s conclusion: that the emphasis of the clause is determined by what has first position in it (excluding conjunctions such as -w and yk); however, I feel he takes this too far (p. 37). I agree that -w does not occupy a place in the clause, as well as do not the negations aløw“ and la'w“, but yKi does, as well as ˆ['m'l], rv,a} etc., because they are subordinating conjunctions.11 11. I hope to be able to draw a list of subordinating conjunctions and non-subordinating particles in the near future. For the moment, see my book review of: W. Groß - H. Irsigler - T. Seidl (ed.), Text, Methode und Grammatik. Wolfgang Richter zum 65. Geburtstag, St. Ottilien 1991, in: LA 44 (1994) 667-692, esp. §3. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 549 After a long quotation from Syntax, pp. 28-29, D. objects to the idea that placing the verb in the second place of the sentence means demoting it from its normal role of predicate, or new information, to the role of subject, or given information. He writes: This opposition of subject and predicate seems overstated. In truth, all the information in a ‘sentence’ (by which he here means ‘clause’)—not just the predicate—is vital to the meaning of the sentence, and though one element may have greater importance, this is only on a sliding scale; to label one element ‘subject’ and another ‘predicate’ in this fashion is to put into black and white that which should be described in terms of greys (p. 38). I doubt that grammatical analysis is a question of ‘greys’ instead of ‘black and white.’ Of course, every element in a sentence is ‘vital’ from the semantic and pragmatic point of view, but not from the grammatical and syntactical point of view simply because there are cases where the subject does not appear at all. A couple of examples of this kind are quoted in Syntax, p. 27: Judg. 1:2 and 6:29 versus 20:18 and 15:6, respectively. Other examples are found in a more recent paper.12 In it, one also finds a better description of the ‘phrase coupée’ (in English, ‘cleft sentence’) than the one given by D. on p. 39, by R. Huddleston (pp. 910) and T. Givón (p. 25), and also a description of comparable structures in Greek and in other languages by H.J. Polotsky (pp. 13-14) and H.B. Rosén (p. 26). A further remark on the topic of word order according to the present writer reads as follows: He is also not accurate in his assessment of ‘modern linguists’; it is incorrect to say that they believe the noun phrase to be ‘first in the sentence’. Perhaps this is true of those who do not engage in linguistics as a description of data (though I cannot imagine what other sort of linguistics would exhibit any integrity); it is certainly not true of linguists whose goal is to describe ‘what is there’ (p. 38). The passage of Syntax, pp. 28-29, referred to above simply means that while in many modern languages the subject, or ‘noun-phrase,’ occupies the first place in the sentence (see J. Lyons cited in Syntax, note 17, p. 199) – this is true of English, French, German, Italian and other languages –, in Biblical Hebrew, as well as in other ancient Semitic languages, the first place is taken by the predicate, or ‘verb-phrase.’13 §2. Joseph and Tagmemics. As D. puts it, [Longacre’s Joseph] represents the most significant advancement in Hebrew textlinguistics seen to date; it contains much of near-revolutionary value to the student of Classical Hebrew syntax (p. 56). 12. “Marked Syntactical Structures in Biblical Greek in Comparison with Biblical Hebrew,” LA 43 (1993) 9-69. 13. See my paper, “The Stele of Mesha and the Bible. Verbal System and Narrativity,” Or 63 (1994) 226-248, esp. §6. 550 RECENSIONI Dawson follows the lead of this book whole-heartedly; just to better explain the theoretical base of this book he writes an introduction to the Tagmemic Model, which is especially destined to linguistically untrained Hebraists; from this book he derives his own methodology of text analysis (see Ch. 3). Part Two of Joseph describes the surface structure of Classical Hebrew (pp. 61ff.). Now, while its methodology is a considerable improvement upon traditional grammar based on the sentence, it posits too many types of texts. It is able to discover some regularities in the use of verb forms in specific texttypes but not to perceive any system of the Hebrew verb (see §1d above). Hopefully, things shall become clearer in the course of my discussion. One of the major contributions of this theory is a basic distinction between ‘on-the-line’ and ‘off-the-line’ clauses; this corresponds to what I call ‘verb forms of the main line’ and ‘verb forms of the secondary line of communication.’ Apart from this important area of agreement, there are several areas of disagreement, beginning with the nature of verb hyh, as already indicated (§1e). Another area of disagreement concerns a basic distinction between verb clause and noun clause, that is the corner-stone of my description of the Hebrew verbal system. In this description, wayyiqtol is a main-line verb form and qatal an off-line verb form in historical narrative precisely because the first constitutes a verb clause (wayyiqtol takes the initial position in the clause) while the second constitutes a noun clause (qatal takes the second position). Because, as D. notes, Joseph explicitly rejects any major difference between verb and noun clause, one may ask on what basis are we to distinguish between main-line and off-line verb forms. This subject entails an important point of disagreement also because qatal is considered a off-line verb form per se, while in my opinion it is such in historical narrative only; in direct speech it can be a main-line verb form in the axis of the past (see §4c below). The quest for verifiable criteria becomes acute when one considers the ‘verbal rank scheme’ for Narrative History presented on p. 63. Although for D. “this is one of the most immediately accessible – and revolutionary – contribution of the book,” still I have some problems with it. I have already spelled out my agreement (and reservations) to positing ‘Band 1: Storyline’ for the ‘Preterite,’ i.e. wayyiqtol, and ‘Band 2: Backgrounded Actions’ for ‘Perfect,’ i.e. qatal. Since this ‘verbal rank scheme’ represents different degrees of departure from the storyline, I am surprised to see that the hNEhi constructions are classified as ‘Band 3: Backgrounded Actions.’ In fact, hNEhi is a particle typical of direct speech conveying visual information in the most lively possible way (it is connected, explicitly or implicitly, with a verb of seeing). As such it conveys description, which is not foreground in historical narrative, yet it can hardly be considered a thirddegree departure from the storyline (see e.g. Ruth 4.1.3).14 14. Consult my paper, “Syntactic Analysis of Ruth” in the present volume. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 551 I have already voiced my objections to considering the clauses with hyh automatically off-line (§1e above); it is even said to be ‘Band 4: Setting’ together with the simple nominal (verbless) clause (p. 63). I also have reservations against seeing the negation of a verb clause as off-line per se, even ‘Band 5’ (p. 63). The reason is that in Hebrew the only way of negating wayyiqtol is using aløw“ + qatal; on the other hand, qatal is negated with alø + qatal, and xqatal (i.e. a second position qatal) with x + alø + qatal. As a consequence aløw“ + qatal is not a qatal but a negated wayyiqtol; syntactically, it is on exactly the same level with wayyiqtol. What justification is there, then, to classify it as ‘Band 5’? The only criterion that one can imagine is personal interpretation, certainly not syntax of the Hebrew verb. Interpretation is also the criterion to identify paragraphs. In fact, D. quotes with approval the following definition: Any group of sentences that go together by virtue of cohesion and/or coherence can be shown to have the structure of an (embedded) paragraph of a recognizable type (p. 64). A paragraph is a unit of the text composed of foreground clauses and related background clauses. I consider the background clauses, that are nominal in nature (i.e. verbless or having a finite verb in the second place), to be syntactically dependent on the foreground clause(s) although they are not dependent grammatically – i.e. not governed by subordinating conjunctions like yKi, ˆ['m'l], rv,a} etc. Indeed, background cannot exist in the text without its foreground on which it relies. Note that my definition of a paragraph is purely syntactic (i.e. based on the function of the verb forms used). It does not exclude a semantic definition of a paragraph but the latter should take note of the first and base itself on it. In sum, we have to understand the function of each type of clause in relationship to the others. In this way an acceptable ‘verbal rank scheme’ can be established. As already observed, an introduction to Tagmemics is presented in Ch. 3 in order to help the reader better understand Joseph. A second goal of this presentation is to explain ‘Embedding.’ I must confess that I had a hard time with this concept until the end of the book. Thus, I prefer quoting what is most important for its understanding: A shorthand term for both ‘recursive’ exponence and ‘back-looping’ exponence is ‘embedding’. One could say that ‘a growing distrust of their frequent prevaricating’ is a Noun Phrase in which the Modifier of the Noun Phrase ‘a growing distrust’ is expounded recursively by another Noun Phrase—‘of their frequent prevaricating’. This specifies the exact relationship of the filler to the slot. In this volume, as is done in many others, I will sacrifice some of this precision, and will bypass explicit statement of the nature of this exponence (except where an explicit statement is necessary); the result is that I will describe the above phrase as a ‘Noun Phrase that contains an embedded Noun Phrase’. In this inquiry I will refer to ‘a Narrative text embedded in an Expository text’, ‘a Predictive paragraph embedded in a Narrative History speech formula’, and so on. The concept of 552 RECENSIONI embedding is the most important to my later discussion of those which have been described so far; the material preceding this has served primarily as background so that this feature may be the more readily understood. (…) This concept of ‘embedding’ is a considerable help in elucidating the grammatical role of Reported Speech in, say, Narrative History, since it highlights the interconnectedness between Reported Speech and the framework that supports it. This is essential for the integrity of the framework, and also permits us to examine Reported Speech as individual, fully self-contained, units, which also happen to function as part of something else. The benefit of this is that we are able to ask questions of individual Reported Speech texts, and compare them selectively (for example, to other units of the same text-type), so as to gain a greater understanding of the features of distinctive texttypes. Likewise, we gain insights into the nature of Reported Speech as a grammatical/ syntactic mechanism by approaching it in this way. I will, as I have intimated above, return to this in fuller detail in Chapter 5 (pp. 92-93; italics in the original). After reading the rest of the book, one cannot avoid the suspicion that the whole concept of embedding has been formulated to resolve a problem posed by the theory of the four text-types – ‘Narrative History,’ ‘Narrative Prediction,’ ‘Hortatory,’ and ‘Expository’ (pp. 115-116), all belonging to the category of ‘discourse.’ The problem is the presence of qatal at the beginning of a Narrative History in Reported Speech, that is, what D. calls ‘Narrative History embedded in Reported Speech,’ and myself ‘narrative discourse,’ or ‘oral narrative’ (I must apologize for the confusing terminology!). Now, according to D.’s ‘Narrative History Cline’ (p. 115), qatal (‘Perfect’) is classified as ‘Band 2: Backgrounded Actions,’ but even common-sense analysis shows that this is not the case in certain passages (see examination of texts below, §§5ff.). Precisely for this problem, I think, embedding is envisaged. I will come back to this subject later in my exposition in order to discuss this solution (§9f below). The already-mentioned four text-types are defined according to a matrix consisting of ‘four broad categories – NARRATIVE, PROCEDURAL, BEHAVIOURAL and EXPOSITORY’ (p. 95). Besides the binary opposition ‘+ Agent Orientation’ versus ‘– Agent Orientation,’ a third parameter needs to be applied called ‘Projection.’ The eight ensuing categories are then described (pp. 97100). Finally, D. comes to the internal structure of the text-level units. This structure is marked by features that can be collected into two loose groups: the first includes those features which tend to extend throughout the length of the text—they are roughly similar to the ‘warp’ in woven cloth; the second includes those features which tend to break up those in the first category—they are comparable to the ‘weft’ in woven cloth. As with woven cloth, it is the working together of these features that results in a completed product (p. 100). Among the ‘longitudinal’ features D. examines ‘Main-Line’ versus ‘Off-Line,’ on the one hand, and ‘Foreground’ versus ‘Background,’ on the other. The distinction he establishes between the two pairs requires some attention. The opposition between main-line and off-line is a syntactic question; the opposition ‘foreground’ versus ‘background’ is similar, but it is more a ‘notional’ distinction—in some ways, it is a deep structure distinction that is encoded by a surface structure oppo- DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 553 sition of mainline clauses versus off-line clauses. Foreground material is that which moves the story/exhortation/instruction/etc. toward its essential goal (whether that be the highlighting and resolution of a peak event, or some other text-type-appropriate goal). Background material is that which does not significantly advance the story/ etc. Both ‘off-line’ and ‘background’ material can be categorized in terms of ‘distance from the main-line’ or ‘degree of backgrounding’; the more unlike the main-line clausetype can be shown to be (in terms of tense–aspect–mood values, for example), the further off-line it can be said to be. This is the principle behind Longacre’s clines (p. 102). What we read here is really interesting;15 yet, I am unable to understand the above distinction. The opposition ‘main-line’ versus ‘off-line’ is said to be syntactic, but it is not clear what is meant by syntax. The other opposition ‘foreground’ versus ‘background’ is said to be ‘notional,’ or maybe deep-structure; it consists in the opposition between ‘what moves the main line further’ and ‘what does not.’ Moreover, different ‘degrees of backgrounding’ are established according to the degrees of ‘distance from the main-line.’ Again, according to which criteria are we to measure the ‘advancing capability’ of a verb form and its ‘distance from the main-line’? Semantics is this answer, and nothing else. I do not have anything against semantics but it must be subservient, not contrary, to a sound syntax of the verb (see §1e). As a further element in the analysis D. mentions ‘plot,’ which is a literary term. D. explains that this ‘wandering outside our own domain’ “merely underlines the interdependency of these various ways of approaching texts” (p. 104). He then goes on to list seven elements of the surface structure in a typical Narrative History text (and in other text-types in some way), and nine corresponding elements of the deep structure. Following Longacre, he explains that “these deep- and surface-structure features give to the text a ‘profile’” (p. 106). He also explains the overlapping and interleaving of these features. One may feel uneasy with this description. One wished, first, that the different levels of analysis – syntactic, text-linguistic and literary – might be kept distinct, and, second, that they might be interrelated and ordered in a progression from lower to higher levels. There is a danger of escaping from the problems encountered on the syntactic level to a solution on a higher level or on the deep structure. I always feel uncomfortable with the practice of resorting to a deep-structure explanation at the expense of the surface structure. The only verifiable structure of the text is the surface structure. §3. Methodology. Coming to his own methodology, D. looks for a suitable working hypothesis. He writes: 15. One should mention that the notion of ‘foreground’ versus ‘background’ has been also advanced by German scholars like W. Schneider and W. Groß; see complete references in Syntax, p. 15. There is an unfortunate lack of communication between English-speaking and German-speaking grammarians; e.g., see the bibliography given in: Groß - Irsigler - Seidl (ed.), Text. 554 RECENSIONI I have enumerated several factors above which influence the choice of question(s) we will ask of the data. The question must also be formulated in such a way to lead us to a productive answer. ‘Do verbs have a macro-syntactic significance?’ would be next to useless as working hypothesis; we need a starting point that will result in a concrete observation about the language. ‘Does the distribution of verbs with hyh in non-Reported Speech’ sections of Narrative History, in comparison with other clause-types, indicate possible macro-syntactic significance?’ is a much more functional hypothesis (p. 110; italics in the original). And in note 88 he observes: In fact, this is a kind of sub-hypothesis, since it would be correlative to other questions we must ask at the same time. Perhaps the ‘umbrella’ hypothesis might be: ‘Do suspected clause-level macro-syntactic devices for non-Reported Speech of Narrative History converge to frame a complete picture of the constituent structure of the text?’. Were we to be strictly legalistic about this, hypotheses could not be framed as questions, but would have to take the form of ‘if–then’ sentences. This last scruple is perhaps helpful on occasion, but I tend to bypass it, since the question form accomplishes the task sufficiently well, and without any great ambiguity (p. 110). Despite D.’s honest intention (only announced, though) of disproving his working hypothesis as a means of substantiating it (p. 111), I feel lost. We are told that asking about a macro-syntactic significance of the verb forms would be an almost useless working hypothesis. (Needless to say, I believe just the opposite – the verb forms are the main starting point for syntactic and macrosyntactic analysis; see §1e above.) This raises two questions: are we talking the same language?, and, are we talking about syntax at all? One suspects that behind all this there is a specific presupposition: that macro-syntax is not syntax in the normal sense – i.e. describing the functions of the verb forms in the text – but only identifying the text-types and controlling the ‘profile’ of the text, thus bypassing the plain, syntactic research. Only one who has no confidence in syntactic analysis can make such statements. On the other hand, what D. presents as a ‘more functional’ working hypothesis does not seem to be formulated in such a way as to be faithful to his own ‘hobby-horse’: ‘good theory–good methodology–good communication’ (p. 216). It is difficult to appreciate the linguistic importance of the distribution of hyh in the different clause-types, so that it would be justified to adopt it as a working hypothesis. Besides, as far as one can see, this is not the main working hypothesis in the examination of texts in Ch. 4 and 5 (see also next paragraph). As for his theoretical starting point, D. writes: We have looked at Longacre’s matrix of ‘notional’ text-types, and I have cited his ‘verb rank clines’ of main-line and off-line forms as being particularly productive for Classical Hebrew; we have also looked at constituent structure of texts as something that may be marked by off-line features. I will therefore take as my starting point these theoretical concepts, and examine the data to see whether they are, in fact, viable for describing our language. I have also dealt bluntly with Niccacci and Eskhult, in terms of their treatment of ‘discourse’ (i.e. ‘Reported Speech’), and have suggested that their analyses are deficient because they do not deal well with this feature of the text (p. 114). DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 555 On pp. 115-116, D. lists the ‘verb-rank clines for the four text-types,’ taken from Joseph with only minor changes in terminology. Since I have already commented on the ‘Narrative History Cline’ (see §2 above), I only need to make a remark on ‘Band 2: Backgrounded Actions’ of the same. A distinction is made there between ‘2.1 Perfect [i.e. qatal]’ and ‘2.2. Noun + Perfect (with noun in focus),’ i.e. x-qatal. This statement is true and false at the same time because it does not envisage the basic distinction between historical narrative, on the one hand, and direct speech, on the other. Actually, qatal is an initial verb form in direct speech, but not in historical narrative where it is a second place verb form, i.e. x-qatal; and x-qatal has the function of putting ‘the noun [i.e. ‘x’ element] in focus’ mostly in direct speech, very rarely in historical narrative.16 As for the ‘Narrative Prediction Cline’ (p. 115), I agree that the main-line is indicated by ‘wc + Suffix,’ i.e. weqatal; one should note, however, that no direct speech (or ‘Reported Speech’) of any kind begins with weqatal. In other words, weqatal does express the main-line, it also appears in a chain of the same kind of verb forms, but it does not start the main-line; the main-line is started mostly by a verbless clause (or ‘simple nominal clause’ in my terminology) or by an indicative x-yiqtol (i.e. non-initial yiqtol; see §4c below). Thus, x-yiqtol at the beginning of a direct speech is a main-line form exactly as weqatal, and therefore one should object against classifying ‘Prefix’ (i.e. yiqtol) simply as ‘Band 2: Backgrounded Predictions.’ The objections raised against the analysis of the hNEhi clauses in the ‘Narrative History Cline’ (§2 above) are even more relevant to the ‘Narrative Prediction Cline,’ because hNEhi is a particle of direct speech, and ‘Narrative Prediction Cline’ is direct speech. It seems impossible, therefore, to classify the hNEhi clauses as ‘Band 3: Backgrounded Activities.’ The reason for this classification is presumably the fact that the main-line form is weqatal and therefore all the rest is considered off-line. This is inappropriate, however, because direct speech easily shifts from the future (characterizing the ‘Narrative Prediction text-type’) to the present (characterizing, among others, the hNEhi clauses) and to the past (characterizing the oral narrative; see §4c below). In the ‘Narrative Prediction Cline’ (p. 115), a number of constructions are classified as ‘Band 4: Setting’ that do not belong together syntactically. As noted above (§2), there is no justification in regarding the forms of verb hyh as ‘Setting’ per se; rather, hyh is to be considered according to its grammatical forms and respective function(s) as any other verb. As for the ‘nominal clause (verbless),’ it can express setting but it can also be a main-line construction with present reference. The same applies to the ‘existential clause with yëå’ that is both a mainline construction with present reference (as in ‘Band 1’ of the ‘Expository Cline,’ p. 116) and a circumstantial construction expressing setting. 16. I would refer to Syntax §6 for direct speech, and §48 for historical narrative. 556 RECENSIONI ‘Band 1: Primary line of Exhortation’ in the ‘Hortatory Cline’ correctly includes all the volitive forms (p. 116). However, one should object to classifying the negative construction la' + ‘Jussive / Prefix’ (i.e. yiqtol) as ‘Band 2: Secondary Line of Exhortation’ since this is precisely the way of negating the volitive forms. As observed on the ‘Narrative History Cline’ (§2), the positive verb forms and their negative counterparts have the same syntactic status. The other item in Band 2, called ‘Modal Prefix,’ is the indicative yiqtol (appearing as xyiqtol). Now, there is no justification in classifying this ‘modal’ yiqtol as Band 2 and weqatal (or ‘wc + Suffix’) as ‘Band 3: Results / Consequences (Motivation).’ Finally, in the ‘Expository Cline’ (p. 116), only ‘Band 1: Primary Line of Exposition’ is clearly defined; it comprises ‘Nominal clause (verbless)’ and ‘Existential clauses (with ˆyae or vyE).’The rest remains vague. In sum, the four ‘Clines’ are too theoretical and much too rigid. Real texts are variable, and ‘pure’ text-types are rarely found because direct speech easily shifts from future to past and to present reference.17 As a result, the ‘Clines’ are often inapplicable without making violence to the texts. This shall become clear later in the discussion of the texts examined by D. (§5ff. below). What has been said means that one would do well to forget the text-types as the starting point of syntactic analysis. Other models of text-linguistics do exist. Once a sound text-linguistic syntax has been established, text-types can be investigated on a firmer basis. In p. 119, D. explains his ‘charting methodology,’ that is, the way he arranges the clauses of a text according to the ‘text-types clines.’ It is not easy to understand his theoretical explanation, especially concerning subordinated and non-subordinated material in Reported Speech. If one looks at the different charts and the two Appendixes at the end of the book, the result is frankly confusing. In fact, D. distinguishes ‘subordinated Reported Speech’ (i.e. clauses that are governed by subordinating conjunctions such as yKi, ˆ['m'l], rv,a} etc.) from normal, ‘non-subordinated Reported Speech’ (pp. 156; 176). On this basis, he establishes four columns: ‘A: un-subordinated narration’; ‘B: subordinated narration’; ‘C: un-subordinated rep’d speech’; ‘D: subordinated rep’d speech.’ Soon after, the four columns become two: ‘Narration’ comprising A and B, and ‘Reported Speech’ comprising C and D, although it seems that B is also Reported Speech. However, the columns are three in the charts on pp. 128 and 133 and they are marked by the symbols ‘ML,’ ‘OL,’ and ‘Sub’ whose meaning is explained in p. 127 as ‘main-line non-subordinated clauses,’ ‘offline non-subordinated clauses,’ and ‘subordinated clauses,’ respectively. Reported Speech is not examined there but is indicated with a ‘—’ sign. In the examination of the Reported Speech material in Jephthah and Ruth (Ch. 5), 17. This is recognized by Dawson himself; see his remark no. 2 in p. 207, and my discussion in §10 below. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 557 again three columns are used; however, they are not the same as those on pp. 128 and 133, since the first (from right to left) is for the Speech formula, the second for the un-subordinated Reported Speech, the third for the subordinated Reported Speech. Finally, in the Appendixes also three columns are used but again different: the first is for the un-subordinated narration, comprising both mainline and off-line clauses; the second for the subordinated Reported Speech, and the third for the un-subordinated Reported Speech. The least that one can say is that this ‘charting methodology’ is not particularly helpful to the reader. §4 Verbal System in ‘Discourse’. Before coming to the examination of the texts, I wish to comment on two remarks done by D.: first, qatal at the beginning of a Narrative History in a Reported Speech can be a ‘stage-setting form’ as in Narrative History outside Reported Speech; second, my Syntax did not develop a suitable description of Reported Speech (see pp. 36 and 32, respectively). §4a Beginning of Oral Narrative. In the present writer’s view, the beginning of an oral narrative (or ‘Narrative History in Reported Speech’ in D.’s terms) is different from that of a historical narrative (or ‘Narrative History outside Reported Speech’). At the beginning of an oral narrative, qatal (i.e. clause-initial qatal) or x-qatal (i.e. second-place qatal) is a main-line form, whereas x-qatal at the beginning of a historical narrative is off-line form expressing ‘antecedent information,’ or the ‘setting’ of a story. Although it might appear minor, this controversy is in fact major because it constitutes D.’s main argument against distinguishing historical narrative from direct speech as the two genres of the prose; it is also the principal contribution of his research. Actually, this controversy entails the problem of the syntax of direct speech in general. The position of the present writer is not an a priori but a conclusion of several facts. First, there are clear cases where nominal clauses (i.e. with a finite verb in the second place or without any such verb) in historical narrative indicate the setting of a story (Syntax §§16-19), while I know of no such cases in oral narrative. Second, there are clear cases where (clause-initial) qatal, or x-qatal, in an oral narrative contrasts wayyiqtol in historical narrative for the same fact – first narrated, then reported orally – and both constitute the main line of communication (Syntax §§22-23). Third, an oral narrative frequently uses wayyiqtol forms in the first and second person; a suitable example is the first speech of Moses in Deuteronomy with rm'aøw: ‘I said’ (Deut. 1:9), wWn[}T'w" ‘you answered’ (1:14), jQ'a,w" ‘I took’ (1:15), hW<x'a}w: ‘I commanded’ (1:16; 1:18), [S'NIw" ‘we departed’ and abøN:w" ‘and we came’ (1:19), rm'aøw: ‘I said’ (1:20), ˆWbr“qTiw" ‘you draw near’ (1:22) etc., whereas first and second person wayyiqtol is totally absent in historical narrative. Fourth, an oral narrative begins with qatal or x-qatal, never with wayyiqtol – e.g. Moses’ speeches in Deuteronomy begin with x-qatal (Deut. 1:6; 5:2) – whereas wayyiqtol is frequently found at the beginning of a historical narrative, even at the beginning of books – e.g. 1 Sam 1:1. These are facts, not allegations, and deserve proper consideration. Until these facts are disproven, I adhere to my opinion. 558 RECENSIONI §4b Discourse and Narrative. At this point, the verbal system in ‘discourse,’ or Reported Speech, needs to be expounded. The distinction between ‘discourse’ (Besprechung) and ‘narrative’ (Erzählung) has been proven to be basic in the Neo-Latin languages, which have complete, separate sets of verb forms for the two genres of the prose. In W. Schneider’s and M. Eskhult’s opinion as well as mine, among others, this distinction is also basic for Biblical Hebrew with one difference: the latter does not have complete, separate sets of verb forms for the two genres.18 Of the four text-types admitted by D., my category of ‘discourse’ comprises the Procedural, the Behavioural, and the Expository; it does not comprise the Narrative. These three categories use basically the same verb forms but with different frequency. No verb forms are exclusively found in any of them although, of course, weqatal predominates in Procedural/Predictive, the volitive (‘command’) forms in Behavioural/Hortatory, and the verbless clause in Expository text-type. Conversely, these three categories, taken together, do show distinctive, exclusive verb forms against historical narrative. This opposition is significant with respect to the verb forms used in the texts. As a consequence, it is not correct to subsume the four text-types under the same umbrella of ‘discourse.’ A suitable umbrella for all the four text-types is ‘communication,’ or ‘communication process.’ In sum, two genres are justified in terms of text-linguistic syntax: direct speech and historical narrative; the four text-types may be justified in terms of higher, literary analysis. §4c Verbal System in Direct Speech. Direct speech is much more complex than historical narrative. The reason is that while the latter only uses the axis of the past, the first uses all the three axes available – past, present and future – as the main line of communication (Syntax §§52-53). As a consequence, historical narrative has one verb form only for the main line, i.e. wayyiqtol, while the other verb forms and constructions are used for the secondary line (‘off line’). Direct speech, on the contrary, has a larger choice of verb forms for the main line of communication according to the three temporal axes: - in the axis of the present – simple nominal (verbless) clause; - in the axis of the past – (clause-initial) qatal, or x-qatal, and wayyiqtol as continuation form; - in the axis of the future – indicative x-yiqtol as the initial verb form, and weqatal as continuation form; volitive forms (imperative, cohortative/jussive yiqtol, and weyiqtol). The following are the verb forms used in the secondary line of communication: - in the axis of the present – simple nominal (verbless) clause, volitive forms in the second place (e.g. jussive x-yiqtol); 18. See my paper, “On the Hebrew Verbal System,” Tables 1-3. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 559 - in the axis of the past – x-qatal (not clause-initial qatal!); - in the axis of the future – x-yiqtol (not weqatal!). §4d Volitive versus Non-volitive Forms. With this classification of the verb forms used in direct speech, all kinds of ‘discursive’ material (i.e. excluding historical narrative) can be analyzed. Problems do remain in specific cases especially with the volitive forms. However, I think that the ‘volitional material’ can be analyzed with sufficient confidence by applying the following pattern of volitive forms versus non-volitive forms.19 Volitive forms (x-) yiqtol weyiqtol imperative (or other volitive forms) → weyiqtol = ‘do this → in order that you may …’ versus versus versus versus Non-volitive forms x-yiqtol weqatal imperative (or other volitive forms) → weqatal = ‘do this → and as a consequence you will be able to …’ §4e Mixed Genres. Not all the verb forms used are distinctive and exclusive of one of the genres of the prose – direct speech and historical narrative. In contrast with Neo-Latin languages, Biblical Hebrew shows mixed genres: historical narrative with ‘discursive’ forms, on the one hand, and direct speech with ‘narrative’ forms, on the other. A historical narrative with much discursive forms can be called ‘narrative with comment’ (Syntax §83, with 1 Kgs 6 as a typical example),20 and a direct speech with much narrative forms ‘narrative discourse’ (Syntax §§74-76, with Judg. 11:1-28 as a typical example). These mixed genres show a repeated use of forms that are not distinctive of the basic genre, as simple nominal (verbless) clause, yiqtol and weqatal in historical narrative, on the one hand, and wayyiqtol in direct speech, on the other. It is important to note that non-distinctive forms are used differently from their basic genres. In fact, simple nominal (verbless) clause is a main-line construction in direct speech while it is off-line (circumstantial) in historical narrative; similarly, yiqtol and weqatal are main-line forms in direct speech (in the axis of the future) while they are off-line in historical narrative (they are descriptive or express duration, habit, in this case); and wayyiqtol begins historical narrative while it is a continuation form in direct speech (in the axis of the past).21 19. See Syntax §§61-65; and my paper, “A Neglected Point of Hebrew Syntax: Yiqtol and Position in the Sentence,” LA 37 (1987) 7-19, §1. 20. ‘Narrative with comment’ (in Italian: ‘narrazione commentativa’) is a better designation than ‘comment in the guise of narrative’ as in the English translation; see Syntax, p. 14. 21. A summary on the use of the verb forms is found in Syntax, Ch. 9. 560 RECENSIONI It seems that this description of the verbal system in ‘discourse’ cannot be said to be confused; it is complex and describes the situation in a flexible and coherent way. The main cause of problems is the poverty of verb forms in Hebrew. As already mentioned, Neo-Latin languages possess distinctive and exclusive sets of verb forms and do not show mixed genres. §5 Examination of Texts – Judges 2. After what has been said, nobody will expect from D. much syntactic analysis in normal sense; he rather presents a ‘text-linguistic analysis’ based on the text-types. After a general literary examination of each text (beginning and end), the clauses are counted; then, the clauses are described according to the designations used in the four ‘Clines’ presented in pp. 115-116, and the text-types are determined on the basis of the percentage of the clauses attested; the ‘profile’ of the text is finally investigated and ‘peaks’ are detected with the help of the off-line forms. The first text examined is Judges 2 (p. 124).22 Here I will comment on certain points of D.’s analysis. Clause ‘2.18.1’ is said to be ‘Ellipsis’; it is represented as ‘[…]’ on p. 222, but no explanation is given. This clause is found inside a very interesting (and intriguing) passage that merits a careful syntactic analysis – Judg. 2:17-19. For a quick comparison, D.’s numbers identifying each clause are shown in the first column.23 12.17.1 Even to their judges did they not listen 12.17.2 but they fornicated after other gods 12.17.3 and bowed down to them; 12.17.4 they soon turned aside from the way 12.17.5 in which their fathers had walked by obeying the commandments of the Lord; 12.17.6 they did not do so. 24 12.18.1-2 And when the Lord had raised up judges for them, 12.18.3 the Lord used to be with the judge, W[mev; alø µh,˝yfep]voAla, µg"˝w“ µyrIjea} µyhiløa‘ yrEj}a' Wnz: yKi µh,˝l; Wwj}T'v]YI˝w" Ër<D<˝h'Aˆmi rhem' Wrs… µ˝t…/ba} Wkl]h; rv,a} hw:hy“AtwOx]mi ["mov]˝li ˆk´ Wc[…Aalø hw:hy“ µyqiheAyki˝w“ µyfip]vo µh,˝l; fpeVo˝h'Aµ[i hw:hy“ hy:h;˝w“ 22. The text ‘in Columnar Format’ is found in Appendix 1, pp. 220-222. This text has been also examined by the present writer in Lettura sintattica §15. 23. The first number indicates the chapter, the second the verse, and the third the clause. Each line is one sentence. Some clauses are divided into parts because of their length. 24. As already noted, clause 2.18.1 (‘Ellipsis’) is simply non-existent. DAWSON 12.18.4 12.18.5 12.19.1 12.19.2 12.19.3 TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 561 dY"˝mi µ˝[;yvi/h˝w“ of their enemies all the life of the judge; fp´/V˝h' ym´y“ lKo µh,˝ybey“ao for the Lord used to be moved to pity hw:hy“ µj´N:yIAyKi by their groaning because of ynEP]˝mi µ˝t;q;a}N"˝mi those who afflicted and oppressed them. µh≤˝yqej}do˝w“ µh,˝yxej}lø But it used to happen that when the judge died, fpe/V˝h' t/m˝B] hy:h;˝w“ they used to turn back Wbvuy: and behaved worse than their fathers µ˝t;/ba}˝m´ Wtyjiv]hi˝w“ by going after other gods µyrIjea} µyhiløa‘ yrEj}aæ tk,l,˝l; to serve them and to bow down to them; µh≤˝l; twOj}T'v]hi˝l]˝W µ˝d:b][;˝l] they did not drop any of their practices µh,˝ylel]['Mæ˝mi WlyPihi alø or their stubborn ways. hv…Q;˝h' µ˝K…r“D"˝mi˝W and he used to save them from the hand All the verb forms are off-line. The wayyiqtol in 2.17.3 is not main-line, but continuation, off-line form because it continues a subordinate qatal clause (Syntax §146:2). This phenomenon, correctly noted by D., is not as surprising as the following comment might make us to think: It is 2.17.3 which is the most intriguing—here we have an occurrence of a mainline Narrative clause assigned to a subordinated section. Though this may seem alarmingly out of keeping with my proposed assignment of wc + Prefix forms [i.e. wayyiqtol] to the main line, this clause is clearly to be considered a continuation of the previous clause, which in itself is subordinated (p. 130; the rest of the comment may be dispensed with). More important is to observe the function of weqatal – a form of direct speech – in historical narrative. As mentioned above (§4e), it conveys a description, or a custom; I have rendered this aspectual value, that is lacking in English, by a paraphrase, ‘used to.’ The difference in function from direct speech in the axis of the future, or ‘Narrative Prediction’ in D.’s terms (p. 115), where weqatal expresses simple future, is unmistakable. Indeed, direct speech and historical narrative are significant for the syntax of the verb. On the contrary, none of the four ‘Clines’ adopted by D. are able to handle this text. As signs of this unease with weqatal in historical narrative a couple of unfortunate remarks by D. may be mentioned. The first concerns 2.17.4 (in his terms, ‘Asyndetic Suffix clause’) and 2.19.2 (‘Suffix clause with -w copula’). In this, and in the preceding category, we have two examples of what Niccacci says cannot happen (‘The QATAL which has first position in the sentence is distinct from a second position QATAL. The first kind occurs in discourse [my ‘Reported Speech’] but never in narrative’ [Syntax, p. 30]). My analysis will have less difficulty explaining this feature (note 7, p. 125). 562 RECENSIONI One would observe that, while 2.17.4 is a ‘nude’ qatal, 2.19.2 is a weqatal (i.e. the ‘inverted’ verb form) – not waw ‘copula’ + qatal,25 because it plays the same function as the other weqatal forms of the passage (2.18.3-4; 2.19.1 first verb) and as yiqtol in 2.19.1 (second verb).26 Both qatal and weqatal are off-line forms in historical narrative, the difference being one of aspect, i.e. repeated versus single action. The ‘nude’ qatal in 2.17.4 is explained as coordinated to 2.17.2, and thus contrasting 2.17.1, which is a waw-x-qatal clause; therefore, it is really a non-initial verb form. The same is true of Wc[…Aalø in 2.17.5, a negated qatal.27 Therefore, what is affirmed in Syntax, p. 30, is not invalidated. The second unfortunate remark concerns 2.18.4: On the other hand, I would propose that the material in the longer section, flanking as it does the single main-line clause ‘and he saved them from the hand of their enemies all the days of the judge’ (2.18.4), serves to identify the peak event in the section (p. 129). 25. Usually, two functions of weqatal are listed by grammarians: the inverted, or consecuti- ve form, and the non-inverted, or non-consecutive, form. The first is the one described above (§4e); it represents the future tense in direct speech and has aspectual value in historical narrative (custom, repetition, or description). The second is found in historical narrative with the function of expressing a single action in the past, a phenomenon not fully explained as yet; see Syntax §158 (ii), pp. 183-186. In his paper, “Weqatal Forms in Biblical Hebrew Prose: A Discourse-modular Approach,” in: Bergen (ed.), Biblical Hebrew, 50-98, R.E. Longacre proposed a different approach: “The purpose of this paper is to employ a discourse-modular approach in which (1) the consecution of tenses as such is reduced to a place of lesser importance; (2) the role of weqatal forms as backbone structures in predictive, procedural, and instructional discourse is recognized as primary; (3) most of GKC’s examples of weqatal as frequentative in narrative are explained as embedded procedural discourse; and (4) most of GKC’s residues in narrative are explained not as consecutive forms but rather as constituting a marker of pivotal/climatic events.” Being the initiator of the theory of the four text-types adopted by Dawson, Longacre finds it difficult to explain the function of weqatal in historical narrative. Therefore, he tries two ways: first, frequentative weqatal in narrative is explained as ‘embedded procedural discourse’; second, non-frequentative weqatal is taken as a marker of ‘pivotal/climatic events.’ Thus, he bypasses syntax by resorting to higher literary analysis of the ‘profile’ of text. Note how he plays down the syntactic functions of the verb forms — what he calls ‘the consecution of tenses.’ Pace Longacre, I have strong reservations against this methodology; see e.g. §2 above (by the end). 26. This yiqtol Wbvuy: constitutes a clause by itself although I did not attribute a special number to it following Dawson. In fact, this yiqtol is the apodosis of a ‘double sentence’ (called ‘the two-element syntactic construction’ in Syntax, Ch. 8); the protasis is the prepositional phrase fpe/V˝h' t/m˝B] — same protasis and apodosis are found in Exod. 40:36; see Syntax §102. The verb form hy:h;˝w“ added in front of the double sentence has a macrosyntactic function: it makes the double sentence verbal and expresses the aspect of custom, or repetition, characteristic of weqatal in historical narrative. On the macro-syntactic function of hyh consult Syntax §§28-36; Lettura sintattica §§4.3; 24. Note that in the secondary line of communication, aspect (i.e. repetition, contemporaneity, anteriority) is significant for the choice of the verb forms, while in the main line the verb forms are tenses, and aspect plays no role. See Syntax §133; Lettura sintattica §6.2. 27. See Lettura sintattica, pp. 135-136. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 563 Strangely enough, 2.18.4 is considered ‘the single main-line clause’ of the passage while it is a weqatal, not a wayyiqtol.28 Other comments of detail can be added. For D., the closing clause in Judg. 2:23, [æv¨/hy“Ady"˝B] µ˝n:t;n“ alø˝w“ “and he did not deliver them in the hand of Joshua” is ‘“a momentous negation” clause’ (p. 125). Syntactically, aløw“ + qatal negates a wayyiqtol and is coordinated to the preceding clause having a wayyiqtol. This is the only fact; the rest is speculation. Dawson illustrates the interplay of main-line, off-line and subordinated forms in the text with a musical imagery (pp. 127-128). In my system, the main-line and off-line forms are significant with regard to the flow of the communication process; they indicate connections and interruptions, respectively. They also give different relief to the text by alternating foreground and background (in the sense of H. Weinrich’s Reliefgebung). Without off-line forms the text would be uniform, poor on information and boring. By using foreground and background the author organizes information in a meaningful way as to influence the reader. It is important, therefore, to note and respect the syntactic texture of the text in order to appreciate the author’s strategy of communication.29 §6. Leviticus 14. Lev. 14, that presents a long series of instructions concerning the ritual cleansing of a leper, is a good example of ‘Narrative Prediction,’ or ‘Procedural’ text. According to the ‘Cline’ of this text-type (p. 115), weqatal is the main-line form, the rest is off-line in different degrees. This cline, however, appears to be not flexible enough even to handle a uniform, strictly ‘Procedural’ text such as Lev. 14. The presence of four simple nominal (verbless) clauses in a total of 81 (p. 134) is enough for D. to posit a different, ‘Expository’ text-type. However, it is only natural that ‘14.2.1’ and ‘14.32.1’ are introduction and conclusion, respectively, and that the two coordinated ‘if’ clauses 14.21.1-2 (hardly ‘existential clauses’ as D. calls them, p. 132) introduce an alternative situation to which appropriate instructions are attached – a normal ‘casuistic instruction.’ In brief, the text shifts from the axis of the present (title, case, symptoms) to the axis of the future (what to do). Such a text, which shows strings of weqatal forms and describes ‘what to do,’ can indeed be called ‘Procedural,’ or more generally instructional. On the contrary, this label is forced in other cases where we have sparse weqatal forms and/or not a proper procedure or instruction. Indeed, not every weqatal or string of weqatal is ‘procedural’; besides, no text-type can be taken too rigidly. The following examination will make clearer my point. 28. In the same paragraph in p. 129, as in the chart of the previous page and elsewhere, a clause ‘14.5’ is mentioned that does not appear in the text of the Appendix (p. 221); therefore I was unable to locate it. 29. See on this Lettura sintattica §7.5; and also “Analysis of Biblical Narrative,” and “The Stele of Mesha and the Bible.” 564 RECENSIONI A section of Lev. 14 is examined here in order to show how the verbal system proposed in §4 above functions in a concrete text. 14.2.1 14.2.2 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4.1 14.4.2 14.5.1 14.5.2 14.6.1 14.6.2 14.7.1 14.7.2 14.7.3 14.8.1 14.8.2 14.8.3 14.8.4 14.8.5 14.8.6 14.9.1 [r:xoM]˝h' tr"/T hy<h]Ti tazO in the day of his cleansing. /˝tr:h’f; µ/y˝B] He shall be brought to the priest; ˆh´Ko˝h'Ala, ab…Wh˝w“ the priest shall go out of the camp; hn<j}M'˝læ ≈Wj˝miAla, ˆheKo˝h' ax;y:˝w“ the priest shall look at him ˆheKo˝h' ha;r:˝w“ and behold, the leprous disease has been cured t['r"X;˝h'A[g"n< aP;r“nI hNEhi˝w“ from the leper, [æWrX;˝h'Aˆmi then the priest shall command ˆheKo˝h' hW:xi˝w“ and shall take for him who is to be cleansed two µyrIP’xiAyT´v] rh´F'Mi˝l' jqæl;˝w“ living clean birds and cedarwood zr<a, ≈[´˝w“ t/rhof] t/Yj' and scarlet stuff and hyssop; bzOae˝w“ t['læ/t ynIv]˝W then the priest shall command ˆheKo˝h' hW:xi˝w“ and shall kill one of the birds tj;a,˝h; r/PXi˝h'Ata, fjæv;˝w“ in an earthen vessel over running water, µyYIj' µyImæAl[' cr<j≤AyliK]Ala, while he shall take the living bird H˝t;ao jQæyI hY:j'˝hæ rPoXi˝h'Ata, together with the cedarwood zr<a≤˝h; ≈[´Ata,˝w“ and the scarlet stuff and the hyssop, bzOae˝h;Ata,˝w“ t['læ/T˝h' ynIv]Ata,˝w“ and shall dip them and the living bird hY:j'˝h' rPoXi˝h' ta´˝w“ µ˝t;/a lb'f;˝w“ in the blood of the bird that was killed hf;juV]˝h' rPoXi˝h' µd"˝B] over the running water; µyYIj'˝h' µyIMæ˝h' l[æ he shall sprinkle it seven times upon him rh´F'Mi˝h' l[æ hZ:hi˝w“ who is to be cleansed of leprosy; µymi[;P] [b'v, t['r"X;˝h'Aˆmi then he shall pronounce him clean, /˝rh}fi˝w“ and shall let the living bird go hY:j'˝hæ rPoXi˝h'Ata, jLævi˝w“ into the open field; hd<C;˝h' ynEP]Al[' the one who is to be cleansed shall wash his clothes, w˝yd:g:B]Ata, rheF'Mi˝h' sB,ki˝w“ shave off all his hair, /˝r[;c]AlK;Ata, jLægI˝w“ and bathe himself in water, µyIM'˝B' ≈jær:˝w“ and he shall be clean. rhef;˝w“ Only after that he shall come into the camp, hn<j}M'˝hæAla, a/by: rj'a'˝w“ but shall dwell outside his tent seven days; µymiy: t['b]vi /˝lh’a;˝l] ≈Wj˝mi bv'y:˝w“ then on the seventh day y[iybiV]˝h' µ/Y˝b' hy:h;˝w“ This shall be the law of the leper DAWSON 14.9.2 TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW he shall shave all his hair – his head, his beard and his eyebrows – 14.9.3 literally all his hair shall he shave; 14.9.4 he shall wash his clothes, 14.9.5 and bathe his body in water, 14.9.6 and he shall be clean. 565 /˝varoAta, /˝r[;c]AlK;Ata, jLæg"y“ w˝yn:y[e tBoG" tae˝w“ /˝nq;z“Ata,˝w“ j"L´g"y“ /˝r[;c]AlK;Ata,˝w“ w˝yd:g:B]Ata, sB≤ki˝w“ µyIMæ˝B' /˝rc;B]Ata, ≈jær:˝w“ rh´f;˝w“ 14.2.1 is an indicative waw-x-yiqtol construction beginning the main line in the future axis (§4c). This line continues with a chain of weqatal. Note that (waw-) x-yiqtol30 is the main-line form found at the beginning of direct speech in the axis of the future, while weqatal is the continuation form. The chain of weqatal is not interrupted unless a change in the level of communication is to be brought about.31 This is the case in 14.6.1,32 14.8.5 and 14.9.3 (the case of 14.9.2 is different; see next paragraph). As a consequence, a (waw-) x-yiqtol in the course of a direct speech is a off-line verb form. Its function is to show that the following information does not stand on the same text-linguistic level with the one with weqatal; in other words, it conveys background information to the preceding foreground weqatal. Now, in 14.6.1 the reason for using waw-x-yiqtol instead of weqatal is to convey the fate of the second bird in comparison with the fate of the first one – not as an item separate from, and successive to, it. In 14.8.5 waw-x-yiqtol has the function of stressing the ‘x’ element (‘only after that’); similarly in 14.9.3 (‘literally all his hair’), after that the preceding apposition phrase (‘his head, his beard and his eyebrows’) specified the first instruction having the same content (‘he shall shave all his hair’). In 14.9.2 yiqtol is the apodosis, and the preceding prepositional phrase (‘on the seventh day’) is the protasis. As in Judg. 2:19 (§5 above), hy:h;˝w“ introduces a ‘double sentence’ and, being a weqatal form, places it in the main line of communication in the future axis. There is no reason for analyzing the apodosis 30. Waw is an optional element in this construction; it has no syntactic significance. What is significant is the position of the finite verb in the sentence. The same applies to (waw-) x-qatal. Consult Syntax §113. 31. The result is a tense shift from foreground weqatal to background waw-x-yiqtol, a tense shift parallel to the one from foreground wayyiqtol to background waw-x-qatal; the first is characteristic of direct speech, the second of historical narrative; see Syntax §11. On the various reasons for breaking the narrative chain of wayyiqtol consult Syntax §§39-49; by and large, they also apply to the discursive chain of weqatal. 32. The accusative pronoun H˝t;ao might be considered a ‘resumptive pronoun’ and the preceding hY:j'˝hæ rPoXi˝h'Ata, a casus pendens; see Syntax §124, and Lettura sintattica §4.6 on the criteria to identify a casus pendens. However, it seems preferable to think that H˝t;ao is expressed, though not needed, in order to add a second object; literally, “he shall take the living bird — it and the cedarwood” etc. 566 RECENSIONI (yiqtol) as an off-line form (see D.’s chart, p. 133) except for an undisputed fidelity to the theoretical ‘Narrative Prediction Cline’ of p. 115.33 Because of a similar fidelity, the hNEhi clause in 14.3.3 (‘the priest shall look at him, and behold, the leprous disease has been cured’) is classified as off-line form (see chart, p.133). On the interplay between main-line and off-line forms D. writes as follows: [The wc + Suffix forms, i.e. weqatal] tend to occur in strings. Where these strings are broken by non-subordinated off-line clauses, we can propose paragraph divisions, for example: 14.3.3 (…), 14.6.1 (…); or peak moments in the text, as in the following sequence 14.8.5 [etc. until 14.9.6]. The proposal that these ‘off-line’ clauses mark the peak events of the episode offers a reasonable explanation for the fact that the first shaving of hair is described with wc + Suffix (… 14.8.1 [in fact, 14.8.2]), while the second is encoded with the off-line ‘direct object + Prefix’ clause (14.9.3). (…) The off-line clauses used to mark paragraph division tend to occur singly; those which mark peak sections tend to occur in collections, and form clusters around single mainline clauses, or short strings thereof. This profile is so similar in nature to that of the Judges 2, Narrative History, text that it is difficult to understand how the existence of a Procedural/Instructional text-type has been overlooked by contemporary text-linguists (pp. 134-135; italics in the original). It is not easy to make sense of these statements. One wonders how the hNEhi clause in 14.3.3 can be a paragraph division, and whether the division is to be put before or after it. As a matter of fact, the hNEhi clause is strictly connected to the preceding verb of ‘seeing,’ on the one hand; on the other hand, the clause following it serves to instruct the priest in the case just described (i.e. in case the leper has been cured). Similarly, the off-line clause in 14.6.1 is connected to the previous clause as background to foreground. As a result, it seems impossible to see 14.3.3 and 14.6.1 as paragraph divisions. Second, the distinction between off-line clauses marking paragraph division, that occur singly, and those marking peak sections, that occur in collections, is a principle hard to verify. Here, for instance, of the eight clauses contained in 14.8.5-14.9.6, only the first contains an off-line form (waw-xyiqtol), while yiqtol in 14.9.2 is apodosis, as already mentioned. Moreover, among the eight clauses, one is with verb hyh, that is otherwise taken as a paragraph division marker by D. Third, it is difficult see how the ‘profile’ of Leviticus 14 is ‘so similar’ to that of Judges 2. Here as in other similar occasions, D. makes ‘text-linguistic’ statements without further explanations so that it is easy to miss his point. One gets the impression that his observations are rather at random and ad hoc; they contain more description than evaluation. §7. Leviticus 6-7. There is not much to learn from the very sketchy examination of Lev. 6-7 (less than two pages). As D. notes, 33. In the apodosis yiqtol, weqatal and x-yiqtol exchange freely in the axis of the future; see Syntax §113; Lettura sintattica §§4.2-4.4. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 567 The material is set into a Narrative History framework, where it is recounted that Moses was commanded by God to command the people (and here we have the Hortatory text-type, which uses command forms, and wc + Suffix clauses for the main line) to do certain things. Each of these units is introduced by a verbless clause beginning with taz (p. 136). It is surprising to read that the Hortatory text-type uses ‘command forms, and wc + Suffix clauses for the main line.’ First, the only ‘command forms’ are the three imperative (6:2; 6:18; 7:23); second, the ‘wc + Suffix clause,’ i.e. weqatal, is not a main-line form but ‘Band 3: Results / Consequences (Motivation)’ according to the ‘Hortatory Cline’ on p. 116. The structure of Lev. 6-7 can be outlined as follows: (1) ‘The Lord spoke to Moses saying’ (2) ‘Command to (Aharon and his sons; or to the Israelites) saying’ (3) ‘This is the law of the (holocaust; offering etc.)…’ (4) Instruction; main section. Wayyiqtol is used in (1), imperative in (2) and simple nominal (verbless) clause in (3). The instruction (4) begins with indicative x-yiqtol,34 continues with weqatal for the main line and x-yiqtol for the secondary line (expressing background information, or putting emphasis on an ‘x’ element of the sentence). Sometimes, (3) is missing. Even without doing a complete examination of Lev. 6-7, one can say that it behaves according to normal syntax. The same applies to other ritual material in Leviticus. §8. Parallel Pericopes from Exodus. Parallel texts are normally informative because they are favorite occasions to learn the potentialities of a language in expressing the same thing with different constructions.35 This is particularly true of the parallel pericopes from Exod. 25-30 and 35-40. They are called by D. ‘first account’ and ‘second account,’ respectively, but Ch. 25-31 are instruction by God and Ch. 35-40 execution of the same works by the Israelites. What is informative is the repetition of the same text first as instruction, afterwards as execution. These texts clearly show the syntactic structures characteristic of direct speech (instruction) and of historical narrative (execution). In his examination of these chapters, D. is interested, as usual, in identifying the text-types, boundaries in the text, peaks etc., while syntactic analysis is done 34. With infinitive absolute in 6:7; consult GK §113 cc, gg. 35. Parallel texts of the Bible are conveniently arranged in synoptic columns in a useful book by A. Bendavid, Parallels in the Bible, Jerusalem 1972. Besides these texts from Exodus, partially studied in Syntax §§58-59, parallel accounts in 2 Samuel 5-7 and 1 Chronicles 11ff. are fully examined in Lettura sintattica §§21-23. Note that in the table of Syntax, p. 88, one should read ‘Instruction’ instead of ‘Command’ in the first column, because weqatal is a non-volitive form; therefore, it does not convey commands but instructions. As mentioned above (§4d), the volitive counterpart of weqatal is weyiqtol. 568 RECENSIONI by percentage. I will only make some remarks on syntax. With regard to Exod. 36 he writes: There is a significant break in the pericope between vv. 13 and 14, which is marked by the pericope’s only wc + Prefix clause with hyh (36.13.3—dja ˆkvmh yhyw); this clause is followed by a clear topic shift (from the curtains of linen to the curtains of goats’ hair), and can therefore be said clearly to mark a paragraph boundary. This is consistent with the function of such hyh clauses in other Narrative History texts (cf. Judg. 2) (pp. 139-140). If we look at the parallel passages 36:13-14 and 26:6-7, we find the following correspondence of verb forms for the same items: Execution, wayyiqtol (Exod. 36:13) ‘and thus the sanctuary became one thing,’ with yhiy“w" (36:14) ‘and he made,’ c['Y"w" versus versus versus Instruction, weqatal (26:6) ‘and thus the sanctuary will become one thing,’ with hy:h;w“ (26:7) ‘and you shall make,’ t;yci[;w“ Both wayyiqtol (execution) and weqatal (instruction) are a link of a long chain of identical verb forms. Syntactically, nothing marks a ‘paragraph boundary.’ Only the items change, and this happens even where no form of hyh appears in the text. The function of hyh as a ‘paragraph boundary’ depends, then, on a given semantic conviction, which I do not share but I cannot disprove. In any case, semantics cannot overrule syntax (see §1e above). Before leaving the subject, I wish to mention the main correspondences between the verb forms of the instruction and those of the execution as shown in Syntax §§58-60: - weqatal in the instruction becomes wayyiqtol in the execution for a single action; - weqatal and x-yiqtol in the instruction are preserved in the execution for a repeated action or description; - initial indicative x-yiqtol also becomes wayyiqtol; - ‘emphatic’ x-yiqtol (emphasizing the ‘x’ element) becomes ‘emphatic’ xqatal (with the same function); - simple nominal (verbless) clauses remain unchanged, but their temporal value changes: present tense in the instruction, and imperfect in the execution. These correspondences fit well into the verbal system outlined above (§4). First, wayyiqtol is characteristic of historical narrative and weqatal of direct speech; both appear in strings. Second, x-yiqtol and x-qatal are emphatic, or marked, constructions with an opposition of tenses: future in direct speech and past in historical narrative, respectively. Third, simple nominal (verbless) clauses are used in both genres but with a different temporal values: present in direct speech and imperfect (i.e. ‘present in the past’) in historical narrative, respectively. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 569 On Exod. 38:9-20 // 27:9-19 D. writes as follows. The exceptional feature of this pericope is that these [‘wc + the appropriate conjugation’ clause, i.e. wayyiqtol and weqatal] are the only clauses with finite verbs; all others are verbless clauses. (…)36 These texts are clearly neither Narrative History (or Procedural/Lab Report) nor Procedural/Instructional; following clues from their semantic content and their macro-structure, we are lead to conclude that we have here another instance of an embedded Expository text (…) (p. 150). These remarks reflect a confused idea of the structure of the texts. This structure is very simple: - (1) ‘You shall do (this and this),’ in the instruction; and ‘He did (this and this),’ in the execution; - (2) Description of the thing to be done, in the instruction, or done, in the execution. In (1), weqatal is mostly used in the instruction, wayyiqtol in the execution. The description in (2) is done by x-yiqtol clauses or by simple nominal (verbless) clauses. Both constructions have a future temporal value in the instruction – x-yiqtol in itself, the simple nominal (verbless) clause for the fact of appearing in a future context indicated by weqatal. In the execution, x-yiqtol becomes x-qatal – except when a frequentative meaning is implied; in this case, x-yiqtol remains unchanged, and so does the simple nominal (verbless) clause; however, their temporal value changes: future in direct speech, past in historical narrative. A consequence of this is that Exod. 38:9-20 // 27:9-19 do not show any exceptional features at all. Another consequence is that none of D.’s text-types applies here simply because none of them explains all the elements of the text. The rigidity of the text-types approach is again visible, as well as the need for distinguishing direct speech (instruction) from historical narrative (execution). In fact, in order to handle these two genres together, D. had envisaged a strange text-type called ‘Procedural/Lab Report’ (pp. 146-147). However, he is forced to dismiss this genre here because the percentage of characteristic verb forms (weqatal and wayyiqtol) is minimal, and the percentage is a basic criterion for him. D. finally decides to identify Exod. 38:9-20 / / 27:9-19 as ‘embedded Expository text.’ One wonders who will believe him. Before drawing his conclusions, D. makes some methodological reflections that merit attention: Our data here present no conclusive evidence with regard either to the text-type identification of this ‘Historical’ texts or to the question of whether the two text-types under discussion [i.e. ‘Narrative History text-type’ and ‘Procedural/Lab Report text-type’] are differentiated in the surface structure of Classical Hebrew. (…) We may proceed in spite of this insecurity, however, to gain as much ground as we can at this early stage in our description, for little in the way of further text-linguistic 36. I skip a passage on the participles of this pericope because it hardly adds anything to our knowledge. 570 RECENSIONI description in this volume will be hindered by the relative insecurity of these particular observations (p. 149). The need for a larger data-base is frequently voiced by D. In itself, this claim is certainly correct. The problem is that without good criteria the examination of more data will not help, and percentage is not a good criterion, nor are the four text-types. As the reader has recognized by now, the kind of analysis done by D. is basically a description of Biblical texts from the perspective of the texttypes. It is only logical that this kind of examination is not complete until all the texts are examined. Faced with problems for lack of syntactic criteria, from time to time D. professes a kind of ‘eschatological’ hope that more texts will, eventually, produce more conclusive results (see also §10 below). A text-linguistic analysis based on syntax can, on the contrary, produce firm results even if not all the Biblical texts are examined. In fact, it looks at the function of the verb forms in themselves and in relationship to one another in the framework of a comprehensive verbal system. Such functions are the same in all the possible texts and do not depend at all on the identification of the different text-types. For this reason, already in the first draft of Sintassi in 1986 I dared to affirm that while a scrutiny of a wider selection of texts might contribute further refinements, I did not envisage major modifications. Curiously enough, D. who criticizes this statement (p. 39), expresses something similar himself as he writes, Owing to the small amount of data currently reviewed, I offer these [conclusions] as a tentative working hypothesis, although I do not believe they will require much alteration as more data are processed (note 56, pp. 150-151; italics added). §9. Jephthah. The intention of D.’s examination of this narrative is clearly stated in the following quotation: My main purpose, as I turn to the Jephthah story, is to underline a principle which will be received with skepticism by some hebraists, and which, therefore, will require more thorough explanation. The principle is this: Features that are characteristic of specific text-types will be found in material of that text-type, whether in Reported Speech sections or not. To this end we will look to the non-subordinated narrative, and compare it to five Reported Speech sections of the Jephthah story. Here I will be confronting directly Niccacci’s thoughts on this passage, for he comes to very different conclusions from my own (p. 154). The subject under discussion is what I called the ‘narrative discourse,’ or ‘oral narrative’ (§4a above). Its difference from historical narrative is double. On the one hand, oral narrative is done from the perspective of the speaker and uses, besides the third, also the first and the second person, while historical narrative is done by a third party, the historian, and uses the third person only. On the other hand, the beginning of the main line of communication is marked by a different verb forms: (clause-initial) qatal or x-qatal in oral DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 571 narrative, wayyiqtol in historical narrative; however, in the course of the narrative the two genres use the same verb forms: wayyiqtol for the main line, and waw-x-qatal for the secondary line (expressing antecedent, or background information). This similarity is due to the fact that Biblical Hebrew, unlike NeoLatin languages, does not possess a complete set of distinctive verb forms for the two genres. Dawson is uncompromisingly opposed to this idea because, of course, the distinction of direct speech and historical narrative undermines the basis of his theory. The whole Ch. 5 of his dissertation is a hard itinerary through Reported Speech sections with this intention in mind. §9a Judg. 11:4-5. The analysis of the Jephthah story (Judg. 10:6-12:7) is done in two stages; first, the historical narrative outside the Reported Speech is investigated, then the direct speech. The historical narrative is outlined in a very sketchy way. Moreover, from the ‘macrosyntactic clues (with minimal reference to other [e.g. semantic] clues)’ presented on p. 157, it is not always clear which clauses are referred to as ‘off-line clauses at the beginning of a section’ or ‘at the end of a section’ (p. 158). D. operates with the criteria we have already discussed, e.g. the negated verb forms and the hyh clauses are considered off-line constructions indicating the boundaries of the different sections. I do not need to repeat my reservations about the syntactic status of both the negated verb forms (§3 above) and the hyh clauses (§1e above). It is instructing to observe the function of two yhyw forms in Judg. 11:4-5. 11.4.1 It happened after a certain time 11.4.2 that the Ammonites started war against Israel. 11.5.1 And when the Ammonites had started war against Israel, 11.5.2 the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. µymiY:˝mi yhiy“˝w" la´r:c]yIAµ[i ˆ/M['AynEb] Wmj}L;YI˝w" ˆ/M['AynEb] Wmj}l]nIArv,a}˝K' yhiy“˝w" laer:c]yIAµ[i tj'qæ˝l; d[;l]gI ynEq]zI Wkl]YE˝w" b/f ≈r<a≤˝me jT…p]yIAta, Both yhiy“˝w" forms are ‘macrosyntactic markers’ because they introduce a double sentence composed of protasis and apodosis (§1e above). In 11:4, ‘after a certain time’ (a prepositional phrase) is the protasis, and ‘the Ammonites started war’ (a wayyiqtol clause) is the apodosis; in 11:5, the protasis is ‘when the Ammonites had started war’ (a subordinated rv,a}˝K' + qatal clause), and the apodosis ‘the elders of Gilead went’ (again a wayyiqtol clause). Note that both these patterns of double sentence are also attested without a preceding yhiy“˝w";37 for the first pattern, i.e. prepositional phrase (protasis) – wayyiqtol (apodosis) see Syntax §103, and for the second pattern, i.e. rv,a}˝K' (or another subordinating 37. Other cases of µymiY:˝mi yhiy“˝w" are Josh. 23:1 and Judg. 15:1; cf. 2 Chron. 21:19. Initial µymiY:˝mi (without yhiy“˝w") is found in Judg. 11:40; cf. 1 Chron. 17:10. 572 RECENSIONI conjunction) + qatal (protasis) – wayyiqtol (apodosis) see Syntax §§98 and 101. This fact means that yhiy“˝w" is not part of the sentence grammatically. It has a syntactic function, however: it makes the double sentence verbal. It also has a ‘macrosyntactic’ function: it makes the double sentence a main-line construction because of the very fact of being a wayyiqtol. This syntactic analysis is, on the one hand, an indirect proof against the function of hyh as a ‘paragraph boundary’; in fact, for this function a nominal sentence would be used without any form of hyh.38 On the other hand, from a semantic point of view alone, it is hard to convince anybody that, e.g., yhiy“˝w" in 11.5.1 is an off-line form as it picks up the news of the war given in 11.4.2. Dawson’s analysis goes on only interested in paragraph boundaries, and real syntactic problems remain untouched (e.g. 11:29). On p. 158, his conclusion concerning the pattern of the text-type is unverifiable for lack of precision. He writes: These clauses have a distribution similar to those we looked at in Judges 2; that is, those which occur singly appear to indicate minor paragraph breaks; those that occur in larger blocks appear to indicate a major break, or a peak in the episode (p. 158). In addition to the lack of syntactic criteria,39 the lack of precise comparison of the texts involved is frustrating because similarities are claimed rather than demonstrated.40 §9b ‘Narrative History in Reported Speech’. From p. 164 on, D. examines the ‘Narrative History in Reported Speech’ in greater detail. This topic constitutes a major casus belli that is mentioned several times, but the suspense about the solution intended by D. remains high until the very end. Upon comparing the more important passages, D.’s stand appears to vacillate a bit. He writes: 38. Nominal clauses, both simple (verbless) and with a finite verb in the second place, are devices interrupting the main line of communication in historical narrative; they are also used in the closure of a text (see Ruth 1:22-23 and 4:18-22 examined in: “Syntactic Analysis of Ruth”). 39. This is also apparent in the way Dawson expresses himself, e.g.: ‘It is not inconceivable’; ‘I would suggest’; ‘some conclusions can be ventured’;‘I would like to make another tentative observation’; ‘I am tempted to propose,’ and the like. One may wonder whether this is only a sign of commendable humility in expounding his own ideas. A similar remark on off-line clauses marking paragraph division or peak was made during the examination of Lev. 14 (p. 134); even there, the remark is flawed by incorrect syntactic analysis (see my comment in §6 above). 40. In a rare case of a precise reference, we find an unfortunate parallel. On p. 162 Dawson writes: “we have seen that single main-line clauses flanked by off-line clauses tend to stand out as the peak clause of a unit;” and in note 19 he adds: “For example, at Judg. 2.18.4; we have seen similar features in other text-types as well, in our examinations of Leviticus and Exodus texts; see Ch. 4 above.” Now, while the reference to Ch. 4 is vague, the one to the passage from Judges is precise but inaccurate because, as observed above (§5), the clause 2.18.4 is a weqatal, that is a off-line, not a main-line, form. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 573 I found that, yes, what Niccacci calls ‘narrative discourse’ is indeed distinctive, but that this is traceable to factors related to the embedding of a unit or Reported speech in the Speech Formula clause, rather than it being a distinctive type of text in its own right. In this case, I had distrusted Niccacci’s observations, while they were accurate, and yet found a different explanation which, I believe, describes the data more accurately and elegantly than his (p. 121; italics in the original). The most significant point here is that there is nothing out of the ordinary about this Narrative History text. It opens, as do many Narrative History texts, with the same stagesetting device of a hyh clause; its boundaries are marked by the same sort of features as we have noted in other Narrative History texts. This begins to call into doubt the conclusions voiced by Niccacci on Judges 11: that somehow ‘narrative discourse’ has a different shape to it from narrative proper (p. 166; italics in the original). Dawson’s solution is finally given at p. 175; but before discussing it, I wish to comment on his examination of the texts. In his view, the ‘Narrative History text’ in Judg. 12:2-3 “opens, as do many Narrative History texts, with the stagesetting device of a hyh clause” (p. 166). In a footnote 26 he adds: We will see the same device employed in the book of Ruth on more than one occasion. Logic as well gives us a rationale for such a function and device: do we not say that a story has to ‘start somewhere?’ We expect a story to start with some kind of anchor into space and time—this kind of anchor is provided by such things as Verbless, and hyh clauses—and if such a setting slot were filled by an embedded text of more than one clause in length, we would expect it to be an Expository one, which has as its main line just such clauses (note 26, p. 166). One would remark, first, that simple nominal (verbless) and hyh clauses are not interchangeable because, as R. Bartelmus has shown,41 verb forms of hyh occur to express a reference to the past (wayyiqtol, qatal) and to the future (yiqtol, weqatal), while for a reference to the present, hyh does not appear but the simple nominal (verbless) clause is used instead. Second, since D. makes no distinction between different verb forms of hyh, we can ask: is there any difference between qatal in Judg. 12:2 and wayyiqtol in Ruth 1:1-2? Third, the ‘stagesetting’ clauses studied in Syntax §§16-19 (and attested in real texts, not merely ‘expected’) contain, besides the simple nominal (verbless) clauses that D. would ‘expect’ in an Expository text-type, also waw-x-qatal, waw-x-yiqtol, and weqatal of any root (not only hyh). This means that the ‘stage-setting clauses’ (called ‘antecedent’ constructions in Syntax) simply convey, in the secondary line of communication, the setting of the following story, and this does not correspond to the Expository text-type described by D. Fourth, there are examples of (clause-initial) qatal or x-qatal at the beginning of an oral narrative, corresponding to wayyiqtol in historical narrative, both used for the same event, first narrated by the historian, then reported orally.42 41. See bibliography and discussion in my paper, “Sullo stato sintattico del verbo häyâ.” 42. See §4a above, and the examination of Ruth 3:15 versus 3:17 and 4:13 versus 4:17 in: “Syntactic Analysis of Ruth.” In Syntax §§22-23 about twenty such cases are listed. 574 RECENSIONI On this basis, I feel justified to affirm that Judg. 12:2 and, say, Job 1:1 show clauses that are superficially identical but syntactically different. Judg. 12:2 I and my people had a great feud with the Ammonites. Job 1:1 Now, there was a man in the land of Uz. y˝Mi['˝w“ ynIa} ytiyyIh; byrI vyai daom] ˆ/M['AynEb]˝W ≈W[A≈r<a≤˝b] hy:h; vyai Indeed, the function of the two texts is different. In Judg. 12:2, Jephthah is informing orally on the war against the Ammonites described in the previous chapter, and therefore a stage-setting function of qatal is excluded; on the contrary, this function is clear in Job 1:1, which provides antecedent information before the beginning of the story.43 The two texts are, therefore, not comparable. Qatal at the beginning of an oral narrative is main-line form. §9c Judg. 10:10 10.10.1 10.10.2 10.10.3 10.10.4 rmoa˝le hw:hy“Ala, laer:c]yI ynEB] Wq[}z“YI˝w" ‘We have sinned against you, Ë˝l; Wnaf;j; precisely because we have forsaken our God Wn˝yheløa‘Ata, Wnb]z"[; yki˝w“ and have served the Baals.’ µyli[;B]˝h'Ata, dbo[}N"˝w" The Israelites cried to the Lord, saying, Dawson comments as follows: 10.10.3-4 is an embedded Narrative History text, filling the Direct Object slot in the speech formula. The second clause in this embedded text begins with a wc + Prefix form [i.e. wayyiqtol], but the first begins wit yk, which must be clause-initial; so the verb form in this first clause (and therefore the clause-type) must accommodate it—this is the only reason we need to seek for the Suffix clause replacing a wc + Prefix clause (p. 167; italics in the original). In note 29 he adds: We are, of course, speaking of non-entities; there is no ‘wc + Prefix clause’, and therefore we can only posit that it ‘would otherwise have been there’. It is clear, however, that if it ‘wanted’ to be there, it nevertheless could not be there, owing to the restrictions placed on the clause by the subordinating conjunction (p. 167). Dawson first affirms, then disproves his affirmation. The result is that one is left without a solution. On the one hand, D. argues as if the initial qatal (10.10.2) was not there; on the other hand, he labels the clauses 10.10.3-4 as Narrative History text because they contain a wayyiqtol. It seems clear that, first, D.’s theory is incapable of handling this text; second, the quest for texttypes is misplaced here. With a rigid theory of text-types, and without a clear syntax of the clause, any text-linguistic analysis is impossible. 43. The antecedent information extends throughout vv. 1-5 and develops into a short narra- tive; see Syntax §90. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 575 In my system, the analysis of Judg. 10:10 is simple. Clause 10.10.2 contains an initial, main-line qatal in direct speech; 10.10.3 is a subordinated clause with a causal function, and 10.10.4 is a continuation wayyiqtol having the same function as the causal clause, i.e. it is not a main-line wayyiqtol (see Judg. 2.17.3 examined in §5 above). By comparing other, almost identical passages, e.g. 1 Sam. 12:10 and Num. 21:17, it is clear that the waw in yKiw“ (10.10.3) is epexegetical or emphatic; therefore, I have translated it with ‘precisely.’ Another clause-initial Wnaf…j; is found in Judg. 10:15. §9d Judg. 10:11-14 10.11.1 10.11.2 10.12.1 10.12.2 10.12.3 10.13.1 10.13.2 10.13.3 10.14.1 10.14.2 10.14.3 10.14.4 la´r:c]yI ynEB]Ala, hw:hy“ rm,aYo˝w" ‘Is it not that when the Egyptians, µyIr"x]Mi˝mi alø˝h} the Amorites, the Ammonites ˆ/M[' ynEB]Aˆmi˝W yrImoa‘˝h…Aˆmi˝W and the Philistines, on the one hand, µyTiv]liP]Aˆmi˝W and the Sidonians, the Amalekites qlem;[}˝w" µynI/dyxi˝w“ and the Maonites, on the other, oppressed you, µk,˝t]a, Wxj}l; ˆ/[m;˝W and you cried to me, y˝l'ae Wq[}x]Ti˝w" I saved you from their hand? µ˝d:Y:˝mi µk,˝t]a, h[;yvi/a˝w: You, on your part, have forsaken me y˝ti/a µT≤b]z"[} µT,a'˝w“ and served other gods; µyrIjea} µyhiløa‘ Wdb]['T'˝w" therefore I will save you no more. µk≤˝t]a, ["yvi/h˝l] πysi/aAalø ˆk´˝l; Go Wkl] and cry to the gods µyhiløa‘˝h…Ala, Wq[}z"˝w“ whom you have chosen; µ˝B; µT≤r“j'B] rv,a} let them save you in the time of your distress.’ µk,˝t]r"x; t[´˝B] µk≤˝l; W[yvi/y hM;h´ The Lord said to the Israelites, I doubt that D.’s analysis of this ‘rather complex’ text (p. 168) has anything to recommend itself. He writes: YHWH’s response begins with a question (an elliptical one, at that). (…) This Narrative History text is introduced by a Suffix clause (providing, along with the rhetorical question preceding it, a setting for the text that follows), and a second episode of it is signalled by another of the same [i.e. 10.13.1]. This text presents us with no surprises (pp. 168; 169). A different analysis recommends itself. Units 10.11.2 and 10.12.1 are one sentence type x-qatal introduced by alø˝h}. The names of the peoples in 10.11.210.12.1 are linked according to the following pattern: -w … ˆmi ‘from … to’;44 44. The pattern -w … ˆmi ‘from … to’ is equivalent to d['w“ … ˆmi; see Josh. 23:4; 2 Sam. 5:9; 2 Kgs 10:33 etc. 576 RECENSIONI therefore, I translated, ‘on the one hand … on the other.’ Since the sentence is complete without it, the particle alø˝h} has no grammatical function but does have a pragmatic, or illocutory, function. The sentence is double, composed of an xqatal (10.11.2-10.12.1) and a continuation wayyiqtol (10.12.2) as the protasis, and of wayyiqtol as the apodosis (10.12.3).45 The following clause (10.13.1) is a waw-x-qatal with the function of indicating a contrast with the preceding one,46 i.e. the response of the people is in contrast with God’s salvation. This off-line waw-x-qatal clause is followed by another continuation wayyiqtol (10.13.2). Because it comes after volitive clauses (10.14.1-2, two coordinated imperative forms), the x-yiqtol clause in 10.14.4 is also volitive (jussive),47 and the ‘x’ element in front of the yiqtol bears emphasis as the speech situation shows very clearly: ‘I will save you no more … let them save you.’ §9e Judg. 11:7 11.7.1 But Jephthah said to the elders of Gilead, 11.7.2 ‘Did you not hate me, 11.7.3 and drive me out of my father’s house? 11.7.4 Why then have you come to me now 11.7.5 when you are in distress?’ d[;l]gI ynEq]zI˝l] jT;p]yI rm,aYo˝w" y˝ti/a µt≤anEc] µT,a' alø˝h} y˝bia; tyB´˝mi ynI˝Wvr“g:T]˝w" hT;[' y˝l'ae µt≤aB; ["WDm'˝W µk,˝l; rx' rv,a}˝K' After a strange remark where, in his words, he ‘toys’ with the rhetorical question and compares it to the infinitive absolute (sic), D. concludes that 11.7.2 is “in any case a simple statement of a past event” (p. 171); however, according to his theory, qatal is ‘Band 2: Backgrounded actions’ (p. 115). A few lines later in the same page D. betrays his hesitation between theory and common sense as he writes: Thus, I consider 11.7.2 to be a Narrative History clause, turned inside out to express annoyance, or superiority, or some other such nuance. It serves the purpose of introducing the historical setting (and first event) of a brief Narrative History text (p. 171; italics added). In my understanding, to say that the same qatal introduces ‘the historical setting’ and also ‘first event’ is self-contradictory; D. is probably trying to solve the contrast between theory (‘historical setting’) and common sense (‘first event’) concerning the function of qatal in oral narrative. 45. For an x-qatal clause functioning as protasis see Syntax §105. The apodosis shows, in the axis of the past, wayyiqtol, qatal or x-qatal without any difference; in the axis of the future, we find weqatal, yiqtol or x-yiqtol, also without any difference; and for the axis of the present, the simple nominal (verbless) clause. See Syntax §113; Lettura sintattica §4.2. 46. This ‘tense shift’ type wayyiqtol → waw-x-qatal is characteristic of historical narrative. As already noted, the oral narrative uses the same verb forms as the historical narrative except for the beginning (§§4; 9 beginning). 47. See Syntax §64:3; “A Neglected Point” §1.3.1. DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 577 §9f Judg. 11:15-27. Judg. 11:15-27 is the longest text examined by D.; it is also studied in Syntax §§75-76. After a rather sketchy analysis D. comes to a conclusion where at last he explains his solution against mine. He repeats his conviction that there is no difference between ‘Narrative History in non-Reported Speech,’ or historical narrative, and ‘Narrative History in Reported Speech,’ or oral narrative. Yet, a little difference at least must be present because he writes: What little evidence Niccacci cites in favor of his proposal is more elegantly explained by two, somewhat overlapping, principles (pp. 174-175). His first principle is something we both agree upon: a Narrative History text frequently begins with a ‘stage-setting section,’ i.e. what I called ‘antecedent information.’ D. continues: Second, even where a text might conceivably employ a clause-initial, main-line for Narrative History, wc + Prefix clause [i.e. wayyiqtol], this does not happen. The language prefers to underscore the relationship between the embedded Reported Speech material, and the speech formula into which it is embedded as Direct Object. This may sound very like what Niccacci has proposed; it is, in fact, radically different. Niccacci proposes that ‘narrative discourse’ is a different ‘type of narrative’; I propose that Narrative History texts are formulated according to the same principles whether in Reported Speech or in non-Reported Speech—there is no ‘different type of narrative’ for Reported Speech. Material in Reported Speech is, however, subject to restrictions with regard to its initial clause—in order to call attention to the fact of its being embedded—as if to say ‘this is not actually the beginning of the clause; rather, it is the Direct Object of another clause’ (p. 175; italics in the original). Some comments are in order. First, I noted several times in this paper an incertitude in D.’s analysis of qatal in direct speech; it is said to be ‘a stagesetting device,’ on the one hand, and ‘a simple statement of a past event,’ on the other. Second, if a Narrative History in Reported Speech is embedded as Direct Object of the speech formula – that is, I suppose: ‘He said that…(Narrative History)’ –, how is it possible to analyze this supposedly ‘that-clause’ as a ‘stage-setting device’? Third, having stated the principle, “Features that are characteristic of specific text-types will be found in material of that text-type, whether in Reported Speech sections or not” (p. 154), D. now concedes that this is not true in at least one aspect, since qatal replaces wayyiqtol in the first clause of a Narrative History text. §10. Conclusion. Dawson presents a summary and conclusions after his examination of Jephthah and Ruth,48 and then a general summary, conclusions and implications of his dissertation. He lists three hindering factors with regard to the examination of Reported Speech material, the main point under discussion: 48. Due to space problems, I publish separately my discussion on Ruth; see “Syntactic Analysis of Ruth” earlier in the present volume. There I comment more fully on the phenomenon of embedding as envisaged by Dawson; see end of the previous section. 578 RECENSIONI 1. Although I have, throughout this volume, cited the need to test our conclusions against further data, here the need is the greater; in short, the data-sample has been too small to make any but the most obvious, and the most tentative observations, for a variety of reasons. Nonetheless, here more than elsewhere we need to process more texts. 2. The first of these reasons for needing a larger data-base is that text-types within Reported Speech material shift rapidly, and it is not common to find long stretches of material in a single text-type. Broadening our data-base would bring to us more texts of a greater length, which are a better starting point for research than shorter ones. 3. It is clear that subordination (which is more common in Reported Speech than in non-Reported Speech), specifically, and embedding, more generally—by reason of their cohesion with other units within their context—both limit the kinds of clauses that can occur at the outset of any text unit in such a section. This immediately means that we have a greater number of clauses than we would like whose surface-structure signals as to text-type have been obscured by such permutations (p. 207). One would observe, first, that the largest data-base possible cannot solve the problems unless one is equipped with sound criteria of analysis; quantity will never be a substitute for quality. Second, one may wonder why did D. not choose texts with ‘long stretches of material in a single text-type,’ such as Lev. 14 and Exod. 25-31 which he studied in only a very sketchy form; or as Deuteronomy, instead of engaging in the examination of Ruth. On the other hand, if it proves difficult to find texts suitable for the theory of the text-types, the theory itself might be in need of revision. Reported Speech ‘shifts rapidly’ not only in the texts D. has examined but also elsewhere. As a matter of fact, D.’s theory proved to be too rigid in the definition of the text-types; as a result, it seemed inadequate to handle Reported Speech material. There is also a need for a better syntactic basis; see my remarks on the ‘Clines’ of the text-types established in pp. 115-116 (§3 above). Let us discuss D.’s understanding of subordination and embedding. I go back here to a point raised at the end of §9f above. After having used the two terms almost interchangeably, D. seems to understand subordination as specific and embedding as general phenomenon (see remark no. 3 quoted above). This point is never fully explained and some ambiguity remains as to what are the grammatical consequences of embedding as compared to subordination. In other words, one would like to know whether embedding involves a grammatical change in the texts. In the following statement, D. is more specific: [The Narrative History texts in Reported Speech] were found to conform significantly to patterns we had seen in earlier Narrative History material [i.e. Jephthah and Ruth], with one slight exception: the first clause in the embedded Narrative History material never took a wc + Prefix form [i.e. wayyiqtol]. However, rather than following Niccacci’s lead in defining this as a different type of Narrative, I propose that the first clause in any Reported Speech unit always indicates its status as an element in the (speech introduction) clause in which it is embedded, and therefore it is never, in terms of surface structure, clause initial (p. 214). First, the assumption of a grammatical change in the first clause of a direct speech because of embedding – that is, because it is an Object clause of the speech introduction – is totally speculative. The only verifiable case of embed- DAWSON TEXT-LINGUISTICS AND BIBLICAL HEBREW 579 ding is ‘indirect speech’ (oratio obliqua). Second, if qatal is a ‘stage-setting device’ as supposed by D. a number of times, then embedding is unnecessary, even out of the question; because as D. maintains, this qatal is also found in ‘non-embedded Narrative History texts.’ On the contrary, if qatal is a substitute for main-line wayyiqtol because of the embedding, then it cannot be at the same time a ‘stage-setting device,’ which is an off-line form. Among the ‘encouraging results’ of his investigation, D. explicitly mentions Ruth 2:15-16. He writes as follows: One of my working hypotheses was that the constituent structure of a text would be marked by divergences from the main-line form in all text-types, and that the ‘off-line marking of constituent structure will be confirmed by other types of marking devices’. Where the text has been ample enough to examine both main-line and off-line clauses in a single text-type, we have seen this hypothesis substantiated: Ruth 2.15.216.4 is a good example of this, where syntactically marked divisions are confirmed by a shift in topical focus (p. 207). This is a rather cryptic allusion to the analysis of the passage presented in p. 196. However, my analysis diverges considerably from that of D. because we evaluate differently the function of the verb forms involved.49 Similarly, other two ‘encouraging results’ in pp. 207-208 are in need of revision if the remarks made here merit some credit. In the last section of Ch. 6, ‘Implications for Progress,’ D. indicates several points for future research. Of course, he intends to continue with the text-types and their verb-rank clines. I have already commented on the strong point as well as weakness of this methodology; it constitutes an advancement with regard to traditional, clause-bound grammar, but it is too rigidly defined and lacks a solid syntactic base. Happily enough, D. is aware of the necessity of being open to new ideas. As he writes, Much new material is coming out, which has the potential of changing radically the way Hebrew is taught and studied. This will require careful monitoring, of course; much can seem helpful that is not. The most important measure of a description is how well it deals with all the language, especially the difficult data (p. 217; italics in the original). This is correct except maybe for the last sentence. Since every language has its anomalies, one cannot start with these, but rather with well-attested phenomena and regularities. Another good point raised by D. is the need of a text-linguistic description of syntax in poetry. On Watson’s Classical Hebrew Poetry D. writes that it “includes little real syntax” (p. 217). This may be true; however, one can ask what is syntax, and what is text linguistics for D. Something may gleaned from the following words where D. spells out his expectations from a thorough examination of the book of Ruth: 49. See my paper: “Syntactic Analysis of Ruth,” comment on 2:15-16. 580 RECENSIONI In a different vein, a more thorough examination of the book of Ruth than I have been able to present in this work would allow us to trace the themes and purposes of the book, as reflected in the peak marking, topic continuity and shifts, participant reference, and the deployment of tension-maintaining devices in the text (p. 218). Dawson goes on to envisage a possible contribution of text linguistics to text-critical discussions; but he does not explain how this could happen. Finally, he affirms the advantage of text linguistics in the following terms: (…) learning (and therefore teaching) any language is greatly simplified if its forms are systematized—all the more so if it is a dead language. If the system of text-types were presented to students (I do not mean the theoretical parameters, but rather the simple existence of these text-types), and their associated main-line forms, then this much, in one stroke, would give the learner a handle to begin sorting through the various distributions and functions of the Hebrew verb (p. 218; italics in the original). As the reader knows well at this point, we agree on the general outlook, that is, giving priority to the text; we disagree on the necessity of text-types. In my opinion, a ‘bottom-up methodology’ is a necessary starting point. From a sound syntax of the verb forms, their functions and relationships at successive ascending levels – sentence, paragraph, and text – it is possible to make a good analysis of the texts. On this basis, I think, a sound theory of text-types can be built in order to proceed to a higher literary analysis of the texts. Hopefully, dialogue will continue. Alviero Niccacci, ofm Clifford Richard J., Creation Account in the Ancient Near East and in the Bible (The Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 26), Washington 1994, XIII-217 pp., $ 9.00 L’A., nella stessa collana, aveva già curato, con J.J. Collins, Creation in the Biblical Tradition (1992). Il lavoro che presentiamo ha una breve introduzione (o cap. I: pp. 1-10) e conclusione (pp. 198-203) e due parti. Nella prima si studiano le cosmogonie dell’Antico Oriente, di cui diciamo subito che non daremo il lungo elenco, e nella seconda i testi biblici analoghi dell’AT. L’A. inizia con i testi mesopotamici, cui dedica due capitoli: uno a quelli sumerici (cap. II: pp. 13-53) e l’altro a quelli accadici (cap. III: pp. 54-98). Facendo notare che le cosmogonie dell’Antico Oriente sono arrivate anche in Canaan (tra gli Ittiti, a Ugarit, perfino a Megiddo e in una biblioteca scoperta recentemente a Emar, nella Siria orientale), l’A. passa in rassegna documenti sumerici del terzo millennio e dell’inizio del secondo: a) liste di divinità da cui si può ricostruire una loro genealogia, b) testi narrativi di Nippur, con i relativi motivi “cosmici” che, cioè, abbracciano cielo e terra, c) quelli di Eridu, con i loro motivi “ctonici”, dove si considera solo la creazione della terra, ed infine d) un testo a sé stante, di Assur. CLIFFORD CREATION ACCOUNT IN THE ANCIENT NEAR EAST 581 La tradizione di Nippur immagina un periodo precedente la creazione, con le prime divinità (An e Ki) che, nell’accoppiamento primordiale, abbozzano l’opera, e poi il loro figlio Enlil compie il vero atto creativo. Gli uomini “emergono” come piante dalla terra, inseminata dal cielo. Nella tradizione di Eridu la creazione è opera di Enki, dio dell’acqua e della sapienza. Mediante l’acqua degli inferi, egli impregna sessualmente la terra, attraverso fiumi e canali, originando la vita vegetale, animale ed umana. L’uomo sembra “formato” dalla terra con qualcosa in più: l’acqua divina. In una seconda tappa dio crea la civiltà umana, la società, la cultura. Troviamo già qui la figura di Gilgamesh, come pure una storia del diluvio che divide in due fasi la vita dell’umanità sulla terra. Comune alle due tradizioni è l’idea della sorte di ogni uomo e il piano dell’universo, prestabiliti fin dall’inizio dal creatore. I documenti accadici presi in considerazione vanno dal sec. XVIII alla fine del primo millennio a.C. Sono: a) alcune cosmogonie minori, in gran parte messe come introduzione a testi rituali, c) un documento particolare di Dunnu, città di ubicazione incerta, scritto in tardo babilonese e pubblicato nel 1965, b) ma soprattutto i due famosi poemi Atrahasis (sec. XVII) e Enuma elish (tardo I millennio). Mentre i testi del primo gruppo mostrano come il primordiale gesto creativo sia considerato in connessione con la situazione attuale, per es. del malato oggetto del rito, ed anche in quello di Dunnu la creazione sfocia nella situazione attuale della città, i due grandi poemi “antologici” considerano gli eventi primordiali più in se stessi, in un’ottica quasi filosofica e teologica, ma sempre in quanto connessi con la realtà e la vita dei destinatari del poema. Atrahasis, dove gli dèi sono Anu, Enlil ed Ea, si concentra sulla razza umana, sulla sua dignità (gli dèi ne hanno bisogno) e la sua mortalità. Enuma elish esalta Marduk, legittimando la sua regalità sugli dèi e sugli uomini (contro Tiamat). Nella letteratura accadica, che sembra meno grossolana di quella sumerica, sopravvive la creazione sumerica dell’uomo intesa come “formazione” dalla terra, ma al posto di altri elementi (l’acqua primordiale) vi si infonde sangue di divinità uccise. Nel cap. IV (pp. 99-116) si studia la creazione nella letteratura egiziana, prima descrivendo gli elementi comuni delle cosmogonie (fase preliminare, dio creatore, il monte primordiale, modi della manifestazione del creatore e processo creativo); poi le differenti tradizioni (di Heliopolis, di Menfis e di Hermopolis), negando infine l’influenza egiziana sui testi biblici, eccetto che per il Sal 104. I testi cananei (cap. V: pp. 117-133) sono presi soprattutto da Ugarit e poco dal materiale fenicio-punico. C’è infine una lunga disquisizione sulle cosmogonie riportate da Filone di Biblos (50-150 d.C.), che a sua volta è conosciuto attraverso Eusebio (260-340). Nella letteratura ugaritica il dio creatore è El insieme con Ashera, ma di Ugarit non conosciamo narrazioni cosmogoniche. Conosciamo solo i miti di Baal, in lotta col mare e la morte, ma si tratta di gesta posteriori alla creazione. 582 RECENSIONI Nella II parte, quella biblica, si dedica una dozzina di pagine (137-150, cap. VI) a Gen 1-11, negando l’influsso diretto delle cosmogonie extrabibliche su Gen 1, attribuito al Codice sacerdotale, ma inteso come redazione dei documenti precedenti. Invece su Gen 2-11, non separato nei distinti documenti ma considerato nella sua redazione sacerdotale unitaria, si afferma tale influsso particolarmente da parte dell’Enuma-elish. Nel cap. VII (pp. 151-162) si studiano solamente due generi di salmi: le lamentazioni collettive e gli inni. Dal primo gruppetto contenente, secondo l’A., il tema della creazione (44; 74; 77; 80; 83; 89), egli si ferma ad analizzare solo il primo e l’ultimo. Dal secondo gruppo, segnala 66,5-7; 105; 111; 114; 135; 136; 149; tra quelli di Jahweh re, 93 e 96, ed infine 114. Ma quanto vi sia presente veramente il motivo della creazione lo vedremo nella discussione finale. Ad essa rimandiamo anche per il problema della creazione nel secondo Is, cui l’A. dedica il cap. VIII (pp. 163-176). L’ultimo capitolo (pp. 177-197) è dedicato solo ad alcuni passi di Prov (3,16-26 e 8) e a Giobbe. L’elenco delle abbreviazioni è alle pp. XI-XIII. Dopo la bibliografia (pp. 204-207) il libro è corredato di utili indici: delle opere antiche citate (pp. 209ss), degli Autori (pp. 212-15) e dei temi (pp. 216s). Il primo sopperisce alle lacune dell’indice (p. V), che avremmo voluto più dettagliato. Come dice lo stesso Clifford nella prefazione, più che di un’opera completa e di uno studio sistematico, si tratta d’una cernita soggettiva di testi, sia per quelli dell’Antico Oriente sia per quelli biblici. Ha il pregio di offrire una sintesi, aggiornata ed equilibrata, per quanto personale, su un problema complesso, su cui non è facile orientarsi, essendo i dati del problema sparsi in tante ricerche ed analisi. Una sintesi, valida una ventina di anni fa, la troviamo già nel commentario al Genesi di E. Testa, della vecchia Marietti (1969, pp. 31-45). Si noti che il problema non è solo quello di definire gli influssi dell’antica letteratura medio-orientale sulla Bibbia, fosse anche solo sul punto particolare della creazione. Intanto è difficile definire cos’è la creazione e il mito. Clifford ci prova nel primo capitolo, ma la sua vera definizione di creazione finisce per darla nella conclusione (pp. 198s). Ed è proprio lì che nasce il problema. Nell’introduzione, dopo aver criticato l’opera di G.F. Brandon, Creation Legends of the ANE, del 1963, indubbiamente da aggiornare, si oppone a C. Westermann e alla sua scuola, non tanto perché, specialmente nel grosso commentario (Biblischer Kommentar) al Genesi, nello studio del tema della creazione si avvale anche di cosmologie e miti relativamente recenti, che non possono aver influenzato i racconti di Gen 1-11, ma soprattutto perché distingue tra la creazione dell’individuo e quella del mondo (p. 6). Il problema però è ben più complesso. Si tratta dello scontro tra due scuole, una delle quali fa capo a von Rad, mentre l’altra potremmo definirla nordamericana (Cross?). Precisiamo alcune cose. Anzitutto von Rad non negava affatto che il tema della creazione portava il pio israelita ad applicarne la lezione alla sua vita: dalla creazione iniziale si passava allo stesso creato attualmente esistente di cui CLIFFORD CREATION ACCOUNT IN THE ANCIENT NEAR EAST 583 l’individuo o Israele è al centro. Il passaggio è più diretto ed esplicito in salmi come il 104, dove la contemplazione della natura è fatta direttamente, senza pensare all’atto creativo iniziale, oppure come il 139, che ci fa ripiegare su noi stessi e sulla formazione dell’individuo sin dal seno della madre. In qualche modo anche tutti questi sono passaggi dalla creazione/natura alla storia. In secondo luogo l’aggiunta della considerazione del creato nel Pentateuco (Gen 111) per von Rad non era affatto tardiva; era del Jahwista, da lui datato al sec. X, comunque debba essere giudicata la sua teoria dell’antichità del “credo storico”. Da questa sistemazione dei temi teologici biblici, infine, sgorgava la tesi che Israele si caratterizza rispetto a quelle culture contemporanee o precedenti per la sua concezione della storia, della storia della salvezza, sviluppata prima e indipendentemente dalle considerazioni sulla creazione/natura. Ai tempi della prima impostazione teologica del pensiero di von Rad (ancora prima della guerra!) non era ancora a disposizione tutto quel materiale delle culture antiche medio-orientali, da cui Clifford ha pescato. Forse è per influsso di questo comparativismo che la tesi di von Rad è poi stata modificata da Westermann, colla distinzione tra storia dell’individuo e storia della natura, da Clifford giustamente criticata. Sta di fatto che, ora, si rischia di esagerare dall’altra parte. Così succede che si catalogano come allusioni alla creazione o cosmogonici brani dei salmi (44,2ss; 77,16-21; 89,2-5) o del Deutero-Isaia, che vogliono solo descrivere i fatti storici dell’esodo, quello di Mosè o quello nuovo della fine dell’esilio. In questi ed altri salmi o poemi gli autori fanno, sì, uso di testi cosmogonici delle letterature parallele, ma per descrivere fatti della storia d’Israele. L’A. si sforza di annullare la differenza tra cosmogonia e storia, dicendo che le antiche cosmogonie pagane sboccano sempre ad un santuario o ad una città, col suo re, in funzione delle quali quelle sono narrate, e proponendo una illusoria divisione tra testi “soprastorici” (al posto di “mitici”) e testi “storici” (p. 153). Ma se non si mantiene la distinzione di von Rad, tra natura e storia, qualsiasi contemplazione della natura diventa narrazione storica e qualsiasi allusione alla storia diventa cosmologica e mitologica. Qui confessiamo che, per noi, la concezione ebraica e cristiana della storia della salvezza del popolo di Dio va rigorosamente difesa, nell’attuale confusione teologica. Va rigorosamente distinta anche dalla storia salvifica personale, che pure, assieme al creato e alla storia di tutti gli altri popoli, con quella è collegata. Teilhard de Chardin e, prima di lui, Giovanni Duns Scoto e la scuola francescana insegnano che il Verbo di Dio è il modello della creazione: Dio si sarebbe incarnato ugualmente, anche se non ci fosse stato bisogno della redenzione. Paolo e Giovanni ci dicono che Gesù Cristo, incarnatosi nella storia, è colui per il quale e in vista del quale tutto è stato creato. Ma questo non deve far confondere le due prospettive, quella della storia e quella della natura. Specialmente se si mantengono debitamente distinte, la prima illumina la seconda, che, comunque, è ad essa complementare. 584 RECENSIONI Quanto al Deutero-Isaia, ammettiamo che la connessione tra creazione e storia è particolarmente stretta (l’A. fa bene a seguire Stuhlmüller). E si potrebbe pensare che ciò sia una reazione ai miti cosmogonici, celebrati a Babilonia e agli esuli certamente noti. Avremmo, allora, una reazione dell’ortodossia israelitica, che si rifà alla sua dottrina della creazione e la contrappone ai miti nel prospettare la futura salvezza agli esuli. Dopo questa critica di fondo e questa discussione, facciamo ancora qualche riserva sul lavoro di Clifford. Prima di tutto sul confronto tra i documenti antichi, che metodologicamente non dovrebbe essere fatto prima della presentazione dei testi biblici (per es. a p. 81; ed anche a p. 201). Così pure sarebbe stato opportuno presentare testi propriamente sapienziali della letteratura antica medio-orientale per il confronto con la parallela letteratura biblica nell’uso delle cosmogonie. Sembra, poi, esserci contraddizione tra l’affermazione che l’era prediluviana è (sempre) aurea (pp. 146s) e quella della corruzione che provoca il diluvio (per es. p. 46). Infine dovrebbe essere una confusione del tipografo Enki al posto di Enlil di Nippur, a p. 200. Chi legge questo libro, nonostante le critiche da noi fatte, sente un dovere di gratitudine verso l’A., perché da lui viene messo di fronte ad un problema biblico importante, con un’esposizione stimolante, che fa intravedere prospettive appassionanti per la ricerca biblica. Enzo Cortese Richter Wolfgang, Biblia Hebraica transcripta, BHt, das ist das ganze Alte Testament transkribiert, mit Satzeinleitungen versehen und durch die Version tiberisch-masoretischer Autoritäten bereichert auf der sie gründet (Münchener Universitätsschriften. Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament, 33.116), EOS Verlag, St. Ottilien 1991-93. Genesis (ATS 33.1) VIII-485 pp. (1991) DM 58; Exodus, Leviticus (ATS 33.2) VI-629 pp. (1991) DM 68; Numeri, Deuteronomium (ATS 33.3) VI-701 pp. (1991) DM 78; Josua, Richter (ATS 33.4) VI-428 pp. (1991) DM 48; 1 und 2 Samuel (ATS 33.5) VI-585 pp. (1991) DM 63; 1 und 2 Könige (ATS 33.6) VI-569 pp. (1991) DM 63; Jesaja (ATS 33.7) VI-433 pp. (1991) DM 48; Jeremia (ATS 33.8) VI-497 pp. (1991) DM 58; Ezechiel (ATS 33.9) VI-433 pp. (1991) DM 48; Kleine Propheten (ATS 33.10) VI-357 pp. (1991) DM 43; Psalmen (ATS 33.11) VI-589 pp. (1993) DM 78; Ijob, Sprüche (ATS 33.12) VI-389 pp. (1993) DM 48; Megilloth (ATS 33.13) VI-253 pp. (1993) DM 34; Daniel, Ezra, Nehemia (ATS 33.14) VI-341 pp. (1993) DM 42; 1 und 2 Chronik (ATS 33.15) VI-491 pp. (1993) DM 68; Sirach (ATS 33.16) IV-140 pp. (1993) DM 24,80 Un lavoro enorme portato avanti con coerenza e in breve tempo da una équipe ben affiatata e ben organizzata (J.P. Floß, W. Groß, H. Irsigler, T. Seidl, S.Ö. Steingrimsson, G. Vanoni, H.H. Witzenrath, W. Eckardt, L. Edzard, C. Dyck- RICHTER BIBLIA HEBRAICA TRANSCRIPTA 585 hoff, B. Maier, C. Riepl). Non si tratta di una semplice trascrizione del testo ebraico traslitterato in caratteri latini, come si potrebbe pensare a prima vista, ma di qualcosa di molto più interessante e complesso. Per capire quanto lavoro e pazienza stiano dietro a quest’opera occorre consultare il volume dello stesso Richter, Transliteration und Transkription. Objekt- und metasprachliche Metazeichensysteme zur Wiedergabe hebräischer Texte (ATS 19) 1983. Lì l’A. presenta e discute vari tipi di trascrizione (la “trascrizione” è l’oggetto della questione). Si tratta di una trascrizione “pregnante” che tiene conto dell’ortografia, della fonetica, della fonologia e della morfologia (e sintassi). Richter presenta esempi dei vari tipi di trascrizione di alcuni testi antichi: iscrizione di Siloe (tunnel di Ezechia), testi di Qumran (ad es. Sl 121,1-8 e Is 49,22-26; 50,1), un testo dalla Secunda di Origene (Sl 30 [29],1-13), vari testi dal codice di Aleppo (fra cui 1Re 1,1-5) e testi trasmessi secondo le tradizioni palestinese e babilonese. Così, ad es., l’iscrizione di Siloe viene trascritta varie volte, prima tenendo conto del sistema ortografico, poi della struttura fonologica, infine di quella morfologica (e sintattica). Manca, ovviamente, la trascrizione fonetica (il testo non è vocalizzato). Dunque non è un’impresa da liquidare in due parole, ma merita di essere presa in considerazione. Tutta l’opera è disposta su due facciate (fa eccezione l’ultimo volume dedicato a Ben Sira, edizione curata da Z. Ben Óayyim per conto dell’Accademia della lingua ebraica e del Museo del libro, Gerusalemme 1973, in cui il testo compare solo in traslitterazione e trascrizione). Nella facciata di destra compare il testo in caratteri ebraici, preso dalla BHS, con vocali e accenti biblici diviso in unità sintattiche logiche, seguito da analisi sintattica di tutto il testo frase per frase. Vengono individuate e analizzate tutte le frasi di cui è composta la Bibbia ebraica. La facciata di sinistra contiene la traslitterazione in caratteri latini e la trascrizione di tutte le singole unità (parole e frasi) e la ripetizione dell’analisi sintattica per chi legge il testo ebraico in trascrizione. La trascrizione cerca di rendere ogni singola parola nella sua forma antica (ma quanto antica?) tentando di rendere conto di tutti gli elementi, anche di quelli invisibili all’occhio umano, in modo che sia possibile, conoscendo le regole secondo cui il testo è stato trascritto, passare dal testo traslitterato in caratteri latini a quello ebraico masoretico (cosa non sempre facile e possibile). Alcuni criteri per la trascrizione e l’analisi: è una trascrizione che tiene conto della storia della lingua ebraica e della semitistica comparata. L’ebraico trascritto è presentato in una forma più antica (ma quanto più antica?) rispetto a quella riscontrabile nella vocalizzazione dei masoreti, quando la sua vicinanza ad altre lingue semitiche (soprattutto cananaiche) doveva essere notevole. Così, ad esempio, tutti i raddoppiamenti vengono rappresentati graficamente nella trascrizione tenendo conto della radice della parola e del modello nominale, anche se tali raddoppiamenti non sono graficamente visibili nel testo ebraico. Dunque la trascrizione può servire anche per approfondire lo studio della grammatica biblica (una grammatica per progrediti, ovviamente). Anche 586 RECENSIONI le vocali brevi e lunghe, compresi gli shewa mobili, vengono trascritte. C’è un segno particolare anche per le vocali difficili da riconoscere. Nel campo dell’ortografia si tiene conto della scriptio plena / defectiva delle vocali lunghe, della geminazione secondaria, o del dagesh facente funzione del mappiq (per ogni situazione c’è un segno). C’è un segno anche per indicare la lettera alef dopo vocale, non pronunciata e/o non scritta. Mancano invece segni per indicare la vocale anaptitica segol (non viene trascritto melek bensì malk) e il pata˙ furtivum la cui presenza ubbidisce a criteri fonetici. Per quanto riguarda la prosodia: si segnalano le forme pausali dell’ultima parola del versetto e non viene elisa nella trascrizione la consonante alef originalmente all’inizio di parola, quando viene a trovarsi fra 2 vocali (ad es. l] + µyhlaÖ che diventa µyhlale) e non viene pronunciata. I nomi propri vengono trascritti in carateri latini maiuscoli senza vocali. Questo aiuta la loro individuazione nella colonna di sinistra. Sono importanti i segni marginali per l’analisi della parola, della frase e del testo. Per quanto riguarda la parola, i segni: parentesi tonda, quadra corsiva e quadra normale possono indicare la restituzione, restauro, ricostruzione di parte del testo o di un’indizio linguistico. Per quanto riguarda la frase, come abbiamo accennato sopra, ogni frase della Bibbia è stata segnata con numeri e lettere che spiegano in maniera sintetica (a mo’ di sigla) il tipo di frase. Ad es. la sigla 1a significa “prima frase del versetto”, la sigla 3bP significa “Casus Pendens nella frase b” e così via fino a situazioni più complesse. Il terzo tipo di segni è riservato alle varianti testuali, come il Ketib e Qere, oppure alle varianti prese da altri codici, ecc. Ci pare, e questo sembra essere anche il parere di Richter, che la parte più importante / la novità consista in ciò che riguarda la frase. Ad esempio la divisione del testo in piccole unità numerate permette, attraverso l’uso del computer, di avere a disposizione subito delle liste / concordanze di determinati tipi di frasi. L’apporto dato dall’uso del computer è la cosa nuova e utile. Quando avremo a disposizione questo testo su dischetti potremo sperimentare in prima persona l’utilità e provare i vantaggi di queste sigle a prima vista così astruse. Questo metodo si è già imposto ad un gruppo di ricercatori dell’Università di München. E’ la proposta di una scuola degna di essere presa in considerazione. Sarà accettata ampiamente? Dipenderà in gran parte dall’uso pratico che se ne potrà fare. Massimo Pazzini, ofm Marconcini Benito (e collaboratori), Profeti e Apocalittici (Logos 3. Corso di studi Biblici), Leuman LDC, Torino 1995, 459 pp., L. 55.000 Spreafico Ambrogio, I Profeti. Introduzione e saggi di lettura (Lettura pastorale della Bibbia 27), EDB, Bologna 1993, 139 pp., L. 16.000 MARCONCINI ET AL. PROFETI E APOCALITTICI 587 Presentiamo assieme i due libri perché hanno lo stesso argomento e l’autore del secondo è anche collaboratore del primo, ma soprattutto perché la discussione finale, tra amici, la facciamo partendo da entrambi. Logos vuol rinnovare e sostituire la precedente introduzione alla Bibbia “Il messaggio della salvezza”. In quest’ultimo, il volume sui profeti era spropositatamente lungo (più di mille pagine) in rapporto agli altri e la sola introduzione al profetismo occupava più di 200 pagine; il materiale non vi era ben separato. Il volume di Logos, invece, è meno della metà e l’introduzione generale è ridotta a meno di un quarto (pp. 29-53). Inoltre l’esegesi dei brani scelti è separata dall’introduzione ai singoli libri e messa in una seconda sezione (pp. 251-389), seguita da una terza su temi di teologia biblica profetica. Nella prima sezione, i libri profetici sono suddivisi cronologicamente in quattro parti: profeti preesilici, attorno all’esilio, dopo l’esilio e apocalittici. Le due parti centrali sono di G. Boggio e le due estreme di Marconcini. La seconda sezione, quella dei saggi esegetici, è suddivisa solo in tre parti: 1) per testi del solo Isaia (Marconcini: Is 6; 7,10-17 e i canti del Servo), 2) per Ger, Ez e Dan, dove ai commenti di Boggio (Ger 3,1-4,4 e 7,1-15) ) se ne aggiungono due di L. Monari (su Ez 1 e Dan 7) e infine 3) su profeti minori, dove i commenti sono di A. Spreafico (su brani tratti da Am 2 e Sof 5) e Boggio (Gioele 3,1-5). Nella terza sezione, la prima parte presenta temi generali: la giustizia (Spreafico) e la politica (Monari), e temi particolari, tutti di Marconcini: culto e giustizia in Is, l’uomo nuovo (Ger ed Ez), Dio creatore (Dt-Is). Oltre al pregio della relativa brevità e della migliore disposizione del materiale, già ricordati, e dell’ottima veste tipografica, il volume ha anche quello notevole di fornire una buona bibliografia, soprattutto italiana, visti i suoi destinatari, e di essere abbastanza aggiornato sui problemi discussi nella bibliografia internazionale. Personalmente troviamo particolarmente valida la parte apocalittica nella prima sezione. Segnaliamo solo un errore a p. 223: Treves (e non Trever), precisando che la nostra non è stata, comunque, una lettura sistematica e meticolosa. Ci sembra che la menzione del testo di Deir Alla (p. 32), che pure costituisce un aggiornamento sulla questione del profetismo, vada ulteriormente aggiornata in favore di una datazione più antica dei reperti (J. Hoftijzer - G. van der Kooij, The Balaam Text From Deir ‘Alla Re-evaluated, Leiden 1991). Inoltre sarebbe meglio usare il termine “riletture”, non come si fa talvolta, almeno nella seconda sezione, per testi profetici ripresi in altri libri posteriori, ma solo nel senso tecnico, di rielaborazione posteriore del testo stesso. Certo, non sempre c’è omogeneità in un’opera a più mani. Avremmo anche desiderato qualche pagina sulla storia della redazione del complesso dei libri profetici, magari con una presa di posizione sulle ipotesi attuali (per es. quella di O.H. Steck, Der Abschluss der Prophetie im AT: ein Versuch zur Frage der Vorgeschichte des Kanons, Neukirchen 1991). Soprattutto sareb- 588 RECENSIONI be necessaria una maggiore attenzione all’escatologia e al messianismo, ma su questo argomento vogliamo discutere alla fine con i nostri amici. Il libro di Spreafico non ha la pretesa di essere un’introduzione sistematica. Nella prima parte (Aspetti generali) con una serie di spunti presi da varie pagine bibliche (anche da 1Re, per Elia) si vuol presentare la figura del profeta in generale: i suoi detti o discorsi e le visioni, la partecipazione alla vita e alla storia del suo popolo, la differenza dai falsi profeti, le sofferenze, l’intercessione, l’istanza di conversione, la speranza profetica, l’accettazione e il rifiuto del profeta. Nella seconda parte (Saggi di lettura) si sceglie un brano dai libri di Am, Os, Is (due brani), Mi, Sof, Ger, Ez, Dt-Is. Nella seconda parte si vede la mano dell’esperto di letteratura profetica e la bibliografia è quasi inesistente. Nella prima parte questa non è molto abbondante, ma ci sarebbe voluto un elenco bibliografico, per facilitare l’eventuale consultazione. Come errore tipografico segnaliamo quello della linea 3 a p. 91. A p. 104 la parte finale del v. 12 andrebbe messa con il v. successivo, dove i verbi vanno tradotti al plurale, secondo il TM. E, per capire l’argomentazione della pagina successiva, bisognerebbe tradurre non “discendenza d’Israele”, ma “resto”. Sempre lì e a p. 108 cambieremmo l’espressione “parlerà menzogna”. Ma il punto che vogliamo discutere più a lungo è una lacuna, di cui le opere recensite non sono propriamente colpevoli: riguarda l’escatologia e il messianismo, che in esse è come soffocato. La colpa è degli esegeti in genere. Da tempo regna incontrastata l’opinione che i testi profetici non contengono un messaggio escatologico se non a partire dall’esilio e quelli messianici sono ancora più tardivi. Perciò si sospetta dell’autenticità dei brani dei grandi profeti scrittori, soprattutto di Isaia, che nella tradizione sono stati caratterizzati per questo loro messaggio di speranza. Non è questo il luogo per vedere come questa opinione scettica si è fatta strada nel mondo dell’esegesi: cf. E. Cortese, “Le sventure annunciate dai profeti preesilici e l’Escatologia dell’AT”, Theol (Milano) 1 (1977) 91-107; “Escatologia del AT y Teología de la Liberación”, RevBi (Buenos Ayres) 51 (1989) 129-141. Sta di fatto che, nell’esegesi di Is 7,10-17, coronata da cenni a 9,4ss e 11,19, dopo aver portato avanti il discorso in maniera ottima, lo si conclude (p. 270) in maniera soffocata, per usare ancora questo termine. E le successive indicazioni per uno studio sul messianismo (pp. 271ss) seguono la pista di Cazelles, il cui libro del 1978 (dell’81 è la traduzione) è già frenato dalle opinioni scettiche allora in vigore e la cui ipotesi viene ulteriormente soffocata dalle ulteriori indicazioni bibliografiche dello stesso Marconcini (p. 273). Eppure su nessuno di questi testi, che noi ci ostiniamo a chiamare messianici, vengono sollevati dubbi di autenticità nelle pagine esegetiche che esaminiamo. Anche Spreafico, nel suo libro, difende l’autenticità di Is 11,1-9 (pp. 8594). Egli, nella prima parte, sente anche il bisogno di mettere un capitolo sull’argomento, il VII: “Non tutto è perduto. Dio può ancora salvare” (pp. 51-60). SPREAFICO I PROFETI 589 Ma nella parte esegetica il valore messianico di Is 11 ci sembra, ripetiamo la parola, soffocato e nell’altra parte sembra significativo che i profeti preesilici su cui poggia l’argomentazione circa la salvezza escatologica (pp. 51-60) siano Ger, Ez, Os, Ab, mentre Is è ignorato. E quando l’A. si occupa dei poemi del Servo sofferente (pp. 43s) egli si limita all’ipotesi del senso collettivo. D’altra parte, nel primo libro (pp. 373382 e nel suo commentario a Sofonia del 1991, non citato a p. 111!) egli difende l’autenticità di Sof 3,14-20, senza dare sufficientemente risalto, secondo noi, al significato escatologico del passo, mentre Marconcini difende il significato personale dei poemi del Servo (pp. 275-295), ma il discorso non viene portato pienamente a termine. Così rimane sbiadita (o coperta da un velo, come per i nostri fratelli ebrei? 2Cor 3,12-16) quella “parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione: è come una lucerna che brilla in un luogo tenebroso” (2Pt 1,19). Tra molti esegeti, anche e forse soprattutto neotestamentaristi, che non hanno voglia di rimettere in discussione certi pregiudizi e rivedere certi falsi punti di partenza, è diffusa l’idea che il senso cristiano dei testi messianici l’abbia inventato il NT e in quelli non ci sia affatto. L’esegesi moderna dei libri profetici, che talvolta trova la maniera di rendere le pagine profetiche addirittura “tenebrose”, ha avuto il pregio di far ricordare che il messaggio profetico non è solo quello messianico. Errore, questo, ancora attuale nella liturgia, dove praticamente i testi da leggere sono esclusivamente quelli della speranza. Ma non andiamo all’eccesso opposto: quello di dire che di testi messianici e consolanti non ce n’è nessuno! Nei nostri articoli citati sottolineiamo i pregi della concezione dell’escatologia di G. von Rad (contrapposta a quella di G. Fohrer), alla cui Teologia dell’AT (vol. II) molti oggi dovrebbero tornare (o, forse, dovrebbero finalmente studiarla). Egli dimostra che l’escatologia, quella negativa (castigo escatologico) ma anche quella positiva (speranze al di là del castigo), non nasce affatto dopo l’esilio. Certo, non è quella visione diretta di Cristo che l’esegesi antica attribuiva ai profeti, ma è, comunque, un’attesa dell’attuazione delle promesse fatte a Davide di un suo grande discendente e di una Gerusalemme grandiosa; un’attesa che nella preghiera dei salmi è tenuta quotidianamente viva e non nasce solo nel periodo oscuro dell’esilio e del postesilio, quando il re ormai è sparito e manca il supporto della speranza davidico-sionica. Nel postesilio, anzi, si perde spesso la speranza del re. E’ lì che nasce l’interpretazione collettiva del Servo sofferente, sovrappostasi all’altra, e quella del figlio dell’uomo di Dan 7. E’ lì che ci si concentra sullo splendore di Sion (nel Secondo e Terzo Is), passando dal quadro (il messia), lasciato vuoto, alla cornice (la sua città). Ma è anche lì che matura l’idea della salvezza messianica ottenuta attraverso la morte del re [W.H. Schmidt, “Die Ohnmacht des Messias. Zur Überlieferungsgeschichte der messianischen Weissagungen im AT”, KuD 15 (1969) 18-34; ora in U. Struppe (a cura di), Studien zum Messiasbild im AT, 590 RECENSIONI Stuttgart 1989], passaggio, questo, che non si può capire se non si ammette che il messianismo c’è già molto prima dell’esilio. Quanto al messianismo preesilico, oggi si comincia a capire che il messaggio della profezia di Natan, anch’esso, non nasce solo nell’esilio e che la prima stesura dell’Opera deuteronomistica, la quale fa leva su di essa, è del tempo di Giosia [in “2 Sam 7 e 1 Cron 17: prospettive attuali dell’esegesi”, Ant 69 (1994) 141-155. Ricordiamo anche l’acuta interpretazione dei famosi condizionamenti deuteronomistici della profezia di Natan ad opera di Nelson, contro N. Lohfink. Si veda anche “Sal 72: che Messia? Per quali poveri?”, LA 41 (1991) 41-60]. Ci scusiamo per queste autocitazioni. Hanno lo scopo di fornire degli spunti, per quella discussione tra amici di cui parlavamo all’inizio e per incoraggiare coloro che in Italia sono i nuovi specialisti sulla letteratura profetica a portare avanti il discorso senza paura e con un coraggio almeno pari a quello di chi, meno competente di loro, ha condotto la nostra esegesi sui profeti nell’attuale oscuro tunnel. Enzo Cortese Weigl Michael, Zefanja und das ‘Israel der Armen’ (Österreichische Biblische Studien 13), Österreichisches Katholisches Bibelwerk, Klosterneuburg 1994, 329 pp. E’ la rielaborazione di una tesi di laurea difesa a Vienna nel 1991, sotto la guida di G. Braulik. Rispetto a quella è stata aggiunta la sezione riguardante Sof 1,7.1011.14-16, cioè il tema del giorno di Jahweh, per un complesso di oltre cinquanta pagine. Fortunatamente è stata abbreviata l’analisi sincronica, uno studio grammaticale e sintattico molto pedante, che può interessare chi ha studiato queste cose con libri vecchi e vuol sapere come si chiamano oggi i termini “soggetto”, “predicato”, “complemento” (l’A. segue la Grammatica “metaforica” di H. Schweizer) e che allunga enormemente la prima parte (pp. 5-229), rispetto alla seconda (pp. 230-254), sulla composizione generale e alla terza sulla “Opzione (divina!) per i poveri” (pp. 255-284), che è il tema vero e proprio dello studio. In esso vengono tralasciati, inoltre, gli oracoli contro le nazioni (Sof 2,410 e 12-15) e, perché tardiva, la pericope finale (3,16-20); vengono anche tralasciati 1,8a.12a. Nell’introduzione l’A., tra il metodo della vivisezione diacronica moderna e quello della semplificazione sincronica strutturalistica, sceglie una terza via: considera quasi tutto il testo autentico e ben strutturato, seguendo la recente posizione di N. Lohfink1. 1. “Zefanja und das Israel der Armen”, BiKi 39 (1984) 100-108 = “Zephaniah and the Church of the Poor”, TDig 32 (1985) 113-118. WEIGL ZEFANJA UND DAS ‘ISRAEL DER ARMEN’ 591 Nell’analisi, suddivide il testo in molte brevi pericopi, presentando prima testo originale e traduzione, poi la critica testuale e letteraria, con giustificazione della propria delimitazione del brano, quindi la struttura ed infine l’analisi sincronica e diacronica. Nell’analisi sincronica studia qual’è la “predicazione”, gli “attanti”, la “illocuzione”, la “determinazione semantico/pragmatica”, le caratteristiche delle “parole pragmatiche”. Nell’analisi diacronica l’A. studia i passi simili nel resto della letteratura biblica, sforzandosi con essi, in particolare, di difendere la datazione antica del testo di Sofonia. Prima di discutere il lavoro presentiamo i risultati, che W., come s’è detto, espone nella seconda e terza parte: nella seconda, soprattutto la suddivisione dei tre capitoli di Sof come segue: 1,2-18a; 2,1-3,5; 3,6-15, e, nella terza, la tesi che i poveri d’Israele, intesi nel senso letterale e non spiritualizzato, e i gentili sono coloro che Dio ha scelto per continuare la storia della salvezza, che altrimenti i ricchi d’Israele avrebbero fatto naufragare. Alla fine del libro viene ripresentato tutto il testo ebraico di Sofonia, comprese le parti tardive, per lo più non analizzate, suddiviso nelle singole pericopi, a loro volta disposte separando i singoli elementi di ogni frase. Cosa che sarebbe stata ancor più pregevole se si fosse ripetuta anche la traduzione data nella parte analitica dall’A., tanto più che solo in essa, e non nell’ebraico, vengono segnalate, mettendole tra parentesi, le poche frasi ritenute tardive. E queste, oltre alla pericope finale, sono solo piccole frasi in 1,3s.10.17s; 3,5.8.10, per lo più non molto rilevanti ai fini della tesi di fondo. Infine il libro è corredato di una spiegazione delle abbreviazioni e sigle, di un’ampia bibliografia (suddivisa in: fonti, commentari e monografie o articoli) e d’un minuzioso elenco delle citazioni bibliche, elenco, dove, tra i commentari, manca quello di A. Spreafico (Genova 1991) che, essendo il più recente ed uno dei più ampi, meriterebbe di essere consultato. Come s’è già detto, questa tesi è preceduta da una presentazione della composizione del libro di Sofonia che merita apprezzamento, contro l’opinione che anche questo libro profetico sia strutturato secondo lo schema comune: 1) oracoli contro Giuda, 2) oracoli contro le nazioni, 3) oracoli di salvezza per Israele. Come mostra il primo dei tre schemi, che illustrano chiaramente la struttura delle rispettive parti di Sof, la cornice generale (1,2-3 e 17-18a) annuncia il castigo di tutti i popoli, tema che, all’interno, è sviluppato da quello del giorno di Jahweh, in alternanza con quello del castigo a Giuda. Dunque la prima parte non ha solo oracoli contro Giuda, ma sembra parli del castigo universale. La rassegna degli autori che discutono la divisione di Sof, del resto, mostra che ormai quella vecchia non è più accettata2. Un altro pregio del lavoro è soprattutto quello di aver messo in evidenza come tema centrale e genuino di Sofonia quello dei poveri, pregio che va attri2. Con il citato studio di Lohfink, Weigl segnala particolarmente quello di M.A. Sweeney, “A Form-critical Reassessment of the Book of Zephaniah”, CBQ 53 (1991) 388-408. 592 RECENSIONI buito prima di tutto a Lohfink, di cui l’A. segue le tracce. Ma qui deve cominciare la discussione, che sarà severa non per il gusto della critica ostile, ma nell’intento di portare avanti una ricerca molto importante ed appassionante. Affrontiamo subito il problema centrale. Ci siamo imbattuti in alcune contraddizioni che ci aiutano ad impostarlo ed affrontarlo e che presenteremo un po’ paradossalmente. Da una parte si dice che i poveri (≈rahAµ[) sono la gente di campagna, mentre i gerosolimitani sono i ricchi condannati al castigo inevitabile (pp. 112.119s.281); dall’altra si sente il bisogno di precisare che Gerusalemme non è condannata completamente (pp. 53.262). Da una parte si riconosce che per l’AT la ricchezza non è un male, o, per lo meno, non è sempre e totalmente da condannare (p. 257) e dall’altra, nel messaggio di Sofonia, non verrebbe data nessuna possibilità di conversione e di salvezza ai ricchi (per es. p. 261). Pensiamo che la contraddizione si potrebbe superare, se si ammettesse la differenza tra yn[ e wn[ che sosteniamo da parecchio tempo in articoli sui Salmi dei poveri3. Non si deve essere così radicali nel difendere la differenza di significati, da escludere assolutamente che un povero possa essere anche umile e viceversa, ma neanche semplificare le cose e identificare i due termini ebraici in questione. Di fatto nella prima pericope sull’argomento (Sof 2,1ss) abbiamo µw[ (2,3: ≈rahAywn[) e nella seconda (3,12s) abbiamo yn[ (3,12: ldw yn[), che, nell’intento di chi ha scritto il testo, dovran pure avere qualche differenza di significato, altrimenti ci sarebbe lo stesso vocabolo. Tanto più che nel primo caso, nello stesso 2,3, incontriamo il sostantivo astratto con la stessa radice: hwn[, che l’A. correntemente dovrebbe tradurre “povertà”. Al posto di “cercate la povertà”, traduce però “Selbsbescheidung” (p. 99; si veda anche 104.115 e 269), facendo finta di niente, mentre µywn[ lo traduce “poveri”. Da questa errata identificazione nascono altre incongruenze; per es. a p. 112, nella rassegna dei passi dell’AT su ≈rahAywn[, l’A. non separa quelli che hanno ≈rahAyyn[ (Giob 24,4 e Am 8,4) da quelli che hanno ≈rahAywn[ (oltre a Sof 2,3, c’è Sal 76,10 e, incerto, Is 11,4). Così pure, a p. 208, nell’elenco dei testi dove si trovano assieme yn[ e ld, l’A. non fa molta distinzione tra yn[ e wn[. Per la verità lì ricorda che Is 11,4 e Am 2,7 hanno wn[, il che confermerebbe la sua tesi dell’identificazione dei due vocaboli, ma ignora che nel primo caso i LXX hanno ptwco/ß. Quanto ad Am 2,7, se l’A. avesse dato uno sguardo alla masora avrebbe visto che si sente il bisogno di precisare che questo e Is 29,19 sono gli unici casi in cui wn[ si avvicina al significato di povero! E’ vero che ogni tanto nel testo masoretico biblico le due parole si confondono. Ma questo non è dovuto al fatto che i significati sono identici, bensì al fatto 3. Citiamo solo lo studio di partenza: E. Cortese, “Poveri e umili nei Salmi”, RiB 35 (1987) 299-293; o meglio: “Pobres y humildes en los Salmos: No confundir las cartas”, Teol (Buenos Ayres) 24 (1987) 95-106. WEIGL ZEFANJA UND DAS ‘ISRAEL DER ARMEN’ 593 che, nella varie tappe della storia della formazione del testo (e della recita del Salmo) si preferisce dare un senso (“povero”) o l’altro (“umile”) alla parola4. Quanto a Sof, se si mantenessero significati distinti alle due parole, probabilmente si avrebbe per i ricchi non cattivi la possibilità di salvezza di cui si parlava, un miglior equilibrio nel problema della valutazione della ricchezza secondo l’AT ed anche una miglior comprensione di tutto il suo libro. In Sof 2,1ss, infatti, il profeta esorta ad essere umili per sfuggire al castigo, e perciò i ricchi che ascoltassero l’invito potrebbero raggiungere la salvezza. Questa, di fatto, sarà soprattutto per i poveri (3,12). Perché chi gode di una ricchezza onesta, che per l’AT costituisce un ideale, non può sperare di avvicinarsi a Dio (pp. 112.114)? Perché si dovrebbe escludere dal messaggio di Sofonia l’esortazione a sfuggire al castigo (p. 116)? I gentili, cui nel messaggio primitivo (o forse redazionale) è annunciata la salvezza (Sof 2,11), non sono necessariamente poveri. Perché lo devono essere assolutamente tutti i salvati d’Israele? A questo punto, però, bisogna discutere l’altro testo: Sof 3,12s, perché lì i salvati sono effettivamente i veri poveri, nella nostra ipotesi, e si rischia di cadere nei due scogli opposti, come Scilla e Cariddi, cioè di dire che in entrambi i passi si tratta di veri poveri, come vuole l’A., o che si tratta sempre di umili, come vorrebbero la scuola francese (Gelin) e quella interpretazione pietistica ed ecclesiastica, che egli giustamente condanna. Veniamo a Sof 3,12s. Come si può dunque mantenere, e solo al secondo testo, Sof 3,12, il significato di povero vero? Sofonia esprime qui semplicemente l’esigenza che i poveri non debbano subire lo stesso castigo di quelli che l’hanno meritato, proprio opprimendo loro. Per essi la storia della salvezza deve assolutamente mantenere le sue promesse. Questa idea, cui l’A. non bada, non è una novità del solo Sofonia ed è nella logica del messaggio di tutti i profeti. Per la stessa ragione per cui essi proclamano il castigo agli oppressori, esigono che gli oppressi non abbiano a subirlo. Certo, di fronte alla distruzione di Samaria o di Gerusalemme, l’istanza non sembra rispettata; anche i poveri sono castigati. Tuttavia troviamo già l’idea della salvezza per i poveri, prima di Sofonia, in Is 14,30.32 (il castigo assiro colpisce i Filistei, ma non può colpire i poveri d’Israele) e 29,19; poi in 49,13 e ancora in 25,4 e 25,6. Può darsi che nei testi isaiani tardivi tutto il popolo venga detto povero, perché soffre in esilio e merita questa qualificazione. Ma anche nel postesilio ci sono dei testi che distinguono, all’interno dello stesso popolo, oppressori ricchi e oppressi poveri. Agli inizi dell’esilio, in Ger 39,10; 52,15 e soprattutto 40,7 si esprime la stessa idea. Il fatto che i Babilonesi abbiano deportato la classe dirigente e lasciato, invece, sotto la guida di Godolia gente povera (≈rah tldm!, corrispondente a 2Re 24,14 e 25,12), sembra voler notare che quell’istanza è stata rispettata. 4. Contro S. Gilligham, “The Poor in the Psalms”, ExpT 100 (1988/89) 18.6. 594 RECENSIONI Questa è la critica fondamentale che facciamo al lavoro di Weigl, partendo dalla nostra ipotesi che mantiene la distinzione tra yn[ e wn[. Proseguiamo ora nel formulare altre riserve su punti particolari del suo studio. Abbiamo espresso apprezzamento sulla nuova divisione dei tre capitoli di Sof e sul primo dei tre schemi forniti dall’A. Ma per quanto riguarda le parti 2ª e 3ª e i relativi schemi (pp. 250.253) abbiamo delle perplessità. E’ proprio sicuro che 2,11, la conversione dei pagani, sia messaggio genuino di Sofonia? Non potrebbe essere stato messo in quella posizione centrale da un redattore tardivo? Si apre qui la questione della data dell’universalismo nel pensiero biblico e, se l’A. avesse letto il commentario di Spreafico, avrebbe trovato un argomento, a proposito di 3,9 (allusione al racconto della torre di Babele), che gli sarebbe servito a difendere la sua tesi della genuinità dell’idea universalistica. Quanto alla terza parte, sembra strano che il punto centrale dello schema sia 3,11 (verso la fine del versetto): la rimozione dei colpevoli. Sembrano molto più importanti 3,12-15, la salvezza per i poveri e la rinuncia al castigo totale. Questo fa pensare che, invece di due parti (la seconda e la terza) se ne debba ipotizzare una sola (con Sweeny) e lo schema sia un altro. Esso forse non è riuscito bene al redattore, perché aveva a che fare con la serie degli oracoli contro i gentili, di Sof 2. Anche qui Spreafico potrebbe aiutare nella discussione, perché dimostra che sono autentici anche alcuni degli ultimi versetti (3,14-17), lasciati fuori nella struttura difesa dall’A. E qui vien fuori un’altra critica di fondo. Lo stesso Weigl parla di “redazione finale” del libro di Sofonia (p. 246). Ma quando la mettiamo? Il fatto che egli abbia scomposto i tre capitoli in tante piccole unità indipendenti (troppe soprattutto nel 3º!), fa pensare che ritenga tardiva tale redazione, tanto più se di essa facessero parte anche i brani che lui stesso ritiene tardivi. Anche per la prima parte, incorniciata da 1,2s e 17s e composta da minacce di castigo per Giuda, alternate (tre volte!) con il tema del giorno di Jahweh e non si dice nulla sulla storia della formazione e redazione. Ora se 2,11, messaggio sulla conversione dei gentili, così centrale nello schema del libro, fosse tardivo, salta tutta la presentazione del messaggio genuino del profeta, pur rimanendo essa valida per quello formulato, alla fine, dai redattori. Effettivamente una visuale così universalistica non sembra ancora del tempo di Sofonia e, comunque, per sostenere la tesi contraria, ci sarebbe voluto una dimostrazione ben più ampia e convincente delle pp. 127-134 dedicate alla relativa analisi. Tradurre poi hnp (Pi) con “convertire” invece di “far tornare indietro” i popoli ostili, per metterlo in connessione con 2,11 (p. 224) è una forzatura. Un tale significato il testo può averlo assunto, semmai, al tempo della redazione finale, ma prima e normalmente il verbo significa che i nemici saranno respinti. Non è nostra intenzione negare la tesi del libro di Weigl, ma far vedere più accuratamente come, attraverso la storia della formazione di Sof, si è arrivati a formularla. DEIANA IL GIORNO DELL’ESPIAZIONE 595 Pensiamo che di questa idea universalistica qualcosa sia genuino del profeta: per es. l’istanza o la profezia che tutti i popoli verranno a riconoscere Gerusalemme e il suo Dio. Ma la trasformazione di questa idea in quella della conversione dei pagani e la sua combinazione con quella del castigo universale dovrebbe essere il risultato di una storia della formazione e redazione di Sof, che ancora deve essere messa in luce. Dopo queste critiche di valore su tesi e metodo, ricordiamo ancora gli errori che genericamente chiamiamo tipografici: a p. 5 (“begündet”); 19 (µynk invece di µynhk); 85 (“Hiskika-Legenden”); 101 (nota 9: “Ssefanja”); 109 (“Es überwiegen nomen”, invece di “nomina”?); 164 (linea 4ª: Sof “3,8g”, invece di “3,18g’); 168 (hylyl[ invece di hlyl[); 179 (la parentesi del v. 10 andrebbe tutta sulla stessa linea) ed infine alcuni punti vocalici masoretici a p. 285 (1,8b) e 290 (3,11a e 15b). Inoltre i rimandi ad altre parti del libro son fatti senza dare la pagina, ma solo le varie sezioni, che a volte comprendono parecchie pagine, per cui l’indicazione è troppo generica. L’errore tipografico più grosso e, ahimè!, frequentissimo è dovuto alla stampa con computer delle frasi ebraiche, quando si deve andare a capo: i vocaboli delle frasi trascritte sono sistematicamente rovesciati (chi ha corretto le bozze?). Da ultimo notiamo che i caratteri, almeno quelli delle note, dovrebbero essere più grossi. Nonostante la critica severa, riteniamo importante il lavoro di Weigl. Esso ci permette di apprezzare il magnifico libretto di Sofonia, di mettere in chiaro il problema della ricchezza e della povertà di oggi, di confermare alla luce dell’AT il messaggio severo di Gesù contro l’amore alle ricchezze di fronte alla miseria che ci circonda… e di constatare come la tendenza di noi ricchi o benestanti ad attutire questo messaggio fosse già in atto nell’AT, tra coloro che sostituivano volentieri yn[ con wn[! La miglior sentenza con cui si sarebbe potuto concludere questa ricerca è proprio quella evangelica: “In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli” (Mt 19,23). Enzo Cortese Deiana Giovanni, Il giorno dell’espiazione. Il kippur nella tradizione biblica (ABI Supplementi alla Rivista Biblica 30), Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, pp. L. 28.000 Questo studio su Lev 16, la festa dell’espiazione, dopo l’Introduzione, consta di tre capitoli e tre excursus finali. Il cap. I è il più lungo e fondamentale. Vuol essere una traduzione accurata di Lev 16, fatta comparando il testo masoretico con Versioni, Targumim ed altri testi antichi. Nel II cap. si traducono passi paralleli: Lev 23,26-32; Num 29,7-11; Es 30,10. Nel III cap. si confrontano sinotticamente gli elementi comuni di Lev 16 con Lev 9 e 4; e poi quelli di Lev 23,27-32 con Num 29,7-11. 596 RECENSIONI Gli excursus sono: su capro espiatorio e capro emissario, sull’identità di Azazel e sulla teologia del Kippur. Ogni tanto si leggono lungo il cammino delle conclusioni: una dopo il cap. II; una sintesi finale dopo il cap. III e una dopo il secondo excursus. L’opera è preceduta da un lungo elenco di abbreviazioni, contenente anche numerose opere consultate, e conclusa dalla bibliografia e dall’indice delle citazioni, bibliche e degli autori. Il pensiero dell’A., che dà per scontata una storia di differenti redazioni e brani di epoche distinte in Lev 16, senza descriverla con la necessaria critica letteraria, lo riportiamo da un’ennesima conclusione, messa a p. 176, prima della seconda delle tre ricordate: “1) Azazel, di cui alla luce del materiale fornitoci da Qumran e specialmente dal Rotolo del Tempio, è necessario correggere la grafia tramandataci dal TM (‘z’zl) in ‘zz’l, potrebbe nascondere un originario culto del dio Azizo, divinità molto diffusa tra le popolazioni arabe del periodo ellenistico e già attestata nell’epigrafia fenicio-punica e persino nei testi di Ebla. 2) Tale divinità è l’ipostasi della stella Venere, il cui culto aveva un duplice aspetto, maschile e femminile, quest’ultimo radicato nella tradizione cultuale del popolo ebraico sotto il nome di Astarte. 3) Probabilmente durante il periodo ellenistico venne ripreso sia il culto della stella Venere sotto l’aspetto maschile (Azizo) che quello femminile (al-‘Uzza); mi sembra che il testo del Talmud babilonese citato dia adito a tale deduzione. 4) La reazione all’ellenismo, iniziata già nel corso del III sec. a.C. e culminata con la rivolta dei Maccabei e la successiva purificazione del tempio, abbia (sic!) portato alla demonizzazione di tali divinità pagane; tuttavia, per la loro popolarità, il loro culto non fu totalmente eliminato: Azizo divenne un angelo decaduto e, come Lucifero, contribuirà a formare un aspetto della personalità del diavolo nel cristianesimo”. Qui il cenno ad Ebla potrebbe far pensare che l’A. ipotizzi un’origine molto antica del culto descritto in Lev 16 o per lo meno del nome Azazel. Ma fin dall’inizio del lavoro egli dichiara: “la presenza del nome in Lv 16 suppone che quest’ultimo sia stato composto quando, almeno per la parte del rito relativo al capro emissario, la figura dell’angelo decaduto Azazel era non solo già delineata attraverso il testo del Libro dei Vigilanti ma resa popolare, visto che rimane come parte essenziale di un rito in cui il popolo è coinvolto direttamente. Inoltre il modo con cui viene ricordato il nome in Lv 16 suppone trattarsi di un personaggio ben conosciuto nell’ambiente cultuale. Di conseguenza bisogna supporre che tale rito sia stato formato quando detto libro era non solo ultimato (III sec. a.C.), ma addirittura largamente diffuso. Ma una parte di Lv 16 (vv. 10b.20-22) in cui si cerca di sostituire il nome di Azazel con ‘deserto’ suppone un tentativo di purificazione del rito, che probabilmente è da collocarsi nel periodo immediatamente prima dei Maccabei o durante la rivolta di questi ultimi, quando si cerca di eliminare dal culto del tempio gli elementi sincretistici introdotti dall’influenza ellenistica (IV-III sec. a.C.)” (pp. 50-51). DEIANA IL GIORNO DELL’ESPIAZIONE 597 Dato, e non concesso, che il nome Azazel sia una traccia del sincretismo del culto primitivo e tenendo conto che, nell’ipotesi di Deiana, di sincretismo ce ne doveva essere molto di più in Lev 16, dovremmo dedurne che l’opera di revisione sia stata ben più ampia di quella indicata (vv. 10b.20-22) e che gran parte del capitolo andrebbe datato, quindi, nella prima parte del sec. II. Queste idee dell’amico Deiana, sparse per tutto il libro, sono state coltivate a lungo, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, e pubblicate in articoli citati nel lavoro. Noi non le condividiamo e non le comprendiamo; oralmente e per iscritto non abbiamo certo incoraggiato l’A. Ma, come si vede, esse hanno trovato i loro Mentori sia nella elaborazione e sia nella pubblicazione; loro le capiranno. Segnaliamo alcuni errori: a p. 46 la citazione di Gn 1,7 è sbagliata; a p. 55, linea 11 manca il verbo dopo “il quale”; a p. 71, linea 3 pensiamo che si debba mettere “uccisione” al posto di “espiazione”; a p. 130, linea 9 “i.l” per “il”; a p. 143 nella penultima linea prima della citazione ci vorrebbe “del rotolo” invece che “di Lv 16”. Soprattutto manca nell’indice degli autori (pp. 197s) una lunga serie di nomi, a partire da Ventris: quasi una quarantina. Infine, accanto all’indice delle citazioni bibliche, sarebbe stato necessario quello della letteratura intertestamentaria e giudaica, così frequentata dall’A. È vero che alcuni nomi (per es. Giuseppe Flavio o Giovanni Lido) figurano nell’elenco degli autori moderni, ma i rotoli di Qumran o altra importante letteratura no. Tutto sommato il lavoro è accurato. In particolare, quanto alla traduzione, saremmo più inclini ad apprezzarne l’accuratezza, se l’A. stesso, nel riproporne alcuni versetti in seguito (cap. III), nel confronto sinottico, non ne desse spesso una diversa (si confrontino i vv. di Lev 16 ripetuti alle pp. 121ss; 127s; 130s con i corrispondenti dati del cap. I). A noi però interessa soprattutto la sostanza, cioè le idee sulla composizione, datazione e teologia di Lev 16. Perciò facciamo appello alle ultime voci autorevoli, che difendono un’antichità ben maggiore di Lev 16: ci riferiamo specialmente al commentario al Lev di Milgrom (vol. I), del 1991, citato ma non seguito nel lavoro di Deiana, a B. Janowski (“Azazel-Biblisches Gegenstück zum ägyptischen Seth”, in Die hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte, Fs. Rendtorff, Neukirchen 1990, 97-110), non preso in considerazione (l’A. cita un altro lavoro di Janowski, del 1993, in collaborazione con Wilhelm, ma senza prenderlo troppo sul serio quanto all’antichità delle tradizioni sul capro emissario). Quanto alla teologia dell’espiazione, l’A. vi dedica solo il terzo excursus, facendo delle distinzioni che sono discutibili per motivi opposti. La prima circa il significato dell’imposizione delle mani sul capro emissario: per gli uni indicherebbe la trasmissione dei peccati e porterebbe alla teoria dell’espiazione vicaria, che implicherebbe la morte sacrificale della vittima offerta; per gli altri indicherebbe la comunione dell’offerente con la vittima e non si baserebbe sulla morte ma solo sul valore espiatorio del sangue dell’animale (p. 182). 598 RECENSIONI È davvero una distinzione adeguata? Nel nostro commentario al Lev (Casale, Marietti 1982), nel primo dei cinque capitoli finali, dedichiamo alcune pagine alla teologia dell’espiazione sacerdotale, inclusa l’espiazione vicaria (pp. 146149), facendo notare, tra l’altro, che il sacrificio non è espiazione vicaria: col sacrificio si paga di persona. L’espiazione è vicaria quando uno paga per gli altri; è vicaria quella del Servo di Jahweh e del suo sangue per noi. Riguardo alla distinzione tra il TM e i LXX nella traduzione di Lev 17,11s, circa il sangue che, rispettivamente, espia “mediante la vita” o “al posto dell’anima”, non siamo proprio del tutto convinti che solo nel secondo caso “l’offerta della vittima sostituisce quella dell’offerente” (p. 183) e, comunque, questo tema richiede una discussione più ampia di quella di Deiana; su di esso, dopo le pagine dedicatevi nel nostro commentario, intendiamo tornare con uno studio specifico, che programmiamo per LA 1996. Tornando alla questione di fondo del lavoro di Deiana, crediamo opportuno far presente la nostra posizione. Nel nostro sfortunato commentario al Levitico (ritirato presto dal commercio) a p. 76, sosteniamo che Lev 16 è più unitario di quel che si pensi e ne datiamo la redazione finale al tempo di Esdra, da noi messo all’inizio del sec. IV, e non contemporaneo di Neemia, che entra in azione attorno al 450 a.C. Le fasi della formazione di questo documento, la cui forma primitiva (Pg) nasce, per noi, in esilio, le descriviamo in un altro dei capitoli finali, in appendice al commentario (pp. 170-174). Ivi manifestiamo delle perplessità su ulteriori ritocchi redazionali. Le perplessità sono legate a una datazione dell’Opera Cronistica, molto vicina ai rituali del Lev, che allora ritenevamo piuttosto tardiva (250 a.C.) e che ci faceva ritenere molto tardivi quei ritocchi redazionali. Ma ora, dopo il commentario alle Cronache di S. Japhet (Londra 1993), che data il libro attorno al 350, siamo molto più decisi nel sostenere per Lev 16 e tutto il sistema sacerdotale dell’espiazione una datazione molto più antica di quella proposta da Deiana. Il nostro commentario e le relative proposte di datazione non hanno avuto fortuna. Ma la nostra opinione è incoraggiata da autorevoli opere recenti. Oltre al citato J. Milgrom, segnaliamo ora I. Knohl, The Sanctuary of Silence. The Priestly Torah and the Holiness School, Minneapolis 1995. Per essi il Documento sacerdotale è addirittura preesilico e anteriore al Deuteronomio e la legge di Santità (Lev 17-26) è esilica, con redazione finale, tutt’al più al tempo dei Persiani. Qualcuno potrà sorridere, ma, dopo tutto, sono questi i veri specialisti della letteratura sacerdotale ed è con essi, semmai, che ci si deve confrontare. La moda dei biblisti, almeno quella delle cerchie (romane) che contano, porta a concentrarsi solo su lavori che sostengono la datazione più tardiva possibile di Lev 16, mentre ai lavori che lo dicono più antico, come il nostro commentario, non si dedica nessuna attenzione. Ma di queste cose Deiana non è assolutamente colpevole. Enzo Cortese OTTO THEOLOGISCHE ETHIK DES ALTEN TESTAMENT 599 Otto Eckart, Theologische Ethik des Alten Testament (Theologische Wissenschaft 3,2), Kohlhammer, Stuttgart - Berlin - Köln 1994, 288 pp. Fino a ieri un’etica dell’AT partiva e si basava sul concetto di alleanza. E questa veniva concepita come un’istituzione antica, religioso-cultuale. Nel contesto di tale istituzione Israele acquisiva la sua identità. Le leggi gli venivano date, rinnovate, modificate nel corso dei secoli attraverso questa istituzione ed erano perciò per loro natura religiose. Basti menzionare la Teologia dell’AT di Eichrodt. Ma oggi l’istituzione dell’alleanza tra Dio e Israele è ritenuta da molti una cosa tardiva, dell’epoca esilica o deuteronomista. L’anfizionia è ormai considerata una favola. Essa fino a ieri era la struttura attraverso la quale le tribù, appena stabilitesi nella terra, si unirono pian piano tra loro in incontri in cui la dimensione religioso-cultuale era fondamentale. Questa era la culla del Jahwismo, cioè della religione che caratterizzò Israele, anche se questa religione si riteneva provenuta dall’Est, importata in Palestina dalle “tribù di Rachele”. Nel contesto dell’anfizionia si riformularono i racconti dell’antica storia delle singole tribù e vennero “pan-israelitizzati”, cioè divennero patrimonio di un passato concepito come storia comune. Nei racconti del Sinai era facile, così, inserire già in epoca antica il tema dell’alleanza e della legge, data da Dio per mezzo di Mosè. Sono poi arrivati dalla critica letteraria i dubbi sulla genuinità dell’ambientazione della legge al Sinai. E, in più, oggi molti negano anche la datazione classica di questi racconti del Sinai, il cui strato più antico fino a ieri era attribuito ad un Documento J, del sec. X, ed E, del sec. IX. Oggi molti pensano che Israele sia nato per lenta evoluzione dalla stessa popolazione cananea e che il vero Jahwismo biblico sia una caratteristica comparsa tardivamente: solo a partire dall’esilio. Come si concepisce, allora, la storia della legge in Israele, nell’ottica nuova, oggi alla moda? Non è un puro caso che siano comparse recentemente due opere voluminose ed importanti, che tentano di rispondere alle nuove esigenze. La prima, in ordine di tempo, è quella di F. Crüsemann, Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des atl. Gesetzes, München 1992. Ad essa faremo talvolta riferimento nel corso della discussione. La seconda è l’opera che intendiamo appunto presentare. Il lavoro di Otto fa parte d’una serie di testi che, per spiegarci, dovremmo chiamare manuali per studenti di una facoltà di Teologia protestante. Questo è il volume sull’etica, come spiega il primo capitolo, introduttivo (pp. 9-17). Ma, per il valore dei contenuti, esso interessa molto a chi, sorvolando sull’introduzione, si dedica semplicemente allo studio dell’AT e in particolare al tema delle sue leggi. Il volume ha il vantaggio di contenere, o condensati o sviluppati, tanti lavori specifici dell’A. sull’argomento, studi che si trovano sparpagliati in differenti riviste o libri. Nel cap. II si passa subito allo studio del Codice dell’Alleanza (Es 21ss.), cui l’A. si era preparato soprattutto con due specifici volumi, citati rispettiva- 600 RECENSIONI mente nella bibliografia speciale e generale della stessa sezione: uno sul Codice stesso, del 1988, e l’altro sul confronto con il Codice antico-babilonese di Eshnunna, del 1989. Il cap. II, sul Codice dell’alleanza, è lo studio più lungo (pp. 18-116) e forse più importante, almeno dal punto di vista dell’informazione, per chi non è specialista sull’argomento. Dopo una panoramica aggiornata sullo stato delle ricerche (II.1), si studia il diritto casuistico (II.2) ed apodittico (II.3). Inoltre si approfondisce il tema del diritto matrimoniale (II.4) e si trattano gli aspetti della solidarietà (II.5), della serietà dei processi (II.6), della tutela dei deboli (II.7). Segue un aggiornato studio della questione del taglione (II.8). Ma le pagine forse più interessanti e problematiche sono dedicate all’aspetto teologico: come, cioè, in Israele, nasce la legge morale da questo diritto (II.9, pp. 81111). Tale nascita sembrerebbe coincidere soprattutto con la crisi della comparsa della grande povertà prodotta dal sistema, che potremmo chiamare capitalistico, introdotto dalla monarchia. Il capitolo si conclude con un collegamento ed un’applicazione all’economia moderna dei principi studiati nel Codice dell’Alleanza (II.10). Nello studio della legge dell’AT è interessante ed utile dare anche uno sguardo alla letteratura sapienziale. E’ quanto l’A. fa, in parte, nel cap. III (pp. 117-174); diciamo in parte, perché l’esame della letteratura sapienziale tardiva d’Israele (Siracide) vien fatto dopo, alla fine del cap. successivo. Ma qui, nel cap. III, si premette opportunamente una buona panoramica sulla sapienza egiziana, seguendo le tappe dei grandi periodi di quell’impero (III.1), e su quella della Mesopotamia (III.2). La Sapienza israelitica è divisa cronologicamente e contenutisticamente in preesilica, “induttiva” (III.3.1), in quanto scoperta nell’osservazione della realtà, e postesilica, “deduttiva” (III.3.2), in quanto dedotta (o discussa) partendo dalla concezione sapienziale classica su Dio remuneratore. Nella prima sezione si trattano le antiche raccolte del libro dei Prov (Prov da 10 in poi) e nella seconda Prov 1-9, Giob e Qoh (o Eccle). Da segnalare che i due ultimi libri non sboccano, secondo Otto, in quello scetticismo radicale che molti pensano. Nel cap. IV (pp. 175-263) c’è tutto il resto. Contrapposta all’etica ricavata nel cap. precedente dalla natura, ad opera della sapienza, viene trattata quella nata nella storia, a partire dall’esilio (!). Essa si trova anzitutto nel Codice Deuteronomico (IV.1.1-3) e nel decalogo di Deut 5 (IV.1.4), il quale è ritenuto genuino solo qui e non in Es 20, cioè nei precedenti racconti sinaitici. Codice nella forma completa e decalogo non si hanno prima dell’esilio. Questa etica si trova poi nella letteratura sacerdotale (IV.2), ritenuta postesilica, senza distinzione tra strato primitivo e strati posteriori, in particolare nella teologia dell’espiazione (IV.2.1s) e nel posteriore Codice di Santità di Lev 17-26 (IV.4). Come abbiamo già fatto rilevare, Otto ritiene che la legislazione (Codice di Alleanza e previo decalogo di Es 20) sia stata inserita nella storia del Sinai solo dalla redazione tardiva che unì Tetrateuco e Opera deuteronomistica (IV.2.3). OTTO THEOLOGISCHE ETHIK DES ALTEN TESTAMENT 601 L’ultimo punto di questo lungo ed eterogeneo capitolo tratta dell’Ecclesiastico o Siracide (IV.3), tappa finale della sapienza. E’ lì che si opera la fusione e riconciliazione tra le due ottiche, quella sapienziale e universale e quella storica e specificamente israelitica della legge. Così son passate in rassegna quasi tutte le parti dell’AT. Mancano un po’ i profeti: solo i preesilici sono trattati brevemente in II.9.5; alcuni salmi vengono presi in considerazione alla fine di II.9.1 (Sal 8) e in II.9.2 (Sal 15; 24; 93). Quanto all’apocalittica, si considera Dan nel cap. V (pp. 264-269), che è la conclusione del lavoro. Seguono gli indici: delle citazioni bibliche e di quelle dell’antica letteratura, egiziana e babilonese ed uno, prezioso, secondo tematiche e contenuti. I temi o punti principali che sono emersi dalla ricerca l’A. li enumera nella conclusione: storia delle codificazioni delle leggi (“Normensysteme’) dell’AT, loro trasformazione religiosa (“Begründung und Legitimation”) e problema dell’opposizione tra osservanza della legge e riuscita nella vita. Trattare tutti gli argomenti studiati dall’A., qui è impossibile. Basta scorrere l’indice dell’opera per vedere quanti sono e quanto sono interessanti. Nella discussione lasceremo un po’ da parte l’ultimo punto, che riguarda più la letteratura sapienziale. Ma apprezziamo l’aver dato anche uno sguardo a questo settore biblico, cosa che, invece, non ha fatto Crüsemann. Dopo il lavoro di Gerstenberger, Wesen und Herkunft des apodiktischen Rechts, del 1965, era quasi obbligatorio farlo; Gerstenberger, a ragione o a torto, ha creato l’opinione che l’origine delle leggi tipiche d’Israele vada ricercata non negli incontri religioso-cultuali dell’anfizionia, ma nell’ambiente laico e sapienziale del clan. A noi interessa di più occuparci degli altri due punti, dove, tra l’altro si ammira meglio la competenza specifica di Otto. I pregi che vogliamo segnalare sono molti. Anzitutto quello di saper risalire sino alle lontane origini d’Israele e delle sue leggi nell’esame del Codice dell’Alleanza; poi quello di tener molto presenti i Codici legislativi dell’Antico Oriente, due cose alle quali Crüsemann ha rinunciato, per i motivi già ricordati all’inizio. Da questi due pregi ne deriva un terzo: il considerare attentamente non solo le leggi, ma la loro sistemazione e la struttura loro data nei tre rispettivi codici biblici. Lo studio è corredato di abbondante ed aggiornata bibliografia, premessa ad ogni capitolo e alle principali sue suddivisioni, ed è frutto di lunghe ed accurate ricerche, previe o parallele. Per il Codice dell’Alleanza abbiamo già ricordato le principali. Per il Codice Deuteronomico è in arrivo Rechtsreformen in Juda und Assyrien. Studien zum Deuteronomium und zum mittelassyrischen Kodex, nella serie di Leiden (Brill): Studia et Documenta ad Jura Orientis Antiqui Pertinentia. Per il Codice di Santità, oltre ad alcuni articoli indicati nella bibliografia di IV.2.1 e 2.4 e oltre ad un’ottima analisi nel nostro libro, è in cantiere addirittura un commentario al libro del Levitico. Senza dire dei numerosi articoli dell’A. sull’argomento. 602 RECENSIONI Ma veniamo, ora, anche alla critica e alla discussione. Non stiamo a dire dei limiti e delle omissioni di altra letteratura biblica o intertestamentaria. Sarebbe impossibile in un solo volume esaminare tutti i testi biblici ed extrabiblici che hanno a che fare con la legge e la morale. Ricordiamo, per es., Maccabei, Tobia o la parte di Daniele che per noi cattolici è deuterocanonica, con la sua storia di Susanna. Forse qualcosa in più si doveva, comunque, dire sui rituali e soprattutto su Lev 1-7 e 11-15 e sulla loro caratteristica lotta all’“impurità” rituale e al peccato. Si è già capito fin dall’inizio, poi, che non riteniamo accettabile la tesi che la legge sia stata inserita nei racconti predeuteronomistici del Sinai solo da una redazione tardo-postesilica. In ciò preferiamo Crüsemann, per quanto sia anche lui piuttosto titubante sulla questione. Con Crüsemann riteniamo pure che il Codice Deuteronomico sia preesilico e non esilico. La datazione esilica porta Otto a datare genericamente il Codice sacerdotale in epoca troppo tardiva, ancor posteriormente il Codice di Santità, ignorando completamente gli studi recenti sulla letteratura sacerdotale e la sua datazione, in particolare quello ormai classico di A. Hurwitz, A Linguistic Study of the Relation between the Priestly Source and the Book of Ezechiel. A New Approach to an Old Problem, Paris 1982. Anche per la bibliografia forse è preferibile Crüsemann che mette il suo lunghissimo elenco tutto alla fine. Quello di spezzettarla e distribuirla nelle singole sezioni ha il vantaggio di far capire meglio il contenuto delle opere citate, ma implica ripetizioni, dato che un’opera può essere citata per più argomenti, e soprattutto provoca l’inconveniente dei rimandi ad altre parti. Per ragioni di spazio Otto dà inoltre citazioni troppo brevi, per lo più senza dire la città dove l’opera è stampata. Segnaliamo, qui, inoltre l’omissione dell’opera di H.P. Mathys, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Untersuchungen zum atl. Gebot des Nächstenliebe, Freiburg Schw. 1986, nella bibliografia di p. 243, opera che pure viene citata a p. 247. Così pure, facciamo osservare che l’opera di A. Schenker, Versöhnung und Wiederstand, 1990, non si trova, come è detto a p. 74, in I.2, ma in II.2, a p. 25. A parte questi dettagli, c’è però un problema più importante che vorremmo qui discutere e che abbiamo ventilato fin dall’inizio. Secondo Otto le leggi dell’AT ricevono il loro timbro religioso tipico, jahwistico, solo tardivamente. Certo, va riconosciuto all’A. lo sforzo di superare l’impasse attuale dell’esegesi, che sembra non saper risalire oltre l’esilio nella datazione del Jahwismo genuino. Otto vede il marchio dell’etica jahwista non semplicemente nell’attenzione per il povero, ma nel fatto che questa attenzione è voluta da un Dio che tiene ormai assieme i clan in una comunità più ampia (II.9; specialmente pp. 88ss). Ciò presupporrebbe la teologia regale gerosolimitana (p. 85), che lui mostra citando i ricordati Salmi 8, 5, 24… Questa etica jahwista sarebbe ulteriormente affinata grazie ai profeti preesilici che difendono i poveri nella crisi economico-sociale provocata lentamente dalla monarchia. OTTO THEOLOGISCHE ETHIK DES ALTEN TESTAMENT 603 Ma la crisi della monarchia ha proprio portato allo sfascio di quella società tribale da cui è nata la legge d’Israele. Sembra perciò discutibile che la trasformazione jahwistica della legge avvenga proprio ad opera di istituzioni monarchico-gerosolimitane, di quella monarchia che è la causa del crollo della società da cui nascono le leggi. A priori si dovrebbe dire che lo stato monarchico doveva cancellare le leggi e non cercare di salvarle. La comunità cui Dio dà coesione, destinataria delle leggi, non è lo stato monarchico, ma qualcosa di anteriore. Aveva ragione M. Noth – di cui ricordiamo il troppo dimenticato Die Gesetze im Pentateuch, del 1940 (e poi in Gesamm. St., 1960) – a dire che le leggi d’Israele non vengono dalla monarchia, ma sono anteriori e vengono da un “Israele” premonarchico. E noi precisiamo che sono anteriori anche nella loro caratteristica jahwista, religiosa. Purtroppo combattendo esageratamente la teoria dell’anfizionia, si è buttato via tutto: colle fasce, anche il bambino, come si dice. Adesso siamo ridotti all’impossibilità di immaginare degli incontri tra le tribù che abbiano pian piano portato alla formazione d’Israele, prima della monarchia. Eppure ci sono testi che dicono che le tribù si riunivano. Basti citare Giud 5. Come facevano a riunirsi per una battaglia, se non c’era qualcosa in comune e se questo qualcosa in comune non era soprattutto un culto, una forza religiosa, un credo comune, per usare le parole di von Rad? Sembra che oggi molti esegeti siano tutt’al più disposti ad ammettere che le tribù si radunavano solo per motivi profani. A discutere di politica, di filosofia o di sport, forse? La scoperta di tante figurine della “pietà privata” negli scavi archeologici spinge molti a ritenere che il Jahwismo sia nato più tardi. Ma tale dato archeologico deve semplicemente aiutare a correggere un’immagine troppo semplificata del primitivo jahwismo comune delle tribù, non a negarlo. A questo proposito è significativo l’esame delle scoperte archeologiche dei templi di Palestina fatto da W. Zwickel, Der Tempelkult in Kanaan und Israel, Tübingen 1994 (si veda la recensione in questo stesso volume). Egli conclude che praticamente nessun tempio del tardo bronzo è rimasto in uso nell’epoca del ferro e nella civiltà delle tribù improvvisamente spuntate in Israele, se non nella zona filistea e a Bet-Shean (p. 341). Non che queste popolazioni nuove, che le scoperte archeologiche di I. Finkelstein mostrano essere in totale discontinuità nei confronti della precedente civiltà cananea (si veda in From Nomadism to Monarchy. Archaeological and Historical Aspects of Early Israel, edd. I. Finkelstein - N. Na’aman, Jerusalem 1994), fossero atee o s’incontrassero solo per parlare di filosofia o di politica. Avevano le loro “bamoth”, dove incontrarsi. E’ lì che il jahwismo iniziale, per quanto rudimentale, si è imposto e diffuso ed è lì che sono nate le leggi, religiose e jahwiste fin dall’inizio. Non si deve dimenticare che anche nella forma primitiva delle leggi del Codice dell’Alleanza, per la soluzione del caso giuridico, è frequente il ricorso a Dio o il pellegrinaggio al suo luogo di culto (Es 21,6.13; 22,7s.10), e si parla di sacrifici e di offerte (22,19.28s)! E questo luogo di culto non è affatto il tempio di 604 RECENSIONI Gerusalemme. Si tratta di diversi luoghi sacri, in una fase molto anteriore alla centralizzazione del culto. E, soprattutto, pensiamo che nella legislazione antica d’Israele si debbano ancora distinguere due tipi di leggi: casuistica ed apodittica. Quella casuistica è originariamente destinata ai giudici; non tocca al privato dare esecuzione alle pene stabilite per le varie trasgressioni. Quella apodittica, invece, è destinata direttamente al popolo; non è ai giudici che si ricorda che non bisogna presentarsi a Dio a mani vuote o che non si deve uccidere. A. Alt aveva fatto notare che è la legislazione apodittica quella che caratterizza Israele. Ma anche a lui è toccata la sorte di Noth. Invece di limitarsi a correggere certi errori della sua teoria e migliorarla, la si è buttata. E così si è finito per dire o che la legislazione apodittica è laica e nient’affatto jahwistica o che essa è un elemento aggiunto tardivamente. Bisogna invece ritenere che, alle origini, si proclamasse ad Israele, nel suo antico culto, non un codice destinato ai giudici, ma la legislazione di tipo apodittico. Solo tali leggi, e in primo luogo i comandamenti, erano originariamente ambientate nel culto primitivo. Il decalogo, dunque, contrariamente a quanto pensa Otto, non è il risultato finale di tutta la storia della legislazione israelitica, nato solo nell’esilio e inserito nei fatti del Sinai solo dopo. Per queste ragioni, che qui non possiamo sviluppare oltre, ci sembra che lo sforzo di E. Otto per una ricostruzione della storia della legge israelitica, pur essendo oggi, forse, quello meglio riuscito, debba tuttavia essere completato. Enzo Cortese Tov Emanuel, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis - Van Gorcum - Assen - Maastricht 1992, XL-456 pp., $ 40.00 “Ogni persona provvista di buon senso non deve aspettarsi da trattati di critica testuale niente a cui non possa pervenire con la personale ricerca… Ciò che un trattato sull’argomento può offrire è un risparmio di tempo e fatica presentando immediatamente risultati (e considerazioni) ai quali in ogni caso si sarebbe arrivati da soli prima o poi”. Queste parole, con le quali Tov introduce il suo volume, danno il senso di quest’opera. Dopo l’introduzione, nella quale vengono riportati un’ampia e appropriata bibliografia e l’indice generale, seguono 9 capitoli. Ne prendiamo in esame alcuni. Il cap. I (pp. 1-20) è un’introduzione in cui l’A. introduce il lettore ai problemi più generali, come la necessità della critica testuale per sapere interpretare con spirito critico i problemi, la disposizione del testo biblico, la numerazione e divisione in versetti, le differenze di consonanti, vocali e accenti, gli errori nelle diverse edizioni della Bibbia, i problemi legati alla trasmissione del testo. La seconda parte di questo capitolo tratta propriamente della critica testuale: dal TOV TEXTUAL CRITICISM OF THE HEBREW BIBLE 605 concetto di critica testuale si passa ad una breve storia dello studio critico del testo biblico e alla definizione dei termini tecnici usati in questa scienza. Il cap. II (pp. 21-154) è, insieme al cap. IV, il capo centrale dell’opera. Dopo aver introdotto la distinzione fra Testo Masoretico e Testo Proto-Masoretico (l’esistenza del TPM deve essere ipotizzata a causa della grande diversità dei testimoni del TM), vengono presentate le differenze principali che sono di diversi tipi: note della masora, sistemi di vocalizzazione, differenze nel testo consonantico, ecc. L’evoluzione del testo consonantico della Bibbia ebraica può essere ricondotta a tre principali momenti: a) dal momento della nascita fin verso l’anno 70 (distruzione del secondo tempio). In questo primo periodo della durata di quasi 1000 anni il testo consonantico non ha subito cambiamenti di rilievo (p. 30). b) Nel secondo periodo, che va dal 70 all’ottavo secolo, i manoscritti hanno una serie di varianti piuttosto limitata. c) Nel terzo periodo che va dall’ottavo secolo alla fine del Medioevo il testo consonantico diventa standardizzato grazie anche all’aggiunta di vocalizzazione, accenti e note della masora necessitanti di una base consonantica fissata (p. 35). L’A. passa poi a descrivere i diversi tipi di vocalizzazione: tiberiense, palestinese e babilonese (il tutto illustrato da tavole inserite nel testo) a cui seguono elementi paratestuali (la masora parva). Seguono altri interessanti paragrafi dedicati agli accenti biblici, alla masora magna e parva e al loro oggetto e alle diverse edizioni del TM. Quest’ultimo tema viene ripreso e approfondito nel cap. IX dedicato alle edizioni critiche della Bibbia ebraica. Gli ultimi due argomenti del capitolo riguardano il Testo Samaritano (Pentateuco) e la sua relazione con i testi pre-samaritani e, infine, i testi biblici provenienti da Qumran. Particolare attenzione merita l’approccio ai testi di Qumran, campo in cui l’A. è specialista. Dopo aver presentato una lista sintetica delle copie dei testi biblici trovati a Qumran, Tov spiega le caratteristiche ortografiche e morfologiche di questi testi e altre caratteristiche minori. L’ultima parte del capitolo (pp. 121-154) è dedicata alle antiche versioni della Bibbia. Lo spazio maggiore viene riservato alla LXX e alle sue revisioni (recensioni), data la sua antichità (e data la specializzazione dell’A.), a cui seguono i Targumim, la Peshitta e la Volgata. L’A. mostra l’utilità delle antiche versioni (in particolare la LXX) nella ricostruzione del testo ebraico tradotto. Il cap. IV (pp. 199-285) tratta della copiatura e trasmissione del testo biblico. Si spazia dagli elementi più semplici, come materiale e dimensione dei fogli su cui si scriveva, al modo di scrivere, divisione del testo, sticometria, procedure scribali nello scrivere e correggere i loro Mss, qualche nozione di paleografia e un paragrafo sull’ortografia corredato da diversi esempi. L’ultima parte del capitolo, dedicata alla trasmissione del testo, è la parte più interessante. Qui affiora l’esperienza del docente nella materia. Il cap. VI (pp. 293-311) è un capitolo di sintesi in cui l’A. tenta di dare una sua interpretazione e valutazione delle varianti testuali. Più che stabilire o ripetere una serie di regole / criteri, Tov si mantiene sul generale: offre criteri esterni 606 RECENSIONI ed interni e li discute. Non vi sono regole assolute come, ad es., una preferenza incondizionata per il TM, o il numero dei testimoni (manuscripta ponderantur, non numerantur), o la loro antichità e frequenza (la critica testuale non procede secondo la regola democratica della maggioranza), oppure la difficoltà di certi testi (lectio difficilior potior). In definitiva vi sono solo letture preferibili ad altre letture, ogni scelta rimane soggettiva e la scelta più giusta è frutto di arte più che risultato dell’applicazione di regole. Il cap. VII (pp. 313-349) tratta della critica letteraria e del suo rapporto con la critica testuale. La prima si occupa dello stadio della crescita del testo biblico fino a un punto ritenuto definitivo per quanto concerne il contenuto. La seconda prende in esame la ricopiatura e la trasmissione testuale delle composizioni definitive. Dopo aver posto alcune premesse di ordine pratico, Tov discute in 13 paragrafi altrettanti esempi di diversi strati letterari individuabili e ricostruibili dal confronto fra il TM e le versioni antiche. I primi quattro esercizi, riguardanti rispettivamente gli strati letterari di Geremia, Giosuè, Ezechiele e 1Sam 16-18, mostrano chiaramente il modo di procedere di Tov. Anche chi non fosse d’accordo con l’A. dovrà riconoscere la sua chiarezza espositiva e il suo ordinato modo di procedere. Le ultime pagine del capitolo sono dedicate alla problematica interpretazione / valutazione (sia testuale che letteraria) dell’evidenza. L’A. raccomanda la prudenza nell’interpretare i dati ottenuti dal confronto anche se, dopo tale analisi, sarà opportuno trarre qualche conseguenza. In altre parole, è più facile mostrare le differenze di carattere letterario che valutarle. Il cap. VIII (pp. 351-369) tratta degli emendamenti congetturali del testo. La frase citata dall’A. all’inizio del capitolo: “nessuna parte della teoria della critica testuale ha sofferto di maggior incomprensione che l’emendamento congetturale”, sembra esprimere bene il suo punto di vista al riguardo. Ciononostante l’A. riporta in maniera oggettiva i pareri degli studiosi nei confronti dei vari tipi di emendamenti (di carattere contestuale, linguistico, metrico); vi sono proposte accettate dalla maggioranza degli studiosi (ad es. le parole in Amos 6,12; Ez 3,12; Is 11,15), mentre altre sono molto più discusse. Tov si mostra abbastanza critico (a ragione) verso gli emendamenti linguistico-grammaticali, la maggioranza dei quali non sono necessari. E’ abbastanza scettico anche verso gli emendamenti dovuti a ragioni metriche. Non possiamo che condividere il suo pirronismo al riguardo. L’ultimo capitolo (pp. 371-378) tratta delle edizioni critiche del testo della Bibbia ebraica. Viene ripreso e sviluppato un tema già trattato alle pp. 77-79. Abbiamo, fino ad oggi, solo due edizioni critiche della Bibbia ebraica, cioè la BH e la BHS da un lato e la Bibbia dell’Università ebraica di Gerusalemme dall’altro. La prima (o le prime) è l’unica edizione critica completa, mentre la seconda, voluta in particolare dal compianto prof. Goshen Gottstein, è in fase di stallo. Tov spiega brevemente le caratteristiche e gli intenti di ogni opera. Seguono 30 tavole che riproducono manoscritti ed edizioni del testo biblico. Infine tre indici: delle fonti antiche bibliche e non bibliche (pp. 411-434), degli autori (pp. 435-442) e degli argomenti trattati (pp. 433-456). ZWICKEL DER TEMPELKULT IN KANAAN UND ISRAEL 607 Dobbiamo essere grati all’A. per l’immenso lavoro svolto e per la miniera di informazioni che ci propone in sintesi chiara e precisa. Il lavoro di Tov è una sintesi ordinata e un’altrettanto ordinata introduzione al metodo storico-critico. La bibliografia riportata all’inizio dei singoli capitoli o paragrafi permette e stimola l’approfondimento personale. Insomma, si tratta di un libro da raccomandare a docenti e studenti. Mi pare che la parte più riuscita dell’opera siano i capitoli in cui Tov riporta i dati. Le disquisizioni di natura filosofica, ad es. sulla validità dei criteri su cui si basa la critica testuale, sono (almeno per me) meno interessanti. Massimo Pazzini, ofm Zwickel Wolfgang, Der Tempelkult in Kanaan und Israel. Studien zur Kultgeschichte Palästinas von der Mittelbronzezeit bis zum Untergang Judas (Forschungen zum AT 10), J.C.B. Mohr, Tübingen 1994, XVI-424 pp. Dopo quattro anni dalla pubblicazione in OBO 97 (1990) a Friburgo svizzera della tesi di laurea, discussa a Kiel nel 1988, l’A., oltre ad articoli, già numerosi, e all’edizione di una raccolta di studi sul sacrificio olocausto, in onore del suo maestro M. Metzger, presenta questo voluminoso e bel lavoro come abilitazione, presso la stessa università tedesca. Esso ricalca il metodo seguito nella tesi, allargando il campo della ricerca. Là si trattava di studiare gli incensieri, nell’archeologia e nella Bibbia, qui gli oggetti di culto, specialmente in riferimento al sacrificio. L’A., quindi, pur dedicandosi allo studio della Bibbia e del suo culto, ha acquisito una notevole competenza anche in archeologia e la sua capacità di tener lo sguardo rivolto su entrambi questi settori, Bibbia e archeologia, è ricca di prospettive per le ricerche future sulla storia del culto israelitico. Come dice il sottotitolo, i dati archeologici presi in considerazione sono solo quelli dei periodi che vanno dal Bronzo Medio al Ferro II, fino alla distruzione di Gerusalemme da parte dei Babilonesi, con particolare attenzione al momento del passaggio dall’ultimo Bronzo al Ferro I, cioè all’epoca in cui compaiono quelle popolazioni tra cui emergerà il popolo d’Israele. Il Bronzo Medio è scelto come punto di partenza, perché ai suoi inizi si nota un grosso cambio epocale (p. 6). Dopo l’introduzione, Zwickel chiarisce i termini della questione, discutendo i criteri per distinguere tra tempio, cappella e spazio sacro di abitazioni private, in maniera che, di fronte alla rassegna dei dati archeologici, non si finisca col fare la confusione che oggi va di moda, parlando solo di “pietà privata”. Egli presenta pure lo stato delle ricerche, le quali, anche a causa di quella confusione (e della mentalità secolare o secolaristica di alcuni autori), oggi sono piuttosto stagnanti. 608 RECENSIONI Praticamente il lavoro si divide in due parti, anche se la seconda, quella biblica che abbiamo nel cap. VII, non è chiaramente distinta. La parte archeologica ha quattro capitoli, da III a VI, uno per ogni epoca, essendo quella del Ferro suddivisa in due. In ognuno si passano in rassegna prima i ritrovamenti che sono solo apparentemente cultuali, poi quelli discutibili ed infine quelli sicuri; infine si dà un primo bilancio dell’esame fatto. Per leggere questa prima parte del lavoro è raccomandabile munirsi d’una cartina d’Israele con le coordinate, visto che il libro, peraltro fornito di una cinquantina di disegni dei siti archeologici, purtroppo non ce l’ha. Il periodo del Bronzo Medio è studiato nel cap. III (pp. 17-74). Tra i siti sicuri ci sono quelli di Megiddo, Sichem e dintorni, Gezer, Ascalon…, ma molti sono scavi vecchi, fatti, per di più, con criteri che non permettono quelle deduzioni che si richiederebbero oggi. Nei centri grandi ci sono templi di notevoli proporzioni, influenzati dal modello siriano e talvolta da quello babilonese. Il fedele è tenuto distante dalla divinità. L’importanza dei banchi di depositi delle offerte e dei podii (per le statue) sembra piuttosto ridotta rispetto all’epoca del Bronzo Antico. Al posto del podio prende piede la nicchia. Ma la caratteristica principale dei luoghi di culto di questo periodo sono le steli (maßßebot) e le figurine femminili nude, indizio del culto della fertilità. Il culto dei templi è spesso al servizio delle autorità civili e dei nobili, come risulta dagli ex voto scoperti. Il Tardo Bronzo (cap. IV, pp. 75-203) è quello che ci offre il maggior numero di reperti (26, contro i 18 dell’epoca precedente), soprattutto a Megiddo, Lakish, Hazor, Bet Shean. Gli scavi, fatti per lo più secondo tecniche più moderne, forniscono dati migliori. Si impone una forma unica di tempio, dentro la città, e quindi ancor più strettamente legato alle autorità politiche; scarsi i luoghi sacri in campagna. Si mantiene la distanza tra il fedele e la divinità e il punto più sacro è tentuto più nascosto ai profani. Specialmente ad Hazor compaiono strutture che poi troviamo nel tempio salomonico. Invece della nicchia risalta l’altare ed abbondano in numero e misura i banchi per il deposito delle offerte. Rispetto alle figurine femminili aumentano quelle delle divinità maschili e diminuiscono di molto le maßßebot (ci sono solo a Sichem). Nei siti si trovarono strumenti musicali, segno di riti accompagnati dal canto e dalla danza, cosa che continua nell’epoca successiva. Una parte essenziale di tali riti era costituita da pasti sacri che non sempre presuppongono l’uccisione sacrificale di animali. Dai reperti si deduce anche la presenza degli aruspici, la cottura dei pani per il culto, il bruciamento sacrificale di certe parti dell’animale mangiato nel pasto sacro, le libazioni ecc. Nell’insieme si nota continuità rispetto al culto dell’epoca precedente ed uno sviluppo del (sacrificio con) pasto comunitario e delle libazioni. Rarissimi diventano improvvisamente i templi nell’epoca studiata nel cap. V, il Ferro I, a partire dal sec. XII (pp. 204-239), nonostante che vi si noti una grande moltiplicazione di insediamenti, soprattutto sugli altopiani della Palestina centrale e settentrionale. ZWICKEL DER TEMPELKULT IN KANAAN UND ISRAEL 609 Da ricordare subito che Zwickel combatte l’opinione di Zertal e di altri sulle strutture scoperte recentemente sopra il monte Ebal. Per l’A. non si tratta di altare; non è dunque “l’altare di Giosuè”! Troviamo un centro cultuale di campagna ad una certa distanza da Sichem, il cosiddetto sito del vitello, perché se ne scoprì un interessante modello di bronzo. Ma di templi come quelli dell’epoca precedente ne troviamo solo nella zona filistea: Ekron, Ashdod e il non identificato Tell Qasile. In questi continua la tradizionale struttura del tempio e del relativo culto. Il che conferma lo stupore di fronte all’improvvisa rottura operata dai nuovi arrivati nei confronti della religione dell’epoca precedente. Costoro compiono i loro riti in “alti luoghi” (bamot) in aperta campagna. Nel cap. VI (pp. 240-284) si presentano i dati archeologici cultuali del Ferro II, dal sec. IX in poi. Tra le costruzioni sicuramente identificate come templi c’è praticamente solo quella di Arad, il cui strato più antico risale al sec. IX. La costruzione oggi famosa di Kuntillat ‘Ajrud (e di Der ‘Alla, p. 283) non è un tempio. In questo periodo il culto in città sembra svolgersi piuttosto in case private, dove la vecchia religione cananea ha trovato modo di sopravvivere (si veda anche a p. 316). E’ in quel periodo che si sviluppa la pietà privata. Dove ci sono templi, torna a farsi sentire l’influsso babilonese. Nell’unico tempio israelitico conosciuto, quello di Arad, sito di cui manca ancora la pubblicazione completa, le due colonne dell’ingresso, simili a Jachin e Boaz di Gerusalemme, hanno probabilmente a che fare coi culti della fertilità. Scompare il banco delle offerte e la prassi relativa, rimpiazzata dai sacrifici (di animali), che fanno diventare centro della vita cultuale l’altare. Forse compare la prassi delle purificazioni (una conca scoperta a Tell Arad). Si trovano altari anche in case di privati, se non altro per l’uccisione degli animali. Le maßßebot scompaiono a partire dal 750. A giudicare dai reperti di Arad, anche altre installazioni cultuali da quel periodo vengono ridotte. Nell cap. VII (pp. 285-339) comincia la seconda parte, quella dell’esame dei testi biblici sulla prassi rituale d’Israele. Data la grande quantità di riferimenti al culto, si scelgono i testi principali, in ordine cronologico. Testi del periodo premonarchico si trovano in Giud 6, 1Sam 2 e 9 ed Es 20,24-26. Quelli del sec. X (Documento Jahwista compreso) attestano la prassi di feste agricole (annuali) con pasto sacrificale comune, in 1Sam 16 e 20; 1Re 8,2, come pure Es 10,9 (e 5,3; 8,21-25); Giud 9,27; 2Sam 15,7s. Ancora poco attestata è la prassi del sacrificio olocausto (1Sam 10,8; 13,7b-15a; Gen 8,20-22). 2Sam 23,16 ci parla di libazioni. 1Re 1,50-53; 2,28s; 12,33-13,5; 1Sam 21,5 di altari ben costruiti e 1Sam 14,31-35 di altari improvvisati. Altari costruiscono anche Abramo (Gen 12,7s; 13,4.18), Mosè (Es 17,15), e già Noè (Gen 8,20), ma non ci sarebbe un altare per l’olocausto neanche nel primitivo tempio di Salomone (1Re 6ss.)! Zwickel raccoglie testimonianze bibliche antiche anche per altri oggetti cultuali (Efod, Urim e Tummim, Terafim, Pani sacri ecc.) ed in Es 12,21ss segnala la più antica menzione della Pasqua. Dai testi del sec. IX ricava ulteriori tracce del sa- 610 RECENSIONI crificio annuale (1Sam 1ss), l’eco del culto di Baal (2Re 10,18-28 e 1Re 18,2140) e la prassi delle offerte in denaro per il tempio (2Re 12,10). A questo punto Zwickel tratta i più antichi calendari delle feste (Es 23 e 34), fornendo una attendibile ricostruzione del loro sviluppo, a partire dall’antichissimo sacrificio annuale. Sarebbe lungo fornire anche solo le citazioni dei testi del sec. VIII, inclusi i testi profetici, sui vari sacrifici, le offerte, gli altari, la prassi degli oracoli, e di quelli elohisti o jehowisti dell’epoca seguente. Dopo un excursus sulla (improbabile) riforma di Ezechia (pp. 316ss), Zwickel affronta lo studio dei testi del sec. VII, dove il Deut fa la parte del leone (pp. 318-337) e il resto è ridotto praticamente a due facciate. In effetti, o negativamente, per il culto condannato, o positivamente, per quello comandato, il Deuteronomio per gli scopi dell’A. è una miniera. Prima (pp. 320-328) vengono studiate molte pericopi (12; 14,22-29; 15,19-23; 16,1-8.9-12.13ss. 16s.21s e 17,1; 18,1-8; 26,1-4.12-15; 27,4-8…). Segnaliamo che, tra gli autori più recenti ivi citati e seguiti su Deut 12, il lavoro di Renger manca nella bibliografia finale. Poi si dà una visione sintetica per contenuti: sul clima delle feste, gli elenchi e la terminologia dei sacrifici, olocausto e di comunione, le decime, le altre offerte obbligatorie e votive, specialmente i primogeniti. Non c’è nel Deut l’altare dell’incenso e, naturalmente sono bandite maßßebâ e ’asherâ. Urim e Tummim sono menzionati solo in Deut 33,8. La sintesi termina esaminando il calendario deuteronomico delle feste. Dai pochi altri testi del sec. VII Zwickel ricava ancora qualche elemento cultuale: per es. il carro dell’arca (1Sam 6,14), i sacrifici estemporanei, fatti lontano dal luogo di culto (1Re 19,19ss e Num 22), ma i testi non ci sembrano qui al posto giusto, perché sono probabilmente più antichi. Si accenna, in particolare, a qualche rimprovero di Geremia (6,20 e 7,21s) sui sacrifici, alle contaminazioni cultuali di Manasse (2Re 21,50) e alla Pasqua di Giosia (23,12.15), il cui tentativo di riforma non sortì effetto duraturo. Siccome l’A. è cosciente di non poter dare una trattazione completa dei testi biblici aventi riferimento al culto, mette poi una pregevole appendice, in cui offre un elenco più completo della terminologia cultuale, dove le citazioni sono catalogate secondo i vari periodi e documenti letterari e una seconda, complementare, dove si ragruppano nelle varie epoche i termini prima esaminati in ordine alfabetico. Le conclusioni (cap. VIII, pp. 340-344) non è necessario riferirle, anche perché le abbiamo, praticamente, date alla fine di ogni capitolo. In fondo si riducono a due: aver fornito dati archeologici che si illustrano vicendevolmente con quelli biblici per una accettabile e seria ricostruzione della storia del culto ed aver mostrato la rottura nella prassi cultuale operata con l’arrivo della popolazione da cui nasce Israele. Un’ampia bibliografia (pp. 376-415), l’elenco delle citazioni bibliche e delle poche extrabibliche ed un opportuno elenco di temi e contenuti chiudono il lavoro. BOSETTI LA TENDA E IL BASTONE 611 Non si tratta, ovviamente di un’opera definitiva e completa, anche perché le future scoperte archeologiche spingeranno continuamente ad aggiornarla. Noi non sapremmo segnalare lacune e ci sembra che il quadro generale, sia archeologico che biblico, difficilmente subirà gravi modifiche. Il libro, perciò, dovrebbe diventare uno strumento indispensabile per chi vuole studiare la storia del culto israelitico. Enzo Cortese Bosetti Elena, La tenda e il bastone. Figure e simboli della pastorale biblica (Narrare la Bibbia 1), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1992, 160 pp., L. 22.000 Niccacci Alviero, La casa della sapienza. Voci e volti della sapienza biblica (Narrare la Bibbia 2), San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, 186 pp., L. 24.000 Presento insieme queste due monografie con le quali inizia una nuova serie, di cui in terza pagina di copertina si annunciano natura, obiettivi e destinatari. “La collana raccoglie volumi agili che si propongono di comunicare, di narrare, di riattualizzare il testo biblico” e si rivolge principalmente a “studenti di teologia, operatori pastorali, sacerdoti e laici”. Un’altra caratteristica non priva di originalità è costituita dal corredo di appropriate illustrazioni che arricchiscono e completano il discorso, abbinando felicemente simbologia e citazioni bibliche. Analoga funzione complementare hanno i testi dei Maestri di Israele abbondamente citati nel loro contesto e opportunamente rapportati al discorso che viene fatto nel volume. La nascita di una nuova collana riservata ai biblisti italiani non può non rallegrare, sia perché indica la premura “ecclesiale” di studiosi che cercano di rendere accessibili a un vasto pubblico i frutti dei loro studi specialistici, sia perché purtroppo con frequenza gli editori italiani piuttosto che incoraggiare e stimolare gli autori, ripiegano sulle traduzioni di opere straniere, di cui francamente spesso non si riesce a vedere lo scopo e la necessità. (1) Il primo volume si deve a Elena Bosetti, docente presso l’Università Gregoriana di Roma, che lo ha scritto con una duplice sensibilità per il tema: quella, per così dire affettiva, che le proviene dall’appartenenza a una congregazione religiosa che porta il titolo di Gesù Buon Pastore e quella, professionale, che le hanno procurato i suoi studi. La Bosetti infatti si è specializzata in teologia biblica con una ricerca su Il Pastore. Cristo e la Chiesa nella prima lettera di Pietro, Bologna 1990. Anche la sua simpatia per le figure femminili traspira sensibilmente nelle insistenti sottolineature delle dimensioni “pastorali” di Rachele, Miriam e Abigail. Il titolo con il binomio “La tenda e il bastone”, preso nel suo valore storico e simbolico, costituisce il “filo narrativo” seguito dall’A. per selezionare, presenta- 612 RECENSIONI re e attualizzare figure, simboli e testi dell’universo pastorale biblico. Dopo una rapida introduzione alla simbolica pastorale, di cui si mostrano le radici antiche e profonde nelle letterature del Vicino Oriente Antico, al lettore si offre un itinerario storico e teologico all’insegna della pastoralità biblica. Gli si fanno innanzi come in una ideale galleria tre coppie di ritratti: Giacobbe e Rachele, Mosè e Miriam, David e Abigail. Il titolo di questa parte “Pastorale al maschile e al femminile”, che occupa un buon terzo del volume, rivela l’ottica molto particolare con cui queste figure sono contemplate e che l’A. esprime ripetutamente in termini di “reciprocità”, di “complementarità”, di “una ‘leadership’ al maschile e al femminile”. Al termine di ogni schizzo il lettore è ricondotto alla realtà ecclesiale con sobrie e personali attualizzazioni. In tal senso Giacobbe e Rachele ricordano incessantemente la “funzione pastorale dei padri e delle madri”, Mosè e Miriam sono riproposti “come ispirazione per quanti, in modi diversi, sono chiamati a collaborare per la formazione umana, civile e religiosa del popolo di Dio”, David e Abigail insieme ricordano che “il potere va sempre congiunto alla moderazione e alla magnanimità” e che ogni forma di governo deve ispirarsi a uno stile autenticamente pastorale. Figure e simboli pastorali percorrono nella Bibbia non solo i racconti, ma esse fioriscono anche sulla bocca dei profeti, nelle invocazioni degli oranti e nelle riflessioni dei sapienti. Un’accurata spigolatura di testi permette all’A. di mostrare quanto viva e feconda sia rimasta la memoria del tempo in cui Dio si è rivelato pastore che libera e salva Israele. Né si è trattato di una semplice permanenza. I profeti hanno arricchito la metafora pastorale per mezzo di risonanze e nuove evocazioni. Presso di loro l’immagine si intreccia con il tema del resto, della preferenza divina per i poveri e gli oppressi, con la denuncia della condotta dei cattivi pastori. Non meno di una dozzina di salmi accennano a Dio come pastore o a Israele come gregge del Signore e il Sal 23 ha addirittura meritato il titolo di canto al Buon Pastore. Per i Sapienti vengono ricordate la terminologia pastorale e dell’amore del Cantico dei Cantici, la simbologia del pastore che il Siracide usa per spiegare la misericordia universale del Signore verso le sue creature e l’affermazione di Qoelet secondo il quale Dio è pastore degli uomini perché ha dato loro i detti dei saggi. Il discorso “narrativo” fatto dall’A. si ferma alle soglie del NT quando figure e simboli si sono caricati di significati convergenti e complementari. In questo senso basta ricordare un testo del Documento di Damasco, che avrebbe ben figurato tra i testi giudaici antichi: “E questa è la regola per l’ispettore dell’accampamento. Istruirà i molti nelle opere di Dio, insegnerà ad essi le sue meravigliose gesta e narrerà davanti a loro gli eventi eterni con franchezza. Verso di loro sarà comprensivo come un padre verso i suoi figli e ‘ricondurrà’ tutti i dispersi come un pastore il suo gregge” (CD XIII,7-9; tr. L. Moraldi). L’A. si ripromette di completare questa “teologia biblica pastorale” dell’AT con un secondo volume dedicato al NT e alla tradizione cristiana. Tuttavia l’iti- NICCACCI LA CASA DELLA SAPIENZA 613 nerario già percorso vuole contribuire all’apertura di nuove prospettive per il rinnovamento della pastorale nella Chiesa stimolando “donne e uomini” e la comunità a confrontarsi con gli aspetti permanenti delle figure e dei simboli pastorali della Bibbia. Tale confronto aiuterà a tenere nel dovuto conto la “dimensione laicale” della pastorale biblica, affinerà sempre più l’esercizio del ministero pastorale, farà crescere la saggezza pastorale. Anche se, data la natura del volume, non si dà spazio ai problemi storicoletterari posti talvolta dai libri e testi biblici esaminati, essi tuttavia sono sempre tenuti presenti e non raramente accennati con sobrietà. L’opera renderà certamente un utile servizio al pubblico cui è destinato e aiuterà molti a comprendere e gustare non poche pagine della Scrittura. (2) Autore della seconda monografia è Alviero Niccacci, professore di lingua ebraica e di esegesi anticotestamentaria nello SBF. Il volume riflette in misura determinante i suoi studi precedenti sui libri sapienziali e le posizioni che egli ha espresso in articoli già pubblicati sia sulla teologia sapienziale in genere, sia su aspetti storico-letterari particolari di singoli libri e testi. La monografia ha un tono elevato e impegna il lettore in analisi dettagliate e in sintesi molto dense. Il tenore del libro e soprattutto il lavoro personale dell’A. sui testi lo dispensa da rinvii a opere e autori, fatta nobile eccezione per G. von Rad (La sapienza in Israele), ma chi è introdotto, sia pure limitatamente ai libri biblici sapienziali, troverà che egli dialoga di continuo e criticamente con gli altri studiosi. L’A. non si concede sconti nell’affrontare seriamente i problemi storico-letterari dei testi che tratta, e tanto meno accetta luoghi comuni, divenuti principi assiomatici, in esegesi e teologia dei libri sapienziali. Il volume risulta chiaramente una “introduzione speciale” ai libri sapienziali e alla loro teologia e contribuisce notevolmente con apporti originali allo studio della Sapienza biblica. Sono certo che anche professori e studenti di Sacra Scrittura lo accosteranno con frutto. Il sottotitolo della monografia potrebbe dare l’impressione di un’opera non organica, ma non è così almeno per due ragioni, una intrinseca e l’altra metodologica. Le “voci”, di cui l’A. si è messo – e mette il lettore – in ascolto, e i “volti”, i cui tratti egli disegna, convergono, non secondariamente o artificialmente, ma per un dinamismo interiore verso “Gesù di Nazaret Maestro di sapienza e Sapienza incarnata, voce e volto del Dio invisibile, mediatore perfetto tra Creatore e creatura, armonia compiuta dell’universo, l’unico in grado di riconciliare cielo e terra essendo Dio creatore e redentore e insieme creatura e Figlio obbediente” (p. 179). Quanto alla metodologia, non solo l’A. non ha trascurato nessun aspetto essenziale per la comprensione della tematica, offrendo indicazioni sui generi letterari, sulla datazione, sull’ambiente e i rapporti (specialmente con la letteratura sapienziale dell’Egitto, sulla quale egli ha una speciale competenza), sulla composizione e sulle idee teologiche dei libri, ma si è dato premura di collegare e richiamare sistematicamente il discorso sulle singole parti. Non è facile qui riassumere il ricco contenuto della monografia. Ma nel- 614 RECENSIONI l’intento di far cogliere al lettore qualcosa della ricchezza e originalità della monografia sottolineo alcuni aspetti che mi sono apparsi nuovi e rilevanti. Il libro si apre con un “Invito alla Sapienza” dove l’A. espone Pro 9,1-18 che mette dinanzi al ritratto di Signora Sapienza e all’icona di Donna Stoltezza, le quali invitano lo stesso genere di persone ma in direzioni opposte. Il capitolo successivo, intitolato “La via dell’esperienza”, consente all’A. di presentare, con l’aiuto di testi desunti dal libro dei Proverbi, alcuni concetti generali da tenere presenti nello studio dei “detti” e delle “istruzioni”, due generi letterari tipici della sapienza biblica e extrabiblica. Il “detto”, frutto diretto dell’osservazione della realtà, esprime l’insegnamento in forma concisa e efficace. L’“istruzione” risale al maestro di sapienza, risente dell’ambiente della scuola per i giovani e ha uno scopo più direttamente parenetico o didattico. Nel capitolo terzo l’A. presenta “la voce del maestro”, eco dell’insegnamento dei genitori, della tribù e degli antichi saggi, trasmettitore e creatore insieme di sapienza. Si tratta di uno studio molto approfondito, anche attraverso il confronto con il celebre “insegnamento di Amenemope”, di Pro 22,17-24,22 definito “libretto di formazione personale e professionale”. Qui l’A. precisa alcune caratteristiche fondamentali della Sapienza biblica: vuole indicare un ideale di vita; è contrassegnata da apertura verso l’esterno; inculca una formazione fortemente sociale, è attenta all’uomo prima e fuori di ogni determinazione di razza lingua luogo, è un bene da comprare e trovare, ha il suo “inizio / compendio” nel timore di Dio. Quanto al dibattito esegetico-teologico sulla sapienza biblica l’A. contesta subito e ripetutamente la distinzione o addirittura opposizione tra una cosiddetta sapienza religiosa e un’altra profana e la conseguente cronologia (i detti profani sono i più antichi) che si pretende di ricavarne. “La sapienza biblica è un forte movimento religioso, autonomo nell’ambito dell’Antico Testamento ma non estraneo ad esso. Un movimento che non si fonda sulla rivelazione storica, o storia della salvezza, ma sull’esperienza del credente israelita che va alla ricerca del senso delle cose e quindi dell’ordine stabilito da Dio creatore e del come orientare la propria vita in conformità ad esso. Un movimento che pone al centro l’individuo, non il popolo eletto in quanto tale, non però l’individuo isolato ma inserito vitalmente nella comunità” (p. 23). Radicale dissenso l’A. esprime anche verso un’altra posizione degli studiosi divenuta luogo comune che contrappone da una parte Giobbe e Qoelet – sarebbero due scritti tardivi, critici dell’antica sapienza e pessimisti fino a rasentare la bestemmia – e dall’altra il libro dei Proverbi che invece rappresenterebbe la sapienza antica di stampo dogmatico e staccato dalla realtà quotidiana. Di Giobbe l’A. offre una trattazione completa con delle puntualizzazioni nuove sulla datazione, sul genere letterario, sul piano letterario e teologico del libro. Giobbe non è un grido di rivolta del dolore innocente. Il suo problema non è la sofferenza del giusto e neppure la dottrina della retribuzione, ma il dramma dell’uomo dinanzi al suo Creatore. “Dall’incontro con Dio Giobbe riceve ciò che né la dot- NICCACCI LA CASA DELLA SAPIENZA 615 trina tradizionale degli amici né la sana teologia di Eliu erano capaci di dargli. Non impara nulla di nuovo, ma ritrova la preghiera e la lode che aveva perduto nel corso delle dispute a causa dell’amarezza crescente della polemica con i tre amici, e alla fine riesce a convivere con la sofferenza propria e altrui… Il Signore dell’universo certo ricompensa e castiga secondo le azioni, ma anche sottopone alla sofferenza e alla prova per scopi sapienti che lui solo conosce. Egli mira in primo luogo a rivelare, non a castigare e neppure a purificare. Intende rivelare la debolezza della creatura e in particolare la propria grandezza, perché l’uomo accetti il suo stato nel mondo e impari a lodarlo” (pp. 83-84). L’A. non elude nemmeno i problemi posti dal libro di Qoelet, dinanzi ai quali spesso gli studiosi ricorrono a scappatoie (aggiunte, reinterpretazioni). Anche qui l’attaccamento al testo e al principio che esso non può non avere un senso compiuto in se stesso porta l’A. ad approfondimenti illuminanti. Di fronte all’inutilità della fatica umana, che porta l’uomo sull’orlo della disperazione, e dinanzi alla conclusione paradossale, nella quale sapienza e stoltezza confinano pericolosamente, per cui l’uomo non riesce a possedere interamente la prima e ad evitare del tutto la seconda, Qoelet giunge alla conclusione che la saggezza consiste nel tenere insieme gli opposti. “La tensione degli opposti tenuti insieme, senza rifiutare né l’uno né l’altro, emerge varie volte dal libro e in fondo costituisce la sua trama di base” (p. 91). Dinanzi poi al dolore e all’angoscia, che accompagnano l’esercizio di un tale equilibrio, il saggio Qoelet propone un’ultima soluzione: godere della gioia quando Dio la concede e riflettere in silenzio quando egli manda la sofferenza. Questa soluzione non ha nulla in comune con l’edonismo o l’opportunismo, ma è proposta di sapiente equidistanza nello sforzo di cogliere il momento dalla mano di Dio. “Questa sapienza di Qoelet scaturisce da un senso fortissimo di Dio e della sua libertà sovrana, e da un senso fortissimo dell’uomo da lui dipendente in tutto, a lui aperto, che di lui vive e gioisce e anche soffre e muore. Nient’altro ha valore nel mondo” (p. 106). Del Cantico dei Cantici l’A. difende la legittimità sia dell’interpretazione letterale che di quella allegorica mostrandone la convergenza a un livello più alto e profondo. “Il suo scopo è mostrare che l’amore degli adolescenti è per ogni uomo forma speciale di rivelazione. Rivelazione di Dio Amore e forza della vita presente nel mondo… Amore erotico e amore spirituale nelle sue varie specie non sono forme inconciliabili ma manifestazioni rivelatrici dell’unico Amore per gli uomini” (p. 180). Grazie al Cantico apprendiamo che tra sapienza e amore vi è una convergenza significativa e importante. “Sono due realtà divine seminate nel mondo, due veri tesori tra molti altri falsi, due rivelazioni che interpellano l’uomo tramite le creature” (p. 132). Indico semplicemente alcuni altri testi principali che l’A. rilegge lungo l’ideale itinerario alla ricerca della Sapienza biblica, elusiva e presente, divina e umana, diffusa nelle creature, personificata: Gb 28 (inno alla sapienza e poema superbo sulla ricerca dell’uomo), Pro 8 (poema alla sapienza), Sir 1,1-10 e c. 24 (inni alla sapienza che ha la sua radice in Dio e ha posto la sua tenda in 616 RECENSIONI Giacobbe), Bar 3,9-4,4 (discorso penitenziale) e Sap (vari testi su Sapienza e Dio e Sapienza e creato). Ma accanto a questi testi fondamentali molti altri ne vengono chiamati a raccolta per chiarire, completare e giustificare commento e interpretazione. Il viaggio, dopo un sobrio accenno al “mito gnostico della sapienza”, rintracciabile in 1Enoc 42; 4Esdra 5,10-12 e 2Baruc 48,33.36, e agli apocrifi, che completano la traiettoria della sapienza personificata e contribuiscono a “umanizzare” la sua figura, approda ai testi del NT dai quali si ha il ritratto evangelico antichissimo di “Gesù Maestro di sapienza e Sapienza in persona”. I testi passati in rassegna e accompagnati da un rapido commento sono: Lc 7,31-35 e Mt 11,16-19; Lc 10,21-22 e Mt 11,25-27; Lc 11,29-32 e Mt 12,39-42; Lc 11,4951 e Mt 23,34-36; Lc 13,34-35 e Mt 23,37-39. Se si accetta che questi testi facciano parte della fonte (Q) comune di Lc e Mt, ne segue che la cristologia sapienziale che da essi si ricava è la più antica interpretazione del mistero di Gesù Cristo. Seguono poi fugaci accenni alla traiettoria della Sapienza nel Vangelo di Giovanni e negli scritti paolini e all’applicazione ecclesiastica dei titoli di “Donna sapiente” e “Sede della Sapienza” a Maria, Madre di Gesù, a riprova della permanenza e fecondità inesauribile del tema teologico. Nel capitolo conclusivo l’A. ritorna con forza e persuasione sulla visione unitaria che egli vede sprigionarsi dall’ascolto fedele delle molteplici voci e dalla contemplazione assidua dei differenti volti della Sapienza biblica. Solo qualche citazione: “Collocando come in un mosaico i vari elementi che i testi ci offrono è possibile tracciare un quadro coerente. La sapienza, prima di essere qualcosa che l’uomo trae dall’uso delle creature, è rivelazione delle creature stesse, le quali formano come un organismo vivente, una persona, Signora Sapienza, che si rivela; e, dietro di lei, è Dio stesso che si rivela… La sapienza è, in forma eminente, armonia, collegamento cosmico. E’ legame verticale che unisce il Creatore alle creature; infatti, come opera di Dio e sua compagna nella creazione, è mediatrice tra Dio e l’uomo, scende sulla terra ed è versata in ogni creatura. E’ anche legame orizzontale che unisce le creature tra loro, le vivifica e stabilisce rapporti” (pp. 159-160). Ribadisce inoltre l’attualità del messaggio della Sapienza biblica da cui deriva anche un’etica del timore di Dio che impegna tutte le facoltà dell’uomo e della donna nella somma libertà e nella somma dipendenza, nella somma creatività e nella somma remissività, nella somma grandezza e nella somma piccolezza. Mi sia permesso di esprimere un rammarico che riguarda ambedue i volumi. Ho sentito molto la mancanza di indici. L’indice generale che vi si trova è poco più di un sommario e non dà ragione della ricchezza delle rispettive monografie. Senza per questo imprimere al volume un aspetto esigente o cattedratico si poteva almeno aggiungere l’indice delle citazioni bibliche, che avrebbe reso al lettore un servizio prezioso. Giovanni Claudio Bottini, ofm FREDRIKSEN DE JÉSUS AUX CHRISTS 617 Fredriksen Paula, De Jésus aux Christs. Les origines des représentations de Jésus dans le Nouveau Testament (Jésus depuis Jésus), Les Éditions du Cerf, Paris 1992, 345 pp., 165 FF Il libro di P. Fredriksen si inserisce in un lungo filone di ricerca storica sulle origini del cristianesimo e sulla figura di Gesù Cristo, che ha avuto il suo punto di partenza agli inizi del nostro secolo. Schweitzer, Bultmann, Bornkamm, Vermes, Brandon, Barrett, Davies, Harvey, Hengel e Sanders sono soltanto alcuni fra i più noti studiosi che hanno contribuito (o lo fanno tuttora) ad illuminare lo scenario storico del NT. Questo proposito è stato assunto di recente anche da P. Fredriksen, storica del cristianesimo antico dell’università di Boston. Il suo studio è composto di dieci capitoli divisi in tre parti tematiche o cicli. Il primo, descrittivo, intitolato “Il mondo del Nuovo Testamento” presenta le varie immagini di Gesù contenute negli scritti neotestamentari (nell’ordine cronologico di redazione inverso: Giovanni, Luca, Matteo, Marco, Paolo) e storicamente sorte nell’ampio contesto della cultura e della religiosità ellenistica. Il secondo ciclo, “Il mondo del giudaismo”, è di carattere storico e riesamina le immagini evangeliche di Gesù alla luce del suo contesto vitale, collocandole cioè nel quadro del mondo giudaico, delle principali idee teologiche del popolo d’Israele e della complessità socio-politico-religiosa del giudaismo contemporaneo all’evento Gesù Cristo. Nel terzo ed ultimo ciclo, esplicativo, chiamato con un nome significativo “I Cristi delle Chiese”, viene data una ricostruzione della “preistoria” cristiana: lo sviluppo delle tradizioni relative a Gesù nel lasso di tempo situato tra la sua risurrezione e la stesura degli scritti neotestamentari. Alla fine del volume si trova un glossario e due liste di bibliografie: la prima, commentata e distribuita secondo le tematiche (molto utile), e la seconda, alfabetica. L’impostazione del lavoro è interessante e la lettura non comporta grande fatica. Lo si deve anche al fatto che il testo non viene appesantito da numerose note, abituali nei lavori del genere, ridotte soltanto a quelle essenziali. Prima di esprimere la mia impressione sul contenuto dell’opera che presentiamo, vorrei puntualizzare qualche aspetto relativo all’ambito in cui essa si muove. E’ noto che la ricerca moderna sul Gesù “storico” si è orientata su tre filoni principali: le fonti letterarie canoniche, la letteratura apocrifa, il contesto socioculturale [per una sintetica presentazione si può vedere J.-P. Michaud, “Un état de la recherche sur le Jésus de l’histoire”, ÉglT 26 (1995) 143-163]. A dispetto del dispendio di energie, spesso gli autori giungono a risultati negativi e deludenti, specie quando le pretese sono alte e le conclusioni ampie e nette. In realtà la questione è più complessa e richiede approcci complementari, prudenza nelle analisi e nelle conclusioni. L’A. della monografia che presentiamo utilizza il primo e il terzo filone di ricerca, ossia tiene in massima considerazione i testi del NT e ricorre ad una ricostruzione dell’ambiente socio-culturale del tempo di Gesù. L’unione dei dati biblici con un ricostruito contesto storico diventa una piattaforma di lettura per riesaminare le immagini bibliche di Gesù. P. Fredriksen manife- 618 RECENSIONI sta la speranza – e qui non possiamo non ammirare la sua modestia scientifica – che “attraverso questa lettura critica dei vangeli, può darsi che ci sarà dato di percepire i tratti di Gesù della storia. Naturalmente i nostri metodi, per quanto prudenti, critici e coscienti dei loro limiti, e le nostre modeste pretese negli sforzi per ritrovarlo, questo ‘Gesù storico’ non è che un’immagine o meglio un insieme coerente di deduzioni a partire dalla conoscenza storica” (p. 8). Queste parole di riserbo trovano un riscontro lungo tutta la ricerca. Le conclusioni sulle ragioni storiche e i malintesi del passato che contribuirono alla nascita di varie immagini teologiche di Cristo nel NT non vengono proposte con la pretesa di offrire una certezza apodittica, ma quasi sempre sono accompagnate da riserve e caute affermazioni, aperte quindi ad un ulteriore approfondimento. Gli scritti che costituiscono oggi il NT sono di natura teologico-storica; vuol dire che trasmettono un messaggio di fede radicato su un solido fondamento storico. La storia – dal momento che il Figlio di Dio si è fatto uomo – rappresenta un punto di partenza imprescindibile, sia ieri, per poter stendere una relazione circa la vita e il messaggio di Gesù Cristo, sia oggi, per una seria investigazione sulla figura di Gesù di Nazaret. Per questo motivo, i testi del NT esigono di essere guardati e investigati anche come documenti storici. E’ un’impresa senz’altro non semplice e la difficoltà risiede principalmente nel fatto che, negli scritti neotestamentari, la storia si trova sempre legata con la teologia. Basta aprire il NT per rendersi subito conto che tutto ruota intorno alla persona di Gesù, ma questa persona è presentata con tratti che, se non in palese contrasto tra di loro, sono perlomeno di carattere differenziato. “Quante penne, tanti Cristi”, è un’impressione quasi comune ai lettori superficiali del NT, oppure usando un linguaggio più preciso, possiamo vedervi una gamma di immagini teologiche di Cristo unita alla varietà di dati storici riguardanti Gesù di Nazaret. Sarebbe però insensato concluderne che siamo di fronte ad una mistificazione storica a scopo religioso, come pure risulterebbe scorretto un giudizio inverso, che cioè tutto il NT in blocco vada ritenuto come un documento storico nel senso moderno del termine. Consapevoli di numerose difficoltà, è tuttavia giusto e doveroso intraprendere un’indagine sul fondatore del cristianesimo e ciò non solo nell’ambito del biblista-teologo, ma anche in quello proprio dello storico. Certamente, questo tentativo di raggiungere la storia “vera” sarà proficuo ed efficace nella misura in cui la serietà scientifica, libera da pregiudizi, verrà affiancata dall’onestà professionale. Solo così si avranno dei frutti a vantaggio di tutti e soprattutto a beneficio della Verità. I timori e le reticenze da parte della Chiesa, legittima custode del deposito di fede cristiana, sono comprensibili, tenuto conto di certe conclusioni distorte che hanno preteso di essere “storiche”. Queste deviazioni non devono però sbarrare la strada ad un’indagine storica seria sui testi neotestamentari e sulla persona di Gesù Cristo. A ragione la Fredriksen scrive alla fine del suo studio: “La Chiesa, nel proclamare la sua fede in Gesù come oggetto unico della rivelazione divina, è obbligata per ciò stesso ad occuparsi della storia. E fare la storia FREDRIKSEN DE JÉSUS AUX CHRISTS 619 significa intraprendere, con tanto di dati, di simpatia e mediante un’investigazione per quanto possibile realista, la ricostruzione del contesto religioso, sociale, politico e culturale in cui Gesù di Nazaret visse e morì. Tutto ciò porta, inoltre, a rinunciare ad una lettura semplicistica dei racconti che confermano una identità, anche se questi si trovano nei vangeli. Una tale lettura non può che indurre ad una falsa storia. E la storia falsa porta la Chiesa ad una teologia falsa […] Se, per la Chiesa, la storia è importante, la storia non alterata è la più importante di tutto” (p. 312). Non possiamo che sottoscrivere queste parole. E’ vero che la storia è importante per la fede, tuttavia va anche ricordato che l’ultima non si riduce alla prima. Analoga osservazione facciamo riguardo agli scritti neotestamentari. E’ vero che essi sono l’espressione di fede delle prime comunità cristiane, ma è altrettanto vero che nel contempo sono frutto e riflesso di concreti eventi storici. Lo sforzo di raggiungere una storia “non alterata” è degno di lode e va certamente stimolato; questo desiderio non deve neppure frenare, né tantomeno arrestare, la certezza oggettiva di non poter mai raggiungere pienamente l’obiettivo prefisso. D’accordo su questo punto, mi viene spontanea la domanda se le moderne ricerche storiche sulla persona di Gesù Cristo, le ricerche che non possono partire in primo luogo che da una fonte storica privilegiata come quella degli scritti neotestamentari, si siano definitivamente liberate da un pregiudizio di fondo che oppone la storia alla fede e, di conseguenza, il “Gesù della storia” al “Cristo della fede”. Il “Gesù del NT” non è sempre lo stesso e medesimo personaggio che la fede dei suoi seguaci ha fatto uscire dal passato storico al nostro presente? E questo “uscire” deve essere necessariamente visto come risultato di una fede, per lo più influenzata ulteriormente dall’ambiente socioculturale, e non invece come conseguenza diretta di quelli eventi storici che proprio, tramite la mediazione della fede, hanno assunto un volto, altrimenti irraggiungibile? Le domande potrebbero ancora moltiplicarsi. Le perplessità espresse da me in questa forma non intendono colpire direttamente l’opera della Fredriksen; quest’ultima ne è stata soltanto l’occasione. Lo studio merita un’attenzione per la sua originalità espositiva, il modo con cui affronta la problematica e l’equilibrio nei giudizi. Anche se il suo intento non è principalmente quello di ricostruire una “storia di Gesù”, quanto piuttosto quello di ricercare le ragioni di ordine storico (socio-politico-culturale) della nascita di diverse immagini di Cristo negli scritti neotestamentari, mi sembra tuttavia che apporti note nuove nell’ormai lunga discussione sul problema del Gesù storico. Per coloro che intendono affrontare questo argomento, insieme alla questione della diversità di immagini bibliche di Cristo, il presente saggio storico può risultare molto utile, come un tentativo di risposta, come un elemento di dialogo, o come un punto di partenza per ulteriori indagini. Lesław Daniel Chrupcała, ofm 620 RECENSIONI Sesboüé Bernard, Pédagogie du Christ. Éléments de christologie fondamentale (Théologies), Les Éditions du Cerf, Paris 1994, 237 pp., 120 FF Padre Bernard Sesboüé s.j., professore di teologia dogmatica e patristica al Centre Sèvres di Parigi, non ha bisogno di presentazione. E’ conosciuto da un ampio pubblico grazie alle sue numerose pubblicazioni, libri e articoli. La sua competenza nel campo teologico gli è valsa l’onore di diventare membro della Commissione Teologica Internazionale. Il nuovo libro è un saggio che affronta alcuni temi della “cristologia fondamentale” o della “giustificazione della cristologia”; si tratta degli elementi della cristologia che stanno alla base del discorso di fede in Cristo. Dedicato principalmente alle persone esperte, agli studenti di teologia in primo luogo, il libro si rivela utile anche ai catechisti, chiamati a presentare il mistero di Cristo a coloro che sono in cammino di fede o verso la fede. A volte i complessi e problematici dati teologici hanno richiesto all’A. un procedimento tecnico ad essi proporzionato, che non va tuttavia a scapito della semplicità e della comprensibilità dell’esposizione. Anzi, come dimostra lo stile ormai abituale di Sesboüé, persino le tematiche più astruse possono essere rivestite di un abito di linguaggio chiaro e accessibile. Il titolo dell’opera ne rivela già un’intenzione di percorso. I grandi cambiamenti dell’epoca moderna esigono che la fede cristiana non solo venga proposta, ma che anche se ne faciliti l’accesso. In tale processo non c’è altra via migliore che quella di seguire la “pedagogia della rivelazione” o, meglio ancora, la “pedagogia rivelata” da Gesù. Attraverso la realtà della sua umanità assunta, mediante le parole e le azioni, fino all’evento della morte-risurrezione, Gesù di Nazaret ha progressivamente rivelato ai suoi discepoli il mistero della sua identità umanodivina. E’ stato, quindi, a partire dalla figura di Gesù-uomo che si è giunti alla piena rivelazione della persona di Gesù-Cristo-Figlio di Dio. Anche oggi, l’annuncio della fede cristologica deve ripercorrere lo stesso movimento teofanico prendendo quale riferimento di base l’esemplare pedagogia di Cristo. Il libro comprende due parti. Nella prima, intitolata “L’accesso alla cristologia”, viene descritta la genesi della fede in Gesù dei suoi discepoli. La condivisione della vita comune con Gesù diventa per i discepoli un preliminare necessario per comprendere alla luce della risurrezione il mistero del Figlio di Dio incarnato. La Pasqua è il vero punto di partenza della fede in Cristo e, nello stesso tempo, l’inizio dell’annuncio cristologico. Per poterlo fare, i testimoni di Cristo compiono una rilettura retrospettiva del ministero pre-pasquale di Gesù e arrivano quindi alla sua origine in Dio (“un mouvement d’avant en arrière”: ossia il progresso nella comprensione della figura del Cristo risorto è dovuto alla lettura retrospettiva della vicenda umana di Gesù fino alla sua esistenza originaria in Dio). La fine trova così un fondamento storico nell’inizio e viceversa l’inizio riceve la sua piena spiegazione teologica nella fine. Per questo motivo l’annuncio cristologico del NT è composto da una varietà di cristologie che, per motivi di comodo, vengono distinte globalmente in due tipi BROWN LE CHIESE DEGLI APOSTOLI 621 dialettici: la cristologia ascendente (“dal basso”, primitiva o arcaica, “salitaesaltazione”, prima nell’ordine della manifestazione) e la cristologia discendente (“dall’alto”, tardiva o sviluppata, “discesa-umiliazione”, prima nell’ordine della realizzazione). I due tipi sono strettamente legati fra di loro e si richiamano a vicenda. Tale movimento complementare della cristologia del NT – di cui a p. 76 viene dato uno schema grafico – si ritrova presso i Padri, successivamente viene infranto nel Medioevo a favore di una cristologia discendente e, nei tempi recenti, ricompare di nuovo nell’esegesi e nella teologia sistematica. Stabilito un fondamento di partenza, che a mio parere è la parte più suggestiva del libro, la seconda parte, intitolata “La storia e la fede”, si occupa dei temi più controversi della cristologia fondamentale: la risurrezione di Cristo, la scienza e la coscienza del Gesù pre-pasquale, i miracoli e la concezione verginale di Gesù. Per comprendere pienamente la valenza teologica di questi misteri cristologici è necessario però, come a ragione ha fatto l’A., ristabilire un giusto equilibrio tra la storia e la fede. Il percorso storico (pp. 81-106) dimostra che non sempre tra le due c’è stato un rapporto di semplice unità; in pratica a partire dal XVII sec. si assiste ad una rottura che, a seconda delle spinte esterne, ha prodotto un’alternanza tra la storia e la fede, in cui l’una o l’altra si vedevano uscire vincenti. Tuttavia, l’opposizione tra il “Gesù della storia” e il “Cristo della fede” è un antagonismo falso che conduce ad un vicolo cieco. “Il moderno cerchio ermeneutico della cristologia deve mettere all’opera il dato primitivo: l’annuncio di Gesù di Nazaret come Cristo e Signore è una testimonianza di fede resa ad un evento. Questo vuol dire che la fede ci rinvia alla storia… Ma, reciprocamente, la storia ci rinvia alla fede: l’evento di Gesù di Nazaret non ha alcun senso se non in riferimento alla fede: fede in Dio, fede in Gesù, fede dei testimoni” (p. 104; i corsivi sono miei). Lesław Daniel Chrupcała, ofm Brown Raymond, Le chiese degli Apostoli. Indagine esegetica sulle origini dell’ecclesiologia, Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 1992, 189 pp., L. 30.000 “La sostanza di questo libro è stata presentata nelle Sprunt Lectures, un ciclo di conferenze pubbliche tenute allo Union Theological Seminary (Richmond, Virginia)” (p. 7). Inoltre, stando alle intenzioni dell’A., esso “deve essere considerato in connessione ad altre due sue opere: La comunità del discepolo prediletto e Antiochia e Roma” (p. 10). In quanto al contenuto, “questo terzo libro esplora le comunità cristiane dal punto di vista della loro diversa comprensione di ciò che era importante per sopravvivere e crescere dopo la morte degli apostoli. I tre libri rappresentano diversi approcci all’esistenza della Chiesa nel pe- 622 RECENSIONI riodo neotestamentario; tutti e tre intendono parlare alle chiese odierne per essere una forma di correzione, di sfida e di incoraggiamento. Per quel che mi riguarda questo è il compito dell’esegesi: non soltanto determinare quale era la situazione del Nuovo Testamento, ma anche chiedersi che cosa significhi” (p. 10). Proprio per questo, ogni capitolo presenta due parti: una ricostruzione schematica che caratterizza sette diverse “chiese particolari” emergenti dalla testimonianza del NT e un’attualizzazione pastorale che mette a fuoco “forze e debolezze” di queste “chiese” al fine di evitare oggi errori del passato e stabilire una migliore comprensione ecumenica tra le varie “chiese del presente”. In base a ciò, l’A., nel cap. I (pp. 13-34), dopo aver esaminato diversi approcci al problema ecclesiologico, afferma: “Esaminerò un certo numero di diverse situazioni ecclesiali che si riflettono nelle opere sub-apostoliche del Nuovo Testamento (cioè le opere scritte negli ultimi trent’anni del primo secolo), soffermandomi sull’elemento più importante che ha reso capace ciascuna chiesa di sopravvivere dopo che la sua guida apostolica era uscita di scena” (p. 20). Il termine sub-apostolico, per il Brown, non va riferito più al cosiddetto “periodo dei Padri apostolici” (Clemente, Ignazio, Ireneo, Policarpo), ma piuttosto a quel “tempo intermedio” che va dalla morte dell’ultimo apostolo (circa verso l’anno 67) alla fine del I sec. Pertanto, bisogna ben distinguere tra “periodo apostolico” (fino al 67 circa), “periodo sub-apostolico” (fino al I sec.), in cui furono redatti la maggior parte degli scritti del NT, e “periodo post-apostolico” (dal I sec. in poi). Oltre a tale precisazione, il Brown tiene a mettere in evidenza due momenti metodologici della sua ricerca: 1) “Quando tentiamo di usare queste (del NT) testimonianze per ricostruire le situazioni della comunità nel periodo sub-apostolico, sorge un serio problema metodologico di accertare se i pensieri espressi siano peculiari all’autore o siano veramente condivisi da una comunità”; 2) “Un altro problema metodologico richiede cautela nel valutare il livello parziale in cui gli scritti ritraggono le prospettive della comunità” (p. 33). L’opera, poi, si snoda attraverso la presentazione (caratterizzazione e attualizzazione) di “sette testimonianze ecclesiali” del NT: cap. II: L’eredità paolina nelle lettere pastorali: l’importanza della struttura ecclesiale (pp. 35-54); cap. III: L’eredità paolina in Colossesi/Efesini: la Chiesa come corpo di Cristo da amare (pp. 55-72); cap. IV: L’eredità paolina in Luca/Atti: la Chiesa e lo Spirito (pp. 73-89); cap. V: L’eredità petrina in 1 Pietro: la Chiesa come popolo di Dio (pp. 91-101); cap. VI: L’eredità del discepolo prediletto nel Quarto Vangelo: una comunità di uomini uniti a Gesù da un legame personale (pp. 103-124); cap. VII: L’eredità del discepolo prediletto e le epistole di Giovanni: una comunità di persone guidate dallo Spirito Paraclito (pp. 125-152); segue una breve conclusione e l’indice generale. Un giudizio critico su quest’opera di Brown credo che debba avere il suo punto di partenza da ciò che egli scrive all’inizio della Conclusione (p. 181): “In questo libro non ho trattato dei differenti modelli di chiesa che vengono offerti dal Nuovo Testamento, perché nessuno degli autori biblici qui discussi intende- BROWN LE CHIESE DEGLI APOSTOLI 623 va offrire un quadro complessivo di ciò che la chiesa dovrebbe essere”. In altre parole, questo libro parla di “modi di sopravvivenza” delle comunità cristiane nel “periodo sub-apostolico” e non di “chiese” e tanto meno di “Chiesa”, in quanto per il Brown non “c’è alcuna testimonianza in queste opere che faccia emergere una coerente o uniforme ecclesiologia” (p. 181). È un libro sulle “chiese” senza un concetto di “Chiesa”. E l’A. lo dimostra chiaramente, quando a cuor leggero può scrivere: “Sarebbero collegate ad Efeso le lettere ai Colossesi ed agli Efesini, ed il IV Vangelo, opere di ecclesiologia debole, nel senso che pongono poca enfasi sulla struttura della chiesa, ma di alta cristologia, in quanto associano Cristo con la creazione” (p. 20), per poi contraddirsi apertamente: “Avendo descritto la forte ecclesiologia di Colossesi/Efesini, mi volgo adesso al modo in cui essa si correla alla sopravvivenza delle chiese che l’apostolo Paolo ha lasciato dietro di sé alla sua morte” (p. 62). Qualcuno può pensare che sia una “svista”. No! Tutto è calcolato: il metodo del Brown è essenzialmente “selezionatore” di “campioni socio-religiosi” che mettano in luce i diversi orientamenti ecclesiali che delle figure carismatiche della Chiesa primitiva hanno impresso alla loro comunità. Solo in tal modo, egli può stabilire la rilevanza positiva come risposta ad una specifica domanda (p. 33). E la “domanda” di Brown non è di natura “esegetica”, come sembra dichiarare nel sottotitolo della sua opera, ma di natura “socio-religiosa”. Tale indebita identificazione non è superata neppure quando l’A. dichiara che “il compito dell’esegesi non è soltanto quello di determinare quale era la situazione del Nuovo Testamento, ma anche quello di chiedersi che cosa esso significhi” (p. 10). In base a tali orientamenti, mi sembra che risulti poco rilevante la distinzione tra “periodo sub-apostolico” e “periodo post-apostolico”, in quanto non si tratta di un principio-base, ma semplicemente di un’ulteriore “selezione” del materiale ecclesiologico all’interno del NT. Più determinante sarebbe stato il raffronto tra il “periodo apostolico” e quello “sub-apostolico”, ma il metodo selezionatore del Brown ha scansato il problema, in quanto l’unico possibile raffronto poteva avvenire tra le cosiddette “lettere autentiche” di Paolo e gli scritti “sub-apostolici” di tradizione paolina. La tradizione giovannea non sembra aver lasciato tracce significative. In tal senso, mi sembra che l’opera di Brown soffra di uno squilibrio metodologico: ci parla di “scritti sub-apostolici di tradizione paolina” senza farci conoscere gli “orientamenti paolini” in materia di ecclesiologia. È vero che qua e là l’A. si sbilancia in qualche affermazione, ma niente di sistematico. Così, per esempio, può affermare: “L’ecclesiologia del corpo mistico di Colossesi/Efesini dà al Cristo una chiara centralità, ma ironicamente il Cristo, che è la testa del corpo, rimane senza volto. Questo accade perché l’ecclesiologia di Colossesi/Efesini fa parte dell’eredità paolina e nelle sue lettere Paolo (che non conosceva Gesù secondo la carne) non dà le coordinate della personalità di Gesù” (p. 118). Il Brown è cosciente di aver detto qualcosa di “improprio”, tant’è vero che sente il bisogno di una correzione critica: “Si può discutere su ciò che Paolo intendesse di preciso quando disse: «L’amore di Cristo ci spinge» (2Cor 5,14); tuttavia è chiaro che Paolo non 624 RECENSIONI soltanto credeva in Cristo, ma anche lo amava. (Il volto di Cristo può non emergere dall’epistolario paolino, ma Gesù aveva un volto per Paolo)”. Anche qui, non si deve pensare al “caso”, alla “svista”, ma al “metodo selezionatore”. Difatti, l’A. confessa candidamente che tutta la sua ammirazione va “per le prospettive giovannee sulla relazione tra i cristiani e Gesù. L’ecclesiologia giovannea è la più attraente ed entusiasmante del Nuovo Testamento” (p. 152). Ma non sono sicuro se gli studiosi della “letteratura giovannea” siano molto entusiasti dell’ecclesiologia giovannea descritta da Brown, tutta centrata su un rapporto individualista tra il cristiano e il Cristo. Personalmente, credo che su questo punto il “metodo” tocchi il fondo della “non-intelligenza” del messaggio ecclesiologico giovanneo. E non solo giovanneo. Qualunque siano le caratteristiche ecclesiologiche che emergono dai diversi scritti neotestamentari, io credo che esse trovino la loro giustificazione ultima nel “volto di Cristo”, senza il quale né la Chiesa né le chiese possono sussistere. Lo dimostra ampiamente Paolo, per il quale un vero rapporto ecclesiale, “l’essere uno in Cristo” (Gal 3,28), può esistere soltanto se “il mio vivere è Cristo” (Fil 1,21) e “se Cristo vive in me e io vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 3,20). E per Paolo il volto di Cristo è il volto del “crocifisso” (Gal 3,1). Ciò dimostra che il metodo “socio-religioso” e “selezionatore di campioni”, adottato da Brown, non è sufficiente, neppure per descrivere i semplici “comportamenti di sopravvivenza” delle “chiese” del NT. Qualche recensore ha definito questo libro un “piccolo capolavoro”, in quanto Brown all’abilità esegetica sa unire un formidabile intuito pastorale ed ecumenico nelle sue valutazioni delle “forze e debolezze” dei diversi “orientamenti ecclesiali di sopravvivenza”. Può darsi! Personalmente trovo che le sue valutazioni sia esegetiche che pastorali - soffrano di eccessivo schematismo, siano poco originali e spesso rispecchiano una situazione ecclesiale molto ristretta: quella del cattolicesimo americano. Così: “Se mi è consentito prendere la Chiesa cattolica come esempio, il periodo anteriore al Vaticano II fu caratterizzato da un generale silenzio sulle colpe, specialmente quelle degli ecclesiastici e dei religiosi, una colpa di cui, sono sicuro, nessuno ci accuserebbe oggi. Adesso sembra come se la prima pagina di un giornale fosse l’unico foro competente per trattare le difficoltà interne del cattolicesimo!” (p. 66). Una simile affermazione non credo che si adatti molto bene ad un contesto diverso da quello americano, in quanto in Europa, e in Italia in particolare, la critica alla “santità della Chiesa” è stata mossa da sempre e apertamente dall’interno e dall’esterno della Chiesa: dalla bonaria satira di un Boccaccio come dalla forte denuncia di un Savonarola, dalle irriverenti osservazioni di Voltaire come dalle accuse sofferte di un Giordano Bruno, dal “lacerante proclama” di un Lutero come dalla rispettosa e credente presa di posizione di Rosmini nelle “Cinque piaghe della Chiesa”. Ed ho citato solo la “punta culmine” di tale critica. Quindi, generalizzare un atteggiamento probabilmente solo “americano” non mi sembra un buon approccio critico al problema. In quanto al resto di questa presentazione delle “forze e debolezze”, CARRÓN JESÚS, EL MESÍAS MANIFESTADO 625 mi sembra che, oltre a soffrire di eccessiva schematizzazione, ha tutto il sapore di quella “retorica ecumenistica” che cerca di far presa più con le parole che con vere soluzioni dei problemi. In ciò il libro di Brown rispecchia perfettamente la sua genesi: si tratta infatti di un insieme di “conferenze” e non di un libro sistematico, di una “proclamazione” che attraverso l’arte del dire cerca di far presa sull’ascoltatore (o lettore) e in cui l’A. ci ripropone più o meno aggiornate le sue ipotesi altrove espresse (cf. le sue note). Alfio Marcello Buscemi, ofm Carrón Julián, Jesús, el Mesías manifestado. Tradición literaria y trasfondo judío de Hch 3,19-26 (Studia Semitica Novi Testamenti 2), Editorial Ciudad Nueva - Fundación San Justino, Madrid 1993, 361 pp. Muñoz Alfonso Simón, El Mesías y la Hija de Sión. Teología de la Redención en Lc 2,29-35 (Studia Semitica Novi Testamenti 3), Editorial Ciudad Nueva Fundación San Justino, Madrid 1994, 361 pp. 1. Presentiamo insieme due lavori della collana Studia Semitica Novi Testamenti, che si propone di pubblicare “studi filologici che non si limitano alla pura filologia, ma che cercano di portare luce su passi difficili del Nuovo Testameno per i quali la tradizione esegetica attuale non trova facile soluzione. Perciò terranno conto – e in certa misura utilizzeranno i vari metodi che la scienza ha loro applicato – […] e hanno scelto come filo conduttore di questi studi il substrato semitico del greco neotestamentario”. L’interesse al sostrato semitico non costituisce un nuovo metodo, ma è “un dato che permette di spiegare certi passi e può aiutare a comprenderne la storia”. Il volume del Carrón prende come testo di analisi At 3,19-26. Esso costituisce la parte finale del secondo discorso di Pietro (At 3,12-26) ed è senza dubbio un testo che presenta difficoltà di interpretazione, specialmente nei vv. 19-21. Il nostro Autore cita sopra tutte le opere di altri studiosi, quella di A. Barbi, Il Cristo celeste presente nella chiesa. Tradizione e redazione in Atti 3,19-21, Roma 1979, alla quale abbiamo dedicato una recensione in questa stessa rivista (cf. LA 29 [1979] 361-363). Come dice bene il titolo di Barbi, i versetti presentano il Cristo nella sua attuale situazione di risorto e intronizzato in cielo in attesa della parusia. È l’opinione che il nostro Carrón chiama comune. Egli dedica il cap. I all’esposizione delle difficoltà che presenta il testo di Atti e le varie soluzioni offerte dai critici per appianarle. Essi ritengono che si tratti di un passo apocalittico, addirittura di un testo riferito a Elia e poi in Atti applicato a Gesù esaltato in cielo e che tornerà alla parusia. Quindi i vv. 19-21 formano un inciso e, se fosse tralasciato, il discorso acquisterebbe chiarezza. Secondo Carrón, più che risolvere le difficoltà, questa opinione non fa che aumentare i problemi non solo dei due difficili versetti, ma di tutto il contesto. 626 RECENSIONI Carrón non si limita ai vv. 19-21, ma studia il tratto del discorso dal v. 19 al v. 26, cioè l’intera finale del discorso petrino. Non parte dai contenuti, ma dai dati del testo, in quanto l’analisi letteraria e linguistica precede ogni interpretazione. Non possiamo seguire nelle particolarità la sua dimostrazione, ma notiamo come egli dedica uno studio particolare ad ogni elemento, trattandolo indipendentemente dagli altri. Le particelle grammaticali, le espressioni, le costruzioni così chiarite dovrebbero prevenire il pericolo di circolo vizioso in cui spesso cadono coloro che pongono ipotesi poi non dimostrate o poggiano il ragionamento su basi non sicure. Secondo lui nel v. 20 ad o¢pwß a‡n può corrispondere un yD aramaico con valore causale. Quindi le espressioni “tempi di refrigerio” (kairoi« ajnayu/xewß) (v. 20) e “tempi del compimento” (cro/noi ajpokatasta¿sewß) (v. 21) non vengono applicati al futuro, ma al passato, cioè al tempo della vicenda terrena di Gesù. La congiunzione kai«, che sta nel bel mezzo del v. 20, crea nella frase una “unione violenta”, ponendo una coordinazione tipica del semitico, quando per noi va meglio la subordinazione. La congiunzione ha qui valore causale o esplicativo ed equivale a “poiché, quindi, dato che”. La traduzione dei vv. 19-21 suona allora così: “Pentitevi, dunque, e cambiate vita, affinché siano cancellati i vostri peccati, perché sono arrivati i tempi di refrigerio da parte di Dio, in quanto ha inviato il Cristo che teneva pronto, Gesù, che il cielo doveva conservare fino al tempo del compimento di tutto quanto Dio aveva detto per bocca dei suoi santi profeti” (cf. p. 126 e 173). In questo modo scompare la strana motivazione che i Giudei dovrebbero convertirsi in vista della venuta finale di Gesù, per mantenere la motivazione solita di Luca che fonda la conversione sull’opera terrena compiuta dal Salvatore (cf. vv. 13-16). Inoltre il v. 21 non tratta della dimora di Gesù in cielo dopo la risurrezione, ma di quella celeste, precedente la sua apparizione terrena. Quest’ultima avvenne “nel compimento del tempo” e realizzò il disegno preparato da Dio. Coerentemente alla sua metodologia l’A. riporta passi paralleli per provare il senso del termine ajpokata/stasiß (compimento). Non possiamo seguire tutta la sua dimostrazione. Con la sua interpretazione Carrón ritiene risolto anche il problema del verbo ajposte÷llw (inviare), che in tutto il NT è riferito alla vicenda terrena di Gesù e mai alla parusia. Non solo, ma rispetta anche la funzione della lunga citazione del profeta come Mosè (vv. 22-23), che come tutte le prove scritturistiche si riferisce a quanto già avvenuto e non già a cose future. Infine Carrón come conclusione scrive che non solo arriva ad una lettura coerente del testo, ma che i suoi risultati portano conseguenze sia per l’importante questione della composizione dei discorsi in Atti sia della teologia di Luca. Se tanto forte è l’influsso della lingua aramaica in questi versi, si deduce che Luca deve aver usato documenti greci tradotti maldestramente dall’aramaico. Il fenomeno vale anche per il vangelo dell’infanzia, specialmente nei cantici del Benedictus e Magnificat che conservano espressioni tanto simili al tratto studiato di Atti. Non solo la lingua ci riporta all’ambiente primitivo palestinese della CARRÓN JESÚS, EL MESÍAS MANIFESTADO 627 comunità cristiana, ma anche il contenuto, compresa l’idea di Gesù visto quale discendenza promessa ad Abramo. La teologia di Luca si mostra più tradizionale di quanto si poteva supporre e deriva da una comunità che con gioia scopriva che in Gesù si erano compiute le Scritture. Il tentativo ci rende perplessi non tanto per il ricorso all’aramaico al fine di ottenere una migliore comprensione del greco, quanto ad esempio l’incongruenza di dover prendere il presente dei√ (v. 21) come fosse un imperfetto, supponendo una sottostante cattiva traduzione del futuro ebraico o dell’infinito con l (p. 170). Se ammettiamo che Luca ha usato anche fonti scritte, non basta imputare ad una di esse il fatto di essere cattiva traduzione dall’aramaico, perché non si spiega come l’autore neotestamentario l’abbia ritenuta valida e coerente con il suo pensiero. Ora il discorso petrino entra nel complesso del miracolo con la susseguente meraviglia dei presenti e l’attività missionaria degli apostoli. Luca sottolinea che mentre il Cristo glorioso è assunto in cielo, agisce per mezzo della comunità che tende verso il tempo della “restaurazione di tutte le cose” (At 3,21; cf. 1,6: “è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?”). Rimane quindi la difficoltà dell’interpretazione di questo difficile brano, ma siamo certi che quest’opera porta un contributo al dibattito fra gli esegeti. 2. Il volume del Muñoz studia Lc 2,29-35, comprendendo anche il contesto Lc 2,22-28. Il Nunc dimittis (Lc 2,29-32) è il cantico della speranza compiuta, innalzato dal vecchio Simeone che contempla la “presentazione” del bambino al tempio. Si tratta infatti di presentazione, dato che Luca usa l’espressione “della loro purificazione” (lectio difficilior) come mero dato cronologico. Muñoz ricorre all’influsso aramaico per tradurre il participio prosdeco/menoß con la forma finita (v. 25) e pri«n (h£) a·n, cui corrisponderebbe l’aramaico yDI d[', con una particella temporale che rendiamo in italiano con “finché” (v. 26). Anche l’espressione fw◊ß eijß ajpoka¿luyiß ejqnw◊n (“luce per la rivelazione delle genti”) riceve una migliore traduzione vedendo sotto ei˙ß un semitico l] che precede il complemento diretto e ajpoka/luyiß come traduzione di un infinito passivo che meglio vien reso con l’espressione “rivelazione fatta alle genti”. L’uso aramaico può spiegare anche la perifrastica con verbo singolare e participio plurale nel v. 33. In breve egli riconosce alla pericope una forte coesione interna in perfetta sintonia con tutta l’opera lucana. Tre grosse difficoltà egli trova nella profezia di Simeone e sono costituite dal termine ajna/stasiß (v. 34a), dall’immagine della spada (v. 35a) quale conseguenza della manifestazione contenuta in v. 35b. Il testo ha come centro di interesse Maria, perché il v. 34 inizia con la benedizione di Simeone ad entrambi i genitori (eujlo/gesen aujtou/ß), ma la profezia è rivolta esplicitamente alla sola madre. La difficoltà di interpretazione che presenta l’espressione di v. 35a ha suggerito a molti critici che si tratti di una parentesi, nonostante che il greco leghi il discorso con le particelle kai\… de/. Muñoz dedica un lungo Excursus (pp. 413-421) alla storia dell’introduzione di questa parentesi nella profezia di 628 RECENSIONI Simeone partendo dal sec. XVI. Possiamo dire che tutta la sua trattazione mira a difendere una lettura unitaria del testo, escludendo tale cesura. Nel cap. II studia la metafora espressa dai termini ptw/siß e ajna/stasiß, rese nelle traduzioni con “caduta e risurrezione”. Si tratta di esperienze riferite alle stesse persone o a due gruppi differenti? La prima ipotesi è da escludere. Luca usa 26 volte (17 + 9) il sostantivo o il verbo della stessa radice, sempre in senso negativo. A differenza dei paralleli Mc 14,35 e Mt 26,39 evita di usarlo per Gesù nel Getsemani, ma l’adopera per descrivere la caduta di Satana. Perciò qui si deve intendere come caduta nella perdizione–condanna per quanti in Israele rigettano il Messia. In parallelismo antitetico va preso l’altro termine, che si riferisce a quelli che accolgono Gesù. Il Messia è il segno contraddetto, che per gli uni è occasione di caduta, per gli altri di salvezza. Troviamo un caso analogo in Ger 6,16, dove il profeta indica la strada buona per arrivare alla pace, ma il pubblico preferisce di non prenderla e allora gli cade addosso la sventura; così in Ger 23,12 il sentiero sdrucciolevole percorso non può avere come risultato che le tenebre e la sventura. Luca stesso parla di tempo della visita in senso positivo (Lc 1,68.78) come anche negativo, in quanto non avendo riconosciuto il tempo della visita, Gerusalemme cadrà inevitabilmente nella rovina della guerra (19,42-44). L’A. rileva che dal sec. XVI apparve negli editori la tentazione di porre tra parentesi la dibattuta frase della spada (v. 35a). Molti riconoscono nella spada una metafora per il dolore, ma egli osserva che il verbo die/rcomai non vuol dire “perforare, penetrare”, bensì “attraversare un luogo”. A proposito cita Ez 14,17 dove ricorre lo stesso verbo riguardo alla spada che percorre e devasta la regione. La corrispondenza verbale tra la LXX e il passo di Luca è ammessa anche da altri autori, ma per noi la situazione del testo di Ezechiele e quella del terzo vangelo è molto differente. Nel primo si tratta di un oracolo di sventura contro Israele infedele: il giudizio di Dio condanna il paese peccatore e lo colpisce con fame, bestie feroci, spada e peste; nel secondo Maria appare a Simeone come la personificazione di Israele fedele, come “la Figlia di Sion”. Il v. 35b ha contenuto chiaramente negativo. La maggior parte di Israele, di fatto, rientra nella categoria di coloro che hanno quei dialogismoi÷, nel NT sempre intesi in senso negativo in quanto indicano cattive intenzioni. Nonostante i tentativi di validi esegeti anche recenti per chiarire il senso della frase, essa si mantiene enigmatica e le referenze bibliche addotte sono incapaci di spiegarla. Muñoz esamina la proposizione retta da o¢pwß a‡n, di solito presa come finale, ma da lui resa come temporale. Il senso della frase dice che ad un dato momento i pensieri occulti del cuore saranno visibili esternamente, mutandosi in azione. Ritornando al v. 34a dove ei˙ß sta al posto di un l] semitico che introduce il predicato, non abbiamo senso finale, perché il destino del bambino non è di perdere, ma di salvare. A proposito l’A. richiama il pianto di Gesù su Gerusalemme (Lc 19,41-44): la caduta di molti non dipende dalla sua volontà. Grammaticalmente, osserva citando il grammatico Humbert, o¢pwß – che può essere finale – a volte non si distingue che imperfettamente dall’idea di consecuzione. Il no- MUÑOZ EL MESÍAS Y LA HIJA DE SIÓN 629 stro A. propone una nuova lettura, non di valore finale ma temporale. Sotto vi scorge un yDi / ydiK] aramaico che può avere non meno di sette significati, compreso quello temporale. Allora il v. 35b non implica la causa, ma il momento della caduta, cioè l’ora degli avversari che rifiutano il Messia (v. 34b) (pp. 368.372). L’oracolo di Simeone contiene un paradosso: la spada che i capi giudei metteranno in movimento contro Gesù “passerà per” Maria, però il colpo mortale sarà inferto contro loro stessi, che così cadranno (p. 383). La spada è nello stesso tempo arrivo dei tempi escatologici e causerà in Israele “desolazione” (Lc 21,20): essa produrrà la caduta dei discendenti di Israele che non sono Israele e nello stesso tempo si produrrà “la redenzione” dei discepoli di Gesù (Lc 21,28). La metafora riferita a Maria può illuminarsi col passo di Ez 14,17, dove il verbo ebraico rbæ[; è reso con die÷rcomai, passare attraverso. Israele della promessa, coloro che sono fedeli all’alleanza sono personificati da Maria (cf. Lc 1,26.38.45.48), la madre del Signore (Lc 1,43; 2,34). L’anziano Simeone annuncia per tutti la prova, che per una parte di Israele è di caduta; per l’altra egli conferma il “mantenimento fedele” dell’alleanza, ajna/stasiß (ebr.: hm;WqT]). Maria incarna in sé l’ “Israele di Dio”: sono in lei inseparabili la sua missione nell’opera della salvezza e la sua propria realtà più profondamente personale (p. 398). Il testo tanto controverso viene reso in questo modo (p. 391): a) b) a') b') “… e disse a Maria, sua madre: ecco, questi sarà caduta e mantenimento di molti (= tutti) in Israele, e bandiera combattuta, e una spada passerà attraverso di te [figlia di Sion, Israele] quando si manifesteranno i pensieri [malvagi] di molti cuori”. È in questo Israele di Dio che si innestano i gentili che diventano discepoli di Gesù. Allora abbiamo in nuce quello che per Rm 11,25-26 è il mistero di Israele, la cui incredulità offre ai gentili il tempo di essere innestati sull’albero buono di olivo, mentre i rami infruttuosi vengono recisi (Rm 11,20.22). Con analoga applicazione At 3,23 proclama che quanti non ascoltano il secondo Mosè decadono dall’appartenenza al popolo di Dio (p. 316). In questo modo il pensiero di Luca si mostra coerente, quando proclama Gesù “gloria di Israele” e “luce delle nazioni” (2,32). Per concludere notiamo che anche le moderne versioni liturgiche ricorrono a spostamenti di frase oppure ad incisi nel tentativo di rendere chiaro il testo. La lettura che ci offre il Muñoz rende comprensibile il testo. Veramente nella lunga esposizione del Muñoz non è facile seguirne il ragionamento, dato che spesso interrompe il discorso, portando avanti l’intreccio dei vari problemi. Questa fatica non dispensa dalla lettura dell’opera quanti si interessano della teologia di Luca e quanti devono esporre questo passo difficile, molte volte frainteso con un indebito passaggio al vangelo di Giovanni che ci presenta Maria sotto la croce di Gesù. Giovanni Bissoli, ofm 630 RECENSIONI Pitta Antonio, Sinossi paolina. Le lettere di san Paolo in una nuova traduzione ordinate per temi (Universo Teologia 31), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, 318 pp., L. 35.000 L’impianto dell’opera è semplice: Introduzione (pp. 7-12) e Sinossi (pp. 21-315), cui si aggiungono la Prefazione di R. Penna (p. 5), un elenco di Sigle e abbreviazioni (pp. 13-14), il Prospetto sinottico dell’epistolario paolino (pp. 15-20) e l’Indice (pp. 317-318). Nell’introduzione, l’A. in primo luogo sottolinea la liceità di stendere una “sinossi paolina”: “I vangeli sembrano aver talmente monopolizzato il termine «sinossi» da poterlo utilizzare come semplice loro variazione lessicale... Senza negare la validità di tale appropriazione terminologica, si hanno studi di tipo sinottico anche per altri testi della Bibbia, come quello di Eissfeldt dedicato alle fonti dell’esateuco, oppure quello di Vannutelli e di Bendavid sui temi storici dell’Antico Testamento” (p. 7). E in realtà, come precisa Penna, vi sono almeno “tre buone ragioni” per stendere una “sinossi paolina”: la varietà di autori che hanno composto il corpus paulinum; la diversità delle forme letterarie all’interno di tale corpus; il “sempre ricorrente messaggio cristiano” (p. 5). Di fatto, l’impresa è stata tentata per la prima volta da G.M. Heyder, Paulus. Das Wort an die Welt. Eine Synopse der Briefe des Apostels, Olten - Freiburg i. Br. 1957, che nella sua stesura originale somiglia più ad una “concordanza” che ad una “sinossi”, mentre I. Fransen - P. Goidts nell’edizione francese: Paul de Tarse. Synopse des Épîtres, Paris 1962, gli diedero la forma di “sinossi”. Qualche anno più tardi il tentativo è stato ripetuto da F.O. Francis - J.P. Sampley, Pauline Parallels, Philadelphia 1984. Precedentemente a quest’ultimo tentativo D. von Allmen, nel suo articolo “Pour une synopse paulinienne”, Bib 57 (1976) 74-104, aveva enunciato dei “criteri per un’elaborazione di una sinossi paolina” (pp. 84-90): visione simultanea dei testi paralleli; sguardo «contestuale» dei paralleli; identificazione del corpus paulinum; apparato critico; commento esplicativo delle tavole sinottiche. In dialettica critica con i suggerimenti di von Allmen, l’A. delinea una sua breve metodologia. In primo luogo, cerca di stabilire: Quali lettere in sinossi? “Una sinossi paolina deve necessariamente procedere per tredici colonne, quante sono le lettere attribuite a Paolo, che un metodo sinottico, senza arrogarsi il diritto di essere l’unico né il migliore, permette di convalidare o di rigettare” (p. 9). In concreto: bisogna tener conto delle cosiddette “7 lettere autentiche”, delle “lettere ecclesiologiche” (Col, Ef), delle “lettere pastorali” (1Tm, Tt, 2Tm) e della 2Tes. Secondo problema: Quale ordine tipografico? “Nella presente sinossi si seguirà il duplice criterio «cronologico-letterario», in forma evolutiva. Innanzitutto si inizierà dalle lettere più antiche e ritenute generalmente come paoline per passare poi a quelle successive e considerate spesso come deutero- e postpaoline. Tuttavia, l’utilizzazione del solo criterio cronologico si presenta debole... Per questo, la criteriologia delle maggiori o minori connessioni letterarie permette di uscire dalle sabbie mobili della cronologia delle lettere. In questa sinossi, connessioni letterarie e cronologia paolina sono intimamente legate” (p. PITTA SINOSSI PAOLINA 631 9). Terzo problema: Quale materiale sinottico? “Lo scopo di questa sinossi non è quello di sostituirsi a delle concordanze tematiche, ma quello di offrire le categorie portanti dell’argomentazione paolina... Da questo dipende la scelta per una sinossi paolina che non proceda tanto per temi, più o meno accattivanti, quanto soprattutto per generi letterari, argomentativi ed epistolari, che permettano di verificare processi letterari attendibili” (p. 10). In base a tali criteri, la “sinossi paolina” del Pitta si snoda in 24 sezioni, “suddivisibili nella seguente ramificazione: Epistolografia: prescritti, postscritti, ringraziamenti o esordi, apusia-parusia epistolare. Fonti: citazioni dirette dell’Antico Testamento, citazioni dei detti di Gesù e di autori extrabiblici. Generi argomentativi: escatologia apocalittica, argomentazione midrashica, argomentazione diatribica, innologia e dossologia, codice domestico, codice ecclesiale, paraclesi conclusiva, catalogo delle difficoltà, catalogo dei vizi e delle virtù. Metaforologia: motivo agonistico, motivo dell’edificio, motivo della natura, motivo cultuale, maternità/paternità, somatologia. Narrativa: autobiografia, oppositori, colletta” (p. 10). È chiaro che la presente catalogazione non intende essere né esaustiva né rigida, anzi nelle intenzioni dell’A. è aperta a possibili sviluppi futuri. Senza dubbio, mi unisco al plauso di Penna: “Di certo non si è trattato di un lavoro semplice e bisogna perciò dare atto a Pitta non solo del suo coraggio, ma anche di una serietà di impegno degna di plauso”. Ma non mi sento di condividere la sua valutazione globale dell’opera: “Crediamo che la sua fatica, pur pionieristica, abbia prodotto un’eccellente risultato” (p. 5). Basterebbe un solo sguardo a questa “sinossi” per restare ampiamente perplessi sul risultato. Così, è vero che Pitta ha discusso il problema dell’“ordine tipografico”, ma tutto si riduce a stabilire se bisogna seguire un “ordine cronologico”, un “ordine letterario” o un “ordine di maggiori o minori connessioni”. Purtroppo non mi sembra che abbia saputo dare alla “sinossi” una “veste tipografica” accettabile. In tal senso, l’elemento più visibile nella “sinossi” è il vuoto. Si contano: 15 pagine vuote con i soli titoli di lettere, 16 pagine vuote per motivi tipografici, 65 pagine con una sola colonna, circa 41 mezze pagine. Tutto ciò da solo rappresenta metà dell’opera. Non me ne voglia male l’A., ma voglio soltanto mettere in rilievo che una buona “sinossi” richiede anche “un’organizzazione tipografica” adeguata, traduzione grafica delle proprie scelte metodologiche. Su ciò il von Allmen, nonostante la sua visione alquanto utopistica, ha dato delle esemplificazioni migliori di quelle messe in atto da Pitta. Così, per esempio, sono pochi i casi in cui tutte le 13 lettere siano coinvolte nella sinossi: prescritti e postscritti, mentre per lo più si ha un numero molto limitato di paralleli. Allora, perché moltiplicare le pagine bianche? perché non scegliere un criterio tipografico diverso, che metta meglio in evidenza il dato sinottico dei paralleli e renda forse più proficua la suddivisione in “livelli”? Certamente, la scelta metodologica di stabilire dei “livelli” all’interno delle “ramificazioni sinottiche” può dare l’impressione di una maggiore organicità a questa “sinossi”. Purtroppo, non è così. Infatti, essa: 632 RECENSIONI 1) accresce gli spazi vuoti. Nell’intenzione dell’A. probabilmente c’è il desiderio di distinguere tra i vari gruppi di paralleli di una stessa ramificazione. Ma per far ciò, egli ha scelto di porre una griglia comune per tutti i livelli della “ramificazione interessata”. In tal modo, gli spazi vuoti si moltiplicano necessariamente. 2) determina dispersione tra i paralleli, impedendo una percezione sinottica. Di questo fenomeno si registrano molti casi. Ne prendo in considerazione alcuni: la ramificazione 4. Oppositori di Paolo, per Pitta ha 8 “livelli”, che si possono rintracciare in 11 lettere paoline, che formano automaticamente la griglia della “sinossi”. Il risultato è il seguente: il primo livello è rappresentato da sole tre lettere: 1Tes, 2Tes, Col, che vengono poste in “sinossi” all’interno della griglia stabilita, determinando un eccesso di spazio vuoto e una difficoltà di lettura sinottica evidente tra 1Tes 2,13-16 e 2Tes 1,3-12 poste a p. 50 e Col 2,6-7 posta a p. 51. Ciò si poteva evitare, ponendo in una sola pagina i tre testi paralleli ed eliminando drasticamente la menzione inutile delle altre lettere. Il criterio di Pitta si dimostra ancora più inadeguato nelle pagine che seguono: così, nelle pp. 5253, il secondo livello non solo non ha un parallelo sinottico, ma determina insieme al primo e al terzo livello una pagina completamente vuota; e la cosa si ripete nelle pp. 54-55 e in parte nelle pp. 56-57. La dispersione è ancora più evidente nella “ramificazione sinottica” 5. Citazioni dirette dall’Antico Testamento, dove la divisione in “livelli” (rappresentati dai diversi libri dell’AT), se si escludono pochi casi, non solo moltiplica gli spazi vuoti, ma fa scadere questa “sinossi” ad una “concordanza” dispersa qua e là tra p. 72 e p. 98. Confesso di non conoscere l’opera di Pierini-Berardi, ma se l’A. si serve dei loro risultati, allora bisogna dire che non c’è proprio bisogno di stabilire tale “ramificazione sinottica”. Anche perché – e Pitta ne è cosciente (cf. p. 70) – le citazioni dell’AT in Paolo fanno parte essenziale delle sue argomentazioni midrashiche e quindi il parallelismo sinottico tra i vari testi biblici lo si può stabilire all’interno di tali argomentazioni. 3) isola i testi, andando così contro la tecnica essenziale di una “sinossi” e non mettendo in risalto le differenze e somiglianze diacroniche tra un testo e un altro. Oltre all’esempio già ricordato di 2Tes 2,1-4 (pp. 52-53) e ad altri che si possono rintracciare lungo tutta la “sinossi”, voglio ricordare in particolar modo quello della “ramificazione sinottica” 10. Innologia e dossologia, in cui l’A. distingue a proposito degli inni tre “livelli”: inni cristologici, inni teologici, inno all’amore. Ora tale distinzione, a mio parere, non doveva essere previa, ma doveva sorgere proprio dalla comparazione sinottica. Ma il procedimento dell’A. non solo ci priva dal poter determinare da noi le differenze, ma dal gustare anche le somiglianze tra gli inni teologici e gli inni cristologici. Inoltre, la sua distinzione in “livelli” ha creato un caso evidente di isolamento dell’“inno all’amore” di 1Cor 12,31b-13,13, determinando ben quattro pagine con una sola colonna (pp. 150-153). Inoltre, io credo che 1Cor 12,31b-13,13, per quanto qualche autore lo consideri un “inno”, sia solo una “prosa ritmata” che potrebbe trovare paralleli nel testo di Rom 12,9-19, anch’esso alquanto ritmato, e di Rom 13,8-13. CARBONE - RIZZI LE SCRITTURE AI TEMPI DI GESÙ 633 Ho letto con interesse le introduzioni alle 24 “ramificazioni” stabilite dall’A. e ritengo che siano molto utili per una comprensione più profonda dei procedimenti esegetico-teologici dell’epistolario paolino. Ma ritengo che non debbano essere concepite come giustificazioni per stabilire la suddivisione in “livelli”, ma come delle osservazioni critiche che aiutano il lettore ad una comprensione più profonda dei “parallelismi sinottici” stabiliti. Ciò comporta che la giustificazione critica delle 24 “ramificazioni” non va fatta lungo la sinossi, ma nell’introduzione generale all’opera, precisamente all’interno del problema: Quale materiale sinottico? A mio parere, infatti, non si può imporre al lettore una divisione senza darne una giustificazione esauriente e senza avvertirlo che il metodo usato prevede anche delle suddivisioni in “livelli” delle 24 “ramificazioni sinottiche”. Tale procedimento, oltre a dare una base metodologica più sicura, darebbe all’A. la possibilità di allargare le sue osservazioni critiche e mettere più in evidenza le “diacronie” dei testi, come d’altra parte suggerisce anche il von Allmen. Non discuto la scelta di Pitta circa il problema: Quali lettere in sinossi? Personalmente propendo verso la soluzione adottata dagli autori Francis Sampley: 10 lettere, anche perché 2Tes, Col, Ef, per quanto contestate, non lo sono certamente quanto le Pastorali, le quali ormai dalla stragrande maggioranza degli autori sono considerate “non-autentiche”. Se Pitta, invece, insiste nel dire che esse hanno fatto parte del corpus paulinum, allora bisogna includere anche Ebrei, in quanto anch’essa ha fatto parte del corpus paulinum, è certamente di “scuola paolina” e mostra molti punti in comune anche con l’epistolario paolino autentico. Mi scusi l’A. la “parresia” con cui ho espresso le mie osservazioni, ma volevano essere solo un contributo a quegli “approfondimenti” che egli ha in vista (p. 10). Anzi, mi auguro che l’A. non si fermi solo ad una “sinossi paolina” di tipo divulgativo, ma si impegni anche in una “sinossi paolina” di tipo scientifico, soprattutto sul testo greco. Se ne sente il bisogno! Alfio Marcello Buscemi, ofm Carbone Sandro - Rizzi Giovanni, Le Scritture ai tempi di Gesù. Introduzione alla LXX e alle antiche versioni aramaiche (Testi e commenti - Sez. “La Parola e la sua tradizione” 1), Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, 154 pp., L. 18.000 Carbone Sandro - Rizzi Giovanni, Il libro di Osea secondo il testo ebraico Masoretico, secondo la traduzione greca detta dei Settanta, secondo la parafrasi aramaica del Targum (Testi e commenti A2- Sez. “La Parola e la sua tradizione” 1), Edizioni Dehoniane, Bologna 1993, 295 pp., L. 44.000 Carbone Sandro - Rizzi Giovanni, Il libro di Amos. Lettura ebraica, greca e aramaica (Testi e commenti A2- Sez. “La Parola e la sua tradizione” 2), Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 176 pp., L. 27.000 634 RECENSIONI Due giovani biblisti, formati a Gerusalemme nel nostro Studium, si sono accinti a una generosa impresa: “rendere accessibile alle comunità cristiane impegnate nella lettura della Bibbia, ai sacerdoti, ai religiosi e religiose, agli studenti dei vari istituti di teologia dei seminari e nei vari istituti una traduzione della Settanta e dei Targumim, che resterebbero altrimenti ignorati ancora per lungo, troppo tempo” (Le Scritture, 11). Questo l’intento programmatico, che si legge nella monografia introduttiva, la prima delle opere qui presentate. I due autori hanno precisato ancora meglio le prospettive del loro lavoro in un articolo elaborato e apparso in RivBiblIt 43 (1995) 363-379 dopo la pubblicazione dei tre volumi. Anche se per chi scrive è stato il contrario, mi sembra utile raccomandare la lettura di quest’ultimo contributo prima di affrontare i singoli volumi. Essi scrivono “Vorremmo dare quindi la possibilità di comprendere che nella comunità ebraica, sia di lingua aramaica sia di lingua greca, nel I secolo prima e dopo la nostra era, il testo biblico in parte ancora fluttuante era stato tramandato e fissato sulla base di una tradizione vivente la quale, scegliendo tra le varianti (TE = Testo Ebraico e poi TM = Testo Masoretico) e specialmente traducendo (LXX = Settanta e Tg = Targum), aveva in parte trasformato e reso più attuale il testo, introducendovi del nuovo, in armonia con lo sviluppo delle idee religiose e con le esigenze di situazioni nuove rispetto a quelle in cui era nato il testo originale” (RivBiblIt 43, 1995, 363). Il corsivo è mio e vuole sottolineare l’aspetto che, credo, risulterà più nuovo per la maggioranza dei destinatari di questa impresa forse abituati a una concezione del testo biblico fisso, immutato e immutabile fin dall’inizio. Se a quanto detto dagli autori si aggiunge la costatazione di Mons. Galbiati – uno degli autorevoli presentatori dei volumi, assieme a R. Le Déaut e a G. Ravasi – si ha un altro elemento essenziale per comprendere la natura e l’importanza dell’iniziativa, per ora limitata ai Profeti Minori. Scrive l’illustre studioso: “Essendo dimostrato che il Targum, anche se messo in scritto dopo l’inizio del Cristianesimo, esisteva già in forma orale ed era usato nella liturgia sinagogale per l’istruzione del popolo accanto alla lettura in ebraico, essendo anche dimostrato che nelle sinagoghe di lingua greca, ad Alessandria ma anche a Gerusalemme, si leggeva solo la versione greca, ne deriva il fatto che nell’ambiente dove è nato il Cristianesimo, nell’ambiente di Gesù e poi degli scritti del Nuovo Testamento, esistevano almeno tre forme non del tutto equivalenti del testo biblico, immerso, per così dire, nella tradizione vivente” (E. Galbiati, “Presentazione”, in Il libro di Osea, 7-8). 1. Opportunamente la nuova serie si apre con un volume di introduzione, che porta il titolo Le Scritture ai tempi di Gesù. Dopo quanto si è detto si capisce l’intenzionalità del plurale “[Sacre] Scritture”. La monografia costituisce una introduzione alla traduzione greca dei Settanta (pp. 23-77) e alle antiche versioni aramaiche o Targumim (pp. 79-126). Si tratta chiaramente di una introduzione limitata alle cose fondamentali e finalizzata alla serie cui fa da volume di apertura. Della traduzione dei Settanta CARBONE - RIZZI LE SCRITTURE AI TEMPI DI GESÙ 635 viene trattata l’origine, la formazione, l’influsso e le caratteristiche. Della letteratura targumica, dopo brevi cenni generali sono passati in rassegna i Targumim del Pentateuco, dei Profeti e degli Agiografi. In due capitoli sono illustrati scopi e metodi del Targum e si offrono alcuni esempi concreti, attraverso testi campione, di immersione nel mondo della letteratura giudaica antica (la prova di Abramo e il sacrificio di Isacco; l’albero della vita; il pozzo di Miriam). Gli autori tornano insistentemente su alcune convinzioni fondamentali che hanno ispirato l’impianto del loro lavoro e lo sorreggono: la versione dei Settanta è più di una semplice versione, perché è testimone del testo dell’AT e la sua importanza per la fede e la cultura cristiana è incalcolabile; i Settanta e il Targum sono un grande “monumento” di interpretazione giudaica delle Sacre Scritture di lingua ebraica: traduzione greca e parafrasi aramaiche costituiscono un anello insostituibile di congiunzione tra mondo biblico dell’AT, giudaismo antico e cristianesimo delle origini; i Settanta e i Targumim testimoniano in concreto tutti i metodi di lettura e interpretazione dell’esegesi giudaica (tecniche di traduzione e tendenze midrashiche) usati nella sinagoga e nella scuola. Attorno a questo corpo centrale gli autori hanno raccolto non poche altre informazioni sui metodi esegetici in voga nella sinagoga e nella scuola (beth midrash) al tempo di Gesù e degli autori neotestamentari, sul concetto di ispirazione, sulle tappe della formazione del TM, sui problemi linguistici e di datazione, sulla relazione tra midrash e Targum, sul rapporto tra questa letteratura e il NT. Trattandosi di un manuale introduttivo, il volume andrà collaudato dall’uso nella scuola e fuori e potrà certamente essere migliorato nelle successive edizioni. In questa prospettiva faccio qualche osservazione e suggerisco alcune correzioni, anche di minore rilievo. Si sente la mancanza di un dizionarietto terminologico. Uno sforzo in tal senso, secondo me, risulterebbe estremamente utile a chi muove i primi passi nel mondo della letteratura giudaica antica e gioverebbe in ogni caso a una maggiore precisione nell’uso di termini e concetti. A p. 11 probabilmente manca l’articolo dinanzi a “profeti minori”. A p. 13, n. 2 si parla della Geniza del Cairo, ma il termine viene spiegato alla p. 21, n. 7. A p. 15, trattando dei metodi esegetici, si accenna alla datazione delle tradizioni targumiche attraverso il confronto con altre opere ben datate del giudaismo antico, quali Filone e Giuseppe Flavio ma non si nominano neppure gli scritti di Qumran (stessa osservazione per p. 93). Penso che il paragrafo andrebbe completato e più ampiamente sviluppato con la menzione esplicita dei criteri comunemente accettati per la datazione. A p. 34, n. 40 forse è più appropriato parlare di “grotta delle Lettere in Na˙al Óever” anziché di “cava delle Lettere in Na˙al Óever”. A p. 81 credo che “traduzione halakica” sia da leggere “tradizione halakica”. A p. 124 forse è più corretto invertire gli attuali termini di paragone tra la roccia percossa da Mosè e il fianco di Cristo trafitto dalla lancia. La bibliografia ha bisogno di un controllo più attento: non vi è sempre uniformità nell’indicazione delle collane; a Arnaldez è attribuito un ti- 636 RECENSIONI tolo (Constitution…) che non si trova nel volume citato; sotto il nome di Bonsirven è finito un titolo bibliografico (“Les mécanismes…”) che in realtà appartiene a Bogaert (pp. 131-132); il titolo Jellicoe… è ripetuto alla fine dei nomi inizianti con la lettera elle; in nomi e titoli di lingua spagnola molto spesso mancano gli accenti. Alcune correzioni: p. 28, n. 4 dovrebbero per dovrebbe; p. 33 Jellocoe per Jellicoe; p. 45 prosh/luto per prosh/lutoß, plerow per plhro/w; p. 47, n. 95 Sapienziali per gli “Scritti”; p. 49 nota 5 per nota 8 (lo stesso a p. 55 n. 19); p. 51, n. 10 cap. II per cap. III; p. 61 n. 36 Ecco per ecco; p. 86, n. 6 Speber per Sperber; p. 129 issu per iussu; p. 131 Genesius per Gesenius; p. 134 1Coe per 1Cor; virgolette di citazione rovesciate: pp. 45-47, 54, 61, 95, 108, 122-125. 2. Come primo traguardo della grossa iniziativa Carbone - Rizzi si sono proposti di pubblicare i Profeti Minori, perché si tratta di un complesso significativo insieme non troppo esteso né troppo limitato. Alla monografia introduttiva hanno già fatto seguito i primi due volumi dedicati rispettivamente a Osea e Amos. Il primo volume reca nel frontespizio (non sulla copertina) un titolo un po’ macchinoso – giustamente semplificato in quello dedicato a Amos – forse dovuto al desiderio di essere fin troppo chiari: Il libro di Osea secondo il testo ebraico Masoretico, secondo la traduzione greca detta dei Settanta, secondo la parafrasi aramaica del Targum. La struttura del volume è semplice. Dopo le consuete rubriche (Abbreviazioni e Bibliografia) si trova una brevissima Introduzione generale (pp. 23-24 dove sono riportate alcune considerazioni che compaiono già nel volume introduttivo. Ugualmente molto breve è la Introduzione alla traduzione del TM del libro di Osea (pp. 27-28). Contiene alcune avvertenze e precisazioni sul testo ebraico masoretico che viene tradotto e sul tipo di traduzione. Seguono poi due notevoli introduzioni alla versione dei LXX (pp. 31-46) e al Targum (pp. 49-71). Sarebbe molto difficile riferire qui le molteplici e minuziose osservazioni che gli autori fanno in queste due introduzioni, le quali presuppongono il confronto sinottico diretto, e forse ancora più arduo sarebbe per il lettore della presente rassegna seguire tali osservazioni. Per questo, al fine di dare un’idea della ricchezza, dell’interesse e della complessità mi limito a descrivere sinteticamente il loro contenuto. Punto di riferimento oggettivo e necessario resta il TM di Osea. Anzitutto gli autori affrontano il problema delle differenze tra TMOs e LXXOs che possono dipendere dal fatto che l’interprete greco traduceva da un Testo Ebraico diverso dal TM (p. 31: “in numerosi punti”). Quindi, poiché il testo dei LXX è una “traduzione che interpreta”, gli autori facendo il confronto mostrano le differenze che si possono far risalire alle tecniche di traduzione (modifiche per esigenze di traduzione, procedimenti stilistici e equivalenti culturali) e quelle che dipendono dalle tendenze midrashiche dalle quali risulta una “esegesi trasformante in atto” (p. 36). Concretamente il midrash halakah è presente in CARBONE - RIZZI IL LIBRO DI OSEA 637 LXXOs in riferimento a questi temi specifici: idolatria, coscienza del peccato, purità rituale, condotta sessuale, condizione giuridica della diaspora. La lettura midrashica di tipo haggadico non è meno presente in LXXOs. Carbone Rizzi ne individuano quattro temi principali: Dio e il suo popolo, l’esilio e la dispersione del popolo, la diaspora e le concezioni escatologiche riguardanti la riunione dei figli di Israele, la guerra escatologica, la liberazione dalla morte, la pace e la prosperità escatologica, il mistero e la vocazione d’Israele. Nella Introduzione al Targum del libro di Osea gli autori notano anzitutto che la parafrasi targumica rispetto al TM colpisce per la sua ampiezza e per l’articolazione dei temi che affronta (cf. p. 49). Il Targum è “una traduzione che spiega” e che cerca di non lasciare nulla di oscuro, perciò rispetto a LXXOs è “meno sobrio, meno preoccupato di riprodurre materialmente il testo ebraico originale” (p. 51). Carbone - Rizzi ritengono che TgOs ha di fronte un testo ebraico del tutto simile a quello che poi sarà vocalizzato dai masoreti (cf. p. 51). Nel confronto TMOs e TgOs essi distinguono tra fenomeni particolari e tecnici, ricorrenti o più occasionali e fenomeni dipendenti dalla attività derashica. Tra i primi vanno annoverate le divergenze testuali e sticometriche, la soluzione di oscurità e incertezze del TM, gli adattamenti della toponomastica, alcune questioni connesse con la traduzione dei tempi e dei modi dei verbi in aramaico. Appartengono invece alla seconda serie di fenomeni o caratteristiche da una parte la glossa (“inserzione propria del targumista senza che vi sia un appiglio letterale o letterario nel TM: si tratta di una vera e propria aggiunta, con vari scopi”, p. 54) e dall’altra la parafrasi propriamente detta e le letture midrashiche. Per le glosse si possono individuare: glosse esplicative, glosse secondo il midrash halakah, glosse secondo il midrash haggadah. Quanto alla parafrasi si nota che essa resta aderente al testo e “tende a esporre il testo originale cambiando qualche parola, usando termini specifici, introducendo esplicitazioni sintattiche, allargando più o meno sensibilmente le immagini o le similitudini” (p. 54 e 57). “Le letture midrashiche… sono molto più libere, anche se mai totalmente sciolte, dalla lettera del testo, per attingere al patrimonio della tradizione nell’interpretarlo. Il midrash halakah evidenzia il contenuto morale e giuridico del testo, mentre il midrash haggadah mette in luce l’interpretazione spirituale, storica, edificante, messianica, escatologica, comunitaria, ecc.” (p. 54 e 57ss). Sotto la parafrasi propriamente detta gli autori classificano alcune tecniche (ricorso al plurale, “Israele” per tutto il popolo di Dio, attenuazione o accentuazione di un testo biblico, ampliamento delle immagini e riduzione a similitudine) e alcuni contenuti (differente contestualizzazione come attualizzazione del testo, contenuti halakici e contenuti haggadici). Sotto le letture midrashiche essi classificano: la traduzione del tetragramma sacro, il midrash halakah (alcune formulazioni generali, il peccato, il timore di Dio, la Legge e le opere, gli aspetti concreti della vita morale, il perdono del Signore e la giustizia futura), il midrash haggadah (la sventura, il memoriale salvifico dell’esodo e l’amore di Dio per “i padri”, la salvezza). 638 RECENSIONI A queste robuste introduzioni seguono, disposte in sinossi, la traduzione del TM (ed. K. Elliger in BHS), dei LXX (ed. J. Ziegler), del Tg (ed. A. Sperber) e le note di commento. La traduzione è volutamente e sempre molto letterale per permettere di fare un confronto corretto e stringente fra i tre testi. Talvolta il testo tradotto risulta un po’ duro, ma ritengo sia valido il principio che quando il calco non distorce la lingua, favorisce la formazione di un linguaggio speciale e quindi più propriamente caratterizzato. In calce alla traduzione e a seguire si trovano tre fasce di note rispondenti a tre testi. Per il TM la traduzione italiana è costantemente confrontata con quella di H.W. Wolff e vengono segnalate le modifiche apportate al TM, le interpretazioni filologiche divergenti e la diversità possibile nella resa dei tempi del verbo ebraico in poesia. Nella fascia riservata a LXXOs sono messe in evidenza le differenze rispetto al TM cercando di individuarne le ragioni specifiche nei singoli casi. Qui vengono discussi anche casi controversi del TM. In quella dedicata al TgOs le note cercano di spiegare le ragioni di interpretazioni e ampliamenti rispetto al TM. Chi avrà letto attentamente le introduzioni ritroverà qui in dettaglio e con maggiore ricchezza di particolari quanto nelle introduzioni specifiche ai tre testi si trova raccolto, classificato e esposto. Alla traduzione sinottica segue un breve capitolo conclusivo dove si istituisce un confronto sulle caratteristiche proprie di LXXOs e TgOs. Tale confronto viene fatto sulle tecniche di traduzione e sulle tecniche di interpretazione. Carbone - Rizzi ritengono che attraverso questa metodologia si possa “giungere certamente a delineare un quadro teologico abbastanza ampio dell’interpretazione del libro di Osea nella tradizione giudaica almeno tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C.” (p. 280). Chiudono il volume alcuni indici: dei passi biblici del TM e dei LXX, dei passi dei Targumim e della letteratura rabbinica (esteso a Qumran, Filone, Giuseppe Flavio e agli Apocrifi del NT). Quest’ultimo è di scarsa utilità perché si limita a dare solo il titolo del libro, senza alcuna specificazione ulteriore. Questa osservazione va estesa pure al volume già presentato e a quello che segnalerò in seguito. Gli autori esprimono in anticipo “viva gratitudine ai critici e agli studiosi che [ci] vorranno segnalare errori, inesattezze, integrazioni, ecc.” (p. 23-24). In questa ottica aggiungo qualche osservazione e suggerisco alcune correzioni, anche in vista di ulteriori edizioni che sinceramente auguro all’opera. Ho trovato arduo seguire le varie introduzioni per vari motivi e non solo per la materia in sé. L’inserimento continuo di rinvii all’interno del testo e non in nota affatica non poco la lettura. Sembra che gli stessi autori lo abbiano già avvertito perché nel volume su Amos hanno proceduto in questa direzione. Nell’attuale disposizione grafica non si riescono a vedere i diversi livelli delle suddivisioni. Questa per me è stata una difficoltà maggiore, solo in parte compensata dal fatto che alla fine di ciascuna divisione vengono annunciate quelle CARBONE - RIZZI IL LIBRO DI AMOS 639 successive. Questo limite è aggravato dal fatto che nel libro non si trova un indice generale che permetta di vedere l’articolazione complessiva e completa del volume. Ritengo sia necessario chiarire bene questo non solo con una diversa disposizione grafica, ma anche con apposite lettere, numeri e, se necessario, paragrafi. Mi permetto di suggerire una rilettura più rigorosa da parte degli autori in modo da evitare ripetizioni non necessarie. Mi rendo conto che non è facile evitare delle ripetizioni quando si passa dalle introduzioni ai commenti nelle note e nella conclusione, tuttavia man mano che il metodo e la terminologia si affinerà forse ciò sarà possibile. Credo convenga fare qualche sacrificio per migliorare questi aspetti, tenuto conto del vasto pubblico che l’opera vuole raggiungere. Bisogna aggiungere nella bibliografia i dati completi di Galbiati - Aletti, Atlante e di Manns, Symbole (p. 265 non ripreso nell’indice degli autori) citati solo in forma abbreviata. A p. 76, n. 10 penso che PER sia da leggere PRE. Nella colonna del Tg a p. 144 il n. 22 del v. va corretto in 21. 3. Il volume dedicato al libro del profeta Amos ripete ovviamente la struttura di quello che lo ha preceduto. Gli autori non vi hanno premesso neppure una introduzione ma hanno preferito limitarsi a una brevissima prefazione dove riportano quasi alla lettera quanto si legge nei volumi precedenti (cf. Le Scritture, p. 9 e 11; Libro di Osea, p. 23). Tuttavia sono visibili già alcuni miglioramenti. Nelle introduzioni sono state introdotte sistematicamente le note di rinvio ai tre testi, anche se ridotte alle cose più essenziali. Ciò permette di leggere in maniera più scorrevole il testo. Anche qui, come nel volume su Osea, si trova un imponente lavoro di classificazione e presentazione del materiale specifico dei tre testi. Per TMAm (pp. 23-26) gli autori fanno osservare che anche questa “lettura” non è priva di segnali interpretativi e glosse. Tuttavia il testo in sé presenta meno asperità rispetto a Osea. Per LXXAm (pp. 29-41) Carbone - Rizzi ripetono anzitutto la costatazione che esso è “esegesi in atto”, poi indicano le numerose divergenze testuali rispetto al TMAm, di cui alcune possono rivelare un TE diverso e migliore del TM. Quindi passano ad elencare tutta una serie di procedimenti abbastanza frequenti e riconducibili alle seguenti ragioni: stile e vocabolario, nuove contestualizzazioni (per es. spostamento del punto di osservazione da quello preesilico di Amos a quello postesilico del giudaismo), attività di glossatura (quantitativamente non rilevante) con presenza di halakah e haggadah, letture midrashiche (presenza rilevante anche se non nella misura di quelle di Osea) di impianto haggadico proteso a illustrare il tema bipolare della salvezza e del giudizio su Israele e sui pagani. Per TgAm (pp. 45-58) si rileva anzitutto una maggiore sobrietà e concisione nell’attività derashica della parafrasi rispetto al Targum di Osea. I problemi testuali sono di vario tipo, ma non numerosi. Non pochi casi, in cui il Tg si allontana dal TM, si possono considerare come traduzioni attraverso “l’equivalente culturale”. Inoltre la distinzione tra i vari fenomeni letterari che 640 RECENSIONI gli autori avevano potuto fare per TgOs non la ritengono agibile per TgAm. Essi distinguono glosse esplicative rispetto a TMAm e glosse con sviluppo halakico e haggadico e poi classificano il materiale proveniente dalla parafrasi e quello più propriamente midrashico sotto la “teologia”, il midrash halakah (formulazioni generali e varie, ingiustizie e sovvertimento della giustizia, il culto), il midrash haggadah (la parola, la profezia e il ministero di Amos, la sventura, la tipologia dell’esodo, l’elezione di Israele e il perdono divino, le prospettive escatologiche). La sinossi con traduzione di TMAm (ed. K. Elliger in BHS), di LXXAm (ed. J. Ziegler), del TgAM (ed. A. Sperber) con le relative fasce di note occupa la parte centrale e principale del volume (pp. 59-157). Una differenza rispetto al volume dedicato a Osea gli autori l’hanno apportata riguardo al modo di trattare TMAm. Sia l’introduzione che l’apparato critico filologico-testuale sono maggiormente sviluppati. Come per i volumi precedenti avanzo qualche suggerimento e segnalo degli errori. Confesso di aver fatto pure qui una grossa fatica a individuare le divisioni principali e minori nelle introduzioni a LXXAm e TgAM. Come si diceva per il precedente volume, è importante che gli autori introducano espedienti grafici e di altro genere per mostrare chiaramente le articolazioni. Non si vede poi perché non vi sia un indice generale, della cui utilità, credo, nessuno possa dubitare. A p. 13 si legge Genesius per Gesenius, a pp. 16-17 ouevres per oeuvres; mancano gli accenti in nomi e titoli in spagnolo. L’interesse e la fecondità a diversi livelli del confronto che gli autori istituiscono tra i due libri profetici fa intravvedere la mole di osservazioni e la possibilità di conclusioni che permetterà la realizzazione del disegno complessivo. Fin da ora essi mettono a disposizione non solo di un vasto pubblico di amanti e devoti delle Sacre Scritture, ma anche di ricercatori e studenti, una quantità notevolissima di materiale su cui fare verifiche e approfondimenti. I lettori sono avvertiti che il viaggio cui sono invitati da Carbone - Rizzi non è una facile passeggiata, ma riserva sorprese e soddisfazioni. R. Le Déaut nella Prefazione al primo volume della serie scrive: “Chi avrà il coraggio e la pazienza perseverante di superare le difficoltà iniziali a comprendere le inevitabili ‘crisi’ scientifiche e spirituali connesse alla scoperta del mondo del giudaismo, ai suoi metodi interpretativi e al suo linguaggio, scoprirà un tesoro inesauribile da cui non vorrà più separarsi, di essenziale attualità e ricco di sorprese” (Le Scritture, 9). I due giovani e coraggiosi autori possono dirsi paghi della loro fatica se come c’è da augurarsi - essa aiuterà “le comunità italiane a familiarizzarsi con l’idea che la parola di Dio si è storicamente rivelata in una viva tradizione, nel corso della quale le successive edizioni del testo ebraico, delle traduzioni greche e i targumim aramaici hanno dato contributi diversi, ma insostituibili nell’evidenziarne i contenuti e nel disvelarne il mistero” (Il libro di Osea, 27). Giovanni Claudio Bottini, ofm GILLESPIE THE FIRST THEOLOGIANS 641 Gillespie Thomas W., The First Theologians. A Study in Early Christian Prophecy, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (Michigan) 1994, XIV-286 pp., $ 24.99 Il volume è una revisione della tesi dottorale dell’A. fatta a distanza di più di vent’anni dalla sua elaborazione. Sicuramente valeva la pena ritornare sull’argomento che tratta il “carisma profetico” nel NT. L’A., un ministro della Chiesa presbiteriana negli USA, ha analizzato un fenomeno che non appartiene solo al passato ma entra a far parte del complesso delle esperienze di Dio e della percezione della realtà da parte di popoli e di loro singoli gruppi (cf. Foreword di M. Welker). Il piano dell’opera è nitido: dopo l’introduzione seguono sei capitoli che analizzano i testi paolini. Ad eccezione del cap. I (1Tess 5,20 e Rm 12,6), gli altri capitoli sono consacrati alla lettura della 1Cor: 12,1-3 (cap. II); 12,4-31a (cap. III); 14,1-10 (cap. IV); 2,6-16 (cap. V) e 15,1-51 (cap. VI). La conclusione presenta brevemente i risultati raggiunti. L’introduzione, abbastanza estesa (pp. 1-32), espone lo stato della ricerca sull’argomento. Il Gillespie riporta le considerazioni di vari studiosi e dalla lettura successiva si apprende che egli deve molto alla loro riflessione. In primo luogo l’A. sottolinea che l’interesse per il fenomeno profetico nella Chiesa antica fu suscitato dalla scoperta e della pubblicazione della Didaché. Sulla scia di Harnack, il Gillespie si occupa dei predicatori itineranti, e fra essi dei “profeti”. Essi appaiono come prescelti da Dio e perciò sua “voce” (pp. 2-4). Peccato che l’A. si fermi qui e tralasci altre testimonianze, le quali dimostrano che la Chiesa del I sec. ha goduto di un particolare carisma di apostoli e di profeti. Il Gillespie si interessa piuttosto delle questioni esegetiche sviluppate da R. Bultmann e E. Käsemann, che egli cerca poi di valutare e mettere nel contesto della ricerca condotta da altri studiosi. Emergono da questo quadro le posizioni di D. Aune che ha studiato il fenomeno del profetismo nel vasto panorama storico e culturale. L’argomento cruciale è quello del significato della diakrisis e diakrinein, ridotto piuttosto a quello di interpretare la rivelazione, che poteva presentare anche lati oscuri. Il nostro A. è più incline ad accettare la tesi di Müller, per il quale la profezia è un discorso chiaro ed univoco, le cui forme sono l’ammonizione, l’edificazione, i dati kerygmatici, ecc. Lo stesso favore si nota per le affermazioni di Hill che vede in S. Paolo il paladino del carisma profetico. Nello stesso tempo l’Apostolo cerca di purificare il dono dello Spirito dalle intemperanze e di dare ad esso un orientamento di insegnamento pastorale e morale. J.D.G. Dunn ha sottolineato che il processo del diakri÷nein doveva comprendere anche il momento della valutazione. Il Gillespie analizza, infine, la posizione di Dautzenberg che ha sostenuto, con ricchezza di argomentazioni, l’esistenza di una netta distinzione tra la profezia e il kerygma (pp. 28-31). Si profila così la linea seguita dall’A.: la profezia indica il carisma di una parola ispirata e illuminante. Il cap. I si occupa della relazione tra la profezia e la predicazione del 642 RECENSIONI Vangelo. In sostanza non si tratta soltanto dell’analisi di 1Tess 5,20 e Rm 12,6, come preannuncia il sottotitolo, ma delle due pericopi: 1Tess 5,19-22 e Rm 12,3-8. A giudizio del Gillespie l’atteggiamento diffidente e minimalistico dei tessalonicesi nei confronti dei carismi va integrato con la descrizione presentata in Rm. Secondo l’A., si deve considerare che per S. Paolo la profezia era una delle forme della proclamazione del Vangelo, facendo conoscere la volontà di Dio in ordine al mondo e al singolo credente (cf. G. Friedrich, “profh/thß ktl.”, GLNT 11, 634). Seguendo il metodo dell’analisi esegetica, l’A. cerca di individuare e esporre i problemi più importanti, pertinenti al fenomeno del profetismo, che sono evidenti nell’opera paolina. L’analisi appare molto ricca nella sua concisione e segue con molta accuratezza e penetrazione la storia dei principali vocaboli nonché delle nozioni che vi sono connesse. Così ben tre capitoli si occupano della testimonianza più celebre sulla manifestazione dei carismi, e in particolare della profezia, di 1Cor 12-14. Il Gillespie scorge il nesso tra la profezia e la confessione di fede (cap. II), analizza il fenomeno profetico alla luce dello “Spirito” (cap. III) e il parlare in lingue (cap. IV). Le riflessioni paoline sono considerate, sulla scia di Aune, “le più importanti fonti della nostra conoscenza riguardante la profezia cristiana del I secolo” (p. 65). Il cap. II si occupa di 1Cor 12,1-3. L’argomento principale dell’esposizione paolina va al di là della situazione contingente di Corinto, che richiedeva un suo intervento diretto, e si snoda in un discorso teologico più ampio. Le disposizioni per l’ordinata conduzione delle assemblee in cui si manifesta il dono della profezia sono di primaria importanza e qui Paolo è certamente erede della prassi normale delle Chiese giudeo-cristiane della Palestina. Le riflessioni di questa parte della trattazione del Gillespie si intrecciano con l’analisi di 1Cor 12,4-31a, fatta nel cap. III. L’A. ritiene che in questa pericope Paolo cominci a situare l’autentica profezia nel largo contesto della diversità di azioni dello Spirito e dimostra che per l’Apostolo la molteplicità dei carismi è una ricchezza da accogliere e valorizzare. Il cap. IV permette di entrare nel cuore delle regole paoline sull’uso dei carismi, di quello della profezia e glossolalia in particolare. S. Paolo dedica tutto il cap. 14 della 1Cor a fare l’elogio della glossolalia ed insieme purificarlo da intemperanze e usi non appropriati. L’Apostolo contrappone la profezia alla glossolalia, in polemica con la sopravvalutazione di questa presso la comunità di Corinto. A giudizio del Gillespie, questo atteggiamento dei corinzi è dovuto all’alta considerazione che i fenomeni estatici avevano nel mondo ellenistico. L’A. rileva bene che per l’Apostolo si tratta in fondo di uno dei tanti doni dello Spirito che opera nella Chiesa, edificando, esortando e incoraggiando i fedeli. In questa maniera si perfeziona ogni comunità cristiana. Nella tradizione testimoniata da Paolo la profezia implica la comunicazione di misteri divini che sono stati rivelati al profeta, elementi di una “sapienza” rivelata o “gnosi” delle cose nascoste. L’A. consacra a questa problematica il GILLESPIE THE FIRST THEOLOGIANS 643 cap. IV che mette al centro dell’attenzione 1Cor 2,6-16. La pericope analizzata conclude l’attacco paolino contro un certo tipo “della sapienza di parole” (p. 166). L’argomento della 1Cor 1,18-2,5 si esprime nelle antitesi: sapienza/follia e potenza/debolezza, sapienza/potenza e follia/debolezza. La sapienza che fa riferimento al Cristo crocifisso è distinta da qualunque sapienza di tipo puramente umano, ossia “sapienza verbale”, come quella attribuita da Paolo ai corinzi. Le considerazioni sulla rivelazione del Vangelo e sul Vangelo profetico di S. Paolo intendono offrire alcuni spunti per giustificare il ruolo della continua costruzione della Chiesa tramite la proclamazione del Vangelo e l’interpretazione dell’opera redentiva di Cristo. Però per l’A. un posto eminente spetta alla “rivelazione”, perché “nella sapienza apocalittica si trova l’origine della teologia cristiana” (l’opinione di Niederwimmer riportata a p. 197). Nel cap. V il carisma profetico è collegato con il kerygma. La riflessione si basa su 1Cor 15,1-51 e cerca di vedere in questa pericope l’esempio della “predicazione profetica”. I pregi dell’opera del Gillespie non sono pochi. Attraverso l’analisi da lui condotta si può costatare che la diffusione del carisma tra i membri delle comunità cristiane ha provocato la specificazione del ruolo dei “profeti” e la loro sottomissione alle norme pratiche e disciplinari. Nello studio abbonda l’analisi grammaticale e lessicale dei testi scritturistici. Essa però viene fatta in un modo “discorsivo”, che talvolta appesantisce in modo eccessivo la trattazione. Molto illuminanti sono le conclusioni alla fine di ogni capitolo. Tra le imperfezioni formali rileviamo soltanto che l’intestazione del cap. IV (“Prophecy and Tongues”) nella sua forma (“Prophecy and the Gospel”) sembra poco appropriata. Nell’ampia bibliografia si nota la palese assenza dei titoli in lingue neolatine. L’A. solleva, anche se di passaggio, la questione del profetismo femminile (p. 67, nota 9). Sicuramente il fenomeno non è da escludere, ma neppure da cercare dove esso non sia accertato. Benché il carisma fosse comune a uomini e donne, a queste tuttavia l’Apostolo ne vieta l’esercizio nelle assemblee (cf. 1Cor 14,34). Pur considerando che il passaggio dal concetto neotestamentario del carisma profetico allo sviluppo successivo è fluido e graduale, si può ammettere che la descrizione del fenomeno, come appare in S. Paolo e negli scritti dei Padri Apostolici (Didache, Pastore di Erma), non è differente da quella che risulta dalle fonti successive. Ne è testimone Ireneo: “Noi abbiamo inteso molti fratelli nella Chiesa che avevano dei carismi profetici, parlavano mediante lo spirito in ogni lingua, manifestavano i segreti dei cuori per l’utilità (comune)” (Adv. Haer. V,6,1: SC 153, 7475). Non di rado si sostiene che “il montanismo fu l’ultimo grande bagliore del profetismo nella Chiesa” (Friedrich, “profh/thß”, 652). La reazione antimontanista non era però anti-carismatica, ma dimostrò una comune tendenza a non lasciare tutto alla spontaneità o agli entusiasmi apocalittici. Tuttavia, il carisma profetico persiste nella “grande Chiesa” anche successivamente. Un luogo privile- 644 RECENSIONI giato della sua presenza è la vita monastica. Ogni monaco, in qualche maniera, poteva ritenersi successore o seguace dei profeti biblici. Nell’agiografia monastica si incontra perciò questo carisma in modo particolarmente vitale, dato che le eminenti figure del monachesimo venivano chiamate “profeti”. Nella tradizione orientale questo appellativo viene unito al nome dei grandi direttori spirituali. Dire che qui si è lontani dal NT è affermare una cosa ovvia. Però la storia della Chiesa rivela che il carisma di coloro che “parlavano nel nome di Dio” è utilizzato nella difesa della fede, chiamato in causa nella vita interna delle comunità e nella formazione spirituale. Questo percorso invita a non assolutizzare nessuna delle forme di manifestazione dello Spirito che “ha parlato per mezzo dei profeti”, ma cercare quelle che aiutano nell’oggi a condurre una vita “secondo lo Spirito”. Mieczysław Celestyn Paczkowski, ofm Puech Émile, La croyance des Esséniens en la vie future: immortalité, résurrection, vie éternelle? Histoire d’une croyance dans le Judaïsme ancien. I. La Résurrection des mort et le contexte scripturaire; II. Les données qumraniennes et classiques, Paris 1993, XVIII-956 pp., 560 FF Due tomi per un totale di quasi 1000 pagine! Il primo volume di carattere sintetico-teologico tratta dei dati biblici che affrontano l’argomento e cerca di arrivare ad una conclusione generale che permetta di dare un punto di partenza per il secondo volume di carattere storico-epigrafico, i dati riguardanti Qumran per l’appunto. Il primo tomo è una sintesi dei dati ricavabili dalla S. Scrittura, dai libri apocrifi e dal contesto religioso giudaico. Nella parte dedicata ai dati scritturistici l’A. riporta e commenta brevemente i brani scritturistici che hanno una qualche relazione con la vita futura sia quelli più vaghi, come ad es. Os 6,1-3 e Ez 37,114, sia quelli più pertinenti, come 2 Maccabei. Il senso di questo capitolo è che “la fede nella risurrezione dei giusti si va precisando e affinando a partire dal terzo secolo a. C. in certe correnti del giudaismo” (p. 98). Nella letteratura apocrifa il contorno del problema assume toni più chiari. Si passa da una visione spirituale della vita futura ad una visione più concreta (= risurrezione della carne, soprattutto in 1 Henoch), per esprimerci con termini teologici presi dal cristianesimo: esistenza di una vita dopo la morte, esistenza di un oltretomba molto simile al purgatorio, a volte comune per giusti ed empi, a cui segue il paradiso o l’inferno (ma la beatitudine o la sofferenza dell’oltretomba cominciano già prima del giudizio), risurrezione dei soli giusti (questo tema è abbastanza chiaro), giudizio giusto di Dio, riunione di anima e corpo per il giudizio… Alla fine di questo capitolo ci sono alcune interessanti pagine (182-199) dedicate alle iscrizioni e ai monumenti funerari dove viene affrontato anche il problema dei giudeo-cristiani. Peccato che l’A., che mostra di avere idee ben chiare al riguardo, non abbia COMM. BIBL PONT. L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS L’ÉGLISE 645 approfondito ulteriormente il suo punto di vista. Il terzo capitolo è dedicato all’atteggiamento dei partiti religiosi ebraici (sadducei e farisei) e del NT verso la vita futura, a cui seguono 2 brevi excursus sui samaritani e sui Padri apostolici. Segue una conclusione dettagliata a tutto il volume, prima una sintesi analitica dei vari testi / problemi presi in esame (pp. 303-316), poi una sintesi teologica (anche se l’opera non si prefigge questo scopo) in cui l’A. mostra come l’idea della vita futura si sia sviluppata nella mente del pio israelita (pp. 316-323). Il genere comune a tutta questa prima parte è la sintesi, anche se non mancano tratti di analisi. L’A. segue alcune linee-guida (ad es. Cavallin e Nickelsburg), autori che hanno affrontato il problema prima di lui. Ci meraviglia la mancanza in bibliografia del volume Risorgeremo, ma come? Risurrezione dei corpi, degli spiriti o dell’uomo? Per un contributo allo studio della speculazione apocalittica in epoca greco-romana: II sec. a. C. - II sec. d. C. di Cesare Marcheselli-Casale (Bologna 1988) che tratta dello stesso argomento. Il II volume, dedicato a Qumran, si trasforma in un’antologia di epigrafia, paleografia e storia. L’A. studia vari testi, alcuni dei quali inediti, per vedere in che relazione stiano con i dati raccolti nel I volume. Viene ripercorso nei testi di Qumran tutto il cammino già affrontato nel primo volume con i testi biblici e apocrifi. La conclusione generale è che la fede degli Esseni nella vita futura non si fermava all’affermazione dell’immortalità dell’anima, ma professava la risurrezione della carne (dei soli esseni giusti ovviamente), non un semplice ritorno alla vita precedente, ma una risurrezione gloriosa che comportava una nuova creazione dell’uomo (come in certi testi di S. Paolo). Dopo la sintesi teologica del primo volume sarebbe bastato, forse, riportare quei pochi testi che potevano comportare un contributo diretto alla comprensione del problema. Invece viene ripercorso tutto il cammino con la conseguenza di appesantire non poco lo svolgimento della composizione. Infatti, i testi qumranici che trattano esplicitamente della vita futura sono relativamente pochi e i dati più espliciti sembrano venire dall’esterno della comunità. Inoltre la ricostruzione di testi molto frammentari ha valore relativo come le teorie che potrebbero basarsi su tali ricostruzioni. Non possiamo che raccomandare molta prudenza nella ricostruzione delle epigrafi. E’ meglio un testo mutilo che una ricostruzione azzardata. Quest’opera è una miniera dove, chi voglia approfondire un qualche aspetto riguardante la vita e la fede della comunità, potrà trovare numerosi e utili spunti per approfondire la sua ricerca. Massimo Pazzini, ofm Commission Biblique Pontificale, L’interprétation de la Bible dans l’Église, Les Éditions du Cerf, Paris 1994, XXIII-129 pp., 45 FF Non è stato casuale che il nuovo documento della Pontificia Commissione Biblica sull’interpretazione della Bibbia abbia visto la luce in concomitanza con 646 RECENSIONI due date importanti: il centenario dell’enciclica Providentissimus Deus di Leone XIII (18.11.1893) e il cinquantenario dell’enciclica Divino afflante Spiritu di Pio XII (30.9.1943). Infatti, i due scritti pontifici, entrambi consacrati alle questioni bibliche, segnarono le tappe cruciali dell’evoluzione delle scienze bibliche nel campo dell’esegesi cattolica. Con un proprio contributo, il documento della Commissione Biblica ha voluto proseguire in questa linea. L’introduzione del volume che presentiamo, redatta dal P. Jean-Luc Vesco o.p., membro della Pontificia Commissione Biblica, avvia alla lettura del documento, facendone vedere gli antecedenti storici e descrivendo brevemente il suo contenuto. Il documento L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (il testo è riportato alle pp. 23-119) si prefigge, come scopo primario, di rispondere ai bisogni del tempo e di chiarire una situazione nel campo esegetico diventata assai confusa, indicando nel contempo le vie che “conviene intraprendere al fine di arrivare ad una interpretazione della Bibbia che sia tanto fedele quanto possibile al suo carattere umano-divino” (p. 26; questa e le successive traduzioni dei testi sono mie). Non si ha la pretesa di esaminare tutte le questioni bibliche, ma unicamente i metodi esegetici in grado di contribuire alla migliore conoscenza del testo sacro. Il contenuto del documento è ormai abbastanza noto per cui, dopo averne brevemente ricordato le linee fondamentali (per un ampio commento rinvio a J.A. Fitzmyer, The Biblical Commission’s Document “The Interpretation of the Bible in the Church”. Text and Commentary, Roma 1995), mi soffermerò su qualche aspetto per metterne in evidenza l’importanza. Nella I parte, “Metodi e approcci per l’interpretazione”, viene fatta una breve descrizione di vari metodi scientifici (il metodo storico-critico; i metodi letterari: analisi retorica, narrativa, semiotica) e approcci interpretativi (basati sulla tradizione; scienze umane: sociologia, antropologia culturale, psicologia e psicoanalisi; legati al contesto: liberazionista, femminista). La presentazione di ciascun metodo è accompagnata dalle indicazioni sulle loro possibilità e i loro limiti. La II parte si occupa di alcune “Questioni d’ermeneutica” biblica. In primo luogo, si prende in esame l’incidenza che esercita la contemporanea ermeneutica filosofica sull’interpretazione dei testi biblici. In secondo luogo, vengono dati alcuni principi generali sui tre sensi tradizionali della S. Scrittura: letterale, spirituale, pieno. La III parte è intitolata “Dimensioni caratteristiche dell’interpretazione cattolica”. Qui viene messo in evidenza il carattere proprio dell’esegesi cattolica, la quale si ispira e segue l’interpretazione del testo sacro fatta dalla tradizione biblica e da quella ecclesiale. In seguito ci si sofferma sull’opera e sui compiti dell’esegeta cattolico ed infine sui rapporti che legano la scienza biblica con le altre discipline teologiche. Nella IV ed ultima parte, “Interpretazione della Bibbia nella vita della Chiesa”, viene mostrato l’impatto dell’interpretazione biblica sulla vita eccle- COMM. BIBL PONT. L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS L’ÉGLISE 647 siale. L’analisi scientifica non è fine a se stessa, ma è chiamata ad incarnare il messaggio biblico in forme pratiche di attualizzazione, inculturazione e nei diversi impieghi del testo ispirato (la liturgia, la “lectio divina”, il ministero pastorale, l’ecumenismo). Il documento termina con una “Conclusione” in cui si sottolinea la funzione indispensabile svolta dall’esegesi biblica e il ruolo primario, benché non esclusivo, del metodo storico-critico. L’approccio diacronico, favorito nel documento, non vuol dire comunque una pretesa di monopolio; la coscienza dei propri limiti deve spingere i fautori del metodo storico-critico a procedere anche alle ricerche sincroniche sul testo sacro. Nel solenne discorso (riportato alle pp. 3-16 del volume), pronunciato in occasione della pubblicazione del documento (23.4.1993), Giovanni Paolo II si è soffermato anzitutto sul contenuto e sui valori delle due encicliche papali. Al di là del loro valore intrinseco, le nuove prospettive e i vari cambiamenti di situazione hanno richiesto – rileva il Pontefice – di riprendere e approfondire le problematiche del passato e soprattutto quelle attuali. A giudizio del Papa, nel documento della Pontificia Commissione Biblica “quello che colpisce a prima vista è l’apertura di spirito nella quale esso è concepito. I metodi, gli approcci e le letture praticate oggi nell’esegesi vengono esaminati e, nonostante alcune riserve – a volte gravi – che è necessario esprimere, viene ammessa la presenza, in quasi ognuno di essi, di elementi validi per un’interpretazione integrale del testo biblico. […] Un altro tratto caratteristico di questa sintesi è il suo equilibrio e la sua moderazione. Nell’interpretazione della Bibbia, essa è capace di armonizzare la diacronia e la sincronia, riconoscendo che le due si completano a vicenda e sono indispensabili per far uscire tutta la verità del testo e per soddisfare alle legittime esigenze del lettore moderno” (nn. 13.14). Le caratteristiche sottolineate dal Papa, ossia l’apertura ai nuovi orizzonti e l’equilibrio di valutazione, sono confacenti non soltanto al documento in questione, ma anche alle parole dell’allocuzione pontificia in cui le incoraggianti espressioni positive superano di gran lunga quelle di un comprensivo riserbo sulla presunta impeccabilità dei metodi biblici di studio, non escluso il metodo storico-critico. Tra il discorso papale e il documento esiste una perfetta sintonia di lettera e di spirito. Questa impressione è condivisa anche dai critici che hanno riservato al documento un’accoglienza eminentemente positiva, valga per tutti ad es. J. Kremer, “Die Interpretation der Bibel in der Kirche: Marginalien zum neuesten Dokument der Päpstlichen Bibelkommission”, Stimmen der Zeit 213 (1994) 151-166. Rispetto alle due encicliche precedenti e agli interventi di un passato non molto lontano della Pontificia Commissione Biblica, il nuovo documento si distingue, quanto al contenuto, per l’assenza di una prospettiva apologetico-polemica e quindi puramente difensiva, e quanto allo stile, per la rinuncia al tono impositivo. I tempi sono ormai cambiati e la protezione dell’interpretazione cattolica della Bibbia non deve necessariamente basarsi sulle direttive di stu- 648 RECENSIONI dio e di ricerca imposte in forma apodittica dal Magistero della Chiesa. Va ricordato che i documenti della Commissione Biblica godevano fino a poco tempo fa della stessa autorità dei decreti dottrinali delle congregazioni romane. Commentando questo significativo cambio di tendenza, H.-J. Klauck paragona la nuova condotta del Magistero nei confronti della scienza biblica alla restituzione della libertà agli schiavi ebrei, richiesta nell’anno giubilare [cf. “Alle Jubeljahre. Zum neuen Dokument der Päpstlichen Bibelkommission”, Biblische Zeitschrift 39 (1995) 1-27 qui 1]. Se, quindi, l’enciclica Providentissimus Deus ha iniziato un nuovo periodo quanto all’atteggiamento della Chiesa verso la Bibbia, altrettanto possiamo dire dell’ultimo documento. Dopo il Vaticano II (Lumen gentium) e la riscoperta dell’ecclesiologia di comunione, i rapporti tra esegesi scientifica e Magistero sono mutati profondamente, liberati da sospetti e pregiudizi. Per uno sguardo sull’evoluzione storica del rapporto esegesi/Magistero sarà utile vedere le relazioni di M. Gilbert e A. Vanhoye, raccolte in P. Laghi – M. Gilbert – A. Vanhoye, Chiesa e Sacra Scrittura. Un secolo di magistero ecclesiastico e studi biblici, Roma 1994. Oggi il Magistero preferisce affidarsi nella materia biblica alla competenza e all’autorevolezza di un gruppo internazionale di esperti nell’esercizio del suo compito di custodire l’integrità della Parola di Dio. Non è un caso che l’attuale Pontefice, pur così abituato a ricorrere alle encicliche per dirimere numerose questioni della vita ecclesiale, abbia preferito di usufruire, nelle questioni bibliche, del contributo di esperti studiosi e ha preso atto del dibattito in corso e anzi lo ha incoraggiato. E’ un chiaro segno di apertura e di comunione ecclesiale, un “cambiamento di rotta” [così L. Ruppert, “Neue Impulse aus Rom für die Bibelauslegung. Zum neuesten Dokument der Päpstlichen Bibelkommission”, Bibel und Kirche 49 (1994) 202-213 qui 203: “Kursänderung”], ma anche un riconoscimento reso ai biblisti per il continuo sforzo versato da essi nell’interpretazione della Scrittura. Riconoscere questa novità significa tuttavia, per gli studiosi della Bibbia, una maggiore presa di coscienza e di corresponsabilità che grava sul loro operato. Nel discorso pronunciato in occasione della presentazione del documento, Giovanni Paolo II ricorda l’importanza di due aspetti che nello studio biblico non devono essere mai trascurati. Si tratta di cose già note, e almeno in parte contenute nelle due encicliche bibliche antecedenti, ma il richiamo papale vuole ridare ad esse forza e significato. Il primo aspetto riguarda l’analogia della Scrittura con il mistero dell’Incarnazione. La Scrittura segue da vicino la legge dell’Incarnazione in cui il divino e l’umano formano un unico mistero, distinto ed inseparabile. Di conseguenza, la ricerca biblica non deve ridursi ad un’esegesi fondamentalista di tipo spirituale-mistico che sfigura il testo biblico e spoglia pericolosamente la Rivelazione della sua dimensione incarnazionisticostorica, ma è chiamata anche a scrutare il volto materiale della Parola, con l’aiuto del metodo storico-critico e di altri approcci descritti nel documento della Commissione Biblica [cf. il commento di F. Raurell, “El método histórico- COMM. BIBL PONT. L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS L’ÉGLISE 649 crítico frente a las lecturas fundamentalistas e integristas de la Bíblia”, Laurentianum 35 (1994) 273-318]. D’altra parte sarebbe nociva una ricerca che si limitasse unicamente al volto umano dei testi biblici, dimenticando la finalità primaria della Parola di Dio: la crescita nella fede e nell’amore di Dio. “La Chiesa di Cristo – scrive Giovanni Paolo II – prende sul serio il realismo dell’Incarnazione e per questo motivo attribuisce una grande importanza allo studio storico-critico della Bibbia. […] E’ senz’altro necessario che l’esegeta stesso percepisca nei testi la parola divina, ma ciò non gli sarà possibile realizzare senza che il suo lavoro intellettuale venga sostenuto da un fervore spirituale. Privata di questo sostegno, la ricerca esegetica rimane incompleta; perde di vista la sua finalità principale e si confina nei compiti secondari” (nn. 7.9). Un altro aspetto ricordato dal Pontefice riguarda la funzione ecclesiale del biblista. La fedeltà alla Chiesa esprime ed assicura una giusta orientazione dell’esegesi cattolica. In concreto, ciò vuol dire svolgere un umile servizio con e a beneficio della Chiesa. “L’esegeta cattolico non deve nutrire un’illusione individualistica che porta a credere che, al di fuori della comunità dei credenti, si può comprendere meglio i testi biblici. E’ vero proprio il contrario, dal momento che questi testi non sono stati consegnati ai singoli studiosi … ma alla comunità dei credenti, alla Chiesa di Cristo, per nutrire la fede e guidare la vita della carità” (n. 10; cf. pp. 11-12). In secondo luogo, la natura ecclesiale del biblista richiede da lui il rispetto e la filiale sottomissione alla Chiesa, in quanto legittima custode e sicuro garante della Parola di Dio e della sua interpretazione. “Essere fedeli alla Chiesa significa, in effetti, situarsi decisamente nella corrente della grande Tradizione che, sotto la guida del Magistero, assicurato da una speciale assistenza dello Spirito Santo, ha riconosciuto gli scritti canonici come parola indirizzata da Dio al suo popolo e non ha mai smesso di meditarli e scoprire in essi le insondabili ricchezze” (n. 10; cf. p. 12). I due aspetti, ricordati dal Papa, sono fondamentali e non stupisce pertanto che anche il documento della Pontificia Commissione Biblica dedichi, esattamente nella III e nella IV parte, un ampio spazio a questi punti nodali su cui si regge e da cui dipende il pieno successo dell’esegesi biblica. Alla fine di questa presentazione, non sarà superfluo fare ancora una piccola osservazione sulla natura del documento biblico. Dicevamo sopra che negli ultimi tempi l’atteggiamento della Chiesa, quanto al modo d’indicare ai cattolici un giusto comportamento nel dirimere questioni bibliche, ha subito un notevole cambiamento, di cui il presente documento è una chiara dimostrazione. Qual è allora il valore del documento, se esso non ha più – come una volta – la forma di un decreto della Chiesa? Se, in via di principio, esso non esige un assenso interiore né una sottomissione esterna, il suo valore va ridotto unicamente al carattere informativo? Il cardinale J. Ratzinger, nella prefazione al documento, precisa che la Pontificia Commissione Biblica (creata da Leone XIII il 30.10.1902) non è più un organo magisteriale composto di cardinali (con il Motu proprio Sedula cura del 1971 Paolo VI ha cambiato la sua com- 650 RECENSIONI posizione e le sue funzioni), bensì una commissione di consulenza formata da qualificati specialisti in scienze bibliche, chiamati a prendere una posizione sui problemi essenziali dell’interpretazione della S. Scrittura e che in quest’opera sanno di poter contare sulla fiducia da parte del Magistero. L’insistenza nel voler sottolineare questo fatto sembra intenzionale. Invero, anche se il documento non va considerato come “magisteriale” nel senso stretto del termine, tuttavia l’autorevole avallo del Magistero, visibile già nella persona del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede in qualità di presidente della Commissione stessa, gli conferisce una tale forza da poter richiedere, soprattutto dagli esegeti e dagli insegnanti cattolici, più che una mera attenzione. E’ una precisazione, ci sembra, tutt’altro che marginale. Lesław Daniel Chrupcała, ofm Vesco Jean Luc (a cura di), Cent’anni di esegesi. I. L’Antico Testamento. L’École Biblique di Gerusalemme (ABI. Supplementi alla Rivista Biblica 25), Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, 211 pp., L. 26.000 I due volumi, uno per l’AT e uno per il NT, coi quali l’École biblique ha voluto commemorare i suoi primi cent’anni di vita, sono usciti nell’edizione originale nel 1990. Questa traduzione italiana è presentata da G. Ghiberti, allora Presidente dell’Associazione Biblica Italiana e, naturalmente, dal curatore. Il I vol., che qui presentiamo, è diviso in quattro parti: L’ambiente biblico, La storia, I libri dell’AT e l’Intertestamento. Per il II vol. si veda più avanti. Nella prima parte abbiamo quattro capitoli: sulla Geografia (pp. 15-24: J. Murphy-O’Connor), l’Etnografia (pp. 25-33: J.M. de Tarragon), l’Assiriologia (pp. 35-41: R.J. Tournay) e la Filologia semitica (pp. 43-50: J.M. de Tarragon). La Storia è divisa in due capitoli: Prima (pp. 53-66: J.M. de Tarragon) e Dopo l’esilio (pp. 67-80: É. Nodet). Tre sono i capitoli per l’AT: il VII è dedicato al Pentateuco (pp. 83-116: J. Loza); l’VIII ai Profeti (pp. 117-147: F.J. Gonçalves) e il IX ai libri poetici e sapienziali (pp. 149-186: R.J. Tournay, ma per Sap: G.J. Norton). Tre brevi capitoli son dedicati all’Intertestamento: il X al Giudaismo (pp. 189-91: di Murphy-O’Connor, Norton e Puech), l’XI a Qumran (pp. 193-203: É. Puech) e l’ultimo a Giuseppe Flavio (pp. 205-207: É. Nodet). L’indice (pp. 209211) chiude il volume. Il libro si legge con interesse, perché non è solo un riassunto dell’attività scientifica della famosa scuola biblica domenicana di Gerusalemme, specialmente del pioniere iniziale, padre Lagrange, ma anche un aggiornamento sui principali problemi biblici attuali. Sarebbe stato opportuno un indice degli autori. Inoltre i capitoli non sono sempre uniformi. Nelle pp. 71-80 sull’epoca postesilica, per es., sembrano mescolati il MURPHY-O’CONNOR CENT’ANNI DI ESEGESI 651 pensiero di Lagrange e quello dell’autore del capitolo. Il cap. X è troppo lacunoso. E, purtroppo, manca la rassegna sui profeti “anteriori”, cioè sui libri Gios-Re. La traduzione è buona. Gli errori che facciamo presenti sono, a volte, anche nell’originale: a p. 41, nel testo e in nota Vuk e non Vink; p. 112, l.4/5 “parenesi” e non “parentisi”. Altri sono propri della traduzione : p. 50 Baruch Levine è un autore solo; a p. 160 si deve tradurre “rinviare a dopo…” non “rifiutare”. Segnaliamo anche qualche errore propriamente tipografico, come a p. 167, nota 54, o a p. 181, per la trascrizione di parole egiziane. L’inconveniente più grave nasce a p. 110, dove nel testo italiano viene inserita una nota, la 98, che fa spostare la successiva numerazione delle altre, che, per di più, alla fine, risultano sbagliate: infatti, le opere citate alle note 122 e 124s sono di Loza e non di Vesco. Enzo Cortese Murphy-O’Connor Jérôme (a cura di), Cent’anni di esegesi. II. Il Nuovo Testamento. L’École Biblique di Gerusalemme (ABI. Supplementi alla Rivista Biblica 26), Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, 233 pp., L. 28.000 Anche il pubblico italiano, grazie a questa traduzione che esce a distanza di due anni dall’originale francese, può prendere ora più ampia conoscenza dell’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem ed ammirare i grandi meriti di questo rinomato centro di studi biblici nei cent’anni della sua esistenza (1890-1990). Un secolo di storia che meritava non solo di essere celebrato ma, giustamente, anche descritto. Il volume è dedicato alle ricerche riguardanti il Nuovo Testamento e segue da vicino quello precedente relativo all’Antico Testamento. L’evoluzione della Scuola Biblica nel campo neotestamentario viene presentata negli otto capitoli del libro. Il primo, a modo di introduzione, traccia uno schizzo degli umili inizi della Scuola, mentre l’ultimo cerca di evidenziare in che cosa consiste il carattere proprio dell’École. Nei rimanenti capitoli vengono messi in luce i momenti principali della Scuola Biblica legati alle diverse figure di illustri professori: M.-J. Lagrange, P. Benoit, M.-É. Boismard, J. MurphyO’Connor, F.-P. Dreyfus, B.T. Viviano, J. Taylor. La parte finale del libro contiene le bibliografie degli autori citati; le loro pubblicazioni (limitate al NT) sono disposte in ordine cronologico e comprendono le liste di libri, articoli e una scelta di recensioni. Raccogliere in un unico volume cent’anni di esegesi neotestamentaria della Scuola Biblica di Gerusalemme non è stato certamente un compito facile. A maggior ragione, quindi, merita plauso il lavoro svolto dal curatore dell’opera, Murphy-O’Connor che non si è limitato a riunire insieme le schede biobibliografiche dei grandi maestri, ma a partire dai loro ritratti ha saputo descrive- 652 RECENSIONI re con competente equilibrio il periodo cruciale degli studi biblici condotti nell’ambito cattolico. La presentazione dei singoli autori si concentra sull’influsso che questi hanno avuto nei determinati campi della ricerca biblica. I loro studi vengono sintetizzati con concisione e chiarezza, ma anche – ed è la cosa più interessante – collocati in un preciso contesto storico e, legato ad esso, clima scientifico. Ciò permette al lettore di prendere familiarità con le varie problematiche, tipo l’ispirazione della Sacra Scrittura, l’approccio storico-critico al testo sacro, il cristianesimo primitivo, i manoscritti di Qumran. Oggi questi temi sono entrati ormai a pieno titolo nell’esegesi cattolica, ma perché ciò avvenisse, ci è voluto – soprattutto nel periodo antecedente al concilio Vaticano II – coraggio, pazienza e umiltà scientifica. In questa opera i docenti della Scuola Biblica di Gerusalemme hanno contribuito in maniera considerevole. Non rimane che sperare che i prossimi cent’anni di questo stimato centro di ricerche bibliche portino dei frutti altrettanto abbondanti. Lesław Daniel Chrupcała, ofm Contreras Enrique - Peña Roberto, Introducción al estudio de los Padres. Periodo pre-niceno, Editorial Monasterio Trapense de Azul, Azul (B) 1991, XXX-325 pp. Il volume non pretende in alcun modo – secondo le parole del prof. L. Glinka – di sostituire i manuali di patrologia che sono diventati ormai dei classici: Altaner e Quasten. Non si può negare però che la Introducción al estudio de los Padres risulta una comoda guida allo studio dei Padri. Gli autori hanno inteso offrire una lettura dei Padri fatta “con il cuore” e acuire l’appetito dei lettori, suscitando il desiderio di una maggiore conoscenza della letteratura patristica. Il tutto è condensato in 325 pagine. Si tratta di un’opera che renderà grande servizio agli studenti di teologia di lingua spagnola, ma anche a chiunque abbia bisogno di avere sottomano una trattazione sintetica e pienamente affidabile su personaggi, fatti, basi culturali e linee di riflessione teologica dell’età patristica. L’opera tiene conto dei manuali di patrologia disponibili e di molti sussidi. Probabilmente per questo motivo, chi non è digiuno di studi patristici troverà l’esposizione ripetitiva e avrà impressione del “già visto e letto”. Questi lettori sapranno però apprezzare gli scorci sulla letteratura patristica che offrono i brani delle opere dei singoli Padri riportati per esteso a titolo illustrativo e di compendio. Inoltre, offrendo le nozioni di base, gli AA. segnalano i principali stimoli che la teologia di oggi può ricevere dallo studio dei Padri. L’importanza dello studio dei primi scrittori e teologi della Chiesa è presentata attraverso i documenti della Chiesa. Tale studio “serve per una migliore CONTRERAS - PEÑA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS PADRES 653 maturazione intellettuale e spirituale degli studenti di teologia, affinché possano diventare pastori di anime adeguatamente preparati” (Congregazione per l’Educazione cattolica, Lo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale. Istruzione, Bologna 1990, 3). Appare chiaro che la riflessione teologica non ha mai perso di vista il valore del Padri della Chiesa. La teologia del passato li poneva tra le autorità (auctoritates), accanto alla Bibbia e al magistero della Chiesa. Però anche oggi, quando si nota il “ritorno” alle fonti, che ha caratterizzato l’opera dei teologi più illustri, si è indotti a guardare con molta attenzione ai Padri. Essi non sono considerati solo come le fonti di frammentarie conferme di determinate tesi, ma sono percepiti come un “fermento” per la riflessione teologica di tutti i tempi. Rendendosi conto che il quadro in cui si muove lo studio dell’antica letteratura cristiana è ampio e complesso, i nostri due AA. non esitano a corredare la loro trattazione con materiale illustrativo: schemi grafici, tabelle e sinossi cronologiche. I nove capitoli offrono una trattazione assai rapida del periodo patristico preniceno. Essi sono preceduti dall’introduzione che fa una panoramica sulla vita della Chiesa del periodo preniceno. Di carattere introduttivo è anche il cap. I che si ferma sul concetto del “Padre della Chiesa”, patrologia, patristica e letteratura cristiana antica. Nel cap. II vengono presentati i primi scritti cristiani (Padri Apostolici) e si passa in rassegna la produzione patristica del II secolo (cap. III). Il cap. IV presenta gli “scritti” minori di vario genere, come apocrifi, poesia e epigrafia cristiana, agiografia e le Costituzioni Apostoliche. Analizzando il complesso delle dottrine gnostiche, la trattazione si sofferma sulla figura emblematica di Ireneo in cui si fondono in maniera particolare i compiti di teologo e di difensore della retta fede (cap. V). La trattazione successiva aiuta ad accostarsi alle grandi figure dei Padri alessandrini, Origene in particolare (cap. VI). Altri Padri e scrittori ecclesiastici sono raggruppati per aree geografico-culturali: Siria, Palestina, Asia Minore (cap. VII), Roma (cap. VIII) e Africa (cap. IX). Particolare rilievo viene dato al pensiero dei Padri più significativi. Il volume è completato dalla bibliografia che dà preferenza ai titoli in lingua spagnola. Nonostante incontestabili pregi, nel volume si notano alcune mancanze: vi si costatano con facilità alcune “stranezze metodologiche”. A quanto pare, nella bibliografia, il de Aldama risulta “privilegiato”: i suoi nomi sono riportati per esteso e non abbreviati come quelli di tutti gli altri autori. E’ difficile abituarsi al sistema di riportare le note: alcune sono messe a pie’ di pagina, altre invece nel corpo del testo tra le parentesi. Il lettore si trova disorientato e infastidito. Per la comodità dei lettori e il bene degli studenti che consulteranno l’opera in questione, sarebbe stato più opportuno seguire un criterio uniforme, logico e più comune. Mieczysław Celestyn Paczkowski, ofm 654 RECENSIONI Goranson Stephen Craft, The Joseph of Tiberias Episode in Epiphanius: Studies in Jewish and Christian Relations, University Microfilms International, Ann Arbor (Michigan) 1992, 203 pp. Lo studio di S.C. Goranson, pur essendo una dissertazione di laurea non è la prima opera dell’A. che ha al suo attivo altre pubblicazioni. Difatti si scorge subito la sua esperienza nell’impostazione delle questioni e nella documentazione scientifica. L’indole dell’opera è tipica delle tesi di dottorato; nulla è trascurato: stato di ricerca sull’argomento, specificazione dell’oggetto, suddivisione della materia, bibliografia ricca e aggiornata. Dalle affermazioni dell’A. apprendiamo che la sua ricerca non è sorta a caso. Il Panarion 30, in passato ha attirato l’attenzione degli studiosi: si tratta infatti di un documento sul giudeo-cristianesimo palestinese nel IV sec. Oltre a questo fatto, l’A. stesso afferma che la persona di Giuseppe di Tiberiade lo ha interessato per una serie di ragioni. Dagli scavi di Sefforis, a cui egli ha preso parte in passato, risulta che non si è sicuri sulla data esatta dell’arrivo dei cristiani in quella località. L’altro interrogativo è se la prima chiesa scoperta a Sefforis fu opera di Giuseppe. Inoltre, non ci sono molti dati non equivoci sull’insediamento dei giudeo-cristiani a Sefforis (p. 7). Tuttavia lo studioso, attraverso la relazione di Epifanio nel Panarion, esamina il grande tema delle relazioni giudeo-cristiane in Palestina del IV sec. A questi problemi aggiunge la questione degli esseni che Epifanio annovera tra gli “eretici samaritani e giudei” (pp. 7-8). L’A. non si affida soltanto ai dati tramandati dalle fonti letterarie dirette, ma li legge, insieme ad altri documenti dell’antichità cristiana, con acume rifacendosi alle testimonianze archeologiche. Questa inquadratura è per lui una scelta metodologica cosciente e applicata con coerenza. Il piano dell’opera conferma che sul campo della ricerca concernente il “conte” di Tiberiade Goranson spazia con sicura autorevolezza in settori diversi e distanti. Dopo il capitolo di carattere introduttivo, egli esamina varie questioni legate con Giuseppe di Tiberiade sottoponendo a rigorosa verifica le notizie tramandate dalle fonti storico-letterarie e le ipotesi. Nell’introduzione Goranson fa un rapido ma denso esame dello “status quaestionis” sulle relazioni ebraico-cristiane in Galilea al IV sec.; passa poi ad una panoramica sulla figura di Giuseppe di Tiberiade e le prospettive che offre la ricerca su questo personaggio. Infine si occupa dei problemi e dell’opportunità di usare Epifanio come fonte. Il secondo capitolo ci avvicina alla relazione su Giuseppe di Tiberiade del Panarion con l’ambiente storico dell’opera. L’opera di Epifanio, come rivela il titolo stesso (Panarion: “Cassetta dei medicinali”), si propone come antidoto contro il veleno delle eresie. Più interessanti in questo complesso sono le informazioni, addotte anche di prima mano, e i testi degli autori precedenti che egli riporta. Si può intuire quindi il valore di questa opera monumentale, che GORANSON THE JOSEPH OF TIBERIAS EPISODE IN EPIPHANIUS 655 purtroppo non ha avuto molta fortuna in edizioni e traduzioni. Finora non esiste un’edizione critica dell’intera opera, ma solo edizioni parziali. Lo stesso vale per le traduzioni, tranne in russo (p. 48). L’A. si sofferma sull’edizione critica annunciata da Nautin che, a suo giudizio, contribuirà a risolvere non pochi problemi. Sullo sfondo della polemica antiereticale Epifanio delinea i tratti di Giuseppe, descrivendolo come convertito e promotore della “retta fede” (antiariana). I confronti cronologici permettono a Goranson di ritenere che la storia di Giuseppe narrata da Epifanio non è inventata di sana pianta. E’ doveroso riconoscere i modelli letterari presenti nella descrizione epifaniana del “conte” di Tiberiade, ma l’incontro tra questi due personaggi è molto plausibile. Il cap. terzo, il più esteso, si occupa del problema di Giuseppe quale costruttore di chiese. L’esposizione comincia con la questione della presenza cristiana nelle città di Galilea: per Epifanio, come per gli scrittori del III e IV sec., i cristiani erano di stirpe gentile. Tra di essi non venivano annoverati nazareni o ebioniti, i quali si ritenevano obbligati ad osservare le prescrizioni della legge mosaica e si imponevano la separazione dalle comunità cristiane di origine non ebraica. L’A. si occupa delle testimonianze riguardanti i “minim”, gli “ebioniti” e i “nazareni”. La relazione di Epifanio, che enumera nazareni e ebioniti fra le 80 altre sette, si ricollega alla presenza dei “minim” menzionati dalle fonti ebraiche. Goranson tralascia le testimonianze di Eusebio di Cesarea che nella Storia Ecclesiastica enfatizza la presenza dei giudeo-cristiani, ma sottolinea che la costruzione delle basiliche costantiniane ha avuto una grande ripercussione sulle sorti della Chiesa palestinese. Le considerazioni basate sulle scoperte archeologiche non sono molte, perché, come fa notare l’A., dal materiale trovato negli scavi non è possibile giudicare inequivocabilmente quale popolazione occupasse il sito. Neppure dagli elementi decorativi ritrovati si può fare la distinzione tra segni giudaici e cristiani. A proposito del tentativo di Giuseppe di costruire una chiesa nel luogo dell’“Hadrianeum” a Tiberiade, Goranson si ricollega alle considerazioni già attestate e conclude che il “conte” non è riuscito nel suo intento. Epifanio però tace su questo “fallimento” del protagonista del suo racconto. Parlando di Nazaret, l’A. mette in luce la presenza della comunità cristiana di ceppo giudaico. L’analisi delle testimonianze archeologiche non suscita problemi e Goranson si avvale dei risultati di scavi che hanno messo in evidenza, nel luogo di Annunciazione, una prima fase costruttiva con grotte cultuali, un battistero e “martyrium” e una seconda con la chiesa di tipo sinagogale. La questione della presunta sepoltura di Giuseppe di Tiberiade a Nazaret e della sua opera rimangono problemi aperti. Più problematica è la fondazione di una chiesa attribuita a Giuseppe a Cafarnao. Le intricate questioni vengono risolte localizzando la chiesa del “conte”, a Tabga, per controbilanciare il peso della “domus-ecclesia” di Cafarnao. L’A. sostiene anche l’opinione che bisogna forse cercare la chiesa costruita da Giu- 656 RECENSIONI seppe in un’altra zona della “città di Gesù”. Per Goranson quest’ultima supposizione è una “logica opzione” (p. 116). I nuovi scavi a Sefforis hanno permesso di dare un rinnovato indirizzo alla storia della diffusione del cristianesimo in Galilea. Dalla descrizione di Epifanio si apprende che Giuseppe completò la costruzione delle chiese a Sefforis (Diocesarea) e in alcuni altri luoghi. Goranson vede in questa relazione epifaniana segni che il conte di Tiberiade incontrò qui delle ostilità alla sua opera, come nella sua città natale. Le soluzioni dell’A. sono da ritenere nell’insieme plausibili, almeno allo stato attuale delle conoscenze in materia. Negli altri due capitoli (4 e 5) l’A. discute la questione di identificazione del “conte” di Tiberiade con gli altri personaggi oppure con l’autore del Hypomnêstikon. Tra le possibili identificazioni del “conte” di Tiberiade abbiamo un certo Rabbi Giuseppe menzionato nel Talmud Babilonese. Le tracce di una possibile identificazione sono più chiare a proposito di un certo Giusto di Sefforis, soprannominato “il sarto”. Pur non potendo attestare con certezza che sia lo stesso Giuseppe, l’A. cita un’iscrizione danneggiata di Sefforis dove appare il nome di un certo Ioustos agoranomos, concludendo che si tratta di una somiglianza negli incarichi dei due personaggi. Un’altra ipotesi di identificazione viene offerta dal Koch che presenta la figura di Yose (o Jose) da Ma Jon menzionato dal Talmud Palestinese. Goranson rileva però che tutta la faccenda si addice meglio alla questione dell’autorità dei “patriarchi” ebrei (nasi’) che non all’identificazione del “conte” di Tiberiade. In seguito, l’A. analizza, senza condividerla, l’identificazione della sepoltura di Giuseppe a Tabga proposta da Pixner. Le ultime considerazioni riguardano poi l’identità di Giuseppe, chiamato “Christianus”, al quale viene attribuito l’Hypomnêstikon. Goranson fa dei paragoni molti illuminanti tra alcune eresie descritte dall’Hypomnêstikon e quelle riportate nell’opera di Epifanio; ritiene molto probabile che l’autore dell’Hypomnêstikon sia da identificare con Giuseppe, con cui si è incontrato Epifanio di Salamina. Goranson conclude che l’intento di Giuseppe di costruire le chiese non ebbe molto successo; nonostante ciò, le vicende di questo personaggio sono entrate autorevolmente a far parte della storia cristiana della Galilea. In appendice viene riportata la traduzione inglese di Panarion 30,3,6-13,1 eseguita da F. Williams. Lo studio è corredato dalla ricca e aggiornata bibliografia che andrebbe divisa, almeno in “fonti” e “studi”. Sono da rilevare alcuni errori tipografici, soprattutto nelle trascrizioni in diverse lingue (pp. 114, 137, 175, 178). In conclusione, la monografia di Goranson è uno studio stimolante, non solo per le argomentazioni – valide e vagliate – ma soprattutto per il ricco materiale utile per chi si occupa delle testimonianze storiche, archeologiche e letterarie concernenti la storia del giudeo-cristianesimo e dei Luoghi Santi, inquadrato in una visione critica e scientifica rinnovata. Per questi motivi è auspicabile la pubblicazione dell’opera di Goranson nella forma di un libro, magari più curato e più BUX L’ODEGITRIA DELLA CATTEDRALE 657 accessibile agli studiosi. Mancano gli indici che senza dubbio accrescerebbero il valore dell’opera. Dalla pubblicazione della monografia sono passati ormai 4 anni. La bibliografia, quindi, richiederebbe qualche aggiornamento. Vogliamo segnalare il contributo di F. Manns, “Joseph de Tibériade, un judéo-chrétien du quatrième siècle”, in G.C. Bottini - L. Di Segni - E. Alliata (edd.), Christian Archaeology in the Holy Land. New Discoveries. Essays in Honour of Virgilio C. Corbo, Jerusalem 1990, 553-559. Il detto contributo studia il contesto letterario di Panarion 30,4-12, la struttura del testo e le sue fonti. Le notizie tramandate da Epifanio vengono paragonate con quelle degli altri autori cristiani e giudei. Invece per completare e attualizzare la sintesi sulla Chiesa “ex-circumcisione”, l’A. dovrebbe tener conto dell’articolo di C. Dauphin, “De l’Église de la circoncision à l’Église de la gentilité. Sur une nouvelle voie hors de l’impasse”, LA 43 (1993) 223-242, che mette a punto le recenti ricerche archeologico-storiche sui giudeo-cristiani. Mieczysław Celestyn Paczkowski, ofm Bux Nicola (a cura di), L’Odegitria della cattedrale. Storia, arte, culto (Per la storia della Chiesa di Bari, Studi e materiali 11), Edipuglia, Bari 1995, 161 pp., ill., L. 20.000 Basta guardare le vetrine delle librerie religiose in Europa per rendersi conto che da un po’ di tempo c’è abbondanza di studi sulle immagini sacre. Il primato spetta alle icone. Purtroppo la quantità non va sempre di pari passo con la qualità. Nella maggioranza dei casi non si tratta di impegnativi studi iconografici o di storia dell’arte, ma di volumetti a carattere piuttosto spirituale e devozionale, per i quali l’argomento “immagine sacra” o “icona” è solo un’attrattiva. Non mancano però gli studi di altro tipo: ben documentati, che fanno tesoro della storia materiale e formale, con una lettura iconografica ben fondata. L’attrattiva, in questi casi, consiste in una curata veste tipografica, e abbondanza di materiale illustrativo, perché i volumi di questo genere sono piuttosto poco digeribili per la grande cerchia dei lettori comuni. L’opera curata da N. Bux è da annoverare in quest’ultima categoria. Il volume, presentato da S. Palese e introdotto dallo stesso N. Bux, raccoglie contributi di vari specialisti, frutto di un seminario di studio; esso tratta nel modo più completo possibile, e perciò sotto diversi aspetti, l’immagine del dipinto su tavola dell’“Odegitria”, venerata nella cripta della cattedrale di Bari e recentemente restaurata (1992/94). Si tratta di un’immagine della Vergine del tutto particolare a motivo del suo culto e dei molteplici legami con la storia del popolo e della diocesi dove la sua devozione è molto diffusa. Apprendiamo che la terra di Bari non è solo “dominio di San Nicola”, ma cattedrali, varie chiese e parrocchie, cappelle, altari e luoghi di culto in genere, sono dedicati a Maria con i titoli più vari. 658 RECENSIONI Sicuramente il compito di descrivere l’importanza di detta icona nella vita della Chiesa particolare non era facile. Richiedeva di sottolineare non solo l’importanza data all’“Odegitria” come immagine di culto ma anche, e soprattutto, il valore di essa nel complesso della storia dell’arte. Per comprendere queste complesse vicende e la stessa storia dell’immagine mariana barese, è necessario il contributo della teologia. Don Bux lo fa notare già nell’introduzione che apre il libro. I primi contributi dell’opera che presentiamo sono rivolti a chiarire l’origine storica, le vicende artistiche e culturali della Madonna di Bari. Pina Belli d’Elia presenta una ipotesi sull’origine della icona mariana: il dipinto attuale è una replica di un’icona bizantina altomedievale. L’ipotesi avanzata dalla studiosa è documentata dai riferimenti alla storia dell’arte e dell’immagine della Vergine di Bari. Gli interessi storici dei lettori saranno sicuramente appagati dalle esposizioni di Clara Gelao e dall’appendice documentaria di Emma Lobalsamo. Nonostante ciò, la storia presentata è intessuta di “poche certezze… per lo più in negativo” ed è fatta “di domande destinate a rimanere senza risposta” (p. 35). La sintesi delle intricate vicende del dipinto è completata dalla breve descrizione di Fabrizio Voma e Maria Lucia Strada, che prende in considerazione vari ritocchi e restauri dell’immagine: da quelli settecenteschi e ottocenteschi a quello del 1932 e, infine, all’ultimo attuato negli anni 1992-1994. L’appendice documentaria curata da Gaetano Barracane completa questa esposizione. Le suddette considerazioni, nel loro insieme, ricostruiscono frammenti di storia passata. Non mancano neppure quelli della “storia più recente che sfugge ai libri e ai documenti” (p. 67). La Madonna di Bari ebbe la sua epopea ai limiti del leggendario. Ne è testimonianza la Translationis historia che ricorda la storia dell’icona dell’Odegitria. Delle fonti letterarie riguardanti la leggenda dell’immagine si occupano Giovanni Pinto e Rosa Lupoli. Il primo apre la via agli studi critici sulla questione. Più specificamente, la sua ricerca intende riaffermare, “attraverso l’esame della Translationis historia…, il carattere «apocrifo» del documento (= come pura invenzione) e nel contempo dimostrare che l’icona della Madonna di Costantinopoli, venerata nella cattedrale barese… non ha nulla a che vedere con l’Odegitria di Bisanzio” (pp. 74-75). L’intento, del tutto riuscito, non contesta e non intacca però la linfa della devozione mariana del popolo della terra di Bari. La Lupoli avvicina il lettore alla intricata questione del “confezionamento” del documento conosciuto come la Translationis historia. L’A. mostra chiaramente l’origine cinquecentesca della leggenda e il suo successivo ricupero settecentesco. Queste tappe vanno giudicate come “una svolta importante nella storia culturale della città” di Bari e del ricupero e valorizzazione delle tradizioni religiose più antiche. Nell’esposizione di Francesco Quarto viene dimostrato in modo convincente che nel Cinquecento esisteva il fenomeno dell’“importazione” del culto alla Madonna di Costantinopoli e la diffusione della devozione sotto varie forme. BUX L’ODEGITRIA DELLA CATTEDRALE 659 Segue un’appendice che riporta un breve tratto di un documento quale testimonianza sulla devozione alla Madonna di Costantinopoli. Esso ricorda che “non sono le tavole o le tele… ma solo la nostra viva fede che per mezzo delle Immagini di Maria antiche o recenti, ci ottiene dalla potentissima intercessione di Maria… li favori e le grazie” (p. 113). L’affermazione non ha perso niente della sua attualità pastorale. L’ipotesi dell’esistenza di un’antichissima immagine mariana e del suo culto è confermata dall’esame di alcuni sigilli in cera apposti alle pergamene medievali conservati nell’Archivio della Basilica di S. Nicola. Lo studio dei sigilli è stato condotto con competenza da Gerardo Cioffari che offre anche una rassegna biografica dei vescovi baresi dal 1078 al 1225. L’ultimo contributo riguarda la liturgia dell’Odegitria nel calendario barese, vista nel contesto di culto locale e teologia bizantina. Poche pagine riassumono bene che il culto mariano in terra di Bari è una costante che ha acquistato la sua originalità in un equilibrio tra la teologia orientale e la devozione popolare. Tutto questo sfocia nelle linee teologiche e spirituali del “proprio” per la celebrazione liturgica della Madonna Odegitria. Per facilitare la consultazione, l’opera è stata corredata da un indice dei nomi di persona e di luogo. Il libro è invitante non solo per le immagini riprodotte, ma anche per gli stimoli a far rivivere la memoria storica, culturale e spirituale delle comunità cristiane locali. Sono preziosissime le ipotesi sulla storia e il cambiamento del tipo iconografico nella copia dell’immagine venerata. Le peculiarità iconografiche fanno di questa raffigurazione barese un tipo a sé stante, che esula dall’ambito delle Madonne Odegitrie classiche. Le indagini presentate nel volume offrono già un quadro dettagliato e documentato che è un buon punto di partenza per ulteriori approfondimenti. Benché l’opera sia ricca di particolari, messi in rilievo con dovuta chiarezza, alcuni punti richiederebbero un’analisi più accurata, come, ad esempio, le possibili cause del cambio di tipo iconografico: dall’immagine della Madonna con Bambino alla Vergine Orante sui sigilli dei vescovi baresi a partire dal vescovo Rainaldo. E’ dovuto forse alla provenienza monastica di questo pastore della Chiesa barese? La Madonna assunse una marcata connotazione di “palladio”, difesa e protezione della città e della sua popolazione. La rappresentazione della Vergine Orante induce però a pensare che quell’immagine di Maria sia essenzialmente una figura di intercessione. La Madonna di Bari offre un’occasione di riflessione e di dialogo, ma anche di confronto critico e di studio per coloro che sono interessati alle discipline di carattere storico, artistico ed iconografico. Ci auguriamo che la pubblicazione barese ispiri studi e ricerche analoghe per altre icone mariane bizantine o di ispirazione orientale che impreziosiscono santuari e chiese di Italia e un po’ di tutta l’Europa. Mieczysław Celestyn Paczkowski, ofm 660 RECENSIONI LIBRI RICEVUTI Baudoz Jean-François, Le miettes de la table. Étude synoptique et socioreligieuse de Mt 15,21-28 et de Mc 7,24-30 (Études Bibliques, N. S. 27), Éditions J. Gabalda et Cie, Paris 1995, 452 pp., 340 FF Bux Nicola (a cura di), L’Odegitria della cattedrale. Storia, arte, culto (Per la storia della Chiesa di Bari. Studi e materiali 11), Edipuglia, Bari 1995, 165 pp., L. 20.000 Congar Yves, Église et Papauté (Cogitatio fidei 184), Les Éditions du Cerf, Paris 1994, 318 pp. Corsani Bruno e collab., Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, 2 ed., Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma 1994, 427 pp. Dawson David Allen, Text-Linguistics and Biblical Hebrew (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 177), Sheffield Academic Press, Sheffield 1994, 242 pp., £ 37.50 (cloth) Deiana Giovanni, Il giorno dell’espiazione. Il kippur nella tradizione biblica (ABI. Supplementi alla Rivista Biblica 30), Edizioni Dehoniane, Bologna 1995, 218 pp., L. 28.000 Fusco Vittorio, La casa sulla roccia. Temi spirituali di Matteo (Spiritualità biblica), Edizioni Qiqajon, Magnano 1994, L. 20.000 Geva Hillel (ed.), Ancient Jerusalem Revealed, Israel Exploration Society, Jerusalem 1994, XVI-336 pp., ills, 8 pls., $ 40.00 Gillespie Thomas W., The First Theologians. A Study in Early Christian Prophecy, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1994, XIV-286 pp. Grelot Pierre, Réponse à Eugen Drewermann (Théologies Apologique), Les Éditions du Cerf, Paris 1994, 222 pp., 100 FF Gruenler Royce Gordon, Meaning and Understanding. The Philosophical Framework for Biblical Interpretation (Foundations of Contemporary Interpretation 2), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1991, XVII-223 pp. LIBRI RICEVUTI 661 Heil John Paul, Blood and Water. The Death and Resurrection of Jesus in John 18-21 (The Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series 27), The Catholic Biblical Association of America, Washington DC 1995, XI-196 pp., $ 9.00 Jiménez F. Bonhomme Manuel, Ese Jesús de ayer hoy y siempre, Kiosko, Cuernavaca 1995, 272 pp. Kahl Jochem, Das System der ägyptischen Hieroglyphenschrift in der 0.-3. Dynastie (Göttinger Orientforschungen. IV. Reihe: Ägypten 29), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1994, XIII-1051 pp., DM 248 Lioi Francesco S. (a cura di), Una vita per la Bibbia. Atti del Convegno di studi “Personalità e opera di p. Angelo Lancellotti” (Collana di studi su Oppido Lucano 5), Banca di Credito Cooperativo, Oppido Lucano 1995, 48 pp. Longmann Tremper III, Literary Approaches to Biblical Interpretation (Foundations of Contemporary Interpretation 3), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1987, XI-164 pp. Marconcini Benito e Collaboratori, Profeti e apocalittici (Logos. Corso di Studi Biblici 3), Editrice Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1995, 459 pp., L. 55.000 Marín Heredia Francisco, Torrente. Temas Bíblicos (Publicaciones Instituto Teológico Franciscano. Serie Mayor 13), Editorial Espigas, Murcia 1994, 261 pp. Muller Richard A., The Study of Theology. From Biblical Intepretation to Contemporary Formulation (Foundations of Contemporary Interpretation 7), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1991, XVII-237 pp. Munro Irmtraut, Die Totenbuch-Handschriften der 18. Dinastie im Ägyptischen Museum Cairo. Mit einem Beitrag von Wolfgang Helck. Textband Tafelband (Ägyptologische Abhandlungen 54), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1994, XIV-247 pp. + 4 tav con foto a colori e 80 tav. con foto in bianconero - 160 tavole, DM 448 Murphy-O’Connor Jérôme, Cent’anni di esegesi. II: Il Nuovo Testamento. L’École Biblique di Gerusalemme (ABI. Supplementi alla Rivista Biblica 26), Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, 233 pp., L. 28.000 Norelli Enrico, L’Ascensione di Isaia. Studi su un apocrifo al crocevia dei cristianesimi (CISEC Origini. Nuova serie 1), Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1994, 359 pp., L. 42.000 662 LIBRI RICEVUTI RECENSIONI Otto Eckart, Theologische Ethik des Alten Testaments (Theologische Wissenschaft 3,2) Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart - Berlin - Köln 1994, 288 pp. Passoni Dell’Acqua Anna, Il testo del Nuovo Testamento. Introduzione alla critica testuale (Percorsi e traguardi biblici), Editrice Elle Di Ci, Leumann 1994, 238 pp., L. 26.000 Pitta Antonio, Sinossi paolina. Le lettere di san Paolo in una nuova traduzione ordinate per temi, San Paolo, Torino 1994, 318 pp., L. 35.000 Poythress Vern S,, Science and Hermeneutics (Foundations of Contemporary Interpretation 6), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1988, IX-184 pp. Ritter Thomas, Das Verbalsystem der königlichen und privaten Inschriften. XVIII. Dynastie bis einschließlich Amenophis III. (Göttinger Orientforschungen. IV. Reihe: Ägypten 30), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995, 389 pp., DM 78 Sesboüé Bernard, Pédagogie du Christ. Élements de christologie fondamentale (Théologies), Les Éditions du Cerf, Paris 1994, 237 pp., 120 FF Silva Moisés, God, Language and Scripture. Reading the Bible in the Light of General Linguistics (Foundations of Contemporary Interpretation 4), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1990, X-160 pp. Silva Moisés, Has the Church Misread the Bible? The History of Interpretation in the Light of Current Issues (Foundations of Contemporary Interpretation 1), Zondervan Publishing House, Grand Rapids (Michigan) 1987, VIII-136 pp. Vesco Jean-Luc, Cent’anni di esegesi. I: L’Antico Testamento. L’École Biblique di Gerusalemme (ABI. Supplementi alla Rivista Biblica 25), Edizioni Dehoniane, Bologna 1992, 211 pp., L. 26.000 Young Ian, Diversity in Pre-Exilic Hebrew (Forschungen zum Alten Testament 5), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993, XV-256 pp., DM 158 Zwickel Wolfgang, Der Tempelkult in Kanaan und Israel. Studien zur Kultgeschichte Palästinas von der Mittelbronzezeit bis zum Untergang Judas (Forschungen zum AT 10), J.C.B. Mohr, Tübingen 1994, XVI-424 pp.
Scaricare