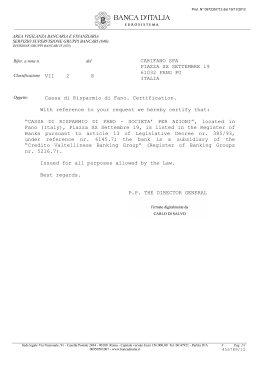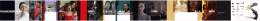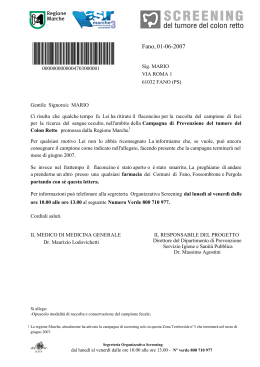Aldo Deli Guerra di liberazione era necessario “un posto al sole”? Non entro nel grave attualissimo tema della denatalità europea: penso invece con ironia ad Hitler che coltivava il mito della razza pura mentre ora, in Germania, ci sono più di tre milioni di turchi..! È proprio vero che a volte la storia fa matte risate sulle nostre trovate, e chissà quante ancora ne farà! A scuola (rivado nei lontani tempi della mia adolescenza) non s’insegnava e nemmeno si accennava al culto della libertà, ma si esaltavano quelli del nazionalismo e della forza. Si diceva e si ripeteva, al canto di “Giovinezza” (parole di Salvatore Gotta) “molti nemici, molto onore”. Vecchio vizio se trovo che addirittura nel 1896 il buon Cesare Selvelli (poi ingegnere) ce l’aveva a morte con Menelik e in alcune strofette “garibaldine” gli dava del boia, dell’assassino, del birbaccione. Ricordo la guerra contro l’Abissinia (1935) e mi chiedo che cosa mai ci aveva fatto il Negus Neghesti (re dei re) Ailé Selassié. Me lo sono chiesto in ritardo, ma allora erano gli anni del “consenso” al fascismo e gl’italiani, troppi, molti, avevano abbassato la testa, obbedendo al Duce. A scuola e per ogni dove ci veniva detto che avevamo bisogno di “un posto al sole” perché nella penisola eravamo in troppi e non c’era lavoro per tutti. Gli studenti si mostravano particolarmente sensibili al richiamo del Capo e lo mostravano facendo grandi “dimostrazioni”; da noi a Fano era così, cantando, oltre a “Giovinezza”, “L’inno di Roma” (che era stato musicato da Giacomo Puccini) e dando anche saggio del “passo romano” che, benché copiato dal tedesco “passo dell’oca”, serviva o doveva servire a dare vigore, a coltivare sogni di gloria. Le dimostrazioni non erano preparate con la cartolina precetto, bastava passare la voce e spesso nel pomeriggio, con la banda del 94° fanteria in testa, gli studenti sfilavano per il Corso o in Piazza ripetendo lo slogan infame che il giornalista Mario Appelius lanciava dalla radio: “Dio stramaledica gli inglesi!”. Ricordo che in una di quelle dimostrazioni un cartello illustrato mostrava un balilla che faceva la pipì nella bocca aperta del Negus, ma soprattutto ho in mente qualche strofetta allora in voga: “Caro Negus se permetti/ in Italia stiamo stretti/ allungheremo lo stivale/ fino all’Africa Orientale”. E poi ricordo: “Con la barba del Negus ci farem gli spazzolini/ ci pulirem le scarpe al Re e a Mussolini”. Quando Dio vuol perdere una persona la fa impazzire, ma il diavolo più lieve (come argutamente nota Salvatore Satta) la fa ridere e la fa diventare ridicola. E noi ridevamo molto, il diavolo era con noi, vittime predestinate non capivamo nulla del disvalore che il regime ci propinava. Chi riusciva a capirlo (ma erano troppo pochi) finiva in prigione o al confino. E il posto al sole? Fu una favola breve con brutta fine. 2004 Storie o storielle di casa nostra Ormai sono passati sessantatre anni. Quel giorno, nel tratto di strada fra via Giordano Bruno e Borgo Cavour mi apparve proprio lui, Mussolini col gran faccione giallo incastrato fra sahariana e berretto bianchi. Proveniva dal campo d’aviazione dove era stato ossequiato dalle autorità. I fanesi applaudivano e lui sorrideva: l’aver da poco dichiarato guerra a Francia e Inghilterra e ricevere tanti applausi dai cittadini di Fanum Fortunae doveva sembrargli di buon augurio, e lui ne aveva tanto bisogno. C’erano molti, e non tutti giovanissimi, che per ben fissare in mente quel volto atteggiato a fierezza e paternalismo correvano a perdifiato dietro la Mercedes che, veloce, andava su per il Corso rimasto sgombro da capi di stato o di governo dal maggio 1857 quando Pio IX scarrozzò per la nostra città che, solo tre anni dopo, gli avrebbe voltato le spalle per re Vittorio Emanuele. A Benito, transitante per il Corso nell’estate del 1940, capitò di peggio tre anni dopo. A lui quel giorno non gettarono petali di rose come a Pio IX; anzi venne giù da una finestra del “Gafòn”, poco prima di arrivare al Caffè Centrale, un bel mazzo di fiori ancora tutto ben legato: gli passò a un palmo dalla visiera! Maragno, il segretario politico (è inutile aggiungere che c’era solo quello fascista) detto bonariamente “Cinq e tre òtt” per via del suo claudicare dovuto ad una mutilazione di guerra, impallidì: forse sospettò un attentato; caspita potevano colpirgli la testa! Quel segretario politico era noto per essere perpetuamente in lotta con la lingua italiana. Una volta, dal balcone della Casa del fascio in Piazza XX Settembre, aveva lanciato tuoni e fulmini contro gli “anglofilini e francofilini”. Più tardi, dopo la dichiarazione di guerra agli Stati Uniti, disse con incrollabile fede: “Abbiamo messo a pecorone la Grecia, ci metteremo anche l’America!”. Tuttavia, benché ispirato come Nostradamus, fece piuttosto cilecca nel suo profetare osceno. Nelle popolaresche storie cittadine quel segretario politico era ricordato quale vittima di ignoti ladruncoli che nottetempo gli ripulirono il pollaio, tralasciando per ironico sfregio un gracile striminzito galletto al collo del quale appesero un militaresco cartoncino con la scritta “rividibile”. Era il tempo del riso amaro. Intanto Lui, quel giorno dell’estate 1940, proseguì verso Pesaro inseguito dal martellante “du-ce, du-ce”. Eh, sì, purtroppo parecchi fanesi l’avevano facile quel verso. Ricordo (l’ho già scritto qualche anno fa) che quando il principe Umberto di Savoia venne a visitare la scuola allievi ufficiali e si affacciò alla finestra centrale del Casermone la gente da sotto gli gridava: “du-ce, du-ce”. Ve l’immaginate la sua faccia? Questi fanesi, questi fanesi! 2003 Il bombardamento del 17 aprile 1944 Nell’aprile 1944 Fano subì ventun incursioni di aerei alleati: naturalmente e purtroppo ci furono morti e feriti fra i civili. Oltre ai ponti sul Metauro gli alleati avevano preso di mira la stazione ferroviaria che nei loro rapporti (è fonte documentatissima il libro di Gastone Mazzanti “Dalle vie del cielo a quelle della città”) chiamavano “scalo ferroviario”. Gravissimo il bombardamento del 17 aprile. Sessant’anni fa le bombe sganciate da dodici aerei Marauders sudafricani scortati da sei Spitfires (i famosi Sputafuoco) colpirono duramente Via Nolfi. Gli edifici centrati dalle bombe sono ora scomparsi e sostituiti da nuove costruzioni. Furono allora colpiti: La filanda Solazzi, la vecchia sede delle Maestre Pie Venerini, la farmacia S. Elena aggregata all’Istituto tecnico commerciale (ex ospedale di S. Croce) che poi verrà totalmente spianato in un successivo bombardamento, il portico e la chiesa di S. Croce. Fu colpita anche la chiesa di S. Agostino che non crollò del tutto ma vide invece crollare il soffitto reso famoso da una prospettiva secentesca del fanese Giovanni Battista Manzi (già attribuita a Francesco da Bibiena) raffigurante S. Agostino in gloria. Non so se nella stessa occasione dalle bombe fu provocato uno squarcio nelle mura malatestiano-pontificie, sopra la linea ferrata, che mise in luce, come scrisse il Selvelli, “un paramento secolare in grossolano opus reticulatum” (sic!), muro di origine romana del quale successivamente, riparando le mura, il geom. Menegoni del Genio Civile ebbe la felice idea di lasciare scoperto un breve tratto. 2004 Il battaglione della liberazione “fortes in fide” Abbiamo avuto occasione di parlare, su questo foglio, dello sbandamento dell’8 settembre 1943 nelle file dell’esercito. In proposito merita ricordare un episodio che i più non conoscono. Il giorno 9 il Ten. Col. Giuseppe Cecchini aveva esortato i militari in servizio presso la Caserma Montevecchio a rimanere uniti. L’appello cadde nel vuoto; la stessa fine fece l’invito rivolto al Comando del Campo d’Aviazione di Fano dalla Concentrazione antifascista di Pesaro. Il 16 settembre il Cecchini, uomo di profonda fede religiosa, assecondato da alcuni ufficiali, soldati e civili procedette alla costituzione di un reparto, il primo nella provincia, che venne chiamato “Battaglione della liberazione Fortes in Fide”; trasposizione in campo patriottico di un motto d’origine ecclesiale sul tipo di quelli allora usati dall’Azione Cattolica. Il reparto si andò organizzando nella zona di Mombaroccio, Monte della Mattera, Monte Marino: poche bombe a mano, due pistole d’ordinanza, alcuni fucili da caccia erano tutto lo sparuto armamento di quegli uomini. In seguito furono ottenute altre armi; ma lo scopo del Cecchini e dei suoi non era quello di passare all’attacco dei tedeschi o dei militi della RSI (che nel frattempo si andava organizzando) affrontando le in- cognite di una lotta civile. Lo scopo era quello di tenere in piedi un nucleo operativo pronto a collaborare con gli alleati non appena fossero sbarcati. Un altro nucleo di dieci uomini, col tenente Reali, si costituì a Pergola con lo stesso scopo. È da pensare che anche il citato invito della Concentrazione antifascista al comandante del campo di aviazione fanese si muovesse nella stessa logica: e cioè di mantenere libero il campo per gli aerei alleati. Proponimenti generosi, come si vede, ma che nascevano da una superficiale valutazione degli avvenimenti in corso. Essi denotano come fra molti fosse diffusa la speranza, destinata a svanire in pochi giorni, di una rapida evacuazione dei tedeschi sotto la spinta del moltiplicarsi di sbarchi alleati. Le mosse del Col. Cecchini, che a fine ottobre disciolse il concentramento pur rimanendo in contatto con i suoi uomini, non passarono inosservate. Fino al maggio 1944 egli venne ricercato con l’accusa di diserzione e costituzione di banda ribelle. Dal primo rifugio nel Seminario Regionale passò via via ad altre sedi. Dopo la liberazione fu nella prima giunta democratica fanese; successivamente aderì al Partito Cristiano-Sociale dell’on. Bruni. 1993 Dopo l’8 settembre a Fano Non intendiamo fare tutta la possibile cronaca dei giorni e dei mesi che seguirono l’8 settembre, ma solo richiamare qualche dato che molti non conoscono o hanno dimenticato. La Concentrazione antifascista di Pesaro pubblica sul “Corriere adriatico” l’11settembre 1943 un ordine del giorno e saluta “l’esercito con il quale il popolo si stringe in una volontà sola per la difesa della Patria”. Le cose, però, andarono diversamente. Il 14 settembre il Comando della zona militare di Ancona sciolse i reparti stanziati a Fano. Ad evitare future accuse di diserzione i militari furono inviati in licenza; nei giorni seguenti i tedeschi occuparono le caserme Paolini e Montevecchio senza trovare alcuna resistenza. Il 14 e il 15 settembre c’era stata l’invasione della caserma Paolini, sede della scuola allievi ufficiali di complemento. Furono asportati materiali e suppellettili, ma non furono preleva- te armi o munizioni perché, si sentiva 44 dire, “ormai la guerra è finita”: quello 45 che sarebbe successo non era immaginabile dai più. E qui è bene ricordare che subito dopo l’8 settembre molti a Fano, come altrove, pensavano con notevole ingenuità, alimentata anche dalla scarsità delle informazioni sui tedeschi e sugli alleati, che fosse prossimo uno sbarco degli angloamericani. Il tenente colonnello Giuseppe Cecchini, del 94° Fanteria, addirittura lo ipotizzò fra Ancona e Pesaro e, conseguentemente, operò clandestinamente in tale ottica organizzando, a partire dal 16 settembre, un piccolo reparto da lui chiamato “Battaglione della liberazione “Fortes in Fide”. Tale reparto che avrebbe dovuto unirsi agli alleati non raggiunse mai la consistenza e la forza di un battaglione né condusse azioni belliche contro i tedeschi: la sua fu solo una testimonianza di amor di Patria. Non è un di più ricordare che Giuseppe Cecchini era profondamente cattolico. A Fano un distaccamento G.A.P. (Gruppo di Azione Partigiana) fu formato con un centinaio di uomini solo nell’aprile 1944. L’iniziativa fu del locale Comitato di Liberazione Nazionale presieduto dall’avv. Enzo Capalozza. Detto Comitato nel periodo clandestino aveva sede permanente poco lontano da Fenile, nella villa Simonetta, messa a disposizione dal dott. Hageman. Comandante del distaccamento fu Valerio Volpini affiancato da chi scrive e da Otello Vitali. Era un distaccamento “sui generis” perché chi ne faceva parte (quasi tutti giovani) pur tenendosi pronto ad ogni chiamata, continuava ad abitare con la propria famiglia. Era strutturato in sei squadre, forzatamente limitato nell’armamento (qualche partigiano aveva solo la rivoltella). Si rivelò più adatto a fare opera di sabotaggio e azioni limitate più che a scendere in campo aperto contro i reparti tedeschi. Prima del distaccamento operavano nel territorio del Comune due squadre G.A.P. composte da pochi uomini: altri fanesi, come si sa, operarono nei distaccamenti partigiani della zona di CagliCantiano; circa sessanta si arruolarono nell’ottobre 1944 nel Corpo Italiano di Liberazione. Non si hanno dati orientativi sugli effettivi fanesi nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana. 2003 Una Pasqua clandestina: a Monte Giove con Valerio Volpini Correva la primavera del 1944. Quell’anno la Pasqua era stata “alta”. Noi disertori dell’esercito della R.S.I e partigiani l’avevamo festeggiata, come tutti, un po’ in sordina. Valerio qualche giorno dopo mi disse: “Dobbiamo ‘prendere Pasqua’ e fare la Comunione”. Non era un problema; il Seminario Regionale, luogo sicuro per noi, era lì vicino e ci avrebbe facilmente ospitato per una breve permanenza. Ma Valerio continuò: “Andremo a Monte Giove, lì ci sono solo i frati e ci staremo per un giorno intero, così avremo anche modo di riflettere con calma”. Si vede che nel suo animo c’era ancora nostalgia per i ritiri spirituali tante volte fatti lassù. Valerio era il comandante del distaccamento partigiano fanese, io ero in qualche modo il suo aiutante: entrambi provenivamo dalla F.U.C.I., la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Bene, si decise per Monte Giove. Per non dare nell’occhio andammo, una mattina di buonora, solo noi due. Le inseparabili biciclette, inservibili da Rosciano in su (la “costa” per arrivare all’eremo è piuttosto lunga), ci sarebbero invece state utili per il ritorno e pertanto non ce ne separammo. Mentre salivamo parlammo a lungo delle nostre responsabilità sia verso chi faceva parte attiva della Resistenza (un centinaio di persone) sia verso la popolazione, in grandissima parte sfollata dalla città e sistemata nelle case e nei villaggi di campagna. Era costante preoccupazione di Valerio non coinvolgere i civili in atti di guerra, evitando quei colpi di testa che provocavano da parte tedesca, lo sapevamo da vari racconti, feroci e selvagge rappresaglie. Suonammo alla porta dell’eremo; venne ad aprire don Michele, il padre “cellerario”, cioè l’economo della comunità monastica; ci conosceva bene e ci accolse con grande affabilità. Spiegammo il perché della nostra visita; ci portò subito in chiesa e fu lui stesso ad ascoltare la nostra confessione e a somministrarci la Comunione. Intanto qualche altro camaldolese, incuriosito, venne e ci propose di salire sul campanile; così, per passare un po’ di tempo. Salimmo e dopo poco fummo involontari testimoni di un bombardamento aereo dalle parti di Pesaro. La città non si vedeva, ma il brontolio degli scoppi e le dense nuvole di fumo che, grigiastre, si alzavano verso il cielo erano troppo eloquenti: per essere liberi bisognava sopportare i bombardamenti dei liberatori, che strana guerra! Con padre Michele parlammo a lungo del fronte che lentamente avanzava e dell’attesa degli “alleati”. Il buon padre non sospettava che di lì a poco tempo l’eremo (che già custodiva preziosi codici della Federiciana) sarebbe diventato rifugio per molti, nonché il bersaglio di qualche colpo d’artiglieria! A mezzogiorno ci fu offerto il frugale pranzo a base di verdura, poi ancora padre Michele ci portò nella sua cella per una specie di ritiro spirituale. Venne il tramonto e noi due prendemmo la via di casa. Avevamo “preso Pasqua” e andavamo sereni incontro al nostro destino che, per grazia di Dio, fu felice. Ma questo lo capimmo in seguito. 2002 Come Valerio divenne un “ardito” In occasione del conferimento “alla memoria” della “Fortuna d’oro” a Valerio Volpini sono stato invitato a dare di lui una testimonianza. Non ho esitato ed ho preso uno spunto da un accenno che Valerio (al quale fui vicinissimo nel tempo della resistenza) fece nella rubrica “Pubblico e Privato” apparsa per parecchi anni su Famiglia Cristiana. Voglio dire che, senza vantarsi di nulla, scrisse di aver preso parte alla liberazione del Nord militando tra gli arditi del IX reparto d’Assalto. Come giunse Valerio, anzi, come giungemmo in quel famoso e focoso reparto? Dopo che Fano venne liberata nell’agosto 1944 parecchi ex partigiani erano convinti (altra scelta politica) che una forte presenza italiana fosse necessaria fra le truppe alleate che avrebbero liberato il molto che ancora restava in mano nemica. Fu così che dopo aver ben considerato ogni scelta seguì l’arruolamento volontario nel Corpo Italiano di Liberazione che, nel frattempo, si era articolato in cinque divisioni armate ed equipaggiate dagli alleati. Valerio ed altri fanesi partirono alla fine di ottobre. Da Fano, in camion si giunse a Jesi. Qui cominciò la mala avventura (diciamo così per sfuggire ad ogni tentazione di retorica). Alla stazione ferroviaria ci fecero salire su vagoni-merce su cui certamente era stato trasportato catrame. Ce n’erano abbondanti inconfondibili tracce. Lì rimanemmo due giorni prima di giungere a Roma dove fummo fatti salire su un’altra tradotta di carri-merce (oh, com’era ridotta l’Italia!) che a passi di lumaca ci portò verso Sud per raggiungere la zona di addestramento. Avemmo occasione di vedere l’allucinante spettrale visione di Monte Cassino. Finalmente dopo un viaggio massacrante fummo portati in un accampamento nei pressi di Caserta: era notte ma ugualmente trovammo la possibilità di riposare alla menopeggio ficcandoci nelle tende piene di soldati sbandati. Il giorno dopo fu una vera tragedia. Non c’era per noi la colazione: pazienza, ci arrangiammo alla meglio. Poi, più tardi, ci dissero che non ci avrebbero distribuito nemmeno il rancio perché non c’era, e nessuno aveva avvertito e provveduto al nostro arrivo. Allora Valerio, vedendo che ci trattavano con noncuranza, se non con ostilità, si mosse verso la “tenda-comando” per far valere la nostra protesta. Dietro lui, che ormai era considerato il capo, si misero in molti. Davanti all’ufficiale responsabile del campo avvenne una scena che è difficile dimenticare. Valerio su tutte le furie, urlò e protestò, si strappò il fazzoletto che teneva al collo, poi, improvvisamente, apparve nelle sue mani un revolver. Per fortuna fu svelto a disfarsi di quell’arma che certamente avrebbe causato guai a tutti quanti, però continuò nella sua audace e amara filippica. L’ufficiale, pallido e sconcertato, gli diede ragione e disse che avrebbe provveduto subito a farci portare dove ci sarebbe stato per noi tutto quello che cercavamo. Non aggiunse altro. Però è facile immaginare il pensiero che gli attraversò la mente: “Questi ex partigiani sono un po’ matti, adesso li sistemo a dovere!” Vennero poco dopo due camion e ci portarono a S. Angelo sul Volturno. Pioveva a dirotto. Nessuno di noi sapeva che lì c’era una compagnia (la 104 per esattezza) del battaglione arditi “Col Moschin”, il IX Reparto d’assalto. Fu così che, senza aver presentato alcuna richiesta, Valerio e gli altri si ritrovarono “arditi”, quasi per scherzo. Bah, non parliamone più. Quella compagnia poi schierata al fronte in prima linea partecipò alla presa di Bologna, il 21 aprile 1945. Pochi giorni dopo (la guerra ufficialmente terminò l’8 maggio) fu impegnata a Monte Casale, vicino al Lago di Garda, nel combattimento che in Italia fu l’ultimo della II guerra mondiale. Cinque dei nostri morirono; a pensarci bene ci volle coraggio e imprudenza nel mettere a repentaglio la propria vita negli ultimi cinque minuti di guerra. Ma andò così, proprio così. 2002 1944: i pescherecci affondati Nel 1944, alla fine di luglio, cominciarono a farsi sentire i cannoni degli alleati che avanzavano verso il Metauro. Poi, oltre al rombo, arrivarono i primi proiettili; ma al di là del Metauro la sosta dei “liberatori” fu abbastanza lunga. I pochi tedeschi di retroguardia si difesero con accanimento. Nel frattempo il locale comando germanico si preparava a compiere a Fano due atti atroci: l’abbattimento dei campanili (ho sempre creduto che ciò fu fatto per odio contro il Vescovo Del Signore che s’era proposto come amministratore della città dato che nessun laico si lasciava convincere ad assumere, come volevano i tedeschi, tale carica) e la distruzione della flottiglia peschereccia. Come sappiamo, il primo intento purtroppo riuscì; il secondo, per fortuna, no. Una foto che mostra i pescherecci affondati nel porto ha fatto concludere a molti che i marinai stessi affondarono tutte le loro barche per salvarle dalla totale distruzione. Ciò solo in parte è vero. Alcuni pescherecci furono effettivamente e scientemente affondati da certi marinai che riuscirono ad eludere la sorveglianza nemica. “Dei natanti rimasti i tedeschi pensavano di fare un gran falò”, così dice il foglio “Frusaglia” pubblicato a Fano il 15 ottobre 1955. E prosegue: “Tirava un forte vento da est e logicamente bastava appiccare il fuoco ai pescherecci posti in testa rispetto a quella direzione perché le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni attraccate in fila indiana. Il caso volle che proprio al levarsi dei primi bagliori sorgesse altro vento con direzione del tutto contraria al precedente. Il fuoco rimase circoscritto e si ebbero a lamentare pochi danni. I tedeschi ricorsero allora a cariche di dinamite, sicché i pescherecci affondarono ma senza subire danni irreparabili”. Dopo la liberazione di Fano i marinai cominciarono, con immensa fatica, a riportare a galla i natanti incuranti delle risatine che i rudimentali mezzi a loro disposizione suscitavano fra i soldati alleati i quali consigliavano di rimandare tutto a tempi migliori. L’ebbe vinta la tenacia dei marinai: fatto sta che nel gennaio 1945 parecchi dei pescherecci “affondati” ripresero finalmente il mare. 2003 All’alba del 20 agosto a Fano strage di campanili La mattina del 20 agosto 1944, verso le sette, aprii la finestra (ero rifugiato in una casa colonica a Chiaruccia) e come al solito guardai verso Fano. Per un attimo ebbi la sensazione che la città fosse del tutto scomparsa, sprofondata. Da quella finestra in mezzo alla campagna mi erasempre apparsa, fra gli alberi, la sagoma della sommità di quasi tutti icampanili, quello di Santa Maria Nuova in particolare; ma quella mattina avevo davanti solo l’azzurro intenso del cielo: mancavano i “segni crociati” della città. All’alba i tedeschi della Wermacht, non le SS, avevano fatto saltare i campanili più importanti e più belli: quello del Duomo, di Santa Maria Nuova, di San Paterniano, di Sant’Arcangelo e la torre di piazza. Il giorno dopo la stessa sorte toccò ai minori campanili di San Silvestro e di San Domenico (e così furono sette!), ma toccò anche al maschio della fortezza malatestiana, alla lanterna del porto, alla torretta di una casa privata tra via Froncini e via De Cuppis. Si salvarono i campanili di San Marco e di San Francesco di Paola (alla stazione). La cupola di San Pietro in Valle scampò non si sa come al disastro; i tedeschi entrarono in chiesa e si accontentarono di sparare colpi di pistola e di mitra contro i settecenteschi angeli del transetto. Perché tante rovine e tanto scempio di edifici? Ancor oggi qualcuno pensa che i campanili siano stati abbattuti perché potevano servire da osservatorio agli alleati. E’ una tesi insostenibile. Dal punto di vista militare poteva essere 46 valida nella prima guerra mondiale, non 47 già nel 1944 nella fase di avanzata degli alleati abbondantemente dotati di aerei ricognitori che tenevano sotto controllo, notte e giorno, i vari settori del fronte. Se i tedeschi avessero voluto distruggere possibili centri di osservazione avrebbero gettato a terra, fra i primi, i campanili di Monte Giove e del Beato Sante, che invece non furono toccati. Inoltre i campanili e gli altri edifici abbattuti non si trovavano su careggiate strategicamente importanti e nemmeno in punti di svincolo della città. C’è poi da tener presente che nessuna città delle Marche (tutte ricche di campanili) ebbe a soffrire lo stesso sfregio di Fano. E allora? Ho dei sospetti sul comandante tedesco della piazza di Fano, ten. Eberard Fischer. Nella lettera indirizzata al vescovo per comunicargli che sarebbero stati abbattuti “cinque” campanili (e disse una bugia) afferma, genericamente, che l’ordine era venuto da “un comandante militare superiore”. Ma chi era questo Fischer? Sarebbe interessante appurarlo perché la distruzione dei campanili, con relativo scempio delle chiese, potrebbe essere un atto di barbarie completamente gratuito. Un modo con cui Fischer dimostrò rancore, rabbia e disprezzo verso la città, verso la Chiesa e il Vescovo che si era assunto la responsabilità di rappresentare anche civilmente la città, in mancanza di personalità disposte a farsi avanti (chi se la sentiva di passare per “collaborazionista” alla vigilia della liberazione?). Insomma, a Fano potrebbe essere toccata la sfortuna di avere un comandante tedesco “antipapista” (non dimentichiamo che in Germania il nazismo non era stato contrastato da molti luterani, ma prevalentemente dai cattolici) dimostratosi particolarmente spietato nel colpire nei suoi monumenti e soprattutto nelle sue testimonianze cattoliche una città che, per altro, non aveva compiuto alcuna azione particolarmente clamorosa o cruenta contro i tedeschi. 1992 20 agosto del ’44: il Duomo fu coperto di macerie Fra venti giorni (quando questo settimanale sarà chiuso per ferie) ricorre il 54° anniversario del diroccamento a mine del campanile del Duomo di Fano. Si badi che nel 1940 il Vescovo Mons. Del Signore aveva fatto molti e costosi lavori nella cattedrale per celebrarne l’ottavo centenario della costruzione. Dopo quattro anni dovette ricominciare tutto da capo, affrontando problemi enormi. “Non so - diceva - quanti anni ci vorranno; ma prima di morire voglio rivedere il Duomo a posto!”. E anche questa volta la spuntò. Ritornando a quel tragico 1944 le cose cominciarono a mettersi male per la Cattedrale nella notte fra il 15 e il 16 gennaio. Aerei alleati sganciarono alcune bombe che colpirono non gravemente il tetto. Andarono in frantumi tutte le nuovissime vetrate comprese le sei, molto belle, istoriate da Vittorio Menegoni. Crollarono i soffitti di alcuni locali annessi alla sacrestia. Danni più gravi subirono i palazzi posti poco lontano dal Duomo. Le funzioni religiose ridotte al minimo furono dirottate verso la grande sacrestia ove si accedeva attraverso un cortile interno evitando la chiesa. Ed ecco il racconto un po’ sconnesso che delle giornate più tragiche ha registrato il Cancelliere Vescovile Mons. Agostino Narducci: “Venne l’ordine tassativo di abbandonare la città... Diventarono sempre più difficili le condizioni con l’avvicinarsi delle azioni guerresche e coll’inasprimento continuo delle esigenze delle truppe Tedesche che imposero lavori, requisizioni di ogni specie senza alcun riguardo ai bisogni della popolazione. Non fissiamo qui i soprusi e le ruberie subìte dalla cittadinanza, ma certo le sofferenze furono gravissime e tali da lasciare il più brutto ricordo. Si può dire che i pericoli dei bombardamenti e delle armi passarono in seconda linea perché superati dalle malversazioni e prepotenze. Il giorno 20 agosto, senza preavvisi di sorta, anzi dopo una affermazione della autorità tedesca qui di stanza mentre la minaccia di atterrare i campanili della città si supponeva rientrata, potentissime mine fatte esplodere dai guastatori tedeschi fecero saltare il poderoso tor- rione detto Torre di Belisario su cui era stata innalzata la cella campanaria e la relativa guglia del campanile del Duomo. L’esplosione provocò oltre il crollo del campanile, lo sfondamento del tetto e delle volte della Cattedrale su tutto il presbiterio e navata sinistra relativa; della prima campata della navata centrale e della sinistra aderente al presbiterio; il crollo del tetto e volta della Cappella di N. Signora del Sacro Cuore e l’abbattimento del muro perimetrale della Cappella del Sacramento sino al Battistero. Conseguenza di tale inqualificabile sacrilegio fu anche lo sfondamento e la rovina di parte dell’Episcopio attiguo; il crollo della Sala adibita ad Archivio storico della Cancelleria; la rovina quasi completa degli edifici civili fiancheggianti il Duomo per via Rainerio. Le macerie hanno ostruito la strada pubblica e riempito in proporzioni paurose la Cattedrale. In tali bruttissime condizioni, al rientrare della popolazione in Città, si dovette riprendere l’ufficiatura ridotta nell’ambiente della Sagrestia. Rovine meno ingenti, ma gravissime e deplorevolissime hanno subito in Città le Chiese di S. Paterniano, S. Domenico, S. Maria Nuova, il Santuario detto della Madonna di Piazza delle quali furono pure fatti saltare i relativi campanili. Tutte sono così rese impraticabili”. Bisogna aggiungere il campanile di S. Arcangelo. A testimoniare la grossolana bugia dei tedeschi, secondo cui i i campanili potavano offrire punti di osservazione, vale ricordare che gli unici due campanili con grande vista panoramica, cioè quello di Monte Giove e quello del Beato Sante non furono toccati. Senza contare che i tedeschi sapevano benissimo che gli alleati per spiare le loro mosse avevano numerosa aviazione da ricognizione. Vollero fare uno sfregio al Vescovo, uno sfregio alla Città. 1998 Il giorno della Liberazione Di quella fine d’agosto di mezzo secolo fa rivedo tutto, come se fosse ieri. La città vuota, molte serrande dei negozi sfondate, case sventrate ai due angoli di piazza XX Settembre col Corso, altre sventrate dal crollo di sette campanili e del Maschio della fortezza malatestiana demoliti a mine; in tutto il Comune i genieri tedeschi avevano fatto saltare i ponti in muratura, di ferro, di legno grandi e piccoli. La centrale della Liscia era un mucchio di rovine, i moli irriconoscibili, i pescherecci affondati, la lanterna fatta saltare. A tutto ciò bisogna aggiungere i danni precedentemente causati dai bombardamenti alleati con la distruzione delle chiese di S. Agostino, Santa Croce, S. Francesco di Paola, S. Cristoforo (la vecchia chiesa in via Petrucci), dell’Istituto Tecnico commerciale, di Palazzo Zavarise e di parte del Gabuccini ecc. Sembravano una beffa quelle scritte “Vincere e vinceremo”, “Molti nemici molto onore” ancora balbettanti dai muri in cui erano state dipinte dai fascisti; “Dio stramaledica gli inglesi” aveva tuonato per anni la radio del regime: e adesso, per uno di quei duri rovesciamenti di aspettative imposti dalla storia (cioé dagli uomini e, in questo caso, dalla loro capacità di guardare in faccia la realtà), il popolo aspettava come liberatori proprio gli “stramaledetti” di ieri. Nell’ultima settimana del “passaggio del fronte” gli alleati avevano infittito i bombardamenti di artiglieria: dalle colline sulla destra del Metauro si scaricò una pioggia di granate nella zona di Saltara e Cartoceto, qualche colpo toccò l’Eremo di Montegiove. Era “l’ultimo assaggio” contro le postazioni tedesche (poche in realtà) prima che polacchi e canadesi varcassero il Metauro: i primi a Madonna del Ponte, Ferriano, Falcineto, i secondi nella zona di Montemaggiore-Calcinelli. Ci furono scontri con morti e feriti fra i combattenti e, purtroppo anche fra i civili, ma non fu combattuta una vera e propria battaglia; ci fu una grande manovra di avvicinamento alla linea gotica che si snodava al di là di Pesaro e di Urbino. Non voglio dire altro sulle operazioni militari. Quello che ricordo più nitidamente di quei giorni è il senso di vera e autentica “liberazione” che, pur tra le sofferenze e le recenti macerie, aleggiava in ogni volto, in ogni discorso. Era finito l’incubo dei rastrellamenti, delle ruberie, delle paure, delle prepotenze varie imposte dall’esercito tedesco in ritirata. Era finito l’incubo dei bombardamenti: finalmente si respirava! Ne ebbi una prova certissima il 25 agosto. Quel giorno attraversai il Metauro nella zona della “passerella” tedesca, sotto le Caminate; una pattuglia polac- ca mi rilevò per portarmi al comando operativo; salimmo su per una “costa” dov’erano attendati molti che avevano dovuto lasciare all’improvviso le case dov’erano sfollati, c’erano parecchi fanesi. Si trovavano in condizioni precarie, sembrava un accampamento di nomadi eppure, questo è meraviglioso, erano tutti contenti, sorridenti, vocianti e ciarlieri come se fossero a una scampagnata. “Il più é fatto”, dicevano, “Presto si torna a casa”, “Bisogna ricostruire tutto”, “Non ne potevamo più”, “En ne pudemi più!!”. Quando leggo certi discorsi di carattere riduttivo o assolutorio sulla guerra voluta dal fascismo mi tornano subito in mente gli occhi raggianti, i volti felici di quegli uomini e di quelle donne attendati alla campagna sotto il sole d’agosto: erano felici perché avevano la certezza che tedeschi e fascisti se n’erano andati, per sempre! Senza retorica, senza forzature ideologiche possiamo essere certi che quelli furono giorni di autentica Liberazione. 1994 La pace fra gli uomini: ne sono capaci? La prima bomba atomica fu lanciata il 6 agosto 1945 sulla città giapponese di Hiroshima: quella data è ricordata da pochi. Allora molti plaudirono perché la bomba atomica praticamente poneva fine alla sanguinosa seconda guerra mondiale. Ricordo che solo “L’Osservatore Romano” prese le dovute distanze da quell’orribile ordigno. Erano le otto e un quarto del mattino e le sirene dell’allarme nemmeno suonarono poiché solo due aerei statunitensi volavano sopra la città di Hiroshima abituata a vedere sul proprio cielo grossi stormi di velivoli. Poi qualcosa si staccò da uno degli aerei e giunto a qualche centinaia di metri dal suolo scoppiò e come un lampo abbagliante investì la città. Era entrata nella storia la bomba atomica: un nuovo potente strumento di morte si trovava nelle mani dell’uomo. Morirono all’istante 71.000 persone; le case presero fuoco; verso le quattro del pomeriggio l’ evaporazione prodotta dal gigantesco incendio si trasformò in torrenziale pioggia. Una moltitudine di urlanti ustionati aveva cercato illusorio rimedio gettandosi nell’acqua dei canali. Solo allora arrivarono i primi soccorsi: erano i gesuiti (ma chi lo sa?) che abitavano in una vicina collina; tra essi c’era padre Pedro Arrupe, destinato a diventare Generale della Compagnia di Gesù. Di loro parlò poi con ammirazione la relazione ufficiale giapponese. Mi sembra opportuno aggiungere quanto sul quel tragico avvenimento scrisse Valerio Volpini attingendo da Robert Jungk che aveva avuto un colloquio con uno dei pochi superstiti di quel tragico sei agosto. Si chiamava Kazuo e quando scoppiò la bomba aveva quattordici anni. Quel ragazzo nove giorni dopo lo scoppio e la scomparsa di Hiroshima gridando come un pazzo “tutti gli uomini sono degli imbecilli (Otona, Wa Bo-ka)” fece a pezzi ciò che aveva di più caro: il suo libro di lettura. Dopo quello che aveva visto a che servi- va pensare e sapere? 48 La scena, evocata da Volpini ha valore 49 anche per noi che predichiamo sulla pace fra gli uomini; ma essi ne sono capaci? 2007 I brani qui riproposti sono stati stralciati da “I merli di Fano”, raccolta di articoli scritti da Aldo Deli per il settimanale ‘Il Nuovo Amico’. Il libro, curato da Enzo Uguccioni, è stato edito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel dicembre 2008. • Il fungo atomico sviluppatosi sulla città di Nagasaki il 9 agosto 1945. Tre giorni prima toccò a Hiroshima. I due bombardamenti, che causarono secondo stime oltre 120.000 morti all’istante, costrinsero il Giappone alla resa il 15 dello stesso mese. Angelo Sferrazza La busta gialla Il 25 luglio del figlio del maresciallo La memoria di un bambino cattura, inconsapevolmente, eventi importanti e li conserva nitidi per sempre. Capita quasi a tutti: c’è chi afferma di ricordare addirittura cose di quando aveva due anni! Nel luglio del 1943 di anni ne avevo sette e mezzo. Finita da poco la II elementare alla Corridoni e tesserato d’ufficio come “figlio della lupa”. Ho indossato la divisa una sola volta, all’asilo Manfrini perché scelto (una mia zia ne era la direttrice!) a montare la guardia in occasione della visita del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai a Fano. Le foto di quell’evento furono in mostra nella vetrina del fotografo Eusebi per molti mesi. Mio padre, nonostante le mie continue richieste, si rifiutò sempre (lo capii qualche tempo dopo), di comperare una copia di quella che mi immortalava mentre facevo il noto saluto al Ministro dell’Educazione Nazionale, che mi accarezzò e disse “che bel bambino”. Raccontai la cosa a casa, mia madre fiera, mio padre fece finta di non capire, ma dalla sua bocca uscì qualche parola, che non riuscii a sentire: sono sicuro in siciliano, lingua che utilizzava quando si arrabbiava! Vivevo allora nel deposito militare di Piazza d’Armi, di cui non è rimasto nulla, fra l’Adriatica e la ferrovia. Si entrava da una strada, ora chiusa, che portava alla fornace, (dalla Nadia ci sono esposte bellissime foto di quel periodo) e che percorrevano gli ortolani e i carrettieri, grandi bevitori e robusti bestemmiatori, che andavano a caricare la “breccia”. Mio padre, maresciallo del 94° Reggimento Fanteria, era responsabile del deposito da tutti chiamato “magazzeno militare” e abitavamo in una casetta all’interno del complesso, rete e filo spinato, con un cane nero (femmina di lupo belga) Diana, addestrata a Firenze al centro cinofilo dell’Esercito che, non so come facesse, riusciva a distinguere un militare in divisa da un “borghese”, contro il quale si lanciava ferocemente! In una parte del deposito erano alloggiati 7 od 8 soldati, “sedentari” come venivano chiamati perché non idonei alla guerra, tutti di paesi vicino a Fano, Fossombrone, Fratterosa, San Michele, per lo più agricoltori o di “campagna” come si diceva allora, bravissimi, che mi insegnarono tanto sulle piante, gli animali e a togliere la pelle (preziosa nel periodo dell’autarchia) al coniglio morto. Di loro racconteremo parlando dell’8 settembre. Quasi cinque anni, come in caserma! Giocavo sempre da solo spesso nel “magazzeno” fra armi, elmetti, “buffetterie” per muli ed altro, ma con a disposizione un telefono della Teti con il quale, chiedendo la linea alla centralinista, potevo chiamare degli zii, unici parenti con telefono. Il telefono era installato dentro il piccolo ufficio di mio padre, senza derivazione nella casa e quindi inutile dalle 19 alle sette del mattino. Quel telefono restò inesorabilmente muto il 25 luglio e l’8 settembre! La sera del 25 luglio, era una domenica caldissima eravamo stati dagli zii, a cena, forse si festeggiava una prima comunione. Tornammo a casa a piedi verso le dieci. Un po’ tardi per il coprifuoco e l’oscuramento, ma mio padre essendo militare poteva circolare. Sul ponte in fondo ai passeggi, al termine della via Flaminia, lo zio fu salutato da due agenti di polizia in borghese e chiese loro cosa facessero. Risposero che aspettavano il passaggio di alcune macchine della “famiglia” dirette in Romagna. Cosa che accadde. Andammo a letto. Mio padre non accese la radio, quindi non sentì l’ormai famoso comunicato di Badoglio trasmesso poco prima di mezzanotte! Dormivamo tutti insieme nella stessa stanza per timore dei bombardamenti, come se questo ci avesse potuto salvare da una bomba! Nella notte, forse le tre, mio padre fu svegliato. Un sergente armato, assieme ad altri due soldati, consegnò a mio padre una busta gialla da ufficio. Mio padre, un po’ preoccupato, con il Reggimento che combatteva in Montenegro e per altre ovvie e comprensibili ragioni, gli chiese cosa contenesse. Il sergente rispose di non saperlo, poi lo sentii bisbigliare “Maresciallo, è caduto Mussolini”. Mio padre disse “era ora”, poi aprì la busta, la lesse, la piegò, si vestì, radunò i soldati che già festeggiavano, (lo avevano già saputo da quello della pattuglia), li fece armare e li dispose ai quattro lati dell’area del deposito. Non so cosa ci fosse scritto in quel foglio, ma da quanto fecero, immagino fosse l’ordine di difendere il deposito, pieno di armi ed altro importante materiale bellico, stivato e mai inviato al Reggimento al fronte! Ricordo centinaia di elmetti disposti in fila per terra nel pavimento, mi impressionavano. Si temeva forse una reazione della Milizia od altro. Non successe niente. Non ricordo nessuna ispezione di qualche ufficiale, tutto sembrava tranquillo. “La guerra continua” continuava a spaventare la gente. Quando qualche giorno dopo uscimmo mia madre ed io (mio padre non poteva lasciare naturalmente il deposito), trovammo una città tranquilla, solo pattuglie armate che circolavano, soprattutto vicino alla stazione ferroviaria. Agosto passò noioso e caldo come sempre ed io segregato più che mai all’interno del deposito fino all’8 settembre. Ma questa è un’altra storia, tragica e seria, da raccontare. Protagonisti i soldati del deposito, alcune famiglie che abitavano nelle piccole case popolari aldilà dell’Adriatica e i treni, i treni con i vagoni “tappezzati”di giovani che cercavano di tornare a casa … 8 settembre: la grande paura Altri ricordi del figlio del maresciallo Non avevo mai visto mio padre in abiti borghesi, sempre in divisa: accadde qualche giorno dopo l’8 settembre, una data che fu certamente più traumatica di quella del giorno della caduta di Mussolini e del suo fascismo. Non ci furono buste gialle, nessun ordine e il telefono rimase silenzioso. Mio padre l’usò spesso per chiamare il centralino del comando del Reggimento, senza ottenere risposta. Allora prese la bicicletta (il 9, il 10?) e si avvio da Piazza d’Armi alla caserma Montevecchio. Restò fuori più di un’ora, i soldati erano molto nervosi e preoccupati. Rientrò e comunicò che nella caserma non c’era più nessuno, solo il rumore di migliaia di fogli di ufficio che il vento faceva volteggiare nel cortile. Tutti erano scappati (qualcuno sembra con la cassa del Reggimento…), dimenticandosi di avvertire un povero maresciallo e i suoi 8 soldati che ancora fedelmente presidiavano un deposito colmo di armi e tante altre cose di valore militare! Ricordo che mio padre disse ai soldati di andarsene (abitavano tutti nelle vicinanze di Fano) nel timore che arrivassero i tedeschi, che ancora a Fano non si erano visti. Cinque di loro se ne andarono subito, tre rimasero. Ricordo che dissero a mio padre “Ma- resciallo, sapete cosa dobbiamo fare prima”. Mio padre rispose”Sì”. Intanto alcune persone che conoscevamo e che abitavano in piccole case popolari aldilà dell’Adriatica vennero a prenderci (mia madre, mia sorella e me) e ci portarono a casa loro dove restammo chiusi per alcuni giorni. Un gesto da non dimenticare, una manifestazione di solidarietà e bontà. Mio padre lasciò il deposito nel tardo pomeriggio. Solo allora i tre soldati se ne andarono: uno a Fossombrone, uno a Fratterosa e l’altro mi sembra a Monterado. Dei primi due ricordo il cognome, curiosamente lo stesso anche se non erano parenti. Quello che ricordo è che erano comunisti e io a sette anni e mezzo lo sapevo. Un volta (prima del 25 luglio) uno di loro prese una falce e un martello, li posizionò come il simbolo e mi disse quando sarai grande, comanderemo noi”. E’ chiaro che mio padre mi impose di non raccontare niente, anche a mia madre che sarebbe sicuramente svenuta! Chiesi a mio padre la sera cosa avessero fatto. Mi rispose “l’inventario”. Era vero. Mio padre prima di chiudere il magazzeno aveva stilato l’elenco di tutto quello che c’era, elenco che conservò e consegnò a Iesi al comando di raccolta del rinato Esercito Italiano subito dopo lo scioglimento nel settembre 1944 del CIL (Corpo Italiano di Liberazione). Qualche mese dopo fu richiamato in servizio fra i primi, non avendo aderito alla Repubblica Sociale. Rividi così di nuovo mio padre in divisa, una curiosa divisa che nulla aveva in comune con la precedente: era un mix di indumenti inglesi ed americani. Ricordo un giaccone invernale verde, americano, che assomigliava a una giacca da casa, calda e comoda, ma certo poco marziale. Solo dopo la guerra mi disse che con i tre soldati avevano reso inutilizzabili le armi, mitragliatori e mitraglie. Gli otturatori, messi in casse furono gettati in mare, dove oggi c’è il go kart. Abbandonammo così la casa con tutto quello che c’era dentro. Un momento tristissimo fu dover lasciare Diana, la fedele sentinella, a cui mio padre era affezionatissimo. Anche lì trovammo solidarietà. La prese un contadino che abitava non lontano dal campo sportivo. Mio padre ed io l’accompagnammo. Fu legata alla catena. Guaì a lungo quando la lasciammo, guaiti che sentimmo a lungo, nel silenzio di quelle notti. Quando tornammo a Fano nella seconda quindicina del settembre ’44, una delle prime cose che mio padre fece fu di andare a ricercare Diana. Ci dissero che era morta qualche settimana dopo che la lasciammo: non mangiava. Era abituata a mangiare solo nella ciotola che le veniva data da uno in divisa! Il problema a questo punto era nascondersi. Fu risolto dal marito della mia balia, che io amavo come una seconda madre. Commerciava in pollame, uova e tutto quello di commestibile che ancora si poteva trovare. Aveva un camioncino e il suo punto di riferimento era Corinaldo. Trovò lì una famiglia (straordinaria) che ci ospitò per un anno. Eravamo sfollati! Partimmo una mattina all’alba. Un ultimo sguardo al deposito, alla nostra 50 casetta, alla casa cantoniera, all’oste- 51 ria della Ilde, dove i vecchietti chiamavano Hitler, Ilter e in barba al cartello che pendeva in una parete, “qui non si sputa per terra, non si bestemmia e non si parla di politica” facevano al contrario gioiosamente le tre cose! Quando partimmo non passavano più i treni dei primissimi giorni dopo l’8 settembre, carichi fin sopra il tetto delle carrozze, di soldati che cercavano di mettersi in salvo e a cui molte donne lanciavano abiti civili. A Corinaldo restammo un anno. Con un particolare di non poco conto. Mani amiche, a cui va una grandissima riconoscenza, fornirono alla nostra famiglia autentici documenti “falsi”. Un altro cognome, carte d’identità per i miei genitori ed altro. Ovviamente se questi documenti a un normale controllo potevano reggere, non erano sufficienti per ottenere sussidi per gli sfollati, carte annonarie, iscrizione alla scuola … Fu un anno difficile e di fame … ma per me un anno senza scuola, in giro per i campi, a tirare con la fionda e ad imparare il corinaldese. Ma fu anche un anno di paure, paure dei repubblichini, dei tedeschi e delle spie. Molti sapevano che mio padre era un militare, ma nessuno lo disse. Per tutti era un impiegato con una malattia renale, era il signor M. Ma anche questa è un’altra storia: di cannonate e morte, di preti e giovani coraggiosi, di persone buone e solidali, che sapevano di rischiare (per primi i nostri padroni di casa), di qualche squallido fascistello, non solo maschio, di qualche opportunista, ma anche della dolcezza della mamma di santa Maria Goretti, vicina di casa, di preghiere e di attesa, un’attesa che durò troppo a lungo: ma gli alleati dov’erano? Anche se di notte da radio Londra giungevano i famosi messaggi che mio padre ed altri (chi erano?!) ascoltavano con attenzione: “ la pipa del nonno è spenta”, i “garofani sono fioriti”… (Da http://www.fanocitta.it, blog di cultura, arte e sport su Fano e dintorni.) • A fianco, 8 settembre 1943, grandi emozioni per il ritorno a casa di soldati italiani. Ma la guerra non era ancora finita, il peggio doveva ancora venire. Mario Omiccioli Valerio Volpini Due liriche Cronaca partigiana Nuvole e ceneri nel vento A Omar Conti Tornano le urne come pallide nuvole vengono e si murano ceneri di cemento su vecchi mattoni ocra - nuvole su scogliere di silenziose montagne. Ormai è spento il ricordo nessuno sa più il colore degli occhi la camminata e le speranze dei morti, in quali case abbandonate di queste onde di colli vissero, se avevan spose e figli, moto, bicicletta o calesse. C’è chi sa che fu l’ultima - ultima per noi guerra terribile la falce della loro breve vita, sa che una spada acuminata trapassò il cuore delle madri, e non la cercavano gli uomini come cancellate di giardini, per dare ferro alla patria; brillavano gemme nelle ciglia delle madri e non le volevano le gazze nere che cercavano l’oro per la patria. Ora son tornati i figli consumati, piccoli, in un cestino di lana, e già dormono le madri sotto le pietre: nessuno vede nelle loro mani l’anello di ferro con l’antico segno dell’oro. Nulla è accaduto, tutto è senza pietà, calmo, ordinato, una pietra in più e in meno, un fiore vivo e uno appassito, le nuvole e la cenere nel vento e uno squarcio di cielo sereno. Due pensieri e due amori Ci sono due pensieri, due amori e sono due case e due fuochi, quelli del carceriere e del carcerato, c’è una pallottola per ognuno dei due e qualcuno ha sparato, c’è una corona di fiori due corone di fiori. C’è una madre piangente e, tra le dune del mare, un’altra silente, c’è una donna sperante ed una sola disperata, c’è un lungo gemito d’amore e un grido febbrile di dolore per tutti i venti del cielo. Ci sono due pensieri, due contrasti, il mare in tempesta guarda il cielo sereno, c’è l’ombra dei più, la spada dei meno: i prati non hanno lo stesso confine i fiumi non gli stessi colori la vita non uguale la fine, ci sono due idee di lotta, due amori, c’è una corona di fiori due corone di fiori ... • A fianco, Mario Omiccioli e Valerio Volpini. Due tra i protagonisti fanesi della cultura della Resistenza. Laico il primo, cattolico il secondo. • Sopra, Omar Conti, perseguitato politico antifascista, nativo di Pieve di Cento, ma fanese di adozione da quando il padre si trasferì con la famiglia a Fano come capostazione FS. Studiò ingegneria a Torino. Subì carcerazioni e lunghissimi anni di confino a Ustica, a Ponza, a Corigliano Calabro, in cui strinse amicizie con antifascisti illustri come Pertini e Amendola. Non li aspettavo; quel giorno avevo deciso di recarmi alla casetta bianca di Cesarin verso i Tre Ponti per vedermi anche con Aldo che stava, poco distante, da Tartàn. La mia base invece era alla Croce di Falcineto. Tino, Libero e Nelio giunsero che già stavo gonfiando la bicicletta. A loro, ai tre moschettieri, andava sempre l’acqua per l’orto e m’irritava che facessero sempre tutto facile, sempre molto alla garibaldina. “Dobbiamo andare a prendere un fucile mitragliatore e alcune cassette di munizioni vicino a casa mia”. Aveva parlato Libero che stava sfollato in una casa lungo il fiume all’altezza di Lucrezia. Era abitudine non chiederci dettagli sulle informazioni e chi o perché. Io funzionavo da “comandante “ e cercavo di fare le cose per bene e di passare sempre attraverso il rischio minore e di non mettere nei guai, ma a volte temevo che questo potesse sembrare timore o incertezza al loro giudizio. Ero il “ comandante “ del GAP ma anche il più ragazzo di tutti e questo, in realtà, mi metteva in uno stato di soggezione più che non mostrassi. “Ma non ci si può andare stanotte? Se andiamo in cinque , con quel che c ‘è in giro. E poi dove sono queste armi?”· “No, bisogna andarci subito e tutti perché è roba che pesa”. “Prima ci fermiamo a casa a mangiare la frittata. Mia moglie ha trovato le uova e abbiamo anche il vino”· Libero era di tutti il più euforico, Tino il più sicuro di sé, Nelio il più lucido. Di giorno preferivamo andare isolati e incontrarci solo nel momento necessario. Di soldati tedeschi ce n’erano molti perché uno dei guadi sul Metauro era propria alla Chiusa. A cento metri dalla casa di Libero ci incrociò una pattuglia; ci guardarono appena; erano preceduti da una topolino mimetizzata con a bordo due in abiti civili: gli altri erano con le biciclette a mano o a piedi come noi. “Ragazzi è meglio non fermarci in casa; mi sa tanto che a quelli abbiamo dato nell’occhio. Se andiamo in casa potremo far la fine del sorcio. E’ meglio che ci sparpagliamo e fra un’ora ci rivediamo, tanto le armi aspettano”· “Ma mia moglie prepara da mangiare e abbiamo fame; quelli ormai chissà dove sono andati”. Sulla porta feci un altro e poco convinto tentativo di dissuaderli. “Ma se te non hai fame vai sotto l’ombra a dormire”· Non potevo imporre un comportamento che, dopotutto, era discutibile. Non avevamo fatto in tempo a sedere che risentimmo la topolino. “Ve l’ho detto; disgraziati, ve l’avevo detto sì o no? Usciamo e facciamo finta di niente”· Io, Nelio e Loris uscimmo di fianco casa. Libero e Tino passarono, da dentro, nella cantina. Pensare di mettersi a sparare era assurdo; c’erano le famiglie dei contadini e non avremmo fatto altro che far ammazzare tutti. Dovevamo recitare a soggetto. Ma non avevamo fatto in tempo a fare qualche metro all’aperto che con la topolino arrivarono gli altri. Ci puntarono contro le armi urlando che ci avvicinassimo con le mani alzate. Non eravamo più lontano di una quindicina di metri. Quando vidi che Loris e Nelio obbedivano fingendo di essere stupiti capii che erano spacciati; Loris aveva in tasca la “Berretta-lunga” che gli prestava Otello e Nelio una bomba a mano. lo avevo la “Berretta corta”· Non pensai di sparare, ma neppure di alzare le mani come loro. Non avrebbero potuto scamparla in ogni modo e tanto valeva che cercassi di scappare. Io ero discosto da Nelio quattro-cinque metri e con un balzo presi l’angolo della casa. Cominciarono a sparare all’impazzata e a urlare alt alt. Mi abbassai dietro la capanna degli attrezzi e mi tolsi le scarpe. Sentii i proiettili delle raffiche conficcarsi per terra con quel rumore ovattato che ricorderò sempre come i soffi della morte. Lo scoppio delle raffiche e le grida dei tedeschi mi parevano d’un altro mondo. In istanti come questi credo che anche l’istinto si metta in moto come un compiuter per aiutare a scegliere la soluzione migliore. In me il terrore lo aveva messo in moto. Ormai avevo dato già morti gli altri e io non dovevo pensare che a salvarmi. Oltre la capanna c’erano venti-venticinque metri di scoperto e poi cominciava un fittissimo filone di granturco alto (era la fine di luglio) e se fossi riuscito ad arrivarci potevo avere qualche speranza. Ricominciai la corsa frenetica e dal compiuter subcoscienziale tornò la scheda di una lettura di ragazzo; i fumetti di Cino e Franco (i cinquanten- ni li ricordano) che mitragliati avevano 52 pensato di correre a ziz-zag; corsi a zig- 53 zag alla disperata mentre avvertivo ormai solo i sibili delle raffiche a un metro o a un dito dalla testa. Davanti c’era il verde e la luce accecante della giornata estiva. Entrai galoppando nel granturco che mi fasciò e mi coperse con la buona sensazione del nascondimento alla morte che alla bestia braccata deve dare la propria tana. Ancora l’istinto nell’informe e totale invocazione alla Madonna di Loreto; era una preghiera senza parole, fatta con tutte le fibre della coscienza. Quei dannati continuavano a spararmi freneticamente. Sentivo cadere tagliate le piante di granturco intorno, ma ormai sparavano alla cieca perché io mi misi a correre fra solco e solco per non scoprire, col movimento delle piante, la mia posizione. Mi accucciai verso la fine e mi tolsi la camicia chiara che mi distingueva troppo e fui di nuovo allo scoperto. Dietro una casa mi specchiai nei volti esterrefatti di alcune persone immobili (c’era, poi me lo raccontò, anche quell’Omiccioli capomastro che dirigeva la Cooperativa del Metauro) mentre io spremevo le mie ultime energie di mediocrissimo centometrista per trovare dove proseguire e allontanarmi ancora. Smisi di correre quando non ne potevo proprio più. Ormai le raffiche erano cessate; non mi vedevano. Tornò la ragione e la logica. I sentimenti e una incredibile indescrivibile gioia fisica... Sono vivo. sono vivo, non mi hanno ammazzato... Ma poi anche e subito il tormento per gli altri quattro che erano morti. E il rimorso: “io non ho fatto niente per aiutarli e non sono morto con loro”. Comunque dovevo muovermi; dovevo andare alla base e poi riferire subito a Cesarìn. Lungo un filare incontrai un anziano contadino che sbroccava le viti. Gli chiesi se aveva sentito la sparatoria; “Ostia, se l’ho sentita”· Era a torso nudo coi soli pantaloni; mi sfilai i miei e gli chiesi i suoi. Dovevo cambiare connotati così se quei maledetti mi avessero cercato potevo cavarmela. Quel contadino che non mi chiese nulla era Ruscin, il padre di Manlio, fidanzato di una mia cugina dov’eravamo sfollati e dove avevo la base. Prima di avvicinarmi a casa mandai una ragazza, che avevo incontrato, a vedere se c’erano tedeschi; dovevo essere stra- lunato ed eccitato perché cominciò a tremare e poi di lontano mi fece cenno di proseguire. Raccontai a mia madre quel che era successo. Ci aveva visti andar via in cinque; “gli altri li hanno ammazzati e io non so ancora come ho fatto a uscir vivo”· Dovevo comunque andarmene subito; dopo ogni azione era sempre meglio scomparire. Mi rivestii, tagliai di fuga la barba che m’ero fatto crescere da qualche settimana (oh l’incosciente) senza bagnarmi la faccia e - potete credermi - senza fare il contropelo. Dovevo andarmene e cambiare pelle. Presi a braccetto mia sorella quattordicenne (che m’aveva aiutato più d’una volta, come staffetta e persino recapitando qualche sporta di bombe a mano) per arrivare da Cesarin. Se mi avessero incontrato i tedeschi sarei passato per un innamorato che non ha nessun pensiero della guerra. A Bellocchi rimandai indietro mia sorella. Cesarìn si scomponeva sempre poco e pareva che prendesse gusto ad essere freddo e ironico in tutte le occasioni. Credo che talvolta facesse il duro apposta. Non si scompose neppure al racconto che gli feci. Sottolineai il mio comportamento poiché ora sentivo il rimorso del superstite. “Sei stato bravissimo a farcela; no, sei stato solo fortunato”· “Ma gli altri quattro son morti e non mi dici che questo?”. “Mo, o testa de c .. , vlevi murì anca te?” e mi piantò una di quelle risatine beffarde a mezza bocca che lui solo era capace di fare. “Adesso resti qui; fino a domani non ti devi muovere”. Ero solo con la stanchezza e il dolore per gli altri quattro; ero spossato dall’emozione e questo giocava sui nervi e mi pareva una colpa il non essere morto con loro. Le parole di Cesarìn non mi avevano convinto. Loro avevano anche famiglia e figli. “Chissà che avranno pensato di me? Chissà come mi avranno giudicato?”. Mi sentivo proprio a terra e non riuscii a chiudere occhio tutta la notte per quanto mi fossi buttato a riposare su un mucchio di sacchi vuoti assai comodi. Fu una delle mie notti più lunghe; sentivo il fischio del trenino sulla Metaurense e non pensavo che avrei dovuto far saltare di nuovo i binari. Fino ad ora non avevo mai visto la morte così vicino e non ave- Ricordo di Giannetto Dini vo mai sofferto per quella degli altri di cui mi sentivo corresponsabile. “Dovevo impormi, dovevo obbligarli a fare quello che dovevo comandare; ero stato un debole e li avevo condannati”. La sera dopo tornai alla base. C’era stato un seguito: poco dopo che m’ero squagliato con mia sorella i tedeschi, quei tedeschi, avevano circondato la casa e con grande eccitazione l’avevano perquisita da cima a fondo. Mia madre capì che erano proprio quelli di cui sapeva. Rovistando trovarono della roba della drogheria che Esposto (la drogheria di via Giordano Bruno) aveva sfollato. Presero alcune bottiglie di liquori e si diedero una calmata; così mia madre cercò di sapere “ tirando a scartare”. Le mostrarono la pistola e una bomba che ci avevano tolto: “Partigiani, partigiani molti, bosco, e le sembrò di capire che fossero scappati tutti e che non erano riusciti a fare caput a nessuno. E dopo un paio di giorni (per rassicurarmi su una bagatella del genere non se la sarebbe presa calda) Cesarìn venne a dirmi che non era morto nessuno, che io ero un po’ troppo pessimista e che all’indomani dovevamo incontrarci con i due-tre capisquadra, con Aldo e 0tello, per vedere di stabilire quel che si poteva ancora fare. Era andata così: disarmati e messi al muro c’era stata una gran confusione; le donne e i bambini che piangevano, i sol- dati tedeschi sconcertati; alcuni erano intenti a spararmi altri a prendere posizione sulla strada. Quelli che dovevano sparare su Loris e Nelio esitarono e loro, quando videro che il maresciallo che li comandava stava per strappare la pistole-machine ad un soldato per incaricarsi dell’esecuzione, fecero civetta e scattarono verso la macchia del fiume sul davanti della casa. Con loro erano stati più precisi nel tiro perché Nelio trovò un buco nella camicia. Evidentemente anche i tedeschi avevano una gran paura di essere circondati; con tutte quelle piante intorno erano convinti che chissà quanti partigiani dovevano esserci. E si affrettarono a cambiare aria. Il mistero che non sono riuscito a sciogliere è come avessero fatto ad arrivare alla mia base. Non era pensabile che fosse stato per caso; di abitazioni di contadini tra Lucrezia e Falcineto ce n’erano a centinaia e, d’altro canto, non avevo mai subito perquisizioni, nessuno s’era mai fatto vivo. Non ho mai capito se quei due in abiti civili entro la topolino fossero gli stessi che un paio di volte si erano spacciati per venditori ambulanti di filo e di sale e che invece di vendere facevano domande curiose sui partigiani e sui tedeschi, domande alle quali naturalmente mia madre e gli altri si erano guardati bene dal rispondere. Lei li conosceva di vista, ma non mi curai più, dopo la liberazione, di farmeli indicare. Io ti ricordo quando assieme a Sandro, a Max, a Drago, a Serjosa, a Mario, agli altri stavamo davanti al gran fuoco nella casa di Giovanni di Dindi Boja, lassù, in montagna fra la neve. Parlavamo di tutto. Cose solite e cose nuove, che avevamo poste alla nostra meditazione con amore ed entusiasmo: libertà, giustizia, diritto del lavoro ... Allora c’era una specie di voluttà nel sentirsi braccati a causa di quella Verità, per via di quella lotta dalla quale doveva sorgere il nuovo mondo scevro dai falsi idoli. Ed era bello che ancora una volta dal dolore e dalla fatica dei giovani sorgessero gli uomini della libertà. Quante cose dovrei ricordare di te Giannetto! Che eri il più coraggioso, che seppure il più giovane, il più “uomo” ... ma lasciamo stare, dal momento che più di tutti hai dato è naturale che eri più di tutti ... E ti hanno ucciso per questa tua Fede che è la nostra e che non potevano uccidere perché era più forte del loro odio. Sei caduto per quelle parole, le nostre parole, per quel mondo che tu sentivi come sentivi nelle tue vene il sangue ribelle. E tu hai dato per tutti noi, per ognuno di noi che non ha saputo dare come te ... per Sandro comunista, per Max ebreo, per Drago slavo, per me democraticocristiano, per tutti gli uomini nei quali riconoscevi la tua stessa umanità e che al di sopra di ogni singola idea ci fa fratelli. Vorrei dirti ancora, ma ho paura di poter falsare ... io ti ricordo così davanti al fuoco, era gennaio, parlavi poco e poco ridevi ed il tuo sguardo era oltre. (Valerio Volpini, “Costruire”, 5 aprile 1946) La Resistenza: cinquant’anni dopo Ci sono certamente dei rischi nel ricordare la Resistenza e la Liberazione e prima di tutto quelli di lasciarsi prendere dall’empito della memoria privata e dalla retorica. Ma sono rischi che bisogna pur correre e senza indulgere a nessuna sorta di trionfalismo, rendere testimonianza ai fatti della verità storica ed a quanti di quegli eventi storici sono stati protagonisti. La memoria storica è la coscienza dei popoli ed una componente della loro stessa civiltà. In particolare negli ultimi decenni - di parte o di contro-parte che sia - si è molto discusso (e polemizzato) su quello che è stata la Resistenza. Tentativo di rivoluzione politica, guerra civile, liberazione. Non credo di dire cosa originale che a seconda di chi ha vissuto la Resistenza stessa c’è stata un’intenzione diversa ma erano modi che avevano un innegabile denominatore comune e cioè l’intento di liberare l’Italia e l’Europa dalla occupazione nazista. C’era insomma la volontà di sconfiggere Hitler e l’Europa dalla occupazione nazista. opporsi alla sua volontà di dominio fondato sull’aberrante principio dell’odio razzista ed in parte attuato attraverso la distruzione fisica degli ebrei e di altri gruppi di uomini e donne considerati esseri “inferiori” da cui purificare l’Europa medesima. Non si può dimenticare la mostruosità dell’Olocausto quando si parla di Resistenza perché solo di fronte ai fatti che la soluzione finale si può capire e far capire che la Resistenza è stata prima di tutto la ribellione dell’Europa e del mondo, il rifiuto degli uomini della vecchia Europa di annullare millenni di civiltà e in primo luogo il senso del sacro rispetto per l’uomo. Sarebbe troppo lungo in questa sede descrivere quello che tra il 1939 e il 1945 ha rischiato di essere distrutto in umanità e verità. Non è necessario fare il calcolo ragionieristico di quanto la Resistenza ha dato alla liberazione perché quello che conta è stato il soprassalto morale di fronte all’infuriare della “matta bestialità nazista”. E non è certamente giusto distinguere fra chi ha opposto la difesa arma- ta da chi nei campi di concentramento 54 nazista ha resistito senza piegarsi alle 55 lusinghe dei carcerieri. Bisogna infatti considerare che la Resistenza non è stato un fenomeno italiano ma una scelta degli europei che hanno poi saputo trarre nella loro lotta per il destino del mondo anche altri popoli. Non si può dimenticare che l’Europa è segnata di bianche croci di giovani caduti giunti a sostenere in nome della comune dignità il feroce duello dell’uomo contro il non-uomo. E naturalmente non è neanche il caso di ripetere che nel ricordo della Resistenza c’è l’impressione di una comune pietà per tutti coloro che hanno patito, che hanno sofferto fame e paura, che hanno avuto strappi non rimarginabili negli affetti. In fondo Resistenza era opporre pietà, fraternità contro l’odio. Una forte scommessa sull’amore nel quale entrano anche la comprensione per quanti in buona fede e ingenuamente rappresentavano purtroppo il potere degli aguzzini. A cinquant’anni deve essere chiaro alla mente ed al cuore quel che ha significato la Resistenza non certo per provocare nuove divisioni ma anche senza confondere il vero con il falso. (Valerio Volpini, “Il nuovo Amico”, 31 luglio 1994, Editoriale) • Sotto, partigiani della 5a Brigata Garibaldi Marche al disarmo in Urbino. Al centro, col cappello, il comandante Giuseppe Mari (Carlo). Marco Ferri Remo Rovinelli si racconta Io sono uno di quelli che per la questione … dei comunisti … dal 1920 in avanti io sono stato sempre così ma è dopo il 1920 che abbiamo … c’erano diverse cose appunto brutte … c’erano i fascisti, così io ero preso di mira, ero preso di mira e un bel momento, la sera del primo gennaio 1922, sono venuti a Fano non so quanti fascisti e nella notte hanno cercato i sovversivi perché noi ci chiamavano sovversivi e ci hanno presi, a me e un altro compagno che si chiama … che abita … mah! Verrà fuori … e quella notte dicevo mentre nasceva mio fratello sono venuti a prendere me. Io ero in convalescenza, ero soldato, era l’ultimo giorno di convalescenza … insomma ci hanno … e di lì poi è venuta una cosa sempre più brutta … ad esempio io avevo un libretto marittimo e non ho più potuto averlo. Me l’hanno requisito. Così ero un uomo … senza più niente, senza … prima avevo fatto il marinaio, ero stato in Grecia, nel 1919, ma dal 1926 in avanti sono stato sempre sotto le grinfie dei fascisti. Non sono riuscito a espatriare. Tanti andavano all’estero. Io non ci sono mai riuscito. Dicevano che eravamo in molti a Fano, un paio di cento dicevano. C’erano i giovani. E facevamo un giornale: “La Scintilla”. Il povero Venturini doveva fare il … come si dice, lui aveva buttato giù … il pezzo! Il pezzo … perché Nesti e Petrolati avevano la possibilità di stampare. E avevano con loro un uomo che noi non conoscevamo bene. Allora il partito comunista era a cellule e ogni cellula era composta di tre persone. Non come oggi. Ebbene, questa persona la chiamavano Landrù. Landrù! Questo Landrù andava a casa di Petrolati e siccome era povero gli davano gli abiti vecchi, i vestiti dei figli, non era molto considerato … ed è stato lui a portare il foglio al capitano dei fascisti che si chiamava … mah! Comunque … questo capitano ha portato la faccenda alla lunga per un mese, voleva prenderci tutti anche se, come dico se loro avevano le loro spie non è che noi ignoravamo tutto … difatti, a me vengono a dire, dice: siamo traditi. E da chi, chiedo io. Eh, dice, uno che si chiama Landrù ci ha traditi. Naturalmente quella sera parliamo con Nesti e Petrolati. Gli dico: guarda, così e così, ormai siete pedinati. Da un momento all’altro vi prendono. Non c’è via di scampo. Eh, dice, vedrai che noi ci sappiamo fare … insomma, dico io, guardate che quando vi prende la polizia non si sa come va a finire … così ci hanno presi tutti. Un centinaio, tra Fano e Pesaro. E siamo rimasti in tredici davanti al tribunale speciale. Io ho avuto sette anni. Altri ne hanno avuti dieci. Altri meno, perché nel 1932 c’era stata l’amnistia. Allora ho detto … quando non potevo lavorare, rompevo i sassi con i martelli, per portare la ghiaia sulle strade. Ebbene, un bel momento hanno detto a quello che faceva … come si dice, che prendeva il materiale, gli hanno detto che non doveva prendere più roba da me … ecco, l’appaltatore! Che dice: guarda, hai tre o quattro o cinque metri di roba. Questa te la prendo ma dopo non posso più prenderla. Così facevo tanti lavori. Cercavo … inverno 1977 Il racconto è pubblicato in “Noi che siamo uomini ancora gustosi” di Marco Ferri e Paolo Talevi, Nuove Carte, Fano 1978. • Sotto, Remo Rovinelli, al centro, mentre spiega le vicende della sua vita agli amici. La foto è di Paolo Talevi. 56 57 La guerra sul corpo delle donne Dopo l’armistizio, il secondo conflitto mondiale assunse le caratteristiche di guerra civile e di guerra totale. In questo arco di tempo il coinvolgimento della popolazione e delle donne in particolare crebbe enormemente. Gli schemi che regolavano la normale convivenza civile saltarono, lasciando spazio a varie forme di violenza, soprattutto laddove l’occupazione tedesca si protrasse più a lungo: nei fronti di guerra come la Linea Gotica. L’atmosfera di emergenza e precarietà provocò un allentamento delle inibizioni che a volte si tradusse in libidine violenta o stupri. Questa drammatica esperienza fu vissuta da molte donne, alcune la subirono senza potersi difendere, altre, più fortunate, riuscirono in qualche modo a salvarsi. Ques’ultima è anche la storia della fanese Elsa Volpini, che lei stessa ci racconta in un libro dedicato alla sua vita: «... due tedeschi spalancarono a calci la porta di casa, entrarono nella grande cucina e cominciarono a cercare in ogni angolo. Spaventatissima, corsi per le scale che portavano al piano di sopra e mi nascosi sotto il letto della nonna, nella stanza che dava sul retro della casa. Ma anche loro vennero su, capirono subito dov’ero e coi fucili puntati mi urlarono di uscire. Erano armati fino ai denti e mai più potrò dimenticare quel giovane viso triangolare che mi squadrava freddamente nel momento in cui uscivo da sotto il letto e mi rialzavo. Dai suoi occhi compresi benissimo quali fossero le sue intenzioni e mi sentii morire. Inconsapevolmente ebbi però una reazione fulminea: sapevo che la finestra era aperta e così mi slanciai di scatto in quella direzione e mi gettai di sotto [...], poi un altro salto e via in mezzo al granoturco, che in quell’estate del ‘44 era cresciuto bello alto» (Volpini, 2004 p. 113). Elsa si salvò, ma la sua famiglia visse molte ore di angoscia: infatti i tedeschi, infuriati dall’essersi fatti scappare la ragazza, minacciarono di morte i suoi genitori nel caso lei non fosse tornata. Li fecero poi scendere in una buca scavata precedentemente dal padre come rifugio antiaereo e li coprirono con un tavolo, lasciandoli lì per un tempo imprecisato. Solo alle prime luci dell’alba, quando non si sentivano più rumori, i due uscirono dalla buca: «Uno spettacolo agghiacciante si presentò ai loro occhi: la casa bruciava e le fiamme avevano già raggiunto il tetto; e tutt’intorno bruciavano le altre case coloniche in uno scenario apocalittico a cui nessuno aveva mai immaginato di dover assistere. Bruciò il corpo della nonna – già asfissiata dal denso fumo che aveva avvolto la sua stanza – bruciarono le ultime bestie rimaste e bruciarono tutte le nostre masserizie» (E. Volpini, 2004 p.115). Fonte: Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche, Ancona. A ulteriore commento si può solo qui aggiungere che le molestie sul corpo delle donne avvengono tuttora anche in contesti diversi da quelli bellici, purtroppo. E’ certo che la guerra rende questa sopraffazione, se possibile, ancora più terrificante. Ed è doveroso non circoscrivere questo tipo di barbarie alla sola soldataglia tedesca, che di sicuro non può trovare scusanti. In seguito le donne tedesche subiranno, per contrappasso dai vincitori sovietici occupanti, la stessa sorte a prezzo gravato di alto interesse. Ma, per restare in Italia, anche fra le truppe alleate ci fu chi si macchiò dello stesso tipo di crimine, basti ricordare, ad esempio, lo splendido film di Vittorio De Sica, “La Ciociara”. Come dire che il peggio della natura umana è trasversale più di quanto si possa essere portati a credere. (D.P.) • Sopra, una drammatica immagine del film “La Ciociara” che racconta la vicenda di madre e figlia adolescente, violentate da un plotone di marocchini, del Corpo di spedizione francese alleato, risalente la penisola verso Roma, nel 1944. Sophia Loren ottenne l’Oscar per la recitazione. Nella realtà è stato stimato che il numero di stupri e violenze carnali, compiuti tra Campania, Lazio e Toscana ammontò a oltre 60.000. Giuseppe Perugini Tribunale italo - tedesco: condanna e morte del diciottenne Giovannino Contigiani “L’episodio che ci piace riportare è quello riferitoci da Mons. Giuseppe Amici Rettore del Pontificio Seminario Regionale, che ha avuta tanta parte nel tragico svolgimento del medesimo. Nel luglio 1944 i tedeschi avevano già, qui a Fano, il tribunale militare nella villa di Giannetto Montanari al Viale Margherita (ora Bruno Buozzi) n. 10, con la prigione per i condannati, nei relativi sotterranei. Nel pomeriggio del giorno 15 luglio, in questo tribunale si svolse il processo a carico del diciottenne Giovannino Contigiani. Era il Contigiani uno studente universitario, orfano di padre, oriundo di Gaeta e sfollato a Roma con la mamma e la sorella, dove era anche impiegato per guadagnare un po’ di sostentamento per sé e per i suoi. A Roma, in un momento di entusiasmo, tutto proprio dell’ età giovanile, decise di arruolarsi con le truppe tedesche e servire nelle loro file, ma ben presto se ne pentì; disertò e fu arrestato. Pochi giorni innanzi alla sua cattura fu comandato di accompagnare le bestie razziate da Ascoli Piceno a Cesena, e, durante questo lungo tragitto, passò anche per Fano. Fatta questa “corvée” ritornò indietro per rientrare al reparto in cui era assegnato e nel ripassare per Fano venne a sapere che Perugia, perduta dai nazisti, era stata occupata dagli Alleati. Il ragazzo già tanto pentito del suo arruolamento, decise subito di scappare, raggiungere Perugia per poi ritornare a Roma fra le braccia della mamma e della sorella. Fu arrestato e condotto immediatamente nella prigione di Viale Margherita. Fu processato, giudicato e condannato a morte quale disertore. Erano le ore 20,30 di quel brutto giorno quando una macchina si fermò dinanzi al Seminario Regionale in Via Flaminia; scese un soldato tedesco e domandò di un sacerdote. Senza tanto esitare, il Rettore Mons. Amici accettò l’invito e salì sulla macchina, recando con sé la SS. Eucarestia, presumendo che si dovesse dare i conforti religiosi a qualche moribondo. Non sapendo, però, dove dovesse andare, chiese all’autista: “Per dove: per chi? per un italiano? per un tedesco?”. “Per un disertore italiano condannato a morte che ha chiesto i conforti religiosi” rispose il tedesco. E portò il sacerdote nella prigione alla villa Montanari. Appena giuntavi, il giovane condannato gli si buttò con le braccia al collo e se lo strinse forte forte al petto come per non separarsi più. Poi chiese ed ottenne di restare soli nella prigione. Il tribunale militare, qui a Fano, era composto di tre ufficiali: due tedeschi ed uno italiano. Il sacerdote per non fare spegnere l’ultimo barlume di speranza, si avvicinò all’ufficiale italiano e supplicò per poter salvare il povero ragazzo. “Non è possibile, non è possibile, non si può, lei faccia su di lui quello che può e vuole, non si può fare di più” rispose l’ufficiale in tono freddo. Il Contigiani si confessò, si comunicò e gliene venne nell’animo tanto conforto, da essere rassegnato. Durante la notte, e fino all’ultimo istante prima dell’esecuzione, avrebbe voluto essere continuamente assistito dal sacerdote. Costui provò di restare ancora; non gli fu permesso. All’indomani, 16 luglio, alle ore 4,30, una macchina tedesca si presentò di nuovo di fronte al Seminario Regionale; doveva riportare Mons. Rettore nella villa Montanari. Giuntavi, e sceso nella prigione, trovò Giovanni Contigiani addormentato. Dal lato sinistro della branda, sopra uno sgabello, aveva collocato l’immagione dell’Ecce Homo e, da una parte e dall’altra, le fotografie della mamma e della sorella. Quel figliolone, un allievo dei Salesiani, si svegliò e con gli occhi assonnati si accostò, con un sospiro di sollievo, al sacerdote. Erano le 4,45 ed il colloquio fra i due si protrasse oltre le 5,30, ora in cui furono avvertiti esser giunto il momento di salire in macchina per andare al luogo del supplizio. Vi salirono in quattro, il condannato e il sacerdote nel sedile posteriore e l’autista e un altro tedesco armato, davanti. Dalla villa Montanari si diresse verso l’Arco di Augusto, vi passò sotto, e proseguì per il viale Cristoforo Colombo; arrivò in fondo alla spiaggia, voltò a destra, continuando ancora, lungo il viale Adriatico, giunse dinanzi alle due case abbinate n. 84 e n. 86. Qui era il luogo del supplizio, dove già alcuni militari e il plotone di esecuzione (dodici soldati) attendevano per lo svolgimento del tragico epilogo. Il condannato, fatto avvicinare accanto ad un albero smozzato, cui doveva essere legato, rimase lì, immobile ad attendere la sua triste sorte. Il plotone se lo vedeva di fronte e all’intorno altri, tra soldati, ufficiali, l’ufficiale medico, una quarantina di persone in tutto. Al disertore, già vicino al palo, fu posto dalla parte del cuore, appuntato nel taschino della giubba, uno straccetto bianco, indicante il punto da essere preso di mira nel far fuoco. Mons. Amici, dopo di aver consegnato all’infelice ragazzo un bel Crocifisso d‘argento, rimase al suo fianco. L’ufficiale tedesco prima di comandare il fuoco, chiese all’infelice se avesse qualche cosa da dire. Ecco un repentino colpo di scena: Lui, il primo attore della tragedia, parlò subito e chiese di vedere il soldato che lo aveva arrestato, poiché già riconosciuto tra quelli del plotone di esecuzione. L’ufficiale in lingua tedesca disse: «Chi ha arrestato questo giovane si faccia avanti». Dal plotone si staccò un soldato con il mitra tra le mani, e si accostò alla vittima che gli buttò subito le braccia al collo e lo baciò con grande effusione da una parte e dall’altra del volto. Il soldato tedesco confuso, esterrefatto, non fece alcun gesto; restò impassibile; e, in quel momento supremo: “Ti perdono, ti perdono”, ripeté più volte il condannato. Mentre gli sbirri legavano il morituro al palo, il sacerdote sempre vicino, gli dette l’assoluzione. Prima di fare fuoco lo bendarono. L’ultima assoluzione, l’ultimo colpo di rivoltella da parte dell’ufficiale e il Contigiani spirò. Mons. Amici avrebbe voluto interessarsi di dare alla salma una regolare sepoltura, ma un’altro ufficiale, con un rigido e brusco gesto di mano, ordinò all’autista di caricare il sacerdote sulla macchina, lì accanto, per riportarlo al Seminario Pontificio Marchigiano”. (Giuseppe Perugini, Fano e la seconda guerra mondiale, Bologna, 1949, pagg. 180-185). Giuseppe Perugini Giuseppe Perugini: chi era? Scalza, sulle stoppie del grano, senza avvertire dolore Il cronista fanese di guerra più citato che conosciuto Dal racconto dell’allora ventiduenne Ester Angelucci su quanto le accadde la mattina del 5 agosto 1944. (Giuseppe Perugini, Fano e la seconda guerra mondiale, Bologna, 1949, pagg. 188-189). Nell’elaborazione di questa sintetica ricerca su aspetti dell’ultimo conflitto mondiale, in particolare per quanto essi abbiano interessato la città di Fano, ho trovato, al pari di altri studiosi, grande utilità e una miniera di fonti di riferimento, nella lettura del libro “Fano e la seconda guerra mondiale” di Giuseppe Perugini. Questa introvabile pubblicazione, edita a Bologna nel 1949, di cui raccomanderei la ripubblicazione magari annotata da precisazioni a commento espresse da Enzo Capalozza, mi è stata prestata da Carlino Bertini che l’aveva avuta da Tom Storer quando questi era ancora in vita. Si tratta della cronaca più ampia e coscienziosa, esistente a tutt’oggi, sugli avvenimenti riguardanti Fano, correnti fra gli anni 1938 -’947. Quindi un resoconto fondamentale. Ho chiesto in giro, tra la popolazione fanese anziana, notizie biografiche sull’autore ma pochi hanno saputo dire qualcosa e peraltro in modo vago e confuso. Il fatto mi ha un po’ meravigliato spingendo la mia curiosità ad andare più a fondo nel tentativo di dare un volto e una più precisa identità alla persona in questione. I dati di partenza risultano dalla sua narrazione quando, subita un’intrusione da parte di due soldati tedeschi nella propria abitazione e accusato di essere una spia degli inglesi, a causa della raccolta di notizie che conservava in preparazione della sua fatica letteraria, si mette a spiegare, di fronte al mitra spianato - a quindici cm. dallo stomaco (sic)- in preda a comprensibile agitazione, di essere un ufficiale in congedo dell’esercito italiano e mostrando la tessera dell’appartenenza all’Associazione mutilati e invalidi di guerra. Questo bastò a convincere della sua sincerità il caporale tedesco, che, grazie a Dio, parlava un buon italiano (pp.185-187). Altra affermazione diretta: abitava in una zona non sottoposta all’obbligo di sfollamento perché al di là della circonvallazione delle mura del centro storico. Al cimitero urbano dove mi sono recato per continuare la mia minimale indagine, il caso mi ha fatto incontrare la gentilissima custode Rita – la ringrazio viva- “... l’altro tedesco mi fa cenno di seguirlo. A pochi passi di distanza, scendendo un piccolo greppo, sotto due grosse quercie, scorgo due capanni e in uno di quelli mi fa cenno di entrare: la paura andava sempre più crescendo poichè non vedevo vicino nessuna probabilità di salvezza. Mi sono messa a piangere, dicendo che non vi sarei entrata; allora mi sono sentita puntare contro il fucile; ma, vedendo che nemmeno quello m’intimoriva, mi ha presa per un braccio e mi ha spinta dentro; appena entrata mi ha fatto cenno che mi dovevo spogliare; nel vedere quel gesto ho detto che non l’avrei fatto; allora ha caricato il fucile e poi me lo ha nuovamente piantato addosso. Tanta fu la ripugnanza che, piuttosto che cedere preferivo morire; pensavo fra me: che cos’è un colpo di fucile? Le sofferenze sarebbero state poche. Giorni prima avevo letto le gesta della dodicenne Maria Goretti di Corinaldo (Ancona) che si è fatta martirizzare piuttosto che essere contaminata; tale pensiero mi dava aiuto per prepararmi alla morte piuttosto che cedere. Ho chiesto aiuto al Signore proferendo queste parole: «Signore, io muoio per salvare la mia purezza, fate rassegnare quelli di casa, aiutatemi». Le forze le avevo ormai perse; il tedesco è stato un poco silenzioso, poi ha detto: «adesso chiamare altro camerata», e poi è uscito in direzione di dove era il compagno. Non ho fatto in tempo a vederlo uscire dal campo che una forza, datami certamente dall’Alto, mi ha ispirata a fuggire, lasciando nel capanno gli zoccoli, poiché, data la minima distanza, mi avrebbero potuto udire. Benchè corressi scalza per la prima volta sul campo dove avevano mietuto il grano, non sentivo alcun dolore. Ringraziando Dio sono riuscita a raggiungere la casa più vicina senza essere veduta”. 58 59 mente – peraltro portatrice dello stesso cognome del nostro scrittore (la coincidenza la incuriosiva molto al pensiero di possibili parentele) che consultando i registri e facendo sopralluoghi fra le tombe di vari omonimi mi ha fatto trovare, addossata al muro, la sua sconosciuta fotografia e quella della di lui moglie. La grigia lapide porta la data di nascita 13 agosto 1883 e di morte 5 marzo 1966. La consorte, Ione Cavallini, 1883/1949. Dalle relative schede di sepoltura risulta che entrambi erano nativi di Cingoli e residenti a Fano in via Alessandro Nini, n. 21. Dunque nei pressi dell’Ospedale, fuori dall’allora circonvallazione. Il conto mi tornava perfettamente. Si sposarono a Cingoli nel 1913. La signora Ione apparteneva alla nobile famiglia dei Cavallini. Al momento null’altro. Mi pare comunque un minimo per restituire visibilità alla figura fisica dello schivo cronista al quale il Sindaco di Fano, Silvio Battistelli, inviò la lettera di cui lo stesso Perugini pubblicò uno stralcio in apertura del suo libro: ... Il suo lavoro “Fano e la seconda guerra guerra mondiale” risulta diligente e accurato da incontrare un generale favore. Mi è grato, pertanto, esprimerLe il più vivo compiacimento di quest’Amministrazione Comunale per la sua nobile fatica nell’intento di consacrare alla storia le vicende della nostra Città duramente provata nel recente conflitto mondiale... (D.P.)
Scarica