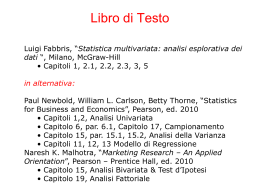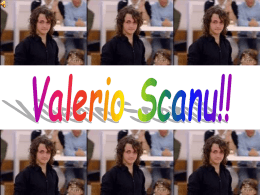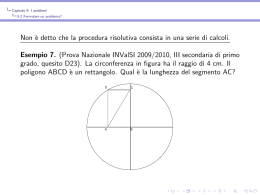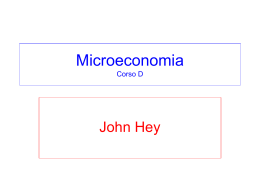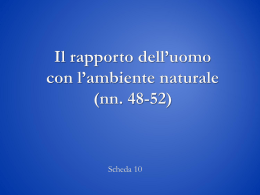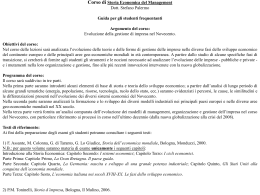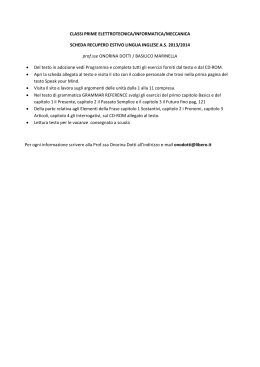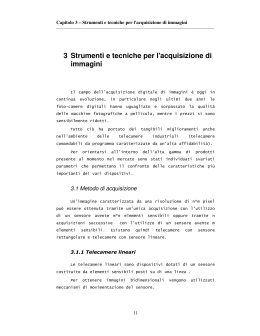Saggistica Aracne 269 Bruno Picozzi Venti parole da un altro mondo Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133/A-B 00173 Roma (06) 93781065 isbn 978-88-548-5976-0 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: aprile 2013 A Irene che mi ha svegliato dal sogno. Per continuare a sognare ho cominciato a scrivere… Che il linguaggio contribuisca a forgiare ciò che pensiamo, sentiamo e addirittura percepiamo è qualcosa che la ricerca scientifica sa da tempo. […] È con le parole che costruiamo la nostra capacità di pensare Giovanna Cosenza, Multiverso, 11/2012 Indice 13 Premessa 17 Capitolo I Arigatō ( ありがとう ) o dell’amabilità 27 Capitolo II Banzai ( ばんざい ) o della fede 37 Capitolo III Kamikaze ( 神風 ) o della ponderazione 47 Capitolo IV Samurai ( 侍 ) o dell’effimero 57 Capitolo V Sūdoku ( 数独 ) o della naturalezza 67 Capitolo VI Shinkansen ( 新幹線 ) o dell’orgoglio 9 10 Indice 77 Capitolo VII Salaryman ( サラリーマン ) o della felicità 87 Capitolo VIII Hikikomori ( ひきこもり ) o della sconfitta 97 Capitolo IX Manga ( 漫画 ) o della passione 107 Capitolo X Geisha ( 芸者 ) o della signorilità 117 Capitolo XI Kogal ( コギャル ) o della trasgressione 127 Capitolo XII Sushi ( 寿司 ) o della sostenibilità 137 Capitolo XIII Shiatsu ( 指圧 ) o dell’immaginario 147 Capitolo XIV Tsunami ( 津波 ) o del destino 157 Capitolo XV Hibakusha ( 被爆者 ) o del rinnovamento Indice 167 Capitolo XVI Jūdō ( 柔道 ) o della tradizione 177 Capitolo XVII Karaoke ( カラオケ ) o dell’incomunicabilità 187 Capitolo XVIII Tamagotchi ( たまごっち ) o della solitudine 197 Capitolo XIX Yakuza ( ヤクザ ) o del buongoverno 207 Capitolo XX Harakiri ( 腹切り) o del futuro 217 Conclusione 11 Premessa Nel 1963 la casa editrice “Dover” pubblicò negli Stati Uniti un libretto dal titolo Grammatica giapponese essenziale, a cura di Everett F. Bleiber. Nell’introduzione, l’autore spiegava quanto la lingua del Sol levante differisse da quella inglese e, si aggiunga, da tutte quelle del ceppo indoeuropeo. Tanto per dirne qualcosa, i nomi non si declinano e i verbi non si coniugano. In compenso si coniugano gli aggettivi, per esempio al passato o al condizionale. Non esistono preposizioni ma una quantità di suffissi che si aggiungono alle parole per indicarne il ruolo nel contesto. Il verbo va rigorosamente in fondo alla frase e non raramente viene omesso, così come anche il soggetto. Ecco perché molti, erroneamente, ritengono questo un linguaggio impreciso. Invece è solo un modo altro di comunicare. «Non è solo una questione di forme e terminazioni diverse, come succede spesso comparando l’inglese con il tedesco, il francese, lo spagnolo o il russo — scriveva Bleiber — la questione è invece una diversa classificazione dell’esperienza umana». Lo studioso consigliava di sospendere completamente le proprie convinzioni sul linguaggio e su come le parti del linguaggio debbano essere usate. Non limitarsi semplicemente a memorizzare parole e costruzioni ma «cercare di capire la psicologia del linguaggio che si cela dietro questo modo così diverso di esprimere le proprie esperienze». Un esercizio di diversità che sarebbe bene spingere oltre il linguaggio perché modi espressivi così diversi non possono non essere legati a percorsi mentali profondamente diversi. Nel dia13 14 Premessa logo tra noi e loro, così come risulta difficile tradurre parola per parola anche la più quotidiana delle affermazioni, allo stesso modo non si troverà una corrispondenza perfetta tra i rispettivi concetti di amore, libertà, felicità, onore e via dicendo. Se tante nostre idee fisse sul linguaggio non sono assolutamente universali e non vanno applicate alla lingua nipponica, anche tante nostre convinzioni sulle relazioni umane non sono universali e non possono essere trasferite in toto all’Impero del crisantemo. Qualsiasi tentativo netto di generalizzazione sarebbe del resto fuorviante. Parliamo di un popolo di oltre 120 milioni di individui e di una società in continua e rapida trasformazione. Quando si crede di aver fissato un punto, sempre capita qualcosa che rimette tutto in gioco. Questo pensavo dopo aver incontrato casualmente il professor Okimoto al caffè “Dean&Deluca”, nei pressi della stazione di Tokyo. Prima di andare in pensione, anni fa, il professore insegnava business management all’Università di Tokyo ed era stimato al punto da prendere parte ad alcune missioni ministeriali durante importanti negoziati commerciali con l’estero. Per circa un’ora chiacchierammo amabilmente su vari argomenti inerenti al rapporto del Sol levante col resto del mondo e non ci trovammo d’accordo praticamente su nulla. Okimoto–san aveva opinioni molto differenti dalle mie e me lo faceva notare con cordialità. Io, più italianamente, lo incalzavo con le mie domande senza trovare nelle sue risposte quel che cercavo. Ritengo che, dal proprio punto di osservazione, ciascuno di noi due avesse le sue giuste ragioni. Dico questo per sottolineare che i capitoli seguenti non vogliono essere un trattato esaustivo sulla mentalità e sulla cultura dei giapponesi — non basterebbe un’enciclopedia — ma solo una collezione documentata di immagini, impressioni, opinioni e punti di vista, messi insieme con perizia giornalistica, senza alcuna pretesa di assoluto. Il mio non è un ragionamento perfetto ma un racconto veritiero, una rappresentazione pertinente della realtà che troverà d’accordo alcuni, in disaccordo altri. Premessa 15 Quel che descrivo in queste pagine è comunque ciò che ho vissuto e imparato in vari mesi di splendido soggiorno in terra nipponica e attraverso l’incontro con molti dei suoi figli, alcuni dei quali ho il privilegio di poter chiamare amici. 1 Note minime. Ogni capitolo è pensato come entità a sé stante. Sia perdonata la ripetizione di alcuni concetti. I nomi propri giapponesi sono citati alla maniera tradizionale, a partire dal nome di famiglia. In omaggio alla maniacale precisione nipponica, nella prima versione del libro tutti i capitoli hanno esattamente la stessa lunghezza pari a 15mila caratteri. I contenuti sono aggiornati al dicembre 2012. Capitolo I Arigatō ありがとう o dell’amabilità Chiunque voglia rendersi simpatico agli occhi di un giapponese non potrà mancare di esibirsi nel suo più sincero arigatō alla prima occasione concessa. Magari anche solo per ringraziare di un’informazione ricevuta o di un simpatico scambio di battute per strada. Ma quanta differenza tra il secco “mille grazie” delle varie parlate occidentali, spesso imbevuto di banale noncuranza, e il melodico e cerimonioso arigatō gozaimasu di un giapponese verace, accompagnato da inchini multipli e sorrisi a tutta bocca. Non è forse questa gente così lontana da noi l’incarnazione stessa della cortesia e della dolcezza? Ebbene, questa affermazione non trova tutti d’accordo. «La gentilezza dei giapponesi è una qualità completamente costruita, un prodotto dell’educazione piuttosto che dell’indole». Con queste parole, nel 1903, il diplomatico brasiliano Manoel de Oliveira Lima, di stanza a Tokyo, descriveva la sua esperienza di vita a contatto con questo popolo antico, uscito appena da una generazione o poco più da un profondo isolamento culturale durato secoli. Nel 17 18 Capitolo I suo saggio dal titolo No Japão: impressões da terra e da gente, de Oliveira fa un’analisi culturale e politica della società nipponica durante l’era meiji (settembre 1868 — luglio 1912), ossia in pieno processo di occidentalizzazione. Egli si sofferma a lungo a esaminare come mai, a dispetto della loro proverbiale amabilità, i sudditi del Sol levante godessero di pessima fama presso i coreani e i cinesi. E sottolinea di questo popolo la naturale impetuosità caratteriale «che, in presenza di determinate circostanze, può degenerare in brutalità». Un’indole violenta, dunque, e una vocazione a comportamenti estremi probabilmente alimentata dalla tradizione shintō, pratica spirituale autoctona elevata a religione di Stato verso la metà dell’Ottocento e tradotta in un’irrefrenabile spinta militarista a fini coloniali. Secondo l’insegnamento dello shintō, i giapponesi sono esseri superiori in quanto unici discendenti della divinità solare, la dea Amaterasu. Un messaggio inbevuto di razzismo che, secondo l’opinione comune, avrebbe contribuito a trasformare l’avventura coloniale della dinastia meiji in un processo di odiosa sottomissione dei popoli vicini. De Oliveira denuncia il distruttivo autoritarismo della colonizzazione giapponese molto prima che gli orribili crimini di guerra degli anni Trenta potessero svelare al mondo il vero volto della monarchia del crisantemo. «In Corea, dove pretendono di dominare, i giapponesi sono odiati dagli autoctoni, che essi maltrattano, e lotteranno sempre contro la memoria di alcune pagine di sangue, in particolare l’assassinio della risoluta e patriottica regina che notoriamente fu concertato all’interno della legazione diplomatica giapponese». La storia del Giappone e molti aspetti della sua realtà odierna ci sono largamente sconosciuti, e ciò contribuisce Arigatō 19 ad alimentare lo stereotipo di un popolo tutto inchini e sorrisi. Un’immagine a dir poco fuorviante. Non pochi si stupiscono nell’apprendere che il Giappone è una delle sette “democrazie liberali” al mondo che ancora comminano ed eseguono la pena di morte. Secondo i dati diffusi da Nessuno Tocchi Caino, nel 2008 15 persone sono state giustiziate nelle carceri giapponesi mentre circa 95 detenuti erano ospitati nel braccio della morte. Le autorità del Sol levante hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulle esecuzioni al punto che, prima del dicembre 2007, il governo si limitava a dichiarare il numero di detenuti passati alla forca, rifiutando perfino di rivelarne i nomi. Inoltre le esecuzioni avvenivano massimamente in concomitanza con la chiusura del Parlamento, d’estate e a fine anno, per evitare ogni dibattito politico sull’argomento. Odiosa oltremodo la procedura adottata, descritta nei dettagli sul sito di Nessuno Tocchi Caino: «I detenuti di solito non sono informati sulla data della loro esecuzione fino al giorno dell’impiccagione. Poiché vengono avvertiti solo un’ora prima dell’esecuzione, i detenuti non possono incontrare i parenti o presentare un appello finale. Familiari e avvocati sono generalmente informati dopo l’esecuzione, alla quale non possono assistere nemmeno gli avvocati». La pena capitale può essere considerata un timido esempio di come i nostri stereotipi sul candore dei giapponesi siano perlomeno inesatti. Parliamo infatti di una società costruita in ragione di una complessa composizione gerarchica, capace di sostenere la propria struttura solo attraverso un continuo ricorso a prove di forza. Nelle aziende, ad esempio, è normale che l’impiegato subisca furiose reprimende da parte dei superiori per il solo fatto di essere in basso nella scala del personale. «Stia al suo posto», minacciano di continuo i dirigenti ai loro sottoposti. Questi ultimi, quando avranno meritato sul campo 20 Capitolo I una promozione, faranno altrettanto con i colleghi di un tempo. Fenomeni di nonnismo impazzano nell’esercito, e questa non è una novità per nessuno. Ma anche nel sumo, pratica sportiva fortemente legata alla tradizione shintō. Un grande scandalo scoppiò nel 2007 quando durante il Nagoya Grand Sumo Basho, uno dei sei grandi tornei nazionali, un lottatore diciassettenne, nome d’arte Tokitaozan, collassò e morì. Il giorno prima era stato picchiato con estrema violenza dai compagni e dall’allenatore. Per educarlo, si giustificarono questi. Secondo molti analisti la società giapponese è costruita sull’imposizione della volontà superiore e sulla mortificazione dell’individuo. Sempre nel 2007 circolò la notizia secondo cui nelle scuole pubbliche della provincia di Iwate i gruppi di cheerleaders praticano una forma istituzionalizzata di nonnismo a danno degli alunni della prima classe. Questi subiscono intere sessioni di urla, minacce, umiliazioni fisiche e chi più ne ha più ne metta, fin quando non si piegano a salutare il nome della scuola con una serie di hurrà accompagnati da sincero entusiasmo, mimica facciale soddisfacente e salti di gioia inequivocabili. Due ore al giorno di questa tortura per le prime due settimane di corso servirebbero, secondo fonti scolastiche, a inculcare nelle matricole uno spirito combattivo, il senso della gerarchia e il rispetto dell’autorità. Nelle dichiarazioni parole come obbedienza, tradizione e spirito di gruppo si sprecano. Il fatto che alcuni ragazzini vengano umiliati fino alle lacrime non è oggetto di preoccupazione. La debolezza dell’individuo non è utile alla società e in un sistema sociale rigido e spietato come quello giapponese nemmeno la fragilità dell’adolescenza può essere oggetto di compassione. Da questo humus forse prende origine una partico- Arigatō 21 lare forma di bullismo scolastico chiamata ijime che consiste nell’individuare un soggetto debole all’interno della classe, una vittima designata da perseguitare o ignorare sistematicamente a seconda dei casi per distruggerla nel morale e, alle volte, nel fisico. Non è raro che il tutto avvenga nel divertimento generale e con la complicità degli insegnanti. L’ijime è un fenomeno relativamente ristretto, certamente non da prendere come regola di una nazione. Il più semplice bullismo scolastico invece non risparmia nessuno. A inizio 2010 persino la principessina Aiko, 8 anni all’epoca, figlia unica del principe ereditario Naruhito e nipote dell’imperatore, fu fatta oggetto delle attenzioni indesiderate di un gruppetto di ragazzini nell’esclusiva scuola elementare Gakushuin di Tokyo. Per vari giorni la piccola non poté frequentare i corsi a causa di attacchi d’ansia e crampi psicosomatici. Una recente ricerca governativa contribuisce all’immagine di una società dove nessuno è salvo, nemmeno tra le mura di casa. Secondo i dati forniti, una donna sposata su tre avrebbe subito violenza fisica o psicologica dal marito. Nel 2008 sono finiti in tribunale oltre 28mila casi di violenza domestica e quasi 15mila di stalking. «Gli uomini giapponesi non dedicano il loro tempo alla famiglia», rivela Azu, segretaria di Nagoya emigrata in Italia per amore. Forse per questa ragione il rapporto coniugale diventa spesso una gabbia per entrambi i coniugi. Ma la violenza è in qualche modo connessa alla cultura profonda della società. La provincia di Osaka è conosciuta per la commedia. «Negli sketch c’è sempre qualcuno che viene picchiato — rivela una studentessa della regione — e questo sembra divertente, al punto che è normale picchiare qualcuno per divertimento». Il dialetto locale suona piuttosto aggressivo e capita che i genitori trattino con vio- 22 Capitolo I lenza i figli persino in strada. Anche in questo caso il fine ultimo è l’educazione. Per quanto riguarda il rapporto con gli stranieri, questo è un argomento assai delicato. Prima e durante la Seconda Guerra Mondiale l’occupazione coloniale dei territori continentali fu oltremodo violenta. La schiavitù sessuale in cui furono ridotte circa 200mila donne, alle quali ci si riferisce solitamente con l’eufemismo comfort women, è cosa assai conosciuta. E non è un mistero il fatto che centinaia di migliaia di stranieri furono deportati in Giappone per essere costretti ai lavori forzati. Un tribunale di Nagoya nel marzo 2010 ha ammesso nel merito il ricorso di 23 coreani che furono vittime di questa pratica ma ha rigettato ogni richiesta di risarcimento in base al trattato di compensazione firmato nel 1965 tra Corea del Sud e Giappone. Tokyo pagò 800 milioni di dollari al governo di Seul sotto forma di cooperazione economica e pace fu fatta, ma i soldi finirono nel calderone del bilancio dello Stato e nessuna delle vittime ne ebbe benefici diretti. Ecco perché c’è chi ha continuato a chiedere risarcimenti al governo giapponese che, dal canto suo, nega ogni addebito. «Tutti vogliono essere risarciti ma è tempo di mettersi queste storie alle spalle», era il cinico commento su un forum del “Japan Today”. «Il governo del Giappone di oggi non è responsabile delle azioni del precedente imperatore e del suo esercito», sosteneva un altro lettore. E a coloro che furono ridotti in schiavitù rimangono solo amarezza e un pugno di mosche. A lungo la parola kokusaika, internazionalizzazione, è stata sulla bocca di tutti. Internazionalizzazione del lavoro, dei rapporti commerciali, delle aziende, degli investimenti. Bellissimo fare acquisti all’estero e girare il mondo da tu- Arigatō 23 risti. Non per questo chiunque deve accettare con piacere che uno straniero gli abiti a fianco, lavori nella sua azienda o faccia la corte alla figlia. Il fatto è che a internazionalizzare la società i giapponesi non ci pensano assolutamente. «Nonostante vada incontro a un’imminente mancanza di forza lavoro dovuta all’invecchiamento della popolazione — scriveva a inizio 2011 il “New York Times” — il Giappone ha fatto veramente poco per aprire le porte all’immigrazione. In realtà, per proteggere gli interessi di piccoli gruppi, il governo sta facendo esattamente il contrario, incoraggiando attivamente gli stranieri sia lavoratori che laureati nelle sue università e scuole professionali a ritornare in patria». Nel 2008, secondo l’agenzia di impiego “Mainichi Communications”, solo 11mila dei 130mila studenti stranieri usciti dalle varie istituzioni scolastiche giapponesi avevano trovato lavoro nell’arcipelago. Nel 2009 il numero di stranieri registrati è andato calando per la prima volta dopo mezzo secolo, segnando un totale di 2,19 milioni di individui ovvero appena l’1,71 per cento dei 127,5 milioni di residenti. Un’inchiesta del quotidiano “Asahi Shimbun” condotta a inizio 2011 su circa 2.400 lettori ha rivelato un buon 65 per cento di contrari all’approvazione di facilitazioni in tema di immigrazione. Secondo de Oliveira, «con gli stranieri i giapponesi non impiegano nemmeno la decima parte della cortesia che mostrano verso i loro compatrioti». L’avversione evidente verso i non–giapponesi registrata a inizio Novecento dal diplomatico brasiliano sarebbe stata un effetto del disprezzo e dell’umiliazione che gli europei avevano riversato sull’impero del Sol levante durante la seconda metà del diciannovesimo secolo. Oggi, a distanza di varie generazioni, storie di pregiudizio e discriminazione verso i residenti stranieri sono ancora all’ordine del giorno, le leggi in 24 Capitolo I materia rimangono deboli e i diritti che ne conseguono appaiono più un’opinione che un fatto. Nel gennaio 2012 le cronache hanno riportato a Osaka l’assassinio di un lavoratore nepalese da parte di quattro giovani locali, due ragazzi e due ragazze. Il gruppo ha aggredito «lo straniero» — così l’hanno definito — senza nessun motivo reale, finendolo a pugni e calci. «Non sembra il Giappone», commentava ingenuamente un lettore del “Japan Today”. «Risparmia i “non sembra il Giappone” — rispondeva un altro — sono stato aggredito anch’io senza motivo, probabilmente solo perché ero un gaijin». Uno di fuori. Uno straniero. E poiché «non esiste una legge contro i crimini a sfondo razzista — aggiungeva un terzo lettore — questi non vengono riportati [dalle statistiche, N.d.A.] in quanto tali». È ovvio che un unico crimine, benché grave, non può servire da metro di giudizio. Ma gli esempi di discriminazione non mancano nei confronti di tutti gli stranieri, asiatici in particolare. La comunità coreana nell’arcipelago conta circa un milione di individui dei quali circa 600mila sono conosciuti come zainichi, i residenti, discendenti in gran parte da coloro che per volontà o per costrizione vi giunsero dal continente durante il periodo coloniale. Immigrati di terza o perfino di quarta generazione, nati e cresciuti in Giappone parlando solo giapponese, essi non posseggono diritti civili perché sono considerati residenti e non cittadini a pieno titolo. Vivono in un limbo indefinito, retaggio delle contraddizioni maturate durante la prima metà del Novecento, quando tutti i Paesi del mondo modellavano le proprie regole interne sulla base del concetto di razza. Nell’immaginario popolare gli zainichi coreani sono associati alla yakuza, la locale criminalità organizzata. Della loro storia e dei loro diritti non si parla né in TV né a scuola perché Arigatō 25 l’unica Corea di cui discutere è quella nemica, quella che sta a Nord. Kono Haruka, blogger giapponese, racconta di una sua amica zainichi coreana che desiderava essere naturalizzata per aver subito in prima persona episodi di discriminazione. La signora Oori di Kyoto ha tenuto nascosta la sua origine coreana alle due figlie fin quando queste non hanno compiuto vent’anni. Ben conoscendo il Paese in cui vive ha preferito evitar loro cattive esperienze, a scuola o sul lavoro. E le due ragazze, ora che sono al corrente della cosa, la tengono nascosta agli amici. Mai fare di tutt’erba un fascio e mai fermarsi alle apparenze, questa è la regola quando ci si pone di fronte a una società diversa da quella in cui siamo cresciuti. Chi ha voglia di ben conoscere la verità sul Giappone provi a viverci per qualche mese a contatto con la gente, negli ingorghi del quotidiano, e di sicuro scoprirà un Paese affascinante popolato di persone meravigliose. Ma le sorprese, quelle non mancheranno. Provare per credere.
Scarica