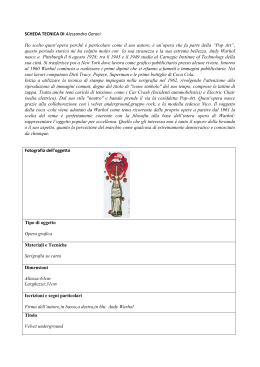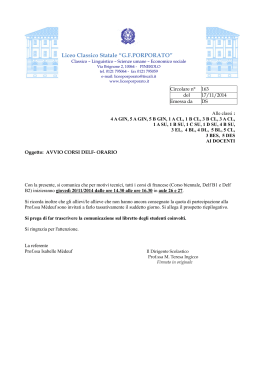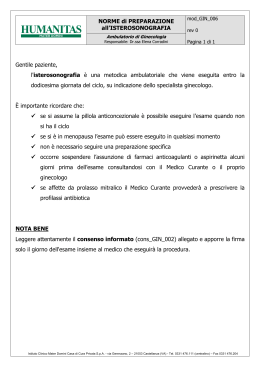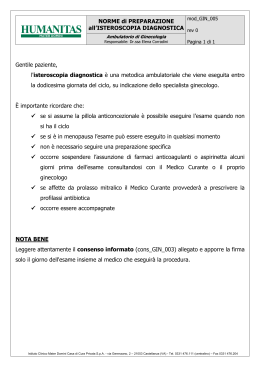LADOMENICA DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 NUMERO 449 DIREPUBBLICA Nella sua casa newyorchese la figlia Giovanna apre l’album dei ricordi CULT E racconta il papà scrittore che tra due giorni avrebbe compiuto novant’anni All’interno La copertina Quando l’artista diventa guru fissando le regole della felicità DARIO PAPPALARDO ed ELENA STANCANELLI Il libro C’è una porta insuperabile per il mediocre di Soseki Mio padreItalo FRANCO MARCOALDI Calvino Straparlando Sergio Zavoli “Il mio sogno dai Vitelloni al Giro d’Italia” GIOVANNA CALVINO DA BAMBINA CON IL PAPÀ DISEGNO DI MASSIMO JATOSTI ANTONIO GNOLI Il teatro L’attualità Amburgo tifa per il Lampedusa Football Club ANDREA TARQUINI Il documento Le lettere infuocate di Enrico VIII ad Anna Bolena NADIA FUSINI ANTONIO MONDA G PAOLO MAURI NEW YORK iovanna Calvino vive da più di vent’anni negli Stati Uniti, dopo aver trascorso la propria infanzia e adolescenza a Parigi. È una donna raffinata e spiritosa, e ha arredato con un’eleganza sobria l’appartamento su Central Park. Vi campeggia una stampa dell’Avana, città in cui il padre Italo è nato e dove ha sposato la madre, Esther Singer, da tutti detta Chichita. Nella grande libreria sono mescolati, senza ordine apparente, libri di ogni genere: le traduzioni dei romanzi del padre, molta letteratura inglese e i testi che sta leggendo in questi giorni: 10 Dicembredi George Saunders e La mia lottadi Karl Ove Knausgaard. Dopo aver conseguito un Ph.D in letteratura comparata, ha insegnato a New York e oggi racconta che quegli anni di studio le hanno consentito di imparare meglio la lingua paterna. A cominciare dalle regole del congiuntivo che, scherza, ha di nuovo dimenticato. (segue nelle pagine successive) «I o appartengo alla generazione che si è fatta più sui poeti italiani che sui narratori… appartengo a una letteratura italiana che ha la sua spina dorsale nella poesia più che nella prosa e negli scrittori che scrivono stando attenti a ogni parola, così come devono stare attenti i poeti» raccontava Italo Calvino a Gaetano Rando in una intervista dei primi anni Ottanta che ora si può leggere nel volume mondadoriano curato da Luca Baranelli Sono nato in America. Calvino pensava a Eugenio Montale e al primo Montale in particolare, avendo qualcosa da ridire sull’ultimo che, dopo Satura, aveva scelto un linguaggio più colloquiale. In un’altra occasione aveva detto: «Montale fin dalla mia adolescenza è stato il mio poeta e continua a esserlo». (segue nelle pagine successive) con articolo di EUGENIO SCALFARI Da Pippo Delbono Bobò e gli altri una bella lezione su cosa è la vita ANNA BANDETTINI L’arte Il Museo del mondo L’epica lattaia di Vermeer MELANIA MAZZUCCO Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 30 La copertina Italo Calvino “C’è una bella foto: io adolescente malinconica, lui con i basettoni tipici di quegli anni” Con la figlia Giovanna sfogliando l’album di famiglia ANTONIO MONDA (segue dalla copertina) arla raramente del padre, al quale assomiglia in maniera impressionante, ma ha deciso di farlo per celebrarne il novantesimo anniversario della nascita e dopo avermi mostrato uno scatto nel quale lo scrittore la guarda con tenerezza. «È una foto scattata quando ci siamo trasferiti a Roma», racconta mentre si siede sul pavimento, «siamo in mezzo ai calcinacci, io in piena malinconia adolescenziale e lui con le basette lunghe, tipiche di quell’epoca». Qual è la prima immagine di suo padre che le viene in mente? «Un suo autoritratto, in una lettera che mi mandò quando avevo otto anni, in cui lui è alle prese coi ferri cercando di fare la calzamaglia». E l’ultima? «Chinato sul suo lavoro con la testa tra le mani. Stava lavorando alle Lezioni americane ed era pochi mesi prima dell’emorragia cerebrale che lo avrebbe ucciso». Ha letto tutti i suoi libri? «Quasi. E devo dire, con un certo sollievo, che mi piacciono molto. Ma per esempio Il Visconte dimezzato non l’ho letto tutto, anche se in pubblico faccio finta di conoscerlo. Quando insegnavo a Philadelphia mi era stato chiesto di fare una lezione proprio sul Visconte: ho avuto un blocco e ho chiesto a un collega di sostituirmi per quel giorno, poi non ho più ripreso in mano il libro». Parlavate spesso di letteratura? «Ricordo un’estate in Maremma insieme a mia madre: si erano appassionati alla scrittrice inglese Barbara Pym, che avevano scoperto tramite Carlo Fruttero. In seguito anch’io me ne innamorai». Suo padre si è mai confrontato con lei mentre scriveva? «Quando avevo quindici anni mi chiese se preferissi la leggerezza della piuma o quella dell’uccello. Era una riflessione di Paul Valéry che riprese nelle Lezioni americane. La risposta giusta è facile da intuire, ma ricordo che io non riuscii a spiegarne il perché». C’è una sua frase che le è rimasta particolarmente impressa? «Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane». Ultimamente si è cimentata anche lei nella scrittura. «Ho scritto un libro per bambini intitolato La Strega dentro di me a quattro mani con l’illustratrice Marina Sagona. È una storia personale, anche se in chiave metaforica. Sentivo il peso del mio cognome, ma ho trovato un escamotage scrivendola prima in inglese, lingua nella quale mi sento più libera». Come mai i romanzi di suo padre non sono diventati film? «Moltissimi anni fa Dino De Laurentiis comprò i diritti del Barone rampante per farne un film con Jean-Paul Belmondo: non se ne fece nulla, ma con quei soldi i miei costruirono la casa in Maremma. In seguito si interessò al romanzo Louis Malle, però mio padre non diede seguito. Considerò anche una collaborazione con Fellini. Ma in fondo un romanzo riuscito è una cosa P Li ho letti (ma non tutti) i libri di papà compiuta in sé: se l’adattamento non è geniale si può fare a meno del film». Sua madre Chichita ha una personalità straordinaria: che importanza ha avuto nell’evoluzione artistica e nella carriera di suo padre? «Avevano un rapporto intellettuale molto forte e lui diceva che mia madre era i suoi occhi: lei guardava il mondo e glielo raccontava. Va detto che senza occhiali mio padre non ci vedeva molto… Mi dispiace che mia madre non abbia scritto le sue memorie: ha un tesoro di ricordi di vicende e incontri con personaggi diversissimi, da Che Guevara a Roland Barthes». Che ricordo ha degli amici scrittori di suo padre? «Per esempio ricordo Mary McCarthy, una donna splendida che per me rappresentava l’America. O anche Octavio Paz con sua moglie Marie-José. E Sonia Orwell, la vedova di George, che i miei amavano molto. E la traduttrice Aurora Bernardez, amica del cuore di mia madre, e prima moglie di Julio Cortazar. Lui alla mia nascita mi regalò una pecorella di peluche che ancora possiedo». Ci sono alcune foto in cui lei gioca con lui sotto gli occhi di sua madre. «Ci troviamo nello studio di mio pa- dre a Parigi, all’ultimo piano della nostra casa nel quartiere allora operaio di Porte d’Orléans. Una casa stretta e lunga, di quattro piani, come certe case inglesi». In un’altra immagine è ritratto suo nonno a caccia. «Sì, in Somalia o Eritrea, e mi fa impressione per la quantità di animali che ha ucciso. Mio nonno Mario era un agronomo ed è stato colui che ha importato in Italia l’avocado e il pompelmo. In un'altra foto è ritratto con mia nonna Eva, la prima donna in Italia ad avere una cattedra di botanica». Lei ora è diventata madre. «Mia figlia ha già quattro anni, suo padre è americano con origini nel Belize e Suriname. Fa il biologo. La maternità mi ha piuttosto rincitrullita, ma è la più bella cosa del mondo». Come mai ha scelto di vivere a New York? «Avevo l’idea che l’America mi avrebbe salvato la vita, ed è stato proprio così». Qual è la prima definizione che le viene in mente, pensando a suo padre? «Penso che lui abbia lavorato al fine di non poter essere ridotto a una sola definizione, e che ci sia riuscito». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ■ 31 Il compagno di banco Su quella panchina a discutere di Dio EUGENIO SCALFARI taloCalvino l’ho conosciuto nell’ottobre del 1938, quando il professore di latino e italiano, un dotto e severo sacerdote, chiamò l’appello degli alunni della «prima C» del regio liceo G. Cassinis di Sanremo. Fummo destinati allo stesso banco e da allora, per tre anni, vivemmo insieme a scuola e fuori. (...) Ma l’immagine del Calvino grande scrittore, forse il più grande degli scrittori italiani di questi anni, per me è come giustapposta ed esterna rispetto al Calvino che ho avuto compagno. Aveva uno strano modo d’incedere, camminava muovendo appena le braccia e le muoveva impacciato, quasi non sapesse dove metterle e che cosa farne. aveva occhi dolci, gli occhi di sua madre. Molto umorismo. La sua prima attività creativa furono vignette e fumetti. Leggeva accanitamente il Bertoldo. Lo affascinava il teatro. I suoi primi lavori furono alcuni brevi racconti nei quali in filigrana si vedono già le Cosmicomiche. (...) La sera andavamo in un fumoso caffè sul Corso, con una sala di biliardo. Giocavamo interminabili FOTO GENTILMENTE CONCESSE DALLA BIBLIOTECA “ITALO CALVINO” DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA I LE IMMAGINI E LA MOSTRA Sopra, una lettera-autoritratto di Calvino alla figlia Giovanna, classe 1965, quando aveva otto anni Nella foto grande: lei adolescente a Roma col padre Nelle piccole, da sinistra: “nonno” Mario Calvino nel ’28 a caccia in Africa; Italo bambino con la madre a Cuba; Giovanna nel ’74 con i genitori a Parigi e in un’immagine recente. Le foto e altri documenti saranno esposti dal 25/10 al 31/1 presso la Biblioteca nazionale di Roma nella mostra “Il lavoro editoriale di Italo Calvino” partite alternandoci — eravamo un gruppo d’una dozzina di amici per la pelle — e negli intervalli chi non giocava faceva i compiti per sé e per gli altri. Dopo cena, sulle panchine della passeggiata Imperatrice, parlavamo dell’esistenza di dio, che bonariamente chiamavamo Filippo. Lui, figlio di liberi pensatori, in Filippo non ci credeva, ma non era del tutto persuaso che proprio non esistesse. Voleva convincersene con la ragione, e giù, discussioni interminabili su Filippo, sulla sua assoluta improbabilità, sulla sua inspiegabile (qualora fosse esistito) capricciosità. E tutte le domande che solitamente seguono a problemi di quel genere e che, tra i sedici e i diciott’anni, tutti si sono posti, almeno all’epoca in cui li avevamo noi: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, perché ci andiamo... (Repubblica, 20 settembre1985 dall’articolo scritto in occasione della morte dello scrittore, avvenuta il giorno prima) © RIPRODUZIONE RISERVATA LA FOTOGRAFIA Sanremo, passeggiata Imperatrice, fine anni Trenta. Eugenio Scalfari (il primo da sinistra) e Italo Calvino (il secondo da destra) insieme ad altri compagni della classe Prima C del Liceo Cassinis: da sinistra Roero, Pigati, Dentone e, ultimo a destra, Donzella Lo scrittore Una ponderata leggerezza PAOLO MAURI (segue dalla copertina) a dichiarazione è preziosa. E le affiancherei subito quell’altra, che si trova in una lettera aperta ad Anna Maria Ortese del 1967 in cui Calvino dice di aver trovato in Galileo un maestro di stile capace, quando parla della Luna, di raggiungere, oltre alla grande precisione, una «rarefazione lirica prodigiosa». Non è strano dunque che oggi al nome di Calvino venga quasi sempre associata una parola: quella «leggerezza» cui dedicò una delle Lezioni americane uscite postume e che fu anche una linea guida nella sua ricerca di narratore. La leggerezza dello «scoiattolo della penna», secondo la celebre definizione di Pavese, a proposito de Il sentiero dei nidi di ragno quando narrando il vero della Resistenza si lasciava tentare dal fiabesco, la leggerezza che consisteva nel “togliere” e che lo portò a tanto ragionare intorno ai suoi esordi che ancora a vent’anni di distanza gli faceva quasi desiderare di non avere scritto quel libro. Calvino non ci ha dato il grande romanzo-cattedrale alla Thomas Mann, del resto lontano dalla tradizione italiana, ma ha scelto di muoversi — e con grande libertà e intelligenza — ancora una volta con strumenti più leggeri, ma non per questo meno lavorati e incisivi. Nel ’63, dopo un lungo silenzio (Il cavaliere inesistente è del ’59) esce La giornata di uno scrutatore. Lo scrittore ha quarant’anni. L’esperienza a cui si rifà il racconto, la partecipazione come scrutatore nel seggio elettorale allestito presso il Cottolengo, casa di ricovero per persone spesso incapaci di intendere e volere, risale a dieci anni prima, alle elezioni del ’53. Amerigo Ormea, alter ego dello scrittore, è stato nominato dal Pci scrutatore, con il compito di osservare e se possibile contrastare gli abusi del partito di maggioranza che pilotava i voti dei degenti con la complicità delle monache. Notò Guido Piovene recensendo il libro sulla Stampa che si trattava di un romanzo-saggio, «l’unica strada, a mio parere, sulla quale può incamminarsi un vero romanzo moderno». L’oggettività era stata al centro di una lunga me- L ditazione di Calvino, ed era stata il rovello di un’epoca intera. Ma, come ricorda il bellissimo titolo di una raccolta di saggi e interventi su letteratura e società, certi discorsi si fanno e rifanno per metterci poi Una pietra sopra. All’altezza del 1980 Calvino osservava: «Certo il mondo che ho oggi sotto gli occhi non potrebbe essere più opposto all’immagine che quelle buone intenzioni costruttive proiettavano sul futuro. La società si manifesta come collasso, come frana, come cancrena (o nelle sue apparenze meno catastrofiche, come vita alla giornata); e la letteratura sopravvive dispersa nelle crepe e nelle sconnessure, come coscienza che nessun crollo sarà tanto definitivo da escludere altri crolli». Da tempo Calvino s’era inoltrato in esperienze letterarie che tenevano conto dell’arte combinatoria e dell’infinita progettualità del Caso. Si era misurato con Il castello dei destini incrociati a ridosso dei tarocchi e da poco con le avventure di un lettore in Se una notte d’inverno un viaggiatore. Era ormai postmoderno? Non so, non saprei. Mi sembra che racchiudere un’esperienza così larga in una formuletta sia per lo meno poco proficuo. «Non chiedermi la parola…». Non diceva proprio così Montale? E Calvino non era, a un certo punto, andato a sedersi sulla Luna per meglio osservare quello che succedeva ai terrestri? Palomar torna a Galileo e a Leopardi. Lo scrittore che aveva cercato di raccontare la realtà e che poi aveva dato spazio alle invenzioni fantastiche per raccontarla ancora meglio, dall’alto degli alberi o da dentro la corazza del cavaliere inesistente, ora aveva dotato il proprio laboratorio anche di un potente telescopio. Grazie a quello intrecciava cosmicomiche e decifrava i profili di città invisibili. E spesso, semplicemente guardava. Alla fine anche senza telescopio, come quando mandò a questo giornale un pezzo breve e mirabile sul volo degli storni nel cielo di Roma. La letteratura è ricerca e non bisogna porle dei limiti. Oggi il novantenne Calvino non credo direbbe altrimenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 32 L’attualità Rivincite 1 2 Lampedusa G Hamburg Football Club AMBURGO ibri ha ventidue anni, da mezzala è il più temuto. Benkofi, ventiquattrenne, è formidabile in difesa. Bright, sui venticinque, passa con disinvoltura da fuoriclasse dal ruolo di centrocampista a quello di attaccante. Takyi Stephen è l’allenatore che tutti ascoltano. È una squadra africana giovane, carica d’ambizioni e voglia di vincere, l’avete capito. Meno consueto è il suo nome: FC Lampedusa Hamburg. I giocatori sono tutti ragazzi fuggiti prima dai loro paesi in Africa per scampare a persecuzioni politiche o religiose, poi dalla Libia dove nel dopo-Gheddafi il Gastarbeiter nero era il nemico necessario, e infine da Lampedusa: 500 euro a testa pagati dall’Italia per spedirli a nord, fino in Germania. E adesso eccoli in campo contro gli avversari-amici del St.Pauli che concedono il loro campo per allenarsi. Il Fussball Club Lampedusa Hamburg è una squadra ma anche un luogo. È l’antica chiesa di St.Pauli, quartiere di puttane e marinai che ricorda canzoni di Jacques Brel e che ha una formazione nella massima divisione tedesca, con una tifoseria di estrema sinistra. In mattoncini rossi, la chiesa è nascosta tra il grande Kindergarten cristiano e le ombre lunghe e lontane di gru e dock del grande porto che rilancia attutite appena le sirene degli enormi cargo dell’export made in Germany. Eccoci, un pezzo dei dolori e delle tragedie di Lampedusa è approdato qui. Mi dice Affo Tchassei: «Noi siamo i sopravvissuti», e me lo dice col suo bel sorriso triste pensando ai morti di Lampedusa mentre ce ne stiamo seduti al tavolo di un bistrò turco. Annuisce Takyi Stephen, l’allenatore: «Arrivammo in Europa, a Lampedusa, chi due e chi tre anni fa. L’Italia diede a ognuno di noi 500 euro dicendo che non poteva più ospitarci, che eravamo troppi, che altri ne stavano arrivando e che saremmo stati meglio al Nord. Così siamo finiti qua. Non scappiamo per soldi, fuggiamo da persecuzioni etniche, politiche e religiose, e ogni volta che uno di noi voleva fuggire sapeva di affidare la sua vita al Mediterraneo, al mare spietato». La tv turca diffonde il rock di Istanbul e i notiziari con la faccia di Er- ANDREA TARQUINI 5 1. I TIFOSI I tifosi dell’FC Lampedusa Hamburg (squadra al completo nella foto grande centrale) Tra i sostenitori ci sono molti volontari della chiesa Sankt Pauli che ospita i rifugiati 2. IL TORNEO Il Sankt Pauli, squadra della massima divisione tedesca, ha organizzato un torneo per rifugiati, partecipando con una sua selezione di amatori 3. IL TRIONFO L’FC Lampedusa Hamburg ha sconfitto nella finale proprio il Sankt Pauli festeggiando al termine con grande entusiasmo. E perfino fuochi d’artificio Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ■ 33 Sono ragazzi e sono africani. Hanno sconfitto il Sahara e il Mediterraneo. Sono stati sull’isola che ancora conta i morti e ora dormono accampati in una chiesa nella più fredda tra le città della Germania. Ma sono vivi E hanno avuto un’idea: sfidare l’Europa intera a pallone. Questa è la loro squadra 3 vani o delle famiglie con bimbi piccoli che padre Wilm e gli altri volontari stanno aiutando. «Abbiamo saputo del massacro di Lampedusa dagli sms che ci hanno mandato i parenti che stanno in America», racconta Affo e intorno al tavolo gli sguardi tornano cupi per la commozione. «Non volevamo crederci, abbiamo acceso la tv e ci siamo collegati a Internet per saperne di più. Da quel giorno ogni nostra partita comincia con un minuto di silenzio, e gli amici del St.Pauli fanno lo stesso. Da allora noi qui ad Amburgo siamo “quelli di Lampedusa”, non siamo più soltanto esuli ma sopravvissuti, quelli che possono mandare a casa soldi e notizie». Il Ghana con cinque giocatori (Gibri, Benkofi, Mussah, Bright, Sopesi), poi il Mali con Amadou e Kabore, poi il Niger con Mourtala. Gioco aggressivo e veloce. L’FC Lampedusa Hamburg conquista sempre più simpatie tra i tifosi del St.Pauli, squadra proletaria e multietnica. L’inglese li salva come lingua comune. Herr Georgie, coach e volontario, tedesco, li ha aiutati a organizzarsi. «I tifosi crescono, adesso alle nostre partite vengono in pullman noleggiati anche da altre parti della Germania», dice Takyi Stephen : «Insieme agli amici del St.Pauli, ai pastori della Chiesa, ai volontari cerchiamo di far capire con il pallone alla gente di qui che siamo persone capaci, con tanta voglia di fare». Dalla loro tenda della protesta, a un passo alla stazione, ogni mercoledì i lampedusiani neri di Amburgo sfilano in corteo contro «l’apartheid». Di questo oggi hanno paura. Il sindaco più che altro li ignora, tratta con la Chiesa, mai con loro. «Dovrebbero fornire le loro generalità complete alle autorità per chiedere asilo», afferma glaciale Marcel Schweitzer, portavoce del governo socialdemocratico di una delle più ricche città del mondo, come se servisse agli eredi di Brandt e Schmidt cavalcare umori xenofobi. E allora forza Gibri, forza Benkofi, forza Amadou, pensi col groppo in gola vedendo come se la cava l’undici degli africani di Lampedusa in terra tedesca. «Lo sport unisce la gente, ci si diverte insieme tifando per squadre opposte», mi dicono salutandomi i giovani africani. «All’Europa non vogliamo togliere nulla, vogliamo solo darle i nostri talenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA FOTO DI MARIA FECK dogan mentre ascolto il racconto dei lampedusani di Amburgo. Chi ad Amburgo ci è arrivato in treno, via Monaco, chi in aereo fino a Norimberga e poi in autobus. La chiesa di St.Pauli è il loro rifugio. «Il pastore, Sieghard Wilm, ci ha subito offerto di dormire lì per salvarci dal gelo in arrivo. Prima di ogni funzione sgomberiamo da sotto la navata e dall’altare sacchi a pelo, ceste di biancheria e panni stesi ad asciugare», spiega Affo Tchassei. Il borgomastro, il socialdemocratico Olaf Scholz, ha vietato a padre Wilm di ospitare i profughi in container nel giardino della chiesa, come il prete avrebbe voluto. Ancora Affo: «I documenti europei che ci hanno dato in Italia per il momento ci permettono di restare qui, ma non di cercare un lavoro, avere assicurazione sanitaria o pensionistica, diritto alla scuola per i nostri figli». È il volto orrendo, spietato, isterico della fortezza Europa. A cui qui ad Amburgo gli africani di Lampedusa reagiscono scommettendo sul calcio. Sì, il calcio. «L’idea ci è venuta quattro mesi fa», racconta il mister. «Ci alleniamo ogni giorno, nel campo degli amici del St.Pauli o nel giardino della chiesa. Il calcio per noi africani è una passione e il passaggio in Italia di certo non ci poteva fare guarire. Ci ha acceso nel cuore la voglia di mostrare ai tedeschi che non siamo pigri e passivi, venuti fin qui per mangiare col loro welfare». Gibri, il più giovane, sorride e supera la timidezza davanti al mio vecchio registratore. «Come molti della squadra vengo dal Ghana, e tutti abbiamo attraversato quel mare assassino. Non sai quanto possa riscaldarci il cuore giocare a calcio. E non sai, scusa la presunzione, che cosa voglia dire sentirti nascere dentro il sogno di giocare un giorno in una squadra europea, come Asamoah. Tornare a casa per noi vorrebbe dire morte sicura». Sono umidi di lacrime gli occhi del giovane Gibri che narra il suo sogno. E tace quando il suo allenatore dice: «Questo ragazzo è stato scelto dagli amici della squadra del St.Pauli anche per addestrare la loro formazione. Sono grandiosi. La prima partita l’abbiamo vinta noi 5 a 4, e nello stadio stracolmo di tedeschi nessuno se l’è presa». Gibri è fuggito dal Ghana. Anant Kofi Mark e Asuro Udo sono scampati ai massacri religiosi in Nigeria, altri compagni di squadra sono scappati dal Togo. Ogni giocatore del Fussball Club Lampedusa Hamburg ha alle spalle una storia simile a quella di ognuno dei gio- 4 6 4. IL CORTILE Abdullah, uno dei rifugiati, si allena con un pallone all’esterno della chiesa che ha accolto lui e i suoi compagni dopo tante traversie 5. LA MUSICA Sullo sfondo Agyei si esercita con la tromba regalatagli dal pastore e che suona durante le funzioni religiose della domenica 6. IL DORMITORIO L’interno della chiesa di Sankt Pauli trasformata in dormitorio per dare riparo, dallo scorso giugno, a un’ottantina di esuli africani Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 34 Il documento Relazioni pericolose “Sogno di trovarmi tra le braccia della mia amata, le cui graziose mammelle presto vorrei poter baciare”. Le ardenti missive del Re d’Inghilterra alla sua futura seconda moglie (di sei) ora tradotte e raccolte in un libro Per lei provocò lo scisma anglicano. Poi la mandò al patibolo Il monarca ossessionato da una donna differente NADIA FUSINI ei molti ritratti ufficiali di Holbein, Enrico VIII appare come un uomo grande, grosso e corpulento, ben ritto sulle gambe aperte, sicuro di sé, aggressivo. Sfoggia in aperta evidenza una forza virile e muscolosa che tutta si condensa nella gonfia brachetta — a conferma di un potere che si sostiene sulla potenza procreativa. Del resto, è sulla performance sessuale del sovrano che si fondano le dinastie regnanti. È proprio questo, però, il punto debole del nostro aitante monarca, il quale, per quanto sia bello e forte sembra non riuscire a depositare nel grembo della sua regina Caterina d’Aragona il seme del futuro. Dopo anni di matrimonio tutto il raccolto consiste in una deludentissima femmina, mentre crescono gli aborti, le morti precoci dei regali infanti, e il disamore tra i coniugi. Enrico si distrae con le dame di corte e con la caccia, finché non incontra Anna Bolena, meno regale, ma più giovane di Caterina; ed è tutto preso da lei. Ha già avuto un affair con la madre, si mormora, e anche con la sorella, sì che torbida è la loro liason, odora di incesto. Anna non sarà bella, ma in tutte le descrizioni si esalta il suo “magnetismo” animale. Ha sex appeal. È svelta di lingua, precoce d’intelletto e ha potuto coltivare tali doti naturali nelle corti di Francia e di Navarra. È raffinata nel gusto: a Parigi e Amboise l’arte è di casa, Leonardo lavora a corte. È amica di Margherita d’Asburgo, figlia di Maria di Borgogna, grande principessa, e di Claudia di Francia, la quindicenne moglie di Francesco I, e di Margherita Angoulême. Forse proprio Margherita la introduce all’interesse per la poesia e la letteratura e per la riforma religiosa. Con un corredo di modi perfetti, e una moderna curiosità rivolta alla vita intellettuale, è appena tornata in patria che abbocca al suo amo niente meno che il re. Anna potrebbe fare come fan tutte, compiacerlo. E invece no. È una donna moderna, una donna dei tempi nuovi. Non sarà nobile abbastanza per la corona, ma è troppo intelligente per fare la concubina. Così tiene a bada la voracità dello spasimante bulimico: non si concederà a lui, a meno che in cambio non le siano concesse le nozze. Qui non c’entra il pudore, c’entrano l’orgoglio e l’ambizione. E c’entra l’intuito: Anna capisce che non di facili amori quest’uomo è alla ricerca, né di più o meno eccentrici bunga-bunga. Enrico non è un libertino; è un’altra la sua magnifica ossessione. Si annida sempre nell’orizzonte del coito, ma lo trascende nella tensione ideale di chi intende assolvere il compito politico della continuità dinastica. Anna non è affatto avversa all’idea, ma comprende che l’atto procreativo al servizio della dinastia troverà il massimo orgasmo, se la copulazione produrrà un frutto che non sia bastardo. Anna ha intelletto d’amore, e si impegna nel soddisfare quel desiderio: darà a Enrico il maschio per la corona. Per questo, però, Enrico dovrà divorziare da Caterina. Si badi bene, non è per gelosia servile, né per vendetta sociale; semplicemente Anna non vede altra strada, né la vede Enrico, per realizzare il sublime scopo: bisogna che Enrico abbia l’annullamento del matrimonio incestuoso; non si può pensare che succeda a Enrico la figlia Maria la spagnola, come la madre cattolica e in combutta con la Spagna. Anna è inglese, una patriota, e vuole l’indipendenza della sua isola: Maria Tudor non la garantisce. La garantirà invece il figlio maschio che lei darà al suo re. Quando l’avrà sposata. Se Anna diventerà regina, sarà grazie alla memorabile accusa contro se stesso e la legittima consorte da parte di Enrico VIII, che dichiarerà di aver vissuto in incestuoso adulterio con la sposa vedova del fratello Arturo. Seguirà il grande scisma da Roma, che non riconosce il “sacrosanto diritto” del re inglese a sciogliersi da chi non gli scodella il figlio maschio. Purtroppo neanche la politica Anna ci riuscirà. Il 7 settembre 1533 nasce non un bel bambino, ma una femminuccia: Elisabetta. E nella testa di Enrico ritorna l’antico rovello: Dio lo umilia nella sua virilità perché copula nel letto di una donna impura. Al terzo aborto Anna è davvero nei guai. Enrico la denuncia come strega eretica: lui è un cornuto, lei un’adultera, Elisabetta una bastarda. Il 15 maggio del 1536 è processata per adulterio, incesto, stregoneria e alto tradimento, il 18 sale sul patibolo. Il giorno dopo, il re tutto vestito di bianco sposa Jane Seymour. A questo punto, Enrico si trasforma in un Barbablù paranoico, immobilizzato in una montagna di grasso, che colleziona regine come prede immolate sull’altare della sua impotenza. Tanto che in inglese circola una filastrocca che elenca le sue ben sei successive spose recitando: ripudiata, decapitata, morta; ripudiata, decapitata, sopravvissuta. Comincia con Caterina ripudiata; continua con Bolena decapitata; poi è la volta di Jane Seymour che muore spontaneamente, di Anne di Clèves ripudiata, di Catherine Howard decapitata, e di Katherine Parr che gli sopravvive e muore di morte naturale. N © RIPRODUZIONE RISERVATA Enrico VIII ~ Anna Bolena “Signora, brucio nell’attesa” ENRICO VIII ante luglio 1527 ia Signora e Amica, Ci mettiamo nelle vostre mani — io e il mio cuore — e vi supplichiamo e ci raccomandiamo ai vostri favori, perché l’assenza non diminuisca l’affetto che provate per noi. Sarebbe infatti una gran pena accrescere la nostra sofferenza, che già l’assenza basta ad aumentare, ben più di quanto mai avrei pensato possibile. Mi viene in mente un assunto della scienza astronomica, ovvero, che più i giorni si allungano, più s’allunga la distanza del sole; epperò, tanto più rovente è il calore. Così è col nostro amore, che malgrado la lontananza conserva il suo calore, almeno da parte nostra. Ho la speranza che sia lo stesso per voi, e vi assicuro che per me il disagio dell’assenza è già troppo grande. E quando penso al prolungamento di quel che già sono costretto a soffrire, mi sembra quasi intollerabile, non fosse per la ferma speranza che nutro nel vostro indissolubile affetto per me. Ora, perché almeno a volte ve ne ricordiate, vedendo che non posso esservi accanto di persona, vi invio la cosa più prossima, cioè il mio ritratto, incastonato in un bracciale, con l’emblema che già vi è noto, e vorrei essere io al suo posto, quando piacerà a voi. Dalla mano del vostro Servitore e Amico, Rex ante luglio 1527 Riflettendo fra me e me sul contenuto delle vostre ultime lettere, sono entrato in grande agitazione, non sapendo come interpretarle, se a mio svantaggio, come mi pare da alcuni passi, o a mio van- taggio come capisco in altri. Perciò vi supplico con tutto il cuore di farmi conoscere apertamente e con certezza le vostre intenzioni riguardo al nostro amore. Sono necessariamente costretto a incalzarvi per avere risposta, essendo stato colpito dal dardo d’amore ormai da più di un anno intero, senza la certezza di poter trovare posto nel vostro cuore e tra i vostri affetti. Questa incertezza mi impedisce da qualche tempo di potervi chiamare mia Signora, poiché il nome non è appropriato per voi, se mi amate di un amore comune, visto che denota una singolarità ben lontana dall’ordinario. Ma se vi piacerà compiere l’ufficio di una vera, leale amante e amica, e darvi corpo e anima a me che sarò come sono sempre stato vostro leale servitore (se per rigore non me lo proibite), vi prometto che non solo vi sarà dato il nome, ma che vi prenderò anche come mia unica Signora, e allontanerò dai miei pensieri e dai miei affetti tutte le altre, che sono in competizione con voi, e servirò soltanto voi. Vi prego di dare una risposta chiara a questa mia rude lettera, perché io possa conoscere quanto e fino a che punto posso fare affidamento su di voi. Se non vi piacesse rispondere per iscritto, designate un luogo in cui io possa avere una risposta per bocca vostra, e verrò con tutto il cuore. Per ora basta, non voglio tediarvi. Scritta per mano di colui che ben volentieri resterebbe vostro, H. Rex ante luglio 1527 Anche se, mia Signora, non avete avuto la compiacenza di ricordarvi della promessa che mi avete fatta l’ultima volta che ero con voi, e cioè che avrei avuto vostre notizie, e una risposta alla mia ultima lettera; pure credo convenga a un leale servitore (dal momento che non può saperlo in Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 MOSTRE LE ■ 35 DI REPUBBLICA E IL SOGNO AMERICANO TROVÒ LA SUA ESTETICA ACHILLE BONITO OLIVA utti si rassomigliano e agiscono allo stesso modo, ogni giorno che passa di più. Penso che tutti dovrebbero essere macchine. […] Io dipingo in questo modo perché voglio essere una macchina». Così afferma Andy Warhol in una intervista su Art News del novembre 1963. E infatti con la sua presenza fredda e distaccata cancella ogni traccia di profondità e i suoi quadri, i suoi ritratti, diventano la celebrazione della superficie per la superficie. Lo strumento da lui usato è uno stile che non rifiuta il sistema meccanico di riproduzione dell’immagine, perlomeno dell’ottica e dello spirito che lo determina, ma anzi accoglie il procedimento e la neutralità di fondo che lo sorreggono. Perché questo avvenga è necessario eliminare ogni discriminazione per quanto riguarda l’ambito dove l’immagine nasce, cresce e si sviluppa. Warhol trasporta nell’arte l’idea del multiplo, dell’oggetto fatto in serie: l’individuo ripetuto in uomo massa, in uomo moltiplicato portato dal sistema in una condizione di esistenza stereotipata. Al prodotto unico subentra l’opera ripetuta, la cui reiterazione non comporta più un’angoscia esistenziale ma il raggiungimento di uno stato di ostentata indifferenza, che è lo stesso attraverso cui Warhol guarda il mondo e che costituisce la premessa di quel consumo cui la civiltà americana e l’artista stesso non intendono sfuggire. L’occhio cinico di Warhol ci restituisce la condizione oggettiva del ceto medio americano accettata così com’è e per quello che è, poiché i modelli adoperati non sono fuori di quella realtà, ma dentro: le facce inespressive dell’uomo-folla gettato nella sua solitudine quotidiana, separato dagli altri uomini; gli incidenti d’auto; le nature morte di fiori psichedelici riprodotte con gelida allegria attraverso il procedimento meccanico della serigrafia. Sono tutte immagini recuperate dallo spazio cittadino: una megalopoli sconfinata e proliferante, portato di una economia in espansione anche oltre i confini degli Stati Uniti. La metropoli è l’alveo naturale dell’american dream, inteso come sogno continuo di opulenza e di stordimento organizzato dalla merce. La città è un grande happening, un evento incontrollato, in cui le immagini si associano tra loro, si scompongono, si sovrappongono e scompaiono all’interno di un paesaggio artificiale vissuto come l’unica natura possibile dell’uomo moderno. (segue nella quarta pagina) «T DUE MOSTRE A PISA E A MILANO CELEBRANO IL PADRE DEL POP CHE HA ANCORA GRANDE INFLUENZA SULL’ARTE CONTEMPORANEA ANDYWARHOL Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LE LEGRANDI GRANDIMOSTRE MOSTRE ■ 36 ANDY WARHOL A Palazzo Blu, un percorso diviso in otto stazioni tematiche mette ordine in una produzione sterminata che arriva fino al rapporto con Napoli, Beuys e il gallerista Lucio Amelio I QUARANT’ANNI CHE CAMBIARONO IL MONDO DELL’ARTE Da Liz a Marilyn, passando per gli autoritratti ecco miti, simboli e icone di un genio multimediale PAOLO RUSSO DOLLARO Dollar Sign (1981) vernice sintetica polimerica e inchiostro serigrafico su tela FIORI Flowers (1964) pittura acrilica e serigrafica su tela La mostra “Andy Warhol. Una storia americana”, fino al 1° febbraio 2014 a Pisa, Palazzo Blu. Promossa da Fondazione Palazzo Blu e prodotta in collaborazione con Gamm Giunti e The Andy Warhol Museum di Pittsburgh. Curata da Walter Guadagnini e Claudia Beltramo Ceppi. Orari: dal lunedì al venerdì 10-19; sabato e domenica 10-20. La biglietteria chiude un’ora prima. Biglietti: intero 10 euro; ridotto 8,50. Informazioni e prenotazioni: telefono 050 220.46.50 Numero verde: 800.144.385 Catalogo: Gamm Giunti PISA idea di America è formidabile, perché più una cosa è uguale a un’altra e più è americana». Superlativo forgiatore di paradossi, cantore seriale di masse e consumi, artefice di miti alla base della moderna americanità, Andy Warhol ha sempre seminato qua e là indizi su di sé che facessero contenti quei media coi quali ha giocato tutta la vita. Ripagandone, inesauribile Fantômas, la brama d’una verità su di lui con ciò che volevano ogni volta sentirsi dire. Ma dietro quell’osmosi con l’eterna superficie – d’un prodotto, un oggetto, un volto baciato dalla fama – Warhol ha penetrato anche alcune delle grandi paure dell’uomo. La morte, ad esempio, e la violenza. Celebre nell’arte come nessuna star è mai stata, ma ingabbiato in quell’“anticonformismo di massa” – una delle sue boutade – da lui generato, Warhol è però di fatto poco conosciuto nella sua camaleontica complessità, al di là del clamore della stagione Pop: come se fosse rimasto rinchiuso in una delle sue lattine di Campbell. Il disvelamento in profondità del suo lavoro è il merito più evidente di Andy Warhol. Una storia americana, che fino al 2 febbraio porta in Palazzo Blu a Pisa 230 opere che i curatori Walter Guadagnini e Claudia Zevi hanno scelto in collaborazione con l’Andy Warhol Musem di Pittsburgh – più grande raccolta monotematica Usa – e altri eccellenti musei europei e gallerie americane. Voluta da Fondazione Palazzo Blu e Gamm Giunti, la mostra analizza la ciclopica produzione warholiana in otto stazioni tematiche che mettono ordine in una sterminata produzione. E raccontano i quarant’anni che il creativo di Pittsburgh, dov’era nato nel 1928 da religiosissima famiglia nuti di riprese mute chiesti ad amici e vislovacca, ha attraversato con infiniti me- sitatori) di Duchamp, Dylan, Dalí, Dendia (cinema, scrittura, giornalismo, con nis Hopper, Nico e Lou Reed; le adorate la leggendaria rivista Interview, musica, Polaroid, con e senza l’artista, di Lennon coi Velvet Undergound di Nico e Lou e Yoko, Lichtenstein, Stevie Wonder, BaReed, performance, teatro, moda, teatro, con, Haring e l’eterna Gloria Swanson. tv, fino ai primi vagiti di computer art). Poco o punto viste pure le foto di ChriAnche se foto e serigrafia sono sempre stopher Makos in cui Warhol si offre lunstati i prediletti: la prima dato di partenza go una metamorfosi in drag queen, did’ogni lavoro, la seconda strumento seriale per natura, pilastri entrambe del nevrotico, ostentato distacco di Warhol. La mostra riapre l’indagine anche rilevando importanti fil rouge come le fototessera e gli autoritratti che l’aprono nella sezione “That’s Me” e che poi l’attraversano tutta, trionfo d’egotismo esibizionista. E se eran d’obbligo i grandi hit della sua produzione pop, Campbell’s Soup, Flowers, le scatole Brillo e il Dollar Sign, ecco con loro il raro bianco e nero di Avanti Car. Vira di registro “The Dark Side of America” in cui violenza e morte assumono le artificiose, lancinanti policromie delle Electric Chair, arricchite dalla foto originale di quella di Sing Sing sulla quale fu- stante attore d’un esibizionistico gioco rono uccisi i Rosenberg che Warhol usò teatrale in cui né militanze gay – Warhol come base della serie; il gelo di Gun, Skull lo era apertamente – né sessualità o sene Knives; l’impersonale tecnicismo d’un sualità lasciano traccia. Ed è una vera rimanuale di polizia in uno dei Most Wan- velazione la pittura anni ’80 nella quale ted Man; il durissimo bianco e nero, solo elabora le sue foto, sempre loro, fino alserigrafato, di una rivolta razziale e quel- l’irriconoscibile rarefazione dell’iconico li di Avedon del torso di Warhol pieno di volto nelle Shadows, debutta, con Eggs, cicatrici per l’intervento dopo l’attentato nell’indagine sulla forma, facendo di Myths catalogo e congedo dal Pop anni della femminista Valerie Solanas. Ne “Il mito diventa icona” ecco pun- ’60, e dal suo oggi datato cinema sperituali le celeberrime Marilyn e Liz, Mick mentale. In chiusura le opere napoletaJagger, Beuys e il piccolo inedito b/n di ne, nate dal legame di Warhol con la città Troy Donahue con cui la serie nacque nel e il gallerista Lucio Amelio, che oltre ad ’62. E se la politica – come natura e sesso esporlo ne favorì l’amicizia con Beuys: le – è estranea a Warhol ecco, nella sala de- acriliche serigrafie del Vesuvio, rilettura dicata, l’isolato e clamoroso Nixon con la tra spettacolarità e morte di un topos del scritta “Vote McGovern”, Jackie Kennedy vedutismo per una mostra dell’85, e Seiprima e dopo Dallas, Mao e Ted Kennedy. smograph, impenetrabile nero su nero Mentre “Factory”, che di quel think tank- col tracciato delle scosse del terremoto palcoscenico censisce la bizzarra freake- dell’81. rie, brilla per gli inediti screen test (i 3 mi© RIPRODUZIONE RISERVATA «L’ LIZ Liz (1964) serigrafia inchiostro e polimeri sintetici MARILYN Blue shot Marilyn (1964) serigrafia inchiostro e polimeri sintetici SCHELETRO Skull (1976) vernice sintetica polimerica e inchiostro serigrafico su tela Repubblica Nazionale @ DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 PER SAPERNE DI PIÙ www.palazzoblu.it www.warholmilano.it ■ 37 Al Palazzo Reale le opere della raccolta dell’amico Peter Brant, che condivise con il padre della Pop Art la produzione di film indipendenti e l’avventura nella rivista “Interview” ZUPPA Campbell’s Soup (1962) colori acrilici su tela IL COLLEZIONISTA CHE LO CONVINSE A TORNARE “PITTORE” Tra polaroid, teschi e provocazioni glamour tutte le tracce di una singolare “affinità elettiva” CHIARA GATTI SOLDI Untitled (Roll of Bills) (1962) matita, pastello e pennarello su carta SCARPE Diamond Dust Shoes (Random) 1980, acrilico inchiostro serigrafico e polvere di diamante su lino La mostra “Warhol” dal 24 ottobre al 9 marzo 2014 a Palazzo Reale di Milano. A cura di Peter Brant con la collaborazione di Francesco Bonami - inserita nel progetto Autunno Americano - è prodotta e organizzata da 24 Ore Cultura Gruppo 24 Ore e Arthemisia Group. Orari: lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30. Biglietti: intero 11 euro (audioguida gratuita); ridotto 9,50. Informazioni e prenotazioni: telefono 02 54913; www.ticket.it/warhol. Catalogo: 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore MILANO dieci anni, collezionava monete insieme al papà, un intellettuale di origini bulgare, laureato in ingegneria a Lipsia, amante dei dipinti rococò ed emigrato in America al tempo della guerra. A diciotto anni, comprò la prima opera d’arte, la tela del pittore figurativo Samson, suo insegnante all’Università del Colorado. A diciannove anni, investì in borsa 10mila dollari che gli regalò il nonno e, con i guadagni, comprò un quadro di Franz Kline, maestro dell’espressionismo astratto, famoso per i grandi segni neri simili a ideogrammi giapponesi. Era il 1966 e Peter Brant, magnate newyorchese della carta da giornale, inaugurò così la sua raccolta destinata a diventare una fra le collezioni più ricche al mondo votate al lavoro degli artisti americani contemporanei. Andy Warhol in testa. Che Peter, giovanissimo, in abito stile college, inseguiva fra le gallerie di tendenza a Manhattan. Come quella di Leo Castelli, il principe dei mercanti d’arte statunitensi che, nell’Upper East Side, fece la fortuna di Pollock, de Kooning, Rauschenberg o Jasper Johns, e poi di Roy Lichtenstein, il signore dei fumetti e dei retini tipografici eletti a regola d’arte, o dello stesso Warhol, col quale però collaborò poco «perché – confessò a Brant – non era facile acchiapparlo, faceva mostre con galleristi d’ogni genere ed era impossibile da gestire». Tant’è che i primi pezzi di Warhol acquistati da Peter, appena ventenne, non uscirono dal magazzino di Castelli, ma da dimore private che Leo conosceva bene e gli suggerì di rastrellare a tappeto. Nel Missouri, a St. Louis, c’era un tale Jack Glenn, fabbricante di camicie da bowling, che fu felice di vendergli un ritratto del ballerino Merce Cunnin- be portati a condividere l’avventura gham, oltre alla serigrafia Red Elvis, editoriale di Interview, la prima vera ricon la faccia del re del rock ripetuta 36 vista fashion, e a produrre insieme due volte su fondo rosso. A New York, un ti- film, L’Amournel ’73 e Badnel ’76. Pecpo che viveva sulla Quinta Avenue gli cato che, impegnato in mille attività e cedette un ritrattone di Marilyn Mon- mai realmente ripresosi dall’incidente roe che aveva un foro in fronte. Era la del ’68, quando Valerie Solanas, femmitica Blue Shot Marilyn, la “Marilyn minista folle, gli sparò nel suo studio riblu sparata”, ovvero il volto dai toni schiando d’ammazzarlo, Warhol avesfluo della Monroe che nel 1964 Dorothy Podber, una ragazzaccia del Bronx che voleva fare l’artista e frequentava la Factory, bucò con una pistolettata; la bravata, studiata per farsi notare, le costò l’allontanamento a vita dalla “fabbrica” del pop. È proprio attorno a queste immagini, simbolo degli esordi di Peter Brant nel mondo del collezionismo made in Usa, che ruota l’importante mostra allestita a Palazzo Reale a Milano (prodotta dal Comune, 24Ore Cultura e Arthemisia, dal 24 ottobre fino al 9 marzo), curata dallo stesso Brant con la collaborazione di Francesco Bonami, intitolata in modo lapidario Warhol e dedicata al- se smesso di dipingere. Merito di Peter l’affinità elettiva fra il divo dell’arte se, a un certo punto, («ti prego Andy riamericana e il suo cultore appassiona- comincia!» insisteva, caldeggiato dal solito Leo Castelli) tornò a firmare serito. Ecco allora, dietro il sorriso fragile grafie. Come quella di Mao, celebrità dell’icona più glamour del cinema, della politica svuotata di contenuti e ribellissima e mortale, riprodotta sui dotta a emblema di un’epoca tanto manifesti come all’epoca d’oro del suo quanto le sue scatole di zuppa. O come boom mediatico, allineate 160 opere, l’infilata di teschi multicolori che, diedisegni, serigrafie e decine di quelle tro un velo di seduzione, nascondevapolaroid che Andy scattava, con la sua no lo stesso senso di deteriorabilità ceinseparabile macchina al collo, ai per- lato negli occhi tristi di Marilyn, ritratsonaggi famosi, da Liza Minnelli a Tru- ta a due anni dalla scomparsa, o di Liz man Capote, da Yves Saint-Laurent a Taylor, ai tempi della presunta malatDiana Ross, affidati poi alle stampe nei tia. Ma anche nei volti dell’Ultima cena colori elettrici delle tirature industria- di Leonardo, riletta in versione techno li. Quando conobbe Brant, nei primi e presentata proprio a Milano un mese anni Settanta, anche per lui scattò foto prima della sua morte improvvisa, nel a raffica: sorridente, col sigaro strizza- 1987. Altra icona popolare che, per il to fra i denti, o con il cappello da cow- suo cuore inquieto, si trasformò, alla fiboy calato sugli occhi. Immagini flash ne, in un segno del destino. di un’amicizia che, negli anni, li avreb© RIPRODUZIONE RISERVATA A LE BOTTIGLIE Silver coke bottles (1967) vernice argento su bottiglie di vetro in cassetta di legno Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 PER SAPERNE DI PIÙ www.palazzoblu.it www.warholmilano.it LE LEGRANDI GRANDIMOSTRE MOSTRE ■ 38 ANDY WARHOL UN ESTETA NEL NUOVO MONDO DELLA MERCE Storia del loft che produceva serigrafie, rock, follia e film low cost rivoluzionari ACHILLE BONITO OLIVA (dalla prima pagina dell’inserto) L C’ERA UNA VOLTA LA FACTORY TRA SESSO, DROGA E NUOVO CINEMA DARIO PAPPALARDO el loft newyorchese al quinto piano del 231 sulla 47esima Est, si consumavano sesso, droga e rock n’roll. Le vite bruciavano. Le quotazioni di amici e amanti salivano e precipitavano. “The Factory” era l’enclave di Mr. Andy Warhol e della sua compagnia di giro. In quello spazio di trenta metri per dodici, rivestito di stagnola e di vernice d’argento, tra il divano rosso raccattato per strada, i carrelli e le scale appese alle pareti, ci si poteva imbattere in drag queen, spacciatori e superstar. C’era Robert Olivo, alias Ondine, regina delle anfetamine del San Remo Bar, «la persona più interessante che abbia conosciuto negli anni Sessanta», dirà di lui Andy. C’erano i Velvet Underground che provavano il loro disco. Malinconiche bellezze: tra le altre, Nico ovviamente, Anita Pallenberg, poi compagna di Keith Richards, e Edie Sedgwick, ragazza di buona famiglia che, diventata Factory Girl, si perderà per sempre. Dallo sgangherato montacarichi entravano Truman Capote e Jim Morrison; Mick Jagger e Brian Jones; ragazzi palestrati in cerca di fortuna e starlette che non sfioravano nemmeno il quarto d’ora di celebrità. Là dentro, tra il fumo, le pasticche e mente lo spazio della scena in l’eroina, l’eco della guerra del quello che è un primo, personaVietnam non arrivava. Si cam- lissimo adattamento, prima di minava in coma lisergico e tran- Kubrick, di A Clockwork Orange. Chelsea Girlsmostra dodici sice etiliche sul wild side che Lou Reed avrebbe cantato di lì a po- tuazioni tra lacrime, strazio, droga, violenza e comicità. Il rico. Ma le sostanze psicotrope e le sultato di queste scene girate orge non toglievano spazio alla nell’estate del 1966 è lungo sei creatività e alla produzione di ore e mezzo, troppo per una norquella macchina infernale chia- male distribuzione. Per dimezmata Pop Art. Alla Factory, ex zare la durata Warhol proietta fabbrica di cappelli, si assem- due rulli simultaneamente su blavano serigrafie, si realizzava- uno schermo diviso in due: nano scarpe, oggetti firmati dal sce così il primo successo del cimaestro, si componeva e dise- nema underground. Ma l’exgnava musica – vedi la celebre ploit di Chelsea Girls – 130 mila copertina della banana per la dollari di incasso in 19 settimane band di Reed e John Cale – e si solo a New York – mette la polisperimentava un nuovo modo zia sul chi va là. La Factory didi fare cinema. Nel 1963, appena inaugurato, lo spazio diventa subito un set. Mentre dalla Francia Godard e Truffaut diffondono la rivoluzione della Nouvelle Vague, Warhol dal canto suo prova a fare lo stesso. Cerca forme narrative alternative, tenta un linguaggio visivo sporco, amatoriale, frammentato. Il montaggio è pressoché abolito. La sua è un’estetica del provino, del semilavorato: la dissonanza, l’errore, il guasto tecnico fanno parte del prodotto finale. I primi film made in Factory, girati e proiettati lì – quando non in club notturni o venta teatro di retate antistupecinema a luci rosse – hanno tito- facenti. L’Fbi è presente sull’ulli di una sola parola: Sleep, Eat, timo film diretto da Andy, che laKiss. Registrano semplici mo- scia la macchina da presa dopo menti di soddisfazione di un bi- essere stato ferito da Valerie Sosogno fisico: dormire, mangia- lanas, in quello stesso anno, il re, baciare. Al protagonista di 1968. La pellicola del congedo è Blow Job qualcuno pratica una Lonesome Cowboys, scritta cofellatio fuori campo. L’ossessio- me sempre dal fido Paul Morrisne del corpo è il filo rosso che le- sey. Qui il mito americano del ga la ventina di titoli realizzati fi- west viene riletto in chiave gay no al 1968: il corpo del ragazzo a con una sola donna, Viva (la noleggio di My Hustler, del mo- “Garbo” di Warhol), che cerca di tociclista di Bike Boy, dei clienti tenere testa a una banda di cownudi di The Nude Restaurant o boy omosessuali. Altro che dei vestitissimi interpreti di Brokeback Mountain. Vinyl, che riempiono intera© RIPRODUZIONE RISERVATA N a produzione, sostenuta dal gioco serrato della pubblicità, crea, per soddisfare i propri ritmi, una sorta di fame, un desiderio di oggetti e consumi. Ma la situazione presto s’inverte: ora è l’oggetto a inseguire il soggetto. La città apre la sua caccia sadica all’uomo, in quanto ormai esiste un’inversione di ruoli e una nuova gerarchia di posizioni: la città è il fine, l’uomo il mezzo. La città non è più, infatti, lo spazio delle relazioni interpersonali ma il luogo dello scambio, di un puro passaggio di merci. La merce, infatti, è la grande madre che accudisce il sonno, i sogni e gli incubi dell’uomo americano, che lo assiste in tutti i suoi bisogni, fino al punto di incentivare e creare nuovi consumi. E il lavoro è l’unico tramite che l’uomo può stabilire con la realtà urbana. Neutralità, oggettività e impersonalità sono i caratteri che identificano, nel pragmatismo anglosassone e nel suo sistema economico, il produttore con il prodotto. Una lezione ripresa poi da Jeff Koons che ne ha celebrato la perennità con la sua discendenza. Palcoscenico per antonomasia della pop-art è New York, già pronta all’inizio degli anni Sessanta a trasformare la “società di massa” in “società dello spettacolo”. Qui le immagini accompagnano il viaggio diurno e notturno dell’uomo, irregimentato nell’ingranaggio produttivo di una macchina che funziona senza sosta, secondo ruoli già assegnati che lo rendono partecipe e soggetto passivo del grande spettacolo della merce. Le immagini della città vengono accettate nel loro improvviso narrativo come reali. Perciò la tecnica del sogno diventa il tramite necessario per leggere la città e le sue imprevedibilità. D’altronde il sogno, la sostanza onirica, permea di sé la vita quotidiana della società americana, attraversata da immagini e da merci che affollano il suo panorama visivo e tattile. Da un deposito imperituro di sogni incalzanti muove lo sguardo lucido di Warhol, per effettuare il prelievo di una singola immagine. L’arte diventa il momento di esibizione splendente ed esemplare del sogno, la pratica alta che mette sulla scena definitiva del linguaggio lo stile basso delle immagini prodotte dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità e dagli altri strumenti di persuasione occulta ed esplicita dell’industria americana. L’accumulo grammaticale delle immagini è l’effetto di una mentalità che non ha il mito della complessità del mondo. Warhol situa le proprie immagini per associazione elementare, che riflette con cinica disperazione il destino dell’uomo: l’esibizione come esibizionismo, come ineluttabile cancellazione della profondità e riduzione a uno splendente superficialismo. Lo spegnimento della profondità psicologica segna il punto di massima socialità nell’opera di Warhol. In una realtà tecnologica che tende alla moltiplicazione e a moltiplicarsi, l’unica maniera di affermare tale identità è raddoppiare se stessi. Tale procedimento passa inevitabilmente attraverso lo specchio, l’esibizionismo, il narcisismo e definisce l’uomo come semplice voyeur della propria solitudine e del mondo. AUTORITRATTO Autoritratto (1967) fotografia BASQUIAT Jean-Michel Basquiat (1982) acrilici e serigrafia su tela DRACULA The kiss (Bela Lugosi) (1964) monotipo su carta MAO TRAVESTIMENTI Mao (1973) acrilici e serigrafia su tela Self portrait in drag (1980); in alto Self portrait (Green) 1964 © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ■ 39 IL LIBRO Lettere d’amore ad Anna Bolena è la prima raccolta in un unico volume delle diciassette lettere d’amore inviate da Enrico VIII ad Anna Bolena tra il 1527 e il 1528, quando lei era una damigella d’onore della regina Caterina, prima moglie dalla quale il sovrano aveva già chiesto il divorzio alla Chiesa di Roma. La Bolena sarà la seconda delle sue sei consorti e verrà giustiziata nel 1536 Il libro, che include i saggi di Nadia Fusini e Iolanda Plescia (che ha curato anche la traduzione), sarà in libreria da domani, 14 ottobre, per Nutrimenti (126 pagine, 12 euro) LE IMMAGINI A sinistra un ritratto di Enrico VIII, opera di Hans Holbein, autore anche dei due progetti per pendente, qui accanto, conservati al British Museum; sotto, Anna Bolena dipinta da un anonimo e due delle lettere di Enrico VIII custodite nell’Archivio Vaticano altro modo) di mandare a chiedere notizie della salute della sua Signora; ed è per poter dunque assolvere al compito del leale servitore che vi invio questa lettera, supplicandovi di comunicarmi se vi trovate in salute, del che prego Dio come per la mia, affinché ve la conservi a lungo; e perché vi ricordiate più spesso di me, vi invio con questo messaggero un cervo ucciso ieri sera tardi dalla mia stessa mano, sperando che quando ne mangerete penserete al cacciatore; e così per mancanza di spazio termino la mia lettera, scritta per mano del vostro servitore, il quale sovente desidererebbe voi al posto di vostro fratello. H. Rex 15 giugno 1528 La sola ragione per cui vi scrivo in questo momento, cuor mio, è quella di sapere se siete in buona salute e prosperità, del che sarei felice come se si trattasse della mia, mentre prego Dio (se è Sua volontà) di volerci presto riunire, perché vi giuro che lo desidero ardentemente, e sia come sia confido che il momento non sia troppo lontano. E visto che la mia adorata è assente, non posso fare a meno, in rappresentanza del mio nome, di mandarle della carne, carne di cervo al posto di Enrico, con il pronostico che di qui a poco per volontà di Dio gusterete la mia, e Dio volendo, magari fosse subito. Riguardo la questione di vostra sorella, ho fatto scrivere da Walter Welche a vostro padre le mie intenzioni e confido che Eva stavolta non riuscirà a ingannare Adamo. Perché certo, qualunque cosa si dica, non potrà conservare l’onore se non si prende com’è suo dovere cura di lei, sua figlia legittima, ora che si trova nell’estremo bisogno. Non vi scrivo altro per ora, mia adoratissima, se non che vorrei che potessimo passare insieme una notte dalla mano del vostro H. Rex 23 GIUGNO 1528 Mi sono giunte all’improvviso nella notte le notizie più sgradite che potessi ricevere. Ho almeno tre ragioni, infatti, per dolermi. La prima è che sono venuto a conoscenza dell’infermità della mia Signora, che mi è più cara di ogni altra cosa al mondo, e la cui salute bramo come fosse la mia — e volentieri mi prenderei metà della vostra malattia pur di vedervi guarita. La seconda è che temo di dover sopportare ancora a lungo la tediosa Assenza, che finora mi ha inflitto ogni pena possibile, e per quello che posso giudicare continuerà così o peggio. Prego Dio di liberarmi da questo importuno persecutore. La terza ragione è che il medico del quale più mi fido in questo momento non c’è, proprio quando potrebbe farmi il piacere più grande. Spererei infatti di ottenere da lui, e dalle sue arti, la gioia per me più grande a questo mondo; cioè la guarigione della mia Signora. Tuttavia, in sua mancanza ve ne invio un altro, l’unico che c’è, pregando Dio che ben presto possa guarirvi, e lo avrò più caro che mai. Vi prego di lasciarvi governare dai suoi consigli, e se così farete ben presto vi rivedrò, e sarà per me un ricostituente più prezioso di tutte le gem- me del mondo. Scritto dal segretario che è, e sarà sempre, Vostro leale e sicuro Servitore, H. (AB) Rex18 21 luglio 1528 Mia adorata, mi raccomando con tutto il cuore a voi, assicurandovi che sono non poco perplesso per via di ciò che vi riporterà da parte mia vostro fratello, al quale vi prego di credere, perché sarebbe troppo lungo da spiegare per iscritto. Nelle mie ultime lettere vi informavo di come mi aspettassi di vedervi presto, un fatto che è più risaputo a Londra che da chi mi è accanto — il che desta in me non poca meraviglia, ma necessariamente la causa dev’essere una mancanza di discrezione. Non vi scrivo altro per ora, tranne che ben presto i nostri incontri dipenderanno, così confido, non dalla condotta poco accorta degli altri, ma dalla vostra. Scritto dalla mano di colui che desidera ardentemente di essere vostro, H. Rex luglio 1528 Cuor mio, questa mia è per dirvi della grande solitudine che provo da quando siete partita: vi assicuro che il tempo passato dalla vostra ultima partenza mi pare ben più lungo di due intere settimane. Credo che siano la vostra amabilità e il fervore del mio amore a farmi sentire così, ché altrimenti non mi sembrerebbe possibile addolorarmi per un’assenza così breve. Ma ora che sto arrivando da voi, mi pare che la metà dei miei dolori siano guariti, e inoltre mi dà grande conforto il fatto che il mio libro procede ed è di aiuto sostanziale alla mia causa, e infatti oggi ho passato più di quattro ore a scrivere. Il che mi costringe a una lettera più breve, a motivo di un certo dolore di testa, mentre sogno di trovarmi (specialmente di notte) tra le braccia della mia amata, le cui graziose mammelle presto vorrei poter baciare. Scritta dalla mano di colui che è stato, è, e sarà vostro per suo volere, H. Rex © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 40 Spettacoli Sopra le righe Più che a Bernstein si paragona a Bakunin, più che von Karajan ricorda Pete Doherty, odia la Scala e distruggerebbe il Met. Siamo andati a sentire e vedere il direttore d’orchestra che sta sovvertendo il (suo) mondo CECILIA BARTOLI HÉLÈNE GRIMAUD GUSTAVO DUDAMEL VANESSA MAE Mezzosoprano: 47 anni, offre un look “scandaloso” al servizio di progetti molto raffinati Francese, 46 anni, ha inciso 17 dischi ed è fra le star più popolari della classica Venezuelano, 32 anni, è il più noto diffusore del metodo Abreu Inglese, 34 anni, violinista, nota per terribili produzioni techno-classiche VITTORIO GRIGOLO RICCARDO CHAILLY JUYA WANG LANG LANG Tenore, 36 anni, segni particolari: bellissimo Spazia da Mozart ai musical Direttore di lungo corso, 60 anni, collabora con Bollani ed entra nelle hit parade 26 anni, bravissima e sexy, siede al piano in miniabito e tacchi vertiginosi Pianista, 32 anni, è amato come una rockstar, suona interpretando anche con il corpo GIUSEPPE VIDETTI N BOCHUM el silenzio dell’auditorio l’arrivo del direttore si annuncia con passi pesanti, da generale, che risuonano già dal retropalco. Indossa stivali punk Teodor Currentzis, ha 41 anni e ne dimostra 25. Si accomoda sul podio e inizia la sua comunione totale con Stravinsky. La sagra della primavera è l’evento clou della RuhrTriennale, culla delle avanguardie e paradiso degli artisti puri che per quaranta giorni si danno convegno nelle ex miniere di carbone e di ferro della Vestfalia riconvertite a spazi per la cultura. Pallido, magro, vestito di nero, Currentzis si lascia attraversare dalla musica, la asseconda con i movimenti del corpo — ora morbidi, ora impetuosi — mentre dirige la sua orchestra Musica Aeterna. Più Nijinsky che Bernstein, più Pete Doherty che von Karajan. «Ho una missione: salvare la musica classica», dice con la voce baritonale che contrasta con il fisico fragile quando si riprende dalla trance, scosso dall’entusiasmo di un giovane pubblico che per oltre mezz’ora non smette di applaudire. Mission impossible per un direttore d’orchestra greco che dopo un periodo di militanza nella Novosibirsk State Opera si è confinato all’ombra degli Urali, a dirigere la State Opera e il Ballet Theatre di Perm? Non esattamente, il metodo Currentzis ha scosso e incuriosito il mondo della classica. «Abbiamo creato una comune, artisti liberi con altro credo che lottano per far cambiare direzione alla musica», ci spiega. «Da noi si crea senza orario, magari al lume di candela e con un bicchiere di vino». Il mondo (della musica) non è quello che sognava al conservatorio. «Ci sono due opzioni: allontanarsi dall’universo che gira intorno alla musica e che mi disgusta; crearsi una nicchia in cui alimentare il sacro fuoco. Troppa musica nell’aria, non siamo più in grado di apprezzarla. Provi a immaginare il mondo in mano a un dittatore che la proibisca per cinque anni; cosa succederebbe? Tutti, di notte, di nascosto, ad ascoltare in cuffia le radio pirata. La musica risorgerebbe dal silenzio, carica di forza e di potere». Currentzis è un radicale, si paragona a Bakunin e Kropotkin, i grandi anarchici. Non sogna la Scala, il Covent Garden o il Met. Più esattamente, li raderebbe al suolo. «Chi ama la musica può solo aspirare a distruggere il sistema che la controlla per ripartire da un piccolo, fedele pubblico. Le grandi istituzioni sono destinate a morire. Anche nel rock e nel jazz le cose migliori stanno arrivando dal mercato indie, il mainstream è agonizzante, Mtv defunta, i supermarket dei suoni allo sbando. Chi ama la musica ascolta i Sigur Rós, non Lady Gaga. Oggi si dice troppo spesso: dobbiamo riportare i giovani a teatro. Ma anche questo va fatto nel modo giusto; non basta affidarsi alla superstar del momento (i cantanti d’opera belli, fotogenici e palestrati). Noi parliamo ai giovani che hanno un’opinione sul mondo, che reagiscono al sistema, quelli che poi a teatro ci andranno per tutta la vita». Da ragazzo, in Grecia, sognava di diventare un compositore. Come Mahler, il suo idolo, «che scriveva musica solo d’estate». Già all’epoca era la poesia l’unico metro con cui IN CONCERTO Teodor Currentzis: alla Triennale della Ruhr cinquemila giovani fan in delirio lo hanno applaudito In alto una galleria di musicisti che nei modi più diversi tentano di “rilanciare” la musica classica Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ■ 41 Quarant’anni, greco, si è autoesiliato in Siberia e ha un solo obiettivo: “Liberare l’arte dalla routine dello show business”. Certamente non è il primo L’eresia sul podio a tentare l’impresa, probabilmente non sarà l’ultimo LEONETTA BENTIVOGLIO untormentone melodioso e un sinfonico assillo: le industrie discografiche, le istituzioni concertistiche, i teatri d’opera, gli artisti stessi, insomma tutto il mondo musicale “classico” s’interroga sul modo più efficace per diffondersi, riempire le sale, evadere dall’élite dei musicofili e popolarizzarsi. Dopo il boom discografico dell’epoca di Herbert von Karajan, sfrenato promotore della propria immagine e abile nel cogliere per primo le potenzialità delle nuove tecnologie, la flessione commerciale della classica è stata progressiva e inesorabile. Come reagire? Mescolando i generi, percorrendo crinali borderline, puntando sul glamour e lo charme degli interpreti. Con effetti a volte prodigiosi e a volte discutibili. La collaborazione con Stefano Bollani di un direttore d’orchestra del calibro di Riccardo Chailly ha generato frutti preziosi non solo sul versante delle vendite. Sarebbe assurdo porla sullo stesso piano dei vizi patinati e pseudo-sexy della violinista (nata a Singapore e cresciuta a Londra) Vanessa Mae, raccoglitrice di consensi grazie ad atteggiamenti scollacciati e a una terrificante produzione techno-classica, cioè ad arrangiamenti di brani storici in chiave moderna. Muovendosi a un livello più stimolante, seppure criticato dai puristi, il pianista cinese Lang Lang crea di continuo opportunità di comunicazione trasversale. Realizza soundtrack per videogiochi, inserisce stranianti cloni tecnologici di se stesso e di compositori “alti” (Chopin), inventa il format sensazionale del “Concerto per 100 pianisti” che riunisce nei teatri, con clamore planetario, giovani studenti di pianoforte. A volte il look scandaloso è funzionale alla visibilità di progetti musicalmente raffinatissimi. Un’esperta di questa tendenza è la cantante-star Cecilia Bartoli, che nelle copertine dei suoi dischi, dedicati ad antichi repertori inediti e meravigliosi, può mostrarsi con travestimenti scioccanti quali il corpo nudo di una statua marmorea (Sacrificium) o il volto di un prete calvo e horror (Mission). E il geniale violoncellista Yo-Yo Ma, consulente della Chicago Symphony, non teme di assumere, nel ruolo di composer in residence della prestigiosa orchestra, il dj adorato dai giovani Mason Bates (che è anche un bravo compositore “serio”). Sono tanto più ruffiane le operazioni del violinista inglese Nigel Kennedy, il quale con la sua furia punk fece vendere alle Quattro Stagioni di Vivaldi due milioni di dischi. Oggi risollevano i destini del mercato personaggi dirompenti come l’organista statunitense Cameron Carpenter, che ha impresso al suo strumento una fisionomia più spettacolare che liturgica (vedi il fortunato Revolutionary, comprensivo di titoli di Bach e Liszt), e il virtuoso tedesco-americano David Garrett, che col suo violino scatenato, in certi pezzi rubati al rock, arriva a sostituire la chitarra di Kurt Cobain e la voce di Michael Jackson. Tutto è concesso, senza esclusione di colpi. È DAVID GARRETT SORELLE LABÈQUE NIGEL KENNEDY Tedesco, 32 anni, col suo violino ha sostituito le chitarre di Brian May o Kurt Cobain Sessantenni, il duo pianistico di Katia e Marielle ha dissacrato la musica classica Violinista inglese classe 1956, ha in repertorio anche il jazz e la musica klezmer YO-YO MA Americano di origini cinesi, 58 anni, tra i primi veri divulgatori della classica © RIPRODUZIONE RISERVATA TEODOR CURRENTZIS L’uomo che voleva salvare la Musica classica misurava l’arte. Era stregato dai surrealisti, Artaud in testa, e divorava i versi di Georg Trakl, Baudelaire, Lautréamont e Mallarmé. «Musicalmente, i miei punti di riferimento non sono i dinosauri — von Karajan o Bernstein — ma Gieseking, Cortot, Glenn Gould, Harnoncourt». E quando ipotizza collaborazioni con altri artisti, ha parole solo per estremisti della sua specie: Peter Sellars, Bob Wilson, Lars von Trier e Romeo Castellucci. «A Perm abbiamo fatto a pezzi la routine che uccide l’arte. Vogliamo colpire al cuore un sistema che programma le opere e scrittura gli artisti con cinque anni di anticipo. Non era così ai tempi di Caruso». Altro che realismo nella lirica, Currentzis vagheggia un «teatro rituale» che preservi l’opera come i Vangeli, «la parola sacra cantata», per esaltare il mistero del libretto e conservare intatta la leggenda. Non sono solo chiacchiere. La crisi dilaga, gli enti lirici chiudono, la ripresa passa anche per artisti come lui. I manager di Sony Classical sono andati a scovarlo a Perm, gli hanno dato carta bianca e offerto un contratto a lungo termine. «Non accetterò compromessi, voglio il tempo e gli strumenti necessari, niente glamour intorno a me, nessuna pressione. E loro hanno risposto: è per questo che siamo venuti. Ho già inciso alcune composizioni di Jean- Philippe Rameau, Le Nozze di Figaro e Così fan tutte. Presto faremo La sagra della primavera, il Don Giovanni, le sinfonie e la Messa solenne di Beethoven». Alla fine dell’esecuzione della Sagra il pubblico è in delirio. Currentzis e l’orchestra tornano in scena e si mettono in sintonia con l’asse Stravinsky-Diaghilev-Nijinsky con The Riot of Spring (“La rissa della primavera”) del giovane compositore russo Dmitri Kourliandski. In un crescendo di archi gli orchestrali abbandonano uno a uno il palco e si sparpagliano tra il pubblico. Violini, viole e violoncelli vengono passate ai ragazzi che con poche istruzioni continuano a rumoreggiare su una base elettronica. Il geniale primo violino Andrey Baranov, 27 anni da San Pietroburgo, stabilisce una relazione quasi sessuale con la ragazza appena ventenne cui ha ceduto lo strumento. Il caos musicale che ne deriva ha perfettamente senso, è vivo, lirico, creativo. Alla fine alcuni strumenti finiscono in pezzi, i ragazzi fanno a gara ad accaparrarsene i resti da conservare come cimeli (tra Oistrach e Hendrix non c’è confine). Heiner Goebbels, blasonato direttore artistico della RuhrTriennale, lascia la sala estasiato: «Non immaginavo che il carisma di un direttore d’orchestra potesse arrivare a tanto». Ma Currentzis già pensa a domani. «Voglio diventare un artista più appassionato, più illuminato. Il romanticismo esiste ancora, dipende da noi. Vogliamo essere i lettori o gli eroi del romanzo della vita? Io ho fatto la mia scelta, non la più comoda». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 42 Next Nuovi mondi Entusiasmo, creatività e concretezza: la rivoluzione degli artigiani digitali alla prima Maker Faire europea, una vera Woodstock dell’innovazione La stampante all in one L’obiettivo ora è trasformare la scintilla in industria e rilanciare l’economia Parola d’ordine: “Il cielo non è più un limite” ■ MASSIMO MORETTI Fondatore progetto Wasp RICCARDO LUNA ggi non avete più bisogno del permesso di nessuno per inventare delle cose meravigliose». La celebre frase con cui Massimo Banzi, il creatore di Arduino, chiuse il TED Global del 2012, non è mai stata tanto vera e concreta come nei giorni della prima Maker Faire di Roma nello scorso week end, di cui chi scrive è stato il co-curatore. È stata una festa di creatività, un rito pagano in cui decine di migliaia di persone si sono riappropriate del futuro. Della possibilità di crearsene uno migliore. Con le proprie mani, perché questo fanno i makers: making stuff, si fanno le cose che immaginano. Magari con una stampante 3D. O una tagliatrice laser a controllo numerico. O una scheda Arduino, appunto, che grazie a una elettronica facile, a prova di bambino, consente di dare un’anima agli oggetti. E così quando la fiera ha chiuso i battenti, quasi tutti invece di andare a casa sono rimasti sul piazzale antistante il Palazzo dei Congressi a ballare con il gigantesco robot suonatore di basso elettrico che un artista tedesco aveva portato per l’occasione. In quel momento è stato evidente a cosa avevamo assistito per quattro giorni: alla Woodstock dell’innovazione. E, forse, anche a una tappa verso un nuovo made in Italy. Un “futuro artigiano” come lo chiama il professor Stefano Micelli, docente a Venezia e uno dei più attenti osservatori del fenomeno: «Gli artigiani digitali e gli inventori faida-te stanno dando prova di vitalità e creatività. Ora dobbiamo trasferire quell’entusiasmo al resto dell’economia per farla ripartire». Operazione non facile, perché si tratta di contaminare vecchi artigiani e piccole imprese in crisi, ma intanto dal basso, dal mondo dei makers, si avverte una spinta incredibile. Una voglia di fare che sembra voler smentire le statistiche su un paese deluso, disilluso e rassegnato. «I makers fanno soprattutto per la gioia di fare» spiega il professor David Gauntlett, autore de La Società dei Makers appena uscito in Italia. La “gioia” è quindi una delle chiavi per capire questo mondo. E riguarda naturalmente i bambini, i veri protagonisti delle Maker Faire, chiamati a costruirsi i giocattoli invece di chiedere ai genitori di comprarne uno nuovo (grazie al crollo dei costi delle stampanti 3D, «me lo stampi, papà?» è una delle frasi destinata a prendere il posto del classico «me lo compri?»). Ma riguarda anche gli adulti che nell’atto del “fa- «O La guida tattile per ipovedenti ■ SERENA RUFFATO Ideatrice Inventarsele tutte perché la fantasia vada al potere 230 ILLUSTRAZIONE DI ANNALISA VARLOTTA Le invenzioni presentate ed esposte durante la quattro giorni romana di Maker Faire re” riscoprono un senso profondo, un equilibrio interiore. Un “fanciullino” avrebbe detto Pascoli. Come è accaduto al giornalista Mark Frauenfelder, oggi direttore di Make, la bibbia dei Makers, che un giorno ebbe la classica crisi di mezza età e si trasferì con la moglie su un atollo del Pacifico per capire solo dopo che quello che stava cercando era il piacere di imparare a farsi le cose con le proprie mani: un orto, un caffé perfetto, una casa per le api, una chitarra e così via. In tutto questo c’è anche una nuova visione della società, evidentemente, una società nella quale non siamo più solo consumatori, ma produttori; e soprattutto dove si spreca di meno, le cose infatti si riusano, si riciclano, si reinventano all’infinito (a Roma una delle performance più apprezzate è stata l’esibizione dei Capone Bungt Bangt, band napoletana che fa musica stile Daft Punk usando pentole, scope e barattoli pescati nella spazzatura). Ma la gioia è solo il presupposto, la scintilla iniziale. Il resto lo fa un contesto in cui inventare una cosa che non c’è sul mercato è diventato infinitamente più facile visto che gli strumenti tecnologici per farsi un prototipo costano sempre meno e non richiedono un master in elettronica, anzi. «Sky is not the limit, il cielo non è più il nostro limite» ha scandito il giorno della inaugurazione il professore svizzero Raffaello D’Andrea, che è un incredibile addomesticatore di droni (nella sua Flying Arena di Zurigo, li fa giocare a tennis e li manda a raccogliere oggetti manco fossero cani da riporto). Ma se non abbiamo più limiti alla fantasia, vuol dire davvero che tutto o quasi è possibile. Basta crederci e provarci. In questa autentica esplosione di creatività si intravedono almeno tre filoni. Uno più legato a oggetti unici, irripetibili, amatoriali: come le elaboratissime costruzioni di legno a pedali per fare le bolle di sapone che realizza un giovane falegname pugliese a Tricase. Uno che punta a sfruttare le potenzialità dell’Internet delle cose per esempio nel progetto sardo di una macchina del caffé che ti fa l’espresso solo se glielo chiedi via Facebook. E un terzo che pensa in grande e quindi al futuro dell’auto, dell’energia, delle case (fra i tanti, ha avuto un ottimo riscontro la PowerWasp, una stampante 3D fatta a Ravenna, alla base del progetto di stampare case in argilla in Africa «e salvare il mondo»). Tutto questo può diventare una industry e contribuire a far ripartire l’economia? «Sì, ma trasformare un prototipo fatto per passione in un prodotto commerciale non è facile» avverte Dale Dougherty, il fondatore delle Maker Faire e leader indiscusso del movimento. In realtà dei casi di successo già esistono: la MakerBot, la startup che fa una stampante 3D a basso costo inventata in una cantina di Brooklyn da un hacker, Bre Pettis, è stata recentemente venduta per 403 milioni di dollari; Adafruit, la società creata da una donna ingegnere del MIT, Limor Fried, che realizzata kit di elettronica per inventori, ha già quasi cinquanta dipendenti; e la Intel ha appena lanciato un nuovo prodotto per gli studenti assieme ad Arduino. Si chiama Galileo, un omaggio alla grande tradizione italiana di makers. In fondo il primo di tutti è stato un certo Leonardo da Vinci che cinquecento anni fa diceva: «La conoscenza non è abbastanza, sento l’urgenza del fare». La PowerWasp è una prototipatrice 3D che all’occorrenza diventa fresatrice: una volta ottenuta la forma, si potrà tagliare, incidere e levigare, così da modellarla a piacere L’obiettivo è realizzare oggetti ecosostenibili e a basso prezzo Da oggi le opere d’arte hanno il dono della parola. Merito di questa start up, che realizza modelli tattili dotati di sensori Quando il dito sfiora un particolare del modellino, si attiva l’audio, che descrive quella parte dell’opera La lampada ad acqua ■ THOMAS BORRELLI Ideatori Spock ha bisogno di poco per funzionare: acqua (distillata) e luce Combinando l’uso di tre celle combustibili a tre pannelli solari, agganciati alla struttura, avremo una lampada completamente eco-friendly Il carrello intelligente ■ MARCO GIACOMELLI ■ DAMIANO BERTATO Ideatori Si tratta di un prototipo di robot in grado di seguire il proprietario Shopper può trasportare facilmente oggetti pesanti: le possibili applicazioni prevedono supermarket aeroporti e aziende Può essere d’aiuto ad anziani e disabili © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ■ 43 Il vaso mobile ■ MAKEINBO Associazione di makers bolognesi Come dice il nome E-vaso è un fioriera che scappa, e che si sposta autonomamente a seconda della luce Ha sei “zampe” per muoversi, e sensori per captare i raggi solari Le maschere 2.0 ■ ALESSANDRO ZOMPARELLI ■ FILIPPO NASSETTI Soci della Do the mutation Il collagene è una delle componenti nei tessuti connettivi I ricercatori di Do the mutation l’hanno scelto per produrre maschere I volti sono scansionati e analizzati da un software che disegna la maschera, poi stampata in 3D La cyclette smart ■ DUILIO PERONI Coordinatore del progetto Con questa bici si può arrivare ovunque, senza neanche uscire di casa La Gooble Bike è una cyclette integrata con le mappe di Google Street View. Riproduce la pendenza del percorso modificando la resistenza dei pedali, mentre lo schermo mostra i luoghi attraversati La musica da disegnare ■ GILDA NEGRINI ■ RICCARDO VENDRAMIN e na m y M H EL is LO ! ideatori Con Music Ink ogni strumento viene disegnato con una vernice conduttiva e una volta ultimato si collega a un circuito costruito con Arduino Basta sfiorare il disegno per ascoltare i suoni Gli eco-mobili Le protesi stampate ■ MAURIZIO COSTABEBER General manager di DWS Neanche il tempo di una visita dal dentista e questa macchina è in grado di riprodurre incisivi, molari e canini, ma anche calchi dentali che sostituiscono quelli tradizionali in gesso ■ AMLETO PICERNO SERASO Promotore Mediterranean FabLab La linea Havana nasce da un’idea di Mediterranean Fab Lab I mobili sono realizzati in cartone ondulato, sfruttando le potenzialità di questo materiale. La collezione comprende tavoli, sedie, lampade, e persino alcuni elementi d’arredo che si possono incastrare fra loro Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 44 I sapori Gin Trasformisti con Piace a James Bond ma anche ai monaci Perché l’infuso di ginepro inventato dai medici olandesi per combattere la gotta è febbrifugo, diuretico, antisettico. E molto tonico LICIA GRANELLO ond ordinò un doppio Gin Tonic e un lime. Quando arrivò il drink, tagliò il lime e fece cadere le due metà spremute nel bicchiere, riempiendolo di ghiaccio fin quasi all’orlo, poi versò l’acqua tonica. Portò il drink sulla terrazza e si sedette ammirando lo spettacolare panorama davanti a lui». La competenza di James Bond (e del suo creatore Ian Fleming) in fatto di cocktail è fuori discussione. Ma dal Gin Tonic bevuto nelle pagine del Dr. No (1958) a oggi, il gin ha cambiato pelle cento volte, e in scia al gin l’universo dei cocktail che portano la sua firma: né potrebbe essere diversamente, per questo campione del bere alcolico nato a fini curativi, come infusione alcolica delle bacche di ginepro. Una scelta legata alle proprietà benefiche dell’olio essenziale di juniperus communis, di cui in questi giorni si raccolgono le bacche per la produzione invernale: febbrifugo, diuretico, antisettico, tonico. E visto che nella ricca Olanda mercantile del Seicento una delle malattie più diffuse era la gotta, l’intuizione alchemica del dottor Franciscus de la Boe si trasformò in un successo planetario. Il jenever finì prima in Inghilterra con l’esercito olandese (i due stati erano alleati contro la Spagna) e poi in America, grazie ai pellegrini ospitati nella distilleria di Plymouth prima di salpare con il Mayflower. Attraversando prima la Manica e poi l’Atlantico, la ricetta originaria perse due sillabe e acquistò finez- «B Il miglior amico del cocktail party za, diventando rapidamente il liquore ufficiale della Royal Navy, tanto che gli ufficiali di stanza in India lo adottarono per “battezzare” l’acqua tonica, anti-malarico per eccellenza grazie al chinino. In patria, la diffusione del gin si tradusse in un vistoso incremento dell’alcolismo: ma l’introduzione dei “Gin Acts” per arginarne la diffusione non riuscì a fermarne la dirompente popolarità. Nel tempo, Olanda e Inghilterra hanno sviluppato due linee produttive differenti: maturazione in terracotta e gusto morbido per il nipotino del jenever, palato asciutto e toni freschi per il britannico dry gin, con l’eccezione dell’Old Tom, addolcito da un quid zuccherino. L’evoluzione tumultuosa degli ultimi anni — che ha coinvolto marchi storici come Bombay Sapphire (pepe nero e lemongrass per il nuovissimo East), o Beefeater, con la Burrough’s Reserve affinata in botti di quercia — ha sdoganato il gin dal ruolo di fratello minore della vodka. Profumati con cardamomo o frutti rossi, liquirizia o agrumi, rosa o anice stellato, i gin hanno conquistato l’alta ristorazione, a partire dal Gin Tonic, aromatico ma rispettoso dei piatti, ideale per pulire le papille gustative. In più, lo status di long drink — grazie a ghiaccio e acqua tonica, a sua volta ormai frammentata in decine di etichette, con intensità differenti — è apprezzato sia in chiave salutistica che nel conteggio calorico. Se la botanica alcolica vi attrae, partite in escursione verso le colline di San Sepolcro, Arezzo, dove i frati del monastero di Vallombrosa elaborano il gin dalle bacche più profumate del mondo (il ginepro della macchia mediterranea è ambitissimo dai migliori produttori internazionali). Assaggiato il loro gin, benedetto e buonissimo, potrete meditare sulla bellezza della campagna in autunno. © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ ‘‘ Raymond Chandler Un vero Gimlet è metà gin e metà succo di lime Rose’s e niente altro da “IL LUNGO ADDIO” (1953) Anthony Burgess Ha un sapore molto liscio, induce una specie di euforia metafisica e di rado lascia sbronzi da “THE REAL LIFE OF ANTHONY BURGESS” (2005) ‘‘ ‘‘ Francis Scott Fitzgerald Tom rientrava precedendo quattro bicchieri di gin che tintinnavano pieni di ghiaccio da “IL GRANDE GATSBY” (1925) Humphrey Bogart Di tutti i Gin Joints di tutte le città di tutto il mondo, lei è finita nel mio da “CASABLANCA” (1942) Gli indirizzi TORINO SMILE TREE Piazza della Consolata 9/C Tel. 331-1848136 ALBA (CN) SODA COCKTAIL BAR Corso Italia 6 Tel. 346-5938838 MILANO REBELOT Ripa di Porta Ticinese 55 Tel. 02-84194720 VENEZIA ORIENTAL BAR (HOTEL METROPOLE) Riva degli Schiavoni 4149 Tel. 041-5205044 SESTRI LEVANTE (GE) BASQUIAT LOUNGE BAR Via Garibaldi 48 Tel. 0185-458492 L’AQUILA LA DOLCE VITA Viale Corrado IV Tel. 329-1605001 ROMA THE GIN CORNER (HOTEL ADRIANO) Via di Pallacorda 2 Tel. 06-68802451 Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ■ 45 Gin Tonic Martini Negroni White Lady Tumbler grande pieno a metà di ghiaccio, tre parti di gin e sette di acqua tonica, versata sulla spirale verticale del cucchiaio da cocktail Solo due ingredienti: gin e Martini Dry in coppetta ghiacciata Nel Vesper (prediletto da James Bond), gin, vodka e China Lillet Gin, Campari e Vermut rosso in parti uguali per il cocktail servito nel tumbler (bicchiere cilindrico) basso Ghiaccio e fetta d’arancia Dedicato alla sofisticata lady Ella Fitzgerald, vanta cinque parti di gin, tre di Cointreau e due di limone. Nella coppetta, una ciliegia candita Gin Fizz Spopola negli anni ’70 il drink a base di gin, limone e sciroppo di zucchero, shakerato con ghiaccio, servito con soda nel tumbler A tavola Il signore in giallo Farfalle PIERO COLAPRICO Etichette &drink Alcune etichette storiche delle migliori marche di gin Nelle foto: un Gimlet (in basso, a sinistra) il cocktail preferito dal detective Marlowe, e vari tipi di cocktail Martini, il drink di James Bond volte il lapsus è rivelatore di un mondo. È il caso dello Sbagliato, un cocktail che sin dal suo nome promette bene. Piccolo (necessario) antefatto. Con ingredienti italiani, si serve l’Americano, antico cocktail internazionale. A Firenze un conte, Camillo Negroni, chiede al suo barman di fiducia di fargli un Americano, però senza seltz: ci metta il gin. Un successo immediato, tanto che il Negroni diventa l’aperitivo italiano doc. Si arriva così negli anni ’60 dove, in un fumoso e famoso bar milanese, il Bar Basso, il Negroni una sera viene versato con lo spumante al posto del gin: lo Sbagliato nasce così. Senza immaginare che in quel lapsus c’è uno spartiacque letterario. Nei romanzi gialli, noir, polizieschi italiani, il protagonista di solito che cosa beve? Vino. Lo fa anche l’indimenticabile catalano Pepe Carvalho, nei gialli di Montalbán. Per non parlare di Maigret, dei suoi rossi della Loira. Lungo il nostro Mediterraneo il detective pensa, specula, a volte troppo. Nei gialli americani il vino non c’è, infatti scorrono cocktail a fiumi, l’azione prevale, e a volte i morti si contano a carrettate. Un romanzo-simbolo di rara bellezza è Il lungo addio di Raymond Chandler. Narra dell’investigatore privato Philip Marlowe, che sull’Hollywood Boulevard si sente come «Tarzan su un monopattino rosso». Beve spesso un Gimlet, fatto per metà di gin. Ed è il Succhiello(traduzione di Gimlet) ad aiutarlo nell’amicizia con un cliente complicato che, colpo di scena dopo colpo di scena, gli lascerà addosso una tristezza tale da rendere inimmaginabile l’euforia del vino. Nel Mondo Nuovo made in Usa bisognava tagliare corto. Meglio rilassarsi secondo i precetti del GrandeGatsby: il primo drink lo prendi tu finché, a un certo punto, è il drink che prende te. A © RIPRODUZIONE RISERVATA Salmone affumicato, panna e gin al posto della vodka, per profumare la nota alcolica del piatto simbolo della nouvelle cuisine all’italiana Scaloppine Nota fresca, secca e speziata per le fettine infarinate, spadellate, sfumate con il gin, in alternativa ai classici limone o vino bianco Coniglio Rinforzo della nota aromatica per il principe delle carni bianche, arrostito in pentola o nella teglia del forno con bacche di ginepro Fragole Sentori balsamici per i frutti di bosco battezzati con gin e poco zucchero Golosa la macerazione della frutta secca Gelato Contrasto di note balsamiche tra miele e gin nel mantecato di crema, servito con foglioline di menta o timo, abbinato con sorbetto alla lavanda LA RICETTA Luci d’autunno NAPOLI PIANO B Vico Pallonetto Santa Chiara 15 Tel. 081-5442798 LECCE 300MILA LOUNGE via Centoquarantesimo Reggimento Fanteria 11 Tel. 0832-279990 CATANIA SALOTTO 69 Via Gornalunga 17 Tel. 366-5481631 Nello shaker mettere la pera fatta a pezzi e lavorarla con un muddler, il pestello del barman Aggiungere quindi, a uno a uno, tutti gli altri ingredienti (uva, acqua, limone e miele)e solo alla fine il ghiaccio Shakerare e colare in una coppetta fredda Guarnire il tutto, infine, con un rametto di rosmarino e servire con accanto alcune sottili fettine di pera caramellata ✃ Luigi Iula e Salvo Romano gestiscono uno dei bar più interessanti della scena mixologist di Torino, il BarZ8, in corso Moncalieri, dove il gin — oltre cento le etichette servite dai due giovani creativi— viene interpretato in modo sapiente e innovativo, come in questo drink appositamente ideato per i lettori di Repubblica Ingredienti gin 2 pezzi di pera 3 chicchi d’uva 1 cl di succo di pera 1 cl d’acqua 1.5 cl di succo di limone 1 cucchiaino di miele 1 rametto di rosmarino Repubblica Nazionale DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 LA DOMENICA ■ 46 L’incontro Brave (ex) ragazze Meg Ryan All’università studiava per fare la reporter, resterà nella storia del cinema per la scena cult di un finto orgasmo al ristorante Anche per questo l’attrice di “Harry, ti presento Sally” a cinquantadue anni dice di essere stufa di Hollywood e del ruolo che le ha affibbiato “Non ne posso più di fare la romantica carina Un’etichetta che mi ha creato molti problemi. Anche nella vita vera” è un ristorante a New York, meta di gite scolastiche e pellegrinaggi turistici. È il “Kat’z Delicatessen”, sulla Houston Street, East Village. È lì che un quarto di secolo fa è stata girata una delle più famose scene della commedia cinematografica, il finto orgasmo dimostrativo di Meg Ryan in Harry, ti presento Sally davanti a un imbarazzatissimo Billy Crystal in una sala allibita. Si ricorderà che a missione compiuta l’attrice riaddentava tranquillamente il suo sandwich, mentre al tavolo accanto un’attempata signora s’affrettava a ordinare «Quello che ha preso la signorina». Tra le cento battute più memorabili del cinema, questa è la trentatreesima nella classifica dell’American Film Institute. Da quando il film di Rob Reiner uscì in tutto il mondo, nell’89, una foto della Ryan giganteggia sopra il tavolo hot del ristorante. La scena aveva richiesto innumerevoli ciak, e altrettanti finti orgasmi, entrambi coronati a fine riprese dal regalo del proprietario del locale alla troupe: «Un enorme salsiccione». Lo ricorda, ridendo, la stessa protagonista, incontrata in una innocua terrasse parigina durante un break-vacanza che lei spaccia per definitivo anche se va minacciandolo da almeno cinque anni: «Basta, tra me e Hol- ‘‘ e adesso interpreta a Broadway l’adattamento teatrale. Forse è stata decisiva, al provino, la mia risposta sull’amicizia uomo-donna, perno del film: sì, ho detto, ci può essere semplice amicizia. Ho molti amici maschi e il sesso è fuori questione». Oggi risponderebbe ancora così? «Certo. Lei no?». Difficile sostenere il suo sguardo, e non — come potrebbero sostenere i maligni — per via dei troppi ritocchi di chirurgia estetica. La Ryan rimane l’impertinente scolaretta proiettata nei nostri sogni dal grande schermo. Oggi zietta di se stessa, conserva intatta la verve da nipote con quegli incantevoli occhi velati d’azzurro e l’immutato sorriso di ciliegia, sempre sospeso tra il sognante e la presa in giro. Zatteroni e tubino neri su cui sfiammano capelli da ex adolescente. La scorsa estate al Taormina Film Fest l’avevamo vista divertirsi davanti alle clip birichine montate dal direttore Mario Con le registe donne ci si capisce al volo Per i registi uomini tu non sei mai il soggetto del film ma l’oggetto FOTO GETTY C’ PARIGI lywood, è finita! Dopo i quaranta, non esistiamo più per gli schermi Usa», e intanto è alla terza serie tv di Web Therapy: «È una sorta di “psico-lettino” via internet, tre minuti a botta, anziché l’interminabile blabla delle sedute classiche di un’ora». Il rischio, in un’intervista con Meg Ryan, è di fermarsi lì, chiedendo tutto di tutto su quella sequenza di culto: come se, davanti a Sharon Stone, ci si impuntasse solo su quel punto là o si obbligasse Anita Ekberg a ripetere la doccia nella Fontana di Trevi. Per di più la Ryan, botox a parte, è oggi come ieri l’eterna ragazzina, allora di ventisette anni oggi di cinquantadue (li compirà il 19 novembre). Tanto vale, dunque, soddisfare subito la principale curiosità e togliersi il pensiero, secondo l’insegnamento di Groucho Marx che dopo le prime righe di Memoirs of a Mangy Lover scriveva: «E ora che abbiamo liquidato la questione sesso, possiamo occuparci del resto». Del resto è lei la prima a incoraggiare, maliziosa e complice: «Sa chi è la signora che chiede “quello che ha preso la signorina”? Estelle Reiner, la madre del regista». E a chi va il merito della scena? «È una pensata collettiva. Durante le riprese, il regista e la sceneggiatrice, Nora Ephron, si resero conto che occorreva riequilibrare i due protagonisti: Nora ha pensato all’orgasmo simulato, io ho suggerito il ristorante strapieno, Crystal ha trovato la battuta-clou della signora». E gli innumerevoli compagni che le sono stati assegnati dalle cronache rosa, da Andy Garcia a Russell Crowe, non sono mai stati sfiorati dal dubbio dopo averla ammirata in quella scena? Scoppio di risa: «Non ci posso credere che nessuno m’abbia mai rivolto prima questa domanda! Senza entrare in dettagli personali, posso fornirle un dato statistico: durante le proiezionitest, a divertirsi erano solo le donne, mentre gli uomini ne uscivano intontiti». Altri retroscena? «Sa da chi ho saputo che ero diventata una gigantografia al “Kat’z Delicatessen”? Da mia figlia (Daisy True, la bambina cinese adottata sette anni fa, ndr). Corse verso di me al ritorno dalla gita scolastica: “Mamma, mamma, eri nella foto!” mi ha detto. Ha solo otto anni: le ho raccontato una bugia». E com’è arrivata al ruolo che l’ha lanciata? «Il regista aveva già scelto Molly Ringwald di Bella in rosa, che all’ultimo ha rinunciato Sesti. Tra queste, la dimenticabile apparizione in Top Gun di Tony Scott, suo primo volo accanto all’altro divo agli esordi, Tom Cruise. «Avevo due scene. “In una sei felice, nell’altra sei triste”, era stata l’unica indicazione del regista. Altro che Actor’s Studio. E a poco più di vent’anni non avevo l’esperienza che di qualche ruoletto al limite della comparsa: nell’ultimo film di George Cukor, Ricche e famose, e nel quasi-ultimo di Richard Fleischer, Amityville 3-D, oltre che nella sitcom As the World Turns. Dove m’ero fatta apprezzare perché capace di piangere a comando. Per me fare l’attrice è stata una distrazione di gioventù. Da ragazza ero sicura di diventare una reporter, e se così fosse andata forse ora sarei qui al suo posto. Ho studiato giornalismo a New York, all’inizio recitavo solo per arrotondare la paghetta da universitaria». Poi il cinema ha finito per scandire la sua vita, anche quella sentimentale: «Quasi subito, con Dennis Quaid, sposato nel ’91. L’avevo conosciuto a ventisei anni in Salto nel buio di Joe Dante: sul set ero la sua ragazza, lui un ufficiale miniaturizzato che finiva iniettato per errore nel corpo d’un timido commesso. Un bel triangolo... Siamo stati insieme dieci anni e abbiamo avuto un figlio, Jack Henry, oggi ventunenne, anche lui fa attore». Il viavai realtà-finzione l’ha stordita o aiutata? «Tutt’e due le cose. Non mi è mai piaciuto dover recitare anche nella vita la parte dell’inguaribile romantica, carina e frizzantina, modellata sui personaggi che mi hanno reso celebre. L’etichetta cinematografica della girl friend fedele e sognatrice mi ha creato problemi anche nel privato. Per questo, appena ho potuto, ho cercato di dare uno schiaffone alla mia immagine, interpretando per esempio nel ’94 una giovane madre alcolizzata in When a Man Loves a Woman. Ruolo che ha coinciso positivamente con la realtà, perché mio marito stava attraversando proprio un periodo d’alcolismo: grazie a quanto imparato nel film ho potuto capirlo meglio e quindi aiutarlo». Per tutti, però, lei rimane la vagheggiata fidanzatina della porta accanto, la bionda silhouette dell’innamorata ideale che, film dopo film, da sceneggiatrice o da regista, le ha cucito addosso Nora Ephron, scomparsa l’anno scorso: «Le ero molto legata. La sua morte ha colpito moltissimo sia me che Tom Hanks. Aveva saputo farci diventare un tandem perfetto con soli due film, Sleepless in Seattle e C’è post@ per te. Con lei è cominciata una nuova era per la commedia sofisticata, vanto del cinema americano di quegli anni. Ne conosceva i due princìpi base: l’intelligenza dei dialoghi, dai ritmi magicamente calibrati come partiture musicali, e la miracolosa alchimia dei partner, che ha evidentemente funzionato tra me e Crystal e, di nuovo, con Hanks, anche se resta inspiegabile l’empatia tra attori, dalle affinità mai naturali ma sempre apparenti». Meg Ryan è stata diretta di tanto in tanto anche da registe: oltre alla Ephron, Diane Keaton e, dieci anni fa, Jane Campion, nel thriller erotico In the Cut. Avverte sostanziali differenze rispetto alle regie maschili? «Assolutamente. Il film della Campion rappresenta un cambiamento radicale nella mia carriera: sul set ci capivamo subito, si può dire che siamo state entrambe autrici del film. Con i registi non m’è mai capitato. Per un uomo non sei mai il soggetto di un film ma l’oggetto. Una donna, invece, vede quel che vedi tu, sente quel che senti tu, è sempre interessata a quello che provi. Per capirci: la scena nel film della Campion (quella in cui lei è nuda e fa sesso con l’ispettore Malloy/Mark Ruffalo, ndr) l’ho vissuta come l’esatto contrario di quella del finto orgasmo al “Kat’z Delicatessen”». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ MARIO SERENELLINI Repubblica Nazionale
Scarica