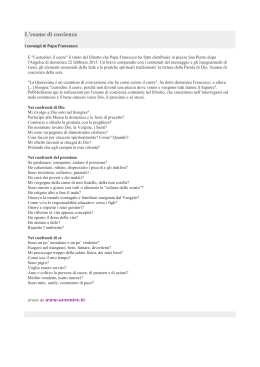Domenica La di DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 Repubblica la memoria Lo spot controvento del Mulino Bianco EDMONDO BERSELLI e ETTORE LIVINI i luoghi Manzoni, un libertino-bigotto a Parigi FRANCESCO MERLO Salgado FOTO SEBASTIÃO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO alle origini del mondo Acqua, aria, fuoco e gli animali che l’uomo non ha toccato: ecco Genesi, il viaggio nel tempo di un grande fotografo GABRIELE ROMAGNOLI SEBASTIÃO SALGADO cultura come osservare un uomo adulto e vedere in lui il bambino, la creatura priva di condizionamenti, lontana dalla guida ma anche dal peso dell’educazione, libera dalla gabbia di ogni (prima o poi) fallimentare struttura sociale. Un’entità pura, nel modo di esprimersi, nei desideri e, anche, nella ferocia con cui li manifesta. Le fotografie scattate da Sebastiao Salgado nella prima metà del suo progetto Genesisono l’album del mondo bambino che sopravvive dentro il mondo adulto. Scoprirne la documentata esistenza è al tempo stesso una consolazione e un timore: ci sono ancora oasi in questo fragoroso deserto, ma quanto sopravviveranno alla sua avanzata? È perfino spiazzante osservare un cormorano che non sa volare non perché le sue ali siano state impiastricciate da una macchia di petrolio ma perché non ne ha bisogno: il mare gli dà talmente tanto cibo che gli basta saper nuotare e non ci sono predatori a infastidirlo rendendo necessaria una rapida fuga in cielo. (segue nella seconda pagina di copertina) l mondo è in pericolo. Questo grido d’allarme si sente così spesso che ormai viene in gran parte ignorato. Si organizzano regolarmente conferenze internazionali per discutere di effetto serra, risorse idriche, distruzione di foreste e altri aspetti della crisi globale, ma in pratica questi problemi fondamentali sono affrontati solo in maniera superficiale. Il nostro rapporto con la natura è andato perduto. Viviamo sotto la minaccia costante di un disastro ambientale: inconcepibili arsenali di armi nucleari sono passibili di essere utilizzati in guerra o di finire nelle mani di terroristi, l’agricoltura industrializzata sta decimando gli habitat naturali, i prodotti chimici avvelenano il suolo e le falde acquifere, le foreste tropicali stanno scomparendo. Solo nelle zone incontaminate la biodiversità è ancora florida. Solo in questo mondo primigenio possiamo ancora capire le origini della nostra specie. (segue nella quarta pagina di copertina) Wiesenthal, la lettera-testamento È I CAFERRI, LA ROCCA, STAGLIANÒ e TARQUINI il racconto Torna Peter Pan, al femminile ENRICO FRANCESCHINI e DARIA GALATERIA l’incontro Flavio Briatore, lo spaccone timido DARIO CRESTO-DINA 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 la copertina Un viaggio nel tempo e nello spazio per andare a scoprire dove la natura è ancora incontaminata, dove l’uomo non è ancora arrivato con la sua mano distruttrice. Il viaggio per immagini di un grande fotografo da un continente all’altro della Terra per lanciare un messaggio di speranza e di salvezza contro i pericoli che minacciano il nostro pianeta Genesi La violenza bellissima di un mondo bambino Un viaggio fotografico alle origini del mondo. Un viaggio nella nostra preistoria per cercare i luoghi incontaminati, le radici della natura e della civiltà umana. Questo è il progetto “Genesi” che Sebastião Salgado ha iniziato nel 2003 e che lo vedrà impegnato per otto anni. Il lavoro sarà diviso in quattro capitoli: “La creazione”, “L’Arca di Noè”, “I primi uomini” e “Le prime società”. Le didascalie di queste pagine sono scritte da Salgado GABRIELE ROMAGNOLI (segue dalla copertina) el “mondo bambino” di Salgado la violenza è un fiume di lava incandescente che corre per lo spettacolo, lontano da ogni insediamento di creature viventi. La minacciosa zampa artigliata di un’iguana appartiene in realtà a un animale socievole e disponibile a lasciarsi avvicinare da chiunque. Gli sfondi dietro queste scene in primo piano sono di una vastità imprevedibile: quell’oasi non è una pozzanghera, ma un oceano, ciò che resta intatto nel corpo malato non è un residuo agglomerato di cellule, ma una volonterosa alleanza di organi vitali. La “genesi”, comunque sia avvenuta, non è morta. La sua natura miracolosa sta, quanto meno, nella sua capacità di resistere perpetuandosi. Queste fotografie ci sembrano, anche, testimonianze di un mondo lontano, non nello spazio, nel tempo: un ieri felice, ma inevitabilmente trascorso e quindi irraggiungibile. L’equivoco nasce nel nostro sguardo: quello documentato da Salgado è un presente, così rimosso più ancora che remoto da riuscirci estraneo e stupefacente. L’età dell’oro convive con l’età del ferro, ma non ce ne rendia- N IN ESCLUSIVA SU REPUBBLICA E D La domenica di Repubblica, per quattro settimane, e D-La Repubblica delle donne da sabato 22 ottobre per i numeri successivi pubblicano in esclusiva per l’Italia il progetto Genesi. La divulgazione dell’opera di Sebastião Salgado in Italia, attraverso mostre e libri, avviene a cura di Contrasto, suo editore e agente. Tra i titoli già usciti, citiamo Un incerto stato di grazia, La Mano dell’Uomo, In Cammino e il volume della collezione Fotonote a lui dedicato mo conto, adagiati sull’incudine a temere il martello. C’è una sensazione di fondo che pervade tutte le immagini, affondata sotto strati di meraviglia, spontaneità e naturalezza. È un senso incombente di minaccia. La scelta del bianco e nero è propria dello stile di Salgado, ma in questo caso contribuisce a generare quell’impressione. Gli oceani sono catini oscuri, i cieli sipari pronti allo strappo. Spiegando le ragioni che l’hanno spinto a questo lungo viaggio Salgado ha iniziato affermando che «il mondo è in pericolo» e quest’oasi nel deserto riflette quella convinzione. Le ombre che si allungano appartengono non al futuro (ancora una volta non c’è distanza di tempo, solo di spazio) ma a quel che c’è oltre i fragili confini, oltre le rocce dove i leoni marini riposano beati, oltre le acque dove una tartaruga gigante antidiluviana si muove pigra da sempre. Quell’ombra è proiettata dalla seconda metà del progetto Genesi, in cui si documenterà l’avvento sulla scena della presenza umana. Quella incontaminata, tradizionale, preconflittuale, assicura l’autore. Ma come in ogni uomo è rintracciabile il bambino, in ogni bambino, fin dalla nascita, traluce per un istante nitido e inequivocabile l’uomo che verrà. E ogni inizio proietta sullo specchio del tempo la propria fine. DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 FOTO SEBASTIÃO SALGADO/AMAZONAS/CCONTRASTO LE TESTUGGINI PREISTORICHE Le testuggini giganti sono imponenti per dimensione - possono arrivare a un metro e mezzo di grandezza e pesare 250 chili per longevità - possono vivere più di 150 anni e per la loro solitudine. In effetti, tranne che durante la stagione dell’accoppiamento, le testuggini vivono in solitudine per tutta la vita. IL LEONE MARINO E LA LUCERTOLA Qui una lucertola della lava è seduta su un leone marino. Ciò che mi ha maggiormente colpito alle Galapagos è stata la gioiosa coabitazione tra le diverse specie animali. A volte si vedono animali di specie diverse condividere lo stesso territorio in grande armonia a dimostrazione del loro essere complementari. Alcuni uccelli, per esempio, puliscono le tartarughe eliminando zecche e altri parassiti e ciò garantisce cibo agli uni e sollievo agli altri. Un altro esempio: sull’isoletta Daphne Major i fringuelli bevono sangue dalle sule bianche 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Genesi DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 I grandiosi leoni marini, le testuggini ultracentenarie e poi cormorani all’ombra dei vulcani e iguana a caccia di un raggio di sole: sono gli animali che abitano I CORMORANI CHE NON VOLANO Cormorani inabili al volo a Punta Espinoza. Isola Fernandina. Presso queste acque fresche c’è una vasta colonia di questi uccelli davvero speciali. Delle 29 specie di cormorani che esistono al mondo, questa è l’unica che ha perso la capacità di volare FOTO SEBASTIÃO SALGADO/AMAZONAS/CONTRASTO lo scenario primitivo delle Galapagos Dove tutto è ancora in perfetta armonia SEBASTIÃO SALGADO (segue dalla copertina) IL GIGANTE DELL’ARCIPELAGO Leoni marini a Puerto Egas, James Bay. Isola Santiago. Il leone marino delle Galapagos è uno degli animali più grandi dell’arcipelago; può arrivare a pesare 250 kg ma anche così è più piccolo dei leoni marini della California, di cui anche lui è originario. Qui, un gruppo si sta riposando all’ombra di bellissime rocce formate da cenere vulcanica che si è ammucchiata e compattata lì che intendo cercare i volti incontaminati della natura e dell’umanità: mostrare la natura senza uomini e donne, e come l’umanità e la natura siano per lungo tempo riuscite a coesistere in quello che oggi viene definito equilibrio ambientale. È un progetto che affonda le sue radici nelle lunghe ricerche fotografiche che hanno portato ai libri e alle mostre realizzate in questi anni: Other Americas, Sahel: L’Homme en Détresse, La mano dell’uomo e In cammino. È al tempo stesso il frutto di un’iniziativa intrapresa insieme a mia moglie, Lélia Deluiz Wanick, per riforestare 600 ettari di terra in nostro possesso in Brasile con specie originarie della foresta atlantica. Ho chiamato questo progetto Genesi perché il mio obiettivo è tornare alle origini del pianeta: all’aria, all’acqua e al fuoco da cui è scaturita la vita, alle specie animali che hanno resistito all’addomesticamento, alle remote tribù dagli stili di vita “primitivi” e ancora incontaminati, agli esempi esistenti di forme primigenie di insediamenti e organizzazione umani. Le fotografie saranno divise in quattro capitoli: “La creazione”, “L’Arca di Noè”, “I primi uomini” e “Le prime società”... ... Penso che questo progetto m’impegnerà per almeno otto anni, ma sono convinto che saranno i più ricchi e i più pieni della mia vita. A 59 anni comincio a comprendere i punti di forza e di debolezza della razza umana. Con mia moglie ho anche imparato a conoscere e amare la natura. I quattro capitoli non saranno fotografati separatamente, né le regioni geografiche saranno trattate come tali. Come sempre, scatterò in bianco e nero. In questa occasione mi auguro di trovare le risorse che mi permetteranno di dedicare tutte le mie energie esclusivamente a questo progetto. Una volta completate, vorrei che le fotografie fossero esposte in spazi pubblici nelle grandi città, libere dalle costrizioni di musei e sale mostre. A questa mostra pubblica si affiancherà un grosso libro – o più libri, magari uno per capitolo – distribuiti da un editore di portata mondiale e venduti a un prezzo ragionevole. M’immagino inoltre una serie separata di libri per bambini. Forse si riuscirà perfino a inserire questi libri e questi programmi educativi all’interno dei vari sistemi educativi nazionali. È DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 IL FOTOGRAFO DEGLI SCONFITTI Sebastiao Ribeiro Salgado nasce l’8 febbraio 1944 ad Aimorés, nello stato di Minas Gerais, in Brasile. A 16 anni si trasferisce nella vicina Vitoria, dove finisce le scuole superiori e comincia gli studi universitari. Nel 1973 si trasferisce a Parigi per intraprendere la carriera di fotografo. Lavorando prima come freelance e poi per le agenzie fotografiche Sygma, Gamma e Magnum, Sebastião viaggia molto, occupandosi prima degli indios e dei contadini dell’America Latina, quindi della carestia in Africa verso la metà degli anni Ottanta. Queste immagini confluiscono nei suoi primi libri. Tra il 1986 e il 2001 si dedica principalmente a due progetti. Prima documenta la fine della manodopera industriale su larga scala nel libro La mano dell’uomo ( Contrasto, 1994). Quindi documenta l’umanità in movimento, non solo profughi e rifugiati, ma anche immigranti verso le immense megalopoli del Terzo mondo, in due libri di grande successo: In cammino e Ritratti di bambini in cammino (Contrasto, 2000). LE IGUANE AL SOLE Come altri rettili, l’iguana marina è una creatura ectotermica, così deve regolare la temperatura del corpo: appena il sole sorge, l’iguana marina si distende esponendo l’area pià ampia possibile del proprio corpo ai raggi solari. Quando raggiunge la temperatura di 35,5° Celsius cambia posizione per evitare il surriscaldamento. 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 la memoria Società dell’immagine Nell’ottobre di trenta anni fa la Barilla lancia il marchio Mulino Bianco. Sembra il momento meno adatto: shock petrolifero, inflazione elevata, terrorismo rampante. Eppure quelle immagini flou di famiglia felice e di ritorno ai valori contadini riattivano ricordi e sentimenti nascosti nel Paese. Con successo Lo spot che vinse controvento nosciuto la motorizzazione convulsa, l’Autosole, Carosello, e sullo sfondo dell’industrializzazione le grandi migrazioni interne, la raffigurazione del vecchio mulino costituiva non tanto un’immagine empirica quanto un luogo della memoria. Le prove degli annunci pubblicitari si spingevano a spiegare quel mondo ormai perduto e che il Mulino Bianco recuperava miracolosamente dalle pieghe del ricordo: «Quanti di noi ricordano il sapore del latte appena munto?». Quasi nessuno, ovviamente: ma l’immagine della mucca e della ragazza, mentre una gallina becchetta lì attorno, toccavano strati di sentimento che fino allora erano rimasti inerti. Slogan che erano non-slogan, lunghissimi, che evocavano il grano, il burro, il latte, il miele. Testi in corpo più piccolo che descrivevano minuziosamente il piacere di una colazione possibile. E sopra tutto, l’icona del Mulino: «Quando i Mulini erano bianchi». Negli spot di Giuseppe Fina, un regista di cinema e televisione, ecco le scene di vita rurale, con i contadini (quasi sempre) veri, i lavori nei campi, un manierismo documentario in cui la natura era l’acme dell’artificio. Per i pubblicitari, il Mulino Bianco significava «valori forti, prodotti buoni, coinvolgimento emotivo, una presenza amica», addirittura «un riferimento di comportamenti etici». Per il pubblico era un serial, una soap opera in cui la narrazione si sviluppava cambiando via via tonalità. Quando “il bel tempo andato” non funziona più, viene fuori l’idea una modernità ambientalista, il desiderio di una vita buona fuori dallo stress quotidiano e immersa nella natura. EDMONDO BERSELLI n principio erano solo biscotti. Ma se si azzecca l’idea, se questa idea viene lavorata, se il prodotto, cioè il biscotto e derivati, si integra perfettamente con la sua immagine, e se l’immagine genera un sentimento, e il sentimento diventa uno spot, o perfino un film, e se tutto questo, compreso il “packaging”, compreso il “coccio” di terracotta, compresa la famiglia felice, compreso il mulino restaurato ad hoc in Toscana, insomma compreso tutto, diventa un mito, anzi «un moderno mito collettivo», come dicono i pubblicitari, be’, allora non si tratta più di biscotti, tarallucci, macine, galletti e via sgranocchiando la mattina a colazione: siamo piuttosto nei pressi dell’«invenzione della tradizione» di cui ha parlato Eric Hobsbawm, lo storico del Secolo breve. Qualcuno ha inventato il kilt e una Scozia archetipica, qualcun altro ha inventato il mondo a parte della natura incontaminata, dove le famiglie erano buone, la vita era sana, e i mulini erano bianchi. Per l’appunto. I Desideri subliminali Era il 1975 quando Gianni Maestri avviò la regia culturale e pratica del progetto che si sarebbe realizzato nell’immagine del Mulino Bianco. In quella metà degli anni Settanta il clima non era rassicurante: inflazione elevata, scontro sociale acuto, «anni di piombo» nella percezione di tutti. Eppure, a ripensarci oggi, erano anche gli anni in cui un ricognitore appassionato e spesso in controtendenza come Giuseppe De Rita vedeva una straordinaria creatività sociale: la spinta dell’impresa famigliare, il modellarsi di quel tessuto che un economista curioso e non dogmatico come Giorgio Fuà (l’autore a metà degli anni Settanta di un libro seminale, Occupazione e capacità produttive) avrebbe più tardi denominato «industrializzazione senza fratture»: cioè l’industria dietro la siepe, il territorio come culla delle competenze, l’ambiente artigiano come fonte di una crescita economica spesso non censita dalle fonti ufficiali. Certo, per costruire un mito, ci vuole il realismo freddo di chi intuisce i desideri anche subliminali della platea dei consumatori, e su questa struttura percettiva allestisce un repertorio di prodotti: «sei piccoli biscotti», scrisse lo stesso Maestri, «a cui seguirono sei pani e poi sei merende, sei torte». Una successione scandita, quasi un andamento ritmico da favola, ma di una favola che misurava di continuo l’effetto sul pubblico attraverso le indagini “di profondità”, e addirittura cercava di tarare l’affettività della clientela verso quei prodotti nuovi iscritti nella stessa cornice visiva e simbolica, «il muro giallo che era davanti agli occhi di chi entrava nel supermercato, che sarebbe divenuto presto familiare a tutti». Non è necessaria neanche una sociologia rudimentale per descrivere l’Italia degli anni Settanta: reduce dallo shock petrolifero che aveva indotto la soluzione retorica delle domeniche a piedi, imbrigliata dal blocco dei prezzi sui generi alimentari di base (gli americani che avevano acquisito la Barilla rimasero traumatizzati da misure antimercato di questo tipo); e poi, schiacciata dall’asprezza micidiale dell’avventura terroristica, permeata da un conflitto ancora intriso di fattori classisti, ma soprattutto condizionata da alcuni grandi ideologismi che si riassumevano nella concezione che la cadu- ta tendenziale del saggio di profitto stava avendo la meglio sul capitalismo, che Marx aveva liquidato Braudel, il proletariato moderno avrebbe scalzato la borghesia, e che insomma il modello di sviluppo stava giungendo al capolinea, le risorse si stavano esaurendo e il futuro si profilava buio tenebra. Ci voleva un’intuizione di eccezionale capacità analitica per comprendere che in quell’Italia lì, in quella società apparentemente disintegrata, permanevano nella psicologia condivisa sentimenti non riconosciuti né dalla politica né dall’economia. Cioè sopravviveva almeno negli strati profondi della mentalità diffusa una specie di utopia rivolta all’indietro, che si sarebbe fatta suggestionare dalle «buone cose di una volta». In parte “albero degli zoccoli”, ma in parte anche desiderio implicito di pacificazione e di serenità: una vita «fresca di Mulino», disegnata con le spighe e i fiori, con tonalità da primo Novecento, volutamente ricalcata sulle oleografie. Una visione regressiva? Evidentemente la pubblicità non ha pregiudizi culturali, è onnivora esattamente come i consumatori. Il Mulino Bianco rappresentava infatti il quadretto a colori pastello di un’età incontaminata e di una In quell’Italia apparentemente disintegrata, sopravvivevano nella psicologia di massa emozioni non riconosciute né dalla politica né dall’economia: una specie di utopia rivolta all’indietro natura piacevole, e presentava alcuni suoi prodotti nelle nuove/vecchie confezioni in sacchetto, memoria tattile dei buoni prodotti di una volta. Ciò significava che si era creata nella produzione industriale e nel mercato una nicchia, che sarebbe diventata uno spaccato sociale, in cui il pubblico intravedeva la genuinità, rispetto al prodotto massificato delle aziende alimentari, i cui ingredienti erano invece anonimi e manipolati dal processo industriale. Questo atteggiamento intercettava allora anche un’altra dimensione del gusto, un’altra tendenza alimentare: il «mangia sano, torna alla natura», l’idea che quando sono caduti tutti i miti l’uomo è davvero ciò che mangia. La fitness gastronomica incrocia in modo irresistibile la wellness della vita salubre. Il Mulino Bianco sintetizzava in un’immagine-simbolo il non troppo inconscio desiderio bucolico, o arcadico, degli abitanti delle metropoli nevrotizzate dallo scontro di classe e dalla crisi dell’industria nazionale. Alludeva al consumo e non al consumismo, alla piccola patria della natura, alla valle felice quando «qui era tutta campagna» e c’erano ancora le stagioni. E soprattutto, quando c’era ancora la memoria. In effetti, per un paese che aveva co- Atmosfere rarefatte Accanto al Mulino Bianco, visto che a causa di una malattia non fu possibile ricorrere all’arte di Ella Fitzgerald, ci può essere la ragazza contadina con la chitarra, una boccoluta folksinger rurale, che canta i versi di Bruno Lauzi: «Hai mai visto il grano? / È come un mare biondo / che si muove / e fino nel profondo ti commuove…». Oppure lo sfondo delle musiche di Ennio Morricone, «una vera e propria melodia, sinuosa e articolata nel suo arco di otto battute», che accompagna le avventure minimali e benigne della Famiglia del Mulino. Atmosfere rarefatte, in una “saga” che agli esordi ha interiorizzato Ermanno Olmi e lo traduce in una versione flou, virata nella maniera, e poi, dopo lo stereotipo del ricordo, conia la matrice narrativa del ritorno. Forse l’unica cosa vera, reale, oggettiva di questa visione è proprio il Mulino di Chiusdino (Siena), restaurato e dipinto di bianco, in cui può rifugiarsi la famiglia che lascia la città e si ritrae nei colori della memoria, filmata da Giuseppe Tornatore. A due passi c’è l’abbazia di San Galgano, ignorata da tutti e fatiscente: i turisti in gita domenicale accorrono a fotografare il Mulino, un reperto ad un tempo vero e falso, esaltato dalla potenza della televisione, assaporato insieme alla fragranza dei prodotti della Barilla. Probabilmente ignare di gustare madeleine molto più popolari di quelle proustiane, le folle che ammirano il Mulino ignorano anche che stanno consumando un prodotto insieme reale e immaginario, una specie di corpo o articolo mistico fabbricato secondo procedure industriali, con il lavoro di gruppo, con i test sulla clientela, nel tentativo, evidentemente riuscito di suggerire ciò che il consumatore vuole, crede di volere, crede di credere. LE TAPPE I PRIMI SPOT IL MONDO CONTADINO IL PICCOLO MUGNAIO LA RAGAZZA CON LA CHITARRA LA FAMIGLIA FELICE Mulino Bianco approda in tv nel 1976: le prime pubblicità sono in bianco e nero. Sono gli anni in cui esce lo storico spot del bambino a cavallo Nel gennaio del ’78 vengono trasmessi i primi spot a colori e ha inizio la saga del mondo contadino, attento ai valori dei sentimenti e delle piccole cose A partire dal 1982 compaiono i brevi cortometraggi animati con le avventure del piccolo mugnaio bianco che vuole far innamorare coi suoi dolci la bella Clementina Nel 1987 arriva un personaggio più moderno: è la Ragazza con la chitarra che canta la vita nei campi, ma si smarrisce un po’ l’atmosfera familiare di sempre Nel ’90 protagonista degli spot è la “famiglia felice” che sogna di vivere in una casa nel verde: la musica dai toni affettuosi e sereni è di Ennio Morricone DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 LA LOCATION A destra, la famiglia dello spot Mulino Bianco A sinistra dall’alto, una stampa ottocentesca e uno schizzo di Gio Rossi per la creazione del marchio. In basso, il mulino di Chiusdino prima e dopo il restauro La famiglia “Mulino Bianco” Pubblicità modello studiata all’università ETTORE LIVINI ualcuno è cresciuto a Tarallucci. Altri hanno iniziato molte delle loro giornate inzuppando un Galletto in una scodella di latte. Oppure pucciando nel tè una Macina. In una sfida quotidiana per riuscire a metterla in bocca una frazione di secondo prima che si sciolga nella tazza. I gusti variano. Ma i biscotti del Mulino Bianco — il marchio della Barilla che proprio in queste settimane festeggia i suoi trent’anni d’età — sono diventati un po’ come le canzoni di Lucio Battisti: tutti li conoscono (il 96% delle famiglie italiane, secondo la Nielsen, consuma i biscotti, il 75% le fette biscottate), senza distinzioni d’età. Nonni, mamma, papà e figli. Come l’idilliaca famiglia felice del mulino di Chiusdino (tinteggiato di bianco per l’occasione) che cinque anni di spot tra il ‘90 e il ‘94 — con la regia di Giuseppe Tornatore e la musica di Ennio Morricone — hanno trasformato in un’icona del potere della pubblicità e in un archetipo dell’immaginario collettivo nazionale. Così oggi questa «visione straordinaria, frutto di tanto pathos emotivo» — come ricorda Guido Barilla, presidente della società — è diventata un fenomeno sociologico oggetto di studio alle università. E soprattutto una gallina dalle uova d’oro per la famiglia parmigiana. I numeri parlano da soli: ogni giorno si consumano 25 milioni di biscotti del Mulino Bianco e 11 milioni di fette biscottate. Il business — compresi gli altri 110 prodotti, dai cracker alle merendine — occupa 2.500 persone e vale 900 milioni l’anno, con 300 milioni investiti in ricerca e sviluppo dal 2000. I “cocci” — i regali promozionali distribuiti tra l‘80 e il ‘95 — sono diventati oggetto di culto tra collezionisti, con le brocche che su E-Bay si trattano oggi sui 50 euro l’una. Il segreto? Guido Barilla non ha dubbi: il rispetto trentennale dei valori su cui Gianni Maestri, Mario Belli, Francesco Alberoni e Mambelli & Landò hanno “inventato” il Mulino. «Il primo è l’assoluta qualità — spiega il presidente — che ci ha permesso di vincere la sfida con i prodotti non di marca. Poi la fedeltà ai concetti di salute e famiglia, una frase forte che ci ripeteva spesso nostro padre. Oggi, con la società moderna che continua a cambiare, dobbiamo garantire questo equilibrio nutrizionale con prodotti che diano anche una gratificazione». Concetto che in futuro vorrà dire ridurre al minimo o eliminare gli ingredienti non bilanciati e non naturali «come i grassi idrogenati». Questi sono i pilastri. Attorno ci lavorano, in un’organizzazione orizzontale e interdisciplinare, tutte le strutture del gruppo. Marketing, sviluppo, ricerca e produzione. Affiancati da qualche tempo da un Nutritional advisory board, una sorta di comitato di superconsulenza di quattro luminari nel settore dell’alimentazione e della medicina. Il lievito del successo del Mulino Bianco, però, non sono solo freddi processi di flussi di produzione industriale o le riunioni oceaniche di guru dello pubblicità. Gli eredi di Tarallucci, Galletti e Macine nascono in un micro-laboratorio dove lavorano 80 maestri pasticceri. Una sorta di tempio della prima colazione e della merenda, dove ogni giorno si impastano farine, si amalgamano cereali e si scioglie cioccolato con la passione e gli strumenti (mattarello compreso) della bottega di un artigiano. Qualcuna di queste “invenzioni” (qualche decina all’anno) supera il primo studio di fattibilità industriale. Ma l’esame più difficile, l’ultimo prima di arrivare sugli scaffali dei negozi, è oggi lo stesso di trent’anni fa: l’assaggio dei fratelli Barilla. Al secondo piano dello stabilimento di Parma, tra i Picasso, i Guttuso e i Morandi della straordinaria collezione di famiglia, questa degustazione dà l’imprimatur al lancio di nuovi prodotti. Funziona? Evidentemente sì. Se è vero che il Mulino inventato a due passi da Parma, a furia di macinar idee di successo (e malgrado qualche diversificazione all’estero non proprio felicissima) è riuscito a fare della Barilla una delle poche grandi aziende di casa nostra in grado ancora di competere a livello mondiale. Q LA BAMBINA CON L’ORSETTO Esce, infine, nel 2004 lo spot con la bambina che, dopo aver tuffato i Pan di Stelle nel latte, li offre al suo orsetto. Per musica la colonna sonora de “Il gladiatore” 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA FRANCESCO MERLO P PARIGI iero Fassino forse non ci ha pensato, ma anche la sua fede, la conversione-ritrovamento o la conversione-risveglio, è tema manzoniano, come del resto tutti i temi dello Spirito italiano. E, prima ancora che del romanzo, è un tema del Manzoni parigino, quello che nel giugno 1805 arrivò libertino nella città più libertina del mondo, e ne ripartì devoto e bigotto nel giugno 1810, passando da Voltaire all’abate Degola. Manzoni incontrò Dio sugli stessi boulevard dove gli artisti incontravano il piacere sensuale e dove oggi non si incontra né il cielo né la terra. Chi oggi si ostina a passeggiarvi trova solo quello spaesamento urbano che a Parigi descrisse per primo Baudelaire. La casa del Manzoni stava nel tratto più elegante del boulevard des Italiens, nel piccolo universo degli incontri, dei fiocchi svolazzanti, delle esibizioni dell’equilibrista madame Saqui su una corda tesa tra due balconi. Oggi quella Parigi è altrove, si sposta qua e là: Parigi ambulante tra «gli ambulanti che soffriggono musica» direbbe Paolo Conte. Dunque è persino difficile immaginare la casa che si affacciava sul mercatino della frutta, dal quale si alzava una nuvola di mosche e moscerini, e sul Bains Chinois, strana costruzione a pagoda ritratta nelle stampe d’epoca, sede di un bagno e di un caffè di grandissima reputazione, quasi quanto il caffè Godet, dove anche Manzoni sedeva alla ricerca di una identità non solo letteraria. Quei “salotti” sul boulevard inauguravano il modello ideale dei caffè che sono ancora le vere piazze di Parigi, mondi aperti ma gerarchizzati, raffinati e simbolici, come vorrebbe ancora essere, dall’altra parte della Senna, il famoso Flore, nel quale, diceva Italo Calvino, «servono il più costoso uovo fritto di Parigi». La morte di Stendhal Da tempo il boulevard non è più quel campo di battaglia degli scrittori e delle cortigiane dove una sera del 1842 Stendhal, rimpinzato di carne e di vino, cadde a terra morto stecchito, lo Stendhal “milanese” e italianista che dei Promessi Sposi aveva detto: «Un libro veramente troppo lodato. Senza dubbio Tommaso Grossi è migliore scrittore, o almeno ha più ingegno». Manzonianamente, col senno di poi: «Tommaso Grossi, chi era costui?». Manzoni vi abitò con la moglie Enrichetta e con la madre proprio nell’anno della conversione. In quella casa nacque sua figlia, per mano di una levatrice, perché il parto era faccenda di donne. Persino Kant aveva notato che il «vero parto» avveniva solo con l’intervento del padre: la denunzia anagrafica. Manzoni scelse il nome Giulia, quello di “maman”. Per un altro conformismo, divenuto anch’esso tipicamente italiano, Manzoni volle il battesimo cattolico, imponendolo sia a se stesso, ché (ancora) non credeva, sia alla moglie calvinista. E fu lui a scegliere la chiesa di san Nicola a Meulan, dov’era stato celebrato il funerale del compagno della madre, Carlo Imbonati: strana cerimonia cattolica con il padre (ancora) “libertino”, la nonna che ripensava al suo Carlo, la mamma che avrebbe voluto un altro rito, e il padrino Charles Fauriel a recitare un Credo al quale non avrebbe mai creduto. La chiesa è ancora lì, isolata nella campagna, persino più bizzarra di allora, in una Parigi a 50 chilometri da Parigi. Chi oggi si mette a passeggiare seguendo l’itinerario manzoniano non ha guide, e deve andare per accenni... I luoghi manzoniani sono infatti più ideali che reali e non soltanto perché, nella immensa bibliografia, Nella Parigi dove Manzoni incontrò Dio nessuno ha tracciato, quando ancora si poteva, la mappa completa della Parigi manzoniana che, a sua volta, è un altro mito fondativo di un’Italia che poi si fece mentre Parigi si disfece. La verità è che il Manzoni parigino è solo una vaghezza culturale, un linea dritta di astrazione che va dalla Madeleine alla Bastiglia, lungo la rue Saint Honoré, oggi linea dello shopping. Sappiamo che ventenne, balbuziente e non ancora consapevolmente malato di nervi, Manzoni passava molto tempo in una libreria italiana e la madre lo prendeva in giro perché la proprietaria, la signora Fayalle — diceva — «non è certo un’amante adatta a mio figlio». La libreria si trovava al 244 di rue Saint Honoré, un numero civico che non esiste più. E non c’è più neppure l’appartamento che madre e figlio vi presero in affitto, sentendosi insieme «quasi in paradiso». Nella rue Saint Honoré è rimasta solo san Rocco, la chiesa di quel miracolo che è il solo avvenimento sul quale si è molto lavorato e speculato. Il 2 aprile 1810, durante i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone e Maria Luisa, spaventato dai fuochi d’artificio, pigiato nella calca dove aveva perso la moglie, Manzoni sarebbe stato colto dalla sua prima crisi convulsiva e, nel tentativo di correre a casa, si sarebbe rifugiato in san Rocco mentre i monaci cantavano «O mio Dio, se tu esisti, rivelati a me...». Oggi in questa chiesa, che pure ha inaugurato, come nostra identità, la nevropatia miracolistica, non c’è che una lapide distratta. Sui gradini riposano i turisti e, alla fine, esplorando la storia di san Rocco, risulta più evocativa la celebrazione del matrimonio del marchese de Sade. La verita è che lo stesso Manzoni inaugurò il “grattage” della Parigi libertina dalla propria vita. E il grattage del passato è un altro fondamento del carattere degli italiani che poi scoprirono l’antifascismo nel fascismo, il comunismo nel corporativismo, il liberalismo nell’estremismo del sessantotto... Così alla fine viene ricordato come luogo tipicamente manzoniano solo l’ultima casa, in rue de Seine, dove la famiglia, ormai numerosa, abitò per alcuni mesi nel 1818, tredici anni dopo il primo viaggio a Parigi, quello da “libertino”. Manzoni, già devotissimo, rimase a letto malato per quaranta giorni disturbati dai rumori del mercato, che, bellissimo, è ancora lì. Il quartiere è oggi quello del post esistenzialismo ma con una presenza ancora forte e discreta di boutique di liturgia, madonne e santi in vetrina, sartorie di abiti talari, librerie religiose tra le due grandi chiese, Saint Sulpice, e soprattutto Saint Severin dove Enrichetta pronunziò l’abiura, che è un altro paradigma italiano. Oggi Saint Severin, una delle più antiche e belle chiese di Francia, è circondata da ristoranti greci, pessimi già all’aspetto. Di fronte, chiusa da una porta di legno, c’è ancora la stradina più stretta del mondo, l’impasse Eliane-Divron, il cul-de-sac che spinse Voltaire a imporre il nome impasse a tutti i cul-de-sac di Parigi: «Chiamo impasse quel che voi chiamate cul-de-sac. Trovo che una strada non somiglia né a un culo né a un sacco. Vi prego dunque di servirvi della parola impasse che è nobile, sonora, intelligente, necessaria». Manzoni si divideva tra Saint Severin e Saint Sulpice, la cui facciata è ancora oggi sapientemente “grattata”: durante la rivoFOTO CORBIS Vite letterarie Nel 1805 il giovane Alessandro arriva nella capitale con la reputazione, fondata, di libertino. Ne riparte cinque anni dopo cattolico devoto e bigotto. Abbiamo ricostruito e seguito le tracce della sua vita francese: dalla casa in boulevard des Italiens alla chiesa di San Nicola a Meulan. Un salto all’indietro per definire una mappa di quegli anni di svolta che lo stesso autore dei Promessi Sposi cercò di cancellare FOTO ROGER VIOLLET i luoghi DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 luzione fecero sparire la croce, il triangolo, la barba di Dio... Dentro, anche Manzoni rimase stupito dallo strano gnomo, ora reso famoso dal Codice da Vinci. Oggi c’è un cartello severo che mette in guardia dalle «suggestioni pagane di un pessimo romanzo di successo». Ma di sicuro il bizzarro gnomo astrologico che sta tra due altari non è un simbolo cattolico. Anche questo dunque è grattage. Lo stesso che spinse Manzoni a consegnare al canonico Tosi le preziose Oeuvres di Voltaire, cento volumi con dedica originale dell’autore. Alla morte del Tosi furono trovati solo i cartoni. Oggi, dimesso e modesto, al 66 di rue de Seine c’è l’hotel Welcome, due stelle: 96 euro per una doppia, dove forse ha dormito Manzoni. Settanta la singola. Almeno cinquecento euro costa invece la camera all’Hotel Vendôme, dentro il quale è inglobato il primo appartamento parigino di Manzoni. Il permesso di soggiorno è datato 12 luglio 1805, ma è probabile che Alessandro sia arrivato in una sera di giugno e che dunque abbia fatto in tempo ad abitare nella casa che la madre aveva condiviso con Carlo Imbonati al numero 3 della piazza ottagonale che è più o meno come allora, se si esclude la torre che, proprio in quei giorni, gli operai cominciavano a costruire. Dormì dunque in una stanza col soffitto ricco di fregi a corona, le tende di percalle, sentendo gli operai che lavoravano al gabbione e il gracchiare di un pappagallo al quale un vicino di casa, un mutilato di guerra senza un braccio, cercava inutilmente di I SUOI POSTI Alessandro Manzoni visto da Tullio Pericoli A sinistra, stampe d’epoca della chiesa di Saint Sulpice e del boulevard des Italiens DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 CHIESE E CAFFÈ FOTO ROGER VIOLLET FOTO ROGER VIOLLET A sinistra, un disegno del Cafè Godet, e una foto dell’interno della chiesa di Saint Severin, luoghi frequentati da Alessandro Manzoni nel suo soggiorno parigino Dove sorgeva il caffè Ranelagh ora c’è una brasserie specializzata in birre forti. E dentro Saint Sulpice, lo scrittore si stupì per lo gnomo oggi reso famoso dal Codice da Vinci insegnare la Marsigliese. Oggi in quella città-cantiere che Napoleone voleva rendere «la più bella e la più libera del mondo» non è rimasta alcuna traccia biografica dei libertinaggio di un ragazzo che pure a Milano aveva avuto l’educazione sentimentale tipica di un allievo del collegio religioso, «il sozzo ovile», mettendo in cinta bimba la cameriera della cugina, e beccandosi pure la comunissima «grave ciprigna» che allora si curava con impacchi di seme di lino, dieta di pane, beveraggi di camomilla, lunghi giorni di letto. A Parigi invece la sua vita sarebbe stata libertina ma casta, a meno di non immaginarlo sotto i portici del Palais Royal, dove oggi si aprono ristoranti e negozi di antiquari tra cui un famoso rivenditore di pipe, mentre allora c’era il bordello regolamentato, cellula di quel French System sotto controllo dell’ufficiale medico e sotto stretta sorveglianza delle tenutarie, che per circa due secoli si sarebbe imposto come modello sessuale in tutta Europa. La diligenza che veniva da Milano passando per Digione lasciò Alessandro in place de la Concorde che era un luogo sinistro, un grande slargo di terriccio e di erbacce degradante verso la Senna. Per molti anni vi era rimasta, sia pure inoperosa, la ghigliottina che aveva giustiziato anche il re. I soldati avevano coperto di pietre e calce le pozze di sangue, ma c’era ancora, fortissimo, il cattivo odore. Anche oggi la Concorde non riesce a diventare né bella né piazza, forse perché è aperta da tre lati. Il traffico, intenso e disordinato, la rende uno dei luoghi urbani più pericolosi del mondo. E, nonostante lo spazio, vi domina di nuovo il cattivo odore, quello dei gas di scappamento. Gli imbronciati di Auteuil Rimane dunque inesplorato il libertinaggio del Manzoni che sarebbe stato solo “culturale”. E infatti i luoghi della città dove gli parve che più ardesse il libero pensiero furono... le colline. I famosi Idéologues vi si erano rifugiati, marcando così anche geograficamente il proprio disilluso distacco dal regime e dalla napoleonica capitale del mondo. Come il Candide di Voltaire avevano concluso che «bisogna coltivare il proprio giardino». Napoleone li chiamava con sarcasmo les boudeurs d’Auteuil, gli imbronciati di Auteuil. Oggi quelle colline sono diventate residenza privilegiata delle ricche famiglie inglesi e americane: molti figli, molti cani, molte jeep, molto canottaggio. Auteuil, nome che Manzoni avrebbe voluto dare alla villa di Brusuglio, è addirittura un quartiere dentro Parigi, ha conservato la struttura urbana del villaggio, ed è bello e vivace sul modello di Saint Germain. Ma non c’è più la casa dove la vedova Helvetius teneva il famoso salotto. Né sappiamo in quali caffè Manzoni si sedeva; almeno una volta sostò con la madre nel caffè Ranelagh, che oggi è una simpatica brasserie, specializzata in birre ad alta gradazione. Nel menu ce n’è una di nome “Morte Subito”. Si può berla alla sua memoria anche se non risulta che Manzoni sia mai stato un tipo da birra. È invece un casermone sia pure secentesco, integrato dentro l’ospedale, la famosa Maisonnette, la residenza di campagna di Meulan-sur-Seine, dove le vite impastoiate di Sophie de Condorcet e del suo compagno Charles Fauriel facevano sentire al giovane Alessandro il pregio di un legame fuori da quella “promessa degli sposi” verso cui avrebbe confessato di sentirsi «da sempre naturalmente portato». Fauriel era stato l’amante di Madame de Stael, e Sophie, tra gli altri, era stata l’amante di un ex prete, il padre di Charles Baudelaire. Il paesaggio che vi si gode è ancora quello di allora, sebbene meno incantato per le fabbriche e i palazzoni lungo la valle che degrada verso la Senna, dove l’isola è sempre bellissima. In quel che fu il parco alberato, la cappella sconsacrata è un deposito di attrezzi da giardino. E nella cameretta dove dormiva Alessandro, «questa piccola cameretta dove per sempre si perderà la mia immaginazione», oggi (forse) dorme una vecchia signora, Madame Sarte, con una bella faccia che pare corrosa da un temporale. Non sa nulla di letteratura, e parla solo dei suoi due figli, sepolti al cimitero di Meulan, volati via come due foglie di ottobre, come due pagine di quel catechismo che, pur tra tanta devozione, e grazie anche alla Parigi libertina, ha insegnato a generazioni di italiani che non bisogna esser codardi e opportunisti come don Abbondio; che siamo tutti Renzo Tramaglino, tutti impulsivi e masochisti; che c’è sempre una donna Prassede, pronta a torturarci per il nostro bene. 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 Prima di morire, l’uomo che ha dedicato la vita alla cattura dei responsabili dell’Olocausto comprese di avere un’altra missione: combattere contro il nuovo antisemitismo. Decise così di scrivere una lettera ai grandi della Terra, chiedendo di prendere posizione di fronte al fenomeno. Quel testo, finora inedito, è diventato il testamento spirituale del suo autore. E “Repubblica” ne ha girato le domande a intellettuali, scrittori e religiosi. Ecco le loro risposte “Il genocidio e le atrocità nel mondo non sono finite con la caduta del regime di Hitler. Non posso restare in silenzio davanti all’attuale ondata di odio nei confronti degli ebrei” FRANCESCA CAFERRI er tutta la vita ha scavato nel passato, Simon Wiesenthal: nei documenti, nelle carte, nei ricordi di chi come lui aveva attraversato l’inferno e dalle fiamme era uscito vivo, chissà per quale motivo. Il suo motivo Wiesenthal l’aveva trovato quasi subito: perpetuare il ricordo, fare giustizia, evitare l’oblio. Ma negli ultimi anni dopo che per ragioni anagrafiche, sue e dei suoi obiettivi, aveva smesso di inseguire i nemici di una vita, il cacciatore di nazisti era stato colto da un’altra ossessione, quella del futuro: «Nel mio 95simo anno di vita, dopo aver constatato che il genocidio e le atrocità nel mondo non sono finite con la caduta del regime nazista, non posso restare in silenzio di fronte all’attuale ondata di antisemitismo». Inizia così la lettera che è diventata il testamento spirituale di Simon Wiesenthal. Nella missiva, inviata l’inverno scorso, l’uomo diventato il simbolo della domanda di giustizia dei sopravvissuti alla Shoah invita capi di Stato e di governo, parlamentari europei, premi Nobel, intellettuali e esponenti di tutte le religioni a un dialogo intorno agli interrogativi che lo hanno assillato nell’ultima parte della sua vita. «Cos’è l’antisemitismo?». E ancora: «Cosa pensate andrebbe fatto a proposito?». Lo scopo, come spiega lo stesso Wiesenthal, era avviare una discussione pubblica sulla scorta di quella da lui stesso voluta sul tema della vendetta e del perdono e raccolta nel libro Il girasole. Dalle risposte sarebbe dovuto nascere un altro libro, dedicato all’antisemitismo e alla convivenza pacifica fra le diverse religioni e le diverse società: Wiesenthal lo aveva pensato come ideale ponte fra passato e futuro, come il suo lascito alle prossime generazioni. Quel testo, che i collaboratori avrebbero voluto presentare a Wiesenthal per il suo 97simo compleanno, nel dicembre prossimo, vedrà ora la luce postumo. «È il nostro modo per rendere omaggio alla sua memoria», spiega Shimon Samuels, direttore del braccio europeo del centro Simon Wiesenthal e curatore dell’opera. Nelle prossime settimane Samuels e i suoi collaboratori raccoglieranno le risposte già arrivate e solleciteranno quelle che ancora mancano: lo scopo è arrivare alle stampe per la fine dell’anno. «Non ha mai voluto che in sua memoria fosse eretto un monumento statico — prosegue Samuels — ha acconsentito a dare il suo nome al centro perché voleva che il suo lavoro andasse avanti». «Ho ricevuto molti premi — diceva Wiesenthal negli ultimi anni —, quelli moriranno con me. Ma il centro continuerà ad operare e questa sarà la mia eredità». Un’eredità che oggi vive nel lavoro che la fondazione sta facendo in posti come i Balcani e il Ruanda, dove le domande che Wiesenthal si è fatto per cinquant’anni sul rapporto fra criminali e vittime, il perdono, la giustizia e la vendetta sono ancora attuali. E che trarrà nuova linfa dalla pubblicazione del libro, che ha il titolo provvisorio di Strategie per la tolleranza: combattere l’antisemitismoe che sarà edito in collaborazione con l’Unesco e con il contributo del braccio italiano del Centro Wiesenthal, l’organizzazione Olokaustos. Il testo si comporrà di due sezioni: nella prima saranno raccolte le testimonianze di chi si batte in prima linea contro l’antisemitismo in Europa e nel mondo, nella seconda le risposte alla lettera. In attesa della pubblicazione del testo Repubblica ha girato le domande di Wiesenthal a scrittori, intellettuali, religiosi e politici. Quelle che pubblichiamo in queste pagine sono le loro risposte. P L’APPELLO “Sono convinto che l’antisemitismo, anche se colpisce gli ebrei, danneggi l’intera società. Inoltre, i metodi per contenere l’antisemitismo sono sicuramente applicabili a forme di pregiudizio e discriminazione contro altre vittime”. Così Simon Wiesenthal ha scritto pochi mesi prima di morire nella letteraappello inviata a personalità di tutto il mondo, invitate a rispondere a queste due domande: che cosa si intende oggi per antisemitismo? E che si dovrebbe fare per contrastarlo? Il filosofo Avishai Margalit “Per troppe persone restiamo un’ossessione” vishai Margalit è uno degli intellettuali più autorevoli di Israele. Filosofo della politica all’Università ebraica di Gerusalemme è l’autore, con Ian Buruma, di Occidentalismo, in cui confuta l’idea di “scontro di civiltà”. Citando l’invito contenuto nella “lettera aperta” di Simon Wiesenthal, lei “cosa intende con antisemitismo”? «Una volta sentì Isaiah Berlin dire che era “hating Jews beyond necessity”, “odiare gli ebrei al di là di ogni comprensione”. Non so se sia sua ma la trovo utile. I pregiudizi contro altri gruppi sono comuni, le ossessioni no. E troppe persone sono ancora ossessionate dagli ebrei, pur ammettendo che le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi non aiutano». Alcuni commentatori dicono che oggi i musulmani si trovano nella condizione di doversi scusare di appartenere alla loro religione per non essere accusati d’altro, un pregiudizio simile a quello sofferto per secoli dagli ebrei. È d’accordo? «Non c’è dubbio che ci siano virulenti pregiudizi anti-islamici nel mondo. Tuttavia il confronto non regge per la semplice ragione che il mondo islamico consiste di circa un sesto della popolazione mondiale mentre gli ebrei sono sempre stati un piccola minoranza, perciò molto più vulnerabile». Qual è il lascito più importante di Wiesenthal? «Il suo è stato un enorme contributo nel forgiare gli ebrei come una comunità di memoria dopo l’Olocausto e nel far sì che il mondo desse conto in maniera concreta dell’enormità di quell’evento. E sono entrambi risultati epocali. Che peccato che neppure un ministro di Israele ha trovato il tempo di partecipare al suo funerale». (riccardo staglianò) A DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 IL PERSONAGGIO Nato nel 1908 nell’odierna Ucraina, morto a Vienna il 20 settembre di quest’anno, Simon Wiesenthal vide morire più di ottanta suoi familiari nei campi di sterminio. Liberato a Mauthausen, ha dedicato la sua vita a scovare i criminali nazisti che si erano nascosti in tutto il mondo dopo la fine della guerra e la caduta del regime, facendone catturare più di mille. Il più famoso fu Adolf Eichmann, il teorico della “soluzione finale” Elio Toaff: vigiliamo per evitare che quella tragedia si ripeta “Giustizia senza vendetta ecco la nostra missione” ORAZIO LA ROCCA ’opera di Simon Wiesenthal deve continuare. Anche dopo la sua scomparsa, è importante che ci sia qualcuno disposto a raccogliere il testimone per completare la ricerca dei criminali nazisti ancora in libertà. Non per vendetta ma per un elementare senso di giustizia e per onorare, così, la memoria dei sei milioni di vittime innocenti dell’Olocausto». Questo il tributo del maestro Elio Toaff, rabbino capo emerito di Roma, a Simon Wiesenthal, l’architetto ebreo che ha dedicato tutta la vita a scovare i gerarchi nazisti responsabili della Shoa. Wiesenthal — continua Toaff, 90 anni — oltre ad assicurare alla giustizia centinaia e centinaia di nazisti in seguito all’apertura di 1.100 procedimenti penali, «ha contribuito a tenere viva la memoria dell’Olocausto, un’opera insostituibile per la quale l’umanità intera gli sarà sempre riconoscente». Maestro Toaff, lei era quasi coetaneo di Wiesenthal. Vi siete mai incontrati? «Sì, una volta sola, qualche anno fa. Fu un incontro casuale, durante una cerimonia. Era già molto noto per la sua attività di “cacciatore” di nazisti. Grazie al suo lavoro molti gerarchi erano stati processati e condannati, come Adolf Eichmann e Karl Silberbauer, responsabile dell’arresto di Anna Frank. Ma non parlammo di questo. Ci stringemmo la mano, toccammo argomenti di circostanza, niente di più». Chi era Simon Wiesenthal? «Era un uomo animato da un altissimo senso di giustizia e per questo, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, si dette subito alla ricerca dei veri responsabili dell’Olocausto: per consegnarli alla giustizia ma anche per evitare il ripetersi di tragedie simili. Non era mai soddisfatto dei successi raggiunti. Era spinto da una forza interna, dal desiderio di andare sempre avanti nella ricerca e nella denuncia. Purtroppo in quest’opera fu quasi subito abbandonato dagli Stati Uniti per motivi politici legati alla guerra fredda. Ma lui non si arrese mai». Una vita dedicata a cacciare nazisti, dopo essere stato internato in tredici lager, tra cui Buchenwald e Mauthausen. Alla fine i frutti raccolti lo hanno ripagato di tanto lavoro? «Credo di sì. Ha fatto tanto: ha trovato persone, indicato nomi, descritto circostanze e individuato luoghi dove i nazisti si nascondevano. Ha fatto una grande opera di pulizia con puntualità e prove inappellabili: un lavoro di denuncia e prevenzione che, senza di lui, non penso si sarebbe potuto fare». Quindi è grazie anche a uomini come Wiesenthal che il pericolo della follia nazista è stato debellato? «Wiesenthal ha fatto tanto per evitare un altro Olocausto. Anche se non si può escludere che quella tragedia possa ripetersi. Basta guardarsi intorno e vedere che, in tanta parte del mondo, c’è sempre la follia della guerra, tante popolazioni vengono massacrate, sottomesse, umiliate. Ma non mi lascerei intimidire. Il bene alla fine trionferà». «L Eredità Wiesenthal L’ultima battaglia del cacciatore di nazisti Lo storico Joachim Fest Lo scrittore Tahar Ben Jelloun “Ma oggi in Germania è tornata l’armonia” “Il razzismo va colpito a partire dalle scuole” l termine antisemitismo indica una grande tragedia che pesa sul mondo dalla morte di Cristo. Da allora si è sviluppato un pregiudizio terribile che nel corso dei secoli ha portato a continue persecuzioni. Questo pregiudizio non è ancora morto». Così Joachim Fest, massimo studioso mondiale del Terzo Reich e biografo di Hitler, risponde alle domande poste da Simon Wiesenthal. Perché quel pregiudizio non è mai morto? «Una volta a Roma un diplomatico italiano mi fece notare quanti carabinieri fossero posti a protezione della missione commerciale israeliana. Mi disse, “gli ebrei tendono a farsi notare ovunque”». In Germania il tema è particolarmente sentito. «Eppure in Germania ci fu, prima di Hitler, una simbiosi tra ebrei e tedeschi. Ebrei e tedeschi si somigliano nei gusti e nelle passioni: il pensiero speculativo, la musica, la filosofia, le scienze, la letteratura. Forse anche per questo, quando Hitler arrivò al potere, molti di loro commisero l’errore fatale di sottovalutare la minaccia». Come viene vissuto oggi in Germania il tema dell’antisemitismo? «Oggi, secondo me, gli ebrei in Germania commettono a volte un errore ben diverso. Quello di confondere a volte posizioni critiche verso il governo israeliano con posizioni antisemite». E invece come stanno le cose? «Per quanto possa apparire paradossale dopo Hitler, siamo tornati alla tendenza alla simbiosi. Gli ebrei sono tornati a sentirsi molto a loro agio in Germania. Berlino è tornata un centro della vita e della cultura ebraica. È una sconfitta dell’antisemitismo di cui ci si potrebbe dire felici, anziché tacerne in nome dell’eterno pessimismo tedesco». (andrea tarquini) ahar Ben Jelloun, marocchino ma da tempo residente in Francia, è da anni uno degli intellettuali più impegnati sul fronte del dialogo fra l’Occidente e il mondo musulmano. Musulmani contro ebrei. Wiesenthal temeva questa contrapposizione. Aveva ragione? «Il mondo arabo-musulmano non ha problemi particolari con il mondo ebraico. C’è un conflitto non religioso bensì politico che oppone due popoli su una sola terra, ma non bisogna confondere l’esasperazione che può provocare la politica dello Stato di Israele con un rifiuto dell’entità ebraica. Sono due fatti separati». Quindi il dialogo fra musulmani ed ebrei è possibile? «Non è solo possibile ma anche inevitabile, perché si tratta di due popoli caratterizzati da un immaginario, da tradizioni e da modi di vita molto simili. Non è un caso che ebrei e musulmani abbiano convissuto per molti secoli in Andalusia e vi abbiano costruito una cultura comune». Wiesenthal vedeva nascere un nuovo antisemitismo. In particolare lo avevano spaventato episodi avvenuti in Francia, paese dove lei vive. Crede che avesse ragione? «È vero che in Europa si è visto apparire quel razzismo particolare che attribuisce agli ebrei tutte le sventure dell’umanità. Talvolta ciò è espressione di una sorta di solidarietà tribale con le popolazioni che soffrono per il conflitto israelo-palestinese. Ma la trasposizione di un conflitto mediorientale nei sobborghi parigini è un errore di valutazione. Per evitare queste derive occorre un lavoro pedagogico quotidiano nelle scuole: senza educazione, senza una spiegazione calma e giusta, precisa e obbiettiva, il razzismo e l’antisemitismo continueranno a imbrogliare tutti e a scavare un fossato tra i popoli». (f.c.) «I T Perché così ottimista? «Perché vedo che, malgrado i tanti esempi negativi, la coscienza morale per la pace e la convivenza tra le popolazioni sta maturando. Specialmente tra i giovani. È da qui che cresce la speranza per il futuro». Il settimanale della Namibia Plus, in lingua tedesca, in una inserzione a pagamento definisce Wiesenthal «mostro» e saluta la sua morte con «gioia e soddisfazione». «Mi fa orrore. È la prova che occorre sempre vigilare perché l’odio nazista e razzista ancora non si è placato del tutto. Ecco perché è importante che l’opera di Wiesenthal non venga dispersa e che la ricerca di criminali nazisti non sia archiviata». Eppure è stato lo stesso Wiesenthal ad affermare, poco tempo prima di morire, che considerava chiuso il suo lavoro perché gli ultimi nazisti ancora in circolazione non sono più arrestabili, essendo anziani di 80-90 anni. «Non sono per niente convinto che l’opera di Wiesenthal sia finita. Il criminale, anche a 90 anni, resta un criminale. È importante che sia scovato e consegnato alla giustizia. Anche per rispetto delle vittime e per dare un esempio all’opinione pubblica. È bene che si sappia che a nessuno è consentito uccidere innocenti, opprimere, violentare, sopraffare... e poi farla franca. Anche a decenni di distanza». Si è a lungo discusso dell’atteggiamento da tenere nei confronti dei nazisti anziani che si pentono. Lei che ne pensa? «Su questi pentimenti postumi sono molto perplesso. Sono tentato a pensare che il nazista che dice di essere pentito non sia sincero e che, più che pensare alle vittime, sia animato da una forte voglia di scamparla. Forse mi sbaglio, ma la penso così». E tra il perdono e la giustizia, lei cosa sceglierebbe? «La giustizia, sempre. Il perdono no. Non siamo noi che dobbiamo perdonare. C’è solo un Ente Supremo, Dio, che lo potrà fare. Tra gli uomini, il perdono lo possono dare solo quelli che sono stati offesi. E nel caso delle vittime dell’Olocausto non credo proprio che possano farlo. Ai sopravvissuti spetta solo il compito di assicurare i responsabili alla giustizia e di vigilare affinché gli errori del passato non si ripetano più». Tra i sopravvissuti, a volte, esplode il desiderio di vendetta. «È necessario assicurare alla giustizia i nazisti in libertà non per desiderio di vendetta. La vendetta è un sentimento negativo che acceca, che non fa ragionare e che aggiunge drammi a drammi. Con la vendetta non si risolve nulla perché, spesso, dà luogo ad una catena di altre vendette». Erich Priebke, condannato per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, è agli arresti domiciliari. Ha 82 anni. «È giusto che continui a rimanere agli arresti domiciliari e, ripeto, non per vendetta ma per spirito di giustizia. Non mi pare che abbia manifestato sentimenti di pentimento: durante i processi è rimasto sempre impassibile, non ha mai avuto una parola per le vittime innocenti». 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA il racconto DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 Fiabe immortali A circa cent’anni dalla sua nascita, è in arrivo il seguito di una delle favole più famose e fortunate di sempre. La Walt Disney si prepara a lanciare, con una campagna mondiale, una seconda puntata che è anche un rovesciamento con “Campanellino” protagonista per una prospettiva tutta al femminile. Ecco l’anteprima PeterPan Il nuovo Trilli porta le bambine nell’isola dei sogni DARIA GALATERIA Capodanno del 1897 — Peter Pan non era ancora nato —, J. M. Barrie si trovò accanto, a tavola, «la più bella creatura mai vista»; era riservata, e, a fine cena, fece una cosa straordinaria. Raccolse dal vassoio i dolci, e se li infilò nella borsetta da sera. Al vicino allibito spiegò: «Sono per mio figlio», e seguì l’agnizione. La signora era la madre di George, il diavoletto bruno di quattro anni con cui James Mattew Barrie giocava tutti i pomeriggi nei giardini di Kensington. Ora che era un famoso drammaturgo, Barrie aveva preso casa in Gloucester Road, nel quartiere elegante di Londra, vicino a quei giardini dove portava a passeggio l’immenso cane San Bernardo, di nome Porthos, alto quanto lui — Barrie, a 37 anni, non superava di molto il metro e cinquanta; «ah, cosa non avrei detto alle donne se avessi avuto le gambe lunghe», protestava. Un’altra piccola amica, Pamela di sei anni, lo descrisse come un uomo pallidissimo, e gli occhi azzurri sempre cerchiati, fragile in apparenza, ma che diventava intrepido quando lottava con Porthos; parlava delle fate come se le conoscesse benissimo, e a volte cadeva in lunghi silenzi, «che però non erano inquietanti, perché vi si esprimeva bene come quando parlava». A Insolente e vanesio Quell’inverno, nacque Peter Pan, crepuscolare, faunesco e crudele. “Il bambino che non voleva crescere” era ben diverso dai piccoli eroi di epoca vittoriana, come Alice, creata buona e gentile dal reverendo Dodgson — Lewis Carroll — quando Barrie aveva cinque anni. Ora l’Inghilterra edoardiana diventava scanzonata, sotto un sovrano donnaiolo, Edoardo VII, la cui sagoma in cilindro si stagliava in tutte le occasioni mondane d’Europa. Così, Peter Pan è vanesio, egoista, dispettoso, coraggioso, fascinoso, insolente, mentitore, senza memoria e senza cuore (tutti i ragazzi per Barrie sono «allegri, innocenti e senza cuore»). Ora esce un sequel di Peter Pan, l’incantevole Trilli e l’isola delle fate, della famosa scrittrice per l’infanzia Gail Carson Levine (pp. 198, edito dalla Disney Publishing in Italia a fine ottobre; ma diffuso, in un milione di copie, in 45 paesi e in 35 lingue): un seguito, ma anche un rovesciamento, tanto l’universo è cambiato, dalla Londra del 1906 in cui uscì Peter Pan nei giardini di Kensington. Trilli è l’adorabile Campanellino, ma la sua storia ora è dedicata alle bambine; e infatti nel romanzo manca la mamma — come succede ad esempio nella narrativa sentimentale di genere, per non ingombrare con fastidiose presenze il sogno edipico. Peter Pan si sceglieva delle mamme vica- rie, bambine che sapessero raccontare le fiabe e, accessoriamente, gli riattaccassero l’ombra. In Trilli esiste certo una figura materna, unica per tutta l’Isola-Che-Non-C’è, una Colomba piena di tubante saggezza, che, covando un Uovo prodigioso, preserva tutti dalla vecchiaia — anche Capitan Uncino bada a tenersi alla larga dal Coccodrillo che ticchetta, per aver ingoiato una sveglia: una delle più carnose immagini del tempo divoratore. Ma mamma Colomba è una madre esaustiva, lontana e perfetta come una madonna; le fate sembrano creaturine liberate, il cui principale tratto consiste nell’avere un talento. Trilli ripara pentole e padelle, Beck si occupa degli ani- mali; tutte sono al lavoro: una fata fornaia si consulta con la fata parrucchiera per acconciare una treccia di pane; le fate ortolane raccolgono ciliegie per la torta; altre si occupano di produrre e conservare nelle zucche vuote la polvere magica, che dai tempi di Barrie consente alle minuscole eroine di volare, emanando un luccichio giallo limone, ornato d’oro. Meno stordite e capricciose delle antenate inglesi, le fatine odierne rimangono sbalordite quando, suscitata come al solito dal primo sorriso di un bambino, sbarca sull’IsolaChe-Non-C’è una fatina senza talento. È una cosa così imbarazzante, che tutte cercano di cambiare discorso; ma la neofata, Prilla, ne soffre molto. Tenta tutti i mestieri (la parola per la verità non è mai pronunciata): pascolare bruchi, riparare mestoli, essiccare funghi a ombrello. Trilli aiuta Prilla a cercare di scoprire qual è il suo talento, ed «è dai tempi di Peter Pan che non passava tanto tempo senza lavorare». La vergogna, per Barrie, era continuare da adulto i giochi infantili; nei sogni, si scopriva a giocare a palline di vetro, e si giudicava «con severa riprovazione»; il terrore delle fatine di Trilli e l’isola della Fate è di sottrarre tempo al lavoro. Le piccole donne crescono, e Gail Carson Levine pensa a cospargerle della polvere magica che nel nostro mondo allontana la morte: l’orgoglio del lavoro e dell’emancipazione. Un solo folletto compare nel romanzo, Terence; ha due caratteristiche: è bello, ed è innamorato di un’altra. Ai tempi di Peter Pan, le femminucce erano mamme. Si sa del dramma di J. M. Barrie, e di sua madre, l’intelligentissima, puritana Margaret di Kirriemuir, paesino scozzese sopra Dundee; figlia di uno scalpellino, e moglie di un tessitore, con i telai in casa. Il figlio prediletto, David, all’età di tredici anni morì nel 1867 pattinando sul ghiaccio; la madre si chiuse al buio nella sua stanza. Un giorno il nostro Barrie entrò; la madre chiese: «Sei tu?»; «no», rispose all’oscurità il piccolo, «sono solo io, James»; aveva capito bene che la madre cercava il figlio perduto. Svolse da allora una Lo scandaloso destino di James Barrie il ragazzo che non voleva crescere ENRICO FRANCESCHINI Q matrimonio infelice, terminato con un divorzio in cui lei sostiene che le nozze non sono state consumate. Fogli scandalistici ironizzano che la favola sul «bambino che non vouando James Matthew Barrie morì, nel 1937, la Gran leva crescere» (the boy who wouldn’t grow up) è opera del Bretagna si mise a lutto. Migliaia di persone seguirono il fune«bambino che non poteva averlo ritto» (the boy who rale per le vie di Londra. L’arcivescovo di Canterbury lesse wouldn’t go up). La descrizione che ne fanno i giornali del un’orazione funebre nella cattedrale di St. Paul. Giornali e citempo non potrebbe essere più diversa dal divo hollywoonegiornali trasmisero la notizia ai quattro angoli della terra. diano Johnny Deep, il Barrie di Finding Neverland del 2004: Da allora, ogni anno, a Natale, i teatri londinesi mettono in sce«Alto a malapena un metro e mezzo, come un bambino di na la storia del “bambino che non voleva crescere”, e la fama dieci anni. Taciturno. Sguardo gelido, paralizzante. Attegdel suo autore continua a crescere, con le innumerevoli edigiamento furtivo di chi ha qualcosa da nascondere». zioni del libro in tutte le lingue, con le trasposizioni che ne ha Su cosa sia quel “qualcosa” circolano feroci malignità. ricavato Hollywood, da un indimenticabile cartone animato L’amore di Barrie per i cinque figli di Arthur e Sylvia Davies, alle versioni interpretate da attori, fino a quella dello scorso la coppia di sposi con cui lo scrittore passa i week-end, inanno, Finding Neverland, biografia di Barrie in forma di fiaba. sinuandosi nella loro esistenza, accompagnanEppure la vera storia di questo artista straordoli a Kensington Gardens con il suo San Bernardinario, capace di creare con Peter Pan un mito do, raccontando storie di indiani, cow-boy e rasenza tempo, è rimasta nella penombra, inegazzini magici, componendo mentalmente il splorata, forse perché troppo amara e scandaloprimo canovaccio di Peter Pan, suscita all’epoca sa. A fare luce per la prima volta sull’autentico J. e in seguito infinite supposizioni. Cosa c’è tra M. Barrie è una nuova biografia pubblicata in Inquello strano uomo e quei bambini? La biografia ghilterra, Hyde and seek with angels (Nascondidi Lisa Chaney tende ad escludere episodi di peno con gli angeli), della giornalista e saggista Lidofilia, ma sottolinea gli apparenti doppi sensi di sa Chaney, l’opera «più accurata e completa» The little white bird (L’uccellino bianco), libro sull’argomento secondo la stampa nazionale. che Barrie scrisse prima di Peter Pan, come nella La sua vita comincia con un’infanzia povera e scena in cui il Capitano invita David, figlio di amiinfelice in Scozia, dove i genitori, alla morte per ci, a dormire da lui: «Gli sfilai dolcemente gli stiannegamento del fratello maggiore, prediletto L’AUTORE vali, lo misi sulle ginocchia e rimossi anche la cadalla madre, lo scacciano di casa mandandolo in James Mattew micia. Era un’esperienza deliziosa, ma rimasi collegio. Non meno difficili sono gli inizi come Barrie meravigliosamente calmo». Un caso, conclude il giornalista a Londra, dove sbarca senza un solTimes Literary Supplement, degno di essere studiato dagli do, senza un amico e senza nemmeno riuscire a farsi comavvocati difensori di Michael Jackson, il cantante procesprendere a causa dell’accento scozzese: «Chiedevo che mi sato per pedofilia: tanto più che il presunto luogo del delitpulissero gli stivali e pensavano che chiedessi un bicchieto di Jackson era il suo ranch chiamato Neverland (La terra re d’acqua», ricorderà anni dopo. Come cronista, Barrie che non c’è), in omaggio a Peter Pan. non sembra una promessa. Scrive un romanzo, ma è coI dolori, per James Matthew Barrie, non finirono lì. Alla stretto a pubblicarlo a sue spese. Opta per il teatro, ma la morte precoce dei coniugi Davies, lo scrittore ne adottò i fisua commedia d’esordio è un fiasco, primo fra tanti. gli, rivelandosi un pessimo padre. I loro rapporti peggioraNon si arrende, insiste, e finalmente sfonda: successi a rirono gradualmente, il figlio da lui più amato morì nella pripetizione, al punto che in certe stagioni i teatri del West End ma guerra mondiale, un altro annegò, probabilmente suiospitano cinque suoi drammi differenti. Diventa ricchissicida. «Io sono la gioia, io sono la giovinezza», dice Peter Pan: mo e celebre; poi scrive Peter Pan, ed ha la consacrazione e noi lettori o spettatori, ascoltandolo, ci commuoviamo al mondiale. «Io sono un artista, lei è un genio», gli dice il suo ricordo della giovinezza perduta. Adesso sappiamo anche contemporaneo Robert Louis Stevenson. Nel frattempo, perché il suo autore non avrebbe voluto crescere. purtroppo, arrivano altri guai. Sposa un’attrice: un lungo LONDRA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 I SUCCESSI LA PRIMA IL LIBRO IL CARTONE ANIMATO IL KOLOSSAL La pièce teatrale di James Barrie “Peter Pan” debutta al Duke of York di Londra il 27 dicembre 1904: si tratta di una rappresentazione di beneficenza Sette anni più tardi, nel 1911, Barrie raccoglie in un volume la storia di Peter Pan. Che però era già comparso nel 1903 in un suo racconto Nel ’53 esce il cartoon della Disney, di cui è stato realizzato il sequel “Ritorno all’isola che non c’è” nel 2002. Ma il primo film su Peter Pan è il muto di Brenon del ’24 Nel 1991 Spielberg firma “Hook” con Dustin Hoffman e Julia Roberts. Nel 2004 esce, invece, “Neverland”: un film su Barrie con Johnny Depp e Kate Winslet L’autrice è la famosa scrittrice Gail Carson Levine, i disegni sono di David Christiana che è tornato ad ispirarsi allo stile di fine Ottocento IL MAGICO MONDO DELLE FATE “Trilli e l’isola delle Fate” (titolo originale “Fairies Dust and the Quest for the Egg”), il nuovo romanzo di Gail Carson Levine pubblicato da Disney Publishing, sarà in libreria a fine ottobre. Sarà stampato in un milione di copie, tradotto in 32 lingue e distribuito in 45 paesi: un lancio mondiale di proporzioni straordinarie nel campo dell’editoria per ragazzi. Il libro si propone come un seguito di “Peter Pan”, un ritorno all’Isola-Che-Non-C’è centrato attorno al magico mondo delle fate e arricchito dalle illustrazioni, ispirate al primo “Peter Pan”, di David Christiana sorta di ruolo vicario, accanto alla madre; e fu così che Peter Pan, quando tenta di tornare a casa, trova la finestra sbarrata. La picchia con le piccole mani, ma vede che la mamma culla un altro piccolo, e diventa scettico terribilmente sulle mamme; non potendo rifiutare la sua, per esserne stato rifiutato, in qualche modo è costretto, senza confessarselo, a amarsi da solo, e restare bambino, nel caso ne compaia un’altra. «Diventavo un uomo, e mio fratello David continuava a avere 13 anni», scrisse Barrie, e in una delle prime storie di Peter Pan compare il prediletto George dei giardini di Kensington, ma col nome di David. L’ILLUSTRATORE I disegni di queste pagine sono quelli che David Christiana, famoso illustratore di libri per ragazzi, ha creato per i personaggi di Gail Carson Levine Creature preraffaelite Peter Pan, quando da commedia diventò, nel 1906, un libro, era illustrato da Arthur Rackham, elegante pittore neogotico premiato, quello stesso anno, all’Esposizione Internazionale di Milano. Splendide fate preraffaellite, sensuali e sinuose, si avvolgono misteriosamente a atroci alberi rinsecchiti; i colori pastello e l’animazione del mondo minuscolo del sottobosco sono invasi da un vento inquieto; compare una volta, nei suoi giardini di Kensington, di spalle, il re. Sinuosi arabeschi liberty percorrono anche oggi le tavole che decorano Trilli e l’isola delle Fate; David Christiana ha piegato il suo pennello ironico e ansioso a visioni che citano il volger del secolo, ma gaie e molto colorate, su esclusive tonalità pastello. Le sue fate sono bambine allusive e piccanti, e toni surreali compaiono solo quando la vicenda diventa davvero rischiosa. «Volete un’avventura subito, o prendete una tazza di tè?» chiedeva educatamente Peter Pan. Qui l’avventura parte subito, tra draghi infuocati e dorati falchi predatori; a rischio è l’Uovo fatato, e l’eterna giovinezza; subito Peter Pan perde i dentini da latte, e Spugna, il nostromo di Capitan Uncino, non trova più gli occhiali. Le fate si coalizzano; anche le più arriviste scoprono la solidarietà; ma riusciranno, così piccole, a preservare dalla vecchiaia L’Isola-Che-Non-C’è? Ringrazio il cielo d’aver preservato la mia infanzia, annotò nel diario Jean Cocteau, avendo visto in prima mondiale, come giurato del Festival di Cannes del 1953, il film che Disney aveva tratto dal romanzo. Il cinema se ne era già occupato, e Charlie Chaplin, tornando in patria nel 1921, era andato per prima cosa da Barrie, ormai baronetto, a lamentarsi di non aver mai potuto interpretare il suo mitico piccolo eroe. Trilli e il mondo delle fate diventerà, nel 2007, un dvd; forse un film, con la sua lezione per piccole adolescenti dal futuro felicemente attivo, e solidale. Con Hook di Stephen Spielberg Peter Pan (Robin Williams) già era diventato un brillante avvocato d’affari. Imparò la lezione anche Barrie, quando il suo romanzo si avverò. La sua bellissima vicina di tavola del capodanno 1897, Sylvia Llewelyn-Davies, era diventata un’amica cara; Barrie, malvisto da tutte le governanti dei bambini dorati di Kensington — di alcune bambinaie ostili c’è ancora il ricordo; del resto, Barrie non ha dato mai il pur minimo seguito ai suoi affetti infantili — si insinuò nel nido splendido e distratto di Sylvia e di suo marito, l’avvocato Arthur, e scrisse che Peter Pan era nato sfregando insieme i loro bambini — che intanto erano diventati cinque — come i selvaggi cavano, da rametti secchi, il fuoco. Poi però Arthur e Sylvia erano scomparsi, quasi di concerto, e Barrie ereditò la cura dei ragazzi, George, Jack, Peter, Michael e Nico. Lui li rapì come Peter Pan i fratelli Darling del romanzo del 1911, Wendy e Peter, e li coprì di attenzioni. E loro gli fecero mille dispetti, crescere, morire in guerra — Barrie tolse dalla commedia, che ogni bambino inglese ha visto a Natale, la frase di Peter Pan: «E anche morire sarà una splendida avventura». Del resto, diceva, «nulla di quello ci accade dopo i dodici anni ha molta importanza per noi». DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 la lettura Dietro il sipario LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 Si possono comporre con le mani o con l’aiuto di sagome, con una candela o con più moderne fonti luminose, hanno anticipato il cinema con le loro immagini in movimento. Ora un grande illusionista, Arturo Brachetti, le rilancia con un libro e un nuovo spettacolo La magia antica delle ombre cinesi Un libro in uscita e un nuovo spettacolo. Il grande trasformista Arturo Brachetti torna con un libro fotografico, Le ombre cinesi (Priuli&Verlucca Editori, 96 pagine, 9,90 euro) dove racconta la magia e la tecnica di una delle più antiche arti teatrali. E torna anche in scena con lo spettacolo L’uomo dai 1000 volti che debutterà il 22 ottobre a Milano al Teatro della Luna per essere poi replicato a Bologna, Napoli, Trieste e Roma STEFANO BARTEZZAGHI i possono comporre con una bidimensionali: ma la silhouette è tanmano, con due mani o con to più suggestiva in quanto il profilo l’aiuto di sagome manovrate che l’ha originata risulta riconoscibile come fossero marionette anche da pochi tratti, mentre l’ombra (ma dal basso). Si possono diventa spettacolare quando si separa realizzare con un’arcaica dall’oggetto che l’ha proiettata e pare candela o con più aggiornate, e meno qualcos’altro. I suoi cultori si nominatremolanti, fonti luminose. Si possono no con un francesismo non ancora reproiettare alla buona contro un muro, a gistrato da alcun vocabolario: ombrocasa, o più professionalmente sul retro mani. Con l’invenzione del cinema, di uno schermo. Si possono esibire per il l’ombromania non è scomparsa: nel divertimento di un bambino che riconuovo capitolo della sua storia è venunoscerà il cane, il cigno, il coniglio, opta in soccorso del cinema stesso (Bergpure per una platea teatrale gremita di man, Rossellini, Hitchcock: più recenspettatori paganti. Sono le ombre cinetemente si agitano ombre dietro uno si, una semplice e antichissima forma di schermo cinematografico in una gag gioco e di spettacolo che — come accadi Nel corso del tempo di Wim Wende con tutti gli incanti durevoli nella stoders, e il regista cinese Zhang Yimou ria dell’umanità — ha certamente a che ha dedicato il suo Vivere! alla storia di fare con qualche archetipo più profonun ombromane nella Cina maoista), e do e molto più complesso della forma per il resto si è trasformata in una forche lo esprime. ma magica di teatro, in cui la sorpresa Le chiamiamo “cinesi”, ed è possibile e la fascinazione dello spettatore sono che le ombre con cui si gioca, si fa teatro consapevoli dell’arcaicità del mezzo e illusionismo siano state davvero inespressivo. ventate in Cina: ma propriamente sicuPer la copertina di un suo fondamenra è solo la loro origine orientale. Nel Settale libro dedicato alla Scoperta dell’omtecento che diffuse dalla bra (Mondadori, 2000) il fiFrancia a tutta l’Europa la losofo Roberto Casati ha moda dei giochi d’ombra, impiegato una divertente “Cina” era il nome d’arte illustrazione in cui un conidell’Oriente più remoto. glietto inventa una scomoUn altro Mondo: e trattanda postura per riuscire a dosi di ombre pare approproiettare sul muro l’ompriato parlare di other side, bra di una mano umana: faccia nascosta. come se Amleto decidesse Per secoli quella delle di intraprendere la carriera ombre è stata una delle teatrale. Ma l’arguzia della pochissime forme d’arte vignetta ci dice che l’ombra in cui si potevano avere non è quel che sembra. immagini fittizie in movi- IL LIBRO DI BRACHETTI L’ombra è ambra, ha cantamento: e non a caso il pri- Le immagini sono tratte to Paolo Conte. L’ombra è il mo, lunghissimo capitolo da “Le ombre cinesi” teatro del mondo, secondo della sua storia si chiude (qui sopra la copertina) il mito platonico della cacon l’invenzione del cineverna, che nega la luminoma. Si era aperto, il capitolo, in quelsità del mondo da noi percepito e la posl’Oriente favoloso e altro, passando da sibilità di una reale conoscenza terrena India, da Giava e dalla Turchia, e arridella cose. L’ombra è uno spettacolo vando in Francia nel momento in cui ci sacro a Chichén Itzá, nello Yucatan, dosi divertiva con le silhouette, ritratti live dai tempi dei Maya gli equinozi sono mitati al contorno. In un suo articolo celebrati da un’ombra che risale la piPrimo Levi (ora in L’altrui mestiere, Eiramide, come il serpente che simbonaudi, 1985) ha fatto l’elogio di questo leggia la rigenerazione delle stagioni. nome, silhouette: «Una parola che diL’ombra segna la linea di confine fra le pinge: è snella e leggera, affusolata..., età dell’uomo, nella potente metafora ed ha tutta l’aria di un grazioso diminunarrativa di Joseph Conrad. L’ombra tivo femminile, prezioso per descrivedei pianeti e dei loro rilievi orografici si re, ad esempio, il corpo di una bagnanè offerta come quantità misurabile allo te adolescente che si staglia contro il sguardo dei primi astronomi, consencielo tuffandosi da un trampolino». Ma tendo loro di approssimarsi alla conocome Levi ben sapeva non è un dimiscenza delle dimensioni spaziali e dei nutivo: Étienne de Silhouette era il micicli temporali dei corpi celesti. L’omnistro delle Finanze del Re Sole, che imbra è insomma il lato fantasmatico del pose tasse pesanti e inefficaci, tanto visibile, ma anche il suo residuo necesche furono inventati i “pantaloni à la sario, un dato razionalmente ponderaSilhouette” (privi di tasche), e che il suo bile. I bambini giocano a pestare le omnome passò poi a indicare provvedibre dei loro compagni; i pittori sanno menti stupidi, cose malfatte e, con che solo l’ombra àncora i soggetti delle un’estrema torsione di significato, riloro opere allo spazio virtuale della raptratti limitati al contorno. presentazione. Senza ombre non c’è Ombra e silhouette sono proiezioni realismo: e non c’è neppure realtà. S 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 Passato il periodo d’oro degli anni Cinquanta, sfiorite le dive come Bettie Page e Tempest Storm, l’avanspettacolo ammiccante a base di pin-up senza veli ha rischiato di finire nell’oblio. Oggi però gli show sono tornati a fare il tutto esaurito. Grazie a Dita Von Teese, promessa sposa della rockstar Marilyn Manson. Ma soprattutto protagonista di esibizioni sempre più trasgressive Burlesque GIUSEPPE VIDETTI ono le tre del pomeriggio, il locale, semibuio, ha un’aria sinistra, come uno di quei single bar di Sunset Boulevard dove James Ellroy ha ambientato L. A. Confidential. Accecato dal sole, entri e per cinque minuti non riesci a mettere a fuoco né il luogo né i volti. Solo che qui siamo a Milano, di sole ce n’è poco e la creatura che abbiamo davanti assomiglia più a una malriuscita incarnazione di Belzebù che a un’invitante stellina in cerca di celebrità sul Viale del Tramonto. Marilyn Manson, il principe del rock satanico, si fa intervistare così, scegliendo i luoghi e l’illuminazione, facendo ben attenzione che la messa in scena sia perfetta, e soprattutto che nessuno lo fotografi al naturale, pallido, spalle piccole, pochi muscoli e faccia da serial killer di Salt Lake City. In un angolo, seduta con le gambe accavallate, un tailleur rigoroso e un cappellino pervinca alla Boy George, una magnifica creatura assiste muta e composta all’intervista. «È la compagna di Marilyn Manson», bisbiglia qualcuno, «credo sia una spogliarellista». Troppo distinta per essere una stripteaseuse di varietà, troppo originale per vivere all’ombra di una rockstar che si nutre di assenzio, scampoli di grand guignol e teatro espressionista. Qualcuno più informato, spiega meglio: «È la nuova regina del burlesque, ha un sito internet pazzesco, www.dita.net». Tutto questo era quattro anni fa, quando Dita Von Teese era un cult per nostalgici del burlesque. Marilyn Manson non parlava troppo della sua diafana compagna, la liquidava con frasi a effetto, spesso sconce, del tipo «a Dita piace essere sbattuta con violenza». Oggi la von Teese è più di un sex symbol, più di una pin-up o di una calendar girl: è riuscita a far rinascere l’interesse per un’arte che era ormai retaggio di certi teatrini americani fra le due guerre, è richiesta dai fotografi e dalle case di moda, ha un book zeppo d’impegni fino al prossimo febbraio, compresa l’apparizione a una due giorni di «strip tease revival» organizzata al Corona Theatre di Montreal a metà gennaio con la complicità dello stilista Thierry Mugler. Il suo sito internet si è evoluto, non più indirizzo frequentato da onanisti in cerca di emozioni, ma celebrazione di una star che ha ai suoi piedi i più bei nomi della moda e dello spettacolo, da Marc Jacobs a Elton John e Christian Louboutin, il mago della calzatura. Con un malizioso shop-on-line che fa S Latex e paillettes la nuova vita dello striptease La stella del momento si confessa in un libro pieno di nudità seducenti ma mai ostentate. E a gennaio a Montreal revival con le vecchie glorie la felicità dei feticisti doc («vendo lo stesso tipo di calze che indosso, e qualcuna anche già usata, con tanto di smagliature», assicura). Ora la Bettie Page del nuovo millennio si racconta (per immagini) in un libro, Burlesque and the Art of the Teese (Ed. HarperCollins, 256 pagg.) che uscirà a novembre. Pieno di nudità promesse e mai ostentate, secondo le regole classiche del burlesque. Meno volatili delle veline, più intriganti delle spogliarelliste, anche le vecchie dive del burlesque avevano nomi di fantasia creati per solleticare l’immaginazione maschile: Dee Milo, Zorita, Mimi Reed, Leri Vale, Val de Val, Patti Starr, Rusty Lane, Lily St. Cyr, Rose la Rose, Mona Vaughn. «Nel momento stesso in cui un guanto scendeva sotto il gomito, in sala incominciava a crescere la tensione», racconta Dee Milo, ultrasettantenne. Il burlesque è una forma di avanspettacolo che ha le sue radici nel vaudeville. Poi, con l’avvento del cinematografo, Hollywood cominciò a generare cloni e a vomitare star di serie B, che dopo una particina finivano nei teatrini di provincia. Ma il burlesque era un varietà sufficientemente esotico e raffinato per generare un culto con le proprie risorse. Al- Roma, 21 ottobre - ore 12,00 Centro Studi Americani -Via M. Caetani, 32 SEMINARI POLITICI RESET-DISSENT Politica e religione tra Europa e Usa Al termine del seminario Reset-Dissent, discussione pubblica con: Giuliano Amato, Giancarlo Bosetti, Mitchell Cohen, Michael Walzer Presentano relazioni: Klaus Eder, Alessandro Ferrara, Michael Kazin, Gilles Kepel, Krzysztof Michalsky, Paolo Pombeni Evento organizzato in collaborazione con «Dissent» e il Centro Studi Americani, con il contributo di Acea SpA e il patrocinio del Comune di Roma LE VEDETTES Nella foto qui sopra, la regina dello striptease dei giorni nostri Dita Von Teese. In alto una diva di inizio ‘900 lo spogliarello si sgusciava di nascosto e con il senso di colpa, al burlesque con la benedizione della moglie. Come nell’avanspettacolo, c’erano comici e illusionisti, ma gli uomini ci andavano in cerca di quelle emozioni che solo le esperte nell’arte della seduzione sapevano stuzzicare. Fantasie che, dalla fine dell’Ottocento a Dita von Teese, sono diventate sempre più strane e bizzarre. Quando nel 1868 sbarcò a New York la compagnia inglese guidata da una certa Lydia Thompson, chiamata Imported British Blondes (bionde inglesi d’importazione), la città gridò allo scandalo. Le ragazze in realtà indossavano gonne alla caviglia, i top erano a mezze maniche e le scollature tutt’altro che osée. L’elemento più audace era la foggia delle calzature. Ma la Thompson, morta nel 1908, aveva fatto una scoperta e dal suo brevetto ricavava contanti: «I maschi sono attratti dai lustrini», diceva. Poi ai lustrini si aggiunsero le piume, alle piume i tacchi a spillo, ai tacchi a spillo le maliziose cascate di perline attaccate ai capezzoli. E i pesanti taffettà della Thompson vennero rimpiazzati da veli sempre più leggeri, cosicché i maschi più facoltosi, quelli delle prime file, potessero sbirciare le forme come se le ragazze danzassero nude. A guardare oggi quelle foto, si direbbe che le più antiche dive del burlesque non fossero molto diverse da certi ritratti di Grazia Deledda o Marie Curie. Ma subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Shawna St. Clair cominciò a provocare il pubblico con il suo sguardo ammiccante, la bocca tumida e il visone sapientemente calato sul seno giunonico, il burlesque era già diventato quella forma di spettacolo di cui troviamo tracce vistose nei concerti di Madonna, Christina Aguilera e Gwen Stefani, in film come Moulin Rouge (il clip di Lady Marmalade è puro burlesque postmoderno), nella fantasia erotica creata dal Cirque du Soleil con Zoomanity e nelle collezioni di provocatori della moda come Vivienne Westwood e John Galliano. «A ogni uomo devi far sentire che sei lì solo per lui. Che ti può trovare dentro il suo cocktail Martini, in topless accanto all’oliva», diceva la St. Clair, che si è ritirata nel ‘72. Electra, popolarissima negli anni Cinquanta, raccontava che ogni diva del burlesque era frutto di uno spregiudicato patchwork fatto con “pezzi” di Mae West e Rita Hayworth. Tutte sapevano che non sarebbero mai arrivate a quel livello, la loro massima aspirazione era di diventare un sex symbol come la maestra di tutte le “tigresse”, Bettie Page, che ancora oggi, a 82 anni, è una esotica leggenda raccontata nel film The Notorious Bettie Page, appena presentato al Festival di Toronto, in cui la pin-up è inter- DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 Ma tra i padri nobili c’è persino Shaw LEONETTA BENTIVOGLIO pretata da una grintosa Gretchen Mol. Alle signorine del burlesque non è mai piaciuto essere chiamate spogliarelliste, perché lo striptease era solo un elemento dello spettacolo, il più sospirato, ma mai integrale, almeno in quella che i cultori chiamano l’epoca d’oro, tra i Quaranta e i Cinquanta, quando c’erano centinaia di teatri in tutta America che facevano quattrini con i poster delle pin-up esposti per adescare clienti e riempire la sala. Nella trappola c’è cascato anche Bob Dylan con l’album Empire Burlesque (1985). Una delle canzoni scartate dalla selezione e poi pubblicate in un bootleg si chiamava Tempest Storm, titolo che non ha nulla a che fare con tempeste e bufere. Tempest Storm era la più po- LE PERFORMANCE Nella foto grande, una spogliarellista anni ’50. A destra, biglietti di ingresso per gli spettacoli. In alto, una locandina di inizio secolo e alcuni momenti di un burlesque del dopoguerra polare spogliarellista degli anni Cinquanta. «Le più belle tette di Hollywood», secondo Jerry Lewis e Dean Martin. Finita anche sulla copertina di un album dei Mano Negra (Puta’s fever, 1990), Tempest, classe 1928, racconta di aver sedotto sia JFK che Frank Sinatra. Alla “reunion” di Montreal, miracolata dal chirurgo plastico, ci sarà anche lei. Negli anni Settanta, a New York e San Francisco, i gay andavano pazzi per il “male burlesque”, con solo maschi in scena. Ce n’erano tracce ancora dieci anni dopo, quando gli ozi della comunità omosessuale di Manhattan, flagellata dall’Aids, non erano più frizzanti come un tempo. Un Gaiety Theater era al primo piano di una vecchia palazzina con la tipica scala antincendio all’esterno, all’angolo tra la 46esima e Broadway. Nel 1987, Piervittorio Tondelli, che era a New York con Moravia per una serie di conferenze alla Columbia University, alloggiava nel Century Paramount (ora, ridecorato da Stark, si chiama semplicemente Paramount), a venti metri dal teatrino. L’amico scrittore era curioso, e dopo molte esitazioni decise di salire l’angusta scaletta. La sera ci raccontò ogni particolare della sua avventura, delle farse grottesche recitate da boys palestrati, degli ammiccamenti e dei maldestri tentativi di dare dignità a uno spettacolo di poche pretese. «Adescano anche i clienti?», domandammo. «Assolutamente no. Ma alla fine qualche attempato signore si avventura dietro al palco. Forse a contrattare un incontro fuori dal teatro». Oggi i gay vanno pazzi per le “vere” dive del burlesque. A Los Angeles, il Mayan Theater (aperto nel 1927) è tornato agli antichi splendori grazie alle male arti della fascinosa Lucha VaVoom, che promette notti indimenticabili per gli spettacoli di Halloween, il 26 e 27 ottobre, infarciti di glamour latino e wrestling. «Il burlesque è un’arte che non deve cadere nell’oblio», dice Jane Briggeman, che sull’argomento ha scritto due libri e ha fondato una Golden Days of Burlesque Historical Society con lo scopo di rintracciare le sopravvissute, di raccogliere testimonianze e materiale fotografico e ricostruire una storia dettagliata di una forma di spettacolo che per decenni è rimasta tagliata fuori dall’informazione. Dee Milo, ancora in forma, è sempre presente alle periodiche riunioni dell’associazione, che normalmente si tengono a Reno o a Las Vegas. E le gambe sono ancora quelle. Traghettare la tradizione in un’epoca in cui il burlesque può permettersi qualche trasgressione in più è compito di Dita von Teese. Non rivela la sua età, ma giura di chiamarsi Heather Sweet (un nome, un destino). Una sua foto nuda costa cinquemila euro. La volete in reggicalze a casa vostra? Basta mettersi in lista e mettere mano al libretto degli assegni. La volete in latex? È sul numero 33 della patinata rivista fetish Marquis. Lei, intanto, il primo dicembre sposa il suo demonio, Marilyn Manson, a Dublino. E c’è da giurare che in viaggio di nozze non andranno all’inferno. orna a fiorire il burlesque, consegnato a rivisitazioni rock e a spettacoli che pescano nelle mitologie del nostro tempo, variopinte o neo-gotiche, giocherellone o dark. Però il burlesque originale è un’altra cosa. E mentre in quello di tradizione americana il culto del nudo femminile fa la parte del leone, il burlesque inglese, suo progenitore illustre, è pura dimensione parodistica: non tanto il contenitore dei numeri erotizzanti delle girls, conditi da apparizioni di comedians e virtuosi dell’acrobazia, quanto umorismo critico ben definito nella sua peculiarità britannica. Insomma il vero burlesque, l’originario, è un teatro che ride di se stesso. È la beffa scenica che diventa genere di spettacolo. È il gioco strutturato che nasce per prendere di mira le ampollosità di certi drammaturghi, la macchinosità di certe scenografie e i vizi recitativi degli attori. Le ascendenze di questo autentico burlesque sono remote: risalgono al teatro elisabettiano. Shakespeare ne offre vari esempi, come quel Piramo e Tisbe, rappresentato alla fine del Sogno di una notte di mezza estate, che prende in giro i drammi scanditi in forme poetiche, o ancora come i Nove prodi, proposti all’interno di Pene d’amor perdute come uno sprazzo di teatro nel teatro. Un autore come Ben Jonson ride del puritanesimo nella Fiera di San Bartolomeo, e gioca sui temi della pomposità e dell’avarizia nel Volpone. Il primo spettacolo di burlesque inglese in molti atti fu The Rehearsal, cioè “La Prova”, del Duca di Buckingham, che a metà Seicento sbeffeggiò lo stile ponderoso e gli espedienti ricercati di vari illustri drammaturghi, ottenendo un clamoroso successo, mentre fu Shakespeare l’oggetto delle burle di Thomas Buffet, che nello stesso periodo realizzò caricature teatrali del Macbeth e della Tempesta. A inizio Settecento John Gay, autore di burlesque e molto amico di Swift, scrisse, pare proprio su suggerimento dell’autore de I viaggi di Gulliver, The Beggar’s Opera, ovvero “L’opera del mendicante”, parodia del melodramma e vivida rappresentazione della malavita londinese, a cui molti anni dopo si sarebbe ispirato Brecht per la sua Opera da tre soldi. Fu The Beggar’s Opera, nel 1750, a introdurre per la prima volta il genere del burlesque negli Stati Uniti. Un altro bersaglio del burlesque fu la pantomima, caratterizzata da un gusto spiccato per il travestitismo, e stilizzata nella gestualità imprescindibile dall’accompagnamento musicale. Premiato da un’enorme popolarità in Inghilterra, fu un genere longevo al punto da vantare profeti fino ai giorni nostri, come il regista-mimo-attore-ballerino Lindsay Kemp, prodigo di allestimenti sofisticati e kitsch. Nel Settecento la pantomima divenne preda delle satire di Henry Fielding, come The Tragedy of Tragedies, che fu pure musicata col titolo The Opera of Operas. Anche il dramma tedesco si prestava a roventi prese in giro: in The Rovers John Frere e George Canning parodiarono brillantemente Schiller e Goethe. Nell’Ottocento il burlesque decadde, pur con qualche eccezione. Lo sono, per esempio, le comic-operas di Gilbert e Sullivan, autori di miscugli intriganti di commedia e burlesque. Gilbert firmò anche Patience, una saporita messa alla berlina di Oscar Wilde e del suo mondo letterario, e Bernard Shaw, nel 1901, onorò il genere del burlesque con la sua firma tramite un pezzo di perfido humour, The Admirable Bashville. Nel frattempo in America trionfava il vaudeville, cioè più o meno quello che noi chiamiamo lo spettacolo di varietà, sulla cui nascita, a fine Ottocento, furono determinanti gli honky-tonk, ovvero i saloon per uomini e prostitute, animati da show fragorosi e triviali in cui s’alternavano comedians, cantanti, ballerini e chorus-girls. È questo il terreno su cui cresce il burlesque versione Usa, con le sue ragazze semi-spogliate e tutto il resto, ovvero numeri musicali e giochi licenziosi. Questo contesto rappresentò una vera palestra per plasmare i talenti dei grandi comici americani, costretti a soddisfare un pubblico greve e fin troppo esigente con virtuosistiche improvvisazioni da proporre a ritmo serrato. Non a caso le stelle del burlesque finirono poi per passare alla radio, al cinema e alla televisione, generi trionfanti nel secolo nuovo, e feroci nel sancire il declino del varietà. Dai fulgori dell’età dell’oro del music-hall fino agli sviluppi più o meno intellettuali del café-chantant, il varietà equivale a un mondo densissimo di filoni e forme, che contamina e intreccia i suoi percorsi col burlesque. In Francia può corrispondere alle spumeggianti esibizioni dei leggendari teatri parigini di fine Ottocento, come il Moulin Rouge e le Folies-Bergère, che festeggiarono l’irruzione della quadrille réaliste, come dire il can-can, immortalato dai quadri di Toulouse-Lautrec, essenza e simbolo di un’epoca. Ma alla famiglia eterogenea del varietà francese appartengono anche i cabaret pensosi degli chansonniers del secolo successivo, che animarono le scene parigine tra le due guerre, così come la moda delle caves della rive gauche, nella Parigi del secondo dopoguerra, con le sue cupe sacerdotesse esistenzialiste. Accanto a Juliette Gréco e alle sue compagne fiorivano ancora i frivoli grands spectacles, generosi di lustrini e carezzati da piume di struzzo, con vedettesfascinose come Renée Jeanmaire, guizzante e sexy con la sua chioma alla maschietta (forse qualcuno la ricorda quando dava scandalo nei nostri sabato sera televisivi in bianco e nero, gambe fasciate di nylon troppo trasparente e maglioni vasti e stiracchiati fino all’inguine). Fu lei, a fine anni Cinquanta, a tentare di ricondurre il varietà d’oltralpe agli antichi splendori che parevano tramontati con Mistinguett e Joséphine Baker. Quanto all’Italia, il varietà nacque a fine Ottocento dalla mescolanza dei profumi francesi del café-chantant con quelli dei più antichi spettacoli popolari nostrani, col filone partenopeo in prima linea. Nel clima belle époque appaiono, sulle scene italiane, le stelle estrose della Bella Otero e di Lina Cavalieri, femmes fatales esperte nel dilapidare patrimoni, e ai primi del Novecento i caffè-concerto romani accolgono chansonnier e macchiettisti del livello di Petrolini. Qui, come in America, si costruiscono in scena mestieri agguerriti, dove le capacità istrioniche attingono linfa dal rapporto diretto con platee sboccate . Arditi e triviali, i numeri alternano coreografie e canzoni alle più imprevedibili follie circensi. Vige tra le vedettes il vezzo degli pseudonimi francesi, da Yvonne de Fleuriel a Gina de Chanery. E in generale la terminologia attesta l’asservimento al mito di Parigi: la donna viene chiamata diseuse, gommeuse, étoile, artiste à la voix, chanteuse légère, endiablée. È irresistibile anche il gergo italiano: tra le specialità elencate nelle locandine figurano il romanzista, il fine dicitore, il bambino prodigio, il posteggiatore napoletano, il ventriloquo e il mangiatore di spade. In scena si offrono danze serpentine, danze con lampadine, riproduttori di uomini celebri, riproduttori di statue classiche, divinazioni del pensiero, casse misteriose, contorsionisti, dialettologhi e quant’altro. Negli anni tra il 1920 e il ‘30 la rivista e l’avanspettacolo, celebrati con passione, tenerezza e anche una vena di disgusto da Fellini nel film Roma, finiscono per assorbire definitivamente il varietà. Tra le nuove leve che si affermano in questo campo ci sono maschere assolute e memorabili come Totò, Nino Taranto e Rascel. T 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i sapori Annata 2005 DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 Sono i giorni delle uve nere, che chiudono la stagione della raccolta: i raggi del sole devono portare a maturazione e asciugare l’umidità agli acini più refrattari, compensando le forti piogge delle ultime settimane. Così anche quest’anno potranno arrivare bottiglie pregiate della bevanda che più di ogni altra giova alla salute del cuore e delle arterie Le previsioni per i magnifici otto I rossi scelti come “testimonial” della nuova vendemmia sono i vincitori delle rispettive tipologie secondo la Guida dei vini dell’Espresso 2006, curata da Ernesto Gentili e Fabio Rizzari, che sarà presentata giovedì a Firenze CHIANTI La Casuccia 2001 Castello di Ama Dopo tanta pioggia, la speranza è chiudere la vendemmia sotto il sole. È stata una stagione strana: primavera siccitosa, estate altalenante, temperature sotto la media. Per fortuna, il freddo ha fermato i funghi: la maturazione però è stata faticosa BAROLO Monfortino 1998 Conterno Il Nebbiolo è ancora in buona parte da raccogliere, perché gli acini non erano perfettamente maturi. Grazie ai diradamenti drastici, le piogge abbondanti non preoccupano. La speranza è di ripetere il 2002, annata piovosa eppure ottima BRUNELLO DI MONTALCINO 2000 Franco Pacenti Il Sangiovese è stato tutto raccolto già a inizio ottobre. Una settimana intera di pioggia in chiusura d’estate non ha certo aiutato. La mancanza di sole si fa sentire. Difficile raggiungere il livello della scorsa stagione. Ma l’annata non è persa AMARONE Monte Lodoletta 2000 Dal Forno Parola d’ordine: accontentarsi. Fino a fine settembre, le previsioni erano discrete, poi le piogge continue hanno rovinato tutto. La possibilità di fare l’Amarone 2005 è ridotta al lumicino. Le uve salvate finiranno nel Valpolicella, che sarà eccellente Vino Il bicchiere che allunga la vita LICIA GRANELLO hi beve vino rosso campa cent’anni. La massima non va presa alla lettera. Intanto, perché senza la specifica della quantità si tende a esagerare un po’, con effetti controproducenti sull’allungamento della vita. E poi perché se si sopravvive a cancro e infarto il traguardo del secolo d’età ormai sembra perfino riduttivo... Comunque, siamo certi — confortati da medici e ricercatori — che assunto alle famose dosi modiche (due o tre bicchieri al giorno), l’alcol incrementa la quota di Hdl, il colesterolo buono del sangue, assommando proprietà antisclerotiche e anti-Alzheimer. Il tutto, senza dimenticare il mitico resveratrolo, principe dei polifenoli, e i suoi fratelli flavonoidi, antociani, eccetera. Dicono gli scienziati che alle dosi consigliate, insieme al vino rosso ingeriamo ben 120 milligrammi di questi micropassaporti per l’immortalità (contro gli 8 forniti dai bianchi). Per questo, siamo così attenti all’andamento della seconda fase della vendemmia, quella che, praticamente chiusa la raccolta delle uve bianche, interessa le uve nere. Certo, da una parte all’altra d’Italia, i tempi della raccolta cambiano in funzione di clima e tipologia d’uva. Volendo fare un primo screening serio sul vino che verrà, bisogna tener conto che i produttori di Pinot Nero, Dolcetto e Merlot hanno già gran parte dell’uva (definita precoce) in cantina, seguiti a ruota da chi coltiva Cabernet e Barbera. Gli altri, i vignaioli che hanno scelto di cimentarsi con Nebbiolo, Aglianico, Montepulciano d’Abruzzo, uve cosiddette tardive, passano queste giornate tra i filari, decidendo dove e come raccogliere in base alla maturazione raggiunta e ai capricci di Giove Pluvio. Ognuno a suo modo: perché le variabili enologiche sono troppe per poterle misurare addosso a un terreno che superi la grandezza di un fazzoletto (o quasi). Per esempio, il tipo di terra in cui le viti affondano le radici, la sua pendenza, l’altitudine, l’esposizione solare, la ventilazione, la presenza di trattamenti fitosanitari. Le mani di chi coltiva sono decisive. Mai sentito parlare di diradamenti? Si prendono le forbici e si taglia. Quando i grappoli sono appena formati, e di nuovo dopo, quando sono a un passo dalla maturazione. Si dimezza il raccolto, a volte lo si riduce a un terzo: tre quattro grappoli per pianta, a loro volta “modellati” in modo da lasciare attaccata al graspo una manciata di acini pronti ad assorbire il meglio di sole, aria, acqua, e di farsi scivolare sopra gli eccessi di pioggia e (in parte) la grandine. Tanto impegno feroce, però, non annulla gli effetti di un andamento stagionale a dir poco bizzarro, che ha risparmiato pochissimi fortunati, disseminati a macchia di leopardo, tra qualche collina piemontese e le assolate, benedette vallate siciliane. Quasi ovunque ha piovuto tanto, troppo. Il sole degli ultimi giorni scalda gli acini più refrattari, asciuga l’umidità, sottrae un poco d’ansia ai responsabili della vendemmia. Potrebbe non bastare, se è vero che un super vino come l’Amarone è ad alto rischio di cancellazione, esattamente come successe due anni fa, quando alcuni “barolisti” si rifiutarono di tramutare l’uva in vino. A goderne, sarà il Valpolicella, che si arricchirà per l’occasione di uve abitualmente impiegate nella fattura del Primo Vino. Bottiglie da comprare e bere in allegria, consci che mentre ci deliziamo il palato, diamo una botta di giovinezza a cuore e arterie. Difficile trovare una medicina più goduriosa. C DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 Atripalda (Av) itinerari Il vignaiolo langarolo Bruno Rocca ha raccolto l’eredità familiare nella produzione di Barbaresco. Il suo “Rabajà”, 30.000 bottiglie all’anno, 30 mesi di maturazione tra barrique e bottiglia, è considerato uno dei migliori vini rossi italiani Ripa Teatina (Ch) È stata centro sannita e colonia romana. Tra i prodotti di pregio, i tartufi e i vini da uve Fiano, Greco di Tufo e Aglianico Vignale Monferrato (Al) Comune ricco di reperti archeologici e centro monastico. Abbondano produzioni di qualità dalle uve Trebbiano e Montepulciano d’Abruzzo Nelle sue millenarie campagne, in competizione con le altre storiche eno-colline delle Langhe, si coltiva una grande uva Barbera DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE ATRIPALDA BED&BREAKFAST C/da Alvanite 20 Tel. 0825-623948 Camera doppia da 55 euro, colazione inclusa AGRITURISMO LA CAPEZZAGNA Contrada Santo Stefano 64 0871-398040 camera doppia da 66 euro AGRITURISMO COLONNA Strada per Cuccaro, Frazione San Lorenzo 0142-933239 Camera doppia da 85 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE VALLEVERDE Via Pianodardine 112 Tel. 0825-626115 Chiuso domenica, menù da 25 euro VILLA MAIELLA (con camere) Via Sette Dolori 30 - Guardiagrele Tel. 0871-809362 Chiuso domenica sera e lunedì, menù da 22 euro LA BRAJA Via San Giovanni Bosco 11 - Montemagno Tel. 0141-653925 Chiuso lunedì e martedì, menù da 37 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE ENOTECA IL TEMPIO DI BACCO Via Nazionale 39 Mercogliano Tel. 0825-685307 ENOTECA REGIONALE D’ABRUZZO Corso Giacomo Matteotti 1 Ortona Tel. 085-9068302 DRÈ CASTÈ IL MONGETTO (con cucina e camere) Via Piave 6 Tel. 0142 933442 30 mln Gli ettolitri di vino rosso che si prevede di produrre 560 mln Le bottiglie di rosso vendute quest’anno 21 Le Denominazioni di origine controllata e garantita rosso NERO D’AVOLA Deliella 2003 Principi di Butera Tutto perfetto: giornate splendide, asciutte e ventilate in estate e autunno, precedute da piogge fino a tarda primavera. Risultato: un’ottima rete fogliare per proteggere i grappoli. La maturazione è stata appena rallentata. Sarà un’annata memorabile Le condizioni meteo restano la variabile fondamentale per una produzione d’eccellenza Ma la vendemmia perfetta è un sogno impossibile TAURASI ENZO VIZZARI uanto è ricca nella letteratura e nell’arte l’iconografia legata al vino e alla vendemmia, tanto è oggi freddamente tecnologico l’approccio a ogni fase del “ciclo produttivo” del vino. Fa effetto tornare con la mente alle immagini dei Baccanali di Tiziano, al Sileno di Annibale Contucci, all’Età dell’Argento di Pietro da Cortona nel quale Bacco spreme con le mani grappoli d’uva per una lieta e formosa Cerere… e poi leggere Attilio Scienza, massimo scienziato italiano della vite, che dice: «Entrare in vigneto muniti di un microchip molecolare, per verificare se è il momento di vendemmiare, non è fantascienza ma è il futuro prossimo». Insomma, poesia niente; ma tanto tanto impegno di cervello, di cultura magari empirica ma consolidata da decenni d’esperienza, di lavoro manuale, e via via di affinamento delle tecnologie e del loro impiego. Perché ogni vitigno, ogni terreno, ogni regione, ogni collina, ogni vigneto e ogni cru hanno peculiarità proprie. Un vitivinicoltore piemontese d’antico pelo e di primaria grandezza ama ripetere che l’imprenditore agricolo «ha un partner, il tempo, a fianco degli altri tre fattori — capitale, terra, lavoro — che fa come gli pare, che eleva all’ennesima potenza il fattorerischio, poiché dalle condizioni climatiche deriva il risultato finale per quanto concerne sia la quantità sia la qualità». Che è come dire che, al di là delle previsioni trionfalistiche che a ogni inizio agosto i produttori lanciano, non ha alcun senso fare pronostici sulla qualità della vendemmia sino a quando la vendemmia non è conclusa, essendo oltretutto decisivo per la riuscita ottimale l’andamento climatico addirittura delle ore e non solo dei giorni scelti dal viticoltore. Chiaro, allora, che la “vendemmia ideale” uguale per tutti non esiste. Dice per esempio Renzo Cotarella, deus ex machina dei vini di Antinori: «Per una vendemmia eccellente occorrono uve che maturano lentamente e che sfruttino soprattutto settembre con stagioni tendenzialmente secche. Bene qualche pioggia a agosto e ancora meglio a giugno e luglio quando gli acini ingrossano, ma per la maturazione e l’equilibrio delle diverse componenti dell’uva settembre è decisivo. In Toscana la vendemmia che mi ha dato più soddisfazione è stata quella del ‘97 in generale e il ‘99 e 2001 per il Chianti Classico. Per il Brunello la vendemmia più interessante degli ultimi tempi è stata certo la 2004 perché Montalcino ha goduto di un settembre lunghissimo. Le peggiori negli ultimi anni la 2002 e ancor più la 1992». Chiosa Jacopo Biondi Santi: «La nostra miglior vendemmia a Montalcino e in Maremma è stata la ‘97 per alcuni vini, per altri, come il Sassoalloro, il ‘98. La peggiore che io ricordi è quella del 1972, piovve sempre e quasi non raccogliemmo le uve». Dalla Sicilia commenta Alessio Planeta: «La migliore vendemmia è stata quella di quest’anno. Abbiamo finito la raccolta da pochi giorni, ma una vendemmia così non l’avevamo mai vista. Il 2005 è stato straordinario con un agosto e un settembre freschi che hanno permesso una maturazione lunga e equilibrata, uve decisamente mature e non passite. Le meno interessanti? La ‘98 e la ‘99, troppo calde». Il “sogno” del saggio piemontese? «Un inverno ricco di nevicate come l’8990, che assicurano l’umidità delle falde sino all’estate. Una primavera anticipata, con piogge abbondanti e temperature miti, senza gelate, e ventilazione durante la fioritura, come nel ‘97. Un’estate non caldissima, luminosa, con piogge moderate, come nel ‘96, e naturalmente, senza grandine. Un autunno asciutto e ventilato, con temperature notturne basse, come nel 2001». Qualcuno crede ancora alle favole e alla poesia della vendemmia? Q Radici riserva 1999 Mastroberardino L’inizio della vendemmia è previsto per questo fine settimana. Malgrado la piovosità superiore alla norma, il microclima ventilato ha salvato l’uva Aglianico dalle muffe. I tannini sono morbidi, buon viatico per una produzione più qualitativa del 2004 BARBERA Ai Suma 2003 Braida Raccolta completata con un piccolo anticipo rispetto ai tempi classici perché le piogge di fine agosto facevano temere l’insorgenza di muffe. L’uva risulta fruttata, profumatissima, con una componente acida un poco più elevata. Buone previsioni MONTEPULCIANO D’ABRUZZO Villa Gemma 2001 Masciarelli Essendo un’uva “tardiva” il Montepulciano ha subito tutte le piogge di inizio ottobre. Le uve sono comunque sane, merito anche della grande areazione. Le bucce buone e il colore intenso fanno pensare a un 2005 migliore del 2004 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 le tendenze Da Pechino non arrivano soltanto falsi e prodotti di qualità infima ma anche idee, tecniche e oggetti ispirati alle tradizioni del più famoso impero asiatico. E così mobili e abiti, gioielli e lampade conquistano ancora una volta i mercati europei, rinnovando Stile orientale il mito secolare della Via della Seta Ming Il fascino trendy AURELIO MAGISTÀ CINESERIA ALLA FRANCESE “Il bacio del dragone”: anelli a nappine in oro bianco e giallo di Cartier FIOR DI PELLE Tra Cina e Rococò, la zeppa aperta e decolleté con motivi floreali di Miu Miu n fantasma si aggira per l’Europa: è quello di un dragone. Per di più a due teste. Il dragone cinese che popola gli incubi dell’Occidente, infatti, non ci offre solo la testa che conosciamo meglio e che temiamo, quella delle merci a basso costo, delle imitazioni e dei falsi, della manodopera selvaggia con cui è impossibile competere, ma una seconda identità, più antica e raffinata. La storia dei rapporti tra Occidente e Cina, infatti, assomiglia proprio alle spire di un dragone: insinuante nell’arte, nella cultura, nella moda, ma anche capace di scattare in avanti e mordere con improvvise, febbrili passioni. Una storia raccontata, per esempio, da Guido Magnoni in La moda cinese e le cineserie in Europa nei secoli XVII e XVIII, dove si sottolinea che l’interesse per la civiltà cinese e per i suoi oggetti in Italia è, come in Francia o in Germania, fenomeno che riguarda essenzialmente le corti e l’alta aristocrazia, e quindi elitario. In particolare Venezia, potenza marinara e commerciale, sviluppa per esempio un proprio modo di laccare i mobili alla cinese, usando colori diversi dal rosso e dal nero caratteristici del modello originario e dilaganti in tutta Europa. In altre zone del suo territorio si diffondono decorazioni floreali delle case, che contaminano il rococò con la cineseria. Simbolo di questa passione colta e raffinata che periodicamente ha sedotto e continua a sedurre l’Occidente è il suo canale di trasmissione: la via della Seta, U Spesso l’influenza del dragone si vede anche nelle nostre produzioni artigianali e conferma che i due mondi sono sempre stati in contatto dell’antica Cina un percorso carovaniero di oltre 7 mila chilometri che, passando per Palmira e Samarcanda, arriva in Europa. E non è un caso che proprio a Treviso, antica marca veneziana e ideale capolinea ovest di quel percorso, si inauguri il 22 ottobre La nascita del Celeste impero, la prima di quattro grandi mostre (vedi scheda in alto) dedicate alla via della Seta con molti capolavori esibiti per la prima volta. In realtà, gli indizi di questa seconda identità cinese, fondata su una cultura antichissima e fatta di eccelse eleganze, di materiali da noi poco usati e sconosciuti, talvolta di know-how di cui ci siamo appropriati (ulteriore prova che il sapere finisce quasi sempre per rispettare una sua contabilità del dare e dell’avere) è tessuto anche il nostro presente. Stilemi, oggetti, forme che appaiono talvolta nella loro manifestazione più tipica e originale, in altre occasioni rielaborate dalle multiformi culture locali, in altre ancora riesplorate secondo un’eleganza rarefatta e cosmopolita. Un’ennesima riscoperta che, per gioco, possiamo chiamare neoMing, dal nome della dinastia cinese, durata dal XIV al XVII secolo, che più di tutte ha reso celebre la Cina e conquistato l’Occidente. Un termine dal significato esteso, una bandiera sotto cui si raccolgono disinvoltamente mobili e gioielli, packaging e vestiti, scarpe e lampade e che può perfino servire, con il frivolo alibi della tendenza e dello stile, ad aiutare la conciliazione di due mondi che, malgrado le tante collisioni, non possono fare a meno di cercarsi, con la misteriosa ciclicità di un’attrazione, si spera, non fatale. CAMMINANDO SUI PETALI IL PARAVENTO DI MADEMOISELLE In collaborazione fra Puma e Shangai Tang, le scarpe si chiamano Peony Trainers, peonie che allenano. In edizione limitata I paraventi cinesi molto amati da Coco Chanel, danno il nome (coromandel) alla moderna trousse laccata della casa ISPIRAZIONE ILLUMINANTE In bambù e tessuto, l’abat jour quadrata è importata da Oltrefrontiera ORIENTE AL QUADRATO La borsa per lui, un azzardo Vuitton, accorda l’Est europeo anni Venti con l’Estremo Oriente DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 51 LA MOSTRA Si apre sabato prossimo alla Casa dei Carraresi di Treviso “La nascita del Celeste Impero”, prima di un ciclo di quattro mostre dedicate a “La via della Seta e la civiltà cinese”. Le altre tre si terranno ogni due anni, dal 2007 al 2011. La prima raccoglie oltre 200 reperti provenienti da più di 60 musei e caveaux blindati del mondo. Fino al 30 aprile 2006. Info tel. 0422-5936000 Così la famiglia reale aprì un’epoca d’oro La dinastia della Luce che inventò una civiltà RENATA PISU o, questa volta il trend non è quello di un generico China Chic, come se un tre o quattromila anni si potessero riassumere e distillarne il succo, l’essenza di tradizioni, costumi, innovazioni, dall’arte popolare a quella dotta, dal nord al sud, passando per il centro, un’insensata cavalcata, un pescare alla rinfusa in un enorme tripode di bronzo e… ecco a voi un vaso Sung, una calligrafia preziosa, scarpette ricamate per “piedi di giglio”, lanterne rosse, fiori di carta intagliata, lacche e ricami, draghi a profusione. No, questa volta la visione si va finalmente restringendo ad un’epoca, ad una dinastia, svelando così preziosità e raffinatezze che sono soltanto dei Ming, una dinastia che regnò in Cina all’incirca trecento anni, puntigliosamente possiamo precisare: dal 1368 al 1644, cioè da quando il capo di un’insurrezione contadina cacciò i mongoli che avevano conquistato il Paese del Centro e si proclamò imperatore, fino a quando l’ultimo dei suoi discendenti venne spodestato da altri barbari conquistatori, i manciù. Un trecento anni in cui la Cina fu tutta davvero cinese. Già l’ideogramma che designa questa dinastia autoctona sembrerebbe profetizzare una vocazione, purtroppo mancata. Ming significa Luce, Splendore, Luminosità, si compone di due segni grafici, uno che rappresenta il sole, l’altro la luna, nelle tenebre di un medioevo barbarico si accendono dei Lumi di una precoce modernità che avrebbe potuto gemellarsi con quella di altri più tardi Lumi lontani, anche se mai il luminoso regno dei Ming diventò illuminista. Eppure, ci è mancato poco. In epoca Ming la Cina era una immensa fucina di trasformazioni sociali ed economiche, un cantiere di grandiose opere militari e civili: Pechino, per esempio, allora era tutta sottosopra, tutta in costruzione, come oggi, avendo deciso l’imperatore Yungle di farne la capitale Ming: ed edificò la Città Proibita, quale possiamo ammirarla oggi, così come il Tempio del Cielo, complessi grandiosi nei quali dominano colori in contrapposizione, il rosso purpureo delle mura del Palazzo Imperiale, le tegole blu dei tetti conici del Tempio del Cielo, lo stesso colore della volta celeste che è ripetuto nelle porcellane sacrificali, negli abiti che l’Imperatore e i suoi ministri indossano per il sommo sacrificio, esaltato dalla luce che illumina la cerimonia, filtrata da tondini di vetro azzurro raccolti in lunghissime collane. Raffinatezze ancora non esasperate, intrise di un forte simbolismo. Come è simbolica ma allo stesso tempo vivificata dal genio la pittura dei quattro eccelsi maestri di epoca Ming: Tang Yin, Wang Chen-ming, Shen Shih-tien e Chiu Ying. So bene che questi nomi da noi non dicono niente, suonano ostici. Ma ha scritto Werner Speiser che «questi contemporanei di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Tiziano, non altrimenti che i maestri europei, rappresentano uno dei culmini della storia dell’arte del mondo». Ideali estetici diversi, senza dubbio, sublimi “dilettanti” i cinesi, esponenti del mandarinato, già professionisti i nostri. Ma in Cina erano già “professionisti” gli artigiani, già capaci per le lacche, gli intarsi e, soprattutto, la ceramica, di una produzione su ampia scala per l’esportazione, come la ceramica bianca e blu — non quella gialla destinata alla corte imperiale — che raggiunse prima i paesi dell’Islam, poi l’Europa. Ma se le prime porcellane cinesi di epoca Ming che si possono oggi ammirare nei musei di Istanbul e Teheran sono pezzi unici e stupendi, quelle che un secolo dopo giunsero in Occidente erano già una sorta di produzione in serie. Eccelsa, comunque. Questo perché, in epoca Ming, la Cina era più “moderna” di qualsiasi altra civiltà al mondo. Vi si stampavano, prima che Gutemberg nascesse, opere di medicina, di farmacopea, romanzi e racconti, capolavori e letteratura di pura evasione. Nell’arredo e nell’architettura, nei giardini come nelle case, dominava una semplicità essenziale, quasi un minimalismo Zen, che è visione del mondo cinese, non giapponese. Insomma, ancora non era sorto quello stile ricco e barocco che si impose con la dinastia straniera dei conquistatori manciù, la dinastia Qing, madre di tutte le “cineserie”, nostre e loro. Solo che, quando la visione si restringe e si focalizza, ed il trend non è Cina ma è Cina dei Ming, si corrono altri rischi, cioè si accresce la confusione. Che non è “fusion”, come per la cucina. È proprio confusione. Ma il trend è fusione o confusione? Ditemi, per favore dite a me occidentale, se quel vaso è Sung, Ming o Qinq… Ditemi, per favore ditemi a me cinese, se quel vaso è etrusco, magno greco o romano. E non sarà per caso una copia? Quanto tarda? Noi non lo sappiamo, beatamente globalizzati senza storia, senza conoscenza, senza datazioni, seguiamo il trend. FOTO SEATTLE ART MUSEUM/CORBIS N COPPIA STORICA Modernissima, ma in perfetto stile Ming, la coppia di sedie è proposta da Latitudinimobili PRIMA TENTAZIONE La coppa Serpentine in cristallo rosso di Lalique allude contemporaneamente all’oriente e alla prima tentazione VERDE PROFONDO Il verde bottiglia della borsa bomboniera rievoca certi verdi orientali di intensa profondità. Tracolla in metallo smaltato. Di Céline GIARDINO IN GIALLO Il vaso di ceramica in giallo imperiale, è importato da Chineart SHANGAI CONTADINA Versione contemporanea del mobile rustico, usato in coppia nella zona di Shangai. Dakini Orientalart TÈ E BAMBÙ BACCHETTA E BARCHETTA Il cofanetto Atiko ha quattro tazze in quattro colori, la teiera con manico in bambù e zuccherini colorati di Geneviève Lethu Sopra, quattro ciotoline in boccio, con barchetta per poggiare le bacchette, dalla collezione Cina di Upim 52 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 16 OTTOBRE 2005 l’incontro Gente da copertina Intervistare il manager che oggi festeggia la vittoria in F1 è come stare dentro un western: lui fa la parte del cattivo, ti guarda come un bounty killer, è convinto di essere il più veloce con la pistola. Poi parla di tutto, della sua fuga dalle montagne cuneesi, dei soldi e della politica, dell’amore, del sesso e della famiglia che non ha mai voluto avere. Uno spaccone con un punto debole:“Gli occhiali da sole? Li porto sempre,per difendermi dagli sguardi della gente” Flavio Briatore hissà, forse al collegio vescovile di Mondovì un professore ostinato cercò di insegnarglielo, ma lui era uno studente a dire poco disattento. Insomma, Flavio Briatore può non essere d’accordo, eppure incarna e porta fino all’estrema conseguenza la legge filosofica che viene chiamata il rasoio di Occam. Il principio che prese il suo nome da quello di un aristotelico francescano del 1300 dice: «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem», non bisogna presumere che esistano più cose del necessario. Briatore ha asciugato il concetto all’essenziale. L’unica cosa che gli è necessaria è il denaro. Tutte le altre sono semplicemente delle derivate. «I soldi — dice — servono a pagare i dottori». Deve essere un proverbio contadino ereditato dal nonno o dal padre, e portato giù dalle montagne piemontesi dov’è nato. Malvolentieri. Di soldi ne ha tanti, tantissimi. «Non so quanti, credimi, non so esattamente quanto guadagno. Non me ne occupo personalmente. Sono un uomo ricco, è vero, non vedo che cosa ci sia di male». I soldi non servono soltanto a pagare i medici. C’è anche lo champagne. «La ricchezza mi ha consentito di comprare la libertà. Traduco: faccio quello che voglio, vivo nei migliori alberghi del mondo e posso prendere qualsiasi decisione senza dovermi prima chiedere: ma questa roba me la posso davvero permettere?». Briatore è uno spaccone, non uno stupido. C’è ancora chi lo definisce un geniale ignorante, ma lui se ne fotte — parole sue —, come se ne fotte di non avere mai ripulito, pur vivendo a Londra e girando in lungo e in largo il mondo, il suo marcatissimo accento cuneese; come non si vergogna di ammettere che è fattoria a Saluzzo, ma sono luoghi in cui non torna più. Questione di location, dice. «Se nasci in mezzo al Congo mica vorrai dire di essere stato fortunato. Io non sono nato in Congo, ma tra quelle montagne già da bambino avvertivo un certo malessere, sentivo che ero uno senza radici. Quando mi domandavano che cosa volessi fare da grande, se il pompiere, l’avvocato o il notaio, rispondevo che volevo prima di ogni altra cosa andare via di lì, da quelle asperità, da quelle fatiche, da quei sacrifici». Aveva pochi amici: «Ne ho pochissimi anche adesso. Due, forse tre. Nel mio mestiere c’è troppa competizione». In mezzo alle salite della montagna cercava discese, scorciatoie, soprattutto. «È vero, non faccio nulla che non sia calcolato. Ho preso il diploma di geometra da privatista, dopo essere stato bocciato due volte, in seconda e in terza, nell’istituto pubblico. Non me ne fregava niente, avevo scelto quella scuola perché qualcuno mi aveva detto che era la più facile. Alla maturità ho Cambio spesso donna perché non mi piace perdere tempo, quando sento che un rapporto è alla fine non lo tiro in lungo. La vita è una, non sai quando ti tocca morire FOTO LA MALFA / TEAM / GRAZIA NERI C MILANO dai tempi della scuola (ahilui, anche quella) che non legge un libro, neppure una spy story. «Non mi piace e non ho tempo». Nemmeno d’estate a Cala di Volpe, sullo yacht di settanta metri carico di ogni ben di dio. «Mentre gli altri giocano a golf, io lavoro», dice e dà persino l’impressione di crederci. La sua fabbrica di soldi, va riconosciuto, ha distribuito intorno molte fortune. Da Schumacher a Alonso, che oggi festeggia il suo primo titolo mondiale in Formula Uno. Fino a alcuni dipendenti del Billionaire, il locale di Briatore in Costa Smeralda. «Ogni anno portano a casa uno stipendio due o tre volte superiore al reddito dichiarato da molti presunti grandi industriali con la puzza sotto il naso che mi guardano come si guarderebbe un marziano con la testa verde solo perché sono di Cuneo». È la verità o siamo alla sindrome Ricucci? «Ma quale sindrome Ricucci… A parte che Ricucci mi sta simpatico. Pensa un po’ che fenomeno, un odontotecnico, un parvenu, che tenta la scalata al Corriere della Sera, che c’ha sempre il portafogli in mano e vuole pagare per tutti. E gli altri, quelli che con l’uno per cento se la tirano da padroni del Paese, che fanno pure gli offesi. Ma dai… Sai che ti dico? Viva Ricucci, autentico testimonial della globalizzazione. Il suo quartierino dei furbetti è pur sempre più grande di certi salotti milanesi della finanza». Incontrare Briatore è un po’ come stare dentro un film western. Lui fa la parte del cattivo, si dondola a gambe larghe sulla sedia, ti guata come un bounty killer e non parla mai per primo. È convinto di essere il più veloce, con la pistola. Fai le tue domande cowboy. Solo che non siamo in un saloon di El Paso, ma su un divano della suite presidenziale del Park Hyatt di Milano. Giapponesi ovunque, lingua più parlata l’inglese, giovani cameriere che bussano ogni dieci minuti a uno o all’altro degli ingressi dell’appartamento per chiedere se serve qualcosa. Lui è gentile, beve acqua minerale non gasata da una bottiglia di design senza etichetta, indossa i pantaloni blu di una tuta e una felpa rosa, ha sul tavolo di fronte un’agenda di appuntamenti lunga e fitta come un elettrocardiogramma e due cellulari che ogni tanto fanno «gnek» e si agitano sul piano di vetro. Briatore risponde solo un paio di volte — a un collaboratore per un impegno di lavoro e a una donna che chiama da una località di mare della Sicilia —, in tutte le altre si limita a osservare con indifferenza l’agonia del telefonino fino all’ultimo sussulto. Con buona pace di chi sta dall’altra parte. Se vuole, richiamerà. Non è uno che si affeziona. Lo capisci subito. Flavio Briatore è nato 55 anni fa a Verzuolo, un paese del Saluzzese a 462 metri sul livello del mare conosciuto per le cartiere Burgo, ha seguito i genitori insegnanti elementari a Montaldo di Mondovì, ha un fratello con una presentato come tesina il progetto di una stalla, quando sono diventato un manager di successo, quindi antipatico a molti, hanno detto che all’entrata della stalla avevo disegnato anche i gradini. È una balla». Lo chiamavano il “tribula”, in dialetto piemontese uno che non sta mai fermo, si infila ovunque, si arrabatta tra il lusco e il brusco pur di arrivare dove vuole. «Nei paesi c’è un soprannome per tutti. A me lo affibbiarono quando lavoravo in un ristorante di San Giacomo di Roburent. Mi davo da fare, smaniavo... ero un “tribula”, sì». Voleva fuggire: Cuneo, Milano. Voleva donne. Voleva divertirsi. Voleva soldi. S’infilò, il “tribula”, in un brutto giro. Carte truccate, clienti famosi spennati dal tramonto all’alba. Venne processato e condannato a tre anni di reclusione. Lui, previdente, se ne andò nelle isole Vergini, dove attese l’amnistia. Questione di location, no?. «È la mia storia, non la nascondo. Ero giovane e ho sbagliato, un incidente di percorso che mi è servito a farmi furbo. Nessuno è perfetto, questo è il bello della vita». Briatore ha un suo sito internet. Carenato, metallizzato. Lui si presenta come un manager «dallo stile di gestione dinamico e innovativo». Sullo schermo il suo sorriso è quello di un uomo felice e realizzato, eppure l’impressione che se ne ricava è la stessa che sembra di percepire in questa suite di mobili moderni e pavimenti levigati, senza la minima asprezza montanara, lo slogan di un uomo solo. Lui alza le spalle, dice: «È la mia vita, non ne vorrei una diversa. Sono un privilegiato». Gli domando dell’amore. «Non so definirlo. Credo che non ci siano luci che si accendono e si spengono per avvertirti che sei innamorato. È una roba fatta di creatività, è molto personale. Cambio spesso donna perché non mi piace perdere tempo, quando sento che un rapporto è alla fine non lo tiro in lungo. La vita è una sola, non sai quando ti tocca morire». Gli chiedo se ha mai desiderato una famiglia. «No, e non credo sia obbligatorio. Mi manca il libretto delle istruzioni per mettere su casa. Non puoi stare nella Formula Uno, come ci sono stato io, portandoti dietro moglie e figli. Diciamo che voglio evitare disastri. Aiuto bambini non miei, finanzio associazioni che costruiscono asili e orfanotrofi, ma di questo non voglio parlare». Il sesso? «Spero di essere normale, non sono malato di sesso. Dormo poco, non più di cinque ore per notte da sempre. Certo, un po’ di tempo libero ce l’ho...». E il tempo che passa? «La vecchiaia non esiste più. È importante però restare lucidi sino alla fine. Mi spaventa molto la malattia, il mio incubo è di perdere la mente, non essere più in grado di pensare. Di riconoscermi». La politica? «Non voto da 25 anni. Le idee della sinistra italiana mi piacciono, ma non le ho mai viste realizzare. Mi chiedo quando pensano al Paese, i ministri italiani: sono sempre a convegni, dibattiti, porte a porte in tv, sui giornali. Ci vorrebbe un governo parallelo, degli amministratori delegati che lavorano al posto loro». Berlusconi? «Come imprenditore è stato straordinario, il migliore degli ultimi trent’anni assieme a Benetton. Come politico... beh, la politica è un mestiere difficile». Suona il telefono della scrivania. Dalla hall lo avvertono che c’è gente che deve salire. Lui guarda l’agendaelettrocardiogramma e dice di farli aspettare mezz’ora, sono in anticipo sull’appuntamento. «Ho impegni a Milano fino alle cinque del pomeriggio, poi volo a Londra, cambio le valigie e vado dall’altra parte del mondo». Un tormento. «Macché, inseguo risultati. Bisogna fare così. Nel 2001 sono arrivato alla Renault e ho detto: diventeremo campioni del mondo nel 2005. Ce l’abbiamo fatta, altrimenti a dicembre mi sarei dimesso. C’è una bella differenza tra vincere con la Ferrari e vincere con la Benetton e la Renault. Quello che ha fatto i miracoli sono io, non loro, ma mi sono costati sangue. Montezemolo e Todt hanno vinto con il pilota che io ho inventato. Vabbè, che vuoi che ti dica, ho un solo rimpianto: aver lasciato andar via Schumacher nel ‘96. Fra me e lui è rimasto il rispetto, l’amicizia no. Non c’è affetto nel nostro mondo. È giusto così». Disseminati qua e là, nella grande living room che ci ospita, ci sono i suoi occhiali da sole. Il suo marchio di fabbrica. Non esiste Briatore senza occhiali scuri. Ne conto almeno tre paia. Di fogge e colori diversi. Lenti azzurre, rosse, gialle. Gli servono a nascondersi. «Quando entro in un posto mi intimoriscono gli sguardi della gente. Porto sempre gli occhiali per difendermi». Lo dice serissimo, quasi timido. Non è la verità, ma che gli si creda o no a lui non interessa. ‘‘ DARIO CRESTO-DINA
Scarica