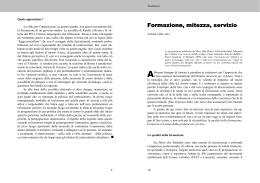I cattolici combattono, devono combattere il male che è l’unica cosa che non possono amare; ma non possono combattere, essere nemici degli uomini, anche quando questi sono al servizio del male, anche quando combattono la verità, la giustizia, la carità, la Chiesa. ... È certamente questa una delle leggi più singolari e difficili del cattolicesimo: difendere le proprie idee, i propri diritti che sono idee e diritti della Chiesa, ma difenderli amando quelli che combattono per ideali opposti. (Vittorio Bachelet, 1947) Mensile dell’associazione culturale Oscar A. Romero Anno XXVIII (2008) n. 4 L’AUTOBIOGRAFIA DI UNA NAZIONE VITTORIO BACHELET: LA NUOVA COSCIENZA DEI LAICI Andrea Decarli Francesco Ghia FORMAZIONE, MITEZZA, SERVIZIO PIETRO SCOPPOLA, UN CATTOLICO “A MODO SUO” Luciano Azzolini Vincenzo Passerini ALDO MORO: PASSATO E PRESENTE CAMBOGIA, LA TRAGEDIA E LA MEMORIA Alberto Conci Periodico mensile - Anno XXVIII, n. 4, aprile 2008 - Poste Italiane S.P.A. spediz. in abb. postale - d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Trento - taxe perçue. Redaz. e amministraz.: 38100 Trento, cas. post. 359 – Una copia € 2,00 – abb. annuo € 20 www.il-margine.it Sitia Sassudelli IL MAR MARGINE 4 APRILE 2008 Alberto Conci 3 L’autobiografia di una nazione Andrea Decarli 11 Formazione, mitezza, servizio Luciano Azzolini 15 Aldo Moro: passato e presente Sitia Sassudelli 22 Vittorio Bachelet: la nuova coscienza dei laici Francesco Ghia 26 Pietro Scoppola, un cattolico “a modo suo” Vincenzo Passerini 31 Cambogia, la tragedia e la memoria «Forse siamo sempre più pronti a dare drastiche norme per la morale individuale, sfumando quelle per la vita sociale, che pure sono altrettanto impegnative per un cristiano, e che sono non meno importanti per un’autentica presenza cristiana, proprio a cominciare dalla pastorale giovanile. Mi chiedo come possiamo meravigliarci che i giovani si frastornino nelle discoteche o nella droga, si associno per violenze di ogni genere, si esaltino nel bullismo, quando gli adulti, anche quelli che si proclamano “cattolici”, nel mondo economico e in quello politico danno troppo spesso esempio di arrivismo e di soprusi, giustificano la loro illegalità ed esaltano le loro “furberie”, e noi uomini di Chiesa tacciamo per “non entrare in politica”, finendo con sponsorizzare questo esempio deleterio, che corrompe l’opinione pubblica e sgretola ogni cammino di sana educazione. Ci stracciammo le vesti quando all’on. Prodi scappò detto che non aveva mai sentito predicare l’obbligo di pagare le tasse; ma avremmo dovuto farlo altrettanto quando altri invitavano a non pagarle [...]». dalla Lettera aperta ai confratelli vescovi scritta in vista della Assemblea annuale della Conferenza Episcopale Italiana da Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea IL MARGINE mensile dell’associazione culturale Oscar A. Romero Mentre andiamo in stampa Direttore: Emanuele Curzel «Non so quale sarà il giudizio della CEI sui risultati delle recenti elezioni. La nostra gente ha sempre pensato che i Vescovi, pur astenendosi da interventi diretti, non riuscissero a nascondere una certa simpatia per il Centrodestra, forse perché, almeno apparentemente, si dichiara più severo nei confronti dell’aborto e dei problemi degli omosessuali e più favorevole alle scuole e alle organizzazioni confessionali. […] In un mondo, come il nostro Occidente, dominato dal capitalismo, che sta impoverendo sempre più la maggioranza dei popoli e tutto teso, tra noi e fuori di noi, verso la ricchezza e il potere – la “mammona” evangelica, che Gesù contrappone drasticamente a Dio – tra i valori “non negoziabili”, accanto alla campagna per la vita nascente e per le famiglie “regolari”, va messo il rispetto per la vita e lo sviluppo della vita di tutti, in tempi in cui si allarga la divaricazione già denunciata da Paolo VI nella Populorum progressio (quarant’anni fa!) tra i popoli e i settori più sviluppati e più ricchi e quelli più poveri e dipendenti, avviati a situazioni di fame inappagata e di malattie non curate, vanno messi l’impegno per un progressivo disarmo, richiesto da Benedetto XVI all’ONU, e quello per la nonviolenza attiva, che è la caratteristica del messaggio e dell’esempio di Gesù (“Obbediente fino alla morte, e a morte di croce” – Fil 2, 16)». In redazione: Alberto Conci, Marco Furgeri, Pierangelo Santini, Angelo Scottini (continua in quarta di copertina) Amministrazione e diffusione: Luciano Gottardi [email protected] [email protected] Webmaster: Maurizio Betti [email protected] Comitato di direzione: Celestina Antonacci, Monica Cianciullo, Giovanni Colombo, Francesco Comina, Marco Damilano, Fulvio De Giorgi, Marcello Farina, Guido Formigoni, Paolo Ghezzi (resp. a norma di legge), Paolo Giuntella, Giovanni Kessler, Roberto Lambertini, Paolo Marangon, Fabrizio Mattevi, Michele Nicoletti, Vincenzo Passerini, Grazia Villa, Silvano Zucal. Collaboratori: Carlo Ancona, Anita Bertoldi, Dario Betti, Omar Brino, Stefano Bombace, Vereno Brugiatelli, Luca Cristellon, Marco Dalbosco, Mirco Elena, Cornelia Dell’Eva, Michele Dorigatti, Michele Dossi, Eugen Galasso, Lucia Galvagni, Giancarlo Giupponi, Paolo Grigolli, Alberto Guasco, Tommaso La Rocca, Paolo Mantovan, Gino Mazzoli, Milena Mariani, Pierluigi Mele, Silvio Mengotto, Walter Nardon, Francesca Paoli, Rocco Parolini, Nestore Pirillo, Gabriele Pirini, Emanuele Rossi, Flavio Santini, Pierangelo Santini, Sergio Setti, Giorgio Tonini. Progetto grafico: G. Stefanati Una copia € 2,00 - abbonamento annuo € 20 - d’amicizia € 30 estero € 30 - via aerea € 35. I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. n. 10285385 intestato a: «Il Margine», c.p. 359 - 38100 Trento o sul conto corrente bancario con le seguenti coordinate: ABI 07601, CAB 01800, CIN J, CC 000010285385, IBAN: IT25J 07601 01800 000010285385. Per i bonifici dall’estero: BIC: BPPIITRRXXX. Autorizzazione Tribunale di Trento n. 326 del 10.1.1981. Codice fiscale e partita iva 01843950229. Redazione e amministrazione: «Il Margine», c.p. 359, 38100 Trento. http://www.il-margine.it e-mail: [email protected] Publistampa Arti Grafiche, Pergine Il Margine n. 4/2008 è stato chiuso in tipografia il 12 maggio 2008. «Il Margine» è in vendita a Trento presso: “Artigianelli”, via Santa Croce 35 - “Centro Paolino”, via Perini 153 - “La Rivisteria” via San Vigilio 23 - “Benigni” via Belenzani 52 - a Rovereto presso “Libreria Rosmini” - a Milano presso “Libreria Ancora”, via Larga 7 - a Monza presso “Libreria Ancora”, via Pavoni 5. editore della rivista: ASSOCIAZIONE OSCAR ROMERO Presidente: Piergiorgio Cattani [email protected] Vicepresidente: Fabio Olivetti Segretario: Veronica Salvetti Editoriale La semplificazione del quadro parlamentare è impressionante. Il bipolarismo, costituito da due coalizioni formate ciascuna «da un partito e mezzo» (Ceccanti), è oggi estremamente marcato. La somma dei seggi dei primi due partiti era inferiore al 50% nel 1994, oggi è pari al 78,3%, e se si considerano anche IdV e Lega, le due coalizioni raggiungono il 93,8% dei seggi. E in questo quadro, con il Consiglio comunale delle due capitali d’Italia, Roma e Milano, in mano al Pdl, si completa il profilo di un Paese che ha deciso di andare a destra. Contro il quale evidentemente il messaggio di Veltroni e i due anni di governo del centrosinistra non sono stati convincenti. L’autobiografia di una nazione ALBERTO CONCI L’editoriale è il risultato di una discussione redazionale (17 aprile 2008). N on so se abbia ragione chi, all’indomani del voto del 13 e 14 aprile, ha parlato di un passaggio alla Terza Repubblica. Ci sarebbe, per la verità, da discutere se si possa attribuire a un risultato elettorale, sia pure sconvolgente, il ruolo di un cambiamento istituzionale. Anche perché permangono elementi di continuità con il passato, non ultimi i volti dei protagonisti, se si esclude Veltroni. Tuttavia è chiaro che il Parlamento uscito dal voto è qualcosa che per molti aspetti non ha precedenti nella storia repubblicana. All’indomani del voto, Stefano Ceccanti (www.federalismi.it, 8/2008) ha ricordato che gli elettori si sono trovati a scegliere in un quadro che già in partenza era completamente rinnovato, con la possibilità di muoversi fra «quattro proposte principali: due di Governo, Pdl e Pd con i relativi junior partners, e due identitarie, Sinistra Arcobaleno e Udc. In termini di voti non c’è dubbio che, sia pure in misura diversa, siano state premiate solo le due proposte di Governo, con un particolare beneficio per gli junior partners, utilizzati in entrambi i casi dall’elettorato portatore di critiche più radicali al sistema come una sorta di correttivo tribunizio interno alla proposta di Governo. Il Pdl cresce in termini reali di un milione e mezzo di voti validi, di cui 330.000 in Campania (effetto diretto dell’immondizia) e 380.000 mila del LombardoVeneto (anche qui in larga parte effetto di quella situazione in Campania). In fondo, se consideriamo la Lega come un equivalente funzionale dei tre principali partiti regionalisti spagnoli (Ciu, Pnv e Erc), rientra in standard quantitativi normali il fatto che il partito a vocazione maggioritaria debba fare i conti con un 6-7% di voti (e seggi) che lì si raccolgono, anche se nel caso spagnolo si ricorre (sinora) ad appoggi esterni e non a un Governo di coalizione. [Sull’altro versante] Pd e Idv salgono in termini reali di poco meno di 190.000 voti, di cui quasi 150.000 in Lazio (effetto della candidatura Veltroni) e poco più di 75.000 tra Toscana, Umbria e Marche, in parte compensati dalla débacle siciliana (meno 62.000) [evidentemente Mangano è proprio un eroe… n.d.r.]. Per chi perde restare oltre un terzo dei voti significa aver comunque ormai raggiunto la dimensione europea della forza politica a vocazione maggioritaria che arriva seconda. Sono livelli paragonabili, punto più punto meno, a quelli di Spd, Psf, Conservatori inglesi, Pp spagnolo». 3 Gli scomparsi L’altra faccia della medaglia è costituita dalla scomparsa delle cosiddette posizioni identitarie. Nel nuovo Parlamento, per effetto dello sbarramento, non compaiono quelle forze politiche che hanno segnato la storia repubblicana del nostro Paese. E in qualche modo dobbiamo dire che sono rimaste fuori tradizioni politiche e visioni della repubblica che hanno contribuito a costruire il nostro assetto costituzionale. Non solo, come si è detto molto spesso, la sinistra arcobaleno con la lunga tradizione del PCI, ma anche il PSI e i Verdi. E a queste va aggiunta la riduzione a “micro” presenza della tradizione democristiana con l’UDC. È il taglio più impressionante mai avvenuto, in termini di rappresentanza, delle tradizioni politiche più significative che hanno scritto la Costituzione: quella socialista, quella comunista, quella cattolica. E il taglio con il passato è ancora più vistoso se si valuta che, in termini formali, la più “anziana” delle forze politiche presenti nel parlamento è la Lega. È proprio la Lega a uscire per molti aspetti come la vera vincitrice delle elezioni, grazie al radicamento sul territorio e a un messaggio tanto semplificato quanto inquietante. Il linguaggio antiistituzionale, antisistema, violento, islamofobico, minaccioso, rancoroso, profondamente egoista, strutturalmente pagano della Lega ha fatto presa anche in zone di tranquilla integrazione, economicamente ricche, che poco avrebbero avuto da rimproverare al Governo del Paese. Ed è ancora una volta la Lega, che pesca ormai sempre più spesso nel tessuto operaio delle piccole aziende, che ci dà la misura non solo della sconfitta della sinistra, ma anche dello spostamento del voto e quindi della fine del movimento operaio che tanta parte aveva avuto nella costruzione 4 dell’identità del Paese e nella storia politica del Novecento. La perdita del movimento operaio da parte della sinistra è un fenomeno che non è solo italiano. E la domanda, tutt’altro che scontata, è quale sia la forza politica, se esiste, che si farà carico di questa eredità. Il rischio è che a farsi carico del malcontento delle classi più povere siano forze politiche dai tratti fondamentalisti e violenti (e la Lega si colloca in questa prospettiva), come accade in altre aree del pianeta. Un problema serio, sul quale la sinistra non può non riflettere. Altrettanto preoccupante è la scomparsa dei Verdi. È ben vero, come sostengono gli ottimisti, che le istanze verdi sono trasversali e sono ormai presenti in diversa misura in tutte le forze politiche rappresentate in parlamento; ma è altrettanto vero che l’assenza dei Verdi rischia di spostare alcune battaglie ambientali unicamente al di fuori del parlamento. Sto pensando non solo alla Tav o alla questione rifiuti, ma anche alla partita nucleare che Berlusconi ha promesso di riaprire con la promessa (propagandistica e infondata sul piano scientifico) di strepitosi ridimensionamenti della bolletta energetica e di una riduzione consistente di emissioni di gas serra. Ma anche qui, la domanda sulla motivazione di questa scomparsa dei Verdi va pur sempre posta, se non altro perché è indice di un cambiamento profondo nella vita del Paese, e si deve chiedersi se tale scomparsa sia da attribuire unicamente alla scarsa sensibilità ecologico-ambientalista dei cittadini o se non sia anche il frutto di una classe dirigente che non è riuscita a trasmettere la questione ambientale come una questione vitale per il futuro nostro e dei nostri figli. Il problema che la scomparsa della sinistra pone è almeno su tre livelli. Prima di tutto, come accennato, sul piano della cultura politica, con la scomparsa di una delle forze che hanno contribuito non solo a costruire il tessuto costituzionale del Paese, ma anche a mantenere il timone della democrazia in anni difficili, come gli anni di piombo, evitando la deriva insurrezionalista che affondava le radici nella tradizione espressa da Pietro Secchia. In secondo luogo, ci pone il problema dei luoghi di espressione e di rielaborazione politica delle istanze di cui la sinistra è portatrice. Una dimensione extraparlamentare è sempre presente nella vita politica di un Paese. Ma è anche vero che molte delle istanze che si esprimevano in aree contigue alla sinistra hanno sempre trovato espressione, anche istituzionale, proprio all’interno di quelle forze politiche. L’assenza di questi riferimenti istituzionali può condurre da un lato a una sfiducia “antipolitica”, ma dall’altro an- 5 che alla tentazione di “saltare” la politica, di non considerarla più in grado di risolvere questioni di carattere sociale o problemi internazionali considerati essenziali. Non si tratta necessariamente, come paventato da alcuni già all’indomani del voto, dello scivolamento nella violenza; ma di certo siamo di fronte alla possibilità che molti considerino di essere alla fine della politica. Per questo, ed è il terzo livello, si tratta di capire se il PD avrà la volontà politica da un lato e la capacità dall’altro di diventare un luogo “inclusivo” rispetto a queste istanze, accettando di darvi voce. La sfida, tuttavia, è tutt’altro che facile. Non solo perché il governo precedente è caduto anche in ragione di fratture con la compagine di quella che sarebbe stata la Sinistra Arcobaleno, ma anche perché si tratta di vedere se sulle battaglie più delicate e difficili gli “esclusi” accetteranno di riconoscere nel PD il luogo della propria rappresentanza. In questo quadro va letta anche la permanenza, per la verità abbastanza insignificante sul piano numerico, dell’UDC, l’ultimo partito identitario del Novecento. Un partito che, con 530.000 voti in meno, ha pagato la fuga nel PdL degli elettori che credevano nella coalizione e ha contemporaneamente fatto da diga all’espansione del PD verso il centro. Facendo così un servizio più a Berlusconi che a Veltroni. Infine una nota merita la sconfitta della Destra della Santanchè, che per molti aspetti pone gli stessi problemi della dimensione extraparlamentare della sinistra. Anche qui, non si tratta solo del rischio di derive antipolitiche o addirittura violente, ma si tratta soprattutto di capire quanto il Pdl sia in grado di accogliere almeno alcune delle istanze sollevate dalla Destra. Si può certamente dire che il bipolarismo che ne esce ci conduce verso i grandi sistemi bipolari europei; ma è anche vero che la grande differenziazione politica del nostro Paese e la frammentazione geografica e culturale avevano trovato, all’indomani della guerra, nel sistema proporzionale una modalità di rappresentanza delle istanze delle minoranze. La situazione di oggi, con l’esclusione dei due estremi, rischia di condurre a un cortocircuito e pone il problema non tanto della governabilità, quanto proprio quello della rappresentanza. O si va nella direzione di una maggiore inclusività, accettandone anche la fatica, o si dovrà pensare a forme di rappresentanza che permettono anche a forze politiche minoritarie di ottenere rappresentatività. Tantopiù che il rientro della SA e della Destra, data questa soglia di sbarramento, appaiono comunque difficili, almeno nelle condizioni uscite dal voto di aprile. 6 La linea morbida e la frattura vera La linea morbida usata da Veltroni in campagna elettorale, la linea della non inimicizia, dell’abbandono e del rifiuto della dialettica amico-nemico non ha cambiato la situazione, perché il Paese, anche al di là della forte presenza della Lega rimane marcatamente diviso. E non si tratta di una divisione di carattere unicamente politico. La frattura riguarda la concezione della persona, il suo rapporto con gli altri, con la comunità e con le istituzioni. Da questo punto di vista il “pensiero debole” di Veltroni può essere una tecnica elettorale adeguata per gli elettori che si pongono razionalmente di fronte ai grandi temi della giustizia, della legalità, della convivenza civile, delle regole; ma è assolutamente inefficace in un Paese che ha scelto ancora una volta di andare a destra. In qualche modo questo risultato elettorale potrebbe confermare la tesi che in Italia il centrosinistra vince solo in un’emergenza storica; altrimenti prevale quel misto di ricerca dell’interesse personale, di sfiducia nelle istituzioni, di pretesa di fronte allo Stato che hanno spostato l’elettorato a destra. Come dire che se non siamo in emergenza, allora non vogliamo pagare le tasse, vogliamo guadagnare di più, vogliamo che non ci vengano tolti i servizi. E, soprattutto, vogliamo vivere sicuri. Una giocosa irresponsabilità… La sicurezza, appunto. Uno degli elementi chiave della campagna elettorale; uno degli elementi che nella storia della Repubblica sono stati sempre usati per spingere il Paese a destra. Ma questa volta non è più la spinta esercitata con le paure delle diverse fasi della strategia della tensione. È una paura molto più “privata”: lo stupro e la rapina in casa hanno paradossalmente la possibilità di spostare a destra l’asse politico molto più di un attacco al cuore dello Stato (scrivo nei giorni in cui si ricorda il rapimento Moro, a pochi giorni da un incontro con Manlio Milani sui misteri dello stragismo italiano…). E su questo spostamento l’allarmismo dei mezzi di informazione ha giocato non poco, strillando per settimane in prima pagina ogni atto di violenza, che è diventato l’emblema dell’insicurezza globale del Paese. Certo il problema è serio. Dieci anni fa, in un documento pubblicato su Esprit, Repubblicani al bando la paura!1, un gruppo di intellettuali francesi poneva il problema della sicurezza sociale come un problema che la sinistra non può accantonare. Invitando a riflettere sull’inclusione sociale, sulla necessità di 1 creare condizioni di integrazione, sulle modalità dell’integrazione, sulla necessità che alla base dell’inclusione sociale debbano essere posti i pilastri fondamentali della repubblica. Il problema di un risorgere di sentimenti e di linguaggi razzisti è estremamente serio, perché si fonda sull’affermarsi di un approccio prerazionale, mitologico, idolatrico. È un errore sottovalutare la portata in questo senso della ritualità leghista neopagana (dalle ritualità parabattesimali ai matrimoni celtici…) con il suo corollario di egoismo di gruppo, di violenza, di paura del diverso, di rozza semplificazione, di disprezzo della persona umana: si tratta di uno dei messaggi più apertamente antievangelici presenti nel nostro Paese, portato avanti nei gazebo fuori dalle chiese, mentre si difende magari la presenza del crocifisso a scuola. Un messaggio contro il quale la Chiesa post-ruiniana, se si escludono alcune illuminate eccezioni, non ha voluto porre argine. Scegliendo il silenzio, e cioè l’insignificanza, a fronte di messaggi di aperto disprezzo della vita umana. Da questo punto di vista la frattura fra le scelte etico-politiche operate nella vita personale e il magistero ecclesiale è marcata e richiama quella frattura (che assume talora i tratti dello scisma sommerso) già presente in molti altri Paesi europei. E a poco serve parlare di sconfitta dello zapaterismo perché, se questo è il metro, la vittoria appare molto più ricca di zone d’ombra che di luce. A questo si deve aggiungere l’assenza, in campagna elettorale, delle grandi questioni internazionali nei due maggiori schieramenti. La crescita del prezzo dei cereali, che condanna alla morte per fame decine di milioni di persone per ogni punto percentuale di aumento, la situazione di conflitto in cui si trovano 36 Paesi, la difficoltà posta da una crescita senza freni del petrolio e da una caduta libera del dollaro, la crescita delle spese in armamenti e la corsa al nucleare militare, tutto questo non è rimasto che sullo sfondo. Per vincere in Italia si deve promettere di fare gli assessorati alla sicurezza, di mettere due poliziotti in ogni via, di abolire l’ICI, di togliere il bollo auto, di fare il federalismo fiscale, di far crescere illimitatamente PIL e redditi, e di conciliare la crescita illimitata con la sostenibilità ambientale. Il Paese delle favole… nel quale non sembra pagare, sul piano elettorale, nessun richiamo alla responsabilità personale o a quella collettiva. L’indignazione per le dichiarazioni dei redditi pubblicate ne è un tragico esempio: per quelle il Paese delle favole e del mito della ricchezza facile si solleva, per i settanta inquisiti entrati nel nuovo Parlamento no. Pubblicato su “Il Margine”, 19 (1999), n. 3; sul tema si svolse poi un interessante seminario; l’intervento presentato da Carlo Ancona in quell’occasione fu poi pubblicato su “Il Margine”, 19(1999), n. 8. 7 8 Testimoni Quale opposizione? La sfida per l’opposizione, in questo quadro, non passa unicamente dalla formazione di un governo-ombra. La sconfitta di Rutelli a Roma e la vittoria del PD a Vicenza impongono una riflessione. Roma è stata consegnata ad Alemanno grazie a una scelta che appare in linea più con la logica della “legge porcellum” che con il coraggio della discontinuità, contando probabilmente sul voto responsabile dei cittadini di centrosinistra. Ma, come abbiamo avuto modo di dire troppe volte su queste pagine, non si può chiedere in eterno agli elettori di turarsi il naso, di guardare oltre, di passar sopra, di dar fiducia preventiva. E così si è consegnata anche la capitale, con tutto ciò che questo significa, alla destra. Non riuscendo a capitalizzare nulla del lavoro di Veltroni. A rendere più cocente la sconfitta di Roma è paradossalmente la consolante vittoria di Vicenza. La quale indica che anche nella roccaforte del pensiero leghista, il più profondamente e irrazionalmente radicato fra i pensieri politici, si può vincere, se solo si ha l’accortezza di tener conto delle esigenze delle persone, della necessità di essere inclusivi, della possibilità di allargare e non di restringere gli orizzonti di dialogo, come la questione Dal Molin ha imposto. Se alla base della sconfitta elettorale si deve dunque riconoscere un profondo cambiamento della struttura e della sensibilità sociale, è anche su quel piano che va ripensata la politica del centrosinistra. In primo luogo immaginando modalità di inclusione per quella parte di società civile più attiva e responsabile che fatica oggi a ritrovare nell’arco parlamentare un riferimento politico. In secondo luogo accettando la sfida di diventare luogo di progettazione di una politica che metta al centro le grandi sfide del futuro quali la questione ambientale, il rifiuto della guerra, un’economia della reciprocità, la partecipazione democratica, il rispetto della legalità; tutto questo creando sul territorio luoghi di partecipazione sistematica, aperta e inclusiva. In terzo luogo ripartendo dalla necessità di contrastare l’espansione della destra abitando il territorio, tornando a dialogare con le persone, inventando, e accettando, il rinnovamento – nello stile e nelle strutture – della politica, un rinnovamento che da troppi anni gli elettori di centrosinistra attendono. Formazione, mitezza, servizio ANDREA DECARLI Le presentazioni pubbliche del libro Aldo Moro e Vittorio Bachelet. Memoria per il futuro (con testi di Achille Ardigò, Paolo Giuntella, Roberto Ruffilli e Pietro Scoppola, Il Margine, 2008) sono state l’occasione per riflettere su questi personaggi, sulla loro vita e sulla loro testimonianza per l’oggi. In questo numero del Margine offriamo ai lettori tre dei contributi esposti nel corso di tali presentazioni. A bbiamo bisogno di tornare a guardare ai testimoni con l’approccio che è ben espresso dal sottotitolo del libretto: memoria per il futuro. Non è la nostalgia che ci deve guidare, ma la volontà di imparare ad essere all’altezza delle sfide del nostro tempo. E i testimoni ci aiutano in questo perché l’esempio della loro vita e del loro impegno di discernimento sono capaci di orientarci in tempi in cui i punti di riferimento sono scarsi. Sono convinto che, al di là delle idee e delle scelte contingenti, è soprattutto la personalità interiore, la robustezza e la trasparenza della coscienza che fa di questi testimoni (fino al prezzo della vita: tutti e due assassinati!) dei maestri per il nostro presente. A partire da qui vorrei fare un discorso non di pura memoria, ma appunto di memoria che apre al futuro. Vorrei rilanciare tre sfide, che individuo nella loro testimonianza di vita e di cui mi pare oggi ci sia urgente bisogno di fare tesoro, e non solo per la vita politica: la qualità della formazione, la mitezza e il senso della gratuità nel servizio. La qualità della formazione Sia Moro che Bachelet sono stati uomini di riconosciuta e profonda competenza professionale, di cultura, ma anche persone di solida formazione spirituale e teologica, forgiati attraverso quel «lavoro di preparazione severissima», come si esprimeva Ardigò (p. 48) caratteristico dei movimenti intellettuali dell’Azione Cattolica (FUCI e Laureati), orientati, secondo il 9 10 progetto montiniano, a formare una élite intellettuale capace di dirigere la ricostruzione della convivenza democratica. Come ricordava Scoppola: «la scuola montiniana dei movimenti culturali dell’AC degli anni ’30 fu la scuola comune di questi due grandi» e anche, come ricorda Ardigò, lo spazio di militanza successiva, nei laureati cattolici e, per Bachelet, nell’Azione Cattolica. Ritroviamo in loro il segno di una formazione solida nella robustezza di principi e di impostazione, ma, anche e proprio per questo, capace di grande flessibilità nell’ascolto dei segni dei tempi, con la volontà di comprenderli. Una formazione non centrata sull’indottrinamento per addestrare a contrapporsi ed a saper rendere efficace la difesa dei propri ideali, ma orientata a maturare una larghezza e profondità di mente e cuore per comprendere anzitutto ed per entrare in dialogo con tutti. Una formazione solida e flessibile, dotata di un senso profondo e sereno della complessità e dunque lontana dalle semplificazioni banali ed interessate e dai giudizi rozzi e trancianti. Penso che la lezione di Moro, a proposito di questo profondo e sereno senso della complessità, non possa essere dimenticata; e in questo fu certamente discepolo di quel suo grande amico e maestro, Montini, il futuro Paolo VI, considerato spesso, proprio a causa della sua fervida percezione della complessità delle questioni, un incerto e un indeciso o addirittura un angosciato. Un senso della complessità che in entrambi si accompagnava però alla grande apertura per comprendere con atteggiamento di amore il proprio tempo, come emerge in un testo di Moro riferito agli anni del ’68, riportato da Scoppola (p. 29): «Come siamo tutti facili alla condanna! Come ci piace straniarci dal nostro tempo, per scuotere da noi pesanti e fastidiose responsabilità. Non amiamo il nostro tempo, perché non vogliamo fare la fatica di capirlo nel suo vero significato, in questo emergere impetuoso di nuove ragioni di vita, in questa fresca e misteriosa giovinezza del mondo». La sfida della loro testimonianza, allora, diventa per noi oggi un richiamo all’ineludibile scommessa sulla formazione di coscienze, solide, robuste, competenti e aperte, contro il devastante dilettantismo educativo; la scommessa su una formazione seria e paziente contro l’improvvisazione presenzialista e l’illusione che la tecnica, in questo caso quella della comunicazione, possa sostituire o surrogare le idee. Una formazione capace di valorizzare la ricchezza di una tradizione educativa e di buoni maestri e nel contempo di guardare con coraggio al nuovo che emerge. È un tema evidenziato in tutto l’intervento di Scoppola. 11 La sfida della mitezza È una sfida urgente per questo tempo feroce ed eccessivo. Moro e Bachelet furono due uomini miti nel senso evangelico del termine; non solo per il carattere, ma per la scelta di uno stile che pian piano plasma la personalità. Penso alla scelta costante ed imprescindibile del dialogo da parte di Moro, l’uomo delle “convergenze parallele”, ossimoro che manifesta la volontà precisa di non chiudere mai il dialogo; l’uomo che dialoga perfino con i carcerieri. Penso anche al sorriso disarmato di Bachelet che si manifestò persino nel momento dell’assassinio; a quella “cordialità mite” che tutti gli amici ricordano in lui e che ha lasciato un segno indelebile anche nei cuori dei figli, come testimoniò il figlio Giovanni in quelle parole di perdono al funerale, parole nelle quali io penso si possa riconoscere simbolicamente il momento della sconfitta del terrorismo di quegli anni tragici. Sono uomini miti non per superficialità di analisi della situazione, né per volontà di starsene in pace, ma per scelta evangelica. In un articolo su “Ricerca” del primo agosto 1947, intitolato Amici di tutti, Bachelet scriveva: «I cattolici combattono, devono combattere il male che è l’unica cosa che non possono amare; ma non possono combattere, essere nemici degli uomini, anche quando questi sono al servizio del male, anche quando combattono la verità, la giustizia, la carità, la Chiesa. ... È certamente questa una delle leggi più singolari e difficili del cattolicesimo: difendere le proprie idee, i propri diritti che sono idee e diritti della Chiesa, ma difenderli amando quelli che combattono per ideali opposti». Ma mi preme sottolineare che questi uomini miti non erano per ciò dei perdenti, perché la mitezza non è necessariamente sconfitta, ma capacità di distinguere l’impegno che si spende da quello che si vende per l’efficacia dell’azione. Dunque non remissivi e perdenti per scelta, ma convinti che i mezzi non sono indifferenti ai fini e che l’efficacia dell’azione non è l’unico criterio di giudizio, come ricorda bene Ardigò citando (a p. 57) la frase che Bachelet gli rivolse proprio la sera prima della morte, in riferimento ad un cinico intervento di un collega: «non si può accettare l’efficacia se questa efficacia significa l’accettazione del machiavellismo». È il tema che ritroviamo anche nel bell’intervento di Ruffilli. 12 Testimoni La gratuità del servizio È la terza sfida che riconosco come pertinente ed urgente per noi. Moro e Bachelet erano due persone capaci di assumere responsabilità anche molto impegnative, ma disponibili a gestirle secondo le logiche di un vero atteggiamento di servizio. Moro fu un uomo potente, ma la sua figura non fu mai quella di un uomo di potere. Di entrambi vale come segno di autenticità la sobrietà di vita che hanno sempre mantenuto per sé e per le famiglie: la politica e gli impegni istituzionali ed ecclesiali non sono stati per loro mezzi per arricchirsi. E questo è un fatto che costituisce sempre un sigillo di garanzia sull’operato di chi riveste incarichi di responsabilità. Un altro elemento, che mi piace sottolineare qui attraverso il ricordo di un gesto di Bachelet, è la capacità di assumere diversi incarichi con grande senso di responsabilità e insieme con quel distacco di chi non si ritiene insostituibile ed è disposto anche a farsi da parte al momento opportuno. È la sua scelta di lasciare la guida dell’AC nel 1973 dopo il primo mandato di presidente dell’associazione rinnovata, nella consapevolezza che il suo ruolo storico di “traghettatore” del cambiamento era concluso. E a chi gli chiedeva perché non continuasse, vista la sua competenza, rispondeva ironicamente: «Sarei troppo bravo!». L’invito a saper fare la propria parte e fare il proprio tempo è un monito irrinunciabile per l’oggi. La gratuità, assunta come modalità fondamentale della propria esistenza cristiana, risplende poi nella loro fine, che diventa l’emblematica manifestazione della loro conformazione al Cristo, che è venuto a dare la vita perché tutti abbiano la vita. Vorrei concludere con un testo impressionante di Bachelet, pronunciato alla seconda assemblea dell’AC nel 1973, che sembra una prefigurazione della sua morte: «Non si vince l’egoismo mostruoso che stronca la vita se con un supplemento d’amore, se non contrapponendogli la capacità di dare la vita per il sostegno e la difesa degli inermi, degli innocenti, di chi vive in una insostenibile situazione di ingiustizia. Non si vince questo nostro egoismo se non riscoprendo il valore di ogni uomo come figlio del Padre che dà la vita. … Ciò è sempre vero, ma lo è particolarmente nei grandi momenti di svolta della civiltà: quando le carte di navigazione costruite dall’esperienza non servono più gran che per un cammino del tutto nuovo, è ancor più necessario orientarsi facendo riferimento alle stelle del cielo». 13 Aldo Moro: passato e presente LUCIANO AZZOLINI R ileggendo i contributi di Achille Ardigò, Pietro Scoppola, Roberto Ruffilli e Paolo Giuntella contenuti nel volume edito dal Margine Aldo Moro e Vittorio Bachelet. Memoria per futuro (Il Margine 2008) riscopri, 25 anni dopo, la ricchezza e la tensione di “filoni culturali” che oggi sembrano desueti, se non del tutto fuori moda. Concetti come “il farsi carico”, l’“ispirazione religiosa”, l’essere “distinti ma non separati”, “la politica non è tutto” accompagnato al “tutto si tiene” sono le chiavi di lettura che ci hanno accompagnato, e se vogliamo anche confortato nelle scelte che ciascuno ha fatto, in questi decenni e che trovano in Moro e in Bachelet il punto più alto di questo pensiero, ancora così ricco anche per il futuro. Questa comunicazione mi obbliga a ricordare soprattutto Aldo Moro. Avendolo avuto come professore e poi per averlo frequentato fino a poche settimane dal suo rapimento mi risulta impossibile non sentirmi emotivamente coinvolto. Difficile separare i diversi momenti, l’esperienza universitaria, i colloqui personali, gli incontri di approfondimento, i consigli. Il ricordo di Moro è una sorta di “impasto” dove – appunto – tutto si tiene. Vorrei solo cercare di distinguere tre momenti: quello più personale, quello legato al perché della sua morte e in infine quello più squisitamente politico. Ragionare nella complessità Conobbi Aldo Moro nella tarda primavera del 1972 alla facoltà di Scienze Politiche a Roma, dove insegnava Diritto e procedura penale. Mi avvicinai a lui con una naturale curiosità, come tanti altri studenti, nel corridoio della facoltà appena terminata la lezione. Subito volle sapere perché dal Trentino ero approdato a Roma, perché avevo scelto quella facoltà, mi chiese della mia famiglia e poi quasi a bruciapelo mi disse: «Ad agosto verrò a trascorrere qualche giorno di vacanza a Bellamonte, vienimi a trovare». Risposi di sì, ma non ci andai. A novembre, mentre entravo in facoltà, lo incrociai quando stava uscendo e mi chiamò per nome: «Luciano, perché non sei venuto a trovarmi a Bellamonte?». Toccato e sorpreso. Ricordava il mio 14 nome pur avendogli parlato una sola volta. Ebbi la prontezza, o forse la sfrontatezza, di dirgli la verità: «Pensavo fosse il solito invito che fanno i politici e che poi se ne fosse dimenticato». Sorrise divertito. Da quel giorno nacque un rapporto che segnò profondamente il mio stile di vita soprattutto riguardo a quei passaggi che in qualche modo ti possono segnare più o meno definitivamente. Moro non era solo un professore che aveva un canale privilegiato con i suoi studenti. Era qualcosa di più profondo che, forse, emerge con più chiarezza se ad esempio ricordiamo il suo “essere” professore universitario. Pur ricoprendo incarichi politici di primo piano non si assentava quasi mai e quando lo faceva lo comunicava una settimana prima e indicava anche la data in cui la lezione sarebbe stata recuperata. Durante i periodi di occupazione, numerosi anche in quel periodo, si preoccupava di recuperare le lezioni perse; in qualche occasione ci siamo ritrovati, perfino, in una saletta attigua alla cappella universitaria. Quando si doveva sostenere l’esame voleva che sullo “statino” venisse indicato se si era frequentanti, non frequentati, fuori sede, fuori corso oppure si stesse svolgendo il servizio militare ecc. ed in base a questa “sua” classificazione determinava l’ordine degli esami. Gli ultimi a sostenere la prova erano gli studenti frequentanti considerati più fortunati e con i quali era sicuramente più esigente. Le sue lezioni non erano certamente semplici, anche se non mancavano acute osservazioni ironiche, il suo ragionare seguiva percorsi complessi quasi si trattasse di dare anima e luce ad una costruzione barocca. Un aspetto fondamentale del suo ragionare era che la complessità in quanto tale non poteva essere semplificata. Non mancava mai di accompagnarci a visitare un carcere, quasi a volerci far toccare con mano cosa accade quando in una persona si rompe l’”equilibrio”, è portata a compiere un atto delittuoso, e come lo Stato debba, attraverso la pena, ricomporre quella frattura, facendo inoltre in modo che quelle condizioni iniziali non debbano ripetersi. Il suo obiettivo, che corrispondeva anche al desiderio intellettuale di capire che cosa noi giovani pensavamo, era quello di fornirci strumenti di lettura della società del contesto in cui eravamo inseriti. Di qui l’iniziativa, a cui lui partecipava sempre, di farci incontrare con persone che nei diversi campi di riflessione ci potevano fornire utili elementi di approfondimento. Ricordo gli incontri con i professori Elia, Andreatta, Mortillaro, Fabiani, Fava e tanti altri. L’ultima volta lo incontrai a Bellamonte nei primi giorni di gennaio del 1978, gli avevo portato uno strudel che aveva preparato mia madre. Non lo avevo mai visto così preoccupato e quasi rassegnato. 15 Chi sparò in via Fani? Chi sparò in via Fani? Questo non è che uno dei tanti buchi neri di quella tremenda tragedia che attende risposta. Attorno all’assassinio di Moro sono state condotte inchieste della magistratura, sono stati scritti molti libri, prodotti film, si è scavato tra le carte, si è cercato nelle possibili prigioni… eppure la sensazione comune è che le risposte finora emerse non convincano, che ci sia ancora una “verità” tutta da scoprire. Come nel caso di altri assassinii (pensiamo a quelli di Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme), ci si è fermati ad un tempo “penultimo”, un tempo che però lascia tutti insoddisfatti. Quel 16 marzo 1978 molti testimoni parlarono di una moto Honda con a bordo due uomini che spararono avendo il volto coperto da passamontagna. Per i brigatisti quella moto non è mai esistita. Per la giustizia è un fatto acclarato con sentenza passata in giudicato. Sono i due specialisti che spararono sulla macchina di Moro uccidendo gli agenti Ricci e Leonardi senza colpire il presidente. Una perizia, durante il processo Moro-quater, ha accertato che in via Fani sparò un numero di armi superiore a quello dichiarati dai brigatisti. Almeno sette: 4 mitra, 2 pistole e un’altra arma che utilizzava proiettili calibro 7,65 parabellum. Ma i Br affermano, invece, che spararono solo in quattro: Bonisoli. Fiore, Gallinari e Morucci. A Bonisoli, però, il mitra si inceppò subito, quello di Morucci «quasi subito». A Gallinari accadde a metà raffica. Fiore ha detto che il suo M12 si inceppò «subito», che sfilò il caricatore e lo sostituì, ma che non partì alcun colpo. Tutti mitra si incepparono. Allora chi sparò quel giorno a Via Fani? La difficile ricerca della verità condotta dentro il mondo del terrorismo italiano ha ormai esaurito i suoi filoni. Probabilmente quello che si poteva sapere si è saputo, anche se non ha fornito elementi sufficienti di convinzione. Quindi è, forse, necessario spostare la riflessione ad un livello diverso, nel contesto internazionale di quel periodo. Nell’amministrazione USA il sentimento anticomunista era molto forte e non si poteva certo facilmente tollerare, ancora in piena guerra fredda, che in un Paese occidentale il PCI potesse accedere alle stanze di governo senza che questo non comportasse un mutamento di linea anche nei confronti degli stessi Stati Uniti. La linea morotea non aveva fatto alcuna breccia alla Casa Bianca. Anzi, era vista con molto sospetto. Contemporaneamente nei paesi dell’Est (pensiamo alla Polonia, all’Ungheria alla Cecoslovacchia) si guarda 16 con interesse a cosa sta accadendo in Italia, e ciò preoccupa non poco Mosca, che rischia di perdere il controllo politico di quei paesi che sognano un’apertura democratica e che vedono nell’esempio italiano la possibilità di coniugare la democrazia con il mercato o meglio con il nemico di sempre, il capitalismo. Come poteva Mosca consentire che il PCI governasse con i nemici democristiani, e per di più senza alcuna spinta rivoluzionaria? Israele, infine, osserva con grande preoccupazione la politica di apertura al mondo arabo condotta da Moro. Insomma un incrocio di interessi di natura diversa, se non opposta, convergevano sulla necessità di porre fine all’esperienza italiana pensata da Aldo Moro. Giovanni Galloni, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e noto leader democristiano molto vicino a Moro, ha recentemente rivelato nuovi particolari sul rapimento di Aldo Moro che confermano l’ipotesi non nuova di un ruolo occulto della CIA e del Mossad in quella vicenda. «Non posso dimenticare un discorso con Moro poche settimane prima del suo rapimento: si discuteva delle BR, delle difficoltà di trovare i covi. E Moro mi disse: “La mia preoccupazione è questa: che io so per certa la notizia che i servizi segreti sia americani che israeliani hanno infiltrati nelle BR, ma noi non siamo stati avvertiti di questo, sennò i covi li avremmo trovati”». «Nei 55 giorni di prigionia di Moro avemmo grandi difficoltà a metterci in contatto con i servizi americani, difficoltà che non incontrammo poi durante il rapimento del generale Dozier». Il generale americano della Nato J.L. Dozier fu rapito dalle BR a Verona il 17 dicembre 1981 e liberato senza colpo ferire con un blitz delle forze speciali dei Nocs il 28 gennaio 1982. Il modo rapido e apparentemente “brillante” con cui fu risolto il caso destò subito forti sospetti sulla possibilità che i rapitori fossero infiltrati dai servizi segreti americani, se non addirittura che la “liberazione” dell’ostaggio fosse stata in qualche modo concordata con i rapitori. Galloni conferma questi sospetti, rivelando una sorta di politica a doppio binario da parte dei servizi segreti USA nei due casi: collaborativa nel caso di Dozier, per nulla collaborativa nel caso del rapimento di Moro. «La minaccia più grande – osserva ancora Galloni – fu fatta a fine settembre 1977 a New York da Kissinger, che chiamò in disparte Moro e gli predisse una cattiva fine se non avesse mutato la sua linea politica, così come Moro riportò (di ritorno dal viaggio in America dove aveva accompagnato, come Ministro degli Esteri, il presidente della Repubblica), a tre persone: alla moglie, a Guerzoni, e a me, in un colloquio privato». 17 Una conferma della preoccupazione espressa da Galloni l’ho avuta direttamente quando incontrai il mio professore a Bellamonte nei primi giorni di gennaio del 1978. Ricordo perfettamente che la sua preoccupazione maggiore era che gli americani, Kissinger in particolare, non comprendevano il disegno politico che stava faticosamente portando avanti e si meravigliava soprattutto del fatto che non valutassero positivamente la via italiana al consolidamento e all’allargamento dell’”area democratica”. Per Moro anche la stagione, per alcuni aspetti estrema, della “solidarietà nazionale” non era, come la intendevano gli USA, una resa ma piuttosto una calcolata scommessa di futuro che dopo la “legittimazione” del PCI avrebbe portato alla “democrazia dell’alternanza”. La fragilità della democrazia Nella riflessione politica di Aldo Moro, e siamo all’ultimo punto di questa mia comunicazione, è centrale l’idea della fragilità della democrazia italiana, che rende impossibili le dinamiche caratteristiche delle democrazie più mature, fondate sui meccanismi della alternanza, e obbliga ad evitare contrapposizioni nette realizzando aggregazioni politiche articolate e complesse. Egli denuncia d’altra parte i pericoli di una «passionalità» e di una irrazionalità latente nel paese che, coniugandosi alla fragilità delle strutture dello Stato, può travolgere la democrazia. L’aggregazione delle forze politiche nelle coalizioni di governo ha, nella sua visione, un obiettivo che va al di là della formazione delle maggioranze parlamentari e di governo, ma investe i fondamenti stessi della democrazia: le assemblee rappresentative sono la sede naturale di una reciproca legittimazione e della maturazione di un comune concetto di democrazia. In definitiva il limite della democrazia italiana – l’impossibilità che essa si muova secondo la logica del ricambio e dell’alternanza – diventa per Moro occasione e talento da valorizzare per il consolidamento della democrazia stessa. Fu così, nell’operosa tessitura del centrosinistra, guadagnato non come rottura rispetto al centrismo degasperiano, ma come prolungamento coerente della lenta fatica di consolidamento dell’“area democratica”. Il partito, nel primo pensiero di Moro deve essere il «punto di passaggio obbligato dalla società allo Stato», l’elemento che «riconduce costantemente lo Stato alla fonte del potere, lo tiene in allarme, lo pone in crisi, lo spinge a controllare in ogni istante la sua giustizia e la sua umanità. La dia- 18 lettica cittadino-Stato – osserva Moro – è ineliminabile. Ma essa si realizza attraverso la mediazione dei partiti, senza la quale la distanza appare incolmabile e risulta impossibile l’equilibrio della libertà individuale e dell’autorità sociale». La sua visione sul ruolo del partito va anche oltre: i partiti non sono solo il momento di sintesi fra società e Stato ma anche «tra la realtà del presente e il futuro». Ma le forti identità partitiche iniziali impallidiscono nei decenni successivi. A seguito dello sviluppo economico, il consumismo, la secolarizzazione che non investe solo il “mondo cattolico”, ma tutte le forme di appartenenza. Con la comparsa del movimenti e l’attuazione di un istituto di democrazia diretta, come il referendum, i partiti cessano di essere gli unici soggetti politici: si pongono le premesse di una più libera e matura partecipazione dei cittadini alla vita politica. Gli italiani maturano a modo loro un senso più forte di cittadinanza, anche se con una accentuazione dei diritti rispetto ai doveri. La riflessione di Moro accompagna questa evoluzione. Moro avverte tutte le ambiguità presenti nella crescita della società italiana: «C’è una sproporzione, una disarmonia, una incoerenza fra società civile, ricca di molteplici espressioni ed articolazioni, e società politica» afferma in un notissimo passo dal discorso del presentazione del suo Governo alle Camere il 3 dicembre 1974; la vita politica gli appare «stanca», «sintesi inadeguata e talvolta persino impotente». Egli vede che la società italiana ha raggiunto un punto di svolta di fronte al quale gli strumenti del passato sono insufficienti. Si apre la sua riflessione sulla “terza fase”. L’espressione viene usata per la prima volta da Moro, con riferimento alla DC e non alla politica italiana nel suo insieme: «l’avvenire – afferma Moro nel discorso al consiglio nazionale della DC del 20 luglio 1975 – non è più in parte nelle nostre mani», è cominciata una «terza difficile fase per la Democrazia cristiana». La terza fase si definisce per l’emergere di nuove dinamiche sociali che hanno messo in crisi il ruolo centrale della Democrazia cristiana nel sistema politico. Ma all’indomani delle elezioni politiche del 1976 la formula “terza fase” assume un più ampio e comprensivo significato: la “terza fase” non è riferita solo alla DC ma investe tutto il sistema. Essa esprime la coscienza di una crisi che esige, come nel 1945, un coinvolgimento dl tutte le energie disponibili. L’iniziativa di Moro, ha notato Roberto Ruffilli, è legata ad un visione complessa del rapporto fra il politico e il sociale che supera ogni pretesa totalizzante della politica. Secondo l’interpretazione di Ruffilli, la terza fase 19 avrebbe avuto due tempi: il primo della solidarietà, necessaria alla legittimazione reciproca fra i due maggiori partiti, la seconda dell’alternanza. La solidarietà nazionale è stata l’ultimo stadio di sviluppo di un sistema politico; al di là di essa doveva necessariamente aprirsi la via di una riforma di sistema. Il periodo successivo, dopo la morte di Moro e la crisi della solidarietà nazionale, registra invece per un lungo tratto un ripiegamento del sistema in un disperato sforzo di autoconservazione. Il processo di riforma si riapre, in un mutato quadro internazionale, negli anni novanta, con un pesante ritardo e con un offuscamento di quel primato della questione morale ben presente a Moro. Non servirebbe forzare il pensiero di Moro per trarne indicazioni sui problemi del presente. La sua opera resta al di là della soglia della riforma istituzionale. «La vera tradizione nelle grandi cose – ha scritto Paul Valéry – non è di rifare ciò che gli altri hanno fatto, ma di ritrovare lo spirito che ha fatto queste grandi cose: ma che farebbe cose diverse in tempi diversi». Il primato della questione morale Ritrovare lo spirito di Moro, io credo, significa anzitutto tornare al primato della questione morale: «Questo paese non si salverà, la grande stagione dei diritti risulterà effimera – disse in un passo famoso del suo discorso al XIII congresso della DC – se non nascerà in Italia un nuovo senso del dovere». Moro non ha mai fomentato l’illusione di una società civile buona contrapposta ad una società politica cattiva; coniugando diritti e senso del dovere ha indicato la via della crescita della cittadinanza democratica. Aldo Moro con il suo pensiero e la sua opera appartiene alla storia della Repubblica, la sua figura è lontana nel tempo e la distanza la rende più grande; ma lo spirito che lo ha animato è ancora un orientamento sicuro, nel presente. «La politica – scriveva – è un fatto di forza, più propriamente di consapevolezza, di fiducia nel proprio compito. Ma ci deve pur essere, più in fondo, una ragione, un fondamento ideale, una finalità umana per i quali ci si costituisce in potere e il potere si esercita. È solo nella accettazione incondizionata di una ragione morale che si sviluppa con coerenza il patrimonio della nostra idealità ed il complesso degli impegni per il nostro tempo». È questa un’interpretazione esigente dell’agire politico, dedotta da quella «intuizione cristiana del mondo» cara ad Aldo Moro. 20 Testimoni Vittorio Bachelet: la nuova coscienza dei laici SITIA SASSUDELLI B achelet non arriva alla presidenza dell’Azione Cattolica per sua scelta. È la risposta a una chiamata di Paolo VI. Egli arriva chiamato nel nome del Signore. Una cosa chiara fin dall’inizio, che nasce nella fede e nell’obbedienza. Ci viene “chiamato”, ma non da fuori. Viene da dentro, da una vita che fin da ragazzo è segnata dalla presenza attiva nell’apostolato. È uno che conosce l’associazione come una realtà che gli è cara e che ha scelto per sé. È stato anche fucino, impegnato al centro nazionale. Ci viene non senza sacrificio, in un periodo che gli sarebbe stato comodo dedicare piuttosto al perfezionamento della sua professione universitaria. Era infatti docente universitario, ma ancora solo incaricato, e in sede molto dislocata… Ed è la sua prima inconsapevole lezione: la Chiesa si serve con disinteresse, in gratuità. Ci arriva con una intelligenza delle cose – le cose del mondo e le cose della Chiesa – particolarmente acuta; ha una formazione umana, culturale, religiosa di grande consistenza. È un credente che ha imparato a “pensare la fede”, un figlio della Chiesa che ha già fatto unità viva dentro di sé tra l’uomo e il cristiano. Ha già un suo stile di vita sobrio e severo, che irradia letizia. Ha fatto una sua esperienza di cristiano che si espone nella vita temporale e di laico che si impegna nella vita ecclesiale. “Scuola Montini”, insomma. È in grazia di questa sua preparazione che viene facilmente riconosciuto autorevole. Come presidente si viene a collocare subito non “sopra” ma “in mezzo”. Non sarà un capo che comanda, né un leader che trascina, ma una guida sicura ed amica che lavora in équipe. Sarà rispettoso e accogliente di tutti, vecchi e nuovi, attento alle diversità, capace di tessere, con la pazienza che occorre, le chiarificazioni necessarie e le intese. Comincia subito col dare 21 fiducia e col chiamare tutti, vecchi e nuovi, a lavorare insieme, con semplicità. Lavorare con lui per l’Azione Cattolica sarà bello e darà gioia. Con la sua cultura e il suo intuito egli sa guardare largo e lontano più di noi, eppure questo non lo tiene isolato: le sue vedute le mette a confronto, i giudizi li mette in comune e li spiega, le proposte le fa motivate; cerca il dialogo non volendo imporsi ma desiderando il consenso libero. È così che un po’ alla volta si viene a creare nell’associazione un sentire comune, una coscienza comune, un’appartenenza reciproca che è già una prima esperienza di comunione. Con la sua presenza, quella che era un’organizzazione di ‘quadri’ diventa un po’ alla volta una rete di persone e di gruppi, dove la passione per la causa non avrà nulla da perdere – anzi! – dalla carica di amicizia che vi saprà immettere. Nella lunga consuetudine di lavoro avuta con lui nella presidenza dell’Azione Cattolica, una delle cose che più mi è rimasta impressa è stato il modo del suo approccio ai problemi dell’associazione. Di qualunque genere fossero, per prima cosa cercava di conoscerli, di definirli, ma mai in astratto; cercava di collocarli nel loro contesto reale (di Chiesa, di cultura, di società); ne cercava la verità nel quadro d’insieme. Ricordo bene come nelle riunioni di Giunta non mancasse mai di premettere all’ordine del giorno una riflessione di largo respiro su quanto stava accadendo. A volte la distanza tra la lunghezza d’onda dei suoi pensieri e la portata oggettiva dell’ordine del giorno saltava agli occhi. E magari qualcuno – un po’ spiccio – si spazientiva. Ma a lungo andare questo insegnò a fare una cosa difficile: ascoltare sempre la realtà, cercare di capirla prima di valutarla, chiamarla col proprio nome, secondo verità. Solo così, dopo, vi si può agire dentro anche con la prospettiva più alta e anche l’azione più piccola può diventare significativa. Mentre ci occupavamo delle nostre piccole cose interne, sentivamo di concorrere al farsi della Chiesa in concreto. Questa scuola di riflessone fu quanto mai provvidenziale in un tempo che già impressionava per l’ampiezza e l’accelerazione delle trasformazioni che si andavano annunciando; essa segnò l’avvio di una presa di coscienza comunitaria della fase storica in corso (erano gli anni del ‘68) e portò a maturare in quel contesto un atteggiamento libero, capace di giudizio e di responsabilità cristiani. Il vecchio motto dell’azione cattolica Preghiera – azione – sacrificio, si trovò di conseguenza arricchito con la parola “studio”, termine che appariva ben inadeguato, ma almeno alludeva a quell’impegno di consapevolezza storica che avevamo assunto. Studio come attenzione, come accettazione della 22 complessità, come discernimento, come serietà di preparazione umana e religiosa, come amore al proprio tempo, come indispensabile mediazione culturale. La grazia del Concilio Ed ora qualche nota sul presidente nel kairòs del Concilio. A un occhio che guardava con quella sua lunghezza d’onda, esso appare subito l’elemento dominante in campo ecclesiale: la Chiesa che in presenza del “mutamento epocale” si interroga seriamente e prende coscienza, come daccapo, di quello che veramente è e lo esprime in modo comprensibile al mondo moderno. Il Concilio ci sorprende come un vento che cambia l’aria, che spinge fuori, in avanti. Le parole nuove che risuonano fanno apparire vecchie d’un colpo tante formule e schemi tradizionali. Viene allo scoperto l’essenziale, il genuino, il semplice, il necessario. Il nudo Vangelo per il nostro tempo. Si leva potente la chiamata alla conversione. Si deve cambiare, la Chiesa comunità deve cambiare. Per fedeltà al Signore e per amore della salvezza di tutti. Noi dobbiamo cambiare. Questo era il clima, straordinario, unico. Questa la grazia. Ricordo che l’Azione Cattolica era in contatto allora con tanti Padri conciliari – alcuni erano anche nostri amici, erano stati nostri assistenti –; essi ci tenevano via via interessati a quel che avveniva. Bachelet era uomo di Chiesa della loro statura e con una passione non inferiore alla loro. Con la differenza che, mentre ad essi incombeva di interpretare collegialmente ciò che lo Spirito dettava alla Chiesa, e trascriverlo, a lui toccava qualcosa di complementare e non meno importante: tradurre il dettato conciliare in una nuova coscienza di laici e in una rinnovata esperienza associativa. Oggi non mi pare stonato guardare a Bachelet come a una specie di padre conciliare laico, mandato a mediare il Concilio non in una diocesi, come i vescovi, ma in quella associazione che aveva rappresentato nella Chiesa una prima e ormai centenaria esperienza di impegno organizzato dei laici. Lo fece insieme all’assistente generale, monsignor Costa, in una intima e intensa collaborazione che rappresentò un esempio straordinario di corresponsabilità, vissuta nello stile di quei “familiari rapporti” tra clero e laici che il Concilio aveva auspicato. 23 La mediazione del concilio comportò dunque rinnovamento: si diceva: “rinnovare l’AC per attuare il concilio”. Occorreva partire da quello che l’Azione Cattolica era, metterla a confronto con quello che avrebbe potuto essere se si fosse lasciata impregnare dallo spirito nuovo, e darsi da fare. Coniugare nova et vetera, con sapienza evangelica. Bachelet aiutò l’associazione a coinvolgersi con entusiasmo. Si dedicarono al concilio tutte le nostre energie. Si studiarono le Costituzioni, nelle diocesi e al centro, nei convegni... una per una. Ricordo che proprio Bachelet ci teneva perché non ci limitassimo al decreto sull’apostolato dei laici, ma anche quello vedessimo nel contesto del grande disegno delle costituzioni, soprattutto la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes. E insisteva perché della Lumen Gentium si sottolineasse quel capitolo V sulla “universale vocazione alla santità”, che conteneva la chiave per entrare correttamente nella nuova ecclesiologia. Quel capitolo ci diede la gioia di vedere finalmente benedetta quella spiritualità laicale che nell’Azione Cattolica si era cominciato a vivere: quella che non si sviluppa “nonostante la condizione secolare” ma proprio all’interno di essa, nel gestire – come è proprio del laico – le realtà temporali ordinandole secondo Dio. Si capì ben presto che per la riforma non sarebbero bastati semplici ritocchi ma occorreva una rigenerazione statutaria. L’impegno del presidente sarà di investire in questa impresa l’associazione tutta: al centro nazionale come nelle diocesi, nei quattro “rami” come nei movimenti. Per anni essa divenne un laboratorio, dove si incrociavano e confluivano apporti diversi: la spinta naturalmente unitaria dei presidenti diocesani e la genialità collaudata dei rami, il carisma degli assistenti e la creatività dei laici, uomini e donne, la buona tradizione degli adulti e le attese dei giovani. Si fanno progetti e si mettono a confronto. Bachelet promuove, incoraggia, discute, compone: è un grande moderatore, nel senso alto del termine. Soprattutto vigila perché del Concilio siano recepite le istanze più profonde. Alla fine, il suo pensiero fluisce, limpido e forte, come sintesi del pensiero di tutta l’associazione, nella premessa dello Statuto. Là troviamo segnata per sempre come fu la prima recezione del Concilio in casa nostra. Ricordo che i cambiamenti che si fecero avvennero sempre per scelte chiare; e l’accento della scelta non fu su quel che si lasciava perdere (ciò avrebbe significato ridurre, diminuire) ma su quello che si voleva acquisire in una logica di crescita e di superamento. Ciò diede alla riforma una tensione tutta costruttiva. Per esempio la scelta religiosa non fu il tirarsi indietro da responsabilità proprie dei laici nell’ambito temporale, ma il liberare 24 Testimoni l’associazione come tale da supplenze e interventi impropri, e il concentrare le energie sulla ben più impegnativa opera di formazione nei soci di una coscienza cristiana all’altezza dei tempi. Perché diventava sempre più chiaro che quel che conta è la qualità cristiana del proprio essere, senza la quale non vi è testimonianza né apostolato né presenza di Chiesa. E quello che anche allora occorreva non era tanto la pressione sociale di opere cattoliche quanto la testimonianza credibile di cristiani che vivano in sé le due cittadinanze, la civile e l’ecclesiale, in una vita coerente. Credere nello Spirito In un momento critico della nostra storia, Bachelet osò credere che lo Spirito liberato dal Concilio potesse rianimare e trasformare l’Azione Cattolica, e questa ne potesse diventare suo umile efficace strumento. Questo fu il suo sogno e la sua fatica. Questa è l’eredità che ci ha lasciato. Ma al di là di questo, nella sua presidenza, Vittorio Bachelet ci ha fatto dono della sua persona, della sua umanità e della sua fede contagiosa. Abbiamo visto vivere un uomo davvero evangelico, l’abbiamo visto camminare sulle nostre strade, in totale aderenza alle stringenti esigenze della vita, attento a fare saggiamente gerarchia di valori, e insieme attento a custodire nel cuore l’amore al Signore, cercato in queste cose e al di là di queste cose. L’abbiamo visto lavorare e gioire, pensare e pregare, incontrare persone di ogni tipo. A sprazzi abbiamo intuito la sua esperienza di croce, di cui lasciava vedere solo il risvolto della pazienza sorridente e della speranza tenace. L’abbiamo conosciuto amico, fratello, maestro, interlocutore franco e pacifico. Ci è stato tolto violentemente e oggi ci manca – lo sentiamo bene: ma noi possiamo nel suo nome continuare a procedere per il cammino che egli ha fatto per primo. Pietro Scoppola, un cattolico “a modo suo” FRANCESCO GHIA «I libri», mi spiegava tempo fa un amico bibliofilo, «si dividono per me in due categorie: quelli da leggere e quelli da ri-leggere». Dopo aver letto il bellissimo libretto Un cattolico a modo suo, giustamente definito, sul retro di copertina, il “testamento spirituale” di Pietro Scoppola1, mi permetterei, sommessamente, di aggiungere, a quella dei libri “da rileggere”, una sotto-categoria, i libri cioè da rileggere partendo dal fondo. Ci sono opere infatti che, se rilette a partire dalle pagine conclusive, acquistano una luce particolare, più vivida, quasi una sorta di chiave di lettura che dischiude mondi nuovi, inediti, eppure già contenuti tra le pieghe dello scritto fin dalle sue battute iniziali. Come non rimanere suggestionati, per esempio, di fronte al conclusivo The rest is silence dell’Amleto shakespeariano pensando che, forse, in quel silenzio che resta vi è la cifra risolutiva dell’intero dramma del personaggio, del suo permanere da ultimo un enigma a se stesso, della sua impossibilità di articolare la lacerazione interiore in parola? Come non vedere nelle finali stelle dantesche lo spiraglio di luce che può forse rendere meno oscura la selva iniziale in cui il poeta aveva disperatamente smarrito la via? In silentio et in spe E allora proviamo, partendo dal fondo, a “rileggere” questo prezioso libretto di Scoppola. E precisamente a partire dall’ultimo paragrafo, intitolato Silenzio. Lascio la parola all’Autore: 1 25 P. Scoppola, Un cattolico a modo suo, Premessa di G. Tognon, Morcelliana, Brescia 2008. Scoppola, che era nato il 14 dicembre 1926, è morto il 25 ottobre 2007, poche settimane dopo aver consegnato questo libretto di 126 pagine all’editore. 26 «Immaginavo di avere infinite cose da scrivere e che i pensieri bianchi non finissero mai. Registrerò ancora pensieri. Se verranno. Ma non voglio che queste pagine diventino lo spazio del lamento… Sarà meglio in quel caso la preghiera e il silenzio: “Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui” (Salmo 37,7). Queste pagine si chiudono così senza formalità, ancora sul piccolo computer bianco, al termine di quest’estate un po’ triste. In fondo uno sprazzo di luce, un motivo di impegno che mi ha tenuto vivo in questi mesi sono state proprio queste note, queste pagine bianche, questi pensieri aperti» (pp. 125-126). Lo intuiamo subito: si tratta di parole scritte dall’Autore avendo di fronte la morte che si fa strada ogni giorno per effetto della malattia che consunge, parole che, nella forma autobiografica per eccellenza, quella della confessione del cuore, inverano il senso profondo del melete tou thanatou, della cura e della meditazione del morire che nel Fedone platonico è individuata come la pratica più veracemente autentica dell’essenza del filosofare. Si può affermare che quasi ogni riga del libro lasci trasparire questo orizzonte finale, ultimo, la consapevolezza inconfessata che chi scrive quelle righe non avrà la ventura di leggerle pubblicate a stampa… Il paragrafo immediatamente precedente a quello intitolato Silenzio reca il titolo, jobico come pochi, L’assurdo (il nome di Giobbe viene non a caso evocato tre righe prima: «mi aggrappo a Giobbe e alla sua fede e chiedo al Signore di liberarmi dalla tentazione di cedere alla logica dell’assurdo», p. 124). Risuona in esso, lacerante, la domanda che più sconcerta la coscienza di fronte al mistero apparentemente, fenomenicamente iniquo del limite umano: perché? «Ma non è assurdo – si chiede (ci chiede) Scoppola – andarsene così per un grumo di cellule impazzite che dall’interno ti invadono e ti distruggono l’organismo? Non ho avuto una vita avventurosa; eppure ho traversato momenti difficili: la guerra; ho visto cadere le bombe a poca distanza; ho visto le camionette tedesche che facevano le retate per portare via i giovani atti al lavoro; ho vissuto quasi in prima fila gli anni Settanta; mi hanno messo una bomba sotto la macchina e mi hanno minacciato. E adesso un grumo delle mie cellule deve fare quello che non hanno fatto le bombe americane, le retate tedesche, i bombaroli degli anni Settanta… Perché? Non c’è nessuna ragione plausibile se non questa logica stringente e inesorabile per cui la realtà abbandonata alle sue leggi se ne va lungo una strada di cui ci sfugge la direzione, il senso e il punto di arrivo» (pp. 124-125). Non c’è nessun indulgere, nelle parole di Scoppola, né alla tentazione della autocommiserazione rabbiosa e disperata, né a un banale irenismo con- 27 solatorio: neppure la fede, su cui Scoppola ha riflettuto intensamente sia sotto il profilo scientifico, da storico, sia sotto quello individuale2 (si pensi anche solo all’importanza che assume, nella sua opera, il sintagma “libertà e coscienza religiosa”3), offre a questo riguardo un alibi per potersi sottrarre al compito di fare i conti con l’assurdo della condizione umana: «Penso che il fatto di credere, di avere una visione escatologica, non ci esoneri affatto dalla condizione umana e quindi dal condividere il senso dell’assurdo che è intorno a noi. Quando poi questo assurdo ci investe nelle nostre carni… Eppure con l’assurdo dobbiamo misurarci, dargli un senso, dominarlo: anche l’assurdo fa parte della realtà» (p. 125). De nobis ipsis silemus: la parola famosa della Instauratio magna di Francis Bacon, chiamata da Kant a “vegliare” sulla sua prima Critica e scelta da Gadamer come epigrafe per la sua autobiografia, potrebbe altrettanto bene stare a suggello di questo testamento spirituale scoppoliano. È un libro che muove dalla vita vissuta, dal bios, ma non è un’autobiografia nel senso classico del termine, appesantita cioè da quella autoreferenzialità spesso urtante che troppo facilmente evoca nel lettore l’insofferenza pascaliana per il moi haïssable. No, i pensieri che Scoppola consegna coram morte sono effettivamente “pensieri aperti” o “bianchi”, come suonava il titolo originariamente pensato dall’Autore per le sue meditazioni. “Aperti” o “bianchi” in quanto chiedono al lettore un intervento attivo, l’impegno a continuarli, a re-interpretarli rinnovandoli4. Sono pensieri che, guardando al passato, si aprono in avanti, verso il futuro. Un futuro che l’Autore sa di non poter più contribuire personalmente a costruire, ma per il quale professa ancora tutta la sua passione. 2 «Il mio credere, senza negare nulla della dottrina tradizionale, si poneva su un terreno diverso: non era la conclusione di una prova, ma il frutto di una scelta motivata e consapevole, quella dell’appartenenza appunto e dello stare liberamente dentro una grande corrente di fede. Dicevo: non ci sono prove, c’è una scelta che ha una sua razionalità e un suo fondamento ma che resta una scelta. Questo non comporta un minore impegno, comporta anche il senso di un rischio, o, con Pascal, di un ‘pari’, di una scommessa» (p. 56). 3 Si veda per esempio P. Scoppola, Coscienza religiosa e democrazia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna 1966. 4 Se ne può avere testimonianza anche solo scorrendo, ad oculos, i titoli dei capitoletti di questo libro: “Una conferenza a Bose”; “Qualche ricordo”; “La storia come ricerca d’identità”; “Un modo di credere”; “Nella Chiesa”; “Fede e ragione”; “Il ritorno della religione”; “Laicità”; “Democrazia e verità”; “Maschio e femmina”; “Novissimi”; “Sacrificio e riscatto”; “Un confronto tra generazioni”; “Pensieri aperti”. 28 La passione della speranza, che può dare un parziale, primo e sempre provvisorio senso all’assurdo… “A modo suo”. Il modernistico “senso religioso” Perché allora – ci si potrebbe chiedere – non mantenere il titolo originariamente pensato? Perché intitolarlo Un cattolico a modo suo? In apparenza Scoppola, con estrema finezza e discrezione, sembra dare di questo titolo una spiegazione del tutto occasionale. Si ha ragione tuttavia di ritenere che il titolo sia tanto poco occasionale da potersi vedere raccolto in esso il significato profondissimo di questo volumetto. Cerchiamo di capire perché. Il titolo ha un antefatto, che Scoppola spiega sobriamente. Nel 1974 Scoppola aveva reso pubblica la sua presa di posizione per il no al referendum sul divorzio, in aperto contrasto con le indicazioni della Chiesa italiana. La rivista “Coscienza” aveva quindi pubblicato una sua conferenza sul pluralismo in cui Scoppola criticava la posizione delle gerarchie ecclesiastiche e per questo era stato duramente attaccato dall’“Osservatore Romano”. Poiché nel frattempo Scoppola era stato invitato a far parte del Comitato promotore del convegno ecclesiale Evangelizzazione e promozione umana, Scoppola decide, «per non creare difficoltà con la mia presenza» (p. 47), di rassegnare le dimissione dal Comitato, ricevendo però dal segretario della CEI mons. Enrico Bartoletti, un vescovo di sincera fedeltà al Concilio, l’invito ad aspettare: «Mons. Bartoletti – spiega Scoppola – voleva sentire il Papa. Mi convocò al mattino prestissimo in Circonvallazione Aurelia, sede della CEI, e mi dette la decisione di Paolo VI, in sostanza in questi termini: Scoppola è un cattolico un po’ a modo suo, ma è bene che rimanga. Fui felice di quella risposta e anche della motivazione, rimasi nel comitato e partecipai attivamente al convegno. Un “cattolico a modo suo”, detto dal Papa, era il massimo che potessi desiderare» (p. 47). Certo, con un po’ di malizia si potrebbe obiettare che l’espressione «cattolico un po’ a modo suo» è tutta montiniana, non priva anche di amletica ambiguità. Ma difficilmente si negherà che riconoscere, se pure solo a denti stretti, la legittimità di una posizione cattolica sui generis significa riconoscere la legittimità di un approccio individuale alla sostanza dell’“essere cattolico”, un approccio cioè non pigramente uniformato, ma fedele – nel- 29 fedele – nello spirito della obbedienza autentica, ovvero un’obbedienza non prona, ma “in piedi”5 – al dettato della coscienza. Riconoscere la legittimità dell’essere cattolico “a modo suo” (sui generis, iuxta naturam suam) significa allora riconoscere lo spazio all’autonomia, nelle scelte dirimenti, della coscienza religiosa, significa legittimare, nel singolo individuo, lo spazio di un “senso religioso”. Ora, se consideriamo che proprio sul tema della legittimità di un “senso religioso” nella coscienza del credente si appuntava la critica più feroce della Pascendi contro il modernismo6, si potrebbe persino osare l’interpretazione di quell’“a modo suo” come una sorta di attualizzazione del concetto “modernistico” (ma di chiara ascendenza idealistica, si pensi, per non fare che due esempi, a Schleiermacher e Fichte) di senso religioso. Probabilmente a Scoppola, raffinato interprete della “crisi modernista”7, non sarebbe dispiaciuta troppo una lettura di questo suo ultimo libro come un libro “modernista” costruito attorno all’evocazione potente della centralità del senso religioso. Senso religioso per definire il quale possiamo senz’altro avvalerci delle seguenti parole di Giovanni Battista Montini, involontario artefice del titolo del libro: «Il senso religioso indica l’aspetto soggettivo del fatto religioso, la disposizione dell’anima a intuire ed a cercare Dio, a trattare con Lui, a credere, a pregare, ad amare Dio, ad avvertire il carattere sacro delle cose o delle persone, a connettere una responsabilità trascendente all’operare umano. Dà in concreto la misura di quanto un soggetto umano, e non soltanto la natura umana considerata in astratto, sia “capax Dei”, capace di Dio»8. 5 «Occorre vivere una “obbedienza in piedi”, secondo la bella immagine di Fonsegrive ripresa tante volte da don Mazzolari. Obbedire in piedi vuol dire con una partecipazione diretta; Fonsegrive diceva “obbedire in piedi per servire meglio”. Non obbedire passivamente, in ginocchio, con senso di sudditanza. Non sudditi ma cittadini della Chiesa» (p. 62). 6 Nel modernismo, la Pascendi dominici gregis di Pio X vedeva come condannabile quam maxime l’affermazione secondo cui «Revelatio nihil aliud esse potuit quam acquisita ab homine suae ad Deum relationis conscientia» («la Rivelazione non poté essere altro che la coscienza acquisita dell’uomo della sua relazione con Dio»): cfr. H. Denziger, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcinone – Friburgi Br. – Romae 196030, n. 2020. 7 P. Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, Il Mulino, Bologna 1961. 8 G. B. Montini, Sul senso religioso, Lettera pastorale all’arcidiocesi ambrosiana per la santa Quaresima dell’anno del Signore MCMLVII, in “Rivista diocesana milanese”, 46 (marzo 1957), pp. 95-118, qui p. 98. Sul tema si veda G. Moretto, “Quel tanto di discussione filosofica, di cui l’anima moderna ha bisogno, per ritornare religiosa”. Giovanni Battista Montini e la pedagogia del senso religioso, in id., Figure del senso religioso, Morcelliana, Brescia 2001, pp. 19-49. 30 Oltrefrontiera Cambogia, la tragedia e la memoria VINCENZO PASSERINI O bbedivano agli ordini, lavoravano per il bene comune, erano spinti dalla sete di giustizia per i più miserabili del loro popolo. Così si raccontano i leaders dei Khmer Rossi che stanno sfilando davanti al Tribunale internazionale che li sta processando. È cominciata a Phnom Penh la “Norimberga del comunismo cambogiano”. Il feroce regime dei Khmer Rossi, guidato da Pol Pot, si instaurò nell’aprile del 1975 e cadde tra la fine del 1978 e l’inizio del 1979 per mano del Vietnam, che invase il paese e instaurò un nuovo governo. Tre anni, otto mesi, venti giorni: tanto durò il lucido e sanguinario “esperimento” che costò la vita a 1 milione e 700 mila cambogiani, un terzo della popolazione. Uno dei crimini più spaventosi del Novecento. Un genocidio, non etnico, razziale o religioso, ma politico. Giunge tardiva e contraddittoria la “Norimberga cambogiana”. Ma per i parenti delle vittime, e per tutti coloro che hanno assistito con disgusto all’impunità garantita in tutti questi anni ai responsabili del regime, è “meglio tardi che mai”. Davanti ai giudici stanno sfilando un pugno di imputati eccellenti. Il più importante, Pol Pot, è però morto dieci anni fa, nel suo letto. Sono distinti, cortesi questi imputati («Ho forse la faccia di un criminale?», ha chiesto ironicamente uno di loro a un giornalista riprendendo un’analoga battuta attribuita a Pol Pot). Sono personaggi tutt’altro che mediocri. Colti, intellettuali marxisti per lo più con ottimi studi alle spalle, magari alla Sorbona. Personaggi complessi, anche sofisticati. Chi si immagina dei folli, dei tirannelli sanguinari da “terzo mondo” o degli esecutori senza coscienza è fuori strada. C’è molto Oriente millenario nelle loro personalità, molta tradizione cambogiana, sia nello stile che nell’ideologia. Ma c’è in loro anche molta più Europa di quanto non si creda, molta cultura e mitologia politica europea. Non per niente i più importanti di loro hanno studiato nella Parigi degli anni 31 cinquanta, frequentandone i circoli marxisti allora di moda nell’intellettualità occidentale e tra le nuove élite anticolonialiste africane e asiatiche. Nelle loro risposte e nei loro atteggiamenti c’è soprattutto un terribile già visto, già sentito che per noi europei rimanda in particolare alle storie e alle parole di coloro che furono chiamati a rispondere dei crimini nazisti: obbedivano agli ordini, lavoravano per un grande progetto di rinnovamento politico e umano. Erano anche colti, distinti e cortesi. Amavano Bach e Beethoven. Non avevano certo la faccia di criminali. Non uccidevano per il gusto di uccidere. Questo terribile già visto, già sentito fa assumere al dramma cambogiano, pur così orientale e così comunista, cioè così particolare, i connotati di una perdurante tragedia universale, insieme politica ed esistenziale, che angosciosamente si rinnova. Ed è la tragedia dell’uomo che non impara niente dalla storia e che deve fare i conti, ogni volta come se fosse la prima volta, con il male che è dentro di lui. E non solo con il male puramente egoista o distruttivo annidato nel profondo sia dell’individuo che del corpo sociale e che balza fuori in determinate circostanze. Ma anche con il male più terribile, più subdolo e seduttivo, quello cioè che assume il volto del bene: il bene come ricerca della giustizia, dell’uguaglianza, della libertà, del miglioramento delle condizioni umane, della lotta contro il “male” stesso. Questo angelo-demone vuole perseguire un alto obiettivo umano distruggendo pezzi di umanità (anche i responsabili della morte di migliaia di desaparecidos in Argentina lavoravano, negli stessi anni, per un progetto di “civiltà” che passava per la lucida distruzione di un pezzo di umanità). Ci vorrebbe un Dostoevskij per descrivere quanto successo in Cambogia, il processo in corso, la natura angelico-diabolica di quel regime, le personalità così complesse dei suoi capi, l’intreccio così perverso ma per nulla strano tra bene e male che esse rivelano. Ma se lui fosse qui, forse ci direbbe: io queste cose le ho già analizzate e raccontate nei miei libri, dovrei ripetermi, e comunque li avete i grandi scrittori che potrebbero dedicarsi a quest’opera se non si occupassero d’altro. Gli imputati al processo Il processo di Phnom Penh è ancora alle fasi preliminari. Verso la fine dell’anno dovremmo entrare nel vivo del dibattimento. Insieme all’individuazione delle colpe di ciascun imputato, che è l’obiettivo inevitabile del 32 processo, gli interrogatori, le testimonianze e la documentazione prodotta ci diranno ancora molto sulla natura del regime cambogiano, anche se moltissimo già si sa, almeno per chi ha voluto sapere e non si è girato dall’altra parte in tutti questi anni (hanno ragione coloro che accusano la sinistra storica mondiale e italiana di aver fatto tardi e male i conti con la lezione cambogiana; ancor oggi è disdicevole in certo ambienti occuparsi di questo tema, e l’esigua produzione editoriale italiana sull’argomento ne è un inequivocabile segnale). Gli imputati sono cinque, almeno finora. “Duch” (Kaing Khek Iev), insegnante, 66 anni, capo di “S-21”, la prigione di Tuol Seng, un ex-liceo della capitale (oggi sede del Museo del Genocidio), il più importante centro di detenzione del paese dove furono ammazzate non meno di 14.000 persone e altre migliaia torturate; personaggio rigoroso, austero, inflessibile, era un giovane inquisitore e carnefice animato dalla volontà di costruire una Cambogia senza più ingiustizie; la prigione che dirigeva era organizzatissima, e tutto, ogni momento della vita e della morte, era attentamente pianificato, studiato nel dettaglio, classificato, e oggi noi ne possiamo conoscere ogni aspetto grazie all’abbondante documentazione che i Khmer Rossi non hanno avuto il tempo di distruggere. Duch si è poi convertito al cristianesimo; arrestato nel 1999 sta raccontando molte cose, dopo aver rilasciato anche lunghe interviste a giornalisti stranieri. Khieu Samphan, 77 anni, giovane austero e impegnato per la causa dei poveri, laurea alla Facoltà di diritto alla Sorbona con una tesi su L’economia della Cambogia e i suoi progetti di modernizzazione dove si prefiguravano i tratti del futuro regime dei Khmer Rossi: necessità dell’autarchia più completa, cioè dell’isolamento totale sia economico che politico del paese, eliminazione della borghesia e degli intellettuali formatisi sotto l’influenza occidentale, eliminazione della proprietà fondiaria, collettivizzazione assoluta, esaltazione della vita contadina e dei suoi legami di mutuo aiuto, costruzione di una nuova generazione. Tra i fondatori dei Khmer Rossi, fama di politico incorruttibile ma che faceva giustiziare le sue vittime dopo averle invitate a cena, capo di Stato dal 1976 al 1979, Samphan ha rappresentato poi i Khmer Rossi nelle sedi internazionali e ha vissuto in benestante libertà nel suo paese, protetto dal capo del governo Hun Sen, fino al novembre 2007 quando è stato arrestato; il suo avvocato difensore è Jacques Vergès, personaggio non meno multiforme e inquietante, partigiano e intellettuale comunista franco-vietnamita, amico di Pol Pot fin dagli anni parigini (ha passato la vita a difendere tutto e il contrario di tutto: gli indipendentisti algerini, il nazista Klaus Barbie, il terrorista venezuelano Carlos, alcuni 33 nazista Klaus Barbie, il terrorista venezuelano Carlos, alcuni serial killer, alcuni poveri diavoli senza soldi, e poi Slobodan Milosevic...). Nuon Chea, 85 anni, giurista, studi a Bangkok, ideologo, capo della sicurezza e della propaganda, per un certo tempo anche capo del governo, braccio destro di Pol Pot, responsabile delle principali spietate “purghe” di stampo staliniano contro i nemici interni, mandante di molte esecuzioni di massa, coniava neologismi (proprio come accade in 1984 di Orwell, che non aveva letto) e cancellava dall’uso comune altre parole: distruggeva parole e persone per creare nuove parole e nuove persone; è stato arrestato nel settembre 2007 dopo aver vissuto sempre in benestante libertà. Ieng Sary, 84 anni, ministro degli esteri, compagno della prima ora di Pol Pot fin dalle frequentazioni culturali e politiche a Parigi, tra i fondatori del Partito comunista cambogiano, ha sposato la sorella della prima moglie di Pol Pot, è stato arrestato nel novembre del 2007 dopo aver vissuto sempre in benestante libertà a Phonm Penh. Ieng Thirith, 68 anni, moglie di Ieng Sary e sorella della prima moglie di Pol Pot, ministro per i problemi sociali, è stata arrestata col marito nel novembre del 2007 dopo aver vissuto con lui in benestante libertà a Phnom Penh. Un altro illustre imputato, Mok, uno dei principali capi militari, arrestato nel 1999, è morto in carcere nel 2006. Lo sterminio per ripartire da zero Tra gli imputati non ci sarà, come detto, il massimo responsabile del regime, Pol Pot, il cui vero nome era Saloth Sar. È morto proprio dieci anni fa, il 15 aprile del 1998, a settantatré anni. Si è spento nel suo letto. Figlio di una famiglia contadina benestante, scuola elementare dai missionari cattolici francesi, noviziato buddista, studente poco brillante, Saloth Sar consegue un brevetto di studi tecnici (carpenteria), ma riesce a ottenere con altri venti studenti il raro privilegio di una borsa di studio a Parigi messa in palio dal giovane re Norodom Sihanouk. Nella capitale francese, dove arriva nell’ottobre del 1949, frequenta una scuola di radio-elettronica, non la Sorbona come altri. Partecipa alle riunioni del circolo progressista degli studenti cambogiani che discutono su come liberare il paese dal colonialismo francese. Non sono ancora marxisti, lo diventano. Per i giovani cambogiani il Partito comunista francese, su posizioni staliniane, si rivela il solo faro an- 34 ticolonialista (qui si aprirebbe una interessante riflessione su come molti giovani africani e asiatici che studiavano in Europa e che avrebbero guidato nei loro paesi le lotte di indipendenza dal colonialismo europeo trovassero solo nel comunismo una chiave di lettura, un metodo di lotta, un obiettivo di riscatto politico ed economico per i loro popoli; questi strumenti indispensabili non li trovarono, perché non c’erano, né nella cultura politica cattolica, né in quella liberale o socialdemocratica, né tantomeno nella Chiesa ancora strettamente legata al potere coloniale; non era semplicemente presa in considerazione, invece, la lotta nonviolenta di Gandhi che aveva portarto l’India alla liberazione dal colonialismo inglese). Salot Sar, il futuro Pol Pot, frequenta i circoli del Partito comunista francese di Thorez, Eluard, Aragon, Sartre, Picasso. Più che dagli obbligatori testi classici del marxismo-leninismo, è affascinato da Stalin ma anche dalla Rivoluzione francese e dal suo Terrore, in particolare dall’interpretazione che ne diede il principe e rivoluzionario russo Kropotkin: la nuova società può nascere solo dalla campagna, non dalla corrotta città; il riformatore sociale deve anzitutto distruggere il vecchio mondo con i suoi legami di autorità, e ciò libererà finalmente le tendenze naturali alla cooperazione, al mutuo aiuto insite nell’uomo: il compito del rivoluzionario è distruggere, il nuovo sarà costruito dal popolo liberato. Dopo tre anni di permanenza a Parigi, Salot Sar torna in Cambogia proprio mentre il Paese ottiene l’indipendenza totale dalla Francia e la famiglia reale Sihanouk assume il controllo. Insegna storia e letteratura francese in una scuola privata. Nel 1963 è eletto segretario centrale del clandestino Partito cambogiano dei lavoratori, futuro nucleo di quello comunista, e si aggrega alla guerriglia. Il capo è lui anche se si tiene nell’ombra. Diventano celebri il suo sorriso, i suoi modi straordinariamente affabili con cui tratta gli interlocutori, il suo eloquio suadente dal fascino irresistibile. Il partito attacca il “revisionismo” sovietico di Krusciov e riafferma il ruolo della rivoluzione violenta verso il socialismo che sarà guidata dall’alleanza contadini-intellettuali. La subalternità rispetto ai vietnamiti comunisti, che combattono contro gli americani, è mal tollerata. Riemerge l’atavico conflitto tra Cambogia e Vietnam. Si rafforzano i legami, ideologici, politici ed economici con Mao e la Cina, che sarà la protettrice dei Khmer Rossi fino alla fine, soprattutto in funzione antisovietica. Nei primi anni Settanta si intensifica la guerriglia dopo il colpo di Stato dell’impresentabile generale Lon Nol che, con l’aiuto degli americani, ha cacciato il re Sihanouk, personaggio dalle mille vite e dalle mille bandiere. 35 Nelle zone occupate (due milioni di abitanti, un terzo della popolazione) i Khmer Rossi cominciano ad attuare la loro rivoluzione, il loro “esperimento” comunista, sapientemente propagandato ma in realtà poco conosciuto data l’impenetrabile cortina dietro cui si cela, e raccolgono sempre più consensi, interni e internazionali, soprattutto dopo i terribili bombardamenti americani sulla Cambogia. Ma un numero crescente di abitanti dei villaggi “liberati” dai Khmer Rossi fugge e racconta di spaventose oppressioni ed esecuzioni. Un antropologo francese, Francois Bizot, alla fine del 1971 è detenuto in prigionia per tre mesi dai Khmer Rossi nella giungla. Il suo inquisitore è Duch, il futuro comandante della famigerata prigione-lager di Phnom Penh, che lo sottopone a lunghi interrogatori ma che si intrattiene con lui anche in vivaci discussioni politiche e che alla fine lo giudica innocente e incredibilmente lo libera. Bizot racconterà in un bellissimo libro (Il cancello, vedi nota bibliografica) i suoi terribili mesi nella foresta, il sistema di terrore instaurato dai “liberatori”, e di come fosse rimasta inascoltata la sua verità sulla reale natura della rivoluzione dei Khmer Rossi e dell’assurdo credito che invece questi avevano presso molti intellettuali occidentali. Il 17 aprile 1975 i guerriglieri conquistano la capitale Phnom Penh e si instaurano al potere. Subito dopo ordinano l’evacuazione completa della città. Un esodo allucinante di due milioni e mezzo di persone. La città è il luogo della corruzione occidentale e borghese, deve essere svuotata, annichilita, la popolazione deportata nelle campagne per essere rieducata. Tutte le proprietà, anche gli oggetti personali, devono essere abbandonati. Ci sono massacri ed esecuzioni. Stesso destino per le altre città. Il 17 aprile diventa il “giorno primo” della nuova era. Comincia una storia nuova. Svuotate le città, la popolazione è dislocata nei villaggi agricoli, in condizioni spesso difficilissime. È divisa in due categorie: il popolo vecchio (i contadini che da sempre vivevano in campagna) e il popolo nuovo (i deportati). Il primo ora ha tutto, il secondo nulla, neanche la speranza di vivere. I deportati sono passati al vaglio uno ad uno dagli inquisitori per individuare i “nemici” da eliminare. Bastava avere un minimo di istruzione, una certa parentela, aver svolto un determinato lavoro ma anche solo pronunciato una qualche parola “pericolosa” per essere individuati come nemici ed uccisi. Tutti sono potenzialmente nemici. Le esecuzioni sono continue. Molti muoiono di fame, malattie, torture, lavoro disumano. I contadini, da sempre i più poveri ed oppressi, ora hanno il primo posto nella gerarchia sociale. E con loro i bambini e i giovani che devono essere liberati da tutti i legami precedenti (familiari, educativi, sociali, religiosi) per farne il nucleo del popolo davvero nuovo. I bambini 36 devono chiamare i loro genitori “zio” e “zia”, così come gli altri adulti. A volte sono coinvolti come inquisitori nei processi contro i loro genitori, nonni, parenti. A volte devono uccidere. Il linguaggio è epurato e reinventato. Nuon Chea, il capo della sicurezza e della propaganda, oggi sotto processo, proibisce un certo numero di parole, come “bellezza” o “benessere”, perché i pensieri pericolosi, cioè borghesi, spariscono se spariscono le parole che li esprimono. La proprietà privata è abolita, e così il mercato. È abolito anche il denaro. Nessuna rivoluzione era giunta a tanto. Cucine e mense comuni nei villaggi. Anche ogni pensiero individuale deve essere distrutto. La costruzione della nuova personalità passa attraverso il duro lavoro nei campi, cui tutti, nessuno escluso, devono essere soggetti; e poi attraverso la fame e il poco sonno. Indebolito così l’individuo, si possono seminare in lui i valori rivoluzionari. L’“io” deve essere sostituito dal “noi”. I matrimoni non sono affari privati ma dello Stato. La religione cancellata. I centri buddhisti demoliti o trasformati in magazzini. I monaci, “parassiti”, mandati nei campi. Il Partito comunista cambogiano emana in continuazione direttive sul ruolo decisivo della repressione violenta per distruggere sul nascere ogni avvisaglia controrivoluzionaria. I “nemici interni” sono i peggiori e vanno eliminati. Nel carcere “S-21” diretto da Duch arrivano nella primavera del 1977 almeno mille prigionieri al mese. Si tortura, si estorcono confessioni, si uccide, soprattutto battendo a morte con i bastoni i prigionieri. Nei villaggi aumentano le esecuzioni decise sul posto. Lo sterminio di una parte della popolazione è la condizione per ripartire da zero e costruire un popolo nuovo salvando l’unico nucleo puro, quello dei contadini. La propaganda del regime diffonde però ben altre immagini del tragico “esperimento”. Pol Pot esalta l’“originalità” della rivoluzione cambogiana rispetto ai vecchi modelli di comunismo, i suoi successi economici (del tutto inesistenti), il recupero di forme antiche di vita comunitaria rurale. La nuova Cambogia è vista nel mondo con non poche simpatie, non solo dai governi amici. Ieng Sary, ministro degli esteri, oggi sotto processo, afferma in quegli anni: «Noi desideriamo realizzare qualcosa che non si è mai verificato prima nella storia». Ma nessun giornalista straniero è ammesso nel paese, chiuso nella più impenetrabile segretezza, rotta però dalle testimonianze agghiaccianti di missionari, giornalisti, singole personalità, e soprattutto di migliaia di profughi che sono riusciti a fuggire e raccontano gli orrori visti e subiti. Ma molti non li ascoltano, tra cui tanti intellettuali di sinistra ancora affascinati dal- 37 l’“originalità” della rivoluzione cambogiana. Un fascino duro a morire. Poi arriveranno i pentimenti (come nel caso di Tiziano Terzani). Si ripropone la tragedia dei lager nazisti: molti dissero “non sapevamo”, ma si sapevano molte cose. Bisognava essere però disponibili ad accettare delle verità scomode e terribili. Anche se non venivano dalla propria parte. Anche se mettevano in discussione la propria parte. Non si voleva vedere, perciò non si vedeva. Tra il 1977 e il 1978 aumentano di intensità e di violenza le purghe interne contro i “microbi”. Vengono assassinati centinaia di dirigenti del partito e migliaia di Khmer Rossi di origine vietnamita. Nella primavera del 1978 si moltiplicano i massacri e gli scontri soprattutto sul confine con l’amico-nemico comunista Vietnam, sostenuto dall’Unione Sovietica, che da sempre costituisce una potente minaccia per l’indipendenza cambogiana. La Cina sostiene la Cambogia di Pol Pot in funzione antisovietica. L’antico conflitto tra Cambogia e Vietnam, pienamente riemerso, assume ora i connotati di uno scontro più vasto. Quello tra i due colossi del comunismo, l’Urss e la Cina, in primo luogo. Ma anche quello tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che finirà per portare il governo americano, che ha aperto una nuova stagione di rapporti con la Cina, dalla parte di Pol Pot in funzione antisovietica. Nel Natale del 1978 il Vietnam invade la Cambogia e in dieci giorni il regime dei Khmer Rossi è cancellato. Pol Pot e i suoi fuggono nella giungla, ai confini con la Thailandia, per riprendere la guerriglia, sostenuti dalla Cina e dalla stessa Thailandia (ma anche da altri). Il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna l’invasione della Cambogia da parte del Vietnam con 13 voti contro 2, URSS e Cecoslovacchia. Ma è una decisione tutt’altro che transitoria. E qui c’è la tragedia nella tragedia. Chi si aspetta un qualche tribunale per i Khmer Rossi, o almeno una loro ovvia messa al bando da parte della comunità internazionale, ora che si sa tutto sulle loro atrocità, deve assistere invece alla loro legittimazione. Mentre Pol Pot nei villaggi occupati instaura il consueto, spietato regime, i suoi rappresentanti formano con il re Siounuk un governo in esilio. E sarà questo governo in esilio a rappresentare la Cambogia alle Nazioni Unite per un decennio (come se i nazisti fossero stati legittimati a rappresentare la Germania all’ONU dal 1945 al 1955). Dal 1979 al 1990, quando erano ben noti i crimini del regime dei Khmer Rossi, questi hanno continuato ad essere accreditati all’ONU come i legittimi rappresentanti della Cambogia. Ovviamente tutto questo accadeva con il consenso degli Stati Uniti e di 38 molti paesi occidentali. C’era da condurre la battaglia campale contro l’Unione Sovietica. Ogni alleanza, a partire da quella con la Cina e i suoi amici, era utile. E così come ci si serviva dei talebani in Afghanistan in funzione antisovietica, ci si serviva per lo stesso motivo dei Khmer Rossi: anche loro contribuivano a denunciare e ostacolare e l’espansionismo sovietico che stava dietro il Vietnam invasore della Cambogia... Il decennio maledetto Questo vergognoso capitolo di politica internazionale, vero capolavoro di cinismo (quello che gli strateghi e i politologi chiamano realismo), trovò il suo inevitabile e infelice compimento nell’accordo di pace sottoscritto a Parigi nell’ottobre del 1991, sotto l’egida dell’ONU, da Vietnam, Khmer Rossi e re Sihanouk (cioè da russi, americani e cinesi) che prevedeva libere elezioni a cui tutte le parti avrebbero potuto partecipare. I Khmer Rossi venivano così definitivamente legittimati. Nel testo dell’accordo di pace non si fa menzione del genocidio che ha cancellato un terzo della popolazione cambogiana. Si parla soltanto di «politiche e pratiche del passato». I Khmer Rossi decisero poi di non partecipare alle prime elezioni che ebbero luogo nel 1993, e l’anno dopo vennero dichiarati “fuorilegge”. Molti si arresero, altri continuarono la guerriglia sotto la guida di Pol Pot. Alla fine di luglio del 1997 lo scontro interno ai Khmer Rossi arriva al suo apice. Pol Pot subisce un processo politico nella giungla da parte dei sopravvissuti gruppi di Khmer Rossi che si rivoltano contro di lui per acquisire un qualche merito prima della resa definitiva. La rivolta è guidata da Mok, braccio destro militare di Pol Pot e “mitico” comandante. Il processo politico, cui era stato invitato anche il giornalista americano Nate Thayer, si conclude con la condanna di Pol Pot all’ergastolo e la condanna a morte, invece, subito eseguita, di tre comandanti dei Khmer Rossi. Posto agli arresti domiciliari, Pol Pot continua la sua vita normale per alcuni mesi finché viene trovato morto nel suo letto il 15 aprile del 1998. Un attacco di cuore. Qualcuno dice un suicidio. Davanti a specialisti e giornalisti stranieri il suo corpo viene fotografato e analizzato, e poi cremato con rito buddista su di una catasta di rifiuti e gomme d’auto. Neanche Shakespeare avrebbe potuto inventare un finale così squallido per una vicenda così enormemente tragica. Ma è stato lui a scrivere che la realtà supera sempre la fantasia. Mok ai giornalisti dice: «Pol Pot è morto come una papaia matura. Adesso è niente più che escre- 39 menti di vacca, anzi meno importante perché quelli li possiamo almeno utilizzare come concime». Nei mesi successivi Mok rifiuta di arrendersi. Viene catturato e imprigionato l’anno seguente. È morto in carcere due anni fa. Agli altri capi del regime, Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Sary, viene permesso di vivere in libertà in Cambogia. Le instancabili pressioni dei parenti delle vittime e delle associazioni per i diritti umani perché si istituisca un Tribunale internazionale vengono fatte proprie dall’amministrazione Clinton, in particolare dal segretario di Stato Madeleine Albright, che vuole chiudere l’infelice stagione di complicità diplomatiche con i Khmer Rossi. E dopo anni di discussioni, le resistenze del governo cambogiano di Hun Sen, più propenso ai “basta col passato”, “è tempo di pacificazione”, “pensiamo al futuro”, vengono piegate. Con l’istituzione di processi in più parti del mondo contro regimi e dittatori sanguinari, una eccezione cambogiana risulterebbe insostenibile. E così nel 2003 ONU e Cambogia firmano finalmente un accordo per istituire un tribunale misto, cambogiano-internazionale, per processare i leader dei Khmer Rossi. Il tribunale viene inaugurato soltanto nel luglio del 2006. L’anno scorso gli arresti dei leader sopravvissuti e il 20 novembre 2007 l’inizio delle udienze. Proprio mentre queste erano in corso, il 30 marzo è morto Dith Pran, il giornalista-fotografo cambogiano del “New York Times” sopravvissuto ai campi di sterminio di Pol Pot e che in questi trent’anni aveva partecipato in prima fila alla battaglia contro la legittimazione internazionale dei Khmer Rossi e per l’istituzione, invece, di un tribunale che li processasse. La storia di Dith Pran, raccontata dal giornalista americano Sydney Schanberg che aveva lavorato in Cambogia con lui fino all’arrivo al potere dei Khmer Rossi, divenne un famoso film, Urla del silenzio, girato nel 1985 da Roland Joffé, che emozionò e scosse il mondo. La Commissione dell’Onu per i diritti umani si rifiutò, nel decennio maledetto, di ascoltare la testimonianza di Dith Pran, così come di prendere in considerazione i tanti dossier che documentavano i massacri dei Khmer Rossi. Il coraggioso fotografo cambogiano non avrebbe mai immaginato che gli ultimi difensori del feroce regime comunista che aveva distrutto il suo popolo sarebbero stati gli anticomunisti. 40 Nota bibliografica Casa Editrice Il Margine La bibliografia in italiano è assai limitata. In inglese e in francese c’è una messe ricchissima di testi, in libri, giornali, internet. Tra i gli autori più autorevoli vanno segnalati David P. Chandler (The Tragedy of Cambodia, A History of Cambodia, Brother Number One, Voices from S-21) e Ben Kiernan (The Pol Pot Regime, Genocide and Democracy in Cambodia). Impareggiabili come sempre le cronache del “New York Times”. Qui ci limitiamo a segnalare alcuni libri in italiano molto utili: Philip Short, Pol Pot. Anatomia di uno sterminio, Rizzoli, Milano 2005, 663 pp. Un monumentale ritratto politico di Pol Pot e del suo regime, ricco di documenti di prima mano, opera di un autore, già corrispondente della BBC, che ci ha dato anche un’importante biografia di Mao. Un libro discusso per talune tesi interpretative, ma che è il più completo pubblicato in Italia, e con una eccellente bibliografia. Francois Bizot, Il Cancello, prefazione di John Le Carrè, Ponte alle Grazie, Milano 2001, 277 pp. L’autore, un antropologo francese, tenuto prigioniero nel 1971 nella giungla dai Khmer Rossi per alcuni mesi, racconta il regime di terrore da loro instaurato nei villaggi occupati e riporta nel dettaglio le lunghe discussioni politiche da lui avute con Duch, il suo inquisitore, uno dei personaggi oggi sotto processo. Rithy Panh-Christine Chaumeau, S-21. La macchina di morte dei Khmer Rossi, O barra O edizioni, Milano 2004, 187 pp. Un cineasta cambogiano e una giornalista francese danno voce ai sopravvissuti della prigione-lager di Phnom Penh; un libro intenso che tocca i temi della memoria, del perdono, della giustizia, della verità. Tiziano Terzani, Fantasmi. Dispacci dalla Cambogia, Longanesi, Milano 2008, 380 pp. Un testo importante, di un grande giornalista e testimone del nostro tempo, ma che ne documenta anche il pentimento rispetto ai duraturi abbagli filo-Khmer Rossi, non inevitabili, che gli impedirono di vedere quello che accadeva («L’immagine di una Cambogia retta da sanguinari khmer rossi, che fino a ieri è stata presentata nella stampa occidentale attraverso i racconti dei rifugiati cambogiani scampati a quello che essi definiscono “il regno del terrore”, è entrata ora pari pari nella propaganda di Hanoi», così scriveva ancora il 3 gennaio 1978 in una corrispon denza per “La Repubblica”). ultimi volumi pubblicati Guido Formigoni, Alla prova della democrazia. Chiesa, cattolici e modernità nel Novecento italiano Il libro affronta alcuni passaggi decisivi nella storia dei rapporti tra cattolici e politica nell’Italia del Novecento. Un tema di grandissima attualità che continua a segnare la politica italiana di oggi. L’autore unisce la profondità dell’analisi all’acutezza dell’interpretazione. Il libro risponde ad alcune questioni centrali. Quali sono le correnti di pensiero che da sempre dividono i cattolici in politica? Qual è stato l’atteggiamento della Chiesa di fronte alla democrazia? E il ruolo del partito cattolico? Perché è finita la DC? Qual è stato il ruolo del cardinale Ruini nell’ultimo ventennio? E cosa resta della lezione di grandi protagonisti come Sturzo, Dossetti, De Gasperi, Lazzati, Moro? Piergiorgio Cattani, Cara Valeria. Lettere sulla fede Un giovane, bloccato fin dall’infanzia in carrozzina, scrive a un’amica e le rivela sofferenze, incertezze, speranze. Lettere che diventano a poco a poco un canto di amore per la vita e un atto di profonda fede, nonostante tutto. Le domande sul senso della vita, l’amore, il dolore, la morte, Dio, il bene, il male stanno dentro ciascuno ma non sempre trovano la possibilità di esprimersi. Attraverso un epistolario semplice e intenso l’autore instaura con l’amica Valeria un dialogo profondo che tocca i temi decisivi dell’esistenza e arriva al cuore di tutti. Paolo Renner, Frontiere – Grenzen. Vita free lance di un prete felice L’autore si trova a suo agio sulle frontiere, luoghi di incontro e scontro, luoghi rischiosi ma che lui giudica sempre originali e stimolanti: la frontiera italo-tedesca, quella dei non credenti, delle altre religioni, dei poveri, dei malati, degli immigrati, degli omosessuali... La felicità dell’essere prete in mezzo all’umanità vera, non quella dei manuali. I libri del Margine possono essere richiesti nelle librerie, oppure direttamente alla casa editrice: tel. 0461-1871871/0461-983368 (il mattino dalle 9 alle 13); e-mail: [email protected]; oppure attraverso il sito www.il-margine.it dove si può effettuare l’acquisto online con carta credito (e con ottimi sconti). C’è anche la formula dell’abbonamento: 10 libri a scelta a 110 euro (per informazioni telefonare in sede). 41 42
Scaricare