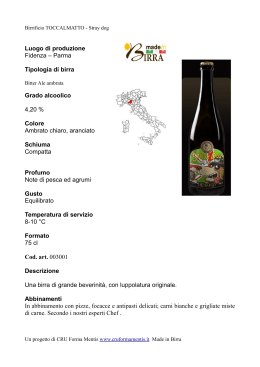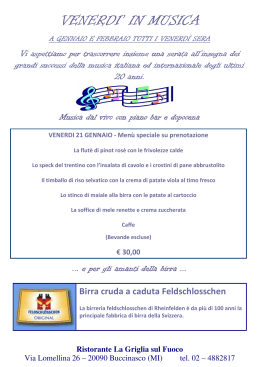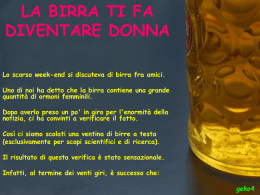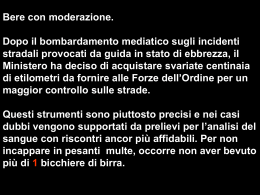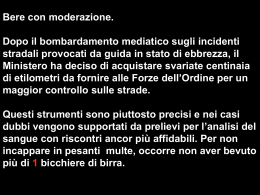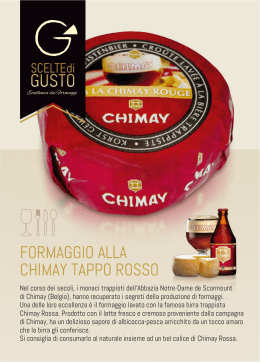Usare l’ellissi per riflettere sulla lingua Carla Marello (Università di Torino) In a cura di Ugo Cardinale A scuola d'italiano a 150 anni dall'Unità Più Lingua più Letteratura più Lessico: tre obiettivi per l' italiano d'oggi nella scuola secondaria superiore, Il Mulino, Bologna, pp. 175-188 1 Introduzione. Gli enunciati ellittici sono sempre stati considerati nell’insegnamento della grammatica delle lingue, prime e seconde, come qualcosa da ricondurre a frasi ben formate non ellittiche; e, d’altra parte, il grammatico quando si trova a fronteggiare enunciati a cui pare manchi qualcosa, rispetto alla completezza dell’insieme “soggetto+predicato+ eventuale complemento”, ricorre volentieri all’ellissi per liquidare, riconducendoli all’ordine, enunciati che per il parlante non sono incompleti, perché li integra con le informazioni che ricava dal contesto extralinguistico o dalla conoscenza del mondo. C’è quindi una certa distanza fra ciò che il grammatico, in base a un’idea di frase completa, considera mancante di qualche cosa e ciò che il parlante sente come incompleto. Tipicamente il parlante, anzi lettore/ascoltatore, comune è colpito dai puntini di sospensione nello scritto, dagli enunciati lasciati in sospeso nel parlato, con un contorno intonativo di frase anomalo 1; il lettore/ascoltatore comune è anche colpito, soprattutto se rende l’interpretazione difficoltosa, dall’implicito semantico, che invece non viene considerato un’ellissi dal grammatico 2. Dal punto di vista pragmatico, dell’efficacia dell’interazione comunicativa, come già osservava l’autore anonimo di Fiori e vita di filosafi, non abbiamo bisogno di enunciati sintatticamente completi. a) Molto giova la parola che a poco a poco si agiugne a la mente; e non bisognamo di molte 1 ma de eficaci parole1 (Fiori e vita di filosafi, cap. 24, rr. 221-222)3 In questo scritto non ci occuperemo tanto dell’aspetto pragmatico della comunicazione orale, né dell’ implicito semantico, né di enunciati non finiti prodotti, ad esempio. da non nativi; vogliamo invece sostenere l’efficacia degli enunciati ellittici, scritti, per un insegnamento grammaticale 1 Proponete a un parlante nativo un’intervista televisiva tagliata per ragioni di tempo quando sintatticamente l’intervistato aveva concluso, ma intonativamente sospesa perché aveva detto altro di seguito: questo sarà per il parlante comune un enunciato a cui “manca qualcosa”. 2 Mortara Garavelli 1979 e Marello 1999 hanno cercato di far affiorare nella riflessione metalinguistica di studenti universitari italiani che cosa sia un’ellissi attraverso test di parafrasi e completamento. Adottiamo il simbolo per indicare l’elemento linguistico mancante e il numero sottoscritto in pedice per gli elementi che appartengono alla stessa catena anaforica, cioè si rifanno allo stesso referente nel testo. Quando l’anello della catena anaforica è costituito da una o più parole, queste sono sottolineate per evidenziare i confini della ripresa. 3 esplicito di quella unità linguistica utilissima - ma ancora sottovalutata dai non-linguisti – che è il sintagma o gruppo. 1.1 Definizioni di ellissi. Sotto il nome di ellissi troviamo raggruppati fenomeni diversi il cui elemento comune è la mancanza in un enunciato di una porzione di testo che sarebbe 4 necessaria per l’interpretazione dell’enunciato oppure per la sua completezza sintattica. Si parla di ellissi in presenza quando è possibile, per chi ascolta o per chi legge un enunciato, recuperare dall’intorno linguistico il materiale necessario a completarlo e interpretarlo. Il costituente completo, che stabilisce quale valore si debba attribuire all’elemento mancante, è detto antecedente, e ha una relazione anaforica con il costituente ellittico. La massima riportata in (a) è un esempio di ellissi in presenza: infatti molte precede un parole non scritto, ma ricavabile dal secondo membro del congiunto avversativo de eficaci parole. Poiché in questo caso il costituente completo, che stabilisce quale valore si debba attribuire all’elemento mancante, non è antecedente, ma successivo, diremo che si tratta di una relazione cataforica fra il costituente ellittico e quello completo. Rispetto all’ ellissi anaforica, che si configura come un’economia, una ripetizione evitata di materiale linguistico, e rispetto alla catafora affidata a un pronome come in (b), la catafora affidata all’ellissi è una forma espressiva ricercata, che si ritrova nello scritto o al massimo nel parlato pianificato5. b) Te lo1 ripeto: stai scherzando col fuoco1 Si parla di ellissi in assenza, invece, quando ciò che manca non si può reintegrare con materiale del contesto linguistico, ma si inferisce in base alle caratteristiche di una costruzione sintattica. I due meccanismi, benché distinti, si servono tuttavia di procedimenti comuni che tengono conto della struttura e dei confini dei costituenti degli enunciati. Nell’es. (c) che novelle si può considerare ellittico di portate o avete, sulla base del fatto che la sintassi delle interrogative prevede che ci sia un predicato verbale compatibile con la semantica del sintagma realizzato e dell’enunciato. c) Ben vegnate [siate il benvenuto], il signor mio: che novelle [notizie]? (Novellino, 70, r. 12) 1.2 Meccanismi di ellissi e struttura dei costituenti di frase I meccanismi di ellissi sono specifici di ogni lingua e anche di varietà diacroniche della stessa lingua, anche se accade abbastanza di rado che un comportamento ellittico cambi nel tempo. In italiano, ad esempio, le ellissi che si facevano nel DueTrecento ( cf. Marello 2010) sono le stesse che si fanno ancora oggi con poche eccezioni. Ad esempio, l’ausiliare in italiano antico si 4 Il condizionale sarebbe è appunto legato al dubbio che i parlanti davvero non sentano mancanti di qualcosa le ellissi dei grammatici e dei linguisti.. 5 Se usata nel parlato, va accompagnata da adeguata intonazione che segnali come ciò che manca, appositamente omesso per richiamare l’attenzione dell’ascoltatore, sarà fornito subito dopo. comportava come l’ausiliare dell’inglese odierno: in una risposta e in congiunti poteva svolgere funzione di sintagma verbale ellittico del participio passato, mentre oggi non è più possibile. d) Uno si confessò da un frate e disse che, essendo egli una volta alla ruba d’una casa con assai gente, «il mio intendimento si era di trovare in una cassa cento fiorini d’oro, et io la trovai vota: ond’ io non ne credo avere peccato1». Il frate rispose: «Certo sì hai 1, tale come se tu li avessi avuti». (Novellino, 91, rr. 2-7) I meccanismi di ellissi sono una spia della struttura dei costituenti, e di questa caratteristica approfittano i linguisti quando si servono dell’ellissi come test per enucleare un costituente. E’ quella che insegniamo nei corsi universitari di linguistica di base come “enunciabilità in isolamento” . I sintagmi nominali, i sintagmi verbali, i sintagmi preposizionali vengono enucleati da una domanda non polare, cioè da una domanda che non richiede una risposta sì / no, ma verte su un preciso elemento del contenuto proposizionale, individuato da un avverbio o pronome interrogativo: chi, che cosa, quale, quando, dove, come, perché. La risposta più naturale a questo tipo di domande è una risposta breve, costituita dal sintagma che veicola l’informazione richiesta. e) Dov’è il castello? a-Fra gli alberi. b- Il castello è fra gli alberi. c- Il castello è sotto gli alberi. f) Febbraio viene prima o dopo gennaio? a-Viene dopo. b-Viene prima. c- Non viene prima6. L’esempio (e) mostra anche come l’ellissi svolga una funzione forte di coesione tra frasi nei testi e, anzi, sia l’unica forma di legame coesivo sufficiente a fare di due frasi un testo. Infatti mentre si potrebbe sostenere che la sequenza (e1) è formata da due frasi finite per caso una di seguito all’altra, ma possibili anche indipendentemente l’una dall’altra, (e2) è invece un testo in cui il sintagma preposizionale Fra gli alberi è enunciabile in isolamento perché prima c’è la domanda, ma da solo potrebbe al massimo essere un titolo7. (e1) Dov’è il castello? Il castello è fra gli alberi. (e2) Dov’è il castello? Fra gli alberi. Questi due esempi sono degli esercizi contenuti nel testo Benvenuta-Benvenuto, ( Ciari 2005) preparato dall’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte. Combinano sintassi e semantica con l’intento di veicolare molte informazioni linguistiche: la forma Dov’è, la differenza fra sotto e fra, facilmente individuabile dal disegno che mostra il Castello del Valentino fra gli alberi, e anche la sintassi della risposta breve, utile per far vedere com’è fatto un sintagma in italiano (cf Marello 2006) 6 Non viene prima è una risposta vera ma innaturale, introdotta per avere, come in tutti gli altri esercizi a risposta multipla di Benvenuta-Benvenuto 2004, una risposta falsa, ma in italiano corretto. 7 E i titoli hanno, se mai, una funzione cataforica rispetto al testo di cui sono il titolo. cf. Cortelazzo 1992 2. Domande e risposte brevi per la riflessione sulla lingua italiana Partendo da una vignetta di un testo di italiano per stranieri che mostrava una scena di vita in un bar, abbiamo costruito il seguente esercizio. Per gli stranieri la vignetta accompagnata da una lista di 31 nomi, richiamati dai numeri all’interno della figura, è un ausilio importante, ma non necessario ai fini sintattici dell’esercizio. Lo stesso esercizio dato a italofoni della scuola secondaria inferiore dovrebbe a maggior ragione poter essere svolto anche senza la vignetta. In questo esercizio l’ellissi presente in quasi tutte le risposte8 viene sfruttata per integrare nella domanda l’interrogativo che motiva tale risposta. E’ un esercizio di completamento basato proprio sulla comprensione della funzione sintattica e della struttura del sintagma enucleato nella risposta. Per gli stranieri è un esercizio difficile da svolgere; per gli italofoni non è molto difficile, ma è inusuale, in quanto finora l’insegnamento dell’italiano come lingua madre non ha insistito a sufficienza sul grande potenziale metalinguistico della coppia domanda-risposta. Alcune coppie sono più difficili di altre, anche per gli italofoni, come ad esempio B3, B7, B10. Completa ciascuna domanda in base alla risposta data. Tra parentesi tonde è indicato il numero di parole richiesto. 1/2 significa che si può riempire sia con una sia con due parole. Grammatica della domanda - prima parte A1 …(1/2)… sta facendo l’uomo seduto al bancone ? Sta bevendo A2 …(1)… sono le bottiglie di liquore? Dietro al barista A3 …(1)… ha una maglia a righe? L’uomo che mangia la brioche A4 …(1/2)… bevono i due giocatori di carte? Del vino A5 …(1)… vino hanno ordinato i giocatori di carte? Una bottiglia A6 …(1)… si svolge la scenetta ? Alle cinque di pomeriggio. A7…(1)… si chiama nell’Italia Centrale e meridionale la brioche che sta mangiando l’uomo in piedi al bancone? (Si chiama) Cornetto A8…(1)…persone ci sono in tutto nella vignetta? Nove/Ce ne sono nove. Grammatica della domanda - seconda parte B1 ….(1)…’è la birra che il barista sta servendo? E’ alla spina. B2 E’ un …(1)… quello nella tazza sul tavolino di sinistra? No, non lo è. B3 Da …(1/2)… si capisce che cos’è? Dal fatto che nella tazza c’è una bustina con l’etichetta. B4 L’uomo seduto al bancone ha …(1)… bevuto la sua birra? No, non ancora. B5 …(1)… è il più bravo dei due giocatori di carte secondo te? Quello di destra B6 …(1)…? Sembra più sicuro 8 A8 e B2 hanno risposte anaforiche attraverso i pronomi ne e lo; B6 e B7 sono collegate da ellissi del pronome soggetto, normalissima in italiano. B7 …(1)… torta è quella nella vetrina a destra sul bancone? E’ una torta alla crema B8 …(1)…’ è lo zucchero? Sul bancone del bar. B9 …(1)… si beve un espresso in Italia? Soprattutto al mattino e dopo pranzo. B10 …(1)… le paste nella vetrina a destra sono alla crema? No, non tutte. Gli scopi dell’esercizio sono, in generale, verificare se lo studente padroneggia l’ellissi del tema o topic e se, avendogli dato il rema o comment nelle risposte, sotto forma di diversi sintagmi (SN, SP, SV, Savverbiale B4 e B9), riesce a individuare l’interrogativo necessario di volta in volta. Nel dettaglio si vuole: -verificare che individui il valore partitivo di Del vino in A4, e che riconosca un quantificatore naturale ( una bottiglia) in A5 -verificare che sappia usare Qual/chi in B5, che sappia usare Com’, dov’ in B1, B8 -verificare che in B3 sappia che il fatto che non implica l’uso di fatto nella domanda -richiamare l’attenzione su già/non ancora in B4 -richiamare l’attenzione in B10sulla peculiare posizione pre-articolo caratteristica di tutto in italiano -far notare che in B7 quale non può essere l’interrogativo giusto, perché non si tratta di scegliere fra molte torte, ma di dire il tipo di torta. -verificare che sappia padroneggiare le domande polari (sì/no) B2, B10 ricavando dalla risposta su che verte la domanda. Per quanto concerne la capacità di ricavare il completamento caffè , oppure succo, in B2 ( E’ un …(1)… quello nella tazza sul tavolino di sinistra? No, non lo è), è importante che l’allievo si basi anche su B3 (Da …(1/2)… si capisce che cos’è? Dal fatto che nella tazza c’è una bustina con l’etichetta). La strategia di completamento in questo caso si avvale dei ragionamenti tipici per risolvere il cloze, oltre che della riflessione sul rapporto domanda-risposta. In B10 la lacuna è più facilmente riempibile, in quanto la parola mancante tutte sta nella risposta, mentre in B2 , se non si legge B3 come la prosecuzione di B2, le proposte di riempimento debbono essere fatte sulla base della conoscenza di ciò che si beve in tazza in un bar italiano ed è di genere maschile. 3. Risultati di un’ esperienza con allievi 3.1 Studenti francofoni di livello avanzato Abbiamo fatto svolgere l’esercizio in una classe di universitari francesi con almeno quattro anni di studio dell’italiano9 e, come era prevedibile, non hanno avuto grandi difficoltà. La lacuna in B2 9 Siamo grati a Barbara Meazzi , professore di italiano presso l’Université de Savoie- Chambéry, per aver proposto nel febbraio 2004 l’esercizio ai suoi studenti del primo anno di Master Langues et Affaires (quarto anno di studi). salvo un non riempimento10, un allievo che ha inserito espresso, uno che ha optato per cappuccino, è stata riempita da tutti gli altri con caffè. Interessante che una studentessa abbia riempito con tutto B4 (ha tutto bevuto la sua birra?). Più problematiche si sono rivelate le risposte a B1 e B7. Quattro su tredici hanno sbagliato B1, riempiendo con qualle (sic), qual’, dove. Cinque su tredici hanno riempito la domanda B7 con quale, anziché con il corretto che. In entrambi i casi sullo sfondo di questi errori c’è la possibilità di avere versioni con Di quale tipo, Qual/che tipo di. Tale versione nel caso di B1 è non parafrastica, nel caso di B7 parafrastica salva veritate, cioè conservante lo stesso significato11. B1 bis Di quale tipo è la birra che il barista sta servendo? E’ alla spina. B7 bis Quale/che tipo di torta è quella nella vetrina a destra sul bancone? E’ una torta alla crema Se si riempissero le domande in B1 e B7 con il solo qual / quale, come suggerito dagli studenti francesi (Qual è la birra che il barista sta servendo? Quale torta è quella nella vetrina a destra sul bancone?) risposte adatte alle domande sarebbero rispettivamente E’ quella alla spina, E’ quella alla crema. Da queste risposte si potrebbe partire per spiegare perché qual / quale non sono i riempimenti richiesti nelle domande in B1 e B7. Infatti qual / quale non ammette la risposta E’ una torta alla crema, con l’articolo indeterminato. Per altro la risposta E’ alla spina in B7 è ellittica, e sottintende una birra, non la birra . Dalle risposte di B1 e B7 si capisce che le domande vertono una sul modo di servire la birra, non sulla specifica quantità o qualità di birra servita dal barista in quel momento e l’altra sul tipo di torta a cui appartiene una torta non definita in precedenza. La differenza è fine e non stupisce che si possano incontrare difficoltà nel capirla. 3.1.1 La spiegazione dei linguisti Per quanto concerne l’uso di quale in una interrogativa come B1, Fava (1995, pp. 90-91) spiega che “Quale presuppone sempre un riferimento a un dominio definito, mentre questo non vale per che. […] L’interrogazione dei nomi massa non è esclusa. Ma interrogati con quale, i nomi di massa sono ricategorizzati come numerabili”. Quindi se si vuole intendere B1 come B1 tris, la birra non è un nome di massa, ma è ricategorizzato come un tipo di birra fra altri o il boccale di birra ( ordinato in precedenza, di cui si è già parlato) che il barista sta riempiendo, e l’ammissibilità dell’ellissi del SN definito è quantomeno dubbia. B1 ….(1)…’è la birra che il barista sta servendo? E’ alla spina. B1 tris Qual è la birra che il barista sta servendo? E’ quella/la birra/*?Ø alla spina Per usare la terminologia introdotta nella Grande Grammatica italiana di consultazione, ciò che conta è la differenza tra due tipi di frasi copulari. La birra che il barista sta servendo è una birra alla spina; la torta nella vetrina a destra sul bancone è una torta alla crema sono frasi predicative, mentre La birra che il barista sta servendo è quella alla spina; la torta nella vetrina a destra sul bancone è quella alla crema sono frasi specificative ( cf Frison 1988 p. 200). La frase specificativa 10 Si tratta di un’allieva che ha risposto dove a B1, non ha risposto a B2 e a B7. 11 Si veda tuttavia la nota 14 sull’apostrofo che passa inosservato o viene ignorato. ammette che il focus dell'interrogativa sia un referente definito. Gli apprendenti che integrano B1 con quale, usano un elemento WH fortemente definito come quale, perché interpretano erroneamente la risposta ellittica come una specificativa ellittica di quella: E’ (quella) alla spina, ellissi che è, come dicevamo, molto problematica, poiché se il focus è sul referente definito, allora tale referente deve essere esplicitato nella risposta o con quella o con la birra. Non suscita problemi invece l’ellissi del SN indefinito una birra , quando l’attenzione è attirata su alla spina12, e perciò l’interrogativa da integrare è come, anzi com’. 3.2 Studenti di livello intermedio L’esercizio è stato anche proposto a studenti, di varie lingue madri e di livello non omogeneo, che frequentavano un corso di italiano per stranieri presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Torino 13. Rispetto ai francofoni di livello avanzato, si nota che gli allievi a livello intermedio non hanno sempre riconosciuto in A5 il valore di una bottiglia, quantificatore ellittico della materia quantificata, e hanno integrato con Quale e che. Alcuni hanno capito la funzione di quantificatore e adottato una strategia di ricostruzione a partire dalla risposta, mettendo quante bottiglie, ma trascurando il necessario di, nonché la consegna che chiedeva di riempire la domanda con una sola parola. Ben dieci allievi su ventitré hanno riempito B1 con quale o dove, o di chi. E’ interessante osservare che hanno offerto soluzioni che danno una domanda sintatticamente giusta 14. E’ la correttezza del testo domanda-risposta che viene disattesa. Discutendo con gli studenti questo aspetto, emerge chiaro il ruolo dell’ellissi come meccanismo che fa di due enunciati un testo. L’integrazione di B7 non è stata l’auspicato che in ben tredici casi su ventitré, e, rispetto alle soluzioni degli allievi francofoni di livello avanzato, quale è apparso solo in tre casi; ben tre studenti hanno lasciato vuota la lacuna, cinque hanno riempito con soluzioni volenterose e ingegnose, come ad esempio di che cosa, ma costituite da più di una parola e errate dal punto di vista testo domanda-risposta coeso e coerente: g) *com’è/come e/che è/di che cosa/che cosa torta è quella nella vetrina a destra sul bancone? Uno studente ha offerto una soluzione accettabile a livello di domanda isolata: h) La torta è quella nella vetrina a destra sul bancone? Solo uno studente ha proposto (i), parafrasi estesa ed esplicitante del che richiesto. 12 Sintagma preposizionale che è messo in grande rilievo proprio dall’ellissi della sua testa. 13 Dobbiamo alla gentilezza della Prof.ssa Franca Bosc, che nel 2004 teneva tale corso, l’aver proposto ai suoi studenti l’esercizio. 14 Ovviamente sono soluzioni giuste se si trascura il fatto che ’è la birra che il barista sta servendo? contiene un apostrofo che, se non ignorato, non ammetterebbe riempimento né con qual , né con quale, né con dove intero, né tantomeno con di chi. i) Che tipo di torta è quella nella vetrina a destra sul bancone? Gli allievi di livello intermedio hanno adottato più spesso degli studenti francofoni di livello avanzato la strategia di evitamento consistente nel disattendere la consegna e fornire una domanda sintatticamente corretta, se presa isolatamente. Anche il segno grafico dell’apostrofo è stato spesso ignorato nei riempimenti di B8, relativamente più facile. j) Come/cosa/quello ’ è lo zucchero? Indicativi di una fase di apprendimento meno sviluppata possono considerarsi riempimenti per B3 come quelli mostrati in (k) e forse risentono del “bagno linguistico” in un italiano colloquiale parlato riempimenti come quello in (l), sempre se non si tiene conto della struttura sintattica della risposta e si bada di più al senso. k) *Da come/quale si capisce che cos’è? Dal fatto che nella tazza c’è una bustina con l’etichetta l) Da dove si capisce che cos’è? Dal fatto che nella tazza c’è una bustina con l’etichetta 4 Conclusioni Spesso le risposte degli apprendenti stranieri di italiano ci fanno capire meglio anche le difficoltà che gli studenti italiani trovano con le strutture marcate, con la ripresa pronominale della testa del sintagma, con l’individuazione del tema/rema (topic/comment) e dell’articolazione dato/nuovo in generale e del focus. Non sempre le grammatiche del biennio delle superiori aiutano con questo tipo di problemi, perché, ad esempio, la sintassi della coppia domanda-risposta e delle frasi scisse è più affrontata nelle grammatiche per stranieri che in quelle per italiani, come pure i casi di ellissi in presenza. D’altra parte le trattazioni dei linguisti affrontano questi temi con un metalinguaggio solo parzialmente proponibile in classe, sia pure in classi delle secondarie superiori. Resta nondimeno la forza dell’esempio, l’opportunità, in qualche caso la necessità, di allenare all’esercizio della riflessione sulla propria lingua. Proporre più spesso di quanto non si faccia ora esercizi basati sulla coppia domanda-risposta con risposta ellittica, su lacune artificialmente create da riempire in base alla struttura e al senso di quanto è stato detto/scritto, si rivela sempre molto fruttuoso per far esercitare gli allievi a riflettere sulla lingua che dovrebbero saper usare meglio. Bibliografia Cortelazzo M. A., 1992 Il titolo e il testo, Atti del XV Convegno Interuniversitario Bressanone 1113 luglio 1987, Editoriale Programma , Padova, Ciari M. 2005, Benvenuta-Benvenuto, Libretto, CD-rom interattivo e audio-cassette, per l’apprendimento dell’italiano L2 da parte di allievi con età 6-12 anni; n° 11 versioni bilingui (italiano e albanese, arabo, cinese, francese, greco, inglese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco), Nuova edizione, Torino, MIUR-USR Piemonte e Regione Piemonte. Fava E. 1995, Tipi di frasi principali. Il tipo interrogativo in L. Renzi, G. P. Salvi. (a cura di) 1988-1995, Grande Grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino, vol. III, 1995, pp.70-127 Frison L. 1988, L’ordine degli elementi nella frase e le costruzioni marcate §3 La frase scissa in L. Renzi, G. P. Salvi (a cura di) 1988-1995, Grande Grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino, vol. I, 1988, pp.194-225 Marello C.1999, Parafrasi di enunciati ellittici in B.Mortara Garavelli, L. Lumbelli (a cura di), Parafrasi. Dalla ricerca linguistica alla ricerca pedagogica, Edizioni dell'Orso, Alessandria, Edizioni dell'Orso, Alessandria pp. 109-131. --2006, La formazione dell’insegnante di italiano L2 tra scuola e Università ,in F Bosc, C.Marello, S. Mosca (a cura di), Saperi per insegnare.Formare insegnanti di italiano per stranieri. Un’esperienza di collaborazione fra università e scuola, Loescher, Torino 2006, pp. 10-20 --2010, Ellissi in (a cura di) L. Renzi, G. P. Salvi, Grammatica dell’italiano antico, Il Mulino, Bologna, vol. II, pp.1369-1386 Mortara Garavelli B. 1979, Il filo del discorso. Giappichelli, Torino
Scarica